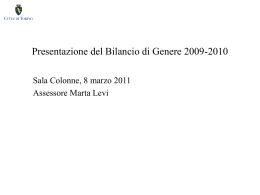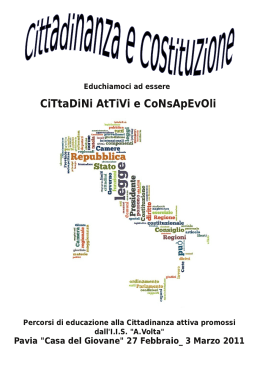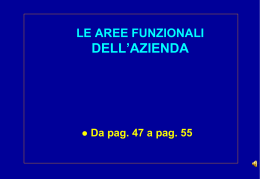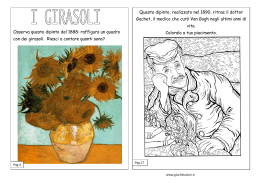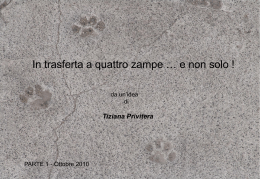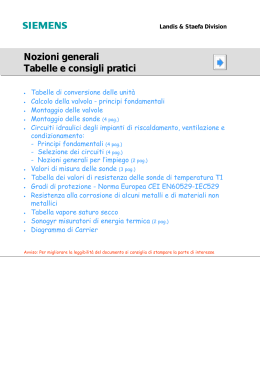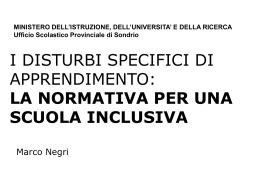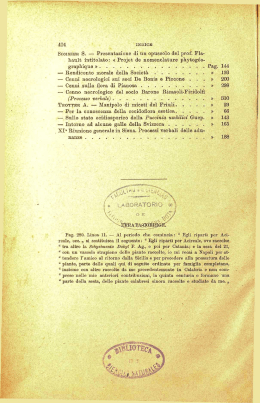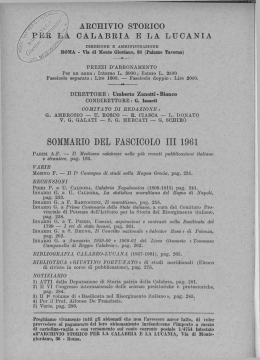Anno scolastico 2013/2014 ISTITUTO D’ARTE “N. NANI” sperimentazione “Michelangelo” Documento finale del Consiglio di Classe Classe V E Presentazione dell'Istituto Il Liceo Artistico di Verona nasce con la delibera della giunta regionale n. 120 del 31/01/2012: “Operazione di dimensionamento: istituzione di un nuovo liceo artistico in cui confluiscono le classi dell’ISA Napoleone Nani e del LA Umberto Boccioni ”. Il nuovo Istituto raccoglie in un' unica realtà: il “nuovo” Liceo Artistico di Verona previsto dalla Riforma, arrivato al suo quarto anno; l'Istituto d'Arte “Napoleone Nani”, che sta concludendo il suo ciclo con le ultime classi quinte, non essendo più previsto dagli ordinamenti scolastici; il “vecchio” Liceo Artistico (LAS) “Boccioni”, anch’esso ad esaurimento, con le ultime classi impegnate nel quinto anno integrativo. Gli indirizzi previsti nel nuovo Liceo Artistico della Riforma, avviato nel 2010/11, sono: Architettura e Ambiente, Arti figurative, Audiovisivo e multimediale, Design industriale, Design della Moda, Grafica, Scenografia. Il Liceo Artistico di Verona è oggi l’unico Istituto Superiore della Provincia che consente di conseguire una formazione artistica in tutte le declinazioni previste dai nuovi ordinamenti. Nella sua lunga storia ha saputo far emergere da ogni allievo quanto di unico e irripetibile risiede nella sua creatività, in armonia con il contesto sociale, culturale, economico, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili. Gli allievi provengono da un’area ampia, quale è la provincia di Verona, fortemente differenziata geograficamente ed economicamente. Il nostro Istituto ha saputo assolvere al proprio fine istituzionale rafforzando le basi culturali degli alunni e valorizzando il carattere vocazionale ed orientante delle materie artistiche. La ricchezza artistica della città e del territorio si presenta come laboratorio permanente e contesto di valorizzazione delle competenze e delle abilità dei nostri allievi. Il Liceo artistico ha offerto e continuerà a offrire, anche quando il processo di Riforma sarà stabilizzato: accessibilità alle Facoltà universitarie, alle Accademie di Belle Arti, agli Istituti Superiori delle Industrie Grafiche; Pag. 1 accessibilità al mondo del lavoro (disegnatore di architettura, designer, grafico pubblicitario, pittore, scultore, scenografo, regista, illustratore, stilista, fashion textile, decoratore, restauratore pittorico, restauratore del mobile, restauratore di edifici). Il Liceo Artistico si impegna a: consolidare il ruolo di unico polo di attrazione e formazione di personalità e professionalità artistiche indispensabili e riconosciute dal sistema produttivo territoriale, nazionale e internazionale; incrementare l’interazione con le realtà culturali e istituzionali di Verona, città d’arte; sviluppare una sempre più ampia sinergia con il mondo produttivo locale, formando intelligenze creative, valorizzando il merito, appassionando alla ricerca per l’innovazione. I nostri alunni e la nostra scuola classi 42 + 3 del 5^ anno integrativo pomeridiano alunni 1084 Il personale della scuola Docenti 120 Amministrativi 8 Tecnici 2 Ausiliari 14 L'integrazione scuola - territorio: attività e progetti Il nostro Istituto, nella sua attuale articolazione di Istituto d’arte e Liceo artistico, si propone come riferimento per le associazioni culturali, le istituzioni e le aziende che fanno della produzione artistica, della creatività, della progettualità le risorse del proprio sviluppo e la ragione sociale della loro esistenza. L’istituto declina i propri obiettivi finali e i propri profili in uscita in termini di conoscenze, abilità e competenze, che definiscono l’occupabilità dei propri allievi sul mercato del lavoro locale e globale. Anche nel corrente anno scolastico la scuola ha ricercato e realizzato positivi rapporti con le realtà culturali, associative ed aziendali del territorio: sia il Liceo, sia l’Istituto d’arte hanno partecipato con successo a concorsi e mostre che hanno valorizzato le competenze artistiche e progettuali degli allievi; significativo il rapporto con Enti, istituzioni e aziende che hanno svolto un ruolo impegnativo di committenza, ma hanno saputo anche riconoscere e valorizzare i meriti degli studenti e dei docenti che li hanno guidati nello svolgimento dei lavori. Strumenti tecnologici, multimediali e loro utilizzo nella scuola L’Istituto è dotato di numerosi laboratori artistici e di quattro aule informatiche, di cui una di nuova realizzazione, per corrispondere alle esigenze più avanzate della didattica multimediale. Il pieno utilizzo dei laboratori ha consentito, per tutte le classi, un approccio al software di base connesso alla progettazione artistica e architettonica: Autocad, Photoshop, Free Hand e altro ancora. Pag. 2 Competenze A conclusione del triennio sperimentale “Michelangelo” dell’ Istituto d’Arte “Nani” nelle specializzazioni di architettura ed arredo disegno industriale gli allievi sono preparati a area umanistico-scientifica: leggere, interpretare, individuare i nuclei concettuali e contestualizzare un testo letterario, filosofico, storico, artistico; produrre testi di diverso tipo, rispondenti a diverse funzioni, utilizzando tecniche compositive adeguate e linguaggi specifici sia in italiano che in inglese; relazionare date, eventi, autori, utilizzando strumenti e metodologie disciplinari specifiche; sostenere una conversazione sufficientemente articolata, su argomenti di carattere specifico in lingua inglese; individuare analogie e differenze tra concetti, modelli, o metodi nei diversi ambiti disciplinari; operare con il simbolismo matematico; applicare le regole della logica; utilizzare correttamente e con autonomia strumenti e tecniche informatiche. sono in grado di area di indirizzo “Architettura e arredo”: strutturare un percorso progettuale; utilizzare correttamente e con apporti personali, i metodi di rappresentazione grafica per lo studio e la comunicazione delle forme di progetto; conoscere le misure dell’uomo in rapporto con l’ambiente; utilizzare correttamente la simbologia grafica; rappresentare correttamente i particolari costruttivi; verificare e comunicare le scelte progettuali attraverso modelli sia grafici che tridimensionali; utilizzare correttamente e con autonomia strumenti e tecniche informatiche; conoscere i principali architetti e riconoscerne i caratteri compositivo - progettuali area di indirizzo “Disegno industriale”: strutturare un percorso progettuale; utilizzare correttamente e con apporti personali, i metodi di rappresentazione grafica per lo studio e la comunicazione delle forme di progetto; utilizzare correttamente la simbologia grafica; rappresentare correttamente i particolari costruttivi; verificare e comunicare le scelte progettuali attraverso modelli sia grafici che tridimensionali; conoscere le misure dell’uomo in rapporto con l’ambiente; utilizzare correttamente e con autonomia strumenti e tecniche informatiche; utilizzare con proprietà e originalità i materiali; conoscere i principali designer e riconoscere i caratteri linguistico - progettuali. Pag. 3 Presentazione della classe Elenco degli alunni (candidati interni) Cognome e Nome ADAMI CRISTIAN BALLARINI SARA BLAJ ALEXANDRA FLORINA BRAGGIO VALERIO CORAME ILARIA DALLA BELLA LUCA FACCINCANI EMILIO FASOLI SILVIA* GJERGJI STELA IACUZZI MARCO MALAFFO DEBORA MANZATI CATERINA MARTINO ARIANNA MASSALONGO NICOLO' MIGLIASSO VANESSA PROVOLO IRENE SCHIARANTE EMILY SOFFIATI ANNA TOAIARI ELISA TURRI DAVIDE VANTINI BEATRICE ZANOLLI ANNA ZANONI LAURA * L'alunna Fasoli Silvia ha interrotto la frequenza scolastica nel secondo quadrimestre Pag. 4 Breve descrizione della composizione della classe e della sua storia 1 Composizione della classe Femmine Maschi TOTALE Indirizzo Architettura 8 3 Indirizzo Design Industriale 7 4 Classe al completo 15 6 22 Storia della classe A.S. Classe 2011/2012 III 2012/2013 IV 2013/2014 V Composizione alunni (provenienza e percorso scolastico) Tot. alunni Provenienza 24 Stesso Istituto 25 Stessa classe + 1 nuovo inserimento Stessa classe 23 Ripetenti Nuovi inserimenti Ritiri 1 2* 1 1** *Un non ammesso **Un’alunna, alla data odierna, ha superato il numero massimo di assenze consentite Nella classe è presente n. 1 allieva certificata con DSA. È disponibile agli atti e viene consegnata alla Commissione d’esame la documentazione relativa all’allieva con DSA. Alla classe sono aggregati n. 6 (sei) candidati esterni. Elenco candidati esterni assegnati alla classe Cognome / Nome 1 FAGNANI Martina 2 GUIA Alexandro Teodor 3 GIACOMINI Marco È disponibile agli atti e viene consegnata alla Commissione d’esame la documentazione relativa ai candidati esterni (curriculum, verbale delle prove d’esame per l’ammissione all’esame di stato, documenti). 1 Descrivere IV e V di ordinamento, III IV e V sperimentali Michelangelo. Descrivere brevemente la formazione della classe iniziale indicando le classi di provenienza, le squadre, i maschi e le femmine, eventuali ripetenti e nuovi inserimenti in itinere, eventuali ritiri. Pag. 5 RELAZIONE SULLA CLASSE 5E La classe è eterogenea nella sua composizione, con la presenza dei due indirizzi di Architettura e Arredo e Design Industriale. Globalmente ha presentato, fin dall’inizio del percorso, buone potenzialità cognitive, nonché motivazione ed attitudine – in alcuni casi spiccate - rispetto all’indirizzo di studi prescelto. Tali caratteristiche si sono confermate durante l’iter formativo. Alcuni studenti hanno manifestato, peraltro, un approccio allo studio superficiale e discontinuo. Tale modalità, anche quando non ha compromesso risultati di profitto sufficienti, ha comunque inficiato la qualità e la stabilità dell’apprendimento, che, specie nelle discipline di area generale, appare spesso prevalentemente mnemonico. In tali casi, si riscontra, di conseguenza, limitata autonomia nell’applicazione delle conoscenze e scarso livello di rielaborazione dei contenuti. Per alcuni studenti si sono registrate anche frequenti assenze e/o ritardi(segnalati anche nei precedenti anni scolastici), che hanno ulteriormente peggiorato la qualità dell'apprendimento. Alcuni allievi hanno manifestato comportamenti ed atteggiamenti non sempre in linea con quanto atteso per il contesto scolastico. In quanto alla relazione con i docenti, il dialogo si è mantenuto aperto e generalmente corretto. Alcuni studenti, hanno manifestato interesse rispetto alla preparazione di un elaborato personale da produrre per l’Esame di Stato, chiedendo anche suggerimenti e aiuto ai docenti. Il coordinatore, a questo proposito, ha proposto, negli esigui limiti del monte ore a disposizione, attività specifiche mirate al miglioramento delle capacità di ricerca, lettura selettiva dei testi, accesso alle fonti informative. Durante l’ultimo anno si sono registrate difficoltà organizzative nella gestione della didattica (specie per le materie di Inglese e Filosofia), derivanti dalla struttura dell’orario settimanale, che prevedeva alcune “settime ore”, nelle quali molti studenti hanno richiesto autorizzazione all’uscita anticipata per problemi di trasporto. Ciò ha comportato, di fatto, la perdita quasi totale della lezione, nonché la difficoltà, per i docenti, nel gestire le prove di verifica, le attività di recupero in itinere e l’introduzione di nuovi argomenti. Si è, infine, presentata la necessità di ridimensionare il contenuto della programmazione di Filosofia, Inglese e Religione: spesso, infatti, è accaduto che le ore di lezione previste per queste discipline fossero destinate ad attività di ampliamento/approfondimento, orientamento, viaggi o uscite, oppure che coincidessero con periodi di vacanza. Pag. 6 Composizione del corpo docente Materia Religione o mat. Alternativa Italiano Storia Lingua straniera (inglese) Filosofia Matematica Fisica Ed. fisica Storia dell'arte Progettazione Geometria descrittiva Esercitazioni di laboratorio Cognome e Nome Continuità sì/no Corso Giovanna Sì Lanzino Concetta Sì Lanzino Concetta Sì Dusi Elena Sì Nardi Francesca No Bovo Giuseppe Sì Bovo Giuseppe Sì Zanderigo Riccardo No Castagna Cristina Sì Bellintani Giovanna/Tonoli Sì/No Giovanna Berruti Claudio/Grapulin Roberto Sì Caceffo Stefano/Costantini Lina Sì Note aggiuntive2: a) Precisazioni sulla composizione del corpo docente - Squadra indirizzo Architettura Docente di Progettazione: Giovanna Bellintani Docente di Esercitazioni di laboratorio: Lina Costantini Docente di Geometria descrittiva: Roberto Grapulin Squadra indirizzo Design Docente di Progettazione: Giovanna Tonoli Docente di Esercitazioni di Laboratorio: Stefano Caceffo Docente di Geometria descrittiva: Claudio Berruti b) Supplenze prolungate: Filosofia (dal 10.12.13 al 19.01.14) Inglese (dal 10.03 al 20.05.14) 2 Eventuali supplenze prolungate con eventuale alternanza di docenti, specificare eventuale strutturazione a squadre Pag. 7 Attività di ampliamento / approfondimento realizzate in corso d’anno Materie coinvolte Contenuti Studenti destinatari Collaborazione con la ditta “Revers Lab” per la realizzazione di un oggetto modulare per la realizzazione di stand espositivi per la manifestazione fieristica “ArtVerona”, svoltasi presso la Fiera di Verona nel mese di ottobre 2013. Sicurezza stradale: incontro formativo presso l'Ist. Tecnico Industriale G. Marconi in data 31.01.2014 Progettazione Laboratorio di progettazione Tutte Studenti dell’indirizzo di Design Industriale L'intera classe Attività di recupero attivate in corso d’anno cui hanno partecipato alunni della classe Materie Alunni Filosofia Fisica Inglese Matematica Progettazione Design Storia dell’Arte Laboratorio Design Geometria descrittiva Il gruppo classe (recupero in itinere, in orario curriculare) Singoli studenti, con interventi individualizzati Metodologie didattiche adottate dal C.d.C. Le attività di insegnamento nelle varie discipline sono riassunte nella seguente tabella. Per gli obiettivi, i contenuti, i tempi, gli spazi e i materiali dell'insegnamento rimandiamo alla relazione delle singole materie. Tipo di attività Tipologia\ Materie Lezione frontale Lezione interattiva Lavori di gruppo Esercitazione guidata Esercitazione con “peer tutoring” ITALIANO STORIA X Esercitazione di laboratorio ALTRO Studio autonomo o produzione grafica su consegna di un argomento concordato e discusso con l’insegnante Pag. 8 X STORIA DELL’ARTE MATEMATICA FISICA FILOSOFIA X X X X X X X X X X Tipologia\ Materie Lezione frontale Lezione interattiva Lavori di gruppo Esercitazione guidata Esercitazione con “peer tutoring” Esercitazione di laboratorio INGLESE GEOMETRIA DESCRITTIVA PROGETTAZI ONE LABORATORIO ED. FISICA IRC X X X X X X X X X X X X X ALTRO X X Studio autonomo o produzione grafica su consegna di un argomento concordato e discusso con l’insegnante Valutazione degli apprendimenti e dei comportamenti Lessico di riferimento per la valutazione Il C.d.C. ha stabilito di descrivere i risultati nell’apprendimento degli alunni in termini di conoscenze, abilità e competenze. Conoscenze (Sapere) Abilità (Saper fare) Competenze (Saper essere) Acquisizione di contenuti, principi, teorie, concetti, termini, regole, procedure, metodi, tecniche. È l'insieme di alcune conoscenze teoriche afferenti ad una o più aree disciplinari. Utilizzazione delle conoscenze acquisite per risolvere situazioni problematiche o produrre nuovi oggetti (inventare, creare). Utilizzazione significativa e responsabile di determinate conoscenze e abilità in situazioni organizzate in cui interagiscono più fattori e/o soggetti e si debba assumere una decisione. Indicatori utilizzati per la valutazione delle verifiche Nei dipartimenti disciplinari sono stati individuati gli indicatori in oggetto e sono elencati nelle relazioni delle singole materie allegate al presente documento. Per quanto riguarda l’attribuzione del voto in decimi, ogni insegnante espone agli studenti il suo metodo, e in genere lo esplicita chiaramente nella verifica stessa. Tutti comunque si attengono alla seguente “griglia”: Pag. 9 V O T O 10 9 8 7 GIUDIZIO Eccellente Ottimo Buono Discreto CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE L’alunno possiede una conoscenza completa, ricca e approfondita dei contenuti, acquisita anche grazie a ricerche personali. L’alunno applica le conoscenze in modo corretto e personale, anche in situazioni nuove. L’alunno organizza, confronta, collega e rielabora conoscenze e competenze in modo autonomo e con spirito critico. L’alunno possiede una L’alunno applica le conoscenza completa e conoscenze in modo corretto approfondita dei contenuti. anche in situazioni nuove. L’alunno organizza, confronta, collega e rielabora conoscenze e competenze in modo autonomo. L’alunno possiede una conoscenza completa dei contenuti. L’alunno applica le conoscenze in modo corretto in situazioni note. L’alunno organizza, confronta e collega conoscenze e competenze in modo autonomo. L’alunno possiede una conoscenza soddisfacente dei contenuti. L’alunno organizza in modo L’alunno applica le autonomo conoscenze e conoscenze in situazioni note competenze, ma necessita commettendo sporadici errori di guida per confrontare e di lieve portata. collegare. L’alunno possiede una conoscenza essenziale dei contenuti. L’alunno applica le conoscenze in situazioni note e già sperimentate commettendo alcuni errori. Solo guidato l’alunno organizza e confronta conoscenze e competenze. L’alunno possiede una conoscenza superficiale e parziale dei contenuti. L’alunno applica le conoscenze in situazioni note e già sperimentate commettendo errori significativi. Anche guidato, l’alunno ha difficoltà nell’organizzare conoscenze e competenze. L’alunno possiede una conoscenza lacunosa e frammentaria dei contenuti. L’alunno applica le conoscenze con notevole difficoltà anche in situazioni note e già sperimentate. Anche guidato, l’alunno ha notevoli difficoltà nell’organizzare le conoscenze. L’alunno possiede una conoscenza quasi nulla/nulla dei contenuti. L’alunno non è in grado di applicare conoscenze. L’alunno non è in grado di organizzare le conoscenze. Sufficiente: 6 obiettivi minimi raggiunti Insufficiente: 5 obiettivi minimi parzialmente raggiunti Gravemente insufficiente: 4 obiettivi minimi non raggiunti Totalmente insufficiente: 3-1 obiettivi non raggiunti Pag. 10 Numero delle prove (medio per alunno) effettuate utilizzando le diverse tipologie di verifica indicate Tipologia\ Materie Interrogazione Trattazione breve di argomenti Tipologie previste dalle prove scritte degli conclusivi (A,B,C,…) Analisiesami e soluzione di un problema Prove grafiche/ pratiche/esercitazioni Progetti ITALIANO STORIA STORIA DELL’ARTE 3 4 4 MATEMATICA FISICA FILOSOFIA 2 2 2 2 4 2 4 2 3 Prova strutturata Quesiti a risposta multipla Quesiti a risposta Vero-Falso Completamento Collegamento Tipologia\ Materie INGLESE Interrogazione Trattazione breve di argomenti Tipologie previste dalle prove scritte degli esami conclusivi Analisi e soluzione di un problema (A,B,C,…) Prove grafiche / pratiche/esercitazioni Progetti 3 TEORIA E ED. APPL. GEOM. VISIVA PROGETT. LAB. ED. FISICA IRC 1 2 2 2 3/4 6 6 1 Prova strutturata Quesiti a risposta multipla Quesiti a risposta Vero-Falso Completamento Collegamento Prove pluridisciplinari secondo le tipologie previste per la 3^ prova dell'Esame di Stato Discipline coinvolte Tipologia della Prova Filosofia, Fisica, Inglese, Storia Tipologia B dell’Arte Filosofia, Inglese, Matematica, Tipologia B Storia dell’Arte Periodo di effettuazione 7 marzo 2014 15 aprile 2014 Preparazione del colloquio interdisciplinare del nuovo esame di Stato Gli alunni, nella preparazione della parte di colloquio loro dedicata, sono stati invitati a predisporre tracce ragionate o tesine o elaborati che esaltassero le competenze acquisite nel corso di studi, gli interessi culturali, le passioni artistiche e culturali. Si sono curati quindi i collegamenti interni all’argomento prescelto e il loro sviluppo logico. Gli studenti sono stati invitati a evitare collegamenti e riferimenti forzosi e troppo schematici alle varie discipline coinvolte per sviluppare l’argomento. L’intento è stato quello di introdurre il colloquio Pag. 11 valorizzando le capacità comunicative, pratiche e teoriche acquisite nel percorso scolastico e formativo. Il giorno 28 aprile 2014 gli studenti hanno partecipato ad un incontro con docente esperto, appositamente incaricato, per la preparazione al colloquio d’esame, con particolare riguardo all’individuazione, progettazione e realizzazione dell’elaborato/argomento di avvio del colloquio. Misure compensative e dispensative per alunni DSA Misure compensative (i materiali di studio sono stati forniti in fotocopia o in formato elettronico) testi semplificati immagini mappe sintesi possibilità di usare la calcolatrice eventuale compensazione/integrazione di prove scritte con prove orali Misure dispensative lettura ad alta voce prendere appunti (facoltativo) rispetto di tempi standard dettatura di testi e/o appunti studio mnemonico Per ulteriori informazioni, si rimanda al Piano Didattico Personalizzato, qui allegato. Criteri adottati per la valutazione del comportamento degli alunni A seguito del Regolamento sulla valutazione emesso con decreto governativo 13 Marzo 2009 e successivi riferimenti nell’O.M. n 40 all’Art. 2 Comma 1 e della circolare ministeriale n.46 che chiarisce definitivamente che il voto di comportamento fa media con gli esiti delle altre discipline, il Collegio Docenti nella Sua seduta del 21/10/2013 ha deliberato quanto segue: “Tenendo conto delle previsioni della norma, secondo cui (Regolamento di valutazione alunni - DPR n. 122/2009): la valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici; tale valutazione si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile, basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare; la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 del DPR n. 122/2009 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. Il Collegio dei docenti del Liceo Artistico delibera che il voto di condotta va graduato con intenzione educativa, considerando i seguenti aspetti: atteggiamento rispettoso e responsabile nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale ATA e di ogni altra persona con cui si entra in relazione durante l’attività scolastica; frequenza assidua delle lezioni e di tutte le attività proposte, salvo motivi gravi e documentati (si prega di porre particolare attenzione al problema dei ritardi frequenti, non dovuti a motivi gravi e documentati e non giustificati puntualmente); svolgimento del lavoro per casa, rispetto delle consegne, partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni; Pag. 12 dotazione costante e cura del materiale necessario per la svolgimento delle attività previste; comportamento rispettoso degli ambienti e delle regole dell’Istituto; disponibilità a collaborare con la classe e con i gruppi con cui si condivide l’apprendimento e la formazione. Il Collegio sottolinea che la valutazione del comportamento va declinata su ogni singolo alunno, è irriducibile a griglie rigide e va graduata tenendo conto di comportamenti reiteratamente scorretti, di eventuali note, ammonizioni del DS e sanzioni disciplinari del C.d.C. L’uso del 7 va supportato da sanzioni disciplinari (note ripetute o ammonizioni del DS) o comportamento reiteratamente scorretto; l’uso del 6 va supportato da sanzioni disciplinari prese dal C.d.C (con allontanamento dalle lezioni e comportamenti offensivi o poco rispettosi della dignità della persona), Il 5 si attribuisce solo nei casi previsti dalla norma (DPR n. 122/2009, DPR 249/1998, DPR 235/2007), debitamente documentati; nello scrutinio finale, determina la non ammissione all’anno successivo o all’esame di stato. Criteri per la valutazione dei crediti scolastici Per collocare il credito ottimale nei limiti della fascia di competenza si tiene conto della media dei voti, del voto di condotta, della partecipazione al dialogo educativo e alle attività integrative e complementari interne alla scuola. Attività di volontariato Attività sportiva agonistica Attività sportiva in orario extrascolastico Partecipazione alle manifestazioni e alle attività organizzate dalla scuola con compiti specifici Collaborazione con Enti locali Rappresentante nei Consigli di Classe Rappresentante nel Consiglio di Ist ituto Rappresentante nella Consulta Provinciale degli Studenti Corso di lingua straniera Tirocinio formativo – stage Frequenza corsi di musica, danza, recitazione e/o teatro Frequenza corsi extra scolastici ad indirizzo artistico e letterario Criteri per la valutazione dei crediti formativi In base all'art. 2 dei DM 49/2000, si adottano i seguenti criteri per la valutazione dei crediti formativi: 1. esperienze di lavoro, comprovate da una dichiarazione dei datore di lavoro, recante anche la certificazione delle competenze acquisite, e dalla copia dei libretto di lavoro; 2. corsi di lingua straniera 2.1. svolti all'estero; 2.2. svolti in Italia; La relativa certificazione deve recare l'indicazione dei livelli di competenza linguistica previsti dall'ordinamento locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione. Le certificazioni dei crediti acquisiti all'estero sono legalizzate dall'autorità diplomatica o consolare italiana, fatti salvi i casi di esonero da tali adempimenti previsti dalle convenzioni o accordi internazionali vigenti in materia. 3. stage all'estero 4. lavoro di volontariato con riguardo alla crescita umana in generale: 4.1. Assistenza handicappati ed anziani 4.2. Attività ricreativa in ambito parrocchiale e scout (come capi) 4.3. Salvaguardia dell'ambiente 5. attività artistiche Pag. 13 6. attività sportive 6.1. a livello individuale con partecipazione a gare a livello regionale e nazionale, anche gare studentesche; 6.2. in squadre, con partecipazione a campionati interprovinciali ed interregionali; 7. corsi di formazione europea. Tutte le attività svolte devono essere documentate e certificate; è prevista l'autocertificazione solo per le attività lavorative svolte presso enti pubblici. Attività svolte dalla classe e dagli alunni Visite guidate di particolare interesse per la formazione culturale e professionale degli studenti Dove Docente/i - Materia/e Mostra “Verso Castagna – Storia dell'Arte Monet- storia del paesaggio” presso Gran Guardia Verona Banco PopolareCastelvecchio, Verona Viaggio d’istruzione a Parigi durante il periodo di fine marzo Milano: il “Fuori Salone” Periodo di effettuazione 11 dicembre 2013 T/A T Modalità di Valutazione Osservazione in itinere Prove orali e scritte Costantini-Laboratorio prog. Bellintani-Progettazione 28 febbraio 2014 T Osservazione in Itinere Costantini – Laboratorio prog. Tonoli - Progettazione 12-16 marzo 2014 T Osservazione in Itinere Costantini – Laboratorio prog. 11 aprile 2014 T Osservazione in Itinere Attività di orientamento ed eventuali Stage Attività/ progetto Docente referente Modalità di effettuazione T/A Master di orientamento riguardanti vari temi Stage estivi Su proposta e in collaborazione con il COSP di Verona In convenzione con negozi di arredamento e studi professionali T Full Immersion In collaborazione con e presso Accademie di Verona Con Referenti esterni, in orario curricolare presso la Scuola Su proposta e in collaborazione con Italia Orienta, presso il Liceo Messedaglia di Verona, in orario curricolare T In orario curricolare, presso la Scuola In convenzione con l'Università, presso l'Università e con rilascio di attestati di frequenza ai corsi T Incontri di Orientamento Incontri di Orientamento (Italia Orienta) Prof.sa Lina Costantini Incontri con docenti e studenti di Università e Accademie Progetto “Tandem” Pag. 14 T T T T Corso di preparazione al test d'ingresso di Architettura In collaborazione con il Politecnico di Milano, presso Sede di Mantova, anche in orario curricolare T Visita e/o Open Day di Accademie/Università “Job&Orienta” - manifestazione fieristica Uscite didattiche anche in orario curricolare Visita in orario scolastico presso la Fiera di Verona T T Per maggiori dettagli, si rimanda alla consultazione dei fascicoli personali degli studenti. Allegati Programmazione delle singole materie con dichiarazione, per ogni contenuto, del livello minimo accettabile o livello di minima suf ficienza e gli strumenti di verifica adottati; a a a griglie di valutazione 1 , 2 prova, 3 prova; testi delle prove di simulazione; PDP per alunni DSA. Verona, 15 Maggio 2014 Prof. Pag. 15 Il coordinatore del C.d.C. Francesca Nardi Anno scolastico 2013/2014 ISTITUTO D’ARTE “N. NANI” sperimentazione “Michelangelo” Documento finale del Consiglio di Classe Classe VE ALLEGATI: Programmazione delle singole materie Pag. 16 ISTITUTO STATALE D’ARTE DI VERONA “N.NANI” RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE Prof. Concetta Lanzino Materia: Italiano classe: V sez: E a.s . 2013/14 In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: CONOSCENZE: Gli alunni hanno acquisito a diversi livelli: • La conoscenza dei temi principali del dibattito culturale di fine Ottocento e del Novecento in Europa e in Italia inseriti nel relativo contesto storico-politico. • La conoscenza delle principali caratteristiche delle più significative correnti (in particolare Realismo, Naturalismo, Verismo, Simbolismo, Futurismo, Crepuscolarismo, Decadentismo, Esistenzialismo, Ermetismo) e generi letterari (romanzo, lirica) di fine Ottocento e della prima metà del Novecento attraverso lo studio delle personalità artistiche più rappresentative (Verga, Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire, Pascoli, D'Annunzio, Marinetti, Govoni, Palazzeschi, Cardarelli, PirandelIo, Svevo, Ungaretti, Montale, Saba). • La conoscenza accettabile delle peculiarità di alcune tipologie testuali: articolo di giornale, saggio breve, tema argomentativo, testo poetico. ABILITA’: La classe ha dimostrato di: Saper studiare in modo accettabile prendendo appunti e organizzandoli; Saper esporre gli argomenti in modo appropriato, prestando attenzione, per quanto possibile, al linguaggio specifico della disciplina; Saper analizzare, sia dal punto di vista contenutistico che da quello stilistico, i brani scelti di prosa e di poesia. In particolare, nel corso dell'analisi delle varie opere letterarie e soprattutto poetiche, si è cercato di sviluppare negli allievi la capacità di riconoscere le caratteristiche essenziali della metrica e le principali figure retoriche e di individuare, con la guida del docente, i contributi peculiari di ogni autore studiato nel contesto dell'evoluzione letteraria, sia sul piano formale che su quello contenutistico. E' stata inoltre sollecitata la riflessione personale dei ragazzi sull'opera e la personalità di alcune grandi figure di autori (viste sia nella loro specificità sia nei rapporti reciproci di somiglianza e diversità), nonché sul diverso impatto che, in momenti storici e culturali diversi, la figura del poeta ha avuto in rapporto alla società. Saper produrre articoli di giornale, saggi brevi, testi poetici, utilizzando le fonti a disposizione. COMPETENZE: La classe ha dimostrato di: Saper cogliere in modo sufficientemente accettabile il senso di un testo poetico o narrativo Saper effettuare gli opportuni collegamenti tra autori o movimenti diversi o affini. Pag. 17 Saper operare confronti tra opere diverse ma tematicamente accostabili. Saper effettuare interpretazioni personali fondate e argomentate con qualche riferimento testuale. Essere sufficientemente consapevole della stretta dipendenza esistente sia tra le esperienze letterarie di autori differenti, sia - da un punto di vista più ampio e generale tra le varie forme di espressione artistica (letterarie, pittoriche, ecc.). PROFITTO: La classe ha ottenuto un profitto complessivo mediamente attestato su livelli più che sufficienti. METODOLOGIE Lezione frontale; Lezione partecipata; Lettura espressiva di testi; Appunti. MATERIALI DIDATTICI L’uso del manuale; Fotocopie; Appunti integrativi. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Diversi sono stati gli elementi considerati al fine di formulare una corretta valutazione di ogni singolo studente: in tal senso, oltre alle prove scritte ed alle verifiche orali effettuate periodicamente, sono stati determinati anche l’impegno mostrato nello studio, l’attenzione durante le lezioni, nonché le individuali attitudini. A disposizione delle Commissioni sono depositati in Segreteria i seguenti esempi delle prove effettuate: Verifiche di Italiano basate sulle differenti tipologie della Prima Prova previste per l’Esame di Stato: tipologia A, tipologia B, tipologia C, tipologia D. ATTIVITA'-APPROFONDIMENTI Conferenza su Gabriele D'Annunzio nel 150° anniversario della nascita (Relatore: dott. Fabio Salandini) Visione del film “In the darkness” in occasione del Giorno della memoria (Cinema “Fiume” di Verona) Il quotidiano. LIBRO DI TESTO ADOTTATO Marta Sambugar – Gabriella Salà, GAOT. Dall'Ottocento al Novecento – Edizione La Nuova Italia – Volume 3. OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE affinamento del linguaggio specifico della disciplina; analisi di un testo poetico e di un testo narrativo; conoscenza dei macroargomenti, trattati secondo percorsi cronologici o modulari in base Pag. 18 alle autonome decisioni dei Consigli di materia. IL CONTESTO STORICO-CULTURALE Novecento GLI AUTORI attraverso le OPERE più significative Giovanni Verga Giovanni Pascoli Gabriele D’Annunzio Luigi Pirandello Italo Svevo Giuseppe Ungaretti Eugenio Montale Saba COMPETENZE saper comprendere, organizzare, memorizzare, rielaborare ed esporre i contenuti fondamentali della disciplina saper stabilire confronti tra autori e opere saper stabilire collegamenti essenziali tra le discipline saper produrre testi scritti secondo le tipologie previste dall’esame di stato CA PAC I T A ’ capacità di argomentare e di costruire ragionamenti utilizzando le conoscenze acquisite capacità operazioni di analisi e sintesi capacità di operare confronti e collegamenti in una prospettiva diacronica e sincronica nonché interdisciplinare sotto la guida del docente capacità di proporre semplici valutazioni personali capacità di esprimersi, in forma scritta e orale, in un linguaggio appropriato, con coerenza e correttezza ortografica e morfo-sintattica Firma del Docente LANZINO Concetta Pag. 19 NUOVO LICEO ARTISTICO “NANI-BOCCIONI” - VERONA Percorso formativo disciplinare Classe : V E – Architettura Docente: Lanzino Concetta Anno Scolastico 2013-14 MATERIA: ITALIANO Contenuti disciplinari sviluppati Argomenti Panorama letterario del secondo Ottocento e del Novecento: fenomeni storici, cultura. Realismo e naturalismo: cenni. Giovanni Verga: ritratto biografico, opere. Ritratto letterario. Il Verismo. Il ciclo dei vinti. Da “Vita dei Campi”: “La lupa”. Da “Novelle Rusticane”: “La roba”. Identikit del romanzo “I Malavoglia”. Identikit del romanzo “Mastro don Gesualdo”. Da “Mastro don Gesualdo”: “La morte di Gesualdo”. Il Movimento francese dei decadenti e il Decadentismo europeo. Caratteri del Decadentismo italiano. Gli studi di psicanalisi: cenni. Il Simbolismo francese. Charles Baudelaire: ritratto biografico e poetica. Da “I fiori del male”: “L’albatro”. Arthur Rimbaud: ritratto biografico Da “Poesie”: “Vocali” Giovanni Pascoli: ritratto biografico e opere. Ritratto letterario: il pensiero e la visione della vita. La poetica del Fanciullino – I temi delle piccole cose. Pascoli e la dissoluzione della frase nella sua architettura logico-sintattica. Da “Myricae”: “Lavandare” Da “Myricae”: “Novembre” Da “Myricae”: “X Agosto” Da “Myricae”: “Lampo”. Dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”. Da “Il Fanciullino”: “E’ dentro di noi un fanciullino”. Gabriele D’Annunzio: ritratto biografico e opere. Ritratto letterario: L’esteta e il Superuomo Panismo e Sensualismo. Identikit del romanzo “Il Piacere” Da “Il Piacere”: “Una guarigione incerta” Da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto”. Da “Alcyone”: “I pastori”. Cultura nel XX Secolo – Le avanguardie storiche. Pag. 20 Periodo Ore Settembre - Ottobre 23 ore Novembre-Dicembre 19 ore Il Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti e il suo Manifesto. Da “Zang Tumb Tuum”: “Adrianopoli, ottobre 1912” di F. T. Marinetti. Guillaume Apollinaire: Ritratto biografico. Da “Calligrammi”: “Il Pleut” (Piove) Il Crepuscolarismo. Corrado Govoni: biografia. Da “Rarefazione e parole in libertà”: “Il palombaro”. Aldo Palazzeschi: biografia Da “L’Incendiario: “La fontana malata” . Ritorno all’ordine: neoclassicismo. Vincenzo Cardarelli: biografia. Da “Poesie”: “Autunno”. L’Esistenzialismo. Luigi Pirandello: ritratto biografico e opere. Ritratto letterario: Vita e forma. Relatività della conoscenza (Einstein), il sentimento del contrario. Da “L’Umorismo”: Il sentimento del contrario. Il teatro come l’esistenza. Il cerebralismo dei personaggi pirandelliani. Da “Novelle per un anno”: “La patente”. Identikit de “Il fu Mattia Pascal”. Identikit di “Uno, nessuno, centomila”. Da “Il Fu Mattia Pascal”: “Cambio treno”. Da “Il Fu Mattia Pascal”: “Pascal porta i fiori alla propria tomba”. Da “Uno, nessuno, centomila”: “Filo d'aria”. Il romanzo psicanalitico. Italo Svevo: ritratto biografico. Ritratto letterario: formazione tecnico-scientifica. La funzione della letteratura. L’emergere della coscienza. L’inettitudine. Identikit del romanzo “Una vita”. Identikit del romanzo “La coscienza di Zeno”. Identikit del romanzo “Senilità”. Analisi comparata tra i romanzi “Una vita”, “Senilità”, “La coscienza di Zeno”. Da “Una vita”: “L'insoddisfazione di Alfonso”. Da “Senilità”: “Amalia muore”. Da “La coscienza di Zeno”: “L'ultima sigaretta” . L’Ermetismo. Eugenio Montale: ritratto biografico e opere. Ritratto letterario: Il male di vivere, Il “Varco”, Amore e “Donna angelo”. Da “Ossi di seppia”: “Spesso il male di vivere ho incontrato”. Da “Ossi di seppia”: “I limoni”. Da “Le occasioni”: “Ti libero la fronte dai ghiaccioli”. Da “La bufera e altro”: “La frangia dei capelli”. Da “Satura”: “Caro piccolo insetto”. Giuseppe Ungaretti: ritratto biografico e opere. Pag. 21 Gennaio-Febbraio 21 ore Marzo–Aprile 29 ore Maggio 16 ore Ritratto letterario: Necessità dell’armonia. Primato della letteratura. Compianto umano. Stile. Da “L’allegria dei naufragi”: “Fratelli”. Da “L’allegria dei naufragi”: “Mattina”. Da “L’allegria dei naufragi”: “Soldati”. Umberto Saba: ritratto biografico. Il poeta contro corrente, periferico; la “poesia onesta, eccentrica”. Da “Il canzoniere”: “La capra”. Da “Il canzoniere”: “A mia moglie”. TOTALE: Pag. 22 108 ore ISTITUTO STATALE D’ARTE DI VERONA “N.NANI” RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE Prof. Concetta Lanzino Materia: Storia classe: V sez: E a.s. 2013/14 In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: CONOSCENZE: Gli alunni hanno acquisito a diversi livelli: Un'accettabile conoscenza dei principali eventi che hanno caratterizzato la storia europea e mondiale dalla seconda metà dell'Ottocento alla metà del Novecento; Un'accettabile conoscenza delle più significative teorie economiche, produttive e commerciali, lette in chiave storiografica, del periodo considerato (concetti di liberismo, protezionismo, fordismo, taylorismo); In tale inquadramento generale, si è avvertita la necessità di favorire un apprendimento che non si limitasse all'interiorizzazione di semplici date o eventi storici isolati, ma si configurasse come una capacità di correlare gli avvenimenti e di indagarne le cause profonde e le conseguenze politiche, sociali e culturali. COMPETENZE: La classe ha dimostrato di: Saper esporre gli argomenti in modo ordinato ed esauriente; Saper utilizzare in modo sufficientemente accettabile il linguaggio specifico della disciplina e comprendere i principali termini che le sono propri; Saper leggere e utilizzare semplici fonti; Saper analizzare negli elementi salienti i principali fenomeni storici oggetto di studio. CAPACITA': La classe ha dimostrato di: Saper conoscere e comprendere le relazioni tra passato e presente; Saper riconoscere, nell'esaminare fatti esemplari, l'interazione dei fattori storici in causa, cogliendone la complessità e la strutturazione Essere in grado di comprendere l' enorme portata di alcuni degli eventi e dei cambiamenti storici del Novecento, valutandone l'impatto sulla società e la cultura. PROFITTO: La classe ha ottenuto un profitto complessivo mediamente attestato su livelli discreti. Pag. 23 METODOLOGIE: Lezione frontale; Lezione partecipata; MATERIALI DIDATTICI: Uso del manuale; Fotocopie; Appunti. Appunti integrativi. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: Diversi sono stati gli elementi considerati al fine di formulare una corretta valutazione di ogni singolo studente. In tal senso, oltre alle verifiche orali effettuate periodicamente, sono stati determinanti anche l’impegno mostrato nello studio, l’attenzione durante le lezioni, nonché le individuali attitudini. ATTIVITA'-APPROFONDIMENTI: Visione del film “In the darkness” in occasione del Giorno della memoria (Cinema “Fiume” di Verona) LIBRO DI TESTO ADOTTATO: F. Feltri – M. Bertazzoni – F. Neri, Chiaroscuro. Novecento e oltre – Volume 3 – Società Editrice Internazionale. OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE Conoscere i momenti più significativi della storia della seconda metà dell'Ottocento e del Novecento. COMPETENZE/CAPACITA’ Sapere che le conoscenze storiche sono elaborate da fonti, secondo modelli e riferimenti ideologici; effettuare riferimenti diacronici; effettuare collegamenti con altre discipline; esporre concetti e termini storici, inserendoli in contesti storico – culturali; osservare le dinamiche storiche; riconoscere gli intrecci politici, sociali, culturali, religiosi e ambientali CONTENUTI DISCIPLINARI L'OTTOCENTO: L'AFFERMAZIONE DELLA SOCIETA' BORGHESE INDUSTRIALE. L'ITALIA DOPO L'UNITA' LA GRANDE GUERRA IL FASCISMO IL NAZISMO LA SECONDA GUERRA MONDIALE LA GUERRA FREDDA LA REPUBBLICA ITALIANA. Pag. 24 Percorso formativo disciplinare Classe : V E – Architettura e Design Docente: Lanzino Concetta Anno Scolastico 2013-14 MATERIA: STORIA Contenuti disciplinari sviluppati Argomenti I problemi dell’unità d’Italia La seconda Rivoluzione industriale (1870-1912). L’Età dell’acciaio Il Positivismo – Società di massa Dibattito di fronte alla Rivoluzione industriale: tendenza liberale, democratica, socialista, anarchica, cattolica Il Governo della “Destra Storica” La Sinistra storica al potere La crisi di fine secolo L’età giolittiana P e r i o d o Settembre-Ottobre Ore 13 ore Dal colonialismo all’imperialismo La Russia nel XIX Secolo. Le Rivoluzioni del 1917 di Febbraio e d’Ottobre La Belle Époque Novembre-Dicembre 13 ore La Prima Guerra Mondiale: cause politiche, militari, economiche, culturali Lo Stalinismo Il Biennio Rosso Il Fascismo: fase legalitaria (1922-24), inizio dittatura (1925) L’Italia nel Ventennio Fascista. Gli USA: dalla crisi al “New Deal” Gennaio-Febbraio 14 ore Il Manifesto della razza (1938) La Germania di Hitler: Il Nazismo La Seconda Guerra Mondiale: gli schieramenti contrapposti e la loro motivazione ideale a sostegno del sacrificio di milioni di uomini Cause e andamento della Seconda Guerra Mondiale: anni 1940-41; anni 1942-43-44-45 La vita in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale Marzo-Aprile 14 ore Maggio 10 ore TOTALE: 64 ore L’Italia della Resistenza e di Salò Lettura: “Lettere di condannati a morte della Resistenza” Epitaffio “Ma io sono soltanto una mamma...” di P. Calamandrei La Guerra Fredda (1945-55) L’Italia repubblicana (1945-48) L'Europa unita. La Docente, prof.ssa Concetta Lanzino Pag. 25 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE Prof.ssa Cristina Castagna Materia: Storia dell’arte classe: V sez: E a.s. 2013/14 In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: CONOSCENZE La classe ha raggiunto, nel complesso, un discreto livello di conoscenze relativamente ai contenuti dei moduli proposti, alla terminologia specifica della disciplina e al metodo ordinato e sistematico di lettura dell’opera d’arte. ABILITA’ Gli alunni sono in grado di: esporre le conoscenze acquisite con linguaggio idoneo e sufficientemente corretto, dimostrando una sufficiente padronanza nell’uso della terminologia specifica della disciplina e del metodo ordinato e sistematico di lettura dell’opera d’arte; operare collegamenti tra il contenuto storico – culturale e i relativi fenomeni artistici; individuare la funzione, le proposte tecniche e le soluzioni formali e stilistiche che caratterizzano i diversi linguaggi figurativi sottolineandone le progressive innovazioni e i cambiamenti sia rispetto ai codici tradizionali di rappresentazione, sia rispetto al modo di utilizzare i materiali specificatamente artistici usati per creare l’opera d’arte. COMPETENZE Gli alunni hanno acquisito, a diversi livelli, competenze nell’operare confronti sincronici e diacronici dimostrando di saper inserire in un quadro logico ed organico i nodi concettuali e le connessioni fondamentali da analizzare in riferimento alle diverse personalità e/o correnti artistiche. Quasi tutti hanno partecipato con interesse e impegno alle lezioni proposte, dimostrando un comportamento adeguato e raggiungendo profitti in sintonia con i livelli di partenza e le capacità individuali. Il metodo di lavoro e di studio proposto dall’insegnante nel triennio è stato assimilato e condiviso permettendo il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Solo in qualche caso l’impegno è stato discontinuo e scarsa la partecipazione al dialogo didattico-educativo, portando a risultati non pienamente soddisfacenti. Pag. 26 1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI Modulo Periodo/ore Modulo 1 IL REALISMO Settembre-ottobre Significato del termine applicato alle arti visive, il nuovo modo di 8 ore rappresentare la realtà, concetti generali. La rappresentazione del vero e del quotidiano. Gustave Courbet. Brevi note biografiche, poetica. Un seppellimento a Ornans. Lo spaccapietre. Giovani donne sulla riva della Senna. Jean – Francois Millet. Brevi note biografiche, la poetica. L’An gelu s . Il seminatore. Honoré Daumier. Brevi note biografiche, la poetica. Il vagone di terza classe. Vogliamo Barabba. I MACCHIAIOLI Formazione, elementi di rinnovamento. Concetti generali. Giovanni Fattori. Soldati francesi del 59. La rotonda di Palmieri. La vedetta. Modulo 2 Ottobre 3 ore Modulo 3 L’IMPRESSIONISMO Ottobre-novembre Formazione e sviluppo. Giovani pittori contro le istituzioni: elementi di 19 ore novità rispetto alla tradizione accademica del tempo. Prima mostra degli Impressionisti e nascita del termine. L’influenza delle stampe giapponesi. I rapporti tra la pittura e la fotografia, invenzione del secolo. Edouard Manet, pittore della vita moderna e precursore dell’Impressionismo. Poetica, stile. Differenze tra la pittura di Manet e quella, in generale, degli Impressionisti. Colaz ion e su ll’er b a . Olympia. Claude Monet, pittore delle “impressioni”, poetica, stile. Regate ad Argenteuil. Impressione levar del sole. La pittura in serie. La serie delle ninfee in generale. La Cattedrale di Rouen, il portale e la torre di San Romano. Impressione al mattino.Armonia in bianco. Covone effetto neve. Edgar Degas, poetica, stile, elementi all’Impressionismo. L’assen z io . La classe di danza. Donna che si spugna nella vasca da bagno. Pierre-Auguste Renoir. Ballo al mulino della Galette. Canottieri a Chatou. Bagnante seduta che si asciuga un piede. di diversità rispetto IL POSTIMPRESSIONISMO Caratteri generali. Il puntillismo di Georges Seurat in contrapposizione alla poetica impressionista. Una d o men ica p o mer iggio all’iso la d ella Gra nde Jatte. Paul Cézanne, poetica, stile, il superamento dell’Impressionismo. La casa d ell’im p iccat o a Au vers – sur – Oise. Giocatori di carte. Le grandi bagnanti di Filadelfia. La montagna Sainte – Victoire vista da Louves. Paul Gauguin, poetica, stile, confronti con gli Impressionisti, il sintetismo. Il Cristo giallo. La belle Angèle. La vision e d o p o il sermo n e (la lot t a d i Giaco b b e co n l’an gelo ) . Ia orana Maria. Vincent Van Gogh, vita, formazione, poetica, stile, confronti con Gauguin e gli Impressionisti. I mangiatori di patate. Postino Roulin. Camera di Vincent as Arles. Campo di grano con volo di corvi. Edward Munch, grande maestro e precursore di molti temi dell’arte del Novecento, vita, formazione, stile. L’espressione del disagio esistenziale. Il grido. Pubertà. Sera sul viale Karl Johann. Modulo 4 Dicembre- gennaiofebbraio 20 ore IL NOVECENTO DELLE AVANGUARDIE STORICHE Introduzione generale. Il concetto di avanguardia, significato del termine, le avanguardie del primo Novecento, presentazione generale. L’esperienza del “nuovo”. Caratteri di continuità e rottura rispetto al passato. Gli Espressionisti, caratteri generali. I Fauves in Francia, il gruppo del Ponte in Germania, l’interesse per l’arte popolare, africana e primitiva. Il Primitivismo, concetti generali. Espressionismo tedesco: gli scritti e il pensiero di Kirchner sulla pittura. Le tecniche grafiche nel gruppo del Ponte. Otto Muller, Tre teste di ragazza; Karl Schmidt Rottluff, Gatti; Erich Heckel, Due donne. Il colore e la materia nell’arte degli espressionisti tedeschi. Kirchner, Ballerine; Karl Schmidt Rottluff, Donna che fa toilette. Ernst Ludwig Kirchner. Marcella. Il colore nell’arte dei Fauves. Andrè Derain, L’Est aq u e, t re alb eri ; Henri Matisse, N u d o n ell’a t elie r ; Maurice Vlaminck, Interno di cucina; Kees Van Dongen; Ritratto di Fernanda. Henri Matisse, brevi note biografiche, formazione, poetica, stile. La danza. Gioia di vivere. Il Cubismo. Significato del termine, nascita e formazione, fase cezanniana, analitica e sintetica. George Braque. Il portoghese. N at u ra mo rt a co n l’asso d i f ior i. Il violino. Pablo Picasso. Periodo blu, Poveri in riva al mare. Periodo rosa, Saltimbanchi. La nascita del Cubismo. Les d em o iselle s d ’Avign o n . Ritratto di Ambrosie Vollard. Natura morta con sedia impagliata. Guernica. Il Futurismo, caratteri generali, origini, formazione, il manifesto generale di Marinetti. Le varie fasi di sviluppo del Futurismo. Umberto Boccioni. La città che sale. Forme uniche nella continuità dello spazio. Luigi Russolo. D in amismo d i u n ’au t o mo b ile. Giacomo Balla. Automobile in corsa. Dinamismo di un cane al guinzaglio. Mercurio passa davanti al sole. Pag. 29 Mercurio passa davanti al sole Modulo 5 La ragazza che corre sul balcone Febbrio/marzo Astrattismo, significato del termine in riferimento alla pittura, origini e 30 ore formazione, caratteri generali. Blaue Reiter e Vasilij Kandinskij. La simbologia dei colori e delle forme in Kandinskij. Il colore e la musica. Le teorie esposte nell’Almanacco. Kandinskij. Senza titolo acquerello astratto 1910. Alcuni cerchi. Pu n t e n ell’arco. Piet Mondrian. Il percorso verso l’astrazione. L’alb ero ro sso . L’alb ero argen t at o . Melo in fiore. Composizione in rosso, giallo, blu, 1927. Il Dadaismo, origini, formazione del gruppo, significato del termine. Le nuove tecniche espressive. La poetica del gruppo. Marcel Duchamp. Ruota di bicicletta. Fontana. L.H.O.O.Q, 1919. Ready - made rettificato: la Gioconda con i baffi. Man Ray. Regalo ( Cadeau). Il Surrealismo, origini, formazione, caratteri generali, significato del termine. Le tecniche dell’arte surrealista. René Magritte. Il tradimento delle immagini (questa non è una pipa). La condizione umana II. Il doppio segreto. svolte dal docente nell’intero anno scolastico Ore effettivamente 96 ore Salvador Dalì. La Venere a cassetti. 2. METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, libro di testo, LIM, eventuale materiale per l’approfondimento ecc..): Testi adottati: Giulio Carlo Argan, L’Ottocento, Il Novecento, Sansoni. Materiali: testi e riviste, LIM, scritti di artisti. L’insegnante ha proceduto in senso diacronico cercando di ricostruire con un massimo di ordine e chiarezza gli avvenimenti, sempre reciprocamente collegati secondo una linea unitaria di sviluppo, che hanno determinato la storia delle arti. Diacronia quindi ma non mera successione cronologica per evitare da parte degli allievi uno studio puramente mnemonico, si è cercato al contrario di stimolare costantemente le capacità critiche della classe e dei singoli alunni nel corso delle lezioni frontali e delle verifiche orali. L’arte è sempre una funzione sociale e partendo da questo presupposto si è cercato, di volta in volta, di far emergere il contesto storico, culturale, politico, religioso, che ha reso possibile l’evoluzione delle arti considerate come uno dei linguaggi permanenti della società. Si sono così creati i nessi fondamentali per collegare l’arte con altre importanti discipline di studio quali la letteratura, la filosofia e la storia. Non bisogna però dimenticare che la storia dell’arte è storia delle opere e in questo senso uno Pag. 30 degli obiettivi fondamentali è stato l’individuazione e la lettura analitica delle maggiori opere di ogni epoca presa in considerazione. Si è cercato di accrescere il patrimonio culturale ma anche la sensibilità di ogni singolo allievo fornendo nel corso dell’anno gli strumenti idonei ad un approccio vivo e coinvolgente con l’opera, sia essa architettura, pittura o scultura, in quanto realtà quotidiana, tangibile e non “monumento”, “museo” da dimenticare oltre la lezione in classe. Ogni argomento è stato introdotto e adeguatamente spiegato in classe utilizzando il libro di testo per la lettura delle varie opere. Lo studio domestico è stato quindi condotto sugli appunti presi in classe e fissati sul quaderno nonché sul libro adottato; vari approfondimenti sono stati condotti mediante la lettura e lo studio di appunti e materiali fotocopiati dall’insegnante e forniti nel corso dell’anno scolastico. Le carenze di apprendimento manifestate dagli allievi sono state recuperate in itinere durante le ore curriculari di lezione. L’analisi del testo figurativo è stata condotta tenendo conto della seguente scheda di lettura: PRIMO LIVELLO DATI PRELIMINARI: Autore Titolo Data Genere SCHEDA DI LETTURA DELL’OPERA D’ARTE Collocazione originaria e attuale Committenza Tecnica Dimensioni SECONDO LIVELLO LETTURA ICONOGRAFICA: Riconoscimento soggetto Tipi iconografici e attributi Simboli e allegorie Fonti storiche Fonti letterarie e di ispirazione TERZO LIVELLO ANALISI DEGLI ELEMENTI DEL LINGUAGGIO VISIVO: Colore Linea Luce Chiaroscuro Spazio Movimento Espressione personaggi Geometria interna QUARTO LIVELLO ANALISI DEL CONTESTO: informazioni sull’artistacontesto storico e sociale confronto con altri autori e opere giudizio sull’opera innovazioni stilistiche, tecniche e iconografiche QUINTO LIVELLO Pag. 31 LETTURA ICONOLOGICA: significato complessivo dell’opera d’arte. 3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Specificare (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, simulazioni di terza prova dell’esame, prove grafiche, prove di laboratorio ecc.): Tipologia delle prove: Sono state effettuate delle interrogazioni orali e verifiche scritte come simulazioni della terza prova dell’Esame di Stato. L’insegnante ha valutato il livello di assimilazione dei contenuti, la pertinenza e la quantità delle informazioni riportate, la comprensione e la padronanza della materia, la padronanza del linguaggio specifico e la capacità espositiva degli alunni nel rispetto delle singole personalità e diverse situazioni secondo i criteri riportati nelle griglie di misurazione. Criteri di valutazione: Nel giudizio finale l’insegnante ha tenuto conto anche della situazione di partenza, dell’attitudine, dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrata dai singoli allievi nel corso dell’intero anno scolastico. A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e verifiche effettuate: Verifica scritta 30-10-13 Simulazione della terza prova 7-3-14 Simulazione della terza prova 15-4-14 4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE PER APPROFONDIRE LA DISCIPLINA (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) Visita alla mostra “Verso Monet- storia del paesaggio” presso Gran Guardia Verona. Verona, 15 Maggio 2014 Firma del Docente Prof.ssa Cristina Castagna Pag. 32 ISTITUTO STATALE D’ARTE DI VERONA “N.NANI” RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE Prof. Riccardo Zanderigo Materia: Educazione Fisica classe: V sez: E a.s. 2013/ 2014 In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: CONOSCENZE Conoscere le potenzialità del movimento del corpo, le posture corrette e le funzioni fisiologiche. Riconoscere il ritmo delle azioni. Conoscere i principi scientifici fondamentali che sottendono la preparazione motoria e sportiva. Conoscere e riconoscere la differenza tra il movimento funzionale ed espressivo. Conoscere gli aspetti essenziali della terminologia, regolamento e tecnica degli sport e il loro aspetto sociale – educativo. ABILITA’ Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse. Assumere posture corrette, soprattutto in presenza di carichi. Consapevolezza di una risposta motoria efficaca ed economica. Padroneggiare gli aspetti non verbali della comunicazione. Trasferire e ricostruire tecniche, strategie e regole adattandole alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si dispone. Cooperare in equipe utilizzando e valorizzando le propensioni e le attitudini undividuali. COMPETENZE Potenziamento fisiologico. Padronanza del proprio corpo e percezione sensoriale. Coordinazione, affinamento e integrazione degli schemi motori, equilibrio e orientamento. Espressività corporea. Consolidamento del carattere e sviluppo della socialità. Gioco e gioco-sport Pag. 35 1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: Unità didattiche e/o Moduli e/o Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento Periodo/ore 1 - Il movimento come mezzo per conseguire benessere e salute in armonia con spirito e mente 2 - Discipline bio-naturali e trattamenti olistici: massoterapie e shiatsu (argomenti teorici) 3 - Interazione di movimento e musica: ginnastica aerobica e danze folkloristiche dio diversa provenienza 4 - Capoeira del Brasile Tutto l'anno scolastico 5 - I benefici dello Yoga e la sequenza del “Saluto al Sole” Primo quadrimestre 6 – Uso del bastone giapponese Secondo quadrimestre 7 – Pallavolo, hit-ball e altri giochi con la palla Tutto l'anno scolastico Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico Primo quadrimestre Tutto l'anno scolastico Secondo quadrimestre 58 2. METODOLOGIE (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recuperosostegno e integrazione ecc..): Lezioni frontali Visione di slides e filmati Gruppi di lavoro Processi individualizzati 3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi come previsti dalla terza prova, prove grafiche, prove di laboratorio ecc.): Prove pratiche in palestra Interrogazioni orali su argomenti teorici Verona, 15 maggio 2014 Firma del Docente (Riccardo Zanderigo) ALL. A Pag. 36 ALL. A ISTITUTO STATALE D’ARTE DI VERONA “N.NANI” RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE Prof. Francesca Nardi Materia: Filosofia classe: V sez: E a. s. 2013/14 In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: CONOSCENZE Gli allievi conoscono i temi-chiave dei filosofi e dei movimenti filosofici studiati, nonché i principali fattori dei contesti socio-culturali della produzione filosofica studiata. Conoscono i termini essenziali del lessico disciplinare inerente alle tematiche affrontate nell’anno in corso. Conoscono la procedura necessaria a condurre una semplice ricerca bibliografica e sitografica, nonché le regole essenziali per la corretta descrizione e citazione bibliografica. ABILITÀ Gli allievi sono in grado di utilizzare le conoscenze acquisite per leggere e comprendere brani antologici di testi filosofici, con l’aiuto di domande-guida produrre semplici documenti scritti di sintesi, utili allo studio e alla comunicazione dei contenuti appresi esporre, a richiesta, in modo essenziale e schematico, il pensiero dei filosofi e delle correnti filosofiche studiate Alcuni allievi sono in grado di utilizzare le conoscenze acquisite per analizzare, contestualizzare e commentare un brano antologico di Autore o argomento filosofico studiato, individuandone i passaggi logici, i nuclei concettuali e la tesi di fondo produrre testi scritti ed orali con l’uso attivo, appropriato ed autonomo del lessico disciplinare studiato nell'ultimo anno Pag. 37 COMPETENZE Gli studenti sanno di operare su sollecitazione del docente collegamenti interdisciplinari tra questioni o concezioni filosofiche e prodotti dell’arte e della letteratura delineare semplici percorsi tematici, articolati sugli argomenti studiati, su proposta e con la guida del docente Alcuni studenti sono in grado di operare autonomamente collegamenti interdisciplinari, esprimendo il proprio punto di vista nel colloquio orale di costruire autonomamente percorsi tematici in cui convergono conoscenze pluridisciplinari, attitudini ed interessi personali individuare analogie e differenze tra Autori, concetti, modelli, o metodi della ricerca filosofica 1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per Unità didattiche e/o Moduli e/o Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti I contenuti ritenuti irrinunciabili sono evidenziati in corsivo U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento INDICAZIONI E DISCUSSIONE SU metodo di studio e uso del manuale ricerca fonti bibliografiche e web norme di base per la descrizione bibliografica DAL KANTISMO ALL'IDEALISMO Kant fra Illuminismo e Romanticismo: revisione dei concetti essenziali delle prime due Critiche (forme a priori della sensibilità e dell'intelletto, idee della ragione, caratteri della legge morale) il giudizio estetico, il sublime, l’arte e il genio Approfondimento mediante lettura di brani antologici dalla Critica del Giudizio (arte, natura, genio; il bello e il sublime) Il Romanticismo: concezione della natura, dei fenomeni storico-culturali, dell’arte Caratteri generali dell’Idealismo tedesco Approfondimento sulla nascita dell'estetica moderna (Illuminismo, Romanticismo, Idealismo), mediante dispense fornite dal docente Schelling: inquadramento generale del pensiero (la filosofia dell'identità) la riflessione sull’arte Approfondimento mediante lettura di brano antologico dal Sistema dell'Idealismo trascendentale (il prodotto artistico, la poesia dell'arte e il genio) Hegel: i capisaldi del sistema (finito e infinito, ragione e realtà, funzione della filosofia) la dialettica e alcuni dei suoi critici critiche a Kant, ai romantici e a Schelling la Fenomenologia dello spirito (in particolare la relazione “signoria-servitù” Pag. 38 Periodo/ore Settembre - Novembre 3 ore Settembre – Ottobre 11 ore (di cui 2 per prove di verifica scritta – quesiti a risposta breve - ed orale) Novembre – Febbraio 22 ore (di cui 10 per 3 prove di verifica scritta – 2 di lettura e comprensione dei testi antologici, 1 con domande a risposta sintetica – ed orale) e la “coscienza infelice”) lo spirito soggettivo ed oggettivo: cenni generali e concezione dello Stato lo Spirito assoluto, con particolare riguardo alla riflessione sull’arte LA FILOSOFIA POST-HEGELIANA DELL'OTTOCENTO Kierkegaard: l’attenzione al “singolo” e ai problemi dell’esistenza i “tre stadi” lo stadio “estetico” e la disperazione Approfondimento mediante lettura autonoma di brani antologici da Aut-aut, forniti dal docente in fotocopia Schopenhauer: Il richiamo a Kant e alla tradizione orientale Il mondo come volontà e rappresentazione Le vie per la liberazione dal dolore L’arte Approfondimento mediante lettura autonoma di brevi brani antologici da Il mondo come volontà e rappresentazione e da Pererga e paralipomena, forniti dal docente in fotocopia (il genio; la musica) Caratteri generali del positivismo Marx: contesto culturale - destra e sinistra hegeliane (cenno a Feuerbach) rapporto con Hegel (eredità e discontinuità) il materialismo storico-dialettico/struttura e sovrastruttura cenni alla teoria economica e ai concetti di alienazione e lotta di classe Approfondimento sulle considerazioni marxiane riguardo l'arte, mediante lettura di un saggio breve di Diego Fusaro, fornito dal docente in formato elettronico e mediante sintesi curata e fornita dal docente Nietzsche (in ore aggiuntive a quelle curricolari di Filosofia): la nascita della tragedia la liberazione dalla verità, dalla storia, dal cristianesimo, dalla morale l’“oltre-uomo” IL NOVECENTO Freud: la scoperta dell’inconscio il metodo della psicoanalisi la struttura della personalità (prima e seconda topica) il sogno la concezione dell’arte Febbraio – Aprile 5 ore Marzo 6 ore (di cui 5 per prove di verifica orale) Maggio RIPASSO, REVISIONE E APPROFONDIMENTO Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 9 ore (stima) (di cui 5 stimate per prove di verifica) 56* *7 ore curricolari di Filosofia sono state dedicate alle seguenti attività: ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO, ORIENTAMENTO, USCITE, PROGETTI D'ISTITUTO 31 gennaio (incontro sulla sicurezza stradale) 28 febbraio (visita al Banco Popolare-Castelvecchio, Verona) 14 e 17 marzo (viaggio di istruzione) 11 aprile (visita al “Fuori Salone” di Milano: 15 studenti) 28 aprile (incontro con esperto per preparazione del colloquio d'Esame) 5 maggio (torneo di pallavolo di Istituto) SIMULAZIONI PROVE D'ESAME (1^ E 2^ prova) Pag. 39 31 Gennaio – 15 Maggio 5 ore 21 e 28 marzo 2 ore 2. METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI: Metodologie Lezione frontale e dialogata per l’introduzione agli argomenti. Processi individualizzati per la preparazione dell’argomento di avvio del colloquio di Esame, su richiesta dei singoli studenti. Attività di recupero in itinere per il gruppo classe. Gruppi di lavoro, in base agli interessi manifestati dagli studenti, per l’approfondimento di alcune tematiche. Gli studenti sono stati introdotti e guidati all’utilizzo i servizi bibliotecari del territorio (servizi bibliotecari urbano e provinciale di Verona). Alcuni studenti, inoltre, su sollecitazione del docente, hanno occasionalmente usufruito degli spazi scolastici per lo studio pomeridiano in gruppo. Il docente si è reso disponibile all’utilizzo della posta elettronica per richieste di chiarimenti e/o approfondimenti Sussidi Libro di testo in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero, Le basi del pensiero, voll. II e III, Paravia Editori, 2007 Brani antologici forniti dal docente in fotocopia e/o in formato elettronico Altri manuali di storia della filosofia forniti dal docente in consultazione per approfondimenti individuali Dispense e sintesi fornite dal docente per la focalizzazione di alcuni argomenti di estetica Documenti e informazioni bibliografiche reperibili sul web, con indicazioni del docente Schemi di sintesi su fotocopia, o su lavagna tradizionale, o su LIM, o trasmesse in formato elettronico Manuali e guide alla redazione di saggi brevi e/o “tesine” forniti dal docente su specifica richiesta 3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: Prove scritte domande a risposte sintetiche comprensione e commento di brani antologici di opere filosofiche, con domande-guida redazione di una semplice bibliografia su argomenti in programma simulazioni di terza prova d’Esame Prove orali: colloquio su argomenti o testi proposti dal docente trattazione di percorsi tematici proposti dal docente o dallo studente A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e verifiche effettuate: Simulazioni di terza prova allegate al presente documento Verona, 15 Maggio 2014 Firma del Docente (Francesca Nardi) ALL. A Pag. 40 ISTITUTO STATALE D’ARTE DI VERONA “N.NANI” RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE Prof. GIUSEPPE BOVO Materia: FISICA classe: V sez: E a.s. 2013/14 In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: CONOSCENZE La quasi totalità degli studenti conosce le principali proprietà e leggi fisiche trattate anche se alcuni sono abituati ad uno studio soprattutto mnemonico. Qualcuno ha una conoscenza frammentaria degli argomenti per uno studio non continuo nel corso dell'anno scolastico. ABILITA’ Un gruppo di studenti sa utilizzare il linguaggio scientifico abbastanza correttamente. La quasi totalità di essi sa spiegare le principali proprietà e leggi fisiche trattate. Alcuni manifestano qualche difficoltà a collegare tra loro gli argomenti trattati e a riconoscere le proprietà studiate in situazioni reali. COMPETENZE La classe si presenta abbastanza diversificata: alcuni riescono ad utilizzare le proprie conoscenze in maniera abbastanza autonoma e con padronanza, altri invece devono essere guidati e seguiti appena devono dimostrare una qualche libertà decisionale. 1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE: U.D. - Modulo - Percorso Formativo – Approfondimento LE CARICHE ELETTRICHE IL CAMPO ELETTRICO LA CORRENTE ELETTRICA IL CAMPO MAGNETICO L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico Pag. 41 Periodo/ore 6 ore 9 ore 15 ore 9 ore 13 ore 52 ore PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO FISICA - CLASSE 5E LE CARICHE ELETTRICHE L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. La carica elettrica. La legge di Coulomb. L’elettrizzazione per induzione. Il modello planetario dell’atomo. Il sistema periodico degli elementi. IL CAMPO ELETTRICO Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. le linee del campo elettrico. L’energia elettrica. La differenza di potenziale. Il condensatore piano. LA CORRENTE ELETTRICA L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione. I circuiti elettrici. Le leggi di Ohm. Resistori in serie. Resistori in parallelo. Lo studio dei circuiti elettrici. la forza elettromotrice. La trasformazione dell’energia elettrica. IL CAMPO MAGNETICO La forza magnetica. le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e correnti. Forze tra correnti. L’intensità del campo magnetico. le forze su una corrente e su una carica in moto. Il campo magnetico di un filo e in un solenoide. Il motore elettrico. L’elettromagnete. L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA a corrente indotta. Il flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-Neumann. Il verso della corrente indotta. L’alternatore. Le centrali elettriche. Il trasporto dell'energia elettrica. Il trasformatore. 2. METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, libro di testo, LIM, eventuale materiale per l’approfondimento ecc..): L'introduzione di ogni argomento è stata fatta tramite lezioni frontali, utilizzando prevalentemente il metodo induttivo, favorendo la partecipazione attiva dei ragazzi, stimolando interventi, suggerimenti, osservazioni, domande. È stata posta un'attenta cura nella motivazione all'apprendimento, presupposto fondamentale per un lavoro proficuo e duraturo, che può scaturire da un rapporto di reciproca stima, dal dialogo e rispetto fra insegnante e allievo, dall’interesse e curiosità per nuove conoscenze, dal coinvolgimento della classe, da un approccio positivo alla materia e da una sua contestualizzazione storica e scientifica. 3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Specificare (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, simulazioni di terza prova dell’esame, prove grafiche, prove di laboratorio ecc.): Sono state utilizzate verifiche orali e prove strutturate valutabili come orali. Le prove strutturate sono state articolate sotto forma di questionario a risposta aperta. Le interrogazioni orali tendevano ad accertare l’uso corretto del linguaggio specifico, la conoscenza di nozioni specifiche, il livello di preparazione complessivo in relazione agli obiettivi prefissati. Sono state svolte due simulazioni della terza prova d’esame, in cui era coinvolta nella prima simulazione come materia anche Fisica. La tipologia scelta in tale occasione è stata la B (3 domande a risposta breve).A disposizione della commissione sono depositate in segreteria copie delle prove e delle verifiche effettuate. Verona, 15 Maggio 2014 Firma del Docente (prof. Giuseppe Bovo) Pag. 42 ISTITUTO STATALE D’ARTE DI VERONA “N.NANI” RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE Prof. Claudio Berruti Materia: Geometria descrittiva classe: V sez: E a.s. 2013/1 4 La classe è composta da ragazzi piuttosto vivaci che hanno dimostrato interesse per la materia raggiungendo, nel complesso, risultati più che sufficienti. In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: CONOSCENZE: Nel complesso la classe conosce discretamente i contenuti esposti nella programmazione COMPETENZE: Sono in grado di eseguire lavori con utilizzo di assonometrie oblique, eseguite a disegno strumentale e prospettive accidentali di volumi schematici. I metodi grafici utilizzati sono stati quelli dei soli punti di concorso, dei punti misuratori e dei raggi visuali. CAPACITA’: Nel complesso sono in grado di collegare gli argomenti e stabilire delle relazioni tra loro. Mod 1 Ripasso proiezioni assonometriche Ripasso proiezioni prospettiche Prospettiva con i punti di concorso Esercitazioni con modellini Settembre 5 ore Ottobre 5 ore Novembre 5 ore Dicembre 5 ore Prospettiva con i punti misuratori Teoria delle ombre Esercitazioni con solidi Esercitazioni con modellini Le proiezioni centrali Gennaio 5 ore Febbraio 6 ore Marzo 5 ore Aprile 5 ore Maggio 5 ore Mod 2 2. METODOLOGIE Lezioni frontali 3. MATERIALI DIDATTICI Libri di testo, dispense. 4. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE Verifiche scritte Firma del docente Pag. 43 ALL. A ISTITUTO STATALE D’ARTE DI VERONA “N.NANI” RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE Prof. Grapulin Roberto Materia: Geometria Descrittiva classe: V sez: E a.s. 2013/14 In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: CONOSCENZE Tutti gli alunni conoscono ed sono in grado di approfondire i vari metodi teorici di rappresentazione prospettica, e cenni del metodo delle ombre applicato alla prospettiva. ABILITA’ Gli alunni hanno acquisito abilità ad utilizzare la prospettiva mediante la rappresentazione grafica, con l’utilizzo di supporti tecnici, applicata al progetto di varie tipologie edilizie per una rappresentazione più vicina alla realtà. Sa riconoscere tipi, modi e ragioni delle deformazioni utilizzate nella comunicazione per immagini. COMPETENZE Gli alunni si sono impadroniti delle tecniche e dei metodi di rappresentazione propri della geometria descrittiva. Hanno competenze di scegliere autonomamente il metodo, e di saper padroneggiare l’aspetto ambientale, pittorico della rappresentazione realistica. Sono in grado di interpretare gli elaborati grafici ed i concetti base della teoria delle ombre. Pag. 44 1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: Unità didattiche e/o Moduli e/o Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento Nozioni preliminari sulla prospettiva Periodo/ore Dal 18-09-2013 al 25-9-2013 ore 4 Variabili prospettiche: a) distanza del punto di vista b) direzione dell’asse visivo c) posizione del quadro prospettico d) altezza del punto di vista dal geometrale Prospettiva di rette generiche, Prospettiva di rette a 45 gradi rispetto il quadro, Prospettiva di rette perpendicolari al quadro, 27-11-2013 ore 2 12-03-2014 ore 2 Prospettiva di rette passanti per il punto di stazione, Prospettiva di rette parallele al quadro PROSPETTIVA FRONTALE : Dal 02-10-2013 al 16-10-2013 ore 6 Metodo dei punti di distanza Metodo delle perpendicolari al quadro a) prospettiva di solidi e di composizioni architettoniche b) prospettiva di un fabbricato PROSPETTIVA ACCIDENTALE: Metodo dei punti di fuga: prospettiva di composizioni Dal 23-10-2013 al 13-11-2013 ore 8 architettoniche con scala e solidi vari. Metodo del taglio dei raggi visuali: prospettiva di uno spazio espositivo. Metodo del taglio dei raggi visuali: prospettiva di composizioni architettoniche e di fabbricati progettati con ambientazioni. Metodo del taglio dei raggi visuali: prospettiva di un tempio con colonne. Dal 20-11-2013 al 19-12-2013 ore 8 Dal 08-01-2014 al 15-01-2014 ore 4 Dal 22-01-2014 al 12-02-2014 ore 6 Metodi misti: prospettiva di un museo in stile post-modern. Dal 19-03-2014 al 09-04-2014 ore 8 Pag. 45 Metodo dei punti misuratori: prospettiva di un monumento (Aldo Rossi). Dal 16-04-2014 al 30-04-2014 ore 6 TEORIA DELLE OMBRE: Sorgente luminosa di fronte all'osservatore Ombra di un rettangolo Dal 19-02-2014 al 12-03-2014 ore 4 Ombre di solidi Sorgente luminosa dietro l'osservatore Ombra di un rettangolo Ombre di solidi Sorgente luminosa affianco all'osservatore Ombra di un rettangolo Ombre di solidi Esercitazioni varie e ripasso teoria della prospettiva di punti, rette e segmenti. Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico Dal 07-05-2014 al 04-06-2014 ore 8 TOTALE ORE 66 2. METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, libro di testo, LIM, eventuale materiale per l’approfondimento ecc..): Il docente ha guidato gli allievi all’acquisizione del metodo della rappresentazione prospettica, partendo da spiegazioni teoriche alla lavagna e successive esercitazioni seguite individualmente. La collaborazione e la buona volontà della gran parte degli alunni ha permesso di ottenere ottimi risultati nella materia. Durante l’anno scolastico l’insegnante ha effettuato alcuni interventi individuali per perfezionare la tecnica della prospettiva. 3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Specificare (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, simulazioni di terza prova dell’esame, prove grafiche, prove di laboratorio ecc.): Esercitazioni grafiche di sviluppo di prospettiva. Verona, 15 Maggio 2014 Firma del Docente (Roberto Grapulin) …………………………………………………………….. ALL. A Pag. 46 ALL. A ISTITUTO STATALE D’ARTE DI VERONA “N.NANI” RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE Prof.ssa Corso Giovanna Materia: IRC classe: 5 sez: E a.s. 2013/14 In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: CONOSCENZE La classe ha raggiunto nel complesso un discreto livello di conoscenze dei contenuti disciplinari proposti e delle metodologie da adottare per trattare le tematiche inerenti la questione etica e religiosa. Si segnala che per diversi motivi (uscite didattiche, conferenze, festività) il monte ore annuale ha visto una riduzione significativa rispetto a quello previsto a inizio anno, pertanto la programmazione è stata semplificata o ridimensionata. ABILITA’ La maggior parte degli alunni dimostra nel complesso una discreta capacità di espressione e di rielaborazione dei contenuti delle questioni etiche e delle posizioni religiose e laiche al riguard o. Comprende inoltre l’importanza del dialogo fra i differenti saperi (filosofico, scientifico, artistico e teologico) e il loro specifico contributo nella ricerca di una risposta alle domande di senso dell’uomo per l’elaborazione di un proprio sistema di valori in vista di un progetto di vita orientato alla promozione della persona nelle dimensioni individuale, relazionale e spirituale. COMPETENZE La maggior parte degli alunni è in grado di confrontarsi in modo costruttivo con quanti vivono scelte religiose e impostazioni di vita diverse dalle proprie; sa esprimere con valide argomentazioni il proprio punto di vista in base al sistema di valori maturato; comprende l’importanza del rapporto tra libertà e responsabilità nelle scelte personali. 1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: Unità didattiche e/o Moduli e/o Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento La questione etica La genesi dell’etica nella comunità sociale. Tipologie di etica contemporanea (soggettivistico-libertaria; utilitaristica; tecnico-scientifica; ecologista; della responsabilità; personalistica; religiosa). Individualismo e relativismo etico. Pag. 47 Periodo/ore 8 Etica cristiana, fondamenti evangelici e magistero della Chiesa sul tema della vita tra adesione e dissenso. Tematiche specifiche di bioetica (aborto, procreazione assistita, ricerca genetica, biotecnologie, eutanasia…) Interventi con esperti esterni Centro Diocesano Aiuto Vita – Legge sulla tutela della maternità. La figura di Jerome Lejeune e la ricerca scientifica a servizio dell’uomo. Il progresso scientifico e la responsabilità dell’etica. La formazione della coscienza e del sistema di valori del soggetto tra condizionamento, libertà, legge e responsabilità nelle scelte di vita della persona. Antropologia teologica biblica: le dimensioni della persona. La persona tra libertà e limiti creaturali. Dialogo tra teologia, filosofia e scienza. L’esistenza di Dio e il problema del male. I rischi e le opportunità delle tecnologie scientifiche e informatiche e dei nuovi mezzi di comunicazione nella società del terzo millennio (meta-comunicazione, social network, il condizionamento dei mezzi di comunicazione di massa). Il giorno della memoria: testimoni della Shoah e la teologia del Dio dopo Auschwitz Arte e teologia: la ricerca della spiritualità in alcune opere del ’900. Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 2. METODOLOGIE 3 6 4 2 2 1 1 27 E SUSSIDI DIDATTICI (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, libro di testo, LIM, eventuale materiale per l’approfondimento ecc..): Lezione frontale, esposizione con l’ausilio di tecnologie informatiche, interventi di esperti. 3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Specificare (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, simulazioni di terza prova dell’esame, prove grafiche, prove di laboratorio ecc.): Elaborati scritti, interventi orali sulle tematiche trattate in classe, trattazione di argomenti brevi concordati con il docente. A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e verifiche effettuate: --4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE PER APPROFONDIRE LA DISCIPLINA (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) Intervento di esperti esterni (Centro Diocesano Aiuto Vita; studente in medicina). Firma del Docente Giovanna Corso ALL. A Pag. 48 ISTITUTO STATALE D’ARTE DI VERONA “N.NANI” RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE Materia: Lingua e Civiltà Inglese classe: 5^ sez: E a.s.2013/14 In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: CONOSCENZE Nel quinto anno l’insegnamento della lingua straniera ha favorito l’approfondimento e lo studio di fasi più complesse delle strutture grammaticali e il loro specifico riferimento alla storia , alla letteratura e alla storia dell’arte del periodo considerato. L’analisi testuale ha interessato testi letterari, storici e aspetti di civiltà, mentre per la storia dell’arte lo studio è stato indirizzato ad alcuni esempi di architettura e pittura dell’ 800 e del periodo vittoriano. Questo è avvenuto nella prima parte dell’anno. Nel secondo quadrimestre sono stati sviluppati temi riguardanti soprattutto l’età post-vittoriana, del 900 e cenni sull’età ed arte contemporanea. ABILTA’ Al termine del 5° anno lo studente è mediamente in grado di: -1 saper sostenere una conversazione piuttosto corretta, anche su argomenti di carattere specifico -2 accedere alle letture di testi di carattere generale, ricorrendo, quando opportuno al dizionario -3 acquisire una conoscenza della cultura e della civiltà anglosassone Per quanto riguarda in particolare le abilità produttive scritte, gli studenti hanno riportato in modo sintetico il contenuto di un testo, esercitandosi a scrivere relazioni su argomenti incontrati su testi analizzati . Le prove simulate sono state infatti somministrate con questo tipo di esercitazione (domanda risposta aperta, tip B). COMPETENZE La classe ha mediamente conseguito i seguenti obiettivi: 1. gestione della lingua per i principali scopi comunicativi e sufficiente correttezza nel rispondere a quesiti su argomenti letterari e artistici. 2. ampliamento degli orizzonti umani, culturali e sociali degli studenti attraverso la conoscenza di realtà diverse 3. analisi ed interpretazione di diverse tipologie di testi per un corretto approccio specificoLe abilità produttive sono state ampliate in modo da affrontare situazioni comunicative che richiedevano, oltre al coinvolgimento della classe, un minimo di espressioni e opinioni personali. Pag. 49 1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER Unità didattiche e/o Moduli e/o Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento Contenuti specifici e tempi di svolgimento del percorso formativo di storia e letteratura Inglese L’età vittoriana: inquadramento storico del periodo: Social change and political reform- The challenge of Empire ,Victorian values (fotocopia) Victorian Novelists Charles Dickens: life and works – Hard Times – lettura brano Coketown tratto da Hard Times Visione film “A Christmas Carol” The End of the Victorian Age Aestheticism Oscar Wilde: life and works – lettura brano tratto da “The Picture of Dorian Gray” Modernism: the period at a glance Historical Background: Britain in the first half of the 20th century The importance of being Earnest Modernism – Historical and Cultural background – The disintegration and redefinition of man and literature Modernism in Art – Modernist Poetry Modernist Fiction Virginia Woolf – Life and works – The Bloomsbury Group Mrs Dalloway – lettura brano “A London walk” James Joyce – Life and works Dubliners – lettura brano “Eveline” Art History Contents - 19th Century Analisi del quadro “The Nightmare” di Fuseli Iron and glass architecture: Crystal Palace by J. Paxton The Gothic Revival: Houses of Parliament – The British Museum Painting: The Pre-Raphaelitism: D.G.Rossetti “ Symbolism in painting” “Ecce Ancilla Domini!”(The Annunciation) W. Morris and the Arts and Crafts Movement J. S. Sargent.: “ A morning walk” – Essai de Figure en plein-air 20th Century From Modernism to Pop Art P. Picasso and Cubism: “ Les demoiselles d'Avignon”, G. Braque “The Violin and the Pitcher” Henry Matisse and Fauvism: “Harmony in red” W.Kandinsky and the abstract art: “Composition IV” J.Pollock: “Blue Poles” Pop Art: A. Warhol: Marylin Diptych Pag. 50 Periodo/ore 1° Quadrimestre Ore 2 Ore 2 Ore 2 Ore 2 Ore 2 Ore 2 Ore 2 Ore 2 Ore 2 2° Quadrimestre Ore 2 Ore 2 Ore 2 Ore 2 Ore 2 Ore 2 Ore 2 1° Quadrimestre Ore 2 Ore 2 Ore 2 Ore 2 Ore 2 Ore 2 Ore 2 2° Quadrimestre Ore 1 Ore 2 Ore 2 Ore 2 Ore 1 Ore 2 Ore 1 Ore 1 Grammatica e strutture Ripasso dei modi e dei tempi verbali del passato e del futuro con riferimenti a brani di civiltà e a dialoghi ed esercizi sul testo Uso delle strutture grammaticali riguardanti le differenze tra passati e uso del condizionale più frasi ipotetiche di 1° e 2° grado Le restanti ore sono state utilizzate per prove di verifica o esercitazioni varie in classe, compresi i recuperi in itinere Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 1° Quadimestre Ore 6 2° Quadrimestre Ore 6 Ore 26 Ore 96 2. METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione ecc..): L’attività didattica si è svolta principalmente in lingua Inglese con lezioni frontali e con spiegazioni anche in lingua italiana. Si è cercato di sviluppare nello studente una competenza testuale per fargli acquisire la lingua in modo operativo. Lezioni di grammatica, di ripasso e recupero tipologia B sono state svolte periodicamente per tutti gli alunni con esercizi di riassunto e di Pair-works. I testi in adozione sono quelli che risultano dalla Programmazione iniziale e precisamente: per la grammatica :Horizon 2 + Work Book – ed. Oxford-La Nuova Italia Storia e letteratura: Litfest- Perrucchini, Pajalich, Lynch – ed. Europass Arte: Only Connect – Looking into Art - M. Spiazzi – ed. Zanichelli 3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi come previsti dalla terza prova, prove grafiche, prove di laboratorio ecc.): Le prove di verifica scritte sono state 2 per quadrimestre. Due delle 4 sono state somministrate all’interno della terza prova simulata con tipologia B (domanda a risposta aperta con non più di 10 righe a disposizione per la risposta). Le altre prove scritte hanno avuto esercizi di collegamento, vero-falso o brevi relazioni e sintesi di concetti studiati come nella prova simulata. Per le verifiche orali ci sono state 2 interrogazioni per quadrimestre. Le griglie di valutazione sono state fornite in base alla tipologia della prova e in base alle difficoltà delle prove stesse. Per le prove con diversi items si è tenuto conto della sufficienza col raggiungimento del 60% del punteggio totale. A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle prove e delle verifiche effettuate: Un esempio di prova simulata con 3 domande a risposta aperta di tipologia B con allegata griglia di valutazione Firma del Docente ……………………………………………. Pag. 51 ISTITUTO STATALE D’ARTE DI VERONA “N.NANI” RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE Prof._Lina Costantini Materia: Laboratorio arch./arredo classe: 5^E sez: Arch. a.s. 2013/14 In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: CONOSCENZE La classe 5E è formata da 11 elementi quasi tutti pienamente in possesso delle conoscenze che permettono a loro di applicare appropriatamente il metodo progettuale per quanto concerne, ovviamente, il grado di acquisizione disciplinare dell’ultimo anno di una scuola superiore , utilizzando i sistemi compositivi appresi, i metodi di rappresentazione, le tecniche grafiche e di elaborazione plastica. Pochi presentano delle difficoltà soprattutto nell’ambito della sintesi e della velocità di risposta alle problematiche proposte. ABILITA’ La classe è, per la quasi totalità, in grado di sviluppare un tema di architettura o di arredamento operando secondo un corretto metodo progettuale che prevede quattro fasi. La prima di ANALISI, la seconda di SINTESI, la terza di SVILUPPO e la quarta di COMUNICAZIONE, utilizzando in modo appropriato il linguaggio tecnico-grafico-plastico ed espressivo. I tempi di esecuzione, nella norma, dimostrano una adeguata capacità di autonomia. COMPETENZE Anche per le competenze la classe, in generale, è pienamente in grado di utilizzare e controllare gli aspetti tecnici acquisiti durante l’anno, sapendo gestire, per alcuni allievi anche con disinvoltura, i vari sistemi di rappresentazione, raggiungendo risultati da considerare buoni, in alcuni casi più che buoni o eccellenti. 1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: X Unità didattiche e/o X Moduli e/o X Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento Tema n°1: Progetto di sistemazione di uno spazio esistente all’interno Pag. 52 Periodo/ore Settembre-ottobrenovembre del nostro Istituto . Lo spazio ubicato al piano -1 dello stabile dovrà contenere una zona adibita ad esposizione di elaborati delle varie sezioni/indirizzi e una zona per il ricevimento settimanale Docenti/Genitori con strumenti multimediali: si dovrà tener conto dei vincoli esistenti quali finestre, pilastri, scala d’accesso, percorsi, ecc. ORE 77 Rilievo dello spazio esistente Fase di elaborazione dell’idea e trasposizione in extempore Fase di sintesi e rappresentazione con esecutivi Rappresentazione tridimensionale con assonometrie e/o prospettive Modello rappresentativo dell’area – fase esecutiva Modello rappresentativo dell’unità – fase progettuale Modello rappresentativo dell’unità – fase esecutiva Tema n°2: Progetto di riuso di uno spazio adibito a laboratorio, da demolire, annesso ad una libreria inserita in un palazzo del ‘700 che prospetta su una piazza porticata. La nuova costruzione dovrà contenere spazi che richiamino lettori giovani con un ambiente variamente articolato per la presentazione di nuovi libri, ascolto di musica, presentazione di autori, ecc.. Novembre-dicembregennaio ORE 86 Fase di elaborazione dell’idea e trasposizione in extempore Fase di sintesi e rappresentazione con esecutivi Rappresentazione tridimensionale con assonometrie e/o prospettive Modello rappresentativo dell’area – fase esecutiva Modello rappresentativo dell’unità – fase progettuale Modello rappresentativo dell’unità – fase esecutiva Gennaio-febbraiomarzo Tema n°3: Progetto per la costruzione di un piccolo museo situato in un’area edificabile di 800 mq all’incrocio di un importante viale della nostra città. Dovrà ospitare mostre artistiche contemporanee e dovrà svilupparsi su più piani, mantenendo una piccola porzione del lotto a zona verde. L’interno dovrà contenere biglietteria, servizi, bookshop e sala conferenze, ecc; la copertura sarà a terrazzo e praticabile. Fase di elaborazione dell’idea e trasposizione in extempore Fase di sintesi e rappresentazione con esecutivi Rappresentazione tridimensionale con assonometrie e/o prospettive Pag. 54 ORE 89 Modello rappresentativo dell’area – fase esecutiva Modello rappresentativo dell’unità – fase progettuale Modello rappresentativo dell’unità – fase esecutiva Tema n°4: 1^ SIMULA ZI O NE 2^ PRO VA D’E SAME Progetto per sistemazione di un’area verde situata in una zona periferica cittadina, con organizzazione dei percorsi ed accesso alla strada, piantumazione, illuminazione, sistemazione degli spazi destinati ad area attrezzata per sport e relax, area ludica per bimbi dai 2 ai 12 anni, piccolo chiosco/bar con annessi servizi alla ristorazione e servizi igienici . Il lotto di dimensioni 100x50 mt. È situato frontalmente in uno dei due lati più lunghi alla strada principale ed è delimitato da una cortina di palazzine di tre piani ad uso prevalentemente residenziale, già distanziate a 6 mt. dall’area. Marzo ORE 17 Fase di elaborazione dell’idea e trasposizione in extempore Fase di sintesi e rappresentazione con esecutivi Rappresentazione tridimensionale con assonometrie e/o prospettive Modello rappresentativo dell’area – fase esecutiva Modello rappresentativo dell’unità – fase progettuale Modello rappresentativo dell’unità – fase esecutiva Tema n°5: Marzo-aprile-maggio Nella cortina di unità abitative, con caratteristiche architettoniche ottocentesche (edifici a due piani più sottotetto ed altezza media all’intradosso di mt 7.60) che si snoda lungo la via principale di una cittadina di provincia, si rende libero lo spazio per la ricostruzione di una unità edilizia con una destinazione d’uso scelta tra: Agenzia viaggi Punto mostre/vendita oggettistica di design Attività commerciale di abbigliamento Studio di Bio-Architettura e progettazione di giardini L’area di progetto è posizionata con un fronte su una delle vie principali, e l’altro su una zona di pertinenza di dimensioni uguali all’area d’intervento stessa (6.80x20) Fase di elaborazione dell’idea e trasposizione in extempore Pag. 55 ORE 47 Fase di sintesi e rappresentazione con esecutivi Rappresentazione tridimensionale con assonometrie e/o prospettive Tema n°6: 2^ SIMULA ZI O NE 2^ PRO VA D’E SAME Progetto di sistemazione di uno spazio esistente all’interno dell’ateneo di Architettura. L’aula/laboratorio dovrà soddisfare tutte le esigenze specifiche legate alla ricerca, alla rappresentazione grafica e di modello; pertanto, dovrà contenere zone adibite a biblioteca cartacea e multimediale, a spazi per il disegno tradizionale e a quello assistito, a zone tecnologicamente attrezzate per la modellistica e per il deposito dei materiali. Il volume di dimensioni 20x15 ml e 5.50 di altezza, con finestrature a nastro posizionate ad una altezza di 2.00 per tutta la lunghezza di una delle pareti più lunghe, permette un intervento anche a doppia altezza e dovrà contenere almeno 50 studenti. Maggio-giugno ORE 36 Fase di elaborazione dell’idea e trasposizione in extempore Fase di sintesi e rappresentazione con esecutivi Rappresentazione tridimensionale con assonometrie e/o prospettive Modello rappresentativo dell’area – fase esecutiva Modello rappresentativo dell’unità – fase progettuale Modello rappresentativo dell’unità – fase esecutiva Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico ORE 352 2. METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, libro di testo, LIM, eventuale materiale per l’approfondimento ecc..): Metodo scientifico – Metodo progettuale: Per temi e/o unità didattiche Comunicazione, approfondimento personale degli alunni e verifica. Mod al i tà d i svol gi men to d el l ’att i vit à d i d att i ca: Lezione frontale con l’ausilio di strumenti informatici Relazione degli allievi Ricerca di dati dimensionali, normativi, formali di progetti già realizzati. Sviluppo individuale del progetto Comunicazione individuale e/o collettiva dei risultati. Mod al i tà d i svol gi men to d el l ’att i vit à d i r ecu p er o/app r of on d i men to : Attività di recupero svolta nelle ore curricolari. Pag. 56 Misurazione e valutazione delle prestazioni Strumenti utilizzati per le verifiche: Verifica del progetto svolto in base allo stato di avanzamento del lavoro. Trattazione sintetica di argomenti. Criteri di misurazione: Capacità di definire il problema assegnato. Capacità di analizzare, ricercare dati, e porli in relazione tra loro. Capacità di definire ipotesi progettuali in relazione agli obiettivi e ai dati analizzati Capacità di operare scelti del tipo di modello di scala, di materiale, di colore sulla base di conoscenze teoriche e tecnico-pratiche acquisite. Capacità di rappresentare con idonea espressività grafica le soluzioni adottate. Descrizione dei livelli e rispettivi punteggi Si rimanda alla griglia adottata dal Consiglio di Classe e dal Collegio dei Docenti 3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Specificare (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, simulazioni di terza prova dell’esame, prove grafiche, prove di laboratorio ecc.): Prove grafiche complete di extempore, esecutivi (piante, prospetti, sezioni in scale adeguate), prospettive interne ed esterne, relazione tecnica. Prove di laboratorio: modello di studio, modello rappresentativo e/o particolareggiato in scala adeguata Simulazioni seconda prova d’esame A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e verifiche effettuate: Nessuna 4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE PER APPROFONDIRE LA didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) DISCIPLINA (uscite Viaggio d’istruzione a Parigi: approfondimento di esempi di architettura contemporanea e riuso di edifici di pregio con destinazione d’uso diversa- urbanizzazione moderna Firma del Docente ………………………………………………. Firma degli Studenti Pag. 57 ALL. A ISTITUTO STATALE D’ARTE DI VERONA “N.NANI” RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE Prof. Stefano Caceffo Materia: Lab. Design classe: V sez.: E (Design) a.s. 2013/14 In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: CONOSCENZE Gli alunni hanno appreso le conoscenze teoriche e pratiche per una corretta metodologia di realizzazione del progetto, che consiste nell'organizzazione meta-costruttiva delle funzioni e delle unità spaziali di varie tipologie di elementi d'arredo. Hanno acquisito conoscenze sui vari elementi costitutivi di un oggetto. ABILITA’ Gli alunni hanno acquisito una metodologia costruttiva attraverso ricerca, analisi e sintesi dei progetti. Approfondimento di elementi costruttivi e decorativi. Tecniche costruttive idonee alla realizzazione di un prototipo. COMPETENZE Quasi tutti gli allievi hanno dimostrato più che buone capacità di analisi, comprensione e valutazione del problema proposto, di gestione di un metodo per la realizzazione ed il controllo della fase comunicativa attraverso specifici modelli tridimensionali. 1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: Unità didattiche e/o Moduli e/o Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento “Letto, cucina, lampada”. Realizzazione di un prototipo per il progetto realizzato a “Progettazione”. “Cioccolateria: tavolino con seggiola”. Realizzazione di un prototipo per il progetto realizzato a “Progettazione” “Gelateria: tavolo e sgabello”. Realizzazione di un prototipo per il progetto realizzato a “Progettazione”. “Giardino di una villa: chaise loung, carrello porta vivande, casetta per gli attrezzi”. Realizzazione di un prototipo per il progetto realizzato a “Progettazione”. “Simulazione 2° prova: Pannello espositivo”. Realizzazione di un prototipo per il progetto realizzato a “Progettazione”. “Sistema di illuminazione per una sala d'attesa”. Realizzazione di un Pag. 58 Periodo/ore Sett. Ott. Ore 50 Nov. Ore 44 Dic. Gen. Ore 42 Gen. Feb. Ore 77 Ore 30 prototipo per il progetto realizzato a “Progettazione”. Ore 55 Ore 37 Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico Tot. Ore 335 2. METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, libro di testo, LIM, eventuale materiale per l’approfondimento ecc..): Ogni tema progettuale proposto è da considerarsi un modulo comprensivo di lezione partecipata, invito ad una continua verbalizzazione dei contenuti individuando analogie, differenze e problematiche all'interno degli stessi. Su argomenti del programma di interesse generale sono state svolte prevalentemente lezioni frontali. Gli interventi individualizzati sono stati svolti durante la trattazione di ogni singolo tema proposto al fine di contribuire alla corretta interpretazione e allo svolgimento del tema stesso senza peraltro “interferire” con la personalità ed espressività dell’allievo. Attività di recupero sono state svolte in classe attraverso interventi individualizzati ed approfondimenti a casa. 3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Specificare (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, simulazioni di terza prova dell’esame, prove grafiche, prove di laboratorio ecc.): Prove di laboratorio relative alla realizzazione di modellini e prototipi costituite dalle seguenti fasi: -Extempore: modello volumetrico in cartoncino -Esecutivi: prototipo in scala ridotta realizzato con materiali appropriati. Ogni consegna, al termine del progetto, è stata motivo di valutazione. E' stata eseguita nel II° quadrimestre una prova pratica (simulazione 2^ prova) in collaborazione con il collega di progettazione. A disposizione della commissione: A disposizione della commissione sono depositate presso l’armadio dell’insegnante tutte le prove effettuate durante l’anno scolastico. 4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE PER APPROFONDIRE LA DISCIPLINA (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) Collaborazione con la ditta “Revers Lab” per la realizzazione di un oggetto modulare per la realizzazione di stand espositivi per la manifestazione fieristica “ArtVerona”, svoltasi presso la Fiera di Verona nel mese di ottobre 2013. Firma del Docente (Stefano Caceffo) ………………………………………………. ALL. A Pag. 59 ALL. A ISTITUTO STATALE D’ARTE DI VERONA “N.NANI” RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE Prof. GIUSEPPE BOVO Materia: MATEMATICA classe: 5 sez: E a.s. 2013/14 In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: CONOSCENZE Alcuni studenti dimostrano di conoscere le definizioni e gli enunciati dei teoremi dell'analisi infinitesimale. Un gruppo più numeroso di studenti ha però manifestato qualche diffico ltà nell’utilizzo del linguaggio specifico e nell’applicarsi con continuità. Pochi studenti hanno una conoscenza solo parziale degli argomenti trattati. ABILITA’ In generale, la quasi totalità degli studenti sa applicare correttamente le conoscenze apprese nel calcolo delle disequazioni e dei sistemi di disequazioni, nel calcolo dei limiti e delle derivate. Alcuni invece dimostrano qualche difficoltà nell’applicare i metodi risolutivi e nello svolgere esercizi applicativi di una certa difficoltà. COMPETENZE Un gruppo di studenti dimostra di saper collegare con padronanza le conoscenze, completando tutte le fasi richieste per uno studio di funzione di una funzione razionale. Alcuni studenti, invece, non riescono a collegarle in un ambito più vasto. 1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: Unità didattiche e/o Moduli e/o Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento DISEQUAZIONI E SISTEMI DI DISEQUAZIONI FUNZIONI DI UNA VARIABILE I LIMITI CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI DERIVATE Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico Pag. 60 Periodo/ore 4 ore 8 ore 12 ore 28 ore 38 ore 90 ore PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO MATEMATICA - CLASSE 5E DISEQUAZIONI DI 1° E 2° GRADO A UNA INCOGNITA Disuguaglianze tra espressioni algebriche. Generalità sulle disequazioni. Disequazioni equivalenti e principi di equivalenza. Disequazioni di 1° grado ad una incognita o ad esse riconducibili. Disequazioni di 2° grado ad una incognita o ad esse riconducibili. Disequazioni fratte. Sistemi di disequazioni ad una incognita. FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE Definizioni. Classificazione delle funzioni. Rappresentazioni di una funzione. Proprietà specifiche di alcune funzioni. Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione razionale fratta. LIMITI Introduzione al concetto di limite di una funzione. Limite finito di una funzione in un punto. Limite infinito di una funzione in un punto. Limite destro e limite sinistro di una funzione in un punto. Limiti finito e infinito di una funzione all’infinito. Operazioni sui limiti. Forme indeterminate, o di indecisione. FUNZIONI CONTINUE Definizioni. La continuità delle funzioni elementari. Funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato. Continuità delle funzioni composte. Punti di discontinuità di una funzione: classificazione. Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui di una funzione. DERIVATE DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE Introduzione al concetto di derivata. Derivata di una funzione in un punto. Calcolo della derivata in un punto. Continuità e derivabilità. Significato geometrico della derivata. Funzione derivata. Derivate di alcune funzioni elementari razionali (solo definizioni). Teoremi sulle derivate (solo enunciati). Tabella delle formule e delle regole di derivazione. TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE Teorema di Lagrange e di Rolle (solo enunciati). Teorema de L’Hospital (solo enunciato). Applicazione del Teorema de L’Hospital per la risoluzione di forme di indecisione nel calcolo dei limiti di funzioni razionali fratte. ESTREMI. STUDIO DI FUNZIONE Studio dei massimi e minimi relativi con la derivata prima. Studio della concavità con la derivata seconda. Punti di flesso. Punti di non derivabilità: punti angolosi, di flesso a tangente verticale, di cuspide. Studio di una funzione razionale. Studio di una funzione razionale fratta. Firma dei rappresentanti degli studenti Pag. 61 Firma del Docente 2. METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, libro di testo, LIM, eventuale materiale per l’approfondimento ecc..): L'introduzione di ogni argomento è stata fatta tramite lezioni frontali, utilizzando in prevalenza il metodo induttivo, favorendo la partecipazione attiva dei ragazzi, stimolando interventi, suggerimenti, osservazioni, domande. Ogni lezione è stata corredata da un cospicuo numero di esempi ed esercizi svolti in classe, tali da consentire ai ragazzi la più completa assimilazione ed analisi critica della materia in esame, nonché per permettere loro di avere delle utili tracce per poter affrontare proficuamente il lavoro domestico. È stata posta un'attenta cura nella motivazione all'apprendimento, presupposto fondamentale per un lavoro proficuo e duraturo, che può scaturire da un rapporto di reciproca stima, dal dialogo e rispetto fra insegnante e allievo, dall’interesse e curiosità per nuove conoscenze, dal coinvolgimento della classe. 3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Specificare (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, simulazioni di terza prova dell’esame, prove grafiche, prove di laboratorio ecc.): Sono state utilizzate verifiche scritte, orali, e prove strutturate. Le verifiche scritte sono state articolate sotto forma di problemi ed esercizi da risolvere. Le prove strutturate sono state articolate sotto forma di questionario a risposta aperta. Sono state svolte due simulazioni della terza prova d’esame, in cui era coinvolta nella seconda simulazione come materia anche Matematica. La tipologia scelta in tale occasione è stata la B (3 risposte brevi sulle fasi dello studio di una funzione razionale fratta assegnata). A disposizione della commissione sono depositate in segreteria copie delle prove e delle verifiche effettuate. Firma del Docente ALL. A Pag. 62 ALL. A ISTITUTO STATALE D’ARTE DI VERONA “N.NANI” RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE Prof.sa GIOVANNA TONOLI Materia: PROGETTAZIONE classe: 5 E sez: DESIGN a.s. 2013/14 In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: CONOSCENZE La classe 5E è formata da 12 elementi quasi tutti in possesso delle conoscenze che permettono di utilizzare correttamente il metodo progettuale, i diversi sistemi compositivi, i metodi di rappresentazione, le tecniche grafiche e di rendering e l’elaborazione plastica ABILITA’ La classe è in grado di utilizzare e controllare glia spetti tecnici più generali della progettazione riguardanti i sistemi costruttivi e i materiali da costruzione, oltre a saper gestire con autonomia i sistemi di rappresentazione, in questo modo è possibile raggiungere risultati che attestano il livello di professionalità raggiunto COMPETENZE La classe è in grado di sviluppare un tema di architettura e di arredamento operando secondo un corretto metodo progettuale che prevede quattro fasi. La prima di analisi, la seconda di sintesi, la terza di sviluppo e la quarta di comunicazione, utilizzando in modo appropriato il linguaggio tecnico-grafico-plastico ed espressivo Pag. 63 1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: Unità didattiche e/o Moduli e/o Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento Periodo/ore Presentazione del programma Settembre 3 ore TEMA: Settembre, Le abitazioni delle giovani famiglie hanno dimensioni sempre più ridotte ottobre, novembre pertanto in un monolocale di 35 mq dovrà trovare spazio l’angolo cottura, la Ore 36 zona notte ed un tinello/salotto. In rapporto alle esigenze manifestate, il candidato, sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato, ipotizzi una serie di soluzioni per il razionale utilizzo dello spazio e per gli arredi più coerenti, sviluppi infine uno dei seguenti progetti: Posto – letto matrimoniale Cabina/doccia con idromassaggio Set di lampade in sospensione, da terra, da mobile Angolo cottura Si chiedono i seguenti elaborati: Schizzi preliminari Progetto esecutivo con annotazioni, campionature e prototipi Tavole dedicate all’ambientazione degli arredi ipotizzati Relazione illustrativa dell’intero iter progettuale e dei materiali impiegati TEMA: Novembre, Sulla base delle metodologie e delle esperienze tecnico-progettuali acquisite dicembre, nel corso degli studi e nelle attività laboratoriali di indirizzo, il candidato Ore 21 sviluppi una personale proposta sul tema di seguito indicato e ne fornisca una rappresentazione efficace e completa mediante elaborati a sua scelta. Un’antica “cioccolateria”, situata in un centro storico, rispondendo alle esigenze di un pubblico esigente e raffinato, ha recuperato un ampio locale con volte a crociera realizzando anche una tea-room per la degustazione dei suoi prodotti. Ideare per tale spazio u n sistema di tavoli e di poltroncine, variamente componibili secondo il numero degli avventori e le esigenze di servizio. Si chiedono i seguenti elaborati. Schizzi preliminari Progetto esecutivo con annotazioni, campionature e prototipi Tavole dedicate all’ambientazione degli arredi ipotizzati Relazione illustrativa dell’intero iter progettuale e dei materiali impiegati TEMA: Dicembre, gennaio Un’importante azienda produttrice di arredi per il giardino ha avviato un Ore 21 concorso tra giovani designers per raccogliere nuove proposte da selezionare Pag. 64 ed eventualmente inserire in catalogo. Il candidato, sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo frequentato, proponga uno dei seguenti prodotti a sua scelta. Set di chaise longue e poltroncine da riposo in vari materiali Carrello portavivande Cabina – ripostiglio per gli attrezzi Mini serre Si chiedono i seguenti elaborati Schizzi preliminari Progetto esecutivo con annotazioni, campionature e prototipi Relazione illustrativa dell’intero iter progettuale e dei materiali impiegati TEMA: Gennaio, febbraio In un centro storico si vuole aprire una nuova gelateria. Progettare uno spazio Ore 15 di circa 3,50mq x 4,00 mq con altezza del locale di 3,00 m. con relativo arredamento. Il candidato, sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo frequentato, proponga uno dei seguenti prodotti a sua scelta. Tavolino per gelateria Sedia o poltroncina o sgabello Si chiedono i seguenti elaborati Schizzi preliminari Progetto esecutivo con annotazioni, campionature e prototipi Relazione illustrativa dell’intero iter progettuale e dei materiali impiegati TEMA: Febbraio, marzo, Gli spazi d’attesa sono spesso considerati luoghi secondari, o addirittura aprile, Ore 30 negativi, in cui si rimane in solitudine pur in mezzo ad altre persone, dove il tempo sembra non passare mai, mentre si aspetta di entrare da un medico, di prendere un treno o di poter parlare con qualcuno in un centro d’accoglienza. Si tratta comunque di ambienti, a volte di sofferenza, altre di speranza, altre ancora facenti parte della routine quotidiana, in cui si è costretti a fermarsi a riflettere su se stessi, in atmosfera sospesa. Progettare un apparecchio, o un sistema, illuminante per una sala d’attesa a scelta che sia in grado di valorizzare l’ambiente e contribuire alla creazione di un senso di sicurezza e serenità. Si chiedono i seguenti elaborati Schizzi preliminari Progetto esecutivo (piante, prospetti e sezioni in scala adeguata) con annotazioni, campionature e prototipi Assonometria della lampada o del sistema Studio di dettagli in scala 1:5 e/o 1:1 Prospettiva con ambientazione Relazione illustrativa dell’intero iter progettuale e dei materiali impiegati I° Prova d’esame Durata della prova: Pag. 65 Sulla base delle metodologie e delle esperienze tecnico-progettuali acquisite nel corso degli studi e nelle attività laboratoriali di indirizzo, il candidato sviluppi una personale proposta sul tema di seguito indicato e ne fornisca una rappresentazione efficace e completa mediante elaborati a sua scelta. All’interno di un padiglione espositivo facente parte di un liceo artistico, progettare l’allestimento di una mostra relativa al lavoro di un illustratore. Sono da prevedere: Un piccolo ufficio Almeno un bagno ( soddisfacente le normative sulle barriere architettoniche ) Area espositiva, dotata di: pannelli espositori per disegni elementi per la collocazione di libri pedane per il sostegno dei personaggi che l’illustratore realizza, tridimensionalmente, come fossero piccole sculture di cartapesta. Non deve essere previsto un deposito per le opere in quanto collocato in un edificio attiguo. L’intervento dovrà porre particolare attenzione alla creazione di un percorso e alla valorizzazione dei lavori più significativi. E’ richiesto: Schizzi preliminari Piante in scala 150 con indicazione dei punti luce dei percorsi Prospetti e sezioni Prospettiva/e interna/e Studio di un pannello esecutivo Relazione illustrativa dell’intero iter progettuale e dei materiali impiegati TEMA: Sulla base delle metodologie e delle esperienze tecnico-progettuali acquisite nel corso degli studi e nelle attività laboratoriali di indirizzo, il candidato sviluppi una personale proposta sul tema di seguito indicato e ne fornisca una rappresentazione efficace e completa mediante elaborati a sua scelta. Per una mostra di gioielli d’epoca, ospitata in un’antica chiesa sconsacrata, ideare un sistema di teche che possono essere utilizzate secondo scomponibilità diverse, sia in verticale che in orizzontale. Si chiedono i seguenti elaborati Schizzi preliminari Progetto esecutivo in scala appropriata e dettaglio della soluzione definitiva con annotazioni, campionature e prototipi Rappresentazione tridimensionale (assonometria, prospettiva) Relazione illustrativa dell’intero iter progettuale e dei materiali impiegati Allestimento fiera “Art VR” Proiezione del video “Storia del design” Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) Maggio, giugno Ore 18 Settembre ore 6 Febbraio ore 3 189 2. METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, libro di testo, LIM, eventuale materiale per l’approfondimento ecc..): Lezione frontale Pag. 66 Attività individualizzate Attività di approfondimento Metodo Scientifico – Metodo progettuale Per temi e unità didattiche Comunicazioni, approfondimento personale degli alunni Modalità di svolgimento delle attività didattiche Lezione frontale Relazione degli allievi Ricerca di dati dimensionali, formativi di progetto già realizzati Sviluppo individuale del progetto Comunicazione individuale e collettiva dei risultati Modalità di svolgimento dell’attività di recupero/approfondimento Attività di recupero nelle ore curricolari Misurazione e valutazione delle prestazioni Strumenti utilizzati per le verifiche Verifica del progetto svolto in base allo stato di avanzamento del lavoro Trattazione sintetica degli argomenti Criteri di misurazione Capacità di definire il problema assegnato Capacità di analizzare, ricercare dati, e porli in relazione tra loro Capacità di definire ipotesi progettuali in relazione agli obiettivi e ai dati analizzati Capacità di operare scelti del tipo di modello in scala, di materiale, di colore sulla base di conoscenze teoriche e tecnico-pratiche acquisite Capacità di rappresentare con idonea espressività grafica le soluzioni adottate Descrizione dei livelli e rispettivi punteggi Si rimanda alla griglia adottata dal Consiglio di Classe e dal Collegio Docenti 3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Specificare (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, simulazioni di terza prova dell’esame, prove grafiche, prove di laboratorio ecc.): Prove grafiche complete di extempore ed esecutivi (piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi in scala adeguate). Prove di laboratorio modello di studio, modello rappresentativo e particolareggiato in scala adeguata. A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e verifiche effettuate: Nessuna 4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE PER APPROFONDIRE LA DISCIPLINA (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) Viaggio d’istruzione a Parigi durante il periodo di fine marzo Verona 02/05/2014 Firma del Docente Giovanna Tonoli Pag. 67 ALL. A ISTITUTO STATALE D’ARTE DI VERONA “N.NANI” RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE Prof. Giovanna Bellintani Materia: PROGETTAZIONE arch./arredo classe: 5^E sez: Arch. a.s. 2013/14 In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: CONOSCENZE La classe 5E è formata da 11 elementi quasi tutti pienamente in possesso delle conoscenze che permettono a loro di applicare appropriatamente il metodo progettuale per quanto concerne, ovviamente, il grado di acquisizione disciplinare dell’ultimo anno di una scuola superiore , utilizzando i sistemi compositivi appresi, i metodi di rappresentazione, le tecniche grafiche e di elaborazione plastica. Pochi presentano delle difficoltà soprattutto nell’ambito della sintesi e della velocità di risposta alle problematiche proposte. ABILITA’ La classe è, per la quasi totalità, in grado di sviluppare un tema di architettura o di arredamento operando secondo un corretto metodo progettuale che prevede quattro fasi. La prima di ANALISI, la seconda di SINTESI, la terza di SVILUPPO e la quarta di COMUNICAZIONE, utilizzando in modo appropriato il linguaggio tecnico-grafico-plastico ed espressivo. I tempi di esecuzione, nella norma, dimostrano una adeguata capacità di autonomia. COMPETENZE Anche per le competenze la classe, in generale, è pienamente in grado di utilizzare e controllare gli aspetti tecnici acquisiti durante l’anno, sapendo gestire, per alcuni allievi anche con disinvoltura, i vari sistemi di rappresentazione, raggiungendo risultati da considerare buoni, in alcuni casi più che buoni o eccellenti. 1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE esposti per: X Unità didattiche e/o X Moduli e/o X Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti Pag. 68 U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento Tema n°1: Progetto di sistemazione di uno spazio esistente all’interno del nostro Istituto . Lo spazio ubicato al piano -1 dello stabile dovrà contenere una zona adibita ad esposizione di elaborati delle varie sezioni/indirizzi e una zona per il ricevimento settimanale Docenti/Genitori con strumenti multimediali: si dovrà tener conto dei vincoli esistenti quali finestre, pilastri, scala d’accesso, percorsi, ecc. Rilievo dello spazio esistente Periodo/ore Settembre-ottobrenovembre ORE 36 Fase di elaborazione dell’idea e trasposizione in extempore Fase di sintesi e rappresentazione con esecutivi Rappresentazione tridimensionale con assonometrie e/o prospettive Modello rappresentativo dell’area – fase esecutiva Modello rappresentativo dell’unità – fase progettuale Modello rappresentativo dell’unità – fase esecutiva Tema n°2: Progetto di riuso di uno spazio adibito a laboratorio, da demolire, annesso ad una libreria inserita in un palazzo del ‘700 che prospetta su una piazza porticata. La nuova costruzione dovrà contenere spazi che richiamino lettori giovani con un ambiente variamente articolato per la presentazione di nuovi libri, ascolto di musica, presentazione di autori, ecc.. Fase di elaborazione dell’idea e trasposizione in extempore Fase di sintesi e rappresentazione con esecutivi Rappresentazione tridimensionale con assonometrie e/o prospettive Modello rappresentativo dell’area – fase esecutiva Modello rappresentativo dell’unità – fase progettuale Modello rappresentativo dell’unità – fase esecutiva Tema n°3: Progetto per la costruzione di un piccolo museo situato in un’area edificabile di 800 mq all’incrocio di un importante viale della nostra città. Dovrà ospitare mostre artistiche contemporanee e dovrà svilupparsi su più piani, mantenendo una piccola porzione del lotto a zona verde. L’interno dovrà contenere biglietteria, servizi, bookshop e sala conferenze, ecc; la copertura sarà a terrazzo e praticabile. Pag. 69 Novembre-dicembregennaio ORE 51 Gennaio-febbraiomarzo ORE42 Fase di elaborazione dell’idea e trasposizione in extempore Fase di sintesi e rappresentazione con esecutivi Rappresentazione tridimensionale con assonometrie prospettive Modello rappresentativo dell’area – fase esecutiva Modello rappresentativo dell’unità – fase progettuale Modello rappresentativo dell’unità – fase esecutiva Tema n°4: 1^ SIMULA ZI O NE 2^ PRO VA D’E SAME e/o Progetto per sistemazione di un’area verde situata in una zona periferica cittadina, con organizzazione dei percorsi ed accesso alla strada, piantumazione, illuminazione, sistemazione degli spazi destinati ad area attrezzata per sport e relax, area ludica per bimbi dai 2 ai 12 anni, piccolo chiosco/bar con annessi servizi alla ristorazione e servizi igienici . Il lotto di dimensioni 100x50 mt. È situato frontalmente in uno dei due lati più lunghi alla strada principale ed è delimitato da una cortina di palazzine di tre piani ad uso prevalentemente residenziale, già distanziate a 6 mt. dall’area. Marzo ORE 9 Fase di elaborazione dell’idea e trasposizione in extempore Fase di sintesi e rappresentazione con esecutivi Rappresentazione tridimensionale con assonometrie e/o prospettive Modello rappresentativo dell’area – fase esecutiva Modello rappresentativo dell’unità – fase progettuale Modello rappresentativo dell’unità – fase esecutiva Tema n° 5: Nella cortina di unità abitative, con caratteristiche architettoniche ottocentesche (edifici a due piani più sottotetto ed altezza media all’intradosso di mt 7.60) che si snoda lungo la via principale di una cittadina di provincia, si rende libero lo spazio per la ricostruzione di una unità edilizia con una destinazione d’uso scelta tra: a) Agenzia viaggi b) Punto mostre/vendita oggettistica di design c) Attività commerciale di abbigliamento d) Studio di Bio-Architettura e progettazione di giardini L’area di progetto è posizionata con un fronte su una delle vie principali, e l’altro su una zona di pertinenza di Pag. 70 Marzo-aprile-maggio ORE30 dimensioni uguali all’area d’intervento stessa (6.80x20) Fase di elaborazione dell’idea e trasposizione in extempore Fase di sintesi e rappresentazione con esecutivi Rappresentazione tridimensionale con assonometrie e/o prospettive Tema n°6: 2^ SIMULA ZI O NE 2^ PRO VA D’E SAME Progetto di sistemazione di uno spazio esistente all’interno dell’ateneo di Architettura. L’aula/laboratorio dovrà soddisfare tutte le esigenze specifiche legate alla ricerca, alla rappresentazione grafica e di modello; pertanto, dovrà contenere zone adibite a biblioteca cartacea e multimediale, a spazi per il disegno tradizionale e a quello assistito, a zone tecnologicamente attrezzate per la modellistica e per il deposito dei materiali. Il volume di dimensioni 20x15 ml e 5.50 di altezza, con finestrature a nastro posizionate ad una altezza di 2.00 per tutta la lunghezza di una delle pareti più lunghe, permette un intervento anche a doppia altezza e dovrà contenere almeno 50 studenti Fase di elaborazione dell’idea e trasposizione in extempore Fase di sintesi e rappresentazione con esecutivi Rappresentazione tridimensionale con assonometrie e/o prospettive Modello rappresentativo dell’area – fase esecutiva Modello rappresentativo dell’unità – fase progettuale Modello rappresentativo dell’unità – fase esecutiva Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico Maggio-giugno ORE24 ORE 192 2. METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, libro di testo, LIM, eventuale materiale per l’approfondimento ecc..): Metodo scientifico – Metodo progettuale: Per temi e/o unità didattiche Comunicazione, approfondimento personale degli alunni e verifica. Mod al i tà d i svol gi men to d el l ’att i vit à d i d att i ca: Lezione frontale con l’ausilio di strumenti informatici Relazione degli allievi Ricerca di dati dimensionali, normativi, formali di progetti già realizzati. Sviluppo individuale del progetto Comunicazione individuale e/o collettiva dei risultati. Mod al i tà d i svol gi men to d el l ’att i vit à d i r ecu p er o/app r of on d i men to : Attività di recupero svolta nelle ore curricolari. Pag. 71 Misurazione e valutazione delle prestazioni Strumenti utilizzati per le verifiche: Verifica del progetto svolto in base allo stato di avanzamento del lavoro. Trattazione sintetica di argomenti. Criteri di misurazione: Capacità di definire il problema assegnato. Capacità di analizzare, ricercare dati, e porli in relazione tra loro. Capacità di definire ipotesi progettuali in relazione agli obiettivi e ai dati analizzati Capacità di operare scelti del tipo di modello di scala, di materiale, di colore sulla base di conoscenze teoriche e tecnico-pratiche acquisite. Capacità di rappresentare con idonea espressività grafica le soluzioni adottate. Descrizione dei livelli e rispettivi punteggi Si rimanda alla griglia adottata dal Consiglio di Classe e dal Collegio dei Docenti 3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Specificare (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, simulazioni di terza prova dell’esame, prove grafiche, prove di laboratorio ecc.): Prove grafiche complete di extempore, esecutivi (piante, prospetti, sezioni in scale adeguate), prospettive interne ed esterne, relazione tecnica. Prove di laboratorio: modello di studio, modello rappresentativo e/o particolareggiato in scala adeguata Simulazioni seconda prova d’esame A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi di prove e verifiche effettuate: Nessuna 4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE PER APPROFONDIRE LA DISCIPLINA (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, viaggi ecc.) Viaggio d’istruzione a Parigi: approfondimento di esempi di architettura contemporanea e riuso di edifici di pregio con destinazione d’uso diversa- urbanizzazione moderna Firma del Docente Prof.ssa Giovanna Bellintani Pag. 72 Anno scolastico 2013/2014 ISTITUTO D’ARTE “N. NANI” sperimentazione “Michelangelo” Documento finale del Consiglio di Classe Classe VE ALLEGATI: griglie di valutazione 1a, 2a prova, 3a prova Pag. 73 GRIGLIE VALUTAZIONE PRIMA PROVA D’ESAME DESCRITTORI E INDICATORI DI VALUTAZIONE Analisi del testo CANDIDATO: Grav. Insuff. 1-5 Indicatori Descrittori Insuff. 6-9 Suff. 10 Discreto 11 - 12 Buono 13 - 14 Ottimo 15 Approfondita, esauriente e con apporti personali Padronanza efficace e significativa degli strumenti di analisi Comprensione del testo Gravi errori nella comprensione e interpretazione Parziale e approssimativa Essenziale ma corretta Essenziale e completa Completa e sicura Competenza negli strumenti di analisi Gravi difficoltà nell’uso degli strumenti di analisi Uso improprio degli strumenti di analisi Uso corretto di alcuni strumenti di analisi Uso corretto degli strumenti di analisi Padronanza sicura degli strumenti di analisi Correttezza e proprietà linguistica Gravi e diffusi errori morfosintattici, ortografici e lessicali Presenza di errori morfosintattici, ortografici e lessicali Accettabile pur con qualche incertezza morfosintattic a e lessicale Stesura corretta pur con qualche impropriet à lessicale Esposizione corretta, approfondit a e fluida Esposizione appropriata, fluida e originale Contestualizzazione Assente o arbitraria Parziale e approssimativa Parziale, ma pertinente Completa e pertinente Precisa ed efficace Articolata, precisa e originale Totale Punteggio = /4 Pag. 74 Griglia per la correzione della prima prova Analisi del testo CANDIDATO: Grav. Insuff. 1-5 Indicatori Descrittori Insuff. 6-9 Suff. 10 Comprensione del testo Competenza negli strumenti di analisi Correttezza e proprietà linguistica Contestualizzazione Totale Punteggio = /4 Pag. 75 Discreto 11 - 12 Buono 13 - 14 Ottimo 15 DESCRITTORI E INDICATORI DI VALUTAZIONE Saggio breve/articolo di giornale CANDIDATO: Indicatori Descrittori Aderenza e sviluppo della tematica proposta Grav . Insu ff. 1Esclude la tematica5 proposta Insuf f. 69 Affronta marginalmente la tematica proposta Comprensio ne dei documenti dati Gravi errori nella comprensione e nell’interpretazi o- ne Gravi errori nella comprensione e nell’interpretazi o- ne Coerenza e coesione dello sviluppo argomentati vo Correttezza e proprietà linguistica Frammentari a e con evidenti incongruenze logiche Frammentari a e con evidenti incongruenze logiche Gravi e diffusi errori morfosintattici, ortografici e lessicali Gravi e diffusi errori morfosintattici, ortografici e lessicali Consegne: destinatario, titolo, attualizzazio ne Assenza o gravi errori nel rispetto delle consegne Parziali rispetto delle consegne Suf f. 1 0 Si attiene alla tematica proposta Comprensione globale dei documenti pur con qualche incomprensione Argomentazione coerente anche se poco autonoma rispetto ai documenti dati Accettabile pur con qualche incertezza morfosintattica e lessicale Rispetto delle consegne pur con qualche incongruità Totale Punteggio = /5 Pag. 76 Discreto 11 - 12 Buono 13 - 14 Si attiene alla tematica proposta e la sviluppa con una certa articolazione Sviluppa la tematica proposta anche con riferimenti a conoscenze personali Comprensio ne complessiva e corretta Comprensio ne precisa e puntuale Argomentazi o- ne coerente e autonoma Argomentazi one autonoma e chiara Stesura corretta pur con qualche improprietà linguistica Esposizione corretta e fluida Rispetto delle consegne con una corretta formalizzazio ne Rispetto pieno e corretta delle consegne Ottim o 1 Sviluppa la 5 tematica proposta in modo rigoroso ed originale Approfondi ta e completa Argomentazione chiara e persuasiva Esposizione fluida e con appropriato registro linguistico Rispetto delle consegne congruo e originale Griglia per la correzione della prima prova Saggio breve/Articolo di giornale CANDIDATO: Grav. Insuff. 1-5 Indicatori Descrittori Insuff. 6-9 Suff. 10 Aderenza e sviluppo della tematica proposta Comprensione dei documenti dati Coerenza e coesione dello sviluppo argomentativo Correttezza e proprietà linguistica Consegne: destinatario, titolo, attualizzazione Totale Punteggio = / 5 Pag. 77 Discreto 11 - 12 Buono 13 - 14 Ottimo 15 DESCRITTORI E INDICATORI DI VALUTAZIONE Tema di attualità CANDIDATO: Indicatori Descrittori Grav. Insuff. 1-5 Insuff. 6-9 Suff. 10 Discreto 11 - 12 Buono 13 - 14 Si attiene alla tematica proposta pur sviluppandola in modo generico Si attiene alla tematica proposta e la sviluppa con una certa articolazione Sviluppa la tematica proposta anche con riferimenti a conoscenze personali Sviluppa la tematica proposta in modo rigoroso e con riflessioni personali Essenziale anche se non ricca Essenziale e completa Sicura ed esauriente Approfondita e documentata Stesura coerente ed equilibrata nelle parti Stesura lineare chiara e persuasiva Esposizione corretta e fluida Esposizione fluida e ricca nel lessico Aderenza e sviluppo della tematica proposta Esclude la tematica proposta Affronta marginalmente la tematica proposta Informazione sui contenuti Scarsa Parziale e approssimativa Coerenza e coesione Frammentaria con evidenti incongruenze logiche Frammentaria e con qualche incongruenza logica Stesura sostanzialmente coerente Correttezza e proprietà linguistica Gravi e diffusi errori morfosintattici, ortografici e lessicali Presenza di errori morfosintattici ortografici e lessicali Accettabile pur con qualche incertezza morfosintattica e lessicale Totale Punteggio = / 4 Pag. 78 Stesura coerente e con un appropriato uso dei connettivi Stesura corretta pur con qualche improprietà linguistica Ottimo 15 Griglia per la correzione della prima prova Tema di attualità CANDIDATO: Grav. Insuff. 1-5 Indicatori Descrittori Insuff. 6-9 Suff. 10 Aderenza e sviluppo della tematica proposta Informazione sui contenuti Coerenza e coesione Correttezza e proprietà linguistica Totale Punteggio = /4 Pag. 79 Discreto 11 - 12 Buono 13 - 14 Ottimo 15 DESCRITTORI E INDICATORI DI VALUTAZIONE Tema storico CANDIDATO: Indi cato ri Desc rittor i Aderenza e sviluppo della tematica proposta Conoscenza dei contenuti Correttezza e proprietà linguistica Contestualizzazione Grav. Insuff . 1-5 Esclude la tematica proposta Insuff. 6-9 Suff. 10 Affronta marginalment e la tematica proposta Discreto 11 - 12 Si attiene alla tematica proposta Si attiene alla tematica proposta e la sviluppa con una certa articolazione Gravi e diffuse lacune Parziale e approssimativ a Essenziale e corretta Essenziale e completa Gravi e diffusi errori morfosintattici , ortografici e lessicali Presenza di errori morfosintattici , ortografici e lessicali Accettabile pur con qualche incertezza morfosintattic a e lessicale Assente o arbitraria Parziale e approssimativ a Parziale, ma pertinente Stesur a corretta pur con qualche improprietà linguistica Completa e pertinente Totale Punteggio = /4 Pag. 80 Buono 13 - 14 Ottimo 15 Sviluppa la tematica proposta anche con riferiment ie conoscenz e personali Sviluppa la tematica proposta in modo rigoroso e con riflessioni critiche Completa e sicura Approfondita, esauriente Esposizion e corretta e fluida Esposizione fluida e con appropriata terminologi a specifica Precisa ed efficace Articolata , precisa e critica Griglia per la correzione della prima prova Tema storico CANDIDATO: Grav. Insuff. 1-5 Indicatori Descrittori Insuff. 6-9 Suff. 10 Aderenza e sviluppo della tematica proposta Conoscenza dei contenuti Correttezza e proprietà linguistica Contestualizzazione Totale Punteggio = /4 Pag. 81 Discreto 11 - 12 Buono 13 - 14 Ottimo 15 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO PROGETTAZIONE A.S. 2013/2014 CLASSE 5° E CANDIDATO INDICATORI PUNTI MAX 1 - Capacità di analizzare, ricercare dati e porli in PUNTI ASSEGNATI 3 relazione tra loro; 2 - Capacita di definire ipotesi progettuali in relazione agli 3 obiettivi e ai dati analizzati; 3 - Capacità di rappresentare graficamente le soluzioni 3 adottate; 4 - Capacità di rappresentare volumetricamente 3 mediante modelli tridimensionali, grafici e plastici; 5 - Capacità di esprimere un prodotto progettuale con 3 creatività ed originalità TOTALI 15 DESCRITTORI PUNTEGGIO Assolutamente insufficiente 1-3 Gravemente insufficiente 4-6 Insufficiente 7-9 Sufficiente 10 Discreto 11-12 Buono 13-14 Ottimo 15 Pag. 82 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA Indicatori Descrittori Sviluppo descrittori Sa individuare le tematiche ed analizza la loro struttura in modo essenziale 1 DISCRETA Individua le tematiche e le conduce in modo autonomo e personale 2 OTTIMA Sa cogliere gli elementi significativi delle tematiche e li organizza in modo originale 3 2 - Capacita di definire SUFFICIENTE Conduce ed 1 ipotesi essenziale Conduce l’elaborato con autonomia e opera scelte caratterizzanti e personali 2 Conduce l’elaborato con note personali,creative e con originalità, servendosi in modo appropriato delle esperienze curricolari Utilizza il linguaggio grafico in modo scolastico, ma corretto da un punto di vista tecnico 3 DISCRETA Utilizza compiutamente il linguaggio grafico con personalità e sicurezza 2 OTTIMA Utilizza in modo sicuro e con interpretazioni personali il linguaggio grafico, dimostrando conoscenze e proprietà esecutive Dimostra di saper visualizzare la tridimensionalità 3 1 - Capacità di analizzare, SUFFICIENTE ricercare dati e porli in relazione tra loro; progettuali relazione agli in obiettivi e DISCRETA ai dati analizzati; OTTIMA 3 - Capacità di SUFFICIENTE rappresentare graficamente le soluzioni adottate; 4 - Capacità di SUFFICIENTE rappresentare elementare 1 1 Dimostra di saper visualizzare con completezza la tridimensionalità dell’oggetto e la descrive con sicurezza 2 OTTIMA Dimostra di saper visualizzare la tridimensionalità dell’oggetto con sicurezza e proprietà di linguaggio e originalità 3 Dimostra di saper esprimere idee personali con essenzialità espressiva 1 Dimostra di saper esprimere idee personali con forza espressiva 2 Dimostra di saper esprimere idee originali innovative e di forte personalità 3 plastici; 5 - Capacità di esprimere SUFFICIENTE un prodotto progettuale creatività modo DISCRETA modelli tridimensionali, grafici e con in dell’oggetto con rappresentazioni convenzionali volumetricamente mediante l’elaborato ed DISCRETA originalità; OTTIMA GRIGLIA VALUTAZIONE TERZA PROVA D’ESAME - Tipologia “B” Classe Disciplina Data Candidato Indicatori Descrittori Livello Non conosce i contenuti richiesti Conoscenze disciplinari Competenza linguisticoespressiva Capacità di elaborazione e sintesi Conoscenza e comprensione degli argomenti proposti Correttezza ed efficacia nell’esposizione, con l’utilizzo del lessico disciplinare Rapporto tra completezza e sintesi, rielaborazione e personalizzazione dei contenuti Conosce e comprende solo una minima parte dei contenuti richiesti Conosce solo parzialmente i contenuti Conosce alcuni contenuti Conosce in modo sufficiente i contenuti, pur con qualche lacuna e imprecisione Conosce e comprende in modo adeguato i contenuti Conosce e comprende in modo approfondito i contenuti Punti 1 2 3 4 5 6 7 Si esprime in modo poco chiaro, con gravi errori formali 1 Si esprime in modo comprensibile, con alcune imprecisioni formali e con limitato uso del lessico specifico 2 Si esprime in modo lineare, pur con qualche lieve imprecisione lessicale 3 Si esprime, usando il lessico specifico, in modo corretto e complessivamente coerente Si esprime con precisione ed uso raffinato del lessico specifico, costruendo un discorso ben articolato Procede senza ordine logico 4 5 1 Analizza gli argomenti richiesti, con una minima rielaborazione 2 Analizza gli argomenti richiesti operando sintesi appropriate anche in modo personale 3 Totale parziale Totale complessivo Pag. 84 1Q 2Q 3Q Anno scolastico 2013/2014 ISTITUTO D’ARTE “N. NANI” sperimentazione “Michelangelo” Documento finale del Consiglio di Classe Classe VE ALLEGATI: testi delle simulazioni di 1a e 3a prova (per le simulazioni di 2^ prova si rimanda alla programmazione delle rispettive discipline) Pag. 85 Pag. 86 Pag. 87 Pag. 88 Pag. 89 Pag. 90 Pag. 91 Pag. 92 Pag. 93 SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO STORIA DELL’ARTE Classe 5E Alunno…………………………………………….data…………………..voto…………………….. 1. Definisci l’estetica del Puntillismo o Neoimpressionismo indicando: le date di sviluppo, il più noto esponente e un’opera che ritieni significativa, gli elementi di novità e superamento dell’Impressionismo. 2. Identifica e descrivi l’opera proposta in relazione alle seguenti voci: autore, titolo, breve lettura iconografica, schema compositivo, scelte cromatiche, stesura del colore, sviluppi su ricerche successive. Pag. 94 3. Come si evolve il linguaggio pittorico di Vincent van Gogh dopo l’arrivo a Parigi? Per rendere la spiegazione più efficace puoi fare riferimento alle opere di tua conoscenza. Pag. 95 SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO STORIA DELL’ARTE Classe 5E Alunno…………………………………………….data…………………..voto…………………….. 1. Come intende l’arte Gustave Courbet? Indica gli elementi fondanti la sua poetica. Fai un breve riferimento alle opere di tua conoscenza. 2. Si indichino le caratteristiche principali che rendono il Futurismo un movimento di rottura rispetto alla tradizione pittorica del tempo. Pag. 96 3. Identifica e descrivi l’opera proposta in relazione alle seguenti voci: autore, titolo, corrente artistica di appartenenza, breve lettura iconografica, rappresentazione dello spazio, scelte cromatiche, eventuali altre riflessioni, pertinenti all’opera, da te proposte. Pag. 97 English written test Surname 1. 5°E 15.04. 2014 Name Describe the painting by Manet called Olympia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. About Modernism write: a. The period when it began and when it flourished b. Names of famous Modernists in the fields of literature, visual arts and music c. What the different Modernists have in common --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pag. 98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. What is “the stream of consciousness” and who were the main representatives of this technique? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag. 99 A.S. 2013/14 – CLASSE VE SIMULAZIONE ESAME DI STATO TERZA PROVA: MATEMATICA tipologia B COGNOME................................................. NOME.......................................... CLASSE 5 SEZ. E x2 1 x2 4 Sia data la funzione reale di variabile reale Rispondi ai seguenti quesiti (puoi utilizzare sia lo spazio sottostante per rispondere, sia il retro di questo y foglio): 1) Determina il campo di esistenza della funzione, le sue intersezioni con gli assi cartesiani, gli intervalli di positività e di negatività della funzione. 2) Calcola i limiti a cui tende la funzione per x tendente agli estremi degli intervalli che costituiscono il suo campo di esistenza. Da essi determina le equazioni degli eventuali asintoti per la funzione e classifica i punti di discontinuità della funzione. 3) Calcola la funzione derivata. Con lo studio del suo segno, determina gli intervalli di crescenza o di decrescenza della funzione e gli eventuali punti di massimo o di minimo. Sul secondo foglio rappresenta il grafico della funzione. Pag. 100 A.S. 2013/14 – CLASSE VE ESAME DI STATO MATERIA: FISICA TIPOLOGIA B SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA CANDIDATO: Rispondi ai seguenti quesiti: 1) Che cos'è l’effetto Joule? Che cos'è e da cosa dipende la potenza dissipata da un resistore? 2) Che cos'è un magnete? Che cosa sono i Poli di un magnete? Perché si chiamano polo Nord e polo Sud? Che cosa succede se due magneti sono posti vicini l'uno all'altro? 3) Fai un confronto tra la forza magnetica tra magneti e la forza elettrica tra cariche, evidenziando le analogie e le differenze. Pag. 101 A.S. 2013/14 – CLASSE VE Simulazione Terza Prova Esame di Stato – Filosofia Lo studente risponda in forma sintetica ai seguenti quesiti, rispettando gli spazi assegnati: Quali sono e come si caratterizzano per Kierkegaard i tre stadi dell'esistenza umana? Quali critiche rivolge Hegel ai Romantici e a Schelling? Pag. 102 Che cos'è la volontà secondo Schopenhauer? Data: Studente: Valutazione: Pag. 103 A.S. 2013/14 – CLASSE VE Simulazione Terza Prova Esame di Stato – Filosofia 1. Opera un confronto tra Kant e Schopenhauer circa i concetti di fenomeno e noumeno 2. Dopo aver contestualizzato l’arte all’interno del Sistema hegeliano, spiegane la funzione Pag. 104 3. Dopo aver spiegato il significato di “Materialismo storico-dialettico” di cui parla Marx, illustra, in particolare, i concetti di struttura e sovrastruttura. Data: Studente: Valutazione: Pag. 105 Verona, 15 Maggio 2014 I Docenti del Consiglio della Classe VE – a.s. 2013-14 Materia Cognome e Nome Ed. fisica Zanderigo Riccardo Esercitazioni di laboratorio Caceffo Stefano Costantini Lina Filosofia Nardi Francesca Fisica Bovo Giuseppe Geometria descrittiva Berruti Claudio Grapulin Roberto Italiano Lanzino Concetta Lingua straniera (inglese) Dusi Elena Matematica Bovo Giuseppe Progettazione Bellintani Giovanna Tonoli Giovanna Religione o mat. Alternativa Corso Giovanna Storia Lanzino Concetta Storia dell'arte Castagna Cristina Pag. 106 Firma
Scarica