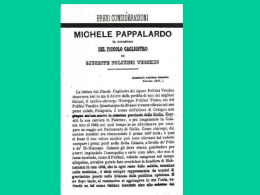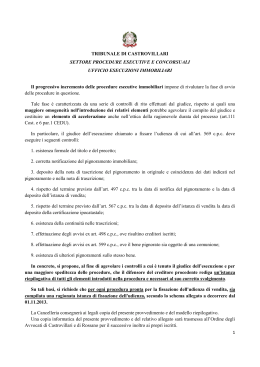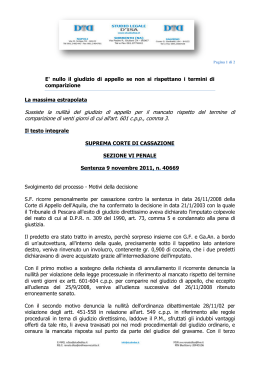CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO RELAZIONE AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DI PRATICA ex art. 7 D.P.R. 101/90 Dr.ssa Anna Pia Esposito Libretto di pratica n. 11493 1 2010-2011 All’Onorevole Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Salerno La sottoscritta Dr.ssa Esposito Anna Pia, nata a Salerno il 23/06/1983 e residente in Nocera Inferiore (SA) alla via Papa Giovanni XXIII n. 47, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da codesto Ordine a partire dal 02/07/2010 con libretto di pratica n. 11493, rassegna la seguente relazione annuale attestante l’effettivo esercizio della pratica forense presso lo studio professionale dell’Avv. D’Emma Rosaria. Lo studio presso il quale svolgo la pratica forense tratta principalmente, ma non esclusivamente, questioni attinenti al diritto del lavoro e previdenziale. La mia attività consiste, nelle ore mattutine, nell’assistenza alle udienze presso il Tribunale e l’Ufficio del Giudice di Pace, alle quali partecipo insieme all’Avvocato stendendo, talvolta, anche il relativo verbale e nello svolgimento dei vari adempimenti presso gli Uffici Giudiziari. Nelle ore pomeridiane, invece, mi dedico alla redazione di atti giudiziari e stragiudiziari, previa consultazione con l’Avvocato e con revisione successiva di quest’ultimo, nonché allo studio delle questioni giuridiche e ricerche giurisprudenziali attraverso la consultazione di manuali di diritto, riviste giuridiche e con l’utilizzo del computer e di internet. In questo primo anno di pratica ho avuto modo, così, di approfondire varie tematiche civili, dagli aspetti tecnici a quelli puri di diritto sostanziale, approfondendo numerose questioni giuridiche e allo stesso tempo di apprendere una corretta formazione professionale, intesa nel duplice senso, del rapporto con i colleghi, improntato ai principi di lealtà ed onestà, e con i clienti fondato sugli imprescindibili criteri di stima e fiducia reciproca. La relazione, così come prescritto dall’art. 7 del D.P.R. 101/90, verte sulle attività indicate nel libretto e consta della descrizione dell’attività svolta in un minimo di 10 udienze, dell’approfondimento di almeno 5 questioni giuridiche e di 5 atti, nonché di una questione di deontologia forense. Con ossequi Salerno, lì 02-07-2011 Dr.ssa Anna Pia Esposito Avv. Rosaria D’Emma 2 QUESTIONI GIURIDICHE: 1. Sul licenziamento disciplinare: nullità per violazione dell’art. 7 L. 300/70 L’inosservanza delle disposizioni impartite dal datore di lavoro può essere sanzionata, secondo quanto previsto dall’art. 2106 c.c., mediante l’irrogazione di speciali pene private, dette sanzioni disciplinari, che il datore di lavoro può applicare in proporzione alla gravità della infrazione e in conformità delle norme dei contratti collettivi. In particolare, le sanzioni previste dai contratti in relazione alle inadempienze (c.d. mancanze) elencate dagli stessi sono: il rimprovero verbale oppure scritto, la multa, la sospensione dal lavoro e della retribuzione, ed il licenziamento extrema ratio. L’art. 7 della L. n. 300/70 (Statuto dei lavoratori) subordina l’esercizio del potere disciplinare alla pubblicazione di un vero e proprio regolamento (c.d. codice) disciplinare da portare a conoscenza dei lavoratori mediante l’affissione in luogo accessibile a tutti. Tale regolamento deve indicare ( in analogia con il principio nulla poena sine lege vigente in materia penale) le sanzioni e le infrazioni applicabili, nonché le procedure di contestazione. La pubblicità è, dunque, elemento costitutivo del potere disciplinare in capo al datore di lavoro, in assenza della quale il potere non può essere esercitato: l’unico mezzo di assolvimento dell’onere della pubblicità è costituito dall’affissione. Alla rilevata rigidità circa la configurazione dell’onere di pubblicità sono collegati gli effetti della scorretta o mancata affissione, di dirompenza tale da determinare la paralisi ex tunc del potere disciplinare, al punto che vien comminata la nullità della sanzione. Nella fattispecie che ha dato l’opportunità di approfondire la questione sub indice, nel momento in cui era stato comminato il licenziamento alla ricorrente, senza che il datore di lavoro avesse previamente sollevato alla stessa le contestazioni, il codice disciplinare non risultava affisso nei locali nei quali dove la ricorrente esercitava l’attività e quindi il procedimento può ritenersi nullo e il licenziamento illegittimo. Lo stesso art. 7 dello Statuto dei lavoratori prevede che nessun provvedimento disciplinare può essere adottato nei confronti del lavoratore senza che gli sia stato preventivamente contestato l’addebito e senza che sia stato sentito a sua difesa. La procedura di contestazione, perciò, deve essere tale da consentire al lavoratore un’effettiva difesa. I provvedimenti più gravi del rimprovero verbale non possono 3 essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione scritta del fatto che ne ha costituito la causa. Il lavoratore al quale sia stata comminata la sanzione ha poi la facoltà di impugnarla entro i venti giorni successivi. La contestazione deve contenere i dati e gli aspetti essenziali del fatto nella sua materialità, in guisa tale che, pur senza una precisa menzione delle norme legali o contrattuali che si assumono violate, sia consentita l’esatta individuazione delle norme legali o contrattuali che si assumono violate, sia consentita l’esatta individuazione della infrazione contestata e del comportamento nel quale il datore di lavoro ravvisa l’addebito disciplinare sanzionato. La Cassazione, in diverse pronunce (Cass. Civ., sez. lav. sentenza n. 16249 del 19/08/2004; Cass. Civ., sez. lav. sentenza n. 11933 del 07/08/2003) ha sancito la nullità e la illegittimità di procedimenti disciplinari ove risultavano omessi o esposti in modo insufficiente i dati e gli aspetti essenziali del fatto in guisa tale che potesse essere consentita l’esatta individuazione della infrazione e del comportamento nel quale veniva ravvisato dal datore di lavoro l’indebito sanzionabile. Una successiva pronuncia della Suprema Corte ( Cass. Civ. sez. lav. sentenza n. 13998 del 30/06/05) ha ribadito che nell’esercizio del potere disciplinare, la contestazione dell’addebito deve avere per oggetto fatti specifici, attesa la funzione di garanzia a tutela del diritto di difesa del lavoratore e anche al fine di porre a base del licenziamento fatti specifici e non più modificabili nel corso ulteriore del procedimento disciplinare o del processo cui da corso l’impugnativa di licenziamento. Inoltre, la contestazione, sempre per agevolare lo “ius defensionis”, deve essere ragionevolmente immediata, ossia deve avvenire in stretta connessione temporale con la condotta posta in essere dal lavoratore (da ultimo ex plurimis Cass. sez. lav. 6/10/05 n. 19424; Cass. Civile sez. lav. sentenza n. 5527 del 18/03/04;Cass. Civ. sez. lav. sen. 17/12/03 n. 30050). L’ art. 7 della L. 300/70 va letto in combinato disposto con l’art. 2119 cod. civ. e con l’art. 3 L. n. 604/66. Per quanto attiene la giusta causa o il giustificato motivo che devono essere prodromici al licenziamento. La Cassazione dà rilievo all’esistenza di una mancanza del dipendente ed impone che detta mancanza debba valutarsi assumendo a parametri: la sua portata oggettiva e soggettiva, il grado di colpa o dolo, le circostanze in cui è stata realizzata, i presupposti e, segnatamente, gli effetti nella prospettiva di far venir meno la fiducia del datore. E’ importante sottolineare che, per esserci giusta causa, il comportamento del lavoratore deve essergli imputabile ed il giudice deve verificare l’intensità del dolo o della colpa; tale valutazione deve avere carattere 4 oggettivo dovendo prescindere dalla soggettiva rappresentazione che ne abbia avuto il datore di lavoro. Peraltro, per il licenziamento per giusta causa, vale anche il principio di proporzionalità della reazione datoriale al fatto addebitato al lavoratore. La formula utilizzata costantemente dalla Cassazione, chiamata a pronunciarsi circa la sussistenza della giusta causa, può sintetizzarsi come segue: il licenziamento è legittimo soltanto se, sulla base di un accertamento condotto con riferimento non già al fatto astrattamente in sè considerato, bensì agli aspetti concreti di esso, risulti che la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo comportamento oggettivo ma anche nella sua portata soggettiva, specie con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui essa è stata posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti ed all’intensità dell’elemento intenzionale dell’agente, risulti idonea a ledere, in modo grave da farla venire meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente e tale quindi da esigere sanzioni non minori di quella massima, definitivamente espulsiva. Come si è già avuto modo di accennare, al licenziamento, come ogni altra sanzione disciplinare, deve essere applicato il principio di proporzionalità contenuto nell’art. 2106 c.c. a norma del quale l’infrazione può essere punita, sussistendone gli estremi, con una sanzione proporzionata in rapporto sia alla gravità in sé del comportamento ritenuto scorretto, sia ad altri elementi da considerare soggettivi ed oggettivi, aggravanti ed esimenti. Peraltro, per consolidata giurisprudenza, proprio in base al principio di proporzionalità, va valutato se i fatti sono destinati ragionevolmente a ripetersi ed in caso di risposta negativa la sanzione deve essere meno grave ed escludersi il licenziamento che è extrema ratio. Il potere disciplinare trovo quindi un limite sostanziale che investe essenzialmente la congruità del provvedimento disciplinare irrogato. Quello della proporzionalità è, dunque, un requisito di legittimità dell’atto datoriale che viene direttamente tipizzato dalla legge con una norma da considerarsi imperativa, inderogabile sul piano individuale e collettivo ed assistita, in caso di violazione, secondo una costante del sistema disciplinare, dalla sanzione “forte” della nullità dell’atto ex. 1418 c.c.. 5 2. Sulle preclusioni e decadenze derivanti dalla non osservanza dei termini ex art. 416 c.p.c., 3°comma e art. 437 c.p.c. Ai sensi dell’art. 414 c.p.c., che disciplina la forma della domanda nelle controversie soggette al rito del lavoro, <<la domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere>>, fra l’altro, <<l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni>> (n. 4) e <<l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione>>. L’art. 416 c.p.c., che disciplina la costituzione del convenuto nelle medesime controversie, dispone, al terzo comma, che il convenuto deve, fra l’altro, <<proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare>>. Le riportate disposizioni (unitamente a quelle che disciplinano singole eccezioni alla regola generale, quali possono definirsi le disposizioni contenute nei commi quinto e settimo dell’art. 420 c.p.c.) compongono il sistema delle preclusioni riguardo all’onere, che la legge attribuisce alle parti, di allegazione di fatti e deduzione di prove. Il quadro rigoroso così delineato, che potrebbe dirsi improntato ad un generale onere delle parti di allegazione e contestazione , com’è noto ammette un contemperamento, attribuendo al giudice di primo grado il potere di disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova (art. 421, secondo comma, c.p.c.). Un tale sistema, così contemperato, condiziona la struttura del giudizio d’appello delle controversie in esame, il quale – in coerenza con l’intento del legislatore del 1973 di attuare nel modo più rigoroso il principio del doppio grado di giurisdizione – è caratterizzato dal divieto di estendere la cognizione del giudice del gravame oltre i limiti oggettivamente fissati nella fase di primo grado, con il conseguente vincolo ad un giudizio <<sulle carte>>, cioè sul materiale probatorio raccolto dal primo giudice, che pure il giudice dell’appello dovrà riesaminare e rivalutare. Tutto ciò si compendia nel divieto di nova, che esclude anzitutto l’ammissibilità di nuove domande ed eccezioni (art. 437, secondo comma, prima parte, c.p.c.), a pena di nullità della sentenza, rilevabile in ogni stato e grado del processo pur in presenza di accettazione del contraddittorio, ma colpisce, di regola, anche le deduzioni probatorie (art. 437, secondo comma, seconda parte, c.p.c.). 6 Testualmente, per la parte che qui interessa, il dettato normativo dispone che <<non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa…>> (art. 437, secondo comma); <<qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, l’udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza…>> (art. 437, terzo comma). La regula juris è quindi: i nuovi mezzi di prova sono preclusi in appello. L’eccezione alla regola riguarda – oltre al giuramento estimatorio – la ammissibilità di nuovi mezzi di prova che il collegio anche d’ufficio ritenga indispensabili, sicché – tenuto conto che il rilievo d’ufficio, formalmente riferito alla valutazione di indispensabilità, è comunque riferibile alla ammissione della prova nel suo complesso – risulta valida l’enunciazione per cui: sono eccezionalmente ammissibili, anche d’ufficio, nuovi mezzi di prova ritenuti dal giudice indispensabili. L’applicazione della regola e dell’eccezione così enunciate implica tuttavia la necessità di alcune definizioni, poiché occorre chiarire: a) cosa si intende per novità; b) quali sono i mezzi di prova di regola inammissibili, se nuovi, ed eccezionalmente ammissibili, se nuovi ma ritenuti indispensabili; c) cosa si intende per indispensabilità. tali principi sono massimati dalla sentenza delle Sezioni Unite 20 aprile 2005 n. 8202 : <<Nel rito del lavoro, in base al combinato disposto degli artt. 416, terzo comma, cod. proc. civ., che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare – onere probatorio gravante anche sull’attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 – e 437, secondo comma, cod. proc. civ., che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova – fra i quali devono annoverarsi anche i documenti -, l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall’evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di 7 riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello. Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse>>. Per la nozione di novum soccorre la definizione usata dalla S.C.(Sezioni Unite) nella citata sentenza n. 8203, relativa al processo ordinario, secondo cui, semplicemente: i mezzi di prova nuovi sono quelli non proposti in primo grado. Mette conto rilevare che l’utilizzazione di una nozione riferita al rito ordinario discende dalla sostanziale sovrapponibilità, in parte qua, dell’art. 437, secondo comma, e dell’art. 345, terzo comma, c.p.c. (salvo che nel primo l’ammissione dei nuovi mezzi di prova può avvenire per l’iniziativa del giudice e l’unico mezzo comunque ammissibile è il giuramento estimatorio, mentre nel secondo l’ammissione può scaturire solo dalla deduzione delle parti e il giuramento comunque deferibile è quello decisorio). E, peraltro, il fatto che la seconda disposizione, come modificata dalla novella del 1990, sia essenzialmente modellata sulla prima, ne consente una utilizzazione a fini puramente interpretativi: per esempio, la precisazione – contenuta nell’art. 345 – che sono ammissibili, oltre a quelli ritenuti indispensabili, nuovi mezzi di prova ove <<la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile>> consente di argomentare che evidentemente anche nel rito speciale i mezzi di prova non deducibili in precedenza siano ammissibili in appello, a prescindere dalla indispensabilità di essi; e se ne può inferire che la nozione di nuovi mezzi di prova, eccezionalmente ammissibili, è evidentemente più ampia di quella che comprende le sole prove sopravvenute o comunque non deducibili in primo grado. Dalla definizione di novum discende, poi, che non possono considerarsi nuovi i mezzi di prova richiesti in primo grado ma esclusi dal giudice con un provvedimento che ne abbia sancito la inammissibilità. In tal caso, è evidente l’estraneità rispetto alla 8 disciplina dell’art. 437, secondo comma, c.p.c., poiché il mezzo di prova dedotto in primo grado ed escluso dal giudice non è, evidentemente, nuovo (secondo l’accezione di <<non proposto in primo grado>>); la sua eventuale introduzione in appello non può realizzarsi attraverso il meccanismo dell’ammissione come nuovo mezzo di prova, ma può conseguirsi mediante l’impugnazione della decisione di primo grado nella parte in cui il mezzo di prova è stato escluso. Così precisato, quindi, il carattere della novità, è ora di valutare quali siano i mezzi di prova cui l’art. 437, secondo comma, c.p.c. riconnette la regola della inammissibilità in appello e, particolarmente, se vi siano compresi i documenti. Occorre subito rilevare che la lettera della legge (art. 437, secondo e terzo comma, c.p.c.) non ammette distinzioni fra <<mezzi di prova>> e <<prova>> (la quale distinzione potrebbe autorizzare teoriche differenziazioni tra prova-mezzo istruttorio e prova-contenuto, nel senso che la preclusione possa eventualmente riguardare solo la prima e non la seconda): il secondo comma dell’art. 437 si riferisce ai <<mezzi di prova>>, il terzo comma prevede che il collegio fissi entro venti giorni l’udienza per l’assunzione delle eventuali <<nuove prove>>. Non su questo, dunque, potrebbe fondarsi l’esclusione dei documenti dal novero dei mezzi di prova inammissibili. Ma mette conto osservare, al riguardo, proprio sotto il profilo teorico, che la prova, in sé, è un fatto che dimostra un altro fatto, giuridicamente rilevante, costitutivo o impeditivo del diritto azionato (contenuto); il mezzo di prova è lo strumento che, secondo determinate modalità di acquisizione (assunzione, esibizione, produzione), serve a rivelare quel fatto nel processo (forma). Quanto al contenuto e al mezzo processuale, può porsi l’equazione tra fatto riferito da testimonianza (o confessato ecc.) e fatto attestato da documento; quanto alle modalità di acquisizione, la prova testimoniale, orale, è assunta, la prova documentale, scritta, è prodotta o esibita. Pertanto, il documento è il mezzo di prova che, acquisito al processo mediante produzione o esibizione, dimostra un fatto costitutivo o impeditivo del diritto azionato. Né muta, tale natura, per il fatto che il documento, quando viene prodotto nel giudizio, sia già formato, senza necessità di alcuna attività ulteriore (c.d. prova costituita): la differenza attiene al tempo di formazione della prova, posto che in un caso la prova è attestata in uno scritto (o in una riproduzione fotografica ecc.), mentre nell’altro essa è riferita oralmente (c.d. prova costituenda). 9 Sotto l’aspetto sistematico, la <<prova documentale>> è contemplata nel capo secondo, titolo secondo (<<delle prove>>), libro sesto del codice civile (<<della tutela dei diritti>>), e comprende: l’atto pubblico, la scrittura privata, le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, le riproduzioni meccaniche, le taglie o tacche di contrassegno, le copie degli atti, gli atti di ricognizione o di rinnovazione; la <<prova testimoniale>> è contemplata nel successivo capo terzo, mentre ai capi successivi seguono le <<presunzioni>>, la <<confessione>>, il <<giuramento>>. La definizione trova riscontro nello stesso codice di rito: l’art. 414, n. 5, c.p.c., sopra ricordato, prevede che il ricorso indichi specificamente <<i mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione>>; l’art. 416, terzo comma, c.p.c. prevede che il convenuto nella memoria costitutiva indichi specificamente <<i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare>>. Con le premesse sistematiche di cui sopra, tali formulazioni indicano in modo chiaro i documenti come species del genus <<mezzi di prova>>; e anche testualmente, peraltro, questo rapporto di specialità, all’interno di un genere comune, è esplicitato dall’espressione <<e in particolare>>. Non pare significativo, infine, che il citato terzo comma dell’art. 437 preveda che le nuove prove eventualmente ammesse vengano <<assunte>> entro un certo termine, tenuto conto, peraltro, che anche il paragrafo secondo della sezione terza, capo secondo, libro secondo del codice di rito (intitolata <<dell’istruzione probatoria>>) è intitolato <<dell’assunzione dei mezzi di prova in generale>>, mentre i successivi paragrafi prevedono le modalità di acquisizione di altri <<mezzi di prova>>, diverse dalla assunzione: stante la indicata, sistematica differenza delle modalità di acquisizione dei diversi, eterogenei mezzi di prova al processo, è ben coerente che, se la nuova prova ammessa in appello è una prova orale, cioè da assumere, la norma (applicativa) indichi le modalità di assunzione; ugualmente, non pare determinante la distinzione lessicale, che si fa derivare dalla ricordata diversità del tempo di formazione della prova e trova qualche riscontro letterale (cfr. art. 184, primo comma, c.p.c.), secondo cui il mezzo di prova <<si ammette>> mentre il documento <<si produce>> (salvo il potere del giudice di valutarne successivamente la rilevanza), atteso che, in definitiva, anche per il documento è comunque necessaria un’attività valutativa del giudice in ordine alla sua introduzione nella realtà del processo. 10 Così definiti gli elementi della regola (cioè individuati i mezzi di prova nuovi che sono di norma inammissibili in appello), occorre ora definire gli elementi dell’eccezione (cioè individuare quali mezzi di prova, di regola inammissibili perché nuovi, possano essere ammessi eccezionalmente nel medesimo giudizio d’appello). Si discute, in primo luogo, se possano essere ammessi, se indispensabili, mezzi di prova preclusi, perché non dedotti rite et recte, ai sensi degli art. 414, 416 e 420 c.p.c., o dai quali la parte sia decaduta per esplicito provvedimento giudiziale. Per coerenza con il sistema sopra delineato, non pare che tali mezzi di prova possano trovare ingresso nel giudizio d’appello, ai sensi dell’art. 437, secondo comma, cit., ancorché indispensabili: il contrario significherebbe ampliare lo jus novorum, e lo stesso potere officioso, senza alcuna limitazione, poiché ogni prova, purché indispensabile, diverrebbe ammissibile sebbene proposta per la prima volta in appello (persino dalla parte rimasta contumace in primo grado), sì che il rapporto fra regola (inammissibilità) ed eccezione (ammissibilità) sarebbe rovesciato e la stessa disciplina in esame avrebbe, in definitiva, una scarsa giustificazione sistematica (essendo equiparabile alla vecchia disciplina del rito ordinario ante novella del 1990) . Appare invece corretto, sotto il profilo sistematico, richiamare al riguardo i limiti del potere d’ufficio del giudice di primo grado, ex art. 421 c.p.c., per inferirne un’analoga delimitazione per il potere officioso del giudice d’appello ex art. 437 c.p.c., nel senso della inammissibilità, comunque, di prove ormai precluse, sebbene considerate indispensabili. In realtà, infatti, il potere d’ufficio del giudice del lavoro è un unicum, che può espletarsi in diversi modi, a seconda della funzione che esso è destinato ad assolvere nell’àmbito del processo, ma con il medesimo limite costituito dalla impossibilità di supplire integralmente all’inerzia della parte: ebbene, i poteri d’ufficio previsti dall’art. 421 c.p.c. sono propriamente poteri istruttori, che intervengono, cioè, ad integrare l’istruttoria nell’àmbito di una fase del giudizio, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine che il giudice, per sua iniziativa, può approfondire; ed è coerente con il sistema che tale potere non comprenda l’ammissione di mezzi di prova ormai preclusi per le parti in causa. Analogamente, il potere riconosciuto dall’art. 437 al giudice d’appello - di ammettere anche d’ufficio nuovi mezzi di prova che egli riconosca indispensabili – è un potere che riguarda direttamente la decisione di secondo grado ma interviene sul materiale probatorio dedotto e acquisito in primo grado, già valutato dal primo giudice, rispetto al quale esso si pone come eccezionale. 11 Rispetto a tale potere, che dunque è funzionalmente analogo, rilevano – quanto a deduzioni probatorie - non soltanto le preclusioni, che si pongano rispetto al giudizio d’appello, ex art. 434 e 436 c.p.c., ma anche quelle già verificatesi nel primo grado, ex art. 414, 416 e 420 c.p.c., atteso che, come s’è visto, il thema decidendum atque probandum deve essere identico nei due gradi di merito. Al di fuori del collegamento con le deduzioni probatorie di primo grado, sussiste, poi, una limitazione esterna, anch’essa di tipo sistematico (dovuta, cioè, a tale necessaria identità), sancita dall’art. 437, secondo comma, prima parte, c.p.c. con il divieto di proporre nuove domande ed eccezioni (cui adde, in base a quanto ricordato riguardo all’onere di contestazione: <<nuove contestazioni>>). Se tale limitazione viene coordinata con l’eccezionale ammissibilità di nuovi mezzi di prova, e si tiene anche conto che le prove sopravvenute sono comunque ammissibili anche se non indispensabili (poiché non deducibili in primo grado), ne deriva che: i nuovi mezzi di prova eccezionalmente ammissibili in appello sono mezzi sopravvenuti ovvero ulteriori rispetto a quelli già ritualmente dedotti in primo grado e devono riguardare fatti allegati e contestati dalle parti nella precedente fase di giudizio. Ciò posto, si deve precisare, quanto alla relazione che deve intercorrere fra il mezzo di prova dedotto in primo grado e quello ulteriore dedotto (o ammesso d’ufficio dal giudice) in grado d’appello, che i diversi mezzi possono essere indifferentemente omogenei od eterogenei. Nel primo caso si avrà la sequenza: deduzione in primo grado di prova scritta → deduzione in appello di diversa prova scritta ovvero: deduzione in primo grado di prova orale → deduzione in appello di diversa prova orale. Nel secondo caso, invece, la sequenza sarà del tipo: deduzione in primo grado di prova scritta → deduzione in appello di prova orale ovvero: deduzione in primo grado di prova orale → deduzione in appello di prova scritta. Infine, occorre definire il requisito della indispensabilità. Poiché il nuovo mezzo di prova, per divenire ammissibile, deve essere indispensabile ai fini della decisione della causa, si ritiene generalmente che debba trattarsi di mezzi non soltanto rilevanti, ma anche necessari per la cognizione di un fatto decisivo: nel senso 12 che il fatto, una volta dimostrato, sia idoneo a fondare l’accoglimento o il rigetto della domanda . Acquisito tale ulteriore segmento, si può pervenire alla seguente definizione riguardo alla ammissibilità di mezzi di prova nuovi in appello: Nel giudizio d’appello delle controversie soggette al rito del lavoro, non sono ammessi, di regola, nuovi mezzi di prova (compresi i documenti), diversi, cioè, da quelli dedotti in primo grado; tuttavia, eccezionalmente, il giudice può ammettere, anche d’ufficio, ove li ritenga decisivi per la definizione della controversia, nuovi mezzi di prova, ulteriori, cioè, ed anche eterogenei, rispetto a quelli dedotti in primo grado a dimostrazione di fatti ritualmente allegati dalle parti. Il primo grand arrêt nella materia in esame, volto a dirimere divergenze giurisprudenziali soprattutto riguardo alle modalità e ai limiti temporali per la produzione di nuovi documenti nel grado d’appello del processo lavoristico, è costituito dalla sentenza delle Sezioni unite 6 settembre 1990 n. 9199, così massimata dall’Ufficio del Massimario della S.C.: <<Nel rito del lavoro, la produzione in appello di nuovi documenti ( che si sottrae al divieto sancito dal secondo comma dell’art. 437 cod. proc. civ.) esige, a pena di decadenza, che essi siano specificamente indicati dalle parti nel ricorso dell’appellante o nella memoria difensiva dell’appellato e depositati contestualmente a questi, a norma degli art. 414 e 416 cod. proc. civ., richiamati dagli art. 434 e 436 dello stesso codice, restando in tal caso i documenti sottratti ad una preventiva valutazione d’indispensabilità e soggetti solo al normale giudizio di rilevanza in sede di decisione della causa. L’operatività della detta decadenza – che dà luogo ad una preclusione rilevabile d’ufficio dal giudice – è esclusa, in base al criterio ricavabile dall’art. 420, quinto comma, cod. proc. civ., con riguardo a documenti sopravvenuti (od anche anteriori la cui produzione sia giustificata dallo sviluppo assunto dalla vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria predetti), ferma, peraltro, in tale ipotesi, la necessità che la produzione dei documenti sia autorizzata dal giudice ed effettuata prima dell’inizio della discussione orale>>. Come risulta dalla massima, la decisione non ha riguardato il tema della ammissibilità, sia pure in via di eccezione e previa la valutazione di indispensabilità, di prove precluse in primo grado. Né alcuna valutazione al riguardo può inferirsi dalla soluzione adottata nel caso concreto (si trattava, nella specie, di documenti - modelli “101” e “740” - prodotti in appello – ma solo all’udienza di discussione - da un datore di lavoro, al fine di provare gli importi retributivi erogati al proprio dipendente, che 13 aveva agito nei suoi confronti deducendo l’inadeguatezza della retribuzione; il giudice d’appello aveva ammesso la produzione in ragione della decisività dei documenti; la S.C. ha cassato con rinvio la decisione – impugnata dal lavoratore – sul presupposto che i documenti non erano stati prodotti tempestivamente, cioè con l’atto introduttivo del giudizio di appello): non giova, in particolare, che la valutazione di indispensabilità del giudice d’appello fosse fondata – a quanto riferisce la narrativa della sentenza delle Sezioni unite – sulla ritenuta idoneità probatoria dei documenti prodotti <<valutati unitamente alle già prodotte buste paga>>, poiché non è stato specificato nella predetta narrativa (e la circostanza, evidentemente, non è stata valorizzata dalle Sezioni unite) se queste ultime fossero state <<già>> prodotte nel giudizio di primo grado o nel ricorso in appello (nel primo caso, i nuovi documenti sarebbero stati ulteriori rispetto a mezzi di prova dedotti in primo grado; nel secondo, si sarebbe trattato di mezzi di prova del tutto svincolati da precedenti deduzioni probatorie). Riguardo alla estensione del divieto di nuove prove, di cui all’art. 437 c.p.c., alla prova documentale, la pronuncia ha invece esplicitamente rimarcato- in linea con l’indirizzo prevalente nella giurisprudenza di legittimità – che il divieto si riferisce solo alle prove costituende, e ciò in base alla considerazione che unicamente per queste ultime è previsto, in generale, un giudizio di ammissibilità e un procedimento di assunzione (cui fa riferimento, in particolare, il terzo comma dell’art. 437 cit.). La sentenza, però, ha inteso precisare che la produzione dei documenti non può essere indiscriminata, ma è soggetta a determinati limiti, nell’àmbito del sistema di preclusioni proprio del giudizio d’appello. Le regole poste sono le seguenti: a) i nuovi documenti di cui le parti intendono avvalersi devono, a pena di decadenza, essere indicati specificamente nei rispettivi atti introduttivi di quel grado di giudizio e depositati contestualmente al deposito di tali atti, rimanendo sottratti ad una preventiva necessitata valutazione di indispensabilità e soggetti soltanto al normale giudizio di rilevanza in sede di decisone della causa; b) la preclusione, che discende dalla prevista decadenza, è rilevabile dal giudice d’ufficio; c) il principio di preclusione può non operare, oltre che in relazione alle nuove esigenze difensive che insorgano a seguito del particolare sviluppo delle vicende processuali (proposizione di appello incidentale, intervento di terzi, esercizio di poteri istruttori d’ufficio), soltanto per la sopravvenienza dei nuovi documenti, che ne giustifichi la 14 produzione dopo il limite temporale in base al criterio ricavabile dall’art. 420, quinto comma, c.p.c.; in tal caso la produzione deve essere autorizzata dal giudice ed eseguita prima dell’inizio della discussione orale, a garanzia della regola del contraddittorio, rimanendo pur sempre riservato in sede di decisione della causa il giudizio circa la loro rilevanza. Le precisazioni contenute nella sentenza delle Sezioni unite del 1990, pur avendo successivamente trovato una generale conferma, quanto alla esclusione dei documenti dal divieto posto dall’art. 437 c.p.c., a volte anche con interpretazioni più permissive in relazione ai termini di deposito nel grado d’appello, non hanno tuttavia evitato la formazione di un indirizzo più restrittivo, nel senso che, per esempio, non può essere prodotto in appello il documento che poteva essere indicato nel ricorso introduttivo di primo grado ovvero che il giudice di primo grado abbia già dichiarato inammissibili per decadenza. Più in generale, alcune pronunce hanno criticato la differenziazione tra prova documentale e altri mezzi di prova, fondata sulla diversità fra prove costituite e prove costituende e tesa al fine di superare le rigide preclusioni del codice di rito in materia di lavoro; altre, che si segnalano per la tendenza, sottolineata nelle premesse di questa trattazione, a ricercare un punto di equilibrio, hanno ritenuto ammissibili i nuovi documenti solo in quanto idonei a valorizzare prove già dedotte in primo grado. Tra le prime, particolare interesse – per la profondità dell’analisi esegetica delle norme e per la ricostruzione sistematica degli istituti - assume la sentenza della Cassazione Civile, Sezione lavoro 20 gennaio 2003 n. 775. La pronuncia, premessa un’ampia ricognizione normativa e giurisprudenziale, anche con specifico riferimento alla sentenza delle Sezioni unite n. 9199 del 1990, valorizza i seguenti dati: a) letteralmente, la locuzione dell’art. 416, terzo comma, c.p.c. <<in particolare>> qualifica i documenti come species del genere costituito dai mezzi di prova; la distinta enunciazione è determinata dal meccanismo della produzione dell’atto, come fatto materialmente precedente rispetto alla richiesta di prova; coerentemente, nella formulazione dell’art. 437, secondo comma, c.p.c. i mezzi di prova, essendo menzionati non come oggetto di una “richiesta di ammissione” bensì come “ammissione”, assorbono e comprendono nel lor spazio anche i documenti; b)sotto il profilo sistematico, l’estinzione – per intervenuta decadenza – del diritto di produrre il documento, derivante dal mancato assolvimento dell’onere previsto dagli art. 414 e 416 c.p.c., è irreversibile e vale ad escludere che il diritto stesso possa poi 15 risorgere in un successivo grado del giudizio: la novità indicata dall’art. 437 cit. è da interpretare nel quadro delle preclusioni e delle deroghe previste dagli art. 416 e 420, per cui, da un lato, la sanzione espressamente prevista in primo grado – quando anche non pronunciata espressamente dal giudice - non si dissolve nel grado successivo e, dall’altro, la eccezionale ammissibilità prevista dall’art. 437 non è dissimile da quella di cui all’art. 421, che è anzi proiezione della prima, nel senso che, come l’art. 421 non consente di ammettere prove in relazione alle quali si sia verificata una decadenza, in egual modo non lo consente la parallela norma dell’art. 437: coerentemente al sistema, la parte che per preclusione o decadenza non poteva dedurre prove, anche documentali, nel corso del giudizio di primo grado non può produrli in appello, neanche se relativi ad eccezioni rilevabili d’ufficio, né il giudice – il cui potere incontra il limite esistente nel primo giudizio ed ininterrottamente protrattosi – può ammetterli d’ufficio. Nel risolvere la controversia al suo esame, la S.C. ha riformato la sentenza d’appello che aveva ammesso la produzione di documenti mai dedotti in primo grado, ritenendoli esclusi dal divieto dell’art. 437 c.p.c. in quanto <<prova costituita>>. Alla cassazione della decisione impugnata è conseguita l’enunciazione del seguente principio: <<L’omessa indicazione nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado (ricorso o comparsa di risposta) dei documenti (anche eventualmente attinenti ad eccezioni rilevabili d’ufficio) o l’omesso deposito degli stessi contestualmente a questo atto (anche ove quivi indicati) determinano la decadenza del processuale diritto di produrre i documenti stessi, ove non si tratti di documenti formatisi dopo l’inizio del predetto giudizio ovvero di documenti la produzione dei quali sia giustificata dallo sviluppo assunto dal giudizio stesso (per l’art. 420 quinto e settimo comma c.p.c.). Poiché questa decadenza esclude la possibilità che i documenti stessi possano dalla parte essere prodotti in appello, e poiché i documenti sono compresi nei nuovi mezzi di prova indicati dall’art. 437, secondo comma, c.p.c., la parte può produrre in secondo grado i documenti solo ove (attraverso la stessa logica dell’art. 420, quinto e settimo comma, c.p.c.) la produzione sia giustificata dal tempo della formazione dei documenti stessi o dallo sviluppo assunto dal processo, e sia dal collegio ritenuta indispensabile per la decisione>>. Una funzione di contrappeso di questa tendenza restrittiva, intesa a riportare il giudizio d’appello nel sistema di preclusioni delineato dal legislatore del 1973, può invece essere assegnato alle pronunce indicate nel primo gruppo come equilibratrici. 16 In realtà, si tratta di decisioni che presuppongono l’esattezza di alcune delimitazioni, e in particolare l’inammissibilità, anche in via eccezionale, di mezzi di prova preclusi, ma, nel contempo, avvertono l’esigenza di un qualche rimedio idoneo all’accertamento della verità materiale, nell’àmbito di un processo in cui sono coinvolti interessi meritevoli di particolare tutela. Questo rimedio riequilibratore è stato individuato nella possibilità, per il giudice d’appello, di esercitare i poteri officiosi di cui all’art. 437 in tutti i casi in cui questi siano diretti al definitivo accertamento di fatti costitutivi (o impeditivi, estintivi ecc.) allegati nel giudizio di primo grado e, se pure in modo incompleto, risultanti da mezzi di prova già dedotti ritualmente in quel giudizio (c.d. piste probatorie o di indagine). Si segnala, per la particolarità della fattispecie, la sentenza 23 maggio 2003 n. 8220 (Cass. Civ. sez. lav.), che ha ritenuto ammissibile la prova testimoniale dedotta per la prima volta in appello in quanto finalizzata ad approfondire le risultanze istruttorie di primo grado, costituite da documenti ritualmente acquisiti agli atti del giudizio di primo grado . Si trattava, nella specie, di accertare il requisito della esposizione a rischio (polveri di cemento) in relazione a domanda di rendita INAIL per malattia professionale (broncopneumopatia) avanzata da un lavoratore: in primo grado la domanda era stata respinta per carenza di prova in ordine a tale requisito; il giudice d’appello, sul presupposto della preesistenza di altri elementi valutativi (fra cui un certificato dell’INAIL attestante l’avvenuta prestazione di attività lavorativa come <<impiantista betonaggio>>), ha ammesso una prova per testi – dedotta per la prima volta in quel grado – relativa alle mansioni espletate dal lavoratore e, sulla base delle relative risultanze (essendo emerso che questi aveva lavorato per sei anni nell’insaccamento e travaso di cemento fuso), aveva accolto la domanda; la S.C. ha respinto il ricorso dell’Istituto, basato sulla violazione dell’art. 437, secondo comma, c.p.c., fondando la propria decisione su queste osservazioni: a) in generale, anche al giudice di appello è riconosciuto il potere di disporre d’ufficio nuovi mezzi di prova, purché questi siano considerati come indispensabili ai fini della decisione della causa e la parte interessata non sia incorsa in decadenza; b) l’operatività di tale ultimo limite, rappresentato dall’avvenuta decadenza della parte, va ulteriormente precisata, nell’ambito di una evidenziata esigenza di contemperamento del principio dispositivo con il principio di ricerca della verità materiale, in particolare nel rito del lavoro e nella materia della previdenza e assistenza, 17 nel senso che, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, occorre che il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere– dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l’incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati nell’atto introduttivo, senza che a ciò sia di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti interessate; c) il potere d’ufficio è diretto a vincere, in relazione alla verifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie, intese come complessivo materiale probatorio (anche documentale) correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado, e non può invece supplire ad una totale carenza di elementi di prova, con la conseguenza che, ove tali elementi siano invece presenti, non si pone, propriamente, alcuna questione di preclusione o decadenza processuale a carico della parte, dato che la prova nuova, disposta d’ufficio, altro non è se non l’approfondimento, ritenuto indispensabile, di elementi probatori che siano già ritualmente acquisiti, e quindi obiettivamente presenti nella realtà del processo. La sentenza n. 8202 del 2005, premessa un’ampia ricostruzione dei variegati orientamenti della giurisprudenza e della dottrina, si ricollega alle esigenze da ultimo sottolineate, quanto alla necessità di rendere compatibili tutela sostanziale e coerenza del sistema processuale. In particolare, la ratio decidendi è fondata essenzialmente sulla circolarità esistente fra gli oneri di prova e l’onere di allegazione e contestazione, siccome delineato, quest’ultimo, dalla nota sentenza delle Sezioni unite n. 761 del 2002 e divenuto ormai cardine del sistema processuale, e cioè, da un lato, riferito sia all’attore che al convenuto e, dall’altro, caratterizzato da una tendenziale irreversibilità (dovendosi fare salvi i casi di contestazione di atti successivi a quelli introduttivi) <<in piena coerenza con la struttura del processo che, nel rito del lavoro, è finalizzata a far sì che all’udienza di discussione la causa giunga delineata in modo compiuto, quanto ad oggetto e ad esigenze istruttorie>>: circolarità che – nell’àmbito di una esigenza di concentrazione e celerità che è espressione della garanzia della ragionevole durata del processo - significa reciproco condizionamento e necessaria correlazione che lega l’attività di deduzione delle prove (attività istruttoria) e quella di introduzione dei relativi fatti da provare (attività assertiva). Con queste premesse sistematiche, la sentenza esclude, coerentemente, un regime diversificato fra prove costituite e prove costituende, considerato peraltro ingiustificato 18 alla stregua della lettera della norma e dello stesso sistema codicistico (che invece configura, secondo le Sezioni unite, un rapporto – fra documenti e mezzi di prova – di species a genus, così come sopra ricordato: cfr. par. n. 3, specie nota n. 9), tanto più in considerazione del fatto che la produzione tardiva di documenti può determinare la protrazione del processo in dipendenza della proposizione di querele di falso e istanze di verificazione e della deduzione di mezzi di prova ulteriori connessi alla documentazione prodotta ex novo. In conclusione, secondo la pronuncia delle Sezioni unite, l’omessa indicazione nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado dei documenti e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall’evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione. E ciò vale anche per la successiva fase di giudizio, posto che l’inosservanza degli oneri correlati al rispetto di termini perentori comporta una preclusione definitiva e irreversibile. Nel contempo, il sistema così delineato non impedisce – per le Sezioni unite – la possibilità di un esercizio dei poteri officiosi del giudice del lavoro, anche d’appello, che funzioni da ammortizzatore per l’eventualità che la predetta verità materiale si allontani da quella emersa nel processo rebus sic stantibus, sempre che le nuove prove, ritenute indispensabili, attengano a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti. Per il perseguimento del quale risultato la sentenza si richiama alla soluzione adottata dalle pronunce – sopra ricordate – aderenti alla teoria delle piste probatorie: <<allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull’onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti>>. La condizione, quindi, per la ammissibilità eccezionale, anche d’ufficio, di prove indispensabili per la dimostrazione (o la negazione) di fatti costitutivi allegati (o contestati) è pur sempre la preesistenza di altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e acquisiti, meritevoli di approfondimento: con esclusione, quindi, dell’ammissibilità dei medesimi mezzi di prova, orale o scritta, che per le parti siano definitivamente preclusi. 19 3. Sulla reintegrazione e il diritto di opzione del lavoratore illegittimamente licenziato (art. 18, 5°co.,L.300/70) Nella sostanza, l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori fa divieto al datore di lavoro, che abbia alle dipendenze della propria azienda più di 15 persone, di licenziare il lavoratore con provvedimento individuale, in mancanza di giusta causa o giustificato motivo: la lettera della legge prevede che, se il datore di lavoro ha intimato il licenziamento, il giudice si pronunci per la reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente, e per il pagamento a questi di un indennizzo pari alle retribuzioni relative al periodo nel quale egli sia rimasto inoccupato, non inferiore comunque al valore di cinque mensilità. E’ ormai pacifico che la revoca di un licenziamento illegittimo da parte del datore di lavoro debba intendersi quale mera offerta la quale, in mancanza di accettazione del lavoratore, non è idonea a rimuovere l’effetto estintivo del rapporto. In particolare la Cassazione,sez.lav, con la sentenza n. 8493 del 13/06/2002, ha così argomentato: “Il diritto del lavoratore illegittimamente licenziato di ottenere, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, l’indennità sostitutiva prevista dal comma quinto dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che configura un’obbligazione con facoltà alternativa dal lato del creditore- deriva dalla illegittimità del licenziamento e sorge contemporaneamente al diritto alla reintegrazione; non è pertanto necessario un ordine giudiziale di reintegrazione per l’esercizio di tale opzione, sicchè il lavoratore può anche inizialmente limitarsi a chiedere in giudizio tale indennità in sostituzione della domanda di reintegrazione, anche nelle ipotesi in cui il licenziamento sia stato revocato dal datore di lavoro e alla revoca non abbia fatto seguito il ripristino del rapporto di lavoro...”. Ne deriva che, poiché la revoca del licenziamento da parte del datore di lavoro si concreta in una proposta contrattuale avente ad oggetto la ricostruzione del rapporto di lavoro, essa non impedisce al prestatore di richiedere, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, l’indennità sostitutiva prevista dall’art. 18, comma quinto, della legge 300/70. Per la giurisprudenza della Cassazione e quella Costituzionale (Corte Cost. Sent. 30 marzo 1992 n. 141) la richiesta del lavoratore illegittimamente licenziato di ottenere, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, l’indennità prevista dall’art. 18, 5° comma, l. n. 300 del 1970, nel testo modificato dall’articolo 1 della legge 11 maggio 20 1990 n. 108, costituisce esercizio di un diritto derivante dall’illegittimità del licenziamento, riconosciuto al lavoratore secondo lo schema dell’obbligazione con facoltà alternativa ex parte creditoris; pertanto, l’obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro facente carico al datore di lavoro si estingue soltanto con il pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegrazione, per la quale abbia optato il lavoratore, non già con la semplice dichiarazione da questi resa di scegliere detta indennità in luogo della reintegrazione e, conseguentemente, il risarcimento del danno, il cui diritto è dalla legge fatto salvo anche nel caso di opzione per la succitata indennità, va commisurato alla retribuzione che sarebbero maturate fino al giorno del pagamento dell’indennità sostitutiva e non fino alla data in cui il lavoratore ha già operato la scelta. (Cass. civ. sez. lav. 16/3/2009 n. 6342). Con la disposizione in esame, ha affermato la Corte, il legislatore ha inteso innegabilmente attribuire all’elemento fiduciario che connota il rapporto, una valenza bidirezionale, nel senso che, la rottura di quel vincolo può essere posta a fondamento per un verso del licenziamento per giusta causa e, per altro verso, del diritto del lavoratore, in luogo del ripristino del rapporto che sia da questo valutato negativamente (per la perdita della reciproca stima, per ostilità ambientale, etc.) all’attribuzione dell’indennità sostitutiva, in conseguenza di un recesso di cui sia accertata l’illegittimità. La revoca del licenziamento e l’invito a riprendere il servizio non possono sottrarre al prestatore il diritto all’indennità sostitutiva il cui esercizio verrebbe altrimenti ad essere rimesso, di fatto, al datore di lavoro. In caso di reintegra nel posto di lavoro, il termine di trenta giorni per la ripresa del servizio (ovvero per la richiesta dell'indennità sostitutiva) da parte del lavoratore decorre, ai sensi dell'art. 18, quinto comma, legge n. 300 del 1970, dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro o dalla comunicazione del deposito della sentenza contenente l'ordine di reintegra. Ne consegue che, ove il datore di lavoro abbia formalmente comunicato l'invito a riprendere il servizio, l'inutile decorso del termine comporta la risoluzione del rapporto, dovendosi considerare insufficiente una generica adesione all'invito da parte del lavoratore non seguita dall'effettiva ripresa dell'attività lavorativa, salvo che ciò non sia stato possibile a causa di forza maggiore o di legittimo impedimento, nel qual caso le circostanze giustificative addotte dal lavoratore medesimo ineriscono non al termine, sospendendolo, ma unicamente all'obbligo del lavoratore subordinato di prestare la sua opera in costanza di rapporto. (Cass. civ. sez. lav. 6/6/2008 n. 15075). 21 Una volta comunicata l'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione il rapporto di lavoro si estingue e il lavoratore non può più pretendere di essere reintegrato nel caso di mancato pagamento delle quindici mensilità, con conseguente cessazione della maturazione delle retribuzioni a titolo di danno. (Corte App. Roma, sez. III, 29/3/2007). In caso di opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione ex art. 18, 5° comma, SL, il momento di effettiva cessazione del rapporto coincide non già con la semplice dichiarazione di scelta, ma soltanto con il pagamento dell'indennità, sicchè il risarcimento del danno complessivamente dovuto al lavoratore va commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate fino al giorno dell'adempimento dell'obbligazione alternativa alla reintegrazione. L'art. 18 della L. n. 300 del 1970, nel testo risultante dalla novellazione introdotta con L. n. 108 del 1990, fa riferimento, nei commi 4 e 5, al medesimo parametro - la "retribuzione globale di fatto" - sia per il risarcimento del danno che per la determinazione dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, ancorchè nel primo caso si risarcisca un danno provocato dal comportamento illegittimo del lavoratore, mentre nel secondo si quantifica un'indennità legata a una scelta del lavoratore. Tanto nell'uno che nell'altro caso per retribuzione globale di fatto deve intendersi quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, a eccezione di quei compensi legati non già all'effettiva presenza in servizio ma solo eventuali e dei quali non vi è prova della certa percezione, nonchè quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione e aventi normalmente carattere indennitario. Nell'ipotesi in cui il lavoratore, licenziato e successivamente reintegrato con provvedimento d'urgenza, non riprende il lavoro nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito in tal senso rivoltogli dal datore di lavoro (ovvero nel diverso termine indicato nel suddetto provvedimento), il rapporto deve ritenersi risolto, con preclusione dell'esercizio di opzione per l'indennità sostitutiva, dovendo la disposizione dell'art. 18, L. n. 300/1970, stabilita per le sentenze che dispongono la reintegrazione, intendendosi analogicamente estesa anche ai provvedimenti cautelari di eguale contenuto, non rilevando in senso contrario, la circostanza che ad essi non sia seguito il giudizio di merito. (L'opzione sostitutiva della reintegrazione formulata dal lavoratore a seguito dell'ordine di reintegrazione emesso dal giudice di primo grado, essendo indissolubilmente legata alla statuizione ex art. 18 SL, non esprime l'indisponibilità del dipendente alla prestazione; conseguentemente il giudice di secondo grado, ove decida di fare applicazione non dell'art. 18 SL ma dei principi di diritto comune, deve 22 comunque disporre la riattivazione del rapporto ed il pagamento delle retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto. Nell’ipotesi in cui non dovesse sussistere in capo all’azienda il requisito dimensionale (più di 15 dipendenti) per il quale trova applicazione l’articolo 18 dello Statuto,. e che consente di richiedere la tutela reale, trova applicazione l’indennità risarcitoria prevista dall’art. 8, legge n. 604/66, come modificato dall’art. 2, legge n. 108/90, che contempla fino ad un massimo di 6,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. 4. Sull’accessione invertita (o occupazione acquisitiva) ex art. 938 c.c. Nella fattispecie concreta, il Sig. Caio, nel conseguire lavori di costruzione sul proprio suolo di un immobile (un albergo), era sconfinato in buona fede sul fondo attiguo del Sig. Tizio. Quest’ultimo, a lavori ormai ultimati, lamentava occupazione abusiva di suolo e addiveniva alle vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, pari ad un danno valutato dal convenuto come non “obiettivo”. La questione giuridica, che mi ha visto interessata, ha avuto ad oggetto l’istituto dell’accessione (occupazione di fondo attiguo) ex art. 938 c.c.. Ai sensi dell’art. 934 c.c. l’accessione viene definita come un modo di acquisto a titolo originario , in base al quale appartiene al proprietario del fondo qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sotto o sopra di esso. Ciò avviene automaticamente e senza la necessità di una manifestazione di volontà del soggetto acquirente. Requisito necessario per l’acquisto della proprietà è la definitiva incorporazione dell’opera al suolo così che il materiale adoperato venga a perdere la propria individualità. Tale acquisto si verifica, in omaggio al principio della prevalenza, sempre a favore del proprietario della cosa principale (accessorium sequitur principale). Nella fattispecie sub indice si configura la cd. accessione invertita che è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario che opera in modo “inverso” a quello dell’accessione ex. art. 934 c.c., e dunque, in deroga alla regola generale secondo cui qualunque costruzione esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo (quod inaedificatur solo cedit). L’art. 938 c.c., infatti, dispone che, qualora si realizzi un edificio occupando parzialmente il fondo confinante altrui, in linea di massima il proprietario del terreno 23 occupato acquista altresì la proprietà di quella parte di costruzione che insiste sul proprio fondo. Tuttavia, in presenza delle condizioni richieste dalla legge, detta regola viene ad essere capovolta: in particolare, a tal fine, occorre che l'occupazione del suolo sia avvenuta in buona fede, che il proprietario del suolo non richieda l'abbattimento dell'edificio entro tre mesi dall'inizio della costruzione e che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, tenuto anche conto delle circostanze, attribuisca la proprietà del suolo occupato al proprietario della costruzione, con efficacia costitutiva. Ciò detto, residuerà comunque,a carico di chi abbia acquisito la proprietà della porzione del fondo altrui, l'obbligo di corrispondere al precedente proprietario un'indennità pari al doppio del valore del terreno stesso. Detta regola, da ultimo, si riferisce esclusivamente alla costruzione di un edificio, cioè di una struttura muraria complessa, e pertanto non può essere invocata con riguardo ad opere diverse, quali un muro di cinta (Cass. Seconda Sez. civ., 10 febbraio 1984, n. 1018). Il legislatore ha, quindi, previsto la possibilità di invertire la direzione in cui solitamente opera l’acquisto per accessione; la finalità principale sottesa a detta norma sarebbe garantire l’interesse generale allo sviluppo delle costruzioni, nonché la tutela della buona fede del costruttore contro l’eventuale comportamento del proprietario del fondo il quale, a costruzione inoltrata o addirittura compiuta, potrebbe agire per reclamarne la demolizione. I presupposti dell’azione ex art. 938 c.c. sono: la costruzione di un edificio – compreso il caso di una scala esterna di accesso all’edificio medesimo –; lo sconfinamento in senso orizzontale; il limite dello sconfinamento ad una ‘porzione’ del fondo attiguo; la mancata opposizione da parte del proprietario del suolo vicino entro tre mesi dall’inizio della costruzione; la buona fede del costruttore. L’accertamento dello stato soggettivo in questione è richiesto per evitare che il vicino-costruttore tragga profitto dalla sua condotta disonesta. La buona fede contemplata dalla disposizione in esame non coincide con quella richiesta per la qualificazione del possesso di buona fede, poiché deve essere provata da chi invoca l’acquisto ex art. 938 c.c.: questa buona fede deve consistere nella ragionevole convinzione – fondata su circostanze univoche ed obiettive – di costruire su suolo proprio o sul quale si abbia comunque diritto di costruire. Tale convinzione può anche discendere dall’ignoranza di sorpassare la linea di confine. 24 Tuttavia, il punto fondamentale della buona fede deve consistere nella convinzione di esercitare una facoltà inerente al diritto di proprietà, cioè nell’opinione di non invadere illegittimamente il suolo del vicino e, di conseguenza, di non ledere il diritto altrui. Numerose sono anche le pronunce giurisprudenziali riscontrate sul requisito della buona fede. A tale proposito, e con riferimento al momento in cui è necessario riscontrare il predetto requisito, si è notato come la Suprema Corte abbia recentemente sovvertito un orientamento sino a quel momento maggioritario. Con questa pronuncia, il Supremo Collegio ha affermato che: “il requisito della buona fede del costruttore, ai fini della declaratoria dell’accessione invertita ex art. 938 c.c., deve sussistere solo nel momento iniziale, in cui nell’effettuare la costruzione di un edificio il costruttore operi inconsapevolmente lo sconfinamento sul fondo altrui, laddove non è richiesto che persista oltre tale momento, né tanto meno fino al completamento dell’opera” (Cass.Civ. 19 agosto 2002, n. 12230). Al contrario, secondo la teoria fatta propria dal precedente orientamento giurisprudenziale, lo stato soggettivo connesso alla buona fede deve sussistere fino al completamento della costruzione non operando l’art. 938 c.c., nel richiedere tale requisito, alcuna distinzione tra l’inizio ed il termine della costruzione. Avuto, poi, riguardo alla mancata opposizione entro tre mesi da parte del confinante, è stato da più parti affermato che la surriferita mancata opposizione non può essere validamente utilizzata per dimostrare lo stato soggettivo di buona fede del soggetto che ha eseguito la costruzione,onerato della relativa positiva dimostrazione. Si è già rilevato che, ai fini probatori, è necessario che il costruttore provi la sussistenza della buona fede e in simili ipotesi si dovrà avere riguardo alla ragionevolezza dell’uomo medio e al convincimento che questi poteva legittimamente formarsi in merito all’esecuzione della costruzione sul proprio suolo e non su quello altrui, in base alle cognizioni possedute effettivamente o che tali debbano presuntivamente ritenersi. Pertanto, la buona fede dovrà essere esclusa allorquando, in relazione alle particolari circostanze del caso concreto, il costruttore avrebbe fin dall’inizio anche solo dubitare della legittimità dell’occupazione del suolo del vicino (Cass. Civ., sez. II, 29 novembre 1993, n. 11836). Da ultimo, ma sempre con riferimento al requisito della buona fede, è opportuno soffermarsi ad analizzare una pronuncia della Corte di Cassazione in virtù della quale la 25 dimostrazione della sussistenza del predetto requisito ha avuto esito negativo a fronte della ex adverso dedotta eccezione di usucapione del bene conteso. Sostanzialmente, nel corso del giudizio di primo grado i giudici avevano escluso la buona fede dei convenuti nell’occupare, con la relativa costruzione, parte del terreno dell’attrice poiché, incombendo a chi invoca l’acquisto della proprietà provare la propria ignoranza dell’altrui titolarità del terreno occupato, tale prova non poteva risultare dal semplice silenzio mantenuto dal proprietario né, soprattutto, dall’aver addirittura dimostrato, avendo dedotto l’usucapione, che sapevano essere l’immobile di pertinenza di parte attrice. Infatti, hanno giustamente osservato i giudici della Suprema Corte, l’usucapione si fonda sul possesso continuato per il tempo legale, esercitato contro il proprietario che trascura l’esercizio dei suoi poteri dominicali. Pertanto, il Supremo Collegio ha riconosciuto non solo che – se si assume di aver posseduto – inevitabilmente si riconosce che colui contro il quale si è esercitato il potere di fatto era il proprietario, ma addirittura che – se si assume di aver posseduto per il tempo necessario ad usucapire – si riconosce altresì che, fin dall’origine, il possesso è stato esercitato contro il proprietario. In conclusione, la Suprema Corte ha statuito che il sostenere, ad un certo momento dell’iter processuale, che si sarebbe venuti a conoscenza della qualità di proprietario di colui contro il quale si è esercitato il possesso solo dopo che si erano verificate le condizioni per l’acquisto di proprietà per accessione invertita, è affermazione contraddittoria con il precedente comportamento processuale. Per completezza si precisa che: 1) secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, il diritto del costruttore ex art. 938 c.c., così come l'applicazione del generale principio di accessione incontra, tra i vari limiti imposti dalla legge (oltreché dal titolo) anche quelli sanciti dalle disposizioni normative in materia di edilizia. Se l'eventuale costruzione, posta in essere sul suolo occupato "abusivamente", è stata edificata in violazione delle leggi in materia di edilizia e degli strumenti urbanistici, in vigore nel territorio ove è ubicato l'immobile, oggetto della vendita, il giudice non applicherà l'articolo 938 c.c., anche in considerazione della facoltà discrezionale che la norma riserva all'organo giudicante (l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato). In materia di limiti al generale principio di accessione e di osservanza delle norme edilizie, posso citare la sentenza n.24679, 26 emessa in data 21 novembre 2006 dalla Corte di Cassazione - II sezione civile, oltre alle sentenze n.21585 del 7 novembre 2005, n.4623 del 27 marzo 2003 e n.7583 del 17 luglio 1999 (anche se non riguardano in particolare, l'istituto dell'accessione invertita, i principi espressi hanno valenza generale e sono applicabili anche alla fattispecie "de quo"). 2) secondo la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, sentenza 20 dicembre 2007 – 27 febbraio 2008, n. 5133, "la buona fede rilevante ai fini dell'accessione invertita (art. 938 c.c.), comunque, consiste nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione in danno del vicino, sicché la mancata opposizione di costui non vale a dimostrare lo stato soggettivo di buona fede dell'occupante, che deve, invece, riguardare le condizioni in cui il costruttore si è trovato ad operare, sì da generare il convincimento di esercitare un suo preteso diritto". E’opportuno ribadire nuovamente che il trasferimento della proprietà del suolo al costruttore non si compie esclusivamente per il fatto della costruzione, ma solo in virtù di una sentenza, mediante la quale il giudice competente deve tenere conto della opportunità di operare il predetto trasferimento. Quando il giudice dichiara il compimento dell’accessione invertita, sorge in capo al proprietario sia un diritto al risarcimento dei danni subiti, sia un diritto al pagamento di una indennità pari al doppio del valore del suolo occupato al momento della liquidazione. Il fatto che sorga un diritto al risarcimento dei danni verificatisi è logica conseguenza dell’occupazione e non una condizione dell’acquisto; al contrario deve dirsi per quanto riguarda il pagamento dell’indennità, la quale si configura come una vera condizione del trasferimento coattivo. L’indennità costituisce debito di valore e non di valuta. Il corrispettivo dell’accessione invertita ex articolo 938 c.c., deve essere determinato con criterio obiettivo, tenendo conto soltanto del valore che il suolo occupato ha di per sé, in virtù della sua natura, della sua conformazione e delle sue caratteristiche in genere, indipendentemente dalla diversa e maggiore utilità che, per destinazione ad essa data, possa averne tratto il costruttore rispetto a quella che avrebbe potuto trarne il proprietario ( Cass. Civ., sez. II, 6/6/89 n. 2748). L’azione per ottenere l’indennità ed il risarcimento dei danni è di carattere personale e deve essere proposta contro il costruttore e non eventualmente anche contro i successivi acquirenti dell’immobile. La domanda per il risarcimento del danno è 27 domanda autonoma rispetto al pagamento del doppio del valore del suolo; ai fini della competenza per valore le due domande si sommano secondo il disposto dell’art. 10 c.p.c.. 5. Sulla responsabilità contrattuale del mandatario. La questione giuridica sulla quale mi sono attardata trova origine nel caso che ha riguardato la Sig.ra Caia, beneficiaria dei contributi per la ristrutturazione dei fabbricati post terremoto ex legge 219/81, la quale, in concomitanza con la presentazione dell’istanza e della documentazione all’Ente preposto, nominava l’Ing. Tizio “delegato alla riscossione”. Costui illegittimamente tratteneva il contributo governativo dovuto alla Sig. Caia la quale adiva le vie legali. La fattispecie rientra nella figura giuridica del mandato. Il mandato, così come definito dall’art. 1703 c.c., è il contratto con il quale un soggetto si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di altri. Il contenuto dell’attività a cui il mandatario si obbliga, che è il compimento di atti giuridici, può essere il più vario. Il mandato è con rappresentanza o senza rappresentanza, secondo che il mandatario abbia o no il potere di impegnare il mandante spendendo il suo nome. Il potere di rappresentanza però non ha la sua fonte nel mandato, che, essendo un contratto, ha effetti diretti limitati alle parti, e dal quale deriva appunto l’obbligo del mandatario verso il mandante. La rappresentanza presuppone una procura esplicita o anche soltanto implicita. Il mandatario deve agire secondo l’incarico accettato: se questo è con rappresentanza il mandatario agirà in nome del dominus (contemplatio domini), altrimenti agirà in nome proprio. Se il mandato è senza rappresentanza si stabiliscono rapporti diretti tra il mandatario e il terzo, e non ttra il mandante e il terzo. Il mandante è in rapporto con il mandatario, il mandatario nei confronti del terzo assume in proprio gli obblighi ed acquista in proprio i diritti che derivano dall’affare trattato per conto del mandante. Al mandante devono pio essere devoluti i risultati del negozio compiuto per suo conto dal mandatario. 28 Il mandante, anche se i terzi non hanno conosciuto l’esistenza del mandato, ha diritto di far valere in via diretta verso di loro i diritti di credito sorti in virtù del negozio di gestione, cioè nell’esecuzione del mandato. Il mandato è speciale o generale, secondo che sia conferito per il compimento di singoli atti o per tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Esso è un contratto consensuale che si perfeziona con il semplice accordo delle parti. Ed è obbligatorio perché dà origine soltanto a rapporti personali. Il mandato si estingue, oltre che per cause generali, come la scadenza del termine o il compimento dell’affare per cui fu concepito, anche per la revoca del mandante o per rinunzia del mandatario. Grava sul mandatario l’obbligo di compiere gli atti giuridici previsti dal contratto con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 cod. civ.), con quella diligenza, cioè, che è lecito attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza e accortezza, memore dei propri impegni, cosciente delle relative responsabilità (Cass. Civ., sez. III, n. 19778 del 2003). La relativa responsabilità è, quindi, contrattuale e l’azione si prescrive in dieci anni. In sostanza quindi, è sulla scorta di tale criterio, di generale applicazione in tema di adempimento delle obbligazioni (art. 1176 cod. civ.), che deve valutarsi la condotta del mandatario, onde stabilire se egli sia venuto meno alle sue obbligazioni nei confronti del mandante (Cass. ult cit.). Nei confronti di eventuali terzi, estranei al rapporto, tra cui anche l’altra parte coinvolta nell’affare che tuttavia non ha dato alcun incarico, il mandatario risponderà a titolo extracontrattuale, secondo il principio generale del naeminem laedere di cui all’art. 2043 del c.c.. Secondo la Relazione al codice civile la diligenza consiste in “quel complesso di cure e di cautele che il debitore deve impiegare per soddisfare la propria obbligazione”. Il criterio della diligenza esprime un modello ideale di comportamento a cui il debitore deve uniformarsi nell'adempiere l'obbligazione. Tale modello viene ricostruito avendo riguardo all'uomo medio (bonus pater familias): la diligenza del buon padre di famiglia, precisa la dottrina, non è un criterio statistico, bensì deontologico. In realtà, non si tratta di un'unica figura indifferenziata, bensì di una serie di diversi modelli ideali che vengono determinati in riferimento, per lo più, all'attività svolta dai singoli soggetti coinvolti: il buon banchiere, il buon costruttore, il buon professionista, il buon automobilista, etc. Ogni modello impone il proprio standard; attraverso tale modello, la regola della diligenza trova la sua 29 concretizzazione. Dicendo che il debitore “nell'adempiere l'obbligazione deve usare la diligenza del buon padre di famiglia”, si intende che il debitore è obbligato ad osservare una condotta conforme allo standard di riferimento. Pena l'inadempimento e, al tempo stesso, la colpa. La diligenza svolge, infatti, più di un ruolo nell'area della responsabilità contrattuale: essa è criterio di determinazione delle modalità della prestazione, criterio di imputazione dell'inadempimento e criterio di imputazione dell'impossibilità della prestazione. La regola della diligenza riguarda, anzitutto, il giudizio sull'adempimento del debitore. L'adempimento è l'esatta esecuzione della prestazione: “l'esattezza della prestazione deve essere valutata rispetto a diversi criteri, che sono (a) le modalità della esecuzione, (b) il tempo dell'esecuzione, (c) il luogo dell'esecuzione, (d) la persona che esegue la prestazione, (e) la persona destinataria della prestazione, (f) l'identità della prestazione”. Per valutare se la prestazione del debitore sia stata esattamente eseguita (in specie, sotto il profilo qualitativo), è necessario fare riferimento al criterio della diligenza: l'esecuzione non diligente di una prestazione equivale ad inadempimento. Ciò vale, in particolare, con riguardo alle obbligazioni di mezzi, ove “il giudizio sull'inadempimento per definizione fa corpo con l'agire negligente, essendo per contrapposto l'agire diligente la materia dell'obbligazione”: l'adempimento presuppone l'osservanza della diligenza prescritta dall'art. 1176 c.c.; così come, per contro, l'inosservanza della diligenza prescritta dall'art. 1176 c.c. determina l'inadempimento. Ciò è confermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità del medico, del notaio, dell'avvocato, del mandatario professionista, dell'agente di assicurazione, della banca, etc.: “in queste obbligazioni [si intende, di mezzi] in cui l'oggetto è l'attività, l'inadempimento coincide con il difetto di diligenza nell'esecuzione della prestazione” (Cass. civ., Sez. III, 09/11/2006, n.23918); “la diligenza assume nella fattispecie un duplice significato: parametro di imputazione del mancato adempimento e criterio di determinazione del contenuto dell'obbligazione” (Cass. civ., Sez. III, 13/01/2005, n.583). La diligenza è criterio di determinazione della prestazione anche in relazione alle obbligazioni di risultato: “con riguardo all'obbligazione dell'appaltatore, ad es., (...) l'esattezza della prestazione deve infatti essere pur sempre verificata alla stregua dell'adeguato sforzo tecnico e dei risultati che normalmente si realizzino con l'impiego di tale sforzo: si giudicherà allora, tra l'altro, se l'opera sia stata eseguita a regola d'arte”. Poniamo ad esempio che l'attore-creditore lamenti un'inesatta esecuzione della 30 prestazione per mancato rispetto delle regole c.d. dell'arte; se il debitore-convenuto fornisce la prova in giudizio della sua diligenza, ovviamente, egli non sarà tenuto a risarcire danno alcuno, poichè ha provato l'adempimento, fatto estintivo dell'obbligazione. La diligenza rappresenta altresì criterio di imputazione dell'inadempimento al debitore. L'inosservanza della diligenza, infatti, costituisce colpa: se il debitore tiene una condotta difforme da quella imposta dall'ordinamento attraverso la regola della diligenza, egli versa in colpa. Il giudizio di colpevolezza consiste nella difformità della condotta da un modello ideale di riferimento. Il primo comma dell'art. 1176 c.c. prende in considerazione le prestazioni non tecniche, prevedendo che il criterio normale della colpevolezza è quello della negligenza; il secondo prende in considerazione le prestazioni tecniche, stabilendo che, in questo caso, la misura della colpa deve essere desunta dalle regole dell'arte: il riferimento è pertanto all'imperizia. In base all'art. 1218 c.c., il debitore “è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Sulla nozione di causa non imputabile non esiste una definizione legislativa, nè identità di vedute negli interpreti. La giurisprudenza utilizza il criterio della diligenza per valutare se la causa che ha determinato l'impossibilità della prestazione debba essere imputata al debitore, oppure no: la causa non è imputabile quando è imprevedibile o, quantomeno, inevitabile da parte del debitore; in quest'ottica, l'imprevedibilità e l'inevitabilità sono intesi come endiadi designanti complessivamente la mancanza di colpa. La diligenza, quindi, rappresenta il criterio per la valutazione del comportamento del debitore in relazione alla sopravvenuta impossibilità della prestazione (cioè, in ultima analisi, per la decisione in ordine alla sussistenza della responsabilità dell'obbligato oppure no). 31 N. 10 Udienze: 1) e 2) Udienze del 5/10/2010 e del 27/01/2011;Tribunale ordinario di Salerno sez. Lavoro Dott.ssa Sabbato Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio la società Alfa srl presso la quale aveva prestato lavoro subordinato. Per un periodo la ricorrente aveva lavorato in nero, senza cioè che il datore regolarizzasse la sua posizione contributiva. Solo successivamente veniva assunta formalmente con le mansioni di operai e con inquadramento nel V livello del C.C.N.L. per gli addetti al settore alimentari. La ricorrente, invero, dall’assunzione e fino alla data del licenziamento, pur essendo stata formalmente inquadrata nel V livello, ha espletato mansioni superiori, riconducibili al III livello del CCNL richiamato. La ricorrente adiva dunque le vie legali per ottenere accertamento e dichiarazione che la stessa aveva prestato lavoro subordinato alle dipendenze dalla società resistente, senza soluzione di continuità fino all’avvenuto licenziamento; che fosse accertato e dichiarato che la stessa aveva svolto mansioni superiori a quelle previste dal livello nel quale era formalmente inquadrata. Chiedeva dunque la condanna della resistente al pagamento di tutte le differenze retributive maturate dall’assunzione e fino al licenziamento. Nel corso dell’udienza del 5/10/2010, la ricorrente in veste del suo avvocato chiedeva escutersi i testi presenti e già indicati nelle richieste istruttorie. Al termine della prova testimoniale, si chiedeva al Giudice un rinvio per la nomina del CTU. Nella successiva 32 udienza del 27/01/2011 gli Avvocati della ricorrente chiedono si proceda alla nomina del CTU. La resistente riportandosi ai propri scritti difensivi faceva notare che la resistente con lettera del 14/03/2008, inviata alla CONFLAVORATORI, richiedeva una somma diversa e minore rispetto a quelle in corso di causa per le differenze retributive. La ricorrente impugnava e contestava quanto dedotto, perché fatto, per altro, tardivamente. Il Giudice rinviava per esame ed eventuale nomina CTU. 3) Udienza del 9/02/2011 Tribunale Ordinario Salerno Sez. Lavoro Dott. Cavaliero Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato alle parti, la ricorrente conveniva in giudizio la dott.ssa Tizia socia della società Gamma srl (restata poi inattiva dal 2005) alle dipendenze della quale aveva lavorato dal 2001 al 2008,e la società Beta s.r.l (di cui la dott.ssa Tizia ne diventava socia) alle dipendenze della quale era stata formalmente assunta con contratto di apprendistato dal 2005 al 2008, espletando per l’intera durata del rapporto le mansioni di estetista professionista. Nell’anno 2008 la ricorrente subiva licenziamento illegittimo. La resistente società Beta srl affermava che la ricorrente sarebbe stata assunta nel marzo 2005 con la qualifica di apprendista estetista e per il conseguimento della qualifica di estetista. Nella comunicazione inoltrata dalla società alla Regione Campania all’esito del licenziamento della ricorrente, quale motivo della cessazione del rapporto di apprendistato, la società adduce licenziamento per giusta causa. In realtà, a differenza di quanto dichiarato agli Enti preposti, nella memoria difensiva sostiene altro e cioè che il rapporto di apprendistato è stato anticipatamente risolto perché la ricorrente aveva conseguito le capacità per diventare lavoratore qualificato. Il CCNL di riferimento, all’art. 46, comma 8, definisce la durata “normale” e non “massima”dell’apprendistato in 60 mesi (5 anni). Nell’udienza i legali della ricorrente chiedono escutersi i testi comparsi. Essendo emersa, nel corso della prova testimoniale, la necessità di citare come teste, ai fini di giustizia, la Sig.ra Sempronia, ne fanno formale richiesta al Giudice, sollecitandone i poteri istruttori anche in considerazione delle risultanze istruttorie. L’ Avvocato della resistente impugnava quanto dedotto . 33 Il Giudice, rilevava che detta richiesta poteva trovare una sua proposizione solo ai sensi dell’art. 421 c.p.c. e previa indicazione dei capi di prova su cui dovrebbe vertere la prova testimoniale. Per questi motivi si riservava e rinviava in prosieguo di prova. 4) e 5) Udienze del 01/02/2011 e del 22/04/2011 Ufficio del Giudice di Pace di Salerno: Dott. Torre Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. Tizio conveniva in giudizio Caio Mevio srl in persona del legale rappresentante e l’ AXA Assicurazioni Spa. Il giorno 31.01.2007 l’automezzo targato XXXXXX, di proprietà del Sig. Caio Mevio srl, nel percorrere ad alta velocità la strada statale 163 per Amalfi, andava violentemente ad incastrarsi sotto il balcone prospiciente l’abitazione del ricorrente. A seguito del forte urto, il balcone dell’abitazione di proprietà del Sig. Tizio riportava ingenti danni per il cui risanamento si renderà necessario l’esborso di euro 3.000,00 come da preventivo che viene allegato all’atto di citazione. Si chiedeva quindi al Giudice la condanna dei convenuti al pagamento di tale somma in qualità di risarcimento del danno. Nel corso dell’udienza del 01/02/2011 comparivano gli avvocati dell’attore, mentre le parti convenute, come dall’inizio del giudizio, rimanevano contumaciali. Come da richiesta fatta in precedente udienza, era presente anche il CTU nominato dal Giudice, il quale presentava dichiarazione di accettazione dell’incarico e prestava giuramento. Il Giudice procedeva ad elencare i quesiti. Il CTU fissava l’inizio delle operazioni peritali per il giorno 07/02/2011, ore 15,00 sul luogo teatro del sinistro. A questo punto il Giudice concedeva giorni 60 per il deposito della CTU. Disponeva inoltre la cifra di euro 350,00 da intendersi quale acconto e saldo da versare all’inizio dei lavori peritali e rinviava la causa. Nella successiva udienza del 22/05/2011 compariva l’attore mentre i convenuti rimanevano contumaciali. L’attore si riportava alle conclusioni già rassegante e impugnava la CTU in quanto stimava un danno inferiore a quello che risultava da preventivo allegato all’atto di citazione. Si chiedeva poi che la causa fosse decisa con vittoria di spese. Il Giudice, valutata la contumacia dei convenuti,riteneva opportuno rinviare ad udienza successiva per conclusioni e discussione. 34 6) Udienza del 31/03/2011 Tribunale Ordinario di Salerno Sez. Lavoro Dott.ssa Viva Con ricorso ex art. 414 c.p.c , ritualmente notificato, la ricorrente Sig. Sempronia chiamava in causa la Sig. Caia, sua datrice di lavoro. La ricorrente aveva prestato lavoro subordinato alle dipendenze della ricorrente, presso l’abitazione di quest’ultima. Il rapporto di lavoro subordinato, iniziato nel settembre del 2003 si era risolto nel novembre del 2007. Lo stesso intercorso rapporto di lavoro non era mai stato denunciato ai fini della regolarizzazione contributiva ed assicurativa e la datrice non rilasciava buste o prospetti paga. La ricorrente aveva svolto mansioni di baby-sitter e quindi la stessa risultava inquadrabile nella seconda categoria del CCNL per i collaboratori familiari (lavoro domestico). Durante tutto l’intercorso lavoro, la ricorrente percepiva la somma di euro 3,84 all’ora, anziché quella contrattualmente stabilità e pari ad euro 4,46. Non percepiva la tredicesima mensilità, non godeva di giorni di ferie e non ha percepito la dovuta indennità sostitutiva né TFR. L’udienza sub indice vedeva il Giudice Unico in funzione di Giudice del lavoro dott.ssa Viva procedere all’escussione dei testi sia di parte ricorrente sia di parte resistente. La prova testimoniale, come da richieste istruttorie di parte ricorrente, mirava ad accertare, ai fini di legge, l’esistenza del rapporto di lavoro tra parte le parti in causa e la non sufficiente e proporzionata retribuzione. Durante la prova testimoniale il Giudice, nonostante la prodromica lettura della formula di impegno di uno dei testi di parte ricorrente, è costretto ad ammonire nuovamente il teste sulle conseguenze penali delle dichiarazioni falese e reticenti. Conclusa la prova testimoniale, il Giudice chiede e suggerisce alle parti, personalmente presenti in udienza, assistite dai rispettivi avvocati, di considerare l’ipotesi di un accordo. Il giudice concedeva quindi alle parti alcuni minuti perché le stesse, congiuntamente, potessero valutare la proposta. Le stesse, nell’intercorsa udienza, accogliendo la sollecitazione del magistrato, raggiungono un accordo includente anche la somma retributiva spettante alla Sig.ra Sempronia. Viene così compilato verbale di conciliazione e il Giudice autorizza il ritiro di produzione di parte. 7) e 8) Udienza del 25/11/2010 e Udienza del 18/02/2011 Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Dott. Ruggiero 35 La causa, instauratasi innanzi al Giudice Unico in funzione di Giudice del lavoro, aveva inizio con rituale ricorso ex. art. 414 c.p.c, notificato alla resistente ed avente ad oggetto impugnativa di licenziamento e differenze retributive. Il ricorrente Sig. Tizio lamenta, nel ricorso, l’illegittimità del recesso, revocato poi dalla Società Beta, datrice di lavoro, e il mancato adempimento, da parte di quest’ultima, dell’obbligazione alternativa (risarcimento del danno ex. art. 18, comma 5°, legge 300/70) richiesta dal ricorrente, in sostituzione della reintegra nel posto di lavoro. Nel corso dell’udienza del 25/11/2010 le parti chiedono al Giudice un rinvio per discussione con note difensive. Il Giudice, essendoci contestazione del quantum, sollecita le parti ad un’eventuale nomina di CTU per l’indagine peritale. Il Giudice concede poi termine fino a 10 gg. prima per il deposito di note difensive ed autorizza il ritiro delle rispettive produzioni, rinviando l’udienza al 18/02/2011. Nel corso di tale udienza le parti si riportano integralmente alle rispettive note difensive depositate nei termini di legge. La parte ricorrente, assistita dal mio dominus, chiede altresì la nomina del CTU. La parte resistente invece chiede che la causa venga rimessa in decisione. Il Giudice del lavoro, rilevato che si appalesa la necessità di procedere ad un’indagine peritale, nomina CTU Dott. XXXX e rinvia la causa. 9) Udienza del 17/11/2010 Tribunale Ordinario di Salerno Sez. Civile Dott.ssa Di Stasi Nel 2007 la Sig.ra Caia citava in giudizio, con atto ritualmente notificato, l’Ing. Sig. Sempronio. L’attrice, proprietaria di un immobile, partecipava alla ricostruzione del fabbricato ex legge 219/81, in uno con i signori Tizio, Mevia e Orazio. In concomitanza con la presentazione dell’istanza e della documentazione all’Ente preposto per l’attribuzione del contributo spettante ai fabbricati terremotati, veniva conferito, dai condomini dello stabile, all’Ing la funzione di delegato alla riscossione dei contributi. Il contributo totale stanziato per l’attrice ammonta a euro 5.076,06. Il perceptum ammonta ad euro 2.436,00 liquidato dall’Ente tramite il delegato Ing. Sempronio. Ai fatti l’attrice risulta essere creditrice della restante somma pari ad euro 2.640,06 che l’Ing. Sempronio illegittimamente trattiene. Si rendeva in seguito necessario chiamare in causa il Comune di Baronissi (Ente debitore del contributo ex. legge 219/81) e la Sig.ra Mevia, comproprietaria dell’immobile, aveva revocato formalmente, a suo tempo, e per sé 36 soltanto, all’Ing. Sempronio la delega a riscuotere il contributo. L’Ente, aveva poi disposto con delibera nel 2004 la riscossione a firma congiunta della Sig.ra Mevia e dell’Ing. Sempronio, quest’ultimo in qualità di delegato delle restanti proprietà tra cui l’erede Sig.ra Caia. Ma della somma riscossa all’attrice nulla è stato riconosciuto dell’Ingegnere. Nel corso dell’odierna udienza di trattazione della causa ex art. 183 c.p.c. , alla quale la sottoscritta ha preso parte, l’Avvocato di parte attrice, ovverosia il mio dominus, esibiva e contestava note alla Ctu della quale era stata fatta richiesta nella precedente udienza per valutare l’effettivo valore a cui ammonta il contributo. Di tali note ne dava copia alla controparte Sig.ra Mevia rappresentata dal suo Avvocato. Quest’ultimo depositava foglio di deduzione contenente osservazioni alla CTU Mentre il convenuto Comune di Baronissi e l’Ingegnere restavano contumaciali. Il Giudice fissava rinvio dell’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ex. art. 184 c.p.c. 10) Udienza del 16/11/ 2010 Corte di Appello di Salerno Dott.ssa Giancaspro In primo grado erano state emesse due sentenze: l’una dichiarativa del diritto in base alla quale veniva attribuita la proprietà dell’edificio e del suolo occupato al costruttore Sig. Caio, che nel conseguire lavori di costruzione sul proprio suolo di un immobile (un albergo), era sconfinato in buona fede sul fondo attiguo del Sig. Tizio; l’altra sentenza stabiliva la quantificazione del doppio del valore della superficie occupata e il risarcimento del danno che il costruttore era tenuto a pagare al proprietario del suolo. Il Sig. Ciao promuoveva appello per contestare la sentenza di quantificazione di primo grado. Nel corso dell’udienza del 16/11/2010 l’appellante, riportandosi alla valutazione del CTU, in precedente udienza nominato, ribadiva che il corrispettivo dell’accessione invertita ex articolo 938 c.c., deve essere determinato con criterio obiettivo, tenendo conto soltanto del valore che il suolo occupato ha di per sé, in virtù della sua natura, della sua conformazione e delle sue caratteristiche in genere, indipendentemente dalla diversa e maggiore utilità che, per destinazione ad essa data, possa averne tratto il costruttore rispetto a quella che avrebbe potuto trarne il proprietario. Chiedeva dunque che la causa fosse rimessa in decisione. Parte appellata, invece, si opponeva alla CTU ritenendo che non si trattasse di accessione invertita ex. art. 938 c.c. bensì di occupazione abusiva di suolo, con carenza di buona fede (che pure, invece, era già stata 37 confermata dalla sentenza di primo grado), e pertanto chiedeva risarcimento danni ex. art. 2043 (cioè per fatto illecito). Il Giudice, dopo il contraddittorio tra le parti, rimette la causa in decisione. Questione di Deontologia Forense: Il dovere di diligenza per il professionista forense. Il Codice deontologico forense, e precisamente con l' articolo 8 (Dovere di diligenzaL'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza) , impone agli avvocati di adempiere i propri doveri professionali con diligenza. Pertanto, in questa prospettiva la diligenza che l'avvocato deve utilizzare per lo svolgimento della propria attività professionale coincide con quella ordinaria ovvero con quel grado di attenzione medio nei confronti del cliente. L'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 codice civile, in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. Pertanto, l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine – positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire – circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo. Cassazione civile, sezione II, 11 agosto 2005, n. 16846. La responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell'articolo 1176, comma 2, codice civile; tale violazione, ove consista nell'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è esclusa né ridotta per la circostanza che l'adozione di tali mezzi sia stata sollecitata dal cliente stesso, essendo compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale. (Enunciando il principio 38 di cui in massima, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva accertato la responsabilità professionale dell'avvocato per avere questi proposto una domanda di risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dinanzi ad un giudice diverso da quello che aveva deciso la causa di merito, così esponendo il cliente alla soccombenza nelle spese). Cassazione civile, sezione II , 28 ottobre 2004, n. 20869 . Si può ritenere di individuare nella norma contenuta nell' articolo 1176 codice civile una specificazione del principio generale espresso nell'articolo 8 del Codice deontologico forense. Di conseguenza, quest'ultimo va interpretato proprio sulla base della formula generale contenuta nel codice civile (art. 1176). Solo per fare degli esempi, l'omessa iscrizione a ruolo di una causa civile oppure l'omessa redazione di una comparsa di costituzione e risposta costituiscono delle chiare applicazioni pratiche di violazioni al dovere di diligenza prescritto dall'articolo 8 del C.D.F. Tuttavia, mio modesto parere, il giudizio di diligenza per l'attività giudiziale deve tener conto che, di norma, l'obbligazione del professionista forense è soltanto di mezzi e non di risultato. La responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata. Inoltre, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente (nella specie, del giudizio di appello), il danno derivante da eventuali sue omissioni (nella specie, redazione e notifica di un atto d'appello privo dell'indispensabile indicazione della data di udienza di comparizione) in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici. Infatti, proprio sulla base di questa importante premessa, non si può desumerne la violazione per il mancato raggiungimento del risultato, qualora l'avvocato abbia adempiuto alla propria obbligazione professionale con la diligenza media esigibile . Non c'è alcun dubbio che l'avvocato, per le prestazioni giudiziali, assuma un'obbligazione di mezzi, poiché si impegna a mettere a disposizione del proprio cliente le sue conoscenze. Di conseguenza, il professionista forense si impegna ad essere 39 presente con puntualità alle udienze etc.., ovvero a compiere tutte quelle attività professionale che rendono possibile vincere la lite, ma non si impegna a vincere la lite. Invece, un discorso ben diverso deve necessariamente essere fatto per l'attività stragiudiziale dove, secondo la giurisprudenza di legittimità l'avvocato si trova di fronte un'obbligazione di risultato. Infatti, al contrario dell'obbligazione di mezzi, in questo caso l'oggetto dell'obbligazione non è costituita dalla semplice attività professionale, quanto piuttosto dal raggiungimento del risultato. In estremi sintesi, nell'attività stragiudiziale il dovere deontologico di diligenza assume un diverso spessore ovvero una diversa connotazione. Si pensi, ad esempio, all'avvocato che ometta di scrivere, nei termini stabiliti dalla legge, una lettera interruttiva di prescrizione ad una compagnia di assicurazione facendo, così, prescrivere il risarcimento pecuniario al proprio cliente. Quindi, l'avvocato in questa ipotesi è pienamente responsabile per avere violato anche il dovere deontologico della diligenza ex art. 8 del Codice deontologico forense. In conclusione, a sostegno della mia sopraesposta tesi, riporto in allegato la massima della Cassazione che sul punto ha stabilito un nuovo ed importante principio di diritto. Di regola, le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, non per conseguirlo. Tuttavia, avuto riguardo all'attività professionale dell'avvocato, nel caso in cui questi accetti l'incarico di svolgere un'attività stragiudiziale consistente nella formulazione di un parere in ordine all'utile esperibilità di un'azione giudiziale, la prestazione oggetto del contratto non costituisce un'obbligazione di mezzi, in quanto egli si obbliga ad offrire tutti gli elementi di valutazione necessari ed i suggerimenti opportuni allo scopo di permettere al cliente di adottare una consapevole decisione, a seguito di un ponderato apprezzamento dei rischi e dei vantaggi insiti nella proposizione dell'azione. Pertanto, in applicazione del parametro della diligenza professionale (art. 1176, secondo comma, c.c.), sussiste la responsabilità dell'avvocato che, nell'adempiere siffatta obbligazione, abbia omesso di prospettare al cliente tutte le questioni di diritto e di fatto atte ad impedire l'utile esperimento dell'azione, rinvenendo fondamento detta responsabilità anche nella colpa lieve, qualora la mancata prospettazione di tali questioni sia stata frutto dell'ignoranza di istituti giuridici elementari e fondamentali, ovvero di incuria ed imperizia insuscettibili di giustificazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, decidendo nel merito ed affermando la responsabilità 40 dell'avvocato il quale, nella formulazione di un parere stragiudiziale, aveva omesso di indicare al cliente che il diritto che questi intendeva far valere in giudizio era prescritto, omettendo altresì di approfondire l'eventuale sussistenza di elementi e circostanze in grado di contrastare l'eventuale eccezione di prescrizione) (Cassazione civile, sezione II, 14 novembre 2002, n. 16023). 41
Scarica