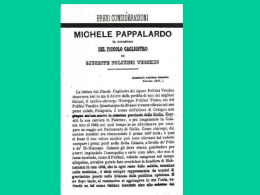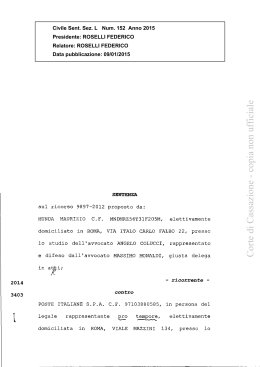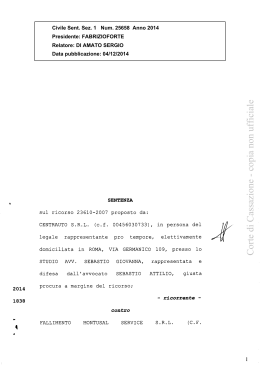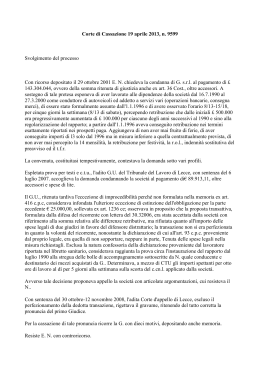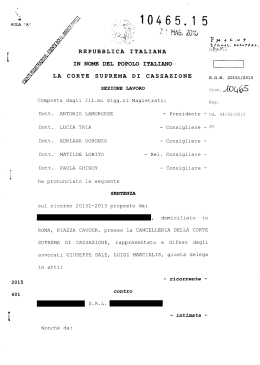Corso di preparazione per l’esame forense www.overlex.com DOCENTE Avv. Luigi Viola 1 DISPENSA DI DIRITTO CIVILE PARTE I 2 INDICE DIVIETO PATTO COMMISSORIO:……………………………………pg. 14 REGOLAMENTO E CONTRATTO CONDOMINIALE:………………pg. 15 CONDOMINIO MINIMO:………………………………………………..pg. 16 Cass. 1337/2005: al condominio minimo si applica la disciplina del condominio. Cass. 3264/2005: la disciplina giuridica prevista per le scale si estende all’ascensore. VENDITA A PREZZO IRRISORIO:…………………………………….pg. 24 PRELIMINARE PER PERSONA DA NOMINARE:……………………pg. 26 Cass., sez. unite, 11624/2006: sul preliminare di cosa altrui. Cass.26232/2005: contratto preliminare di vendita, caparra confirmatoria e risoluzione di diritto del contratto. PROPOSTA IRREVOCABILE ED OPZIONE:…………………………pg. 36 MANDATO POST MORTEM:………………………………………….…pg.38 Cass.12143/2006: mandato post mortem. COMUNIONE LEGALE E MOMENTO DELL’ACQUISTO DEL BENE:………………………...pg. 41 Cass. 1197/2006: comunione legale e diritti di credito Cass.16177/2001: contratto concluso senza il consenso dell'altro coniuge. MANDATO AD ACQUISTARE UN IMMOBILE, REVOCA E FORMA NECESSARIA: ………………………………………………………….pg. 54 Dottrina: Nastasi, La rappresentanza indiretta ed il mandato ad alienare. ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE: ………………………………..pg.63 Cass. 20256/2006: infedeltà e separazione. Cass. 1198/2006: assegnazione della casa familiare. Cass.6276/2005: rapporti sessuali negati e separazione. CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO:…………………………pg. 74 Cass. 14470/2005: sul contratto di apertura di credito. 3 DOLO OMISSIVO: ……………………………………………………….pg. 83 Cass.20260/2006: dolo omissivo e risarcimento del danno. Cass. 9253/2006: dolo omissivo ed annullamento. SUCCESSIONE TESTAMENTARIA:……………………………………pg.96 Cass, sez. unite, 13524/2006: sull'individuazione della quota di riserva spettante ai legittimari. Cass., sez. unite, 20644/2004: sul termine di prescrizione dell'azione di riduzione. RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE:……………………….pg. 107 Cass. 8520/2006: la responsabilità per rovina di edifici. RESPONSABILITA’ DEL MEDICO:…………………………………..pg. 117 Cass. 5444/2006: operazione non consentita e violazione della libertà di autodeterminazione. Cass. 861/2000: danno esistenziale per violazione del diritto all' autodeterminazione del paziente. DANNO TANATOLOGICO:…………………………………………..pg. 137 Cass. 15760/2006: danno parentale non patrimoniale. Cass. 15019/2005: danno da morte dei nonni. trib. Arezzo 123/2005: danno da morte del convivente. Cass. 88/2002: danno biologico da morte immediata. PRINCIPIO DI INDIVISIBILITA’ DELLA SERVITU’:……………pg. 159 Cass. 8727/2005: comunione impropria. PAGAMENTO MEDIANTE ASSEGNO BANCARIO:………………pg. 163 Cass. 12372/2006: conto corrente bancario e termine di decadenza di sei mesi per l’impugnazione dell’estratto conto. Cass. 19997/2005: deposito e restituzione. Cass. 8 luglio 2005: responsabilità della banca. Cass. 18947/2005: pluralità di conti correnti e compensazione. CULPA IN VIGILANDO……………………………………………….pg. 197 Cass. 12501/2000: responsabilità dei genitori. 4 Cass. 1478/06: principio della vicinanza della prova. INCIDENTE STRADALE E CINTURE DI SICUREZZA:………..pg. 215 Cass. 4993/2004: incidente stradale e cinture di sicurezza. CONDOMINIO E PARCHEGGIO…………………………………pg. 226 Cass. 4599/2006: diritto di uso del cortile. DIRITTO DI ABITAZIONE:……………………………………….pg. 230 ACCOLLO E DONAZIONE INDIRETTA:……………………….pg. 231 DIRITTO DI SOPRAELEVAZIONE:……………………………..pg. 233 Cass. 4258/2006: sopraelevazione e proprietari dell'ultimo piano. Cass. 4920/2006: condominio e animali domestici. Cass. 13371/2005: condominio minimo. Cass. . 8066/2005: condominio orizzontale. Cass. 3264/2005: spese ascensore. PRELIMINARE CON RISERVA DI USUFRUTTO:………….pg. 253 Dottrina: Il contratto preliminare di vendita (estratto dal Trattato di diritto privato, Giappichelli), di Francesco Gazzoni. PATTO COMMISSORIO:……………………………………….pg. 267 Cass. 7296/2006: sale and lease-back. PRELIMIARE DI COSA ALTRUI:…………………………….pg. 270 Cass. 11624/2006: preliminare di cosa altrui. Cass. 16937/2006: preliminare e soggetto incapace. PATTO COMMISSORIO E BENE CONCESSO DA UN TERZO:……………………..…pg. 283 ANNULLAMENTO E RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE:……………………………………..…pg. 284 Cass. 16937/2006: responsabilità precontrattuale e contrattuale. 5 CEDIBILITA’ DEL CONTRATTO DI OPZIONE:…………...pg. 293 ATTI GIURIDICI UNILATERALI ATIPICI:………………..pg. 294 BONDS – TRUFFA:…………………………………………….pg. 296 Tribunale di Genova, Sentenza 15 marzo 2005 N. 1230 Tribunale di Palermo, sentenza N. 3293-2005. RETTIFICA DEL CONTRATTO:………………………………pg. 313 COMUNIONE TRA CONIUGI E CONTRATTO PRELIMINARE:……………………………..pg. 314 Cass. 16177/2007: preliminare senza consenso dell'altro coniuge ed azione di annullamento MANDATO AD ACQUISTARE E FORMA:…………………...pg. 323 CONTRATTI COLLEGATI:………………………….………pg. 324 Cass. 1150/2005: contratti misti SOSTITUZIONE DEL RAPPRESENTATE:……………….pg. 330 CLAUSOLA DI IRRISOLUBILITA’:……………………….pg. 331 6 PATTO COMMISSORIO AVENTE PER OGGETTO L’USUFRUTTO:…………………….pg. 332 Dispensa sul divieto di patto commissorio. Cass. 10490/2006: causa in concreto. Cass. 7296/2006: contratto di sale and lease-back . RESPONSABILITÀ DEI GENITORI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA DA PARTE DEL FIGLIO:…………………….…pg.354 Cass. 6685/2007. SIMULAZIONE E FRODE ALLA LEGGE:………………….……..pg. 356 VACANZA ROVINATA:……………………………………………...pg. 357 Cass. 3462/2007: vacanza rovinata e risarcimento del danno esistenziale. TRASPORTO GRATUITO ED AMICHEVOLE:…………………..pg. 362 Cass. 13130/2006: art. 2054 c.c. e terzo trasportato. Cass. 17444/2006: trasporto aereo e prescrizione. DIRITTO DI ABITAZIONE, COMODATO E DONAZIONE:…...pg. 369 Cass.3179/07: comodato precario e recesso. CUSTODIA E DEPOSITO:…………………………………………...pg. 372 Cass. 7493/2007: rimozione del veicolo in divieto di sosta ed obbligo di custodia. CLAUSOLA REGOLAZIONE PREMIO-ASSICURAZIONE:……pg. 375 Cass., sez. unite, 4631/2007: contratto di assicurazione e clausola di regolazione del premio. Cass. 395/2007: contratto di assicurazione e massinale. PROPRIETÀ E IUS AD AEDIFICANDUM:………………………pg. 387 PARCHEGGIO E SERVITÙ:……………………………………….pg. 388 Cass. 12793/2005: cedibilità dei parcheggi in eccesso. CONDICIO IURIS E NOVAZIONE:……………………………….pg. 402 Cass., sez. unite, 13294/2005: REVOCA E COMUNIONE LEGALE:……………………….pg. 414 Cass. 966/2007: revocatoria ordinaria e fondo patrinmoniale. Cass. 1197/2007: 7 comunione legale e diritti di credito. Cass. 19250/2004: acquisto in deroga alla comunione. Cass. 16177/2001: comunione legale e preliminare. USUFRUTTO CONGIUNTIVO CON CLAUSOLA DI ACCRESCIMENTO NEGLI ATTI ONEROSI: ………………………………………pg. 440 ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DELL’IMMOBILE OGGETTO DI USUFRUTTO:………………………………………………....pg. 441 RESPONSABILITÀ DEL NOTAIO:……………………………pg. 442 Cass. 9238/2007: responsabilità dell'avvocato e chance di succeso. Cass. 12 dicembre 2001: responsabilità dell'avvocato ed obbligazione di mezzi. Cass. 8826/2007: responsabilità medica ed obbligazione di risultato. TRUST A FAVORE DI FIGLIO DISABILE:…………………….pg. 468 Tribunale di Bologna 4545/2003: sulla legittimità del trust. COMUNIONE LEGALE TRA CONIUGI E CREDITO:…………….pg. 492 Cass., sez. unite, 17952/2007: preliminare e consenso dei coniugi. Cass. 4823/2006: preliminare e legittimazine ad agire del coniuge. Cass. 1197/2006: comunione e contratto di conto corrente. CESSIONE DEL CREDITO ALIMENTARE:……………………….pg. 508 Cass.4102/2007: figlio maggiorenne e diritto al mantenimento. NATURA CONTRATTUALE DELL’ESPROMISSIONE CUMULATIVA:………………………….pg. 514 Cass. 8622/2006: espromissione e momento di perfezionamento dell'accordo. Cass. 19396/2004: espromissione. ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONE NATURALE:……………..pg. 529 Cass. 3713/2003: obbligazione naturale e convivenza more uxorio. CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA:……………………….pg. 534 Cass. 5997/2006: garanzie autonome e principio di buona fede. Cass. 23900/2006: 8 contratto autonomo di garanzia e fideiussione. Cass. 10864/1999: exceptio doli generalis. PRESUPPOSIZIONE:……………………………………………………pg. 556 Cass. 12235/2007: presupposizione e necessità di autonomo rilievo. Cass. 6631/2006: presupposizione, condizione e causa. RESPONSABILITÀ DELLA BANCA ED ASSEGNO NON TRASFERIBILE: ………………………………………………………pg. 574 Cass., sez. unite, 14712/2007: responsabilità della banca ed assegno non trasferibile. Cass. 8826/2007: responsabilità del medico e contatto sociale. Cass. 24456/05: responsabilità degli insegnanti ed autolesioni. DIRITTO DI SOPRAELEVAZIONE ED INDENNITÀ:……………..pg. 620 Cass., sez. unite, 16794/2007: sul diritto di sopraelevazione. Cass. 12880/2005: indennità di sopraelevazione. Cass. 972/2006: condominio ed uso della cosa comune. DEFINITIVO DIVERSO DAL PRELIMINARE:…………………pg. 636 Cass. 233/2007: rapporti tra definitivo e preliminare. Cass. 10678/2007: preliminare e clausola di pagamento a mezzo leasing. Cass. 9647/2006: obbligo di concludere il definitivo e difformità catastali. Cass., sez. unite, 11624/2006: preliminare di cosa altrui. NULLITÀ VIRTUALE:……………………………………………….pg. 651 Cass. 3683/200/: obblighi informativi degli intermediari finanziari: rimessione alle sezioni unite. Cass. 19024/2005: obblighi informativi e nullità. PRELIMINARE AD EFFETTI ANTICIPATI:………………………pg. 663 Cass. 16937/2006: azione contrattuale ed extracontrattuale. Cass. 25703/2006: preliminare e licenza di abitabilità. Cass. 12323/2001: preliminare di vendita e vizi della cosa. 9 VENDITA A CATENA:……………………………………………….pg. 679 Cass. 5428/2002: vendita a catena ed azioni esperibili. CAUSA E SCOPO DI VACANZA:…………………………………..pg. 684 Cass. 16315/2007: finalità turistica e causa in concreto. Cass. 10490/2006: causa in concreto. Cass. 13580/2004: contratto di sale and leaseback . CLAUSOLA LEASING:……………………………………………..pg. 703 Cass. 10678/2007: preliminare e clausola di pagamento a mezzo leasing. Cass.10424/2007: incidente stradale ed autovettura in lesing. Cass. 17145/2006:leasing finanziario DANNI NON PATRIMONIALI:…………………………………….pg. 714 Cass. 21976/2007: danni iure succesionis e lasso temparale di 24 ore Cass. 2546/2007: danni iure proprio. Cass. 18163/2007: danno biologico terminale. Cass. 20987/2007: danno parentale. Cass. 22338/2007: età e danno alla salute. Cass. 10840/2007: danno da perdita di chances lavorative. Cass. 2311/2007: danno da lesione del diritto alla sessualità Cass. 8828/2003: danno non patrimoniale in assenza di reato. Corte Cost. 30 giugno 2003: danno non patrimoniale e colpa presunta. PRELIMINARE DI COSA ALTRUI:……………………………….pg. 756 Cass., sez. unite, 11624/2006 Cass.. 24782/2005 Cass. 20976/2007: preliminare di vendita, comunione ordinaria e fallimento del marito DANNI DA MANCATE INFORMAZIONI:……………………….pg. 771 Cass. 21748/2007: stato vegetativo ed interruzione dell'alimentazione forzata. Cass. 5444/2006: consenso informato. 10 Cass. 1511/2007: errore diagnostico e danno psichico. MORTE DELL’ANIMALE DA AFFEZIONE:…………………….pg. 809 Cass. 14846/2007. perdita del cavallo e danno esistenziale. DANNO ALL’IMMAGINE DELL’IMPRESA: ……………………..pg. 812 Trib. Lecce 46/2005. Erronea segnalazione alla centrale Rischi Cass. 12929/2007: danno all'immagine della persona giuridica. Cass. 10847/2007: danno all'immagine e manager corrotto. cass. 9233/2007: danno all'immagine ed illegittimo protesto. PRELIMINARE E CONSENSO DELLA MOGLIE:………………..pg. 852 Cass.. 21098/2007: diritti di credito e comunione. Cass. 16177/2001: prelimonare ed azione di annullamento Cass., sez. unite, 17952/2007: prelimiare e litisconsorzio. FUMO PASSIVO NEL LUOGO DI LAVORO:……………………..pg 873 Cass. 24404/2006: fumo passivo ed assenze per malattia Cass. 22884/2007: danno da fumo attivo Cass. 1513172007: sigarette light Cass. 14840/2007: cinesi lavorativa Cass. 10840/2007: danno da perdita di opportunità di lavoro VIZI DELLA COSA LOCATA:……………………………………..pg 888 RESPONSABILITÀ DEL MEDICO:……………………………..pg.909 Cass. 8826/2007: contratto di spedalità Cass. 1511/2007: errore diagnostico DIRITTO ALLA SESSUALITÀ:……………………………….pg. 946 Cass. 2311/2007: ammissibilità del diritto alla sessualità Cass. 9801/2005: sessualità e costituzione 11 MINUTA E PUNTUAZIONE:………………………………….pg. 957 Cass. 16118/2006: minuta ed accertamento del giudice Cass. 910/2005: conclusione del contratto 12 13 14 DIVIETO DI PATTO COMMISSORIO TRACCIA: Tizio è un imprenditore di fama internazionale che si trova in una condizione momentanea di carenza di liquidità economica; Tizio è amico da diversi anni di Caio, direttore della società finanziaria di leasing denominata Caltalex. Tizio decide di vendere l’immobile Alfa e diversi beni mobili alla società Caltalex, con l’accordo che quest’ ultima darà in leasing gli stessi beni (Alfa e i beni mobili) a Tizio. In questo modo, Tizio riesce ad avere la liquidità necessaria per portare avanti i suoi interessi economici. Dopo circa un anno, Caio fa presente a Tizio di voler riavere tutta la liquidità consegnata in cambio dell’immobile Alfa e di altri beni mobili, in quanto il contratto, precedentemente realizzato, era affetto da nullità perché in contrasto con il divieto del patto commissorio. Tizio si reca dal legale Sempronio. Il candidato, assunte le vesti di Sempronio, rediga motivato parere sulla questione giuridica posta. POSSIBILE SCHEMA DI SOLUZIONE : In premessa era utile ricostruire sinteticamente il fatto. Successivamente, il problema giuridico posto andava inquadrato nell'ambito del divieto di patto commissorio, ex art. 2744 c.c., per il pegno e l'ipoteca, ed art. 1963 c.c. per l'anticresi. In linea generale, il patto commissorio può essere definito come un accordo con il quale il debitore destina in proprietà definitiva del proprio creditore (per compensazione totale o parziale del proprio debito), un bene in garanzia per il caso di propria inadempienza, senza alcuna previsione di stima di valore sulla base di quelli correnti in tale momento. Il suddetto patto, per espressa previsione di legge è nullo, diversamente dal patto c.d. marciano con cui creditore e debitore stabiliscono che, in caso di inadempimento, il creditore acquista la proprietà di un bene che il debitore trasferisce in garanzia, con l'obbligo, però, che un terzo stimatore provveda a valutare il bene stesso successivamente alla scadenza del credito: al creditore è consentito appropriarsi del bene nei limiti del valore del proprio credito, con l'obbligo di restituire l'eccedenza al debitore. La ratio di tale istituto è stata individuata, con riferimento all'esigenza di tutelare il debitore da ingiustificate coartazioni, ovvero per tutelare la par condicio creditorum, ovvero per rispettare il principio della tipicità dei diritti reali (di garanzia). La giurisprudenza più datata tendeva ad ammettere il patto commissorio con schema risolutivo (il debitore trasferisce il bene al creditore, con l'accordo che quest'ultimo lo ritrasferirà al debitore in caso di adempimento), perchè l'art. 2744 c.c. sembrava vietare solo lo schema sospensivo (il creditore diviene proprietario del bene del debitore in caso di inadempimento di quest'ultimo): si privilegiava la lettera della legge piuttosto che la sostanza; la giurisprudenza più recente, invece, privilegiando la sostanza (perchè il mero 15 rispetto della lettera della legge rischiava di comportare la nullità dell'intero atto per frode alla legge, danneggiando il debitore ed avvantaggiando il creditore, in contrasto con la ratio di tutela del debitore stesso), vieta anche il patto commissorio con schema risolutivo, comminandone la nullità. Indice rivelatore da tenere presente sarebbe la sproporzione tra valore effettivo del bene e valore del debito assunto, da verificare in concreto, secondo la giurisprudenza recente, in quanto è tale sproporzione a danneggiare in debitore, implicando un arricchimento ingiustificato in capo al creditore; in questo senso, allora, non esisterebbero contratti con patto commissorio nullo ex se, ma bisognerebbe verificare caso per caso, sia la sproporzione suddetta che la causa in concreto. Se così è, allora, tutti i contratti realizzati con scopo di garanzia (alienazione a scopo di garanzia, lease-back, vendita con patto di riscatto, ecc.) non implicherebbero, sic et simpliciter, la nullità del patto commissorio. Nel caso di specie, allora, Tizio e la società Caltalex diretta da Caio, non avranno necessariamente violato il patto commissorio con il loro contratto che riguarda il sale and lease-back (c.d. locazione finanziaria di ritorno), ma bisognerà verificare la causa concreta (che non è di garanzia, ma di leasing) e la sproporzione tra il valore del debito e il valore dell'immobole Alfa ed altri beni mobili. In questo senso, pertanto, Tizio potrà legittimamente continuare ad utilizzare il "finanziamento" avuto dalla società Caltalex, in quanto il contratto (rectius: il patto del sale and lease-back) posto in essere non è necessariamente nullo, ma, anzi, sembra valido sotto un duplice profilo: in primis, non sembrerebbe poter emergere un pregresso rapporto economico tra Tizio e Caio, così che è inverosimile ritenere che il trasferimento patrimoniale sia stato effettuato a scopo di garanzia (non vi era ragione di garantire un debito, in quanto non vi erano pregressi inadempimenti, oltre al fatto che Tizio chiedeva un prestito espressamente per causa di leasing), ed in secundis perchè l'amicizia tra Tizio e Caio rende difficilmente credibile un approfittamento. REGOLAMENTO E CONTRATTO CONDOMINIALE TRACCIA: Tizio acquista l’immobile Alfa, sito nel condominio Beta, in via dei Portoghesi a Roma. Il condominio Beta è costituito da sette piani; ogni piano è suddiviso in quattro unità abitative e ad ogni unità abitativa corrisponde un proprietario. Tizio, al momento dell’acquisto dell’immobile Alfa, ha firmato un contratto condominiale, dichiarando di acconsentire al divieto assoluto di possedere animali domestici nella proprietà solitaria di sua appartenenza (Alfa). Tizio comunica al resto della collettività condominiale, prevalentemente idiosincratica verso gli animali, di voler agire verso l’Autorità Giudiziaria per modificare il contratto condominiale. La collettività condominiale si rivolge ad un avvocato per avere dei chiarimenti, precisando di non voler modificare il contratto condominiale. 16 Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato, rediga motivato parere, affrontando le tematiche giuridiche sottese alla fattispecie presa in esame. POSSIBILE SCHEMA DI SOLUZIONE: In premessa poteva essere utile ricostruire sinteticamente il fatto. Subito dopo, il problema andava inquadrato nell'ambito del condominio, con particolare riferimento al regolamento condominiale e contratto condominiale. Il regolamento condominiale può impedire ai singoli condomini di possedere animali domestici nelle singole proprietà solitarie? In generale, la normativa condominiale è inderogabile, ex art. 1138 ultimo comma c.c., nella misura in cui si intende limitare i diritti proprietari delle singole unità immobiliari; tuttavia, tale discorso vale per i regolamenti condominiali (ex art. 1138 c.c.), ma non per atti aventi natura giuridica diversa come i contratti. I contratti (condominiali), in particolare, possono derogare alle previsioni della legge, sia perchè devono essere approvati all'unanimità (per cui tutti i condomini si autolimitano liberamente, diversamente dal regolamento in cui prevale la maggioranza) e sia perchè in tema di contratto si tende ad assicurare la più ampia libertà possibile (anche nel senso di autolimitazione), diversamente dal regolamento condominiale: i regolamenti condominiali possono disciplinare l'uso delle cose comuni (il regolamento condominiale si estende anche ai successori, diversamente dal contratto condominiale), mentre i contratti condominiali possono porre limiti all'uso delle singole unità immobiliari. Pertanto, la collettività condominiale non avrà nulla da temere da Tizio, in quanto quest'ultimo, pur rivolgendosi all'Autorità Giudiziaria, non potrà ottenere alcunchè, in quanto il contratto condominiale è lecito e legittimo, oltre ad essere espressione della volontà contrattuale dei singoli condomini che il giudicante non può censurare, trattandosi di una sfera giuridica intangibile (autonomia negoziale, ex art. 1322 c.c.). CONDOMINIO MINIMO TRACCIA: Tizio è proprietario di una piccola unità immobiliare Alfa; Caio è proprietario di una piccola unità immobiliare Beta; Sempronio è proprietario di una piccola unità immobilare Gamma. Alfa, Beta e Gamma sono unità immobiliari collocate nell'ambito del medesimo edificio Kappa. I rapporti tra Tizio, Caio e Sempronio, all'interno di Kappa, non sono disciplinati nè da un regolamento di condominio e nè da un contratto condominiale; inoltre, non è mai stato nominato un amministratore di condominio. Caio ritiene di non dover pagare le spese per il rifacimento dell'ascensore, in quanto Beta si trova al primo piano, così che non traendo utilità dall'ascensore non sarebbe tenuto a pagare le relative spese. Tizio e Sempronio, invece, ritengono che anche Caio debba pagare le spese per il rifacimento dell'ascensore, perchè le spese, a loro dire, andrebbero divise sempre in modo eguale per i beni comuni (indipendentemente dall'effettivo uso). 17 Caio si reca da un amico avvocato; il candidato rediga parere motivato sul caso posto alla sua attenzione. POSSIBILE SCHEMA DI SOLUZIONE: All'inizio poteva risultare utile ricostruire brevemente il fatto, ponendo particolare attenzione alla struttura di Kappa. Successivamente, era necessario inquadrare giuridicamente il problema interpretativo posto; nell'ipotesi dell'edificio Kappa, in cui le unità immobiliari sono tre e non vi è l'obbligo di nominare un amministratore, è possibile parlare di condominio? Oppure il fatto che non sussista in concreto un'assemblea ed un amministratore depone nel senso di una contitolarità di diritti diversa da condominio, come la comunione? In altri termini, nelle ipotesi di condomini minimi, si applica la disciplina giuridica della comunione o quella del condominio? Se si opta per la tesi della comunione, ex art. 1101 c.c., Tizio, Caio e Sempronio dovranno dividere le spese relative al rifacimento dell'ascensore in proporizioni uguali, in considerazione del fatto che nella comunione non emerge un concetto di ripartizione delle spese in rapporto all'uso, ma solo in rapporto al concetto di quote ed in mancanza, come nel caso di specie, le quote si presumono uguali; se le quote sono uguali, allora, de plano, le spese saranno uguali. Diversamente, se si opta per la tesi del condominio, Caio sarebbe tenuto a pagare di meno rispetto agli altri condomini, in quanto potrebbe trovare applicazione il criterio del maggiore utilizzo, ex art. 1123 c.c. (o art. 1124 c.c.). Pertanto, si tratta di comunione o condominio? Secondo una prima impostazione, nel caso di specie si tratterebe di condominio, in quanto il condominio per esistere dovrebbe essere costituito almeno da quattro condomini, argomentando ex art. 1129 c.c.; inoltre, l'art. 1100 c.c. sembrerebbe formulare una presunzione giuridica relativamente alle contitolarità: se nulla è disposto (tramite regolamento condominiale o legge), allora, nei casi dubbi la contitolarità di diritti sarà in comunione. Invero, secondo la ricostruzione giurispudenziale maggioritaria, il condominio c.d. minimo sarebbe un vero e proprio condominio. A favore di tale ricostruzione, emergerebbe il fatto che la contitolarità riguarda un edificio (proprio come nel condominio) e non un bene qualsiasi; inoltre, l'art. 1129 c.c. richiede la nomina di un amministratore se i condomini sono più di quattro, lasciando intendere sia che possono sussistere condomini con meno di quattro unità abitative, e sia che tale norma riguarda esclusivamente la nomina dell'amministratore, ma non la natura giuridica della contitolarità di condomini cotituiti da meno di quattro unità abitative; id est, l'art. 1129 c.c. non dice che i condomini minimi sono comunioni, ma che sopra i quattro condomini bisogna nominare un amministratore. Altresì, il discorso sulla presunzione giuridica, ex art. 1100 c.c., sarebbe priva di fondamento in quanto applicabile solo "se la legge non dispone diversamente" e nel caso de quo la legge sembra disporre diversamente; infine, laddove si applicasse la disciplina della comunione, si richierebbe di violare l'art. 3 Cost., imponendo di trattare in modo eguale situazioni giuridiche diseguali, ovvero trattare in modo eguale Tizio, Caio e Sempronio, laddove si trovano in situazioni giuridiche diverse, essendo diverso l'utilizzo che possono fare di determinati beni (in particolare l'ascensore). Chiarito tale aspetto, era necessario chiedersi quale disposizione, in concreto, 18 sembrerebbe trovare applicazione nel caso de quo. In particolare, era utile chiedersi: si applicherà l'art. 1123 c.c. (II comma) che sembra individuare il solo criterio dell'utilizzo per la ripartizione delle spese, ovvero l'art. 1124 c.c., che individua una sorta di criterio misto? In altri termini, le spese per il rifacimento dell'ascensore sono parificabili a quelle relative alla manutenzione delle scale? In senso negativo deporrebbe la lettera della legge: se l'art. 1124 c.c. si riferisce alle scale, allora, un'estensione applicativa di tale articolo rischierebbe di violare la lettera della legge. Invero, secondo la giurisprudenza più recente il problema posto andrebbe risolto in termini diversi, in quanto non bisognerebbe tanto verificare la lettera della legge (soprattutto in considerazione del fatto che quando il codice fu formulato di certo non si pensava agli ascensori), quanto piuttosto la sua ratio giustificatrice; così che, se la ripartizione delle spese in tema di scale pone problemi analoghi a quelli dell'ascensore, la soluzione andrà individuata nell'estenzsione applicativa dell'art. 1124 c.c. (per analogia). Da questo angolo visuale, allora, l'ascensore è molto simile alle scale, in quanto sono entrambi "strumenti" per raggiungere i piani più alti, ed in entrambi i casi vi è un diverso utilizzo in rapporto alla distanza dal suolo, con la conseguenza che questa analogia strutturale ben giustifica l'applicabilità dell'art. 1124 c.c. anche agli ascensori. Ne segue, quindi, che in virtù di tali considerazioni, coerenti con la Costituzione (che impone di trattare in modo uguale situazioni giuridiche uguali o analoghe), con la lettera della legge (non vi è violazione di legge, ma interpretazione evolutiva) e con la sua ratio, Caio sarà tenuto a pagare la spesa per il rifacimento dell'ascensore, per metà in ragione del valore del suo piano e per l'altra "metà in rapporto alla distanza dal suolo" (Caio è al primo piano). Si consiglia, poi, di leggere le sentenze che seguono (la prima si occupa del condominio minimo, mentre la seconda della ripartizione delle spese dell'ascensore). -Al condominio minimo si applica la disciplina del condominio e non quella della comunione. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE SENTENZA 22 GIUGNO 2005 N. 13371 (Presidente V. Calfapietra, Relatore C. Cioffi) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 12 giugno 1990 Maria G., Antonio e Paolo T., proprietari di uno dei due piani dell'edificio nel dettaglio indicato, proposero innanzi al Pretore di Rieti azione di danno temuto nei confronti di Agostino e Vincenzo S., proprietari dell'altro piano, denunziando il pericolo costituito dal 19 progressivo crollo del tetto dell'edificio. Ottenuto dal Pretore il provvedimento cautelare richiesto, Maria G., Antonio e Paolo T., che avevano provveduto al restauro del fabbricato, convennero Agostino e Vincenzo S. in riassunzione innanzi al Tribunale di Rieti, del quale il Pretore aveva affermato la competenza, e chiesero che fossero condannati al pagamento di quanto da essi dovuto, "secondo la ripartizione millesima-le da determinarsi in corso di causa", nonché al risarcimento dei danni da essi subiti per la ritardata esecuzione del detto restauro. Agostino e Vincenzo S. si costituirono e chiesero il rigetto della domanda. Contestata la fondatezza dell'azione di danno temuto proposta da Maria G., Antonio e Paolo T., i convenuti sostennero in particolare che essi erano tenuti soltanto al pagamento delle spese relative alla effettuazione dei lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione delle parti comuni dell'edificio, nella misura e secondo la ripartizione millesimale da essi proposta; chiesero inoltre, in riconvenzione, la demolizione di quanto gli attori avevano realizzato, eseguendo le opere previste dall'ordinanza pretorile, che era espressione di una inesistente "servitù di grondaia" gravante su un contiguo fondo. Con sentenza del 27 giugno 1995 il Tribunale di Rieti, individuato con una consulenza tecnica l'ammontare dei lavori urgenti ed indifferibili necessari per la conservazione dell'immobile condominiale, nonché le quote millesimali delle parti in lite, condannò Agostino e Vincenzo S. a pagare a Maria G., Antonio e Paolo T. la somma di 3.602.400 lire (a fronte dei 3.030.802 di lire, di cui i convenuti avevano riconosciuto di essere debitori); e rigettò sia l'azione risarcitoria esperita da Maria G., Antonio e Paolo T., sia la riconvenzionale di Agostino e Vincenzo S., non avendo questi ultimi "neppure dedotto di essere proprietari dell'asserito fondo servente". Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha rigettato il gravame di Agostino e Vincenzo S.. In particolare, ha disatteso il motivo di appello con cui questi ultimi avevano censurato la sentenza impugnata per aver riconosciuto la legittimità dell'ordinanza con cui il Pretore aveva concluso la fase cautelare del procedimento di danno temuto intentato nei loro confronti da Maria G., Antonio e Paolo T.; ha affermato poi che l'immobile per cui è causa è condominiale, e dunque che sono applicabili, nella specie, le norme dettate per gli edifici condominiali; ha disatteso inoltre la censura con cui gli appellanti avevano sostenuto l'erroneità della determinazione delle quote millesimali, osservando che essi non avevano allegato alcunché per dimostrare tale asserita erroneità; infine ha disatteso anche la censura con cui gli appellanti avevano ribadito che gli attori, nel ricostruire il tetto, avevano posto le premesse per l'acquisizione di una servitù di grondaia, osservando che lo sporto realizzato non è maggiore di quello del preesistente tetto, giusta quanto emerge dalla relazione del consulente tecnico di ufficio e dalle fotografie esibite. Vincenzo S. ha chiesto la cassazione di tale sentenza per sette motivi. Maria G., Antonio e Paolo T. hanno resistito con controricorso. Agostino S. non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi quattro motivi del suo ricorso Vincenzo S. censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato la nullità, ovvero per non aver annullato "tutti i provvedimenti emessi nella fase cautelare". Il ricorrente denunzia violazione dell'art. 163, 112, 260 e 689 del codice di rito, dell'art. 1172 del codice civile, e vizi di motivazione. 20 Le censure sono inammissibili. I provvedimenti cautelari emessi nell'ambito del procedimento di denunzia di nuova opera ai sensi degli art. 689 e 690 del codice di rito hanno carattere interinale e strumentale rispetto alla causa di merito e, pertanto, non sono suscettibili di impugnazione autonoma. Volta poi che sia intervenuta una pronunzia che accerti o neghi il diritto del quale con essi è stata chiesta tutela, per l'appunto in via interinale, e provvisoria, viene meno la loro ragion d'essere, e con essa l'interesse ad impugnarli (cfr., tra le tante in tal senso, la sentenza di questa Corte n. 982-1999). Con il quinto motivo del suo ricorso Vincenzo S. censura la sentenza impugnata per ripartito le spese necessarie per i necessari rifacimenti dell'edifìcio applicando le norme del codice civile relative al condominio negli edifici (segnatamente gli art. 1123 e 1134), e non, come egli aveva sostenuto in appello, essendo l'edificio composto da due sole unità immobiliari, quelle sulla comunione in generale (segnatamente l'art. 1110). Il ricorrente denunzia violazione delle citate nome, non senza sostenere che la motivazione della sentenza impugnata è carente ed illogica, non essendo configurabile nella specie, per la ragione detta, un condominio. La censura è infondata. La statuizione impugnata ha fatto puntuale applicazione del principio sempre affermato da questa Corte (cfr. le sentenze n. 7181-1997, 5298-1998, ed in particolare quella n. 5914-1993), secondo il quale, in base all'art. 1139 del codice civile, la disciplina del capo II del Titolo VII del terzo libro del codice civile (art. 1117-1138) è applicabile ad ogni tipo di condominio e, quindi, anche ai cosiddetti "condomini minimi", e cioè a quelle collettività condominiali composte da due soli partecipanti; in relazione alle quali sono da ritenersi inapplicabili soltanto le sole norme procedimentali sul funzionamento dell'assemblea condominiale, che resta regolato, dunque, dagli art. 1104, 1105, 1106. del codice civile. Con il sesto motivo del suo ricorso Vincenzo S. censura la sentenza impugnata per aver rigettato il suo motivo di appello con cui aveva sostenuto che la ripartizione millesimale effettuata dal Tribunale era illegittima. Il ricorrente denunzia violazione dell'art. 1123 del codice civile, e lamenta che la Corte d'appello ha affermato, nella sua sentenza, che "nessun elemento sussiste a conforto delle sue apodittiche affermazioni circa gli errori sulla consistenza volumetrica e gli spazi condominiali", senza tener conto della "precisa e puntuale elencazione di argomenti tecnico-giuridici ampiamente motivati, esposti nelle sue difese, suffragati da una consulenza tecnica di parte (in atti), che espone, con dovizia di particolari e con precise confutazioni tecniche, una precisa tesi circa l'erroneità e la incongruità delle ripartizioni millesimali adottate dal Tribunale per la ripartizione delle spese". Il motivo, con cui si censura la sentenza non tanto per la de-nunziata violazione di legge, quanto piuttosto per vizio di motivazione, è inammissibile. Il ricorso per cassazione - in virtù del principio di cosiddetta autosufficienza dello stesso - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari per individuare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito, e per valutarne la fondatezza, in modo che non sia necessario far ricorso ad altri documenti o atti, in particolare quelli relativi al pregresso giudizio di merito (cfr. tra le tante, tutte conformi, da ultimo, le sentenze n. 12912-2004 e 13550-2004). Il ricorrente non ha precisato, nel ricorso, quali sono gli argomenti tecnici giuridici da lui sviluppati per sostenere il motivo di gravame che a suo dire è stato 21 disatteso senza adeguata motivazione, e che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente considerati e valutati. Con l'ultimo motivo del suo ricorso Vincenzo S. censura la sentenza impugnata per aver confermato il rigetto della sua domanda riconvenzionale relativa alle dimensioni della sporgenza del tetto ricostruito deciso dal Tribunale in prime cure. Il ricorrente sostiene che non è vero quanto affermato al riguardo dalla Corte d'appello di Roma e in narrativa sintetizzato; in particolare sostiene che il consulente tecnico di ufficio si è limitato a proporre "valutazioni presuntive", e che dalle fotografie che raffigurano lo stato pregresso dei luoghi risulta il contrario di quanto affermato in sentenza. Denunzia quindi violazione dell'art. 2697 del codice civile e vizi di motivazione. La censura è inammissibile. Con essa il ricorrente non fa altro che proporre una valutazione delle prove raccolte diversa da quella che ne ha data il giudice del merito, e a contrapporla a quella di questo ultimo; chiede in altri termini un riesame delle prove raccolte, che questa Corte, giudice della sola legittimità, non può effettuare. Le spese seguono la soccombenza. PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso, e condanna Vincenzo S. a rifondere a Maria G., Antonio e Paolo T. le spese di questo giudizio, che liquida in 1.300,00 euro, di cui 1.200,00 per onorari, oltre accessori di legge. -In tema di condominio, la disciplina giuridica prevista per le scale si estende all’ascensore, sussistendone la medesima ratio. CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE SENTENZA 17 febbraio 2005 n. 3264 Svolgimento del processo Con citazione notificata il 27.07.1989 Roberto M. convenne davanti al Tribunale di Milano il Condominio di Via XXXXX in Milano impugnando la delibera 10.07.1989 con la quale l'assemblea aveva approvato la ripartizione delle spese millesimali di ascensore e riscaldamento. Il Condominio, tardivamente costituitosi, chiese il rigetto della domanda. Con separata citazione notificata il 3.11.89 Carlo e Caterina S. convennero in giudizio davanti allo stesso Tribunale il medesimo Condominio impugnando la delibera 12.10.89 con la quale l'assemblea aveva approvato i nuovi millesimi per la ripartizione delle spese diriscaldamento e di ascensore. Il Condominio, costituitosi chiese il rigetto della domanda. Disposta la riunione delle cause il M. chiese, in ordine alla domanda da lui proposta, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in forza della delibera 12.10.89 che soddisfaceva le sue richieste, ed il rigetto della domanda proposta dagli S. nel cui giudizio era intervenuto. Con successiva citazione 25.07.90 Carlo e Caterina S., Elda B., Lino P. ed Edoardo B. impugnarono la delibera 12.10.89 con riferimento all'approvazione delle spese di tinteggiatura dei serramenti, - nonchè la delibera del 27.06.90 relativamente al consuntivo 1.5.89/1.4.90 ed al nuovo regolamento di Condominio con allegate tabelle millesimali. Costituitosi il Condominio, chiese il rigetto della domanda: riunite tutte le cause, 22 ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini dei quali solo in pochi si sono costituiti, il Tribunale, con sentenza 22.10.98 ha respinto sia l'impugnazione delle due delibere 12.10.89 e 27.6.90, sia la domanda di revisione e determinazione giudiziale delle tabelle millesimali, dichiarando cessata la materia del contendere relativamente alla delibera 10.7.89. Su impugnazione di Carlo e Caterina S., che insistevano per la dichiarazione di nullità delle delibera 12.10.89 e 27.6.90, nella parte in cui avevano modificato le tabelle millesimali per il riparto delle spese del servizio di ascensore nonchè per la nullità di ogni altra delibera che avesse comunque modificato le predette tabelle senza il consenso unanime degli aventi diritto, la Corte di appello di Milano, con sentenza 12.5.2000, respingeva l'appello. Precisato che la sola questione controversa fra le parti riguarda la ripartizione delle spese di gestione dell'ascensore della scala C; afferma la Corte d'appello, per quanto riguarda gli ascensori, che la presunzione di comproprietà fra i condomini dell'impianto, è fondata sulla relazione strumentale necessaria fra esso e l'uso comune e poichè la destinazione al soddisfacimento dell'interesse dei partecipanti al Condominio, non ha per tutti pari intensità, ma varia in funzione del piano in cui si trova la porzione di proprietà esclusiva del singolo Condominio, il criterio di ripartizione delle spese, secondo la misura della partecipazione alla comproprietà del bene da parte dei singoli deve essere coordinato con quello della proporzione dell'uso che ciascuno può farne; per cui il principio desumibile dall'art. 1117 c.c. deve essere coordinato con quello stabilito dall'art. 1123 2 e 3 c. C. Civ. che individua il criteriodi riparto in base all'uso differenziato (in particolare all'uso virtuale e non a quello effettivo); - e la disciplina applicabile agli ascensori deve essere analoga a quella stabilita per le scale dall'art. 1124 C. Civ. il quale rappresenta una applicazione della regola generale stabilita dall'art. 1123 2 e 3 c. C. Civ.. - Aggiunge la Corte d'appello che se per le spese di conservazione delle parti comuni, essendo diretta alla tutela della integrità del valore capitale, può in astratto, ammettersi che esse siano dovute in proporzione alla quota di comproprietà; ciò non può ammettersi per le spese attinenti al godimento delle cose comuni, in quanto esse scaturiscono dall'uso, sicchè legittimo è il criterio stabilito con la delibera 12.10.89, ribadito nella successiva delibera del 27.6.90 (cioè 50% dei millesimi di proprietà e 50% in base ai piani). Irrilevante, per la Corte d'appello, è la circostanza che l'impianto sia stato realizzato mediante differenti contribuzioni volontarie da parte dei condomini dal momento che il criterio della proporzionalità alle sole quote di proprietà, non è idoneo a rappresentare la misura secondo cui ciascun condomino gode e fa uso dell'impianto. Con riferimento alla mancanza di una determinazione convenzionale dei valori immobiliari delle porzioni di proprietà esclusiva, afferma la Corte d'appello che il rapporto fra il valore della proprietà dell'intero edificio e quello della proprietà singola, esiste indipendentemente dalla formazione della tabella millesimale; e che l'assemblea, anche in assenza di un regolamento che fissi i criteri, ha il potere di stabilire la ripartizione delle spese fra i condomini; cosicchè nella fattispecie in esame, in cui non si deduce che per le spese dell'ascensore si siano consolidati, con effetti negoziali vincolanti, criteri di ripartizione diversi, del tutto legittimi sono i criteri richiamati nella delibera 12.10.89 tanto più che i valori dei piani espressi in millesimi esistono di fatto e sono applicati da anni senza contrasti. Quanto, infine, alla dedotta ingestibilità" delle "tabelle ascensore" predisposte dal C.T.U. (perchè non esisterebbe una caratura millesimale delle unità immobiliari in 23 base al "valore di piano o porzione di piano") afferma la Corte d'appello che l'inconveniente, ove fosse di fatto ravvisabile, non produrrebbe alcun effetto pregiudizievole, in quanto il Tribunale ha escluso che quelle tabelle avessero immediata efficacia per i condomini, in mancanza di consenso da parte di tutti. Avverso tale sentenza ricorrono in Cassazione Carlo e Caterina S. -Resiste con controricorso il M. Nessuna attività difensiva hanno svolto gli intimati. Motivi della decisione Deducono i ricorrenti a motivo di impugnazione: la violazione e falsa applicazione degli artt. 1100, 1123, 1124 Cod. Civ. in relazione all'art. 360 N 3 c.p.c.. - per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto, conformemente al Tribunale, applicabile, quale criterio di ripartizione delle spese di conservazione e manutenzione dell'ascensore, quello stabilito con la delibera 12.10.89 approvata con 553,71 voti e cioè in base al 50% dei millesimi di proprietà e al 50% del valore dei piani, NONOSTANTE: a) in mancanza dell'unanimità dei consensi, trattandosi di ascensore (realizzato dopo 50 anni dall'edificazione dello stabile) oggetto di una comunione le cui quote sono espresse dalla misura della spesa con cui ciascuno concorse alla sua realizzazione, il criterio diripartizione delle spese non può che essere dettato dall'art. 1101 2^ c. c.c., norma ripresa dall'art. 1123 1^ c. c.c. non essendo applicabile il criterio dell'art. 1123 c. 2^ e 3 cod. civ., di cui l'art. 1124 c.c. è specificazione, norme queste ultime disciplinanti le spese relative agli impianti sorti contemporaneamente alla costruzione dell'edificio condominiale; b) il riparto delle spese in base all'uso differenziato ex art. 1123 2 c.c. civ. NON sia applicabile alle spese generali; c) il regolamento condominiale prescinda da qualsiasi determinazione dei "valori di piano" C quindi non sia possibile ripartire le suddette spese, senza la previa determinazione dei "valori di piano"da effettuarsi ex novo con criteri oggettivi, predeterminati e condivisi da tutti i condomini interessati. Il ricorso è infondato. Non merita, infatti, alcuna censura la decisione della Corte d'appello che, in conformità alla dottrina e giurisprudenza prevalente e consolidata, ha ritenuto legittimo il criterio di ripartizione delle spese di conservazione e manutenzione dell'ascensore, approvato con la delibera 12.10.89, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1124 Cod. Civ., per la ripartizione delle spese relative alle scale; norma ritenuta applicabile in via analogica, in virtù della medesima ratio, alla fattispecie avente ad oggetto l'ascensore, per la cui disciplina manca una specifica norma. Non derogando, inoltre, l'art. 1124 C. Civ. ai criteri generali previsti dall'art. 1123 C. Civ., (il valore e l'utilità); ed incidendo sulle spese di manutenzione il logorio dell'impianto, (maggiore in funzione dell'altezza dei piani), del tutto legittima deve ritenersi la delibera assembleare, in mancanza, come specificato dalla stessa Corte di appello, di criteri convenzionali che deroghino a quelli stabiliti dalle legge. Il rilievo, poi, secondo il quale il criterio di ripartizione delle spese di cui all'art. 1224 C. Civ., sarebbe applicabile solo nell'ipotesi in cui l'ascensore fosse stato installato originariamente con la costruzione dell'edificio, e non, invece, quando, come nella specie, sia stato installato in un secondo tempo, è affermazione dei ricorrenti che prescinde dall'accertamento di fatto di cui in sentenza, dal quale si evince che l'installazione dell'ascensore, fu sì successiva alla costruzione dell'edificio, ma avvenne con il consenso di tutti i condomini, sia pure con il 24 contributo finanziario differenziato degli stessi. Ciò comporta: la proprietà comune condominiale dell'impianto, già considerato tale ai sensi dell'art. 1117 N. 3 Cod. Civ., in mancanza di titolo contrario; nonchè, ai sensi dell'art. 1118 C. Civ., il diritto di ciascun condominio sullo stesso, proporzionato al valore del piano o porzione di piano di proprietà esclusiva. Ne consegue, con riferimento alla ripartizione delle spese, l'applicabilità alla fattispecie dei criteri previsti dall'art. 1123 C. Civ., dei quali la disciplina stabilita dall'art. 1124 c.c., è una specifica applicazione, come precisata correttamente nella sentenza impugnata. Erra, pertanto, il ricorrente nel ritenere applicabile alla fattispecie l'art. 1101 2 c. Cod. Civ., dal momento che, essendo stato l'ascensore installato con il consenso e la spesa di tutti i condomini, la comproprietà sullo stesso è comune a tutti i condomini, a nulla rilevando a tal fine il differente contributo finanziario degli stessi, contributo che ove accertato, per ciascun condomino di entità maggiore della quota di comproprietà non può che dar luogo ad un diritto di credito del singolo, verso il condominio. Lo stesso, comunque, è a dirsi anche in relazione alla ritenuta (dai ricorrenti) applicabilità dell'art. 1101 2^ c. Cod. Civ., considerato che, nella comunione le quote di comproprietà, in mancanza di titolo contrario, si presumono uguali, e coloro che hanno pagato in più, possono vantare solo un credito verso gli altri comunisti. Infondato è, infine, il rilievo sub c) del motivo in esame, dal momento che, come la giurisprudenza di questa Corta ha affermato (v. sentt. 6202/98; 431/90; 5794/83), l'esistenza della tabella millesimale non costituisce requisito di validità delle delibere assembleari, dato che il criterio per la determinazione delle singole quote preesiste alle tabelle, derivando dal rapporto tra il valore dell'intero edificio e quello della proprietà singola; rapporto che, nella specie come indicato dalla Corte d'appello, è stato di fatto determinato ed applicato. Il ricorso va, quindi, respinto. Segue alla soccombenza la condanna dei ricorrenti al pagamento in favore della controparte, delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle controparti, spese liquidate in E. 100,00 oltre E. 1000,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 30 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2005. VENDITA A PREZZO IRRISORIO TRACCIA: Tizio è un anziano signore, che da diversi anni vive in una casa di riposo. Tizio è molto affezionato a Caio, giovane medico, al punto da volergli vendere una villa in Portofino a prezzo molto basso. 25 Tizio è senza eredi e vuole, prima di morire, liberarsi della suddetta villa proprio per rendere contento Caio che è giovane e promettente. Caio e Tizio, così, si recano dal notaio Romolo Romani, che stipula l'atto di vendita, precisando che il bene viene venduto ad un prezzo molto basso (circa ad 1/3 del valore effettivo) per volontà dello stesso Tizio. Dopo circa due anni dalla stipula, inaspettatamente, Tizio fa recapitare una raccomandata con ricevuta di ritorno a Caio, dove viene scritto che il suddetto contratto di compravendita sarebbe nullo, in quanto trasferimento patrimoniale senza causa; l'assenza del prezzo serio in favore di un prezzo irrisorio o simbolico determinerebbe la nullità del contratto: non sarebbe possibile porre in essere una vendita valida ad un prezzo irrisorio. Caio si reca da un legale. Il candidato rediga motivato parere in favore di Caio. POSSIBILE SOLUZIONE: In premessa poteva risultare utile ricostruire sinteticamente il fatto. Successivamente era utile entrare nel cuore del problema giuridico: il prezzo irrisorio può rendere l'atto nullo? La mancanza del prezzo serio è causa di nullità del contratto ex art. 1418 c.c.? Secondo parte minoritaria della dottrina, il problema andrebbe risolto in termini positivi: il prezzo serio sarebbe elemento essenziale del contratto, in quanto oggetto contrattuale; quando vi è una vendita le prestazioni sono il trasferimento del bene ed il corrispettivo economico, così che l'oggetto sarebbe la prestazione del trasferimento dell'immobile per il venditore, e del pagamento del corrispettivo per l'acquirente. In questo senso è stato detto che l'oggetto contrattuale sarebbe anche il prezzo, che deve essere serio per non vulnerare la struttura e ratio del contratto stesso di vendita. Tale tesi, tuttavia, non è condivisibile perchè entra in contrasto con la lettera della legge, che laddove parla di oggetto, ex art. 1346 c.c, richiede che sia possibile, lecito, determinato o determinabile, senza alcun riferimento alla serietà. La giurisprudenza prevalente opta per questa seconda ricostruzione, precisando che la pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa compravenduta, ma non privo del tutto di valore intrinseco, può rilevare sotto il profilo dell'individuazione del reale intento negoziale delle parti e della effettiva configurazione ed operatività della causa del contratto, ma non può determinare la nullità del medesimo per la carenza di un requisitio essenziale. Così, nel caso di specie, la vendita della villa di Portofino non è nulla, ma al più può rivelare all'interprete che si tratta di una vendita mista a donazione (oppure donazione rimuneratoria), soprattutto in considerazione dello spirito di liberalità che sembra aver animato Tizio (si dice che Tizio vuole liberarsi della villa); nella vendita mista a donazione è dubbio se possa trovare applicazione la disciplina giuridica relativa all'istituto che sembra prevalere (nel caso di specie la donazione), ovvero una disciplina giuridica mista (in parte quella della vendita ed in parte quella della donazione). In entrambi i casi, tuttavia, la disciplina giuridica della donazione potrebbe trovare applicazione (seppure in misura ridotta, con riferimento alla tesi mista), con la consegunza applicativa che Caio potrebbe vedersi revocare la villa di Portofino, ex art. 800 c.c. In un'ottica difensiva della posizione di Caio sarebbe possibile sottolineare il fatto 26 che l'atto di trasferimento è una vendita (Romolo Romani ha realizzato un atto di vendita) e non donazione, così che le forme utilizzate nell'atto deporrebbero proprio nel senso della vendita, tanto più che vi è stato un corrispettivo economico; inoltre, se del caso, comunque, Tizio dovrebbe dimostrare una delle cause ex art. 800 c.c. che, allo stato, non sembrano sussistere. PRELIMINARE PER PERSONA DA NOMINARE TRACCIA: Tizio è proprietario dell'immobile Alfa; Caio vorrebbe acquistare l'immobile Alfa e si mette in contatto con il proprietario. Tizio chiede a Caio, per la vendita dell'immobile Alfa, il prezzo di 200.000,oo euro; Caio ritiene il prezzo troppo alto e la vendita non si realizza. La moglie di Tizio conosce, casualmente ad una festa di amici, la moglie di Caio e ne nasce una profonda amicizia. Le due amiche, un giorno, litigano; Tizio, venuto a sapere dei fatti che avevano determinato il litigio, decide di non vendere per alcun motivo l'immobile Alfa a Caio, neanche laddove quest'ultimo avesse proposto un prezzo superiore a 200.000,oo euro. Caio, allora, chiede a Sempronio di mettersi in contatto con Tizio per fingersi interessato all'acquisto dell'immobile Alfa; Sempronio contatta Tizio e i due si incontrano per vedere l'immobile Alfa. Tizio chiede come corrispettivo della vendita dell'immobile Alfa la somma di euro 190.000,oo; Sempronio dice apertamente a Tizio che quell'immobile, invero, avrebbe un valore di gran lunga inferiore. Tizio e Sempronio non realizzano il contratto di compravendita dell'immobile Alfa. Qualche giorno dopo, Caio contatta Quarto, chiedendogli il favore di contattare, a sua volta, Tizio, per fingersi interessato all'acquisto dell'immobile Alfa; Tizio incontra Quarto, proponendogli la vendita dell'immobile Alfa al prezzo di euro 180.000,oo. Quarto spiega a Tizio che il prezzo sarebbe eccessivo per un immobile come Alfa del valore massimo di 100.000,oo euro. Dopo un mese, Caio chiede a Quinto di informarsi sul prezzo di vendita dell'immobile Alfa di proprietà di Tizio; Tizio e Quinto si incontrano. Tizio propone a Quinto di vendergli il bene al prezzo di 100.000,oo euro; Quinto accetta, firmando un preliminare per persona da nominare. Dopo sei mesi, allo scadere del preliminare, Quinto si presenta con Caio per firmare il contratto definitivo, davanti al notaio Romolo Romani, precisando di voler sciogliere la riserva di nomina e nominare Caio acquirente. Tizio va su tutte le furie e decide di non firmare alcunchè. Caio si reca da un legale. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere favorevole alla posizione del suo assistito. POSSIBILE SOLUZIONE: 27 In premessa poteva essere utile ricostruire (molto sinteticamente) il fatto. Subito dopo era necessario affrontare il discorso sulla validità o meno del preliminare per persona da nominare. E’ possibile realizzare un contratto preliminare per persona da nominare? Secondo l’orientamento minoritario e più datato al quesito andrebbe data risposta negativa, perché non sarebbe ammesso uno sfalsamento soggettivo tra preliminare e definitivo, argomentando ex art. 2932 c.c. In particolare, si dice, dall’art. 2932 c.c. sembrerebbe potersi desumere un principio relativo al fatto che tra preliminare e definitivo dovrebbe sussistere una perfetta coincidenza sia soggettiva che oggettiva; se, infatti, il giudice può emettere una sentenza che produce gli effetti “del contratto non concluso”, allora, il contratto definitivo non potrebbe essere diverso (nel contenuto soggettivo o oggettivo) dal preliminare, altrimenti la sentenza del giudice non potrebbe mai avere il significato di sostituire l’adempimento. In altri termini, poiché il giudice può emettere solo una sentenza sostitutiva dell’adempimento (quando possibile e non escluso dal titolo), allora, il contenuto dello stesso adempimento deve essere già predeterminato nel preliminare; diversamente argomentando, sarebbe vulnerata la ratio dell’art. 2932 c.c. ed il giudice non potrebbe mai emettere la sentenza suddetta, perché il definitivo potrebbe sempre avere differenze rispetto al preliminare (che solo la comune volontà delle parti potrebbero determinare). Tale testi, invero, è stata abbandonata sia perché il contratto preliminare è una figura generica e, come tale, compatibile con diversi schemi negoziali (preliminare a favore di terzo, preliminare di cosa altrui, secondo qualche voce isolata anche contratto preliminare di preliminare - quindi compatibilità giuridica anche con se stesso - ), e sia perché l’art. 2932 c.c. non impone un obbligo al giudice, così che lo strumento dell’esecuzione specifica di concludere un contratto è uno strumento ulteriore rispetto a quelli classici; sotto il secondo profilo, precisamente: se non vi è un obbligo vuol dire che non vi è un principio inderogabile, tanto più che lo stesso articolo 2932 c.c. sembra ammettere deroghe, laddove dice “qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo”. In questo senso, pertanto, la giurisprudenza più recente ammette la figura del preliminare per persona da nominare, con la conseguenza applicativa che, in base a tali rilievi argomentativi, nel caso di specie, il contratto realizzato tra Tizio e Quinto sarà pienamente valido ed efficace. Risolto tale quesito interpretativo, allora, bisognava chiedersi: il comportamento posto in essere da Caio è legittimo, ovvero rischia di essere illegittimo (con eventuale annullabilità del preliminare per dolo, nonché possibile responsabilità precontrattuale (a cui si applica, secondo l’orientamento prevalente, la disciplina giuridica della responsabilità aquiliana), sub specie di violazione della buona fede)? Invero, in un’ottica difensiva, si potrebbe dire che il comportamento posto in essere da Caio difficilmente potrebbe essere qualificato come dolo, ex art. 1439 c.c., in quanto l’atteggiamento psicologico non era volto a danneggiare Tizio (dolo intenzionale), ma semplicemente ad acquistare un bene ad un prezzo vantaggioso; seppur, infatti, il comportamento di Caio può essere stato volto a raggirare il venditore Tizio (facendo “credere esistente l’inesistente”, sulla falsariga della truffa contrattuale ex art. 640 c.p.), non è stato, comunque, volto a danneggiarlo, con la conseguenza applicativa che ben si potrebbe versare nell’ipotesi di dolo consentito (o lecito), ove il fine è semplicemente quello di ottenere un bene a condizioni economiche vantaggiose: sarebbe un dolus bonus 28 (come nell’ipotesi in cui l’acquirente dice al venditore che il bene oggetto del futuro acquisto è venduto da terzi commercianti a prezzo inferiore a quello proposto dal venditore stesso). Sotto tale profilo interpretativo, quindi, Caio potrebbe non vedere annullato il suo contratto. Per quanto attiene all’ipotesi di possibile responsabilità precontrattuale cagionata da Quarto e Sempronio, poi, non sembra desumersi dal fatto che le trattative avevano raggiunto un livello talmente avanzato da ingenerare incolpevole affidamento sull’effettività dell’accordo con Tizio. Inoltre, sotto un profilo difensivo, ben si potrebbe dire che la buona fede, ex art. 1337 c.c., non si riferisce ad una trasparenza assoluta nel rapporto negoziale, che è fisiologicamente deputato a presentare luci ed ombre (in quanto entrambi i contraenti cercano di avere il maggiore guadagno economico possibile), ma ad un comportamento complessivamente lecito, che ben si concilia con il dolus bonus di cui si è detto. Il fatto, poi, che Tizio non avrebbe mai voluto vendere l’immobile non può assumere un significativo valore giuridico, non trattandosi di contratti intuitu personae, con la conseguenza logico-deduttiva che, tendenzialmente, non rileva la persona dell’acquirente, ma il solo vincolo obbligatorio. Sotto tali profili ricostruttivi, pertanto, Caio potrebbe aver acquisito legittimamente e validamente l’immobile Alfa. Si consiglia di leggere le sentenze che seguono, le quali, seppur non attinenti al caso proposto, possono essere utili a conoscere gli orientamenti giurisprudenziali più recenti. -Preliminare di cosa altrui: il promissario acquirente, laddove venga a sapere che il bene oggetto di trasferimento non sia del promittente alienante, non può legittimamente rifiutare l'acquisto. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILE SENTENZA 18 maggio 2006, n. 11624 (Presidente Carbone – Relatore Bucciante) Svolgimento del processo Con sentenza del 18 marzo 1998 il Tribunale di Pistoia ha Pronunciato la risoluzione, per inadempimento di Mirella P., di un contratto preliminare con il quale costei si era obbligata a vendere a Wladimiro L. e Teresa V. un podere con casa colonica sito in Larciano, e ha condannato la promittente alienante alla restituzione degli acconti ricevuti, nella misura di lire 17.000.000, nonché al rimborso delle spese di giudizio. 29 Impugnata in via principale da Wladimiro L. e Teresa V., incidentalmente da Mirella P., la decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Firenze, che con sentenza del 21 marzo 2000, in parziale accoglimento di entrambi i gravami, ha dichiarato il contratto risolto per inadempimento del L. e della V., ha rideterminato in lire 16.000.000 la somma che doveva essere loro rimborsata, ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento di danni formulata dalla P., ha posto a carico degli appellanti principali metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio, compensandole tra le parti per l’altra metà. A queste pronunce il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo: che «unica ragione della mancata stipula va ricondotta alla mancata proprietà del bene da parte della promittente venditrice, ma appare pacifico che in realtà anche tale questione era stata risolta precedentemente (il che assorbe ogni rilievo relativo all’effettiva conoscenza di tale altruità da parte dei L.) essendosi la P. presentata munita di procura a vendere del tutto rituale, relativa al bene de quo e rilasciata dai proprietari due giorni prima e davanti allo stesso notaio»; che «è d’altronde indiscusso che in caso di preliminare di vendita l’obbligo del promittente venditore è quello di procurarsi la proprietà del bene o di ottenere dal proprietario il consenso o l’autorizzazione alla vendita – Cassazione, 3677/96; 367/77; 8228/90 per cui non è dato vedere cosa possa imputarsi alla P. che era perfettamente in grado di vendere il bene alla data prefissata»; che «né può sostenersi come sembrano fare i L. che essi acquistando da “altri” potevano risultare meno garantiti, rispetto alla P.: invero nei loro confronti e in relazione alle garanzie loro spettanti per legge, unico interlocutore era e restava la P. personalmente e direttamente, per cui solo sulla P. continuavano a ricadere tutte le garanzie in materia di vizi o di evizione v. Cassazione, 3963/84»; che «non vi è alcuna prova (che la P. nemmeno ha chiesto di fornire)», in ordine ai danni da lei lamentati. Wladimiro L. e Teresa V. hanno proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. Mirella P. si è costituita con controricorso, formulando a sua volta due motivi di impugnazione in via incidentale, e ha depositato una memoria. Motivi della decisione In quanto proposte contro la stessa sentenza, le due impugnazioni vanno riunite in un solo processo, in applicazione dell’articolo 335 Cpc. Con il motivo addotto a sostegno del ricorso principale Wladimiro L. e Teresa V. lamentano che la Corte di appello «ha applicato il disposto dell’articolo 1478 Cc anziché quanto previsto dall’articolo 1479 Cc», pur se «al momento della sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita la Sig.ra P. Mirella non aveva messo a conoscenza i promittenti acquirenti che l’immobile fosse di proprietà di altri» e in tali casi «è possibile per il compratore chiedere la risoluzione del contratto salvo che il venditore non abbia, nel frattempo, acquistato la proprietà della cosa», mentre «nella fattispecie ciò era tanto più importante perché esistevano, come è stato riconosciuto da tutti i tenti, problemi di esercizio del diritto di prelazione da parte di terzi, con la conseguenza che i ricorrenti non avrebbero più avuto la garanzia da parte del loro originale contraddittore e promittente venditore». Secondo i ricorrenti principali, pertanto, 30 Mirella P. avrebbe dovuto acquistare lei stessa l’immobile in questione e poi trasferirlo a loro, sicché legittimamente avevano rifiutato di farselo alienare direttamente dagli effettivi proprietari, per il tramite della stessa P. in veste di loro procuratrice. In ordine alle modalità di adempimento dell’obbligazione assunta dal promittente venditore di una cosa altrui, nella giurisprudenza di legittimità è insorto un contrasto, per la cui composizione la causa è stata assegnata alle Sezioni unite. In prevalenza, questa Corte si è orientata nel senso che la prestazione può essere eseguita, indifferentemente, acquistando il bene e ritrasmettendolo al promissario, oppure facendoglielo alienare direttamente dal reale proprietario, in quanto l’articolo 1478 Cc relativo al contratto definitivo di vendita di cosa altrui, ma applicabile per analogia anche al preliminare dispone che il venditore «è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore», il che può ben avvenire anche facendo al che il terzo, al quale il bene appartiene, lo ceda egli stesso al promissario (v., tra le più recenti, Cassazione, 13330/00, 2656/01, 15035/01, 21179/04, 24782/05). Talvolta si è però deciso che l’obbligazione in questione deve invece essere adempiuta acquistando il bene e ritrasferendolo, in particolare nel caso in cui l’altra parte non fosse stata consapevole dell’altruità, poiché l’articolo 1479 Cc – anch’esso dettato per la vendita definitiva, ma estensibile a quella preliminare abilita il compratore a «chiedere la risoluzione del contratto, se, quando l’ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà» (v. Cassazione 7054/90, 2091/99, relative, rispettivamente, a un contratto definitivo e a uno preliminare di vendita di cosa altrui). Ritiene il collegio che debba essere seguito l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario. Stante la latitudine delle citate previsioni normative, non vi è ragione per escludere che la prestazione possa essere eseguita “procurando” il trasferimento del bene direttamente dall’effettivo proprietario, senza necessità di un doppio trapasso; il comma 2 dell’articolo 1478 menziona bensì l’acquisto che eventualmente compia l’alienante, nel caso di vendita (definitiva) di cosa altrui, ma come una particolare modalità di adempimento, alla quale eccezionalmente riconnette l’effetto di far diventare senz’altro proprietario il compratore. Né una diversa soluzione può essere adottata per il caso in cui il promissario avesse ignorato, al momento della conclusione del preliminare, la non appartenenza del bene al promittente. Il disposto dell’articolo 1479 Cc, che consente al compratore in “buona fede” di chiedere la risoluzione del contratto, è coerente con la natura di vendita definitiva del negozio cui si riferisce, destinato, nell’intenzione delle parti, a esplicare quell’immediato effetto traslatIvo che è stabilito dall’articolo 1376 Cc, ma è impedito dall’altruità della cosa: altruità che invece non incide sul sinallagma instaurato con il contratto preliminare, il quale ha comunque efficacia soltanto obbligatoria, essendo quella reale differita alla 31 stipulazione del definitivo, sicché nessun nocumento, fino alla scadenza del relativo termine, ne deriva per il promissario. Dall’articolo 1479 Cc, pertanto, non può desumersi che egli sia abilitato ad agire per la risoluzione e quindi ad opporre l’exceptio inadimpleti contractuo se l’altra parte, nel momento in cui vi è tenuta, é comunque in grado di fargli ottenere l’acquisto, direttamente dal proprietario. D’altra parte, il ritenere esatta tale modalità di adempimento è in sintonia con l’essenza e la funzione del contratto preliminare di vendita, quali sono state individuate nelle più recenti elaborazioni dottrinali, che hanno superato la concezione tradizionale dell’istituto e che qualche riflesso hanno avuto anche in giurisprudenza. Il contratto preliminare non è più visto come un semplice pactum de contrahendo, ma come un negozio destinato già a realizzare un assetto di interessi prodromico a quello che sarà compiutamente attuato con il definitivo, sicché il suo oggetto è non solo e non tanto un facere, consistente nel manifestare successivamente una volontà rigidamente predeterminata quanto alle parti e al contenuto, ma anche e soprattutto un sia pure futuro dare: la trasmissione della proprietà, che costituisce il risultato pratico avuto di mira dai contraenti. Se il bene già appartiene al promittente, i due aspetti coincidono, pur senza confondersi, ma nel caso dell’altruità rimangono distinti, appunto perché lo scopo può essere raggiunto anche mediante il trasferimento diretto della cosa dal terzo al promissario, il quale ottiene comunque ciò che gli era dovuto, indipendentemente dall’essere stato o non a conoscenza della non appartenenza della cosa a chi si era obbligato ad alienargliela. Né vale obiettare che l’identità del venditore, come i ricorrenti principali deducono, non è indifferente per il compratore, il quale può risultare meno tutelato, relativamente all’evizione e ai vizi. in proposito, in consonanza con le menzionate opinioni dottrinali, la giurisprudenza si é orientata nel senso che la conclusione del definitivo, per tali profili, non assorbe né esaurisce gli effetti del preliminare, il quale continua a regolare i rapporti tra le parti, sicché il promittente alienante resta responsabile per le garanzie di cui si tratta (v., da ultimo, Cassazione, 15035/01). Si deve quindi affermare che il promittente venditore di una cosa che non gli appartiene, anche nel caso di buona fede dell’altra parte, può adempiere la propria obbligazione procurando l’acquisto del promissario direttamente dall’effettivo proprietario. Alla stregua di questo principio, il ricorso principale va rigettato, dovendoci riconoscere che la «Corte di appello correttamente ha ritenuto superfluo accertare se Wladimiro L. e Teresa V. fossero stati inizialmente ignari dell’altruità dell’immobile in questione, essendo anche in tale ipotesi ingiustificato il loro rifiuto di addivenire alla conclusione del contratto definitivo, dato che Mirella P. si era munita di una procura rilasciatale, dagli effettivi proprietari del bene, che la abilitava a effettuarne la vendita in nome loro. Con il primo motivo del ricorso incidentale, si deduce che la Corte d’appello ha dichiarato la risoluzione del contratto preliminare de quo per inadempimento di controparte senza condannarla al risarcimento del danno richiesto che 32 all’inadempimento consegue per legge non tenendo conto che tale domanda di risarcimento del danno. che spetta in ogni modo alla Comparente, era stata avanzata anche in via equitativa». La doglianza va disattesa, poiché con la sentenza impugnata si è rilevato che nessuna prova, in ordine ai danni asseritamente subiti, era stata data né offerta da Mirella P.: prova che comunque avrebbe dovuto essere fornita, relativamente all’an poiché è soltanto per la determinazione del quantum che si può fare luogo alla liquidazione in via equitativa, ove non ne sia dimostrabile il preciso ammontare (v., per tutte, Cassazione, 16112/05). Con il secondo motivo del ricorso incidentale Mirella P. lamenta che «una volta liquidate come da dIspositivo le spese di primo e secondo grado la Corte di appello non ha imposto a controparte la restituzione delle some che le erano state liquidate a titolo di spese legali dal Primo giudice». Neppure questa censura può essere accolta, in quanto dalle conclusioni riportate nell’epigrafe della sentenza impugnata risulta che la domanda di restituzione di cui si tratta non era stata formulata. Anche il ricorso incidentale deve essere pertanto rigettato. Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, in considerazione della reciproca loro soccombenza. PQM La Corte riunisce i ricorsi; li rigetta entrambi; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 16 marzo 2006. Depositata in cancelleria il-18 maggio 2006. -In tema di contratto preliminare di vendita, il promittente acquirente che abbia versato la caparra confirmatoria, dopo aver chiesto che si accerti l’intervenuta risoluzione di diritto del contratto, non può chiedere che la controparte venga condannata a corrispondergli un importo pari al doppio della caparra, perché ciò presupporrebbe il contestuale esercizio del diritto di recesso da un contratto ancora esistente tra le parti. Cassazione, sez. II civile, sentenza 02.12.2005 n° 26232 La Corte suprema di Cassazione Sezione Seconda civile Sentenza n° 26232/05 33 Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato il 05.05.1986 Vittorino C. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Firenze Maria S. perché fosse dichiarata la risoluzione per inadempimento a lei addebitabile, del contratto preliminare dagli stessi stipulato il 18.12.1985, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni quantificati in L. 40.000.000, oltre interessi. Assumeva l’attore che l’inadempimento si riferiva alla clausola concordemente aggiunta in data 27.01.1986, con la quale veniva stabilito di rinviare al 28.02.1986 sia la data di immissione nel possesso dell’immobile in favore di Vittorio C., promissario acquirente; sia il termine per l’adempimento da parte della Simon dell’obbligazione assunta, quale promittente venditrice, di effettuare i lavori di risanamento dell’appartamento per i danni verificatisi nel dicembre del 1985 a causa della rottura delle condutture di scarico dell’appartamento sito al piano sovrastante; obbligazione in ordine alla quale la convenuta si era resa inadempiente nonostante la diffida ad adempiere notificatale il 06.03.1986. Costituitasi, la convenuta contestava l’inadempimento addebitatole eccependo che inadempiente doveva considerarsi l’attore che insisteva nel pretendere l’esecuzione di opere diverse ed estranee all’impegno assunto. Espletata C.T.U. ed assunte prove testimoniali, il Tribunale, con sentenza 13.08.1999 dichiarava risolto il contratto preliminare per inadempimento della convenuta che veniva condannata al pagamento del doppio della caparra a suo tempo ricevuta, e cioè a L. 40.000.000, oltre interessi legali. Su impugnazione della Maria S., la Corte di Appello di Firenze, con sentenza 11.06.2001 respingeva l’impugnazione. Afferma la Corte che la promittente venditrice, a seguito della diffida, avrebbe dovuto comunque a quanto pattuito con la clausola aggiuntiva, cioè ad eseguire le opere di risanamento, per eliminare i danni riportati dall’immobile a seguito delle infiltrazioni dal piano superiore; ed ad immettere l’attore nel possesso dell’immobile; dovendo il pagamento della seconda rata di prezzo essere effettuata con la presa in consegna dell’immobile. La Maria S., viceversa, è rimasta, per la Corte, inadempiente, adducendo che il Vittorio C. pretendeva da lei l’esecuzione di opere diverse da quelle necessarie per l’eliminazione dei danni da infiltrazioni, pretesa non risultante dalla diffida ed il cui accertamento è irrilevante a fronte della inattività della Maria S. Afferma, inoltre, la Corte, al legittima applicazione dell’art. 1385 II° co. c.c. fatta dal Tribunale, nel condannare la Maria S. al pagamento del doppio della caparra ricevuta, trattandosi del legittimo esercizio di un perdurante diritto di recesso rispetto alla domanda originaria di risoluzione del contratto. Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione la Maria S. Resiste con controricorso Vittorio C. La Maria S. ha depositato memoria Motivi della decisione Deduce la ricorrente a motivi di impugnazione. 1) La violazione degli artt. 1362, 1363, 1324, 1360 c.c., vizio di motivazione ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per avere la Corte di Appello nell’affermare che la diffida 13.03.1986 inviata alla Maria S. si riferiva solo all’esecuzione di quei lavori previsti nella clausola aggiuntiva, di risanamento del quartiere per i danni provocati dalle infiltrazioni di acque luride dal piano sovrastante; e che da tale diffida non si evinceva la pretesa del Vittorio C. di eseguire opere esorbitanti dall’obbligo assunto, erroneamente, a favore di una clausola formulata in termini 34 generici, senza alcuna specificazione dei lavori necessari e sufficienti allo scopo di risanare il quartiere da quei danni, proceduto ad una interpretazione pedissequamente letterale e parziale della diffida, non tenendo conto delle premesse costituenti parte integrante della stessa dalle quali si evinceva, secondo le conclusioni del C.T. di parte, che le infiltrazioni avevano gravemente danneggiato parte dei solai in legno (in particolare dell’ex cucina), danno escluso poi dal C.T.U., omettendo ogni indagine sulla comune intenzione delle parti ed ogni valutazione del comportamento delle stesse, anche posteriore alla conclusione del contratto; trascurando di interpretare le clausole contrattuali le une per mezzo delle altre. 2) La violazione o falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. e 184 c.p.c. il vizio di motivazione ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per aver la Corte di Appello, nonostante l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dalla Maria S. nel 1° grado di giudizio oggetto di specifico motivo di impugnazione di appello, erroneamente omesso di procedere ad una valutazione comparativa del comportamento inadempiente delle parti, non accertando, da un lato, se i lavori di ripristino pretesi dal Vittorino C. fossero eccedenti le necessità di risanamento cui la Maria S. era tenuta e se tale pretese giustificasse il timore della Maria S. che il Vittorio C. si sarebbe astenuto dal pagamento: a) a negare che il Vittorio C. avesse avanzato pretese eccessive (sulla base di una interpretazione scorretta dalla diffida; b) a negare rilievo a tali ulteriori pretese e conseguentemente a ritenere inammissibile la prova sul punto; c) a ritenere, quindi, sufficiente, a respingere l’eccezione di inadempimento, la sola valutazione dell’inadempimento della Maria S. 3) La violazione o falsa applicazione dell’art. 1455 c.c., nonché il vizio di motivazione ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per aver la Corte di Appello erroneamente omesso ogni valutazione della gravità dell’inadempimento addebitato alla Maria S., nonostante tale valutazione fosse necessaria per il caso della risoluzione ex art. 1454 (diffida ad adempiere); e competesse d’ufficio al giudice 4) La violazione o falsa applicazione degli artt. 1385, 1453, 1454 c.c. il vizio di motivazione ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto legittimamente liquidato al Vittorio C., a titolo di danno, il doppio della caparra nonostante l’esecuzione dagli oneri probatori relativi all’esistenza ed all’entità del danno sia prevista in caso di esercizio del diritto di recesso e non in caso di risoluzione di diritto del contratto, avvenuta come nella specie con il decorso dei 20 giorni dalla diffida, in un caso, cioè in cui il contratto è già venuto meno ope legis e l’esercizio del diritto di recesso è ormai precluso. I primi tre motivi di ricorso, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. Essi sono infondati. Corretta è, infatti, la decisione della Corte di Appello che, a fronte di una totale inattività della promettente venditrice, che pur era contrattualmente obbligate ad effettuare lavori di ripristino per rendere abitabile l’appartamento oggetto del preliminare danneggiato dalle infiltrazioni d’acqua (ed all’uopo era stata espressamente diffidata con concessione di un termine ulteriore per adempiere) ha ritenuto di confermare la decisione di palese e totale inadempimento della Maria S., formulata dal primo giudice, considerando irrilevante indagare sulle ulteriori 35 pretese che il Vittorio C. avrebbe avanzato in difformità dei patti assunti. Accertato, infatti, dalla Corte territoriale che la Maria S. si era astenuta dall’eseguire qualunque lavoro di ripristino e che il Vittorio C. era tenuto al pagamento della seconda rata di prezzo solo alla immissione in possesso dell’appartamento reso abitabile, cioè in un momento successivo all’adempimento dalla promettente venditrice, questa non poteva opporre l’eccezione di inadempimento per giustificare la sua inattività, se non dimostrando l’evidente pericolo di perdere la controprestazione, pericolo che la Corte di Appello ha ritenuto di escludere ribadendo la volontà di adempiere del Vittorio C. espressa con l’intimazione di cui alla diffida ad adempiere dallo stesso inviata alla controparte. Quanto alla gravità dell’inadempimento imputato alla Maria S., la valutazione della Corte emerge dal rilievo della stessa dato al comportamento di totale inattività della ricorrente, venuta meno all’adempimento di una obbligazione, quella di consegnare l’immobile risanato dalle infiltrazioni, di primaria rilevanza per gli interessi della controparte. I primi tre motivi di ricorso vanno, conseguentemente, respinti. E’, viceversa, fondato il quarto motivo di ricorso. La Corte di Appello, in infatti, nel confermare la condanna della Maria S. al pagamento di favore di Vittorio C. della somma di L. 40.000.000 pari al doppio della caparra da quest’ultimo versata alla stipula del preliminare, ha motivato tale decisione richiamandosi a quel filone giurisprudenziale di questa Corte, che ritiene applicabile il II° comma dell’art. 1385 c.c. e, quindi, esperibile il recesso dal contratto, con l’esercizio dei relativi diritti in ordine alla caparra confirmatoria, anche quando si sia agito per la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno. Si ritiene, infatti, da detta giurisprudenza (V. sent. 7644/94), che in caso di versamento della caparra confirmatoria, chi ha agito per l’adempimento o per la risoluzione del contratto e la condanna al risarcimento danni, può far valere, anche in appello, i diritti di cui al II° comma dell’art. 1385 c.c., perché la modificazione della linea difensiva costituisce solo esercizio di una perdurante facoltà rispetto alla domanda di adempimento, ed una istanza più ridotta rispetto alla domanda di risoluzione, senza introduzione di domanda nuova ex art. 345 c.p.c. Ora, se nel caso di proposizione della domanda di adempimento sostenere il perdurare della facoltà di recesso dal contratto, facoltà cui sono collegati i diritti relativi alla caparra confirmatoria, è del tutto conforme ai principi di diritto, considerato che il recesso non è altro che una forma di scioglimento dal contratto e si è, quindi, in linea con il disposto del II° comma dell’art. 1453 c.c.; nel caso di proposizione della domanda di risoluzione e risarcimento danni, per le quali dispone espressamente il III° comma dell’art. 1385 c.c. con il prescrivere, quanto al danno, la necessità che esso sia provato secondo le regole generali, limitarsi a ritenere ammissibile l’esercizio dei diritti relativi alla caparra confirmatoria, di cui all’art. 1385 II° comma c.c. (perché si tratterebbe di far valere una istanza di danni più ridotta, rispetto a quella maggiore che si suppone esercitata con le azioni di cui all’art. 1385 III° comma c.c.), è argomento che può ritenersi utile a negare, con riferimento alla richiesta di danni, al proposizione di una domanda nuova; ma non spiega come possa, giuridicamente ritenersi ammissibile l’esercizio dei diritti connessi alla facoltà di recesso, recesso che la già avvenuta risoluzione di 36 diritto del contratto, reclude. Nel caso di specie, infatti, con la proposizione della domanda di risoluzione, il Vittorio C. espressamente richiamando gli effetti della diffida ad adempiere e, quindi, l’avvenuta risoluzione di diritto del contratto alla scadenza dei venti giorni concessi per adempiere e già decorsi al momento della proposta domanda di risoluzione, non poteva più esercitare il recesso e, quindi, far valere, con riferimento alla caparra confirmatoria, i diritti di cui all’art. 1385 II° comma c.c. Né la natura dichiarativa della sentenza che accerta la già avvenuta risoluzione di diritto del contratto, consente di affermare (dal momento che non c’è stata contestazione sulla validità ed efficacia della diffida) che il diritto di recesso può ancora essere esercitato fino al passaggio in giudicato della sentenza di risoluzione, come sostiene parte della dottrina e giurisprudenza. Tale argomento, semmai, potrebbe essere valido relativamente alla sentenza costitutiva di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.; ma non per le sentenze dichiarative, come quella oggetto del presente giudizio. Nella fattispecie di cui è causa, pertanto, il Vittorio C. non potendo esercitare il diritto di recesso non può pretendere ai sensi dell’art. 1385 II° comma c.c. il doppio della caparra conferita. Egli ha, tuttavia, diritto ad ottenere dalla parte inadempiente la restituzione della somma conferita di L. 20.000.000, somma che non si configura più come liquidazione convenzionale anticipata del danno; ma come somma indebitamente trattenuta dalla parte inadempiente, una volta venuta meno, con la risoluzione del contratto, la causa giustificativa della dazione, in piena aderenza con gli effetti restitutori propri della risoluzione contrattuale (V. sent. 8630/98, 3828/00). In accoglimento del quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata va, perciò, cassata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze che provvederà ad un nuovo esame della controversia, in relazione al motivo accolto, in applicazione dei principi esposti. PQM La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso; accoglie il quarto motivo; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Così deciso in Roma il 22.09.2004. Depositato in cancelleria il 02.12.2005. PROPOSTA IRREVOCABILE E OPZIONE TRACCIA: Tizio intende vendere la sua splendida collezione di mobili antichi; unico deciso ad acquistare è Caio il quale, però, non ha il denaro sufficiente, ma spera nella donazione di un ricco zio. Tizio e Caio, pertanto, si accordano (firmando una scrittura privata) nel senso che il primo si impegna verso il secondo, senza alcun corrispettivo, a tenere ferma la proposta di vendita, senza precisare alcun periodo di tempo. Dopo due mesi, Tizio vende la sua collezione di mobili antichi, sostenendo che la 37 proposta irrevocabile fatta era senza effetto. Caio si arrabbia molto, anche perchè aveva fatto una serie di rinunce economiche, nei due mesi successivi all'accordo; Caio si reca dal legale Sempronio. Il candidato assuma le vesti del legale Sempronio e rediga motivato parere favorevole al proprio assistito. POSSIBILE SCHEMA DI SOLUZIONE: In premessa poteva essere utile ricostruire sinteticamente il fatto. Subito dopo bisognava parlare della proposta irrevocabile (visto che la traccia fa riferimento a questo istituto): in linea generale si può dire che la proposta irrevocabile, ex art. 1329 c.c., è un atto unilaterale (sulla falsariga dell’offerta al pubblico), gratuito, con un termine (elemento essenziale). L’essenzialità del termine viene desunta, a contrario, dall’art. 1329 c.c.: la revoca è senza effetto, per cui non è possibile revocare la proposta solo se il proponente si è obbligato a “mantenere ferma la proposta per un certo tempo”, con la conseguenza logico-deduttiva che se non vi è la previsione di un termine la proposta è revocabile (e quindi non si tratta di proposta irrevocabile); id est, è possibile revocare ogni tipo di proposta se, in quest’ultima, non è stato previsto un termine di validità. In questo caso, allora, Tizio ben potrebbe revocare la proposta e vendere i mobili antichi a chiunque altro vi abbia interesse, proprio perché la proposta irrevocabile intercorrente tra Tizio e Caio era nulla. Tuttavia, l’avvocato Sempronio, favorevolmente al suo assistito Caio, potrebbe ricostruire la vicenda negoziale in termini diversi; in particolare, Tizio potrebbe aver stipulato con Caio un accordo di opzione, ex art. 1331 c.c., e non di proposta irrevocabile, con la conseguenza che il recesso potrebbe avvenire (come in tutti i contratti) solo per mutuo dissenso (ovvero altre cause non riaventi nella questione giuridica presa in esame). Si tratterebbe, in particolare di opzione (qui il termine può essere disposto di ufficio e non giustifica la revoca del proponente) perché vi sarebbe un accordo (diversamente dalla proposta irrevocabile in cui non vi è un accordo, ma un atto unilaterale), con la conseguenza applicativa che Tizio potrà far valere il suo diritto di prelazione sostanziale rispetto ad altri potenziali acquirenti. L’onerosità dell’opzione, poi, non sarebbe elemento essenziale di tale figura che influisce sulla sussistenza o meno della causa: l’opzione potrebbe essere anche gratuita, purchè corrisponda ad un interesse meritevole di tutela (qui l’interesse di Caio c’è, perché non aveva, al tempo della proposta, altri possibili acquirenti, per cui ha preferito autovincolarsi piuttosto che rischiare di non vendere i mobili antichi); ne segue che il fatto che la presunta proposta irrevocabile sia stata effettuata senza alcun corrispettivo non vuol dire che non possa trattarsi di opzione. In altri termini, ben potrebbe Sempronio sostenere che la suddetta vicenda negoziale rientri nell’opzione, con la conseguenza applicativa che, laddove Tizio abbia venduto a terzi i mobili antichi, sarà tenuto a risarcire i danni causati a Caio, sub specie di inadempimento contrattuale; vi è da segnalare che, come sostenuto da un certo orientamento, Caio potrebbe anche agire ex art. 2932 c.c. 38 MANDATO POST MORTEM TRACCIA: Tizio è un anziano signore di 90 anni; Tizio ha due figli: Tizietto e Tizietta. Tizio si accorda con Tizietto affinchè, alla morte del primo (Tizio), il secondo (Tizietto) si occupi della sepoltura, da effettuarsi nel cimitero di Torino (affianco al padre deceduto 30 anni prima). Tizio, poi, si accorda con Tizietta affinchè, alla morte del primo (Tizio), la seconda (Tizietta) erediti una parte significativa del patrimonio di famiglia, con la clausola che alla morte della stessa Tizietta lo stesso patrimonio dovrà essere trasferito alle suore di clausura di Torino, affinchè si occupino della tomba di famiglia. Tizio decede; Tizietto e Tizietta vengono a sapere dei rispettivi mandati realizzati in vita dal padre Tizio. Tizietta ritiene di dover avere una quota di eredità superiore a Tizio, proprio in virtù del mandato realizzato con il padre Tizio. Tizietto, al contrario, ritiene che il suddetto mandato non sia valido. Tizio si reca da un legale; il candidato rediga motivato parere sulla questione proposta. POSSIBILE SCHEMA DI SOLUZIONE: In premessa poteva essere utile ricostruire sinteticamente il fatto. Successivamente, si poteva accennare alla validità del mandato post mortem intercorso tra Tizio e Tizietto; tale mandato, avente ad oggetto le modalità delle sepoltura, non viola il divieto di patto successorio, ex art. 458 c.c., perché non si realizza una convenzione avente per oggetto la successione. Semplicisticamente: disporre le modalità della propria sepoltura (come ha fatto Tizio con Tizietto) non vuol dire disporre della successione. Si tratta, quindi, di un valido contratto (mandato post mortem exequendum), ex art. 1703 c.c., con cui una parte (Tizietto) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici (relativi alle modalità della sepoltura) per conto dell’altra (Tizio) dopo la morte di quest’ultima. Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza più recente (Cass. 12143/2006, sentenza riportata per esteso subito dopo il presente schema sintetico), argomentando, in particolare dall’art. 587 II comma c.c. Dopo, era possibile affrontare il discorso sulla validità del contratto di mandato realizzato tra Tizio e Tizietta; anche in questo caso si tratta di un mandato post mortem, ma con oggetto illecito. Precisamente, il mandato realizzato tra Tizio e Tizietta viola il divieto di patto commissorio, ex art. 458 c.c., perché ha per oggetto la successione e non le modalità della sepoltura; più da vicino: un mandato post mortem che ha per oggetto un trasferimento del patrimonio successorio alla morte del primo avente causa si traduce, nella sostanza, in una successione alla successione e, quindi, a 39 fortiori, in un accordo relativo alla propria successione. L’oggetto del contratto, pertanto, è illecito, con il corollario applicativo che il contratto realizzato tra Tizio e Tizietta sarà nullo, ex art. 1418 c.c. e art. 1346 c.c. Da questa angolazione prospettica, pertanto, la giustificazione causale addotta da Tizietta per spiegare la maggiore quota di eredità verrà meno, con la conseguenza logica-giuridica che, se del caso, andranno riviste le c.d. quote di legittima. Si consiglia di leggere la sentenza che segue. -Ogni persona fisica puo’ scegliere liberamente le modalita’ ed il luogo della propria sepoltura; la legge consente espressamente che tra le disposizioni testamentarie rientrino anche quelle a carattere non patrimoniale (art. 587, secondo comma c.c.). Tale scelta deve essere esercitata mediante conferimento di un mandato post mortem. Corte di Cassazione - Sezione I - Sentenza n. 12143 del 23/05/2006 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del… il Tribunale di Palermo, in accoglimento della domanda proposta da X, Y e Z, fratelli della defunta A, e nella contumacia di Tizio, coniuge di quest'ultima, dichiarava che la A aveva conferito mandato agli attori di essere sepolta nella tomba destinata ad accogliere le spoglie della famiglia ed ordinava a Tizio di consegnare, nel rispetto delle prescrizioni amministrative, la salma della congiunta per consentirne la tumulazione nella tomba loro assegnata. Avverso la decisione del Tribunale proponeva appello Tizio eccependo la nullita’ del giudizio di primo grado per essere nulla la notifica della citazione, e chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata. Si costituivano i germani X Y Z deducendo l'inammissibilita’ dell'appello per genericita’ dei motivi e chiedendone comunque il rigetto. Con sentenza del… la Corte d'appello di Palermo rigettava l'impugnazione. Contro la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso Tizio sulla base di tre motivi. X Y e Z hanno resistito notificando controricorso. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto che fosse dichiarata l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. Con ordinanza n. 20960 del 2004 la Corte a Sezioni Unite ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso con il quale Tizio aveva dedotto che la decisione impugnata era in contrasto con l'ordinanza sindacale che aveva autorizzato il trasferimento della salma di A nella tomba del marito, trasferimento 40 rientrante a parere del ricorrente nella competenza esclusiva dell'autorità amministrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il secondo motivo di ricorso (il primo riguardando la questione di giurisdizione, che e’ stata dichiarata inammissibile con ordinanza n. 20960/2004 delle Sezioni Unite di questa Corte) il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 116 c.p.c. e degli artt. 1703 e segg. c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.,in quanto la Corte d'appello di Palermo, nel ritenere l'esistenza del mandato post mortem, avrebbe fatto erronea applicazione delle risultanze processuali ed avrebbe trascurato di considerare che un simile mandato non poteva essere provato per testimoni, ma doveva risultare da atto scritto. In mancanza di una disposizione testamentaria, che rendesse evidente la volontà della defunta, il luogo della sepoltura avrebbe dovuto essere individuato tenendo presenti le richieste avanzate dai congiunti, prescelti fra quelli a lei più strettamente legati da vincoli, comparando - e dando prevalenza - allo "ius coniugii" rispetto allo "ius sanguinis". Il motivo e’ infondato. Ogni persona fisica puo’ infatti scegliere liberamente circa le modalita’ ed il luogo della propria sepoltura, la legge consentendo espressamente che tra le disposizioni testamentarie rientrino anche quelle a carattere non patrimoniale (art. 587, secondo comma c.c.). Quando manca la scheda testamentaria, tale volontà può essere espressa senza rigore di forma attraverso il conferimento di un mandato ai prossimi congiunti. L'esistenza ed il contenuto di un simile mandato costituisce questione di fatto; e nella specie la Corte d'appello, con ampia motivazione che ha tenuto conto di una pluralità di elementi (e non soltanto delle risultanze testimoniali), e che appare del tutto corretta sotto il profilo delle norme di legge, ha chiarito le ragioni per le quali era da ritenere da un lato che la de cujus avesse espresso il desiderio di non essere tumulata post mortem nella cappella del marito, dall'altro lato che la sepoltura nella tomba destinata ad accogliere le spoglie della famiglia di A fosse quella più rispondente alla volontà delle defunta. Tale conclusione, investendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, si sottrarre a sindacato in sede di legittimità; ne’ puo’ darsi alcun rilievo all'argomento fondato sulla comparazione tra "ius coniugii" e "ius sanguinis", trattandosi di una tesi del tutto nuova che non risulta prospettata e discussa davanti al giudice di merito. Col il terzo motivo il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 90 e segg. c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. in quanto le circostanze da cui era scaturita la controversia avrebbero suggerito quanto meno una compensazione delle spese processuali. Il motivo e’ infondato, dal momento che la Corte d'appello, condannando Tizio alle spese del giudizio della soccombenza ex art. 90 si e’ limitata a fare applicazione della regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. Sotto altro profilo, la decisione del giudice del merito di compensare in tutto o in parte le spese di lite costituisce espressione di un potere discrezionale ad esso conferito dalla legge, potere il cui esercizio e’ incensurabile in sede di legittimità, a meno che la relativa decisione non sia sorretta da ragioni palesemente illogiche, tali cioè da inficiare per la loro inconsistenza lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto. Nella specie, peraltro, la condanna alle spese e’ stata emessa a favore della parte totalmente vincitrice e nei confronti della parte 41 totalmente soccombente. Consegue da quanto sopra che il ricorso deve essere respinto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, spese che si liquidano in favore dei resistenti - tenuto conto della maggiorazione dovuta nel caso di difensore che assista una pluralità di parti nella misura complessiva di euro 3.700,00 di cui euro 3.600,00 per onorario di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore dei resistenti nella misura complessiva di euro 3. 700, 001 di cui euro 3. 600, 00 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2006. Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2006. COMUNIONE LEGALE E MOMENTO DELL’ACQUISTO DEL BENE TRACCIA : Con atto del Notaio Romolo Romani del 15 marzo 1995, Tizio, in comunione legale con la moglie Tizia, acquistava da Caio l'appartamento che quest'ultimo avrebbe costruito in Portofino. Il 20 settembre 1995, Tizio moriva, prima ancora che Caio avesse ultimato la costruzione. Nel suo testamento olografo, pubblicato un anno dopo e redatto quindici giorni prima della morte, Tizio nominava erede universale la moglie Tizia e legava ogni diritto sul predetto appartamento al nipote Sempronio. Un anno dopo, Sempronio decideva di vendere l'appartamento, ormai ultimato, a Felice Bianchi; Tizia, tuttavia, manifestava la volontà di non vendere il suddetto appartamento, precisando che l'acquisto fatto da Tizio, a suo tempo, era avvenuto in comunione legale, così che era necessario il suo consenso alla vendita. Sempronio si reca da un legale; il candidato, assunte le vesti dell'avvocato di Sempronio, rediga motivato parere. POSSIBILE SCHEMA DI SOLUZIONE: In premessa poteva essere utile ricostruire sinteticamente il fatto. In merito alla comunione legale, vi è da dire che non tutti i diritti acquistati da uno dei coniugi rientrano nella comunione legale, essendo esclusi, oltre i beni personali ex art. 179 c.c., i crediti, i contratti obbligatori e le cc.dd. fattispecie 42 strumentali. Non vi rientrano, inoltre, quei negozi come la vendita obbligatoria che, pur essendo diretti al trasferimento, non lo realizzano immediatamente; ciò perché, secondo la disposizione dell’art. 177 primo comma lett. a) c.c. entrano in comunione non i diritti prodromici all’acquisto, ma i beni acquistati. In altri termini, il momento nel quale si verifica l’acquisto alla comunione è solo quello in cui il coniuge diventa titolare del bene, mentre non rilevano le fasi precedenti, anche se costituite da negozi con effetti reali differiti. In questo senso, allora, nella vendita di cosa futura (relativa all’acquisto dell’appartamento in Portofino, da costruire) non vi è acquisto alla comunione al momento della stipula del contratto (con atto del notaio Romolo Romani), verificandosi in tale frangente soltanto l’effetto obbligatorio immediato e non l’effetto reale (differito), che comporterà l’acquisto alla comunione. Pertanto, applicando quanto detto al fatto preso in esame, si deve concludere che i diritti sull’appartamento in questione, non essendo rientrati in comunione legale, spettano esclusivamente al legatario Sempronio, il quale, di conseguenza, è divenuto l’unico proprietario dell’appartamento; ne segue che Sempronio non ha bisogno del consenso di Tizia per vendere l’appartamento a Felice Bianchi. Si consiglia di leggere le sentenze che seguono. - La comunione legale tra coniugi di cui all'art. 177 cod. civ. non riguarda i diritti di credito sorti dal contratto di conto corrente concluso con la banca dal coniuge intestatario, essendo detto contratto “fonte, a seguito di saldo attivo, di un diritto di credito spettante esclusivamente a quest'ultimo (sentenza segnalata anche nella prima sessione). CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Sentenza del 20 gennaio 2006 n. 1197 (Presidente: G. Lo savio; Relatore: A. Giusti) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. – C. K., con citazione notificata il 1° agosto 1992, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Grosseto C. B., dal quale si era consensualmente separata nel 1989, e sulla premessa che il verbale di separazione non costituiva la totale e completa definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi - chiedeva la condanna del marito al pagamento di circa lire 90.000.000 a titolo di saldo della quota del 50% sulle somme alla medesima spettanti sulla comunione de residuo. Nella resistenza del convenuto, il Tribunale di Grosseto, con sentenza 12 agosto 1997: (a) rigettava la domanda di pagamento in relazione ai maggiori esborsi sopportati nell'acquisto della casa coniugale, caduta in comunione, perché essendo stato il bene acquistato durante il matrimonio - non v'era la prova della dichiarazione di cui all'art. 179, primo comma, lettera f), con cui l'attrice avrebbe potuto dare atto che parte del prezzo era stato pagato con risorse facenti parte del patrimonio personale (b) rigettava la domanda di restituzione della somma di lire 5.000.000, pari alla metà di quanto versato dal B. per l'acquisto di quote del fondo Eptafund, dato che la relativa somma era stata da lui incassata prima della separazione, e non v'era prova che fosse residuata al momento dello scioglimento 43 della comunione; (c) condannava il B. a pagare alla moglie la somma di lire 50.000.000, oltre interessi, pari alla metà dell'importo complessivamente pagato per l'acquisto delle quote dei fondi Imirend e Imicapital, sul rilievo che il convenuto, benché avesse dichiarato che tale importo costituiva il prezzo della vendita di un appartamento acquistato prima del matrimonio, non aveva in realtà prodotto l'atto di vendita, e quindi mancava la dichiarazione di cui al citato art. 179, primo cozza, lettera f), cod. civ., indispensabile per il riconoscimento del carattere personale del bene. 2. - La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 104, depositata il 2 febbraio 2002, accogliendo uno dei motivi dell'appello principale proposto dal B. e rigettando l'appello incidentale della K., respingeva la domanda di quest'ultima in relazione all'acquisto di quote dei fondi di investimento Imirend e Imicapital, così riformando l'impugnata sentenza, che confermava nel resto, dichiarando compensate fra le parti le spese dei due gradi di giudizio. Per quanto qui interessa, la corte d'appello - affermata la validità delle clausole dell'accordo di separazione implicanti l'attribuzione di beni ad uno o ad entrambi i coniugi rilevava che nell'accordo di separazione i coniugi avevano convenuto di "confermare" la loro rispettiva comproprietà dell'immobile al 50%, senza accennare ad alcun credito dell'un coniuge o dell'altro, sicchè la K. non poteva "smentire la rinuncia al proprio credito, quale inequivocamente implicata dall'accordo", a nulla rilevando che costei avesse contribuito all'acquisto della casa coniugale con denaro non facente parte della comunione. In relazione all'acquisto di quote dei fondi comuni di investimento, la corte territoriale - ritenuta raggiunta la prova, "in riferimento alla consecuzione dei fatti, quale emergente dalle prove orali assunte e dalla documentazione acquisita", che "le quote dei fondi Imirend e Imicapital furono acquistate dal B. nel maggio 1986 con il prezzo della vendita, avvenuta quello stesso mese, della piena proprietà di un immobile acquistato nel 1974, ossia prima del matrimonio, e del quale egli era nudo proprietario, mentre la madre era titolare del diritto di usufrutto" - affermava che esse dovevano considerarsi beni personali del marito, ai sensi dell'art. 179, primo comma, lettera f), cod. civ., con conseguente estraneità alla comunione. Questa conclusione non era ostacolata dal fatto che il B. non avesse effettuato la dichiarazione prevista dalla citata disposizione, giacché - osservava la Corte territoriale - l'attestazione della provenienza personale del corrispettivo è necessaria solo quando è obiettivamente incerto se l'acquisto realizzi o meno il reinvestimento di danaro o beni personali, mentre il relativo onere non sussiste allorché, come nella specie, sia obiettivamente corto il carattere personale del corrispettivo. La Corte fiorentina riteneva priva di pregio l'obiezione della K. secondo cui il prezzo ricavato dalla vendita immobiliare sarebbe transitato, prima di essere investito nell'acquisto delle quote, in due conti correnti di pertinenza della comunione. 3. - Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la K., con atto notificato il 4 marzo 2003, deducendo due motivi di censura, ai quali ha resistito con controricorso il B.. MOTIVI DELLA DECISIONE l. - Preliminarmente, deve ritenersi non sussistente la preclusione - che il controricorrente denuncia con il proprio atto, sollecitando questa Corte a rilevarla d'ufficio - che si sarebbe determinata per effetto della proposizione, da parte della K., di una domanda nuova con l'appello incidentale, con conseguente inammissibilità dello stesso per violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. Risulta infatti dagli atti di causa - ai quali è possibile accedere, trattandosi di 44 acclarare l'esistenza o mano di una preclusione all'esercizio della giurisdizione che, sia dalla citazione introduttiva del giudizio di primo grado, la K. ebbe a chiedere la condanna del marito al pagamento di una somma di denaro, pari a circa lire 90.000.000, derivante dallo scioglimento della comunione legale tra gli stessi coniugi, in particolare deducendo tanto il maggior impegno finanziario da essa sostenuto nell'acquisto della casa coniugale quanto la caduta in comunione dell'acquisto, effettuato dal B., delle quote dei fondi comuni di investimento mobiliare Imirend e Imicapital. Questa domanda, ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, è stata puntualmente riproposta con l'appello incidentale, con cui la K. ha chiesto la condanna del B. a restituire e pagare, a titolo di rimborso, la quota da essa versata in eccedenza per l'acquisto della casa coniugale e la conferma, per il resto, della sentenza di primo grado, che aveva condannato il B. a pagare alla moglie la somma di lire 50.000.000, oltre interessi, pari alla metà dell'importo complessivamente investito per l'acquisto delle quote dei fondi Imirend e Imicapital. Non vi è stata, pertanto, alcuna domanda nuova della K. in appello. 2. - Devesi, pertanto, esaminare il ricorso principale. 3. - Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 192, terzo comma, cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, numero 3), cod. proc. civ. Sulla premessa di avere contribuito all'acquisto della casa coniugale in misura notevolmente maggiore rispetto al marito (avendo investito la somma di lire 70.000.000, provenienti dalla eredità paterna, laddove il marito aveva in realtà impiegato denaro della comunione), la ricorrente ritiene che nella specie avrebbe dovuto essere fatta applicazione dell'art. 192, .terzo comma, cod. civ., concernente il rimborso delle somma prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune. Erroneamente la Corte d'appello avrebbe dato rilievo all'accordo intervenuto in sede di separazione personale, giacché l'attribuzione, in esso contenuta, della proprietà della casa coniugale in ragione del 50% a ciascuno dei coniugi non eliminerebbe il riconoscimento, ad opera dello stesso accordo, del fatto storico della diversa contribuzioni, con denaro personale per quanto riguarda la moglie ed invece con denaro della comunione per quanto riguarda il marito. 4. - I1 motivo è inammissibile. 4.1. - I1 giudice del merito, interpretando l'accordo di separazione stipulato dai coniugi, che recava clausole finalizzate a regolare l'assetto patrimoniale in conseguenza dell'allentamento del vincolo coniugale, con particolare riguardo al godimento e alla proprietà dei beni, ha ritenuto che il riconoscimento, in esso contenuto, della comproprietà della casa coniugale al 50%, e - al contempo l'assenza di qualsiasi riferimento a rapporti di dare ed avere tra i coniugi, nonostante gli apporti di diversa misura in relazione all'acquisto di tale immobile, implicasse inequivocamente - rinuncia al proprio credito" da parte della K.. 4.2. - La ricerca della comune intenzione delle parti nella stipulazione di un accordo di separazione è compito del giudice di merito e costituisce una valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione adeguata e immune dalla violazione delle norme dettate per l'interpretazione negoziale. La ricorrente non denuncia l'interpretazione della portata dell'accordo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni di ermeneutica negoziale, la doglianza di mancata applicazione dell'art. 192, terzo comma, cod. civ, non essendo idonea a veicolare una utile censura di violazione delle regole di interpretazione negoziale nel ragionamento seguito dal giudice del merito, tanto più che - come questa Corte 45 ha già statuito (cfr. Cass. 4 febbraio 2005, n. 2354; Cass. 24 maggio 2005, n. 10896) - detta norma non può essere invocata per riequilibrare, in sede di scioglimento della comunione legale, attraverso il meccanismo dei rimborsi e delle restituzioni, il maggiore impegno finanziario sostenuto da un coniuge rispetto all'altro ai fini dell'acquisto di un bene in comunione legale. In definitiva, il motivo di ricorso si risolve nella mera contrapposizione di un'interpretazione dell'accordo di separazione diversa da quella adottata dalla Corte territoriale. 5. - Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione dell'art. 179 cod. civ., in relazione agli artt. 177 e 195 cod. civ. Premette la ricorrente che il denaro per l'acquisto dei fondi è entrato nel conto corrente intestato al marito: ed essendo questa transazione intervenuta durante il matrimonio, il conto corrente, benché intestato al marito, doveva considerarsi appartenente alla comunione familiare, secondo quanto del resto statuito dalla giurisprudenza penale della Corte di cassazione (Cass. pen. 13 novembre 1997, Airoldi). Erroneamente, pertanto, la Corte d'appello avrebbe applicato l'art. 179 cod. civ. relativamente all'acquisto delle quote dei fondi comuni di investimento, essendo stato impiegato per tale acquisto denaro transitato nel conto corrente e quindi divenuto, in forza della presunzione di cui agli artt. 177 e 195 cod. civ., oggetto della comunione legale. 6. - La doglianza è priva di fondamento. 6.1. - La Corte d'appello ha escluso che l'acquisto di quote di fondi comuni di investimento mobiliare da parte del marito fosse caduto in comunione legale, e ciò trattandosi della surrogazione di un bene personale (il prezzo ricavato dalla vendita di un immobile di cui il B. era proprietario prima del matrimonio) ai sensi dell'art. 179, primo comma, lettera f), cod. civ. ed ha giudicato non rilevante l'omissione della prevista dichiarazione, perché essa sarebbe necessaria solo quando è obiettivamente incerto se 1'acquisto realizzi o meno il reinvestimento di denaro personale, non già quando - come nella specie - é certa il carattere personale (ai sensi dell'art. 179, primo comma, lettera a) del corrispettivo. 6.2. - La ricorrente contesta questa conclusione, osservando che il denaro ricavato dalla vendita del bene personale, essendo stato depositato, prima del reinvestimento in quote di fondi comuni, su un conto corrente del marito, sarebbe caduto, per ciò solo, in comunione legale. La tesi della ricorrente - secondo cui il denaro depositato su un conto corrente intestato ad un coniuge in regime di comunione legale entrerebbe a far parte della comunione - non può essere condivisa. 6.3. - Vero è che una pronuncia della Corte di cassazione penale (sentenza 13 novembre 1997; depositata il 23 gennaio 1998; Airoldi) ha statuito che -anche il denaro depositato in un istituto bancario è oggetto della comunione in via assoluta ai sensi dell'art. 177, primo comma, lettera c), cod. civ., senza che possa ammettersi una prova contraria a norma dell'ultima parte dell'art. 195 cod. civ., sia che provenga dall'attività di uno solo dei coniugi sia che provenga dalle singole attività dei due coniugi", ritenendo di conseguenza legittimo il provvedimento di sequestro conservativo avente ad oggetto la metà dei valori esistenti in conti correnti e depositi intestati esclusivamente al coniuge dell'imputato. Ma la giurisprudenza della Cassazione civile segue un indirizzo diverso. La sentenza della V Sezione 1° aprile 2003, n. 4959 - sulla premessa che "la comunione legale tra coniugi di cui all'art. 177 cod. civ. riguarda gli acquisti, vale a dire gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà di un bene o la costituzione di diritti reali sullo stesso, non quindi i diritti di credito 46 sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro natura relativa e personale, pur se strumentali e finalizzati all'acquisto di un bene, non sono suscettibili di rientrare in una comunione legale dei beni" - ha escluso che possa comprendersi nella comunione legale dei beni il contratto di conto corrente concluso con la banca dal coniuge intestatario, essendo detto contratto "fonte, a seguito di saldo attivo, di un diritto di credito spettante esclusivamente a quest'ultimo". Ritiene configurabile una comunione de residuo, ai sensi dell'art. 177, primo comma, lettera c), sui redditi depositati su conto corrente (nella specie, cointestato), Cass., sez. I, 17 novembre 2000, n. 14897, la quale conferma la decisione di merito che aveva considerato rientranti nella comunione de residuo le somme depositate sul conto cointestato, ritirate prima della separazione ed asseritamente utilizzate per l'attività dì impresa del coniuge prelevante. Più di recente, questa Sezione (con la sentenza 27 aprile 2004, n. 8002) ha precisato che il regime di cui all'art. 177 cod. civ. viene in realtà ad indirizzarsi sui soli acquisti di beni e non viene ad inerire, invece, all'instaurazione di rapporti meramente creditizi, quali, ove mai fatti oggetto di cointestazione nell'ambito di un conto corrente bancario, non esorbitano dalla logica di un tal tipo di rapporti e non conoscono, quindi, alcuna preclusione legata al preventivo scioglimento della comunione legale coniugale". 6.4. - Ritiene il Collegio che il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l'alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga, come nella specie, dal medesimo coniuge depositato sul proprio conto corrente. Questa titolarità non muta in conseguenza della mera circostanza che il denaro sia stato accantonato sotto forma di deposito bancario, giacché il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né d'altro canto configurabile come un acquisto nel senso indicato dall'art. 177, primo coma, lettera a), cod. civ., cioè come un'operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell'assetto patrimoniale del depositante. Correttamente, pertanto, la Corte d'appello è pervenuta alla conclusione che il coniuge potesse utilizzare le somme accantonate sul di lui conto corrente, provenienti dall'alienazione di un bene personale, ai fini della surrogazione reale di cui all'art. 179, primo comma, lettera f), cod. civ. 7. - Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso della spose di questa fase del giudizio, liquidate in euro 1.600,00, di cui euro 1.500,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 25 novembre 2005. 47 - Il contratto preliminare di vendita di un bene immobile della comunione legale tra coniugi, stipulato da un coniuge senza la partecipazione o il consenso dell'altro, è soggetto alla disciplina dell'art. 184 c.c.; esso, quindi, non è inefficace nei confronti della comunione, ma soggetto all'azione di annullamento solo da parte del coniuge non consenziente, con la conseguenza che finché detta azione di annullamento non viene proposta esso è produttivo di effetti tra la comunione ed il terzo. Cassazione civile, sez. III 21 dicembre 2001, n. 16177 Pres. Giuliano – Rel. Segreto – P.M. Cesqui (conf.) Bastianelli c. Resi ed altri SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato a Bastianelli Domenico il 19.3.1997, Resi Leonia, Ricci Marco, Ricci Marta e Ricci Emanuela, nella qualità di eredi di Ricci Mario proponevano appello avverso la sentenza del tribunale di Firenze depositata il 13.6.1996, n. 1632, nella causa proposta dall'appellato contro Ricci Mario e con la quale era stato dichiarato l'inadempimento di Ricci Mario all'obbligo assunto nei confronti del Bastianelli con scrittura del 6.10.1988 di trasferirgli un appartamento in Firenze e condannato il Ricci a pagare la somma di L. 10 milioni, pari al doppio della caparra, oltre L. 3.360.394 ed interessi. Assumevano gli appellanti che nessun inadempimento vi era stato da parte del loro dante causa, dovendo, invece considerarsi inadempiente il Bastianelli, che prima della scadenza del termine previsto contrattualmente per la stipula del contratto definitivo, aveva provveduto all'acquisto di altro immobile. Resisteva il Bastianelli. La corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il 25.2.1999, in riforma dell'appellata sentenza, rigettava la domanda del Bastianelli. Riteneva la corte di merito che l'impegno di acquisto, rilasciato dal Bastianelli all'agente immobiliare relativamente all'appartamento del Ricci, essendo stata accettato e sottoscritta da quest'ultimo, già costituiva un contratto preliminare, per cui non vi era la necessità della stipula di un nuovo preliminare davanti ad un notaio, né tanto era previsto nella scrittura del 6.10.1988; che tale eventuale patto, attenendo al preliminare di compravendita, doveva necessariamente risultare per iscritto e non poteva essere verbale, come sostenuto dal Bastianelli. Pertanto non poteva ritenersi che lo stesso Ricci fosse inadempiente, per non essersi presentato davanti al notaio per la stipula di un altro preliminare in data 31.10.1988. 48 Secondo la corte, poiché il bene era in comunione familiare tra il Ricci e la moglie Resi, ben poteva il Ricci effettuare il preliminare di vendita, avendo esso contenuto solo obbligatorio, per cui egli prometteva per il 50% del coniuge (circostanza specificamente indicata nell'atto) l'obbligazione del terzo; che, in ogni caso, con missiva del 5.12.1988 entrambi i coniugi Ricci confermarono espressamente di voler procedere alla vendita; che il contratto definitivo era previsto per il 31.3.1989; che dalle testimonianze escusse non emergeva la volontà dei Ricci di non adempiere al contratto preliminare; che il Bastianelli con missiva del 7.12.1988 dichiarò di non voler acquistare l'appartamento a causa dell'inadempimento del Ricci per la mancata presentazione davanti al notaio per la stipula del preliminare; che il Bastianelli acquistò un diverso appartamento il 20.2.1989, cioè prima della scadenza del termine (31.3.1989) per la stipula del contratto definitivo di compravendita con il Ricci. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Bastianelli. Resistono con controricorso gli appellanti, che hanno anche presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 180, 184 e 1381 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. Assume il ricorrente che nell'ambito della comunione legale o ordinaria, l'obbligazione di vendere un bene immobile da chi non è legittimato a disporne per l'intero risulta inefficace, non trovando applicazione la disciplina dettata dall'art. 1381 c.c.; che, pur rientrando il preliminare di un bene immobile in comunione legale coniugale tra gli atti di straordinaria amministrazione, in caso di consenso di un solo coniuge non è applicabile la sanzione del solo annullamento, che riguarda gli atti di disposizione con effetti reali, per cui gli altri atti, che non comportano la fuoriuscita del cespite dalla comunione, ma solo effetti obbligatori, danno luogo solo all'inefficacia dell'atto stesso. 2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che per l'effetto esso vada rigettato, pur presentando la sentenza impugnata - esatta nel dispositivo - errori di diritto, che vanno corretti nei termini che seguono, a norma dell'art. 384, c. 2, c.p.c. Invero è completamente fuor di luogo il richiamo all'art. 1381 c.c., effettuato dalla corte di merito. Va, anzitutto, rilevato, come affermato dalla Corte Cost. n. 311 del 1988, che la comunione legale dei beni tra i coniugi a differenza di quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei. Ne consegue che nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune, ponendosi il consenso dell'altro coniuge (richiesto dal secondo comma dell'art. 180 c.c. per gli atti di straordinaria amministrazione) come un negozio unilaterale autorizzativo, la cui mancanza non rende inefficace o invalido l'atto, ma lo sottopone alla sola sanzione 49 dell'annullamento ai sensi dell'art. 184 c.c., in forza dell'azione proponibile dal coniuge pretermesso entro i termini previsti dall'art. 184 c.c. (Cass. 2.2.1995, n. 1252; Cass. 14.1.1997, n. 284). 2.2. L'art. 184 c.c., costituente il dato positivo in materia, al comma primo stabilisce che "gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'art. 2863"; al comma secondo aggiunge che "l'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro l'anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data della trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non può essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso". La disposizione prevede testualmente, con espressioni chiare ed univoche, l'annullabilità e la convalida. Orbene, l'annullabilità e la convalida suppongono la piena efficacia degli atti. Sul piano politico, nel conflitto tra la tutela del terzo avente causa dal singolo coniuge e la tutela del coniuge pretermesso, la norma sembra privilegiare la prima, in difformità dal favor comunionis, che certamente ispira l'intera riforma dei rapporti patrimoniali tra coniugi. Sul piano strettamente tecnico, poi, la disciplina statuita dall'art. 184 cit. appare in contrasto con l'indirizzo del codice vigente che, per gli atti di disposizione compiuti dai soggetti privi di legittimazione, contempla la sanzione della inefficacia: in particolare, appare in contrasto con il disposto dell'art. 2258 comma 1 c.c., che in caso di amministrazione congiunta richiede il consenso di tutti coloro, ai quali spetta l'amministrazione. 2.3. La statuizione dell'annullabilità per gli atti riguardanti i beni immobili o mobili registrati, compiuti dai soggetti non legittimati a disporre dell'intero senz'altro raffigura un dato nuovo e diverso rispetto alla comunione ordinaria. Ne consegue, anzitutto, che nella fattispecie non hanno rilevanza i precedenti giurisprudenziali richiamati dal ricorrente, poiché essi attengono alla comunione ordinaria. 3.1. Tenendo conto innanzi tutto che la comunione legale dei beni tra i coniugi non costituisce soltanto una situazione di titolarità, o di contitolarità, di beni, ma integra un "regime giuridico" che si riflette con carattere di specialità sia sulla responsabilità (artt. 186-189-190 c.c.) sia, per quanto specificamente in questa causa interessi, sugli effetti degli atti e dei negozi giuridici, nonché dei rapporti che in essi trovino fonte, il primo problema proposto deve trovare soluzione nella correlazione tra la disciplina degli artt. 180, 184 nonché 186 e 189 c.c. Ove si ritenga che l'art. 180 c.c. stabilisce la regola generale in ordine al potere di amministrare la comunione e l'art. 184 indica le conseguenze degli atti compiuti in violazione della regola, deve ritenersi che gli atti posti in essere da un singolo coniuge senza il consenso dell'altro, o rientrano nella disciplina dell'art. 184 c.c., ovvero al di fuori di detta disciplina sono del tutto inefficaci nei riguardi della comunione, salvo ratifica dell'altro coniuge e salvo che un atto sia posto in essere 50 dal singolo coniuge in nome proprio, per cui gli effetti debbono fare capo a lui secondo, peraltro, la previsione dell'art. 189 comma 1 c.c., che coinvolge, con disciplina speciale sussidiaria, la responsabilità anche dei beni della comunione per le obbligazioni assunte dal singolo coniuge. 3.2. Così impostata la questione, si rileva che il primo comma dell'art. 184 c.c. attiene agli atti che, "se riguardano beni immobili", siano compiuti da un coniuge "senza il necessario consenso dell'altro coniuge". Quando il consenso dell'altro coniuge sia necessario, è indicato dalla disciplina generale dell'art. 180/2 c.c. che, in deroga al principio generale - I comma dell'articolo - in base al quale l'amministrazione dei beni della comunione spetta disgiuntamente ad entrambi i coniugi, pone un'eccezione per "il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione" spettante "congiuntamente ad entrambi i coniugi". Ora, un contratto preliminare di vendita di un bene immobile soggetto al regime della comunione, sia che si richiami il criterio di straordinarietà inerente alla gestione del patrimonio dei minori, sia che si richiamino le norme proprie della comunione ordinaria (art. 1108 c.c.) ovvero quelle in tema di società, non pare dubbio che rientri nel concetto di amministrazione straordinaria, in quanto potenzialmente pregiudizievole all'interesse dell'altro coniuge e della comunione stessa ed in quanto eccedente la normalità degli atti da valutarsi sotto il profilo qualitativo e quantitativo. 3.3. Né può sottrarsi a detta qualificazione il contratto preliminare di vendita immobiliare, sulla base della considerazione che da esso derivano effetti obbligatori e non reali, in quanto il preliminare stesso è fonte di obbligazioni consequenziali a catena che, se ed in quanto validamente assunte ed in quanto si realizzino le condizioni di attuabilità, impongono in sequenza l'effetto distrattivo del bene dalla comunione e traslativo della proprietà, sia che esso avvenga con atto spontaneamente esecutivo dell'obbligazione di contrarre assunta, sia che si determini mediante la sostituzione della volontà del contraente inadempiente con la sentenza ex art. 2932 c.c. costitutiva secondo la disciplina dell'art. 2908 c.c. 3.4. Pur senza seguire la tesi di certa dottrina secondo cui il contratto preliminare di vendita sarebbe munito in sé di efficacia traslativa, sia pure condizionata ad una successiva obbligatoria stipulazione e documentazione del contratto, ovvero ad una successiva e necessitata pronuncia costitutiva; pur ritenendo, per contro, che il contratto preliminare abbia effetti obbligatori, non può non rilevarsi che oggetto dell'obbligo è la stipulazione di un contratto definitivo, di tipo e contenuto predeterminato, e con un oggetto specifico o determinabile. Il contratto preliminare di vendita, quindi, si pone come momento originario di una serie obbligatoria consequenziale e successiva, il cui esito conclusivo necessitato è il trasferimento della proprietà del bene. In virtù dell'effetto conclusivo della sequenza, lo stesso preliminare, che alla serie obbligatoria dà inizio, diviene atto eccedente l'ordinaria amministrazione. Ovvia appare, quindi la deduzione che, se il contratto preliminare di vendita di bene immobile in regime di comunione legale costituisce negozio eccedente 51 l'ordinaria amministrazione, esso costituisce altresì atto che può vincolare direttamente la comunione solo se compiuto congiuntamente dai coniugi, e che, se compiuto da un coniuge senza il consenso dell'altro, diviene atto annullabile a norma dell'art. 184 comma 1 c.c. 4.1. Né può sostenersi che, pur rientrando nella nozione di atto di amministrazione straordinaria secondo l'art. 180 c.c., il contratto preliminare di vendita di immobile non rientrerebbe nel regime dell'art. 184/1 c.c., regime che sarebbe limitato, in una interpretazione restrittiva, agli atti dispositivi con effetto reale e non agli atti con effetto immediatamente obbligatorio. In primo luogo l'interpretazione restrittiva non trova riscontro nella lettera dell'art. 184/1 c.c. che sottopone, come già ricordato, all'azione di annullamento gli atti compiuti da un solo coniuge "senza il necessario consenso" dell'altro coniuge; e quando il consenso sia necessario (come già esposto) lo dispone l'art. 180 c.c. citato con riferimento generale agli atti di amministrazione straordinaria, determinando quindi una coincidenza concettuale tra gli atti di straordinaria amministrazione e quelli per i quali la mancanza del consenso determina, come effetto, l'annullabilità, non l'assoluta inefficacia di essi rispetto alla comunione. 4.2. In secondo luogo il primo comma dell'art. 184 c.c. delinea e delimita, tra gli atti di amministrazione straordinaria, quelli soggetti al regime dell'annullamento, mediante una qualificazione oggettiva: "se riguardano beni immobili". Il "riguardare" beni immobili è espressione volutamente generica che non comprende solo gli atti immediatamente distrattivi dalla comunione in conseguenza di un effetto reale immediato, ma gli atti che comunque abbiano un'incidenza potenzialmente pregiudizievole sulla comunione con attinenza a beni immobili, ancorché l'effetto reale non sia immediato, ma conseguenza legittimamente necessitata, e giuridicamente tutelata fino alla costituzione degli effetti del contratto definitivo, in mancanza di volontà dell'obbligato (art. 2932 c.c. in relazione all'art. 1351 c.c.). 4.3. D'altronde, la suggerita interpretazione restrittiva non è sorretta neanche dal sistema che dalla disciplina dell'art. 184 c.c. emerge. Basti considerare che, a differenza della comunione ordinaria nella quale la sanzione dell'atto derogante il necessario consenso di tutti i partecipanti è l'inefficacia nei confronti della comunione (art. 1108 c.c.), nel regime patrimoniale della famiglia, retto dalle regole della comunione legale, il legislatore si è posto il problema della tutela bilanciata della comunione e del coniuge non consenziente, da un lato, nonché del terzo, dall'altro. La tutela del terzo è massima quando l'atto "riguardi" beni mobili (art. 184, comma 3) in quanto, anche se compiuto in violazione della regola della congiuntività, l'atto stesso è pur sempre valido ed efficace rispetto al terzo, risolvendosi l'eventuale situazione di pregiudizio con il rilievo di situazioni interne tra i coniugi. La tutela del terzo è attenuata nel caso di atto riguardante beni immobili o mobili registrati, ma pur sempre sussistente, in quanto correlata al conferimento al 52 coniuge non consenziente di un potere di annullamento, in base al quale il coniuge incolpevole deve assumere comunque un atteggiamento attivo e dispositivo per ottenere la tutela del proprio diritto, come emerge dal breve termine prescrizionale cui è ristretto l'esercizio dell'azione di annullamento. 5.1. Riportando questi criteri al postulato di premessa, sarebbe illogico ed incongruo limitare la tutela del coniuge incolpevole ad una condotta attiva da esercitare entro breve termine per gli atti ad effetto reale traslativo immediato (e quindi con potenzialità lesiva maggiore ed immediata della comunione e del coniuge dissenziente), e sanzionare con l'assoluta inefficacia verso la comunione (e quindi con una situazione di maggior rilievo a tutela della comunione) un preliminare di vendita di bene comune, da cui derivano direttamente effetti obbligatori, con una prospettazione di pregiudizio o eguale, o minore, in quanto differito nel tempo. 5.2. E' pur vero che di fronte all'inefficacia del preliminare (nell'ipotesi di assoluta inefficacia del preliminare), l'azione di annullabilità, ed il relativo termine prescrizionale, si riproporrebbero davanti al negozio di esecuzione del preliminare. Non sembra però coerente con la disciplina positiva che un atto munito in sé di efficacia obbligatoria, debba essere sanzionato con l'assoluta inefficacia in un sistema che richiede, invece, una condotta attiva del coniuge non consenziente, e ciò a tutela del terzo, in presenza di un negozio immediatamente traslativo del bene. Così ritenendo, si sottoporrebbero ad un effetto sanzionatorio disuguale due ipotesi che o sono eguali negli effetti pregiudizievoli della comunione, ovvero vi sarebbe un effetto sanzionatorio più rigoroso proprio per l'ipotesi di minore pregiudizio immediato; si realizzerebbe, quindi, una inammissibile discrasia sistematica. D'altra parte per la sottoponibilità di annullamento del contratto preliminare di vendita (ancorché in fattispecie diverse) si è già pronunciata questa Corte (Cass. 19 marzo 1988 n. 3483; 18 giugno 1992 n. 7524). 5.3. Risulta superato il rilievo della tesi restrittiva secondo cui il comma 2 dell'art. 184 c.c. fa decorrere il termine prescrizionale dalla trascrizione dell'atto, e ciò al fine di delimitare il regime dell'annullamento (in contrapposizione a quello dell'inefficacia) agli atti previsti dall'art. 2643 c.c., tra i quali non vi sarebbe il contratto preliminare di vendita, pur ricomprendendosi nella previsione del n. 1 di detto articolo anche vendite con effetto obbligatorio. Infatti, anzitutto, a norma dell'art. 2645 bis c.c., introdotto dall'art. 3 del d.l. 31.12.1996, n. 669 (conv. in l. 28.2.1997, n. 30), anche i contratti preliminari relativi a beni immobili devono essere trascritti. Inoltre non bisogna dimenticare che il termine prescrizionale è, in primo luogo, decorrente dalla conoscenza effettiva dell'atto e, solo con carattere di sussidiarietà, dalla trascrizione ovvero dallo scioglimento della comunione, ed il criterio sussidiario non può comportare la delimitazione del criterio generale che detta delimitazione già non abbia in sé. 53 6. In definitiva deve ritenersi che il contratto preliminare di vendita di un bene immobile della comunione legale tra coniugi, stipulato da un coniuge senza la partecipazione o il consenso dell'altro, è soggetto alla disciplina dell'art. 184 c.c.; esso, quindi, non è inefficace nei confronti della comunione, ma soggetto all'azione di annullamento solo da parte del coniuge non consenziente (Cass. 17.12.1994, n. 10872), con la conseguenza che finché detta azione di annullamento non viene proposta esso è produttivo di effetti tra la comunione ed il terzo. 7. Il motivo risulta, quindi, infondato. Ciò rende superfluo considerare che, ove lo stesso fosse stato fondato e che quindi il contratto preliminare stipulato dal Ricci fosse stato inefficace, non poteva aversi per l'effetto un inadempimento di questo ultimo, con le conseguenze patrimoniali tratte dal primo giudice, ma i rapporti tra i contraenti andavano regolati secondo i principi propri del solo indebito oggettivo (art. 2033 c.c., Cass. 13.10.1995, n. 10675). 8. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione dell'impugnata sentenza. Assume il ricorrente che sulla base delle prove testimoniali e confessorie assunte in giudizio la volontà delle parti al momento della scrittura del 6 ottobre 1988 era quella di addivenire ad un successivo contratto preliminare, riportante quanto contenuto nella proposta di acquisto effettuata dal ricorrente e successivamente sottoscritta dal Ricci. 9.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile. Infatti, anzitutto, qualora con il ricorso per Cassazione venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata o insufficiente o contraddittoria valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t., ecc.), è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi - ove occorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. civ., sez. II, 1 febbraio 1995, n. 1161). Nella fattispecie nel ricorso non è indicato il contenuto specifico di dette risultanze processuali. 9.2. Inoltre la sentenza impugnata ha escluso l'inadempimento del promittente acquirente sulla base del rilievo che, costituendo la scrittura del 6.10.1988 già un preliminare, poiché la proposta di acquisto scritta risultava poi accettata e sottoscritta dal promittente alienante, essa già costituiva un contratto preliminare e dalla stessa non risultava l'obbligo del promittente alienante di addivenire ad un successivo contratto preliminare, dovendo anche detto obbligo risultare in forma 54 scritta. Avverso questa seconda ratio decidendi (segnatamente quella fondata sulla mancanza della forma scritta), il ricorrente non ha proposto alcuna specifica censura. Osserva questa Corte che, quando la statuizione impugnata sia fondata su più ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali sia giuridicamente e logicamente idonea a sorreggere la pronuncia, l'omessa censura di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto d'interesse, il motivo di ricorso per cassazione relativo alle altre, in quanto la sua eventuale fondatezza non potrebbe mai condurre all'annullamento della sentenza, essendo divenuta definitiva la motivazione autonoma non impugnata (Cass. civ., sez. lav., 9 dicembre 1994, n. 10555). Il ricorso va, pertanto, rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dai resistenti e liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione, sostenute dai resistenti liquidate in L. 280.000, oltre L. 2.500.000, per onorario di avvocato. MANDATO AD ACQUISTARE UN IMMOBILE, REVOCA E FORMA NECESSARIA TRACCIA: Tizio è amico da 12 anni di Caio. Tizio si accorda con Caio, affinché il secondo acquisti, in nome proprio, l’immobile Alfa, con l’obbligo di ritrasferire il bene al primo; i due firmano una scrittura privata, avente ad oggetto la suddetta operazione, qualificata come mandato senza rappresentanza. Una sera Tizio, a cena con Caio, dice di non essere più interessato all’acquisto di Alfa e di voler revocare il mandato formulato nei confronti di Caio. Dopo un mese, Caio acquista l’immobile Alfa e si reca da Tizio per trasferirgli il bene acquistato. Tizio va su tutte le furie, precisando di aver revocato il mandato ad acquistare l’immobile Alfa un mese prima. Caio si reca da un legale. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga motivato parere. POSSIBILE SCHEMA DI SOLUZIONE : In premessa poteva essere utile ricostruire sinteticamente il fatto. Successivamente si poteva spiegare il contratto di mandato. Il mandato è definito dall’art. 1703 c.c.; si tratta di un contratto consensuale, con effetti obbligatori (normalmente), normalmente oneroso ex art. 1709 c.c., ad 55 esecuzione differita ed è intuitu personae; può essere con rappresentanza (quando al mandato si aggiunge una procura, in forza della quale il mandatario rappresentante è autorizzato a spendere il nome del mandante rappresentato, rendendo, in tal modo, l’attività giuridica immediatamente efficace per quest’ultimo) o senza rappresentanza. Detto questo, bisognava affrontare il discorso relativo alla forma; premesso che per il mandato senza rappresentanza ad acquistare un bene immobile (come Alfa) si ritiene necessaria la forma scritta, argomentando dall’art. 1351 c.c. (il preliminare come il mandato ad acquistare è un contratto obbligatorio ad effetti reali differiti, con la conseguenza che, trattandosi di contratti con la medesima natura giuridica, per analogia l’art. 1351 c.c. sarà applicabile anche al contratto di mandato), che forma deve rivestire la revoca del mandato? Qualsiasi forma, ovvero una forma particolare? Secondo una certa tesi (minoritaria) il problema posto andrebbe risolto in termini negativi: la revoca potrebbe essere effettuata validamente, senza alcuna formalità, con la conseguenza applicativa che, nel caso di specie, Caio risulterà proprietario di Alfa e non potrà trasferirlo a Tizio (perché la revoca del mandato era valida, anche se espressa verbalmente). A favore della tesi sostanziale, si evidenzia l’art. 1325 n. 4 c.c.: la forma è elemento essenziale del contratto solo laddove sia espressamente prevista come tale, con la conseguenza che il silenzio del legislatore in tema di forma nei contratti tipici va inteso come libertà di forma; in questo senso, allora, sarebbe desumibile un principio generale di libertà di forma (tanto nei contratti che negli atti unilaterali), che porterebbe a ritenere valida la revoca verbale del mandato fatta da Tizio verso Caio. Invero, secondo la tesi prevalente in dottrina e giurisprudenza, seppur vi è un principio generale di libertà delle forme (argomentando dall’art. 1325 n. 4 c.c.), tuttavia, tale principio subisce una deroga nella materia del mandato senza rappresentanza ad alienare; in particolare, si dice, nel caso di specie potrebbe emergere una situazione analoga a quella prevista dal legislatore all’art. 1351 c.c., con la conseguenza che verrebbe ad emergere un principio di simmetria formale per cui come tra preliminare e definitivo deve intercorrere la stessa forma, così dovrebbe essere anche per il mandato e la sua revoca. Precisamente: se il mandato è stato conferito rispettando una certa forma, per un principio di simmetria formale, allora, anche la revoca del mandato dovrà avere la stessa forma del mandato iniziale. Applicando tale ricostruzione teorica maggioritaria la caso pratico in esame, Caio non avrà nulla da temere e Tizio sarà tenuto ad adempiere al contratto di mandato, pagando verosimilmente il corrispettivo pattuito per l’esecuzione del mandato. Si riporta di seguito un contributo del giudice Nastasi, La rappresentanza indiretta ed il mandato ad alienare, utile per conoscere varie tesi in tema di rappresentanza. La rappresentanza indiretta e il mandato ad alienare Premessa. La rappresentanza, intesa come attività diretta al soddisfacimento degli altrui interessi, è anche attività di gestione. Essa, però, si distingue dalle figure gestorie presenti nel nostro ordinamento in quanto produce direttamente ed 56 immediatamente effetti nella sfera giuridica del rappresentato. Nelle altre attività di gestione, infatti, tali effetti si producono nella sfera giuridica dell'agente e, solo successivamente, si trasferiscono in capo al gerito. Si suole distinguere in dottrina tra rappresentanza diretta e rappresentanza indiretta: la prima è caratterizzata dall'agire del rappresentante in nome e per conto del rappresentato, mentre la rappresentanza indiretta, detta anche d'interessi, si caratterizza per l'agire del rappresentante in nome proprio e nell'interesse del rappresentato. Da ciò consegue che, mentre nella rappresentanza diretta il rappresentante è solo parte formale del rapporto contrattuale instaurato, divenendo il rappresentato parte sostanziale, nella rappresentanza indiretta, caratterizzata dalla mancanza della contemplatio domini, è il rappresentante ad essere al contempo parte formale e parte sostanziale del negozio, tanto che gli effetti dello stesso si producono nella sua sfera giuridica, salvo poi l'obbligo per il rappresentante di trasferirli al rappresentato. La disciplina ha, però, previsto che alcuni effetti possano esplicarsi direttamente nella sfera giuridica del rappresentato (v. artt. 1706, 1707 c.c.), attenuando le differenze tra i due tipi di rappresentanza. In proposito sono illuminanti le parole del Pugliatti: "l'agire del cooperatore per un interesse altrui ... costituisce la base per mezzo della quale il titolare dell'interesse è posto in condizione di poter conseguire la situazione soggettiva (formalmente) acquistata dal cooperatore e a lui destinata" (Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965 pag. 395). Comunemente la rappresentanza indiretta si attua mediante un contratto di mandato senza rappresentanza. Con tale tipo di contratto, infatti, l'atto giuridico posto in essere dal mandatario senza rappresentanza esplica i suoi effetti solo nei rapporti tra lo stesso ed il terzo, senza incidere nella sfera giuridica del mandante. Natura giuridica. Dibattuta è la natura giuridica della rappresentanza indiretta. Una prima tesi, autorevole ma minoritaria [1], afferma che la rappresentanza indiretta sia una vera e propria rappresentanza, poiché si agisce, così come nella rappresentanza diretta, per tutelare e soddisfare l'interesse altrui, e si realizza un risultato destinato ad incidere comunque nella sfera giuridica del rappresentato. L'Autore individua nelle disposizioni di cui agli artt. 1388, 1705 secondo comma, seconda parte, 1706 e 1707 c.c., gli addentellati normativi cui ancorare il risultato della propria indagine. Le suddette norme, secondo tale tesi, non sono da considerare eccezionalmente dirette al soddisfacimento dell'altrui interesse, ma come norme che sanciscono la generale rilevanza dello stesso. Invero si è sostenuto che, caratterizzandosi la rappresentanza come fenomeno di intermediazione, il rapporto giuridico si instaurerebbe sempre tra il rappresentato e il terzo, sia che il rappresentante dichiari l'alienità dell'interesse, per il cui soddisfacimento agisce, sia che non lo dichiari: i due tipi di rappresentanza sono fattispecie dello stesso fenomeno giuridico, quello della cooperazione giuridica per la costituzione di rapporti altrui. Nell'esaminare le disposizioni normative cui ancorare il ragionamento testé compiuto, il Pugliatti ha affermato che l'art. 1388 c.c. ricollega l'efficacia diretta non solo all'agire in nome altrui ma anche "nell'interesse altrui"; gli articoli 1705, 1706 e 1707 c.c. attribuiscono al mandante importanti rimedi che sostanzialmente fanno coincidere gli effetti del mandato senza rappresentanza con quelli del mandato con procura. In particolare l'art. 1705, 2° comma, c.c., assegna al mandante la titolarità, e quindi la facoltà di esercizio dei diritti acquistati dal mandatario; l'art. 1706, 1° comma, c.c. prevede l'acquisto al mandante delle cose mobili acquisite, nella cura del suo interesse, dal mandatario; l'art. 1707 c.c. statuisce che i creditori del mandatario non possono aggredire i beni che questi ha 57 acquistato in esecuzione del mandato, implicitamente affermando che gli stessi appartengono al mandante. L'Autore sostiene, inoltre, che anche l'art. 1706, 2° comma, c.c., che assegna al mandante il diritto di chiedere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo del mandatario di trasferire ciò che è stato acquisito in esecuzione del mandato, considera il diritto del mandante come espressione della proprietà sostanziale acquistata automaticamente dal mandante rispetto a quella meramente formale del mandatario. Le differenze esistenti tra i due tipi di rappresentanza sono meramente strutturali: nella rappresentanza alla cura dell'interesse altrui, si accompagna la contemplatio domini, che, invece, è assente nella rappresentanza indiretta. Le due figure non sono diverse sotto il profilo effettuale: "se differenza c'è, essa consisterebbe unicamente in ciò, che nella rappresentanza diretta acquista immediatamente e soltanto il rappresentante, mentre in quella indiretta acquistano contemporaneamente il mandante e il mandatario; quest'ultimo, però, acquista e perde automaticamente, nello stesso istante in cui compie il negozio gestorio" (così Pugliatti). Lo stesso autore sottolinea inoltre che si può riaffermare che la rappresentanza indiretta ha in comune con quella diretta la base sostanziale del fenomeno: la cura dell'interesse altrui, a cui si ricollega l'alienità del negozio compiuto dal rappresentante. E oltre: si rende manifesta la necessità di una rielaborazione dello stesso concetto di rappresentanza, sotto il profilo dell'interesse (del dominus), anziché sotto quello della volontà (del cooperatore). Critica. La tesi del Pugliatti è stato oggetto di critiche da parte della dottrina prevalente. In primo luogo si è affermato che l'unico elemento, peraltro non decisivo, che accomuna le figure di rappresentanza è dato nella gestione dell'altrui interesse. Secondo questa opinione dottrinale maggiore importanza riveste la circostanza dell'esplicarsi degli effetti nella sfera giuridica del rappresentato, per cui la rilevanza della gestione dell'altrui interesse rileverebbe solo nella fase del trasferimento degli effetti in capo al gerito. Secondo la dottrina prevalente più che di rappresentanza la figura in discorso rientrerebbe nella più ampia area dell'interposizione gestoria o della sostituzione. Si è, inoltre, affermato che (Mirabelli), soltanto l'attività esplicata in nome del rappresentato, e quindi caratterizzata dalla contemplatio domini, produce direttamente ed immediatamente gli effetti nella sfera giuridica dello stesso. Secondo l'Autore "il particolare modo di agire del sostituto non solo è sufficiente ad individuare il fenomeno, ma rende anche possibile rilevarne la presenza in tutti i casi in cui esso si esplichi unitamente ad una attività di gestione: da questa deriva il soddisfacimento dell'interesse altrui, da quello la diretta esplicazione degli effetti dell'attività nella sfera del titolare della posizione giuridica". Altra critica alla tesi del Pugliatti sostiene che l'istituto in discorso non appartiene al genus della rappresentanza, atteso che in quest'ipotesi si darà luogo ad un contratto di mandato, che si pone in modo del tutto autonomo rispetto alla rappresentanza. Si è, infatti, affermato che il rapporto costituito tra il gestore ed il terzo non può imputarsi al gerito, non essendo sufficiente il mero interesse effettivamente gestito. Opinione prevalente. Secondo la dottrina prevalente la rappresentanza indiretta è un figura che presenta solo alcune analogie con la rappresentanza diretta, rimanendo per il resto del tutto autonoma. L'unico elemento comune è dato dalla gestione nell'interesse altrui. Le conseguenze giuridiche si producono, infatti, nella sfera giuridica del rappresentante e solo mediatamente in capo al rappresentato, sicché la rilevanza del momento gestorio viene in evidenza solo al momento del trasferimento dei suddetti effetti in capo a quest'ultimo. Tale tesi 58 trova riscontro nella stessa lettera della legge. Dal raffronto operato tra l'art. 1388 e l'art. 1705, commi 1 e 2 parte prima c.c. si evince, infatti, che il primo dei due articoli citati prevede che gli effetti del contratto concluso dal rappresentante si producano direttamente in capo al rappresentato, laddove l'art. 1705 statuisce che è il mandatario ad agire in nome proprio e ad acquistare i diritti e gli obblighi scaturenti dal contratto concluso con i terzi e che questi ultimi non hanno alcun rapporto con il mandante. La tesi ha trovato adeguato riscontro in giurisprudenza laddove si afferma che affinché il mandato esplichi effetti nella sfera giuridica del mandante è necessaria la spendita del nome: "nel caso in cui taluno, senza contemplatio domini, abbia agito in nome proprio e per conto altrui, tutti gli effetti del contratto si producono in capo al mandatario e nessun rapporto può costituirsi fra mandante e terzo contraente, non avendo rilevanza, ai sensi dell'art. 1705, l'eventuale conoscenza del mandato da parte di detto terzo" [2]. La dottrina in discorso, che fa leva sulla disposizione di cui all'art. 1705 primo e secondo comma, prima parte, per affermare l'autonomia della figura rispetto alla rappresentanza c.d. diretta, pur conscia delle difficoltà interpretative poste dagli articoli 1705 secondo comma, seconda parte, 1706 e 1707 c.c., le supera asserendo che trattasi di eccezioni al principio generale sancito dal primo comma dell'art. 1705 c.c.. Tali articoli assegnano al mandante alcuni rimedi per l'attività posta in essere dal mandatario. Viene previsto, infatti, che il mandante possa sostituirsi al mandatario per l'esercizio dei diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, che possa rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario e che i creditori del mandatario non possano aggredire i beni acquistati da questo nell'esecuzione del contratto di mandato se il contratto ha data certa anteriore al pignoramento, ovvero, se si tratta di beni immobili, che sia stato trascritto anteriormente al pignoramento. Per spiegare questi rimedi, la dottrina prevalente è concorde nel ritenere che essi abbiano natura eccezionale e che non sanciscano una rilevanza esterna del rapporto gestorio ai fini di un'efficacia diretta del mandato. Le disposizioni di cui agli articoli 1705, 2° comma, e 1706 c.c., infatti, sono il risultato della combinazione dei principi del mandato senza rappresentanza, con il principio consensualistico stabilito dall'art. 1376 c.c. In particolare i principi del mandato senza rappresentanza implicano che il mandante non può esercitare le azioni contrattuali derivanti dal contratto concluso dal mandatario con il terzo. Il mandante, infatti, non può esercitare l'azione di risoluzione del contratto, ovvero l'azione di annullamento dello stesso. Il principio consensualistico, invece, determina la produzione dell'effetto traslativo dal mandante al mandatario, dei diritti che quest'ultimo ha acquistato per conto del primo: "un effetto che, come nei casi di vendita obbligatoria (art. 1476, n. 2), è ritardato al momento successivo alla espressione del consenso contrattuale, ma che, quando è in grado di prodursi (nel nostro caso quando il mandatario ha acquistato), si produce per effetto del consenso. Perciò le azioni ex contractu spettano al mandatario, ed a lui soltanto; le azioni ex re spettano al mandante, come appunto l'azione di rivendica" (così Galgano, Il negozio giuridico, Milano, 1988 pagg. 358, 359). Pur partendo da questa premessa, si riscontra, però, una pluralità di soluzioni interpretative relative a quanto disposto dai suddetti articoli. Quanto al potere di sostituzione del mandante si parla di trasferimento ope legis [3], di azione surrogatoria [4], di azione diretta. In particolare i sostenitori del trasferimento ope legis affermano che mentre gli obblighi del contratto stipulato dal mandatario gravano sullo stesso, non potendo interpretarsi diversamente la norma anche in virtù del principio di affidamento del 59 terzo, invece la proprietà delle cose mobili e dei crediti si trasferisce immediatamente al mandante, con la conseguenza che quest'ultimo può rivendicarle o esigere i crediti. Il trasferimento, quindi, avverrebbe per legge sulla base del contratto di mandato. Altri sostengono, invece, che si sia in presenza di un'azione surrogatoria, apparentemente richiamata dalla lettera dell'art. 1705, 2° comma, c.c., pur in assenza dei presupposti richiesti dall'art. 2900 c.c.. A questa opinione si è obiettato che diversamente da quanto avviene con l'azione surrogatoria, con la quale il creditore esercita i diritti del debitore per la garanzia patrimoniale, il mandante si "appropria di un diritto di credito che gli spetta, in quanto derivante da un'operazione compiuta per suo conto. Questo potere di appropriazione trova tuttavia limite nei diritti che il mandatario ha a sua volta verso il mandante, come il diritto a ricevere i mezzi per adempiere le obbligazioni assunte verso il terzo" (così Bianca, Il contratto, Milano 1987 pagg. 126, 127). La giurisprudenza, aderendo alla tesi della prevalente dottrina, ritiene il carattere eccezionale del principio posto dall'art. 1705, 2° comma c.c. rispetto alla regola generale, secondo cui il negozio concluso con il terzo contraente ricade esclusivamente nella sfera giuridica del mandatario, senza che si costituisca alcun rapporto tra mandante e terzo: "la disposizione del 2° comma - prima parte dell'art. 1705 c.c., introduce, per ragioni di tutela dell'interesse del mandante, un'eccezione al fondamentale principio enunciato nel 1° comma dell'articolo per il quale il mandatario che agisce in nome proprio acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato, consentendo al mandante di esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato" [5]. Quanto al tipo di rimedio concesso al mandante la Cassazione ritiene che si tratti di azione diretta che, però, non implica anche l'esercizio dei rimedi contrattuali: "la natura eccezionale della norma (art. 1705 2° comma c.c.), le finalità di tutela del mandante, l'inequivocità della espressione "diritti di credito derivanti dall'esercizio del mandato" inducono ad escludere, al di fuori dell'azione diretta al soddisfacimento di detti crediti, che il mandante possa esperire contro il terzo le azioni da contratto e, in particolare, quelle di risoluzione per inadempimento e di risarcimento dei danni; opinando diversamente la regola generale sancita dallo stesso art. 1705 c.c. resterebbe svuotata di contenuto" [6]. Quanto al disposto dell'art. 1706 c.c., la prevalente dottrina riconoscendo che trattasi di eccezione al principio dell'efficacia obbligatoria del mandato, fonda la possibilità di rivendica sul presupposto che all'acquisto del mandatario accederebbe un ritrasferimento automatico al mandante (Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, Milano, 1985). Della stessa opinione è anche il Carraro, (Il mandato ad alienare, pp. 9-10) il quale sostiene che "il mandato ad acquistare mobili avrebbe, accanto all'efficacia obbligatoria, un'efficacia reale, nel senso che all'assunzione dell'obbligo ad acquistare si accompagnerebbe già la manifestazione di una volontà di ritrasferire al dominus la proprietà dei mobili che successivamente entreranno nella titolarità del mandatario, operandosi, quindi, il ritrasferimento nello stesso istante in cui detto mandatario ne acquista la proprietà". Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza che, però, ritiene che il secondo trasferimento possa esteriorizzarsi in un successivo negozio, senza che ciò implichi la compromissione del diritto di revindica acquistato dal mandante: "l'art. 1706 c.c., che conferisce al mandante il potere di rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario presuppone che all'atto stesso 60 dell'acquisto da parte di quest'ultimo si attuino due distinti trasferimenti, logicamente successivi, ma cronologicamente contemporanei, l'uno dal terzo al mandatario e l'altro dal mandatario al mandante. Siffatto condivisibile principio non ha tuttavia impedito che, con una non recente sentenza (Cass. 773/66), si sia ritenuto ammissibile che il secondo trasferimento, pur senza compromettere il diritto di revindica già acquisito dal mandante, si esteriorizzi in un successivo, distinto negozio. Invero, il contratto con il quale viene pattuito l'acquisto di cose mobili ad opera del mandatario, che non agisce (e, non essendo munito di poteri di rappresentanza, non può agire) in nome del mandante, vede quali parti uniche e necessarie il terzo alienante e, quale acquirente, lo stesso mandatario; sicché a questi soltanto il primo trasferisce o rimane obbligato a trasferire le cose mobili, specificate nel contratto senza che - nella legittima ignoranza dell'esistenza del mandato e sino a che non sia esercitata dal mandante la revindica ex art. 1706, 1° comma, c.c. - possa sottrarsi alla pattuita consegna alla controparte" [7]. Sempre riguardo all'azione ex art. 1706 c.c. altra dottrina (Tilocca) ha sostenuto che quanto disposto dal primo comma di detto articolo non è un'eccezione al principio statuito dall'art. 1705, 1° comma. Secondo questa interpretazione, ricadendo anche i beni mobili in proprietà del mandatario e potendo anch'egli esperire, al pari del mandante, l'azione di rivendica, l'art. 1706 c.c. andrebbe interpretato alla stregua del disposto dell'art. 1705, ritenendo implicito nella norma in discorso il potere di sostituzione che il secondo comma dell'art. 1705 attribuisce al mandante. L'Autore sostiene, infatti, che la proprietà dei mobili viene acquistata dal mandatario, ma che il mandante può appropriarsene con un proprio atto unilaterale di sostituzione da intendersi come speciale atto di autotutela. Questo sarebbe possibile in forza della considerazione che, per i diritti di credito e per i beni mobili, non sono necessari gli adempimenti relativi alla forma ed alla pubblicità previsti per i diritti reali immobiliari. Anche l'art. 1707 c.c. relativo ai rapporti con i creditori del mandatario, pur essendo espressione della tesi prevalente, che prevede il ritrasferimento dei beni dal mandatario al mandante, è stato oggetto di diverse ricostruzioni dottrinali. Secondo una prima tesi la norma conferma che le cose mobili e i crediti acquistati dal mandatario si trasferiscono immediatamente in capo al mandante, ope legis e che, pertanto, l'art. 1707 c.c. è un'applicazione dell'art. 2914, n. 4, c.c. secondo il quale "non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atti aventi data certa". Altra opinione sostiene che la norma limita le conseguenze, lesive per il mandante, derivanti, in base al disposto degli articoli 2740 e 2741 c.c., dall'appartenenza al mandatario dei crediti e dei mobili, che "se si acquistassero direttamente dal mandante, dovrebbero essere in ogni caso imperseguibili dai creditori del mandatario" (così Tilocca). Da ultimo va ricordata la tesi di chi (Minervini) ritiene che l'art. 7070 c.c., assegnando al contratto di mandato l'effetto di limitare la disponibilità dei beni, sia un'applicazione dell'art. 2915, 1° comma, c.c.. Tesi di Sacco e Bianca. Seppur brevemente vanno ricordate le tesi di due illustri studiosi del diritto civile. Per il Bianca il dibattito tra tesi sostanziale e tesi formale giustifica l'intendimento di un'ampia nozione di rappresentanza, quale legittimazione ad agire per conto altrui. Per l'Autore, pur ritenendo valide le due idee di rappresentanza, ciò che conta è il momento della responsabilità: "ciò che per il nostro ordinamento deve essere tenuto fermo è che l'agire in nome proprio non comporta gli stessi effetti dell'agire in nome altrui: l'agire in nome proprio, 61 infatti, preclude al terzo contraente di esercitare la sua pretesa contrattuale nei diretti confronti dell'interessato. Affinché l'interessato divenga parte sostanziale del rapporto contrattuale occorre che il rappresentante agisca in suo nome: la spendita del nome del rappresentato è quindi il dato caratterizzante e distintivo della rappresentanza diretta". Il Sacco, invece, si segnala per un'originale interpretazione degli effetti derivanti dalla rappresentanza indiretta. Egli, infatti, ritiene che il trasferimento degli effetti in capo al mandante può essere giustificato, per i soli beni mobili, in virtù del disposto dell'art. 1376 c.c.. Lo stesso non si potrebbe, però, sostenere per gli immobili, atteso che l'art. 1706, 2° comma, che esclude, relativamente a tali beni, l'operatività del principio consensualistico. L'Autore continua la propria disamina degli effetti, affermando che il potere di sostituzione del mandante, di cui all'art. 1705 c.c., va interpretato "come equivalente stretto della notifica di cui all'art. 1264, c.c.", e sostiene che quanto statuito dal 1° comma della norma in discorso, si riferisca soltanto alle azioni a tutela del buon fine contrattuale attribuita al mandatario. Ne consegue che nel contratto di mandato saremmo in presenza di un'azione ex contractu per l'adempimento di spettanza del mandatario e di un'azione per il soddisfacimento del credito di spettanza del mandante. Mandato ad alienare. Connessa con le problematiche affrontate è la figura giuridica del mandato ad alienare. Questa ipotesi di mandato, a differenza del mandato ad acquistare, non è espressamente disciplinata dal codice civile. In tal caso la difficoltà che si pone all'interprete è data dal tipo di giustificazione, coerente con il sistema, da dare ad un'operazione contrattuale in cui l'alienante non è titolare del bene. Secondo una prima ricostruzione (Mengoni) il trasferimento del bene avverrebbe direttamente dal mandante al terzo e ciò grazie ad una legittimazione a disporre in nome proprio del diritto altrui, che competerebbe al mandatario. Si sarebbe in presenza di una legittimazione indiretta di persona non titolare del diritto. In tal caso il mandatario farebbe acquistare il bene direttamente al terzo, senza la necessità di un preventivo trasferimento da parte del mandante. Altra tesi sostenuta in dottrina (Carraro) ritiene, invece, che il mandato ad alienare sia una fattispecie complessa data dal mandato e dall'esecuzione dello stesso. In particolare, si è detto, che l'esecuzione del contratto di mandato comporterebbe il trasferimento della titolarità del bene dal mandante al mandatario, grazie all'efficacia traslativa del contratto stesso. Una terza opinione (Minervini) ritiene che nell'ipotesi di mandato ad alienare si assisterebbe ad un duplice trasferimento: dal mandante al mandatario e da questi al terzo. Il primo trasferimento si attua, a seconda degli Autori, o in virtù di un negozio traslativo avente causa esterna, si applicherebbe in tal caso l'art. 1706, 2° co, c.c., e quindi l'atto sarebbe solvendi causa (Minervini); ovvero automaticamente, anche in caso di alienazioni immobiliari, al momento del trasferimento al terzo ad opera del mandatario (Santagata). Quest'ultima ricostruzione è stata ulteriormente perfezionata da chi (Luminoso) ritiene che l'effetto traslativo in favore del mandatario sarebbe subordinato alla condicio iuris sospensiva, rappresentata dall'alienazione del mandatario al terzo. La stessa Corte di Cassazione, pur non volendo prendere posizione, ha opportunamente considerato che se nella figura in discorso fosse sempre necessario il trasferimento del bene dal mandante al mandatario, il mandato perderebbe la propria funzione. Senza considerare che, comunque, identico risultato potrebbe raggiungersi mediante un negozio fiduciario, in cui il fiduciante trasferisce il bene al fiduciario che, successivamente lo trasferirà a determinate 62 condizioni; ovvero attraverso un'intestazione simulata in forza della quale il mandatario figura come proprietario del bene. In particolare la Suprema Corte, in una delle poche pronunce sull'argomento, ha affermato che "se fosse sempre necessario - quanto meno nel mandato a vendere beni immobili o mobili registrati (i quali ultimi, peraltro, si trasferiscono con il solo consenso) - un previo negozio formale di trasferimento dal mandante al mandatario per legittimare la successiva alienazione formale del bene da parte di quest'ultimo, il contratto di commissione e l'istituto del mandato a vendere perderebbero gran parte della loro funzione ed utilità. L'incondizionato trasferimento del bene al mandatario potrebbe, inoltre, essere causa di inconvenienti ed abusi da parte del medesimo, come la dottrina ha sottolineato. Si deve allora ritenere, in adesione dei più recenti studi sull'argomento, che nel mandato ad alienare (e nella commissione, quando abbia ad oggetto questo tipo di mandato) sia ravvisabile un contratto nel quale l'effetto traslativo del bene, derivante dal consenso manifestato dalle parti (art. 1376 c.c.), non si verifica immediatamente ma è sospensivamente condizionato al compimento dell'alienazione gestoria del bene medesimo da parte del mandatario o commissionario" (v. in motivazione Cass. 7 dicembre 1994 n. 10522). I primi commentatori della sentenza, pur evidenziando il carattere innovativo del principio di diritto testé riportato, hanno evidenziato come ciò non valga ad attribuire incondizionatamente al mandato ad alienare efficacia traslativo - reale. È stato sottolineato, infatti, che "quello che caratterizza la fattispecie in esame è la contemporanea presenza di una situazione obbligatoria, derivante dal mandato, e di una situazione reale, derivante dall'alienazione gestoria. Infatti la S.C. parla di effetto traslativo - reale del bene (derivante dal consenso delle parti) e non del mandato. Per legittimare l'atto di disposizione del mandatario, situazione reale e situazione obbligatoria sono tra di loro collegate, operando l'alienazione gestoria come condizione sospensiva legale dell'effetto traslativo dal mandante al mandatario. Tale effetto non si realizza se il mandatario non vende" (Battaglia in Giustizia Civile 1995 pag. 1266 e segg.). Il problema che residua è dato dall'atteggiarsi del meccanismo ora illustrato nell'ipotesi in cui oggetto del mandato siano beni mobili registrati o beni immobili e dell'armonizzazione dello stesso con i principi dell'istituto della trascrizione e con l'assunto, consolidato in giurisprudenza, secondo cui il mandato ad alienare i suddetti beni deve essere conferito, a pena di nullità, per iscritto, anche nell'ipotesi di mandato senza rappresentanza. In proposito si è sostenuto che il terzo acquirente dovrà trascrivere il proprio atto d'acquisto non nei confronti del mandatario, atteso che questi non risulterà proprietario del bene. Né è da accogliere la tesi della diretta trascrivibilità del mandato in considerazione della mera eventualità che l'alienazione gestoria si concluda. Si è allora affermato che se nel mandato ad alienare il negozio gestorio opera come condicio iuris dell'effetto traslativo dal mandante al mandatario, "non può non circoscriversi l'operatività del mandato senza rappresentanza al caso in cui oggetto del negozio sia un contratto preliminare per persona da nominare, a cui faccia seguito la stipula del definitivo tra mandante e terzo acquirente. Qualora l'alienazione gestoria si sostanzi in un contratto definitivo, il meccanismo rappresentativo può funzionare soltanto in presenza di una procura a vendere, che consenta di individuare chiaramente il dominus - proprietario e di risolvere le problematiche relative alla trascrizione" (così Battaglia ibidem). Rapporti con i creditori del mandatario. I problemi inerenti i rapporti con i creditori del mandatario sono risolti diversamente dai sostenitori delle tesi su richiamate. I fautori della tesi dell'efficacia traslativa del mandato solo a seguito 63 dell'alienazione del mandatario, escludono che il bene oggetto del mandato possa essere aggredito dai creditori del mandatario. Il principio, però, non sarebbe applicabile nell'ipotesi di mandato ad alienare beni mobili, poiché in tal caso si potrebbe opporre il mandato al creditore pignorante solo se stipulato in data certa anteriore al pignoramento, ovvero qualora il mandante sia in grado di provare che il proprio titolo di acquisto abbia data anteriore. Coloro che, invece, sostengono la tesi dell'immediata efficacia traslativa del mandato, configurano un vincolo d'indisponibilità a favore del mandante, con la conseguenza che per risolvere i conflitti con i terzi creditori del mandatario troverebbe applicazione l'art. 2915 c.c.. Azione revocatoria. Si discute, altresì, sulla possibilità di esperimento dell'azione revocatoria da parte dei creditori del mandante e del mandatario. Accogliendo la tesi della condicio iuris si nega che i creditori del mandatario possano esercitare l'azione in discorso nei confronti del loro debitore; si ammette, invece, che i creditori del mandante possano esperire tale rimedio, specificando che in primo luogo dovrebbero agire nei confronti del mandatario e, solo successivamente, contro il terzo contraente (v. per tutti Luminoso, in Trattato Rescigno, 12). Antonino Nastasi magistrato [1] V. per tutti Pugliatti, Studi sulla rappresentanza, Milano 1965; Fiducia e rappresentanza indiretta, in Diritto civile. Saggi, Milano 1951. [2] Cass. 7 gennaio 1993 n. 78, in Repertorio del Foro Italiano, voce Rappresentanza nei contratti, n. 14. [3] Ferrara jr. Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano 1995 p. 141. [4] Minervini, Il mandato, p. 106. [5] Così in motivazione Cass. 5 novembre 1998 n. 11118, in Il Foro Italiano, 1999, I, 94. [6] Così in motivazione Cass. 5 novembre 1998 n. 11118, cit. [7] Così in motivazione Cass. SS.UU. 28 gennaio 1994 n. 728, in Il Foro Italiano, 1994, I, 1053. ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE TRACCIA Tizio è sposato da diversi anni con Caia. Tizio e Caia litigano continuamente, soprattutto perché Tizio è violento e perde facilmente la pazienza; inoltre, Tizio ama uscire la sera con Sempronia, ex fidanzata, lasciando in casa la povera Caia. Tizio e Caia decidono di non coabitare più insieme e vanno a vivere in città diverse. Un giorno, Tizio viene a sapere che Caia, in altra città, si è data alla prostituzione; Tizio telefona a Caia, avvertendola che intende chiedere la separazione giudiziale con addebito in capo alla stessa Caia a causa dei suoi comportamenti da meretrice. Caia si reca dal legale Sempronio. Il candidato, assunte le vesti di Sempronio, rediga motivato parere. 64 POSSIBILE SCHEMA DI SOLUZIONE In premessa poteva essere utile ricostruire sinteticamente il fatto. Successivamente, era utile accennare al fatto che l’addebito della separazione è collegato, essenzialmente, alla violazione di doveri coniugali (ovvero doveri collegati con la famiglia, comprensivi di quelli verso i figli, anche se maggiorenni). Tuttavia, secondo la giurisprudenza più recente, ai fini dell’addebito della separazione. non basta la violazione dei doveri coniugali ma è necessario verificare, caso per caso, il momento in cui tali doveri non sono stati rispettati; più in particolare, l’addebito va imputato a colui che pone in essere atti-fatti intollerabili con la prosecuzione della convivenza, ex art. 151 c.c., con la conseguenza che bisogna verificare quale atto-fatto abbia determinato l’impossibilità di prosecuzione della convivenza, indipendentemente dai comportamenti successivi al venir meno dell’affectio. In altri termini, non assume rilievo giuridico ai fini dell’addebito della separazione il comportamento del coniuge, successivo alla verificazione di una causa di incompatibilità con la prosecuzione del rapporto. Pertanto, in questo senso, non rileva ai fini dell’addebito della separazione il comportamento di Caia che si è data alla prostituzione dopo la decisione di non coabitare più con il marito, ma rileverebbe, al più, il comportamento di Tizio che, durante la coabitazione successiva al matrimonio, usciva con la ex fidanzata Sempronia, ponendo in essere un comportamento incompatibile con la vita di coppia; sotto tali profili, allora, l’eventuale addebito della separazione andrà a carico di Tizio. Si consiglia di leggere le sentenze che seguono. -L’infedeltà non è da sola sufficiente a giustificare l’addebito della separazione, perché bisogna verificare il momento in cui si è verificata e, se successiva alla venuta meno dell’affectio maritalis, non ci può essere addebito. CASS. CIV.- SEZ. I- 19 settembre 2006, n. 20256- Pres. Luccioli – est. PanzaniSvolgimento del processoCon atto 5 novembre 1990 Massinelli Walter chiedeva la separazione giudiziale con addebito dalla moglie Bulagna Paola. il matrimonio era stato contratto il 27 luglio 1974 e ne erano nati i figli Daniele e Simone, ora maggiorenni. La Bulagna non si opponeva alla separazione, ma domandava che fosse addebitata al marito.Il Tribunale di Perugia respingeva le domande di addebito reciproche, assegnava la casa coniugale al Massinelli e poneva a carico di quest,ultimo l’obbligo di versare alla Bulagna a titolo di contributo di mantenimento la somma mensile di euro 464,81.Proponeva appello principale la Bulagna ed incidentale il Massinelli. La Bulagna insisteva per la pronuncia dell’addebito al Massinelli, per l’assegnazione della casa coniugale e per il riconoscimento del contributo di mantenimento in misura superiore. Il Massinelli domandava l’addebito alla Bulagna e l’esclusione dell’assegno o, in 65 subordine, il riconoscimento in somma inferiore. La Corte d’appello di Perugia con sentenza 13 giugno 2003 accoglieva parzialmente l’appello della Bulagna revocando l’assegnazione della casa familiare al Massinelli ed elevando l’assegno di mantenimento ad euro 568,10. Rigettava invece la domanda di addebito della separazione al marito e l’appello incidentale del Massinelli.Osservava la Corte territoriale che dalla Ctu esperita era emerso che il fallimento del matrimonioandava ascritto a responsabilità di entrambi i coniugi perché la loro condotta era stata improntata ad «affermazione di responsabilità, egocentrismo, desiderio di sopraffazione, aggressività, conflittualità permanente, reciproche infedeltà, prodigalità». Il fatto che la Bulagna dopo la separazione si fosse dedicata all’esercizio della prostituzione andava collocato nel quadro caratteriale della stessa e Come esplicazione finale degli atteggiamenti di infedeltà già attuati da entrambi i coniugi da prima della separazione. Sia per la Bulagna che per il Massinelli risultavano provati episodi di infedeltà successivi alla separazione e quindi al 1990. il Massinelli aveva avuto varie relazioni extraconiugali successive alla separazione; a carico della Bulagna erano provati episodi di prostituzione risalenti al 1993 ed ad anni successivi.Di qui la reiezione di entrambe le domande di addebito.La casa coniugale non poteva essere assegnata al Massinelli perché i figli erano ormai maggiorenni ed autosufficienti e non vi erano quindi ragioni di tutela dell’ambiente familiare.Quanto all’assegno di mantenimento, la Bulagna era senz’altro il coniuge più debole, pur avendo lavorato in passato, tenuto conto del fatto che il Massinelli godeva di notevoli risorse immobiliari e di un cospicuo reddito. Di qui l’accoglimento parziale della richiesta di aumento dell’assegno avanzata dalla Bulagna.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Massinelli articolando due motivi. Resiste con controricorso la Bulagna che ha anche proposto ricorso incidentale con un motivo, contrastato dal Massinelli con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.Motivi della decisioneCon il primo motivo del ricorso principale il Massinelli deduce violazione dell’articolo 6, comma 6, legge 898/70 in ordine alla revoca del 1 assegnazione della casa coniugale disposta dalla Corte d’appello. Premesso che la revoca in questione non fa venir meno i diritti dominicali che spettano al Massinelli in quanto comproprietario dell’immobile, il ricorrente osserva che ai sensi dell’articolo 6 citato l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore con cui i figli convivono, anche oltre la maggiore età. Le aziende di cui i figli del Massinelli sono titolari e dalla cui esistenza la Corte territoriale ha dedotto la loro indipendenza economica, prospererebbero soltanto grazie alla presenza del ricorrente ed al suo impegno in favore dei figli. D’altra parte la nozione di famiglia non si ridurrebbe al profilo economico, per cui la Corte d’appello avrebbe trascurato la necessità di assicurare il mantenimento della famiglia quale cellula sociale al cui interno si sviluppa la personalità della prole.Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce violazione degli articoli 143 e 146 Cc nonché difetto di motivazione in ordine ad un punto essenziale della controversia.Nel respingere la domanda di addebito la Corte d’appello avrebbe trascurato che nel dedicarsi al meretricio la Bulagna non avrebbe soltanto violato l’obbligo di fedeltà, ma avrebbe tenuto un comportamento incompatibile con il decoro ed il rispetto dell’altro coniuge, obbligo che non viene meno per effetto della separazione.Nel determinare l’assegno di mantenimento la Corte non avrebbe poi tenuto conto che tale assegno non va legato all’attuale reddito dell’onerato,. peraltro erroneamente ritenuto dai giudici d’appello pari a lire 313.352.000 annue, somma che corrisponderebbe invece ai redditi lordi del periodo 1989-97 - ma al reddito all’epoca del 66 matrimonio, mirando l’assegno a garantire al coniuge ritenuto più debole un tenore di vita pari a quello goduto in costanza di matrimonio. il reddito fiscalmente dichiarato nel 1990 era pari a 13 milioni di lire annui e su di esso gravavano le spese relative al mantenimento dei due figli.Con l’unico motivo del ricorso incidentale la Bulagna deduce violazione dell’articolo 156 Cc nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione. La somma liquidata dalla Corte di merito a titolo di assegno di mantenimento sarebbe del tutto irrisoria rispetto alla reale capacità economica del Massinelli ed al tenore di vita, più che agiato, dei coniugi in costanza di matrimonio ed alla lunga durata del matrimonio stesso.2. Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi, principale ed incidentale, ex articolo 335 Cpc.Il primo motivo del ricorso principale non è fondato.Il ricorrente si duole che la Corte territoriale, nel riformare la sentenza di primo grado e nel respingere la domanda di assegnazione al ricorrente della casa coniugale, abbia ritenuto non sussistere i presupposti per tale assegnazione perché i figli del Massinelli erano ormai maggiorenni ed autosufficienti.L’assegnazione della casa coniugale dovrebbe essere disposta anche in questo caso perché da un lato l’autosufficienza economica dei figli, titolari di autonome attività commerciali, si fonderebbe sulla presenza e guida paterna e dall’altro perché la previsione dell,assegnazione della casa coniugale al genitore con cui convivono i figli sarebbe mirata a garantire il mantenimento dell’unità familiare a prescindere dall’indipendenza economica dei figli, al fine di assicurare la permanenza dell’unità della famiglia, quale valore in sé garantito anche dalla costituzione.Va premesso che il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 6, comma 6, legge 898/70, ma che nella specie, trattandosi di giudizio di separazione, trova applicazione l’articolo 155, comma 4, Cc, nel testo vigente prima della riforma introdotta dalla legge 54/2006, che dispone che l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza i e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.Nella memoria ex articolo 378 Cpc la controricorrente ha eccepito che nella specie dovrebbe trovare applicazione la nuova disciplina dettata dalla legge 54/2006, ed in particolare l’articolo 155quater Cc, introdotto dalla legge ora citata.L’articolo 155quater, al comma 1 dispone in particolare che «il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio». Ad avviso della controricorrente tale sarebbe la situazione nel caso in esame, perché da anni il Massinelli convivrebbe nella casa coniugale con altra donna da cui avrebbe avuto anche una bambina.Ad avviso della controricorrente le nuove disposizioni troverebbero immediata applicazione anche nel presente giudizio.L’eccezione è peraltro inammissibile.L’articolo 4, comma 1, della legge 54/2006 stabilisce, infatti, che nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall’articolo 710 del Cpc o dall’articolo 9 della legge 898/70, e successive modificazioni, l’applicazione delle disposizioni della nuova legge.La legge 54/2006 non contiene alcuna disposizione che deroghi al principio generale per cui la legge dispone soltanto per l’avvenire, sancito dall’articolo 11 preleggi.Ne deriva che, qualora sia già stata pronunciata sentenza di separazione, le nuove disposizioni possono trovare applicazione soltanto attraverso un nuovo procedimento nelle forme previste dall’articolo 710 CpcNé può osservarsi che nel caso in esame la sentenza di separazione pronunciata inter partes ed i conseguenti 67 provvedimenti non sarebbero ancora definitivi, in ragione della pendenza del giudizio di cassazione. in tale giudizio, invero, non può trovare ingresso l’esame di nuove circostanze di fatto, nella specie la convivenza del Martinelli nella casa coniugale con una nuova compagna.3. Tornando ora al primo motivo di ricorso va ricordato che con riferimento all’articolo 155, comma 4, Cc questa Corte ha affermato che in materia di separazione o divorzio, anche nell’ipotesi in cui l’immobile sia di proprietà comune dei coniugi, l’assegnazione della casa familiare resta subordinata all’impresciridibile presupposto dell’affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti: diversamente, infatti, dovrebbe porsi in discussione la legittimità costituzionale del provvedimento, il quale, non risultando modificabile a seguito del raggiungimento della maggiore età e dell’indipendenza economica da parte dei figli, si tradurrebbe in una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà, tendenzialmente per tutta la vita del coniuge assegnatario, in danno del contitolare (Cassazione 1545/06, est. Di Amato).Il Collegio condivide tale principio, non senza rilevare che l’autosufficienza economica dei figli maggiorenni consente agli stessi, ormai divenuti adulti responsabili, di effettuare le scelte di vita ritenute preferibili, rimanendo nella famiglia di origine ovvero dando vita a famiglie autonome, senza che più occorra intervenire a protezione degli stessi, differentemente da quanto avviene nel caso di prole minorenne o di figli maggiorenni, ma ancora non economicamente autosufficienti.4. Il secondo motivo del ricorso principale è del pari T infondato. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia considerato che il dedicarsi della Bulagna al meretricio avrebbe leso, al di là dell’infedeltà commessa, il dovere al reciproco rispetto tra i coniugi che permane anche nel caso di separazione, si che avrebbe dovuto essere accolta la domanda di addebito.In realtà la Corte territoriale ha compiuto, sulla scorta della Ctu esperita, una complessa disamina dei rapporti intercorsi tra i coniugi, ben al di là della mera circostanza dell’infedeltà. Ed è pervenuta, con adeguata motivazione, alla conclusione che la comunione morale e materiale tra i coniugi era venuta meno per fatto riferibile alla condotta di entrambi, sottolineando che sia il Martinelli che la Bulagna si erano resi responsabili di “egocentrismo, desiderio di sopraffazione, aggressività, conflittualità permanente, reciproche infedeltà, prodigalità”. In questo quadro il prostituirsi della Bulagna rappresenta soltanto un episodio, successivo alla separazione, di una situazione di conflittualità e di tensione esasperata, che si spiega, osserva la Corte territoriale, non per motivi di mancanza di reddito, avendo anzi la controricorrente sempre goduto di “un notevole tenore di vita e di varie occasioni di lavoro”.Questa Corte ha ancora di recente affermato che in tema di separazione tra coniugi. l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale ed a maggior ragione un comportamento átremo quale l’abbandonarsi al meretricio) rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Pertanto, la riferita infedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell’addebito della separazione solo quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell’unione, mentre il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di 68 intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito (Cassazione 8512/06, est. Giuliani).Nel caso di specie la Corte territoriale ha dato conto, con adeguata motivazione,che l’unione dei coniugi era entrata in crisi già anteriormente al comportamento censurato che ne rappresentava anzi una conseguenza.Va poi aggiunto che, come affermato da questa Corte (Cassazione 17710/05, est. Panzani), il comportamento tenuto dal coniuge successivamente al venir meno della convivenza, ma in tempi immediatamente prossimi a detta cessazione, è privo, in sé, di efficacia autonoma nel determinare l’intollerabilità della convivenza stessa, anche se può rilevare ai fini della dichiarazione di addebito della separazione allorché costituisca una conferma del passato e concorra ad illuminare sulla condotta pregressa, ipotesi quest’ultima che nel caso in esame non ricorre.5. Con ulteriore profilo del medesimo secondo motivo il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per aver determinato l’assegno di mantenimento commisurandolo al reddito attualmente percepito dal ricorrente e non a quello goduto, in costanza di matrimonio, vale a dire nel 1990.Tale censura va esaminata insieme all’unico motivo del ricorso incidentale con cui la Bulagna lamenta che la Corte d’appello abbia determinato l’assegno di mantenimento in euro 568,10 disattendendo la domanda di maggior somma. Per pervenire a tale risultato la Corte territoriale ha osservato che il Massinelli gode “di notevoli risorse immobiliari e di un cospicuo reddito”. Ad avviso della ricorrente incidentale la Corte non avrebbe tenuto conto del reddito complessivo percepito dal Massinelli, pur dando atto che dalle indagini compiute erano emersi conti miliardari di cui questi poteva disporre per 11 tramite delle società di cui era titolare.Entrambe le censure vanno disattese, anche se per quanto concerne il ricorso incidentale è pregiudiziale la pronuncia d’inammissibilità.Questa Corte ha affermato che in tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell’articolo 156 Cc, il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del richiedente; sicché, ai fini dell’imposizione (e della determinazione) dell’assegno, occorre tener conto dell’incremento dei redditi di uno di essi anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (Cassazione 18327/02, est. V. Proto; Cassazione 2626/06, est. Giusti) . Di conseguenza correttamente la Corte territoriale ha tenuto conto del reddito attuale del Massinelli, non essendo venuta meno in costanza di separazione,, la solidarietà economica che lega i coniugi.Per altro verso ai fini del riconoscimento del diritto al mantenimento, in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, è necessario che quest~ sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sussista una disparità economica fra i due coniugi. Al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica e dall’altro lato, non è necessaria la determinazione dell’esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l’acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un’attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto 69 delle quali risulti consentita l’erogazione, dall’uno all’altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze (Cassazione 3.10.2005, est. Del Core).Nel caso in esame la Corte d’appello ha tenuto conto del cospicuo reddito percepito dal Massinelli e della disponibilità di proprietà immobiliari, pur non potendo quantificare esattamente tale reddito, e sulla base di tali circostanze ha determinato il contributo di mantenimento.La controricorrente, nell’affermare che la Corte d’appello ha fatto corretto riferimento ai risultati delle indagini espletate dalla Guardia di Finanza, ma ha poi determinato l’assegno in una somma non in linea con quanto emerso e valutato, propone, denunciando il vizio di motivazione, una valutazione delle risultanze processuali diversa da quella cui è pervenuta la Corte territoriale e formula, di conseguenza, una censura di’ merito inammissibile in questa sede.6. Il ricorso principale va conseguentemente rigettato, mentre il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile.Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.PQMLa Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale.Spese compensate. -Al fine dell'assegnazione ad uno dei coniugi separati o divorziati della casa familiare, non basta la mera constatazione della convivenza con figli maggiorenni, ma occorre che si tratti della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia finchè era unita e che i figli maggiorenni conviventi versino, senza loro colpa, in condizione di non autosufficienza economica. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE (Presidente M. G. Luccioli, Relatore G. V. A. Magno ) SENTENZA 20-01-2006, n. 1198 Svolgimento del processo 1.- Con sentenza depositata il giorno 11/10/2001, il Tribunale di Rimini dichiarò cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario fra i signori C.C. e P.I. e, per quanto ancora interessa, riconobbe a quest'ultima un assegno di divorzio di L. 250.000 mensili, rivalutabili, condannando l'ex coniuge anche al pagamento di un quarto delle spese di lite. 2.- Propose appello C.C. per chiedere, in riforma della sentenza impugnata, la revoca della condanna al pagamento dell'assegno di divorzio e di quella sulle spese. La signora P., costituendosi in giudizio, chiese il rigetto dell'impugnazione proposta ex adverso e spiegò appello incidentale per domandare l'assegnazione della casa coniugale. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Bologna, accogliendo entrambi i gravami, revocò la disposizione relativa all'assegno di 70 divorzio, ma attribuì a P.I., convivente con figlia maggiorenne, l'abitazione nella casa familiare; e compensò integralmente fra le parti le spese di giudizio. 4.- Per la cassazione di tale sentenza C.C. propone ricorso, con un solo motivo, illustrato da memoria, cui resiste P.I. mediante controricorso e proponendo altresì ricorso incidentale, pure con un solo motivo. Motivi della decisione 5.- Devesi disporre preliminarmente la riunione, ai sensi dell'articolo 335 c.p.c., del ricorso principale e dell'incidentale, siccome proposti contro la stessa sentenza. 6.- Con l'unico motivo del ricorso principale, C.C. censura la sentenza impugnata per violazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 6, comma 6, come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, articolo 11, nonchè per omessa, insufficiente ed errata motivazione su un punto decisivo della controversia ed omesso esame di documenti e circostanze decisive per la soluzione della lite, con riferimento all'attribuzione della casa coniugale alla ex moglie. 6.1.- Afferma, in particolare, che non sussisterebbe alcun diritto della donna all'assegnazione della casa di proprietà comune di esse parti, sia perchè tale immobile è diverso da quello, tolto in locazione, in cui la famiglia abitò finchè rimase unita sia perchè la figlia ultraventenne convivente con la madre devesi considerare autosufficiente sotto il profilo economico, tanto da non essere destinataria di alcun assegno di mantenimento a carico del padre, come già motivatamente disposto dal Tribunale con decisione coperta dal giudicato. 6.2.- Il motivo di censura suesposto è fondato, sotto entrambi i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione. 6.2.1.- La sentenza impugnala, premesso che l'abitazione nella casa familiare "spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età", e rilevato che, nel caso di specie, la P. e la figlia maggiorenne Simona - cui il Tribunale non ha riconosciuto alcun diritto al mantenimento da parte del padre - convivono nell'appartamento di proprietà comune degli ex coniugi, ha ritenuto sussistente il presupposto giuridico per l'assegnazione di detta abitazione all'appellata. 6.2.2.- La premessa da cui muove l'argomentazione del Giudice a quo, e la surriferita conclusione, non sono giuridicamente esatte. Per costante giurisprudenza di questa suprema corte, condivisa dal collegio, sono requisiti imprescindibili, per l'assegnazione della casa "familiare" ad uno dei genitori separati o divorziati, la sussistenza di tale requisito - nel senso (indicato da Cass. nn. 13065/2002, 6706/2000, 12083/1995) di habitat domestico, ossia di luogo degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia durante la convivenza dei suoi membri - e l'affidamento a questo di figli minorenni o la convivenza con figli maggiorenni, incolpevolmente privi di adeguati mezzi autonomi di sostentamento (Cass. nn. 12309/2004, 13736/2003, 4753/2003, 661/2003, 2070/2000, 11030/1997 ed altre). 6.2.3.- La corte bolognese non fornisce alcuna motivazione in ordine alla necessaria sussistenza del primo requisito (carattere di casa "familiare" dell'abitazione assegnata) e, pur notando che il Tribunale aveva respinto la domanda proposta dalla P., diretta ad ottenere dall'ex coniuge un contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne convivente, omette di motivare il suo convincimento circa l'esistenza dell'altro presupposto (mancanza incolpevole di autosufficienza economica) per l'assegnazione dell'abitazione. 6.2.4.- Si deve pertanto riaffermare che, al fine dell'assegnazione ad uno dei coniugi separati o divorziati della casa familiare, non basta la mera constatazione 71 della convivenza con figli maggiorenni, ma occorre che si tratti della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia finchè era unita e che i figli maggiorenni conviventi versino, senza loro colpa, in condizione di non autosufficienza economica. 7.- Con l'unico motivo del ricorso incidentale, l'impugnata sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 5, comma 6, (e successive modificazioni), nonchè per omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, consistente nella revoca dell'assegno di divorzio, già stabilito dal Tribunale a favore della P. nella misura di L. 250.000 (pari ad Euro 129,11) mensili. Sostiene, in definitiva, la ricorrente incidentale che l'applicazione corretta dei criteri legali avrebbe dovuto indurre la Corte d'Appello a confermare il modesto assegno di divorzio riconosciutole dal Tribunale. 7.1.- La corte d'appello asserisce, in merito alla (non) spettanza di detto assegno, che la posizione economica di entrambe le parti era peggiorata in epoca posteriore al divorzio; che, comunque, il diritto ad un pur modesto assegno, astrattamente riconoscibile a favore della P., verrebbe meno in considerazione della condizione economica e patrimoniale dell'obbligato, prossima alla soglia minima di sopravvivenza. 7.2.- Osserva il collegio che l'accoglimento del ricorso principale, relativo all'assegnazione della casa, influisce sulla sentenza impugnata, ai sensi dell'articolo 336 c.p.c., comma 1, nella parte in cui questa esclude la spettanza dell'assegno di divorzio, dovendo il Giudice del rinvio, nel decidere anche a questo proposito, rivalutare l'intera situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce della decisione sulla casa. 7.3.- Il ricorso incidentale è, pertanto, assorbito. 8.- Per le ragioni esposte, il ricorso principale deve essere accolto e l'incidentale resta assorbito. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata e la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna, che giudicherà uniformandosi ai principi di diritto suespressi (par. 6.2.4, 7.2) e vorrà anche provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2006. -Il rifiuto di avere rapporti sessuali per ben sette anni è motivo di addebito della separazione. Cassazione Sezione prima civile 72 Sentenza 23 marzo 2005 n. 6276 Svolgimento del processo Con sentenza del 30 maggio 2000, il tribunale di Trapani pronunciò la separazione personale dei coniugi Piera N. e Francesco G., addebitandola a quest’ultimo e adottando conseguenti statuizioni in ordine all’affidamento dei figli minori e agli aspetti economici. Avverso tale sentenza il G. propose appello chiedendo, tra l’altro, nuovamente che la separazione, a lui precedentemente imputata, fosse invece addebitata alla moglie. Il gravame fu respinto dalla Corte d’appello di Palermo, la quale osservò che, contrariamente a quanto sostenuto con l’atto impugnatorio, il primo giudice aveva tenuto presenti tutte le dichiarazioni rese dall’appellante in sede di interrogatorio formale, ivi compreso il riferimento al comportamento, non certo conforme ai doveri di solidarietà verso il marito, assunto dalla N. quando si era schierata col fratello che aveva accusato il G. di essersi appropriato di somme appartenenti alla Cooperativa edilizia da cui era stato realizzato l’appartamento coniugale e della quale era divenuto presidente. Il tribunale aveva infatti valutato l’atteggiamento della N., ritenendo tuttavia del tutto sproporzionata la reazione del G., rifiutatosi per ben sette anni di intrattenere normali rapporti effettivi e sessuali con la moglie. Adottando tale conclusione, il primo giudice aveva fatto retta applicazione dei consolidati principi, invocati dallo stesso appellante, in materia di addebitabilità della separazione, che impongono di valutare comparativamente i comportamenti dei coniugi al fine di accertare quale dei due sia o se entrambi siano causa efficiente dell’avvenuta separazione. Sempre al contrario di quanto affermato con l’atto di appello, il G., in sede di interrogatorio formale, aveva sostenuto di avere interrotto i rapporti con la moglie proprio in reazione alla condotta di questa, così implicitamente affermando che l’interruzione era stata frutto di una sua precisa determinazione. Pienamente da condividere era l’argomento utilizzato dai primi giudici in ordine alla sproporzione tra il comportamento del marito e la risalente condotta della N., improntata si a mancanza di fiducia, e quindi di solidarietà, nei confronti del coniuge, ma certamente non integrante di per sé una trasgressione grave dei doveri coniugali, tale da sorreggere la pronuncia di addebito. Contro tale sentenza Francesco G. ha proposto ricorso per Cassazione, sostenuto da un valido motivo. Piera N. resiste con controricorso in seguito illustrato con memoria. Motivi della decisione La controricorrente ha dedotto la inammissibilità del ricorso, risultandovi indicato un codice fiscale non corrispondente a quello di parte ricorrente. Oltre che speciosa, l’eccezione è del tutto inconsistente. L’errata indicazione del codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio, peraltro non prevista da alcuna disposizione del codice di rito, non può non avere alcun effetto invalidante l’atto medesimo sotto il profilo della identificazione del suo autore. Del resto, anche l’omessa o erronea indicazione dei requisiti di cui all’articolo 143 comma 1 Cpc produce nullità (e non certo inammissibilità) soltanto se comporti l’impossibilità di identificare con sicura certezza il postulante (Cassazione 3745/94, 2895/97). Senza considerare, poi, che qualunque ipotetica nullità dell’atto ricorso, riconducibile a quelle previste e regolate dall’articolo 164 Cpc, comma 1, sarebbe stata nella specie sanata per effetto del raggiungimento dello scopo, identificabile nello svolgimento, da parte della N., di compiute difese nel merito della controversia, per mezzo del tempestivo controricorso. 73 Con l’unico motivo del ricorso, denunziando la violazione degli articoli 143 e 151 Cpc, il G. lamenta che la corte palermitana, al pari del tribunale, ha omesso di valutare comparativamente i comportamenti dei coniugi aifini della dichiarazione di addebito e valorizzato soltanto alcune delle affermazioni da lui fatte in sede di interrogatorio formale. Da quelle pretermesse si sarebbe potuto evincere che la decisione di interrompere ogni rapporto, anche di natura sessuale, con la moglie, pur continuando i coniugi a vivere sotto lo stesso tetto, era stata determinata dalla condotta di quest’ultima. Facendo venire sono l’affectio maritalis, la consorte aveva, infatti, preso le difese del fratello, che, per difendersi dalle proprie responsabilità gestionali, lo aveva ingiustamente accusato di essersi appropriato di somme appartenenti alla cooperativa edilizia che aveva costruito la casa coniugale. Da nessun atto del giudizio, soggiunge il G., era lecito inferire che l’interruzione dei rapporti sessuali fosse stata frutto di una determinazione unilaterale, e ancor meno da ricollegare a una intrapresa relazione adulterina. Il ricorrente imputa, infine, alla corte territoriale di avere ritenuto offensivo per la moglie l’atteggiamento affettuoso da lui tenuto verso una collega d’ufficio, laddove null’altro era emerso in corso di causa se non che egli era solito viaggiare con la donna per recarsi al posto di lavoro e che in un’occasione aveva ritirato presso l’ufficio postale una raccomandata a lei diretta. Il motivo appare inammissibile nella sua formulazione, in quanto, nonostante il richiamo formale a vizi di violazione di legge, si risolve in una serie di censure di mero fatto, diretta a contrastare la valutazioni compiute nella sentenza impugnata e a proporre una diversa ricostruzione dei fatti, ed una diversa lettura del materiale probatorio acquisito, del quale si sostiene la idoneità a dimostrare la responsabilità del G. nel fallimento dell’unione coniugale. In particolare, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la corte di merito non ha affatto disatteso il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale l’indagine sull’intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e comparativa dei comportamenti di entrambi i coniugi, dacchè la condotta dell’uno non può essere giudicata senza un raffronto con quella dell’altro, e solo tale comparazione consente di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crsi matrimoniale (vedi, tra le altre, Cassazione 14162/01, 279/00, 2444/99, 7817/97, 3511/94, 961/92). Per vero, il giudice a quo ha avviato e condotto la sua indagine proprio seguendo questa prospettiva. Sennonché egli è arrivato alla ineccepibile conclusione che il comportamento provatamente mantenuto dal G., costituendo lesione alla dignità, di donna e di moglie, della N., e non potendo giustificarsi per l’evidente sproporzione, come atto di ritorsione alla dedotta provocazione dell’altro coniuge, era tale da rendere di per se addebitabile la separazione, sottraendosi, quindi, al giudizio comparativo. Ciò in applicazione di altro principio su cui questa Suprema Corte è uniformante orientata. E’ stato infatti più volte affermato che nell’ipotesi in cui i fatti accertati a carico di un coniuge integrino violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, in quanto si traducano nell’aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l’incolumità e l’integrità fisica, morale e sociale e la dignità dell’altro coniuge, così superando la soglia minima di solidarietà e di rispetto per la personalità del partner, essi sfuggono ad ogni giudizio di comparazione, non potendo in alcun modo essere giustificati come atti di reazione o ritorsione rispetto al comportamento dell’altro (Cassazione 15101/04, 5397/89, 6256/87, 2809/78). Quindi, la valutazione dei comportamenti dei coniugi effettuata dal giudice a quo 74 è conforme a diritto non potendosi dubitare che il rifiuto, protattosi per ben sette anni, di intrattenere normali rapporti affettivi e sessuali con il coniuge costituisca gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner e situazione che oggettivamente provoca senso di frustrazione e disagio, spesso causa, per come è notorio, di irreversibili danni sul piano dell’equilibrio psicofisico. Consimile contegno, pertanto, configura e integra violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall’articolo143 Cc, nella cui nozione sono da ricomprendere tutti gli aspetti di sostegno nei quali, con riferimento anche alla sfera effettiva, si estrinseca il concetto di comunione; si tratta, peraltro, di un dovere che non può non essere il riflesso precettivo di quel legame sentimentale sul quale realmente può reggersi e prosperare il rapporto di coppia. Ove volontariamente posto in essere, il rifiuto alla assistenza affettiva ovvero alla prestazione sessuale non può che costituire addebitamento della separazione, rendendo impossibile all’altro il soddisfacimento delle proprie esigenze di vita dal punto di vista affettivo e l’esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato. Oltre che condotto secondo corretti criteri giuridici, l’iter arqomentativo espresso dal giudice del merito è privo di mende logiche e sorretto da stringente e esaustiva motivazione. Esso sfugge, pertanto, alle censure mosse dal ricorrente che, come anticipato, pretende di sottoporre al sindacato di questa Corte la valutazione della prova istituzionalmente riservata al giudice del merito. Inammissibile anche sotto altri profili è infine la doglianza riguardante la valenza offensiva asseritamene attribuita dalla corte palermitana all’atteggiamento del G. verso una collega d’ufficio. In proposito, la Corte territoriale, premesso, con argomentazione chiaramente ad abundantiam, che la corrispondente valutazione del primo giudice era sintonica con giurisprudenza di questa Suprema Corte – per la quale la separazione è addebitabile allorquando, in considerazione dei suoi aspetti esteriori, la relazione del coniuge con estranei dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti quindi offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge – ha solo osservato , in rito, che tale ratio decidendi della pronuncia di prime cure non era stata censurata in modo specifico dal G., limitatosi a rimarcare, con l’atto di gravame, la emersa falsità della circostanza addotta dalla moglie a comprova della relazione extraconiugale (la ricezione a casa della collega di una raccomandata a lei dirett). In più, la corte palermitana ha ritenuto del tutto in conducente la doglianza formulata dall’appellante dacchè, per la stessa sentenza del tribunale, non era stata raggiunta la prova dell’adulterio. Ora tale punto della decisione, come detto essenzialmente attinente al rito, e in particolare alla individuazione del devolutum, non è stato censurato con il ricorso dal G., il quale non può riproporre in questa sede la questione relativa alla (presunta) valutazione anche di quell’aspetto dell’atteggiamento tenuto nei confronti del coniuge. Inoltre, la corte territoriale ha posto a base della statuizione di addebitabilità della separazione, quale causa determinante dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza, esclusivamente il comportamento del G., tradottosi nel prolungato rifiuto di avere rapporti sessuali con la moglie, e non certo il contrastante atteggiamento premuroso da costui mantenuto nei confronti di una collega. Il ricorso va in definitiva dichiarato inammissibile. Le spese del presente grado seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 3.100,00, di cui euro 3.000,00 per onorari 75 d’avvocato, oltre alla spese generali e agli accessori di legge. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2005. Depositata in cancelleria il 23 marzo 2005. -----------------------------------------------------------------------------------------------CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO TRACCIA Il costruttore Tizio intende realizzare, su di un suolo di sua proprietà, un complesso immobiliare composto di sei fabbricati, ognuno di cinque piani. Si reca, quindi, presso la banca Alfa e le comunica che intende assicurarsi l’erogazione della somma di dieci milioni di euro; offre in garanzia il credito di pari somma che egli vanta nei confronti del comune di Roma per lavori precedentemente eseguiti. La banca è d’accordo a mettere a disposizione la suddetta somma, ma pretende interessi e provvigione, oltre al patto di utilizzare il credito alla scopo di realizzare la predetta costruzione. Il contratto viene firmato il giorno 20 agosto 2003, con termine previsto il 20 agosto 2005. Tizio nel 2004 chiede l’erogazione della somma di cinque milioni di euro. Il 25 agosto 2005, Tizio si vede recapitare una raccomandata con ricevuta di ritorno dalla banca Alfa, in cui gli viene chiesta la restituzione di dieci milioni di euro più gli interessi sul prestito e per la provvigione. Tizio si reca da un legale. Il candidato rediga motivato parere sulla questione giuridica proposta POSSIBILE SCHEMA DI SOLUZIONE In premessa poteva essere utile ricostruire sinteticamente il fatto. Successivamente era necessario inquadrare giuridicamente il fatto narrato nell’ambito del contratto di apertura di credito, ex art. 1842 c.c., in quanto si tratta di una “messa a disposizione”. La banca Alfa si obbliga a pagare verso Tizio qualsiasi somma di denaro richiesta, nei limiti dei dieci milioni di euro; dal contratto di apertura di credito, nasce un vero obbligo imposto sulla banca ed il cliente (Tizio) vanta un diritto di credito (in senso tecnico). La somma per cui si conviene l’apertura di credito può essere usata liberamente (ad esempio per assumere un’obbligazione verso terzi, realizzando, ad esempio, una fideiussione) ovvero entro determinati limiti (e forme), come nel caso di specie (sulla falsariga del mutuo di scopo, da cui l’apertura di credito diverge perché non vi è un trasferimento patrimoniale immediato, ma una messa a disposizione). Generalmente, si dice che gli atti di utilizzazione non sono atti di esecuzione del contratto di apertura di credito, ma atti autonomi ancorchè collegati al predetto contratto; i prelevamenti da parte del cliente, danno luogo ad un rapporto sostanzialmente di mutuo, per cui il cliente dovrà corrispondere non gli interessi di fido, ma quelli tipici dei prestiti; id est, per il denaro prestato effettivamente vi 76 saranno interessi come quelli del mutuo, mentre per la restante somma messa a disposizione, ma non effettivamente erogata vi saranno interessi più bassi (detti di fido). Nel caso di specie, allora, Tizio sarà tenuto a restituire la somma prelevata pari a cinque milioni, con l’aggiunta degli interessi sulla somma prelevata (interessi corrispondenti a quelli del mutuo classico, perché con il prelievo il cliente realizza sostanzialmente un mutuo, collegato con l’apertura di credito); la provvigione, invece, andrà applicata alla sola somma restante (cinque milioni di euro) a titolo di corrispettivo per il servizio della “messa a disposizione”. Alcune differenze tra apertura di credito e figure molto simili andrebbero ricordate: -l’apertura di credito differisce dal mutuo, come visto, in quanto il secondo non comporta una messa a disposizione di una somma di denaro, ma un effettivo pagamento al momento della conclusione del contratto, tanto che si tratta di un contratto reale (mentre l’apertura di credito è contratto obbligatorio); -l’apertura di credito differisce dalla promessa di mutuo, in quanto il primo è un contratto definitivo e non preliminare e, inoltre, ha come scopo finale non il trasferimento di una somma di denaro o di altro bene fungibile, ma solo la creazione a favore dell’accreditato di una disponibilità che quest’ultimo può anche non utilizzare, senza che il contratto venga meno; -l’apertura di credito differisce dal mutuo consensuale, perché questo contratto, autonomo rispetto al mutuo, obbliga il mutuatario a prendere la somma stabilita, mentre l’accreditato non ha alcun obbligo di prelevamento. Si consiglia di leggere la sentenza che segue, seppur non attinente al caso preso in esame per la redazione del parere. -Il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non richiede la stipula per iscritto a pena di nullità. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA SENTENZA 09-07-2005, n. 14470 (Presidente U. R. Panebianco, Relatore L. Panzani) Svolgimento del processo Il Fallimento della s.p.a. (omissis) conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Napoli il Monte dei Paschi di Siena s.p.a. proponendo azione revocatoria delle rimesse di conto corrente effettuate dalla società fallita sul conto corrente 77 intrattenuto presso la banca convenuta nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per il complessivo importo di lire 1.704.575.482. Radicatosi il contraddittorio il Tribunale di Napoli con sentenza 3.3.2000 accoglieva la domanda, condannando la banca convenuta al pagamento della somma predetta a favore della curatela, oltre interessi e spese. Su appello del Monte dei Paschi di Siena la Corte d'appello di Napoli con sentenza 8.3.2002 confermava la sentenza di primo grado. Osservava la Corte che la banca appellata non aveva provato che il conto corrente fosse affidato e che pertanto le rimesse effettuate non fossero revocabili perchè effettuate nei limiti dell'affidamento. Ciò perchè la scheda degli affidamenti e l'estratto notarile dei libri contabili, prodotti dalla banca, non sostituivano la forma scritta richiesta ad substantiam per il contratto di apertura di credito nè il contratto poteva ritenersi provato per facta concludentia. Le scritture contabili prodotte dalla banca, inoltre, non avevano efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 2710 c.c. essendo il curatore terzo rispetto al contratto stipulato dalla società fallita. Le rimesse effettuate da terzi sul conto, nella specie dalle U.S.L., non potevano essere considerate pagamenti del terzo, perchè si trattava di terzi debitori della fallita, che avevano provveduto al pagamento di un loro debito nei confronti di quest'ultima e non della banca. Sussisteva infine la prova della scientia decoctionis del Monte dei Paschi di Siena, perchè la banca, quale operatore qualificato, non poteva non essere consapevole dello stato d'insolvenza in presenza di elementi sintomatici quali l'iscrizione d'ipoteca sui beni della società fallita da parte di un creditore in forza di decreto ingiuntivo, l'iscrizione sui beni stessi di sequestro conservativo, la presenza di perdite superiori al terzo del capitale sociale, il notevole sbilancio tra crediti e debiti, la relazione ad uso interno della banca in cui si dava atto della crisi di liquidità della società a fronte della mera "speranza" di ottenere un'inversione di tendenza in futuro, lo stesso irregolare andamento del conto corrente, sintomatico della carenza di liquidità. Ha proposto ricorso per cassazione il Monte dei Paschi di Siena che ha formulato sei motivi di ricorso. Resiste con controricorso la curatela del Fallimento che ha proposto ricorso incidentale con unico motivo, illustrato da memoria, Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso (motivo 1.1.) la ricorrente lamenta violazione dell'art. 11 disp. prel. c.c. Ritenendo che il contratto di apertura di credito in virtù del quale era stato concesso affidamento a favore della società fallita fosse regolato dagli artt. 3 legge 154/92 e 117 t.u.b., la Corte d'appello non avrebbe considerato che i rapporti tra banca e cliente risalivano almeno al 1990 e quindi a data anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni citate, che non potevano avere efficacia retroattiva in ragione del generale principio d'irretroattività della legge sancito dall'art. 11 disp. prel. c.c.. Con il secondo motivo (motivo 1.2) la banca ricorrente lamenta violazione degli artt. 3, comma 3, legge 154/92 e 117 t.u.b. nonchè difetto di motivazione ed omessa e falsa interpretazione delle prove acquisite su punti decisivi della controversia, perchè la sentenza impugnata avrebbe trascurato che, in forza del terzo comma dell'art. 3 legge 154/92 e del decreto 24.4, 1992 del Ministro del Tesoro, oltre che della circolare del maggio 1992 della Banca d'Italia, la forma scritta non era obbligatoria per le operazioni e servizi giàprevisti in contratti redatti per iscritto. Nella specie il contratto di apertura di credito era previsto dal contratto di conto corrente stipulato tra le parti in forma scritta, sì che il contratto di apertura di credito non richiedeva la forma scritta. 78 Con il terzo motivo di ricorso (motivo 2.1) la banca ricorrente deduce violazione degli artt. 2698 e 2710 c.c. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello il libro fidi, da cui risultava un affidamento sino a concorrenza di 400 milioni a favore della società fallita, avrebbe efficacia probatoria privilegiata. Inoltre ai sensi dell'art. 8 delle n.b.u. che regolano il contratto di conto corrente, i libri e le scritture contabili della banca fanno piena prova nei confronti del correntista. Deduce ancora (motivo 2.2)violazione degli artt. 2727, 2729, 2733 c.c. in relazione agli artt. 1326 e 1327 nonchè 1842 e 1843 c.c. Se era vero guanto affermato dalla Corte d'appello, che il libro fidi provava soltanto una deliberazione interna della banca in ordine alla concessione di fido, non ancora tradottasi in volontà negoziale con l'accettazione del correntista accreditato, i giudici d'appello avrebbero dovuto ricercare la prova dell'intervenuta pattuizione, rinvenendola nell'andamento del conto, documentato dagli estratti conto che costituirebbero prova diretta del contratto di apertura di credito, conclusosi nei modi di cui all'art. 1327 c.c., in ragione del dimostrato utilizzo della provvista messa a disposizione della banca tramite il fido concesso. Con il quarto motivo di ricorso (motivo 3) la ricorrente deduce violazione dell'art. 67 l. fall. perchè in ragione del fido accordato le rimesse sul conto dovevano considerarsi meri atti di ripristino della provvista, privi di efficacia solutoria. I versamenti inoltre non erano revocabili perchè effettuati da terzi senza alcuna lesione della par condicio creditorum. Con il quinto motivo di ricorso la banca ricorrente lamenta contraddittorietà di motivazione su un punto decisivo della controversia perchè, volendo qualificare i versamenti dei terzi come pagamenti effettuati a favore del fallito e non della banca, e quindi come atti revocabili, la revocatoria andava esperita nei confronti del terzo e non della banca che si era limitata ad espletare il servizio di cassa a favore della società fallita, sua correntista. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta insufficienza e contraddittorietà di motivazione su un punto decisivo della controversia. Nel ritenere sussistente la prova della scientia decoctionis in capo alla banca, la Corte d'appello avrebbe ignorato l'andamento del conto, da cui risultava che la banca aveva continuato ad erogare credito, anche dopo che il saldo passivo si era sensibilmente ridotto, in una situazione che avrebbe giustificato la revoca dell'affidamento se effettivamente vi fosse stata consapevolezza dello stato di dissesto in atto. Anche l'annotazione per uso interno di un funzionario della banca non poteva essere letta come dimostrazione di tale consapevolezza. Con l'unico motivo del ricorso incidentale la curatela lamenta violazione dell'art. 92 e dell'art. 360 n. 5 c.p.c. La Corte d'appello nel condannare la banca appellante al pagamento delle spese di lite ha sensibilmente ridotto l'importo dei diritti ed onorari, oltre che delle spese liquidate, distaccandosi senza alcuna motivazione dagli importi indicati nella nota spese della parte, redatta ai sensi dell'art. 75 disp.att. c.p.c.. Il primo motivo di ricorso (motivo 1.1.) è inammissibile. Esso si fonda infatti sull'eccezione che il rapporto tra le parti risalirebbe almeno al 1990, che è eccezione nuova, mai formulata nei precedenti gradi di giudizio. Va anzi sottolineato che le rimesse oggetto di revoca risalgono al periodo 21 marzo 1994 30 settembre 1994, mentre le delibere di concessione di fido invocate da parte ricorrente si riferiscono, secondo le allegazioni di parte ricorrente non contestate dalla controricorrente curatela, al 19.4.1994 ed all'11.5.1994. Il secondo (1.2), terzo (2.1 e 2.2.) e quarto motivo (3) di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto trattano questioni connesse. Afferma la ricorrente che la Corte territoriale nel ritenere che il contratto di apertura di 79 credito debba essere stipulato per iscritto a pena di nullità, così come richiesto prima dall'art. 3 della legge 154/92 e successivamente dall'art. 117 t.u.b., avrebbe trascurato che in forza del terzo comma dell'art. 3 legge 154/92 e del decreto 24.4.1992 del Ministro del Tesoro, oltre che della circolare del maggio 1992 della Banca d'Italia, la forma scritta non era obbligatoria per le operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto. Nella specie il contratto di apertura di credito era regolato nel suo contenuto normativo dal contratto di conto corrente stipulato tra le parti in forma scritta, si che tale ultima forma non era richiesta anche per la sua stipulazione. Aggiunge poi che nel caso in esame, pur se si doveva concordare con la Corte d'appello nel rilevare che il libro fidi prodotto in atti dimostrava soltanto l'esistenza di una deliberazione interna della banca con cui questa aveva deliberato di concedere un affidamento alla società fallita, dal libro fidi e dalle scritture contabili della banca, oltre che dagli estratti conto comprovanti le movimentazioni del conto corrente, si sarebbe ricavata la prova, per facta concludentia e dunque ex art. 1327 c.c., dell'avvenuta stipulazione del contratto di apertura di credito, in ragione del dimostrato utilizzo della provvista messa a disposizione della banca tramite il fido concesso, l'art. 117 t.u.b. stabilisce al primo comma, con riferimento ai contratti bancari, che i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti, prevedendo al terzo comma, la nullità del contratto in caso d'inosservanza della forma prescritta. Tuttavia il secondo commadella norma dispone che il CICR (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio) può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. L'art. 3, comma 3, legge 154/92 prevedeva analogamente che "su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalità per la forma dei contratti relativi a determinate categorie di operazioni e di servizi". Parte ricorrente afferma che in ragione del decreto 24.4, 1992 del Ministro del Tesoro, oltre che della circolare del 24 maggio 1992 della Banca d'Italia (in G.U. 30 maggio 1992, n. 126), emessa in attuazione di detto decreto, la forma scritta non era obbligatoria per le operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto. La Banca d'Italia era facoltizzata dal decreto del Ministro del Tesoro, che si era sostituito per ragioni d'urgenza al CICR a mente dell'art. 6 D.L. 691/47, ad individuare "modalità particolari per i contratti relativi a operazioni e servizi che si innestano su rapporti preesistenti originati dai contratti redatti per iscritto". La circolare precisava che la forma scritta non era obbligatoria "... per operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto". Nel caso di specie, ha osservato la ricorrente, il contratto di conto corrente disciplinava compiutamente il contratto di apertura di credito, sì che tale ultimo contratto non doveva essere necessariamente stipulato per iscritto a pena di nullità. Va osservato che il decreto 24.4.1992 del Ministro del Tesoro e la circolare 24 maggio 1992 della Banca d'Italia erano state emanate in forza del terzo comma dell'art. 3 legge 154/1992. Anche dopo l'entrata in vigore del t.u. bancario, tuttavia, tali norme erano rimaste in vigore ai sensi dell'art. 161 del testo unico, che nell'abrogare insieme ad altre disposizioni la legge 154/1992 (ad eccezione dell'art. 10 che qui non interessa) stabiliva che "Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo". In seguito la Banca d'Italia provvide ad emanare, sempre in esecuzione del decreto del Ministro del Tesoro del 24.4.1992, nell'ambito delle Istruzioni di vigilanza, nuove disposizioni che nel ribadire la regola generale secondo la quale "I contratti 80 relativi alle operazioni e ai servizi sono redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti", prevedevano che: "La forma scritta non è tuttavia obbligatoria: .... b) per operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto", regolando poi ulteriori ipotesi di esenzione che qui non interessano (cfr. Banca d'Italia, Istruzioni di vigilanza, - Parte 2^ - cap. 5^ - Trasparenza delle condizioni e dei servizi finanziari - agosto 1996). La delibera 4.3.2003 del C.I.C.R., nel dettare la nuova disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, abrogando ai sensi dell'articolo 161, comma 5, del testo unico bancario, il decreto del Ministro del tesoro 24 aprile 1992 già citato, ha poi successivamente stabilito, per quanto attiene alla forma dei contratti, che "La Banca d'Italia può individuare forme diverse da quella scritta per le operazioni e i servizi effettuati sulla base di contratti redatti per iscritto, nonchè per le operazioni e i servizi, oggetto di pubblicità ai sensi della presente delibera, che hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo contenuto per il cliente". In virtù di tale disciplina le istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, nel testo attualmente in vigore (risalente al luglio 2003) al Titolo 10^, capo 1^, n. 2, stabiliscono che: 2. Forma dei contratti. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, è consegnato al cliente. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente sull'esemplare del contratto conservato dalla banca. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente. La forma scritta non è obbligatoria: a) per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto; .....". La sentenza impugnata ha affermato che sulla base della disciplina di legge (art. 3 legge 154/1992 e art. 117 t.u.b.) il contratto di apertura di credito deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e che a nulla rilevano eventuali disposizioni meno restrittive emanate in via amministrativa dalla Banca d'Italia. Tale affermazione non può essere condivisa. Le norme emanate dal CICR (nel 1992 in via d'urgenza, in sua sostituzione, dal Ministro del Tesoro) e dalla Banca d'Italia completano ed integrano la norma di legge, in virtù di una facoltà espressamente prevista dalla legge stessa. Non si tratta pertanto di atti amministrativi illegittimi perchè contra legem, ma di atti a contenuto ed efficacia normativi, emanati dal CICR e dall'Autorità di vigilanza nell'esercizio di unpotere espressamente loro attribuito dal legislatore. Tali norme integrano il precetto legislativo e, nei limiti consentiti dalla legge stessa, vi derogano, con la conseguenza che hanno natura di atti normativi, sia pur non di rango primario e debbono pertanto essere conosciute d'ufficio dal giudice, secondo il principio iura novit curia. E' quindi irrilevante che la Circolare 24.5.1992 della Banca d'Italia e il decreto del Ministro del Tesoro non siano stati prodotti in giudizio da parte della Banca ricorrente, come ha eccepito la curatela. E' stato osservato in dottrina che, ai sensi dell'art. 3, primo comma, legge n. 154/92 la deroga alla forma scritta poteva avvenire solo per motivate ragioni tecniche, mentre la Banca d'Italia nella già ricordata circolare non aveva tenuto conto di tale limite. Si era aggiunto che la lettera della legge consentiva alla Banca d'Italia di stabilire "particolari modalità per la forma dei contratti relativi a determinate categorie di operazioni e di servizi". Anche il decreto 24.4.1992 del 81 Ministro del Tesoro prevedeva che la Banca d'Italia potesse individuare "modalità particolari" per i contratti relativi ad operazioni e servizi che si innestano su rapporti preesistenti originati da contratti redatti per iscritto. Tali modalità, si era detto, non potevano giungere sino alla totale soppressione della forma scritta, perchè in tal modo, di fatto, il contenuto della legge veniva svuotato. Tali rilievi, che già apparivano non convincenti alla luce della ratio legis, rappresentata dalla necessità di assicurare la regolarità dei traffici in situazioni in cui, per le particolari modalità della contrattazione, non poteva esigersi il rispetto della forma scritta, possono considerarsi sostanzialmente superati alla luce del disposto dell'art. 117, comma 2, t.u.b., già in vigore all'epoca in cui sarebbero stati posti in essere i contratti di apertura di credito per cui è causa. La norma, infatti, dispone, come già si è ricordato che "il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma", chiarendo quindi, in armonia con la ratio legislativa, che la deroga consentita al CICR ed all'Autorità di vigilanza permette di derogare all'obbligo della forma scritta. Anche l'omessa menzione nel provvedimento del Ministro del Tesoro e nella circolare della Banca d'Italia, come nei provvedimenti che si sono susseguiti successivamente, dell'indicazione delle "motivate ragioni tecniche" che giustificano la deroga alla forma scritta, sia ai sensi dell'art. 3 della legge 154/92 che dell'art. 117 t.u.b., non può essere considerata fonte d'illegittimità dei provvedimenti in parola, perchè l'onere di motivazione può ritenersi assolto con l'individuazione del tipo di contratto e la precisazione che esso deve riferirsi ad operazioni e servizi già individuati in contratti stipulati per iscritto. Dal 1992 a tutt'oggi le disposizioni della Banca d'Italia, a tanto autorizzata dal CICR, hanno sempre previsto, pur nel variare dei testi normativi, che non fosse richiesta la forma scritta per i contratti relativi ad operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto, tra cui il contratto di conto corrente, in base alla considerazione che costituisce sufficiente garanzia per il cliente che il contenuto normativo del contratto sia redatto per iscritto, mentre poi la sua concreta stipulazione, alle condizioni riportate nel contratto scritto, potrà avvenire in altra forma nel rispetto delle esigenze di celerità ed operatività che taluni tipi di contratti esigono. Venendo al caso di specie, è pacifico in causa che il contratto di apertura di credito era disciplinato dal contratto scritto di conto corrente in essere tra le parti, si che non può in nessun modo condividersi l'affermazione della sentenza impugnata che ha ritenuto che i contratti di apertura di credito che la banca ricorrente pretende che sarebbero stati stipulati tra le parti, sarebbero nulli per difetto di forma scritta. La sentenza impugnata ha peraltro escluso che parte ricorrente abbia provato la sussistenza di un contratto orale di apertura di credito. Nel venire ai rilievi con cui parte ricorrente censura le conclusioni cui è pervenuta la Corte d'appello, occorre osservare che questa Corte ha più volte affermato che le rimesse sul conto corrente dell'imprenditore poi fallito sono suscettibili di revocatoria fallimentare soltanto nell'ipotesi in cui il conto, all'atto della rimessa, risulti "scoperto" (intendendosi tale sia il conto nonassistito da apertura di credito che presenti un saldo a debito del cliente, sia il conto scoperto a seguito di sconfinamento dal fido convenzionalmente accordato al correntista). In siffatta situazione, secondo la distribuzione dell'onere probatorio prefigurata dall'art. 67 legge fall., alla curatela spetta la dimostrazione della sussistenza della rimessa, della sua effettuazione nel periodo "sospetto" e della "scientia decoctionis" del correntista, da parte della banca; mentre questa ha l'onere di provare, per escludere la natura "solutoria" del versamento, sia l'esistenza, alla data di questo, di un contratto di apertura di credito, sia l'esatto ammontare dell'affidamento accordato 82 al correntista alla medesima data, non essendo sufficiente, a tali ultimi fini, la produzione della "scheda degli affidamenti" e dell'estratto notarile del "libro fidi" della banca, qualora il contenuto di detti documenti sia contestato dalla curatela e, comunque, gli stessi non abbiano un significato congruo rispetto al fatto da dimostrare (Sez. 1^, 23.6.1994, n. 6031, rv. 487167). Nel caso di specie la Corte di merito ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte, osservando che per provare l'esistenza del contratto di apertura di credito non costituivano prova sufficiente la disponibilità della banca a concedere il fido, comprovata dalla deliberazione interna relativa alla concessione del fido registrata sul libro fidi. Ha poi escluso che la tolleranza di fatto all'uso dell'affidamento costituisse prova sufficiente dell'avvenuta stipulazione del contratto, osservando che la ricorrente aveva dedotto l'esistenza del contratto di apertura di credito soltanto con la comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado ed aveva inizialmente affermato, davanti al giudice di primo grado, che l'importo dell'affidamento era di 200 milioni di lire, per poi sostenere in appello, senza alcuna spiegazione, che tale importoera invece di 400 milioni. In conclusione la Corte ha valutato tutte le circostanze indicate dalla ricorrente come prova dell'avvenuta stipulazione del contratto di apertura di credito per facta concludentia, giusta la regola dettata dall'art. 1327 c.c., ed in particolare la tolleranza di fatto nell'utilizzo dell'affidamento risultante dalla movimentazione del conto comprovata dagli estratti conto prodotti in giudizio. Ha peraltro ritenuto con valutazione ampiamente argomentata, alla luce del comportamento processuale della ricorrente, e come tale incensurabile in questa sede, che la banca non avesse fornito la prova richiesta della sussistenza del contratto di apertura di credito ed in particolare dell'ammontare del fido accordato, circostanza questa sufficiente ad escludere il carattere ripristinatorio delle rimesse. I tre motivi vanno pertanto rigettati. Il quinto motivo del ricorso principale è manifestamente infondato e dunque inammissibile. La Corte d'appello ha qualificato le rimesse provenienti da terzi (USL) affluite sul conto corrente come pagamenti effettuati dai terzi in favore del fallito e non della banca, escludendo che vi fosse stato il pagamento da parte del terzo di un debito della società fallita verso la banca stessa. Ha conseguentemente affermato la natura solutoria della rimessa, che era valsa a ridurre il saldo passivo del conto scoperto. Afferma la ricorrente che avendo essa espletato il servizio di cassa in ragione della convenzione di conto corrente, i versamenti del terzo dovrebbero essere oggetto di revoca nei confronti di chi ha eseguito il pagamento. E' peraltro evidente da un lato che nessuna azione revocatoria può configurarsi nei confronti del terzo in ragione della sua qualità di solvens, che ha provveduto al pagamento di un debito del fallito, e dall'altro che l'espletamento del servizio di cassa non esclude, per le considerazioni in precedenza svolte, il carattere solutorio della rimessa, effettuata su conto scoperto, e dunque la sua revocabilità. Il sesto motivo è inammissibile. La sentenza impugnata ha argomentato la sussistenza della scientia decoctionis da un complesso di elementi atti a fornire la prova presuntiva della consapevolezza da parte della banca della sussistenza dello stato d'insolvenza della società fallita. In sintesi i giudici d'appello hanno considerato l'iscrizione d'ipoteca sui beni della società fallita in forza di decreto ingiuntivo da parte di un creditore, l'iscrizione sui beni stessi di sequestro conservativo per opera di altro creditore, la presenza di perdite superiori al terzo del capitale sociale, il notevole sbilancio tra crediti e debiti, la relazione ad uso interno della banca in cui si dava atto della crisi di liquidità della società a fronte della mera "speranza" di ottenere un'inversione di 83 tendenza in futuro, lo stesso irregolare andamento del conto corrente, sintomatico della carenza di liquidità. Nel lamentare il vizio di motivazione in ordine alla scientia decoctionis la ricorrente da un lato non considera il complesso di elementi probatori valutati dalla Corte di merito, accentrando le sue censure su alcuni di essi soltanto (la portata dell'annotazione del funzionario proponente la concessione di fido, redatta a fini interni della banca, l'andamento del saldo debitore del conto e la mancanza di un rientro della banca nonostante il ridursi di tale saldo). Dall'altro lungi dal mettere in rilievo la presunta contraddittorietà ed insufficienza di motivazione della sentenza impugnata, pretende di sostituire alla valutazione delle risultanze probatorie compiute dalla sentenza una diversa valutazione, formulando quindi una censura inammissibile in questa sede. Il ricorso incidentale della curatela è inammissibile. Nel dolersi che la Corte di merito abbia disatteso le risultanze della nota spese, la curatela si è limitata ad indicare il totale degli onorari, dei diritti di procuratore e degli esposti riportati in nota spese ed a lamentare che la sentenza impugnata si sia discostata da tali importi senza motivare in proposito. Questa Corte ha più volte affermato che il giudice non può discostarsi nella liquidazione delle spese dalle somme indicate nella nota spese depositata in atti, allo scopo di consentire, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione alla inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 della legge n. 794 del 1942 (Cass., sez. Lavoro, 1.8.2003, n. 11483). E' pertanto indispensabile che il ricorrente indichi le varie voci che compongono la nota spese e non soltanto i totali, con la conseguenza che in difetto il ricorso incorre nel vizio di genericità e va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la prevalente soccombenza e vanno pertanto poste a carico della ricorrente principale, liquidate in euro 15.000 per onorari ed euro 100 per spese, oltre spese generali ed accessorie come per legge. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale alle spese, che liquida in euro 15.100, di cui euro 15.000 per onorari, oltre spese generali ed accessorie come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2005. DOLO OMISSIVO TRACCIA: Tizio è un imprenditore che gode di una discreta fama presso vari istituti di credito. Tizio, un giorno, avendo bisogno di un prestito particolarmente cospicuo, si reca presso la banca Truffield, diretta da Francis. Francis, dopo una breve chiacchierata con Tizio, decide di concedergli il prestito richiesto, soprattutto alla luce della buona fama di cui gode. Dopo un mese dal prestito, Francis viene a sapere che Tizio, al momento del prestito, era già in fase di fallimento. 84 Francis, a causa della reticenza di Tizio sul proprio stato patrimoniale, ritiene di aver perso diversa liquidità che, laddove avesse avuta la disponibilità, di certo l’avrebbe investita in altri affari ovvero l’avrebbe prestata ad altre persone. Francis si reca da un legale. Il candidato individui gli strumenti di tutela favorevoli al proprio assistito. POSSIBILE SCHEMA DI SOLUZIONE In premessa poteva essere utile riassumere sinteticamente il fatto. Successivamente, poteva essere affrontato il cuore del problema: Francis che strumenti di tutela può vantare contro Tizio? E’ possibile ipotizzare un dolo omissivo da parte di Tizio, causativo di danno? Invero, il dolo, ex art. 1439 c.c., può essere sia espresso (si dice qualcosa di falso o, comunque, diverso dalla realtà) che tacito-omissivo (realizzato attraverso reticenze); in questo caso, le reticenze (secondo la giurisprudenza recente e parte della dottrina più accreditata sul punto) devono essere gravi, fraudolentemente sottaciute dall’agente, tali che, ove sapute, il contraente debole non avrebbe, di certo, concluso il contratto, ovvero lo avrebbe concluso a condizioni diverse. Tizio, nel caso di specie, ha sottaciuto il suo fallimento al solo scopo di avere un prestito da Francis, consapevole di sottacere un aspetto importantissimo ai fini della conclusione del contratto, violando anche principi generali di correttezza e buona fede nell’ambito della trattativa che precede la conclusione di ogni contratto; inoltre, Tizio sapeva, verosimilmente, di godere di una discreta fama verso i vari istituti di credito, così che ben sapeva che la comunicazione del suo fallimento avrebbe reso più complicata la conclusione dell’affare. Tizio, in sostanza, ha volontariamente sottaciuto il proprio fallimento fraudolentemente al fine di riuscire agevolmente a concludere il contratto, avente ad oggetto il prestito, con Francis. Si tratta, quindi, di un dolo omissivo, idoneo a giustificare l’annullamento del contratto intercorso tra Francis e Tizio. Inoltre, Francis ha subito dei danni, in quanto ha dovuto rinunciare ad una certa liquidità (che avrebbe potuto investire in altri affari ovvero prestare a terzi), con la conseguenza che ben potrà agire anche con un’azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., oltre che con l’azione di annullamento. In questo senso, pertanto, Francis potrà vantare come strumento di tutela della sua posizone giuridica illecitamente lesa, sia l’azione di annullamento che la collegata azione aquiliana. Si consiglia di leggere le sentenze che seguono. -Il contraente il cui consenso risulti viziato da dolo può bene richiedere giudizialmente il risarcimento del danno conseguente all’illecito della controparte lesivo della libertà negoziale, sulla base della generalissima 85 previsione in tema di responsabilità aquilana di cui all’articolo 2043 Cc (discutendosi di condotta anteriore e prodromica alla formazione dell’in idem placitum consensum), a prescindere dalla contemporanea proposizione della domanda di annullamento del contratto ai sensi del citato articolo 1439 Cc CASS. CIV.- SEZ. I- 19 settembre 2006, n. 20260 – Pres. Proto – est. Napoleoni Svolgimento del processo Il Banco di Sicilia Spa - sulla premessa che i coniugi Vincenzo Ronsisvalle e Maria Colombo avevano chiesto ed ottenuto, negli anni 1988 e 1989, due concessioni di credito (qualificate come “prestiti fiduciari”), tacendo che il Ronsisvalle era stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Siracusa del 7 luglio 1981; e che successivamente la banca istante era stata convenuta in giudizio dalla curatela fallimentare per la dichiarazione di inefficacia, ex articolo 44 legge fallimentare, dei pagamenti eseguiti dal Ronsisvalle in relazione ai predetti prestiti – otteneva dal Presidente del Tribunale di Catania un sequestro conservativo in danno dalla Colombo fino alla concorrenza della somma di lire 12.000.000. La misura cautelare, disposta con decreto del 14 gennaio 1991, veniva eseguita lo stesso giorno mediante trascrizione su un immobile sito in Paternò. Il Banco di Sicilia instaurava quindi il giudizio per la convalida del sequestro e la condanna della Colombo al risarcimento dei danni per quanto la banca attrice avesse dovuto eventualmente restituire alla curatela fallimentare; giudizio nel quale la convenuta si costituiva, contestando la fondatezza della domanda. In corso di causa, il Banco di Sicilia veniva condannato dal Tribunale di Siracusa, con sentenza dell’8 novembre 1993, passata poi in giudicato, al pagamento in favore del fallimento Ronsisvalle della somma di lire 5.000.000, oltre interesse della domanda, nonché al rimborso delle spese giudiziali, liquidate in lire 2.000.000. Il Tribunale di Catania, con sentenza del 5 maggio 1998, rigettava tuttavia la domanda risarcitoria della banca, revocando conseguentemente il sequestro conservativo. I primi giudici ritenevano insussistente, nel caso di specie, la violazione dell’articolo 95 della legge bancaria del 1938 (Dl 75/1936, convertito in legge 141/38, e successive modificazioni), denunciata dal Banco di Sicilia, rilevando come detta disposizione, nel sottoporre a pena i fatti cosiddetti mendacio bancario, facesse riferimento a comportamenti di tipi esclusivamente commissivo e attenesse, altresì, alle sole concessioni di credito a favore di aziende. Osservava inoltre il Tribunale che non v’era neppure prova che la Colombo, all’atto della richiesta, fosse stata a conoscenza dell’avvenuta dichiarazione di fallimento del marito. Avverso la decisione proponeva appello il Banco di Sicilia. Nel giudizio di appello si costituivano, chiedendo il rigetto del gravame, Giovanni e Rosa Carmela Ronsisvalle, quali figli ed eredi legittimi della Colombo, deceduta già nel corso del giudizio di primo grado (il 18 settembre 1997), senza peraltro 86 che tale vento interruttivo fosse stato dichiarato dal suo difensore. A seguito di ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri figli ed eredi legittimi della Colombo, la banca appellante chiamava nel processo anche Rosario ed Elena Ronsisvalle, i quali rimanevano contumaci. Con sentenza del 6 aprile 2002, in parziale accoglimento del gravame, la Corte d’appello di Catania condannava i Ronsisvalle, ciascuno pro quota ereditaria, al pagamento in favore del Banco di Sicilia della somma di euro 6.861,13, oltre interessi legali. La Corte territoriale rilevava che la banca appellante aveva bensì dedotto, in prime cure, che la condotta della Colombo – consistita nell’aver dolosamente taciuto l’avvenuto fallimento del marito al fine di ottenere concessioni di credito – comportava, “tra l’altro”, la violazione dell’articolo 95 della legge bancaria del 1938, ma che da ciò non poteva affatto desumersi che essa avesse inteso fondare unicamente su detta norma penale la propria pretesa risarcitoria. Quest’ultima poteva essere, di contro, agevolmente ricondotta – così come sostenuto nell’atto di appello – alla generale previsione in tema di illecito civile di cui all’articolo 2043 Cc, con operazione di semplice qualificazione giuridica della domanda che escludeva la configurabilità della preclusione ex articolo 345 Cpc, eccepita dagli appellati. A prescindere, pertanto, dal rilievo che gli argomenti in base ai quali il Tribunale aveva escluso la violazione del citato articolo 95 della legge bancaria del 1938 non potevano essere condivisi – dato che,per un verso, la denunciata omissione della Colombo si era inserita in una condotta sostanzialmente commissiva, consistente nell’esporre alla banca una situazione personale e familiare non rispondente al vero; e, per altro verso, la norma incriminatrice in parola non riguarderebbe la sola concessione di credito ad azienda (come potrebbe desumersi dalla formula alternativa “per sé o per le aziende che amministra”, ivi contenuta) – la domanda risarcitoria risultava comunque meritevole di accoglimento in base al citato generale precetto dell’articolo 2043 Cc, essendosi in presenza di una condotta dolosa causativa di ingiusto pregiudizio. Al riguardo, la Corte di merito rilevava, infatti, come la conoscenza da parte della Colombo dell’avvenuta dichiarazione di fallimento del marito – che il Tribunale aveva ritenuto non provata – non fosse stata, in realtà, mai contestata dalla convenuta, risultando quindi sostanzialmente incontroversa, e comunque desumibile in via presuntiva a fronte della quotidiana comunanza di vita tra i coniugi. La Corte d’appello escludeva, per contro, che potesse trovare accoglimento la domanda di convalida dell’eseguito sequestro conservativo, trattandosi di misura cautelare che, in quanto autorizzata anteriormente all’entrata in vigore del Dl 571/94 convertito in legge 673/94, aveva perduto efficacia in forza dell’articolo 4 comma 5 del citato Dl stante la dichiarata inesistenza, ad opera della sentenza impugnata, del diritto a cautela del quale essa era stata concessa, senza che a diversa conclusione potesse pervenirsi in ragione del fatto che l’efficacia esecutiva di tale sentenza era stata sospesa in limine del giudizio di appello con ordinanza presidenziale del 15 giugno 1988. Dichiarata, quindi, l’inefficacia del sequestro, la Corte territoriale condannava comunque i Ronsisvalle alle spese del doppio grado del giudizio “per la parte concernente il merito”, escludendo – stante la marginalità della statuizione concernente la mancata convalida del sequestro e tenuto conto delle relative motivazioni – che sussistessero ragioni per un diverso regolamento delle spese stesse, al di là dell’esclusione del rimborso di quelle correlabili alla predetta misura cautelare. 87 Avverso la decisione proponeva ricorso per cassazione Giovanni Ronsisvalle, sulla base di quattro motivi. Resisteva il Banco di Sicilia con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria. Con ordinanza dell’11 gennaio 2006, questa Corte ordinava, ai sensi dell’articolo 331 Cpc, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Rosa Carmela Ronsisvalle, Rosario Ronsisvalle ed Elena Ronsisvalle – che erano stati parti del giudizio di appello ed ai quali non risultavano tuttavia notificati né il ricorso principale né quello incidentale – stante la loro qualità di litisconsorti necessari per ragioni processuali in quanto eredi della parte originaria deceduta nel corso del giudizio di primo grado. Provvedeva all’incombente il solo ricorrente principale, mentre il Banco di Sicilia depositava memoria illustrativa aggiuntiva. Motivi della decisione 1. Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’articolo 335 Cpc, in quanto proposti contro la medesima sentenza. 2. Con il primo motivo del ricorso principale il Ronsisvalle denuncia violazione, falsa ed erronea applicazione dell’articolo 102 Cpc, rilevando come, a seguito dell’ordinanza della Corte d’appello di Catania del 9 giugno 2000 – con la quale era stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi della Colombo, diversi dai già costituiti Giovanni e Rosa Carmela Ronsisvalle – l’appellante Banco di Sicilia avesse notificato l’atto di integrazione ai soli Rosario ed Elena Ronsisvalle, e non pure ai germani Giuseppe e Salvatore Ronsisvalle, anch’essi figli ed eredi legittimi della Colombo, secondo quanto poteva desumesi dal relativo stato di famiglia. 3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione, falsa ed erronea applicazione dell’articolo 345 Cpc, assumendo che la Corte d’appello di Catania non avrebbe potuto accogliere la domanda risarcitoria del Banco di Sicilia basata sull’articolo 2043 Cc, trattandosi di titolo pretensivo fatto valere per la prima volta in appello, in violazione del principio di immutabilità della domanda, secondo quanto peraltro già formalmente eccepito nel detto grado di giudizio. 4. Con il terzo motivo il Ronsisvalle lamenta violazione, falsa ed erronea applicazione dell’articolo 2043 Cc, nonché omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando che la Corte territoriale abbia basato l’accoglimento della domanda risarcitoria unicamente sulla citata disposizione del Cc, del tutto diversa da quella invocata in prime cure dal Banco di Sicilia – che aveva fatto riferimento, in tale sede, esclusivamente all’articolo 95 della legge bancaria del 1938 – trasformando, inoltre, sulla base di semplici presunzioni, il comportamento della Colombo, da meramente omissivo, qual era, in sostanzialmente commissivo, senza compiere ulteriori valutazioni sulle risultanze istruttorie al fine di verificare la concreta riconducibilità di detto comportamento all’ambito di operatività dell’articolo 2043 Cc. 5. Con il quarto motivo il Ronsisvalle denuncia violazione, falsa ed erronea applicazione dell’articolo 91 Cpc, censurando che la Corte di merito abbia posto a carico degli appellati le spese dei due gradi di giudizio, ancorché la domanda della banca appellante fosse stata accolta solo in parte, con il rigetto del capo riguardante la convalida del sequestro conservativo. 88 6. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile. Il difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario, non costituendo un’eccezione in senso proprio, può essere rilevato d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e dedotto per la prima volta anche nel giudizio di legittimità. In quest’ultimo caso, tuttavia, la relativa eccezione può essere formulata soltanto alla duplice condizione che gli elementi di fatto posti a fondamento della stessa emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito, senza quindi la necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriore attività istruttoria, non consentite in sede di legittimità, e che sulla questione non si sia formato il giudicato (ex plurimis Cassazione 10649/04, 12462/03, 11415/03, 593/01). In particolare, non è ammessa nel giudizio di cassazione la produzione di un nuovo documento per dimostrare la necessità di integrazione del contraddittorio nei precedenti gradi del processo, poiché tale documento non riguarda l’ammissibilità del ricorso o del controricorso e neppure la nullità della sentenza impugnata (articolo 372 Cpc) (Cassazione 2478/87). Nella specie, non può tenersi dunque alcun conto dello “stato di famiglia” di Vincenzo Ronsisvalle rilasciato dal Comune di Catania il 27 luglio 2002 – posteriormente, dunque, al deposito della sentenza impugnata – prodotto dal ricorrente Giovanni Ronsisvalle a sostegno dell’assunto della necessità di integrare il contraddittorio, in grado di appello, anche nei confronti di Giuseppe e Salvatore Ronsisvalle, quali figli ed ulteriori eredi legittimi della defunta Maria Colombo, originaria convenuta. Né, d’altra parte, l’esistenza di tali ulteriori eredi emerge con ogni evidenza dagli atti ritualmente acquisiti nel giudizio di merito – cui questa Corte ha accesso, a fronte della deduzione di un error in procedendo – giacché, al contrario, nel certificato anagrafico del luglio 1998, prodotto in grado di appello, sulla cui base la Corte d’appello di Catania dispose l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della Colombo non volontariamente intervenuti, i predetti Giuseppe e Salvatore Ronsisvalle non figuravano. 7. Il secondo motivo è infondato. Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale il Banco di Sicilia aveva allegato, a fondamento della propria domanda risarcitoria, la mancata comunicazione ad opera della Colombo – in occasione della duplice richiesta di concessione di credito presentata assieme al marito – dell’avvenuta dichiarazione di fallimento di costui: circostanza che, ove conosciuta dalla banca, l’avrebbe senz’altro indotta a respingere la richiesta stessa. Nell’atto di citazione in primo grado – cui questa Corte ha nuovamente accesso diretto, stante la natura del vizio denunciato – la banca aveva bensì dedotto che il denunciato comportamento implicava “anche” una violazione dell’articolo 95 della legge bancaria del 1938, in tema di mendacio bancario: formula che rendeva peraltro palese come l’attrice non intendesse affatto basare solo su tale disposizione, di natura penale, la propria istanza risarcitoria. Il motivo di appello – poi accolto, in parte qua, della Corte territoriale – con cui la banca, a fronte della pronuncia a sé sfavorevole del Tribunale (motivata con l’asserita non configurabilità, nella specie, dell’anzidetta ipotesi criminosa), aveva sottolineato che le “responsabilità civilstiche” che essa appellante aveva inteso far valere “nascono genericamente dalle norme sui principi di buona fede contrattuale e dal disposto dell’articolo 2043 Cc in materia di risarcimento per fatto illecito”, non implicava dunque affatto la proposizione di una domanda nuova, ma si limitava ad esplicitare la qualificazione giuridica della domanda, già trasmessa al 89 giudice in prime cure tramite la prospettazione dei relativi fatti costitutivi. 8. Anche il terzo motivo è infondato. L’istanza risarcitoria della banca poggia, in effetti, sulla deduzione di una fattispecie riconducibile al paradigma del dolo omissivo causam dans: il consenso alla stipulazione dei contratti di mutuo per cui è causa sarebbe stato infatti carpito dall’originaria convenuta grazie alla dolosa reticenza su una circostanza decisiva (articolo 1439 Cc). In tali termini, la domanda è pienamente ammissibile: il contraente il cui consenso risulti viziato da dolo può bene richiedere giudizialmente il risarcimento del danno conseguente all’illecito della controparte lesivo della libertà negoziale, sulla base della generalissima previsione in tema di responsabilità aquilana di cui all’articolo 2043 Cc (discutendosi di condotta anteriore e prodromica alla formazione dell’in idem placitum consensum), a prescindere dalla contemporanea proposizione della domanda di annullamento del contratto ai sensi del citato articolo 1439 Cc (Cassazione 921/80, 2445/68). Quanto, poi, alla effettiva configurabilità del denunciato vizio del consenso, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la reticenza o il silenzio possano integrare il dolo omissivo, ma solo qualora il comportamento passivo si inserisca in una condotta che si configuri, in rapporto alle circostanze e al complesso del contegno che determina l’errore del deceptus, quale malizia o astuzia volta a realizzare l’inganno perseguito (ex plurimis, Cassazione 9253/06, 2104/03, 6757/01, 8295/94). Tanto premesso, si deve osservare come il motivo di ricorso in esame risulti, nella sua prima articolazione, meramente ripetitivo del precedente, tornando il ricorrente a dolersi della pretesa estraneità della disposizione di cui all’articolo 2043 Cc al titolo giuridico invocato dalla banca in prime cure a fondamento della domanda: allegazione della quale si è già acclarata l’infondatezza. Con la seconda parte del motivo, si censura invece che la Corte territoriale abbia “trasformato” la condotta della Colombo da meramente omissiva in commissiva “sulla base di semplici presunzioni”, “omettendo ogni altra valutazione sulle risultanze istruttorie al fine di fare rientrare” la condotta stessa “nell’ambito di operatività dell’articolo 2043 Cc”. La doglianza non ha peraltro pregio, giacché la Corte d’appello ha motivato la propria conclusione con la considerazione che il silenzio serbato dalla convenuta in ordine alla circostanza de qua si era maliziosamente inserito in una condotta complessivamente commissiva volta a conseguire un risultato che sarebbe stato altrimenti negato ai richiedenti, consistente segnatamente nel rappresentare una situazione personale e patrimoniale dei medesimi non rispondente al vero. A fronte di tale assorbente rilievo, non interessa dunque in questa sede verificare se sia condivisibile o meno l’ulteriore affermazione della Corte territoriale – che integra una mera argomentazione ad abundantiam – stando alla quale la condotta in parola, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, integrerebbe comunque anche una violazione dell’articolo 95 della legge bancaria. Per il resto, la censura si palesa affatto generica, dato che il ricorrente non indica – in violazione dei principi di specificità ed autosufficienza del ricorso per cassazione – di quali altre “risultanze istruttorie” la Corte territoriale avrebbe omesso di tenere conto nel formulare il giudizio dianzi ricordato. Giova solo aggiungere, per completezza, come il Ronsisvalle non abbia formulato censure sul punto relativo alla mancata valutazione, da parte della Corte territoriale, della eventuale colpa della banca (anche in riferimento alla previsione dell’articolo 1338 Cc) nel non essersi avveduta, a mezzo dei propri canali 90 informativi, dello status di fallito del Ronsisvalle (al riguardo, nel seno che nell’ipotesi di dolo, tanto commissivo che omissivo, gli artifici, i raggiri, la reticenza o il silenzio debbono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell’altra parte, onde stabilire se fossero idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, per tutte, Cassazione, 20792/04). Con la conseguenza che tale profilo resta estraneo all’odierno thema decidendum. 9. Il quarto motivo è parimenti infondato. La Corte territoriale ha motivato, infatti, in modo del tutto logico e congruente la statuizione sulla spese, rilevando come, a fronte dell’integrale accoglimento della domanda risarcitoria, la domanda di convalida del sequestro, oltre a risultare “marginale”, non fosse stata comunque accolta solo per factum principis (la sopravvenienza del Dl 571/94). 10. Il ricorso principale va quindi conclusivamente rigettato. 11. Il ricorso incidentale condizionato inammissibile, non avendo il Banco di Sicilia provveduto alla sua notificazione a Rosa Carmela, Rosario ed Elena Ronsisvalle, specificamente richiesta da questa Corte, a fini di integrazione del contraddittorio, con l’ordinanza interlocutoria dell’11 gennaio 2006 (ex plurimis Cassazione 5125/00). 12. Le spese processuali relative al contraddittorio ed alle successive difese del Banco di Sicilia, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del Ronsisvalle in base al principio della soccombenza, senza che possa assumere rilievo – ai fini di una eventuale compensazione, totale o parziale – la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale, il quale, per il suo carattere condizionato, sarebbe rimasto comunque assorbito dal rigetto del ricorso principale. PQM La Corte riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale, condanna Giovanna Ronsisvalle al rimborso delle spese processuali in favore del Banco di Sicilia Spa, liquidate in euro 2600 (di cui euro 100 per esborsi ed euro 2500 per onorari) oltre spese generali ed accessori di legge. -Il dolo omissivo può essere causa di annullamento del contratto solo quando l’inerzia di uno dei contraenti si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato con malizia o astuzia a realizzare l’inganno a danno dell’altro contraente SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Sentenza 20 aprile 2006, n. 9253 (Presidente M. Spadone, Relatore V. Mazzacane) Svolgimento del processo 91 Il 10.12.1991 L.A.M. in proprio e quale procuratrice di L.M. e C.M.A. vendeva ad D.A. l'appartamento al piano seminterrato sito in (OMISSIS), Via (OMISSIS), avente autonomo accesso dalla strada, contraddistinto con il civico (OMISSIS). A seguito di contestazioni insorte con i venditori l'acquirente proponeva nei confronti di questi ultimi dinanzi al Tribunale di Roma tre distinti giudizi successivamente riuniti. Con il primo il D. deduceva l'esistenza di numerosi vizi dell'immobile, consistenti in particolare nella assoluta mancanza di manutenzione della rete fognaria che aveva provocato, nell'agosto 1993, il crollo del muro di contenimento ed il conseguente smottamento nel proprio giardino di diversi metri cubi di terreno; aggiungeva che le precarie condizioni statiche del manufatto erano state oggetto di un precedente giudizio, risalente al 1987, tra il Condominio confinante di (OMISSIS) e quello di (OMISSIS), e che quest'ultimo, a seguito del crollo, aveva provveduto ai relativi lavori di ripristino per una spesa complessiva di L. 117.850.000. Il D. asseriva che le gravi carenze dell'immobile lo avevano reso inidoneo all'uso cui il bene era destinato e comunque avevano pregiudicato il godimento di esso, che i venditori gli avevano dolosamente taciuto la reale situazione del bene e che tale comportamento si configurava da un lato come violazione del dovere di buona fede nello svolgimento delle trattative e dall'altro integrava gli artifici ed i raggiri di cui all'art. 1439 c.c.; sulla base di tali premesse chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti, l'annullamento per dolo del Contratto di compravendita o la sua risoluzione ai sensi dell'art. 1492 c.c., o ai sensi dell'art. 1453 c.c.. Con il secondo giudizio il D. proponeva opposizione avverso il decreto emesso il 6.5.1994 con il quale il Presidente del Tribunale di Roma gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo di L. 68.765.000 corrispondente al residuo prezzo che l'acquirente si era obbligato a versare ai venditori mediante accollo del mutuo che essi avevano stipulato con la Banca Popolare di Milano; il D. adduceva a sostegno della opposizione le stesse circostanze esposte nel precedente giudizio. Infine con atto di citazione notificato il 27/29.12.1994 il D. conveniva in giudizio i L. e la C. chiedendone la Condanna al pagamento della somma di L. 18.524.960 versata a titolo di oblazione per sanare gli abusi edili perpetrati dai venditori e chiedendo la declaratoria di nullità del Contratto per incommerciabilità del bene ai sensi della L. n. 47 del 1985 o comunque la sua risoluzione per inadempimento dei venditori. Si costituivano in tutti i suddetti giudizi i convenuti chiedendo il rigetto delle domande attrici. Con sentenza del 16.3.1999 l'adito Tribunale respingeva le domande proposte dal D.. Proposto gravame da parte del D. cui resistevano L. A.M., L.M. e C.M.A. la Corte di Appello di Roma con sentenza del 18.9.2001 ha respinto l'impugnazione. La Corte Territoriale ha rilevato anzitutto che dalla documentazione in atti era risultato che in data 16.2.1961 anche in relazione all'unità immobiliare sita al piano seminterrato dell'edificio, all'epoca destinata ad uso ufficio, era stato rilasciato il certificato di abitabilità; tale circostanza, secondo l'assunto del Giudice di Appello comportava l'irrilevanza della diversa destinazione (deposito) prevista nel progetto approvato, cosicchè ad essa doveva farsi riferimento al fine di valutare le conseguenze derivanti dalla intervenuta utilizzazione del bene ad uso abitativo; orbene, poichè il mutamento in questione non era stato accompagnato dalla esecuzione di specifiche opere, doveva concludersi per 92 l'inesistenza sotto questo profilo, della nullità L. n. 47 del 1985, ex articoli 17 e 40. La Corte Territoriale ha poi aggiunto che l'incommerciabilità del bene ai sensi della L. n. 47 del 1985 doveva essere esclusa anche per quanto concerneva l'intervenuto frazionamento, posto che non era emerso che la realizzazione di due distinte unità immobiliari fosse stata eseguita in epoca successiva al 2.9.1967, considerato che solo in tale evenienza ai sensi dell'art. 40 della legge menzionata l'atto avrebbe dovuto richiamare gli estremi del provvedimento amministrativo. La sentenza impugnata inoltre ha confermato altresì il rigetto della domanda di annullamento della compravendita stipulata tra le parti sia sotto il profilo di cui all'art. 1439 c.c. sia come dolo incidente, osservando da un lato che non poteva ritenersi che il silenzio tenuto dai venditori in merito alla denuncia di danno temuto proposta nei confronti del Condominio di (OMISSIS) dal confinante Condominio di (OMISSIS) svariati anni prima della conclusione del Contratto di compravendita fosse stato intenzionalmente diretto a trarre in inganno l'acquirente in ordine alle condizioni dell'immobile, e dall'altro che l'appellante non aveva indicato alcuno specifico elemento dal quale potesse desumersi che l'eventuale conoscenza della circostanza avrebbe influito sulla determinazione volitiva del D.. Per la cassazione di tale sentenza il D. ha proposto un ricorso affidato a sette motivi cui L.A.M. ed C.A. hanno resistito con controricorso; L.M. non ha svolto attività difensiva in questa sede; le parti hanno successivamente depositato delle memorie. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli articoli 1453 - 1460 1476 - 1477 c.c.; L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40 nonchè vizio di motivazione. Con il secondo motivo il D.deduce violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizio di motivazione. Con le enunciate censure il ricorrente sostiene che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che, premessa la destinazione ad uso ufficio dell'immobile per cui è causa, la sua effettiva utilizzazione ad uso abitativo non era stata accompagnata dall'esecuzione di specifiche opere rilevanti ai fini di una declaratoria di nullità L. n. 47 del 1985, ex articoli 17 e 40 ed aggiunge che neppure può essere condiviso l'assunto in ordine alla commerciabilità del bene suddetto nonostante l'avvenuto frazionamento. Il D. rileva in senso contrario che dalla espletata Consulenza Tecnica di Ufficio erano emersi abusi edilizi consistenti nel frazionamento, nel cambio di destinazione d'uso con esecuzione di opere e nell'aumento di superficie utile e di cubatura; inoltre il Giudice di Appello non ha valutato le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dalle convenute C.M.A. ed L.A., le quali avevano ammesso che l'immobile per cui è causa e l'appartamento soprastante erano stati uniti negli anni 70 con una scala interna successivamente eliminata, cosicchè i due appartamenti erano stati divisi ed abitati separatamente con la costruzione di una scala esterna. Le enunciate censure, da esaminare contestualmente, sono infondate. Anzitutto la sentenza impugnata, pur dando atto dell'intervenuto mutamento di destinazione dell'immobile in questione rispetto a quella prevista nel progetto approvato (deposito) e della effettiva utilizzazione dello stesso ad abitazione, ha rilevato che tale mutamento non era stato accompagnato dalla esecuzione di opere specifiche, ed ha aggiunto, sulla scia di quanto già affermato dal Giudice di primo grado, che non poteva escludersi che l'aumento di cubatura riscontrato dal Consulente Tecnico d'Ufficio fosse riconducibile allo stesso D., che aveva 93 realizzato cospicui lavori di ristrutturazione del bene; contrariamente all'assunto del ricorrente, quindi, il Giudice di Appello ha preso in esame gli elementi emergenti dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio, ma li ha diversamente valutati offrendo una logica motivazione di tale convincimento. La Corte Territoriale ha inoltre escluso una incommerciabilità dell'immobile L. n. 47 del 1985, ex art. 40, per effetto dell'intervenuto frazionamento, rilevando in proposito l'assenso di una prova in ordine alla realizzazione di due distinte unità immobiliari in epoca successiva al 2.9.1967, ed evidenziando invece la circostanza che alla data del 6.5.1970 l'appartamento al piano internato e quello sovrastante già costituivano due distinte unità immobiliari, come tali indicate nell'atto di acquisto concluso dai L. con la venditrice R.; pertanto tale ultima considerazione, non oggetto di specifica censura in questa sede, ha implicitamente indotto la Corte Territoriale a ritenere irrilevanti altri elementi di eventuale segno contrario, in conformità del principio secondo cui spetta al Giudice di merito attingere il proprio convincimento da quelle risultanze probatorie che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso; al riguardo è sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti anche se allegati, perchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati, come appunto nella fattispecie. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 1460 c.c. nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto, sulla base dell'avvenuto rilascio nel 1961 di un certificato per la destinazione ad uso ufficio dell'immobile per cui è causa, che in realtà tale certificato consentisse l'uso del bene come casa di abitazione. Il ricorrente assume invece che si era in presenza della avvenuta vendita di un bene destinato ad uso ufficio e non ad abitazione, come pattuito, circostanza che integrava la vendita di aliud pro alio o, in ogni caso, legittimava una eccezione ex art. 1460 c.c., invero regolarmente sollevata dall'esponente a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo di cui al secondo dei tre giudizi sopra menzionati e successivamente riuniti. La censura è fondata. Il Giudice di Appello, nell'aderire al convincimento del Tribunale di Roma, che aveva rigettato la domanda proposta dal D. di risoluzione della compravendita stipulata tra le parti per la mancata consegna della licenza di abitabilità, ha ritenuto che la accertata destinazione ad uso ufficio a far data dal 16.2.1961 dell'immobile in questione costituiva la prova dell'avvenuto rilascio del certificato di abitabilità. Orbene tale affermazione non può essere condivisa in quanto la ritenuta equivalenza tra destinazione di un immobile ad uso ufficio e destinazione ad uso abitativo contrasta con lo scopo peculiare della licenza di abitabilità nella vendita di immobili destinati ad abitazione, costituendo un elemento che caratterizza il bene in relazione alla sua capacità di assolvere una determinata funzione economico - sociale e, quindi, di soddisfare i concreti bisogni che hanno indotto l'acquirente ad effettuare l'acquisto (Cass. 20.1.1996 n. 442), non vi è dubbio quindi che il certificato di abitabilità, in relazione alla sua evidenziata funzione, assicura il legittimo godimento e la commerciabilità del bene destinato ad abitazione (e non quindi ad uso ufficio), cosicchè la sua mancata consegna, determinando l'acquisto di un bene che presenta problemi di commerciabilità, 94 implica un inadempimento che, sebbene non sia tale da dare necessariamente luogo alla risoluzione del contratto, può comunque essere fonte di un danno risarcibile (Cass. 19.7.1999 n. 7681); nè a diverse conclusioni può giungersi sulla base del rilievo del Giudice di primo grado, cui la Corte Territoriale sembra aver aderito, della concreta utilizzazione del bene ad uso abitativo da parte dei precedenti proprietari e dello stesso D., posto che tale circostanza è irrilevante (vedi in tal senso Cass. 3.7.2000 n. 8880), non incidendo sulla ridotta commerciabilità dell'immobile. Con il quarto motivo il ricorrente, deducendo violazione degli articoli 1439 e 1440 c.c., nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver respinto la domanda di annullamento del Contratto di vendita stipulato tra le parti per dolo. Il D. afferma che tale domanda era basata su tre diverse circostanze, poichè i venditori avevano taciuto l'esistenza di un contenzioso sorto prima del 1981 con il Condominio confinante riguardante la pericolosità del muro di confine successivamente crollato, l'esecuzione di opere abusive e l'avvenuto rilascio della licenza di abitabilità solo per uso ufficio, si era quindi in presenza di un illecito comportamento dei venditori diretto a trarre in inganno l'acquirente, determinandolo a porre in essere una attività negoziale che, senza il dolo, non avrebbe compiuto o avrebbe compiuto a condizioni diverse. La censura è infondata. Il Giudice di Appello, nel disattendere la domanda proposta dal D. ex articoli 1439 e 1440 c.c., ha escluso che il silenzio tenuto dai venditori in merito alla denuncia di danno temuto proposta nei confronti del Condominio di Via (OMISSIS) dal confinante Condominio di (OMISSIS) diversi anni prima della conclusione del Contratto di compravendita stipulato tra le parti fosse stato intenzionalmente diretto a trarre in inganno l'acquirente in ordine alle condizioni dell'immobile, ed inoltre ha aggiunto che l'appellante non aveva indicato alcun elemento specifico dal quale potesse desumersi che l'eventuale conoscenza della menzionata circostanza avrebbe influito sulla determinazione volitiva del D.; a tale riguardo la sentenza impugnata ha anzi evidenziato che una simile conseguenza appariva in contrasto con il cospicuo valore attribuito all'immobile nel Contratto, destinato ad essere limitatamente inciso da eventuali lavori che fossero stati eseguiti sul muro condominiale al fine di assicurarne la stabilità. Orbene tali rilievi, non oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente, sono decisivi soprattutto per quanto attiene alla mancata deduzione da parte dell'appellante di alcun elemento concreto dal quale potersi evincere che, qualora egli avesse conosciuto le sopra evidenziate circostanze, non avrebbe concluso il Contratto o avrebbe comunque preteso di stipulare a condizioni diverse. In linea di diritto deve invero assumersi che, pur potendo il dolo omissivo viziare la volontà e determinare l'annullamento del Contratto, tuttavia esso rileva a tal fine solo quando l'inerzia della parte contraente si inserisca in un complesso comportamento adeguatamente preordinato, con malizia od astuzia, a realizzare l'inganno perseguito; pertanto il semplice silenzio, anche su situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione di essa alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono causa invalidante del Contratto (Cass., 18.10.1991 n. 11038; Cass. 11.10.1994 n. 8295); la reticenza ed il silenzio quindi non sono sufficienti a costituire il dolo se non in rapporto alle circostanze ed al complesso del contegno che determina l'errore del "deceptus", che devono essere tali da configurarsi quali 95 malizia o astuzia volte a realizzare l'inganno perseguito (Cass. 12.2.2003 n. 2104). Orbene nella fattispecie il D., cui incombeva il relativo onere probatorio, non ha dedotto tutti gli elementi necessari ad integrare il preteso dolo omissivo dei venditori con riferimento sia al contesto sopra evidenziato nel quale il silenzio da essi tenuto avrebbe dovuto inserirsi per essere rilevante, sia alla idoneità del silenzio stesso sulle circostanze sopra dedotte dal ricorrente ad incidere sulla determinazione volitiva dell'acquirente. Con il quinto motivo il ricorrente, denunciando violazione degli articoli 1490 1492 - 1494 e 1495 c.c. nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda di garanzia per i vizi che caratterizzavano l'immobile, non avendo considerato che la denuncia di tali vizi, essendo essi occulti, non era necessaria, e che l'azione relativa era stata tempestivamente esercitata il 17.2.1994. La censura è infondata. La Corte Territoriale ha rigettato il motivo di appello al riguardo proposto dal D. sulla base del rilievo dell'avvenuta maturazione del termine annuale di prescrizione, decorrente dalla consegna della casa, entro il quale deve essere esercitata l'azione di garanzia per i vizi, posto che la consegna dell'immobile era avvenuta il 10.12.1991 contestualmente alla stipula dell'atto di compravendita, e la suddetta azione era stata proposta allorchè il suddetto termine era ampiamente trascorso. Orbene tale "ratio decidendi" sufficiente a sorreggere il convincimento espresso dal giudice di Appello, non è stata specificatamente censurata in questa sede, cosicchè il motivo in esame deve essere disatteso. Con il sesto motivo il ricorrente, deducendo violazione degli articoli 1490 - 1492 1494 c.c. e L. n. 47 del 1985, art. 31, comma 3, nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver inspiegabilmente rigettato la domanda di rimborso delle spese sostenute per ottenere la sanatoria di alcune opere abusive eseguite dai venditori sull'immobile per cui è causa. La censura è inammissibile. Come emerge dalla sentenza impugnata, il Giudice di primo grado aveva rigettato la domanda suddetta per la mancanza di prove in ordine alla realizzazione di opere abusive da parte dei venditori nell'appartamento in questione; orbene, pur avendo il D. con l'atto di appello chiesto la condanna delle controparti al rimborso per la evidenziata causale della somma di L. 13.507.200 (vedi conclusioni riportate nella epigrafe della sentenza impugnata), la Corte Territoriale non si è pronunciata al riguardo; tuttavia il ricorrente con il motivo in esame non denuncia in proposito la violazione dell'art. 112 c.p.c., ma deduce inammissibilmente l'omessa motivazione sul mancato accoglimento della domanda, in realtà non esaminata dal Giudice di Appello. Con il settimo motivo il ricorrente, deducendo violazione dell'art. 96 c.p.c. e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver condannato l'esponente al pagamento delle spese di giudizio in misura eccessiva e punitiva. Il motivo resta ambito per effetto dell'accoglimento del terzo motivo di ricorso. In definitiva, quindi, all'esito dell'accoglimento del terzo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa deve esser rinviata per un nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma che provvederà anche alla pronuncia sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il settimo e rigetta tutti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e 96 rinvia anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma, il 2 marzo 2005. Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2006 SUCCESSIONE TESTAMENTARIA TRACCIA Tizio, vedovo, aveva due figlie, Prima e Seconda. Alla prima donava, in data 30 dicembre 1996, la somma di 300.000,oo euro affinché comprasse l’appartamento Alfa, sito in Napoli alla via Possillipo n. 22. Prima, poi, aveva comprato il suddetto appartamento. Accadeva che, l’appartamento acquistato da Prima, dopo pochi mesi dall’acquisto, aumentava di valore in modo esponenziale, per merito del progetto, inaspettato, della costruzione di una fermata della metropolitana. Seconda, indispettita per il comportamento del padre Tizio, scappava di casa. Seconda acquistava, poi, l’appartamento Tuscolano in Piazza dei Martiri n. 5, contraendo con la banca Beta un mutuo di euro 500.000,oo; Seconda riusciva a pagare solo euro 200.000.oo e, non sapendo come fare, si rivolgeva al padre, che le perdonava la fuga di casa. Tizio, padre di Seconda, si obbligava, per iscritto, nei confronti della figlia a tenerla indenne dal debito della residua quota di euro 300.000,oo, senza assumerlo nei confronti della banca. Tizio decedeva, lasciando un testamento in cui disponeva in parti eguali verso le figlie del patrimonio residuo, decurtato dei 300.000,oo euro promessi a Seconda. Tuttavia, Seconda riteneva di essere stata danneggiata dalla ripartizione operata dal padre, assicurando un’azione di riduzione, anche in considerazione del fatto che l’immobile Alfa valeva molto più di 300.000,oo euro. Prima, infastidita, si recava da un legale. Il candidato affronti la questione giuridica posta alla sua attenzione. POSSIBILE SCHEMA DI SOLUZIONE In premessa poteva essere utile ricostruire (molto) sinteticamente il fatto; successivamente era utile chiedersi se il de cuius, in qualche modo, in vita, aveva avvantaggiato Prima in danno di Seconda. La somma di 300.000,oo euro data dal de cuius a Prima serviva per acquistare l’immobile, così che si realizza una donazione indiretta dell’appartamento Alfa, secondo la giurisprudenza prevalente (che pone l’accento sullo scopo e sulla causa dell’emolumento economico). 97 E’ stata violata la par condicio tra i legittimari, tale da giustificare un’impugnazione del testamento? Al quesito bisognerebbe dare risposta negativa, in quanto anche Seconda, nella sostanza, ha avuto una donazione del valore di 300.000,oo euro volta all’acquisto di un immobile, e il valore di quest’ultimo va calcolato al momento dell’acquisto (al pari dell’immobile Alfa di proprietà di Prima). Più in particolare, Tizio ha effettuato in vita una donazione di immobile alla figlia Prima e si è accollato, mediante un accollo interno, il debito dell’altra figlia Seconda. Nella figura dell’accollo si può ritrovare il fenomeno del negozio indiretto: l’accollo stesso, di conseguenza, rappresenta il negozio – mezzo per raggiungere un ulteriore scopo, nel caso di specie quello di liberalità (negozio – fine); lo stesso principio vale, de plano, anche per l’accollo interno che può integrare una donazione obbligatoria, anche se indiretta. Nel caso in esame mediante accollo interno, Tizio è accollante – donante che assume la posizione del debitore nei confronti della figlia Seconda, che viene arricchita dall’acquisto di un diritto di credito, senza alcun sacrificio. Anche verso Seconda, pertanto, si è realizzata una donazione indiretta del valore di 300.000,oo euro relativamente all’appartamento Tuscolano. In altri termini, Caio ha donato l’appartamento Alfa, del valore di 300.000,oo euro, a Prima e parte dell’appartamento Tuscolano, del pari valore di 300.000,oo euro, a Seconda, con la conseguenza applicativa che non è stata violata la par condicio tra legittimari, e non si giustificherebbe alcuna azione da parte di Seconda rivolta ad impugnare il testamento. Se, tuttavia, vi è stato un apprezzabile aumento del valore dell’immobile Alfa, per cui, nella sostanza, l’immobile donato a Prima vale molto di più della parte di immobile donata a Seconda, allora, in considerazione del fatto che la donazione indiretta riguarda l’immobile e non il denaro, Prima dovrà corrispondere a Seconda una somma pari all’eccedenza del valore dell’appartamento oggetto della donazione (giustificandosi eventuali azioni volte ad impugnare il testamento). Si consiglia di leggere le sentenze che seguono. -Ai fini dell’ individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari e ai singoli legittimari nell'ambito della stessa categoria occorre fare riferimento alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento (per rinunzia o prescrizione) dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari. CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 12 giugno 2006 n. 13524 Svolgimento del processoCon atto notificato l'1-4 luglio 1987 Maria Caselli conveniva davanti al Tribunale di Torino il fratello Vincenzo Caselli, nonché i nipoti Enrico, Alberto e Maria Rosa Kiss, ed esponeva:· che in data 17 gennaio 1987 era deceduta Lucia Bertolone, madre di essa attrice e di Vincenzo Caselli e 98 di Thea Caselli, quest'ultima premorta lasciando a succederle per rappresentazione alla madre i figli Enrico, Alberto e Maria Rosa Kiss; · che con atto in data 6 agosto 1980 Lucia Bertolone aveva venduto a Vincenzo Caselli la nuda proprietà su un immobile costituente il suo intero patrimonio; · che tale atto dissimulava una donazione nulla per difetto di forma o comunque una donazione lesiva della propria quota di legittima; · sulla base di tali premesse l'attrice chiedeva che venisse dichiarata la nullità della donazione, con conseguente apertura anche in suo favore della successione legittima o che, nell'ipotesi di validità dell'atto in questione, ne venisse disposta la riduzione nella misura necessaria ad assicurarle la quota di legittima cui aveva diritto.Vincenzo Caselli, costituitosi, contestava il fondamento delle domande.Enrico, Alberto e Maria Rosa Kiss rimanevano contumaci.Con sentenza non definitiva in data 3 novembre 1992 il Tribunale di Torino rigettava le domande proposte dall'attrice, che proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Torino con sentenza in data 8 febbraio 1995.Maria Caselli proponeva ricorso per cassazione, che questa S.C. accoglieva con sentenza in data 18 marzo 1997 n. 2885, ritenendo insufficiente la motivazione con la quale era stata esclusa la simulazione dell'atto in data 6 agosto 1980 ed insussistente in ordine alla subordinata ipotesi della configurabilità di un negotium mixtum cum donatione.Maria Caselli provvedeva alla riassunzione del giudizio davanti alla Corte di appello di Torino, che con sentenza non definitiva in data 6 agosto 2001 escludeva la sussistenza della simulazione dell'atto in data 6 agosto 1980 e disponeva l'ulteriore corso del giudizio al fine di accertare la sussistenza o meno di un negotium mixtum cum donatione.Contro tale decisione Maria Caselli, dopo avere fatto riserva di impugnazione, proponeva ricorso immediato e tale ricorso è stato dichiarato inammissibile da questa S.C. con sentenza in data 30 marzo 2006 n. 7502.Con sentenza in data 15 novembre 2002 la Corte di appello di Torino, frattanto, aveva ritenuto, sulla base della C.T.U. all'uopo disposta, che con l'atto in data 6 agosto 1980 era stato realizzato un negotium mixtum cum donatione, che, costituendo donazione indiretta, non era soggetto ai requisiti di forma previsti per le donazioni dirette.A questo punto si poneva il problema di individuare la quota di riserva spettante a Maria Caselli in una situazione caratterizzata dal fatto che la legittima nel suo complesso era pari ai due terzi dell'asse ereditario, avendo Lucia Bertolone lasciato due figli superstiti e tre nipoti destinati a subentrare per rappresentazione alla terza figlia, ma questi ultimi non erano venuti alla successione.In sostanza, si trattava di stabilire se la quota pari ai 2/9 in teoria spettante a Enrico, Alberto e Maria Rosa Kiss si doveva accrescere in favore delle altre due quote pari a 2/9 ciascuna spettanti a Maria Caselli e Vincenzo Caselli.La Corte di appello di Torino dava risposta negativa a tale quesito in base alla seguente motivazione.È vero che la mancata accettazione dell'eredità dei nipoti Kiss è venuta ad equivalere ad una rinuncia, ma la quota di legittima che è riservata dalla legge non può essere modificata dalla rinuncia di altri eredi. E questo per una serie di ragioni tra loro autonome.In primo luogo il dato letterale della disposizione normativa.L'art. 537 cc che dispone la riserva a favore dei legittimari parla di figli e non di eredi accettanti.In secondo luogo vale la «ratio» della disposizione normativa.Riservando ai figli una parte del patrimonio la legge ha, per così dire, posto un limite inderogabile alla volontà del testatore, nel senso che gli ha impedito di escludere totalmente il passaggio dei suoi beni ai figli col predeterminare a favore di questi ultimi delle quote minime di riserva.Peraltro la mancata accettazione di un erede non può costituire un ulteriore elemento di coartazione della volontà del testatore.In terzo luogo, se è vero che la mancata accettazione dei nipoti Kiss ha comportato la prescrizione 99 decennale del diritto, tuttavia la prescrizione non può essere rilevata di ufficio.Contro tale decisione, nonché contro la sentenza non definitiva in 6 agosto 2001, Maria Caselli ha proposto ricorso per cassazione, ripetendo, per quanto riguarda la sentenza non definitiva, il motivo del ricorso già proposto contro la stessa sentenza ed investendo con tre motivi la sentenza definitiva.Vincenzo Caselli ha resistito con controricorso ed ha anche proposto ricorso incidentale, con un unico motivo, al quale resiste con controricorso Maria Caselli.Con ordinanza in data 22 aprile 2005 la Seconda sezione civile di questa S.C. ha rimesso gli atti al Primo Presidente al fine di valutare l'opportunità di assegnare la causa alle Sezioni unite, in considerazione del fatto che ai fini della decisione occorre risolvere alcune questioni di particolare rilevanza giuridica, cui la dottrina dà contrastanti soluzioni e che non sono state affrontate ex professo da questa S.C.; in particolare occorre stabilire: a) quale sia il criterio di determinazione della quota di riserva nella ipotesi in cui vi siano più legittimari pretermessi, dei quali uno solo abbia esperito l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie; b) se a tale ipotesi possa ritenersi applicabile l'art. 522 cod. civ.Motivi della decisioneVa preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi.Con l'unico motivo del ricorso principale diretto contro la sentenza non definitiva Maria Caselli censura la motivazione con la quale la Corte di appello di Torino ha escluso che la vendita effettuata in data 6 agosto 1980 da M. Lucia Bertolone a Vincenzo Caselli dissimulasse una donazione nulla per difetto di forma.La doglianza è infondata.La ricorrente in via principale, infatti, da un lato, propone una diversa valutazione delle prove testimoniali rispetto a quella effettuata dai giudici di merito, mentre, invece, ai fini della sussistenza del denunciato vizio di motivazione avrebbe dovuto chiarire come le conclusioni cui la Corte di appello di Torino è pervenuta non siano congruenti, dal punto di vista logico, con il contenuto delle prove testimoniali ritenute attendibili; dall'altro, pretende che assurgano al livello di presunzioni elementi indiziari dal valore probatorio non univoco.Con il primo dei motivi del ricorso principale diretti contro la sentenza definitiva Maria Caselli censura la valutazione del donatum data dai giudici di merito e deduce testualmente.Con riferimento alla sentenza n. 1609/2002 occorre quindi osservare come la Corte di Appello di Torino ha, a sommesso parere dell'esponente, omesso di considerare che l'operazione posta in essere, cioè la vendita a prezzo vile della nuda proprietà dell'immobile, abbia comportato un duplice beneficio in favore del Vincenzo Caselli: uno immediato cioè l'acquisto a prezzo di gran lunga inferiore al reale della nuda proprietà dell'immobile, il secondo differito al momento in cui, con il decesso della de cuius, il Vincenzo sarebbe divenuto nudo proprietario dell'immobile.Per calcolare quindi correttamente il beneficio ricevuto la Corte di Appello avrebbe dovuto relazionare il prezzo pattuito e ritenuto pagato nell'agosto del 1980 al valore della piena proprietà dell'immobile al tempo dell'apertura della successione.La Corte di Appello ha invece effettuato un calcolo aritmetico attraverso il quale viene semplicemente trasposta la percentuale del prezzo asseritamente pagato nel 1980 sul valore della nuda proprietà a quella data per concludere che nella medesima percentuale è da considerare il beneficio ricevuto dal donatario al momento in cui l'usufrutto si consolidò nella nuda proprietà.In realtà sarebbe stato corretto, giusto il disposto della norma di cui all'art. 747 cc in punto momento che deve aversi presente per la valutazione del valore dell'immobile, calcolare il valore della donazione e quindi la quota del bene immobile oggetto di donazione alla data dell'apertura della successione.Poiché nel tempo la svalutazione del denaro e la rivalutazione dei beni immobili in termini di valore nominale non ha andamento sempre coincidente (e poi ogni immobile 100 bene infungibile per eccellenza - fa storia a sé), e in ogni caso, poiché con la consolidazione dell'usufrutto il beneficio ricevuto dal donatario è individuabile nella piena proprietà del bene, la quota del donatum doveva essere effettuata parametrando il sacrificio economico sopportato dal Caselli Vincenzo (37 ml nel 1980) al beneficio ricevuto all'apertura della successione (ovvero il valore della piena proprietà dell'immobile al tempo dell'apertura della successione).La Corte di Appello di Torino ha invece del tutto omesso detta operazione trasfondendo la percentuale del «pagato» sul valore della nuda proprietà al 1980 alla quota ideale di donazione (e infatti 37,5 ml rappresentano proprio il 22,22% - la Corte ha finito con l'arrotondare a 22,25% - di 168.750.000 valore della nuda proprietà al 1980 secondo il seguente calcolo aritmetico 168.750.000/100 = 1.687.500; 37.500.000/1.687.500 = 22,22).Il Giudice del merito ha quindi concluso che il donatum fosse una quota ideale pari al 77,75% (100-22,25) dell'immobile.Detto criterio di calcolo non tiene in nessun conto il criterio di cui al citato art. 747 c.c. e soprattutto non considera che con il decesso dell'usufruttuaria il donante ha conseguito l'ulteriore beneficio della consolidazione dell'usufrutto.L'esponente aveva proposto invece il seguente diverso criterio di calcolo: somma di 37.500.000; rivalutata al gennaio 1987 pari a L. 76.500.000;=.Detta somma rivalutata rappresenta una percentuale del 12,96% del valore alla stessa data della piena proprietà del compendio immobiliare (590.000.000). Ne derivava quindi che la percentuale del donatum era da individuarsi nell'87,04% e non già nella minore percentuale del 77,75.Anche a non voler condividere detto criterio di calcolo, in ogni caso, il Giudice del merito avrebbe dovuto individuare criteri atti a rapportare, come sopra visto, il presunto sacrificio economico del Caselli Vincenzo al 1980 con il beneficio complessivo da calcolarsi al momento dell'apertura della successione.Il motivo, a prescindere dalla sua teorica fondatezza o meno, è inammissibile, in quanto investe una questione che non risulta trattata nella sentenza impugnata, né viene espressamente denunciata una omessa pronuncia, il che sarebbe stato necessario, in considerazione delle conclusioni che risultano formulate nell'epigrafe della sentenza impugnata.Con il secondo dei motivi del ricorso principale diretti contro la sentenza definitiva Maria Caselli sostiene che nella specie il negotium mixtum cum donatione doveva considerarsi nullo per difetto di forma, in applicazione del criterio della c.d. prevalenza.Il motivo è infondato, alla stregua quantomeno della più recente giurisprudenza di questa S.C., la quale ha affermato che per il negotium mixtum cum donatione non è necessaria la forma dell'atto pubblico richiesta per la donazione diretta, essendo, invece, sufficiente la forma dello schema negoziale adottato, senza far menzione del criterio della c.d. prevalenza (cfr. sent. 21 gennaio 2000 n. 642; 10 aprile 1999 n. 3499).Con il terzo dei motivi del ricorso principale diretti contro la sentenza definitiva Maria Caselli ripropone la tesi secondo la quale il mancato esercizio dell'azione di riduzione da parte dei nipoti ex sorore comportava l'accrescimento (anche) in suo favore della quota di legittima agli stessi in teoria spettante.Si tratta del problema con riferimento al quale la causa è stata assegnata a queste Sezioni unite.Questa S.C. ha avuto occasione di affermare che se più sono i legittimari (nell'ambito della categoria dei discendenti) ciascuno ha diritto ad una frazione della quota di riserva e non all'intera quota, o comunque ad una frazione più ampia di quella che gli spetterebbe se tutti gli altri (non) facessero valere il loro diritto (sent. 22 ottobre 1975 n. 3500, 1978 n. 5611).Tale orientamento, peraltro, si pone in implicito contrasto con la giurisprudenza formatasi con riferimento alla ipotesi in cui disponibile e legittima variano in funzione della esistenza di più categorie di 101 legittimari o del numero di legittimari nell'ambito di una stessa categoria.Ad es., in base all'art. 542, primo comma, cod. civ., se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge; in base all'art. 542, secondo comma, cod. civ., quando, invece, i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio ed al coniuge spetta un altro quarto.Con riferimento ad entrambe le ipotesi si pone il problema se il mancato esercizio dell'azione di riduzione da parte del coniuge pretermesso comporta che la legittima dell'unico figlio o dei più figli si «espanda», diventando rispettivamente pari alla metà o ai due terzi del patrimonio del de cuius, secondo quanto previsto dall'art. 537, primo e secondo comma, cod. civ.Con riferimento alla ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 542 cod. civ. si pone il problema se il mancato esercizio dell'azione di riduzione da parte dell'unico figlio comporta la espansione della legittima del coniuge, in modo da farle raggiungere la misura prevista dall'art. 540, primo comma, cod. civ.Con riferimento, infine all'ipotesi prevista dall'art. 542, secondo comma, cod. civ. si pone il problema se l'esperimento dell'azione di riduzione da parte di uno solo dei figli comporta che la legittima allo stesso spettante debba essere determinata secondo quanto disposto dal primo comma.La giurisprudenza di questa S.C. si è mostrata favorevole alla tesi della c.d. espansione della quota di riserva con riferimento all'ipotesi di mancato esercizio dell'azione di riduzione da parte del coniuge superstite (sent. 26 ottobre 1976 n. 3888; 9 marzo 1987 n. 2434; 11 febbraio 1995 n. 1529).Si è, in proposito, affermato (sent. 9 marzo 1987, cit.) che ... occorre tenere presente che, a norma dell'art. 521 c.c. la rinunzia all'eredità è retroattiva nel senso che l'erede rinunziante si considera come se non fosse mai stato chiamato all'eredità. È dunque impossibile far riferimento alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione, dal momento che tale situazione è soggetta a mutare, per effetto di eventuali rinunzie, con effetto retroattivo. È quindi alla situazione concreta che occorre far riferimento, e non a quella teorica, riferita al momento dell'apertura della successione, indipendentemente dalle vicende prodottesi in seguito; devesi dunque far riferimento agli eredi che concretamente concorrono nella ripartizione dell'asse ereditario e non a quelli che in teoria a tale riparto avrebbero potuto partecipare.Tale orientamento è conforme a quanto sostenuto in dottrina, in cui ugualmente si è invocato il principio della retroattività della rinuncia fissato nell'art. 521 c.c. e si è sostenuto che un argomento a favore dello stesso sarebbe desumibile dall'art. 538 cod. civ., che regola la riserva spettante agli ascendenti «se chi muore non lascia figli legittimi», in quanto la norma dovrebbe applicarsi soltanto nel caso in cui l'ereditando non abbia avuto figli o questi siano tutti presenti o assenti; se invece sopravvivessero figli capaci di succedere e tutti rinunziassero, si dovrebbe concludere nel senso che o rimane ferma a beneficio degli ascendenti la quota riservata di due terzi stabilita dall'art. 537, oppure che non sorge alcun diritto di riserva in favore degli ascendenti, conclusioni, l'una e l'altra, evidentemente inammissibili.Si tratta di un orientamento che il collegio ritiene di non poter condividere.Appare, in primo luogo, inopportuno il richiamo agli effetti della rinuncia di uno dei chiamati in tema di successione legittima, secondo quanto previsto dagli artt. 521 e 522 cod. civ., per vari motivi.Nella successione legittima il c.d. effetto retroattivo della rinuncia di uno dei chiamati e il conseguente accrescimento in favore degli accettanti trovano una spiegazione logica nel fatto che, diversamente, non si saprebbe quale dovrebbe essere la sorte della quota del rinunciante.La situazione è ben diversa con riferimento alla c.d. successione necessaria.Il legislatore, infatti, 102 si è preoccupato di far sì che ad ognuno dei legittimari considerati venga garantita una porzione del patrimonio del de cuius anche contro la volontà di quest'ultimo.Mancando una chiamata congiunta ad una quota globalmente considerata con riferimento alla ipotesi di pluralità di riservatari (ed anzi essendo proprio la mancanza di chiamata ereditaria il fondamento della successione necessaria), da un lato, viene a cadere il presupposto logico di un teorico accrescimento, e, dall'altro, non esistono incertezze in ordine alla sorte della quota (in teoria) spettante al legittimario che non eserciti l'azione di riduzione: i donatari o gli eredi o i legatari, infatti, conservano una porzione dei beni del de cuius maggiore di quella di cui quest'ultimo avrebbe potuto disporre.La lettera della legge, poi, costituisce un ostacolo insormontabile per l'adesione alla tesi finora sostenuta in dottrina ed in giurisprudenza. Dalla formulazione degli artt. 537, primo comma («se il genitore lascia»), 538, primo comma («se chi muore non lascia»), 542, primo comma («se chi muore lascia»), 542, secondo comma («quando chi muore lascia»), cod. civ. risulta chiaramente che si deve fare riferimento, ai fini del calcolo della porzione di riserva, alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione; non viene preso, invece, in considerazione, a tal fine, l'esperimento dell'azione di riduzione da parte di alcuno soltanto dei legittimari.Mancano, pertanto, le condizioni essenziali (esistenza di una lacuna da colmare e possibilità di applicare il principio ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio) per una estensione in via analogica delle norme in tema di successione legittima. La tesi criticata, poi, sembra in contrasto con la ratio ispiratrice della successione necessaria, che non è solo quella di garantire a determinati parenti una porzione del patrimonio del de cuius, ma anche (come rovescio della medaglia) quella di consentire a quest'ultimo di sapere entro quali limiti, in considerazione della composizione della propria famiglia, può disporre del suo patrimonio in favore di terzi. È evidente che l'esigenza di certezza in questione non verrebbe soddisfatta ove tale quota dovesse essere determinata, successivamente all'apertura della successione, in funzione del numero di legittimari che dovessero esperire l'azione di riduzione.Non possono, poi, essere taciuti gli inconvenienti pratici connessi alla adesione della c.d. espansione della quota di riserva.Occorre, a tal fine, partire dalla considerazione che l'esercizio dell'azione di riduzione è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale e che non è prevista una actio interrogatoria, al contrario di quanto avviene con riferimento all'accettazione dell'eredità (art. 481 cod. civ.). Ne consegue che all'apertura della successione ogni legittimario può esperire l'azione di riduzione solo con riferimento alla porzione del patrimonio del de cuius che gli spetterebbe in base alla situazione familiare di quest'ultimo a tale momento. Solo dopo la rinunzia all'esercizio dell'azione di riduzione da parte degli altri legittimari o la maturazione della prescrizione in danno degli stessi potrebbe agire per ottenere un supplemento di legittima, con evidente incertezza medio tempore in ordine alla sorte di una quota dei beni di cui il de cuius ha disposto per donazione o per testamento a favore di terzi.Né utili argomenti a favore della tesi criticata possono desumersi dall'art. 538 cod. civ.In primo luogo, nel ragionamento sopra trascritto è incomprensibile il riferimento ad una quota pari a due terzi riservata in favore dagli ascendenti dall'art. 537 cod. civ., dal momento che tale disposizione fa riferimento alla quota riservata ai figli legittimi o naturali.Non si comprende, poi, perché sarebbe inammissibile la conclusione (cui si perverrebbe aderendo alla tesi che il collegio ritiene preferibile) secondo la quale, ove sopravvivessero al de cuius figli legittimi e tutti rinunziassero non sorgerebbe alcun diritto di legittima a favore degli ascendenti.Va, innanzitutto, rilevato che non è chiaro se la rinunzia 103 viene riferita all'accettazione dell'eredità o all'esperimento dell'azione di riduzione.Nel primo caso un problema di tutela degli ascendenti non si porrebbe neppure, in quanto in loro favore si aprirebbe la successione legittima ex art. 569 cod. civ., dovendo i figli legittimi, a seguito della rinunzia all'eredità, considerarsi come mai chiamati alla successione.Nel secondo caso la esclusione della configurabilità di una quota di riserva in favore degli ascendenti sarebbe espressione della scelta del legislatore di garantire il conseguimento di una quota del patrimonio del de cuius solo ai parenti più prossimi (oltre che al coniuge) esistenti al momento dell'apertura della successione. I parenti di grado successivo, che sono considerati come legittimari solo in mancanza di quelli di grado più vicino, pertanto, non possono essere rimessi in corsa in caso di mancato esercizio dell'azione di riduzione da parte di questi ultimi.In definitiva, il legislatore ha considerato iniquo il fatto che il de cuius disponga dell'intero suo patrimonio a favore di estranei nel caso in cui abbia solo discendenti o solo ascendenti; non ha considerato, invece, iniquo il fatto che rimangano fermi gli atti con i quali il de cuius, il quale lasci discendenti e ascendenti, abbia disposto dell'intero suo patrimonio a favore di estranei, nel caso in cui i discendenti (unici legittimari considerati) non esperiscano l'azione di riduzione.Alla luce delle considerazioni svolte si può, pertanto, concludere che ai fini della individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari e ai singoli legittimari nell'ambito della stessa categoria occorre fare riferimento alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento (per rinunzia o prescrizione) dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari.Alla luce delle considerazioni svolte è evidente che anche il terzo dei motivi del ricorso principale diretti contro la sentenza definitiva va rigettato.Con l'unico motivo del ricorso incidentale Vincenzo Caselli si duole del fatto che la Corte di appello di Torino, per quanto riguarda la valutazione dell'immobile oggetto della vendita in data 6 agosto 1980, nella quale è stato individuato un negotium mixtum cum donatione, e la rivalutazione dello stesso al momento dell'apertura della successione, abbia recepito le conclusioni del C.T.U., senza tenere conto delle critiche rivolte all'operato dello stesso.Il motivo è infondato, in quanto non viene specificamente censurata la esattezza dell'elemento decisivo sul quale si sono fondate le valutazioni del C.T.U. recepite dalla sentenza impugnata e cioè i dati compartivi desumibili dal mercato immobiliare per costruzioni similari, in base anche alle concrete risultanze ancora in possesso delle agenzie immobiliari operanti in loco.In definitiva, entrambi i ricorsi vanno rigettati.In considerazione della problematicità della questione con riferimento alla quale il ricorso è stato assegnato alle Sezioni unite di questa S.C., ritiene il collegio che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.P.Q.M.la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. -In tema di successione ereditaria il termine di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive della legittima. Corte di cassazione Sezioni unite civili 104 Sentenza 25 ottobre 2004, n. 20644 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 28 settembre 1991 Lidia P., Ersilia P. ed Egidio P. convenivano davanti al Tribunale di Isernia Nicola P. e Francesco P., esperendo azione di riduzione in relazione alle disposizioni contenute nel testamento olografo in data 10 agosto 1968, pubblicato il 13 novembre 1991, del comune genitore Vincenzo Antonio P., deceduto il 30 giugno 1981. I convenuti, costituitisi, eccepivano la prescrizione del diritto ad esperire l'azione di riduzione ed il Tribunale di Isernia, con sentenza in data 16 febbraio 1998, riteneva fondata tale eccezione. Lidia P., Ersilia P. ed Egidio P. proponevano appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di Campobasso con sentenza in data 17 marzo 2000, che riteneva di fare applicazione nella specie del principio affermato da questa Suprema Corte con sentenza in data 5920/1999, secondo il quale il termine di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di pubblicazione del testamento olografo. I giudici di secondo grado ritenevano, poi, che il testamento all'origine della controversia, che conteneva una divisione del testatore non poteva considerarsi nullo ex art. 735 c.c., per essere stata premetermessa quale erede la madre Lucia Martella, alla quale era stato lasciato solo l'usufrutto dell'intero patrimonio. All'epoca della formazione del testamento olografo, infatti, al coniuge spettava solo l'usufrutto di una quota di eredità. Ad ogni modo la moglie del de cuius aveva rinunciato all'eredità. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione Nicola P. e Francesco P., con un unico motivo. Resistono con controricorso Lidia P., Ersilia P. ed Egidio P., che hanno anche proposto ricorso incidentale, con un unico motivo, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi. Con il ricorso principale viene riproposta la questione della individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dell'azione di riduzione, ed è per risolvere il contrasto esistente sul punto che la causa è stata rimessa alle Sezioni unite di questa Suprema Corte. Secondo un orientamento il termine di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di apertura della successione (sentenza 4230/1987, per la quale non ha rilievo l'individuazione del momento in cui il legittimario ha scoperto la lesione della propria quota di riserva; sentenza 25 11809/1997, per la quale non rilevano né l'eventuale ignoranza dell'esistenza di un testamento, né la circostanza che eventualmente il testamento olografo non sia in possesso del legittimario). Secondo una più recente decisione (sentenza 5920/1999, la quale si ricollega alla sentenza 99/1970), invece, il termine di prescrizione dell'azione di riduzione inizia a decorrere dalla pubblicazione del testamento. Soltanto da tale momento, che determina una presunzione iuris tantum di conoscenza delle disposizioni lesive, i 105 legittimari sono in condizione di fare valere il loro diritto e richiedere la riduzione delle disposizioni lesive della propria quota di riserva, atteso che da tale data, salvo prova contraria, sono a conoscenza della lesione. In base al combinato disposto degli artt. 620 e 623 c.c., in relazione all'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, la riduzione delle disposizioni contenute in un testamento non può essere chiesta se le stesse non sono ancora a conoscenza di coloro che da quelle disposizioni hanno visto leso il proprio diritto di legittimari e a nulla rileva che il testamento sia esecutivo. Tale decisione ha, poi, aggiunto che, anche se il testamento pubblico è eseguibile subito, e sin dall'apertura della successione (art. 61 legge notarile e a contrariis ex art. 623, comma 4, c.c.), la comunicazione agli eredi ed ai legatari prevista dall'art. 623 c.c. deve essere fatta a cura del notaio che il testamento ha ricevuto e solo dall'avvenuta pubblicazione può discendere una presunzione iuris tantum di conoscenza delle disposizioni in esso contenute. Ritiene il collegio che nessuno degli orientamenti esposti meriti completa adesione. In proposito sembra opportuno premettere due osservazioni. In primo luogo, nessuna norma prevede che il termine (incontestabilmente quello decennale di cui all'art. 2946 c.c.) per esperire l'azione di riduzione decorra dalla data di apertura della successione. In secondo luogo, un problema di individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dell'azione di riduzione può porsi solo con riferimento alla lesione di legittima ricollegabile a disposizioni testamentarie. Nel caso in cui la lesione derivi da donazioni, infatti, è indubbio che tale termine decorre dalla data di apertura della successione, non essendo sufficiente il relictum a garantire al legittimario il soddisfacimento della quota di riserva. Diversa è la situazione che si presenta, invece, con riferimento alla ipotesi in cui la (potenziale) lesione della legittima sia ricollegabile a disposizioni testamentarie. In tal caso, infatti, il legittimario, fino a quando il chiamato in base al testamento non accetta l'eredità, rendendo attuale quella lesione di legittima che per effetto delle disposizioni testamentarie era solo potenziale, non sarebbe legittimato (per difetto di interesse) ad esperire l'azione di riduzione. Appare allora evidente che se manca la situazione di danno (accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base al testamento) alla quale l'azione di riduzione consente di porre rimedio, non può decorrere il termine di prescrizione di tale azione. Per potere eliminare la situazione di incertezza il legittimario potrà esperire nei confronti del chiamato all'eredità per testamento l'actio interrogatoria ex art. 481 c.c. 106 Alla luce di tali considerazioni appare evidente che non si può condividere l'orientamento di cui sono espressione le sentenze 4230/1987 e 11809/1997, in sostanziale applicazione del principio costantemente affermato da questa Suprema Corte secondo il quale, ai fini della decorrenza della prescrizione, non rilevano gli impedimenti di mero fatto all'esercizio del diritto. Con la sola apertura della successione, infatti, non si è ancora realizzata la lesione di legittima e quindi mancano le condizioni di diritto perché possa iniziare a decorrere il termine per l'esperimento del rimedio predisposto dal legislatore per porre riparo a tale lesione. L'orientamento in questione può essere ritenuto valido, alla luce del principio in precedenza richiamato in tema di interpretazione dell'art. 2935 c.c., nel senso che, successivamente alla accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base a testamento, non costituisce ostacolo alla decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di riduzione la mancata conoscenza da parte del legittimario leso di tale accettazione dell'eredità. Non può condividersi neppure l'orientamento espresso dalla più recente sentenza 5920/1999, a prescindere dalla considerazione che la decorrenza della prescrizione viene ricollegata ad una conoscenza delle disposizioni lesive della legittima desumibile in base ad una presunzione iuris tantum di cui non vi è traccia nella legge e che comunque manca di fondamento logico. Per quanto riguarda il testamento pubblico, infatti, la comunicazione agli eredi e legatari da parte del notaio che l'ha ricevuto, prevista dall'art. 623 c.c., potrebbe in astratto valere come presunzione di conoscenza (salvo individuare le concrete conseguenze sul piano giuridico) per i destinatari di tale comunicazione, ma non per il legittimario leso in base a tale testamento. Per quanto riguarda specificamente il testamento olografo, ricollegando l'inizio della prescrizione dell'azione di riduzione alla pubblicazione dello stesso, a prescindere dal fatto che anche in tal caso non viene chiarito quale sarebbe il fondamento logico di una presunzione di conoscenza da parte dei legittimari, non si tiene conto che: a) tale pubblicazione può anche mancare (cfr. la sentenza di questa Suprema Corte 3636/2004); b) tale pubblicazione deve essere richiesta da chi è nel possesso del testamento, che potrebbe essere - ed anzi spesso è - persona diversa dal chiamato all'eredità in base ad esso e quindi da essa non è desumibile una accettazione dell'eredità da parte del chiamato; c) alla richiesta di pubblicazione del testamento olografo, anche ove dovesse provenire dal chiamato in base ad esso, non è necessariamente ricollegabile una accettazione dell'eredità, potendo essere fatta esclusivamente in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 620, comma 1, c.c. Alla pubblicazione del testamento può essere ricollegata, ai sensi dell'art. 475 c.c., l'accettazione dell'eredità (e, correlativamente, la decorrenza del termine di prescrizione per l'esperimento dell'azione di riduzione) solo ove il chiamato assuma espressamente nel relativo verbale la qualità di eredi. 107 Va, poi, aggiunto che la pubblicazione serve a dare legale esecuzione al testamento olografo, ma nulla esclude che il chiamato in base ad esso abbia compiuto in precedenza atti idonei a comportare l'accettazione dell'eredità e quindi la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di riduzione. Alla luce di tali considerazioni il ricorso principale, con il quale si censura la sentenza impugnata per avere fatto decorrere il termine per la prescrizione dell'azione di riduzione dalla data di pubblicazione del testamento olografo, va cassata, con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di legittimità, che si atterrà al seguente principio di diritto: «Il termine di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive della legittima». Il ricorso incidentale, con il quale si censura la sentenza impugnata, per avere escluso la nullità della divisione operata da Vincenzo Antonio P., con il testamento in data 10 agosto 1968, senza tenere conto che la posizione della moglie superstite quale riservataria andava stabilita con riferimento all'epoca dell'apertura della successione (avvenuta nella vigenza della riforma del diritto di famiglia) e non all'epoca della confezione del testamento, va rigettato. Pur dovendosi riconoscere, infatti, l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata in ordine alla affermazione in diritto, e pur dovendosi riconoscere che l'eventuale nullità del testamento per pretermissione di un legittimario (nella specie la moglie del de cuius) farebbe venire meno la base per l'esperimento dell'azione di riduzione, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, il de cuius lasciò alla moglie l'usufrutto dell'intero patrimonio, per cui non si può parlare di legittimario pretermesso ai sensi dell'art. 735, comma 1, c.c., ma eventualmente di legittimario leso, ai sensi dell'art. 735, comma 2, c.c., senza incidenza sulla validità del testamento e con semplice possibilità di esperimento dell'azione di riduzione. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; in relazione all'accoglimento del ricorso principale cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli anche per le spese del giudizio di cassazione. RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE TRACCIA La società Alfa commissionava alla società Beta la fornitura di anelli guidafune da installare sui propri macchinari; dopo 3 anni, la società Alfa lamentava di aver subito diversi danni dalla rottura di alcuni dei suddetti anelli. Francesco, amministratore di Alfa, telefonava a Marcello, amministratore di Beta, comunicandogli di voler agire per il solo risarcimento dei danni subiti, visto che l’azione ripristinatoria era prescritta. Marcello si recava da un legale. 108 Il candidato, premessi brevi cenni sulla responsabilità dell’appaltatore, rediga motivato parere sulla questione giuridica posta. POSSIBILE SCHEMA DI SOLUZIONE In premessa poteva essere utile ricostruire sinteticamente il fatto. Successivamente, era necessario inquadrare giuridicamente la responsabilità dell’appaltatore (è una responsabilità complessa); si tratta di una responsabilità contrattuale “comune” verso il committente (è possibile, pertanto, risolvere il contratto per inadempimento ed ottenere l’esecuzione forzata degli obblighi di fare, oltre al risarcimento del danno). Sussiste, poi, una responsabilità contrattuale speciale verso il committente, ex art. 1667 c.c. e 1668 c.c. (è dubbio se si tratti di responsabilità oggettiva o per colpa, seppure la tesi prevalente è per la responsabilità colposa). Altresì, vi è una responsabilità speciale extracontrattuale (secondo giurisprudenza più recente) per gli immobili di lunga durata, ex art. 1669 c.c.; si tratterebbe di responsabilità extracontrattuale anche perché, pur presupponendo un contratto, vi sarebbero obbligazioni legali non derogabili dalle parti. Ovviamente, sussiste anche la responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., per danni arrecati a terzi. Dopo, si poteva entrare nel cuore del problema giuridico: l’azione di risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore, ex art. 1668 c.c., in favore del committente è soggetta alla prescrizione dell’azione prevista dall’art. 1667 c.c., oppure l’azione risarcitoria, essendo contrattuale, è soggetta alla prescrizione decennale? La prescrizione biennale, ex art. 1667 c.c., si riferisce solo all’azione ripristinatoria (come sembra desumibile dalla lettera della legge) ovvero è estensibile anche all’azione risarcitoria? La giurisprudenza più recente sul punto sembra aver optato per la tesi della prescrizione breve anche per l’azione risarcitoria, sul presupposto della eadem ratio. In particolare, secondo la giurisprudenza l’art. 1667 al pari dell’art. 1668 c.c. presenterebbero la medesima ratio giustificatrice, identificabile nel contemperamento dell’esigenza di tutelare da un lato, il diritto del committente ad ottenere un’opera immune da vizi e, dall’altro, l’interesse dell’appaltatore ad una sollecita definizione delle eventuali contestazioni nascenti da un suo presunto inadempimento. Se, pertanto, la ratio è la stessa, allora, la disciplina giuridica in concreto applicabile potrà essere la stessa, con la conseguenza giuridica che il termine breve ex art. 1667 c.c. sarà estensibile anche all’azione ex art. 1668 c.c. Ne segue, de plano, che nel caso di specie Marcello non avrà nulla da temere, in quanto l’eventuale azione risarcitoria in capo a Francesco sarà prescritta. Si consiglia di leggere le sentenza che segue. -La responsabilità per rovina e difetti di cose immobili prevista dall'art. 1669 c.c., nonostante sia collocata nell'ambito del contratto di appalto, configura un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE 109 (Presidente G. Losavio, Relatore L. Salvato) Sentenza 12 aprile 2006, n. 8520 Svolgimento del processo 1.- Il Comune di Murisengo (infra, Comune), con citazione notificata il 30 dicembre 1993 e l'11 gennaio 1994, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Casale Monferrato l'impresa A. G. (di seguito, Impresa), in persona del titolare, ed il geom. B.V.. Il Comune esponeva che nella notte tra il 3 ed il 4 marzo 1993 era crollato, lungo un fronte di circa 30 metri, il muro di cemento armato eretto a sostegno della scarpata retrostante la locale scuola media, realizzata dalla succitata impresa in virtù di contratto di appalto stipulato con esso istante. Il Comune deduceva che i tecnici incaricati di verificare le cause del crollo avevano riscontrato che era stato provocato dalla negligente realizzazione delle sezioni resistenti del muro, "ideato e disegnato in modo da contrastare la spinta della terra a monte, a seguito dello sbancamento avvenuto per far luogo alla costruzione dell'edificio scolastico, ma eseguito in modo da fare solo bella mostra di sè e poter essere contabilizzato" e precisava che in data 9 giugno 1993 aveva contestato ai convenuti questo accertamento. L'attore chiedeva che il Tribunale annullasse per dolo gli atti di collaudo e chiedeva la condanna di entrambi i convenuti al risarcimento dei "danni, da quantificarsi in corso di causa. Il Comune chiedeva altresì che fosse disposto accertamento tecnico preventivo e la relativa istanza era accolta, allo scopo di accertare lo stato, le caratteristiche e la consistenza del muro, nonchè la natura del crollo. Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio eccependo la prescrizione dell'azione proposta dal Comune e deducendo, nel merito, l'infondatezza della domanda. Il Tribunale adito, con sentenza del 5 febbraio 2001, non definitivamente pronunciando sulla domanda, dichiarava prescritta l'azione proposta nei confronti dell'Impresa, compensando tra le parti le spese del giudizio, e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio sulla domanda proposta nei confronti di B.V.. In particolare, il Tribunale riteneva prescritta l'azione di risarcimento danni proposta ai sensi dell'art. 1669 c.c., nei confronti dell'Impresa, rigettando la domanda di annullamento per dolo dell'atto di collaudo, in considerazione della sua natura non negoziale. 2.- Avverso la sentenza proponeva appello il Comune, chiedendo, in sua riforma, l'accoglimento della domanda. L'impresa si costituiva nel giudizio di secondo grado, contestando la fondatezza del gravame. La Corte d'appello di Torino, con sentenza dell'11 giugno 2002, rigettava l'appello, condannando il Comune a pagare le spese del secondo grado. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva che "il Comune di Murisengo ha esercitato, in primo grado, azione di "annullamento per dolo degli atti di collaudo" ed azione di "risarcimento dei danni in virtù delle garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 cod. civ." ed osservava che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c. ha natura extracontrattuale. Tuttavia, la sentenza impugnata escludeva che ciò comportasse l'applicabilità dell'art. 2947 c.c., in quanto la tesi così sostenuta dall'appellante "si fonda sul presupposto che "l'attore ha dedotto in giudizio una fattispecie di responsabilità extracontrattuale (penalmente sanzionata e sanzionabile) e il 110 giudice di primo grado non ne ha tratto le dovute conseguenze in tema di calcolo della prescrizione", avendo affermato che la prescrizione decorre dal compimento dei lavori; laddove - si sostiene - "poichè il fatto costituisce reato, essa (...) decorre dal giorno del crollo e per il combinato disposto degli artt. 449 e 157 cod. pen., n. 3 si compie nel 2003". Secondo il giudice d'appello, "della configurazione del fatto dedotto in giudizio (crollo del muro) come reato (...) mai ha parlato il Comune di Murisengo nella citazione introduttiva e nelle sue ulteriori difese di primo grado", avendo formulato questa prospettazione soltanto nella comparsa conclusionale. La Corte territoriale osservava che la sentenza penale, prodotta soltanto in secondo grado, aveva condannato l'appellato per avere "cagionato il crollo di parte del muro di sostegno di conglomerato di C.A. circostante la scuola media (...), crollo assolutamente prevedibile (...) e sul quale nessun effetto, causa o concausa impreveduta o imprevedibile ha giocato", precisando che l'impresa aveva rifiutato il contraddittorio "sulla pretesa risarcitoria fondata sulla prospettazione penalistica del fatto, eccependo la inammissibilità del mutamento della causa petendi irritualmente operata in tal modo dal Comune in questo grado". La sentenza impugnata negava che il "passaggio da una domanda ex art. 1669 (...) a una domanda ex art. 2043 c.c." comportasse una mera emendatici libelli, escludendo altresì la proposizione da parte del Comune di una domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c., pur ritenendola proponibile "quando non ricorrono le condizioni previste dall'art. 1669 cod. civ., come appunto il termine decennale tra l'esecuzione dell'opera e la sua rovina". In particolare, la Corte torinese osservava: a) "è sufficiente rileggere la narrativa e le conclusioni di citazione", riportate all'inizio della motivazione, "per constatare che la pretesa risarcitoria azionata dal Comune di Murisengo è stata fondata "sulle garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 cod. civ. nei riguardi dell'Impresa (cfr. atto di citazione pag. 2)" e che "la richiesta di risarcimento dei danni era esclusivamente riferita alle "causali di cui in narrativa" (cioè alla responsabilità dell'appaltatore per vizi dell'opera e per la rovina del muto), senza riferimento di sorta ad altri profili di responsabilità dell'impresa, in specie a profili penalistici riconducibili alla previsione di cui all'art. 449 c.p."; b) il delitto da ultimo richiamato richiede "che dal disastro contemplato sia derivato un danno effettivo alla pubblica incolumità, quantomeno il pericolo corso dalla stessa come conseguenza del disastro", mentre "nè l'atto di citazione, nè le ulteriori difese attoree di primo grado contengono il benchè minimo cenno" a detto pericolo non potendo "esservi identità fra il suddetto pericolo ed il fatto di danno lamentato dal Comune"", con la conseguenza che "inutile, pertanto, risulta la invocazione tardivamente proposta dall'appellante in questo grado dell'applicazione dell'art. 2043", affermata richiamando la sentenza di questa Corte n. 3338 del 1999"; c) "la norma generale sulla responsabilità per fatto illecito ( art. 2043 c.c.), in tanto può trovare applicazione (...), in quanto il danneggiato che la faccia valere deduca espressamente e dia prova di tutti gli elementi costitutivi di tale responsabilità", onere questo non assolto dall'appellante. In ordine all'azione di annullamento per dolo dell'atto di collaudo, la sentenza impugnata osservava, infine, che questa azione, avente "carattere prodromico rispetto alla suddetta azione contrattuale", non poteva trovare ingresso, non avendo il collaudo natura negoziale ed essendo inapplicabile l'art. 1324 c.c. al collaudo, "il quale non va confuso con la verifica" e che costituisce una dichiarazione tecnica, avente natura di dichiarazione di scienza alla quale non 111 sono applicabili i principi che governano le manifestazioni di volontà. 3.- Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il Comune, affidato a tre motivi; ha resistito con controricorso l'Impresa. Motivi della decisione 1.- Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 2043 cod. civ. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia", dolendosi che la Corte territoriale, "con illogica e incongrua motivazione", ha affermato che "avrebbe agito invocando la responsabilità di cui all'art. 1669 cod. civ. invece di quella di cui all'art. 2043 cod. civ.". A suo avviso, il giudice di secondo grado "invece di spiegare le ragioni per le quali ha ravvisato una "domanda ex art. 1669", si è limitato a motivare una presunta mutatio libelli" in appello, la cui affermazione avrebbe richiesto di esplicitare "il ragionamento preliminare che ha portato ad individuare quale fosse la domanda originaria", con conseguente insufficienza della motivazione sul punto. In ogni caso, i "singoli elementi del ragionamento" sarebbero caratterizzati da "inconcludenza e contraddittorietà", in quanto: a) relativamente all'obiezione concernente la configurazione del reato di cui all'art. 449 c.p., "l'attore non ha l'onere di ricordare al giudice che il fatto dedotto in citazione rientra in una fattispecie penale incriminatrice", dato che iura novit curia e la configurazione del fatto giuridico come reato attiene alla qualificazione giuridica del fatto, spettante al giudice; b) esso ricorrente ha agito deducendo il crollo del muro di sostegno della scarpata retrostante la scuola, sicchè non avrebbe dovuto sottolineare l'idoneità dell'accadimento a porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone, trattandosi di elemento implicito nel fatto dedotto; c) il riferimento alla "deduzione penale del fatto risulta fuori luogo", in quanto l'applicazione dell'art. 2043 c.c. prescinde dalla sussistenza della responsabilità penale del danneggiante; d) la Corte d'appello non "ha colto che la norma dell'art. 2947 c.c., u.c., disciplina il calcolo della prescrizione e non la qualificazione della domanda e che la stessa fu invocata (...) per evidenziare la scadenza del termine prescrizionale nell'anno 2003". Secondo il Comune, è erronea l'affermazione che "avrebbe tardivamente invocato la responsabilità di cui all'art. 2043 cod. civ.", dato che la stessa sentenza ricorda come, nella citazione, fosse stato dedotto "un comportamento doloso dell'Impresa Alessio consistito nell'esecuzione deliberatamente negligente delle sezioni resistenti del muro" e, alla pagina 2, da conto delle istanze istruttorie, dirette ad accertare i "dedotti fatti di dolo, frode, artifizi e raggiri" ed i comportamenti mistificatori dell'appellata nel realizzare l'opera. Dunque, è errata l'affermazione della mancata deduzione degli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c., avendo la sentenza omesso di riferire, in fatto, che tutte le istanze istruttorie erano state dedotte già in primo grado. Il ricorrente sostiene di avere agito per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dal crollo de quo, deducendo che gli accertamenti in sede amministrativa avevano dimostrato che era stato cagionato dalla condotta deliberatamente negligente dell'Impresa. Dunque, il crollo era avvenuto dopo il decorso dei termini delle azioni di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c. e proprio per questo "ha agito in giudizio deducendo quale causa petendi non il vizio in sè considerato, nè la presunzione di responsabilità dell'appaltatore posta dall'art. 1669 cod. civ. (...), ma la condotta negligente dell'Impresa costruttrice, in particolare ritenendola dolosa". In altri termini, agendo in giudizio ha dedotto "un quid pluris rispetto agli elementi tipici" 112 dell'azione ex art. 1669 c.c., univocamente espressivo dell'esperimento dell'azione aquiliana. Secondo il Comune, la Corte territoriale ha violato "il dovere di qualificare giuridicamente la domanda sulla base dei fatti dedotti dalla parte, indipendentemente dall'esattezza del nomen iuris", incorrendo in un vizio che non si esaurisce "nella illogicità e incongruità della motivazione" e configura un "error in procedendo per non aver il giudice pronunciato sulla domanda". Infine, conclude il ricorrente, l'ammissibilità dell'azione ex art. 2043 c.c. è confortata dalla sentenza n. 3338 del 1999 di questa Corte, risultando pacifico che era stata tempestivamente proposta con citazione del 31 dicembre 1993 in riferimento al crollo avvenuto il 4 marzo 1993. 1.1.- Il Comune, con il secondo motivo, denuncia "violazione falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia", deducendo che detta norma, nel testo applicabile nella specie ecioè anteriormente alla riforma realizzata con la L. n. 353 del 199 - permetteva la deduzione di nuove prove in secondo grado e poneva soltanto il divieto della mutatio libelli, con la conseguenza che, se pure fosse corretta l'affermazione che soltanto con l'atto di appello, per la prima volta, è stata invocata la responsabilità dell'Impresa ex art. 2043 c.c., la sentenza sarebbe comunque viziata. A suo avviso, la sentenza di secondo grado: a) è priva di motivazione in ordine alla configurabilità nella specie di una mutatio e non di una emendatio libelli; b) ha violato il principio secondo il quale la diversa prospettazione giuridica, ovvero la diversa qualificazione dello stesso petitum (nella specie, il risarcimento dei danni) non configura mutatio, senza chiarire perchè ha ritenuto che fosse stato alterato l'oggetto sostanziale dell'azione. Le argomentazioni svolte nel primo motivo, osserva il Comune, dimostrano che i presupposti di fatto dedotti in primo grado sono rimasti inalterati nel giudizio di secondo grado, mentre la sentenza penale è stata prodotta in secondo grado, "per sopperire all'inopportuno rifiuto del giudice di prime cure di istruire la causa". 1.2.- Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1442 e 1667 cod. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia", deducendo che, "ove si debba ritenere che, esaurita la possibilità di esperire la domanda di cui all'art. 1669 cod. civ., al danneggiato non competa l'azione generale di cui all'art. 2043 cod.civ.", il rimedio esperibile va rinvenuto "nella possibilità di annullare l'accettazione dell'opera ove conseguita a seguito di comportamenti dolosi dell'Impresa". Il ricorrente censura quindi il rigetto della domanda di annullamento del collaudo, sostenendo che "l'approvazione del collaudo (...) vale a dire l'accettazione dell'opera è dichiarazione di volontà (...) e non di scienza" e lamentando che la Corte territoriale non ha considerato che, con la citazione, non ha chiesto l'annullamento delle "operazioni di collaudo, ma degli atti di collaudo, vale a dire l'articolato procedimento di approvazione in cui si sostanzia l'accettazione dell'opera nei lavori pubblici". 2.- I primi due motivi, da esaminare congiuntamente perchè logicamente connessi, sono in parte fondati e vanno accolti per quanto di ragione, entro i limiti di seguito precisati. 2.1.- Nell'esame delle censure ha carattere preliminare la questione della compatibilità, quindi della ammissibilità, delle azioni ex art. 2043 c.c. e dell'art. 1669 c.c. rispetto al medesimo evento, che va risolta in senso affermativo, dando continuità al più recente orientamento di questa Corte. La responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c., secondo un principio ormai consolidato, nonostante sia collocata nell'ambito del contratto di appalto, 113 configura un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale la quale, pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini, essendo riconducibile ad una violazione di regole primarie (di ordine pubblico), stabilite per garantire l'interesse, di carattere generale, alla sicurezza dell'attività edificatoria, quindi la conservazione e la funzionalità degli edifici, allo scopo di preservare la sicurezza e l'incolumità delle persone (ex plurimis, tra le più recenti, Cass., n. 1748 del 2005; n. 1748 del 2000; n. 81 del 2000; n. 338 del 1999; n. 12106 del 1998). Da questa configurazione consegue l'ulteriore questione del rapporto tra le due disposizioni, risolto da questa Corte in virtù di un principio - di recente confermato, espressamente richiamato dal ricorrente, e che ha convincentemente superato un più risalente indirizzo - nel senso che l'art. 1669 c.c. reca una norma speciale rispetto a quella contenuta nell'art. 2043 c.c., risultando la seconda applicabile quante volte la prima non lo sia in concreto (Cass., n. 3338 del 1999; n. 1748 del 2005). La sentenza impugnata non si è discostata da detto indirizzo e la stessa controricorrente non lo ha contestato, non prospettando alcuna ragione in grado di giustificarne una rimeditazione, sicchè il principio va qui ribadito, in quanto sorretto da rigorose e convincenti argomentazioni. Al riguardo è sufficiente ricordare che "la natura di norma speciale dell' art. 1669 c.c. rispetto all'art. 2043 c.c. (...) presuppone l'astratta applicabilità delle due norme, onde, una volta che la norma speciale non possa essere in concreto applicata, permane l'applicabilità della norma generale", in virtù di una tesi coerente con le ragioni della qualificazione della responsabilità ex art. 1669 c.c. come extracontrattuale, consistenti nell'esigenza di "offrire ai danneggiati dalla rovina o dai gravi difetti di un edificio una più ampia tutela" (Cass., n. 3338 del 1999). infatti, come è stato bene osservato in dottrina, da detta configurazione si desume che l'art. 1669 c.c. non è norma di favore diretta a limitare la responsabilità del costruttore, ma mira a garantire una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale. Il legislatore ha con essa stabilito un più rigoroso regime di responsabilità rispetto a quello previsto dall'art. 2043 c.c., caratterizzato dalla presunzione juris tantum di responsabilità dell'appaltatore, che è stata tuttavia limitata nel tempo, in virtù di un bilanciamento tra le contrapposte esigenze di rafforzare la tutela di un interesse generale e di evitare che detta presunzione si protragga per un tempo irragionevolmente lungo. Pertanto, se la ratio dell'art. 1669 c.c. è quella di introdurre una più incisiva tutela, è coerente con la medesima l'applicabilità dell'art. 2043 c.c., nel caso in cui non sussistano le condizioni previste dalla prima norma, essendo in generale ammissibile la coesistenza di due azioni diversificate quanto al regime probatorio e potendo la parte agire non avvalendosi delle facilitazioni probatorie stabilite per una di esse. Una diversa soluzione va respinta, in quanto comporta una indebita restrizione dell'area di tutela stabilità dalla norma fondamentale in materia di responsabilità extracontrattuale e, in palese contrasto con l'armonia del sistema e con le ragioni alla base della previsione della disciplina speciale, conduce all'irragionevole risultato di creare "un regime di responsabilità più favorevole per i costruttori di edifici, perchè esclude ogni forma di responsabilità in situazioni che potrebbero ricadere nell'ambito - in linea di principio illimitato - dell'art. 2043 c.c., come nel caso di danno prodottosi oltre il decennio dal "compimento" dell'opera" (così, espressamente, Cass., n. 338 del 1999; analogamente, di recente, Cass., n. 1748 del 2005). L'azione ex art. 2043 c.c. è, dunque, proponibile quando in concreto non sia 114 esperibile quella dell'art. 1669 c.c., perciò anche nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera. Nell'ipotesi di esperimento dell'azione disciplinata dall'art. 2043 c.c. non opera, ovviamente, il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore, che lo onera di una non agevole prova liberatoria. Pertanto, in tal caso spetta a colui il quale agisce provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c. e, in particolare, anche la colpa del costruttore. 3.- Posto questo principio, va osservato che il ricorrente, con i mezzi in esame, censura la sentenza impugnata anzitutto perchè, "con illogica e incongrua motivazione", ha affermato che "avrebbe agito invocando la responsabilità di cui all'art. 1669 cod. civ., invece di quella di cui all'art. 2043 cod. civ." (pg. 5), dichiarando prescritto il diritto azionato. A suo avviso, la Corte territoriale erroneamente ha omesso di considerare che ha agito, "deducendo una precisa circostanza, vale a dire il crollo del muro" (pg. 7), prospettando "nella citazione di prime cure un comportamento doloso dell'impresa Alessio, consistito nell'esecuzione deliberatamente negligente delle sezioni resistenti del muro", per le ragioni in questo atto esposte, trascritte nel ricorso e riportate nella stessa pronuncia di secondo grado (pg. 8-9), nella parte in cui ha riprodotto le istanze istruttorie proposte nel giudizio innanzi al Tribunale. Secondo il Comune, "tutto si può dire, tranne che l'attore non avrebbe dedotto gli elementi costitutivi della responsabilità di cui all'art. 2043 cod. civ." (pg. 9), dato che ha invocato "quale causa petendi non il vizio in sè considerato, nè la presunzione di responsabilità dell'appaltatore posta dall'art. 1669 cod. civ. (...), ma la condotta negligente dell'impresa costruttrice, in particolare ritenendola dolosa" (pg. 10), evidenziando un "quid pluris (...) che segnalava che l'attore aveva proposto non una domanda ex art. 1669, ma l'azione aquiliana che spetta al danneggiato quando non ricorrono le condizioni previste dall'art. 1669 cod. civ., come appunto il termine decennale" da questa stabilito (pg. 11), sicchè la Corte territoriale sarebbe incorsa in un error in procedendo. 3.1.- La decisione delle censure così sintetizzate rende opportuno osservare che la sentenza impugnata ha affermato che il Comune ha proposto in primo grado "azione di risarcimento dei danni in virtù delle garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 cod. civ." (pg. 6), esplicitando che soltanto nella comparsa conclusionale, attraverso l'invocazione della responsabilità penale dell'impresa, avrebbe prospettato un diverso titolo, poichè "nè l'atto di citazione, nè le ulteriori difese attoree in primo grado contengono il benchè minimo cenno dell'eventuale pericolo corso dalla pubblica incolumità" ed agli elementi costitutivi del reato dell'art. 449 c.p. (pg. 8-9). La sentenza ha, quindi, ritenuto tardivamente proposta l'azione ex art. 2043 c.c., in quanto "la norma generale sulla responsabilità per fatto illecito in tanto può trovare applicazione nel caso concreto, in quanto il danneggiato che la faccia valere deduca espressamente e dia prova di tutti gli elementi costitutivi di tale responsabilità", ciò che ha escluso sia accaduto (pg. 9). 3.2.- La sintesi delle argomentazioni della pronuncia impone di ricordare che l'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, sicchè ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda non era stata proposta, siffatta statuizione, ancorchè erronea, non può essere direttamente censurata per violazione dell'art. 112 c.p.c.. Infatti, nel caso in cui il giudice del merito abbia svolto una motivazione sul punto, deducendo che una certa questione non possa ritenersi compresa tra quelle da decidere, il difetto di omessa pronuncia non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima 115 motivazione sia erronea. La sentenza non può pertanto essere annullata per omessa pronuncia se preliminarmente non si annulli quella parte di essa in cui si sono spiegate le ragioni che hanno indotto alla trattazione della questione e, in siffatta ipotesi l'errore del giudice attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte, censurabile sotto il profilo del vizio di motivazione di cui all'art. 350 c.p.c., n. 5 (per tutte, Cass., n. 11639 del 2004), come è appunto accaduto nella specie. Un recente orientamento, ricostruendo ed approfondendo compiutamente questo principio in relazione al contenuto del sindacato di questa Corte ed al profilo dell'esame degli atti processuali ha, inoltre, segnalato come questo esame debba essere condotto "nel caso in cui l'errata interpretazione si traduca in una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dettato dall'art. 112 cod. proc. civ., e, quindi, non solo di una errata interpretazione si tratti, ma di una errata interpretazione che abbia determinato una omessa pronuncia, o una pronuncia su una domanda non proposta" (Cass., n. 9471 del 2004, n. 1655 del 2005; cfr. anche Cass., n. 12909 del 2004; alla prima decisione può rinviarsi per un puntuale e completo richiamo delle ulteriori pronunce), che permette ed impone l'esame degli atti,vertendosi in tema di errar in procedendo. Infine, va ricordato che il giudice del merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni, dalla formula e dal nomen iuris adottati dalla parte, dovendo, piuttosto, tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa quale desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte, dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonchè del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta (tra le molte, Cass., Sez. un., n. 27 del 2000; Cass., n. 27428 del 2005; n. 21208 del 2005; n. 20322 del 2005; n. 15802 del 2005). 3.3.- Nel quadro di detti principi va osservato che la sentenza impugnata, nella narrativa, espone che il Comune, nell'atto di citazione, aveva dedotto, richiamando una relazione redatta dai suoi tecnici, che il crollo del muro era riconducibile al fatto che lo stesso era stato "eseguito in modo da fare solo bella mostra di sè e poter essere contabilizzato". La pronuncia da altresì atto delle istanze istruttorie con le quali il Comune aveva chiesto l'ammissione dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale, al fine di dimostrare che l'appaltatore non aveva realizzato le sezioni resistenti del muro "occultando la circostanza (...) e creando l'apparenza di averle eseguite" e che, unitamente al direttore dei lavori, aveva "fatto credere al collaudatore che le opere in questione ormai invisibili fossero state eseguite", insistendo per l'ammissione di c.t.u. onde accertare appunto la mancata edificazione delle sezioni resistenti del muro "con riferimento ai dedotti fatti di dolo, frode, artifizi e raggiri". Nonostante questa puntualizzazione, la pronuncia si sofferma tuttavia a verificare soltanto se il ricorrente avesse o meno dedotto la configurabilità del fatto come reato ed ha escluso che il Comune avesse proposto l'azione ex art. 2043 c.c., riconoscendo a questo fine rilevanza dirimente al profilo formale consistente nel fatto che la domanda era stata "fondata sulle "garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 cod. civ." e la richiesta di risarcimento dei danni "esclusivamente riferita alle "causali di cui in narrativa". Da questa considerazione la pronuncia ha desunto che non poteva ritenersi esperita l'azione dell'art. 2043 c.c., in quanto, questa norma è applicabile solo in quanto "il danneggiato che la faccia valere deduca espressamente e dia prova di tutti gli 116 elementi costitutivi di tale responsabilità". La sintetica motivazione svolta per escludere che la parte avesse dedotto una causa petendi corrispondente a quella che fonda la proposizione della domanda ex art. 2043 c.c., valutata alla luce dell'esposizione contenuta nella narrativa, della natura della responsabilità ex art. 1669 e 2043 c.c. e del rapporto tra le azioni fondate su dette norme ne palesa l'insufficienza. La conclusione non è sorretta da compiute, coerenti e congrue argomentazioni, tenuto conto della significativa precisazione, posta dalla stessa pronuncia, che il ricorrente aveva evidentemente dedotto una condotta illecita della Impresa puntualmente indicata nei suoi estremi oggettivi e soggettivi - produttiva di danni, chiedendo altresì di provare la colpa della convenuta. Le circostanze sono, infatti, sufficienti a palesare che il Comune, al di là del nomen iuris - privo di carattere vincolante (per tutte, Cass., n. 10922 del 2005; n. 3980 del 2004) - aveva dedotto tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e della realtà fattuale allo stesso corrispondente, quindi proposto la relativa azione. E ciò anche in considerazione delle istanze istruttorie, univocamente espressive, per oggetto e contenuto, dell'intento di non limitare l'azione a quella sola caratterizzata dal regime probatorio più favorevole, non avendo la Corte territoriale neppure precisato che le stesse sono state proposte per la prima volta in secondo grado. Inoltre, poichè il ricorrente con le censure in esame ha dedotto un error in procedendo nei termini dianzi precisati, in applicazione del principio sopra enunciato questa Corte può e deve prendere diretta cognizione degli atti, dai quali risulta che il Comune, nell'atto di citazione, aveva univocamente dedotto che la causa del crollo era dovuta alla negligente esecuzione delle sezioni resistenti del muro (...) eseguito in modo da fare solamente bella mostra di sè", deducendo il dolo dell'Impresa ed insistendo per la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni. Inoltre, in accoglimento dell'Istanza formulata con RG n. 30040/02; 1^ Sez. civ.; U.P. 9/02/06 l'atto introduttivo, il g.i., all'udienza del 23 febbraio 1994 aveva investito il c.t.u. del compito di descrivere "la natura fattuale del relativo crollo, in relazione ai fatti esposti in citazione, operando altresì tutti gli accertamenti necessari o utili a consentire alla successiva c.t.u. il giudizio sulle cause del crollo". Nel corso del giudizio di primo grado (introdotto anteriormente all'entrata in vigore delle modificazioni introdotte dalla L. n. 353 del 1990) il Comune aveva anche formulato le istanze istruttorie delle quali la sentenza impugnata ha dato atto, dirette a dimostrare la "mancata esecuzione delle sezioni resistenti del muro" ed a "permettere al Tribunale la valutazione degli elementi soggettivi in punto eventuale dolo, frode, artifizi e raggiri", nonchè la circostanza che l'Impresa ciò aveva fatto "occultando la circostanza (...) e creando l'apparenza di averle eseguite" e, insieme al direttore dei lavori, ha "fatto credere al collaudatore che le opere fossero state eseguite". La valutazione del contenuto sostanziale della situazione dedotta in giudizio, da valutare ed apprezzare anche alla luce della natura della responsabilità ex art. 1669 c.c. e del rapporto esistente tra la relativa azione e quella dell'art. 2043 c.c. e della tendenziale omogeneità della situazione che le fonda, quali sopra precisate, rende chiara l'evocazione, quale titolo della pretesa, di un fatto illecito ascritto all'Impresa, formulata esplicitando la consapevolezza dell'onere probatorio da essa conseguente e, dunque, chiaramente deducendo una pretesa fondata anche sulla norma dell'art. 2043 c.c.. Nell'atto di appello, il ricorrente ha, inoltre, conseguentemente invocato il principio secondo il quale "l'ascrivibilità della responsabilità dell'art. 1669 cod. civ. non fa giammai venir meno l'applicabilità della norma generale di cui all'art. 2043 cod. civ.", insistendo nella prospettazione della situazione e dei fatti sostanziali - in 117 definitiva, della causa pretendi - che imponevano di ritenere proposta in primo grado anche l'azione ex art. 2043 c.c.. Pertanto, la Corte d'appello ha inesattamente ritenuto nuova la domanda ex art. 2043 c.c., non decidendola nel merito, risultando dunque fondate in questa parte le censure del Comune, che vanno accolte, restando assorbite le ulteriori censure formulate nei mezzi in esame ed il terzo motivo. In conclusione, i primi due motivi, entro, i limiti precisati, vanno accolti restando assorbito il terzo motivo - e conseguentemente la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Torino che, in diversa composizione, procederà al riesame della causa, attenendosi ai principi sopra enunciati, provvedendo altresì sulle spese della presente fase ( art. 385 c.p.c., comma 3). P.Q.M. La Corte accoglie per quanto di ragione i primi due motivi del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2006. Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2006. RESPONSABILITA’ DEL MEDICO TRACCIA Tizio è medico chirurgo presso l’ospedale Raffo di Milano. Caia nel dicembre 2005 si ricoverava presso il suddetto ospedale, per la rimozione di un tumore uterino; Tizio spiegava a Caia di dover procedere ad un intervento chirurgico di laparostectomia ed annessiectomia bilaterale. Caia acconsentiva a tale intervento, firmando il documento relativo al consenso. Accadeva, poi, che Tizio procedeva sia all’intervento chirurgico, per il quale aveva avuto il consenso, e sia ad un trattamento radioterapico (anche prolungato nel tempo) ritenuto necessario per la completa asportazione del tumore. L’operazione andava bene e Caia, nel febbraio 2006, veniva dimessa dall’ospedale Raffo. Caia decideva di recarsi da un avvocato, ritenendo di aver subito un torto, in quanto le era stata fatta una terapia per la quale non aveva prestato il consenso, nonostante la conclusione positiva dell’operazione. Il candidato rediga motivato parere sulla questione giuridica proposta. POSSIBILE SCHEMA DI SOLUZIONE In premessa poteva essere utile ricostruire sinteticamente il fatto. Successivamente poteva essere utile accennare alla tipologia di responsabilità del medico. Secondo la ricostruzione classica, il medico risponde in via extracontrattuale verso il paziente ed in via contrattuale verso l’ospedale; di recente, attraverso 118 l’esaltazione della tesi della responsabilità da contatto sociale qualificato, si va affermando la ricostruzione della responsabilità del medico verso il paziente come “da contatto” e, quindi, contrattuale. E’ possibile agire in via risarcitoria verso il medico che non informa adeguatamente la paziente sulle operazioni che andrà a svolgere, anche se necessarie? Può sussistere un danno risarcibile derivante dal solo mancato consenso, indipendentemente dall’esito positivo dell’operazione (anche secondo la migliore scienza e tecnica medica)? La tesi classica rispondeva negativamente, in quanto prevaleva la ricostruzione della risarcibilità dei soli danni patrimoniali e per quelli non patrimoniali era necessaria la sussistenza del reato in concreto, ex art. 2059 c.c. (come interpretato prima delle note sentenze gemelle del 2003 sul danno esistenziale); nel caso di informazioni inesatte da parte del medico verso il paziente con esito positivo dell’operazione, si diceva, non vi è un danno al patrimonio o un reato, per cui nulla è dovuto al paziente, tanto più che la mera violazione di una forma ex se, quale era quella del consenso, non può giustificare un’azione di risarcimento del danno che richiede, al contrario, una danno reale: se la violazione della forma non cagiona danni effettivi, nulla dovrà essere risarcito. Invero, la giurisprudenza più recente sembra essersi orientata in senso contrario; in particolare, vi è una tendenza evolutiva ad ammettere anche il risarcimento del danno per violazione della disciplina sul consenso. In particolare, si dice, il medico che non comunica tutte le informazioni necessarie al paziente viola un obbligo specifico di informativa verso il paziente stesso, derivate dal contatto (o contratto) tra medico e paziente, con il corollario giuridico che si realizza un vero e proprio inadempimento, ex art. 1218 c.c., di cui il medico dovrà rispondere; id est, non chiedere il consenso per tutte le operazioni, vuol dire, violare un obbligo specifico di trasparenza vero il paziente, tanto più che si agisce senza la giustificazione formale del consenso e, perciò, in modo arbitrario ed illegittimo: eccedere nei limiti del consenso vuol dire compiere un’attività illecita (qualcuno parla di illecito contrattuale). D’altronde, la nuova visione prospettica inaugurata con le sentenze gemelle del 2003 serve proprio ad ammettere il risarcimento di quei danni che ledono diritti costituzionali, come la libertà di autodeterminazione, così che l’art. 2059 c.c., letto in combinato disposto con i principi costituzionali di libertà personale, danno vita ad una responsabilità in capo a chi vulnera tali principi. In questo senso, allora, nel caso di specie, Caia potrebbe agire per il risarcimento del danno verso il medico Tizio (eventualmente anche verso l’ospedale Raffo), alla luce degli orientamenti giurisprudenziali più recenti ed in virtù dell’art. 2059 c.c. letto in combinato disposto con i valori costituzionali. Si tratterebbe, in fondo, di un danno esistenziale da liquidarsi in via equitativa, prendendo le mosse principalmente dalle tabelle del danno biologico (ovvero, usando la c.d. equazione Liberati). Si consiglia di leggere le sentenze che seguono. -Se viene realizzata un’operazione non consentita, indipendentemente dall’esito, vi è danno risarcibile per violazione della libertà di 119 autodeterminazione Corte di cassazione civile sentenza 5444/06 del 14/03/2006 Svolgimento del processo 1. Con citazione notificata il 20 dicembre 1997 C. A. conveniva in giudizio, avanti al tribunale di Sanremo l'Azienda Usl n.1 Imperiese per sentirla condannare al risarcimento dei danni riportati a seguito di un trattamento radioterapico che le era stato praticato presso l'Ospedale di Sanremo dal 2 dicembre 1992 all'8 gennaio 1993, quale terapia complementare di un intervento chirurgico di laparostectomia ed annessiectomia bilaterale, eseguito nel precedente mese di agosto presso lo stesso nosocomio per la rimozione di un tumore uterino. La convenuta si costituiva contestando la domanda e chiedeva di chiamare in causa la Compagnia NXXX di Assicurazioni Spa, la RXXX Riunione Adriatica di Sicurtà e i dottori G. L. e D. S., che avevano curato, separatamente ed in due periodi successivi, il trattamento radiologico, per esserne manlevata per il caso di soccombenza. Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano entrambe le società assicuratrici, la RXXX adducendo che la polizza assicurativa per la responsabilità civile stipulata con la convenuta era venuta a scadere il 31 dicembre 1992 e la Compagnia NXXX sostenendo che la propria polizza aveva effetto dalle ore 24 del 31 dicembre 1992 e, pertanto, non poteva coprire i danni cagionati a terzi in epoca anteriore. Si costituiva, inoltre, lo S., che contestava la domanda in rito e nel merito, mentre non si costituiva la L., che veniva dichiarata contumace. All'esito dell'espletata istruzione, il Tribunale, con sentenza del 9 giugno 2000, riconosciuta una responsabilità per violazione del c.d. consenso informato (ed esclusa, invece, una responsabilità per negligenza nell'esecuzione degli interventi), condannava la convenuta a risarcire il danno nella misura di lire 651.998.640 (oltre accessori e spese) e, accogliendo le relative domande di manleva, condannava D. S., la RXXX e la Compagnia NXXX a tenere indenne la convenuta dalla soccombenza nelle rispettive misure del 20, del 15 e del 50%. Dichiarava, invece, il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di manleva nei confronti dellaL. a beneficio della giurisdizione della Corte dei Conti. 1.1. La sentenza veniva appellata in via principale dalla AUSL nei confronti di tutte le parti, con richiesta in via principale di rigetto della domanda risarcitoria della A.i ed in via subordinata di riduzione dell'ammontare del danno liquidato, nonché di condanna dei chiamati in garanzia (ivi compresa la L. nel presupposto che sussistesse la giurisdizione dell'A.G.O.), in solido o per come accertato, a tenerla indenne da quanto liquidato a titolo risarcitorio alla A.. Nel giudizio di appello si costituivano tutte le parti. La A., oltre a contestare la fondatezza dell'appello, svolgeva anche appello incidentale per il mancato riconoscimento del danno patrimoniale e per l'inadeguatezza del danno biologico liquidato dal tribunale. La L. si costituiva eccependo tra l'altro in via pregiudiziale la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e della conseguente declaratoria della sua contumacia. La Compagnia NXXX di Assicurazioni deduceva che i fatti e/o comportamenti dannosi che il Tribunale aveva accertato esclusivamente sotto il profilo della violazione del c.d. consenso informato della paziente si erano verificati anteriormente alla decorrenza della polizza assicurativa di sua pertinenza, chiedeva in subordine ridursi la 120 manleva addebitatagli dal primo giudice, e faceva comunque propri ì motivi dedotti dall'AUSL. La RXXX, oltre a contestare la sussistenza della responsabilità della sua assicurata sotto il profilo che i due sanitari avevano prestato la loro opera a titolo di lavoro autonomo, faceva proprie anch'essa le difese dell'AUSL. Lo S. faceva presente di aver proposto appello principale, del quale otteneva la riunione con quello dell'AUSL e, oltre a sostenere che anche nei suoi confronti difettava la giurisdizione dell'A.G.O., contestava la propria responsabilità in relazione alla mancata assicurazione del consenso informato. 1.2. Con sentenza del 21 marzo 2002 la Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aumentava l'importo del danno già riconosciuto dal Tribunale alla A. a titolo di danno morale, liquidando il danno complessivo nella misura di lire 704.998.640 e condannando la AUSL al pagamento della differenza; rigettava la domanda di manleva dell'AUSL nei confronti di D. S., condannandola alla restituzione al medesimo della somma che aveva dovuto corrispondere in forza della sentenza di primo grado, confermava le condanne in manleva della Compagnia NXXX di Assicurazioni e della RXXX, estendendole, rispettivamente al 50% ed al 15%, sia del maggior importo riconosciuto per il danno morale, sia dell'importo di cui la sentenza di primo grado aveva gravato lo S.; dichiarava, inoltre, la nullità della notificazione della citazione introduttiva, del giudizio di primo grado nei confronti della L. e del giudizio relativamente alla domanda dell'AUSL nei confronti della stessa, e, in applicazione dell'articolo 354 Cpc previa “separazione dei relativi atti”, rimetteva detta domanda avanti al primo giudice. 2. La sentenza, per quello che ancora in questa sede interessa, si fonda sulle seguenti ragioni: l'obbligo di informazione circa l'incertezza degli esiti migliorativi della terapia e la gravità delle possibili sue complicanze doveva ritenersi gravare non sul sanitario dell'Istituto Tumori di Milano, che l'aveva solo proposta «in virtù della superiore competenza in merito alla patologia specifica» della A., bensì sul medico specialista incaricato dall'Ente sanitario di sovrintendere al trattamento radioterapico; la mancanza dell'adempimento dell'obbligo di informazione da parte di tali sanitari e segnatamente della dott.ssaL. (che aveva eseguito la terapia radiante per un primo periodo) era risultata dalla testimonianza del teste F. S. , marito della A. (in regime di separazione dei beni), il quale aveva riferito che la medesima, «qualche giorno prima dell'inizio del trattamento radiologico, aveva avuto un colloquio con la dott.L., la quale si era limitata a raccogliere i dati anamnestici della paziente senza dare alcuna informazione sul trattamento radiologico salvo l'affermazione che quest'ultimo avrebbe, al più, potuto aumentare la stipsi; pur tenendo conto del legame coniugale la valutazione positiva espressa dal primo giudice [andava] condivisa in quanto [trattatasi] di deposizione provvista di linearità ed intrinseca coerenza, in particolare se confrontata con [la] assai debole ed incerta contestazione offerta sul punto, in questo grado, dalla comparsa di costituzione dellaL. […], laddove [rectius là dove] la comparente [aveva contestato) che l'obbligo di informativa fosse a suo carico ripromettendosi comunque di dimostrare in corso di causa di avere sempre avuto “quale sua consuetudine professionale, di informare tutti i propri pazienti e i loro parenti sulle finalità del trattamento nonché sulle possibili conseguenze acute e croniche derivanti dall'uso di terapie d'urto quale la radioterapia” e di avere informato anche la A. davanti a testimoni di ogni possibile esito dannoso potenzialmente connesso alla terapia (senza peraltro indicare i tali testi. Un preciso riscontro emerge[va] altresì dall'esito negativo degli accertamenti svolti al riguardo dal CTU (cfr. relazione del 121 CTU pag. 9)»; sulla base di tali ragioni doveva respingersi il motivo di appello dell'AUSL sul punto; le prestazioni eseguite dallaL. e dallo S., sia pure per ragioni diverse, dovevano ritenersi espletate in regime di attività libero-professionale, ma ciò non escludeva che l'AUSL dovesse ritenersi responsabile (a titolo di responsabilità contrattuale), in quanto ad essa si era rivolta la paziente per ottenere la prestazione specialistica e l'AUSL aveva soddisfatto la richiesta mettendo a disposizione la propria struttura ospedaliera e la relativa organizzazione di personale e di mezzi, essendosi concluso un contratto di prestazione professionale nel momento in cui la paziente era stata accettata nell'ospedale; relativamente alla rivalsa esercitata dall'AUSL contro lo S., avendo il medesimo eseguito la terapia dal 23 dicembre 1992 all'8 gennaio 1993, cioè per undici sedute su venticinque complessive, in prosecuzione del trattamento iniziato dalla L. il 2 dicembre, secondo un programma terapeutico già dalla stessa predisposto, doveva ritenersi che dette modalità esecutive escludessero «un coinvolgimento del predetto sanitario nella responsabilità per omessa informativa», in quanto l'obbligo di informazione assumerebbe rilievo nella fase precontrattuale di formazione del consenso del paziente al trattamento o all'intervento, mentre un'estensione alle fasi successive si potrebbe ipotizzare solo allorquando «tali fasi assumano una propria autonomia gestionale e diano luogo a scelte operative diversificate comportanti rischi diversi», ipotesi che non ricorrevano a proposito della prestazione dello S.; doveva, dunque, rigettarsi per tali ragioni la pretesa di rivalsa nei suoi riguardi, ma ciò non escludeva che il trattamento fosse antigiuridico in ragione della violazione dell'obbligo di informazione per tutta la sua durata, cioè sino alla sua conclusione in dipendenza dell'assenza del consenso informato iniziale della paziente, onde (contrariamente a quanto aveva sostenuto la compagnia assicuratrice) restava ferma l'operatività della polizza stipulata dalla AUSL con la NXXX Assicurazioni decorrente dal 1 gennaio 1993. 3. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione in via principale, affidandolo a sei motivi, l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 Imperiese contro F. S. e D. B. , quale eredi di C. A., frattanto deceduta, nonché contro la Compagnia NXXX di Assicurazioni s.p.a., la Riunione Adriatica di Sicurtà (Ras) e lo S.. Il ricorso, viceversa, non è stato proposto contro la L.. Tutti gli intimati hanno resistito con controricorso e la NXXX Assicurazioni ha anche proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi. Lo S. e l'AUSL hanno depositato memorie ai sensi dell'articolo 378 Cpc. Motivi della decisione 1. Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso incidentale e di quello principale. 2. Con il primo motivo di ricorso l'AUSL lamenta “violazione o falsa applicazione di norme di diritto (articoli 102 e 354 Cpc, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3 Cpc)”, assumendo che la Corte territoriale non avrebbe potuto disporre la separazione del procedimento contro la L. relativamente alla domanda di manleva nei suoi confronti proposta, in quanto ricorreva una fattispecie di litisconsorzio necessario. La corte genovese avrebbe dovuto, invece, in ragione della rilevata nullità della notificazione della citazione, rimettere tutta la controversia al primo giudice, ai sensi dell'articolo 354 Cpc [viene citata Cassazione 4020/85]. La separazione dei giudizi potrebbe, del resto, determinare contraddittorietà di giudicati ove la L. provasse, avanti al tribunale, di avere acquisito il consenso informato. 52.1. Il motivo non è fondato per le ragioni che seguono. Va anzitutto premesso che a seguito della proposizione, con l'atto di chiamata in 122 causa, della domanda di manleva da parte della ricorrente contro la L., per il caso di soccombenza nei riguardi della A., si determinò un litisconsorzio successivo facoltativo per effetto della tecnica della chiamata in causa di cui all'articolo 106 Cpc, secondo una di quelle ipotesi che vengono ricondotte alla chiamata in garanzia c.d. impropria. In particolare, l'ipotesi che si verificò nella specie è riconducibile al caso del convenuto che prospetta l'esistenza di una situazione che identifica un terzo come vero responsabile sul piano passivo della pretesa fatta valere dall'attore e, senza postulare di sottrarsi, in forza di essa, alla responsabilità evocata dall'attore, chiede, per il caso di riconoscimento della pretesa di quest'ultimo nei suoi confronti, soltanto di essere tenuto indenne dal terzo dalle conseguenze di tale soccombenza e per tale ragione chiede di chiamarlo nel giudizio. Il chiamante in questo caso non rigetta la sua legittimazione sostanziale, ma, per il caso che sia riconosciuta fondata verso di lui, assume che il terzo ne dovrà sopportare le conseguenze. La domanda contro il terzo potrebbe essere proposta dal convenuto anche successivamente all'esito per lui sfavorevole del giudizio sulla domanda principale, ma il convenuto - volendo impedire che il terzo, ove evocato separatamente e successivamente, contesti l'accertamento sulla domanda principale che ha portato all'esito sfavorevole le cui conseguenze si vogliono su di lui riversate in rivalsa sfrutta, sulla base all'articolo 106 Cpc, la possibilità di far svolgere il processo sulla domanda di manleva cumulativamente e congiuntamente al processo sulla domanda principale, al fine di ottenere che, ove l'esito del giudizio sulla prima sia sfavorevole, il terzo sempre, naturalmente, che sia riconosciuta fondata la domanda di garanzia - non possa metterlo in discussione e, quindi, non possa contestare il presupposto della garanzia. Il giudizio sulla domanda principale e quello sulla domanda di garanzia restano, in tal caso, distinti e sono suscettibili di separazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 103 Cpc, ove di tale norma ricorrano i presupposti (si vedano, in termini, Cassazione 2986/97; Cassazione 2866/97, in motivazione). Si resta in presenza, quindi, di una situazione di cumulo riconducibile alla nozione di litisconsorzio facoltativo quanto al modo di svolgimento e semmai, soltanto in sede di impugnazione, sì può verificare la necessità di mantenere il cumulo fra le due cause, qualora l'esito degli accertamenti nel grado precedente sulle due cause cumulate e le ragioni di impugnazione diano luogo ad una situazione di dipendenza fra le cause (ai sensi dell'articolo 331 Cpc). E' da rilevare, d'altro canto, che, a seguito della proposizione della domanda di manleva, nessun ulteriore allargamento delle domande oggetto del giudizio ebbe a verificarsi sotto il profilo della proposizione di una nuova domanda da parte dell'attrice originaria verso la chiamata in causa, con postulazione della responsabilità alternativa (rispetto a quella dell'AUSL) e/o concorrente della L.. Nel primo caso, cioè di invocazione di una responsabilità alternativa, si sarebbe verificato un collegamento fra la domanda originaria e quella introdotta contro la L. secondo un nesso di incompatibilità, per cui la fondatezza dell'una domanda avrebbe escluso quella dell'altra, e si sarebbe configurata una fattispecie di cd. litisconsorzio necessario successivo (o “processuale” o “unitario”), sì che la trattazione avrebbe dovuto seguire secondo le regole di svolgimento del litisconsorzio necessario iniziale supposte dall'articolo 102 Costituzione e le cause, nonostante l'apparente generalizzazione della regola dell'articolo 103, secondo comma, Cpc, al litisconsorzio facoltativo (iniziale), non sarebbero state separabili e in sede di impugnazione sarebbero state inscindibili (ai sensi dell'articolo 331 Cpc) , e ciò non diversamente da quanto accade allorquando il 123 convenuto si difenda egli stesso “rigettando” la propria legittimazione passiva ed adducendo quella di un terzo e, dopo averlo chiamato in causa, l'attore “estenda” la sua domanda nei confronti di quest'ultimo (estensione che, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, si verificherebbe anzi in ogni caso per effetto del “rigetto” della legittimazione passiva: conclusione questa sulla cui validità contestata dalla dottrina non è luogo qui a soffermarsi). Nel secondo caso, cioè di invocazione di una responsabilità concorrente e dell'AUSL e della L., si sarebbe, invece, realizzata una situazione di litisconsorzio facoltativo non dissimile da quella che nasce fin dall'inizio del processo, allorquando si invochi nei confronti di più responsabili una responsabilità solidale e semmai un possibile litisconsorzio necessario quanto allo svolgimento (c.d. litisconsorzio “unitario” o “necessario successivo” o “processuale”) si sarebbe potuto configurare in ragione della esistenza di una pretesa di rivalsa dell'AUSL verso laL., che, naturalmente, dipendeva nella sua esistenza od estensione dall' accertamento della responsabilità concorrente di entrambi, postulato con l'estensione della domanda da parte della Agnesi. Senonché, è pacifico che nessuna delle due ipotesi ora dette si è verificata e, quindi, va ribadito che nel corso dello svolgimento del giudizio di primo grado la situazione del cumulo fra la domanda principale e quella di rivalsa dell'AUSL rimase caratterizzata nel senso della facoltatività del litisconsorzio anche quanto al modo di svolgimento, ben potendo trovare applicazione la regola del secondo comma dell'articolo 103 Cpc. 2.2. Una volta pronunciata la sentenza di primo grado, il cumulo di domande in questione rimase connotato nel senso della scindibilità, in quanto la decisione sulla domanda di rivalsa nel senso del rigetto per una ragione il preteso difetto di giurisdizione esclusivamente inerente il rapporto giuridico dedotto dall'AUSL contro la L. , si connotò come decisione del tutto indipendente da quella sulla domanda principale e, pertanto il cumulo fra le due domande, all'atto dell'impugnazione della sentenza si presentava come scindibile ai sensi dell'articolo 332 Cpc e soltanto all'AUSL competeva realizzare il cumulo nuovamente proponendo impugnazione tanto relativamente al rapporto principale inerente la responsabilità, nei confronti della A. , quanto relativamente al rapporto inerente la pretesa di rivalsa. Avendo proposto entrambe le impugnazioni, l'AUSL mantenne il cumulo realizzatosi in primo grado, ma pur sempre come cumulo riconducibile alla nozione di scindibilità fra le cause. Sussistendo tale situazione è di tutta evidenza che il giudice d'appello, una volta rilevata la nullità della citazione introduttiva della domanda di manleva dell'AUSL contro la L., ben poteva dar corso all'applicazione dell'articolo 354 Cpc e, quindi, alla rimessione al primo giudice soltanto della controversia ad essa relativa fra dette parti, separandola dalla domanda principale. Solo se fosse sussistita una situazione di inscindibilítà della cause o di dipendenza fra esse (quest'ultima ipotesi si sarebbe potuta verificare se la domanda di rivalsa in primo grado fosse stata accolta nel merìto), la constatazione della nullità della notificazione avrebbe dovuto comportare la rimessione di tutta la causa al primo giudice. Legittimamente, invece, il giudice d'appello ha rimesso solo la causa di manleva al primo giudice. 2.3. Va rilevato a questo punto che, una volta riguardato rispetto all'esercizio del diritto di impugnazione da parte dell'AUSL in Cassazione, la caratterizzazione del nesso fra le cause nel senso della scindibilità (conseguente ancora una volta all'essere stata adottata sulla domanda di rivalsa una decisione in rito e, quindi, del tutto indipendente da quella sulla domanda principale) comportava che il cumulo 124 fra le due cause potesse essere mantenuto esclusivamente dall'AUSL attraverso l'esercizio del diritto di impugnazione. Senonché l'AUSL non ha esercitato il potere di ricorrere in cassazione avverso la statuizione della sentenza d'appello relativa alla rimessione al primo giudice della causa di rivalsa. Il ricorso, infatti, non indica formalmente come parte (articolo 366, n. 1 Cpc) l aL. e nemmeno risulta al di là della mancanza di indicazione formale notificato e, quindi, nella sostanza proposto, contro la L.. In tale situazione, sempre per il carattere di scindibilità del cumulo pur a seguito della decisione del giudice d'appello qui impugnata è applicabile l'articolo 332 Cpc ma, poiché rispetto alla L. è ormai ampiamente esclusa l'impugnazione per il decorso dei relativi termini, questa Corte non deve nemmeno in alcun modo provvedere ad ordinare la notificazione del ricorso alla medesima. 3. Con il secondo motivo si deduce “violazione o falsa applicazione di norme di diritto (articoli 1218, 1223 e/o 2056 Cc in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3 Cpc)”, adducendosi che, essendo la consulenza tecnica d'ufficio pervenuta alla conclusione che nessuna imprudenza, negligenza e, quindi, colpa fosse addebitabile ai medici, non sarebbe configurabile alcun danno come conseguenza di una condotta professionale colposa e, pertanto, non sarebbe necessario accertare l'esistenza del consenso informato. Esso avrebbe dovuto essere acquisito semmai dal sanitario dell'Istituto Tumori di Milano, Prof. D. R. , che aveva ordinato la terapia radiante. Le norme invocate prevederebbero una responsabilità limitata alle conseguenze immediate e dirette della condotta dell'agente, mentre la Corte territoriale sarebbe andata oltre, in quanto, “l'attrice era malata di un grave tumore, la radio terapia costituiva una cura tipica e corretta, le complicazioni sino al decesso si sarebbero inevitabilmente verificate, addebitare integralmente alla esponente il degrado fisico, sulla base delle c.d. tabelle milanesi previste per persone in normali condizioni, [sarebbe) giuridicamente errato”. 3.1. Anche questo motivo non merita accoglimento. Esso si scinde in due diverse censure. La prima è espressa adducendosi che l'assenza di un comportamento colpevole dei sanitari della struttura ospedaliera nell'esecuzione del trattamento escluderebbe la violazione dell'obbligo del c.d. consenso informato. La seconda nel senso che in ogni caso la violazione di quell'obbligo sarebbe addebitabile al sanitario che aveva prescritto alla A. il trattamento. La prima censura è priva di pregio, in quanto la responsabilità del sanitario (e di riflesso della struttura per cui egli agisce) per violazione dell'obbligo del consenso informato discende dalla tenuta della condotta omissiva di adempimento dell'obbligo di informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente venga sottoposto e dalla successiva verificazione, in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso di causalità con essa, di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, mentre, ai fini della configurazione di siffatta responsabilità è del tutto indifferente se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno, svolgendo rilievo la correttezza dell'esecuzione agli effetti della configurazione di una responsabilità sotto un profilo diverso, cioè riconducibile, ancorché nel quadro dell'unitario “rapporto” in forza del quale il trattamento è avvenuto, direttamente alla parte della prestazione del sanitario (e di riflesso della struttura ospedaliera per cui egli agisce) concretatesi nello svolgimento dell'attività di esecuzione del trattamento. La correttezza o meno del trattamento, infatti, non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell' illecito per violazione del consenso informato, in quanto è 125 dal tutto indifferente ai fini della configurazione della condotta omissiva dannosa e dall'ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione, non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, con la conseguenza che, quindi, tale trattamento non può dirsi avvenuto previa prestazione di un valido consenso ad appare eseguito in violazione tanto dell'articolo 32 comma secondo della Costituzione, (a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), quanto dell'articolo 13 della Costituzione, (che garantisce l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica), e dall'articolo 33 della legge 833/78 (che esclude la possibilità d'accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità; ex articolo 54 Cp), dando la lesione della situazione giuridica del paziente inerente alla salute ed all'integrità fisica per il caso che esso, a causa dell'esecuzione del trattamento, si presentino peggiorate. Per converso, sul piano del danno conseguenza, venendo in considerazione il mero peggioramento della salute e dell'integrità fisica del paziente, rimane del tutto indifferente che la sua verificazione sia dovuta ad un'esecuzione del trattamento corretta o scorretta. La seconda censura è anch'essa priva di fondamento, in quanto i sanitari dell'AUSL, nel sottoporre al trattamento la A., hanno accolto e dato corso alla sua richiesta, agendo quali organi dell'AUSL, senza essere in alcun modo vincolati alla prescrizione della terapia fatta dallo specialista cui la medesima si era rivolta e, quindi, avendo effettuato una scelta del tutto autonoma erano gravati dell'obbligo di informazione circa le sue conseguenze, come esattamente ha ritenuto la Corte territoriale. L'obbligo del consenso informato, infatti, è a carico del sanitario che, una volta richiesto dal paziente dell'esecuzione di un determinato trattamento, decide in piena autonomia secondo la lex artis di accogliere la richiesta e di darvi corso, a nulla rilevando che la richiesta del paziente discenda da una prescrizione di altro sanitario. 4. Con il terzo motivo si deduce “‘violazione o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 2697 Cc in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3 Cpc)”, sotto il profilo che l'impugnata sentenza non avrebbe tenuto conto che l'onere di dimostrazione dell'inadempimento da parte del professionista dell'obbligo di informazione, che era a carico della A., non era stato da costei adempiuto. Infatti, avendo l'unico teste escusso sul punto, cioè il marito della A., S. F. (“verosimilmente privo della necessaria attendibilità”) riferito che la dott.ssa L., aveva fatto presente i rischi di stipsi, la Corte territoriale, avendo nella citazione introduttiva del giudizio la A. lamentato l'insorgere di un'occlusione intestinale foriera di gravi conseguenze, avrebbe dovuto constatare che occlusione intestinale e stipsi sono sinonimi e che, quindi, il consenso informato era stato acquisito. Pertanto, la domanda non avrebbe dovuto essere accolta, perché carente di prova. 4.1. Il motivo è privo di pregio. Non è dato, infatti, comprendere in che modo l'assunta mancata considerazione da parte della Corte d'Appello della pretesa sinonimia fra la stipsi e l'occlusione intestinale dovrebbe avere integrato la violazione della norma sull'onere della prova, denunciata ai sensi del n. 3 dell'articolo 360. L' omessa valutazione della circostanza della suddetta sinonimia, ove quest'ultima fosse effettivamente configurabile e percettibile a prescindere da speciali cognizioni tecniche non esigibili dal giudice del merito, si potrebbe semmai 126 considerare come mancata valutazione di un fatto notorio di natura tecnica e, quindi, foriera di un vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi del n. 5 dell'articolo 360 Cpc. Ove, invece, non si trattasse di notorio tecnico la cui conoscenza fosse esigibile anche dal giudice di merito, bensì di una circostanza che si sarebbe far dovuta constare nel giudizio di merito attraverso opportuna attività probatoria tecnica, si sarebbe in presenza di una circostanza della quale, in assenza di esame da parte della sentenza impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto indicare nel ricorso la sede processuale nella quale trovava riscontro, sempre agli effetti della deduzione del vizio di cui al citato n. 5 dell'articolo 360. Fermo che un simile vizio non è stato denunciato né sotto l'uno né sotto l'altro profilo e che tanto basta a rendere il motivo inconferente (perché, come si è detto, inidoneo ad integrare ín astratto la denunciata violazione di legge), osserva comunque il Collegio che la pretesa sinonimia è anche esclusa, come emerge dalla semplice consultazione di un vocabolario, là dove la stìpsi indica rallentamento del procedere delle sostanze nell'intestino e l'occlusione intestinale un vero e proprio blocco di quel procedere. 5. Con il quarto motivo sì lamenta “violazione o falsa applicazione di norme di diritto (articoli 32, secondo comma, Costituzione, 1337 Cc in relazione all'articolo 160, primo comma, n. 3 Cpc”). Il motivo pertinente all'azione di rivalsa esercitata dalla ricorrente contro lo S. addebita alla sentenza impugnata di non avere, una volta accettata la tesi della violazione del consenso informato, condiviso la valutazione con la quale il primo giudice aveva riconosciuto che anche il suddetto sanitario avrebbe dovuto rispondere del mancato assolvimento del relativo obbligo, in quanto, pur essendo egli subentrato allaL. nell'esecuzione del trattamento, avrebbe dovuto accertarsi dell'avvenuta acquisizione del consenso informato della paziente. Si sostiene, dunque, che egli, non avendo assolto detto obbligo in questi termini, avrebbe dovuto essere dichiarato responsabile in solido ed in misura uguale allaL., ai sensi dell'articolo 1298, comma secondo, Cc. 5.1. Il motivo non merita accoglimento in quanto non si fa carico in alcun modo della ragione sulla base della quale l'impugnata sentenza ha escluso che lo S. dovesse. rispondere della violazione dell'obbligo di assicurare un consenso informato, cioè che l'articolo 4 di una non meglio precisata “Convenzione” prevedeva che Egli dovesse intervenire in prosecuzione del trattamento terapeutico iniziato dalla dott.ssaL. secondo un programma terapeutico dalla medesima predisposto. Sotto tale profilo il motivo di impugnazione non si risolve in una critica al ragionamento svolto dalla sentenza, tant'è che si limita ad evocare la validità di altro ragionamento svolto dal giudice di primo grado, del quale non precisa nemmeno il contenuto. Diventa, dunque, rilevante l'insegnamento, secondo cui il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per la quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo o, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora ì motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica dalla decisione impugnata a, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esso non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non 127 motivo”, è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'articolo 366 n. 4 Cpc (Cassazione 359/05). Il motivo in esame, dunque, deve ritenersi nullo. 6. Con il quinto motivo ci si duole di “violazione o falsa applicazione di norme di diritto (articoli 2059 Cc e 185 Cp, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3 Cpc”, sotto il profilo che, essendo stata giudicata la condotta dei medici corretta dalla C.T.U. sarebbe incomprensibile perché siano stati riconosciuti i danni morali, giacché non sarebbe sussistita alcuna ipotesi di reato, come esigerebbe la normativa invocata ed avrebbe ritenuto la Corte Costituzionale nella sentenza 79/1987. Il motivo è del tutto inconferente, in quanto trascura di considerare che la responsabilità di uno dei due medici e, quindi, della ricorrente (si veda Cassazione 13066/04) è stata ritenuta per violazione dell'obbligo di consenso informato e, quindi, a causa di una condotta idonea per le stesse considerazioni richiamate sopra circa i termini di riferimento normativi dell'obbligo di assicurare quel consenso ad integrare il reato di lesioni colpose, come esattamente deducono i resistenti F. e B.. 7. Con il sesto motivo si lamenta “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio (articolo 360, primo comma, n. 5 Cpc)”, in quanto, essendo la A. affetta da gravissimo tumore, avendo subito un invasivo intervento ed essendo deceduta a seguito dei progressivi sviluppi oncologici, sarebbe incomprensibile la integrale correlazione ritenuta dall'impugnata sentenza fra il peggiorare delle sua condizioni fisiche e la radioterapia, nonché l'assunzione a base di calcolo per la liquidazione del danno delle c.d. tabelle milanesi, come se si fosse trattato di una persona fisicamente integra e con una vita media probabile desunta dalle apposite rilevazioni statistiche. La Corte territoriale nemmeno sarebbe entrata nel merito della sussistenza o meno di un nesso causale tra l'operato dei medici. e le complicazioni successive. La motivazione della sentenza impugnata su tutta tale problematica sarebbe viziata ai sensi del citato n. 5 dell'articolo 360 Cpc. Il motivo merita la stessa sorte del quarto motivo, perché trascura completamente le considerazioni svolte dalla sentenza alla pagina 17, sia sul fatto “che dalla disposta C.T.U. si evince agevolmente che, indipendentemente dalla patologia pregressa le infermità valutate dal consulente sono tutte riconducibili alle complicazioni del trattamento radiante”, sia sulla liquidazione del danno e sul ricorso alle tabelle milanesi, punti riguardo ai quali la Corte territoriale parimenti condivide le valutazioni espressa dal C.T.U. Si tratta, cioè, di motivo che trascura completamente la motivazione della sentenza impugnata, la quale avrebbe dovuto essere criticata o sotto il profilo della non rispondenza alle risultanze della C.T.U. (ma allora con la configurazione di un errore revocatorio, come tale denunciabile non con il ricorso per cassazione, bensì con la revocazione ex articolo 395, n. 4, Cpc) o sotto il profilo della non condivisibilità delle stesse conclusioni della consulenza tecnica (ma allora la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di avere svolto nel giudizio di merito opportuno contraddittorio volto ad evidenziare tale non condivibilità, dovendosi altrimenti considerare le ragioni esposte a sostegno del motivo nuove ed inammissibili in questa sede) . 8. Con il primo motivo di ricorso incidentale la Compagnia NXXX di Assicurazioni (che nel suo controricorso svolge rilievi adesivi ai motivi del ricorso principale) deduce “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 1917 Cc in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3 Cpc”, nonché 128 “omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia (articolo 360, primo comma, n. 5 Cpc)”, sotto il profilo che, essendo stata la polizza assicurativa decorrente dall'1 gennaio 1993, in forza dell'articolo 1917, primo comma, Cc, in mancanza di previsione in essa di un diverso criterio, la copertura assicurativa doveva essere ritenuta operante solo per fatti accaduti durante il tempo dell' assicurazione, con la conseguenza che risalendo il fatto dannoso addebitato all'AUSL e costituito dall' inosservanza dell'obbligo di assicurare il consenso informato all'inizio della terapia, cioè al 2 dicembre 1992, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto l'operatività della polizza in violazione della citata norma. La violazione del n. 5 dell'articolo 360, invece, sussisterebbe in via subordinata, per il caso che non si dovesse ritenere sussistente la violazione di legge, in quanto sarebbe del tutto insufficiente la motivazione con cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto operante la copertura, osservando che il trattamento radioterapico sì era protratto nella vigenza della polizza, senza considerare che non era stato il trattamento ad essere antigiuridico, come la stessa sentenza impugnata non aveva mancato di affermare. Il fatto produttivo del danno sarebbe, invece, da identificare nell'asserita omissione del consenso informato. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe, altresì, contraddittoria là dove ha pronunciato sentenza di rigetto nei confronti dello S.. Sulla base di tali ragioni la Corte viene sollecitata a pronunciare nel merito, previa cassazione della sentenza impugnata sul punto, il rigetto della domanda di manleva dell'AUSL verso la controricorrente. 8.1. Il motivo è privo di fondatezza in tutti i suoi aspetti. Invero, là dove assume che la semplice circostanza della stipula della polizza con decorrenza dal 1 gennaio 1993 sottraeva l'evento alla copertura assicurativa, in ragione della norma dell'articolo 1917, primo comma, Cc, che correla l'obbligo dell' assicuratore di tenere indenne l'assicurato di “quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell' assicurazione, deve pagare ad un terzo in dipendenza della responsabilità dedotta”, dimentica di accompagnare tale deduzione con la riproduzione della clausola della polizza assicurativa: per tale ragione il motivo impinge in una chiara violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Infatti, questa Corte soltanto attraverso la lettura della clausola della polizza potrebbe riscontrare se la sussunzione della vicenda oggetto di lite sotto la vigenza della polizza è avvenuta in violazione della norma della citata norma. Ciò, in quanto per individuare, alla stregua dell'articolo 1917 Cc, il “fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione”, riguardo al quale una polizza assicurativa copra la responsabilità civile dell'assicurato verso il terzo è indispensabile considerare il tenore della relativa clausola identificativa di detto fatto (e, quindi, dell'estenzione della copertura assicurativa) , onda comprendere che cosa le parti abbiano inteso ricondurre sotto la copertura assicurativa ad in particolare se abbiano inteso il fatto idoneo a determinare la responsabilità civile verso il terzo, ove imputabile a condotta umana, come comprensivo solo delle condotte causative di danno a terzi posta in essere sotto la vigenza della polizza ovvero lo abbiano inteso come comprensivo anche delle conseguenze dannose di condotte tenute prima della vigenza della polizza. Il motivo in esame, pertanto, dev'essere disatteso sulla base del seguente principio di diritto: «Il motivo di ricorso per cassazione, con il quale si denunci da parte dell'assicuratore per la responsabilità civile che il giudice di marito abbia violato la norma, dell'articolo 1917, primo comma, Cc, per avere ritenuto una fattispecie concreta di responsabilità civile dell'assicurato in parte sussumibile sotto la 129 vigenza della polizza, succeduta ad altra corrente già con altro assicuratore, pur trattandosi di fatto non accaduto durante il tempo dell'assicurazione, allorquando tale fatto sia rappresentato da una condotta umana causativa del danno ed essa sia stata posta in essere anteriormente alla vigenza della polizza e nella vigenza della polizza cessata, mentre le conseguenza dannose si siano verificato in parte dopo di cosa, qualora il contenuto della clausola determinativa dell'oggetto della copertura assicurativa non sia riprodotto o commentato dalla sentenza e, quindi, la relativa argomentazioni non siano stato esso stanza oggetto dell'enunciazione critica del motivo, deve per essere rispettoso del principio di autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione, applicabile anche all'enunciazione del vizio di violazione di legge (Cassazione, 15910/05) articolarsi necessariamente con la riproduzione del contenuto della clausola, in quanto, in difetto, la Corte di Cassazione non risulta messa in grado di apprezzare il denunciato errore di sussunzione, atteso che la nozione di “fatto accaduto durante il tempo dell' assicurazione”, per la equivocità del termine “fatto”, idoneo a comprendere, se riferito ad un fatto umano, sia la condotta sia gli eventi che essa abbia provocato, si presta di per né a comprendere sia l'una che gli altri e, quindi, spetta alle parti del contratto assicurativo opportunamente precisarla in modo che abbia o non abbia quella estensione». Sulla base dei rilievi svolti resta assorbita la deduzione della contraddittorietà dell'esclusione della responsabilità dello S.. 9. Con un secondo motivo, in nesso di subordinazione rispetto al primo, si deduce “omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia (articolo 360, primo comma, n. 5 Cpc)”, lamentandosi che con l'atto di appello la ricorrente incidentale si era doluta che il giudice di primo grado avesse accertato nella misura del 50% il suo grado di responsabilità per la rivalsa nel presupposto dell'impossibilità di accertare in quale misura il danno si fosse verificato fino al 31 dicembre 1992 ed in quale oltre, mentre la sentenza impugnata nulla avrebbe motivato sul punto e ciò nonostante che le sedute di radioterapia eseguite dopo il 1 gennaio 1993 fossero state cinque sulle venticinque totali. In via subordinata si chiede, dunque, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. Il motivo dev'essere considerato inammissibile, perché inidoneo a sorreggere l'enunciato vizio di omessa motivazione. Ciò, alla stregua del consolidato principio secondo cui la decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura alla sentenza di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame e, quindi, integrando tale vizio un error in procedendo alla stregua del n. 4 dell'articolo 360 Cpc. Ne consegue, quindi, che, se il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello su una censura prospettata con l'appello (principale od incidentale) viene denunciato ai sensi dell'articolo 360 n. 5 Cpc (od anche dell'articolo 360 n. 3), anziché ai sensi dell'articolo 360 n. 4), Cpc, in relazione all'articolo 112 dello stesso codice di rito, il motivo è inammissibile (in termini da ultimo Cassazione 22897/05, fra le tante). La differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'articolo 112 Cpc e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui al n. 5 dell'articolo 360 Cpc sì coglie, infatti, nel senso che nella prima l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa (o, quindi, nel caso dal motivo d'appello uno dei fatti costituitivi della “domanda” di appello), mentre nel caso doll'omessa motivazione l'attività di esame del giudice che si assume omessa non concerne la domanda o l'eccezione direttamente, bensì una 130 circostanza di fatto che, ove valutata avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un'eccezione e, quindi su uno dei fatti c.d. principali della controversia (si veda Cassazione 22979/04 ). Il motivo è, pertanto, inammissibile per come è stato dedotto. 10. Conclusivamente debbono essere rigettati sia il ricorso principale, sia quello incidentale. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione relativamente a tutti i rapporti processuali. PQM la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione. -Danno esistenziale per violazione del diritto all'autodeterminazione di un paziente. Sentenza 4 ottobre 2004 14. 861/2000 R. G. A. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Venezia Sezione III Civile il Giudice Unico dott. Roberto Simone ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 10.2.2000 da M. P., rappresentata e difesa dagli avv.ti Virgilio Calabrese e Donato Bruno, presso il secondo elettivamente domiciliata, per mandato in calce all’atto di citazione, - attrice contro U.L.S.S. 13, in persona del Direttore generale p.t. V. M., rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Fabbrani, presso lo stesso elettivamente domiciliata, per mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione, · convenuta – in punto: risarcimento danni. Causa trattenuta in decisione all’udienza del 5.3.2004 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite Per l’attrice: “1) accertata la responsabilità dell’equipe medica che ha effettuato l’intervento chirurgico di cui è causa, per violazione dell’obbligo di consenso informato nei confronti della paziente M. P., condannarsi la convenuta al risarcimento di tutti i 131 danni subiti dalla attrice (a titolo esemplificativo: biologico, alla vita di relazione, morale, materiale), ammontanti complessivamente a £. 200.000.000 o a quella minore o maggiore somma che risulterà di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal sinistro al saldo. 2) Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. Per la convenuta: “nel merito: respingersi la domanda; spese rifuse”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con l’atto di citazione in epigrafe indicato M. P. conveniva dinanzi al Tribunale di Venezia la l’U.L.S.S. 13, al fine di sentir pronunciare sentenza di condanna al pagamento della somma di Lire 200.000.000 a titolo di risarcimento danni. Esponeva l’attrice che il 26.2.1998 era stata sottoposta presso la Divisione di cardiologia dell’Ospedale di Mirano ad un intervento chirurgico di sostituzione valvolare mitro-aortica con ricovero dal 24 febbraio al 1° aprile 1998; l’anno precedente era stata ricoverata presso l’Ospedale di Chioggia per “doppio vizio valvolare con embolia cerebrale; durante il decorso post-operatorio erano insorte gravi complicazioni a seguito di ictus embolico con conseguente emiparesi destra ed afasia motoria, sì da determinare l’incapacità di provvedere a se stessa; per quanto le fosse stato fatto sottoscrivere prima dell’intervento un modulo di consenso informato, peraltro neppure interamente compilato, non era stata informata in ordine ai rischi ed alle eventuali complicazioni correlabili all’intervento, anche alla luce dell’episodio di ischemia embolica dell’anno precedente; prima di sottoporsi all’intervento, accompagnata da Bozzato L., aveva avuto un colloquio con il primario della divisione di cardiochirurgia dell’Ospedale di Mirano, dott. A. G., il quale l’aveva rassicurata del fatto che il tipo di intervento era fatto quotidianamente e così aveva accettato di sottoporvisi; il 24.2.1998 (il primo giorno del ricovero), presente il figlio Achille M., lo stesso primario l’aveva nuovamente rassicurata che si trattava di un intervento routinario e l’aveva accompagnata nel reparto indicando altri pazienti, che avevano subito lo stesso intervento; la nuova rassicurazione l’aveva indotta a sottoporsi all’intervento poi eseguito dal dott. Guido Michielon; se adeguatamente informata in ordine ai rischi di complicazione, tuttavia, avrebbe ragionevolmente rifiutato di soggiacere all’intervento; stanti le riferite complicazioni, lo stesso giorno delle dimissioni era stata ricoverata presso l’Ospedale Villa Salus di Mestre e successivamente dal 19 giugno alla fine del luglio 1998 presso l’Ospedale San Camillo di Venezia Lido, ove era stata sottoposta a terapie di rieducazione neuromotoria, senza purtroppo ottenere alcun miglioramento; in data 30.10.1998 si sottoponeva a visita medico-legale, dalla quale emergeva che era praticamente impossibilitata a muoversi, riuscendo a deambulare trascinando faticosamente l’arto inferiore destro, mentre l’arto superiore destro risultava perennemente flaccido; inoltre non era più in grado di pronunciare correttamente le parole e presentava una marcata confusione mentale e frequenti stati depressivi con cambio di umore; il riferito quadro clinico attuale doveva ritenersi alquanto grave e le possibilità di conseguire un miglioramento in futuro erano praticamente inesistenti. Si costituiva l’U.L.S.S. 13 e resisteva alla domanda proposta. Deduceva la convenuta che alla fine del 1997 l’attrice, già sottoposta presso l’Ospedale di Padova ad un intervento al cuore, si era rivolta all’Ospedale di Mirano, dove era stata sottoposta ad accurati esami, all’esito dei quali si evidenziava la necessità di procedere all’intervento di sostituzione valvolare mitroaortica; in data 2.12.1997 era stata sottoposta ad una nuova visita, nel corso della quale, alla presenza dei 132 familiari, i medici rappresentavano che non solo la valvola si era richiusa, ma a ciò si era aggiunta una stenoinsufficienza aortica con aggravamento della condizione emodinamica; in occasione di tale visita erano stati sottolineati i rischi dell’operazione, quantificati intorno al 20/25% (misura includente il rischio intrinseco dell’intervento e di quello collegato alla sua pregressa condizione); edotta in merito alla possibilità di sostituzione di entrambe le valvole malate ed ai benefici correlati, nonché prospettata la possibilità di impiantare una protesi biologica ovvero una meccanica, la M. aveva manifestato la preferenza per quest’ultima, concordando, tuttavia, che la scelta definitiva sarebbe avvenuta al momento del ricovero; il 25.2.1998, precedente quello dell’intervento, la paziente era stata nuovamente informata dall’anestesista in merito alle modalità ed ai benefici dell’interevento, nonché in ordine ai rischi dello stesso, alle complicazioni, inclusa la possibilità di un esito letale; alla presenza di terzi la paziente aveva sottoscritto il consenso informato anche per l’effettuazione del test volto ad accertare la presenza di anticorpi HIV e per un’eventuale trasfusione di sangue. Concludeva la convenuta in ordine all’assenza di qualsiasi profilo di responsabilità a carico dei sanitari, avendo questi ultimi informato correttamente ed esaurientemente la paziente in ordine alla natura, alle modalità ed ai rischi dell’intervento di sostituzione della valvola mitroaortica. Radicato il contraddittorio, all’esito dell’udienza di prima comparizione erano concessi i termini per il deposito di memorie ai fini di cui all’art. 180, comma 2, c.p.c. A seguito di istruttoria orale e documentale, disposta C.T.U., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni epigrafate all’udienza del 5.3.2004, previa concessione dei termini per il deposito degli atti ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Non è in discussione in questa sede la sussistenza, o no, della responsabilità della struttura sanitaria convenuta in ordine alla adeguatezza delle prestazioni rese in occasione dell’intervento di sostituzione valvolare mitro-aortica, quanto l’inadempienza da parte dei sanitari da quella dipendenti rispetto all’obbligo di informazione in ordine ai rischi ed alle eventuali complicazioni correlabili all’intervento. Complicazioni, queste ultime, in fatto verificatesi nell’immediatezza del decorso post-operatorio e consistite in un fenomeno di emiparesi ed afasia. Per quanto, come emerso nel corso dell’istruttoria, all’attrice sia stato fatto sottoscrivere in data 24.2.1998 il modulo per il consenso informato anestesiologico e chirurgico (cfr. il doc. 4 del fascicolo dell’attrice), la questione oggi in esame non può certo ridursi all’espletamento di un passaggio di natura burocratica. Infatti, il consenso deve essere il frutto di una relazione interpersonale tra i sanitari ed il paziente sviluppata sulla base di un’informativa coerente allo stato, anche emotivo, ed al livello di conoscenze di quest’ultimo. In altri termini, la conformità della condotta dei sanitari rispetto all’obbligo di fornire un adeguato bagaglio di informazioni deve essere valutata non tanto sul piano tecnico-operatorio, quanto sulla natura dell’intervento, sull’esistenza di alternatitive praticabili, anche di tipo non cruento, sui rischi correlati e sulle possibili complicazioni delle diverse tipologie di cura tali da compromettere il quadro complessivo del paziente, segnando il passaggio, come icasticamente osservato da una prestigiosa dottrina, dalla fase dell’assenso a quella del consenso, ossia del convergere delle volontà verso un comune piano di intenti. In tal senso l’art. 31 dell’allora vigente codice di deontologia medica (approvato il 24-25 giugno 1995) disponeva che: “Il medico non deve intraprendere attività 133 diagnostica o terapeutica senza il consenso del paziente validamente informato. Il consenso, in forma scritta nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche o terapeutiche o per le possibili conseguenze sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione inequivoca della volontà del paziente, è integrativo e non sostitutivo del consenso informato di cui all'art. 29. Il procedimento diagnostico e il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità del paziente, devono essere intrapresi, comunque, solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso”. Infatti, in base all’art. 29 citato: “Il medico ha il dovere di dare al paziente, tenendo conto del suo livello di cultura e di emotività e delle sue capacità di discernimento, la più serena e idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive terapeutiche e sulle verosimili conseguenze della terapia e della mancata terapia, nella consapevolezza dei limiti delle conoscenze mediche anche al fine di promuovere la migliore adesione alle proposte diagnosticheterapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere comunque soddisfatta. Le informazioni relative al programma diagnostico e terapeutico, possono essere circoscritte a quegli elementi che cultura e condizione psicologica del paziente sono in grado di recepire ed accettare, evitando superflue precisazione di dati inerenti agli aspetti scientifici. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazioni e sofferenze particolari al paziente, devono essere fornite con circospezione, usando terminologie non traumatizzanti senza escludere mai elementi di speranza. La volontà del paziente, liberamente e attualmente espressa, deve informare il comportamento del medico, entro i limiti della potestà, della dignità e della libertà professionale. Spetta ai responsabili delle strutture di ricovero o ambulatoriali, stabilire le modalità organizzative per assicurare la corretta informazione dei pazienti in accordo e collaborazione con il medico curante”. Una volta chiarito che il problema della relazione informativa tra medico e paziente, nel costituire parte integrante del contratto di assistenza sanitaria intercorrente tra il paziente e la struttura sanitaria, non potendo lo stesso più essere chiuso in un obbligo di natura precontrattuale attinente al piano dell’art. 1337 c.c., né ridursi a quello meramente accessorio e strumentale rispetto alle prestazioni di diagnosi, di cura o di esecuzione dell’eventuale intervento chirurgico, per essere assurto al livello di piena autonomia nell’ambito del diritto all’autodeterminazione in ordine all’esistenza dell’individuo, senza per questo costituire l’elemento scriminante dell’attività medica, non resta che verificare se ed in quali termini siffatta obbligazione sia stata adempiuta nell’ambito degli incontri che hanno indotto la paziente a ricoverarsi ed a sottoporsi all’intervento di sostituzione valvolare. Non v’è bisogno di alcun riscontro per sostenere che versandosi in campo contrattuale l’onere della prova in ordine all’adempimento dell’obbligo di informazione incomba sul soggetto convenuto (cfr. Cass. 23-05-2001, n. 7027). Il teste G., dirigente medico presso il reparto di cardiochirurgia dell’Ospedale di Mirano, ha affermato: “parlai con la sig.ra M. e le rappresentai i rischi connessi al tipo di intervento cui doveva sottoporsi. Si trattava comunque di un intervento di routine. Considerato che la signora aveva già avuto un episodio di embolia cerebrale, probabilmente le dissi che vi era il rischio di lesioni permanenti, tant’è che ho fatto eseguire una Tac cerebrale e un EEG. La visita preoperatoria con la sig.ra M. durò circa un’ora, probabilmente le dissi che si trattava di un intervento di routine. Non ricordo se la signora manifestò paura per l’intervento. Posso 134 riferire che se la signora manifestò paura per l’intervento la tranquillizzai”. Senonché le indicazioni appena riferite sono contraddette da quanto dichiarato dalla teste M. L. (sorella dell’attrice), la quale presente durante la prima visita fatta dal dott. G. ha riferito: “ricordo che il dottore illustrò tutto l’intervento, disse che il ricovero sarebbe durato 10 giorni e che mia sorella sarebbe stata in sala rianimazione per tre giorni. Nulla disse in merito al rischio di lesioni permanenti …Ricordo che qualche giorno prima dell’intervento il dott. G. chiamò mia sorella per dirle che poteva ricoverarsi. Poiché mia sorella aveva paura dell’intervento il dott. G. la rassicurò. Ciò posso riferire per averlo appreso da mia sorella. Ero presente al momento della telefonata…”. Che l’attrice fosse particolarmente impaurita per l’operazione (reazione pienamente comprensibile) emerge anche dalla testimonianza del M. (figlio dell’attrice), il quale ha ricordato che il giorno del ricovero per tranquillizzare sua madre, dopo una conversazione dal tono colloquiale, il dott. G. disse che si trattava di un intervento di routine e le mostrò altri pazienti già operati in precedenza. Il dato, apparentemente relegabile nel quadro delle reazioni soggettive, in realtà rileva proprio al fine di calibrare l’ambito di estensione della prestazione informativa al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche, come espresso nell’art. 29 del codice citato. Nessun apporto a sostegno della difesa di parte convenuta sovviene dalla testimonianza dell’anestesista (dott.ssa D.A.), la quale, come appreso, provvide a raccogliere la sottoscrizione della paziente sul modulo indicato. La teste ha precisato che (la M.) “era una paziente ansiosa per cui con qualche difficoltà ho potuto effettuare la visita anestesiologica… la visita l’ho effettuata due giorni prima dell’intervento, e in tale occasione ho fatto sottoscrivere il modulo per il consenso informato. Riconosco nel doc. 4 attoreo il modulo per il consenso informato. Ho informato la M. in ordine ai rischi dell’operazione ma dal punto di vista anestesiologico, indicandole l’attività cui sarebbe stata sottoposta a partire dalla cannula al successivo risveglio … Non mi sono occupata dei profili cardiologici, poiché esulanti le mie competenze”. Da tali indicazioni non appare provato, dunque, l’espletamento della prestazione informativa in ordine ai rischi ed alle possibili complicazioni dell’intervento. Nozioni che, come già detto, debbono essere somministrate in funzione della capacità di comprensione della paziente. Ciò non è avvenuto in occasione della visita eseguita dal dott. G., tant’è che lo stesso ha riferito di aver probabilmente informata la paziente in ordine al rischio di lesioni permanenti, pur dichiarando di aver rappresentato i rischi connessi al tipo di intervento, emergendo dalle dichiarazioni delle teste M. una indicazione di segno contrario. Ciò può significare o che l’informazione non fu resa affatto ovvero non fu espressa con linguaggio pienamente comprensibile da chi tecnico non è. In ogni caso un’informazione fornita in modo non pienamente comprensibile dall’intercolutore, nella sostanza non è in grado di assolvere la sua funzione ed equivale ad una non informazione, ossia l’esatto contrario del dovuto. Ad ogni modo non può non rilevarsi come il minor livello di interesse della teste M., rispetto alla posizione del dott. G., ben giustifichi in questa sede la preminenza riservata al suo racconto. Si consideri ancora che il fatto stesso che il modulo per il consenso sia stato fatto sottoscrivere il giorno del ricovero, avvenuto il 24.2.1998, è rappresentativo di una non adeguata valorizzazione del problema da parte della struttura sanitaria, tanto più che, come appreso, il consenso fu raccolto dall’anestesista, dando per 135 scontata la definizione della questione sul piano cardiologico. Ma così non è stato. Senza per questo voler contraddire quanto riferito più sopra, probabilmente al fine di rendere meno problematica la prova relativa, sarebbe stato quantomai opportuna, come peraltro segnalato dal C.T.U., una maggiore puntualizzazione in ordine ai rischi ed ai possibili sviluppi all’interno dello stesso modulo. Questo lo si afferma non tanto per svilire al piano cartaceo il problema in esame, ma per meglio calibrare la stessa possibilità di prova diretta o contraria, dovendo comunque valutarsi le modalità ed il tipo di informazioni rese al paziente. Siffatta affermazione si basa su una regola di distribuzione dell’onere della prova in base alla prossimità delle parti rispetto alla fonte di prova. È evidente che pretendere in capo al paziente la puntuale allegazione e la dimostrazione del tipo di informazione resa (sebbene nel caso di specie, la teste M. ha fornito un quadro sufficientemente chiaro) pare irrealizzabile non foss’altro per l’evidente asimmetria informativa esistente tra le parti. Per contro, esigere dalla struttura sanitaria di documentare e conservare traccia di quanto effettuato, anche in considerazione del trattamento e della conservazione dei dati personali ai sensi dell’allora vigente l. 675/1996 (ed ora del D.leg. 196/2003), appare, oltre che più ragionevole, certamente in linea con la regola di cui all’art. 1218 c.c., da leggersi in unione con l’art. 1176, comma 2, c.c. (cfr. Cass. 23 maggio 2001, n. 7027; sez. unite 30 ottobre 2001, n. 13533; 10-5-2002, n. 6735; 28-5-2004, n. 10297). In altri e più diretti termini, l’affermazione di responsabilità della convenuta non si basa su una regola inferenziale, che trae dalla scarsità di dati disponibili il difetto di diligenza del personale, quanto piuttosto dal fatto che a causa di tale assenza di informazioni non è dato sapere cosa sia stato comunicato alla paziente e, quindi, far ritenere assolto l’obbligo di informazione. Nell’ambito di una vicenda di natura contrattuale, laddove, come nel caso di specie, emerga una situazione di carenza di prova in merito all’ambito delle informazioni rese alla paziente, non v’è spazio per una discussione in merito alla sussistenza del nesso di causa sul piano dell’an (cfr. indicativamente Cass. 13-122001, n. 15759), ponendosi a valle il problema correlabile alla c.d. causalità giuridica ex art. 1223 c.c., che presuppone la già avvenuta identificazione dell’evento oggetto di addebito. Evento, quest’ultimo, da intendersi come inadempimento rispetto all’obbligazione informativa, come tale incidente in via diretta sul diritto della paziente all’autodeterminazione in ordine alle scelte involgenti la propria salute, poco rilevando sapere come l’attrice si sarebbe comportata qualora avesse avuto piena contezza in ordine ai rischi di complicazioni, stimati nell’ordine del 20% da parte del consulente. Quello che rileva è che la M. non è stata in condizioni di esprimere un consenso realmente informato, non senza rilevare che l’eventuale prova diretta a dimostrare che, quand’anche informata, la paziente avrebbe optato per l’intervento a fronte dell’elevato rischio connesso alla sua condizione di soggetto affetto da stenosi mitro-aortica incombeva sulla convenuta (cfr. Cass., sez. III, 10-05-2002, n. 6735). A questo punto, una volta accertata l’inadempienza della convenuta rispetto all’obbligazione contrattuale, sebbene da più parti si è rilevato che quello del consenso informato esula il piano strettamente contrattuale, ossia è un problema ben diverso da quello che attiene al procedimento di formazione dell’accordo contrattuale, fondandosi sulla natura stessa dell’attività medica, occorre passare all’esame dell’ambito delle conseguenze pregiudizievoli risarcibili. Al riguardo il giudizio di valutazione, esulante il piano della causalità materiale, perché involgente quello della causalità giuridica deve operarsi in base all’art. 136 1223 c.c. In altri termini, il criterio di selezione delle conseguenze risarcibili, che come autorevolmente sostenuto involge un problema di opportunità, non può essere governato in base agli stessi parametri che sovraintendono al piano della causalità naturale ed in primo luogo secondo il criterio della condicio sine qua non. È pur vero che in base al giudizio controfattuale basato sull’eliminazione mentale dell’antecendente l’evento in concreto accaduto (emiparesi ed afasia) non si sarebbe verificato, ma in quest’ordine di idee, allora, dovrebbe trovare piena applicazione una valutazione basata sulla comparazione dei rischi, ossia confrontare il rischio di complicazione collegato all’intervento con la possibile evoluzione del quadro di salute della paziente nel caso contrario. In questa prospettiva la bilancia del giudizio dovrebbe pendere dal lato della convenuta, considerato che secondo il consulente tecnico d’ufficio la patologia da cui era affetta la M. era soggetta ad inevitabile evoluzione sfavorevole a breve, sì da giustificare pienamente l’intervento. Senonché una tale prospettiva risulta fuorviante, posto che finisce per non tenere conto del fatto che l’inadempimento non investe le modalità di esecuzione dell’operazione chirurgica, ma l’obbligazione informativa, con il rischio di mettere in secondo piano l’interesse oggetto di tutela: il diritto alla scelta della paziente. Non ignora il giudicante che ben più autorevoli consessi hanno ritenuto il nesso di causa tra la lesione della salute, legata alla complicazione di un trattamento clinico, e la violazione dell’obbligo di una piena informazione da parte dei sanitari (cfr. Cass. 6.10.1997, n. 9705; 24-9-1997, n. 9374; App. Genova 5-4-1995). Osserva al riguardo lo scrivente che una tale affermazione, probabilmente, è il frutto di una configurazione del consenso del paziente quale scriminante dell’operato del medico. Impostazione, quest’ultima, ormai da tempo recessiva, per essere stato da tempo portato in esponente che l’attività medicochirurgica si autogiustifica in funzione della sua utilità sociale, mentre il consenso attiene al piano dei diritti della personalità e, più nel dettaglio, quello all’autodeterminazione in ordine alla propria salute. Diversamente argomentando si dovrebbe dare piena cittadinanza anche alle nostre latitudini ai casi di wrongful life (come accaduto oltralpe nel caso affrontato da Cour de Cassation, ass. plen. 17.11.2000, in Nuova giur. civ. comm., 2001, I, 209), ossia alla pretesa risarcitoria del soggetto che nasce affetto da gravi patologie a seguito dell’erronea diagnosi prenatale con la correlativa perdita per la partoriente della possibilità di decidere in ordine alla opportunità, o no, di interrompere la gravidanza. Seguendo la traiettoria prescelta dal giudicante, comunque allegata dall’attrice, ma allargata al piano della salute, appare possibile circoscrivere l’ambito del pregiudizio di natura non patrimoniale (l’allegazione fatta in comparsa conclusionale alle spese per la futura assistenza è tardiva rispetto a quanto dedotto nel limite per la formazione del thema decidendum) a quello correlato al piano esistenziale, da intendersi come riparazione correlata alla privazione del diritto alla scelta consapevole da parte della M.. Data la particolarità delle prestazioni, in quanto incidenti sulla sfera personale dell’individuo, non è possibile escludere la risarcibilità di una tale posta di danno in base all’art. 1225 c.c., posto che, pur non essendo possibile operare una stima economica esatta del pregiudizio connesso alla lesione di un interesse non patrimoniale, comunque la natura dell’attività svolta deve dare per scontato che la prestazione involge la sfera dell’individuo, sicché il pregiudizio di natura non patrimoniale può essere risarcito senza dover necessariamente far leva su un concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Infatti, la rilettura in chiave costituzionale dell’art. 2059 c.c. operata dalla Cassazione (sentenze 31-5-2003, nn. 8827 e 8828) fa sì che anche in 137 ambito contrattuale possa darsi rilievo a pregiudizi di natura non patrimoniale, sempre che i correlativi interessi possano ritenersi inclusi nell’ambito di tutela del contratto. Al riguardo, consapevole della mancanza di una scala parametrata su basi oggettive o che quantomeno siano in grado di tradurre in termini economici oggettivi il pregiudizio patito, non resta che una valutazione puramente equitativa, liquidando all’attualità il danno patito dall’attrice nella somma di Euro 100.000. Su tale somma, inoltre, saranno dovuti gli interessi legali dall’evento al saldo. Tale valore, per quanto stocastico, tiene conto della specificità del caso di specie, posto che l’operato dei sanitari anche se non censurabile sul piano delle modalità di esecuzione dell’intervento, comunque ha finito per espropriare l’attrice del suo diritto a scegliere in ordine alla propria esistenza. Ora in una visione della libertà come assenza di “coercizione” da parte di terzi, non può non rilevarsi come quello all’autodeterminazione in ordine alla propria salute costituisca un valore primario di rango costituzionale, da cui non si può prescindere, pena la rinuncia al valore di base della nostra società. La domanda proposta, pertanto deve essere accolta e, per l’effetto, l’U.L.S.S. 13, in persona del Direttore generale p.t., deve essere condannata al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 100.000, oltre gli interessi legali dall’evento al saldo. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Spese di C.T.U. a definitivo carico della convenuta. Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe riportata, respinta ogni altra domanda o eccezione, così provvede: 1) in accoglimento della domanda proposta, condanna l’U.L.S.S. 13, in persona del Direttore generale p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento danni per le causali indicate, in favore di M. P. della somma di Euro 100.000, oltre gli interessi legali dall’evento al saldo; 2) condanna l’U.L.S.S. 13, in persona del Direttore generale p.t., alla rifusione in favore dell’attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 13.431,49, di cui Euro 396,68 per spese, Euro 3.072,35 per diritti ed Euro 9.962,46 per onorari, oltre IVA e CPA se dovuti per legge; 3) spese di C.T.U. a definitivo carico della convenuta; 4) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Venezia, li 24 giugno 2004 Il Giudice Unico Il Collaboratore di Cancelleria Depositata in cancelleria Il Collaboratore di Cancelleria PUBBLICATA IL 4 OTTOBRE 2004 DANNO TANATOLOGICO TRACCIA: 138 Tizio è fratello di Marco, con il quale conviveva da 5 anni. Marco, un giorno decideva di uscire a fare una passeggiata con lo scooter. Marco si fermava ad un semaforo rosso; quando il semaforo diventava verde riprendeva la marcia. Inaspettatamente ed imprevedibilmente arrivava a forte velocità, dalla destra, un camion di frutta che investiva il povero Marco. Marco moriva immediatamente. Tizio veniva a sapere dell’accaduto ed, adirato, si recava dal legale Sempronio. Il candidato, assunte le vesti di Sempronio, rediga motivato parere sulla questione giuridica posta. POSSIBILE SCHEMA DI SOLUZIONE: In premessa poteva essere utile ricostruire sinteticamente il fatto. Successivamente era necessario chiedersi che tutela potrebbe vantare Tizio per l’omicidio del fratello Marco; si tratta di un danno tanatologico (danno da morte immediata), per cui sono escluse possibilità risarcitorie sub specie iure successionis (non c’è un apprezzabile lasso di tempo tra lesione e morte, così che eventuali danni biologici o morali non hanno il tempo di maturare nella sfera giuridica del de cuius, prima di essere trasferiti mortis causa). Che tipologia di danno, allora, potrà sostenere di aver subito Tizio? Sembrerebbe poter emergere un danno morale e danno esistenziale, relativamente al fatto che sono stati lesi beni-interessi di rango costituzionale, come la famiglia; la giurisprudenza più recente parla, a tal proposito, di danni parentali estendendo molto il concetto di famiglia, fino a ricomprendere non solo il fratello, ma anche il convivente. In quest’ottica di tutela rafforzata ed estesa della famiglia, Tizio potrà agire in via risarcitoria verso l’investitore di Marco, per il danno morale ed esistenziale (se la morte di marco ha cagionato una malattia nella mente, sarà possibile anche ottenere il risarcimento del danno biologico, sub specie psichico). Si consiglia di leggere le sentenze che seguono. -I parenti del defunto, vittima primaria dell’illecito causativo di morte, subiscono un pregiudizio che può essere qualificato come “danno parentale non patrimoniale”, meritevole di tutela ai sensi dell'articolo 2059 Cc. (anche con riferimento ai “parenti prossimi conviventi”). Trattasi, segnatamente, di un nocumento subito iure proprio, direttamente dai familiari stretti, per la perdita del congiunto, come danno morale derivante dal reato di omicidio colposo costituente illecito civile. Il danno morale può essere risarcito a prescindere dall’accertamento in concreto di un illecito penale e, soprattutto, anche in assenza di un 139 pregiudizio cd. Biologico. Il giudicante deve rispettare il principio di personalizzazione del danno (vanno bene le tabelle, ma bisogna personalizzarle con il singolo caso) e quello di integrale ristoro. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE SENTENZA 12 luglio 2006, n. 15760 (Presidente Duva – relatore Petti) Svolgimento del processo Il 4 luglio 1989 il minore A., mentre si trovava a bordo di un pedalò, nelle acque della rada di Spisone, in Taormina, era investito, scaraventato in mare e travolto da un idrogetto Yamaha condotto dal minore A.. In seguito all’urto il Lombardo decedeva all’ospedale di Messina. Con citazione del maggio 1990 i genitori di XXX, ed il fratello convivente XXX, convenivano in giudizio il conducente del mezzo e per esso ì genitori, i proprietari del mezzo investitore (C. e V.) e l’impresa assicuratrice SARA assicurazioni Spa e ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni morali, conseguenti alla morte del congiunto, nonché alla rifusione dei danni patrimoniali, incluse le spese di costituzione nel giudizio penale, concluso per effetto della sopravvenuta amnistia. Si costituivano tutti i convenuti, contestando l’an debeatur, e l’impresa eccepiva l’inoperatività della polizza, avendo l’idrogetto una potenza superiore ai 25 cavalli ed esigendo, per la guida, la patente nautica. Il Tribunale di Messina, con sentenza del 22 aprile 1998, accertava che la colpa esclusiva dell’incidente era da ascriversi al conducente dell’idrogetto e che vi era responsabilità per culpa in vigilando ed in educando dei genitori, che l’assicurazione copriva il mezzo e che vi era responsabilità solidale dei proprietari del mezzo che era stato locato ai frequentatori del luogo. Il Tribunale liquidava i danni patrimoniali ed i danni morali, contenendoli in cinquanta milioni di lire per ciascun genitore ed in 25 milioni per il fratello (ai valori del 1998). Contro la decisione veniva proposto appello principale dagli aventi causa dal defunto in relazione alla ridotta liquidazione dei danni morali, e ciò sia in relazione alla gravità del danno, sia in relazione ai parametri tabellati dal Tribunale dì Milano, quale sede del maggior contenzioso italiano in materia di danni da circolazione. Veniva proposto appello incidentale dai genitori del giovane conducente e dall’impresa assicuratrice in relazione all’inoperatività della garanzia. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 21 settembre 2001 così decideva: in accoglimento dell’appello principale aumenta la somma relativa al danno morale da corrispondere nella misura di 100 milioni in favore dei genitori e di 40 milioni in favore del fratello convivente, con rivalutazioni ed interessi decorrenti dal marzo 1990, condannando in solido gli appellati a corrispondere le maggiori somme; rigetta gli appelli incidentali e condanna gli appellati, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio in favore degli appellanti principali, compensandole tra gli appellati. Contro la decisione hanno proposto ricorso, in punto di liquidazione del danno morale, gli aventi causa dal defunto XXX, deducendo unico motivo di ricorso e hanno depositato memoria; hanno resistito con controricorso i genitori del conducente minore autore dell’incidente; hanno proposto ricorso incidentale ì 140 proprietari responsabili solidali, in punto di an e quantum debeatur. Per la SARA è stata svolta discussione orale. E’ stata depositata memoria dai ricorrenti principali. I ricorsi sono stati previamente riuniti (articolo 335 Cpc). Motivi della decisione Il ricorso principale merita accoglimento, dev’essere invece rigettato il ricorso incidentale. Secondo l’ordine logico della questioni dev’essere esaminato per primo il ricorso incidentale di V. e C., responsabili civili in quanto proprietari del mezzo investitore. A. Esame del ricorso incidentale (32971/02). Il ricorso si articola in due motivi: nel primo motivo si deduce l’omessa e contraddittoria motivazione della sentenza di appello sia sull’an che sul quantum debeatur. Sotto il primo profilo la tesi è che il giudice di appello ha fondato l’accertamento della responsabilità del minore utilizzando atti e testimonianze rese nel processo penale e la perizia tecnica ivi contenuta. La Corte nella sua motivazione non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni della utilizzazione di tali atti e non avrebbe analizzato le deposizioni testimoniali. Sotto il secondo profilo la tesi è che la Corte avrebbe aumentato la valutazione del danno morale, indicando gli elementi di valutazione personalizzanti, ma disapplicando la limitazione fatta dai tribunali, inclusi quelli milanesi, che lo delimitano ad un terzo circa della valutazione del danno biologico. Nel secondo motivo si chiede la conferma della statuizione della responsabilità solidale dell’impresa, sul rilievo che la perizia tecnica sulla potenza del natante conferma che la potenza effettiva era inferiore ai 25 cavalli e che pertanto il mezzo non esigeva la guida con patente nautica. In relazione al primo motivo si osserva che il medesimo è inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza, in relazione alla critica dello accertamento della responsabilità, che invece risulta ampiamente ed analiticamente motivato dai giudici del riesame (v.ff da 7 a 9 della motivazione). La produzione della documentazione del processo penale è avvenuta sull’accordo e nel contraddittorio delle parti e dunque gli elementi di prova ben potevano essere esaminati e considerati nel contesto probatorio del processo civile. Quanto al secondo profilo del prima motivo, la infondatezza deriva dalla sua non decisività, in relazione alla natura equitativa della valutazione del danno morale secondo criteri di gravità e di personalizzazione del danno, avendo un valore meramente orientativo le tabelle dei tribunali che collegano la valutazione del danno morale a quella del danno biologico. ma sui principi informatori e sulle regole generali per la tutela del danno morale da morte, si dirà più ampliamente nella considerazione della fondatezza del ricorso principale. Quanto al secondo motivo si osserva che la Sara non ha ulteriormente impugnato la statuizione che la vede responsabile solidale, onde sul punto si è formata re giudicata interna. I ricorrenti non possono dunque dolersi della statuizione che giova alla propria posizione di solidali. B. Esame del ricorso principale (31147/02) degli aventi causa dal defunto XXX. Lamentano i ricorrenti “la omessa o quanto meno insufficiente motivazione in ordine ai criteri di liquidazione del danno morale, in relazione agli articoli 2043 e 2059 Cc”. Interpretando la censura, come argomentata nella sua esposizione, essa involge non solo il vizio della motivazione, ma contestualmente l’error in iudicando per la errata applicazione dei criteri di risarcimento del danno morale come danno ingiusto, che viene richiesto iure proprio, come danno consequenziale 141 alla morte del congiunto. Lamentano in vero i ricorrenti la iniquità della decisione dei giudici di appello, e la contraddittorietà della motivazione che pur corregge in parte la liquidazione a livelli minimali del danno da morte. Infatti i giudici messinesi, nella sintetica ed apodittica motivazione, dopo aver sostenuto dì dover tener conto di parametri “intermedi” (quali “la età della giovane vittima, la drammaticità e la violenza dell’evento della morte in una situazione che doveva, invece essere di svago e di divertimento, il conseguente dolore dei genitori”), per la valutazione della gravità rilevante dell’evento, (tale da modificare radicalmente la qualità della vita dei genitori e del fratello convivente), provvedono ad una correzione parziale dei danni senza tener conto della natura di debito di valore e dei parametri tabellari posti in essere dai maggiori tribunali italiani, proprio per assicurare una parità od omogeneità di trattamento. Si aggiunge che la discrezionalità del giudice deve essere rivolta alla conformazione della equità valutativa alla funzione sociale di deflazione delle controversie soprattutto quando il contraddittorio si instaura nei confronti delle imprese assicuratrici che contestano la ragionevolezza della discrezionalità assoluta dei giudici. Il motivo merita accoglimento con alcune puntualizzazioni, onde enunciare i principi di diritto cui dovranno attenersi i giudici cui la lite è rimessa per la rivalutazione del danno morale da morte. Una prima puntualizzazione attiene alla definizione del danno ingiusto da morte, nell’ambito dell’illecito civile, che includa anche lo illecito da circolazione di natanti (cfr articolo 2 legge 990/69) come è nel caso in esame. La struttura dell’illecito, è identica a quella descritta dallo articolo 2043 Cc, come clausola generale del neminem laedere, ovvero come principio regolatore della materia della responsabilità aquiliana (cfr Cassazione Su 500/99). Orbene ritiene questa Corte, dopo aver constatato la infondatezza del ricorso incidentale, che i parenti del defunto, vittima primaria, abbiano dato la prova del fatto storico dell’illecito civile con danno ingiusto da morte, e di avere subito, a propria volta, un danno parentale non patrimoniale, meritevole di tutela ai sensi dell’articolo 2059 Cc. Sulla legittimazione dei parenti per la tutela del proprio danno del resto non si discuteva neppure nella fase del merito, e comunque il ricorso incidentale che dubitava dell’an debeatur è stato respinto ed il dubbio concerneva genericamente la ricostruzione fattuale. Il danno parentale è stato chiesto e liquidato come danno subito iure proprio, direttamente dai familiari stretti, per la perdita del congiunto, come danno morale derivante dal reato di omicidio colposo costituente illecito civile. Poiché questa Corte è vincolata dal motivo del ricorso principale, che insiste nella richiesta del solo danno morale iure proprio, non possono venire in esame, se non come obiter sistematico (descrittivo dell’intera tutela oggi esperibile), il danno morale del defunto, trasmissibile iure hereditatis (cfr.Cassazione 11601/04), ovvero il danno biologico del defunto, in relazione alla morte non immediata, ormai riconosciuto da consolidata giurisprudenza, come trasmissibile iure hereditatis, sia pure con orientamenti contrastanti circa i criteri di liquidazione, ovvero ancora il danno da morte come perdita della integrità e delle speranze di vita biologica, in relazione alla lesione del diritto inviolabile della vita, tutelato dall’articolo 2 della Costituzione (vedi espressamente Corte Costituzionale sentenza 132/85) ed ora anche dall’articolo II-62 della Costituzione europea, nel senso di diritto ad esistere,come chiaramente desumibile dalla lettera e dallo spirito della norma europea. La dottrina italiana ed europea che riconoscono la tutela civile del diritto 142 fondamentale della vita, premono per il riconoscimento della lesione come momento costitutivo di un diritto di credito che entra istantaneamente come corrispettivo del danno ingiusto al momento della lesione mortale, senza che rilevi la distinzione tra evento di morte mediata o immediata. La certezza della morte, secondo le leggi, nazionali ed europee è a prova scientifica, ed attiene alla distruzione delle cellule cerebrali e viene verificata attraverso tecniche raffinate che verificano la cessazione della attività elettrica di tali cellule. La morte cerebrale non è mai immediata, con due eccezioni :la decapitazione o lo spappolamento del cervello. In questo quadro anche il danno da morte, come danno ingiusto da illecito è trasferibile mortis causa, facendo parte del credito del defunto verso il danneggiante ed i suoi solidali. Ma questa suggestiva problematica, che tiene conto della Costituzione europea e del principio di prevalenza della fonte costituzionale europee (articolo 16 ) che integra e completa la fonte italiana sul diritto alla vita (articolo 2 e 3 secondo comma della Costituzione tra di loro correlati, essendo la vita la condizione esistenziale della espansione della persona umana), non è interessata dal caso in esame, che riguarda invece il danno ingiusto parentale conseguente alla morte del congiunto, danno che è stato ormai stabilmente collocato dentro l’articolo 2059 Cc, dal diritto vivente. La seconda puntualizzazione, partendo dalla delimitazione del petitum e della causa petendi, attiene alla individuazione dei principi informatori (cfr.Corte Costituzionale, sentenza 206/04) ovvero dei principi regolatori della materia (cfr Cassazione, terza, Sezione civile, sentenza 382/05), ovvero dei criteri equitativi di valutazione del danno parentale da morte (cfr.articolo 2059 Cc correlato agli articoli 2056 e 1226 Cc) che non risultano derogati o modificati dalle leggi speciali sull’ assicurazione di veicoli e natanti (e neppure dal codice ormai vigente delle assicurazioni). Tale puntualizzazione si rende doverosa in relazione al contenuto della censura dedotta in ricorso ed in vero la iniquità o la insufficienza del risarcimento del danno morale, già evidente dalla sommaria motivazione, deriva dalla mancata consapevolezza della efficacia dei principi informatori e regolatori della materia, sottovalutando la esistenza delle condizioni soggettive rilevanti che attengono ad interessi personali costituzionalmente protetti. Da ciò deriva poi la scelta di criteri di risarcimento non satisfattivi, affidati ad una equità valutativa che rasenta l’arbitrio e che pretende una insindacabilità, pur violando il principio fondamentale (informatore, a livello costituzionale, regolatore a livello codificato) che anche il danno morale, da chiunque subito, deve essere integralmente risarcito. 1. Principio informatore di rango costituzionale (anche europeo, cfr:articolo II-62 e 63 Costituzione ratificata dall’Italia con legge 57/2005) è quello del diritto delle vittime al risarcimento totale dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alla lesione di diritti umani fondamentali (cfr.Corte Costituzionale 132/85 e Corte Costituzionale sentenza 184/86). Il danno da morte dei congiunti (cd danno parentale) come danno morale interessa la lesione (divenendo perdita non patrimoniale) di due beni della vita, inscindibilmente collegati: a) il bene della integrità familiare, con riferimento alla vita quotidiana della vittima con i suoi familiari, in relazione agli articoli 2,3,29,30,31,36 della Costituzione (cfr:puntuale il riferimento in Corte Costituzionale 132/85 cit.) ; b) il bene della solidarietà familiare, sia in relazione alla vita matrimoniale che in relazione al rapporto parentale tra genitori e figli e 143 tra parenti prossimi conviventi, specie quando gli anziani genitori sono assistiti dai figli, e ciò in relazione agli articoli 2,3 29 e 30 della Costituzione. L’attuale movimento per la estensione della tutela civile ai PACS (patti civili di solidarietà ovvero stabili convivenze di fatto) conduce appunto alla estensione della solidarietà umana a situazioni di vita in comune, e dunque prima o poi anche i “nuovi parenti” vittime di rimbalzo lamenteranno la perdita del proprio caro. Nel caso di specie il danno parentale interessa una societas stabilizzata con vincolo matrimoniale e discendenza legittima, onde i referenti costituzionali sono certi. Questa ricostruzione, costituzionalmente orientata e testata, consente di capire il principio informatore della tutela risarcitoria integrale di questa figura di danno morale, principio che informa regole e criteri sottostanti. 2.Un secondo principio, questa volta regolatore della materia (illecito da circolazione di veicoli e natanti) si desume dall’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 Cc, che la dottrina italiana auspicava, anche attraverso la comparazione del diritto italiano con quella europeo ed anglosassone che svincolano il danno morale come lesione della dignità o integrità morale della persona, dall’accertamento dì un fatto reato. La svolta sistematica giurisprudenziale, come è noto, si è verificata, come incipit, con la sentenza, compositiva di un contrasto, delle Sezioni Unite civili 2515/02, che ha affermato la piena autonomia del danno morale rispetto al danno biologico (in relazione ad un disastro ambientale), ed è seguita, sempre sul piano sistematico, ma con orientamento costituzionale dalle due note sentenze nn.8827 e 8928 del 2003, confermate dalla meno nota sentenza 16176/03 che le precede nel tempo della deliberazione e contiene utili precisazioni concettuali. Il principio regolatore della materia che si desume dall’articolo 2059 Cc costituzionalmente orientato, ed esteso, pur mantenendo la cd tipicità delle fattispecie (che esclude la inclusione della categoria generale del danno esistenziale, che solo il legislatore può fare, e non già la dottrina creativa del diritto) al danno parentale, in relazione a posizioni soggettive costituzionalmente protette di danno non patrimoniale, è dunque quella del risarcimento integrale del danno morale diretto, subito dai parenti, a prescindere dall’accertamento del reato (in sede di responsabilità civile) ed a maggior ragione in presenza di un fatto reato lesivo della persona anche a titolo di colpa (omicidio colposo,come è nella specie). Il fatto reato rileva come peso, come entità da valutare ai fini della complessa valutazione del danno parentale morale. La consapevolezza di tale principio giova nella fase della liquidazione del danno. La conclusione ermeneutica da trarre, considerando il principio informatore e quello regolatore, è che la lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 Cc, ferma la tipicità della fattispecie in relazione al danno ingiusto ed alla lesione del diritto o dell’interesse della persona, include anche la qualificazione e la stima del danno morale da reato, e del danno parentale subito dalla vittima di un omicidio colposo. 3. I criteri informatori della valutazione del danno morale parentale, iure proprio, si desumono chiaramente dal combinato disposto tra gli articoli 2056,2059 e 1226 Cc, per la valutazione equitativa del danno morale, che per la sua stessa natura, non puó essere provato nel suo preciso ammontare, essendo un danno eminentemente rapportato alle qualità morali della persona ed alle sue condizioni, oggettive oltre che soggettive. Non a caso la Costituzione europea colloca il danno morale sotto il valore universale della dignità umana (articolo II-61) dotata di inviolabilità e di garanzia giurisdizionale e risarcitoria piena (articolo II-107) e non a caso questa Corte ha 144 collegato la tutela del danno morale alla integrità morale della persona (Cassazione Su 1338/04 e Cassazione 19057/03). Il criterio della valutazione equitativa del danno morale, secondo le regole codificate del codice civile, non è stato toccato dalle leggi di riforma assicurative, e neppure dalle tabelle attualmente vigenti nei tribunali italiani, quando includono i criteri di valutazione di un danno morale strettamente consequenziale al danno biologico primario e per il medesimo soggetto. Il nuovo codice delle assicurazioni, vigente dal 1 gennaio 2006, giustamente non se ne occupa, ad evitare questioni di costituzionalità. L’applicazione dei criteri dì valutazione equitativa al danno ingiusto morale da illecito della circolazione dei natanti, non appartiene pertanto all’arbitrio del giudice, ma alla sua prudente discrezionalità, che è circostanziata, e che considera le condizioni della vittima e la natura permanente del danno, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti, e della integrità della famiglia naturale o legittima, ma solidale in senso etico prima che giuridico. Non a caso il criterio generale dell’articolo 1226 usa le parole “preciso ammontare”, per indicare la tendenza al rendere totale il ristoro satisfattivo, nella valutazione di prudente discrezionalità. Le tre puntualizzazioni sistematiche in ordine ai principi informatori, regolatori ed ai criteri di valutazione equitativa, giovano dunque alla considerazione della fondatezza del ricorso, rendendo evidente la iniquità del risultato valutativo e dunque la violazione delle norme di diritto, segnatamente indicate nel ricorso con il solo riferimento ai principi generali ed ai criteri di valutazione. Riproduciamo per chiarezza l’intero passo della sentenza (ff 11) che riguarda la rideterminazione del danno morale: “Va detto a proposito che non possono prendersi in considerazione i parametri adottati dagli organi giudiziari di Milano perché essi non hanno carattere di generalità e di certezza. Tenendo conto però di altri parametri intermedi, della giovane età della vittima, la drammaticità e la violenza dell’evento della morte in una situazione, che doveva essere invece di svago e di divertimento, il conseguente intenso dolore dei congiunti, importa che il danno morale va valutato ad oggi (31 maggio 2001) in lire 100 milioni per ciascun genitore e lire 50 milioni per il fratello). Il danno morale parentale, si è verificato, nella lettura costituzionalmente orientata, come danno diretto non patrimoniale, a partire dalla consumazione del fatto illecito, che è del 4 luglio 1989 (dodici anni prima della seconda decisione, che lo ridetermina ancora riduttivamente). L’analisi dei due argomenti che sostengono la motivazione impugnata è colpita dalla censura dei ricorrenti: la prima affermazione è logicamente errata, dal punto di vista della valutazione equitativa, sempre per la violazione del principio informatore. Dal punto di vista del danno morale parentale, non conta che il figlio sia morto a Taormina, nella giurisdizione territoriale di Messina, od a Gallarate nella giurisdizione territoriale di Milano, od a Roma nel quartiere dei Parioli ovvero nella sua periferia. Conta la morte in sé, ed una valutazione equa del danno morale, che non discrimina la persona e le vittime primarie o secondarie, né per lo stato sociale, né per il luogo occasionale della morte. Le tabelle milanesi sono quelle statisticamente testate, Per il numero elevato dei casi giudiziari e delle transazioni extragiudiziarie italiane. Esse dunque orientano, per i parametri, in modo statisticamente più equalitario, delle tabelle del tribunale di Messina, e dunque motivi di opportunità e di logica, rendono evidente che, dal punto di vista umano dell’esperienza, esse indicano un 145 criterio generale di valutazione, che il giudice messinese poteva adottare, almeno al fine di valutare comparativamente se la propria valutazione conduceva ad un “ammontare preciso”, minore o maggiore del danno ingiusto parentale. La seconda affermazione, quella che pone sulla bilancia della equità, il peso della gravità del danno utilizzando i parametri intermedi, è invece claudicante. In vero non si tratta di parametri, ma di circostanze e di condizioni, indicate alla rinfusa, posto che in parte attengono al danno diretto della vittima (la età, la violenza dello evento della morte, la morte che viene durante una vacanza) in parte attengono al danno diretto dei parenti (inteso riduttivamente come dolore transeunte, senza alcuna considerazione delle perdite permanenti della integrità e della solidarietà familiare, che pure erano intrinseche alle circostanze dedotte dai ricorrenti). Sulla bilancia della gravità il peso del danno parentale doveva essere esattamente compiuto, posto che sull’altro piatto dell’equità il giudice poneva il peso del criterio della valutazione personalizzante, che deve avvicinarsi, il più possibile al preciso ammontare del danno. Ma la scelta di questo secondo peso, perfettamente equilibratore è totalmente mancata. Un solo verbo : importa. C’é una assoluta contraddittorietà, manca la prudente discrezionalità, manca il criterio informatore della personalizzazione. Se anche il legislatore del codice delle assicurazioni ha mantenuto il rispetto dei principi regolamentatori della materia del danno morale come danno non patrimoniale, aderendo alla giurisprudenza della Cassazione, peraltro condivisa dalla Corte Costituzionale (sentenza 233/03) non si vede come, nella motivazione, necessariamente analitica e circostanziata, del giudice del merito, non appaia un chiaro riferimento ad un parametro equitativo che consideri la entità del danno morale, accertato in misura lieve, grave, gravissima, e la traduca in un congruo equivalente economico, paragonato a tale entità. Il sistema della congrua offerta, introdotto nelle leggi RCA e quindi consolidato come principio dì esatto adempimento, negli articoli 148 e 149 del codice delle assicurazioni, evidenzia il principio generale che l’impresa solidale è tenuta a fare una offerta adeguata all’insieme dei danni, patrimoniali e non patrimoniali (incluso il danno biologico) pur nei limiti del massimale. Orbene il massimale prevede il ristoro del danno da morte, che si estende anche ai familiari, ed indica una cifra elevata (anche nel minimo tabellare di legge). Il parametro di valutazione equitativa del danno morale parentale deve dunque partire dalla soglia della gravità e della permanenza degli effetti del danno ingiusto, nei termini come sopra precisati, e potrà utilizzare i parametri tabellari utilizzati attualmente dai Tribunali o dalle Corti, rispettando il principio della personalizzazione ed il criterio equitativo dell’approssimazione al preciso ammontare, così come potrà utilizzare, sempre orientativamente, le tabelle nazionali di prossima approvazione proprio nell’ambito delle lesioni gravi di cui all’articolo 138 del codice delle assicurazioni. Quello che il giudice di merito non può fare è la applicazione automatica delle tabelle, sia convenzionali che nazionali, le quali sono state concepite per la stima del danno biologico, il quale è per natura e per essenza, la lesione della integrità psicofisica, mentre il danno morale è per natura ed essenza la lesione della integrità morale, dove il termine “integrità” scelto dalla Costituzione europea per descrivere il valore universale e cristiano della dignità umana, esprime la centralità dell’uomo nell’ordine costituzionale della unione europea, di cui siamo Stato membro e fondatore. Alla luce di queste considerazioni la censura dei ricorrenti merita accoglimento, e la sentenza di appello viene cassata con rinvio alla Corte di appello di Reggio 146 Calabria che si atterrà ai principi di diritto come sopra formulati, per la corretta valutazione del danno parentale morale diretto, provvedendo anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione. P.Q.M. Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale, cassa in relazione e rinvia anche per le spese dì questo giudizio di cassazione alla Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma il 6 aprile 2006. Depositata in cancelleria il 12 luglio 2006. -Se il nonno muore i nipoti possono avere diritto al risarcimento del danno. Suprema Corte di Cassazione Sezione terza civile Sentenza 16 febbraio- 15 luglio 2005, n. 15019 (Presidente Duva – relatore Mazza) Svolgimento del processo A seguito di incidente stradale, cagionato da L. Maria, alla guida di una autovettura di proprietà di M. Cesare ed assicurata presso la soc. La Fondiaria, decedeva G. Alvaro e i suoi nipoti , discendenti in secondo grado, tali B. Silvia, B. Alberta, B. Francesco, G. Alessandro, G. Davide, P. Cinzia, B. Andrea e P. Nello adivano il Giudice di pace di Lucca per ottenere la condanna del M., della L. e della soc. La Fondiaria al risarcimento dei danni da loro rispettivamente subiti per la morte del nonno. Il Giudice di pace, con sentenza 20 febbraio 1997, accoglieva la domanda, che era, invece, rigettata dal Tribunale di Lucca, con sentenza 4 maggio 2001, pronunciata su appello della soc. La Fondiaria. Il Tribunale riteneva infatti che non fosse stata data prova di grave turbamento degli appellati in conseguenza dell’evento dannoso. Avverso tale sentenza B. Silvia e gli altri nipoti del G. propongono ricorso per cassazione con due mezzi di gravame. Gli intimati non svolgono difese. Motivi della decisione Il Tribunale ha osservato che il Giudice di pace ha erroneamente fondato la sua decisione unicamente sulle dichiarazioni rese dalle parti in risposta a libero interrogatorio e, pertanto, non su prove in senso tecnico, ma su elementi che non costituiscono neppure indizi sui quali fondare la prova per presunzioni; che l’unico teste escusso ha riferito di normali rapporti tra nonno e nipoti, cosicché non è dimostrato il grave turbamento degli allora appellati, per difetto di prova, e non potendosi trarre argomento di decisione dal solo rapporto di parentela. Ha ancora rilevato, contro l’accoglimento della domanda, doversi tener conto dell’età della vittima e della mancanza di convivenza tra questa e i nipoti. Con il primo mezzo di gravame i ricorrenti lamentano il vizio di omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, osservano che il giudice a quo ha omesso di valutare pienamente la deposizione resa dal teste G., dalla quale risultava la vicinanza psicologica e gli stretti rapporti tra nonno e nipoti. Riportano nel ricorso tale deposizione con la quale la G. ebbe a riferire di rapporti improntati a vicendevole affetto, e di scambio di frequenti visite e di regali, precisando altresì che il defunto G. era solito andare a caccia con i nipoti. Censurano altresì l’assunto del Tribunale, 147 secondo cui il giudice di prima istanza avrebbe fondato la sua decisione unicamente sulle risultanze del libero interrogatorio degli attori e non su prove in senso tecnico. Affermano che tale motivazione è palesemente errata, giacché consolidata giurisprudenza attribuisce valore probatorio alle dichiarazioni così raccolte nel processo, specie quando questo si svolge avanti al giudice di pace. Con il secondo mezzo di gravame, i ricorrenti lamentano violazione di legge per erronea e restrittiva applicazione della normativa in tema di risarcimento del danno da illecito aquiliano, avendo il giudice a quo tenuto conto soltanto della mancanza del requisito della convivenza. Le due censura, da esaminare congiuntamente perché strettamente connesse, meritano accoglimento. Come affermato da Cassazione, terza, 16716/03, la morte di un congiunto, conseguente a fatto illecito, configura per i superstiti del nucleo familiare un danno non patrimoniale diretto ed ingiusto, costituito dalla lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, perché la perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale. Risulta quindi evidente, da siffatta impostazione, che il danno in questione, incidendo esclusivamente sulla psicologia, sugli affetti e sul legame parentale esistente tra la vittima dell’atto illecito e i superstiti, non è riconoscibile se non attraverso elementi indiziari e presuntivi, che, opportunamente valutati, con il ricorso ad un criterio di normalità, possano determinare il convincimento del giudice. Cosicché appare illogica, perché contraria a principi di ordinaria razionalità, la pretesa, avanzata dal giudice a quo, circa la necessità di “una prova in senso tecnico” a dimostrazione del dolore dei superstiti, che, essendo sostanzialmente un sentimento, e, comunque, un danno di portata spirituale, può essere rilevato soltanto in maniera indiretta. L’assunto del Tribunale, secondo cui le dichiarazioni rese dalle parti in risposta al libero interrogatorio non costituiscono neanche indizi su cui fondare la prova per presunzioni, costituisce erronea interpretazione dell’articolo 117 Cpc. Infatti, secondo Cassazione, terza, 15849/01, “le dichiarazioni rese dalla parte nell’interrogatorio libero di cui all’articolo 117 Cpc, pur non essendo un mezzo di prova, possono essere fonte, anche unica, del convincimento del giudice di merito, al quale è riservata la valutazione, non censurabile in sede di legittimità, se congruamente e ragionevolmente motivata, della loro concludenza e attendibilità (conformi, Cassazione, seconda, 7002/00; Cassazione, prima. 10497/98; Cassazione, seconda, 7644/94). Così il giudice a quo avrebbe dovuto esaminare tali dichiarazioni, sulle quali era fondata in tutto o in parte la decisione di primo grado, e dare conto delle sue valutazioni su di esse, anziché definirle, sbrigativamente ed erroneamente, come irrilevanti. La sentenza impugnata presenta, pertanto, sotto tale profilo, anche il vizio di omessa motivazione. Ma, oltre agli elementi desumibili dall’esito dell’interrogatorio libero, era a disposizione del Tribunale anche la deposizione della Gisuti, riportata nel ricorso, come in precedenza precisato. Detta deposizione è stata ritenuta in conferente dal giudice del gravame con l’assunto secondo cui il teste “ha riferito di normali rapporti tra nonni e nipoti”. Tale affermazione contrasta con criteri di ragionevolezza e di comune esperienza. Proprio la sussistenza di normali rapporti, specie in assenza di coabitazione, lascia intendere come sia rimasto intatto, e come si sia forse rafforzato nel tempo, il legame affettivo e parentale tra prossimi congiunti. Legame che, in presenza di tali rapporti, è costruito non soltanto sul ricordo del passato, ma anche sulla base affettiva nutrita dalla frequentazione in atto e dalla consapevolezza della presenza 148 in vita di una persona cara, che è anche un punto di riferimento esistenziale. Sostenere il contrario significa pretendere, contro normale ragionevolezza, ed anche in presenza di un vincolo più stretto, come tra genitori e figli, che il dolore per la morte del congiunto debba essere dimostrato dalla presenza di rapporti di natura ed intensità eccezionali e, come tali, difformi dal vissuto comune. Né l’assenza di coabitazione può essere considerata elemento decisivo di valutazione sotto il profilo che interessa la presente causa, quando si consideri che tale assenza sia imputabile a circostanze di vita che non escludono il permanere dei vincoli affettivi e la vicinanza psicologica con il congiunto deceduto. Anche sotto tale profilo la motivazione appare illogica ed insufficiente. E’ pertanto necessario un nuovo e completo esame della fattispecie con valutazione che si attenga ai principi dettati dalla interpretazione delle norme ad essa applicabili. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Pisa. -Risarcibile il danno da morte del convivente. Tribunale di Arezzo, sentenza 2 febbraio 2005 n. 123; est. Dr. ssa Alessandra Guerrieri N.807/2000 RG N.1032/2000 RG N.1244/2000 RG N.1245/2000 RG TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile di Arezzo, nella persona del Giudice unico D.ssa Alessandra Guerrieri, ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale Conclusioni delle parti all’udienza del 5 ottobre 2004: L’Avvocato Federica Baldassarri, per l’attrice C. Silvana, conclude “come in atto di citazione, specificando il petitum in € 260.000,00”. L’Avvocato Dario Cappelli, per la Nuova Tirrena SpA, conclude nel modo seguente: “Premette quanto già risulta dagli atti e cioè che l’unica controversia da risolvere è la richiesta di risarcimento danni di C. Silvana, poiché tutte le richieste degli altri attori sono già state definite con transazione e gli altri attori hanno dichiarato di rinunziare alla loro originaria richiesta e quindi cessata la materia del contendere. Con riferimento alla richiesta di risarcimento danni di C. Silvana conclude come da comparsa di costituzione.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, F. Roberto, F. Massimo, F. Paolo e Rosina Velina D., rispettivamente fratelli e madre di F. Fausto, convenivano in giudizio la Nuova Tirrena SpA e R. Cyril per sentirli condannare al risarcimento, in solido, dei danni sofferti a causa del decesso del loro congiunto, occorso in 149 seguito all’incidente stradale verificatosi in data 12 settembre 1998 tra la Renault Clio targata L84859 condotta da F. Fausto e la Fiat Coupè targata XXXXXcondotta e di proprietà di R. Cyril, assicurata con la compagnia Nuova Tirrena SpA. Gli attori, premesso che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva del conducente la Renault Clio, il quale aveva invaso l’opposta corsia di marcia per effettuare un sorpasso in zona vietata ed a velocità superiore al limite di 50 Km/h, quantificavano i danni subiti - morali e biologici, anche jure successionis - in £.460.000.000 quanto alla madre ed in £.150.000.000 quanto a ciascuno dei fratelli, oltre interessi e rivalutazione. Instaurato il contraddittorio, si costituivano entrambi i convenuti, senza contestare l’esclusiva responsabilità del R. nella causazione del sinistro ma, soltanto, l’entità dei danni quantificati dagli attori, ritenendo, in particolare, che non fosse dovuto né il risarcimento del danno biologico lure successionis, dal momento che Fattura Fausto - era deceduto istantaneamente in occasione dello scontro frontale con la vettura antagonista, né quello relativo al danno biologico iure proprio, ritenuto insussistente. I convenuti chiedevano, pertanto, che fosse dichiarata equa e risarcitoria la somma di £.230.000.000 già corrisposta agli attori, con vittoria di spese ed onorari. Con autonomo atto di citazione, notificato in data 15/16 febbraio 2000, C. Silvana conveniva in giudizio la Nuova Tirrena SpA e R. Cyril per sentirli condannare, in solido, al risarcimento di tutti i danni morali e materiali subiti in conseguenza dello stesso sinistro causa del decesso di F. Fausto, quantificati nella somma complessiva di £.480.000.000, salvo il più o il meno di giustizia, oltre rivalutazione, interessi e spese di lite. Premetteva l’attrice che, al momento del sinistro, si trovava trasportata nell’ auto condotta da F. Fausto e che aveva riportato lesioni dalle quali era derivata una malattia protrattasi sino al 17 febbraio 1999, con postumi permanenti valutabili nella misura del 25%; la C. sottolineava, altresì, che, sino al tragico incidente, aveva convissuto more uxorio con il F., al quale era legata dal 1992 e si sarebbe presto unita in matrimonio. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la sola Nuova Tirrena SpA, mentre R. Cyril rimaneva contumace. La compagnia assicuratrice, senza contestare l’an debeatur, chiedeva che fosse ritenuta risarcitoria la somma di £.80.000.000 che la Nuova Tirrena SpA aveva già corrisposto a C. Silvana. Distinti procedimenti venivano altresì instaurati a seguito degli atti di citazione notificati alla Nuova Tirrena SpA e a R. Cyril da F. Raffaello, altro fratello di F. Fausto, e da F. Remo, padre del medesimo, i quali chiedevano entrambi il risarcimento dei danni materiali, morali e biologici subiti in conseguenza del decesso del loro congiunto, rispettivamente quantificati in £.134.549.487 e £.584.845.275. In entrambi i procedimenti, i convenuti si costituivano limitandosi a chiedere che fosse riconosciuta equa e risarcitoria la somma rispettivamente offerta agli attori (£.20.000.000 quanto a F. Raffaello e £.165.000.000 quanto a F. Remo). Disposta la riunione di tutti i procedimenti sin qui elencati, venivano espletati CTU medico-legale, interrogatorio formale di F. Massimo e prove testimoniali. All’udienza del 16 settembre 2003, l’Avvocato Leonessi dava atto di aver transatto la vertenza relativa a F. Roberto, F. Massimo, F. Paolo e D. Rosina Velina, dovendosi quindi ritenere cessata la materia del contendere. Analoga dichiarazione veniva effettuata dall’ Avvocato Federica Baldassarri con riferimento a F. Remo e F. Raffaello all’udienza del 17 dicembre 2003. Quindi, 150 sulle conclusioni delle parti relative al solo procedimento n.1032/2000 (attrice C. Silvana), la causa veniva assegnata a sentenza allo scadere dei termini concessi per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE In primo luogo, stante le intercorse transazioni, deve dichiararsi cessata la materia del contendere nelle controversie promosse, rispettivamente, da F. Roberto, F. Massimo, F. Paolo, D. Rosina Velina (Procedimento N.807/2000 RG), F. Raffaello (Procedimento N.1444/2000 RG) e F. Remo (Procedimento N.1445/2000), con compensazione integrale delle spese di lite. Non essendovi, altresì, contestazione alcuna sulla dinamica del sinistro e, quindi, sulla esclusiva responsabilità di R. Cyril nella causazione del medesimo, la presente decisione dovrà vertere, soltanto, sulla quantificazione del danno subito da C. Silvana. Al riguardo, occorre in primo luogo evidenziare che parte attrice, la quale si trovava a bordo dell’autovettura condotta da F. Fausto al momento del sinistro, ha subito lesioni personali da cui sono derivati danni biologici, morali e materiali, dei quali è stato chiesto l’integrale risarcimento. Ma, principalmente, viene in rilievo il profondo legame affettivo che, in vita, legava F. Fausto a C. Silvana, la cui perdita ha indubbiamente determinato un grave danno, del quale parte attrice ha chiesto di essere integralmente risarcita sotto il profilo tanto biologico, che morale ed esistenziale. Quanto al danno biologico, va ricordato quanto emerso dalla CTU medico legale espletata in corso di causa. Afferma il Dr. Caruso (pagg. 5/7 della relazione): “In primo luogo l’evento infortunistico in oggetto ha prodotto con meccanismo traumatico diretto ... la F. traumatica di due archi costali e del corpo dello sterno.., la paziente ha subito anche violento trauma distorsivo a carico del rachide cervicale, con i caratteri biodinamici propri del colpo di frusta... Quanto al danno biologico subito in conseguenza del lutto sofferto per la morte del convivente... si è potuto con certezza individuare un marcato stato depressivo patologico, instauratosi nell’immediatezza del tragico evento del 12.9.1998, con caratteri di noxa patogena ormai cronicizzata all’esperienza elaborata del lutto e, pertanto, la malattia depressiva che ne è derivata nella persona della paziente in concreto costituisce una stabile ed inemendabile patologia, emersa nell’immediatezza dell’evento luttuoso e successivamente strutturatasi con i caratteri che sono patognomonici del disturbo post-traumatico da stress cronico. Quanto surriferito e descritto, in definitiva, ha consentito di accertare che, allo stato attuale, in associazione agli esiti di F. costale e sternale, sulla persona della signorina C. si rileva evidente patologia di natura psichiatrica, clinicamente espressa da un complesso sintomatologico soggettivo ed oggettivo, produttivo di reale e consistente disagio psicofisico, negativamente incidente sul livello di autostima, ovvero caratterizzato da patologiche manifestazioni inquadrabili nell’ambito di turbe della cenestesi.. La psicoterapia alla quale la paziente ancora, sporadicamente, si sottopone e che può essere definita di sostegno per i momenti di maggiore incidenza psico-emozionale, tenuto conto del tempo trascorso dall’epoca dell’evento traumatico e luttuoso, può soltanto attenuare, transitoriamente, i sintomi patognomici più manifesti della depressione quale malattia nosologicamente ormai stabilizzata... Accanto agli esiti del danno distorsivo della cerniera cervicale e F.tivo costale e sternale, il quadro psicoclinico di rilievo attuale, si configura, pertanto, come malattia, ovvero come sindrome depressiva cronica, conseguita a disturbo post-traumatico da violento stress.” Secondo il consulente, “a seguito dell’incidente del 12 settembre 1998, si è 151 realizzato uno stato d’invalidità temporanea biologica protrattosi per complessivi giorni cento di cui giorni sessanta di invalidità temporanea totale e giorni quaranta d’invalidità temporanea parziale... A conclusione dello stato di malattia sono residuati postumi a carattere permanente (che) per natura e grado, nel loro complesso, incidono negativamente sulla validità psico-fisica della paziente, in misura pari al 21% del totale, quale danno biologicamente inteso” (pag. 8 della relazione). Le conclusioni del medico legale appaiono pienamente condivisibili in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e vizi giuridici. In particolare, non appare meritevole di accoglimento la tesi di parte convenuta secondo cui il danno biologico rilevato dal CTU sarebbe in misura preponderante attinente ad una sintomatologia soggettiva, destinata a risolversi con il passare del tempo, stante la giovane età di C. Silvana: ed infatti, come ampiamente motivato dal Dr. Caruso nella sua consulenza, la sindrome neuro-astenica depressiva rilevata nella persona di parte attrice è configurabile come una vera e propria malattia ormai cronicizzata, e pertanto invalidante, in quanto causa di un danno permanente all’integrità psico-fisica. Tra i possibili criteri di liquidazione del danno alla salute adottati dalla giurisprudenza, si ritiene, in aderenza all’indirizzo da tempo affermatosi in questo Tribunale, di adottare quello basato sull’attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente, per determinare il quale si tiene conto contemporaneamente della percentuale di invalidità riconosciuta e dell’età del leso al momento del sinistro. Dal momento che l’entità del danno, sotto il profilo della lesione del diritto alla salute, si coglie anche in relazione al consolidamento dei postumi riduttivi della integrità, e dunque, della durata della malattia - che comporta, di necessità, la temporanea sospensione delle pregresse facoltà di realizzazione del soggetto leso nei vari aspetti esistenziali - la indispensabile completezza del risarcimento impone anche di liquidare una somma per ogni giorno di effettiva inabilità temporanea. Tenuto conto delle tabelle applicate da questo Tribunale, e delle conclusioni della CTU (innanzi ampiamente esposte) il danno biologico può così essere liquidato in un importo, in moneta attuale, pari ad € 2.730,13 per il punto di riduzione della integrità psico-somatica, con abbattimento dello 0,855 in considerazione dell’età di C. Silvana al momento del sinistro, ed a € 52,00 per ogni giornata di inabilità temporanea totale. Il danno alla salute, quantificato secondo i criteri appena esposti, ammonterà quindi a complessivi € 53.151,48 - importo espresso in moneta corrente, quindi già rivalutato. Quanto al danno morale, spettante all’attrice ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.li 2059 cc e 185 II comma cp, appare opportuno operare un’unica quantificazione, con riferimento tanto alla sofferenza inerente alla malattia conseguita al sinistro oggetto di causa quanto al turbamento provocato dalla morte del congiunto, in modo da evitare indebite duplicazioni: ed infatti, come innanzi ampiamente esposto, soltanto in misura modesta il danno permanente biologico evidenziato dal CTU va ricondotto alle lesioni personali riportate dalla C. nel sinistro, essendo prevalentemente riconducibile all’evento luttuoso che ne è conseguito. Nel determinare la misura del danno morale, occorre anzitutto ricordare che, 152 secondo un principio giurisprudenziale ormai consolidatosi, “il diritto al risarcimento da fatto illecito concretatosi in un evento mortale va riconosciuto anche al convivente more uxorio del defunto stesso, quando risulti concretamente dimostrata siffatta relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza” (cfr, per tutte, Cass. n.2988 del 18 marzo 1994). In proposito, è pacifico che C. Silvana e F. Roberto, sin dagli ultimi mesi del 1997, convivessero in un’abitazione condotta in locazione nel Comune di Scandicci; dalle testimonianze raccolte è altresì emerso che i due giovani avevano acquistato assieme in mobili per l’arredo e dividevano tutte le spese relative alla vita quotidiana. Ma vi è molto di più: tutti i testimoni hanno infatti riferito come, tra i due giovani, vi fosse una sostanziale condivisione di ogni aspetto di vita sin dall’ inizio del fidanzamento, risalente al 1992. E’ emerso, al riguardo, che C. Silvana e F. Fausto si erano fidanzati dopo essersi conosciuti all’università, dove entrambi frequentavano la facoltà di Ingegneria; dal novembre 1992, F. Fausto aveva cominciato a condividere con C. Silvana l’alloggio universitario di quest’ultima, dormendo nel suo stesso letto e dividendo con lei tutte le spese. I due giovani avevano portato avanti gli studi assieme ed assieme trascorrevano anche i fine settimana ed i periodi di vacanza, quasi sempre presso i genitori di Silvana, i quali, sin dal 1993, avevano allestito nella loro abitazione una apposita camera matrimoniale. F. Fausto e C. Silvana, laureatisi lo stesso giorno, si sarebbero sposati a breve, avendo in animo dì farlo non appena entrambi avessero potuto contare su un lavoro stabile, circostanza che, al momento del sinistro, si era da poco verificata. Tutte queste circostanze, emerse in modo univoco dalle numerose testimonianze raccolte in corso di causa (cfr. dichiarazioni rese da V. Giulio, T. Luca, C. Barbara, F. Concetta, F. Laura, C. Mirella e M. S.i), evidenziano la particolare intensità e stabilità del rapporto affettivo che legava i due giovani. Non può quindi condividersi l’impostazione di parte convenuta secondo cui quella in esame sarebbe nulla più di una breve convivenza tra due studenti neolaureati. Al contrario, dagli elementi emersi in corso di causa risulta che il legame intercorrente tra F. Fausto e C. Silvana era in tutto e per tutto equiparabile a quello coniugale. Ciò che univa i due giovani costituiva un progetto ormai definitivamente consolidato nelle reciproche aspettative. E la giovane età di parte attrice non vale certo ad attenuare il dolore per la perdita del compagno, ed anzi lo accresce, dal momento che la medesima ha visto cancellato in modo improvviso e brutale, per il gesto sconsiderato di un’automobilista impaziente, l’intero suo futuro, così come da tempo immaginato e desiderato. Prima di passare alla quantificazione del danno morale subito da C. Silvana, occorre tuttavia valutare se, a questa, spetti anche il risarcimento del danno c.d. esistenziale. Parte convenuta ha eccepito che una tale richiesta è stata espressamente avanzata dall’attrice soltanto nella comparsa conclusionale, e quindi tardivamente. Al riguardo, va osservato che, nell’atto introduttivo, C. Silvana non solo ha chiesto genericamente “il risarcimento di tutti i danni morali e materiali, compreso il danno biologico e/o alla salute,” subiti in conseguenza del sinistro, ma, nella parte espositiva, ha anche lamentato “il nocumento della qualità della vita” che ne era derivato - utilizzando un’espressione che rimanda, direttamente, al presupposto tipico del danno c.d. esistenziale. Ad ogni modo, la errata qualificazione del danno per la privazione del rapporto 153 familiare non può essere considerata ostativa al riconoscimento del danno c.d. esistenziale, essendo comunque dovere del giudice individuare quale sia il bene protetto che si assume essere stato leso nonché il contenuto sostanziale della pretesa e la finalità che la parte intende perseguire in concreto. E, nel caso in esame, dal tenore complessivo dell’atto introduttivo emerge in modo evidente la volontà di ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro oggetto di causa, in tutte le possibili espressioni in cui gli stessi possano configurarsi, ivi comprese quelle inerenti lo sconvolgimento della normale vita familiare. Ciò posto, occorre ricordare che il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’uccisione di un congiunto lamenta il pregiudizio ad un interesse giuridico diverso sia dal bene salute del quale è titolare, la cui tutela ex art.lo 31 Cost. si esprime mediante il risarcimento del danno biologico, sia dall’interesse all’integrità morale, che trova riparazione mediante il risarcimento del danno morale soggettivo. Ed infatti, “l’interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt.li 2, 29 e 20 Cost. Si tratta di interesse protetto e di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell’art.lo 2043 cc, nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad un risarcimento (o meglio, ad una riparazione) ai sensi dell’art.lo 2059 cc, senza il limite previsto in correlazione all’art. 185 cp.... Il danno in questione deve essere nato e provato. Trattandosi tuttavia di pregiudizio che si proietta nel futuro (diversamente dal danno morale soggettivo contingente), dovendosi avere riguardo al periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che l’illecito ha invece reso impossibile, sarà consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che sarà onere dei danneggiato fornire. La sua liquidazione, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa, tenuto conto dell’ intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriori utile circostanza.. Ed è appena il caso di notare che il danno non patrimoniale, da perdita del rapporto parentale, in quanto ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo contingente, può essere riconosciuto a favore dei congiunti unitamente a quest’ultimo, senza che possa ravvisarsi una duplicazione del risarcimento. Ma va altresì precisato che, costituendo nel contempo funzione e limite del risarcimento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, dovrà considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli va riconosciuta, poiché, diversamente, sarebbe concreto il rischio di duplicazione del risarcimento. In altri termini, dovrà il giudice assicurare che sia raggiunto un giusto equilibrio tra le varie voci di danno che concorrono a determinare il complessivo risarcimento” (Cass, Sentenza 7-31 maggio 2003 n.8828). Nell’applicare al caso in esame i principi affermati in materia dalla Suprema Corte, va osservato che gli elementi probatori forniti da parte attrice (in primis, le dichiarazioni testimoniali innanzi ricordate) consentono di ritenere senz’altro 154 comprovato il pregiudizio lamentato da C. Silvana per la perdita del danno c.d. esistenziale può essere equitativamente determinato nella misura di € 80.000,00, mentre il danno morale (nell’ottica di evitare indebite duplicazioni) potrà essere quantificato nell’importo di € 160.000,00 - somme entrambe liquidate in moneta attuale e, quindi, non soggette a rivalutazione. Inoltre, sono state documentate spese per prestazioni mediche (cfr. documenti prodotti e non contestati), riconosciute necessarie dal consulente, il quale ha precisato di non prevederne altre nel futuro. A C. Silvana vanno pertanto riconosciuti ulteriori € 401,18 - importo che dovrà essere maggiorato per effetto della rivalutazione monetaria. Competono inoltre gli interessi legali che, in conformità con l’indirizzo seguito dalla più recente giurisprudenza a partire dalla sentenza delle SS.UU. n.1712/95, andranno calcolati sul capitale di anno in anno rivalutato (e, quindi, per quanto riguarda il danno biologico, morale ed esistenziale, sulla somma devalutata al dì del sinistro e rivalutata anno per anno in base agli indici Istat). Occorrerà, infine, tener conto di quanto già corrisposto a parte attrice dalla Nuova Tirrena SpA, pari a £.80.000.000 (ora € 41.316,55) da imputare al capitale calcolato alla data di corresponsione (5 maggio 2000). Sulla somma complessiva, come sopra determinata, decorreranno, a partire dalla data della presente decisione e fino all’effettivo soddisfo, gli interessi legali. Le spese di lite, liquidate secondo dispositivo, seguono la soccombenza. Le spese della CTU relativa alla persona di C. Silvana vanno definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido tra loro. P.Q.M. Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da F. Roberto, F. Massimo, F. Paolo e Rosina Velina D. (Procedimento n.807/2000), C. Silvana (procedimento n.1032/2000), F. Raffaello (procedimento n.1244/2000) e F. Remo (procedimento n.1245/2000) nei confronti di Nuova Tirrena SpA e R. Cyril, ogni avversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: A) dichiara cessata la materia del contendere nei procedimenti n.807/2000, n.1244/2000 e n.1245/2000; compensando per intero tra le parti le spese di lite; B) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di C. Silvana delle seguenti somme, dal cui importo complessivo dovrà, essere detratta la somma di € 41.316,55, da imputare al capitale calcolato alla data del 5 maggio 2000: - € 293.151,48 a titolo di danno biologico, morale ed esistenziale, oltre interessi legali calcolati sulla somma devalutata al dì del sinistro e rivalutata anno per anno in base agli indici Istat dal dì del sinistro alla data della presente decisione, nonché ulteriori interessi legali dalla presente decisione sino al saldo effettivo; - € 401,18 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione sulla base degli indici Istat ed interessi legali dal dì del sinistro alla présente decisione, calcolati sulla somma capitale rivalutata anno per anno in base agli indici Istat, nonché ulteriori interessi legali dalla presente decisione al saldo effettivo, C) condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite,liquidate in complessivi € 13.827,29 di cui € 1.822,29 per esborsi (comprese spese di CTP) ed il resto per diritti ed onorari, oltre accessori come per legge; D) pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese della CTU relativa alla persona di C. Silvana. Così deciso in Arezzo il 2 febbraio 2005 Il Giudice 155 Dr.ssa Alessandra Guerrieri -Non è risarcibile il danno biologico da morte immediata Cassazione civile sezione III 25 gennaio 2002, n. 887 Pres. Giustiniani – Rel. Petti - P.M. Golia (conf.) Polo c. Zurigo Assic. S.p.A. Svolgimento del processo Il 20 gennaio 1995 vittima di un investimento automobilistico, avvenuto in Treviso, decedeva Crosato Maria, di anni 34, lasciando il marito vedovo di trentanove anni ed orfani i due figli di 11 e 5 anni, ed una numerosa parentela costituita dai genitori e da ben quindici fratelli. Tutti costoro (il marito Paolo Martino, in proprio e nell’interesse dei minori Elisa e Matteo; i genitori Crosato Pietro e Biscaro Antonietta, ed i quindici fratelli, Crosato Emilio, Bruno, Raffaella, Renato, Fiorenza, Chiara, Pierluigi, Stefano, Mirco, Massimiliano, Dino, Michele, Loretta, Felice, Roberta) convenivano in giudizio dinanzi al tribunale di Treviso, con citazione del 30 ottobre 1995, Pastrello Fiorella, conducente del veicolo investitore, Pastrello Gaetano proprietario e responsabile civile, e la Minerva Assicurazioni (ora Zurigo Assicurazioni S.p.A.) chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni conseguenti alla morte della propria congiunta, secondo le varie qualità e le voci specificate. I convenuti si costituivano e contestavano il fondamento delle pretese: in particolare l’assicuratrice deduceva di aver già corrisposto la somma di 540 milioni di lire, cui aggiungeva, nel corso della lite, in favore del vedovo e dei minori, ulteriore somma per 100 milioni. I convenuti Pastrello inoltre chiamavano in garanzia l’assicuratrice per la mala gestio, per esserne manlevati nel caso di condanna oltre i limiti del massimale. Istruita la lite e riconosciuta la responsabilità esclusiva del conducente dell’auto, il tribunale con sentenza 1176/97, condannava in solido i convenuti al pagamento di vari importi (vedi amplius in dispositivo) tenendo conto delle varie qualità parentali; operava quindi un conguaglio tra le somme versate dall’assicuratrice, pervenendo alla determinazione delle somme ancora dovute. Il giudice trevigiano qualificava come danno biologico la perdita del rapporto maritale, filiale e di parentela, così riconoscendo la legittimazione passiva agli stretti congiunti (marito e figli, cui attribuiva una specifica posta di danno: 80 156 milioni al marito e 50 milioni a ciascuno dei figli). La sentenza era impugnata: a) con appello principale, dalla società assicuratrice, con l’adesione del danneggiante e responsabile civile; b) con appello incidentale dagli attori aventi causa dalla defunta (vedi atto del 1 maggio 1998) in particolare sui punti: 1. incongruità della liquidazione al marito del danno patrimoniale da lucro cessante per la perdita del contributo dell’attività familiare della casalinga (liquidato in 132.184.000 milioni di lire); 2. incongruità della liquidazione del danno per la perdita del rapporto parentale e del godimento del congiunto, da considerare come danno riflesso, ma dovuto iure proprio agli stretti congiunti in misura superiore al liquidato (80 milioni al marito e 50 milioni a ciascun figlio); 3. incongruità delle somme liquidate a titolo di danno morale al marito (100 milioni) ed ai figli (80 milioni) con riferimento ad altri precedenti di altre corti; 4. veniva poi censurato il calcolo degli interessi e della rivalutazione sulle somme liquidate, contestandosi i criteri della "anomala" sentenza della sezioni unite 1712/95. Con sentenza del 9 dicembre 1998 la Corte di appello di Venezia così decideva: a) accoglieva il primo motivo dell’appello principale e per l’effetto, in particolare riforma della sentenza impugnata, esclude dagli importi risarcitori riconosciuti agli appellanti Polo Martino, Elisa, Matteo, Crosato Pietro e Biscari Antonietta, quelli non dovuti attribuiti ai medesimi a titolo di danno biologico; respinge l’appello incidentale; conferma il regolamento delle spese di lite adottato in primo grado, ponendo la metà residua a carico degli appellati. Contro la decisione ricorrono tutti gli aventi causa della defunta, deducendo articolati motivi di ricorso; resiste la assicuratrice con controricorso; non hanno svolto difese Pastrello Gaetano e Fiorella. Motivi della decisione I motivi di ricorso, nel loro apparente ordine, recano una serie di argomenti e censure che non si coordinano esattamente con la numerazione data, onde l’unico criterio possibile è quello della loro considerazione esaustiva. Inoltre, ai fini dell’effetto devolutivo delimitato del ricorso, dovrà tenersi conto dei motivi svolti nell’appello incidentale (del 1 maggio 1998) di cui si è dato cenno in narrativa. Nel primo motivo di ricorso si deduce, complessivamente, il difetto di "qualsiasi vera motivazione" da parte della corte veneta. 157 Il motivo è inammissibile per la sua estrema genericità, anche se intesa è la vis polemica. Nel secondo motivo si deduce la violazione di legge e l’abnormità del provvedimento con il quale il presidente della Corte di appello (con ordinanze del 4 aprile ed 8 giugno 1998) ha sospeso la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado. Il motivo è inammissibile in sede di ricorso avverso la sentenza di appello, perché i provvedimenti de quo, emessi ai sensi degli artt. 282 e 283 c.p.c., novelli, in deroga all’art. 5-bis della legge 39/1977, come provvedimenti abnormi sono autonomamente ricorribili in cassazione, ma nei termini ordinari di legge per le impugnazioni, tenendosi conto del fatto che le ordinanze sono state comunicate alle parti. Difetta inoltre l’interesse a ricorrere dal momento che la corte adita dovrà statuire sul ricorso determinando o un rinvio o un giudicato interno tra le parti. Nel secondo motivo (2-bis, a pagina 10 del ricorso) si deduce l’error iuris per la complessiva liquidazione dei danni da morte a tutte le vittime parentali, sul rilievo che il defunto trasmetterebbe ai suoi aventi causa (prossimi congiunti, inclusi gli agnati ed i germani), un danno patrimoniale diretto, valutabile secondo i criteri desunti dall’articolo 4 della legge 39/1977 ovvero dai criteri indennizzatori indicati in polizza Rca (come massimale minimo obbligatorio per persona). Il motivo, per quanto suggestivamente argomentato, presenta un profilo di inammissibilità rispetto ai motivi formulati in appello (primo e secondo motivo dell’appello incidentale) ed è comunque infondato, posto che è consolidata la giurisprudenza di questa corte e della stessa Corte costituzionale, sul punto della non risarcibilità del danno tanatologico da morte immediata o da lesione mortale seguita da morte immediata, non potendo il defunto trasmettere, per la perdita della propria capacità giuridica, il diritto di credito consequenziale alla perdita della vita (cfr. da ultimo: Cass. 1704/97; Cass. 13336/99; Cass. 2134/00, tra le tante). Non può dunque trovare applicazione analogica, non essendovi una lacuna giuridica da colmare, essendo il bene della vita costituzionalmente protetto (art. 2 Cost.) e penalmente sanzionato nella sua lesione, con conseguente risarcibilità del danno morale riflesso ai congiunti (art. 185 c.p. e 2059 c.c. correlati), il riferimento suggerito alla norma liquidatoria della r.c.a. (il citato art. 4 della legge 39/1977) od alle norme indennizzatorie di cui alla legge 990/69 da cui derivano i massimali in polizza. È certamente un suggerimento utile "de iure condendo", ove il legislatore italiano decida di seguire la legislazione internazionale in materia di trasporto aereo e navigazione, dove l’evento morte determina di per sé, come lesione del bene della vita, un quid da risarcire ai superstiti legittimati, a prescindere dall’immediatezza o meno dell’evento. Anche i recenti episodi di terrorismo internazionale rendono attuale la necessità di 158 una riforma legislativa più adeguata alla tutela del diritto alla vita, nella sede della responsabilità civile. Con il terzo motivo (il quarto secondo l’ordine effettivo) si deducono tre censure in relazione a tre voci di danno, di cui due liquidate ed una terza esclusa. Si deduce in particolare la sottovalutazione del danno morale al marito ed ai piccoli figli; la sottovalutazione del danno patrimoniale per la perdita della attività della giovane casalinga. Per entrambe le sottovalutazioni occorre rilevare come si tratti di una valutazione equitativa sul quantum debeatur, ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 2056 e 1226 c.c. Non si tratta cioè di una equità pura affidata alla discrezionalità del giudice, ma di una equità circostanziata di un danno certamente esistente (provato o non contestato per l’an) ma che deve essere valutato in concreto secondo una specifica deduzione ed indicazione di circostanze. Queste circostanze, per il vedovo e per i figli, certamente attengono alla perdita delle qualità della vita, insostituibile la figura del compagno amato e della madre verso i figli, ed essendo l’unità della famiglia ed il consorzio matrimoniale costituzionalmente protetti, ma la quantificazione della lesione attiene alla delimitazione del danno in concreto e questa è circoscritta nell’ambito delle norme richiamate per l’illecito civile ed il danno morale. La contestazione della sottovalutazione del danno dev’essere dunque articolata in modo tale da consentire al giudice di constatare la violazione del criterio di liquidazione equitativa, sia come vizio della motivazione che come violazione o disapplicazione della legge. Le censure, pur nel pathos che le anima, non appaiono dunque rispondere ai criteri sopra indicati e l’apprezzamento dei giudici del merito appare corretto ed adeguato alla equità in ordine al quantum debeatur. Quanto infine alla voce di danno esclusa dalla Corte di appello sul rilievo che non può essere attribuito un danno biologico riflesso (vedi dispositivo) occorre tener conto anche delle motivazioni che la corte offre nel contesto dell’accoglimento del gravame proposto sul punto dell’assicuratore (vedi motivazione ff. 11). La corte territoriale infatti concorda con l’insegnamento superiore che ammette per i congiunti il danno biologico riflesso (e cita i vari arresti, anche costituzionali), ma esclude che i congiunti abbiano fornito la prova di tale danno e del nesso di causalità tra tale danno e le lesioni sofferte dal defunto. Replica sul punto il ricorrente (così come aveva fatto nel secondo motivo dell’appello incidentale) che non è stato chiesto un danno biologico riflesso, come menomazione consequenziale della propria integrità psicofisica, ma un danno patrimoniale riflesso per la perdita del rapporto parentale e del godimento del congiunto. 159 Il motivo non è dunque nuovo, perché ripropone e rinvigorisce le censure già svolte in appello, ma è giuridicamente infondato. La pretesa dei superstiti, per la perdita del rapporto parentale e per la perdita del congiunto, ha certamente natura di danno edonistico, secondo una visione tipica del mondo anglosassone e della concezione estesa del danno morale (che talora e esemplarmente risarcito), ma nel nostro sistema di responsabilità civile si traduce appunto nel danno morale, come sofferenza e dolore per la perdita del caro estinto, mentre i danno consequenziali patrimoniali attengono alle perdite economiche che sono descritte in termini di anno emergente e di lucro cessante. Non è dunque possibile, nell’attuale sistema, una duplicazione del danno morale, in favore dei congiunti, mentre è doverosa una sua complessiva riconsiderazione, tenendo appunto conto della peculiarità degli effetti che la morte del proprio caro ha, per i singoli superstiti, con una valutazione equitativa prudente e circostanziata. In tal senso deve correggersi la motivazione data dai giudici del merito, che hanno considerato come danno biologico riflesso un danno prospettato in termini patrimonialistici, ma che attiene alla sfera morale e che è stato comunque correttamente escluso sotto il profilo del difetto di prova vedi ff. 11 della motivazione). Sussistono giusti motivi, in relazione alla natura e complessità delle questioni esaminate, per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite. PRINCIPIO DI INDIVISIBILITA’ DELLA SERVITU’ TRACCIA: Tizio era proprietario del fondo Alfa su cui 15 anni prima era stata costituita una servitù di passaggio a cario del fondo contiguo circostante due condomini (Beta e Gamma). Successivamente, sul fondo dominante Alfa, Tizio aveva realizzato un condominio venduto a Caio e Sempronio. Caio e Sempronio, poi, avevano venuto l’intero stabile a Sandrino. In alcuno degli atti di trasferimento era stato detto alcunché circa la servitù di passaggio. Un giorno, Sempronio si trovava a passare per il fondo dove era situato Gamma; un condomino di Gamma invitava, poi, Sempronio a non passeggiare su una proprietà privata. Sempronio si recava da un legale, per avere informazioni circa la servitù di passaggio gravante su Beta e Gamma. Il candidato rediga motivato parere sulla questione giuridica posta. 160 POSSIBILE SOLUZIONE SCHEMATICA: In premessa era utile ricostruire brevemente il fatto ed inquadrarlo nell’ambito del principio della cd indivisibilità della servitù. La servitù si definisce come un peso che grava su un fondo, cd servente, per l’utilità di un altro fondo, cd dominante: questa caratteristica della servitù comporta l’inerenza del diritto di servitù al fondo indipendentemente dalla titolarità del medesimo: in altri termini il diritto di servitù attiene ai fondi e ne costituisce una prerogativa, i titolari di un diritto di servitù sono, quindi, titolari di un diritto che inerisce ad un fondo, indipendentemente dalle vicende traslative che coinvolgono il fondo cui inerisce il diritto di servitù. Se si parte da questa impostazione si comprende il significato del cd principio di indivisibilità della servitù: in base a tale principio, desumibile dall’art. 1071 cc, comma 1, se il fondo dominante viene diviso, la servitù sussiste nella medesima portata per ciascuna delle porzioni del fondo diviso, sempre che tale situazioni non renda più gravosa la condizione del fondo servente. Dunque il trasferimento del fondo dominante a più soggetti, e il conseguente frazionamento non incide sul diritto di servitù che resta inalterato, e ciò a prescindere da espresse indicazioni in tal senso contenute nell’atto di trasferimento. Infatti, nel silenzio tra le parti, il diritto di servitù permane come qualitas fundi, e tale permanenza costituisce un effetto che si determina ex lege per il disposto dell’art. 1071, comma 1, cc, (sempre che non si abbia un aggravamento della posizione del fondo servente). Nel caso prospettato il fondo dominante Alfa è stato oggetto di un primo trasferimento da Tizio a Caio e Sempronio, e successivamente di un secondo trasferimento da Caio e Sempronio a Sandrino, in tali atti non è stato menzionato anche il contestuale trasferimento del diritto di servitù; tale mancanza, si ritiene, non possa costituire un limite all’esercizio del diritto di servitù da parte degli aventi causa del titolare del fondo dominante, per quanto precedentemente osservato. In particolare il primo trasferimento del fondo dominante ha comportato un frazionamento del medesimo che ai sensi dell’art. 1071, cc non comporta estinzione del diritto di servitù, ma continuazione del medesimo, salvo l’ipotesi di aggravamento della posizione del fondo servente (come ribadito da giurisprudenza recente). Tale aggravamento nel caso prospettato non dovrebbe sussistere in quanto l’esercizio di una servitù di passaggio non è predeterminabile e con una portata permanente a differenza, ad esempio, di una servitù di presa d’acqua che può essere di un ammontare predeterminato e permanente nel tempo. Circa il secondo trasferimento, occorre considerare che con esso il fondo ritorna nella sua consistenza originaria, e dunque, a fortiori, permane l’esercizio del diritto di servitù da parte del diverso titolare del fondo dominante. Infine, va precisato, che un’ eventuale azione di accertamento della servitù, volta a farne riconoscere l’esistenza contro chi ne contesta l’esercizio, ex art 1079 cc, potrà essere promossa da Sandrino e non da Sempronio, in quanto quest’ultimo non è più l’attuale titolare della servitù di passaggio in oggetto. 161 Si consiglia di leggere la seguente sentenza. -Si ha comunione impropria, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, ove il proprietario partecipi anch'egli per una determinata quota al godimento della cosa, insieme all'usufruttuario, ovvero quando su di un medesimo bene concorrano un diritto di proprietà ed uno di usufrutto, avendosi nella prima ipotesi una vera e propria comunione di godimento e, nella seconda un concorso di diritti reali differenti per tipo. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE SENTENZA 27-04-2005, n. 8727 (Presidente F. Pontorieri, Relatore U. Goldoni) Svolgimento del processo Con citazione del 7.8/2.9.1996,la C.M.T. spa., premessa una descrizione dello stato dei luoghi e delle facoltà e diritti spettanti a ciascuno dei soggetti fruenti, a titolo diverso della strada privata che da Via dell'Eremo conduce sino al Monastero della Visitazione, conveniva di fronte al tribunale di Napoli la Rai spa., il comune di Napoli, il Monastero della Visitazione, Ernesto D. e Raffaele M. per sentir dichiarare, per quanto qui ancora interessa, che tutte le parti godono, a titoli diversi, di passaggio veicolare e carrabile sulla predetta via e che nella fattispecie si applica la normativa dettata per la comunione e determinare le quote di partecipazione di tutti i soggetti alle spese per l'amministrazione, conservazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria della predetta strada; i convenuti, ad eccezione del M., si costituivano, resistendo, sotto diversi profili, alla domanda. Con sentenza in data 4/12.11.1999, il tribunale di Napoli, accolte le altre richieste della C.M.T., respingeva la domanda surriportata e compensava le spese. Proponeva appello la C.M.T. in ordine alla domanda rigettata; si costituivano gli appellati, ad eccezione del M., che chiedevano la reiezione del gravame; con sentenza in data 10/24.1.2001, la Corte di appello di Napoli rigettava l'impugnazione e compensava le spese. Rilevava la Corte partenopea che la pronuncia di accertamene dei diritti rispettivamente vantati dalle parti in ordine alla strada privata de qua recava connaturata la specificazione delle facoltà di godimento che costituiscono il contenuto dei diritti stessi. Peraltro, l'occasionale coincidenza di distinte facoltà di godimento costituiva la constatazione di un effetto naturalmente connesso alla declaratoria del primo giudice riguardo ai distinti diritti spettanti alle parti relativamente al bene di cui si tratta. Bene il tribunale aveva ritenuto nella specie insussistente una comunione incidentale impropria o di godimento, a cui si rendono applicabili le norme dettate per la comunione; nel caso di specie infatti, non ricorre un caso di coesistenza di diritti eterogenei tutti incidenti per intero, in forma diffusa, sul medesimo bene, ma una situazione contraddistinta dalla occasionale, frammentata e parziale coincidenza di facoltà inerenti all'esercizio di diritti di proprietà esclusiva, di proprietà comune e di servitù, in rapporto a circoscritte porzioni della detta strada. Conseguiva la impossibilità di ravvisare altrettante facoltà equivalenti di godimento, commisurate per quota. L'invocata applicazione analogica della disciplina della comunione dimostrava la infondatezza dell'appello, in quanto come emerge dall'art. 1106, primo comma, cc, non sussiste un diritto potestativo di ciascun partecipe di ottenere la formazione 162 del regolamento della comunione, come non esiste una norma che consenta al giudice di adottare coattivamente, con efficacia vincolante per tutti i componenti della asserita comunione, le regole che la società appellante pretendeva nel dissenso di tutti gli altri potenziali interessati. Per la comunione in generale e per i condomini più piccoli, manca una norma che legittimi un intervento autoritativo del giudice con carattere preventivo e con prescrizioni di natura generale ed astratta. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di due motivi, la C.M.T. spa; resistono con controricorso la RAI spa. ed Ernesto D.. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Sono state presentate memorie. Motivi della decisione Con il primo motivo, la Società ricorrente ricordato che nell'atto introduttivo aveva chiesto di dichiarare che tutti i convenuti godono, a titoli diversi, di passaggio veicolare e pedonale nella strada de qua; che nella fattispecie si applica la normativa dettata per la comunione; e di determinare le quote di partecipazione di tutti alle spese per l'amministrazione e conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada, ha lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevando che il primo giudice non aveva accolto le domande surricordate, e che la Corte di appello avrebbe travisato le domande avanzate. La censura non coglie nel segno, in quanto è la stessa ricorrente ad ammettere che la Corte territoriale nel decidere sulle domande proposte, ha affermato non potersi far luogo ad applicazione analogica della disciplina della comunione, e non sussistere il diritto potestativo di ciascun partecipe di ottenere la formazione del regolamento della comunione e la possibilità di ravvisare altrettante facoltà equivalenti di godimento, commisurate per quota, sul medesimo bene giuridico. Non può essere pertanto revocato in dubbio che, esclusa, come si dirà più ampiamente a proposito del secondo motivo, la comunione impropria, da tale considerazione viene fatta scaturire l'inapplicabilità delle regole che governano la comunione e quindi la ragione del mancato accoglimento delle domande surriportate. Va quindi escluso che sussista la denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c., stante che, articolatamente, si è dato conto del perchè, sulla base dell'impostazione adottata, le domande attinenti alla regolamentazione della comunione non potevano essere accolte; è appena il caso di aggiungere che se è vero che la ricorrente non aveva chiesto alcun regolamento della comunione, la Corte partenopea ha trattato questo profilo in parte a titolo esemplificativo, in parte interpretando la richiesta di regole che determinassero le modalità d'uso, da parte di ciascun utente. Con il secondo motivo (violazione dell'art. 1100 cc. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia) si lamenta che la motivazione adottata dalla Corte sarebbe stata resa in violazione della norma citata, in quanto nel caso, come quello in esame, in cui sul medesimo bene coesistono diritti reali di godimento di tipo diverso, si ha comunione impropria, cui si applicano le norme sulla comunione. Il riferimento alla comunione impropria o di godimento, istituto non codificato, ma cui la giurisprudenza ha talvolta fatto ricorso e studiato in dottrina, viene invocato sul presupposto, desunto dalla stessa sentenza di primo grado, laddove ha determinato i diritti di ognuno dei soggetti interessati, secondo cui si avrebbe nella specie una ipotesi in cui sul medesimo bene coesistono godimenti di tipo diverso. Tale assunto peraltro appare contrastato da due ordini di motivi, evidenziati sia dal Tribunale che dalla Corte di appello, riferiti al fatto che nella specie si hanno 163 più servitù di passaggio insistenti sul medesimo bene che è a sua volta di proprietà o in comproprietà a più soggetti e che, conseguentemente, il contenuto della servitù di passaggio è circoscritto dalla utilità che il fondo dominante può trarre dall'asservimento del fondo servente, mentre il contenuto della servitù non si estende in forma diffusa sull'intero cespite al pari del diritto di proprietà; può sul punto altresì ricordarsi l'avviso secondo cui il diritto di servitù non può formare oggetto di comunione, la quale esige che la cosa o diritto comune sia suscettibile di quote frazionarie mentre la servitù non può ammettere tale (razionalità, essendo per sua natura indivisibile in quanto inerente a tutto il fondo dal lato sia attivo che passivo (v. Cass. 22.2.1963, n 424). Si ha comunione impropria, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, ove il proprietario partecipi anch'egli per una determinata quota al godimento della cosa, insieme all'usufruttuario, ovvero quando su di un medesimo bene concorrano un diritto di proprietà ed uno di usufrutto, avendosi nella prima ipotesi una vera e propria comunione di godimento e, nella seconda un concorso di diritti reali differenti per tipo (cfr. Cass. 9.2.1987, n. 1337; 15.11.1976, n. 4243). Sulla base di tali premesse, l'elemento caratterizzante la comunione impropria appare quello (coincidente con quanto si ha nella comunione propria) secondo cui tutti i diritti coincidenti sul medesimo bene si estendono in forma diffusa sull'intero cespite, essendo limitati solo in via astratta dalla quota. Appare evidente la differenza rispetto al caso in esame, in cui si hanno più servitù di passaggio insistenti sul medesimo bene su cui insistono diritti di proprietà (e di comproprietà) di altri soggetti. Va chiarito che la sentenza impugnata non ha affatto modificato la pronuncia del tribunale al riguardo (diversa, rispetto ai casi in cui si è ravvisata la comunione impropria, è la situazione di più servitù di passaggio insistenti sul medesimo bene, che a sua volta è in comproprietà a più soggetti, perchè il contenuto della servitù è circoscritto dalle utilità che il fondo dominante può trarre dall'asservimento del fondo servente e, ovviamente, il contenuto della servitù non si estende in forma diffusa sull'intero cespite al pari del diritto di proprietà), ma ha aggiunto altri argomenti (nella evenienza in esame ricorre non già un caso di coesistenza di diritti eterogenei tutti incidenti per intero, in forma diffusa, su medesimo bene, bensì una situazione contraddistinta dalla occasionale, frammentata e parziale coincidenza di facoltà inerenti all'esercizio dei diritti di proprietà comune e servitù in rapporto a ben circoscritte porzioni del bene). E' dalla combinazione di queste due argomentazioni, l'una legata alla natura giuridica del diritto reale di servitù, in rapporto al diritto reale di proprietà, l'altra (a prescindere dalla opinabile constatazione di una carenza di unitarietà del bene) che fa applicazione in concreto di tale principio nella situazione peculiare che viene esaminata e che presenta una assoluta varietà di situazioni giuridiche in essere sulla strada in questione, che scaturisce la completa ratio della decisione adottata, che ne rispecchia la valenza. Sussistono effettivamente diritti di godimento di tipo diverso, ma gli stessi hanno connotazioni non coincidenti e non omogenee e non possono quindi dar luogo ad una comunione impropria, attesa la divergenza dei rispettivi contenuti, che non si estendono in forma diffusa sull'intero cespite. Tanto comporta l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1100 cc. e, conseguentemente, la reiezione del motivo e con esso del ricorso. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese relative al presente procedimento per Cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. 164 Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2005 PAGAMENTO MEDIANTE ASSEGNO BANCARIO TRACCIA: Tizio è amico di Caio da venti anni. Tizio e Caio si accordano affinché il primo aggiusti il tetto della propria abitazione al secondo, dietro corrispettivo in denaro di euro 1000,oo. I due amici redigono una scrittura privata, precisando che il corrispettivo economico sarebbe dovuto avvenire tramite “pagamento in moneta”. Dopo il lavoro eseguito, Caio firma un assegno a Tizio del valore di 1000,oo euro, come da accordi, ma Tizio rifiuta esigendo il pagamento in contanti. Caio si arrabbia, interpretando il gesto di Tizio come una mancanza di fiducia. Tizio dice a Caio che è inadempiente. Caio si reca dal legale Sempronio. Il candidato, assunte le vesti del legale Sempronio, rediga motivato parere. POSSIBILE SOLUZIONE SCHEMATICA: In premessa andava affrontato il discorso dell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie. L’art 1277 cc afferma il principio del pagamento dei debiti pecuniari con moneta avente corso legale: ne deriva, che solo la moneta legale costituisce mezzo di pagamento idoneo ad adempiere ad una obbligazione pecuniaria, in base ad una lettura rigorosa della lettera della legge. Nella prassi, invero, è frequente l’utilizzo di mezzi di pagamento alternativi alla moneta legale che si giustificano in un’ottica di celerità e praticità degli scambi commerciali, si pensi agli assegni bancari, ma anche alle carte di credito, alle carte di debito (cd bancomat), ecc. Il problema interpretativo che pone il pagamento di un’ obbligazione pecuniaria mediante assegno è l’obbligo del creditore di accettare tale pagamento. Sotto tale ultimo profilo, è stato osservato che il creditore sarebbe obbligato ad accettare l’assegno rilasciato dal proprio debitore in base ai principi di correttezza e buona fede, in quanto si tratterebbe di un obbligo accessorio scaturente dalla stipulazione del contratto gravante sul creditore al fine di collaborare alla realizzazione del contratto senza che ciò comporti la sopportazione di un peso ulteriore (cd obbligo di protezione, secondo alcuni). Tale ricostruzione non è pacificamente accolta. Al riguardo occorre distinguere tra assegno circolare ed assegno bancario: mentre l’assegno circolare contiene una promessa di pagamento della banca emittente nei confronti di un terzo beneficiario, l’assegno bancario è costituito da un ordine di pagamento che il traente (cliente della banca presso la quale dispone di un conto corrente e con la quale ha stipulato una convenzione di assegno) fa alla propria banca in favore di un terzo beneficiario. Ne deriva che il pagamento mediante assegno circolare è assistito da maggiori 165 garanzia rispetto al pagamento mediante assegno bancario, poiché nel primo caso la banca si obbliga in proprio, mentre nel secondo caso agisce come mandataria del proprio cliente, con la conseguenza che in mancanza di disponibilità di fondi sul conto corrente del mandante, potrà rifiutare di liquidare la somma indicata nel titolo di credito. Si sostiene, quindi, che l’assegno circolare a differenza dell’assegno bancario, costituisce un mezzo di pagamento equivalente alla moneta legale, e quindi non può essere rifiutato dal creditore: a meno che costui non ravvisi delle irregolarità nel titolo e non abbia un apprezzabile interesse al pagamento mediante moneta, il pagamento effettuato con tale mezzo ha efficacia solitaria per il debitore. Viceversa, aderendo ad una diversa impostazione, si sostiene che tanto l’assegno circolare quanto quello bancario, costituiscono dei mezzi di pagamento alternativi alla moneta legale, quindi l’efficacia solitaria dei medesimi non sussiste se non a seguito di espresso consenso del creditore, venendo in rilievo una datio in solutum. A sostegno di tale ricostruzione si pone la previsione dell’art. 1182, secondo la quale l’obbligazione pecuniaria deve essere adempiuta al domicilio del creditore, mentre il pagamento mediante assegno (bancario e circolare) imporrebbe al creditore l’onere di recarsi presso la banca per “cambiare” l’assegno in moneto o accreditarlo sul proprio conto. Nel caso in esame, quindi, Caio, al fine di adempiere alla propria prestazione, deve ottenere il consenso di Tizio affinché costui accetti il pagamento mediante assegno bancario, con la conseguenza applicativa che, nel caso di specie, nella sostanza, Caio è parzialmente inadempiente. Si consiglia di leggere le sentenze che seguono. -Nel rapporto di conto corrente bancario il termine di decadenza di sei mesi per l’impugnazione dell’estratto conto trasmesso al cliente, fissato dall’articolo 1832 comma 2 Cc, opera anche per la banca, relativamente all’omessa registrazione di partite a credito dell’istituto, con la conseguenza che, decorso inutilmente detto termine, la banca decade dal diritto di far valere crediti che non risultano nell’estratto conto approvato, specie nell’ eventualità si sia a fronte a operazioni non annotate. Corte di Cassazione Sezione Terza Civile Sentenza 24 maggio 2006 n.12372 (Presidente Giuliano – relatore Finocchiaro) Svolgimento del processo In accoglimento del ricorso 22 aprile 1996 il presidente del tribunale di Parma ha ingiunto alla General Waters Srl il pagamento della somma di lire 88.304.240 in favore della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza. Tale somma era reclamata dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza a fronte di una ricevuta bancaria accreditata salvo buon fine su un conto corrente della General Waters Srl e non onorata dalla debitrice. Con atto 18 giugno 1996 la General Waters Srl ha proposto opposizione, innanzi 166 al tribunale di Parma, avverso il descritto decreto, eccependo la nullità del decreto stesso perché emesso in assenza dì una prova scritta e facendo, comunque, presente che la pretesa avversaria era infondata. Costituitasi in giudizio la Cassa di Risparmio dì Parma e Piacenza ha chiesto il rigetto della opposizione. Svoltasi la istruttoria del caso l’adito tribunale con sentenza 990/99, revocato il decreto opposto, ha condannato, comunque, l’opponente al pagamento della somma di lire 88.304.240 oltre accessori. Gravata tale pronunzia dalla General Waters Srl, nel contraddittorio della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza che ha chiesto il rigetto della impugnazione, la Corte di appello di Bologna con sentenza 29 gennaio - 17 luglio 2002 in parziale accoglimento dell’appello ha rigettato la domanda proposta dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza con il ricorso per ingiunzione 22 aprile 1996 e condannato quest’ultima a restituire all’appellante tutte le somme eventualmente percepite in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza nonché al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Per la cassazione di tale pronunzia, notificata l’11 ottobre 2002, ha proposto ricorso, affidato a tre motivi e illustrato da memoria, con atto 5 dicembre 2002, la Intesa BCI Gestione Crediti Spa, quale procuratore della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza. Resiste, con controricorso, la General Waters Srl Motivi della decisione 1. E’ rimasto accertato in linea di fatto, in esito alla istruttoria espletata in sede di merito che: - il 28 maggio 1993 la General Waters ha presentato, per l’incasso, alla Cassa di Risparmio di Parma una fattura a carico della AFS General Waters Limited con sede in Inghilterra per lire 88.304.240, da pagarsi entro il 30 settembre 1993; - il 9 ottobre 1993 l’istituto ha accreditato, su conto corrente intestato alla General Waters l’importo della fattura «salvo buon fine»; - con telegramma 2 febbraio 1994 la Cassa di Risparmio di Parma (nelle more divenuta Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza) ha sospeso l’utilizzazione delle linee di credito già concesse alla General Waters; - il 3 giugno 1994 il conto corrente in questione è stato chiuso e la Cassa, effettuati i necessari conteggi, ha corrisposto alla General Waters il saldo attivo, pari a lire 7.956.092; - l’11 ottobre 1995 la Cassa ha chiesto alla General Waters la restituzione della somma (lire 88.304.240) a suo tempo accreditata, atteso che si era avvalsa, per l’incasso, della collaborazione della National Westminster Bank, ma la fattura non era stata pagata e il titolo era andato smarrito, durante il tragitto dall’Inghilterra all’Italia; 167 - la General Waters ha opposto di non essere tenuta al pagamento della somma in questione, atteso che con la chiusura del conto corrente i rapporti tra le parti erano stati tutti liquidati. 2. Premesso quanto sopra, giudici dì secondo grado hanno rigettato la domanda proposta dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza nei confronti della General Waters sulla base di due, concorrenti, rationes decidendi. 2. 1. La banca - hanno, in primis, evidenziato quei giudici (richiamando la giurisprudenza di questa Corte regolatrice sul punto specifico) - approva gli estratti conto da essa stessa predisposti nel momento in cui li trasmette al cliente: è dunque pacifico che anche gli istituti di credito sono sottoposti alla disciplina dettata dall’articolo 1832 Cc e, quindi, al termine di decadenza previsto dal secondo comma di questo. In particolare, deve escludersi - hanno concluso sul punto quei giudici - che la banca possa realizzare il proprio credito al di fuori del regime di impugnazione previsto dall’articolo 1832 Cc, perché una simile facoltà contrasterebbe con la funzione, propria della disciplina in esame, di conferire definitività e certezza alla situazione contabile cristallizzata in un determinato momento e di tutelare, al tempo stesso, l’affidamento ragionevolmente sorto in ciascuna delle parti circa la inoppugnabilità delle risultanze degli estratti conto approvati. Alla approvazione del conto - contemporaneamente indipendente dal decorso del termine semestrale previsto dall’articolo 1832 Cc, possono sopravvivere le azioni ordinare volte a fare dichiarare la invalidità o inefficacia giuridica del titolo in base al quale è stata effettuata (o si sarebbe dovuta effettuare) una determinata operazione. Nella specie, peraltro, non si contesta la legittimità e la validità del titolo che la General Waters aveva affidato alla Cassa di Risparmio di Parma per l’incasso. A seguito del mancato pagamento la banca avrebbe dovuto procedere alla storno dell’importo in precedenza accreditato sul conto del mandante e deve escludersi che la banca possa recuperare, dopo oltre due anni e mezzo dal conferimento del mandato all’incasso, e a un anno e mezzo dalla chiusura definitiva del rapporto una somma che nell’estratto di chiusura del conto, tacitamente approvato dal cliente e non impugnato dalla banca, risultava definitivamente attribuita. In conclusione, non essendo stato impugnato, dalla Banca l’estratto conto del 3 giugno 1994 nei successivi sei mesi si era verificata la decadenza prevista dall’articolo 1832, comma 2. 2. 2. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, hanno osservato quei giudici che i motivi che avrebbero impedito lo storno (tempestivo) dal conto corrente della General Waters dell’importo della fattura in precedenza accreditato (ritardata conoscenza del mancato buon fine e smarrimento del titolo) derivano esclusivamente dai rapporti interni tra la Cassa di Risparmio e la banca estera cui era stato affidato l’ incarico e sono, pertanto, imputabili alla stessa azienda di credito che risponde non solo per l’eventuale scelta di un sostituto inadeguato, ma anche per la insufficienza o la erroneità delle istruzione fornite, per la omessa 168 sorveglianza sul sostituto affinché questi osservi diligentemente i compiti che gli sono stati affidati e, soprattutto, per il ritardo nella comunicazione al mandante. 3. Parte ricorrente censura la riassunta pronunzia, quanto al primo delle indicate rationes decidendì denunziando (con il secondo motivo «violazione e falsa applicazione degli articoli 1827 Cc, 1829 Cc 1832 Cc 1857 Cc in relazione agli articoli 360 n. 3 e 5 Cpc». Si assume, infatti, che la sentenza gravata ha violato: l’articolo 1827 Cc «nella parte in cui tale norma sancisce che se l’atto è invalido, la relativa partita si elimina dal conto, in linea con un principio di carattere generale per cui ogni credito con la sua individualità e la sua natura rimane legato alla sua fonte e subisce le vicende connesse all’eventuale esistenza di un vizio che infici l’atto che è a suo fondamento, posto che l’inclusione nel conto non sana alcuna nullità o inefficacia dell’atto da cui l’inclusione ha tratto origine»; articolo 1829 Cc «che recita che se non risulta una diversa volontà delle parti (e qui è confermato e documentalmente provato che le parti hanno voluto negoziare il titolo "salvo buon fine"), l’inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola "salvo incasso"»; l’articolo 1832 Cc e l’articolo 1857 Cc «essendo principio consolidato che sul contratto di conto corrente la mancata impugnazione o l’approvazione dell’estratto conto non comportano l’incontestabilità del debito da esso risultante che sia fondato su negozio nullo, annullabile, inefficace». «La Corte di Bologna erroneamente interpreta il principio, peraltro consolidato, affermato dal Supremo Collegio nella predetta decisione 10186/2001, laddove ritiene che la cassa non abbia diritto - a seguito della mancata riscossione del credito con conseguente inefficacia del negozio in virtù del quale aveva provveduto all’inclusione nel corso del relativo importo - a richiedere il pagamento di esso a General Waters». 4. Il motivo, per più aspetti di difficile lettura, non coglie nel segno e deve essere rigettato. Sotto entrambi i profili in cui si articola. 4. 1. Quanto, in primis, alla denunziata «violazione e falsa applicazione» di molteplici norme di diritto, puntualmente indicate nel motivo, si osserva che, come noto, il vizio dì «violazione e falsa applicazione di norme di diritto», dì cui all’articolo 360 n. 3 Cpc consiste nella deduzione di una erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge. La stessa, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre la allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna alla esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa 169 della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Recentemente, in termini, cfr. Cassazione, 4561/06, specie in motivazione). Contemporaneamente si osserva che in sede di ricorso per cassazione il vizio di «violazione e falsa applicazione di norme di diritto», di cui all’articolo 360 n. 3 Cpc, deve essere dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con la interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Corte di cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione (oltre Cassazione4561/06, cit., tra le tantissime, Cassazione 2659/05; Cassazione 18782/05). Pacifico quanto sopra.,si osserva che - come evidenziato sopra - nel rigettare la domanda attrice i giudici del merito hanno nella specie fatto applicazione esclusivamente della regola contenuta nell’articolo 1832, Cc secondo la quale, in tema di conto corrente: - «l’estratto conto trasmesso da un correntista all’altro s’intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze» (comma 1); «l’approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o dì calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L’impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione dell’estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata» (comma 2). E’ evidente - in limine - la non pertinenza al fine del decidere di tutte le considerazioni svolte in ricorso in margine agli articoli 1827 e 1829 Cc di cui -in pratica - non ha fatto alcuna applicazione la sentenza gravata. Sempre al riguardo si osserva che i giudici di secondo grado hanno affermato che la disposizione in parola e, in particolare, il suo secondo comma, deve interpretarsi nel senso che: - da un lato, che nel conto corrente bancario il termine semestrale di decadenza (di cui all’articolo 1832, comma 2, Cc) per la impugnazione dell’estratto conto inviato al cliente opera anche per la banca che, pertanto, decorso tale termini, non più far valere crediti per errore non inclusi nell’estratto; - dall’altro, che decorso il termine semestrale in parola possono sopravvivere (sia in favore del cliente che della banca) esclusivamente le azioni ordinarie volte a fare dichiarare la «invalidità» o la «inefficacia giuridica» del titolo in base al quale è stata effettuata (o si sarebbe dovuta effettuare) una determinata annotazione. 170 Hanno ritenuto - in conclusione - i giudici a quibus (del resto in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte, invocata, anche dalla odierna ricorrente) che nel contratto di conto corrente, l’incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all’approvazione tacita dell’estratto conto, a norma dell’articolo 1832 Cc, si riferisce agli accrediti ed agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino, né l’approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su di un negozio nullo, annullabile, inefficace (o, comunque su situazione illecita) resti definitivamente incontestabile (Cassazione 10186/01). Nessuna di tali affermazioni è censurata (nel rispetto delle regole volute a pena di inammissibilità dall’articolo 366, n. 4, Cpc) dalla parte ricorrente. Questa, infatti, non nega né il primo, dei principi sopra richiamati, né il secondo. Riconosce parte ricorrente - infatti - ancorché implicitamente, che l’articolo 1382 comma 2 Cc esclude «l’impugnazione» delle risultanze del conto, una volta scaduto il termine di sei mesi dalla sua ricezione (o, rispettivamente, per la parte che l’ha inviato, dalla sua spedizione) , ma oppone che, in realtà, nella fattispecie concreta tale decadenza non ha motivo di operare. Certo quanto precede.,è di palmare evidenza la inammissibilità della censura in esame, sotto il profilo di cui all’articolo 360, n. 3, Cpc. Parte ricorrente, infatti, lungi dal censurare la interpretazione data dalla sentenza impugnata all’articolo 1832, comma 2, Cc, si duole - in realtà - che i giudici del merito abbiano valutato le risultanze di causa in modo difforme dalle sue aspettative così affermando che si era realizzata la «decadenza» prevista dalla disposizione in esame, decadenza che doveva - invece -essere esclusa diversamente apprezzando quelle stesse risultanze valutate dai giudici a quibus. 4. 2. Il motivo, comunque non può trovare accoglimento neppure sotto il profilo di cui all’articolo 360 n. 5, Cpc («omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione»). Si osserva, infatti - in termini opposti, rispetto a quanto presuppone la difesa della ricorrente e alla luce di quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi - che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 360 n. 5 Cpc sì configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell’ apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la 171 concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (in argomento, tra le altre, Cassazione 11936/03; Cassazione 11918/03; Cassazione 2222/03). L’articolo 360, n. 5 - infatti - contrariamente a quanto suppone l’attuale ricorrente non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte. Certo quanto sopra, si osserva che la ricorrente lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita - in buona sostanza (per quanto è dato comprendere) - a sollecitare una diversa lettura delle risultanze di causa preclusa in questa sede di legittimità. Pacifico quanto precede si osserva che nella specie parte ricorrente pur assumendo (invocando la tutela dì cui all’articolo 360 n. 5 Cpc) che la sentenza impugnata è incorsa in omessa, insufficiente, o contraddittoria motivazione (allorché, in particolare, ha escluso che essa ricorrente potesse, una volta trascorso il termine semestrale di cui all’articolo 1832, comma 2, Cc, contestare le risultanze dell’estratto conto da lei stessa predisposto) non solo si astiene dall’indicare quali siano i vizi della sentenza gravata, rilevanti sotto il profilo dì cui all’articolo 360 n. 5 Cpc e che ne giustifichino, quindi, la cassazione, ma neppure indica, in ispregio del precetto di cui all’articolo 366, n. 4, Cpc, le ragioni che dovrebbero condurre alla cassazione della sentenza impugnata. Se, infatti, alla luce della giurisprudenza richiamata in ricorso (cui, tra le tantissime, possono aggiungersi gli insegnamenti contenuti in Cassazione 7662/05; Cassazione 11961/03 e in Cassazione 10129/01) l’incontestabilità delle risultanze del conto, derivante dal mancato tempestivo esercizio di detto diritto, non si riferisce alla validità ed efficacia dei rapporti da cui i rispettivi accrediti ed addebiti derivano, né la mancata contestazione (o approvazione) del conto comporta che il debito fondato su negozio nullo od annullabile o comunque su situazione illecita divenga per ciò "nuovo" e, come tale, incontestabile, si osserva che parte ricorrente si astiene dall’indicare le ragioni in forza delle quali, si sia nella specie, a fronte a una operazione «invalida», o a una scritturazione (o non scritturazione) fondata su ne su negozio nullo od annullabile o comunque su situazione illecita. Dalle stesse difese della ricorrente, anzi è indubbio che nella specie si è a fronte a una mancata annotazione - da parte della banca e, certamente per sua esclusiva colpa - di una operazione (e, cioè, la mancata annotazione della omessa riscossione della fattura per lire 88.304.240) ed è evidente, pertanto, che 172 correttamente i giudici del merito hanno ritenuto che la omissione rientra nella previsione di cui all’articolo 1832, comma 2, Cc (per una fattispecie analoga cfr. Cassazione 18626/03, che, ribadito il principio secondo cui nel contratto di conto corrente la mancata contestazione dell’estratto conto e la connessa, implicita approvazione delle operazioni in esso annotate non esclude l’ammissibilità di censure concernenti la validità e l’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali esse derivino, alle quali non è però riconducibile la contestazione avente ad oggetto la mancata annotazione di un’operazione che, ai sensi dell’articolo 1832, secondo comma, Cc deve essere proposta nel termine di sei mesi dall’approvazione del conto e che ha, quindi, cassato la sentenza di merito che aveva confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore di una banca, per il pagamento di una fattura emessa a carico del titolare del conto corrente, benché l’operazione non risultasse annotata nell’estratto conto finale, non impugnato e non contestato nel termine di decadenza di sei mesi. Sempre nello stesso senso, altresì, Cassazione 4140/95). 5. Con il primo e il terzo motivo - intimamente connessi e da esaminare congiuntamente - la ricorrente denunzia: da un lato, «violazione e falsa applicazione degli articoli 342 e 345 Cpc e dell’articolo 2697 Cc, in relazione agli articolo 360 n. 3 e 5 Cpc» (primo motivo); dall’altro, «violazione e falsa applicazione degli articoli 1703 e ss. Cc nonché degli articoli 1353 e ss. Cc in relazione agli articoli 360 n. 3 e n.5 Cpc» (terzo motivo). Con i descritti motivi la ricorrente censura, in particolare, l’ulteriore ratio decidendi contenuta nella sentenza, relativa - come osservato sopra - alla ritenuta (da parte della Corte di appello di Bologna) responsabilità dell’istituto di credito quanto all’omessa riscossione, Inghilterra, del credito portato dalla fattura presentata per l’incasso. 6. I riferiti motivi sono inammissibili, per difetto di interesse (articolo 100 Cpc). Giusta un insegnamento assolutamente pacifico presso la giurisprudenza di questa Corte regolatrice e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinché sì realizzi lo scopo stesso della impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano. E’ sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo dì impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (in tale senso, ad esempio, tra le tantissime, Cassazione 10420/05; Cassazione 2274/05; Cassazione 10134/04). 173 Pacifico quanto precede è evidente, come anticipato, la inammissibilità, per carenza di interesse, dei motivi sopra indicati. Anche, infatti, nella eventualità dovesse pervenirsi all’accoglimento dei detti motivi in nessun caso potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, atteso che questa rimane comunque ferma, essendo stata dimostrata, a seguito del rigetto del secondo motivo, la correttezza di una delle rationes decidendi che ne sorreggono il dictum. 7. Il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, in applicazione dei seguenti principi di diritto: «nel rapporto di conto corrente bancario il termine di decadenza di sei mesi per l’impugnazione dell’estratto conto trasmesso al cliente, fissato dall’articolo 1832 comma 2 Cc, opera anche per la banca, relativamente all’omessa registrazione di partite a credito dell’istituto, con la conseguenza che, decorso inutilmente detto termine, la banca decade dal diritto di far valere crediti che non risultano nell’estratto conto approvato, specie nell’ eventualità si sia a fronte a operazioni non annotate»; «nel contratto di conto corrente, la mancata impugnazione o l’approvazione dell’estratto conto non comportano l’incontestabilità del debito da esso risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile, inefficace o, comunque, su situazione illecita. La verifica - in concreto - se si sia, o meno, a fronte di una contestazione avente i detti requisiti è rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato»; - «ove una sentenza si fondi su una pluralità di rationes decidendi, ognuna, sufficiente, ex se, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite rationes, dall’altro, che tali censure risultino tutte fondate. Deriva, da quanto precede, pertanto, che rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche nella eventualità questi ultimi dovessero risultare fondati non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta». 8. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso deve rigettarsi, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in euro 100,00 per spese oltre euro 3.000,00 per onorari e oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge. -Se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria. 174 La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più eredi, se la cosa non è divisibile. Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a quello che tra essi detiene la cosa. Questi deve darne prima notizia agli altri. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA 14-10-2005, n. 19997 Svolgimento del processo Con citazione del 4 novembre 1997 la sig.ra Alessandrina F. conveniva in giudizio l'Istituto Bancario San Paolo s.p.a. (ora Sanpaolo-IMI s.p.a.), chiedendone la condanna al pagamento di L. 70.160.100, pari alla metà spettantele in via esclusiva - della complessiva somma deposita su due libretti di deposito a risparmio cointestati a lei ed al suo defunto marito, Giulio B., con poteri disgiunti. Resisteva l'istituto di credito convenuto obbiettando che l'originaria operatività a firme disgiunte dei libretti era stata successivamente modificata dai cointestatari, i quali avevano, in conformità all'art. 13 delle norme bancarie uniformi, impartito l'ordine di operare a firme congiunte, sicchè per lo svincolo delle somme era necessario il consenso di tutti i cointestatari, e dunque degli eredi del sig. B.. L'adito Tribunale di Torino, dopo aver autorizzato la chiamata in causa degli eredi predetti (i quali, citati, rimanevano contumaci), respingeva la domanda. Il gravame della soccombente, cui resistevano l'istituto di credito e Marianna, Franco, Cesario, Biagio, Claudio ed Aurelio B., in proprio e quali eredi di Nicola B. e Francesca D., veniva respinto dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 3 luglio 2001. Osservava la Corte che l'art. 13 delle norme bancarie uniformi prevede che la facoltà di disposizioni separate sul conto può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni scritte di tutti i cointestatari. Ciò, appunto, avevano fatto il B. ela F., i quali, con comunicazioni alla banca rispettivamente del 6 novembre e del 2 giugno 1989, avevano chiesto che, per dissapori insorti tra loro, venisse "bloccata qualsiasi operatività sui libretti in questione"; dal che emergeva chiaramente la volontà di revoca della facoltà di disposizione disgiunta, onde conformemente la banca, con comunicazione ai coniugi del 16 febbraio 1993, aveva preso atto che, a seguito di tali diffide, "i libretti devono intendersi come operanti a firma congiunta di entrambi gli intestatari", e questi ultimi non avevano mai contestato tale comunicazione. Pertanto, essendo subentrati nel rapporto gli eredi del B., in mancanza del loro consenso l'appellante non era legittimata a pretendere il pagamento. Avverso tale sentenza ricorre per Cassazione la sig.ra F. articolando due motivi, cui resistono, con separati controricorsi, la s.p.a. Sanpaolo-IMI ed i sigg.ri Marianna, Franco, Cesare, Biagio,Claudio e Antonio B.. Gli intimati Vincenzo ed Aurelio B. non svolgono difese. Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1298, 1834, 1854 e 1772 c.c., deduce: A) che tali norme comportano che i cointestatari di un conto siano, nei confronti della banca, creditori solidali delle somme depositate, mentre nei rapporti interni tra gli stessi il credito si divide, presuntivamente, in parti uguali; sicchè, in caso di disaccordo sulla restituzione delle somme depositate, l'autorità giudiziaria,adita ai 175 sensi dell'art. 1772 c.c., nel contraddittorio di tutte le parti interessate, deve disporre la restituzione delle somme stesse in parti uguali a ciascuno dei depositanti. Conseguentemente, in mancanza, nella specie, di prova contraria (ossia della diversa distribuzione interna del credito), il giudice avrebbe dovuto disporre il pagamento alla ricorrente della metà delle somme depositate spettantele, e ciò a prescindere dal carattere disgiunto o congiunto della facoltà di operare sui libretti da parte dei cointestatari, che non influisce sulla solidarietà del credito; B) che il giudice di merito è pervenuto alla conclusione del rigetto della domanda facendo applicazione dell'art. 13 delle norme bancarie uniformi ed ha ritenuto che le comunicazioni inviate dai coniugi alla banca avessero modificato l'operatività dei libretti. "Ciò anche se non vi fosse, in alcun modo, prova del fatto che tale modifica fosse stata annotata sul contratto di deposito e sul libretto consegnato aidepositanti, documento questo a cui viene attribuita piena efficacia probatoria delle operazioni e dei rapporti intercorrenti tra banca e depositanti (Cass. 16.12.1991, n. 13547, in Giur. it.)". In tal modo preminente rilievo è stato attribuito alle norme bancarie uniformi - piuttosto che al codice civile - pur non avendo esse alcuna forza normativa. 2. - Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia totalmente omesso di esaminare quella parte dei motivi di gravame in cui ella aveva sostenuto che la chiamata in causa degli eredi B. (cui aveva provveduto a seguito delle difese della convenuta) aveva determinato l'estensione nei loro confronti della domanda diretta ad ottenere la condanna dell'istituto di credito alla restituzione della parte della somma depositata spettantele. Alla base - osserva della questione vi era il seguente ragionamento: a) il deposito su libretto bancario trova fondamento in un unico contratto, ancorchè complesso per la presenza di una pluralità di depositanti; b) il giudizio introdotto da essa ricorrente era inteso ad accertare, nel contraddittorio di tutti gli interessati (ai sensi dell'art. 1772, primo comma, c.c.), l'obbligo della banca di provvedere alla restituzione delle somme depositate nella misura e con le modalità di cui agli artt. 1834, 1854 e 1298 c.c.; c) la domanda proposta nei confronti del convenuto (nella specie la banca) deve ritenersi estesa anche nei confronti dei terzi chiamati in causa (nella specie gli eredi B.) se si tratta di rapporto oggettivamente unico; d) conseguentemente la domanda di condanna della banca alla restituzione delle somme doveva necessariamente ritenersi estesa neiconfronti degli eredi B., a seguito della loro chiamata in causa; e) l'obbligo di prestare il consenso alla restituzione della somma pretesa dalla ricorrente sarebbe venuto meno per i chiamati ove gli stessi avessero dimostrato una ripartizione delle quote di spettanza di ciascuno dei depositanti diversa da quella presunta per legge; f) ciò, però, i chiamati non avevano fatto perchè erano rimasti contumaci, dimostrando in tal modo che non avevano nulla da eccepire "circa la presunzione di comproprietà in pari quote delle somme depositate" e che non intendevano negare il loro assenso alla restituzione della somma pretesa dall'attrice. 3. - I due motivi vanno esaminati congiuntamente, per la loro connessione e parziale ripetitività, ed accolti nei limiti che seguono. 3.1. - Occorre premettere che la Corte di appello ha accertato, infatto, che l'originaria disponibilità delle somme a firme disgiunte dei depositanti era stata modificata in disponibilità a firme congiunte, e che tale accertamento non è adeguatamente censurato dal ricorso. 176 Sul punto potrebbero venire in considerazione (nella invero non chiarissima esposizione della ricorrente) i rilievi, contenuti nel primo motivo, sopra esposti al n. 1 sub B); ma essi non colgono nel segno. 3.1.1. - Infatti, il rilievo della inidoneità delle comunicazioni scritte a determinare, in difetto di annotazione sul contratto e sul libretto, la modifica di cui trattasi è, prima ancora che infondato, inammissibile in quanto introduce nel giudizio di legittimità un fatto nuovo (la mancata annotazione, appunto) cui la sentenza impugnata non fa alcun cenno. 3.1.2. - Quanto, poi, al rilievo della mancanza di "forza normativa" delle norme bancarie uniformi - e dunque dell'art. 13 di esse, inconcreto applicato dal giudice di merito - basti osservare che la stessa giurisprudenza di questa Corte richiamata dalla ricorrente (Cass. 12507/1999 e 5815/1994), se esclude che le cc.dd. norme bancarie uniformi abbiano valore di norme diritto oggettivo, non esclude affatto che abbiano tuttavia valore negoziale. E tanto basta a giustificarne l'applicazione nella specie. 3.2. - Va altresì premesso che la sentenza impugnata ha anche accertato la mancanza dell'assenso degli eredi B. al prelievo delle somme depositate da parte della sig.ra F.. Anche tale statuizione in fatto resta insuperata, non essendo stata fatta oggetto di idonea censura nel ricorso (che, con il rilievo di cui al secondo motivo, sopra esposto sub f), in fine, si limita a formulare una pura e semplice censura di merito e non a dedurre, come avrebbe invece dovuto, specifici vizi logici della sentenza impugnata). 3.3. - Tanto premesso, deve però affermarsi che la Corte di appelloha errato nel respingere la domanda della sig.ra F. sulla base del solo accertamento della disponibilità congiunta delle somme depositate e della conseguente necessità dell'assenso, invece mancante, degli eredi del cointestatario dei libretti. Infatti è vero che correttamente la banca depositarla rifiuta, in difetto dell'assenso di tutti i coin-testatari, il pagamento a semplice richiesta di uno solo di essi, se il libretto di deposito è a firme congiunte (se così non facesse, violerebbe il contratto, che prevede la necessità della disposizione congiunta dei depositanti); ma è anche vero che la mancanza di tale assenso non può determinare una situazione di stallo, che dispensi indefinitamente la banca dal rimborso del deposito. Nel conflitto tra le parti, che viene in tal modo a determinarsi, è evidentemente il giudice che deve decidere. Ciò deriva dai principi generali, di cui è espressione, con riguardo al contrasto insorto tra i depositanti nel deposito regolare, l'art. 1772, primo comma, c.c. invocato dalla ricorrente. Oggetto della decisione che il giudice deve assumere, una volta accertata la necessità di disposizioni congiunte e in difetto dell'assenso di taluno dei cointestatari del libretto, è il diritto di credito di ciascuno di essi - e la sua entità nei confronti della banca in ordine alla somma depositata, secondo le norme che regolano il rapporto intercorrente tra i creditori-depositanti e la debitricedepositaria. E', poi, evidentemente interesse della banca che tale decisione venga assunta nel contraddittorio di tutti gli intestatari del libretto, affinchè sia loro opponibile, onde evitare il rischio di essere condannata, in processi separati, a pagare più volte il medesimoimporto sia all'uno che all'altro dei depositanti. Nella specie, la Corte di appello si è fermata all'accertamento della necessità delle disposizioni congiunte dei cointestatari dei libretti e della mancanza dell'assenso al prelievo, richiesto dalla sig.ra F., da parte degli eredi del cointestatario sig. B. (divenuti a loro volta codepositanti iure successionis); avrebbe dovuto, invece, 177 accertare, altresì, se e quale parte delle somme depositate l'attrice aveva diritto di prelevare (non già in forza della mera legittimazione disgiunta al prelievo, che essa Corte ha escluso, bensì) in quanto titolare esclusiva della corrispondente quota del credito di deposito. A tale accertamento, però, la Corte distrettuale si è completamente sottratta, nonostante l'attrice avesse formulato la relativa domanda (la sentenza impugnata dà atto che la sig.ra F. pretendeva la somma di L. 70.160.100 asserendo"essere di sua esclusiva proprietà" in quanto corrispondente alla metà dell'importo dei due libretti cointestati con il marito) ed avesse provveduto a chiamare in giudizio, a seguito delle difese della banca convenuta, gli eredi del marito cointestatario. La chiamata in causa di detti eredi era senz'altro idonea ad estendere nei loro confronti il giudizio, nonostante non contenesse alcuna espressa formulazione di specifiche domande verso i terzi chiamati, perchè, allorquando la chiamata avviene al solo scopo dell'estensione del giudicato (come nell'ipotesi che ci occupa, secondo quanto osservato al penultimo capoverso che precede), è implicita una domanda di mero accertamento, nei confronti del terzo, dell'assetto del rapporto sostanziale come dedotto nei confronti delle altre parti. La Sanpaolo-IMI s.p.a. obbietta, nel controricorso, che invece diversi sarebbero i titoli invocati, a fondamento della domanda, neiconfronti della banca e degli eredi B., non essendo nei confronti di questi ultimi invocabile il titolo posto a fondamento della domanda nei confronti della prima, ossia il contratto di deposito, e che gli eredi stessi non detengono, nè hanno mai detenuto, le somme per cui è causa, onde non possono essere condannati alla loro restituzione. Deve a ciò replicarsi che gli eredi del codepositante sig. B. sono, come affermato dalla Corte di appello, divenuti titolari del (rapporto di) deposito iure succesionis, e che, come si è già osservato, oggetto del giudizio, che li coinvolge assieme alla banca, è l'accertamento della titolarità, in capo alla sig.ra F., di una certa quota del relativo credito. Il fatto che verso la banca la ricorrente avanzi, altresì, una pretesa di pagamento (pretesa evidentemente non sostenibile nei confronti dei codepositanti), non esclude la necessità di tale accertamento, che costituisce il presupposto (causa petendi) di quella pretesa. 3.4. - La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio ad altro giudice, indicato in dispositivo, il quale esaminerà la domanda - del tutto ignorata dalla sentenza impugnata - dalla della sig.ra F. di essere riconosciuta titolare esclusiva della metà del credito relativo ai libretti di deposito, con le conseguenze che ne derivano sulla domanda di pagamento proposta nei confronti della banca. 3.5. - Restano in ciò assorbiti i restanti rilievi della ricorrente, attinenti alla fondatezza della domanda sulla quale la Corte di appello non si è pronunciata. 4. - Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di Cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso in Roma, il 18 maggio 2005. Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2005. -Ha natura quasi contrattuale la responsabilità del banchiere giratario per l’incasso che paghi un assegno circolare non trasferibile a soggetto diverso dal beneficiario indicato dal titolo. Conseguentemente, si applicherà il termine decennale di prescrizione per l’azione di responsabilità nei confronti della banca. 178 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alessandro CRISCUOLO - Presidente Dott. Gianfranco GILARDI - Consigliere Dott. Luciano PANZANI - Consigliere Dott. Sergio DEL CORE - Rel. Consigliere Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BANCA di ROMA S.P.A., in persona del Funzionario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso l'avvocato LUIGI JANARI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAMPAOLO BRUNA, giusta delega in calce al ricorso; - ricorrente contro FALLIMENTO RIVIERA MOTORI DI B. & P. S.N.C., in persona del Curatore Dr. M.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI BETTOLO 4, presso l'avvocato FABRIZIO BROCHIERO MAGRONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO DE GROSSI, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente avverso la sentenza n. 943/01 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 22/11/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/2005 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE; udito per il resistente, l'Avvocato BROCHIERO MAGRONE che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giacomo CALIENDO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Su ricorso in data 21 aprile 1997 della curatela del fallimento Riviera Motori di B. e P. s.n.c., il Presidente del Tribunale di Imperia emise decreto con cui ingiunse alla Banca di Roma s.p.a. di pagare alla ricorrente la somma di lire 53.150.000 oltre interessi e spese - pari all'importo di sei assegni circolari non trasferibili emessi nel 1991 dal Banco Ambrosiano Veneto s.p.a. a favore della società poi fallita, girati per l'incasso alla Banca di Roma - Filiale di Ventimiglia e da quest'ultima pagati a persona diversa dal prenditore. L'ingiunta si oppose, eccependo la prescrizione dell'azione nel presupposto che si verteva in tema di responsabilità extracontrattuale. In corso di giudizio, chiese di provare per testi di avere pagato correttamente gli assegni in questione a soggetto, tale G.L., delegato all'incasso dal B., legale rappresentante della s.n.c. prenditrice e interessato a che le somme riscosse non figurassero nei bilanci ufficiali della 179 società amministrata. L'adito tribunale respinse l'opposizione e stessa sorte la Corte di appello di Genova riservò al gravame della Banca di Roma. Premise la corte ligure che le obbligazioni ex lege nascenti da "ogni altro atto o fatto previsto dalla legge" costituiscono, per l'art. 1173 c.c., un tertium genus definito quasi contrattuale, la cui violazione importa responsabilità contrattuale in quanto connessa a una obbligazione specifica inserita in un rapporto obbligatorio con fonte legale, comunque preesistente alla violazione stessa, in ciò distinguendosi dalla responsabilità aquiliana conseguente a un'obbligazione costituitasi ex novo. Osservò, quindi, che la fonte della responsabilità della banca opponente andava ravvisata nella violazione dei doveri su di essa incombenti per legge, ai sensi dell'art. 43 l.a., ovverosia nel mancato rispetto dell'obbligo di diligente accertamento della legittimazione cartolare del prenditore all'atto della presentazione dell'assegno per l'incasso. Il sorgere della relazione intersoggettiva aveva preceduto la causazione del danno chiaramente connesso alla violazione di un'obbligazione specifica, in cui il responsabile è pre-individuato così come è determinato il contenuto dell'obbligo risarcitorio, commisurato all'interesse tutelato dalla legge. Si verteva, pertanto, nell'ambito di una responsabilità contrattuale, con gli effetti che ne derivano sotto il profilo della prescrizione dell'azione risarcitoria. Corretta era anche la sentenza in relazione al rigetto della richiesta istruttoria, non essendo possibile ritenere che lo specifico dovere imposto alla banca negoziatrice possa essere stato disinvoltamente disatteso da un comportamento ai limiti della responsabilità penale quanto alla banca medesima, resa edotta dei rapporti intercorrenti tra il B. e il L. e delle ragioni che avevano indotto il primo a non apparire come prenditore degli assegni; in ogni caso, le prove dedotte non apparivano idonee a dimostrare l'esistenza di un legittimo atto di delega all'incasso degli assegni ed erano, come tali, irrilevanti ai fini del decidere. La cassazione di tale sentenza è stata chiesta dalla Banca di Roma con ricorso affidato a due motivi. Resiste con controricorso il fallimento della Riviera Motori di B. e P. s.n.c. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunziata la violazione del r.d. n. 1736/1933 e degli artt. 2043 e 2947 c.c., la Banca di Roma critica la sentenza per avere la corte ligure ravvisato nel comportamento della banca girataria per l'incasso, che abbia violato il dovere di identificazione del presentatore dell'assegno circolare non trasferibile, una responsabilità ex contractu nei confronti dell'intestatario del titolo, laddove, ai sensi dell'art. 43 r.d. citato, tale responsabilità va qualificata come extracontrattuale e, quindi, assoggettata alla prescrizione quinquennale, essendo il banchiere giratario per l'incasso del tutto estraneo al rapporto cartolare. Peraltro, la somma portata dagli assegni fu pagata a persona diversa dal prenditore e conosciuta dalla banca, che appose il timbro "per conoscenza e garanzia", dietro precise disposizioni del B. che, nella qualità di amministratore della Riviera Motori s.n.c., aveva sottoscritto la girata "pagate all'ordine Banca di Roma". Non sussisteva, quindi, colpa per mancata diligenza nell'identificazione del presentatore dei titoli, posto che il versamento è stato effettuato al soggetto indicato dal prenditore e con il pieno consenso di costui. Il motivo è da disattendere in entrambe le sue articolazioni. Anche se nell'impianto del mezzo, incentrato sulla natura della responsabilità della banca girataria per l'incasso in caso di inesatto pagamento, è prospettata 180 quasi quale argomentazione di rincalzo (peraltro, senza l'indicazione precisa della norma pretesamente violata dal giudice a quo), la tesi della presunta assenza di responsabilità nella specie da parte della Banca di Roma, avente priorità nell'ordine logico delle questioni, è palesemente destituita di ogni minimo fondamento giuridico. Come correttamente statuito dai giudici di merito (la cui motivazione in diritto sul punto va però integrata, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con le considerazioni di cui infra), la violazione dell'art. 43 legge assegno è manifesta. Per effetto di questa norma, è la banca girataria per l'incasso che è tenuta a identificare il presentatore girante, accertare che egli sia il prenditore del titolo e provvedere al pagamento dell'assegno, che avverrà di norma dopo che la banca trattaria abbia accertato l'autenticità della firma del proprio cliente e inviato la valuta alla banca girataria per l'incasso; questa, peraltro, può anche anticipare la valuta effettuando pur sempre il pagamento al prenditore personalmente e non ad altro soggetto. Nella specie è incontestabilmente accertato che, nonostante la clausola di non trasferibilità, gli assegni circolari in questione, girati per l'incasso alla Banca di Roma dalla beneficiaria Riviera Motori di B. e P. s.n.c., vennero pagati dal cassiere, anziché a quest'ultima, a tale G.L., apponendo prima della relativa firma la dicitura "per conoscenza e garanzia". L'irregolarità del pagamento è dunque evidente, data la presenza della firma del L. (formalmente "per conoscenza e garanzia", ma sostanzialmente "per quietanza"), il cui intervento - figurante sui titoli in termini di attestazione dell'identità del prenditore, a maggior tutela del cassiere sportellista - era in realtà inteso a sostituire il prenditore medesimo nella percezione delle somme e non ad asseverarne la legittimazione a riscuotere. Il tutto in violazione dell'obbligo, espressamente posto a carico della banca negoziatrice dall'art. 43 l.a., di diligente accertamento, all'atto della presentazione dell'assegno per l'incasso, della legittimazione cartolare del prenditore, che costituisce fonte della facoltà di negoziare il titolo e, con la girata, di investire la banca dei poteri del mandatario. In definitiva, essendo l'assegno circolare intrasferibile, la clausola "per conoscenza e garanzia", apposta accanto alla sottoscrizione del L., non era certamente idonea a legittimare il pagamento in favore di persona diversa dalla società prenditrice. Anche il nucleo centrale del mezzo in esame è infondato. A termini dell'art. 43 l.a. (r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736) "L'assegno bancario emesso con la clausola "non trasferibile" non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l'assegno se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo". Soggiunge il secondo comma di detto articolo "Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento". La regola, in virtù del rinvio operato dall'art. 86, comma 1°, ultima parte l.a., si applica anche all'assegno circolare, in quanto non sia incompatibile con la sua natura. E' pacifico in giurisprudenza (Cass. n. 6778/1990, 10111/1993) e presso la dottrina maggioritaria che tale disciplina, e la conseguente responsabilità in caso di sua violazione, vale per "colui che paga" e quindi non soltanto per la banca trattaria ovvero per la banca emittente, in ipotesi di assegno circolare, ma anche per l'eventuale banchiere giratario per l'incasso. Si nota convincentemente, al riguardo, che quantunque non sia corretto parlare di "pagamento" in riferimento alla banca girataria per l'incasso, dovendosi piuttosto dire che essa non "paga", 181 non essendo a ciò obbligata sotto il profilo cartolare, ma anticipa la valuta acquistando la legittimazione all'esercizio del diritto cartolare, tuttavia l'espressione "colui che paga", in una interpretazione che tenga conto altresì di quanto immediatamente prima prescrive l'ultimo comma dell'art. 41 (dove chiaramente si dice "il trattario o il banchiere"), abbia appunto il senso di estendere anche al banchiere giratario per l'incasso le conseguenze per il pagamento dell'assegno effettuato contra legem. Non essendo tenuto il trattario a verificare l'autenticità delle firme, la protezione dei terzi interessati in caso di falsa o irregolare girata per l'incasso sarebbe compromessa se il banchiere giratario non fosse obbligato a tale verifica, cioè all'identificazione dell'intestatario girante. Contrasti presso la giurisprudenza di questa Corte, come anche in dottrina, si sono registrati in ordine alla natura della responsabilità in cui incorre il banchiere giratario per l'incasso che, in violazione dell'art. 43 l.a., paghi un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore. Secondo un primo indirizzo, sorto in tema di assegno bancario (non trasferibile), la banca negoziatrice agirebbe quale sostituta nel mandato (art. 1717 c.c.) impartito dal traente dell'assegno alla propria banca trattaria. Più in particolare, si è ritenuto che la banca girataria per l'incasso di un assegno bancario non trasferibile sia da considerare non soltanto mandataria del prenditore-girante, ma anche sostituta della banca trattaria nell'esplicazione del servizio di pagamento dell'assegno, cui quest'ultima è obbligata nei confronti del traente in base alla convenzione di chèque. Subentrando alla banca trattaria, la banca girataria si sostituisce ad essa nel dovere di identificazione del presentatore del titolo con l'uso della dovuta diligenza professionale, mediante le cautele e gli accorgimenti suggeriti dal caso concreto. Sotto questo profilo, la banca girataria viene chiamata a rispondere del negligente pagamento non solo nei confronti della banca trattaria, ma anche nei confronti del traente, ai sensi dell'art. 1717, ultimo comma, c.c. In altri termini, il traente può esercitare verso la banca che ha effettuato il pagamento irregolare la medesima azione contrattuale che avrebbe potuto esercitare in forza della convenzione di assegno nei confronti della banca trattaria, non potendo i di lui diritti ricevere una tutela diversa secondo che il pagamento venga richiesto alla banca trattaria o ad altra banca girataria per l'incasso (cfr. Cass. nn. 3928/1977, 6929/1986, 4187/1987, 6377/2000 - la quale, tuttavia, distingue l'ipotesi del pagamento in violazione della causa di intrasferibilità dell'assegno circolare, rispetto al quale il richiedente a nome altrui resta un terzo estraneo al rapporto cambiario ed ha solo un'azione extracontrattuale contro la banca che abbia pagato l'assegno a persona diversa dall'intestatario - 14359/2001). Per altro orientamento, anch'esso sorto in fattispecie di assegno bancario non trasferibile, detta responsabilità sussiste erga omnes e si configura come aquiliana o extracontrattuale non potendo qualificarsi il banchiere giratario alla stregua di sostituto della banca trattaria o emittente nell'adempimento della convenzione di assegno, come tale posto in rapporto diretto con il traente, ma dovendosi piuttosto considerarlo, in quanto investito e attivato dalla procura all'incasso, quale rappresentante del girante, in nome e per conto del quale riceve il pagamento (così Cass. nn. 6778/1990, 10111/1993, 1641/1996, 1023/1998, 1087/1999, 9902/2000, 12425/2000). Ad avviso di questa Corte, nessuno dei due indirizzi merita di essere seguito. Non il primo che identifica nel banchiere giratario per l'incasso il sostituto della banca trattaria nell'adempimento della convenzione di assegno, ponendolo perciò in rapporto con il traente che può esercitare contro di lui l'azione contrattuale fondata, appunto, sulla convenzione d'assegno. Una tale costruzione è 182 incompatibile con la considerazione che il banchiere giratario è totalmente estraneo sia alla convenzione di assegno sia al rapporto di emissione del titolo; esso, investito e attivato dalla procura all'incasso, figura soltanto quale rappresentante del girante, in nome e per conto del quale riceve il pagamento. Vero è che la banca trattaria o emittente non potrebbe mai, in caso di girata per l'incasso, procedere direttamente al controllo della legittimazione e all'identificazione del presentatore, cionondimeno appare superfluo ogni richiamo ai principi in tema di mandato, posto che anche per ciò che attiene alla negoziazione dei titoli di credito valgono le stesse regole dettate per il pagamento; anzi, la previsione legislativa della possibilità di girare per l'incasso l'assegno non trasferibile esclusivamente a un banchiere assume un preciso significato proprio in considerazione della responsabilità professionale e della funzione di pubblico interesse degli istituti di credito, cioè dell'estrema sicurezza offerta dalla particolare qualità del soggetto intermediario. In ogni caso, l'interpretazione dell'art. 43 l.a. offerta dalle sentenze che si iscrivono in questo indirizzo, se può apparire confacente in tema di assegno bancario (per il quale è, in realtà, avanzata) la cui struttura si spiega sullo schema della delegazione di pagamento, non sembra per altro verso riproponibile per l'assegno circolare; è infatti largamente contestato che all'atto dell'emissione dell'assegno circolare si stipuli un contratto di mandato, in relazione al quale potrebbe aversi la sostituzione (o il submandato nei confronti) della banca girataria. Ma neanche il secondo orientamento è persuasivo. Deve, in generale, premettersi che esso pare ispirato all'intento pratico di evitare che la configurazione della responsabilità sub specie contrattuale possa condurre a una sorta di deresponsabilizzazione dell'istituto negoziatore, il quale, ove fosse considerato quale mero sostituto della banca trattaria ed esecutore delle istruzioni di quest'ultima, ben potrebbe limitarsi a pagare la somma al presentatore una volta che la trattaria, ricevuto l'assegno in compensazione, non abbia sollevato eccezioni sulla sua regolarità. Di qui l'esigenza di investire la banca girataria di un titolo autonomo di responsabilità, la cui rilevanza non viene meno per via della concorrente condotta della banca trattaria. Ma, a parte ciò, la tesi non è condivisibile sul piano dei principi generali in tema di obbligazioni. Com'è noto, la responsabilità extracontrattuale - nonostante l'ampia portata della dizione dell'art. 2043 c.c., che fa riferimento a "qualunque fatto doloso o colposo" - ricorre solo allorquando la pretesa risarcitoria venga formulata nei confronti di un soggetto autore di un danno ingiusto, non legato all'attore da alcun rapporto giuridico precedente o, comunque, indipendente da tale eventuale rapporto, sicché essa può configurarsi solo per effetto della violazione di una norma di condotta. Ove a fondamento della pretesa dedotta in giudizio venga enunciato l'inadempimento di un'obbligazione volontariamente contratta, o anche derivante dalla legge (art. 1173 c.c.), non vi è luogo per l'illecito aquiliano, ma è ipotizzabile unicamente una responsabilità contrattuale o legale derivante da un preesistente vincolo obbligatorio specifico posto in essere tra le parti dalla volontà delle stesse ovvero direttamente da una disposizione di legge. Orbene, non v'è dubbio che l'obbligazione per l'istituto negoziatore di pagare l'assegno solo al prenditore o al beneficiario deriva direttamente dalla disposizione di legge innucleata nell'art. 43 l.a., a sua volta richiamata dall'art. 86 stesso decreto. Anzi, da tale disposizione sembra promanare il richiamo a una più stretta diligenza proprio dell'istituto negoziatore di assegni in ragione degli aspetti pratici e sostanziali dell'operazione di pagamento. A questo proposito, si rammenta che la banca girataria riceve materialmente il titolo dal proprio cliente, trovandosi così a 183 gestire in forma individuale la presentazione dell'assegno in versamento, con maggiori possibilità di riscontrare eventuali irregolarità nella circolazione del titolo o contraffazioni. Di contro, l'azienda trattaria e quella emittente si vedono normalmente consegnare il titolo in stanza di compensazione, all'interno di una rimessa comprendente una moltitudine di altri titoli, per giunta con tempi assai ristretti per poterne eccepire l'irregolarità (verificandosi, in caso contrario, la presunzione di "pagato" che consegue allo spirare dei termini delle procedure interbancarie). A ciò si aggiunge che solo l'azienda girataria per l'incasso ha la possibilità di un diligente vaglio sulla persona del presentatore (ivi comprese le sue qualità) e sulla natura del documento di identificazione esibito, elementi tutti che devono concorrere a integrare un pagamento diligente e liberatorio. In diversi termini, l'art. 43 l.a., per agevolare l'incasso dell'assegno (assolutamente) intrasferibile, ne ammette la girata per l'incasso esclusivamente a un banchiere sul cui vaglio fa affidamento, rendendolo - per così dire - mallevadore verso la trattaria (o la banca emittente dell'assegno circolare) della esatta identificazione del prenditore e infine responsabile dell'inesatto pagamento, che si pone in evidente contrasto con i principi che reggono il servizio bancario e impongono al banchiere comportamenti conformi alle regole della specifica professionalità. Quindi, promanando direttamente dalla legge, la responsabilità della banca girataria per l'incasso non si configura come obbligazione ex delicto, ma, per l'appunto, come obbligazione ex lege, riconducibile, in base all'art. 1173 c.c., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico. Trattasi, in fin dei conti, di fattispecie tipica di obbligazione che, pur non avendo natura contrattuale, non può per ciò solo essere ricondotta nello schema generale dell'art. 2043 c.c., trovando invece il suo archetipo nell'art. 1173 c.c. Il fondamento della correlativa azione risarcitoria è unico e non vi è bisogno di diversificarne il titolo (contrattuale, extracontrattuale, cartolare) a seconda del soggetto che si ritiene danneggiato. Il criterio per individuare il soggetto titolare della pretesa dovrà essere fondato sull'individuazione della sfera giuridica patrimoniale sulla quale è in concreto caduto il danno. In linea generale, il pregiudizio derivante dal pagamento dell'assegno circolare a soggetto diverso dal prenditore potrebbe ripercuotersi sul richiedente, ovvero sul prenditore, ovvero infine sulla stessa banca emittente se nella negoziazione si sia inserita una banca girataria per l'incasso. Corretto è, quindi, il percorso giuridico seguito dalla sentenza qui impugnata. Il banchiere giratario per l'incasso che paga un assegno circolare non trasferibile a persona diversa dal beneficiario indicato dal titolo incorre in una responsabilità, nei confronti del beneficiario, che non ha natura contrattuale, non essendovi rapporto negoziale di sorta tra banca e beneficiario medesimo, né extracontrattuale, che riguarda il comportamento illecito per la violazione dell'obbligo generico del neminem laedere, bensì quasi contrattuale ai sensi dell'ultima parte dell'art. 1173 c.c. L'obbligazione deriva appunto direttamente dalla legge, ovverosia dalla norma di cui all'art. 43 l.a., la quale prevede l'obbligo, a carico del banchiere giratario per l'incasso, di pagare solo ed esclusivamente al soggetto ordinatario ed il correlativo diritto, a favore di tale soggetto, di chiedere il risarcimento del pregiudizio patrimoniale patito. Ne consegue che il termine di prescrizione per l'azione di responsabilità nei confronti della banca negoziatrice è quello ordinario decennale e non quello quinquennale previsto dall'art. 2947, comma 1, c.c. per la domanda risarcitoria da fatto illecito. Con il secondo motivo, viene denunziata omessa e insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Si duole la ricorrente che 184 la corte, al pari del tribunale, pur avendo ravvisato nella fattispecie una ipotesi di responsabilità contrattuale, ha respinto la prova per testi intesa a dimostrare che la banca non aveva alcuna colpa per avere agito su espressa disposizione del prenditore degli assegni. Né, a proposito della indicazione del L. quale delegato all'incasso da parte del B., poteva obliterarsi che costui aveva agito nella veste di legale rappresentante della Riviera Motori s.n.c. Il motivo è inammissibile sotto due profili. Valutare se la prova non ammessa riguardasse un punto decisivo della controversia richiede, da parte della Corte di Cassazione, il raffronto tra il fatto da provare e le circostanze dedotte a contenuto della prova nel giudizio di appello. Perché la Corte sia posta in grado di compiere tale valutazione è necessario che la parte interessata indichi nel ricorso il contenuto dei capitoli di prova, diversamente il motivo di ricorso viene a mancare del requisito della specificità. Ciò da tempo la giurisprudenza della corte viene affermando attraverso l'enunciazione del principio secondo cui il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci la mancata ammissione in appello di una prova testimoniale, ha l'onere di indicare specificatamente - occorrendo anche mediante integrale trascrizione in ricorso - le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività dei fatti da provare in ordine alla risoluzione della controversia e sulle prove stesse, in quanto, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la Corte di cassazione deve essere in grado di compiere tale verifica solo in base alle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (solo per indicare le più recenti, sentt. nn. 19138/2004, 9711/2004, 9290/2004, 5369/2004, 17904/2003, 15751/2003, 9712/2003). Orbene, nel caso, la ricorrente si è limitata a dedurre di avere formulato una istanza di ammissione di prova testimoniale, ma di questa non ha poi indicato il contenuto. Ulteriore profilo di inammissibilità del mezzo sta nel fatto che con esso non risulta censurata la ratio decidendi autonoma espressa a riguardo dalla corte del merito, per la quale la prova (oltre che inammissibile) era anche irrilevante in quanto, dalla articolazione dei relativi capitoli, appariva inidonea a dimostrare la esistenza di un legittimo atto di delega all'incasso dei titoli. Infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso va rigettato con condanna della sua proponente alle spese del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in € 2.700,00, di cui 2.500,00 per onorari d'avvocato, oltre spese e accessori di legge. Così deciso in Roma, l'8 luglio 2005. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 6 OTT. 2005. -Nel caso in cui si intrattengano con il medesimo istituto di credito, una pluralità di rapporti di conto corrente, è possibile che la banca, sulla base del disposto di cui all’art. 1853 c.c., effettui, salvo diversa pattuizione, la compensazione dei saldi attivi e passivi. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE 185 SENTENZA 28-09-2005, n. 18947 Svolgimento del processo 1.- Renato C., con atto di citazione del 20 giugno 1985, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Banca Nazionale del Lavoro (B.n.l.), esponendo di essere titolare di un conto corrente presso detta banca, sul quale, in data 7 maggio 1983, aveva tratto un assegno dell'importo di L. 500.000, messo all'incasso il 16 maggio 1983 e non pagato dalla B.n.l., sicchè era stato elevato lo stesso giorno protesto in suo danno, benchè il conto avesse un saldo attivo di L. 1.549.644. L'attore deduceva d'essere stato sottoposto a procedimento penale per il reato di emissione di assegno in mancanza di provvista, dal quale era stato assolto, e chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento delle obbligazioni da questa assunte con il contratto di conto corrente. La B.n.l. si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, deducendo la legittimità del mancato pagamento dell'assegno, in virtù dell'effetto della compensazione fra il saldo attivo del conto corrente indicato dall'attore (n. 198967) ed il saldo passivo di L. 1.357.000 del conto corrente speciale (n. 30866) di cui il C. era intestatario, aperto per il pagamento di un mutuo, operata ai sensi dell'art. 5 del contratto di conto corrente. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma, con sentenza del 18 febbraio 1998, accoglieva la domanda, condannando la convenuta a pagare a Renato C. la somma di L. 60 milioni a titolo di risarcimento dei danni. 2.- Avverso la sentenza proponeva appello la B.n.l.; resisteva al gravame Renato C.. Ricostituitosi il contraddittorio, la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 31 luglio 2001, accoglieva il primo motivo, dichiarando assorbite le ulteriori censure, e, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda proposta da Renato C., compensando tra le parti le spese del giudizio. Per quanto qui interessa, la sentenza di appello premetteva che l'art. 5 del contratto stipulato tra le parti prevedeva che, "quando esistono tra l'azienda di credito e il correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura (...) ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. L'azienda di credito ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorchè i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - l'azienda darà pronta comunicazione al correntista. Se il conto è intestato a più persone, l'azienda di credito ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari". La Corte territoriale osservava che il conto corrente sul quale il C. aveva emesso l'assegno presentava un saldo attivo, mentre l'ulteriore "conto corrente speciale" presentava un saldo passivo. Dunque, legittimamente la B.n.l. aveva operato la compensazione in virtù dell'art. 5, cit., che la prevedeva, "senza che occorra alcuna previa formalità o comunicazione per farla valere", dato che "la non omogeneità dei conti non opera per espressa previsione contrattuale e così pure la non necessità di preavviso", mentre "la chiusura del conto speciale poteva essere effettuata solo a fronte di 186 espressa volontà contraria dei correntisti e questo non è avvenuto" 3.- Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso Renato C., affidato a tre motivi; ha resistito con controricorso la B.n.l.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione 1.- Renato C., con il primo motivo, articolato in tre profili, denuncia "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1853 c.c., in combinato disposto con gli artt. 1242 e 1243 c.c., in conseguenza di omessi esame e motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c". Sotto un primo profilo, il ricorrente deduce che è incontestato che il conto corrente sul quale fu tratto l'assegno dell'importo di euro 500.000, non pagato (infra, "c/c ordinario"), alla data di presentazione del titolo per l'incasso, presentava un saldo attivo di L. 1.549.644, tant'è che come risulta dalla contabile del 21 luglio 1983 e dall'interrogatorio reso in primo grado all'udienza del 20 dicembre 1994 dal legale rappresentante della B.n.l. l'addebito del saldo debitore dell'altro conto corrente (di seguito, per ragioni di chiarezza, "c/c speciale") fu effettuato soltanto il 21 luglio 1983, con l'indicazione che si trattava di "giro per compensazione tra il saldo creditore del c/c 198967 e il saldo debitore del c/c 30366". Dunque, anche se la compensazione fosse stata legittimamente operata, essa è divenuta efficace soltanto il 21 luglio 1983, anche perché l'art. 1242 c.c., non prevede, come invece stabiliva l'art. 1286 c.c, del 1865, che la compensazione si verifica "di diritto, in virtù di legge ed anche senza saputa dei debitori", con la conseguenza che la compensazione "richiede ima tempestiva dichiarazione di volontà, nel caso non manifestata" La compensazione è infatti rimessa all'iniziativa della parte, la quale può non avvalersene, ovvero può avvalersene in un tempo successivo a quello della coesistenza del credito-debito. Sotto un secondo profilo, ad avviso del C., il credito vantato dalla B.n.l. in riferimento al saldo debitore del "c/ speciale" non era certo, liquido ed esigibile. Egli, nelle fasi di merito, ha infatti dedotto che: il "c/c speciale" costituiva un prefinanziamento sul mutuo fondiario concesso dalla Sezione di credito fondiario della B.n.l. a lui ed a sua moglie, garantito con mandato irrevocabile all'incasso della erogazione del mutuo, fino a concorrenza dell'estinzione del conto di prefinanziamento; l'erogazione del mutuo dell'importo di L. 70 milioni è avvenuta il 14 novembre 1980, con accredito sul "c/c speciale" e la B.n.l. ha messo a disposizione le somme eccedenti il saldo passivo del conto; essendo il "c/e speciale collegato ad una sola operazione prefinanziamento sul mutuo - poteva essere movimentato soltanto dalla banca e doveva essere chiuso, a cura di quest'ultima, alla data del 14 novembre 1980; era, quindi, illegittima ed infondata la compensazione del saldo passivo del "c/c speciale" maturato alla data del 14 novembre 1980, a causa della mala gestio della B.n.l., che non aveva provveduto a chiudere il conto e neppure aveva dato alcuna comunicazione ai correntisti. D'altronde,la B.n.l. non avrebbe contrastato in alcun modo la contestazione in ordine all'esistenza del credito, omettendo di provarne la sussistenza, con conseguente illegittimità della compensazione tra un debito certo ed un credito non provato. Secondo il ricorrente, sotto un terzo profilo, la compensazione legale sarebbe comunque illegittima, essendo le "posizioni creditorie- debitorie non omogenee e non intercorrenti tra i medesimi soggetti". Il credito opposto in compensazione dalla B.n.l. era relativo alle spese ed alle competenze maturate in relazione al "c/c speciale", che era nella esclusiva 187 disponibilità della banca. Dunque, la compensazione non poteva avere luogo, trattandosi di un debito "estraneo ad un rapporto di conto corrente", inerente a "posizioni non intercorrenti tra i medesimi soggetti". Infine, ad avviso di Renato C., non sarebbe corretto il richiamo operato dalla sentenza impugnata alla clausola contrattuale dell'art. 5, poiché questa "non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui il debito del correntista sia estraneo ad un rapporto di conto corrente, poiché in questo caso la clausola suddetta si risolverebbe in una inammissibile forma di autotutela per l'istituto di credito". 1.1.- Il ricorrente, con il secondo motivo, denuncia "falsa applicazione dell'art. 1853 c.c., in conseguenza della mancata applicazione degli artt. 1374 e 1375 c.c., omessi esame e motivazione in punto, con riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c.", deducendo che la Corte territoriale ha fondato e motivato la decisione valorizzando esclusivamente la clausola n. 5 del contratto di conto corrente, in forza della quale ha rigettato le eccezioni sollevate in ordine alla carenza di omogeneità dei conti, alla mancanza di preavviso ed alla mancata chiusura del conto speciale. Ad avviso di Renato C., la sentenza impugnata non avrebbe però considerato che, ex artt. 1374 e 1375 c.c., i contratti devono essere interpretati ed eseguiti secondo buona fede ed in virtù di questa regola la B.n.l. avrebbe dovuto dare "pronta comunicazione" della compensazione, mentre ciò ha fatto soltanto il 21 luglio 1983, ovvero due mesi dopo il protesto dell'assegno. La Corte d'appello avrebbe, quindi, omesso di accertare e dichiarare la colpa contrattuale della banca, correttamente ritenuta sussistente dalla sentenza di primo grado. 1.2.- Renato C., con il terzo motivo, denuncia "violazione per mancata applicazione dell'art. 2043 c.c., omessa motivazione in punto, con riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c.", deducendo che la domanda di risarcimento era stata proposta anche facendo valere la responsabilità extracontrattuale della B.n.l., per il caso di ritenuta legittimità della compensazione, e sostenendo che "è mancata (...) la decisione della domanda di risarcimento per la concorrente responsabilità extracontrattuale della banca". 2.- I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto logicamente e giuridicamente connessi, sono in parte fondati e vanno accolti per quanto di ragione, entro i limiti di seguito precisati. Le censure pongono anzitutto la questione della ammissibilità della compensazione tra crediti e debiti relativi a conti diversi (i cui effetti si sono prodotti nell'anno 1983), contestata dal ricorrente, poiché uno di essi era cointestato alla moglie, il credito della B.n.l. non era liquido ed esigibile e le "posizioni creditorie- debitorie non erano omogenee". 2.1.- La natura di conto corrente di corrispondenza del conto sul quale il ricorrente ha tratto l'assegno in esame è incontroversa; la sentenza impugnata, nell'esaminare la disciplina contrattuale che lo regolava, ha inoltre fatto riferimento all'art. 5 del contratto (nel testo trascritto nella pronuncia), quale unica clausola recante la regolamentazione convenzionale della compensazione. Il ricorrente e la controricorrente non hanno fatto alcun cenno - esplicito o implicito - a clausole ulteriori. Pertanto, l'accertamento di fatto operato nella fase di merito, incontroverso ed incontestato in questa sede, al quale questa Corte è vincolata, è che la compensazione convenzionale è disciplinata esclusivamente da detta clausola. 2.2.- Posta questa premessa, la questione sintetizzata nel 2 va risolta nel senso della ammissibilità della compensazione,palesandosi infondata la contraria tesi svolta sul punto dal ricorrente. L' art. 1853 c.c., che disciplina la compensazione qualora tra la banca ed il correntista esistano più rapporti o più conti, ha dato luogo, soprattutto in dottrina, ad un contrasto interpretativo in ordine alla possibilità di ritenere che la nonna, 188 diversamente da quella avente ad oggetto la compensazione di "diritto comune", prescinda dall'esigibilità, quindi, operi anche in mancanza della chiusura dei conti. Di questo contrasto non occorre qui occuparsi (peraltro, in senso contrario all'interpretazione restrittiva cfr. Cass., n. 6558 del 1997), poiché le parti, con la clausola contenuta nell'art. 5 del contratto, hanno stabilito una disciplina convenzionale, ex art. 1252 c.c., alla quale deve farsi riferimento per identificare i relativi requisiti. L'art. 5, cit., nel testo riprodotto nella sentenza impugnata, stabilisce: "quando esistono tra l'azienda di credito e il correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura (...) ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. L'azienda di credito ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili (...). Se il conto è intestato a più persone, l'azienda di credito ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari". La lettera della clausola conforta la correttezza dell'interpretazione sul punto della Corte d'appello, che ha ritenuto infondate le deduzioni con le quali il ricorrente ha contestato l'ammissibilità della compensazione, valorizzando appunto la circostanza che detta clausola prevedeva la compensazione anche in riferimento ai crediti relativi a "più rapporti" o a "più conti di qualsiasi genere e natura", essendo peraltro incontroverso che il contratto è stato stipulato per iscritto e non risultando neppure posta la questione della specifica approvazione della pattuizione per iscritto (la deduzione svolta sul punto dalla B.n.l. è rimasta incontestata). Al riguardo è quindi sufficiente ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono sindacabili in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. La relativa censura non può essere formulata mediante l'astratto riferimento alle regole dell'art. 1362 ss. c.c., essendo imprescindibile la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice di merito si sia da essi discostato, in quanto, in mancanza, la doglianza si risolve in una mera critica della ricostruzione della volontà delle parti operata dal giudice e nell'inammissibile prospettazione di un'interpretazione diversa e contrapposta a quella fatta propria dal giudice del merito (per tutte, Cass. n. 11342 del 2004; n. 16099 del 2003; n. 8994 del 2001, n. 1045 del 2000). Nella specie, in riferimento al profilo in esame, questi principi non sono stati osservati dal ricorrente, il quale si è limitato a prospettare un'interpretazione difforme da quella accolta nella sentenza impugnata, senza indicare, nell'osservanza delle regole sopra sintetizzate, i vizi che inficerebbero sul punto la pronuncia e senza neppure contestare, sempre in ottemperanza a dette regole,l'interpretazione della Corte territoriale in ordine alla ritenuta irrilevanza della mancata chiusura del "c/c speciale". La deduzione con cui il ricorrente sostiene che sarebbe mancata la prova del credito della B.n.l. risultante dal conto passivo è, invece, inammissibile. La questione non risulta trattata dalla sentenza impugnata, quindi, deve ritenersi sollevata, per la prima volta, in questa sede, in violazione del principio secondo il quale i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni già comprese nel tema del decidere. Il ricorrente neppure ha, infatti, allegato di averla dedotta avanti al giudice del merito, indicando, specificamente, nell'osservanza del principio di autosufficienza, in 189 quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto (Case., n. 2275 del 2005; n. 1063 del 2005; n. 19254 del 2004; n. 5150 del 2003). Nel ricorso, il C. si è invero limitato a dedurre,genericamente, che "la Banca Nazionale del Lavoro nulla ha mai eccepito o rilevato in merito alla contestazione della sussistenza del credito su cui fondava la pretesa compensazione, omettendo quindi, come era suo onere, di dare la prova della sussistenza di tale credito" (pg. 7) e ciò, peraltro, dopo avere indicato alla fine del capoverso immediatamente precedente che l'importo concernente il conto passivo riguardava somme "maturate solo per colpa della banca". Inoltre, al riguardo non può tenersi conto delle deduzioni svolte nella memoria ex art. 378 c.p.c., che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, è destinata esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero a confutare le tesi avversarie, non anche ad integrare o ampliare il contenuto dei motivi del ricorso (per tutte, Cass., 14570 del 2004; n. 10683 del 2003). 2.3.- La seconda questione posta con i primi due motivi attiene alle modalità della compensazione, anche con riguardo alla rilevanza della relativa comunicazione da parte della B.n.l.. La Corte territoriale, dalla lettera della clausola contrattuale più volte citata, in virtù della quale alla banca spettava "il diritto di valersi della compensazione" "senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione (...) l'azienda darà pronta comunicazione al correntista", ha desunto la legittimità della compensazione "automatica e di diritto, senza che occorra alcuna previa formalità o comunicazione per farla valere", quindi, la sua efficacia nonostante "la mancanza di preavviso". Il ricorrente si duole di questa interpretazione, deducendo che, "come provato dalla contabile della BNL del 21/7/1982 (doc. n. 6fascicolo di parte del primo grado) e dall'interrogatorio reso dal legale rappresentante della banca all'udienza del 20/12/1994 (...), l'addebito con giroconto (...) venne effettuato dalla banca solo alla data del 21/7/1983, con indicazione che si trattava di "giro per compensazione "(...)" (così nel primo mezzo, pg. 5-6 del ricorso). Inoltre, egli lamenta la violazione degli artt. 1374 e 1375 c.c., in quanto, "la banca era tenuta a dare 'pronta comunicazione" della compensazione, mentre nella specie avrebbe provveduto a tanto solo il 21 luglio 1983, con conseguente erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha "mancato di accertare e dichiarare la colpa contrattuale della manca" (in tal senso nel secondo motivo, pg. 9 del ricorso). Dunque, nonostante una non sempre nitida esposizione delle censure, anche alla luce della memoria ex art. 378 c.p.c., che, sul punto diversamente da quanto accaduto in riferimento alla questione sopra esaminata ha contenuto meramente esplicativo, risulta chiaro che il ricorrente pone la questione delle modalità di attuazione della compensazione e della rilevanza della relativa comunicazione. Per la risoluzione di detta questione non può aversi riguardo ad un remoto precedente di questa Corte, che ha esaminato soltanto il profilo dell'ammissibilità della compensazione, ritenendola impedita dalla convenzione di assegno (Cass., n. 1149 del 1956). Questo principio non solo è stato convincentemente rimeditato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 3447 del 1986), ma neppure è riferibile al caso in esame, nel quale, come è stato precisato, la compensazione ha costituito oggetto di pattuizione, che ne ha espressamente previsto l'ammissibilità in deroga alla succitata convenzione. Il principio enunciato in relazione ad una fattispecie analoga - comunque non identica a quello 190 in esame - neppure è utilmente richiamabile, in quanto la clausola che la disciplinava è stata ritenuta nulla per difetto della sua specifica approvazione per iscritto (Cass., n. 1381 del 1987). La modalità con la quale opera la compensazione è stata approfondita dalla sentenza n. 3447 del 1986, che, nella parte qui di interesse, ha affermato che la compensazione tra più conti correnti bancari, ex art. 1853 c.c., "opera con l'annotazione in conto", precisando che, "se, ai fini dell'operatività, è necessario che la compensazione sia fatta valere, a tal fine è sufficiente -come avviene generalmente per le operazioni regolate in conto corrente-l'annotazione in conto". La pronuncia ha quindi ritenuto che, come accade in linea generale per le operazioni regolate in conto corrente, l'annotazione in conto è la scritturazione idonea a produrre la modificazione del credito disponibile per il cliente, ritenendo irrilevante che il correntista possa "ignorare, in occasione dell'emissione di un assegno, che il conto su cui l'assegno è stato fatto è scoperto in conseguenza dell'operata compensazione". Tanto perchè, "come il correntista titolare di un solo conto è sempre in grado di conoscere l'ammontare della provvista disponibile sul conto stesso, sulla base di operazioni compiute o richieste dalla banca, allo stesso modo il titolare di più conti (...), oltre a conoscere lo stato di ogni conto, sa anche in quale misura è ridotta la provvista di un conto attivo in conseguenza del saldo passivo di un altro conto" (Cass., n. 3447 del 1986; in senso sostanzialmente analogo, Case., n. 4735 del 1998; n. 6943 del 2004). Il principio va condiviso in riferimento alla circostanza che la compensazione "opera con l'annotazione in conto" del credito rinveniente da altro conto o rapporto e che, quindi, "ai fini della sua operatività è necessario che la compensazione sia fatta valere, ma a tale fine è sufficiente (...) l'annotazione in conto", precisazione che implica l'imprescindibilità di siffatta scritturazione. La sua assolutezza, in riferimento al profilo concernente la rilevanza della comunicazione, va invece esaminata alla luce del canone generale di buona fede, esplicitamente invocato nel caso in esame e che non risulta invece considerato dalle pronunce da ultimo richiamate. In linea preliminare, occorre osservare che la scritturazione delle operazioni concernenti uno stesso conto, ovvero quella derivante dalla compensazione tra conti diversi non sono pienamente omologabili. Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, tra i risultati di operazioni di segno opposto registrate nello sviluppo del rapporto di conto corrente non si verifica compensazione, poichè essere riguardano un unico rapporto che, nel corso del suo svolgimento, subisce modificazioni quantitative, sicchè il saldo che da esse consegue è il risultato contabile dei movimenti del conto operati dal correntista nell'ambito della sua disponibilità (per tutte, Cass., n. 16261 del 2002; n. 9494 del 2002). Gli addebiti e gli accreditamenti sul conto comportano operazioni di conguaglio che non sono frutto di compensazione in senso tecnico-giuridico, ma costituiscono mero effetto contabile dell'esercizio del diritto del correntista di variare la disponibilità del conto, mediante versamenti e prelievi, prelievi che, di regola, sono imputabili al correntista, il quale ha perciò la possibilità, e l'onere di conoscere, all'atto dell'emissione degli assegni, il saldo disponibile. Diversamente, invece, si ha compensazione nel caso previsto dall'art. 1853 c.c., eventualmente oggetto, come nella specie, di una clausola contrattuale, che concerne la fattispecie dei saldi attivi e passivi di più rapporti o più conti esistenti tra la banca e lo stesso cliente, che le parti hanno ritenuto di mantenere formalmente e contabilmente distinti. Orbene, se, per quanto è stato esposto, è certa l'ammissibilità della compensazione 191 mediante l'immissione del saldo di un conto come posta passiva di un altro attraverso la annotazione contabile sopra indicata - anche mentre i rapporti sono ancora in corso, la comunicazione dell'esercizio della facoltà di compensazione non può affatto ritenersi irrilevante. Infatti, come ha osservato una parte della dottrina, "mentre la disciplina civilistica della compensazione regola un fenomeno estintivo che presuppone già esauriti i cicli vitali dei rapporti, qui si ha a che fare con una situazione dinamica ancora in piena evoluzione" e si confrontano due contrapposte esigenze. Da un canto, vi è l'esigenza del correntista che, in buona fede, può fare affidamento sulla disponibilità dei fondi sul conto sul quale trae l'assegno, ignorando che la banca abbia deciso di avvalersi della facoltà di compensazione; dall'altro, vi è l'esigenza di liquidità della banca e la garanzia sulla quale essa ha fatto affidamento in virtù della convenuta compensazione, che va apprezzata anche alla luce dei maggiori costi che dovrebbe sopportare in un sistema che ne accresce il rischio, una volta che sono incrementate le tutele per il cliente. Queste esigenze devono essere, inoltre, valutate alla luce della esplicita scelta delle parti di privilegiare la distinzione formale e contabile dei differenti rapporti contrattuali tra esse intercorrenti, che occorre adeguatamente considerare. Siffatti interessi possono essere ragionevolmente bilanciati mediante l'applicazione del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto ( art. 1375 c.c.) - che ha costituito oggetto del secondo mezzo ed è stato invocato chiaramente, pur se non con nitida esposizione, dal ricorrente nella fase di merito anche mediante il richiamo alla asserita "malevolenza" della controricorrente -, il quale, secondo il più recente orientamento di questa Corte, "come si legge nella Relazione al codice civile, (...) 'richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore (ivi, p. 558). Esso opera, quindi, come un criterio di reciprocità che, nel nuovo quadro di valori introdotto dalla Carta Costituzionale, costituisce specificazione degli "inderogabili doveri di solidarietà sociale" tutelati dall'art. 2 cost. (...): la sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge" (per tutte, Cass., n. 12310 del 1999; n. 20399 del 2004; n. 14605 del 2004; n. 5240 del 2004). La buona fede costituisce uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni, forma oggetto di un vero e proprio dovere giuridico, che viene violato sia qualora una delle parti abbia agito con il proposito doloso di recare pregiudizio all'altra, sia qualora il comportamento tenuto non sia stato improntato alla diligente correttezza ed al senso di solidarietà sociale che integrano,appunto, il contenuto della buona fede. Il principio della correttezza o buona fede in senso oggettivo si colloca in primo piano nell'ambito della disciplina dei primi due titoli del libro quarto del codice civile perchè (tra l'altro) costituisce un fondamentale dovere di comportamento del debitore e del creditore ( art. 1175 c.c.) (Cass., n. 14726 del 2002). In tema di esecuzione del contratto la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, il quale impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte (Cass. n. 12093 del 2001). La parte è dunque tenuta ad adeguare il proprio comportamento in modo da salvaguardare l'utilità della controparte, tollerando 192 anche inadempimenti ovvero comportamenti della controparte, che però non pregiudichino sensibilmente il proprio interesse (Cass., n. 5240 del 2004), restando tuttavia fermo che l'impegno solidaristico trova il "suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico" (Cass., n. 14605 del 2004; n. 3185 del 2003; n. 14726 del 2002). Infine, come questa Corte ha altresì precisato, anche in presenza di una condotta conforme alla lettera di una clausola convenzionale può sussistere violazione del principio di buona fede contrattuale,sancito dall'art. 1375 c.c., in quanto esso "ha proprio la portata di ampliare (ovvero di restringere) gli obblighi letteralmente assunti con il contratto, nei casi, e nella misura in cui, farli valere (nel loro) letterale tenore contrasterebbe con detto principio, il quale opera essenzialmente come un criterio di reciprocità che deve essere osservato vicendevolmente dalle parti del rapporto obbligatorio" (Cass., n. 15150 del 2003; n. 12310 del 1999; n. 1123 del 1997; n. 888 del 1995). Nel quadro di questi principi, la sentenza impugnata non è immune dalle censure formulate dal ricorrente, nella parte in cui manca della necessaria esplicitazione in ordine all'accertamento delle modalità della compensazione, dato che il tenore letterale della clausola, in virtù delle argomentazioni sopra svolte e del principio di buona fede, non può condurre ad escludere l'imprescindibilltà della annotazione nel conto "ordinario" del saldo del "c/c speciale",come posta passiva del primo, con conseguente rilevanza dell'accertamento sul punto. Inoltre, in presenza di una clausola che stabiliva si l'operatività della compensazione anteriormente all'invio e al ricevimento della relativa comunicazione, ma disponeva anche che di essa doveva essere data "pronta comunicazione" (cfr. il p. 2 della narrativa), contrariamente a guanto ritenuto non correttamente dalla pronuncia in esame (che ha reputato "superate tutte le eccezioni (del) C." anche in ordine alla "mancanza di preavviso", in considerazione della lettera della pattuizione) l'accertamento in ordine all'invio della comunicazione dell'avvenuta compensazione ed alla sua tempestività - valutata alla luce delle circostanze del caso concreto e del principio di buona fede - non è affatto irrilevante, benchè l'eventuale violazione non incida sull'opponibilità della causa estintiva, bensì rilevi sotto il profilo dell'eventuale aggravamento del danno subito dal correntista. La mancata tempestività della comunicazione può peraltro essere giustificata dalla sopravvenienza di fatti che, evidenziando il mutamento delle condizioni patrimoniali del correntista, incidono sulla solvibilità del medesimo e giustificano il ricorso immediato da parte della banca alla compensazione. In difetto di ogni elemento in grado di prefigurare una situazione di pericolo, la compensazione effettuata senza procedere alla "pronta comunicazione" della compensazione, per le considerazioni sopra svolte, è invece suscettibile di determinare la responsabilità della banca, per l'aggravamento del danno eventualmente subito dal correntista. In conclusione, i primi due motivi del ricorso devono essere accolti per guanto di ragione - entro i limiti che sono stati precisati -, restando assorbito il terzo, e, conseguentemente, la sentenza Impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma, che procederà al riesame della controversia, attenendosi al principi sopra enunciati, provvedendo altresì sulle spese processuali di questa fase. P.Q.M. 193 La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso per quanto di ragione, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma, anche per le spese della presente fase. Così deciso in Roma, il 16 giugno 2005. Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2005. -L’obbligo della banca di mettere a disposizione del cliente una determinata somma di danaro, cui quest’ultimo abbia la facoltà di attingere nei modi previsti, nasce solo in dipendenza della stipula di un contratto di apertura di credito. Dalla tolleranza di una situazione di scoperto, comunque motivata e ancorché protrattasi per un consistente periodo, non deriva il vincolo per la banca di pagare assegni privi di copertura, di tal che viola il dovere di diligenza media, con conseguente impossibilità di invocare il fatto scusabile, l’emittente che anziché attenersi al dovere di conformare l’andamento del conto al fine di assicurare che in ogni momento vi sia disponibilità del denaro necessario al pagamento dell’assegno nei termini per la presentazione di esso all’incasso - si limiti a fare affidamento sullo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento di esso correntista, anche in assenza di provvista e nell’ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca precedentemente valutati. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA 24 novembre 2005, n. 24842 (Presidente Vitrone – Relatore Giusti) Svolgimento del processo 1. Con ricorso depositato il 13 ottobre 2001, Gianni F. proponeva opposizione avverso l’ordinanza emessa dal Prefetto di Udine il 20 agosto 2001 con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di lire 26.000.000 a titolo di sanzione amministrativa per avere emesso, nel periodo dal 30 settembre 1999 al 30 giugno 2000, assegni bancari senza autorizzazione e senza provvista, in violazione degli articoli 1 e 2 della legge 386/90, nel testo sostituito dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs 507/99. Il ricorrente chiedeva al Giudice di pace di Udine, in via principale, l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione sul rilievo che l’emissione era avvenuta «in conseguenza di un illegittimo protesto elevato su richiesta della Banca Popolare Udinese» e per fatto scusabile; in via subordinata, la diminuzione dell’entità della sanzione amministrativa pecuniaria, dato che, trattandosi di fatti avvenuti in unico contesto, andava applicato l’istituto della continuazione. 2. L’adito Giudice di pace, con sentenza depositata in data 12 aprile 2002, accoglieva parzialmente il ricorso, modificando l’ordinanza-ingiunzione opposta e determinando in lire 21.000.000 l’entità della sanzione amministrativa pecuniaria. Il Giudice di pace riteneva infondata la richiesta di annullamento dell’ordinanzaingiunzione per fatto scusabile, non risultando che l’emissione degli assegni fosse 194 avvenuta in difetto del necessario elemento soggettivo. Aggiungeva che all’illecito amministrativo in questione non era applicabile il regime previsto dall’articolo 81, comma 2, Cp, atteso che l’articolo 8 della legge 689/81 si riferisce soltanto all’ipotesi di violazione di diverse disposizioni o delle stesse disposizioni, compiute con una sola azione od omissione, non anche alla diversa fattispecie di violazioni attraverso una pluralità di azioni, pur se esecutive di un medesimo disegno. Il Giudice di pace, ai fini della rideterminazione dell’entità della sanzione amministrativa pecuniaria, applicava, in relazione alle violazioni commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria, l’articolo 8bis, comma 4, della legge 689/81, aggiunto dall’articolo 94 del D.Lgs 507/99. 3. Avverso la sentenza del Giudice di pace di Udine ha proposto ricorso per cassazione il F., con atto notificato a mezzo del servizio postale il 22 luglio 2002, deducendo due motivi di censura. Motivi della decisione 1. Con il primo, complesso motivo (articolo 360, numero 3, Cpc: violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 386/90, come modificato dal D.Lgs 507/99, in relazione agli articoli 42 e 43 Cp e all’articolo 3 della legge 689/81; violazione dell’articolo 115 Cpc con omessa motivazione su un punto decisivo della controversia), il ricorrente - premesso che il conto corrente presso la Banca Popolare Udinese, sul quale gli assegni erano stati emessi, «non risultava connesso ad un contratto scritto di scopertura in conto corrente», pur avendo l’istituto di credito in passato sempre regolarmente pagato gli assegni nonostante il conto fosse in rosso, e che gli assegni protestati successivamente a quello che provocò la revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni furono emessi anteriormente alla data del primo protesto (12 ottobre 1999), postdatati o senza data secondo accordi per negoziazioni differite - osserva che la legge 386/90, avendo abrogato gli articoli 116 e 116bis delle disposizioni approvate con il Rd 1736/33, e successive modifiche ed integrazioni, sanziona soltanto l’emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista, non anche l’emissione di assegno senza data o postdatato. Sarebbe arbitrario far coincidere la data di emissione del titolo con la data del protesto ovvero con la data successivamente apposta sull’assegno dal presentatore o dal suo girante che abbia ricevuto l’assegno privo di data di emissione ovvero con una data posteriore a quella della sottoscrizione e della negoziazione, perché l’illecito di cui all’articolo 1 della legge 386/90 si consuma all’atto dell’emissione del titolo senza l’autorizzazione del trattario. In ordine al difetto dell’elemento psicologico dell’illecito amministrativo, il ricorrente - premesso che per il reato di emissione di assegno mancante di provvista era previsto il fatto scusabile - afferma di avere «fornito documentazione di per sé probante di un accordo (ovviamente tacito) sul quale» aveva “fatto affidamento”, dovendo escludersi che egli «debba rispondere per un fatto imprevedibile (il mancato pagamento di un assegno senza preavviso) che ha messo in ginocchio la sua impresa». Ad avviso del ricorrente, la sospensione del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, in attesa della definizione della causa di risarcimento dei danni promossa dinanzi al Tribunale di Udine nei confronti della banca per l’improvvisa chiusura del conto, costituiva per il Giudice di pace un atto dovuto per integrare l’indagine sulla oggettiva sussistenza delle violazioni o sulla non sanzionabilità 195 del comportamento. 1.1. Con il secondo motivo (violazione dell’articolo 8bis, comma 4, della legge 689/81), il ricorrente si duole che il Giudice di pace non abbia preso in considerazione l’introduzione, ad opera del D.Lgs 507/99, dell’articolo 8bis della legge 689/81, che - in quanto norma più favorevole - andrebbe applicato anche agli illeciti compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo. Il ricorrente afferma di non condividere quanto statuito in una recente sentenza di questa Corte (Sezione prima, 3756/01), che ha invece escluso che il regime di cui al citato articolo 8bis possa ricevere un’applicazione retroattiva. 2. Il primo mezzo di impugnazione è in parte inammissibile, in parte infondato. 2.1. Il motivo è inammissibile là dove il ricorrente si duole che siano stati considerati sussistenti gli illeciti amministrativi di emissione di assegni senza autorizzazione sebbene alla data di emissione dei titoli (postdatati o con data lasciata in bianco) - data alla quale occorrerebbe avere riguardo ai fini della consumazione dell’illecito - l’autorizzazione non fosse stata ancora revocata. La ragione di inammissibilità è duplice. Per un verso essa risiede nella novità della censura. Infatti, premesso che il motivo del ricorso per cassazione deve investire statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di merito, non essendo consentito proporre questioni nuove fondate su elementi di fatto diversi da quelli fatti valere nella precedente fase, deve ritenersi nuovo il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca per la prima volta l’insussistenza oggettiva dei contestati illeciti di emissione di assegni senza autorizzazione (e ciò in rapporto al momento in cui i titoli sarebbero stati formati e posti in circolazione), laddove con l’atto di opposizione e in sede di precisazioni delle conclusioni - la cui lettura è consentita trattandosi di verificare una preclusione di ordine processuale - si sia chiesto (in via principale) l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione per la ricorrenza del fatto scusabile, e quindi per il difetto dell’elemento psicologico degli illeciti medesimi. Per l’altro essa dipende dalla circostanza che con la proposizione della doglianza il ricorrente si limita ad offrire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, in tal modo richiedendo un riesame nel merito della vicenda, non consentito in sede di legittimità. Il Giudice di pace di Udine ha infatti accertato, in base alla documentazione prodotta, che il F. ha emesso gli assegni - in relazione ai quali gli sono state contestate le violazioni dell’articolo 1 della legge 386/90, nel testo sostituito dall’articolo 28 del D.Lgs 507/99 - in. data 30 novembre 1999, in data 31 gennaio 2000, in data 28 febbraio 2000, in data 30 aprile 2000 e in data 30 giugno 2000, a fronte di una revoca dell’autorizzazione del 18 ottobre 1999. All’accertamento cui è pervenuto il giudice del merito, il ricorrente oppone il convincimento che gli assegni protestati successivamente a quello che provocò la chiusura del conto sarebbero stati in realtà emessi anteriormente alla data del 12 ottobre 1999 postdatati o senza data secondo accordi per negoziazioni differite; e ciò senza indicare da quali prove la circostanza risulterebbe e senza considerare che l’assunto della divergenza tra la reale data di emissione dei titoli e quella riportata negli stessi abbisogna di una 196 prova rigorosa e che, in difetto di essa, occorre dare la prevalenza a quella risultante dai titoli. 2.2. Inammissibile, difettando l’indicazione nel motivo di ricorso delle precisazioni necessarie a individuare la dedotta violazione processuale, è la censura relativa alla mancata sospensione del giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione fino alla definizione della causa di risarcimento dei danni promossa dal F. nei confronti della banca. Difatti, posto che la sentenza impugnata non solo non contiene alcuna statuizione sulla sospensione del processo in attesa della definizione dell’altra controversia ma neppure dà atto della proposizione di una istanza in tal senso da parte dell’opponente, e premesso che una tale istanza non può essere avanzata per la prima volta in sede di legittimità (cfr. Cassazione civile, Sezione terza, 12596/01), il ricorrente avrebbe dovuto indicare in quale atto processuale del giudizio di merito svolto si dinanzi al Giudice di pace egli ebbe a formulare detta richiesta, atteso che questa Corte può accertare il riscontro della lamentata violazione processuale in atti al di fuori del (e diversi dal) ricorso per cassazione solo se esso indichi i riferimenti necessari ai fini di un controllo mirato. 2.3. In relazione alla censura, sollevata sempre con il primo motivo, attinente alla mancata considerazione del fatto scusabile, occorre premettere che la nuova configurazione come illecito amministrativo dell’emissione di assegno senza provvista - discendente dalla depenalizzazione del corrispondente delitto operata dall’articolo 29 del D.Lgs 507/99, che ha novellato l’articolo 2 della legge 386/90 - comporta che l’imputazione soggettiva al traente può essere tanto a titolo di dolo quanto a titolo di colpa, in applicazione della normativa generale in tema di elemento psicologico tratteggiata dall’articolo 3 della legge 689/81. Ora, con riguardo all’illecito amministrativo di cui all’articolo 2 della legge 386/90, il ricorrente sostiene che basti a dimostrare di avere agito nella incolpevole convinzione di disporre della provvista, l’aver fatto affidamento su un fido precedentemente concesso ed (in passato) onorato dalla banca. La doglianza non è fondata. L’obbligo della banca di mettere a disposizione del cliente una determinata somma di danaro, cui quest’ultimo abbia la facoltà di attingere nei modi previsti, nasce solo in dipendenza della stipula di un contratto di apertura di credito. Dalla tolleranza di una situazione di scoperto, comunque motivata e ancorché protrattasi per un consistente periodo, non deriva il vincolo per la banca di pagare assegni privi di copertura, di tal che viola il dovere di diligenza media, con conseguente impossibilità di invocare il fatto scusabile, l’emittente che anziché attenersi al dovere di conformare l’andamento del conto al fine di assicurare che in ogni momento vi sia disponibilità del denaro necessario al pagamento dell’assegno nei termini per la presentazione di esso all’incasso - si limiti a fare affidamento sullo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento di esso correntista, anche in assenza di provvista e nell’ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca precedentemente valutati. 3. Il secondo motivo - con il quale il ricorrente si duole della mancata applicazione retroattiva della norma sulla programmazione unitaria nell’illecito amministrativo, di cui all’articolo 8bis, comma 4, della legge 689/81, introdotto 197 dall’articolo 94 del D.Lgs 507/99 – è inammissibile per carenza del necessario interesse ad impugnare. Difatti la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile la nuova disciplina - la quale esclude che le violazioni amministrative successive alla prima siano valutate, ai fini della reiterazione, quando le stesse, commesse in un arco di tempo limitato, sebbene plurime da un punto di vista giuridico-formale, appaiano però espressive di un unico sostanziale episodio di trasgressione - anche agli illeciti posti in essere anteriormente all’entrata in vigore del citato decreto legislativo di depenalizzazione. Ciò risulta dalla pagina 3 della sentenza impugnata, ove si legge che «in data 30 novembre 1999 il ricorrente ha emesso due assegni di lire 10.000.000 cad., senza autorizzazione, entrambi protestati il 3 dicembre 1999, essendo stato il conto corrente n. 12205 della Banca Popolare Udinese, sede di Udine, da cui erano stati emessi gli assegni, revocato il 18 ottobre 1999, per cui, ritenuta sussistente la circostanza di cui all’articolo 8bis, comma 4, legge 689/81, ai fini della reiterazione verso il precedente assegno del 30 settembre 1999, si ritiene giusto applicare la sanzione amministrativa di lire 4.000.000, ritenendosi appunto le violazioni commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria». 4. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Nessuna statuizione deve essere emessa sulle spese, non avendo il Prefetto di Udine svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 5 ottobre 2005. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 NOV 2005. CULPA IN VIGILANDO TRACCIA: Tizietto è figlio di Tizia e Tizione. Tizietto frequenta la quarta elementare, presso l’istituto privato Giulio Cesare di Roma. Un giorno, Tizietto si trovava casualmente in bagno, durante la pausa di ricreazione, con Marcus e Violentus, due compagni di scuola, conosciuti per episodi di bullismo. Marcus e Violentus incominciavano a spingere Tizietto, insultandolo per gli occhiali a fondo di bottiglia; a causa degli spintoni, il piccolo Tizietto cadeva a terra, rompendosi gli occhiali. Marcus e Violentus scappavano via, deridendo il povero Tizietto. Tizietto, con le lacrime agli occhi, si alzava e cominciava a correre verso la sua classe alla ricerca della maestra; accadeva, poi, che Tizietto inciampava su una piccola sporgenza del pavimento, anche a causa degli occhiali da vista rotti che riducevano la visibilità. Tizietto riportava una frattura alla caviglia. Tizia e Tizione si rivolgevano ad un avvocato. Il candidato, premessi brevi cenni sul concorso apparente (o improprio) di responsabilità, rediga motivato parere sulla questione giuridica prospettata. 198 POSSIBILE SOLUZIONE SCHEMATICA: In premessa era necessario parlare del concorso apparente (o improprio) di responsabilità. Il legislatore civile, come noto, prevede due tipologie di responsabilità, basate l’una sulla sussistenza di un contratto (ovvero, secondo le tesi più recenti, su un contatto sociale qualificato) che non viene esattamente adempiuto, e l’altra sulla violazione di un dovere generico di buona condotta sociale (neminem laedere). Le due azioni, secondo la giurisprudenza quasi unanime, possono essere cumulate tra loro, nella misura in cui sussistano (in modo cumulativo) i seguenti requisiti: -unicità del fatto lesivo -coincidenza soggettiva danneggiante-debitore e danneggiato-creditore -la derivazione oggettiva del danno aquiliano come conseguenza dell’inadempimento (o inesatto adempimento) dell’obbligazione (si pensa al danno alla persona cagionato da vizi della cosa venduta). Laddove uno di tali requisiti non sussista vi potrà essere un concorso apparente di responsabilità (come nell’ipotesi classica del debitore che cagiona col suo inadempimento contemporaneamente un danno contrattuale al creditore ed un danno extracontrattuale a terzi estranei al rapporto, che si realizza spesso in tema di vizi del prodotto). Nell’ipotesi presa in esame, vi è concorso apparente? Al quesito posto si poteva dare risposta positiva. In particolare, sembra mancare il secondo requisito individuato (coincidenza soggettiva), perché potrebbe sussistere una responsabilità di tipo contrattuale da far valere verso la scuola. che è privata con la conseguenza che l’iscrizione vale come accettazione di proposta contrattuale, cumulabile con un’azione extracontrattuale da far valere verso Marcus e Violentus, se maggiorenni, o verso i relativi genitori, ex art. 2048 c.c. (letto in combinato disposto con l’art. 30 Cost.) per culpa in educando. Più in particolare, il preside e la maestra dovevano vigilare, anche durante la ricreazione, sul buon comportamento di Marcus e Violentus, tanto più che si trattava di ragazzi già noti per episodi di bullismo, per cui non era inverosimile prevedere un comportamento vessatorio verso compagni di scuola (nella specie il povero Tizietto). Inoltre, i genitori di Tizietto potranno agire verso Marcus e Violentus (ovvero verso i genitori)in via extracontrattuale, non sussistendo alcun contratto e venendo in contatto occasionalmente. Marcus e Violentus (o i rispettivi genitori), nonché la scuola ed il preside, dovranno rispondere anche della frattura della caviglia oltre che della distruzione degli occhiali? Tendenzialmente bisognerebbe dare risposta positiva, in quanto la caduta che ha causato la frattura è stata determinata sia dalla rottura degli occhiali, che dalla sporgenza del pavimento: nel primo caso la responsabilità è da imputare ai bulli e bel secondo caso la responsabilità è da imputare alla scuola (principalmente al preside). Al più, la decisione di Tizietto di correre, piuttosto che stare fermo a causa del visus limitato, potrebbe incidere sul quantum, ex art. 1227 c.c., ma non sul piano dell’an. 199 Oltre al danno patrimoniale, quindi, potrebbe essere risarcito anche il danno biologico fisico e psichico (se c’è trauma psicologico), con l’aggiunta del danno esistenziale (se sussiste il danno biologico psichico, ovvero Tizietto viene preso in giro, di più, dopo l’evento). Si consiglia di ripetere il problema analizzato sul testo di Gazzoni, Manuale di diritto privato, ESI, con riferimento alle tematiche della culpa in vigilando (dei maestri) e da custodia. Si consiglia di leggere le sentenze che seguono. La responsabilità del genitore (ex art. 2048 c.c., primo comma) e quella del precettore (ex art. 2048, secondo comma) - per il fatto illecito commesso da un minore capace di intendere e di volere mentre è affidato a persona idonea a vigilarlo e controllarlo - non sono tra loro alternative, giacché l'affidamento del minore alla custodia di terzi solleva il genitore dalla presunzione di colpa in vigilando (dal momento che dell'adeguatezza della vigilanza esercitata sul minore risponde il precettore cui lo stesso è affidato), ma non anche da quella di colpa in educando, i genitori rimanendo comunque tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore in un momento in cui lo stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenirne comportamenti illeciti. Corte di cassazione, Sezione III civile, Sentenza 21 settembre 2000, n. 12501 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 18 aprile 1989 G.T. e G.T., quali rappresentanti legali del minore A.T., convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia S.G., quale padre e legale rappresentante del figlio minore (omissis), nonché il Ministero della pubblica istruzione per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti del minore (omissis) conseguenti al sinistro verificatosi nel corso di una lezione di disegno presso il liceo (omissis) il 19 novembre 1987. Gli attori, a sostegno della domanda, esponevano che il detto sinistro era stato determinato dal fatto che il compagno di classe (omissis) aveva scagliato contro (omissis) una gomma per cancellare, colpendolo in un occhio e procurandogli gravi lesioni. Si costituivano regolarmente i convenuti: S.G., in proprio e quale rappresentante legale del minore (omissis), nonché il Ministero della pubblica istruzione. Ambedue chiedevano il rigetto della domanda sul presupposto dell'insussistenza di una loro responsabilità. n G. faceva anche presente che il contraddittorio non era integro, non essendo stato citato l'insegnante. Nella comparsa conclusionale il procuratore del G. dichiarava, agli effetti dell'art. 300 c.p.c., che (omissis) era divenuto maggiorenne. Il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 14 febbraio 1994, rigettava l'istanza di interruzione del processo anche perché tardiva e, nel merito, 200 accoglieva la domanda nei confronti di S.G. poiché riteneva sussistente la colpa di (omissis) e responsabile il genitore di non avere impartito al figlio un'adeguata educazione; rigettava la domanda nei confronti del Ministero poiché escludeva la colpa dell'insegnante. Condannava, pertanto, S.G. a pagare agli attori la somma di L.24.409.200 per danno biologico e danno morale, oltre gli interessi legali. S. ed (omissis) proponevano appello principale; G.T. e G.T. si costituivano e proponevano appello incidentale contro il Ministro; (omissis), nelle more divenuto maggiorenne, interveniva in causa facendo proprie le conclusioni formulate dai propri genitori; il Ministro chiedeva il rigetto dell'appello e, in via subordinata, proponeva appello incidentale sull'ammontare dei danni. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza depositata il 21 novembre 1997, confermava la pronunzia di primo grado nella parte in cui aveva escluso l'interruzione del processo a seguito della maggiore età di (omissis), ma con motivazione diversa la Corte osservava che, essendo state proposte due domande di responsabilità (l'una nei confronti del minore ex art. 2043 c.c. e l'altra nei confronti del genitore ex art. 2048 c.c.) ed essendo esse autonome (anche se formalmente riunite), la causa interruttiva relativa alla domanda contro il minore non aveva alcun effetto sulla domanda contro il genitore, che era stata l'unica accolta dal Tribunale, il quale aveva condannato S.G. non nella qualità di legale rappresentante del figlio, ma in proprio. Conseguentemente la Corte dichiarava inammissibile l'appello proposto da (omissis), per mancanza di interesse, essendo stata la domanda proposta nei suoi confronti implicitamente rigettata dal Tribunale. Nel merito, la Corte di appello confermava la pronunzia di primo grado, osservando che la responsabilità dell'insegnante, la cui affermazione era stata chiesta dall'appellante S.G., non sarebbe stata sufficiente a sollevare il genitore dalla pressione di colpa in educando posta dall'art. 2048 c.c., poiché, con la dichiarazione di responsabilità dell'insegnante, si sarebbe individuata soltanto una responsabilità concorrente ininfluente nei confronti del danneggiato (ex art. 2055 c.c.) e rilevante nei soli rapporti interni tra coobbligati solidali, ai fini del regresso (nel caso di specie, non esercitato). In ordine alla colpa del genitore G., la Corte giudicava la prova testimoniale dallo stesso articolata inidonea a superare la presunzione posta dall'art. 2048 c.c., perché non dimostrava che il genitore aveva esercitato "una pregnante vigilanza sui risultati dell'educazione", mentre il comportamento del minore in occasione del sinistro, "seppure certamente non sintomatico di un'inclinazione alla violenza" (perché "ispirato da un intento scherzoso"), rivelava '"un'immatura sconsideratezza e una non ancora acquisita coscienza della irrilevanza delle intenzioni sui risultati di un gesto comunque oggettivamente violento". Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia S.G. ed (omissis) hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. G.T. e G.. nonché (omissis) hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale contro (omissis). Il Ministero della pubblica istruzione ha resistito con controricorso. I ricorrenti principali hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). 201 2. Va, innanzitutto, dichiarata l'inammissibilità del ricorso principale presentato da (omissis) (minore divenuto maggiorenne nel corso del giudizio di primo grado) per la sua mancanza di interesse ad impugnare. La Corte di appello ha ritenuto che la domanda proposta dai danneggiati (ai sensi dell'art. 2043 c.c.) nei confronti del minore capace di intendere e di volere sia stata implicitamente rigettata dal Tribunale, il quale ha condannato al risarcimento dei danni soltanto il genitore S.G., accogliendo l'altra domanda proposta dai danneggiati (a norma dell'art. 2048 c.c.). La Corte di appello, pertanto, ha dichiarato (anche in dispositivo) inammissibile l'appello proposto da (omissis). L'assenza di soccombenza di quest'ultimo rispetto all'azione proposta dai danneggiati comporta l'inammissibilità anche del ricorso per cassazione da lui proposto unitamente a S.G. Il ricorso principale, quindi, va ritenuto ammissibile ed esaminato nel suo contenuto solo in quanto proposto da S.G.. 3. Con il primo motivo il ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. (sul litisconsorzio necessario), dell'art. 354 c.p.c., degli artt. 2048 e 2049 c.c. (responsabilità dei precettori e/o dei genitori nonché dei datori di lavoro dei precettori), nonché l'omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo. Il ricorrente ritiene che l'insegnante di disegno prof. A.F. sia litisconsorte necessario nel presente giudizio poiché si discute della sua responsabilità ex art. 2048 c.c., costituente il presupposto della responsabilità del Ministero ex art. 2049 c.c., onde la presenza in giudizio di quest'ultima parte non esclude la necessità di accertare la culpa in vigilando dell'insegnante, che renderebbe priva di rilievo la culpa in educando del genitore. Il motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente non tiene conto del disposto dell'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che ha innovato la disciplina della responsabilità del personale della scuola per i danni prodotti ai terzi nell'esercizio delle funzioni di vigilanza degli alunni sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale. Sotto il primo aspetto, il citato art. 61 ha limitato la responsabilità del detto personale ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza; sotto il secondo aspetto, esso ha previsto la "sostituzione" dell'amministrazione al personale scolastico nell'obbligazione risarcitoria verso i terzi danneggiati, con esclusione quindi della legittimazione passiva degli insegnanti (in tal senso v. Sez. un. , 11 agosto 1997, n. 7454; Sez. III 7 ottobre 1997, n. 9742; Sez. III, 3 marzo 1995, n. 2463). Correttamente, pertanto, i danneggiati hanno instaurato la presente azione nei confronti del Ministero della pubblica istruzione, e non anche dell'insegnante nel corso della cui lezione e avvenuto il fatto dannoso. 4. Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 300 c.p.c. e dei principi che disciplinano l'interruzione e la prosecuzione del processo in ipotesi di giudizi riuniti ma autonomi (litisconsorzio facoltativo), nonché vizi di motivazione su un punto decisivo. Il ricorrente censura la mancata interruzione del processo a seguito della maggiore età conseguita da 202 (omissis) e tempestivamente dichiarata nel corso del giudizio di primo grado, osservando che tale interruzione investe, di necessita, l'intero procedimento anche nel caso di cause autonome riunite, mentre, in quest'ultima situazione processuale, e la riassunzione del giudizio interrotto che può essere parziale. Il motivo di ricorso è infondato, ma va corretta la motivazione della sentenza impugnata (art. 384, secondo comma, c.p.c.). La Corte di appello ha escluso che il processo di primo grado dovesse essere interrotto a causa della dichiarazione - in esso effettuata - della maggiore età conseguita da (omissis), che era stato convenuto in giudizio nella persona del suo rappresentante legale S.G. L'esclusione dell'interruzione del processo è stata giustificata dalla Corte di appello con la considerazione che, essendo la causa proposta contro (omissis) autonoma da quella instaurata contro S.G. in proprio ed essendovi un litisconsorzio facoltativo tra le due domande, il fatto interruttivo relativo alla prima causa non produceva alcun effetto rispetto alla seconda causa, che pertanto doveva proseguire senza essere interrotta dal conseguimento della maggiore età da parte del minore (omissis). A questa ratio decidendi il ricorrente contrappone il richiamo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel caso di riunione per ragioni di connessione di più cause scindibili, la verificazione di un evento interruttivo riguardante uno dei soggetti delle distinte vertenze che non sia partecipe delle altre si riflette di necessità sull'intero procedimento, non essendo concepibile un'interruzione parziale di questo (Cass. 14 ottobre 1993, n. 10167; 10 febbraio 1987, n. 1383). Sulla base del richiamato orientamento giurisprudenziale di questa Corte non può essere condivisa la ragione giustificativa della sentenza impugnata, onde va ritenuto che, a seguito della maggiore età conseguita dal minore (omissis) e dichiarata nel corso del giudizio di primo grado, questo doveva essere interrotto nei confronti di tutte le parti. Va, però, osservato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, poiché l'interruzione del processo è preordinata dalla legge a tutela della parte interessata da determinati eventi, non sono legittimate a dolersi della omessa interruzione del processo le altre parti, onde la mancata interruzione non può essere né rilevata d'ufficio dal giudice, né essere eccepita da altra parte (v., di recente, Cass. 11 settembre 1999, n. 9672; 20 novembre 1998, n. 1175; 29 agosto 1998, n. 8641; 18 luglio 1997, n. 6625). In applicazione di siffatto principio deve affermarsi che legittimato a dolersi della mancata interruzione del processo di primo grado era soltanto (omissis), divenuto maggiorenne e quindi capace di stare in giudizio di persona (anziché a mezzo di rappresentante legale ex art. 75 c.p.c.). (omissis), nel proporre l'atto di appello, ha lamentato la mancata interruzione del processo di primo grado, ma la Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha, come si è detto, dichiarato inammissibile l'appello dallo stesso proposto per mancanza di interesse ad impugnare, avendo il Tribunale rigettato la domanda proposta (ex art. 2043 c.c.) dai danneggiati nei suoi confronti ed avendo accolto la sola domanda dagli stessi proposta (ex art. 2048 c.c.) contro il genitore S.G. 203 Consegue che a fare valere detta mancata interruzione non può ritenersi legittimato S.G. in proprio, non essendo la sua posizione di parte convenuta in proprio interessata dall'evento interruttivo relativo alla posizione del figlio (omissis). Va, pertanto, giudicata corretta la sentenza impugnata, la quale ha escluso che dovesse essere accolto il motivo di appello con cui S.G. aveva lamentato la mancata interruzione del processo di primo grado, anche se per un motivo diverso da quello ravvisato dalla Corte di appello. 5. Con il terzo motivo del ricorso principale il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2048 c.c. e dei principi e norme che disciplinano la responsabilità del precettore e quella dei genitori, dell'art. 2049 c.c. con riferimento alla responsabilità dell'insegnante dipendente ex art. 2048 c.c., nonché l'insufficiente e la contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Con il motivo di ricorso, concernente il merito della causa, si prospettano tre censure: a) il ricorrente lamenta che la Corte di appello ha ritenuta inutile un'indagine sulla colpa in vigilando dell'insegnante, che invece era decisiva e preliminare, perché solo nell'ipotesi di esclusione di tale colpa "si può porre il problema di un'educazione così carente che il minore, pure in presenza di una vigilanza idonea, sia stato in grado di commettere l'illecito causativo del danno"; b) il ricorrente censura le ragioni per le quali la Corte non ha ammesso la prova testimoniale da loro chiesta, osservando che la culpa in educando si configura con riferimento alla condotta dei genitori e non ai risultati conseguiti; c) si denunzia la contraddittoria della sentenza impugnata, la quale, riconoscendo che il comportamento del minore "venne ispirato da un intento scherzoso" avrebbe dovuto escludere la responsabilità del genitore, poiché l'educazione da quest'ultimo impartita tende ad "impedire comportamenti violenti, ma non giochi e scherzi, che sono una componente della stessa crescita culturale dei minori". Il motivo di ricorso è infondato in tutte e tre le censure formulate. 5.1. Per quanto attiene alla censura qui indicata sub a), va premesso che il ricorrente non contesta il principio affermato dalla sentenza impugnata (e conforme, d'altronde, alla giurisprudenza di questa Corte: v., di recente, Cass. 25 marzo 1997, n. 2606), secondo cui la responsabili del genitore (ex art. 2048 c.c., primo comma) e quella del precettore (ex art. 2048, secondo comma) - per il fatto illecito commesso da un minore capace di intendere e di volere mentre è affidato a persona idonea a vigilarlo e controllarlo - non sono tra loro alternative, giacché l'affidamento del minore alla custodia di terzi solleva il genitore dalla presunzione di colpa in vigilando (dal momento che dell'adeguatezza della vigilanza esercitata sul minore risponde il precettore cui lo stesso è affidato), ma non anche da quella di colpa in educando, i genitori rimanendo comunque tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore in un momento in cui lo stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenirne comportamenti illeciti. Il ricorrente ritiene, però, che tale principio sia stato "frainteso" dalla Corte di appello quando ha da esso desunto l'affermazione di una responsabilità solidale del precettore e del genitore, negando che fosse decisiva e preliminare l'indagine sulla colpa in vigilando del precettore, ritenuta dalla Corte inutile. 204 La tesi sostenuta dal ricorrente non tiene conto del disposto dell'art. 2055 c.c., secondo cui, se il fatto dannoso è imputabile a più persone (anche a diverso titolo, secondo la giurisprudenza pacifica), tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. L'affermata responsabilità concorrente del genitore e del precettore comporta un vincolo di solidarietà tra gli stessi, onde ciascuno di essi è tenuto a risarcire l'intero danno subito dal danneggiato, mentre l'eventuale graduazione delle colpe ha rilievo solo nei rapporti interni tra i responsabili, ai fini dell'azione di regresso (art. 2055, secondo e terzo comma). Nel caso di specie, S.G., convenuto dai danneggiati, non ha esercitato azione di regresso contro il Ministero della pubblica istruzione. Pertanto la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dell'art. 2055 c.c. quando ha affermato che, una volta non superata la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048 c.c. a carico del genitore S.G., è irrilevante (rispetto all'azione risarcitoria esercitata dai danneggiati) l'accertamento dell'eventuale concorrente responsabilità dell'insegnante (e quindi del Ministero), che assume rilievo nei soli rapporti interni tra i convenuti (estranei all'oggetto del presente giudizio). 5.2. Per quanto attiene alla censura sub b), concernente le ragioni per le quali la Corte di appello non ha ammesso la prova testimoniale formulata dal ricorrente in ordine all'educazione da lui impartita al figlio minore, occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la presunzione di culpa in educando posta dall'art. 2048 c.c. richiede, per essere superata, che il genitore provi di avere impartito al figlio un'educazione normalmente idonea, in relazione al suo ambiente, alle sue attitudini ed alla sua personalità ad avviarlo ad una corretta vita di relazione e, quindi, a prevenire un suo comportamento illecito, nonché, in particolare, a correggere quei difetti (come l'imprudenza e la leggerezza) che il fatto del minore ha rivelato (v., ex plurimis, Cass. 6 dicembre 1986 n. 7247). Tale dimostrazione comporta, come ha correttamente ritenuto la Corte di appello, che il genitore compia anche "un'adeguata vigilanza in ordine al grado di assimilazione, da parte del minore stesso, dell'educazione ricevuta e della conformità della abituale condotta dello stesso ai precetti dell'educazione impartitagli". Nell'opera di educazione, in altri termini, è insita un'attività di vigilanza sulla rispondenza del comportamento del minore e sui risultati concreti dell'attività educativa. In tal modo, contrariamente a quanto ha rilevato il ricorrente, la colpa non viene ravvisata nel risultato dell'educazione, ma rimane pur sempre collegata alla condotta del genitore. Sulla base di tale individuazione della prova liberatoria richiesta dall'art. 2048 c.c. per superare la presunzione di responsabilità posta a carico del genitore, la Corte di appello ha ritenuto irrilevante la prova testimoniale formulata dal ricorrente, con un giudizio che, per questo aspetto applicativo, non viene censurato nel ricorso (ove, infatti, i capitoli di prova non sono stati trascritti). 5.3. In ordine alla censura sub c), la motivazione della sentenza impugnata non è contraddittoria perché, pur ammettendo l'intento scherzoso con cui l'alunno (diciassettenne) aveva scagliato la gomma contro l'altro alunno, ha ravvisato nell'autore di tale gesto dannoso "un'immatura sconsideratezza e una non ancora acquisita coscienza della irrilevanza delle intenzioni sui risultati di un gesto 205 comunque oggettivamente violento". La contraddizione denunziata dal ricorrente non sussiste perché l'educazione dei minori deve tendere a fare loro acquisire una maturità anche nelle attività di gioco e di scherzo e nei comportamenti che comunque esprimono un intento ludico. 6. Passandosi all'esame del ricorso incidentale proposto dai danneggiati, l'unico motivo di esso concerne la posizione di (omissis). I ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe affermato che l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla domanda da loro proposta nei confronti di (omissis) equivale a rigetto della stessa. I ricorrenti denunziano la violazione dell'art. 112 c.p.c., ritenendo che "l'omessa pronuncia costituisce una mera omissione, e non produce effetti ulteriori, sicché non è mai preclusa la possibilità di riproporre la domanda rispetto alla quale si è verificata l'omissione". Il motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello ha desunto dalla mancanza di statuizione della sentenza del Tribunale nei confronti di S.G. quale legale rappresentante del figlio minore la conclusione che la domanda era stata rigettata nei confronti di quest'ultimo ed accolta nei confronti del solo padre. Il giudice di appello, quindi, non ha ravvisato una omessa pronuncia da parte del Tribunale, e cioè un vizio della sentenza appellata, ma ha ritenuto che vi fosse stato un rigetto della domanda proposta contro il minore. Tale interpretazione della sentenza di primo grado - effettuata dalla Corte di appello - non viene censurata dai ricorrenti, che pongono il problema degli effetti dell'omissione di pronuncia, mentre la Corte di appello ha ritenuto che la domanda nei confronti di (omissis) fosse stata rigettata dal Tribunale. Detta interpretazione (della sentenza di primo grado) non può, pertanto, essere riesaminata da questa Corte. 7. In conclusione, il ricorso principale di (omissis) va dichiarato inammissibile, il ricorso principale di S.G. ed il ricorso incidentale vanno rigettati. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale di (omissis) e rigetta il ricorso principale di S.G. ed il ricorso incidentale. Compensa tra tutte le parti le spese processuali. In virtù del principio della vicinanza della prova, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione, l’onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l’uno o per l’altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione Dunque, la questione giuridica in tema di responsabilità non è mai legata in astratto alla posizione di creditore o debitore di ciascuna delle parti, ma alle singole concrete fattispecie oggetto del contendere e non può essere risolta, 206 quindi, affermando in maniera generalissima e genericissima che "nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, l’attore dovrà quindi soltanto provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onere dei convenuti dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa a loro non imputabile» (Cass. Sez. Unite, 27 giugno 2002, n. 9346)". Non bisogna prendere in considerazione tanto la posizione giuridica astrattamente ipotizzabile, quanto la possibilità concreta per ciascuna delle parti di dimostrare la veridicità della proprie affermazioni. Tale sentenza viene segnalata, essenzialmente, al fine di far conoscere orientamenti giurisprudenziali recenti. Sentenza n. 1478/06 Repubblica Italiana TRIBUNALE DI CATANIA Quinta Sezione Civile In nome del Popolo Italiano Il giudice Felice Lima ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6205/02 R.G., promossa da *** ***, dom. in Catania, via F. Crispi n. 177, presso lo studio dell’avv. Giovanni C. Lisi, rappr. e dif. dall’avv. Orietta Gramillano, per mandato a margine dell’atto introduttivo del giudizio; - Attore contro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nella persona del Ministro in carica, dom. in Catania, via Vecchia Ognina n. 149, presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che lo rappr. e dif. per legge; Convenuto e contro *** *** Assicurazioni s.p.a., con sede in **, dom. in Catania, via F. Pensavalle n. 20, presso lo studio dell’avv. Sebastiano Sapuppo, che la rappr. e dif. per mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione;----------------------------------------------------------------------- Convenuta posta in decisione all’esito dell’udienza del 23 gennaio 2006, sulle conclusioni precisate come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 17.6.2002, *** *** conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Ministero della Pubblica Istruzione, oggi Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.------------------------------------------------------------------------Esponeva il suo procuratore:-------------------------------------------- 207 «- che *** ***, nell’anno scolastico 1998/1999 ha frequentato la classe 3° Sez. G della Scuola Media Statale “G.***ni”;----------------------------------------------------- che, il giorno 15.5.1999 durante l’ora di educazione fisica, mentre l’alunno *** eseguiva un esercizio di salto in alto, si infortunava sbattendo il ginocchio destro sui denti; - che, la prof.ssa *** avvertiva telefonicamente la sig.ra ***, per l’incidente occorso al figlio; - che la sig.ra *** precipitatasi a scuola trovava il figlio *** sanguinante nell’arcata dentaria superiore;---------------------------------------------------------------------- che la stessa madre trasportava il figlio d’urgenza presso l’Ospedale di ***, dove i sanitari di turno lo medicavano e lo sottoponevano a radiografie, indi diagnosticavano contusione arcata mentoniera superiore;-------------------------------------------------------- che in seguito all’incidente e per la contusione riportata *** *** ha subito una menomazione dentaria, che ha compromesso la funzione masticatoria e pertanto si dovrà sottopone a un trattamento ortodontecnico fisso della durata di due anni, subendo un’inabilità temporanea assoluta della funzione masticatoria di giorni 30, e un’inabilità temporanea di giorni 20, ed è residuata un incapacità permanente della funzione masticatoria del 2% rispetto alla totale;---- che il trattamento ortodontecnico dovrebbe avere un costo di € 6.713,94 come da preventivo che si allega, redatto dal dott. Salvatore ***;---------------------------------- che il danno subito ammonta complessivamente a € 9.999,02 così distinto € 1.322,54 per danno da R.C. € 413,17 per danno biologico € 1.162,03 per I.T.A. ed € 387,34 per I.T.R. ed € 6.713,94 per spese;--------------------------------------------------------------------------- che sebbene messi in mora con racc. A.R. sia la Scuola Media Statale ***ni che la *** Assicurazioni, non hanno inteso risarcire il danno;---------------------- che, iniziato il giudizio di risarcimento danni presso il Tribunale di Siracusa Sez. distaccata di ***, il giudice del predetto Tribunale con sentenza n. 5/02 del 12.4.2002 ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, trattandosi di fattispecie demandata alla competenza Territoriale dell’on.le Tribunale di Catania».--------------------------------------------------------Sulla base di tali assunti, chiedeva al Tribunale di «condannare la scuola al pagamento in favore di *** ***, della complessiva somma di € 9.999,02 così specificata € 1.322,54 per danno da R.C. € 413,17 per danno biologico, € 1.162,03 per I.T.A. ed € 387,34 per I.T.R. ed € 6.713,94 per spese, in considerazione che dalla lesioni riportate sono residuati anche postumi invalidanti di carattere permanente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell’incidente al soddisfo». Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio, esponendo: «1) Infondatezza nel merito della domanda di parte attrice.------Nell’affermare la culpa in vigilando dell’Amministrazione odierna convenuta la parte attrice opera un chiaro, seppur implicito, riferimento all’art. 2048 c.c. il quale – com’è noto a questa difesa – pone la presunzione di responsabilità in capo a “precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte” per il “danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.----------------------------------------------------------------------- 208 E’ appena il caso di rilevare, tuttavia, che “in tema di responsabilità civile ex art. 2048 c.c., il dovere di vigilanza dell’insegnante va commisurato all’età e al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto” (per tutte, Cass. civ., sez. III, 10 dicembre 1998, n. 12424).----------------------------------------------------------------------Ovviamente, nel caso che qui ci occupa, l’età della studente (15 anni al tempo dell’incidente) è indice di un grado di maturazione fisio-psichica che attenua in misura rilevantissima il contenuto dell’obbligo di vigilanza dell’insegnante.---------------------------------Le circostanze concrete, del resto, contribuiscono ad escludere la responsabilità dell’Istituto odierno comparente, considerando che, in sede di allenamento ginnico, il rischio di un sinistro della specie di quello per cui oggi è controversia rientra – per dir così – nell’ordine delle cose.-----Vanno peraltro evidenziati due ulteriori elementi di fatto.---------In primo luogo, come asserito nell’atto di citazione da controparte, il danno subito dal minore nell’infortunio di che trattasi è stato provocato da un suo errore nella esecuzione dell’esercizio ginnico. Giova rammentare – relativamente a una fattispecie concreta pressoché identica – che secondo la giurisprudenza “dell’infortunio di un alunno, incespicato durante una partita di calcetto su asfalto, non sono responsabili né il preside che ha autorizzato lo svolgimento del torneo scolastico, né l’insegnante di educazione fisica che lo ha diretto come organizzatore e arbitro” (Trib. Latina, 17 marzo 1994). Il principio desumibile da tale pronuncia – conforme per la verità alla comune logica oltre che al diritto – è chiarissimo: non è possibile imputare ai soggetti tenuti alla vigilanza del minore i pregiudizi che esso minore, nell’ambito della propria libertà di autodeterminazione (man mano crescente con l’approssimarsi alla maggiore età, come si è detto), procuri a sé stesso. In secondo luogo, d’altronde, dei 600 (seicento!) alunni iscritti all’istituto, solo l’alunno *** è incorso in un sinistro di tal genere durante l’espletamento della lezione di educazione fisica: il che, si converrà, appare indice sicuro della attribuibilità del sinistro medesimo a un caso fortuito. Peraltro, nella non temuta ipotesi in cui le superiori argomentazioni non dovessero convincere codesto giudice, si segnala che l’onere economico derivante dalla (si ripete, non temuta) condanna al risarcimento dell’amministrazione odierna comparente graverebbe comunque sull’istituto assicuratore chiamato in garanzia».-------------------------------------------------------Sulla base di tali assunti, chiedeva al Tribunale di:-----------------«a) preliminarmente disporre lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la chiamata in causa della *** Assicurazioni;-------------------------------b) rigettare le domande dell’attore ».--------------------------------Si costituiva anche la *** *** Assicurazioni s.p.a., deducendo:-«Costituendosi nel presente giudizio, la *** *** Assicurazioni s.p.a. contesta le domande, formulate» da parte attrice «nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione – Scuola Media Statale G. ***ni, perché infondate in fatto e in diritto, chiedendone pertanto il totale rigetto. Si fanno proprie tutte le deduzioni ed eccezioni formulate dai Ministero della Pubblica Istruzione nella comparsa di costituzione e risposta, anche in relazione applicabilità dell’art. 2048 c.c. nella fattispecie che ci occupa.-------------------------------------------------------------------------- 209 La Suprema Corte di Cassazione, ha escluso ogni responsabilità dei precettori e maestri se gli stessi provino di non avere potuto impedire il fatto in quanto non prevedibile e pertanto non prevenibile. Tutto ciò depone per una totale assenza di responsabilità a carico dell’amministrazione scolastica. I fatti, in conseguenza dei quali l’allievo *** assume di essersi infortunato appaiono, se provati, frutto di un suo errore durante l’esecuzione di un esercizio ginnico.----------In subordine e per completezza di difesa si contesta il quantum richiesto in quanto irreale, non provato e in ogni caso non dovuto.------------------------------------------A tal fine si rileva che la polizza n. 168/17638 che viene allegata in atti, prevede un rimborso spese odontotecniche di £ 1.000.000 a dente con un invalidanti accertati [la frase, incomprensibile, è così nella comparsa di risposta], sarà risarcibile tenendo conto di una franchigia del 3%».------Sulla base di tali assunti, chiedeva al Tribunale di «rigettare le domande attrici siccome assolutamente infondate in fatto e in diritto. In ogni caso statuire che eventuali esborsi a carico della *** *** Assicurazioni s.p.a. in virtù della polizza stipulata dovranno essere ricondotti entro i massimali previsti e sottoscritti con applicazione delle relative franchigie». Il procuratore dell’attore chiedeva ammettersi due interrogatori formali. Il giudice istruttore, con ordinanza del 27.8/2.9.2004, rigettava la richiesta, inammissibile in relazione al fatto che l’interrogatorio formale può essere richiesto solo con riferimento alle parti del giudizio e, invece, le persone che parte attrice voleva far interrogare non sono parti del giudizio. Acquisiti i documenti offerti in produzione e precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.----------------------------------------------------------------------MOTIVI DELLA DECISIONE 1 ________ Il fatto oggetto del contendere è stato descritto nell’atto di citazione testualmente come segue: «Il giorno 15.5.1999 durante l’ora di educazione fisica, mentre l’alunno *** eseguiva un esercizio di salto in alto, si infortunava sbattendo il ginocchio destro sui denti».---------Il procuratore dell’attore ha prodotto copia di una lettera del 17.5.1999, inviata alla *** Assicurazioni, a firma del Preside della scuola “G. ***ni”, ove è avvenuto l’incidente controverso. In quella lettera il fatto è narrato come segue: «L’alunno *** *** … giorno 15.5.1999 alle ore 11.10, durante l’ora di educazione fisica eseguendo il salto in alto si infortunava sbattendo il ginocchio destro sui denti».-------------------------------------------------------------Tale fatto, così come descritto da parte attrice, non è stato contestato dalle parti convenute. 2 ________ In diritto, il procuratore dell’attore, con la comparsa conclusionale, invoca in favore del proprio assistito le statuizioni contenute in Cass. Sezioni Unite, 27 giugno 2002, n. 9346, e sostiene che: «L’attore ha provato ed è stato anche confermato da controparte, con i documenti prodotti, che il danno alla persona di *** *** si è verificato durante lo svolgimento della lezione di educazione fisica, nell’ambito del quale la prof.ssa di ed. fisica e per essa la scuola doveva dimostrare che l’evento dannoso e il sinistro è stato determinato da una causa a loro non imputabile, in quanto l’obbligazione gravante sull’insegnante dipendente della scuola pubblica deriva da un “contatto 210 sociale” con l’alunno, con il conseguente nascere in quest’ultimo di un affidamento, nella corretta esecuzione della prestazione professionale.---------------------------------------------------Da qui scaturiscono obbligazioni, a carico dell’insegnante e della scuola che sorgono per rapporti contrattuali di fatto ossia per il fatto stesso che l’insegnante entri in contatto con l’alunno, derivano in capo all’insegnante obblighi di comportamento, volti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o esposti al pericolo in occasione del contatto stesso. L’insegnante ha un obbligo di protezione nei confronti dell’alunno, in grado di produrre in caso di danno, a responsabilità contrattuale come conseguenza di violazione di obblighi.------------------------------------Sulla scuola e sull’insegnate, grava una responsabilità di natura oggettiva, identica a quella prevista dall’art. 1218 c.c. La scuola e l’insegnante, per liberasi da tale responsabilità dovevano dare prova ex art. 1218 c.c., dell’impossibilità oggettiva della prestazione, derivante da una causa a loro imputabile, come il caso fortuito. Tale prova da parte del Ministero non è stata data, anziché dare la prova hanno preferito opporsi all’ammissione dei mezzi istruttori sviando la loro responsabilità, sull’art. 2048 c.c.».-----------------------------------------------------------Si tratta di una ricostruzione confusa (probabilmente anche a causa di scelte sintattiche che rendono in parte oscuro il pensiero dell’espo-nente) e, nella sostanza, errata dei principi di diritto indicati dalla Corte Suprema.------------------------------------------------3 ________ E’ anche vero che la sinteticità della motivazione utilizzata dalle Sezioni Unite per illustrare, nella sentenza sopra citata, l’obiter dictum relativo al tema dell’onere della prova, ha indotto più d’uno a trarne conclusioni affrettate e certamente non condivisibili (non è un caso che su questa parte della sentenza si siano concentrate alcune osservazioni critiche della dottrina). Infatti, con il dovuto rispetto per le Sezioni Unite della Corte Suprema, l’affermazione contenuta nella motivazione della citata sentenza n. 9346 del 27 giugno 2002, secondo la quale «circa l’onere probatorio, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, l’attore dovrà quindi soltanto provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onere dei convenuti dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa a loro non imputabile», va ritenuta, nella sua genericità, in una certa misura approssimativa (e ciò può spiegarsi con il fatto, al quale si è già fatto cenno, che la questione non era ri*** per il caso che la sentenza decideva e vi era inserita come un semplice obiter dictum).-------------------------------------------------------------------------Si impongono, dunque, alcune precisazioni.-------------------------Analisi più approfondite del tema si trovano nelle motivazioni di diverse sentenze della Corte di Cassazione che se ne sono occupate in maniera diretta e non incidentale. Fra tutte, si può citare qui (perché è fra le più recenti e richiama le precedenti) Cass. Sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297, relativa a una ipotesi di responsabilità medica (ma la problematica è identica a quella qui in discussione: la ricostruzione dei diversi profili della responsabilità c.d. da contatto sociale). Ha statuito, fra l’altro, quella sentenza che «in tema di onere della prova nelle controversie di responsabilità professionale, questa Corte ha più volte enunciato il principio secondo cui quando l’intervento da cui è derivato il danno non è di difficile 211 esecuzione, la dimostrazione da parte del paziente dell’aggravamento della sua situazione patologica o l’insorgenza di nuove patologie è idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all’inadeguata o negligente prestazione, spettando all’obbligato fornire la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. 21 dicembre 1978, n. 6141; Cass. 16 novembre 1988, n. 6220; 11 marzo 2002, n. 3492). Più specificamente, l’onere della prova è stato ripartito tra le parti nel senso che spetta al medico provare che il caso è di particolare difficoltà e al paziente quali siano state le modalità di esecuzione inidonee ovvero a questi spetta provare che l’intervento è di facile esecuzione e al medico che l’insuccesso non sia dipeso da suo difetto di diligenza (Cass. 19 maggio 1999, n. 4852; Cass. 4 febbraio 1998, n. 1127; Cass. 30 maggio 1996, n. 5005; Cass. 16 febbraio 2001, n. 2335; 16 novembre 1988, n. 6220; altre). I risultati sopra riassunti ai quali è pervenuta la giurisprudenza di legittimità vanno oggi riletti alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell’inadempimento e dell’inesatto adempimento. Le Sezioni Unite, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici, hanno enunciato il principio – condiviso dal Collegio – secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo, costituito dall’avvenuto adempimento. Analogo principio è stato enunciato con riguardo all’inesatto adempimento, rilevando che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adem-pimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento. Applicando questo principio all’onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico deve affermarsi che il paziente che agisce in giudizio deducendo l’inesatto adempimento dell’obbligazione sanitaria deve provare il contratto e allegare l’inadempimento del sanitario restando a carico del debitore l’onere di provare l’esatto adempimento. (…) Porre a carico del sanitario o dell’ente ospedaliero la prova dell’esatto adempimento della prestazione medica soddisfa in pieno a quella linea evolutiva della giurisprudenza in tema di onere della prova che va accentuando il principio della vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell’effettiva possibilità per l’una o per l’altra parte di offrirla. Infatti, nell’obbligazione di mezzi il mancato o inesatto risultato della prestazione non consiste nell’inadempimento, ma costituisce il danno consequenziale alla non diligente esecuzione della prestazione. In queste obbligazioni in cui l’oggetto è l’attività, l’inadempimento coincide con il difetto di diligenza nell’esecuzione della prestazione, cosicché non vi è dubbio che la prova sia «vicina» a chi ha eseguito la prestazione; tanto più che trattandosi di obbligazione professionale il difetto di diligenza consiste nell’inosservanza delle regole tecniche che governano il tipo di attività al quale il debitore è tenuto».------------------------------------------------------------------------Così ricostruito il percorso seguito dalla Corte Suprema per ricostruire gli istituti qui in discussione, va fatto un triplice ordine di considerazioni.------------------------------4 ________ 212 Sotto un primo profilo, l’art. 1218 c.c. dispone che «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile». Dunque, è vero che è il debitore ad avere l’onere di provare l’impossibilità della prestazione, ma tale onere graverà su di lui solo dopo che il creditore abbia provato che la prestazione dovutagli non è stata eseguita o non è stata eseguita esattamente.--------------------------In obbligazioni dallo schema contenutistico semplice – quelle, per esempio, che, con una classificazione che nel quadro ormai molto fitto di opportune distinzioni via via introdottevi appare, nella sua approssimativa semplicità, ormai obsoleta e forse inutile, vengono abitualmente indicate come “obbligazioni di risultato” – la ricostruzione dei rapporti fra le parti è altrettanto semplice. Se Tizio ha assunto l’obbligazione di fornire un certo quantitativo di una merce specificata, da consegnarsi in luogo e data certi, qualora la consegna non avvenga, il creditore dovrà provare soltanto che la merce non è arrivata e il debitore, in presenza di un inadempimento conclamato, per sottrarsi alle conseguenze di esso, dovrà provare che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.------------------------------------------------La situazione si fa più complicata quando il contenuto dell’obbli-gazione è complesso e non è facile stabilire se vi sia stato o no inadempimento.-----------------------Il che avviene frequentemente nei casi di obbligazioni professionali complesse (quelle che, nella classificazione alla quale si è fatto cenno sopra, vengono definite “obbligazioni di mezzi”). Se un paziente sottoposto a un delicato intervento chirurgico muore, non può per ciò solo affermarsi che il medico che lo operava è stato inadempiente, per l’ovvia ragione che l’obbligazione da lui assunta non era quella di sottrarre certamente e in ogni modo il paziente alla morte (che può verificarsi per mille cause anche del tutto estranee al controllo del medico operante e addirittura anche del tutto estranee alle patologie per le quali si interviene), ma quella di compiere l’operazione nel modo più competente e diligente, secondo i dettami delle regole della professione medica di quel tempo. Così come il fatto che un bambino o (come nel caso di specie) un ragazzo si facciano male a scuola non è fatto che da sé solo dimostra l’inadempimento, da parte degli insegnati e della scuola, dei loro obblighi, perché molte sono le situazioni – incolpevoli dal punto di vista degli obblighi qui in discussione – nelle quali in una scuola un fatto del genere può accadere. In casi come questo, il problema non è stabilire quali siano gli oneri probatori che incombono sul debitore inadempiente, ma accertare se egli sia inadempiente o no.-----Dunque, il riferimento all’art. 1218 c.c., contenuto in tutte le sentenze della Corte Suprema sopra citate (e anche in quelle a loro volta citate nelle sentenze sopra riportate) sembra, francamente, errato e frutto di una paralogismo solo suggestivo ma, come tutti i paralogismi, privo di reale fondamento. Non si può utilizzare la regola di cui all’art. 1218 c.c. per stabilire se il debitore sia o no inadempiente, perché quella norma disciplina solo i casi in cui è già certo che il debitore è inadempiente. 5 ________ La questione non riguarda l’art. 1218 c.c., ma – come intuito (senza trarne, purtroppo, le dovute conseguenze) da Cass. Sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297 213 (che non a caso ha indicato come chiave di soluzione del problema Cass. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533) – l’art. 2697 c.c.. Dunque, non è vero, ovviamente, – come, invece, sostenuto dal procuratore dell’odierno attore – che si versi in questi casi in una ipotesi di responsabilità oggettiva; ma non è vero, neppure, che nei casi fin qui discussi gravi, in diritto, sul medico, sull’insegnante, su chi, in genere, è tenuto a una complessa prestazione c.d. di mezzi, un onere di prova fondato sull’art. 1218 c.c..La citata (come si è visto anche esplicitamente da Cass. Sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297, che la pone a base della propria statuizione) Cass. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533, ha affermato il «principio di riferibilità o di vicinanza della prova. In virtù di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione, l’onere della prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l’uno o per l’altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione».---------------------------------------------------Dunque, la questione non è legata in astratto alla posizione di creditore o debitore di ciascuna delle parti (Cass. 13533/2001 ha proprio inteso superare una ricostruzione degli oneri probatori delle parti fondata rigidamente sulla loro posizione – di attore o convenuto – nel processo e su una interpretazione restrittivamente letterale dell’art. 2697 c.c.) ma alle singole concrete fattispecie oggetto del contendere e non può essere risolta, quindi, affermando in maniera generalissima e genericissima che «nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, l’attore dovrà quindi soltanto provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onere dei convenuti dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa a loro non imputabile» (Cass. Sez. Unite, 27 giugno 2002, n. 9346). Ciò che accadrà è che, in relazione alla concreta natura delle lesioni e alle concrete circostanze nelle quali esse sono state causate (così come, nei casi di responsabilità professionale dei medici, in relazione alla concreta natura delle patologie e delle circostanze oggetto del contendere) potrà – o, in relazione alla stessa concreta natura delle lesioni e delle circostanze, non potrà – ritenersi sussistente quella che Cass. Sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297, più volte citata, ha definito come «una presunzione semplice» in ordine all’inadeguata o negligente prestazione dell’insegnante (o del medico, o dell’altro debitore del quale si discuta).------------------------------------------------E sembra del tutto evidente che tale presunzione non potrà ritenersi sussistente in tutti i casi, ma solo in quelli nei quali la concreta vicenda oggetto del contendere la giustifichi. Dunque, se in una scuola materna un bimbo di tre anni verrà restituito ai genitori ferito e la maestra riferirà di non sapere come egli si sia procurato quelle ferite, si potrà e dovrà presumere – in mancanza di una prova del contrario – che la maestra medesima non abbia adempiuto correttamente la propria obbligazione di custodia del bimbo affidato alle sue cure.---------------Ma se, come nel caso di specie, un ragazzo di quindici anni e mezzo (questa è l’età che l’odierno attore aveva quando è accaduto l’incidente controverso) lamenta di essersi fatto male «sbattendo il ginocchio destro sui denti» mentre «eseguiva un esercizio di salto in alto», nessuna presunzione di responsabilità può ipotizzarsi a carico degli insegnanti e della scuola e l’azione di risarcimento dei 214 danni dovrà fondarsi su concrete allegazioni e su prove delle medesime offerte dalla parte attrice. E ciò per un duplice ordine di considerazioni.-----------------------6 ________ Per un verso, infatti, con riferimento alla posizione soggettiva del danneggiato, nessuna particolare difficoltà vi era – a fronte della sua piena capacità, in relazione alla sua età, di percepire e riferire l’accaduto – per l’odierno attore di individuare e allegare in maniera specifica l’inadempimento che concretamente intendeva addebitare agli insegnanti e alla scuola.------Nessun problema di «riferibilità o di vicinanza della prova» si poneva per l’odierno attore e si pone in tutti i casi come quello oggetto di questo giudizio.--------------Il ***, dunque, aveva l’onere – rimasto del tutto inadempiuto – di allegare le ragioni per le quali il fatto che egli abbia sbattuto il ginocchio destro sui denti sia da ascrivere a responsabilità dell’insegnante di educazione fisica e/o della scuola.--------------------------------------Per altro verso, con riferimento all’oggettività del fatto, ritornando, per sola comodità espositiva, alla classificazione delle obbligazioni come “di mezzi” o “di risultato”, non può certamente sostenersi che l’obbligazione dell’insegnante di educazione fisica sia quella di impedire in assoluto qualsiasi tipo di danno che i suoi alunni possano patire, essendo, invece, la sua obbligazione quella di svolgere la lezione e di fare eseguire gli esercizi ginnici in maniera corretta e adeguata.----Ed è fisiologicamente connesso all’esercizio di attività motorie che, facendole, si possa accidentalmente cadere e farsi male, senza che ciò necessariamente significhi che l’insegnante abbia posto in essere azioni o omissioni sotto un qualche profilo censurabili.Il fatto oggetto dell’odierno contendere, così come narrato nell’atto di citazione, appare essere una normale conseguenza dell’esercizio di un’attività ginnica: un allievo compie un salto in alto e, cadendo male, sbatte il ginocchio destro sui denti.-----------------------------------Non avendo l’odierno attore non solo provato, ma addirittura neppure allegato, che ciò sia avvenuto per una qualche ragione attribuibile a responsabilità dell’insegnante (come, per esempio, avere fatto eseguire agli allievi esercizi superiori alle loro capacità o da svolgersi con attrezzature e/o modalità inadeguate, ecc.), deve ritenersi che l’incidente in questione sia frutto di una inevitabile casualità (un piede messo male, la flessione non governata come si deve, ecc.) e che l’unico modo che vi sarebbe stato di evitarlo era non fare eseguire al *** esercizi ginnici nell’ora dedicata all’educazione fisica. Il che, ovviamente, è del tutto illogico.----------------------------------------------Cadere, sbattere il ginocchio sui denti è cosa che può accadere e con una certa “normalità” accade quando si fa ginnastica e, ancor più quando si fanno salti in alto, anche se li si fa sotto la più diligente vigilanza, e, dunque, il solo “essersi fatto male”, senz’alcuna altra precisazione, non può essere considerato indizio e men che meno prova di responsabilità di taluno nella causazione di quel fatto. Sul punto, ha correttamente statuito il Tribunale di Milano che «ai fini della responsabilità dell’insegnante per fatto illecito occorso ad un alunno di scuola elementare, la presunzione di responsabilità per “culpa in vigilando” non può estendersi sino a ritenere sussistente la responsabilità stessa per il fatto solo che sia stato autorizzato lo svolgimento di giochi aerobici e dinamici» (Tribunale Milano, 27 aprile 2001, in Gius 2001, 2784).------------------------------Le domande proposte da *** *** vanno, quindi, rigettate.----------215 7 ________ Le spese processuali, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza. Il 2° comma dell’art. 92 c.p.c., nel testo riformato dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263, consente la compensazione delle spese solo in alcuni casi specifici o per la concorrenza di giusti motivi da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza. Nel caso di specie, nessun motivo sussiste né è stato addotto dalla parte soccombente per legittimare una compensazione delle spese. I procuratori dei convenuti hanno omesso di produrre le prescritte note.-In mancanza di esse, tenendo conto della natura e del valore della controversia e dell’attività difensiva effettivamente svolta, le spese del giudizio vanno liquidate, in favore del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in complessivi € 2.300,00, di cui € 1.000,00 per diritti ed € 1.300,00 per onorari di avvocato, e in favore della *** *** Assicurazioni in complessivi € 2.800,00, di cui € 1.200,00 per diritti ed € 1.600,00 per onorari di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. P. Q. M. Il giudice rigetta le domande proposte da *** *** e lo condanna al rimborso, in favore dei convenuti, delle spese del giudizio, come sopra liquidate in complessivi € 2.300,00 (duemilatrecento/00) in favore del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e in complessivi € 2.800,00 (duemilaottocento/00) in favore della *** *** Assicurazioni s.p.a., oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.------------------------------------------------------------------------------------Deciso in Catania, il 29 aprile 2006. Il Giudice Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2006. Il Direttore di Cancelleria INCIDENTE STRADALE E CINTURE DI SICUREZZA TRACCIA: Tizio è zio del diciottenne Carmelo. Tizio proponeva a Carmelo di uscire a fare un giro con la nuova mercedes classe C. Tizio, saliva in auto indossando la cintura di sicurezza, diversamente da Carmelo; Tizio suggeriva a Carmelo di indossare la cintura di sicurezza, ma quest’ultimo si rifiutava ed il primo non insisteva. Accadeva che Tizio iniziasse a percorrere una strada provinciale; Carmelo sentiva squillare il telefono e lo cercava nella tasca, urtando il braccio di Tizio, che perdeva il controllo dell’autovettura; la mercedes urtava contro un albero. Tizio non riportava ferite per merito della cintura di sicurezza, mentre Carmelo sbatteva il viso contro il vetro, riportando tagli profondi. Carmelo veniva ricoverato in ospedale, da dove usciva con cicatrici sul viso. Carmelo si recava dall’avv. Buonavolontà. 216 Il candidato, assunte le vesti di Buonavolontà, rediga motivato parere favorevole a Carmelo. POSSIBILE SOLUZIONE SCHEMATICA: In premessa poteva essere utile ricostruire sinteticamente il fatto. Successivamente era necessario inquadrare la fattispecie nell’ambito della responsabilità, tendenzialmente, extracontrattuale. Tizio è responsabile per i danni subiti da Carmelo? Bisognerebbe optare per la tesi positiva, in quanto Tizio, verosimilmente, andava ad una velocità eccessiva in rapporto alla strada, visto che è stato sufficiente urtare il braccio di Tizio per fargli perdere addirittura il controllo dell’auto ed finire contro un albero; in altri termini, dalla dinamica del fatto sembrerebbe potersi desumere che Tizio andava ad una velocità eccessiva rispetto alla strada provinciale (diversamente Carmelo non avrebbe riportato tagli profondi sul viso). Altresì, Tizio avrebbe dovuto insistere maggiormente per far indossare la cintura al giovane Carmelo e, in caso di diniego, rifiutarsi di portarlo in giro (si ricorda che il parere richiedeva di redigere parere favorevole a Carmelo). Al più, se proprio si volesse insistere sul problema relativo al fatto che Carmelo aveva urtato il braccio di Tizio, potrà trovare applicazione l’art. 1227 c.c. Si consiglia di leggere la sentenza che segue. -Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di renitenza, anche rifiutarne il trasportato o sospendere la marcia. Corte di cassazione Sezione III civile Sentenza 11 marzo 2004, n. 4993 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 10 luglio 1993 i coniugi L.E. e C.G. in proprio e, quanto al primo, nella qualità di tutore della figlia L. C., convenivano davanti al Tribunale di Ragusa la Milano Assicurazioni e P.G. per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, morale e biologico, subito a seguito delle lesioni gravissime, con coma irreversibile e con invalidità permanente nella misura del 100%, riportata da C. L., all'epoca di anni 27, nell'incidente stradale occorsole il 10 aprile 1992, nel mentre viaggiava come trasportata dall'auto del P. (assicurata con la Milano Assicurazione per la r.c.), che usciva di strada ed andava a cozzare contro un muro. Si costituivano i convenuti che resistevano alla domanda. 217 Il Tribunale di Ragusa, con sentenza depositata il 16 febbraio 1996, riconosciuto un concorso di colpa nella misura del 5% a carico della L., per il mancato uso della cintura di sicurezza, condannava P. al pagamento nei confronti degli attori della complessiva somma di lire 3.158.771.800, oltre rivalutazione ed interessi, nonché la Milano, in solido con il P., fino al limite del massimale di lire 1.500.000.000, oltre rivalutazione ed interessi sulla detta somma. Avverso questa sentenza proponevano appello la Milano ed il P.. Proponevano appello incidentali gli attori. La Corte di appello di Catania, con sentenza depositata il 10 maggio 2000, ritenuto il concorso di colpa della L. nella misura del 30% per il mancato uso della cintura di sicurezza, condannava il P. al pagamento, in favore di L.E., nella qualità, della somma complessiva di lire 2.135.908.022, oltre interessi legali sulle somme devalutate alla data dell'incidente ed annualmente rivalutate, fino al passaggio in giudicato della decisione, e detratti gli acconti. Condannava il P. a corrispondere a L.E. la somma di lire 353.663.000 e C.G. la somma di lire 343.163.000 oltre interessi. Condannava la Milano al pagamento, in solido con il P., della somma di lire 1.500.000.000, maggiorata di rivalutazione ed interessi. Riteneva la Corte di merito che a norma dell'art. 172 c.d.s. del 1992, il passeggero trasportato aveva l'obbligo di allacciare la cintura di sicurezza durante la marcia; che a tanto non aveva provveduto la L., che era stato sbalzata fuori dell'auto per alcuni metri andando ad urtare con il capo sull'asfalto; che tale circostanza aveva concorso nella produzione delle gravissime lesioni, con coma irreversibile, nella misura del 50%, come accertato dal c.t.u. ingegnere; che il mancato uso della cintura andava ascritto per il 30% alla trasportata e per il residuo 20% al conducente, che doveva imporre alla L. l'uso della cintura; che, per l'effetto, a carico del P. andava affermata la responsabilità del 50% per colpa nella guida e per il 20% per non aver fatto adottare la cintura alla trasportata. Pertanto la Corte di appello liquidava, con riferimento alla data della decisione, tenuto conto del concorso di colpa nella misura del 30% della trasportata, il danno biologico, subito da L. C., nella misura di lire 741.201.828; il danno patrimoniale in lire 281.356.194; il danno morale in lire 378.350.000. Quanto all'assistenza infermieristica e fisioterapica, riteneva la Corte di liquidare il danno in lire 735 milioni. Ai coniugi L. venivano liquidate lire 476.000.000 per danni patrimoniali e per ciascuno dei genitori lire 105 milioni per danni morali, oltre lire 10.500.000 a L.E. per la perdita di redditi, per accudire la figlia. Rigettava la domanda dei genitori di risarcimento del proprio danno biologico, perché non provato. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il P.G.. 218 Resistono con controricorso gli attori, che hanno anche proposto ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, a norma dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 172 c.d.s. d.lgs. 28 maggio 1992 e degli artt. 1227, 2055 o 2056 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.; errore logico giuridico della motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Con l'articolato motivo ritiene il ricorrente che, pur avendo il giudice di appello disposto consulenza medico legale e consulenza tecnica in ordine al mancato uso delle cinture di sicurezza ed alle conseguenze di tale omissione e, nonostante che il c.t.u. avesse individuato detto concorso di colpa della L., che fu sbalzata fuori dall'abitacolo per circa 20 metri, nella misura del 50%, aveva erratamente poi ridotto detto concorso di colpa nella misura del 30%, sul rilievo che anche il P. era in colpa per non aver imposto alla passeggera di applicare la cintura. Ritiene il ricorrente che, a norma dell'art. 172 c.d.s., i passeggeri hanno l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia, con conseguente sanzione amministrativa a loro carico, in caso di inadempienza, e che solo in caso di trasportato minore risponde il conducente di detto mancato uso delle cinture. Ciò comporta che, poiché del mancato uso della cintura doveva rispondere solo la L., avendo il c.t.u. ritenuto che detta mancanza avesse contribuito nella misura del 50%, alla produzione del sinistro, detto concorso di colpa non poteva essere ridotto al 30%. Secondo il ricorrente ciò comporta anche una violazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., sulla base del quale il danneggiato non può ottenere il risarcimento del danno, per la parte di cui è stato causa. Inoltre il ricorrente lamenta il vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, in quanto, date le circostanze di tempo (era di notte e vi era un temporale), egli non poteva accertarsi che la L. indossasse costantemente le cinture. Inoltre, secondo il ricorrente, tenuto conto delle modalità dell'incidente, se la L. avesse indossato la cintura, non sarebbe stata sbalzata fuori dall'auto, con la conseguenza che non avrebbe avuto le gravi lesioni sofferte, per lo sbalzo fuori dalla vettura e l'urto con il capo sull'asfalto, come non le aveva avute il conducente, che indossava la cintura e che uscì indenne dall'auto. 2.1. Ritiene questa Corte che il motivo è infondato e che lo stesso va rigettato. 219 Quanto alla prima censura va preliminarmente rilevato che, contrariamente all'assunto delle parti e della stessa sentenza, nella fattispecie non trova applicazione l'art. 172 c.d.s. d.lgs. 30 aprile 1992. Infatti, a parte il rilievo che l'incidente si era verificato il 10 aprile 1992, in ogni caso il nuovo c.d.s. è entrato in vigore solo il 1° gennaio 1992 (v. art. 240 d.lgs. 285/92). Tuttavia, pur emendata la sentenza impugnata sotto questo profilo dell'errata indicazione della norma, la questione giudicata non muta, in quanto le cinture di sicurezza erano state rese obbligatorie, per i soggetti che si trovavano sui sedili anteriori dell'auto, per effetto della l. 111/1988 e degli artt. 1, 2 e 3, l. 143/1999, che, in buona sostanza, prevedevano una normativa in proposito pressoché simile a quella dell'attuale art. 172 c.d.s., anche sotto il profilo dell'aspetto sanzionatorio. Per cui alla data del sinistro, sulla base della l. 143/1999 vi era l'obbligo anche da parte del trasportato sul sedile anteriore dell'auto di indossare la cintura di sicurezza ed il mancato uso delle stesse esponeva il trasportato trasgressore alla sanzione amministrativa (in modo analogo a quanto poi previsto dall'art. 172 c.d.s.). 2.2. Orbene sotto il profilo dell'illecito amministrativo non vi è dubbio che il destinatario della norma, che impone l'obbligo della cintura, sia il soggetto che detta cintura deve indossare, e quindi, in caso di soggetto trasportato (salvo che sia minore), destinatario del dovere sia lo stesso trasportato, che - ove non adempia - è l'unico esposto alla sanzione. Ne consegue che l'omesso uso delle cinture di sicurezza, da parte di persona che abbia subito lesioni in conseguenza di un sinistro stradale, costituisce un comportamento colposo del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell'art. 1127, comma 1, c.c., e legittima la riduzione del risarcimento, ove si alleghi e dimostri che il corretto uso dei sistemi di ritenzione avrebbe ridotto od addirittura eliso il danno. 2.3. Il problema, che si pone nella fattispecie ad oggetto del motivo di ricorso, è se, una volta accertata l'incidenza causale nell'evento del mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del trasportato, un'incidenza causale possa essere ascritta, oltre ovviamente che al trasportato (in quanto trasgressore della norma di circolazione stradale, che impone l'uso delle cinture), anche al comportamento del conducente, come ha ritenuto la sentenza impugnata. 2.4. Ritiene questa Corte di dovere dare risposta positiva al quesito. Infatti qui non si pone un problema di responsabilità per illecito amministrativo, che va regolato esclusivamente nei termini in cui la norma tipizza l'illecito stesso (e nella fattispecie del trasportato, che trasgredisce l'obbligo di indossare la cintura, la norma ritiene questi esclusivo responsabile dell'illecito), ma un problema di responsabilità aquiliana. 220 Nell'ambito della tale ultima responsabilità rilevano tutti i comportamenti, commissivi o omissivi, che abbiano contribuito eziologicamente alla produzione dell'evento dannoso, purché siano connotati da dolo o colpa. Ai fini dell'elemento soggettivo della colpa rileva non solo la colpa specifica (cioè la violazione di specifiche leggi o regolamenti), ma anche quella generica, costituita dalla mancanza di diligenza, prudenza o perizia. 2.5. In questi termini di prudenza e diligenza (quale emerge anche dall'art. 1176 c.c.) il conducente di un autoveicolo non può porre o tenere in circolazione lo stesso, se si è reso conto che qualcuno dei trasportati non si conforma alle regole stabilite dalla normativa sulla circolazione stradale. Infatti, è vero che egli può non essere il destinatario della norma (come nella fattispecie dell'obbligo per il trasportato di indossare la cintura), ma egli rimane pur sempre colui che rende possibile la "circolazione" del veicolo con a bordo il trasportato, e quindi, sotto un profilo di normale diligenza, ha l'obbligo di fare effettuare detta circolazione in sicurezza e nel rispetto delle norme. 2.6. In termini generali già questa Corte ha rilevo (per quanto in fattispecie diverse) che il conducente, in quanto responsabile dei danni prodotti dalla circolazione del veicolo, concorre con il trasportato, nella responsabilità dei danni da quest'ultimo causati a terzi (cfr. Cassazione 6445/1987; 8216/2002). L'ottica del concorso eziologico di cause rimane identica - salvo ovviamente con tale concorso è disciplinato dall'art. 1227, comma 1, c.p.c. - nel caso in cui il trasportato, con il suo comportamento, cagioni danni a sé stesso. Quindi, qualora la messa in circolazione dell'autoveicolo, in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione del veicolo, senza che il trasportato abbia "allacciato le cinture di sicurezza"), sia ricollegabile all'azione od omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell'evento). In tale situazione, a parte l'eventuale responsabilità verso i terzi, secondo la disciplina dell'art. 2054 c.c., deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale dell'art. 2043, 2056, 1227 c.c., anche il pregiudizio all'integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell'incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell'ambito dell'indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili (cfr. Cassazione 1816/1982). 2.7. Va, pertanto, condiviso, anche in tema di responsabilità aquilana, l'orientamento espresso in sede penale da questa Corte (Cassazione penale, Sezione quarta, 9904/1996), secondo cui il conducente di un veicolo è tenuto, in 221 base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di renitenza, anche rifiutarne il trasportato o sospendere la marcia; ciò a prescindere dall'obbligo a carico di chi deve far uso della detta censura. 2.8. Ne consegue che, avendo la Corte di merito ritenuto sulla base della disposta consulenza tecnica d'ufficio che eziologicamente il danno subito dalla L. era da ascriversi per il 50% al mancato uso della cintura di sicurezza, in applicazione del suddetto principio di diritto ha poi correttamente ritenuto, che parte di questo 50% (e precisamente un 20%) andava ascritto ancora a carico del conducente P. (già responsabile del restante 50% a titolo di mancanza di diligenza e prudenza nella guida), per non aver imposto alla sua passeggera l'uso della cintura ovvero sospeso la marcia in caso di rifiuto. 3.1. Non ravvisa questa Corte, nella suddetta decisione, la lamentata violazione dell'art. 1227, comma 1, c.c. Infatti il primo comma dell'art. 1227 c.c. concerne il concorso colposo del danneggiato nella produzione dell'evento che configura l'inadempimento, quindi la sua cooperazione attiva, mentre nel secondo comma il danno è eziologicamente imputabile al danneggiante, ma le conseguenze dannose dello stesso avrebbero potuto essere impedite o attenuate da un comportamento diligente del danneggiato. Consegue che in tema di risarcimento del danno mentre il concorso di colpa del creditore, previsto dal comma 1 dell'art. 1227 c.c. può essere rilevato anche d'ufficio, nella diversa ipotesi dell'esimente contemplata dal 2° comma della stessa norma, il giudice è tenuto a svolgere l'indagine in ordine all'omesso uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore, soltanto se vi sia stata un'espressa istanza del debitore, in quanto in questo secondo caso la dedotta colpa del creditore costituisce inosservanza di un autonomo dovere giuridico posto dalla legge a suo carico e la richiesta del debitore integra gli estremi di una eccezione in senso sostanziale con cui viene fatto valere un contraddittorio per paralizzare l'azione del creditore (Cassazione 3408/1986). 2.3. Ne consegue che, avendo la Corte di merito ritenuto che la mancata adozione della cintura di sicurezza aveva un'efficienza causale nella produzione dell'evento dannoso subito dalla L. del 50% e che detto comportamento era da ascriversi nella misura del 30% alla L. e del residuo 20% al conducente (cui già era stato posto a carico il 50% della responsabilità, per comportamento colposo nella guida), correttamente ha ritenuto che il concorso di colpa della danneggiata andava ridotto nella misura del 30%. 4.1. Quanto alla censura di assunto vizio motivazionale della sentenza nella determinazione del concorso di colpa della danneggiata nella misura del 30%, ritiene questa Corte che il motivo sia infondato. Infatti, la sentenza impugnata, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, ha ritenuto che il mancato uso della cintura avesse influito solo nella misura del 50% nella produzione del danno alla L., mentre ha ritenuto che la responsabilità per tale omissione andasse ascritta al P. per il residuo 20%. 222 Trattasi di una valutazione di merito che sfugge ad un sindacato di legittimità. 4.2. Né può trovare ingresso in questa sede la censura secondo cui, trattandosi di notte ed essendo in corso un temporale, il conducente non poteva accorgersi se la L. facesse uso costante della cintura. Ciò, infatti, costituisce l'introduzione in questa sede di una nuova questione (mancanza di consapevolezza), che, non risultando nel ricorso come in precedenza prospettata (nel quale caso doveva essere proposta la censura sotto il profilo della violazione dell'art. 112 c.p.c., non essendosi sul punto pronunziata la Corte di merito), non può essere avanzata per la prima volta in questa sede, involgendo essa anche accertamenti di fatto, preclusi a questa Corte. Infatti è giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabile di ufficio (Cassazione 29 marzo 1996; 5106/1995; 6428/1984). 5. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il difetto di motivazione ed errore logico giuridico della stessa su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. Lamenta il ricorrente che, pur avendo la sentenza di merito riconosciuto ai genitori della L. la somma di lire 476.327.000 (lire 237.096.697 per spese affrontate fino al 1993, lire 220.500.000, per spese affrontate fino al 1996 e lire 18.730.000, per spese all'estero), ha poi ritenuto che detta somma andasse ridotta del 30%, dando luogo ad una somma ancora pari a lire 476.327.000, mentre, effettuata la riduzione del 30%, la somma finale doveva essere pari a lire 333.428.900. 6.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile. Infatti, con esso si censura un errore di calcolo, o, se si muta prospettiva, un'omissione materiale. In entrambe le ipotesi è esperibile esclusivamente il procedimento di cui agli artt. 287 ss. c.p.c., non essendo denunciabile con ricorso per Cassazione né l'errore di calcolo materiale né l'omissione materiale, che si risolva non in un vizio decisionale del giudice, ma in una mera "svista", rispetto a quanto risulta deciso (cfr. Cassazione 7249/1995). 6.2. Va, infatti, osservato che la speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 ss. c.p.c., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dianzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, 223 atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione (Cassazione 10289/2001; 1348/1995). Peraltro, nella memoria, il ricorrente dà atto di aver proposto istanza in merito alla Corte di appello di Catania e che la stessa è stata accolta. 7. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1223, 2056, 2059 c.c. ed art. 185 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per essere stato riconosciuto il danno morale in favore dei genitori del soggetto leso, che, per quanto in stato di coma dal momento dell'incidente ancora fino alla data del ricorso, tuttavia non era deceduto. 8. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato. Va osservato, infatti e contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, ma in conformità a quanto statuito dalle Su di questa Corte suprema di Cassazione (sentenza 9556/2002), che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale, concretamente accertato in relazione ad una particolare relazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. 9. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 c.c. e dei principi in tema di debito di valore e di valuta, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.. Assume il ricorrente che erratamente la sentenza impugnata l'ha condannato a corrispondere gli interessi sulle somme rivalutate, fino al passaggio in giudicato della sentenza di appello, mentre era con la sentenza di appello che il debito di valore si trasformava in debito di valuta, come tale sottoposto all'art. 1224 c.c. 10.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato. Premesso che la sentenza di appello ha liquidato il danno da ritardo con il criterio degli interessi legali, secondo i principi fissati dalle Su di questa Corte (sentenza 1712/1995), va osservato che detti interessi cd. compensativi nei debiti originariamente di valore, sono dovuti fino al momento in cui il debito di valore si converte in debito di valuta, e cioè fino al momento in cui sia divenuta definitiva la liquidazione del danno. La liquidazione diventa definitiva solo quando la sentenza, che l'ha effettuata, è divenuta definitiva, per cui solo da quel momento vi è l'assoggettamento del debito al principio nominalistico, regolato dall'art. 1224 c.c. (cfr. Cassazione 6231/1986). 224 Non è quindi la sola sentenza di appello che rende la decisione definitiva, ma il passaggio in giudicato di detta sentenza, mentre fino a quel momento il debito rimane di valore. 10.2. Va, pertanto, condiviso il principio, secondo cui, poiché la liquidazione che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta è quella operata con la pronuncia definitiva di merito, la quale non sempre coincide con la sentenza di appello, nonostante le caratteristiche di tale decisione, ove la sentenza di appello sia cassata sul punto della rivalutazione monetaria, non ne deriva in debito di valuta, restando invece la relativa determinazione rimessa alla nuova decisione di merito, la quale deve tenere conto della svalutazione verificatasi medio tempre sino alla liquidazione finale, salve le somme eventualmente già riscosse in esecuzione spontanea o coatta della decisione di appello poi annullata, rispetto alle quali il riferimento va fatto al momento della conseguita disponibilità della somma da parte del creditore (Cassazione 1167/1984). Correttamente, quindi, la sentenza impugnata ha disposto la corresponsione in favore della L. C. degli interessi compensativi sul suo credito di valore, con esclusione delle spese future, fino al passaggio in giudicato della sentenza di appello. 11. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, i ricorrenti L.E., in proprio e nella qualità, e C.G. lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 172 c.d.s., art. 2043 c.c., 1227 c.c., 2697 c.c. e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. nonché il vizio motivazionale su punti decisivi della controversia, a norma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Lamentano i ricorrenti, anzitutto, che la mancata adozione della cintura di sicurezza non ha alcun nesso di causalità con l'incidente stradale, il quale dipendeva solo dalla violazione delle norme stradali da parte del conducente; che in ogni caso mancava la prova che al momento dell'incidente la L. C. non avesse allacciata la cintura; che, in tal senso, la consulenza tecnica d'ufficio non può costituire la prova che la trasportata non avesse la cintura al momento dell'incidente, poiché le uniche prove possibili erano costituite da testimonianze, documenti o confessione; che quindi la disposta consulenza tecnica era inammissibile. 12.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato. Anzitutto va osservato che il giudice di appello, come era suo dovere, ha accertato quali fossero le cause che avevano prodotto il danno alla persona subito dalla L.. Ha individuato queste cause nell'incidente stradale ed inoltre nella mancata adozione delle cinture. Questa omissione, in parte (30%) imputabile alla L. come sopra detto, ha concorso nella misura del 50% alla produzione del danno fisico della L. e di tutti gli altri danni subiti dalla stessa e dai propri genitori. Il giudice di merito, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, ha infatti accertato che se detta cintura fosse stata "allacciata" non si sarebbe verificata 225 l'espulsione dall'auto della L. e non si sarebbero verificate le gravi lesioni al capo della stessa, che sbatté sull'asfalto. 12.2. Quanto alla censura, secondo cui non era stata fornita la prova, che al momento dell'incidente la L. non aveva azionato la cintura di sicurezza, in quanto detta prova poteva essere fornita solo con testimoni, documenti o confessioni, e non con consulenza tecnica, anche essa è infondata. Va, anzitutto, osservato che la consulenza tecnica non è soltanto strumento di valutazione tecnica, ma anche di accertamento e di ricostruzione dei fatti storici prospettati dalle parti, senza peraltro costituire un mezzo sostitutivo dell'onus probandi gravante su di esse (cfr. Cassazione 3734/1983; 8256/1987). 12.3. Nella fattispecie, in ogni caso, la ricostruzione dell'incidente, per la parte che riguardava la cintura di sicurezza, è stata effettuata dal consulente tecnico sulla base del dato incontestato tra le parti che la L. era stata sbalzata - a seguito dell'urto contro il muro dell'auto - fuori dell'abitacolo e ad alcuni metri di distanza dall'auto stessa, battendo il capo contro l'asfalto. Sulla base di questo dato storico certo, che è pacifico tra le parti, il consulente ha effettuato la valutazione tecnica che non era allacciata la cintura ed ha quindi accertato quale fosse stata l'incidenza eziologica della mancanza della cintura nella produzione dell'evento dannoso. Il giudice ha ritenuto di dover condividere detta conclusione del c.t.u. Peraltro i ricorrenti incidentali non danno alcuna altra spiegazione al fatto che la trasportata fosse stata sbalzata fuori dalla vettura, fatto certo ed incompatibile con l'ipotesi che la cintura fosse allacciata. La ricostruzione di un incidente stradale, attenendo ad un accertamento fattuale, rientra nei poteri del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizio motivazionale, che nella specie non si ravvisa, avendo il giudicante ritenuto che la L. non avesse la cintura sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. 13. In definitiva i ricorsi vanno rigettati. Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. 226 CONDOMINIO E PARCHEGGIO TRACCIA: Tizio e Tizia sono proprietari di due abitazioni del medesimo condominio Alfa. Tizio ritiene di aver acquistato dal venditore anche il diritto di uso di un cortile comune, dove permette agli amici di parcheggiare l’auto liberamente, non essendo previsto alcun divieto in tal senso dal regolamento condominiale. In particolare, l’atto di acquisto dell’immobile da parte di Tizio recava la dicitura “Tizio, con l’acquisto dell’immobile, diviene titolare anche del diritto di uso del cortile comune al condominio Alfa”. Tizia, invece, ritenendo che Tizio non possa far parcheggiare liberamente gli amici nel cortile, si reca dal legale Sempronio. Il candidato, assunte le vesti di Sempronio, rediga motivato parere sulla questione giuridica proposta. POSSIBILE SOLUZIONE SCHEMATICA: In premessa poteva essere utile ricostruire sinteticamente il fatto. Successivamente, era necessario far riferimento al principio generale di libertà negoziale, ex art. 1322 c.c., che incontra del limiti nella volontà della legge, come ad esempio nell’ipotesi di cui all’art. 1024 c.c., con la conseguenza che, nel caso di specie, Tizio non potrà aver acquisito un diritto di uso del cortile, perché non cedibile. Altresì, non era neanche possibile qualificare in concreto il diritto di uso come servitù, perché, comunque, Tizio si serviva del bene in misura superiore alla maggiore comodità, ex art. 1028 c.c., sconfinando in un abuso del diritto. Si consiglia di leggere la sentenza che segue. -Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza del bene accessorio e del bene principale in proprietà al medesimo soggetto, nonchè del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare una "utilità" al bene principale, e non al proprietario di esso. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE 227 SENTENZA 02-03-2006, n. 4599 Svolgimento del processo Con citazione notificata il 22 ed il 23/10/1997, P. F., proprietario della nuda proprietà di metà della quota ideale dello spiazzo adibito a cortile di circa 100 mq. antistante il fabbricato in ......., conveniva in giudizio davanti alla pretura di Napoli (poi Tribunale), sezione distaccata di P., D.M.V. e C.M.R., i quali, proprietari di appartamenti rispettivamente ai nn. 40 e 38 della predetta via, vantando un presunto diritto di uso sul cortile, vi facevano sostare autovetture di parenti ed amici; ciò premesso, chiedeva declaratoria di insussistenza, in capo ai convenuti, del diritto di uso del cortile, per intrasmissibilità dello stesso e per non uso. Si costituivano entrambi i convenuti, i quali replicavano che il diritto di uso del cortile in contestazione era previsto nei rispettivi titoli di acquisto e nei titoli dei loro danti causa e chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda. Interveniva volontariamente nel giudizio F.U., usufruttuaria del bene, aderendo alla domanda proposta dall'attore. Con sentenza del 17-8-2000, l'adito Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando inesistente il diritto di uso dei convenuti e condannandoli al pagamento delle spese processuali. Proposto appello da D.M.V., e costituitisi P.F. e F.U. per resistervi, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 2 luglio 2002, pronunciata nella contumacia di C.M.R., ha rigettato l'appello, condannando l'appellante alle spese del grado, con la motivazione che qui di seguito si riassume. Ha spiegato, innanzitutto, la Corte Territoriale che non esiste alcun vincolo pertinenziale tra il cortile oggetto di causa e l'abitazione dell'appellante ai sensi della L. n. 765 del 1967, art. 18 (che ha trovato conferma nella successiva L. n. 122 del 1982), in quanto il vincolo pubblicistico inderogabile riguardante gli spazi adibiti a parcheggio di cui alla citata norma non può riguardare, come ha chiarito la Suprema Corte, le costruzioni anteriori all'entrata in vigore della norma stessa; e, nel caso che ne occupa, deve escludersi il vincolo di pertinenzialità di natura pubblicistica, perchè l'edificio risulta costruito in epoca antecedente all'entrata in vigore della predetta legge. Deve escludersi, poi, anche il vincolo di pertinenzialità previsto dall'art. 817 c.c., non essendovi agli atti la prova nè dell'elemento soggettivo nè del rapporto funzionale tra cosa accessoria e cosa principale, che sono richiesti per la configurabilità della natura pertinenziale della prima. D'altra parte, proprio la previsione del diritto di uso del cortile negli atti di trasferimento dell'appartamento è la riprova, secondo la Corte, dell'inesistenza del vincolo pertinenziale, che, se esistente, non avrebbe richiesto la creazione di un apposito diritto di uso del cortile. 228 Per rispondere, infine, al terzo motivo di appello, la Corte ha rilevato che la deroga alla incedibilità di siffatto diritto prevista nell'atto di compravendita per notaio Golia del 24-11-1963, con cui le venditrici D.R. avevano ceduto il diritto di uso sul cortile in oggetto agli acquirenti D.L., con la specificazione che esso doveva intendersi a favore degli acquirenti e del loro aventi causa, non è stata prevista nè nell'atto di trasferimento del 26-7-1986 da D.L. a M. V. nè in quello successivo del 16-10-1987 da quest'ultimo a D.M.V., essendosi stabilito in detti atti semplicemente il "trasferimento del diritto proporzionale di uso, sosta e parcheggio sul piccolo spazio antistante il fabbricato"; cosicchè, quando con il predetto atto 16-10-1987 M. ha venduto a D.M. il diritto di uso su detto cortile, non avendo egli previsto con i suoi danti causa alcuna deroga alla cedibilità di tale diritto, ha violato quanto disposto dall'art. 1024 c.c.. Ricorre per la cassazione della sentenza D.M.V. con un unico articolato motivo. Resiste con controricorso P. F.. Non ha svolto attività processuale F.U.. Il ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione Il ricorrente denuncia, con un unico motivo: "Violazione e falsa applicazione di legge ( art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 817, 1024 e 1362 c.c., e ss. nonchè della L. n. 765 del 1967, art. 18). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5)", con riferimento ai seguenti punti: a) contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, che non ha interpretato secondo i canoni ermeneutici i negozi giuridici di donazione e di vendita relativi ai trasferimenti dell'appartamento ora di proprietà di esso ricorrente, lo spiazzo antistante l'immobile nel quale è compreso detto appartamento costituisce pertinenza pro quota di questo, ciò ricavandosi chiaramente dalle clausole contenute negli atti predetti, nei quali si dichiara espressamente che l'appartamento viene, rispettivamente, venduto ed acquistato "con tutti i relativi diritti, pertinenze, dipendenze, usi e servitù", ai sensi degli artt. 817 e 819 c.c.. In particolare, con l'atto del 16-10-1987 per notaio Trinchino, veniva trasferito a D. M.V., tra l'altro, "il diritto proporzionale di uso, di sosta, di parcheggio di veicoli di qualsiasi specie sul piccolo spazio di cortile antistante il fabbricato". Si è verificato, pertanto, secondo il ricorrente, "un rapporto pertinenziale tra l'appartamento sito al 1^ piano ed una quota della porzione del cortile, appartenenti entrambi ad un unico proprietario, il D.L., con espressa deroga all'art. 1024 c.c.. Sul punto si è formato il giudicato"; e "sta di fatto che le porzioni immobiliari successivamente acquistate dai coniugi M. P. e poi dal convenuto D.M. sono sempre rimaste legate dal rapporto pertinenziale", per cui, in definitiva, deve ritenersi che "la proprietà dell'appartamento al 1^ piano è in rapporto 229 pertinenziale con una piccola quota, in misura proporzionale, dello spazio antistante, con destinazione duratura e dimostrata dalle scritture citate". b) Non sussiste la violazione dell'art. 1024 c.c. per insussistenza di una deroga espressa,come erroneamente ritenuto dal Giudice di appello, risultando viceversa tale deroga per tabulas, posto che in tutti gli atti successivi a quello per notaio Golia del 24-11-1963, e, quindi, anche in quello del 1987 di acquisto dell'appartamento da parte del D.M., viene manifestata, di volta in volta, l'inequivoca ed espressa volontà di utilizzare la deroga di cui all'art. 1024 c.c., attraverso il trasferimento del diritto sul cortile antistante i beni immobili. Il ricorso è infondato. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza del bene accessorio e del bene principale in proprietà al medesimo soggetto, nonchè del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare una "utilità" al bene principale, e non al proprietario di esso (sent. 12983/2002, n. 14350/2000 ed altre conformi). E'stato, altresì, affermato e ribadito da questa Corte che l'accertamento della sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi che caratterizzano il rapporto pertinenziale fra due immobili e consistenti nella volontaria e permanente destinazione di uno dei due beni al servizio dell'altro, comporta un giudizio di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, se espresso con motivazione adeguata ed immune da vizi logici (sent. n. 4772/1977, n. 2989/1974). Nel caso di specie, la natura pertinenziale dello spiazzo antistante l'edificio rispetto all'appartamento del ricorrente è stata esclusa dalla Corte di merito sulla base di valutazioni compiute in conformità ai principi e criteri sopra richiamati e con motivazione congrua e aderente ai fatti accertati. E' stato affermato, in particolare, dal Giudice di appello - che ha condiviso sul punto la statuizione del Tribunale - che non vi è la prova agli atti della esistenza degli elementi che caratterizzano la natura pertinenziale dello spiazzo in questione, non riscontrandosi nè l'elemento soggettivo nè il rapporto funzionale tra il predetto spiazzo e l'appartamento del D.M.; rinvenendosi se mai, sempre secondo la Corte, la prova contraria nella previsione, negli atti di trasferimento relativi all'appartamento, di un apposito diritto d'uso sul cortile, che non sarebbe stata necessaria qualora questo fosse stato pertinenza dell'appartamento. Analoghe considerazioni valgono per il diritto di uso del cortile che l'odierno ricorrente pretende che gli sia riconosciuto quale proprietario dell'appartamento. Posto, invero, che il diritto de quo è di natura personale e trova la sua fonte in un'obbligazione assunta da un soggetto nei confronti di altro soggetto, che può servirsi della cosa concessagli in uso secondo lo schema delineato dall'art. 1020 c.c., con conseguente divieto di cessione, ancorchè suscettibile di deroga, del diritto stesso (art. 1024 c.c.; sent. n. 3565/1989), non ha errato la Corte nel negare, nella fattispecie sottoposta al suo esame, l'esistenza di tale diritto in capo al ricorrente, una volta accertato che con l'atto per notaio Trinchino del 16-10-1987, con cui M.V. ebbe a vendere al D.M., oltre che l'appartamento, anche il diritto d'uso sul cortile, fu violata, con riferimento alla cessione di questo, la disposizione 230 dell'art. 1024 c.c., non avendo il venditore previsto con i suoi danti causa alcuna deroga al divieto di cessione di cui alla citata norma. Non riscontrandosi, in conclusione, nella sentenza impugnata le violazioni di legge ed i vizi di motivazione denunciati dal ricorrente, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.100,00, di cui Euro 2000,00 per onorari, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2006. DIRITTO DI ABITAZIONE TRACCIA: Nel 1990 Tizio, vedovo, moriva ab intestato, lasciando a sé superstiti la figlia nubile Tizia ed il figlio Caio, quest’ultimo sposato con Caia e senza figli. Alla morte del padre Tizio, i fratelli Tizia e Caio non procedevano a divisione e restavano, quindi, comproprietari in parti uguali dell’unico bene immobile ereditario, relativo alla villa Tuscolana, dove andavano a vivere Caio e Caia. Nel 2000 moriva, ab intestato, Caio, non lasciando altri beni oltre ai suoi diritti sulla villa Tusculana. Caia riteneva di vantare un diritto di uso e di abitazione nella villa Tusculana. Il candidato rediga motivato parere sulla questione giuridica prospettata. POSSIBILE SOLUZIONE SCHEMATICA: In premessa poteva essere utile ricostruire molto sinteticamente il fatto. Il problema interpretativo posto, nella sostanza, riguarda la corretta interpretazione dell’art. 540 secondo comma cod. civ. che riserva al coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano “se di proprietà del defunto o comuni”. Cosa succede, allora, se la casa adibita a residenza familiare non è di proprietà esclusiva del defunto ovvero non è in comunione tra i coniugi (come nel caso della villa Tuscolana)? 231 In termini più chiari, l’art. 540 c.c. si applica nel caso in cui la casa (villa Tuscolana) adibita a residenza familiare non è di proprietà del de cuius Caio ovvero non è in comunione tra i coniugi Caio (defunto) e Caia (coniuge superstite)? Secondo una certa impostazione, il problema andrebbe risolto in termini positivi e Caia avrebbe il diritto di abitazione sulla villa Tuscolana nei limiti della proprietà del coniuge defunto Caio, con la conseguenza che se sussistesse l’indivisibilità dell’immobile stesso, Caia potrebbe chiedere l’equivalente monetario. Secondo l’interpretazione più condivisibile e coerente con la lettera della legge, il problema posto andrebbe risolto in termini negativi, con la conseguenza che Caia non avrebbe il diritto di uso e di abitazione sulla villa Tuscolana. In particolare, si dice, il legislatore limita, ex art. 540 II comma c.c., il diritto di abitazione e di uso ai casi in cui i beni siano di proprietà del defunto o comuni, con il corollario logico-deduttivo che dovrebbe essere escluso dall’ambito applicativo di tale norma il caso in cui la comunione sia con terze persone, come nel caso di specie dove Caio godeva di diritti sulla villa Tuscolana in comunione con Tizia; cioè, nel caso di specie l’art. 540 c.c. non può trovare applicazione. Ne segue, allora, che a Caia non spetteranno i diritti di abitazione e di uso sulla villa Tuscolana. Si consiglia di approfondire il problema sul testo Capozzi, Successioni e donazioni, Giuffrè ACCOLLO E DONAZIONE INDIRETTA TRACCIA: Tizio coniugato in regime di comunione legale con Tizia, nel 1999, acquistava dalla società immobiliare Alfa una villetta, in Sardegna, con annesso giardino pertinenziale. Nell’atto di acquisto, veniva precisato che: -sulla villetta gravava ipoteca convenzionale per 20000 euro, a garanzia della restituzione di un capitale di 18000 euro concesso a mutuo dalla banca Truffield alla società Alfa; -Tizio pagava in parte con versamento diretto alla società Alfa venditrice, ed in parte con accollo della residua somma dovuta dalla società Alfa a Truffield quale restituzione del mutuo, pari ad euro 8000; -l’immobile veniva intestato a Tizietta, figlia di Tizio e Tizia. Tizio e Tizia, due anni dopo, donavano gli immobili X ed Y, del medesimo valore della villa in Sardegna, agli altri figli Turbans e Tritolo. Divenuta maggiorenne, Tizietta si recava da un avvocato, in quanto riteneva di aver diritto ad una donazione, al pari di Turbans e Tritolo. Il candidato, premessi brevi cenni sul contratto a favore di terzo e sull’accollo, rediga motivato parere. 232 POSSIBILE SOLUZIONE SCHEMATICA: In premessa era necessario accennare al contratto a favore di terzo ed all’accollo. Il contratto a favore di terzo, ex art. 1411 c.c., è uno strumento negoziale che permette di far produrre effetti verso un terzo che non partecipa alla formazione del negozio giuridico principale; in particolare, con tale strumento negoziale si stabilisce che, salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa, però, può essere revocata o modificata dallo stipulante, finchè il terzo non abbia dichiarato, anche nei confronti del promittente, di volerne profittare; nel caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto. L’accollo, ex art. 1273 c.c., è una convenzione tra debitore e terzo, con la quale quest’ultimo (accollante) assume il debito del primo (accollato) nei confronti del creditore (accollatario); il creditore, quindi, è estraneo all’accordo ma, se vi aderisce, rende irrevocabile la stipulazione a suo favore. Tralasciando tutte le figure di accollo (accollo interno ed esterno, cumulativo e liberatorio, ad oggetto futuro) su cui sono stati scritti fiumi d’inchiostro (utile leggere il testo di Bianca sulle obbligazioni o, anche, Gazzoni), è sufficiente precisare, in questa sede, che l’accollo presenta la natura giuridica del contratto a favore di terzo. Nell’accollo, infatti, si ritrovano tutte e tre le posizioni giuridiche del contratto a favore di terzo e precisamente: l’accollato è lo stipulante, l’accollante è il promettente ed il creditore è il terzo. Il “favore del terzo” può essere individuato nella persona di un nuovo debitore accanto al debitore originario (accollo cumulativo). Nel caso di specie, dunque, che figure giuridiche vengono ad emergere? Tizio ha realizzato un contratto a favore di terzo, dove il terzo avvantaggiato è la figlia Tizia, che diviene, in concreto, proprietaria dell’immobile Alfa; l’acquisto del bene, viene effettuato in parte con denaro ed in parte con accollo di debito, con la conseguenza che viene ad emergere una compravendita realizzata parzialmente attraverso accollo. Tuttavia, la causa principale della complessa vicenda negoziale è quella di donare a Tizia l’immobile Alfa, per cui l’accollo e il contratto a favore di terzo divengono strumenti negoziali volti a realizzare una donazione indiretta della villa e non del denaro (oggetto eventuale della collazione potrebbe essere la villa). Tizio, poi, donava a Turbans e Tritolo gli immobili X ed Y dello stesso valore dell’immobile Alfa dato a Tizia, con la conseguenza giuridica che non è stata violata la par-condicio della legittima tra i figli; se, infatti, si sottolinea che l’immobile Alfa è stato indirettamente donato a Tizia e che donazioni di pari valore sono state fatte agli altri figli, allora, non vi è spazio logico-giuridico per giustificare la pretesa di Tizia di volere altre donazioni, in quanto nessuna norma è stata violata. Si ricorda che il contratto a favore di terzo differisce da quello per persona da nominare, perché in quest’ultimo la nomina del terzo è solo eventuale, rappresentando l’esercizio di una facoltà della parte che tale nomina si è riservata e può anche non esercitare, con la conseguenza che, in caso di nomina mancata, 233 invalida o intempestiva, il contratto produce i suoi effetti tra i contraenti originari; nella fattispecie, ex art. 1411 c.c., il terzo non è solo eventuale e deve essere specificatamente individuato (non è un contratto ad incertam personam, come quello per persona da nominare). Inoltre, nel contratto per persona da nominare, la dichiarazione di nomina non è a favore di un terzo, perché costui diviene unico contraente al posto di quello originario, non solo acquistando i diritti, ma anche assumendo obblighi nascenti dal contratto (nel contratto a favore di terzi, il terzo non può assumere obblighi); nel contratto per persona da nominare, la persona nominata diviene parte del contratto, diversamente dal contratto a favore di terzo, dove, quest’ultimo, non diventa mai parte del contratto (in senso tecnico-giuridico). Si consiglia di leggere Loffredo, Atti tra vivi, Giuffrè, pag. 139. DIRITTO DI SOPRAELEVAZIONE TRACCIA: Tizio è proprietario, insieme a Caio, dell’ultimo piano del condominio Beta. Tizio e Caio si accordano per realizzare una terrazzina, di circa 12 mq, sopra l’ultimo piano. Sempronio, proprietario di un immobile situato al secondo piano, ritiene che la decisione presa da Tizio e Caio non sia legittimamente seguibile, senza ascoltare gli altri condomini. Sempronio si reca dal legale Valenzano. Il candidato, assunte le vesti di Valenzano, rediga motivato parere sulla questione giuridica posta alla sua attenzione. POSSIBILE SCHEMA DI SOLUZIONE: In premessa poteva essere utile ricostruire molto sinteticamente il fatto. Successivamente occorreva chiedersi se la costituzione di una terrazzina sull’ultimo piano dell’edificio costituisce esercizio del diritto di sopraelevazione ex art 1127 c.c. La norma in parola riconosce il diritto di sopraelevazione al proprietario dell’ultimo piano dell’edificio (o ai proprietari per le porzioni loro spettanti) o al proprietario esclusivo del lastrico solare, ma con dei limiti. Un limite di natura convenzionale, deriverebbe dall’esistenza di un titolo contrario (anche il regolamento condominiale di natura contrattuale potrebbe escludere la facoltà di sopraelevare). Ulteriori limiti sono rappresentati dal pregiudizio alle condizioni statiche dell’edificio, all’aspetto architettonico ed estetico dello stabile, nonché alla luminosità dei piani sottostanti. Chi esegue la sopraelevazione è tenuto a pagare un’indennità. Nel caso in esame il condomino Sempronio,quindi, potrebbe opporsi alla realizzazione della terrazzina all’ultimo piano, se costituisce un’ occupazione in 234 via esclusiva del lastrico solare di proprietà condominiale, ovvero se altera l’aspetto architettonico dello stabile. Sotto tale ultimo profilo, in particolare, in un’ottica difensiva, appare chiaro che la costruzione di una terrazzina alteri l’aspetto architettonico, in quanto idonea a rappresentare un quid pluris rispetto alla struttura architettonica originaria, con la conseguenza di modificarne le proporzioni e l’assetto complessivo. Si consiglia di leggere le sentenze che seguono. -La facoltà di sopraelevare concessa dall'art. 1127 c.c., comma 1, al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale, ove l'ultimo piano appartenga, pro diviso a più proprietari, spetta a ciascuno di essi nei limiti della propria porzione di piano con utilizzazione dello spazio aereo sovrastante a ciascuna porzione e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1127 c.c., comma 2 e 3. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE SENTENZA 24-02-2006, n. 4258 Svolgimento del processo Con citazione notificata il 27/2/92 il condominio di Via ....... convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma, l'Arch. S.F. deducendo: che, a seguito di vertenza, in base alla quale il convenuto aveva citato in giudizio il condominio per ottenere il risarcimento dei danni da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare condominiale, subite dall'appartamento di sua proprietà, era intervenuta fra le parti, in sede di conciliazione giudiziale, una transazione in forza della quale lo S. veniva autorizzato ad eseguire una copertura, a fini igienici, del cassone di rifornimento idrico collocato dallo stesso, in assenza di autorizzazione del condominio, sul lastrico solare, e lo S. rinunziava a richiedere il risarcimento danni subiti dal suo appartamento; che tale transazione era subordinata alla ratifica da parte dell'assemblea che non solo non intervenne, ma fu espressamente deciso, con delibera 1.10.1991, di non ratificare,attese le violazioni urbanistiche e di progetto commesse dallo S. che aveva costruito un vero e proprio appartamentino collegato a quello sottostante di sua proprietà, occupando parte del lastrico solare condominiale. Chiedeva, pertanto, la demolizione di quanto edificato dallo S. sul lastrico solare, la chiusura dell'asola creata fra l'appartamento del medesimo ed il lastrico solare di proprietà comune, il ripristino dello statu quo ante, oltre al risarcimento danni. Lo S., costituitosi, contestava la domanda attrice asserendo di essere stato autorizzato dal condominio ad eseguire i lavori inforza dell'accordo intervenuto fra le parti in sede di conciliazione giudiziale; chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale che fosse affermato il suo diritto di eseguire le opere ai sensi dell'art. 1127 c.c. con condanna del condominio al risarcimento dei danni per l'omessa manutenzione del lastrico solare nella misura accertata dal C.T.U., nella causa dal medesimo precedentemente intentata contro il condominio. Espletata C.T.U. il Tribunale con sentenza 2.12.96 accoglieva la domanda del condominio, con condanna dello S. alla demolizione di quanto abusivamente costruito, al ripristino dello stato dei luoghi; dichiarava l'insussistenza del diritto 235 dello S. di sopraelevare; condannava il Condominio al pagamento in favore del convenuto della somma di L. 43.000.000 a titolo di risarcimento danni per le infiltrazioni. Su impugnazione principale dello S. ed incidentale del condominio, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza 05/09/2001, respingeva l'appello principale ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale riduceva in L. 35.000.000 oltre interessi la somma dovuta allo S. a titolo di risarcimento danni. Dopo aver premesso che la conciliazione giudiziale, pur potendo avere contenuto di transazione, presuppone in ogni caso l'incontro di volontà delle parti, afferma la Corte d'Appello che, non avendo l'amministratore condominiale, di per sè, il potere di disporre delle cose comuni (nella specie il lastrico solare), era onere dello S., che assumeva la dipendenze della legittimità della realizzazione da lui effettuata sul lastrico solare, dalla validità della conciliazione, dimostrare l'esistenza del potere dispositivo dell'amministratore o l'intervenuta ratifica della conciliazione giudiziale, in applicazione dei principi che regolano il fenomeno del falsus procurator; rilevando altresì che, sebbene nella citazione introduttiva del giudizio, il condominio aveva dedotto soltanto la mancata ratifica della transazione da parte dell'assemblea condominiale, tale linea difensiva presupponeva che l'amministratore avesse agito fuori o con eccesso dei suoi poteri. Poichè con l'atto di conciliazione lo S. era autorizzato non solo a completare i lavori tendenti ad incorporare una parte del lastrico solare ed a realizzare su di esso una cubatura, disponendosi in via perenne del lastrico necessario per la copertura e le modifiche relative al volume tecnico, afferma la Corte d'Appello che giustamente il Tribunale ha ritenuto non opponibile al condominio il negozio posto in essere dall'amministratore in quanto non ratificato dall'assemblea; trattandosi di sottrarre in via definitiva una parte del lastrico solare all'uso comune occorreva il consenso di tutti i condomini mai intervenuto nè dedotto; e l'onere che lo S. si era assunto, di trascrivere il verbale di conciliazione, dimostrava che l'accordo aveva la funzione di trasferire allo stesso una parte del lastrico solare, tant'è che la realizzazione del manufatto rendeva più che concreta la possibilità di un uso abitativo con interdizione all'uso comune di parte del lastrico solare. Conclude sul punto la Corte d'Appello che non essendo intervenuti tutti i condomini nell'assemblea con cui si era autorizzato l'amministratore a stipulare l'accordo con lo S. nè avendo mai una assemblea totalitaria ratificato il suddetto accordo, la condanna al ripristino dello stato dei luoghi andava confermata. Quanto al diritto a sopraelevare reclamato dallo S. afferma la Corte d'Appello che esso è da escludere nel caso di specie, inquanto la norma ( art. 1127 c.c.) presuppone la proprietà esclusiva del lastrico solare e consente al proprietario dell'ultimo piano di sopraelevare sempre che sia proprietario dell'interno ultimo piano e non di una parte di esso, come nella specie, è lo S.. Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione lo S.. Resiste con controricorso e ricorso incidentale il condominio. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione Deduce il ricorrente principale a motivi di impugnazione: 1) la falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di interpretazione, perfezionamento ed efficacia del contratto, di rappresentanza, di validità delle deliberazioni condominiali, conconseguente violazione dell'art. 2697 c.c. e art. 345 c.p.c. e connessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; 236 - per avere la Corte d'Appello nel ritenere l'accordo transattivo di cui al verbale di conciliazione giudiziale 17.11.1989, inidoneo a produrre effetti giuridici, per carenza del potere rappresentativo dell'amministratore del condominio che l'ha sottoscritto, erroneamente: A) affermato essere onere del ricorrente, convenuto in giudizio provare l'esistenza del poter dispositivo a favore dell'amministratore o l'intervenuta ratifica assembleare dell'accordo di cui alla conciliazione giudiziaria, nonostante: 1) spettasse al condominio, attore in giudizio, che negava la produzione di effetti del negozio, l'onere di dimostrare di non aver prestato alcun consenso al suo perfezionamento; 2) le clausole di cui al verbale di conciliazione escludessero la volontà delle parti di condizionare l'efficacia delle obbligazioni discendenti dalla transazione ad una successiva formale approvazione da parte dell'assemblea condominiale, dal momento che: 2-1) l'amm.re era stato autorizzato alla stipula dell'accordo dalla delibera dell'assemblea straordinaria del 19.X.1989 edotta del progetto, presentato dal ricorrente alla ripartizione urbanistica del comune ed allegato al verbale di conciliazione; 2-2) la necessità di una successiva verifica dell'assemblea denotasse l'assenza di volontà transattiva; 2-3) l'eventuale discrepanza tra l'atto autorizzato e quello concluso - per essere stato posto in essere dall'amm.re privo di poteri o superandone i limiti rendesse inefficace l'accordo indipendentemente dall'operatività di qualunque meccanismo condizionante l'efficacia; B) ritenuto aver l'amministratore superato i limiti del mandato ricevuto nonostante: 1) la tesi dell'eccesso di rappresentanza dell'amm.re fosse stata formulata per la prima volta in appello, introducendo, inammissibilmente, un tema di indagine e di decisione completamente diverso; 2) l'autorizzazione all'amm.re fosse stata conferita in funzione di una proposta transattiva formulata dal ricorrente e trasmessa al condominio; 3) l'assemblea condominiale non avesse avanzato proposte alternative e fosse consapevole che il progetto presentato al comune non dovesse essere modificato, ma solo completato; C) ritenuto che, trattandosi di disporre di una cosa comune (il lastrico solare), la delibera avrebbe dovuto essere approvata da tutti i condomini, nonostante: 1) in nessun caso sia previsto che le deliberazioni debbano essere approvate con il consenso unanime di tutti i condomini; 2) trattandosi, nella specie, non di trasferimento, ma di concessione in uso di parte del lastrico solare, di cui il condominio continuava a restare proprietario (come risultava dalla quantificazione di un corrispettivo, sia pur simbolico, posto a carico del ricorrente per la concessione del diritto di uso) la delibera assembleare non richiedesse il consenso di tutti i condomini; 3) l'onere di trascrivere il verbale di conciliazione non poteva ritenersi indice della volontà di trasferire la proprietà del lastrico solare, dal momento che la trascrizione è prevista anche per gli atti che costituiscono o modificano il diritto di uso; 2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 1127 c.c., con conseguente omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: - per avere la Corte d'Appello, nel confermare il rigetto della domanda riconvenzionale con cui il ricorrente aveva chiesto l'accertamento del diritto di sopraelevare, erroneamente: A) ritenuto che l'art. 1127 c.c. presupponga la proprietà esclusiva del lastrico solare da parte di chi intenda costruire, mentre la norma nell'attribuire la stessa facoltà anche al proprietario dell'ultimo piano fa ritenere che la titolarietà esclusiva del bene non sia un presupposto necessariamente valevole per entrambe le ipotesi; 237 B) ritenuto eh il diritto di sopraelevare ex art. 1127 c.c., spetti al proprietario esclusivo dell'intero ultimo piano, nonostante: 1) la norma riconduca l'esclusività al solo lastrico solare; 2) la negazione della facoltà di sopraelevare al proprietario di parte dell'ultimo piano non trovi alcuna giustificazione e, comunque, non sia stata motivata dalla Corte d'Appello e contrasti con la giurisprudenza di legittimità che consente, al proprietario della terrazza di copertura, a livello dell'adiacente appartamento, di sopralevare; 3) la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno, con conseguente falsa applicazione dell'art. 2041 cod. civ.; l'omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360c.p.c., nn. 3 e 5; - per avere la Corte d'Appello, nell'accogliere parzialmente l'appello incidentale del condominio, ERRONEAMENTE riconosciuto come dovute allo S. le sole spese sostenute per l'eliminazione delle infiltrazioni alle pareti del suo appartamento, e quelle per rendere impermeabile la parte del lastrico solare posta al di sopra di esso; nulla riconoscendo per il completamento dei lavori autorizzato dal condominio che ha tratto da essi, conseguentemente, un ingiustificato arricchimento. Deduce il condominio, ricorrente incidentale a motivo di impugnazione l'errata decisione della Corte d'Appello per aver riconosciuto allo S. le spese sostenute dal medesimo per rendere impermeabile la parte del lastrico solare posta al di sopra del suo appartamento, nonostante: A) le pretese infiltrazioni fossero state determinate dall'attività abusiva dello S., che ha compromesso la tenutadel lastrico solare; B) al ricorrente NON spettasse alcunchè a titolo di danni per avere egli provocato maggiori svantaggi al condominio, con l'interdizione all'uso comune di parte del lastrico solare, e con la riduzione di aria e luce ai piani sottostanti. Va disposta, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza. L'eccezione di inammissibilità del ricorso principale sollevata dal condominio, va disattesa. L'esposizione sommaria dei fatti, di cui all'art. 366 c.p.c., n. 3 infatti, può ritenersi, nella specie, sufficientemente svolta, in quanto attraverso la trascrizione del fatto, così come riportato nella sentenza impugnata, integrato dalle considerazioni svolte nei motivi di ricorso, è ben possibile rendersi conto delle vicende processuali, fra le parti e sulle quali si incentrano le censure proposte. Passando, quindi, all'esame del ricorso principale, il 1^ motivo è infondato. Trattandosi di interdire, in via definitiva, all'uso comune, una parte del lastrico solare di proprietà di tutti i condomini pro indiviso; e, quindi, anche senza trasferire la proprietà, ma costituendo su di esso un diritto di uso esclusivo a favore dello S. (diritto che, ritenuto soggetto a trascrizione, come argomenta la difesa del ricorrente, dovrebbe configurarsi come diritto reale); (trattandosi) cioè di porre in essere, comunque, un atto di disposizione, che implica una diminuzione del diritto di proprietà comune, non rientra nei poteri dell'assemblea condominiale, che decide con il criterio delle maggioranze, autorizzare l'amm.re del condominio a concludere transazioni che abbiano ad oggetto diritti comuni; In tal senso è chiaro il disposto dell'art. 1108 c.c., comma 3 (applicabile al condominio in virtù del rinvio ex art. 1139 c.c.) che, espressamente, richiede il consenso di tutti i comunisti e, quindi, di tutti i condomini, per gli atti di alienazione del fondo comune, o di costituzione su di esso di diritti reali o per le locazioni ultranovennali (alle quali ben può essere assimilata la concessione in 238 uso eslusivo a tempo indeterminato, ove a tale concessione voglia conferirsi natura obbligatoria e non reale); consenso richiesto, conseguentemente, anche per la transazione cheabbia ad oggetto i beni comuni, potendo essa annoverarsi, in forza dei suoi elementi costitutivi (le reciproche concessioni) fra i negozi a carattere dispositivo. E' vano, pertanto, invocare, a sostegno del potere rappresentativo dell'amm.re, la delibera dell'assemblea straordinaria del 19.10.1989, approvata a maggioranza, essendo necessario il consenso di tutti i condomini (v. 70175/98), consenso che può essere espresso anche attraverso una delibera assembleare che esprima la loro univoca volontà negoziale, o di concedere allo S. l'uso esclusivo di parte del lastrico solare comune; o di ratificare l'operato in tale senso posto in essere in nome e per conto di tutti i condomini, dall'amministratore che sia stato, in precedenza, invalidamente investito di poteri rappresentativi; ipotesi entrambe che, nella specie, non sono state poste in essere. Essendo, perciò, l'assemblea maggioritaria priva di legittimazione a deliberare il conferimento dei poteri rappresentativi all'amm.re, per stipulare, in nome e per conto dei condomini, la transazione di cui si è detto; del tutto fuori luogo è parlare di violazione dell'onere probatorio, dal momento che il condominio attore, con il far valere l'invalidità della delibera, ha fornito la prova della sua pretesa. Il 1^ motivo del ricorso in esame va, pertanto, respinto. E', viceversa, fondato nei limiti che vengano ad esporsi, il 2^ motivo dello stesso ricorso. La sentenza impugnata ha negato allo S. il diritto a sopraelevare, di cui all'art. 1127 c.c., sulla base di due argomenti: il primo basato sulla proprietà comune del lastrico solare, quale risulta dal regolamento condominiale e, quindi, sull'appartenenza a tutti i condomini della colonna d'aria sovrastante il lastrico comune; il, che, secondo la Corte Territoriale, preclude al condomino di sopraelevare (per esplicito dettato normativo che richiede in capo allo stesso la proprietà esclusiva del lastrico solare; il secondo argomento che attribuisce il diritto di sopraelevare al solo condomino che sia proprietario "esclusivo" dell'intero ultimo piano, perchè la norma consentirebbe solo la sopraelevazione di un piano e non di una frazione di piano, a salvaguardia dell'armonia architettonica della copertura dell'edificio; il che nella specie, precluderebbe il diritto di sopraelevare allo S., proprietario all'ultimo piano di un solo appartamento, peraltro di modesta estensione rispetto alle dimensioni del lastrico solare. Ora, mentre nulla quaestio sussiste in ordine al primo argomento in quanto è pacifico che lo S. non è proprietario esclusivo del lastrico solare e, quindi, non può pretendere, in tale veste, di esercitare il diritto di sopraelevare; non altrettanto può dirsi in ordine al secondo argomento posto dalla Corte d'Appello a sostegno della sua decisione, dal momento che la norma che riconosce al proprietario dell'ultimo piano di un edificio condominiale, il diritto di sopraelevare, non specifica nè che questi debba essere proprietario "esclusivo" dell'ultimo piano; nè che sia necessario sopraelevare per tutta l'estensione dell'ultimo piano. Si pone, quindi, una prima questione di diritto che la Suprema Corte deve risolvere per decidere la controversia, e riguarda la disciplina della sopraelevazione sopra l'ultimo piano dell'edificio, nel caso in cui l'ultimo piano non appartenga per l'intera estensione ad un solo proprietario, ma a più proprietari pro diviso. La soluzione si ricava dai principi concernenti l'acquisto dei diritti reali sulle costruzioni, nonchè dalle implicazioni della deroga pattizia al principio dell'accessione ( art. 934 cod. civ.): da tutto ciò si desume l'assetto dei beni siti nell'edificio soggetto al regime del condominio. 239 Per la verità, costruire raffigura una delle facoltà più importanti del diritto di proprietà su un terreno. La proprietà della costruzione, come di i tutto ciò che al suolo viene stabilmente unito, dal proprietario di questo, si acquista per accessione (art. 934 cit.). Impedire che si verifichi l'acquisto - fare si che la proprietà delle costruzioni o delle opere, che al terreno vengono stabilmente unite, spetti a persona diversa dal dominus soli - è possibile in virtù del titolo. Vale a dire, in virtù di un atto negoziale, con cui il proprietario del terreno rinunci all'acquisto che si verificherebbe in suo favore in base ai principi dell'accessione; ovvero, se tale acquisto si sia già verificato, in virtù di un atto con cui egli scinda la cosa (la costruzione incorporata al suolo) in due cose distinte (la costruzione ed il suolo), eventualmente trattenendo per sè la proprietà del terreno e trasferendo ad altri la proprietà della costruzione. La scissione, da cui deriva la costituzione della proprietà superficiaria, può essere fatta dal proprietario in due modi distinti: a) concedendo ad un terzo il diritto di costruire sul terreno e, quindi, di conseguire la proprietà superficiaria per effetto della costruzione ( art. 952 cod. civ., comma 1); b) alienando ad un terzo la costruzione già esistente e costituendo così la proprietà separata ( art. 952 cod. civ., comma 2). Una volta che il proprietario del suolo abbia rinunziato agli effetti dell'accessione in favore del terzo, a costui, divenuto proprietario superficiario, spettano le stesse facoltà che, prima della costruzione dell'edificio, spettavano al dominus soli: compresa la facoltà di sopraedificare, cioè di aggiungere una nuova costruzione a quella preesistente. Gli effetti dell'accessione e della deroga negoziale non cambiano quando insistano sul suolo, anzichè una sola proprietà, più costruzioni sovrapposte, facenti capo a proprietari diversi. Salvo diversa e specifica disposizione per titolo, l'accessione opera volta per volta in favore del proprietario dell'ultimo piano. Se sopra l'ultimo piano qualcuno eseguisse la sopraelevazione, senza aver ottenuto prima il diritto di superficie, egli non potrebbe evitare l'acquisto della proprietà della costruzione in capo al proprietario dell'ultimo piano. Per la verità, a mano a mano che la proprietà superficiaria viene spostata verso l'alto con la costruzione di nuovi piani, in virtù del diritto di superficie il proprietario dell'ultimo piano beneficia del diritto di sopraelevazione e acquista quanto viene costruito sopra. Nell'ipotesi in cui l'ultimo piano sia diviso in più appartamenti, ciascuno in proprietà separata facente capo a diverse persone, ciascun proprietario ha la facoltà di sopraelevare. Il diritto di ciascuno si estende relativamente alla proiezione verticale della sua proprietà sull'ultimo piano, con la conseguenza che ciascuno ha la facoltà di costruire sopra la propria porzione di piano, utilizzando lo spazio aereo sovrastante. In definitiva, gli atti di costituzione della proprietà superficiaria comportano la deroga al principio secondo cui superficies solo cedit e attribuiscono il diritto sulle unità costruite non al proprietario del suolo, ma ai singoli acquirenti degli immobili. Come conseguenza dell'attività negoziale, che da origine a più proprietà esclusive sui piani o sulle porzioni di piano, relativamente al fabbricato insorge il cosiddetto "regime dualista", consistente nella proprietà esclusiva dei piani o delle porzioni di piano e nella proprietà comune delle cose, degli impianti e dei servizi destinati all'uso comune. Queste asserzioni non sono inficiate dalla lettera della legge, che il diritto di sopraelevazione attribuisce al "proprietario dell'ultimo piano dell'edificio...". Nè 240 dalla considerazione che l'art. 1117 c.c., n. 1, attribuisce la proprietà comune del lastrico solare a tutti i condomini dell'edificio. Quanto all'attribuzione del diritto di sopraelevazione, l'uso del predicato al singolare non assume rilevanza alcuna. Poichè il diritto di sopraelevazione non è attribuito in considerazione della presenza di un unico proprietario, ma in ragione della posizione del piano nel fabbricato, i principi valgono allo stesso modo quando i partecipanti sono uno o più di uno. Allo stesso tempo, la proprietà comune del lastrico solare non influisce sulla soluzione della titolarità del diritto di sopraelevazione. Per la verità, in seguito alla costruzione sopra l'ultimo piano il lastrico solare, che adempie alla funzione di copertura dell'edificio, si sposta in altezza e la proprietà comune ed i relativi oneri si trasferiscono sul lastrico della nuova costruzione. Tutto ciò considerato, la disciplina della sopraelevazione sopra l'ultimo piano dell'edificio, non muta quando l'ultimo piano dell'edificio appartenga non ad un solo proprietario, ma a più proprietari: con la conseguenza che ciascun proprietario dell'ultimo piano ha la facoltà di sopraelevare, costruendo sopra la propria porzione di piano e utilizzando lo spazio aereo sovrastante. Viene, con ciò, anche risolta la seconda questione di diritto che la decisione della Corte d'Appello ha posto: quella, cioè, relativa all'estensione che deve avere la sopraelevazione sopra l'ultimo piano, estensione che, contrariamente a quanto si sostiene nella sentenza impugnata, è limitata, nel massimo, alla corrispondente misura della proprietà di cui è titolare il condominio dell'ultimo piano. Resta, comunque, fermo che, ai sensi dell'art. 1127 c.c., la facoltà di sopraelevare concessa al proprietario dell'ultimo piano è soggetta sia alle limitazioni di cui ai commi 2 e 3 della citata norma (condizioni di staticità dell'edificio e pregiudizio dell'aspetto architettonico dello stesso); sia a quelle che abbia posto il regolamento condominiale di natura contrattuale che ben può imporre ai condomini il divieto di sopraelevare, data la natura derogabile della citata norma di legge. Se, quindi, per quanto sopra detto, la Corte d'Appello ha errato nel negare alla S. il diritto di sopraelevare sulla base dell'interpretazione da lei data all'art. 1127 c.c., comma 1, il Giudice di merito deve ancora pronunciarsi, al fine di affermare la piena legittimità della sopraelevazione in concreto posta in essere dal ricorrente, sul rispetto dei suddetti limiti imposti dall'art. 1127 c.c.; sull'esistenza e la portata del divieto di sopraelevazione che si assume (dal condominio) contenuto nel regolamento condominiale (sul quale la Corte di Appello non si è pronunciata ritenendo implicitamente assorbita la questione); sulla natura contrattuale o meno del regolamento condominiale e quindi sulla opponibilità deldivieto allo S.; indagini tutte sulle quali dovrà pronunciarsi il Giudice di rinvio. Il 2^ motivo di ricorso va, pertanto, accolto nei limiti esposti. Il 3^ motivo del ricorso principale va rigettato. La censura, infatti, nella parte in cui viene dedotta la violazione dell'art. 2041 c.c., è inammissibile perchè proposta per la prima volta, in questa sede; per la parte in cui viene lamentato il mancato riconoscimento dei danni subiti dal ricorrente, per le spese di completamento dei lavori da lui sopportate, è infondata in quanto in mancanza di una valida autorizzazione al completamento dei lavori da parte di tutti condomini, le spese sopportate dallo S. a tal fine, devono ritenersi conseguenti ad un suo comportamento volontario e quindi debbono restare a suo carico. Passando all'esame del ricorso incidentale proposto dal condominio, le censure sono infondate in quanto la Corte d'Appello ha ritenuto provata la sussistenza dei danni liquidati allo S. siccome derivati dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico sovrastante di proprietà condominiale, non solo sulla base della C.T.U. eseguita nel processo intervenuto fra le stesse parti e poi dichiarato estinto (C.T.U. dalla 241 quale la Corte Territoriale correttamente ha tratto argomenti di prova, trattandosi di un mezzo istruttorio comunque espletato nel contraddittorio delle stessi parti in causa); ma, anche sulla base di quanto ammesso, nelle premesse dell'atto di conciliazione, dall'amm.re del condominio (a C.T.U. già espletata) il quale ha dato atto dell'esistenza delle infiltrazioni e dei conseguenti danni. Accertata, quindi, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, la causa dei danni liquidati allo S., nelle infiltrazioni dal lastrico comune sovrastante infondato è il profilo sub A) della censura; mentre deve ritenersi inammissibile il profilo sub B) della stessa, per avere il Condominio prospettato, perla prima volta in questa sede, l'esistenza di svantaggi provocati al condominio dalla sopraelevazione, maggiori dei danni reclamati dallo S., svantaggi non oggetto di valutazione nella fase di merito. La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma che provvederà ad un nuovo esame della controversia in applicazione del seguente principio di diritto: "La facoltà di sopraelevare concessa dall'art. 1127 c.c., comma 1, al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale, ove l'ultimo piano appartenga, pro diviso a più proprietari, spetta a ciascuno di essi nei limiti della propria porzione di piano con utilizzazione dellospazio aereo sovrastante a ciascuna porzione e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1127 c.c., comma 2 e 3". P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il 1^ ed il 3^ motivo del ricorso principale; accoglie per quanto di ragione il 2 motivo dello stesso ricorso; rigetta il ricorso incidentale; cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia; anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, davanti ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2004. Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2006. -In tema di condominio degli edifici e nell'ipotesi di violazione del divieto contenuto nel regolamento contrattuale di destinare i singoli locali di proprietà esclusiva dell'edificio condominiale a determinati usi,il condominio può richiedere la cessazione della destinazione abusiva sia al conduttore che al proprietario locatore. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE SENTENZA 08-03-2006, n. 4920 Svolgimento del processo Con sentenza n. 93 del 2000 il Giudice di Pace di Lanciano, in accoglimento della domanda proposta dal Condominio .... di ..... di quella città, inibiva ad B.A., quale conduttore di un appartamento, locato dal condomino D.M. nonchè a S.M., condomino del medesimo edificio, di tenere animali domestici negli immobili dai medesimi occupati nel predetto fabbricato, dichiarando cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta nei confronti di M.G. conduttore di un altro appartamento locato dal condomino D.M.. Avverso tale decisione proponevano appello il B., il M. e il S.. 242 Con sentenza dep. 11-10 dicembre 2001 il Tribunale di Lanciano, in accoglimento del gravame, rigettava la domanda proposta dal Condominio. Per quel che ancora interessa nella presente sede i Giudici di appello ritenevano che il Condominio, a fondamento della domanda,aveva invocato la norma del regolamento condominiale, secondo cui era vietato detenere negli appartamenti dell'edificio animali: le norme che incidono sull'utilizzabilità e la destinazione delle parti di proprietà esclusiva non possono essere approvate a maggioranza dall'assemblea ma hanno carattere convenzionale, sicchè - ove il regolamento sia predisposto dall'originario costruttore - devono essere accettate dai condomini nei rispettivi atti di acquisto o con atti separati,mentre qualora siano deliberati dall'assemblea devono essere approvate all'unanimità. Nella specie - secondo la decisione impugnata - era del tutto mancata la prova dell'esistenza di un regolamento accettato nei singoli atti di acquisto da tutti i condomini o dell'approvazione da parte dell'assemblea all'unanimità, tenuto conto che il verbale del 01/01/1981 non recava le sottoscrizioni di tutti i condomini; in considerazione dell'assenza di un regolamento applicabile, la norma invocata dall'attore non poteva spiegare alcun effetto nei confronti dei conduttori, posto che l'impegno dai medesimi assunto con il contratto di locazione produceva effetti nei confronti del locatore ma non di terzi; infine, il regolamento non poteva trovare applicazione nei confronti dei soli condomini che l'avevano accettato, posto che l'approvazione da parte dell'assemblea costituisce un atto collettivo. Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione il Condominio ….. sito in ……. sulla base di due motivi illustrati da memoria. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., deduce che non aveva partecipato al giudizio di appello, D.M., il quale - essendo il costruttore dell'immobile - era il consorte principale di tutta la vicenda processuale, giacchè in contraddittorio del medesimo doveva stabilirsi la validità della norma regolamentare. Con il secondo articolato motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 360, 100 e 214 cod. proc. civ., in relazione alle norme sul condominio e segnatamente degli artt. 1138 e 1136 cod. civ., deduce che l'approvazione del regolamento di condominio era avvenuta all'unanimità dei condomini che all'epoca facevano parte del condominio con delibera emessa dall'assemblea convocata dal S. che era anche amministratore e segretario dell'assemblea,in cui espresse voto favorevole all'approvazione; in ogni caso, le norme del regolamento erano state accettate dai conduttori in virtù del contratto di locazione intercorso con il D.M., che costituiva la fonte normativa degli impegni dai medesimi assunti. Il primo motivo è fondato. La sentenza di primo grado, emessa nel giudizio instaurato dal Condominio nei confronti dei condomini D.M. e S. ed in contraddittorio dei terzi chiamati B. e M., conduttori degli appartamenti di proprietà del D.M., è stata appellata dal B., dal M. e dal S. nei confronti dell'attore: al giudizio di appello non ha partecipato anche il D.M., che essendo - come detto proprietario degli immobili siti nell'edificio condominiale, era litisconsorte necessario, nei confronti del quale il contraddittorio andava integrato ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.. In tema di condominio degli edifici e nell'ipotesi di violazione del divieto contenuto nel regolamento contrattuale di destinare i singoli locali di proprietà 243 esclusiva dell'edificio condominiale a determinati usi,il condominio può richiedere la cessazione della destinazione abusiva sia al conduttore che al proprietario locatore. Peraltro, nell'ipotesi di richiesta nei confronti del conduttore, si verifica una situazione di litisconsorzio necessario con il proprietario,che deve partecipare al giudizio in cui si controverte in ordine all'esistenza e alla validità del regolamento: infatti, le limitazioni all'uso delle unità immobiliari in proprietà esclusiva, derivanti dal regolamento contrattuale di condominio, in quanto costituiscono oneri reali o servitù reciproche (Cass. 7003/1990; Cass. 1681/1993) afferiscono immediatamente alla cosa. (Cass. 16240/2003; 2683/1994). La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario comporta la nullità del giudizio di gravame e della sentenza impugnata. Il ricorso va pertanto accolto in relazione al primo motivo che ha natura pregiudiziale, essendo assorbito il secondo; la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese della presente fase, al Tribunale di Lanciano in diversa composizione. P.Q.M. Accoglie il primo motivo assorbito il secondo cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Tribunale di Lanciano in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2006. -La disciplina del condominio, pure in ordine alle spese (ad es., per i necessari rifacimenti dell’edificio ), è applicabile ad ogni tipo di condominio, anche a quelli c.d. “minimi”, composti cioè da due soli partecipanti. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE SENTENZA 22 GIUGNO 2005 N. 13371 (Presidente V. Calfapietra, Relatore C. Cioffi) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 12 giugno 1990 Maria G., Antonio e Paolo T., proprietari di uno dei due piani dell'edificio nel dettaglio indicato, proposero innanzi al Pretore di Rieti azione di danno temuto nei confronti di Agostino e Vincenzo S., proprietari dell'altro piano, denunziando il pericolo costituito dal progressivo crollo del tetto dell'edificio. Ottenuto dal Pretore il provvedimento cautelare richiesto, Maria G., Antonio e Paolo T., che avevano provveduto al restauro del fabbricato, convennero Agostino e Vincenzo S. in riassunzione innanzi al Tribunale di Rieti, del quale il Pretore aveva affermato la competenza, e chiesero che fossero condannati al pagamento di quanto da essi dovuto, "secondo la ripartizione millesima-le da determinarsi in corso di causa", nonché al risarcimento dei danni da essi subiti per la ritardata esecuzione del detto restauro. Agostino e Vincenzo S. si costituirono e chiesero il rigetto della domanda. Contestata la fondatezza dell'azione di danno temuto proposta da Maria G., Antonio e Paolo T., i convenuti sostennero in particolare che essi erano tenuti soltanto al pagamento delle spese relative alla effettuazione dei lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione delle parti comuni dell'edificio, nella misura e 244 secondo la ripartizione millesimale da essi proposta; chiesero inoltre, in riconvenzione, la demolizione di quanto gli attori avevano realizzato, eseguendo le opere previste dall'ordinanza pretorile, che era espressione di una inesistente "servitù di grondaia" gravante su un contiguo fondo. Con sentenza del 27 giugno 1995 il Tribunale di Rieti, individuato con una consulenza tecnica l'ammontare dei lavori urgenti ed indifferibili necessari per la conservazione dell'immobile condominiale, nonché le quote millesimali delle parti in lite, condannò Agostino e Vincenzo S. a pagare a Maria G., Antonio e Paolo T. la somma di 3.602.400 lire (a fronte dei 3.030.802 di lire, di cui i convenuti avevano riconosciuto di essere debitori); e rigettò sia l'azione risarcitoria esperita da Maria G., Antonio e Paolo T., sia la riconvenzionale di Agostino e Vincenzo S., non avendo questi ultimi "neppure dedotto di essere proprietari dell'asserito fondo servente". Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha rigettato il gravame di Agostino e Vincenzo S.. In particolare, ha disatteso il motivo di appello con cui questi ultimi avevano censurato la sentenza impugnata per aver riconosciuto la legittimità dell'ordinanza con cui il Pretore aveva concluso la fase cautelare del procedimento di danno temuto intentato nei loro confronti da Maria G., Antonio e Paolo T.; ha affermato poi che l'immobile per cui è causa è condominiale, e dunque che sono applicabili, nella specie, le norme dettate per gli edifici condominiali; ha disatteso inoltre la censura con cui gli appellanti avevano sostenuto l'erroneità della determinazione delle quote millesimali, osservando che essi non avevano allegato alcunché per dimostrare tale asserita erroneità; infine ha disatteso anche la censura con cui gli appellanti avevano ribadito che gli attori, nel ricostruire il tetto, avevano posto le premesse per l'acquisizione di una servitù di grondaia, osservando che lo sporto realizzato non è maggiore di quello del preesistente tetto, giusta quanto emerge dalla relazione del consulente tecnico di ufficio e dalle fotografie esibite. Vincenzo S. ha chiesto la cassazione di tale sentenza per sette motivi. Maria G., Antonio e Paolo T. hanno resistito con controricorso. Agostino S. non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi quattro motivi del suo ricorso Vincenzo S. censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato la nullità, ovvero per non aver annullato "tutti i provvedimenti emessi nella fase cautelare". Il ricorrente denunzia violazione dell'art. 163, 112, 260 e 689 del codice di rito, dell'art. 1172 del codice civile, e vizi di motivazione. Le censure sono inammissibili. I provvedimenti cautelari emessi nell'ambito del procedimento di denunzia di nuova opera ai sensi degli art. 689 e 690 del codice di rito hanno carattere interinale e strumentale rispetto alla causa di merito e, pertanto, non sono suscettibili di impugnazione autonoma. Volta poi che sia intervenuta una pronunzia che accerti o neghi il diritto del quale con essi è stata chiesta tutela, per l'appunto in via interinale, e provvisoria, viene meno la loro ragion d'essere, e con essa l'interesse ad impugnarli (cfr., tra le tante in tal senso, la sentenza di questa Corte n. 982-1999). Con il quinto motivo del suo ricorso Vincenzo S. censura la sentenza impugnata per ripartito le spese necessarie per i necessari rifacimenti dell'edifìcio applicando le norme del codice civile relative al condominio negli edifici (segnatamente gli art. 1123 e 1134), e non, come egli aveva sostenuto in appello, essendo l'edificio 245 composto da due sole unità immobiliari, quelle sulla comunione in generale (segnatamente l'art. 1110). Il ricorrente denunzia violazione delle citate nome, non senza sostenere che la motivazione della sentenza impugnata è carente ed illogica, non essendo configurabile nella specie, per la ragione detta, un condominio. La censura è infondata. La statuizione impugnata ha fatto puntuale applicazione del principio sempre affermato da questa Corte (cfr. le sentenze n. 7181-1997, 5298-1998, ed in particolare quella n. 5914-1993), secondo il quale, in base all'art. 1139 del codice civile, la disciplina del capo II del Titolo VII del terzo libro del codice civile (art. 1117-1138) è applicabile ad ogni tipo di condominio e, quindi, anche ai cosiddetti "condomini minimi", e cioè a quelle collettività condominiali composte da due soli partecipanti; in relazione alle quali sono da ritenersi inapplicabili soltanto le sole norme procedimentali sul funzionamento dell'assemblea condominiale, che resta regolato, dunque, dagli art. 1104, 1105, 1106. del codice civile. Con il sesto motivo del suo ricorso Vincenzo S. censura la sentenza impugnata per aver rigettato il suo motivo di appello con cui aveva sostenuto che la ripartizione millesimale effettuata dal Tribunale era illegittima. Il ricorrente denunzia violazione dell'art. 1123 del codice civile, e lamenta che la Corte d'appello ha affermato, nella sua sentenza, che "nessun elemento sussiste a conforto delle sue apodittiche affermazioni circa gli errori sulla consistenza volumetrica e gli spazi condominiali", senza tener conto della "precisa e puntuale elencazione di argomenti tecnico-giuridici ampiamente motivati, esposti nelle sue difese, suffragati da una consulenza tecnica di parte (in atti), che espone, con dovizia di particolari e con precise confutazioni tecniche, una precisa tesi circa l'erroneità e la incongruità delle ripartizioni millesimali adottate dal Tribunale per la ripartizione delle spese". Il motivo, con cui si censura la sentenza non tanto per la de-nunziata violazione di legge, quanto piuttosto per vizio di motivazione, è inammissibile. Il ricorso per cassazione - in virtù del principio di cosiddetta autosufficienza dello stesso - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari per individuare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito, e per valutarne la fondatezza, in modo che non sia necessario far ricorso ad altri documenti o atti, in particolare quelli relativi al pregresso giudizio di merito (cfr. tra le tante, tutte conformi, da ultimo, le sentenze n. 12912-2004 e 13550-2004). Il ricorrente non ha precisato, nel ricorso, quali sono gli argomenti tecnici giuridici da lui sviluppati per sostenere il motivo di gravame che a suo dire è stato disatteso senza adeguata motivazione, e che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente considerati e valutati. Con l'ultimo motivo del suo ricorso Vincenzo S. censura la sentenza impugnata per aver confermato il rigetto della sua domanda riconvenzionale relativa alle dimensioni della sporgenza del tetto ricostruito deciso dal Tribunale in prime cure. Il ricorrente sostiene che non è vero quanto affermato al riguardo dalla Corte d'appello di Roma e in narrativa sintetizzato; in particolare sostiene che il consulente tecnico di ufficio si è limitato a proporre "valutazioni presuntive", e che dalle fotografie che raffigurano lo stato pregresso dei luoghi risulta il contrario di quanto affermato in sentenza. Denunzia quindi violazione dell'art. 2697 del codice civile e vizi di motivazione. La censura è inammissibile. Con essa il ricorrente non fa altro che proporre una valutazione delle prove raccolte diversa da quella che ne ha data il giudice del merito, e a contrapporla a 246 quella di questo ultimo; chiede in altri termini un riesame delle prove raccolte, che questa Corte, giudice della sola legittimità, non può effettuare. Le spese seguono la soccombenza. PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso, e condanna Vincenzo S. a rifondere a Maria G., Antonio e Paolo T. le spese di questo giudizio, che liquida in 1.300,00 euro, di cui 1.200,00 per onorari, oltre accessori di legge. Roma, 15 aprile 2005. -Al condominio orizzontale si applica la disciplina del condominio. Per i complessi immobiliari che comprendono piu’ edifici, anche se "autonomi", e’ rimesso all'autonomia privata se dare luogo alla formazione di un unico condominio, oppure di distinti condomini per ogni edificio, cui si affianca in tal caso un "supercondominio": figura questa di creazione giurisprudenziale, alla quale sono applicabili le norme relative al condominio, appunto perche’ si verte nella materia delle "parti comuni" indicate dagli art. 1117 cod. civ. e 62 disp. att. cod. civ., caratterizzate dal rapporto di accessorieta’ necessaria che le lega alle singole proprieta’ individuali, delle quali rendono possibile l'esistenza stessa o l'uso, come per esempio le portinerie, le reti viarie interne, gli impianti dei servizi idraulici o energetici dei complessi residenziali, mentre restano soggette alla disciplina della comunione ordinaria le altre eventuali strutture, che invece sono dotate di una propria autonoma utilita’, come per esempio le attrezzature sportive, gli spazi di intrattenimento, i locali di centri commerciali inclusi nel comprensorio. CASSAZIONE CIVILE Sezione II, Sentenza n. 8066 del 18/04/2005 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORONA Rafaele - Presidente Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere Dott. MALPICA Emilio - Consigliere ha pronunciato la seguente: Svolgimento del processo Con atto notificato il 31 maggio 1991 M. C., M. A. e M. G. P. citarono davanti al Tribunale di Cagliari il condominio del complesso residenziale "M. N.", sito in localita’ (XX), esponendo che erano comparse lesioni nella muratura perimetrale e nelle fondazioni di una loro unita’ immobiliare, facente parte di uno dei blocchi di villette a schiera del comprensorio; chiesero che fosse dichiarata invalida la deliberazione assembleare del 4 maggio 1991, con la quale era stata negata ogni responsabilita’ del condominio convenuto, e che questo fosse condannato all'esecuzione delle necessaria opere di riparazione, o in subordine al pagamento del corrispondente importo, nonche’ al risarcimento dei danni. Il condominio "M.N." si difese contestando che le strutture lesionate appartenessero, come presupponevano dagli attori, a tutti i singoli proprietari delle unita’ immobiliari del complesso. 247 All'esito dell'istruzione della causa, consistita nell'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 24 gennaio 2000 il Tribunale dichiaro’ invalida la deliberazione assembleare in questione e condanno’ il convenuto all'esecuzione di alcuni lavori provvisionali al rimborso della somma di lire 13.909.077 spesa dagli attori per l'eliminazione dei guasti, al risarcimento dei danni nella misura di lire 7.112.568 al pagamento delle spese di giudizio. Impugnata dal condominio "M.N.", la decisione e’ stata riformata dalla Corte di appello di Cagliari, che con sentenza del 30 luglio 2001 ha respinto tutte le domanda proposte dagli attori e li ha condannati a rimborsare all'altra parte meta’ delle spese dei due gradi di giudizio, compensandole per il residuo. MC, M. A. e M. G. P. hanno proposto ricorso per Cassazione, in base a tre motivi. Il condominio "M.N." si e’ costituito con controricorso, formulando a sua volta due motivi di impugnazione in via incidentale, dei quali il primo condizionato, che sono stati contrastati dai ricorrenti principali con un proprio controricorso. Il condominio "M.N." ha presentato una memoria. Motivi della decisione In quanto proposte contro la stessa sentenza, le due impugnazioni vanno riunite in un solo processo, in applicazione dell'art. 335 cod. proc. civ. Con il primo e con il secondo dei motivi addotti a sostengo del ricorso principale - tra loro strettamente connessi e da prendere pertanto in esame contestualmente - vengono denunciate "violazione degli artt. 61 e 62 d. a.c.c; violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.; vizio di omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione" e "violazione dei canoni ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e 1363 c.c.; insufficienza della motivazione", per avere la Corte di appello negato la legittimazione passiva del condominio "M.N.", sulla scorta di una erronea e ingiustificata interpretazione del suo regolamento. La censura deve essere accolta, per quanto di ragione. Il giudice di secondo grado ha innanzi tutto precisato che "il concetto giuridico di condominio in senso proprio ha ad oggetto solo la comproprieta’ delle parti comuni degli edifici indicate nell'articolo 1117 del Codice civile", sicche’ "il condominio esiste solamente negli edifici che si estendono in senso verticale, generalmente in piu’ piani, ove le parti comuni indicate dalla legge hanno per loro stessa natura una funzionalita’ che trascende i limiti della proprieta’ individuale", anche se "in tempi recenti, e’ invalso l'uso di qualificare come condominio delle entita’ diverse dall'istituto tipico delineato dalla legge, le quali sono pero’ in realta’ delle semplici comunioni convenzionali, costituite per la gestione di servizi comuni ad un certo numero di edifici...ciascuno dei quali costituente un vero condominio autonomo"; ha poi osservato che "il complesso residenziale denominato M.N. consta di un complesso di edifici...distinti in vari blocchi" e "ciascun blocco, a sua volta, consta di numerosi edifici", con la conseguenza che "si deve ritenere che, nel complesso residenziale in esame, siano presenti una serie di figure soggettive ben distinte per natura e funzione, cioe’: - un super condominio costituito convenzionalmente tra tutti i proprietari delle unita’ immobiliari, abitative e non site sull'area nel suo complesso...; - tanti super condomini costituiti convenzionalmente tra tutti i proprietari delle unita’ abitative site nei vari blocchi...; - tanti condomini quanti sono gli edifici; risulta evidente come solo questi siano dei condomini in senso proprio, costituiti per legge per la gestione delle parti comuni dei singoli edifici, ai sensi del disposto dell'art. 1117 del Codice civile"; ha altresi’ ritenuto che "il regolamento, come appare evidente dalla sua lettura, e’ un insieme indistinto di norme convenzionali che disciplinano sia i rapporti all'interno del super condominio dell'intero complesso immobiliare, 248 sia quelli all'interno dei super condomini dei singoli blocchi, sia quelli dei singoli condomini propriamente detti" e "si deve giungere alla conclusione che la volonta’ dei sottoscrittori dell'atto coincida perfettamente con la previsione normativa", in quanto tiene "ben distinte le proprieta’ comuni solo ai proprietari dei singoli edifici dalle proprieta’ comuni a tutti". Nei termini assoluti in cui e’ stata formulata, non e’ condivisibile la premessa da cui la Corte di appello ha preso le mosse. La varieta’ delle tipologie costruttive e’ tale, da non consentire di affermare aprioristicamente, come si fa nella sentenza impugnata, la configurabilita’ come condominio in senso proprio "solamente negli edifici che si estendono in senso verticale": anche corpi di fabbrica adiacenti orizzontalmente (come in particolare proprio le case "a schiera") possono ben essere dotati di strutture portanti e di impianti essenziali comuni, come quelli che sono elencati nell'art. 1117 cod. civ., peraltro esemplificativamente e con la riserva "se il contrario non risulta dal titolo". Ma anche in mancanza di un cosi’ stretto nesso strutturale, materiale e funzionale, l'ipotesi della "condominialita’" non puo’ essere senz' altro esclusa, neppure per un insieme di edifici "indipendenti". Lo si ricava, come esattamente hanno osservato i ricorrenti principali, dagli art. 61 e 62 disp. att. cod. civ., che consentono lo scioglimento del condominio nel caso in cui "un gruppo di edifici...si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi", pur quando "restano in comune con gli originare partecipanti alcune delle cose indicate dell'articolo 1117 del codice": dal che si desume che e’ permessa la costituzione ab origine di un condominio di fabbricati a se’ stanti, aventi in comune Solo alcuni elementi, o locali, o servizi, o impianti "condominiali" (cfr. Cass. 28 ottobre 1995 n. 11276). Per i complessi immobiliari che comprendono piu’ edifici, anche se "autonomi", e’ dunque rimesso all'autonomia privata se dare luogo alla formazione di un unico condominio, oppure di distinti condomini per ogni edificio, cui si affianca in tal caso un "supercondominio": figura questa di creazione giurisprudenziale, alla quale sono applicabili le norme relative al condominio, appunto perche’ si verte nella materia delle "parti comuni" indicate dagli art. 1117 cod. civ. e 62 disp. att. cod. civ., caratterizzate dal rapporto di accessorieta’ necessaria che le lega alle singole proprieta’ individuali, delle quali rendono possibile l'esistenza stessa o l'uso, come per esempio le portinerie, le reti viarie interne, gli impianti dei servizi idraulici o energetici dei complessi residenziali, mentre restano soggette alla disciplina della comunione ordinaria le altre eventuali strutture, che invece sono dotate di una propria autonoma utilita’, come per esempio le attrezzature sportive, gli spazi di intrattenimento, i locali di centri commerciali inclusi nel comprensorio (cfr. Cass. 3 ottobre 2003 n. 14791). Impropriamente, pertanto, la Corte di appello ha orientato la propria interpretazione del regolamento della "M.N.", avente natura contrattuale, secondo l'indirizzo che ha reputato essere imposto dalla "natura inderogabile delle norme giuridiche relative alla proprieta’ comune dei beni costituenti oggetto dei condomini propriamente detti", i quali a suo avviso non sono configurabili se non con riguardo a singole e unitarie costruzioni, autonomamente munite, nell'ambito della loro proiezione verticale, di tutte le necessarie "parti comuni". Fuorviato da questa erronea impostazione, il giudice di secondo grado e’ effettivamente incorso nelle violazioni di regole ermeneutiche e nei vizi di motivazione lamentati dai ricorrenti principali. Ha infatti trascurato di prendere in considerazione le varie clausole regolamentari Indicate dai ricorrenti principali - i quali le hanno trascritte, in ottemperanza al principio di "autosufficienza", nell'atto 249 introduttivo del giudizio di legittimita’ - che avrebbero potuto in ipotesi condurre a una conclusione diversa: l'art. 1, con il quale viene "costituito un Condominio tra tutti i proprietari degli immobili ubicati in localita’ Terra Mala del Comune di Quartu S. Elena...costituenti un complesso residenziale omogeneo denominato M.N."; l'art. 4, secondo cui "tutti i condomini devono contribuire alle spese per la conservazione ed il funzionamento delle cose comuni"; l'art. 13, che istituisce unitari "organi di rappresentanza del condominio"; le tabelle millesimali, compilate allo "scopo di stabilire le quote di valore delle singole proprieta’ al fine di poter ripartire, in proporzione alle stesse, le spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni degli edifici (blocchi) e delle infrastrutture di uso comune", tabelle che sono "ripartite quindi in quote millesimali distinte " per ogni singolo blocco ed in quote millesimali riguardanti l'intero complesso". Se a queste previsioni si fosse dedicata attenzione, se ne sarebbe potuto eventualmente desumere (come peraltro anche da quelle dell'art. 3, unicamente esaminate nella sentenza impugnata, che elencano distintamente le "parti costitutive dei singoli edifici" e le "parti e servizi comuni ai diversi corpi di fabbrica") che in realta’ era stato costituito un solo generale condominio, facendo semmai salva l'appartenenza delle "parti costitutive" dei singoli "blocchi" ai soli proprietari delle unita’ immobiliari comprese in ognuno: appartenenza "separata" (come e’ pure la correlativa responsabilita’ per le spese inerenti) la cui possibilita’ va senz'altro ammessa, alla luce del principio sancito dal 3^ comma dell'art. 1123 cod. civ., da cui discende la configurabilita’ del "condominio parziale" (cfr. Cass. 12 febbraio 2001 n. 1959) : il che attiene pero’ non alla qualificabilita’ della "M.N." come condominio "in senso proprio", ma alla diversa e ulteriore questione, relativa alla distribuzione della spesa in contestazione tra tutti i singoli proprietari oppure tra alcuni soltanto di loro. E' in queste piu’ ampie prospettive che si sarebbe dovuta vagliare - e dovra’ esserlo nel giudizio di rinvio - l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, che era stata sollevata dalla parte appellante. Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti principali, dolendosi di "violazione degli artt. 1104, 2043 e 2051 c.c.; violazione dell'art. 1131 c.c.; violazione dell'art. 112 c.p.c. motivazione insufficiente e contradditto-ria", lamentano che la Corte di appello ha escluso ogni responsabilita’ di quello che ha qualificato come "supercondominio", pur essendo risultato che le lesioni in questione erano state causate (anche) da difetto di manutenzione di beni sicuramente formanti oggetto di tale presunta "comunione ordinaria". Anche questa censura va accolta. La Corte di appello ha dato atto che "sulla base delle relazioni tecniche si puo’ ritenere che le lesioni alle fondazioni ed ai muri maestri siano state determinate da tre elementi: esecuzione delle fondazioni non a regola d'arte, infiltrazioni di acqua dovute al cattivo funzionamento dell'impianto di canalizzazione delle acque meteoriche ed infiltrazione di acque attraverso le fessure dei marciapiedi circostanti l'edificio", ma ha poi mancato di vagliare, sotto il profilo del secondo e del terzo di tali "elementi", le domande di ripristino e di risarcimento proposte dagli originari attori, assiomaticamente affermando che la responsabilita’ "riguarda comunque sempre il condominio" formato dalla sola villetta n. 2 inclusa nella schiera costituente uno dei "blocchi" del complesso immobiliare (ed ha altresi’ errato, come lo stesso resistente riconosce, nel considerare parte convenuta in primo grado e appellante in secondo la "comunione" del suddetto "blocco", anziche’ il condominio - o "supercondominio", nella sua visione - "M.N."). 250 Con il primo motivo del ricorso incidentale, formulato "per l'ipotesi che codesta Corte accolga il ricorso principale", si sostiene che in realta’ i danni lamentati dagli attori non possono essere stati causati da infiltrazioni provenienti da spazi esterni al "blocco" comprendente la loro villetta e che "una nuova istruttoria con una nuova perizia e l'espletamento delle prove per interrogatorio formale e per testi, richiesta dal Condominio M.N., potra’ portare ad una giusta decisione nei riguardi dello stesso condominio". Il motivo e’ inammissibile, poiche’ concerne richieste istruttorie che dovranno essere esaminate nel giudizio di rinvio e sulle quali non si deve ne’ si puo’ adottare in questa sede alcuna decisione. Resta assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, con cui si nega che la compensazione parziale delle spese di giudizio, disposta dalla Corte di appello, sia stata giustificata con argomenti "convincenti". Pertanto, riuniti i ricorsi, accolto per quanto di ragione il principale, dichiarato inammissibile il primo motivo dell'incidentale e assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice - che si designa in una diversa sezione della Corte di appello di Cagliari - cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di Cassazione. P. Q. M. La Corte riunisce i ricorsi; accoglie per quanto di ragione il principale; dichiara inammissibile il primo motivo dell'incidentale e assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita’. Cosi’ deciso in Roma, il 16 dicembre 2004. Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2005. -Alle ripartizioni delle spese avente ad oggetto l’ascensore si applica la disciplina giuridica in tema di ripartizione delle spese relative alle scale. CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE SENTENZA 17 febbraio 2005 n. 3264 Svolgimento del processo Con citazione notificata il 27.07.1989 Roberto M. convenne davanti al Tribunale di Milano il Condominio di Via XXXXX in Milano impugnando la delibera 10.07.1989 con la quale l'assemblea aveva approvato la ripartizione delle spese millesimali di ascensore e riscaldamento. Il Condominio, tardivamente costituitosi, chiese il rigetto della domanda. Con separata citazione notificata il 3.11.89 Carlo e Caterina S. convennero in giudizio davanti allo stesso Tribunale il medesimo Condominio impugnando la delibera 12.10.89 con la quale l'assemblea aveva approvato i nuovi millesimi per la ripartizione delle spese diriscaldamento e di ascensore. Il Condominio, costituitosi chiese il rigetto della domanda. Disposta la riunione delle cause il M. chiese, in ordine alla domanda da lui proposta, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in forza della delibera 12.10.89 che soddisfaceva le sue richieste, ed il rigetto della domanda proposta dagli S. nel cui giudizio era intervenuto. Con successiva citazione 25.07.90 Carlo e Caterina S., Elda B., Lino P. ed Edoardo B. impugnarono la delibera 12.10.89 con riferimento all'approvazione 251 delle spese di tinteggiatura dei serramenti, - nonchè la delibera del 27.06.90 relativamente al consuntivo 1.5.89/1.4.90 ed al nuovo regolamento di Condominio con allegate tabelle millesimali. Costituitosi il Condominio, chiese il rigetto della domanda: riunite tutte le cause, ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini dei quali solo in pochi si sono costituiti, il Tribunale, con sentenza 22.10.98 ha respinto sia l'impugnazione delle due delibere 12.10.89 e 27.6.90, sia la domanda di revisione e determinazione giudiziale delle tabelle millesimali, dichiarando cessata la materia del contendere relativamente alla delibera 10.7.89. Su impugnazione di Carlo e Caterina S., che insistevano per la dichiarazione di nullità delle delibera 12.10.89 e 27.6.90, nella parte in cui avevano modificato le tabelle millesimali per il riparto delle spese del servizio di ascensore nonchè per la nullità di ogni altra delibera che avesse comunque modificato le predette tabelle senza il consenso unanime degli aventi diritto, la Corte di appello di Milano, con sentenza 12.5.2000, respingeva l'appello. Precisato che la sola questione controversa fra le parti riguarda la ripartizione delle spese di gestione dell'ascensore della scala C; afferma la Corte d'appello, per quanto riguarda gli ascensori, che la presunzione di comproprietà fra i condomini dell'impianto, è fondata sulla relazione strumentale necessaria fra esso e l'uso comune e poichè la destinazione al soddisfacimento dell'interesse dei partecipanti al Condominio, non ha per tutti pari intensità, ma varia in funzione del piano in cui si trova la porzione di proprietà esclusiva del singolo Condominio, il criterio di ripartizione delle spese, secondo la misura della partecipazione alla comproprietà del bene da parte dei singoli deve essere coordinato con quello della proporzione dell'uso che ciascuno può farne; per cui il principio desumibile dall'art. 1117 c.c. deve essere coordinato con quello stabilito dall'art. 1123 2 e 3 c. C. Civ. che individua il criteriodi riparto in base all'uso differenziato (in particolare all'uso virtuale e non a quello effettivo); - e la disciplina applicabile agli ascensori deve essere analoga a quella stabilita per le scale dall'art. 1124 C. Civ. il quale rappresenta una applicazione della regola generale stabilita dall'art. 1123 2 e 3 c. C. Civ.. - Aggiunge la Corte d'appello che se per le spese di conservazione delle parti comuni, essendo diretta alla tutela della integrità del valore capitale, può in astratto, ammettersi che esse siano dovute in proporzione alla quota di comproprietà; ciò non può ammettersi per le spese attinenti al godimento delle cose comuni, in quanto esse scaturiscono dall'uso, sicchè legittimo è il criterio stabilito con la delibera 12.10.89, ribadito nella successiva delibera del 27.6.90 (cioè 50% dei millesimi di proprietà e 50% in base ai piani). Irrilevante, per la Corte d'appello, è la circostanza che l'impianto sia stato realizzato mediante differenti contribuzioni volontarie da parte dei condomini dal momento che il criterio della proporzionalità alle sole quote di proprietà, non è idoneo a rappresentare la misura secondo cui ciascun condomino gode e fa uso dell'impianto. Con riferimento alla mancanza di una determinazione convenzionale dei valori immobiliari delle porzioni di proprietà esclusiva, afferma la Corte d'appello che il rapporto fra il valore della proprietà dell'intero edificio e quello della proprietà singola, esiste indipendentemente dalla formazione della tabella millesimale; e che l'assemblea, anche in assenza di un regolamento che fissi i criteri, ha il potere di stabilire la ripartizione delle spese fra i condomini; cosicchè nella fattispecie in esame, in cui non si deduce che per le spese dell'ascensore si siano consolidati, con effetti negoziali vincolanti, criteri di ripartizione diversi, del tutto legittimi 252 sono i criteri richiamati nella delibera 12.10.89 tanto più che i valori dei piani espressi in millesimi esistono di fatto e sono applicati da anni senza contrasti. Quanto, infine, alla dedotta ingestibilità" delle "tabelle ascensore" predisposte dal C.T.U. (perchè non esisterebbe una caratura millesimale delle unità immobiliari in base al "valore di piano o porzione di piano") afferma la Corte d'appello che l'inconveniente, ove fosse di fatto ravvisabile, non produrrebbe alcun effetto pregiudizievole, in quanto il Tribunale ha escluso che quelle tabelle avessero immediata efficacia per i condomini, in mancanza di consenso da parte di tutti. Avverso tale sentenza ricorrono in Cassazione Carlo e Caterina S. -Resiste con controricorso il M. Nessuna attività difensiva hanno svolto gli intimati. Motivi della decisione Deducono i ricorrenti a motivo di impugnazione: la violazione e falsa applicazione degli artt. 1100, 1123, 1124 Cod. Civ. in relazione all'art. 360 N 3 c.p.c.. - per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto, conformemente al Tribunale, applicabile, quale criterio di ripartizione delle spese di conservazione e manutenzione dell'ascensore, quello stabilito con la delibera 12.10.89 approvata con 553,71 voti e cioè in base al 50% dei millesimi di proprietà e al 50% del valore dei piani, NONOSTANTE: a) in mancanza dell'unanimità dei consensi, trattandosi di ascensore (realizzato dopo 50 anni dall'edificazione dello stabile) oggetto di una comunione le cui quote sono espresse dalla misura della spesa con cui ciascuno concorse alla sua realizzazione, il criterio diripartizione delle spese non può che essere dettato dall'art. 1101 2^ c. c.c., norma ripresa dall'art. 1123 1^ c. c.c. non essendo applicabile il criterio dell'art. 1123 c. 2^ e 3 cod. civ., di cui l'art. 1124 c.c. è specificazione, norme queste ultime disciplinanti le spese relative agli impianti sorti contemporaneamente alla costruzione dell'edificio condominiale; b) il riparto delle spese in base all'uso differenziato ex art. 1123 2 c.c. civ. NON sia applicabile alle spese generali; c) il regolamento condominiale prescinda da qualsiasi determinazione dei "valori di piano" C quindi non sia possibile ripartire le suddette spese, senza la previa determinazione dei "valori di piano"da effettuarsi ex novo con criteri oggettivi, predeterminati e condivisi da tutti i condomini interessati. Il ricorso è infondato. Non merita, infatti, alcuna censura la decisione della Corte d'appello che, in conformità alla dottrina e giurisprudenza prevalente e consolidata, ha ritenuto legittimo il criterio di ripartizione delle spese di conservazione e manutenzione dell'ascensore, approvato con la delibera 12.10.89, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1124 Cod. Civ., per la ripartizione delle spese relative alle scale; norma ritenuta applicabile in via analogica, in virtù della medesima ratio, alla fattispecie avente ad oggetto l'ascensore, per la cui disciplina manca una specifica norma. Non derogando, inoltre, l'art. 1124 C. Civ. ai criteri generali previsti dall'art. 1123 C. Civ., (il valore e l'utilità); ed incidendo sulle spese di manutenzione il logorio dell'impianto, (maggiore in funzione dell'altezza dei piani), del tutto legittima deve ritenersi la delibera assembleare, in mancanza, come specificato dalla stessa Corte di appello, di criteri convenzionali che deroghino a quelli stabiliti dalle legge. Il rilievo, poi, secondo il quale il criterio di ripartizione delle spese di cui all'art. 1224 C. Civ., sarebbe applicabile solo nell'ipotesi in cui l'ascensore fosse stato installato originariamente con la costruzione dell'edificio, e non, invece, quando, come nella specie, sia stato installato in un secondo tempo, è affermazione dei 253 ricorrenti che prescinde dall'accertamento di fatto di cui in sentenza, dal quale si evince che l'installazione dell'ascensore, fu sì successiva alla costruzione dell'edificio, ma avvenne con il consenso di tutti i condomini, sia pure con il contributo finanziario differenziato degli stessi. Ciò comporta: la proprietà comune condominiale dell'impianto, già considerato tale ai sensi dell'art. 1117 N. 3 Cod. Civ., in mancanza di titolo contrario; nonchè, ai sensi dell'art. 1118 C. Civ., il diritto di ciascun condominio sullo stesso, proporzionato al valore del piano o porzione di piano di proprietà esclusiva. Ne consegue, con riferimento alla ripartizione delle spese, l'applicabilità alla fattispecie dei criteri previsti dall'art. 1123 C. Civ., dei quali la disciplina stabilita dall'art. 1124 c.c., è una specifica applicazione, come precisata correttamente nella sentenza impugnata. Erra, pertanto, il ricorrente nel ritenere applicabile alla fattispecie l'art. 1101 2 c. Cod. Civ., dal momento che, essendo stato l'ascensore installato con il consenso e la spesa di tutti i condomini, la comproprietà sullo stesso è comune a tutti i condomini, a nulla rilevando a tal fine il differente contributo finanziario degli stessi, contributo che ove accertato, per ciascun condomino di entità maggiore della quota di comproprietà non può che dar luogo ad un diritto di credito del singolo, verso il condominio. Lo stesso, comunque, è a dirsi anche in relazione alla ritenuta (dai ricorrenti) applicabilità dell'art. 1101 2^ c. Cod. Civ., considerato che, nella comunione le quote di comproprietà, in mancanza di titolo contrario, si presumono uguali, e coloro che hanno pagato in più, possono vantare solo un credito verso gli altri comunisti. Infondato è, infine, il rilievo sub c) del motivo in esame, dal momento che, come la giurisprudenza di questa Corta ha affermato (v. sentt. 6202/98; 431/90; 5794/83), l'esistenza della tabella millesimale non costituisce requisito di validità delle delibere assembleari, dato che il criterio per la determinazione delle singole quote preesiste alle tabelle, derivando dal rapporto tra il valore dell'intero edificio e quello della proprietà singola; rapporto che, nella specie come indicato dalla Corte d'appello, è stato di fatto determinato ed applicato. Il ricorso va, quindi, respinto. Segue alla soccombenza la condanna dei ricorrenti al pagamento in favore della controparte, delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle controparti, spese liquidate in E. 100,00 oltre E. 1000,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 30 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2005. PRELIMINARE CON RISERVA DI USUFRUTTO TRACCIA: Tizio, di oltre novanta anni, stipulava un contratto preliminare con Caio, avente ad oggetto il trasferimento della villa Tuscolana, con riserva di usufrutto a favore del venditore, dietro corrispettivo pari ad euro 100.000.000,oo. 254 In particolare, il preliminare prevedeva la stipula del definitivo entro i successivi dieci mesi. Accadeva, purtroppo, che l’anziano Tizio moriva, prima di poter addivenire alla stipula del contratto definitivo. Caio si recava dal legale Sempronio, per avere informazioni circa gli eventuali strumenti di tutela sussistenti. Il candidato, assunte le vesti del legale Sempronio, rediga motivato parere sulla questione giuridica prospettata. POSSIBILE SCHEMA DI SOLUZIONE. In premessa era utile ricostruire sinteticamente il fatto. Il problema posto dalla traccia era essenzialmente quello di capire la sorte del contratto preliminare con riserva di usufrutto a favore del venditore (Tizio), nell’ipotesi in cui quest’ultimo muoia prima della stipula del contratto definitivo. Più in particolare, è applicabile anche al caso prospettato la tutela prevista ex art. 2932 c.c., al fine di ottenere una sentenza idonea a produrre gli effetti del contratto non concluso? Secondo un’impostazione della dottrina (più datata) il problema andrebbe risolto in termini negativi, con la conseguenza di ritenere inapplicabile l’art. 2932 c.c. al caso di specie, in quanto, si dice, la morte del promittente venditore con riserva di usufrutto modifica, nella sostanza, l’oggetto del contratto, in quanto non potrebbe essere venduto il bene con riserva di usufrutto (nuda proprietà), quanto piuttosto il bene con tutti i suoi diritti;l’art. 2932 c.c. richiede che il trasferimento sia possibile e, si dice, nel caso di morte del promittente venditore con riserva di usufrutto il trasferimento non sarebbe possibile, perché vi sarebbe una modifica dell’oggetto, da nuda proprietà a piena proprietà (si pensi anche al problema della necessità di modificare il prezzo pattuito, in considerazione del “valore aggiunto”, e non previsto al momento della stipula del preliminare, del bene villa Tuscolana). In questo senso, allora, emergerebbe la figura dell’impossibilità sopravvenuta, ex art. 1256 c.c., idonea ad estinguere l’obbligazione assunta con il preliminare (accogliendo la tesi del contratto preliminare come negozio giuridico obbligatorio ad effetti reali differiti nel tempo). Secondo altra impostazione (più recente), invece, il problema posto andrebbe risolto in termini positivi, con la conseguenza applicativa che Caio potrebbe agire ex art. 2932 c.c. Sotto tale profilo, si dice, non bisognerebbe tanto tenere presente l’oggetto contrattuale in modo rigoroso, quanto piuttosto la volontà del promittente alienante con riserva di usufrutto (Tizio), che verosimilmente, in base alla fattispecie negoziale scelta, voleva in concreto trasferire la piena proprietà all’acquirente (si ricorda che alla morte dell’usufruttuario, l’usufrutto si estende alla proprietà, per cui, comunque, Caio sarebbe divenuto titolare della piena proprietà), seppur in un momento successivo a quello della stipula del definitivo. Inoltre, nessuna norma impedirebbe di modificare parzialmente l’oggetto contrattuale ai fini dell’azione di cui all’ art. 2932 c.c., tanto più se, comunque, si riuscisse a rispettare la volontà del promittente alienante con riserva di proprietà (Tizio). In questo senso, allora, il giudice potrebbe modificare o integrare parzialmente l’oggetto contrattuale, con la conseguenza che Caio ben potrà esperire l’azione di cui all’art. 2932 c.c. 255 Tale ricostruzione più favorevole a Caio, d’altronde, sembra più coerente con lo spirito dell’art. 1367 c.c. (conservazione del contratto), nonché con i principi generali in tema di testamento (che, in qualche modo, richiedono sempre di tenere presente la volontà del de cuius), estensibili (seppur con alcuni limiti), secondo alcuni, anche ai contratti inter vivos. Si consiglia di leggere il contributo giuridico di seguito indicato a firma di Francesco Gazzoni. Il contratto preliminare di vendita (estratto dal Trattato di diritto privato, Giappichelli) Francesco Gazzoni (......)Il legislatore, prevedendo all'art. 2645 bis del codice civile la trascrivibilità del contratto preliminare (anche) di vendita, ha preso atto, codificandola, di una realtà commerciale dominata dall'idea che la stipula del preliminare vale vendita obbligatoria. Del resto la stessa giurisprudenza, ha, negli ultimi anni, sempre più decisamente imboccato la strada della svalutazione del definitivo. Il preliminare, infatti, è considerato non più mero contratto che obbliga a contrarre, ma fonte degli effetti e dei diritti ed obblighi finali, con un sostanziale riavvicinamento all'idea francese secondo cui la promessa di vendita, vale vendita, temperata dalla necessità di riconoscere al definitivo il ruolo di modus adquirendi. Questo orientamento emerge netto se si considerano le questioni che sono sorte in materia di preliminare di compravendita. a) Il primo problema, in verità di carattere generale, è quello di stabilire il rapporto intercorrente tra preliminare e definitivo. Secondo l'impostazione più tradizionale, non abbandonata nemmeno da chi rivaluta il preliminare solo in funzione della sentenza, il preliminare può fornire elementi per interpretare il definitivo sul piano della natura e dell'oggetto. Esso non rileva invece per quanto riguarda le singole pattuizioni e questo perché il definitivo assorbe in sé quelle preliminari, togliendo loro ogni efficacia negoziale. E ciò vale anche quando intervengano modifiche. Si porta in tal modo alle estreme conseguenze l'idea del doppio contratto, di cui il primo solo strumentale al secondo, cosicché, in caso di divergenza, il secondo non potrebbe non prevalere, senza possibilità di indagare in ordine alla effettiva volontà dei contraenti di modificare i patti. Senonché è lo stesso rapporto che lega il preliminare al definitivo che va riconsiderato. Se il definitivo "ha sempre più la funzione di un formulario 256 astratto", può ben procedersi ad un accostamento all'ipotesi di definitivo per scrittura privata seguito da ripetizione notarile, cosicché la prospettiva si inverte, perché è al primo contratto che dovrà aversi riguardo. La volontà di modifica dovrà allora essere positivamente provata sia in caso di sequenza preliminaredefinitivo, sia di ripetizione negoziale, solo potendosi discutere se in quest'ultimo caso non debba accentuarsi la presunzione di immodificabilità o, anche in caso di preliminare, non sia vero che i mutamenti del testo definitivo rispetto a quello preliminare debbano essere considerati come mere puntualizzazioni piuttosto che come modifiche e, parimenti, non possa darsi per scontato che, in ogni caso, le clausole del preliminare non riprodotte si debbano intendere espunte. Dunque alle parti di un contratto preliminare, in virtù del principio di autonomia contrattuale, è bensì possibile, in sede di stipula del definitivo, modificare gli accordi, ma tale modifica non è implicitamente deducibile dalla mancata conformità di contenuto del definitivo al preliminare. Ne consegue che se, ad esempio, il preliminare prevede la vendita di una pluralità di beni, il definitivo che abbia avuto ad oggetto solo alcuni di essi rileva solo come adempimento parziale e non elimina l'obbligo di adempiere il preliminare per la restante parte, salvo che sia data la positiva prova di una volontà modificatrice. In buona sostanza, dunque, tutto si gioca in termini di prova, perché è la volontà di modifica che va provata e non già la volontà di non ritenere esaurito il vigore del preliminare. Per giungere a questa conclusione è però necessario ammettere che il preliminare, nella realtà delle contrattazioni "non ha nulla a che vedere con quella costruzione astratta, di dubbia legittimità logico-giuridica, che il legislatore del 1941 [sic!] ritenne di rispecchiare nell'art. 1351". Infatti i c.d. contratti preliminari, nella pratica, "sono comuni contratti con i quali le parti, nel regolare i propri rapporti, inerenti nella maggior parte dei casi a una compravendita, graduano nel tempo le reciproche prestazioni, per ragioni di bilanciamento e di garanzie e in particolare differiscono l'effetto traslativo della proprietà". Pertanto il definitivo è bensì lo strumento offerto dall'ordinamento per attuare quell'effetto traslativo, ma ciò non toglie che la sua stipula "sia nient'altro che un puro e semplice adempimento delle obbligazioni assunte con il c.d. preliminare, che resta l'unico e vero regolamento contrattuale dei rapporti; lo stesso art. 2932 c.c. è una conferma indiretta, ma sicura, di questo assetto". Questa drastica qualificazione dei rapporti preliminare-definitivo, un tempo contenuta nel corpo delle motivazioni, figura ora in qualche massima. Naturalmente quanto fin qui osservato vale per il caso in cui la volontà modificatrice non emerga con evidenza dal modo in cui le parti formulano il definitivo: ad esempio, quando si modifica l'oggetto del preliminare o si sostituisce il pagamento del prezzo con la dazione di un bene, configurandosi così una permuta. In questi casi, sempre che ricorra l'expressio causae, il definitivo ha senza dubbio natura contrattuale e va qualificato come contratto modificativo-estintivo del tipo datio in solutum, con ogni conseguenza quanto alla sua disciplina, in specie sul piano della causa solvendi, pur sempre ricorrente, con possibile applicazione, se del caso, dell'art. 1197, c. 2°. 257 b) Il secondo problema è quello del modo in cui va eseguito il preliminare di vendita ad effetti obbligatori. Va subito ribadito che dovrebbe più propriamente parlarsi di preliminare di vendita ad efficacia reale differita, cosicché non può di certo accostarsi questa fattispecie a quella del preliminare di contratto ad effetti obbligatori, di cui può discutersi l'utilità [infra § 9]. Ove si applicassero le regole, tradizionalmente elaborate, dell'obbligo a contrarre, il preliminare in tal caso dovrebbe essere adempiuto con la stipula di un definitivo di vendita obbligatoria. Ma così non è. Salvo che risulti un'espressa volontà dei contraenti in tal senso, si presume che l'adempimento del preliminare debba avvenire solo se e quando sia possibile concludere una vendita immediatamente traslativa. Dal preliminare nasce dunque in tal caso a carico del promittente alienante l'obbligo di far conseguire al promittente acquirente la proprietà della cosa, nasce cioè un obbligo di dare, al quale sono strumentali la nascita e l'adempimento degli obblighi necessari a questo fine. Ciò significa che vi è bensì diversità tra preliminare di vendita e vendita, ma non già sul piano obbligatorio, quanto dal punto di vista del solo modus adquirendi che, in caso di vendita, coincide con il titulus, mentre in caso di preliminare si identifica con il definitivo, secondo il modello romanistico. Il promittente alienante dovrà dunque - al pari del venditore - procedere alla individuazione della cosa generica, far sì che la cosa futura venga ad esistenza o che la cosa altrui sia acquistata dal promittente acquirente. In particolare l'acquisto di cosa altrui può essere assicurato sia acquistando il bene dal proprietario per poi rivenderlo alla controparte, sia inducendo il proprietario a consentire al trasferimento della proprietà, cosicché il preliminare sarà egualmente adempiuto con la conclusione di un contratto di vendita direttamente tra il promittente acquirente e il terzo. Il contratto definitivo, a questo punto, scompare in quanto tale, essendo intervenuto tra soggetti parzialmente diversi, anche se permane un nesso di interdipendenza, in virtù del quale l'obbligo di dare a carico del promittente alienante di cosa altrui si estingue, ma, ad esempio, non si estingue la garanzia per l'evizione, né quella per i vizi, per gli oneri e per la libertà dell'immobile da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli da lui assunta nel preliminare. Infatti il promittente acquirente, a conoscenza dell'altruità del bene, non potrebbe rifiutarsi di acquistare dal terzo, onde se, viceversa, ignorando l'altruità, egli, anziché risolvere il preliminare, contraesse con il terzo, lo farebbe liberamente, e allora, salvo espressa riserva nell'atto di acquisto, non potrebbe poi agire contro il promittente venditore. Non sembra pertanto dubbio che, alla luce di questi orientamenti, il preliminare di vendita sia considerato alla stregua di una vendita obbligatoria. c) La giurisprudenza è stata ed è all'avanguardia nella rivalutazione del preliminare come fonte degli effetti, anche per quanto riguarda il problema dei vizi, degli oneri ex art. 1489 e delle difformità della cosa promessa in vendita, che possono condurre ad una revisione del contratto, quale esito risarcitorio, a tutela del promittente acquirente. 258 Un tempo, quando al preliminare, anche di compravendita, si ricollegava un mero obbligo di fare, i rimedi contro vizi e difformità conseguivano necessariamente alla stipula del definitivo, essendo essi posti a tutela di chi ha già acquistato la proprietà. Si riconosceva al promittente acquirente solo il potere di chiedere la risoluzione del preliminare o di rifiutarsi di stipulare il definitivo. Che se poi il definitivo fosse stato stipulato, i rimedi erano discutibili, perché se i vizi si erano manifestati prima della stipula non erano più occulti. Si cominciò poi a distinguere l'ipotesi in cui le parti avevano anticipato l'esecuzione di una o di entrambe le prestazioni finali, pagando il prezzo e consegnando la cosa. Si elaborò pertanto la categoria del preliminare ad effetti anticipati, che si riteneva avesse diritto ad una disciplina particolare, dovendo, all'anticipata esecuzione delle prestazioni, corrispondere un'anticipata tutela del promittente acquirente in punto di eccezione di inadempimento e poi di azione volta ad ottenere la riduzione del prezzo o l'eliminazione dei vizi. Tale impostazione è ancora attuale. Il successo della nuova categoria contrattuale è dovuta a ciò, che essa permette di differenziare nettamente questa ipotesi da quella del contratto preliminare tradizionalmente inteso, che non prevede alcuna anticipata esecuzione. Di qui la possibilità di salvare i principi, ma nel contempo di venire incontro alle esigenze poste dai commerci, giungendo ad ipotizzare un preliminare atipico o complesso, ben distinto da quello c.d. puro. Dottrina e giurisprudenza riconoscono che in tale ipotesi può parlarsi di vendita obbligatoria, con il definitivo che svolge il ruolo di modus adquirendi, mentre il preliminare c.d. puro manterrebbe la sua tradizionale configurazione: nel primo caso, dunque, vi sarebbe un obbligo di dare, nel secondo un obbligo di fare. Senonché, con una decisione che, nella evoluzione concettuale del preliminare, ben può definirsi storica, le Sezioni Unite sono intervenute nel dibattito, spesso confuso e contraddittorio, negando rilievo alla distinzione ed affermando che qualsivoglia preliminare di vendita, con o senza effetti anticipati, dà luogo alla stessa intensa protezione in favore del promittente acquirente, tanto più in quanto si deve assicurare che l'interesse di costui alla sostanziale conservazione degli impegni assunti, non sia eluso da fatti ascrivibili al promittente alienante. Se dunque, in caso di effetti anticipati, la tutela dovrebbe riguardare esclusivamente l'assetto pattizio voluto dalle parti, cioè il rapporto intermedio tra preliminare e definitivo, che ha scopo di garanzia connessa con la progressiva attuazione delle varie fasi in cui si svolge l'affare, e non il preliminare in sé e per sé ed il rapporto che ad esso consegue in termini di facere, la svolta nella direzione di un ampliamento della tutela, a prescindere dal rapporto intermedio, non può che passare attraverso una ridefinizione del rapporto che nasce dal preliminare. Già in termini di logica giuridica è assurdo "che per far valere ragioni per le quali il contratto definitivo dovrebbe risolversi o modificarsi, si debba necessariamente prima stipularlo". Sul piano ricostruttivo, poi, deve riconoscersi che il rapporto giuridico che nasce dal preliminare è preparatorio degli effetti finali, perché "il 259 definitivo è parte integrante comunque del preliminare e non viceversa" essendo atto di adempimento dell'obbligo che dal preliminare nasce. Le Sezioni Unite, dunque, hanno affermato che la sentenza ex art. 2932 offre un rimedio contro il rifiuto di contrarre "ma non esaurisce la tutela contro l'inadempimento", che è affidata all'azione risarcitoria ex art. 1218, di cui quella volta alla riduzione del prezzo, in caso di vizi e difformità, è espressione. La prestazione dovuta dal promittente alienante "non si riduce all'elemento formale della prestazione del consenso, ma implica nella sostanza il trasferimento di quel determinato bene nella consistenza e con le caratteristiche fissate nel preliminare". Pertanto non può parlarsi di specifica garanzia in favore del compratore, ma di normale conseguenza del fatto che l'offerta da parte del promittente venditore di un bene che presenti difformità o vizi "viola il sostanziale impegno traslativo dello stesso promittente ed abilita la controparte ad utilizzare tutti i rimedi concessi dalle norme generali in tema di adempimento". Non è chi non veda come, in buona sostanza, l'inadempimento così ipotizzato riguardi essenzialmente un obbligo di dare, a conferma del fatto che si è in presenza di una vendita obbligatoria e di un sistema "diretto a garantire al "creditore" di un bene - e non solo al "proprietario" - il raggiungimento del bene e non solamente il surrogato del risarcimento del danno". Può allora ben dirsi che, con il preliminare, le parti "si promettono "prestazioni" più che "consensi"" e che "lo stesso preliminare non si può distinguere da un definitivo ad effetti più o meno parzialmente differiti". Non si tratta però di applicare in via analogica o diretta le norme sulla tutela dell'acquirente, quanto piuttosto di dare spazio al rimedio risarcitorio di carattere generale. Infatti non vengono in questione gli artt. 1495 e 1497 per la garanzia dei vizi. È dunque possibile, ad esempio, avvalersi degli artt. 1460 e 1461, mentre il promittente acquirente può rifiutarsi di adempiere, cioè di concludere il definitivo, ogni qualvolta sia ravvisabile, da parte del promittente alienante, un adempimento inesatto, configurabile quando egli intenda trasferire in proprietà il bene promesso, benché esso sia quantitativamente o qualitativamente diverso, per fatti pregressi o sopravvenuti. Così è in caso di difetto di certificato di abitabilità o di agibilità o di conformità alla concessione edilizia, pur se il mancato rilascio dipenda da inerzia del Comune o di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, quale sarebbe quella di un pignoramento. Il promittente acquirente può però cautelarsi anche in sede di giudizio ex art. 2932, perché la sentenza potrà, ad esempio, condizionare il pagamento del prezzo all'estinzione, da parte del promittente venditore, della garanzia o del vincolo, mentre non potrà condannarlo a liberare la cosa da pesi di carattere reale da cui fosse gravata, trattandosi di un facere infungibile. Si risolve così agevolmente anche il problema della possibilità di ottenere la condanna del promittente venditore ad eliminare a propria cura e spese i vizi o i difetti della cosa. In termini di applicazione della disciplina della vendita l'azione 260 potrebbe essere ritenuta inammissibile, almeno se si resta ancorati all'idea che dalla vendita stessa non possa nascere un facere, ma solo un dare, ed infatti in tal senso è orientata qualche pronuncia della Suprema Corte. Ma se si riconosce che l'azione per l'esatto adempimento è ammissibile nel quadro più generale della tutela del contraente adempiente, non vi sono ostacoli per un'applicazione del principio anche in caso di preliminare, a prescindere dalla consegna anticipata. Una tale pronuncia è infatti l'alternativa alla risoluzione, avuto riguardo alla prestazione dovuta che, come già osservato, è preparatoria rispetto all'esatto adempimento di quella finale e quindi su di essa si modella. Deve dunque riconoscersi che l'obbligazione del promittente venditore è "ad ampio spettro [perché] include qualunque prestazione (anche di "fare") necessaria ad assicurare la realizzazione di un risultato traslativo finale perfettamente conforme - anche sotto il profilo qualitativo - a quello programmato". Del resto anche in tal caso la fattispecie potrebbe essere ricostruita come compensazione tra il debito da prezzo e il credito da spese sostenute ex art. 612614 c.p.c., cosicché si giungerebbe, indirettamente, ad un risultato corrispondente ad una riduzione del prezzo stesso. Se si assume questa prospettiva ben si comprende perché il promissario acquirente possa agire anche nelle more della stipula del definitivo, senza necessariamente dover cumulare l'azione di riduzione del prezzo o di esatto adempimento con quella ex art. 2932, quasi che presupposto ne fosse il previo acquisto della proprietà. L'unico limite è costituito dal fatto che il bene venga ad esistenza, se futuro, o comunque sia offerto con vizi, oneri o difformità tali da renderlo oggettivamente diverso per struttura e funzione rispetto a quello promesso, sia, cioè, qualificabile alla stregua di un aliud pro alio. Vizi, oneri o difformità devono dunque eventualmente incidere solo sul valore o su secondarie modalità di godimento. Così in caso di preliminare di permuta di bene presente con bene futuro, se tale bene è poi costruito con una superficie superiore a quella prestabilita, è egualmente possibile pronunciare la sentenza costitutiva, con condanna a versare un conguaglio di prezzo. Ciò spiega oltre tutto perché il giudice può pronunciare ex art. 2932 una sentenza non pedissequamente ricalcata sul preliminare. La fissazione di un prezzo ridotto per la cosa promessa in vendita è infatti l'esito di un inadempimento ed è quindi volta a dare attuazione alla volontà delle parti così come essa si era effettivamente formata e avrebbe dovuto essere osservata. Il promittente venditore non può dunque trincerarsi dietro il proprio inadempimento per invocare una pretesa impossibilità di pronunciare la sentenza traslativa. L'azione risarcitoria, pur se autonoma e distinta rispetto a quelle poste a tutela dell'acquirente, ne condivide peraltro la sostanza disciplinare e quindi gli stessi presupposti di fatto. Pertanto, iniziata dal promittente acquirente azione risarcitoria per vizi della cosa nei confronti del promittente venditore-costruttore, ove, nelle more del giudizio, intervenga la stipula del definitivo "nulla vieta che tale azione, volta sostanzialmente al puntuale adempimento dell'obbligazione 261 assunta dalla controparte, sia inquadrata, dopo la stipula della compravendita, nell'ambito dell'art. 1669 c.c.". Ci si può infine domandare se l'inquadramento dei rapporti tra preliminare e definitivo in termini di impegno traslativo sia in grado di chiarire la situazione giuridica soggettiva di cui è titolare il promittente acquirente, il quale sia stato immesso anticipatamente nel godimento dell'immobile. È bene precisare che tale immissione non giustifica causalmente l'eventale anticipazione del prezzo, non essendo l'una in funzione dell'altra. L'anticipazione, infatti, va valutata in sé e per sé, in termini di sostanziale maggiorazione del prezzo, onde non può parlarsi di pattuizione gratuita, quando ad essa non corrisponda l'immissione, né sarebbe necessario indagare circa la presenza, a pena di invalidità, di un interesse patrimoniale del promittente acquirente alla anticipazione senza immissione, essendo esso in re ipsa. L'affare, infatti, si identifica, per lui, con la conclusione del preliminare a quelle condizioni e non già con l'immissione anticipata. Ciò premesso, quando c'è immissione, talvolta le parti regolano il rapporto come una locazione a termine. Essa, secondo la giurisprudenza, darebbe vita, in uno con il preliminare, ad un contratto misto cui, tra l'altro, non era, all'epoca della sua vigenza, applicabile la legge sull'equo canone. Nel silenzio delle parti il problema è invece quello di stabilire se il promittente acquirente sia possessore. Naturalmente non basta la consegna per tale qualifica. Innanzi tutto l'obbligo di consegna derivante dal definitivo, non può dirsi consumato, con immissione nel possesso, ove la consegna stessa sia bensì anticipata, ma dovuta ad esigenze temporanee del promittente acquirente ed abbia perciò il carattere della precarietà. In secondo luogo la consegna è atto di per sé neutro, dal quale, dunque, non può desumersi se l'accipiens possa, esercitando il potere di fatto, divenire possessore o resti mero detentore della cosa. La dottrina è oscillante, al pari della giurisprudenza, la quale talvolta definisce il promittente acquirente detentore qualificato, con inapplicabilità dell'art. 1148, ma con possibilità di agire con l'azione inibitoria ex art. 844, altre volte parla di possesso, con conseguente possibile usucapione. In verità il problema è quello non già della consegna, ma del titolo che ad essa si accompagna e che deve, secondo i principi generali, avere efficacia reale per potersi configurare l'esercizio di un potere di fatto a titolo esclusivo in capo all'accipiens, conseguendo ad un titolo ad effetti obbligatori la mera detenzione, diversamente da quanto accadeva nel diritto romano classico, là dove la vendita obbligatoria trasferiva il possesso, assistito peraltro dall'obbligo, a carico del tradens, di garanzia per l'evizione. Al fine di giustificare la situazione possessoria ci si affida allora ad una anticipazione della rilevanza del definitivo come titolo, posto che di esso si anticiperebbero gli effetti. In tal modo si postula però una mera virtualità, che non sembra idonea a sorreggere la consegna, la quale deve essere preceduta da un accordo, magari viziato, ma pur sempre atto a manifestare, da un lato, la volontà 262 del tradens di dismettere la proprietà e quindi il possesso della cosa, e, dall'altro, la volontà dell'accipiens di iniziare ad esercitare il potere di fatto sulla cosa stessa. Ecco perché l'accordo si identifica con un contratto ad effetti reali ex art. 1376, che però deve precedere e non già seguire la consegna, ed ecco perché non è ipotizzabile un contratto atipico traslativo del puro e semplice possesso, che, quale situazione di fatto e non di diritto, non può circolare. Deve pertanto aversi riguardo al preliminare. Esso, precedendo la consegna, dovrebbe giustificare la dismissione e il correlativo inizio dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa. Senza dubbio il preliminare non è in grado di sorreggere la situazione possessoria se ad esso si ricolleghino puramente e semplicemente effetti obbligatori di fare, cosicché è necessario assumere il punto di vista di chi nega che il c.d. definitivo sia un contratto e valorizza il preliminare, spostando su di esso e sul relativo accordo iniziale l'onere di giustificare l'intera operazione traslativa. Se il definitivo va considerato alla stregua di un fatto che avvera la condizione apposta al preliminare o ha la funzione di rendere definitivi i suoi effetti, vi sarà un solo contratto e dunque un solo titolo, idoneo, come tale, a giustificare l'inizio dell'esercizio del possesso da parte del promittente acquirente. Si determinerebbe così una situazione analoga, per taluni versi, a quella della vendita con riserva di proprietà, là dove l'acquirente è possessore fin dalla consegna, in virtù, appunto, della idoneità del titolo iniziale a produrre gli effetti giuridici finali, ovvero, in altra prospettiva, a dar vita ad un'aspettativa reale in capo all'acquirente-debitore. L'accostamento è anche possibile ove il preliminare sia ricostruito in chiave di "contrattazione reale", perché il possesso conseguirebbe al trasferimento della proprietà inter partes, o di titolo attributivo di un ius ad rem in capo al promittente acquirente, con conseguente possibilità, ad esempio, di ottenere il sequestro giudiziale nel corso del giudizio ex art. 2932. In questa prospettiva ben si colloca l'idea del preliminare di vendita quale vendita obbligatoria, da cui nasce un obbligo di dare. È vero che l'effetto traslativo consegue al modus adquirendi e non al titulus, ma è anche vero che, per quel che già è stato chiarito, si è in presenza di un atto solutorio non negoziale, che carica il preliminare quale titolo di una forza tutta particolare, anche se non decisiva, almeno se autonomamente considerato. Non basta però osservare che il titolo preliminare "tende a realizzare il trasferimento della proprietà del bene". È vero che nell'ordinamento austriaco, in cui vige il sistema della scissione tra titulus e modus adquirendi, la traditio della cosa immobile prima dell'intavolazione, secondo taluni, attribuirebbe all'accipiens un'azione petitoria analoga a quella pubbliciana, nonché un'exceptio rei venditae et traditae nei confronti di chi abbia acquistato dall'alienante, ma pur non considerando che né la proprietà bonitaria o naturale, né l'actio pubbliciana sono state accolte nel nostro ordinamento anche là dove ancora vige il sistema dell'intavolazione, resta il fatto che, a prescindere dalla rilevanza che avrà a posteriori il titolo preliminare, la pur meno intensa tutela possessoria deve 263 misurarsi con una vicenda ancora in itinere sul piano della creazione del modus adquirendi, non potendo l'anticipazione della consegna significare anticipazione della rilevanza del modus stesso, almeno a prescindere da ulteriori manifestazioni di volontà. Ciò non toglie che la sequenza titulus-modus è la stessa che si ravvisa nell'ipotesi di proprietà fiduciaria, là dove il fiduciario gestisce il bene in nome proprio, ma per conto altrui, al pari del promittente alienante al quale incombe un dovere di custodia, che "implica il vincolo a tenere condotte che sono l'opposto della autonomia proprietaria, non solo perché il custode non può alterare lo stato giuridico e materiale del bene, ma perché orienta il proprio agire all'interesse altrui anziché al conseguimento del proprio". Da questo punto di vista è dunque rilevante accertare se il promittente acquirente riconosce o non riconosce l'altruità del bene goduto, ed allora, sotto questo aspetto, quando l'intero prezzo è stato corrisposto e solo manca il modus adquirendi, è difficile negare che egli sia "legittimato a godere ad modum domini della cosa", in virtù di un rapporto "che non si riduce alla figura di un rapporto personale di godimento, ma inquadra in sé il momento del godimento [e] presiede lo svolgimento del programma contrattuale". Viceversa quando il prezzo non è stato ancora versato, l'animus rem sibi habendi non è configurabile, perché il diritto all'acquisto è subordinato a tale adempimento anche in caso di esecuzione forzata (art. 2932 capoverso). Non può allora dirsi che l'obbligo della restituzione sia legato alla sola ipotesi di risoluzione consensuale, per affermare la situazione possessoria. Se poi le parti hanno previsto che il prezzo sia pagato dopo il trasferimento della proprietà, al definitivo consegue l'iscrizione di ipoteca legale, che è in grado di garantire il venditore, al pari, in caso di esecuzione forzata, della sentenza soggetta a condizione [infra § 17], mentre nella fase preliminare l'unica garanzia ipotizzabile, in caso di consegna anticipata con rinvio del pagamento del prezzo, è proprio quella di mantenere in capo al promittente venditore il possesso della cosa. In conclusione, laddove in caso di impossessamento mediante consegna prevale il titulus e in caso di apprensione unilaterale prevale l'animus, nel caso di preliminare di vendita, oltre al titulus è anche necessario che si esaurisca il contegno esecutivo finale, perché allora può configurarsi una sorta di interversione, idonea a definire in termini possessori una vicenda che, in virtù della sola consegna, manterrebbe in capo al tradens, in presenza di un titolo solo virtualmente traslativo, il potere di fatto sulla cosa, esercitato tramite il terzo detentore. L'avvenuto o non avvenuto pagamento del prezzo a fronte del godimento del bene pone poi il problema dell'applicabilità dell'art. 1499. Certamente se il prezzo è stato versato anticipatamente il problema non nasce. Altrimenti, la risposta negativa discende secondo taluni dalla eccezionalità della norma, insuscettibile di applicazione analogica, e dal fatto che non possono decorrere interessi compensativi là dove il credito ancora non esiste. 264 In senso contrario, però, da un lato si nega che la norma non possa essere estesa per analogia e, dall'altro, si sottolinea che il pagamento degli interessi è correlato al vantaggio che deriva per la controparte dalla esecuzione anticipata della prestazione rispetto al tempo previsto nel contratto. Può inoltre sottolinearsi che il credito per il prezzo più che inesistente è inesigibile, in quanto già nato, ma spostato nel tempo, di regola al momento della conclusione del definitivo. È questa un'ulteriore conseguenza del costruire il preliminare di vendita come vendita obbligatoria. In tal senso può contestarsi che nel preliminare di vendita non sia già in astratto ravvisabile l'esigenza di tutelare quell'equilibrio economico tra le prestazioni, che è alla base dell'art. 1499, atteso che con tale contratto le parti non si obbligano ad un mero facere (prestare il consenso). Comunque è giusto ritenere che, in caso di risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente acquirente, costui, se vi è stata consegna anticipata, debba corrispondere al promittente alienante l'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento del bene per il tempo compreso tra la consegna e la restituzione. d) Un ultimo problema è quello di stabilire che cosa accade quando, concluso un preliminare di vendita con riserva di usufrutto, il promittente alienante muoia prima di aver stipulato il definitivo. Ci si è chiesti se gli eredi debbano concludere un definitivo di vendita dell'intera proprietà e, in difetto, possa il giudice pronunciare sentenza traslativa ex art. 2932. Identico problema nasce quando si promette di vendere la sola nuda proprietà, perché dell'usufrutto è titolare un terzo e poi costui muoia prima della stipula del definitivo. Sul piano degli astratti principi il trasferimento della proprietà piena non dovrebbe essere giammai possibile, perché nelle more della stipula del definitivo il promittente alienante della nuda proprietà è ancora proprietario pieno e questa proprietà, nel primo caso ipotizzato, si trasferisce mortis causa agli eredi, i quali non potrebbero concludere un definitivo di vendita con riserva di usufrutto, che riguarderebbe la loro persona e non più, come previsto nel preliminare, quella del de cuius, ma non potrebbero nemmeno essere costretti a trasferire l'intera proprietà, perché ciò supporrebbe un'avvenuta consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprietà ipotizzabile solo dopo la conclusione del definitivo e non già prima, quando la vicenda è a carattere obbligatorio e la scissione tra i due diritti non si è ancora verificata. Analoga considerazione vale anche quando, nella seconda ipotesi, la consolidazione avviene in favore del promittente venditore della nuda proprietà, che non potrebbe essere costretto a trasferire la piena proprietà, né potrebbe riservarsi l'usufrutto. Sotto questo aspetto, dunque, la risposta al quesito dovrebbe essere una e una sola: la risoluzione del preliminare per impossibilità sopravvenuta. È palesemente erroneo osservare, in senso contrario, che la sentenza potrebbe anche limitarsi a trasferire la nuda proprietà, cosicché "l'usufrutto estinto per morte dell'usufrutuario si sarebbe consolidato ex lege con la nuda proprietà dando così vita alla proprietà piena". Si è già detto, infatti, che l'usufrutto che il promittente 265 alienante si riserva, è destinato a costituirsi solo con la conclusione del definitivo e quindi non può estinguersi per la morte di costui, intervenuta in un momento precedente, mentre se dell'usufrutto è titolare un terzo il consolidamento avviene nelle more della stipula e quindi prima del giudizio. Senonché questa rigorosa soluzione va limitata alla sola ipotesi in cui la morte intervenga prima della scadenza del termine di adempimento del preliminare, perché se essa interviene dopo, vi sarà stato inadempimento e, in virtù del principio della perpetuatio obligationis, il rischio delle sopravvenienze potrà allora essere posto a carico dell'inadempiente e quindi anche dei suoi eredi, come accade, ad esempio, in caso di inedificabilità del fondo promesso in vendita, per modifica del piano regolatore, successiva all'inadempimento del promittente acquirente. Certo si tratta pur sempre di una interpretazione estensiva del principio, ma essa è in grado di giustificare la diversa soluzione, considerando che, ove l'adempiento fosse stato tempestivo, il consolidamento in favore del promittente acquirente della nuda proprietà si sarebbe verificato. In tal senso la sentenza altro non farebbe, trasferendo la proprietà piena, se non attuare il regolamento di interessi voluto dalle parti ed ostacolato nella sua attuazione dell'inadempimento. Come si vede si tratta della stessa ratio che giustifica gli interventi modificativi appena visti in materia di vizi o difformità della cosa promessa in vendita. Là dove non c'è inadempimento questa stessa soluzione potrebbe invece essere giustificata solo configurando, in favore del promittente acquirente, una situazione a carattere latamente reale, con totale identificazione tra preliminare di vendita e vendita pur sotto il profilo sostanziale e non già solo della tutela giudiziaria. Ma allora davvero si introdurrebbe anche in Italia il principio francese promessa di vendita, vale vendita. Se poi il preliminare è titulus adquirendi si è già osservato che nemmeno un'anticipata consegna potrebbe giustificare una protezione a carattere petitorio. D'altra parte appare alquanto arduo percorrere strade diverse. Senza dubbio il rischio per la sopravvenienza (cioè per la morte del promittente alienante o del terzo usufruttuario nelle more della stipula) può essere convenzionalmente disciplinato, ma il patto dovrebbe essere espresso, perché comporterebbe uno spostamento del regolamento contrattuale e finirebbe quindi per configurare un contenuto alternativo non desumibile in base a semplici presunzioni. In difetto di ciò non sembra possibile andare alla ricerca di criteri presuntivi basati sull'età del promittente alienante o del terzo e quindi sulla probabilità della sua morte. Chi vuole assicurarsi l'acquisto senza correre rischi può infatti pur sempre ricorrere alla vendita a termine iniziale o alla vendita per scrittura privata seguita da ripetizione per atto pubblico. Questa dovrebbe essere, d'altro canto, la soluzione da dare sul piano qualificatorio all'eventuale contratto stipulato in articulo mortis o in avanzatissima età, là dove l'evento della morte fungerebbe da termine iniziale dell'effetto reale, considerando anche che il prezzo pattuito corrisponderebbe, in concreto nel primo caso ed anche in astratto nel secondo, a quello della vendita della piena proprietà. 266 L'unica cosa certa è che l'opposta conclusione comporterebbe un adattamento del preliminare, cioè una sostanziale modificazione, e non già una sua applicazione tal quale. Quando si dice che, ove non vi sia un accordo per una diversa distribuzione dei rischi, né è configurabile una diversità della prestazione, il rischio per le sopravvenienze future "graverà sul soggetto che se lo è caricato mediante il preliminare", che dovrà quindi essere eseguito senza tener conto delle sopravvenienze stesse, si dice cosa esatta e giusta. Ma quando poi si inquadra la vicenda in questione tra quelle che, da un lato, non determinano uno spostamento della prestazione e, dall'altro, obbligano a concludere il preliminare senza mutarne le clausole, cosicché "gli eredi devono concludere il definitivo per il prezzo indicato nel preliminare", si dice cosa che non appare né esatta, né giusta. L'inesattezza è in ciò che, ammesso e non concesso che la prestazione definitiva non sia "di qualità e quantità diversa rispetto a quella promessa", resta il fatto che il preliminare non sarebbe eseguito tal quale, perché se il prezzo fissato resterebbe lo stesso, la controprestazione sarebbe diversa, con spostamento netto dell'equiibrio contrattuale. Il prezzo della vendita con riserva di usufrutto è, infatti, almeno di regola, stabilito in base a tabelle riferite a dati statistici, che verrebbero contraddetti da una morte prematura. Ed in ciò sarebbe l'ingiustizia. Del resto se è vero che il rischio futuro deve gravare sul soggetto che se lo è caricato mediante il preliminare, non si vede perché esso dovrebbe individuarsi nella eventualità di dover alienare la piena proprietà allo stesso prezzo fissato per la vendita della nuda proprietà (cioè in favore del promittente acquirente), piuttosto che di dover rinegoziare l'affare, se del caso con gli eredi, sborsando una somma più elevata, rischio questo, di certo, più plausibilmente conseguente al preliminare, atteso lo spostamento nel tempo dell'effetto reale ed il fatto che il nuovo, più elevato prezzo sarebbe congruo rispetto alla controprestazione conseguita (acquisto della piena proprietà). La giurisprudenza, per parte sua, solo in apparenza ha mutato avviso rispetto all'applicazione della norma sulla risoluzione per impossibilità sopravvenuta. Sentenze più recenti hanno infatti bensì previsto l'obbligo per gli eredi di vendere la proprietà piena, ma in entrambi i casi la morte era intervenuta non già, come nel caso deciso in precedenza, nelle more della stipula del definitivo, quanto piuttosto nel corso del giudizio ex art. 2932, cosicché al principio della perpetuatio obligationis se ne aggiungeva anche un altro e cioè quello in base al quale deve evitarsi che i tempi del processo si ripercuotano negativamente nella sfera patrimoniale dell'attore vittorioso. Di fronte a questa realtà ineccepibile non si capisce il motivo per il quale il giudice senta il bisogno di giustificare la soluzione più favorevole al promittente acquirente andando alla ricerca di ulteriori, opinabili e alquanto imprecise motivazioni, capaci solo di creare confusione e di indurre a ritenere che la soluzione stessa possa essere generalizzata(segue). 267 PATTO COMMISSORIO TRACCIA: Tizio, avendo urgente bisogno di denaro, si recava da Caio, il quale si dichiarava disposto ad erogargli 2 milioni di euro a mutuo, pretendendo garanzia ipotecaria sul fondo Tuscolano, con l’espressa convenzione che, in caso di mancanza di pagamento del credito nel termine di un biennio, la proprietà sarebbe passata automaticamente a lui. Il notaio dott. Biancus redigeva l’atto esattamente nei termini richiesti dalle parti. Il candidato, premessi brevi cenni sul patto commissorio obbligatorio, rediga motivato parere. POSSIBILE SOLUZIONE SCHEMATICA: In premessa poteva essere utile ricostruire sinteticamente il fatto. Successivamente, era necessario accennare al divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c. (lo stesso principio è presente nell’anticresi, ex art. 1963 c.c.). E’ vietato sia il patto commissorio contemporaneo, che quello successivo (stipulato dopo il sorgere del credito, in base alla seconda parte dell’art. 2744 c.c.). Secondo l’impostazione più recente, è vietato sia il patto commissorio con schema sospensivo (se il debitore non paga, il creditore diviene direttamente proprietario del bene ipotecato) che quello con schema risolutivo (il creditore diviene proprietario di un bene con l’accordo che in caso di adempimento del debitore il bene tornerà di proprietà di quest’ultimo). E’ stato ritenuto patto commissorio anche la clausola con cui il creditore, alla scadenza del termine fissato per la restituzione di una somma mutuata, vanti un diritto di opzione per l’acquisto di un immobile di proprietà del debitore per una somma prefissata. Si ritiene, di massima, che non esistano negozi giuridici vietati ex se, in quanto è sempre necessario verificare, caso per caso, se gli accordi voluti dalle parti realizzano il risultato vietato dal legislatore. Si ritiene che la ratio del divieto di patto commissorio vada individuata nella necessità di evitare un abuso da parte del creditore verso il debitore (con conseguente ingiustificato arricchimento del primo a danno del secondo), ovvero nella necessità di salvaguardare la par condicio creditorum. Si discute, poi, se sia o meno ammissibile il patto commissorio obbligatorio, figura che si realizza tutte le volte che il debitore non trasferisce immediatamente il bene al proprio creditore a garanzia dell’adempimento, ma si obbliga solamente a compiere un successivo atto di trasferimento mediante un successivo atto di alienazione in caso di inadempimento (una sorta di promessa di patto commissorio). La figura del patto commissorio obbligatorio, tuttavia, non è ammessa dalla giurisprudenza (salvo qualche rara pronuncia), in quanto sembra comunque violare la ratio sottesa al patto commissorio (arricchimento ingiustificato - abuso e vulnus alla par condicio creditorum). 268 Nel caso di specie, comunque, non emerge un patto commissorio obbligatorio, ma un patto commissorio reale con schema sospensivo, espressamente vietato dall’art. 2744 c.c. Tizio e Caio, infatti, non si accordano nel senso che in futuro (dopo l’erogazione del mutuo) si addiverrà ad un patto commissorio, ma contestualmente e con la garanzia ipotecaria si accordano realizzando un patto commissorio, con la conseguente nullità della clausola, per cui il fondo Tuscolano, anche nel caso di inadempimento di Tizio, non passerà automaticamente in proprietà di Caio. Si precisa che il patto commissorio successivo (ex art. 2744 c.c. seconda parte) è diverso da quello obbligatorio, in quanto nel primo caso vi è una garanzia ipotecaria o di pegno a cui segue, successivamente, un patto commissorio, mentre nel caso di patto commissorio obbligatorio non vi è alcuna ipoteca o pegno, ma un accordo successivo al mutuo con cui ci si accorda per l’eventuale trasferimento di un bene (da determinare). Il discorso può essere approfondito sul testo di Bianca, Il contratto, Giuffrè. Si consiglia di leggere la sentenza che segue. - Il contratto di sale and lease-back non viola necessariamente il divieto di patto commissorio. Cassazione sezione tributaria Sentenza 29/03/2006, n. 7296. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.- L'Ufficio Imposte Dirette di Gorizia accertò maggiori redditi ai fini IRPEF ed ILOR a carico della Fondisonzo S.p.A. per gli anni 1983-1986. I relativi avvisi di accertamento vennero impugnati dalla società contribuente dinanzi alla Commissione tributaria Provinciale di Gorizia, che accolse parzialmente i ricorsi. L'Ufficio propose appello solamente sul punto relativo alla deducibilità dei canoni relativi ad una operazione di lease back, operazione ritenuta dal primo giudice del tutto assimilabile, ai finì tributar!, ad una normale operazione di leasing. Il gravame venne accolto dalla Commissione tributaria regionale di Trieste. Si legge nella sentenza di secondo grado che, nel contratto atipico di lease back, «l'interesse dell'imprenditore (...) non è quello di ottenere un bene strumentale, ma quello di ottenere denaro da utilizzare per la gestione economico finanziaria, senza nel contempo privarsi del bene», cosicché l'operazione stessa sarebbe assimilabile, anche ai fini tributari, ad un finanziamento, nel quale il trasferimento del bene dall'utilizzatore-venditore al contraente assume «funzione esclusiva di garanzia di un prestito». 2.- Contro tale sentenza la società Fondisonzo propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 269 L'Amministrazione finanziaria non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo la società ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 67 del d.P.R. n. 917 del 1986 e degli artt. 1322 e 2744 c.c, si duole dell'erronea qualificazione giuridica del contratto, in quanto assimilato dal giudice di merito ad un contratto dì finanziamento con contestuale trasferimento di un bene a fini di garanzia, piuttosto che ad una vera e propria operazione di leasing. Con il secondo motivo lamenta, con riferimento all'art. 360, n. 5, c.p.c, l'inadeguatezza del percorso motivazionale attraverso il quale il giudice giunge in sostanza ad affermare che il contratto di lease back di cui si tratta sarebbe un negozio nullo per illiceità della causa, atteso che l'Amministrazione- su cui gravava il relativo onere probatorio - non aveva in alcun modo provato che si trattasse di un contratto in frode alla legge. 1.2.- I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte - dalla quale il collegio non ravvisa ragioni per discostarsi -il contratto di sale and lease-back configura un'operazione negoziale complessa - consistente nell'alienazione, da parte dì un imprenditore, di un proprio bene strumentale, la cui disponibilità egli mantiene in forza di un connesso rapporto di leasing -che non può ritenersi necessariamente preordinata, come il giudice di merito mostra di ritenere, alla finalità di finanziamento con fraudolenta elusione del divieto di patto commissorio posto dall'art. 2744 e.e, salvo che lo scopo di garanzia non assurga, in concreto, a causa del contratto, il che può ritenersi qualora risulti, da dati sintomatici ed obiettivi, che la vendita, nel quadro del rapporto volto a fornire liquidità all'impresa alienante, sia stata utilizzata solo per rafforzare la posizione del creditore-finanziatore, abusando della debolezza del debitore (Cass. 1273/05, 15178/04, 13580/04, 9944/00). 2.- La sentenza impugnata - fondata sull'erroneo assunto che nel contratto di lease-back il trasferimento del bene assuma per definizione una funzione esclusiva di garanzia di un prestito - va pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, che dovrà accertare se sussìstano, in concreto, dati sintomatici ed obiettivi dai quali risulti che la funzione di garanzia costituisca, nel caso di specie, causa esclusiva o prevalente della intervenuta cessione del bene oggetto del contratto di leasing. Il giudice di rinvio provvedere altresì sulle spese del presente procedimento. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione tributaria il 1° febbraio 2006 […omissis] 270 PRELIMIARE DI COSA ALTRUI TRACCIA: Con un contratto preliminare, Tizio si era obbligato a vendere a Caio, che aveva promesso di acquistarlo, un podere con casa colonica. Nel giorno concordato per la conclusione del contratto definitivo, Caio aveva scoperto che il promittente venditore (Tizio) non era proprietario dell’immobile che gli aveva promesso in vendita: Tizio si era presentato dinanzi al notaio dott. Ugo incaricato della stipula, munito di procura a vendere, rilasciata dagli effettivi proprietari del podere con casa colonica in questione. Caio decideva di non acquistare più, ritenendo di essere stato ingannato. Caio si recava dal legale Sandrina. Il candidato, assunte le vesti di Sandrina, rediga motivato parere sulla questione giuridica prospettata. POSSIBILE SCHEMA DI SOLUZIONE: In premessa poteva essere utile ricostruire sinteticamente il fatto. Successivamente il problema posto dalla traccia, andava inquadrato nell’ambito del contratto preliminare di cosa altrui con particolare riferimento all’ipotesi in cui il promissario acquirente (Caio, nel caso di specie) ignori l’altruità del bene. Caio potrebbe fondare una pretesa volta alla risoluzione del contratto facendo valere la buona fede del compratore, ex art. 1479 c.c., perché al momento della stipula del preliminare ignorava che il podere con casa colonica non fosse di proprietà di Tizio; l’ignoranza dell’altruità del bene, ex art. 1479 c.c., in una prospettiva di tutela della buona fede, permetterebbe a Caio di risolvere il contratto ed ottenere il risarcimento del danno, ex art. 1223 c.c. Tuttavia, di contro, è pur vero che la vendita di cosa altrui (anche applicata al preliminare) è ammessa nel nostro ordinamento, ex art. 1478 c.c., ed il promittente alienante (nella specie Tizio) può assicurare la proprietà al promissorio acquirente, attraverso la procura a vendere rilasciata dagli effettivi proprietari del bene. In termini più chiari, l’art. 1479 c.c. potrebbe non trovare applicazione nel caso di specie, in quanto Tizio, promittente alienante, ben potrebbe far acquisire il bene al promissorio acquirente (Caio) attraverso trasferimento diretto del bene dai proprietari effettivi allo stesso Caio, con la conseguenza logica-giuridica che non verrebbero integrati gli estremi applicativi dell’art. 1479 c.c.; più in particolare, l’art. 1479 c.c., ai fini della sua applicazione richiede che il promittente alienante non abbia fatto acquistare la proprietà al promissorio acquirente, diversamente dal caso de quo dove, invece, il promittente alienante permette l’acquisto del bene al promissario acquirente, seppure attraverso la vendita da parte degli effettivi proprietari (terzi, rispetto al preliminare) : non viene, cioè, integrata la dicitura “e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà”. In questo senso, allora, come sostenuto dalla giurisprudenza più recente, Caio non potrà legittimamente rifiutare l’acquisto, se non attraverso inadempimento del preliminare. 271 Sul punto si consiglia di leggere: -Gazzoni, Il contratto preliminare, Torino, 2002; pag. 162. -Serrao, Il contratto preliminare, Padova, 2002, pag. 118; -Luminoso, La compravendita, Torino, 2004, pag. 224; -Costola, Preliminare di vendita di cosa altrui, in Studium Iuris, 1/2007, pag. 97. Si consiglia di leggere le sentenze che seguono. -Preliminare di cosa altrui: il promissario acquirente, laddove venga a sapere che il bene oggetto di trasferimento non sia del promittente alienante, non può legittimamente rifiutare l'acquisto. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILE SENTENZA 18 maggio 2006, n. 11624 (Presidente Carbone – Relatore Bucciante) Svolgimento del processo Con sentenza del 18 marzo 1998 il Tribunale di Pistoia ha Pronunciato la risoluzione, per inadempimento di Mirella P., di un contratto preliminare con il quale costei si era obbligata a vendere a Wladimiro L. e Teresa V. un podere con casa colonica sito in Larciano, e ha condannato la promittente alienante alla restituzione degli acconti ricevuti, nella misura di lire 17.000.000, nonché al rimborso delle spese di giudizio. Impugnata in via principale da Wladimiro L. e Teresa V., incidentalmente da Mirella P., la decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Firenze, che con sentenza del 21 marzo 2000, in parziale accoglimento di entrambi i gravami, ha dichiarato il contratto risolto per inadempimento del L. e della V., ha rideterminato in lire 16.000.000 la somma che doveva essere loro rimborsata, ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento di danni formulata dalla P., ha posto a carico degli appellanti principali metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio, compensandole tra le parti per l’altra metà. A queste pronunce il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo: che «unica ragione della mancata stipula va ? ricondotta alla mancata proprietà del bene da parte della promittente venditrice, ma appare pacifico che in realtà anche tale questione era stata risolta precedentemente (il che assorbe ogni rilievo relativo all’effettiva conoscenza di tale altruità da parte dei L.) essendosi la P. presentata munita di procura a vendere del tutto rituale, relativa al bene de quo e rilasciata dai proprietari due giorni prima e davanti allo stesso notaio»; che «è d’altronde indiscusso che in caso di preliminare di vendita l’obbligo?del promittente venditore è quello di procurarsi la proprietà del bene o di ottenere dal proprietario il consenso o l’autorizzazione alla vendita – Cassazione, 3677/96; 367/77; 272 8228/90 ? per cui non è dato vedere cosa possa imputarsi alla P. che era perfettamente in grado di vendere il bene alla data prefissata»; che «né può sostenersi ? come sembrano fare i L. ? che essi acquistando da “altri” potevano risultare meno garantiti, rispetto alla P.: invero nei loro confronti e in relazione alle garanzie loro spettanti per legge, unico interlocutore era e restava la P. personalmente e direttamente, per cui solo sulla P. continuavano a ricadere tutte le garanzie in materia di vizi o di evizione ? v. Cassazione, 3963/84»; che «non vi è alcuna prova (che la P. nemmeno ha chiesto di fornire)», in ordine ai danni da lei lamentati. Wladimiro L. e Teresa V. hanno proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. Mirella P. si è costituita con controricorso, formulando a sua volta due motivi di impugnazione in via incidentale, e ha depositato una memoria. Motivi della decisione In quanto proposte contro la stessa sentenza, le due impugnazioni vanno riunite in un solo processo, in applicazione dell’articolo 335 Cpc. Con il motivo addotto a sostegno del ricorso principale Wladimiro L. e Teresa V. lamentano che la Corte di appello «ha applicato il disposto dell’articolo 1478 Cc anziché quanto previsto dall’articolo 1479 Cc», pur se «al momento della sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita la Sig.ra P. Mirella non aveva messo a conoscenza i promittenti acquirenti che l’immobile fosse di proprietà di altri» e in tali casi «è possibile per il compratore chiedere la risoluzione del contratto salvo che il venditore non abbia, nel frattempo, acquistato la proprietà della cosa», mentre «nella fattispecie ciò era tanto più importante perché esistevano, come è stato riconosciuto da tutti i tenti, problemi di esercizio del diritto di prelazione da parte di terzi, con la conseguenza che i ricorrenti non avrebbero più avuto la garanzia da parte del loro originale contraddittore e promittente venditore». Secondo i ricorrenti principali, pertanto, Mirella P. avrebbe dovuto acquistare lei stessa l’immobile in questione e poi trasferirlo a loro, sicché legittimamente avevano rifiutato di farselo alienare direttamente dagli effettivi proprietari, per il tramite della stessa P. in veste di loro procuratrice. In ordine alle modalità di adempimento dell’obbligazione assunta dal promittente venditore di una cosa altrui, nella giurisprudenza di legittimità è insorto un contrasto, per la cui composizione la causa è stata assegnata alle Sezioni unite. In prevalenza, questa Corte si è orientata nel senso che la prestazione può essere eseguita, indifferentemente, acquistando il bene e ritrasmettendolo al promissario, oppure facendoglielo alienare direttamente dal reale proprietario, in quanto l’articolo 1478 Cc ? relativo al contratto definitivo di vendita di cosa altrui, ma applicabile per analogia anche al preliminare dispone che il venditore «è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore», il che può ben avvenire anche facendo al che il terzo, al quale il bene appartiene, lo ceda egli stesso al promissario (v., tra le più recenti, Cassazione, 13330/00, 2656/01, 15035/01, 21179/04, 24782/05). Talvolta si è però deciso che l’obbligazione in questione deve invece essere adempiuta acquistando il bene e ritrasferendolo, in particolare nel caso in cui 273 l’altra parte non fosse stata consapevole dell’altruità, poiché l’articolo 1479 Cc – anch’esso dettato per la ?vendita definitiva, ma estensibile a quella preliminare ? abilita il compratore a «chiedere la risoluzione del contratto, se, quando l’ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà» (v. Cassazione 7054/90, 2091/99, relative, rispettivamente, a un contratto definitivo e a uno preliminare di vendita di cosa altrui). Ritiene il collegio che debba essere seguito l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario. Stante la latitudine delle citate previsioni normative, non vi è ragione per escludere che la prestazione possa essere eseguita “procurando” il trasferimento del bene direttamente dall’effettivo proprietario, senza necessità di un doppio trapasso; il comma 2 dell’articolo 1478 menziona bensì l’acquisto che eventualmente compia l’alienante, nel caso di vendita (definitiva) di cosa altrui, ma come una particolare modalità di adempimento, alla quale eccezionalmente riconnette l’effetto di far diventare senz’altro proprietario il compratore. Né una diversa soluzione può essere adottata per il caso in cui il promissario avesse ignorato, al momento della conclusione del preliminare, la non appartenenza del bene al promittente. Il disposto dell’articolo 1479 Cc, che consente al compratore in “buona fede” di chiedere la risoluzione del contratto, è coerente con la natura ? di vendita definitiva ? del negozio cui si riferisce, destinato, nell’intenzione delle parti, a esplicare quell’immediato effetto traslatIvo che è stabilito dall’articolo 1376 Cc, ma è impedito dall’altruità della cosa: altruità che invece non incide sul sinallagma instaurato con il contratto preliminare, il quale ha comunque efficacia soltanto obbligatoria, essendo quella reale differita alla stipulazione del definitivo, sicché nessun nocumento, fino alla scadenza del relativo termine, ne deriva per il promissario. Dall’articolo 1479 Cc, pertanto, non può desumersi che egli sia abilitato ad agire per la risoluzione ? e quindi ad opporre l’exceptio inadimpleti contractuo se l’altra parte, nel momento in cui vi è tenuta, é comunque in grado di fargli ottenere l’acquisto, direttamente dal proprietario. D’altra parte, il ritenere esatta tale modalità di adempimento è in sintonia con l’essenza e la funzione del contratto preliminare di vendita, quali sono state individuate nelle più recenti elaborazioni dottrinali, che hanno superato la concezione tradizionale dell’istituto e che qualche riflesso hanno avuto anche in giurisprudenza. Il contratto preliminare non è più visto come un semplice pactum de contrahendo, ma come un negozio destinato già a realizzare un assetto di interessi prodromico a quello che sarà compiutamente attuato con il definitivo, sicché il suo oggetto è non solo e non tanto un facere, consistente nel manifestare successivamente una volontà rigidamente predeterminata quanto alle parti e al contenuto, ma anche e soprattutto un sia pure futuro dare: la trasmissione della proprietà, che costituisce il risultato pratico avuto di mira dai contraenti. Se il bene già appartiene al promittente, i due aspetti coincidono, pur senza confondersi, ma nel caso dell’altruità rimangono distinti, appunto perché lo scopo può essere raggiunto anche mediante il trasferimento diretto della cosa dal terzo al promissario, il quale 274 ottiene comunque ciò che gli era dovuto, indipendentemente dall’essere stato ? o non ? a conoscenza della non appartenenza della cosa a chi si era obbligato ad alienargliela. Né vale obiettare che l’identità del venditore, come i ricorrenti principali deducono, non è indifferente per il compratore, il quale può risultare meno tutelato, relativamente all’evizione e ai vizi. in proposito, in consonanza con le menzionate opinioni dottrinali, la giurisprudenza si é orientata nel senso che la conclusione del definitivo, per tali profili, non assorbe né esaurisce gli effetti del preliminare, il quale continua a regolare i rapporti tra le parti, sicché il promittente alienante resta responsabile per le garanzie di cui si tratta (v., da ultimo, Cassazione, 15035/01). Si deve quindi affermare che il promittente venditore di una cosa che non gli appartiene, anche nel caso di buona fede dell’altra parte, può adempiere la propria obbligazione procurando l’acquisto del promissario direttamente dall’effettivo proprietario. Alla stregua di questo principio, il ricorso principale va rigettato, dovendoci riconoscere che la «Corte di appello correttamente ha ritenuto superfluo accertare se Wladimiro L. e Teresa V. fossero stati inizialmente ignari dell’altruità dell’immobile in questione, essendo anche in tale ipotesi ingiustificato il loro rifiuto di addivenire alla conclusione del contratto definitivo, dato che Mirella P. si era munita di una procura rilasciatale, dagli effettivi proprietari del bene, che la abilitava a effettuarne la vendita in nome loro. Con il primo motivo del ricorso incidentale, si deduce che la Corte d’appello ha dichiarato la risoluzione del contratto preliminare de quo per inadempimento di controparte senza condannarla al risarcimento del danno richiesto che all’inadempimento consegue per legge non tenendo conto che tale domanda di risarcimento del danno. che spetta in ogni modo alla Comparente, era stata avanzata anche in via equitativa». La doglianza va disattesa, poiché con la sentenza impugnata si è rilevato che nessuna prova, in ordine ai danni asseritamente subiti, era stata data né offerta da Mirella P.: prova che comunque avrebbe dovuto essere fornita, relativamente all’an poiché è soltanto per la determinazione del quantum che si può fare luogo alla liquidazione in via equitativa, ove non ne sia dimostrabile il preciso ammontare (v., per tutte, Cassazione, 16112/05). Con il secondo motivo del ricorso incidentale Mirella P. lamenta che «una volta liquidate come da dIspositivo le spese di primo e secondo grado la Corte di appello non ha imposto a controparte la restituzione delle some che le erano state liquidate a titolo di spese legali dal Primo giudice». Neppure questa censura può essere accolta, in quanto dalle conclusioni riportate nell’epigrafe della sentenza impugnata risulta che la domanda di restituzione di cui si tratta non era stata formulata. Anche il ricorso incidentale deve essere pertanto rigettato. 275 Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, in considerazione della reciproca loro soccombenza. PQM La Corte riunisce i ricorsi; li rigetta entrambi; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 16 marzo 2006. Depositata in cancelleria il-18 maggio 2006. - Il contratto preliminare presenta una struttura negoziale autonoma, destinata a realizzare un assetto di interessi prodromico a quello che sarà compiutamente attuato con il contratto definitivo; il suo oggetto non consiste solo in un “facere” ma anche e soprattutto in un futuro “dare”, consistente nel trasferimento del diritto sul bene. Pertanto, laddove il preliminare sia stato stipulato con persona incapace ( nel caso di specie, inabilitato), l’unica azione a disposizione della parte promissaria acquirente, che abbia già in parte eseguito la sua prestazione, è quella contrattuale ex art. 1443 c.c.; andrebbe, poi, esclusa la cumulabilità con tale azione dell’azione extracontrattuale che sanziona la malafede della controparte durante le trattative, che perdono di autonoma rilevanza con l’intervenuta stipula del preliminare. Cassazione civile , sez. III, 25 luglio 2006 , n. 16937 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente Dott. DURANTE Bruno - Consigliere Dott. FILADORO Camillo - Consigliere Dott. CALABRESE Donato - Consigliere 276 Dott. TRAVAGLINO Giacomo - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: P.G.U., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANSATASIO II 139, presso lo studio dell'avvocato DEL BUFALO PAOLO, che lo difende, giusta delega in atti; - ricorrente contro IFI IMMOBILIARE - FINANZIARIA - INDUSTRIALE S.P.A., con sede in Bolzano in persona del Presidente Sig. S.N., elettivamente domiciliata in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI Luigi, che ha difende unitamente all'avvocato GOSTNER GERHART, giusta delega in atti; - controricorrente avverso la sentenza n. 380/2002 della Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di BOLZANO, emessa il 14/10/2001, depositata il 03/12/2001; RG. 259/2000; udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/04/2006 dal Consigliere Dott. Giacomo TRAVAGLINO; udito l'Avvocato PAOLO DEL BUFALO; udito l'Avvocato EMANUELE COGLITORE (per delega Avv. Luigi Manzi); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r.. 277 Fatto La I.F.I. immobiliare, citando in giudizio dinanzi al tribunale di Bolzano l'ing. P.G. per sentir pronunciare nei suoi confronti una sentenza sia di accertamento (dichiarativa della legittimità del recesso di essa attrice dalle trattative intercorse con il convenuto), sia di condanna nei confronti del predetto (al pagamento della somma di L. 880 milioni, a titolo di risarcimento danni e di restituzione di quanto a lui corrisposto), espose: - di avere intavolato trattative con l'ing. V.A. allo scopo di finanziare la ricerca e lo sviluppo di un nuovo sistema di produzione energetica presentato anche dalla stampa come altamente innovativo; - di aver appreso dal V. che l'invenzione alla base del sistema era da attribuirsi essenzialmente al P., e che depositaria del relativo brevetto sarebbe stata una società costituita e registrata nelle Antille Olandesi (la "Pendolo Corporation" n.v.); - di aver versato, in sede di pre-trattative, un acconto di L. 300 milioni, all'esito del quale fu firmata, tra essa attrice, il V. e il P., una lettera di intenti nella quale questi ultimi, progettisti e soci coinventori del sistema denominato "nuova energia alternativa", si dichiaravano possessori dei relativi diritti in quote uguali, intenzionati, come tali, a trasferire il brevetto alla ricordata società "Il pendolo" delle Antille olandesi, di cui soci erano, ancora, il P. al 76% e tale P.L. per il 24%; - di aver ricevuto ulteriori assicurazioni in ordine alla circostanza che, da quella società, il brevetto sarebbe poi stato trasferito ad altra struttura societaria - le cui quote sarebbero state detenute in esclusiva dal V. e dal P. - la quale avrebbe poi allacciato gli opportuni rapporti commerciali con la costituenda Exo New Energy per lo sfruttamento commerciale dell'invenzione; - di aver previsto, nella lettera intenti, che due consulenti fossero incaricati di verificare la situazione giuridico-amministrativa così descritta; - di avere successivamente versato al P. e al V. le ulteriori somme di L. 350 milioni (il 10.12.1996), L. 100 milioni (il 20.12.1996), L. 130 milioni (il 21.1.1997), per un complessivo importo di vecchie L. 880 milioni; - di aver appreso, all'esito delle verifiche effettuate, che inventore del sistema risultava, in realtà, anche il Po., detentore del 76% del capitale della società "Pendolo", dalla cui gestione, inoltre, a seguito di varie vicissitudini societarie e giudiziarie, il P. stesso stava per essere estromesso, così vanificando le prospettive commerciali (concordate a seguito delle mendaci affermazioni del medesimo in ordine al suo presunto controllo della compagine societaria) concordate nella lettera di intenti; - di aver predisposto una seconda lettera di intenti, più aderente alla realtà, accettata dal V. ma rifiutata dal P. il quale in realtà, rappresentando false circostanze, aveva cercato di carpire alla IFI tutta una serie di prefinanziamenti. 278 Tanto premesso, la IFI spiegò le domande di cui in epigrafe specificando, in particolare, che la restituzione della somma di L. 800 milioni "veniva chiesta a seguito di risoluzione del contratto come giudizialmente spiegata in questo procedimento". Si costituì P.G. in persona del suo curatore - essendo egli stato inabilitato per infermità mentale il 13 luglio 1994 -, il quale sostenne di aver ricevuto dall'attrice la minor somma di L. 630 milioni, di cui L. 500 utilizzati per acquistare quote della "Pendolo corporation", invocando l'annullabilità di tutta la complessa attività negoziale (di straordinaria amministrazione) posta in essere dal suo assistito. Il giudice di primo grado, qualificata la lettera di intenti come atto di straordinaria amministrazione, condannò il P., previa declaratoria di annullamento dell'atto, alla restituzione all'IFI della somma di L. 630 milioni, considerati effettivamente ricevuti a vantaggio dell'inabilitato. Il gravame principale proposto da P.G. avverso tale pronuncia dinanzi alla Corte di appello di Bolzano venne rigettato, mentre ricevette accoglimento quello incidentale avanzato dalla IFI. La corte di merito - premesso che l'appellante principale aveva eccepito il vizio di ultrapetizione in cui era incorso il giudice di primo grado (per avere questi statuito su una restituzione di somme da parte dell'incapace richiesta solo tardivamente dall'attrice) e quello incidentale aveva dal suo canto precisato che il titolo delle proprie richieste di rimborso doveva intendersi "di risarcimento extracontrattuale, per trattative in malafede"-, ebbe ad osservare, per quanto ancora rileva in sede di giudizio di legittimità: 1) che, dell'atto negoziale definito dall'appellante incidentale "lettera di intenti" con la quale il P. si era impegnato a trasferire tutti i suoi diritti sull'invenzione in cambio dei finanziamenti, era senz'altro predicabile la annullabilità: si trattava, nella specie, di una complessa operazione economico- finanziaria, sicuramente suscettibile di esecuzione in forma specifica, con la quale il P. si era concretamente impegnato a disporre, la cui natura giuridica era quella di preliminare vincolante di cessione esclusiva di futuri diritti, il cui carattere era quello di disposizione del proprio patrimonio, di straordinaria amministrazione, annullabile su istanza del curatore dell'inabilitato; 2) che "effettivamente la richiesta di restituzione di quanto l'incapace aveva ricevuto a proprio vantaggio non era mai stata formulata nemmeno in via subordinata da parte della IFI", ma era purtuttavia "prospettata quale effetto naturale in precisazione delle conclusioni" (così, testualmente, la sentenza delle corte alto atesina al folio 12 della motivazione); 3) che, essendo il contratto stipulato con l'inabilitato non nullo, ma soltanto annullabile - e quindi suscettibile in astratto di convalida - l'art. 1443 c.c., in tema di ripetizione contro l'incapace, postula, per la sua legittima applicazione, una specifica domanda dell'interessato, non essendo la ripetizione de qua un effetto naturale dell'accoglimento della domanda: nella specie, dunque, il titolo per la restituzione invocata dalla società IFI non poteva essere costituito dal disposto dell'art. 1443 c.c., difettando, in proposito, una specifica domanda (in tal senso trovava così accoglimento in parte qua l'appello del P.); 279 4) che occorreva, pertanto, appurare l'esistenza di un eventuale, diverso titolo extracontrattuale, come invocato dalla società appellata, che sosteneva di essere stata raggirata dal P.; 5) che, in tema di responsabilità da slealtà precontrattuale, essa andava "inquadrata nella generale annullabilità degli atti - e non dei contratti o obbligazioni - dell'incapace; ci si lega anche con trattative che creino una legittima aspettativa in controparte, ed anche questi sono atti negoziali, per cui non...... si vede quale differenza, ai fini della generale annullabilità degli atti, vi sia" (così testualmente la sentenza al folio 13 della motivazione); 6) che il principio di diritto secondo il quale la responsabilità del genitore, per il danno cagionato da fatto illecito del figlio minore, trova fondamento, a seconda che il minore sia o meno capace di intendere e volere al momento del fatto, rispettivamente nell'art. 2048 c.c., in relazione ad una presunzione "iuris tantum" di difetto di educazione ovvero nell'art. 2047 c.c., in relazione ad una presunzione "iuris tantum" di difetto di sorveglianza e di vigilanza. Le indicate ipotesi di responsabilità presunta pertanto, sono alternative - e non concorrenti - tra loro, in dipendenza dell'accertamento, in concreto, dell'esistenza di quella capacità (la sentenza cita il precedente di cui a Cass. 2606/1997), ponendo una sostanziale e sistematica equiparazione tra minore emancipato e inabilitato che va oltre le disposizioni dettate dalla normativa sulla curatela e riveste anche gli aspetti derivanti da atti illeciti degli stessi inabilitati, doveva trovare ingresso anche nella fattispecie concreta con riguardo al P., inabilitato; 7) che, pur essendo in primo grado mancato del tutto - perchè non richiesto - un qualsivoglia accertamento sulla prova in ordine la effettiva capacità del P. nel condurre le trattative, sul suo intento di voler scientemente truffare la IFI, sul chi dovesse concretamente sorvegliarlo, su chi dovesse conseguentemente rispondere dei suoi atti in caso di omessa sorveglianza e, infine, sul concreto contributo causale di quest'ultimo all'asserito meccanismo truffaldino in caso di sua incapacità mentale al momento dei fatti, "il tenore letterale della scrittura" era "chiaro e inequivocabile: il P. si è presentato come coinventore e titolare dei diritti di sfruttamento al 76% dell'invenzione. Le pressioni che egli riferisce di aver subito per intavolare le trattative mai gli provennero dalla IFI, ma semmai dal V.. E non essendo provato nel caso di specie che la IFI si sia servita del V. per ingannare il P., lo stesso deve rispondere dei danni" (così il folio 14 della sentenza), da quantificarsi in tutto quanto versato dalla IFI; e cioè L. 880 milioni, avendo la IFI "ben diritto, essendo il P. solidalmente coinvolto nel meccanismo che indubbiamente ha sorpreso la buona fede della finanziaria inducendola a compiere il suddetto atto di fede, di essere integralmente risarcita anche dall'incapace"; 8) che "il potere di accordare equa indennità" si ricollegava "alla richiesta di risarcimento del danno procurato dall'incapace, e non abbisognava di domanda ad hoc. Comunque il P., per evitare tale responsabilità, avrebbe dovuto chiamare in manleva chi avrebbe dovuto sorvegliarlo, comprovando nel contempo la propria assoluta incapacità all'epoca dei fatti. Tale prova avrebbe dovuto essere data dal P. non essendo sufficiente a tal fine la sentenza di inabilitazione" (folio 15 della sentenza). 280 Per la cassazione della sentenza della corte d'appello di Bolzano ricorre oggi dinanzi a questa Corte P.G.. Resiste con controricorso la IFI immobiliare. La parte ricorrente ha depositato memoria. Diritto Il ricorso, articolato in 3 motivi di doglianza, è fondato. In limine, va decisa la questione di inammissibilità del ricorso per omessa esposizione del fatto sollevata da parte controricorrente in sede di discussione orale, trattandosi di (eventuale) nullità di un atto del procedimento rilevabile di ufficio da questa Corte. La questione non è fondata. Pur non facendo pedissequamente propri i passaggi e lo svolgimento dei fatti contenuti nella sentenza oggi impugnata, difatti, il ricorso, dal folio 2 al folio 11, riproduce e ripercorre le tappe più significative delle vicende processuali ed extraprocessuali che costituiscono l'oggetto dell'attuale giudizio, fornendo inoltre, e in più occasioni, ulteriori e fondamentali chiarimenti (come, ad esempio, in relazione alle cause e modalità di inabilitazione dell'odierno ricorrente) rispetto alla (non sempre lucida ed esaustiva) ricostruzione dei fatti contenuta nella pronuncia della Corte di appello di Bolzano. Va altresì preliminarmente esaminata la questione della inammissibilità del controricorso, sollevata in memoria da parte ricorrente, per omessa notifica al curatore del P.. La questione non è fondata. L'assenso fornito dal curatore alla impugnazione della sentenza, difatti (della cui esistenza la stessa parte ricorrente non dubita) esaurisce l'attività demandata all'organo di protezione dell'incapace, che, nel manifestare la propria volontà, si rende parte di un atto unilaterale complesso "a complessità disuguale". La sostanziale unicità dell'atto, e (la non contestata e) contestuale elezione di domicilio compiuta dal ricorrente presso il proprio difensore nel giudizio di cassazione (l'avv. Paolo Del Bufalo, con domicilio in Roma alla via Anastasio II n. 139, ove il controricorso risulta concretamente notificato), rendono del tutto valida ed efficace la notifica dell'atto processuale in contestazione. Con il primo motivo, lamenta il ricorrente una pretesa violazione dell'art. 1337 c.c. - violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito, dopo aver correttamente escluso che la pretesa della IFI potesse essere accolta ai sensi dell'art. 1443 c.c. poichè, pur essendo la pattuizione P./ V. sicuramente annullabile in quanto sottoscritta dal solo P. benchè inabilitato, difettava, nella specie, ogni domanda in tal senso da parte della società -, e dopo aver, altrettanto correttamente, qualificato 281 la "lettera di intenti" intercorsa tra le parti come vero e proprio "contratto preliminare vincolante" (e dunque suscettibile di esecuzione coattiva) avente ad oggetto la cessione esclusiva dei futuri diritti di sfruttamento industriale di un'invenzione, sarebbe incorso in un evidente errore di diritto nel predicare l'esistenza di un titolo extracontrattuale di responsabilità a carico del P., così estendendo indebitamente la domanda della IFI, anzichè limitarsi ad annullare la pattuizione. "La pronuncia di invalidità del contratto prosegue ancora il ricorrente "sarebbe stata preclusiva del giudizio sulla legittimità del recesso dalle trattative e sul risarcimento, non potendosi discettare di recesso e di responsabilità se il contratto (sia pur preliminare) si è perfezionato". Il motivo è fondato. Il giudice del merito, difatti, dopo aver conferito alla lettera di intenti per la quale è oggi processo la natura giuridica di "contratto preliminare vincolante di cessione di futuri diritti" (non rileva, in questa sede, analizzare la conformità a diritto di tale qualificazione, essendosi sul punto formato il giudicato interno per avere lo stesso controricorrente ribadito, al folio 6 del controricorso, che "il titolo per le proprie richieste è il risarcimento extracontrattuale per trattative di malafede"), e dopo avere altrettanto rettamente escluso che l'istanza risarcitoria della IFI potesse trovare fondamento nel disposto dell'art. 1443 c.c. (che, come è noto, disciplina l'ipotesi di restituzione, da parte del contraente incapace, in favore della controparte, della prestazione ricevuta entro i limiti in cui questa sia stata rivolta a suo vantaggio), in difetto di apposita domanda aveva poi esteso l'indagine all'accertamento dell'esistenza di un titolo extracontrattuale, così come invocato dalla IFI, che aveva fondato la propria istanza risarcitoria proprio su di una asserita responsabilità extracontrattuale dell'odierno ricorrente "per trattative in malafede". Oggetto della indagine diveniva così, nel ragionamento della corte alto atesina, la "slealtà precontrattuale", da inquadrarsi "nelle generale annullabilità degli atti: ci si lega anche con trattative che creino una legittima aspettativa in controparte, e anche questi sono atti negoziali". Il dictum del giudice di appello è, in realtà, giuridicamente viziato sotto molteplici aspetti. Poco comprensibile, appare, innanzitutto, il riferimento alla categoria della "slealtà contrattuale" come fonte diretta di annullabilità degli atti. Le trattative, difatti, di cui erroneamente si predica, tra l'altro, la natura negoziale (attesone, viceversa, il carattere di atti "prenegoziali", comunemente individuato dalla dottrina) non sono destinate "all'annullamento" (perchè, a tacer d'altro, rientrerebbero pur sempre nell'orbita della responsabilità contrattuale), bensì a sfociare, o meno, in una successiva struttura contrattuale. La mancata stipula del contratto cui esse risultano teleologicamente collegate può pertanto, in ipotesi, dar luogo a responsabilità precontrattuale (sulla cui natura molto si è discusso in dottrina e giurisprudenza, se essa debba, cioè, riconnettersi all'istituto della responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale ovvero ancora sia destinata a costituire un vero e proprio tertium genus intermedio), tutte le volte che (e solo se) mai esse non sfocino nell'alveo di una successiva convenzione negoziale, alla cui stipula, per converso, consegue che per ciò solo esse perdono ogni autonomia e ogni giuridica rilevanza, e sotto il profilo risarcitorio convergono, perdendo ogni autonomia, in quella struttura contrattuale che, essa si, essa sola, potrà (in ipotesi) 282 costituire fonte di responsabilità risarcitoria. Di talchè, nella ipotesi in cui la convenzione negoziale così divisa tragga linfa da condizioni diverse da quelle che avrebbero preso corpo se una parte non avesse tenuto un comportamento contrario a buona fede, la fattispecie di responsabilità legittimamente azionabile dal deceptus è (solo) quella contrattuale, e non più quella precontrattuale ex art. 1337 c.c. la cui configurabilità resta preclusa ed assorbita nella intervenuta stipula del contratto. Nè vale obbiettare che, nella specie, il negozio concluso aveva natura di contratto preliminare, il cui oggetto (tradizionalmente identificato nella prestazione di un futuro consenso) non consentirebbe un autonomo esperimento dell'azione risarcitoria ex contractu, legittimamente riferibile, di converso, alle precedenti trattative intercorse tra le parti. Al di là della inesattezza tout court di tale affermazione, va in questa sede rammentato come la più recente giurisprudenza di legittimità e la più avvertita dottrina si sia indotta a rifiutare (in consonanza con le innegabili evoluzioni economiche e normative dell'istituto) la costruzione del preliminare in termini di puro e nudo pactum de futuro contraendo. Questa stessa Corte, con una recente sentenza resa a sezioni unite (Cass. 1624/2006), nel negare ogni fondamento alla teoria che esclude la legittimità della prestazione del promittente venditore di un bene altrui concretantesi (anche) nel "procurare" il trasferimento del bene al promissario acquirente direttamente dal terzo proprietario senza necessità di un doppio trapasso, e nel predicare il principio secondo il quale l'identità del venditore è del tutto indifferente per il compratore, poichè "la conclusione del definitivo non assorbe nè esaurisce gli effetti del preliminare, che continua, viceversa, a regolare i rapporti tra le parti, sicchè il promettente venditore resta responsabile per il caso di evizione e per i vizi", approda infine alle sponde di un moderna concezione del preliminare inteso come struttura negoziale destinata già (quantomeno in ipotesi di cd. "preliminare impuro" ovvero "a prestazioni anticipate") a realizzare un assetto di interessi prodromico a quello che sarà compiutamente attuato con il contratto definitivo, sicchè il suo oggetto diviene non solo e non tanto un tacere consistente nel manifestare successivamente una volontà rigidamente predeterminata quanto alle parti e al contenuto, ma anche e soprattutto un (sia pur futuro) dare, consistente nella trasmissione del diritto (dominicale o quant'altro), che costituisce, alfine, il risultato pratico avuto di mira dai contraenti. Così, la stessa mappa genetica del preliminare "impuro" (quale quello di specie, essendo la prestazione a carico della parte promissoria acquirente in gran parte già stata eseguita) ne risulta rimodellata, restandone esclusa la configurabilità in termini di mero pactum de contrahendo, sicchè, a più forte ragione, la confluenza tout court, in esso, degli atti di trattativa che lo abbiano preceduto risulta incontestabile. Ne consegue che, stipulato il contratto preliminare, l'unica azione a disposizione della promissaria acquirente già esecutrice di parte della propria prestazione era quella contrattuale ex art. 1443 c.c. (versandosi in ipotesi di contratto di persona incapace legalmente presunta tale per effetto della sentenza di inabilitazione), e che l'azione extracontrattuale, così come proposta dalla società IFI nella specie, non poteva avere ad oggetto, come pure ribadito in questa sede dal controricorrente, gli atti di trattative condotte in (supposta) malafede dalla controparte. Nè legittimo sarebbe il richiamo al principio della cumulabilità, nel nostro ordinamento, dei due tipi di responsabilità da illecito civile, poichè il 283 principio predetto è legittimamente invocabile quando uno stesso fatto autonomamente generatore di danno integri gli estremi tento dell'inadempimento contrattuale, quanto del torto aquiliano (ciò che accade, ad esempio, nell'ipotesi di lesioni subite dal lavoratore per inosservanza di norme antinfortunistiche), ma non anche nell'ipotesi in cui una attività prenegoziale astrattamente generatrice di danno (le trattative) confluisca fisiologicamente nel negozio cui essa risultava funzionalmente e teleologicamente collegata, risultando, in tal caso, soltanto il negozio stesso la eventuale fonte di responsabilità (contrattuale). Il secondo e terzo motivo del ricorso, attinenti al profilo della capacità dell'inabilitato e della relativa prova, pur fondati sotto il profilo giuridico, sono assorbiti nell'accoglimento del primo motivo. Il ricorso è, pertanto, accolto, e il processo rinviato alla Corte di appello di Trento che, nel provvedere anche alle spese del presente giudizio, si atterrà ai principi di diritto suesposti. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Trento. Così deciso in Roma, il 26 aprile 2006. Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2006 PATTO COMMISSORIO E BENE CONCESSO DA UN TERZO TRACCIA: Il candidato rediga motivato parere sulla questione giuridica prospettata. Catullo allo scopo di intraprendere un’attività commerciale, chiedeva a Tizio un mutuo di 30000 euro. I due pattuivano che Catullo avrebbe restituito la somma ricevuta entro un anno, maggiorata degli interessi legali. Tizio, sapendo che Catullo era nullatenente, aveva chiesto a Caio, fratello di Catullo, di trasferirgli la sua proprietà (immobile Alfa), del valore di 40000 euro; inoltre, Catullo si era dichiarato pronto a restituire l’immobile Alfa a Caio in caso di puntuale adempimento di Catullo. POSSIBILE SOLUZIONE SCHEMATICA: In premessa poteva risultare utile ricostruire sinteticamente il fatto. 284 Successivamente, il problema posto dalla traccia (al di là della sfortunata formulazione, soprattutto nella parte finale) andava inquadrato nell’ambito del divieto di patto commissorio, ex art. 2744 c.c., con particolare riferimento all’ipotesi in cui il bene dato in garanzia appartenga ad un terzo (nel caso di specie, il bene Alfa appartiene a Caio, fratello di Catullo). Il patto commissorio che viene ad emergere nel caso di specie è realizzato con schema risolutivo (equiparabile, quanto a disciplina applicabile, a quello con schema sospensivo, secondo la giurisprudenza più recente) e la garanzia viene fornita da un terzo; tale fattispecie viola, comunque, l’art. 2744 c.c.? Secondo una prima impostazione, sostenuta anche da parte della giurisprudenza, l’art. 2744 c.c. non sarebbe applicabile quando manchi l’elemento essenziale della coincidenza, nella stessa persona, della posizione di proprietario alienante del bene in garanzia e di debitore; infatti, si dice, il divieto trae fondamento dalla necessità di impedire al creditore l’esercizio di una coazione morale sul debitore e di sottrarsi alla par condicio creditorum rispetto al patrimonio dello stesso debitore: quando il garante è un terzo (Caio) non vi sarebbero questi rischi e, conseguentemente, non si violerebbe alcun specifico divieto. Secondo l’impostazione più convincente (sostenuta da altra parte della giurisprudenza),il problema posto andrebbe risolto in termini di tutela sostanziale e non meramente formale, estendendo l’ambito applicativo dell’art. 2744 c.c. anche al caso di bene concesso da un terzo. A favore di questa ricostruzione,si dice, deporrebbe l’art. 2808 c.c. che sembrerebbe equiparare l’ipoteca costituita su beni del debitore a quella realizzata su beni di un terzo, per cui anche nell’art. 2744 c.c. il riferimento all’ipoteca del debitore potrebbe essere esteso anche a terzi. Diversamente, d’altronde, la costituzione di ipoteca su un bene del terzo sarebbe un comodo escamotage per vulnerare in concreto l’art. 2744 c.c., a tutto svantaggio della sua ratio di protezione verso il debitore, individuato come soggetto debole. L’art. 2744 c.c., in altre parole, andrebbe visto in modo sostanziale e non meramente formale, ponendo l’accento sulla sua ratio di tutela (il ragionamento è molto simile a quello fatto per estendere l’ambito applicativo dell’art. 2744 c.c. al patto commissorio realizzato con schema risolutivo). Da questa angolazione prospettica, pertanto, il patto commissorio realizzato tra Catullo e Tizio, con il coinvolgimento di Caio è nullo, per cui neanche il trasferimento patrimoniale dell’immobile Alfa avrà effetto. Si consiglia di leggere Bianca, Il contratto, Milano. ANNULLAMENTO E RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE Tizio, incapace, concludeva con Caio un accordo basato su una lettera di intenti (avente ad oggetto un prestito di 55.000,oo euro del primo in favore del secondo); a seguito di tale lettera di intenti, Tizio erogava in favore di Caio 50.000,oo euro. 285 Il candidato, dopo aver qualificato il negozio giuridico intercorso tra le parti, affronti la questione relativa al possibile cumulo tra azione precontrattuale ed azioni di tipo contrattuale. POSSIBILE SOLUZIONE SCHEMATICA: In premessa poteva essere utile ricostruire sinteticamente il fatto. Successivamente bisognava inquadrare giuridicamente l’accordo posto in essere tra Tizio e Caio. Si tratta di una lettera di intenti idonea ad anticipare, quasi del tutto, gli effetti finali del negozio giuridico costituendo. D’altronde, quello che intercorre tra Tizio e Caio è un vero accordo avente ad oggetto un accordo successivo e definitivo, i cui effetti vengono, in gran parte, prodotti al momento del primo accordo (Tizio erogava già 50.000,oo euro a fronte di un debito di 55.000,oo). In questo senso, allora, la fattispecie ben potrebbe integrare un contratto preliminare ad effetti anticipati, in quanto all’accordo relativo alla lettera di intenti segue l’effetto del trasferimento patrimoniale da parte di Tizio (incapace) a favore di Caio. Tale figura, tuttavia, non è unanimemente ammessa, in quanto secondo una certa impostazione il contratto preliminare ad effetti anticipati, in fondo, nulla sarebbe se non un contratto definitivo, perché gli effetti reali non sarebbero differiti nel tempo secondo la struttura classica del procedimento preliminare-definitivo, con la conseguenza che, venendo meno la struttura negoziale del preliminare, a rigore, si dice, non potrebbe sussistere tale figura, ma quella del contratto definitivo: il preliminare per essere tale non tollererebbe la clausola degli effetti anticipati. Secondo altra impostazione (più recente), invece, tale figura giuridica avrebbe piena cittadinanza nel nostro ordinamento, alla luce del principio generale dell’autonomia negoziale, ex art. 1321 c.c.: le parti, invero, nell’esercizio della loro autonomia negoziale possono anche prevedere un’anticipazione del definitivo assetto di interessi programmato, senza che ciò determini un mutamento della causa, cioè del tipo contrattuale. In fondo, come evidente nel caso in esame, il contratto tra Tizio e Caio non può essere definitivo, tanto più che la prestazione non è interamente compiuta: il versamento dei 50.000,oo euro sarebbe, da questo angolo prospettico, pur sempre un acconto (attribuito non a titolo di caparra, ma in conto della futura prestazione – finale – dovuta), per cui vi sarebbe un preliminare con parziali effetti anticipati, ma non un unico negozio giuridico isolato (estraneo al procedimento preliminaredefinitivo); corollario applicativo più importante della qualificazione di contratto preliminare ad effetti parzialmente anticipati è quello, eventualmente, di poter far valere sopravvenienze non prevedibili, ex art. 1256 c.c., idonee ad estinguere il contratto. Detto questo, la traccia richiedeva di prendere in esame il problema dell’eventuale cumulo tra azione precontrattuale e contrattuale. Il problema si pone, evidentemente, perché l’azione precontrattuale (ritenuta, di massima, avente natura giuridica extracontrattuale), fondata essenzialmente sull’art. 1337 c.c., sembra presupporre che le parti non siano addivenute ad un accordo negoziale, in quanto si parla di “trattative”, tanto è vero che il danno 286 risarcibile è limitato all’interesse negativo[*] (diversamente dall’ipotesi di inadempimento, ex art. 1218 c.c., dove si fa riferimento all’interesse positivo). Nel caso di specie, in fondo, potrebbe essere fatta valere l’azione contrattuale di annullamento, ex art. 1425 c.c., in quanto Tizio era incapace, con conseguente “eventuale” ripetizione, nei limiti in cui l’incapace non ne abbia beneficiato, ex art. 1443 c.c. Tale azione è, allora, cumulabile con quella risarcitoria da responsabilità precontrattuale, ex art. 1337 c.c.? In favore della tesi positiva potrebbe deporre il fatto che, in fondo, la natura giuridica della responsabilità precontrattuale è quella extracontrattuale, per cui, si dice, se la natura giuridica è quella extracontrattuale, allora, nulla dovrebbe ostare ad un’eventuale cumulo con azioni di tipo contrattuale, anche ex art. 1425 c.c., proprio alla luce del fatto che si tratterebbe, nella sostanza, di tipologie di responsabilità ben diverse. Invero, la giurisprudenza più recente opta per la tesi negativa, in quanto, si dice, la conclusione di un contratto (seppure ad effetti anticipati o parzialmente anticipati) assorbirebbe, per così dire, l’azione precontrattuale, in quanto quest’ultima azione riguarderebbe solo le trattative inutili o inconcludenti, ma non la conclusione del contratto a certe condizioni piuttosto che altre, ovvero il libero procedimento volitivo, perché in questi ultimi casi già vi sarebbe l’azione di annullamento. D’altronde, il distinguo tra interesse positivo e negativo starebbe proprio a significare ciò: se le parti addivengono ad un contratto si possono porre solo problemi positivi (relativi al contratto) e non negativi (relativi alla mancata conclusione di un contratto per trattative inutili); se si parte dall’idea che l’art. 1337 c.c., laddove parla di trattative, si riferisce solo al coinvolgimento inutile in trattative, allora, ne segue, de plano, come corollario logico-deduttivo, che la conclusione del contratto è concettualmente (oltre che giuridicamente) incompatibile con un’azione volta a far valere la mancata conclusione del contratto. In questo senso, allora, il contratto intercorrente tra Tizio e Caio ben potrà essere annullato, ex art. 1425 c.c., con eventuale ripetizione, ex art. 1443 c.c., ma non vi sarà spazio per un cumulo di tutela con l’azione da responsabilità precontrattuale, ex art. 1337 c.c. [*]La differenza tra interesse positivo (presente nella responsabilità da inadempimento) ed interesse negativo (presente nella responsabilità precontrattuale) è che il primo presuppone la validità del negozio e consiste nei vantaggi che, verosimilmente, sarebbero stati ottenuti ed i danni che, di massima, sarebbero stati evitati con l’esecuzione esatta del contratto; diversamente, il secondo (interesse negativo) presuppone la mancata conclusione o l’invalidità del contratto e consiste nei vantaggi che sarebbero stati ottenuti e nei danni che sarebbero stati evitati non iniziando le trattative ovvero non confidando nella validità del contratto (con riferimento alle ipotesi di nullità o inesistenza). 287 Si consiglia di leggere la sentenza che segue. -Quando si addiviene ad un contratto (nella specie una lettera di intenti veniva qualificata come preliminare ad effetti anticipati) vuol dire che viene superata la fase delle trattative, in favore dell’accordo, con la conseguenza che si potrà configurare un’azione contrattuale, ma non precontrattuale, perché la prima assorbirebbe la seconda. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Sentenza 25 luglio 2006, n. 16937 Svolgimento del processo La I.F.I. immobiliare, citando in giudizio dinanzi al tribunale di Bolzano l'ing. P.G. per sentir pronunciare nei suoi confronti una sentenza sia di accertamento (dichiarativa della legittimità del recesso di essa attrice dalle trattative intercorse con il convenuto), sia di condanna nei confronti del predetto (al pagamento della somma di L. 880 milioni, a titolo di risarcimento danni e di restituzione di quanto a lui corrisposto), espose: - di avere intavolato trattative con l'ing. V.A. allo scopo di finanziare la ricerca e lo sviluppo di un nuovo sistema di produzione energetica presentato anche dalla stampa come altamente innovativo; - di aver appreso dal V. che l'invenzione alla base del sistema era da attribuirsi essenzialmente al P., e che depositaria del relativo brevetto sarebbe stata una società costituita e registrata nelle Antille Olandesi (la "Pendolo Corporation" n.v.); - di aver versato, in sede di pre-trattative, un acconto di L. 300 milioni, all'esito del quale fu firmata, tra essa attrice, il V. e il P., una lettera di intenti nella quale questi ultimi, progettisti e soci coinventori del sistema denominato "nuova energia alternativa", si dichiaravano possessori dei relativi diritti in quote uguali, intenzionati, come tali, a trasferire il brevetto alla ricordata società "Il pendolo" delle Antille olandesi, di cui soci erano, ancora, il P. al 76% e tale P.L. per il 24%; - di aver ricevuto ulteriori assicurazioni in ordine alla circostanza che, da quella società, il brevetto sarebbe poi stato trasferito ad altra struttura societaria - le cui quote sarebbero state detenute in esclusiva dal V. e dal P. - la quale avrebbe poi allacciato gli opportuni rapporti commerciali con la costituenda Exo New Energy per lo sfruttamento commerciale dell'invenzione; - di aver previsto, nella lettera intenti, che due consulenti fossero incaricati di verificare la situazione giuridico-amministrativa così descritta; - di avere successivamente versato al P. e al V. le ulteriori somme di L. 350 milioni (il 10.12.1996), L. 100 milioni (il 20.12.1996), L. 130 milioni (il 21.1.1997), per un complessivo importo di vecchie L. 880 milioni; - di aver appreso, all'esito delle verifiche effettuate, che inventore del sistema risultava, in realtà, anche il Po., detentore del 76% del capitale della società "Pendolo", dalla cui gestione, inoltre, a seguito di varie vicissitudini societarie e giudiziarie, il P. stesso stava per essere estromesso, così vanificando le prospettive commerciali (concordate a seguito delle mendaci affermazioni del medesimo in ordine al suo presunto controllo della compagine societaria) concordate nella lettera di intenti; 288 di aver predisposto una seconda lettera di intenti, più aderente alla realtà, accettata dal V. ma rifiutata dal P. il quale in realtà, rappresentando false circostanze, aveva cercato di carpire alla IFI tutta una serie di prefinanziamenti. Tanto premesso, la IFI spiegò le domande di cui in epigrafe specificando, in particolare, che la restituzione della somma di L. 800 milioni "veniva chiesta a seguito di risoluzione del contratto come giudizialmente spiegata in questo procedimento". Si costituì P.G. in persona del suo curatore - essendo egli stato inabilitato per infermità mentale il 13 luglio 1994 -, il quale sostenne di aver ricevuto dall'attrice la minor somma di L. 630 milioni, di cui L. 500 utilizzati per acquistare quote della "Pendolo corporation", invocando l'annullabilità di tutta la complessa attività negoziale (di straordinaria amministrazione) posta in essere dal suo assistito. Il giudice di primo grado, qualificata la lettera di intenti come atto di straordinaria amministrazione, condannò il P., previa declaratoria di annullamento dell'atto, alla restituzione all'IFI della somma di L. 630 milioni, considerati effettivamente ricevuti a vantaggio dell'inabilitato. Il gravame principale proposto da P.G. avverso tale pronuncia dinanzi alla Corte di appello di Bolzano venne rigettato, mentre ricevette accoglimento quello incidentale avanzato dalla IFI. La corte di merito - premesso che l'appellante principale aveva eccepito il vizio di ultrapetizione in cui era incorso il giudice di primo grado (per avere questi statuito su una restituzione di somme da parte dell'incapace richiesta solo tardivamente dall'attrice) e quello incidentale aveva dal suo canto precisato che il titolo delle proprie richieste di rimborso doveva intendersi "di risarcimento extracontrattuale, per trattative in malafede"-, ebbe ad osservare, per quanto ancora rileva in sede di giudizio di legittimità: 1) che, dell'atto negoziale definito dall'appellante incidentale "lettera di intenti" con la quale il P. si era impegnato a trasferire tutti i suoi diritti sull'invenzione in cambio dei finanziamenti, era senz'altro predicabile la annullabilità: si trattava, nella specie, di una complessa operazione economico- finanziaria, sicuramente suscettibile di esecuzione in forma specifica, con la quale il P. si era concretamente impegnato a disporre, la cui natura giuridica era quella di preliminare vincolante di cessione esclusiva di futuri diritti, il cui carattere era quello di disposizione del proprio patrimonio, di straordinaria amministrazione, annullabile su istanza del curatore dell'inabilitato; 2) che "effettivamente la richiesta di restituzione di quanto l'incapace aveva ricevuto a proprio vantaggio non era mai stata formulata nemmeno in via subordinata da parte della IFI", ma era purtuttavia "prospettata quale effetto naturale in precisazione delle conclusioni" (così, testualmente, la sentenza delle corte alto atesina al folio 12 della motivazione); 3) che, essendo il contratto stipulato con l'inabilitato non nullo, ma soltanto annullabile - e quindi suscettibile in astratto di convalida - l'art. 1443 c.c., in tema di ripetizione contro l'incapace, postula, per la sua legittima applicazione, una specifica domanda dell'interessato, non essendo la ripetizione de qua un effetto naturale dell'accoglimento della domanda: nella specie, dunque, il titolo per la restituzione invocata dalla società IFI non poteva essere costituito dal disposto dell'art. 1443 c.c., difettando, in proposito, una specifica domanda (in tal senso trovava così accoglimento in parte qua l'appello del P.); 4) che occorreva, pertanto, appurare l'esistenza di un eventuale, diverso titolo extracontrattuale, come invocato dalla società appellata, che sosteneva di essere stata raggirata dal P.; 5) che, in tema di responsabilità da slealtà precontrattuale, essa andava "inquadrata nella generale annullabilità degli atti - e non dei contratti o obbligazioni - dell'incapace; ci si lega anche con trattative che creino una legittima 289 aspettativa in controparte, ed anche questi sono atti negoziali, per cui non...... si vede quale differenza, ai fini della generale annullabilità degli atti, vi sia" (così testualmente la sentenza al folio 13 della motivazione); 6) che il principio di diritto secondo il quale la responsabilità del genitore, per il danno cagionato da fatto illecito del figlio minore, trova fondamento, a seconda che il minore sia o meno capace di intendere e volere al momento del fatto, rispettivamente nell'art. 2048 c.c., in relazione ad una presunzione "iuris tantum" di difetto di educazione ovvero nell'art. 2047 c.c., in relazione ad una presunzione "iuris tantum" di difetto di sorveglianza e di vigilanza. Le indicate ipotesi di responsabilità presunta pertanto, sono alternative - e non concorrenti - tra loro, in dipendenza dell'accertamento, in concreto, dell'esistenza di quella capacità (la sentenza cita il precedente di cui a Cass. 2606/1997), ponendo una sostanziale e sistematica equiparazione tra minore emancipato e inabilitato che va oltre le disposizioni dettate dalla normativa sulla curatela e riveste anche gli aspetti derivanti da atti illeciti degli stessi inabilitati, doveva trovare ingresso anche nella fattispecie concreta con riguardo al P., inabilitato; 7) che, pur essendo in primo grado mancato del tutto - perchè non richiesto - un qualsivoglia accertamento sulla prova in ordine la effettiva capacità del P. nel condurre le trattative, sul suo intento di voler scientemente truffare la IFI, sul chi dovesse concretamente sorvegliarlo, su chi dovesse conseguentemente rispondere dei suoi atti in caso di omessa sorveglianza e, infine, sul concreto contributo causale di quest'ultimo all'asserito meccanismo truffaldino in caso di sua incapacità mentale al momento dei fatti, "il tenore letterale della scrittura" era "chiaro e inequivocabile: il P. si è presentato come coinventore e titolare dei diritti di sfruttamento al 76% dell'invenzione. Le pressioni che egli riferisce di aver subito per intavolare le trattative mai gli provennero dalla IFI, ma semmai dal V.. E non essendo provato nel caso di specie che la IFI si sia servita del V. per ingannare il P., lo stesso deve rispondere dei danni" (così il folio 14 della sentenza), da quantificarsi in tutto quanto versato dalla IFI; e cioè L. 880 milioni, avendo la IFI "ben diritto, essendo il P. solidalmente coinvolto nel meccanismo che indubbiamente ha sorpreso la buona fede della finanziaria inducendola a compiere il suddetto atto di fede, di essere integralmente risarcita anche dall'incapace"; 8) che "il potere di accordare equa indennità" si ricollegava "alla richiesta di risarcimento del danno procurato dall'incapace, e non abbisognava di domanda ad hoc. Comunque il P., per evitare tale responsabilità, avrebbe dovuto chiamare in manleva chi avrebbe dovuto sorvegliarlo, comprovando nel contempo la propria assoluta incapacità all'epoca dei fatti. Tale prova avrebbe dovuto essere data dal P. non essendo sufficiente a tal fine la sentenza di inabilitazione" (folio 15 della sentenza). Per la cassazione della sentenza della corte d'appello di Bolzano ricorre oggi dinanzi a questa Corte P.G.. Resiste con controricorso la IFI immobiliare. La parte ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione Il ricorso, articolato in 3 motivi di doglianza, è fondato. In limine, va decisa la questione di inammissibilità del ricorso per omessa esposizione del fatto sollevata da parte controricorrente in sede di discussione orale, trattandosi di (eventuale) nullità di un atto del procedimento rilevabile di ufficio da questa Corte. La questione non è fondata. 290 Pur non facendo pedissequamente propri i passaggi e lo svolgimento dei fatti contenuti nella sentenza oggi impugnata, difatti, il ricorso, dal folio 2 al folio 11, riproduce e ripercorre le tappe più significative delle vicende processuali ed extraprocessuali che costituiscono l'oggetto dell'attuale giudizio, fornendo inoltre, e in più occasioni, ulteriori e fondamentali chiarimenti (come, ad esempio, in relazione alle cause e modalità di inabilitazione dell'odierno ricorrente) rispetto alla (non sempre lucida ed esaustiva) ricostruzione dei fatti contenuta nella pronuncia della Corte di appello di Bolzano. Va altresì preliminarmente esaminata la questione della inammissibilità del controricorso, sollevata in memoria da parte ricorrente, per omessa notifica al curatore del P.. La questione non è fondata. L'assenso fornito dal curatore alla impugnazione della sentenza, difatti (della cui esistenza la stessa parte ricorrente non dubita) esaurisce l'attività demandata all'organo di protezione dell'incapace, che, nel manifestare la propria volontà, si rende parte di un atto unilaterale complesso "a complessità disuguale". La sostanziale unicità dell'atto, e (la non contestata e) contestuale elezione di domicilio compiuta dal ricorrente presso il proprio difensore nel giudizio di cassazione (l'avv. Paolo Del Bufalo, con domicilio in Roma alla via Anastasio II n. 139, ove il controricorso risulta concretamente notificato), rendono del tutto valida ed efficace la notifica dell'atto processuale in contestazione. Con il primo motivo, lamenta il ricorrente una pretesa violazione dell'art. 1337 c.c. - violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito, dopo aver correttamente escluso che la pretesa della IFI potesse essere accolta ai sensi dell'art. 1443 c.c. poichè, pur essendo la pattuizione P./ V. sicuramente annullabile in quanto sottoscritta dal solo P. benchè inabilitato, difettava, nella specie, ogni domanda in tal senso da parte della società -, e dopo aver, altrettanto correttamente, qualificato la "lettera di intenti" intercorsa tra le parti come vero e proprio "contratto preliminare vincolante" (e dunque suscettibile di esecuzione coattiva) avente ad oggetto la cessione esclusiva dei futuri diritti di sfruttamento industriale di un'invenzione, sarebbe incorso in un evidente errore di diritto nel predicare l'esistenza di un titolo extracontrattuale di responsabilità a carico del P., così estendendo indebitamente la domanda della IFI, anzichè limitarsi ad annullare la pattuizione. "La pronuncia di invalidità del contratto prosegue ancora il ricorrente "sarebbe stata preclusiva del giudizio sulla legittimità del recesso dalle trattative e sul risarcimento, non potendosi discettare di recesso e di responsabilità se il contratto (sia pur preliminare) si è perfezionato". Il motivo è fondato. Il giudice del merito, difatti, dopo aver conferito alla lettera di intenti per la quale è oggi processo la natura giuridica di "contratto preliminare vincolante di cessione di futuri diritti" (non rileva, in questa sede, analizzare la conformità a diritto di tale qualificazione, essendosi sul punto formato il giudicato interno per avere lo stesso controricorrente ribadito, al folio 6 del controricorso, che "il titolo per le proprie richieste è il risarcimento extracontrattuale per trattative di malafede"), e dopo avere altrettanto rettamente escluso che l'istanza risarcitoria dellaIFI potesse trovare fondamento nel disposto dell'art. 1443 c.c. (che, come è noto, disciplina l'ipotesi di restituzione, da parte del contraente incapace, in favore della controparte, della prestazione ricevuta entro i limiti in cui questa sia stata rivolta a suo vantaggio), in difetto di apposita domanda aveva poi esteso l'indagine all'accertamento dell'esistenza di un titolo extracontrattuale, così come invocato 291 dalla IFI, che aveva fondato la propria istanza risarcitoria proprio su di una asserita responsabilità extracontrattuale dell'odierno ricorrente "per trattative in malafede". Oggetto della indagine diveniva così, nel ragionamento della corte alto atesina, la "slealtà precontrattuale", da inquadrarsi "nelle generale annullabilità degli atti: ci si lega anche con trattative che creino una legittima aspettativa in controparte, e anche questi sono atti negoziali". Il dictum del giudice di appello è, in realtà, giuridicamente viziato sotto molteplici aspetti. Poco comprensibile, appare, innanzitutto, il riferimento alla categoria della "slealtà contrattuale" come fonte diretta di annullabilità degli atti. Le trattative, difatti, di cui erroneamente si predica, tra l'altro, la natura negoziale (attesone, viceversa, il carattere di atti "prenegoziali", comunemente individuato dalla dottrina) non sono destinate "all'annullamento" (perchè, a tacer d'altro, rientrerebbero pur sempre nell'orbita della responsabilità contrattuale), bensì a sfociare, o meno, in una successiva struttura contrattuale. La mancata stipula del contratto cui esse risultano teleologicamente collegate può pertanto, in ipotesi, dar luogo a responsabilità precontrattuale (sulla cui natura molto si è discusso in dottrina e giurisprudenza, se essa debba, cioè, riconnettersi all'istituto della responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale ovvero ancora sia destinata a costituire un vero e proprio tertium genus intermedio), tutte le volte che (e solo se) mai esse non sfocino nell'alveo di una successiva convenzione negoziale, alla cui stipula, per converso, consegue che per ciò solo esse perdono ogni autonomia e ogni giuridica rilevanza, e sotto il profilo risarcitorio convergono, perdendo ogni autonomia, in quella struttura contrattuale che, essa si, essa sola, potrà (in ipotesi) costituire fonte di responsabilità risarcitoria. Di talchè, nella ipotesi in cui la convenzione negoziale così divisa tragga linfa da condizioni diverse da quelle che avrebbero preso corpo se una parte non avesse tenuto un comportamento contrario a buona fede, la fattispecie di responsabilità legittimamente azionabile dal deceptus è (solo) quella contrattuale, e non più quella precontrattuale ex art. 1337 c.c. la cui configurabilità resta preclusa ed assorbita nella intervenuta stipula del contratto. Nè vale obbiettare che, nella specie, il negozio concluso aveva natura di contratto preliminare, il cui oggetto (tradizionalmente identificato nella prestazione di un futuro consenso) non consentirebbe un autonomo esperimento dell'azione risarcitoria ex contractu, legittimamente riferibile, di converso, alle precedenti trattative intercorse tra le parti. Al di là della inesattezza tout court di tale affermazione, va in questa sede rammentato come la più recente giurisprudenza di legittimità e la più avvertita dottrina si sia indotta a rifiutare (in consonanza con le innegabili evoluzioni economiche e normative dell'istituto) la costruzione del preliminare in termini di puro e nudo pactum de futuro contraendo. Questa stessa Corte, con una recente sentenza resa a sezioni unite (Cass. 1624/2006), nel negare ogni fondamento alla teoria che esclude la legittimità della prestazione del promittente venditore di un bene altrui concretantesi (anche) nel "procurare" il trasferimento del bene al promissario acquirente direttamente dal terzo proprietario senza necessità di un doppio trapasso, e nel predicare il principio secondo il quale l'identità del venditore è del tutto indifferente per il compratore, poichè "la conclusione del definitivo non assorbe nè esaurisce gli effetti del preliminare, che continua, viceversa, a regolare i rapporti tra le parti, sicchè il promettente venditore resta responsabile per il caso di evizione e per i vizi", approda infine alle sponde di un moderna concezione del preliminare inteso come struttura negoziale destinata già (quantomeno in ipotesi di cd. "preliminare 292 impuro" ovvero "a prestazioni anticipate") a realizzare un assetto di interessi prodromico a quello che sarà compiutamente attuato con il contratto definitivo, sicchè il suo oggetto diviene non solo e non tanto un tacere consistente nel manifestare successivamente una volontà rigidamente predeterminata quanto alle parti e al contenuto, ma anche e soprattutto un (sia pur futuro) dare, consistente nella trasmissione del diritto (dominicale o quant'altro), che costituisce, alfine, il risultato pratico avuto di mira dai contraenti. Così, la stessa mappa genetica del preliminare "impuro" (quale quello di specie, essendo la prestazione a carico della parte promissoria acquirente in gran parte già stata eseguita) ne risulta rimodellata, restandone esclusa la configurabilità in termini di mero pactum de contahendo, sicchè, a più forte ragione, la confluenza tout court, in esso, degli atti di trattativa che lo abbiano preceduto risulta incontestabile. Ne consegue che, stipulato il contratto preliminare, l'unica azione a disposizione della promissaria acquirente già esecutrice di parte della propria prestazione era quella contrattuale ex art. 1443 c.c. (versandosi in ipotesi di contratto di persona incapace legalmente presunta tale per effetto della sentenza di inabilitazione), e che l'azione extracontrattuale, così come proposta dalla società IFI nella specie, non poteva avere ad oggetto, come pure ribadito in questa sede dal controricorrente, gli atti di trattative condotte in (supposta) malafede dalla controparte. Nè legittimo sarebbe il richiamo al principio della cumulabilità, nel nostro ordinamento, dei due tipi di responsabilità da illecito civile, poichè il principio predetto è legittimamente invocabile quando uno stesso fatto autonomamente generatore di danno integri gli estremi tento dell'inadempimento contrattuale, quanto del torto aquiliano (ciò che accade, ad esempio, nell'ipotesi di lesioni subite dal lavoratore per inosservanza di norme antinfortunistiche), ma non anche nell'ipotesi in cui una attività prenegoziale astrattamente generatrice di danno (le trattative) confluisca fisiologicamente nel negozio cui essa risultava funzionalmente e teleologicamente collegata, risultando, in tal caso, soltanto il negozio stesso la eventuale fonte di responsabilità (contrattuale). Il secondo e terzo motivo del ricorso, attinenti al profilo della capacità dell'inabilitato e della relativa prova, pur fondati sotto il profilo giuridico, sono assorbiti nell'accoglimento del primo motivo. Il ricorso è, pertanto, accolto, e il processo rinviato alla Corte di appello di Trento che, nel provvedere anche alle spese del presente giudizio, si atterrà ai principi di diritto suesposti. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Trento. Così deciso in Roma, il 26 aprile 2006. Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2006. 293 CEDIBILITA’ DEL CONTRATTO DI OPZIONE TRACCIA: Tizio e Caio redigevano un contratto di opzione relativo alla cessione di 150 libri; in particolare, i due si accordavano nel senso che il primo proponeva irrevocabilmente al secondo, che si riservava di accettare, la vendita dei 150 libri ad un prezzo che sarebbe stato determinato dallo studioso di libri antichi Sempronio. Caio versava a Tizio una somma pari ad euro 100,oo. Successivamente, Caio incontrava Quarto e gli cedeva l’opzione, all’insaputa di Tizio, a fronte del pagamento di euro 110,oo. Così, Quarto si recava da Tizio per acquistare i libri, ma quest’ultimo si adirava, ritenendo insussistente il diritto vantato da Quarto. Quarto si recava dall’avvocato Quinto. Il candidato, assunte le vesti di Quinto, rediga motivato parere sulla questione giuridica prospettata. POSSIBILE SOLUZIONE SCHEMATICA: In premessa era utile sintetizzare il fatto. Successivamente, il problema giuridico doveva essere collocato nell’ambito della cessione dell’opzione: è valida la cessione del contratto di opzione eseguita da Caio in favore di Quarto? In senso negativo, deporrebbe il fatto che il negozio giuridico intercorso tra Tizio e Caio sembrerebbe avere carattere strettamente personale, tanto che lo stesso Caio si adirava quando veniva a sapere della cessione in favore di Quarto; se, allora, si attribuisce natura giuridica personale al contratto di opzione, indubbiamente, la cessione dello stesso in favore di Quarto non avrà valore e dovrà essere caducata. Davvero si può dire che si tratta di contratto a contenuto personale? Invero, potrebbe non essere così, laddove si pensi al fatto che la personalità di una prestazione deriva, generalmente, dall’infungibilità di una certa prestazione (soprattutto nelle obbligazioni aventi ad oggetto un facere) e non da prestazioni fungibili a contenuto patrimoniale (aventi ad oggetto un dare, nel caso di specie); id est, Tizio e Caio sembrano aver realizzato un contratto a contenuto patrimoniale più che personale, in quanto non emerge alcun dato tipico della personalità come della prestazione come l’infungibilità ed il facere specifico, quanto piuttosto una prestazione patrimoniale (fungibilità e dare). Da questo angolo prospettico, allora, vi potrebbe essere spazio per la disciplina della cessione del contratto, ex art. 1406 c.c, che, comunque, richiederebbe il consenso di Tizio, ovvero la cessione del credito, ex art. 1260 c.c., che, al contrario, non richiederebbe tale consenso (anche senza il consenso del debitore). 294 D’altronde, a favore del fatto che si tratti di credito, ben potrebbe deporre il rilievo che, nell’ambito dell’ampio concetto di credito sono compresi anche i cc.dd. diritti potestativi, tra i quali vi è, indubbiamente, il diritto dell’oblato nell’opzione. Sotto tali profili, allora, Quarto ben potrà far valere le sue pretese creditorie verso Tizio, tanto più che, nella sostanza, vi è stata una successione inter vivos a latere creditoris. L’argomento può essere approfondito sul testo di Bianca, Il contratto, giuffrè. ATTI GIURIDICI UNILATERALI ATIPICI TRACCIA: Tizio celibe e senza figli, un anno prima di morire faceva testamento così disponendo: “nomino erede universale Caio, figlio di mio fratello Sempronio, e lego all’altro mio nipote Filano il fondo Tusculano di proprietà di Caio; il trasferimento del bene dovrà avvenire entro un mese dalla mia morte, altrimenti Caio dovrà pagare una penale giornaliera di 1000euro al legatario”. Dopo vendi giorni dalla morte di Tizio, Caio si recava dal notaio Romolo spiegandogli che Filano era all’estero e non sarebbe tornato prima di un anno. Caio e Romolo formalizzavano un atto unilaterale di trasferimento del bene Tusculano. Dopo un anno, Filano tornava in Italia e veniva a conoscenza dell’atto che gli faceva acquisire la proprietà del fondo Tusculano, ma riteneva non fosse valido perché stipulato in sua assenza. Il candidato, premessi brevi cenni sul problema della tipicità degli atti unilaterali, rediga motivato parere sulla questione giuridica prospettata, evidenziando argomentazioni favorevoli a Caio. POSSIBILE SOLUZIONE SCHEMATICA: In premessa poteva essere utile ricostruire sinteticamente il fatto. Successivamente, era fondamentale chiedersi se l’atto (unilaterale) fatto da Caio, avente ad oggetto il trasferimento del bene Tuscolano, in favore di Filano potesse ritenersi valido, oppure invalido, con il rischio di far pagare all’erede universale (Caio) una penale giornaliera di 1000euro al legatario (Filano). Il problema principale da risolvere ai fini della soluzione del caso riguardava, essenzialmente, l’ammissibilità nel nostro ordinamento di atti giuridici unilaterali atipici, in quanto se si opta per la tesi positiva il negozio giuridico (o atto unilaterale) realizzato da Caio sarà valido e non sarà tenuto a pagare la penale, mentre se si opta per la tesi negativa l’atto realizzato da Caio sarà invalido e dovrà 295 pagare la penale in favore di Filano (salvo un’ eventuale tesi di impossibilità sopravvenuta). La tesi classica propende la tesi negativa: sussisterebbe il dogma del numerus clausus, in base al quale il negozio giuridico non può produrre effetti per soggetti diversi dal suo autore fuori dei casi espressamente previsti (a ciò si aggiunge che tali atti costituiscono l’esercizio di diritti potestativi, i quali sarebbero, a loro volta, tassativi). A sostegno di tale ricostruzione, si dice, deporrebbe lo stesso art. 1987 c.c. che, in sostanza, sancendo la nominatività delle promesse unilaterali (fuori dei casi ammessi dalla legge la promessa unilaterale non produce effetto), affermerebbe il principio generale della tipicità dei negozi giuridici unilaterali con efficacia obbligatoria. Secondo altra impostazione, invece, al problema posto bisognerebbe dare risposta positiva, con la conseguenza di ritenere ammissibili gli atti unilaterali atipici. Infatti, se gli effetti che si producono nella sfera di terzi sono incrementativi o, comunque, vi sia la possibilità di rifiuto, l’autonomia negoziale dovrebbe, a rigore, prevalere sul dogma della tassatività, soprattutto perché, come evidenziato da certa dottrina, sarebbe anacronistico far restare valido il principio della intangibilità della posizione giuridica dei terzi, laddove questi ultimi, in concreto, siano stati avvantaggiati. Lo stesso dato letterale dell’art. 1987 c.c. potrebbe anche essere superato, laddove si pensi all’art. 1324 c.c. da leggere in combinato con l’art. 1322 c.c.: se è possibile applicare la disciplina giuridica dei contratti anche agli atti unilaterali, allora, de plano, sarà possibile estendere i principi relativi al contratto, tra cui l’art. 1322 c.c, anche agli atti unilaterali, con il corollario applicativo di arrivare a ritenere ammissibili gli atti unilaterali atipici. In termini più semplici, l’art. 1324 c.c. letto in combinato disposto con l’art. 1322 c.c. sembrerebbe deporre a favore della tesi dell’ammissibilità di atti unilaterali atipici. Ne segue, pertanto, che di fronte al contrasto tra l’art. 1987 c.c. e gli artt. 13221324 c.c., bisognerebbe optare per una tesi coerente con l’intero sistema giuridico, per cui gli atti unilaterali atipici dovrebbero ritenersi ammissibili nella misura in cui sono favorevoli al soggetto verso cui spiegano effetto. Accogliendo tale ricostruzione, allora, l’atto unilaterale atipico stipulato da Caio ben potrebbe spiegare effetto verso Filano, in quanto, nel complesso, quest’ultimo è avvantaggiato. D’altronde, Caio era obbligato a realizzare il trasferimento del fondo Tuscolano entro breve tempo, per cui non poteva attendere il rientro dall’estero da parte di Filano; la stessa tesi dell’impossibilità sopravvenuta ad adempiere il trasferimento, poi, avrebbe comportato in concreto un danno a Filano, in quanto non avrebbe potuto acquisire il bene nel tempo previsto, quanto piuttosto in modo tardivo. Ulteriore problema che era necessario porsi era se il trasferimento del fondo Tuscolano fosse accompagnato da un’effettiva causa, poiché diversamente vi sarebbe la nullità del trasferimento per carenza di causa. Il problema (che si riferisce all’istituto del pagamento traslativo), invero, alla luce della dottrina più autorevole e giurisprudenza, andrebbe risolto in favore della sussistenza della causa; infatti, la causa esiste, seppure è esterna all’atto traslativo, perché si fonda sul negozio (testamento) da cui è nato l’obbligo di trasferimento. 296 Da questa angolazione prospettica, pertanto, l’atto unilaterale atipico stipulato da Caio sarà pienamente valido ed efficace, con il corollario applicativo che Filano non avrà diritto ad alcuna penale. Si consiglia di rivedere l’argomento dal testo di Gazzoni, Manuale di diritto privato, ESI. BONDS - TRUFFA TRACCIA: Tizio si reca alla banca Marxillus per investire parte del proprio capitale in bonds. Il funzionario Certizzo della banca Marxillus consiglia a Tizio di investire parecchio nei bonds della affidabile società Lattex, seppur consapevole di un probabile fallimento. Tizio acconsente, investendo in concreto parecchio denaro nell’acquisto dei Bonds consigliati da Certizzo. Dopo due mesi dall’investimento, la società Lattex fallisce e Tizio si reca da un avvocato. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere. POSSIBILE SOLUZIONE SCHEMATICA: In premessa poteva essere utile ricostruire sinteticamente il fatto. Che strumenti di tutela può vantare Tizio? Sul punto vi sono almeno tre tesi. Secondo una prima ricostruzione, Tizio potrebbe agire (verso Certizzo e/o Lattex) facendo valere la nullità dell’acquisto dei propri bonds; in particolare, si tratterebbe di una nullità virtuale, ex art. 1418 c.c., in quanto sarebbero stati violati gli artt. 21 e 190 T.U.F. che avrebbero portata imperativa, in quanto norme poste a tutela dell’ordine pubblico, in un’ottica costituzionalmente orientata (ex art. 47 Cost.). Secondo altra ricostruzione, Tizio potrebbe agire verso Certizzo con un’azione di responsabilità contrattuale, in quanto l’intermediario Certizzo non avrebbe rispettato l’art. 23 dello stesso T.U.F.; in questo senso, precisamente, Tizio potrebbe far risolvere il contratto relativo all’acquisto di bonds della società Lattex, ex art. 1453 c.c., fatto salvo, comunque, il diritto al risarcimento dei danni subiti. Ultima testi (preferibile) pone l’accento non tanto sul momento successivo al contratto, quanto piuttosto sul momento genetico, sottolineando come, nella sostanza, il procedimento di formulazione del contratto di acquisto di bonds sia viziato, sub specie di errore essenziale, ex art. 1429 c.c. 297 In effetti, il contratto non viene formato in modo libero da vizi, laddove l’informativa non sia stata adeguatamente fornita. Sotto tale angolazione, allora, Tizio potrà esperire l’azione di annullamento del contratto di acquisto dei bonds. Si veda Viola, Le conseguenze civili della vendita di bonds a rischio, in Studium Iuris, 10/2006, 1207-1208. Si consiglia di leggere le sentenze che seguono (seppur di merito). - Gli investitori di bonds che non hanno avuto un’adeguata informazione hanno diritto a risolvere il contratto per inadempimento. Tribunale di Genova, Sentenza 15 marzo 2005 N. 1230 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano il Tribunale di Genova sezione I civile in composizione collegiale, in persona di dott. A Dimundo presidente dott. F. Maganza giudice dott. D. Canepa giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da L.F., residente a Genova ed ivi elettivamente domiciliata in Via Santa Zita 1/5, presso lo studio dell'Avv. Mauro Mortello, che la rappresenta e difende in giudizio come da mandato a margine dell'atto di citazione, unitamente all'avv.. Alessandro Orlando del foro della Spezia -attore contro BIPIELLE Società di Gestione del Credito s.p.a. quale mandataria procuratrice della Banca Popolare di Lodi s.c. a r.l., corrente in Lodi ed ivi elettivamente domiciliata in Via G. D'Annunzio 2/56 Genova, presso lo studio dell'Avv.Ennio Lucarelli, che la rappresenta e difende in giudizio come da procura speciale del 7.8.2002 - convenuta CONCLUSIONI DELLE PARTI Per L.F.: dichiarare la nullità del contratto di compravendita delle obbligazioni per violazione delle norme imperative di cui al TUF ed in relazione all'art 1418 c.c. condannando per l'effetto la società convenuta alla restituzione della somma di € 115.612,010, oltre interessi legali dal 27.07.2000 al saldo e rivalutazione monetaria, in subordine, riconoscere e dichiarare l'annullamento del medesimo contratto ai sensi dell'art. 1427 c.c. condannando per l'effetto la società convenuta alla restituzione della somma di € 115.612,010, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in via ulteriormente subordinata, riconoscere e dichiarare il grave inadempimento della banca convenuta per tutti i comportamenti posti in essere all'atto della vendita delle obbligazioni e pertanto risolvere il contratto de quo, nonché condannare per l'effetto la società convenuta alla restituzione dell'investimento e comunque al risarcimento del danno, oltre interessi e 298 rivalutazione monetaria. Condannare parte convenuta alle spese, diritti ed onorari tutti di giudizio. Per BIPIELLE Società di Gestione del Credito s.p.a. quale mandataria e procuratrice della Banca Popolare di Lodi s.c. a r.l, corrente in Lodi: Respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione; respingere in quanto infondate in fatto e in diritto le domande tutte proposte nei confronti della banca convenuta dalla signora L.F.; condannare di conseguenza la attrice alla refusione delle spese, diritti ed onorari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 16.3.2004 L.F. conveniva in giudizio il Banco di Chiavali e della Riviera Ligure allo scopo di ottenere da questo Tribunale pronuncia di dichiarazione di nullità del contratto di compravendita delle obbligazioni per violazione delle norme imperative di cui al TUF ed in relaziona all'art. 1418 c.c. condannando per l'effetto la società convenuta alla restituzione della somma di € 115.612,010. in subordine, chiedeva di dichiarare l'annullamento del medesimo contratto ai sensi dell'art. 1427 c.c. condannando per l'effetto la società convenuta alla restituzione della somma di € 115.612,010, in via ulteriormente subordinata, chiedeva di dichiarare il grave inadempimento della banca convenuta per tutti i comportamenti posti in essere all'atto della vendita delle obbligazioni e pertanto risolvere il contratto de quo, nonché condannare per l'effetto la società convenuta alla restituzione dell'investimento e comunque al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Assumeva a sostegno che era correntista del Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, che il 27.7.2000 aveva acquistato dall'istituto di credito un titolo obbligazionario CIRIO FINANCE FR03 per un controvalore pari a € 115.612,010, che il titolo le era stato consigliato dal funzionario addetto all'Ufficio Titoli della agenzia di Nervi della Banca, che l'addetto titoli non aveva fatto presente che le suddette obbligazioni avevano un margine di rischio superiore ai titoli di Stato, né la gravità della situazione debitoria del gruppo CIRIO, che era una investitrice con profilo di rischio "basso" in quanto aveva sempre investito in titoli obbligazionari, che fino al "default" del primo titolo del gruppo CIRIO del 4.11.2002 parte attrice si era recata più volte presso l'agenzia per chiedere delucidazioni circa, l'investimento e veniva sempre rassicurata circa il buon esito dell'operazione, che il 8.4.2003, dopo il primo "default", i funzionari la rassicuravano ulteriormente circa la mancata pèrdita di valore del titolo che veniva ancora inserito fra le sue poste attive. Esponeva che le obbligazioni acquistate appartenevano a emissioni effettuate da parte di società estere controllate da Cirio Holding s.p.a. facenti parte del Gruppo Cirio, il cui indebitamento finanziario, in gran parte rappresentato da debito bancario a breve, era passato dai 280 mln. circa di euro del 1996 a 870 mln. di euro nel 1999, che nel periodo 2000-2002 vi è stato il progressivo spostamento dell'indebitamento del gruppo dalle banche alle obbligazioni in quanto i debiti bancari, che avevano raggiunto a fine '99 il massimo di circa 900 mln di euro, si riducono a poco più di 300 min nel 2002 mentre il debito consolidato sotto forma di obbligazioni raggiunge alla medesima data l'ammontare di circa 850 mln. La crescita del debito sotto forma di obbligazioni determina quindi una netta riduzione dell'esposizione bancaria. Ricorda parte attrice che le obbligazioni vendutele dalla convenuta appartenevano a emissioni effettuate da società estere controllate da Cirio Holding s.p.a. dal Gruppo Cirio, il quale tramite sei società aveva emesso obbligazioni per complessivi € 1.125 mln., che le obbligazioni non erano accompagnate da prospetto informativo essendo riservate ad investitori istituzionali, come risultante 299 dalla offering circular e non potevano formare oggetto di sollecitazione al risparmio indistinto; che i fondi raccolti con i titoli emessi da Cirio Finance Luxemburg s.a. erano stati pressoché interamente versati alla Cirio s.p.a., i cui debiti bancari a seguito dell'emissione, si erano ridotti di oltre 130 mln di euro rispetto al livello raggiunto nel 1999 o, nel 2001, l'importo derivante dall'emissione della Ciro Holding Luxemburg s.a. era stato girato a titolo di finanziamento a varie società del Gruppo. Sostiene parte attrice la responsabilità della banca convenuta in quanto inadempiente agli obblighi generali di buona fede e correttezza e per aver scientemente violato la normativa in materia di prodotti finanziari. In particolare, secondo la tesi di parte attrice, la banca avrebbe violato l'art. 21 TUF per il comportamento tenuto nei confronti dell'investitore, il contratto sarebbe nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. per contrarietà alle norme imperative di cui al D. Lgs. 24.2.1998 TUF, è comunque annullabile per vizio del consenso dell'investitore ai sensi dell'art. 1427 c.c, sarebbe in ogni caso risolvibile per inadempimento contrattuale della banca, alla quale è altresì addebitabile una responsabilità precontrattuale e un conflitto di interessi, oltre che uno specifico inadempimento all'obbligo di non vendere agli investitori "retail". Parte convenuta si costituiva in giudizio contestando le opposte pretese delle quali chiedevano il rigetto. Rilevava che era stata la cliente, debitamente sconsigliata dal funzionario di banca che l'aveva avvertita dei rischi dell'investimento a voler effettuare comunque l'operazione, che pertanto erano state rispettate dall'istituto di credito tutte le prescrizioni normative. Dopo lo scambio di memorie di repliche veniva ai sensi dell'art. 12 comma III del D.lgs. 5/2003 fissata l'udienza di discussone della causa davanti al Collegio e le parti provvedevano a depositare le memorie conclusionali. Rigettate le istanze istruttorie volte all'escussione del teste funzionario della banca che aveva curato l'operazione bancaria ed acquisita la documentazione prodotta dalla banca convenuta, le parti insistevano nelle rispettive difese. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda della parte attrice è volta ad ottenere la condanna della banca alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di investimento, in quanto l'istituto di credito avrebbe violato l'art. 21 TUF per il comportamento tenuto nei confronti dell'investitore; il contratto è nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. per contrarietà alle norme imperative di cui al D. Lgs. 24.2.1998 TUF; è comunque annullabile per vizio del consenso dell'investitore ai sensi dell'art. 1427 c.c.; è in ogni caso risolvibile per inadempimento contrattuale della banca, alla quale è altresì addebitabile una responsabilità precontrattuale e un conflitto di interessi, oltre che uno specifico inadempimento all'obbligo di non vendere agli investitori "retail". Partendo dall'esame di quest'ultimo rilievo si osserva che il caso in esame non si colloca nella fase di mercato primario (o di emissione), che intercorre fra l'emissione del titolo da parte dell'impresa, avvenuta, in concreto, adottando non la modalità di offerta diretta al pubblico (sollecitazione all'investimento), ma l'offerta diretta a investitori istituzionali, e la sua sottoscrizione da parte dell'investitore, bensì nella fase successiva di mercato secondario, in cui il titolo, già in possesso dell'investitore, viene negoziato con altro investitore. Si tratta di una modalità di vendita dei tutto legittima, che, peraltro, deve avvenire secondo regole contenute nel TUF e nella regolamentazione attuativa emanata dalla Consob per disciplinare l'attività degli intermediari finanziari. A quest'ultima categoria appartengono anche, le banche, quali soggetti abilitati alla sollecitazione 300 all'investimento cioè all'offerta al pubblico di vendita o sottoscrizione di prodotti finanziari, tra i quali rientrano le obbligazioni negoziabili sul mercato dei capitali (art. 18 D.Lgs. 24.2.1998 n.58). La rigorosa disciplina di vigilanza contenuta nel D. Lgs. 1.9.1993 n. 383 (TUB) è volta ad assicurare un regime di ampia garanzia nel rispetto del principio di trasparenza sancito dall'art. 11 TUB nell'esercizio dell'attività creditizia e richiamata dalla norma di rinvio contenuta nel comma 4° dell'art.19 D. Lgs. 24.2.1998 n.58 (TUF), che stabilisce i requisiti occorrenti per svolgere l'attività bancaria in senso tecnico e i requisiti di affidabile ingresso dell'ente creditizio nel settore dell'intermediazione finanziaria non bancaria. (v. Tribunale di Roma sentenza dell'8.10.2004). La normativa di settore è raccolta nel T.U. 24.2.'98 n.58 delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e del successivo regolamento attuativo del 1.7.'98 che ha specificato i doveri degli intermediari conglobati nei principi codificati nel richiamato testo unico. Tale normativa integra lo statuto dell'intermediatore finanziario e deve applicarsi come regola generale di comportamento a tutte le operazioni eseguite ove non sia disposto diversamente dalla legge. In particolare l'art. 21 TUF impone agli intermediari nell'attività di servizi di investimenti ed accessori di: a- comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; b- acquisire le informazioni necessarie dei clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c- organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque aiclienti trasparenza ed equo trattamento; d- disporre di risorse e procedura, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi; e- svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati. La banca convenuta assume la piena legittimità delle operazioni compiute sottolineando che la richiesta di acquisto è stata formulata dal cliente e che essa ha dovuto accettare detta richiesta, in quanto dopo aver avvertito l'investitore della non adeguatezza dell'operazione non aveva a disposizione alcuno strumento per non dare seguito all'investimento avendo parte acquirente reso la dichiarazione di cui all'art.28 TUF. In realtà i doveri imposti dalla banca si sostanziano essenzialmente nel dovere di informarsi e nel dovere di informare. Nel caso concreto, la violazione da parte della convenuta di tali doveri è consistita, in primo luogo, nella violazione delle regole generali di comportamento sancite dall'art. 21 co. 1 lett. d) TUF: "disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi" e dall'art. 26 D. Consob 11522/98, tra le quali alla lett. e) è previsto che "Gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare.., e) acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dai servizi nonché dei prodotti diversi dal servizi di investimento, propri o di terzi, da essi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire." La suddetta normativa pone a carico degli intermediari e nell'interesse degli investitori un obbligo di conoscenza, che è più della semplice informazione, sui 301 prodotti da loro offerti, conoscenza che si estende alla loro provenienza, alla situazione degli stessi nei mercati, alla loro destinazione tra il pubblico dei consumatori. Va sottolineato che si tratta di conoscenza che l'investitore risparmiatore, per esperienza, per cultura o per diverso campo lavorativo non potrà mai acquisire, pervenendo ad un giudizio completo sulla operazione finanziaria che si appresta a sottoscrivere. Tanto più, se si considera che la negoziazione in esame è stata posta in essere per un titolo "non quotato" e in assenza di rating. ( v. Tribunale di Roma sentenza dell'8.10.2004). Le circostanze dedotte da parte attrice, da considerare provati ai sensi dell'art 13 D.Lgs. 5/2003, evidenziano che la banca si è del tutto sottratta al dovere di informare la cliente in ordine alla tipologia e affidabilità del titolo e, dunque, al livello relativo di adeguatezza e, comunque, ha assunto in tale attività un comportamento non diligente e non rispondente al "need of protection" degli investitori non professionali. La violazione da parte della convenuta degli obblighi a suo carico è consistita, in secondo luogo, nel non aver adeguatamente tenuto in considerazione le informazioni acquisite dal cliente nella esecuzione dell'operazione, che avrebbe dovuto essere conforme a quei principi di diligenza, correttezza e trasparenza, imposti dalla lett. a dell'art. 21 TUF e dalle generali prescrizioni del codice civile secondo il disposto dell'art. 1337 c.c. Si ricorda che l'art. 29 del regolamento CONSOB impone agli intermediari di astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. Dispone in tal senso il 1° comma dell'art. 29 D. Consob 11522/98 che: "Gli intermediari finanziari si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'art. 28 e di ogni altre informazione disponibile in ordine ai servizi prestati." Di conseguenza, l'acquisizione della dichiarazione di cui all'art. 28 non esaurisce l'obbligo di diligenza imposto all'intermediario per dare corso all'operazione, dovendo questi tenere conto di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. Secondo una interpretazione prevalente nella giurisprudenza ed in dottrina, l'acquisizione delle notizie previste dall'art. 28 lett. A non è decisiva per stabilire se l'intermediario debba procedere o debba astenersi dall'operazione per inadeguatezza della stessa. In particolare, la Consob ha precisato con comunicazione n. DI/30396 del 21.4.2000 che: "...in nessun caso gli intermediari sono esonerati dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione disposta dai clienti, neanche nel caso in cui l'investitore abbia rifiutato di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale o finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio; nel caso la valutazione andrà condotta in ossequio dei principi generali di correttezza, diligenza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui l'intermediario sia in possesso (es. età, professione, presumibile propensione al rischio anche alla luce dalla pregressa ed abituale operatività, situazione del mercato...)". Per le specifiche informazioni rese e per essere l'investitore soggetto titolare di conti correnti presso la banca, le notizie in possesso dell'intermediario rendevano chiaro che si trattava di soggetto nei cui confronti l'operazione di negoziazione proposta non fosse adeguata sia in relazione alla sua situazione patrimoniale sia in relazione alla scarsa propensione al rischio. In conclusione l'intermediario è venuto meno all'obbligo di curare 302 l'interesse dell'investitore, obbligo che costituisce espressione del generale principio di correttezza e buona fede e impone al primo di valutare l'adeguatezza di ogni operazione disposta dal secondo (art. 29 Reg. Consob. N. 11522/98). La circostanza che all'investitore sia stato consegnato il documento sui rischi generali degli investimenti finanziari non è sufficiente a soddisfare tale esigenza di tutela del risparmiatore, trattandosi di informativa del tutto generica che non garantisce quella conoscenza concreta ed effettiva del titolo negoziato che l'intermediario deve assicurare in modo da rendere il cliente capace di tutelare il proprio interesse e di assumersi consapevolmente i rischi dell'investimento compiuto.( v. Tribunale di Roma sentenza dell'8.10.2004) Si ricorda che la norma regolamentare in materia dispone che in presenza di una operazione non adeguata l'intermediario debba astenersi dal dare esecuzione all'operazione se prima non abbia avvertito l'investitore e ottenute dal medesimo l'espressa autorizzazione ad agire ugualmente. Questo onere della banca è funzionale alla realizzazione del migliore risultato possibile per il cliente; una valutazione che va fatta non in senso assoluto ma (come specificato anche nell'alt. 26 lett. f del suddetto regolamento) in relazione al livello di rischio prescelto per sé da ciascun investitore. Si ritiene che la sola ipotesi in cui tali obblighi di valutazione dall'adeguatezza e di correlata astensione dall'agire non si applicano è quella in cui il servizio prestato si limiti alla mera esecuzione o trasmissione degli ordini dell'investitore, senza che sia fornita dall'intermediario alcuna indicazione circa le operazioni da effettuare e sempre che vi sia stata da parte dell'intermediario una preventiva individuazione scritta dei limiti quantitativi e delle tipologie di strumenti finanziari, di operazioni e di ordini entro i quali le operazioni sono considerate automaticamente adeguate (ed. execution only). Ne caso in cui, invece, tale servizio consegue ad una consulenza anche solo illustrativa o strumentale, l'intermediario svolge un ruolo attivo nel processo formativo della volontà dell'investitore e, pertanto, sussiste a carico dell'intermediario l'obbligo di valutazione. Nella presente fattispecie, questa attività di consulenza deve ritenersi avvenuta avendo parte attrice affermato di essersi indotta all'acquisto di titoli su indicazione dei funzionari preposti, considerato, altresì, che non aveva l'investitore alcuna possibilità di conoscere altrimenti tali titoli, in quanto la relativa negoziazione è avvenuta per un titolo "non quotato". Ha dedotto dei capitoli di prova la Banca per tentare di dimostrare di aver avvertito l'investitore della non adeguatezza dell'investimento, ma ha indicato quale unico teste il funzionario della banca che ha curato l'operazione. Occorre a tale riguardo affrontare la questione sulla ammissibilità del teste Doriano Guglielmi, funzionario della banca che aveva curato l'investimento operato da parte attrice. L'interesse a partecipare al giudizio previsto come causa d'incapacità a testimoniare dall'art. 246 cod. proc. civ. si identifica con l'interesse a proporre la domanda e a contraddirvi previsto dall'art. 100 dello stesso codice, sicché deve ritenersi colpito da detta incapacità chiunque si presenti legittimato all'intervento in giudizio, senza che possa distinguersi tra legittimazione attiva e legittimazione passiva, tra legittimazione primaria e secondaria (intervento adesivo dipendente), tra intervento volontario e intervento su istanza di parte. In particolare, è incapace di testimoniare chi potrebbe, o sarebbe potuto, essere chiamato dall'attore, in linea alternativa o solidale, quale soggetto passivo della stessa pretesa fatta valere contro il convenuto originario, nonché il soggetto da cui il convenuto originario 303 potrebbe, o avrebbe potuto, pretendere di essere garantito ( v. Cass. 03/04/1998 n. 3432) La presente fattispecie rientra, pertanto, nella suddetta previsione in quanto ai sensi dell' art 2049 cod. civ. il committente è responsabile in solido con il dipendente nei confronti del danneggiato (v. Cass. 11/05/1973 n. 1267) per cui l'investitore avrebbe potuto convenire quale soggetto passivo della stessa pretesa fatta valere contro il convenuto originario anche il funzionario della banca che ha curato l'operazione finanziaria. Ne consegue che quest'ultimo è incapace a testimoniare secondo il disposto dell'art. 246 cod. proc. civ. Sostiene la banca convenuta che, comunque, l'investitore era stato informato della non adeguatezza dell'operazione attraverso l'ordine di acquisto dei titoli del 27.7.2000. L'ordine, prodotto in copia da entrambe le parti, in effetti presenta una doppia sottoscrizione dell'investitore. La seconda firma è stata apposta in calce ad una serie di opzioni diverse tra loro, che seguono la dizione : "vi informiamo che l'operazione oggetto del presente ordine: è una operazione non adeguata, in relazione:", cui seguono sei possibili ragioni di inadeguatezza e ancora " è una operazione in cui abbiamo un interesse in conflitto. Nessuna delle opzioni è stata, peraltro, barrata. L'unica croce è stata apposta in relazione alla dicitura: "è un'operazione non adeguata in relazione.:" Tale generica indicazione non può essere considerata, sicuramente, senza altre specifiche indicazioni, rispondere alla prescrizione di informare adeguatamente l'investitore degli specifici rischi suddetti secondo il disposto del comma 1, dell'art. 21 del d.lgs. 58 del 1998 e l'art. 28, comma 2, della deliberazione 1 luglio 1998 n. 11522, né si può ritenere che con quel generico avvertimento l'investitore sia stato messo al corrente "delle ragioni per cui non" fosse opportuno procedere" all'esecuzione di tale operazione secondo la prescrizione di cui all'art. 29, comma 3, della deliberazione 1 luglio 1998 n.11522. La suddetta conclusione viene altresì rafforzata dalla circostanza che il funzionario addetto, che ha seguito l'operazione, non ha neppure apposto la propria firma in calce alla suddetta generica dichiarazione. La banca stessa predisponendo il modulo firmato con l'indicazione dei vari motivi di inadeguatezza dell'operazione ha riconosciuto che il dovere di informativa doveva essere specifico e non riferito genericamente alla dicitura di non adeguatezza della operazione e barrando la relativa casella ha altresì riconosciuto che era consapevole della non adeguatezza dell'investimento con riferimento all'investitore. Essendo applicabile il co. 6 dell'art. 23 TUF a stregua del quale: "Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta." La banca convenuta avrebbe dovuto adempiere a detto onere. Non avendovi adempiuto, ne consegue che può concludersi nel senso che la Banca convenuta non ha affatto ottemperato agli specifici e circostanziati obblighi che la disciplina di settore le imponeva nei riguardi del cliente investitore, lasciando costui nell'ignoranza circa i reali rischi che l'operazione comportava. ( v. Tribunale di Taranto Sentenza n. 2273 del 27 ottobre 2004) Si ritiene, pertanto, accertata la violazione dei doveri di informarsi e di informare incombente sulla banca negoziatrice e, in particolare, l'omessa informazione sulle caratteristiche dei titoli venduti, sulla non destinazione primaria ai risparmiatori e sul grappo cui 304 appartengono le emittenti, merita, pertanto, accoglimento la domanda di risarcimento dei danni proposta da parte attrice. Al riguardo, si osserva che, secondo un maggioritario indirizzo giurisprudenziale, la violazione dell'obbligo del venditore di informare costituisce inadempimento in quanto: "nei contratti con prestazioni corrispettive i doveri di correttezza, di buona fede e di diligenza, di cui agli art. 1338, 1374, 1575 e 1175 c.c, si estendono anche alle cosiddette obbligazioni collaterali di protezione, di informazione, che presuppongono e richiedono una capacità discretiva ed una disponibilità cooperativa e, quindi, nel tenere conto delle controparti all'acquisto. Tali doveri ed obblighi impongono che l'imprenditore, anzitutto, si preoccupi dell'esatta specificazione delle caratteristiche del bene compravenduto al momento dell'acquisto (Cass.16.11.2000 n. 14865). In particolare la negoziazione dei prodotti finanziari deve avvenire secondo regole di diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti, specificate nel TUF e nel Regolamento attuativo della Consob, regole precise e dettagliate, in quanto i doveri di informazione richiesti agli intermediari si pongono come obbligazioni di carattere primario, il cui adempimento deve essere valutato a stregua dell'art. 1176 c.c. co. 2°, nel quale è indicato il criterio di determinazione della specifica diligenza richiesta nell'adempimento da parte di chi svolge attività professionale. La violazione delle regole di informazione e di valutazione dell'adeguatezza dell'operazione proposta ai clienti risparmiatori costituisce inadempimento imputabile all'intermediario e trattandosi di regole di comportamento esplicitamente codificate nell'interesse del cliente l'inadempimento è da porsi in relazione causale con l'evento dannoso. Ricade sull'intermediario l'onere di provare che tra la violazione ed il danno non vi è alcun nesso di causalità, dimostrando che il danno è derivato da eventi estranei alla sua sfera di azione e la convenuta nulla ha provato al riguardo.( v. Tribunale di Roma sentenza dell'8.10.2004). Bisogna, altresì, considerare che per i titoli negoziati, le agenzie più qualificate non avevano fornito il "rating" internazionale sicché, in assenza di tale dato, non era possibile accertare il grado di solvibilità del debitore e per questo i rischi dell'operazione dovevano ritenersi altamente elevati. Molteplici erano dunque gli elementi a conoscenza dell'istituto al momento della sottoscrizione dell'ordine, elementi che, ove adeguatamente ponderati, avrebbero indotto un soggetto particolarmente qualificato alla maggiore prudenza possibile e a evidenziare la rischiosità dell'investimento sconsigliando ai clienti un tale tipo di operazione. Nulla di tutto ciò risulta sia avvenuto nel caso in esame, certamente quella generica indicazione con riferimento ad un non precisato avvertimento di non adeguatezza dell'operazione non ha assolto all'onere in questione. Ancora osserva la banca che vi era nel caso in esame una mancanza di obbligo di trasmettere al cliente quel prospetto informativo che dette circostanze evidenzia, certamente vista la disciplina legislativa regolamentare e contrattuale fondata sulle informazioni circa i rischi che l'operazione di investimento comporta, non trattasi di circostanza che esimeva la banca da tale onere. Neppure può valere come esimente per la Banca la circostanza che parte attrice in quanto operante già in precedenza nel mercato borsistico attraverso l'acquisizione di titoli, erano consapevole del rischio che correva. 305 Sul punto occorre rilevare che l'acquisto dei titoli presenti nel suo portafoglio, obbligazioni, unitamente a quelli dello Stato, non trasforma automaticamente l'investitore in un soggetto esperto in grado di valutare i rischi dell'operazione. Resta da esaminare la prospettazione di parte attrice secondo cui nelle fattispecie sussisterebbe la nullità della operazione finanziaria. La nullità del contratto per violazione di norme imperative potrebbe conseguire all'applicazione dell'art. 1418, comma 1, c.c. La disciplina regolamentare e legislativa richiamata, di per sè fonte di responsabilità sotto il profilo sanzionatorio amministrativo, secondo il disposto dell'art. 190 del d.lgs. 58 del 1998, comma 1), è stata certamente emanata a protezione di un interesse pubblico. Parte della giurisprudenza condivisibile considera la sanzione amministrativa indice significativo della rilevanza in termini di interesse pubblico della norma alla cui protezione è posta ( v. Cass. 18/07/2003 n. 11247 e Cass. 3 novembre 2000 n. 14381; in senso contrario, Cass. 27 giugno 2002 n. 9380, Cass. 7 marzo 2001 n. 3272 e Cass. 25 febbraio 2000 n. 2135). Gli interessi di carattere eminentemente pubblicistico alla cui tutela la disciplina richiamata è protesa sono evidenti. In tale senso si esprime la Corte di legittimità, "non par dubbio che la normativa introdotta dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1... consideri interessi di carattere generale, che vanno dalla tutela dei risparmiatori uti singoli , a quella del risparmio pubblico, come elemento di valore' della economia nazionale, a quella della stabilità del sistema finanziario, come considerata dalla direttiva 93/22 CEE del 10 maggio 1993, alla esigenza di preservare il mercato da inquinamenti derivanti dall'impiego di risorse provenienti da circuiti illegali, a quella di rendere efficiente il mercato dei valori mobiliari, con vantaggi per le imprese e per la economia pubblica, interessi tutti chiaramente prevalenti su quelli del privato, che pure di riflesso ne rimane tutelato" (Cass. 7 marzo 2001 n. 3272). La violazione della disciplina del settore, che è stata posta a tutela di interessi generali, quindi pubblici, potrebbe comportare la nullità di quegli atti negoziali che siano conclusi in contrasto con essa. Peraltro, nel caso in esame non pare che si possa parlare di vizio genetico, relativo alla conclusione del contratto, bensì di vizio funzionale, che inerisce il contratto oramai perfezionatosi, e cioè di difetto che riguarda le prestazioni che dovevano esser rese sulla base del negozio concluso. ( v. Tribunale di Taranto Sentenza n. 2273 del 27 ottobre 2004). Resta da esaminare ancora la denunciata violazione dell'art 21 del TUIF il quale impone che una organizzazione che "riduca al minimo il rischio di conflitti di interessi e che "in situazione di conflitto", impone di "agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento". Si deve osservare relativamente alla eccezione svolta da parte attrice relativamente alla circostanza che la banca avesse agito in conflitto di interessi che è emerso come la banca non avesse i titoli nel proprio portafoglio ma li abbia acquistati sul mercato contestualmente al ricevimento dell'ordine da parte del cliente. La circostanza provata da documentazione prodotta dalla banca e non contestata esclude la sussistenza del conflitto di interessi nella fattispecie in esame. Va pertanto escluso che la banca abbia violato il disposto di cui agli artt. 21 I co. lett. e) d. lgs. 58/98 e 27 reg. Consob per non avere segnalato di avere un interesse in conflitto con quello del cliente ( v. Tribunale di Mantova sentenza del 18-32004) 306 Deve essere, infine, respinta la domanda di annullamento dei contratti per errore o dolo, non essendovi alcuna prova che la convenuta abbia artificiosamente indotto gli attori ad acquistare i titoli obbligazionari in questione per arrecare ad essi un danno, tale prova non potendosi certamente desumere dalla obiettiva situazione di forte indebitamento del Gruppo Cirio e dalla posizione di creditrice dello stesso rivestita dalla convenuta. Si conferma, pertanto, che nella fattispecie in esame possa ritenersi verificato un inadempimento, da parte della Banca convenuta, di un contratto già perfezionatosi, con ogni consequenziale pronuncia. Relativamente al danno si osserva che è pacifico essersi verificato il rischio che avrebbe dovuto costituire oggetto di apposita ed espressa informativa, ossia il default in relazione alle obbligazioni emesse, ossia essersi determinata l'assoluta incertezza in ordine al recupero del capitale investito, da parte del risparmiatore. La convenuta non ha neppure contestato la sussistenza del danno, che risulta evidente in quanto le obbligazioni non sono più negoziabili sul mercato e non appaiano, allo stato, suscettibili di rimborso. Ne consegue il diritto dell'investitore a recuperare il capitale investito nei confronti della banca che, col suo comportamento inadempiente, ha messo l'investitore inconsapevole nella situazione di accollarsi i rischi dell'investimento, per cui l'azione di recupero del capitale dovrà essere posta in capo all'inadempiente. Deve essere, pertanto, accolta la domanda di parte attrice con conseguente condanna della banca convenuta al rimborso della somma di € 115.612,010. Richiede parte attrice anche gli interessi e la rivalutazione monetaria, peraltro, non essendo stato dimostrato che investimenti finanziari alternativi avrebbero reso interessi superiori al tasso legale, sì ritiene di attribuirli in tale misura, dalla data dell'investimento, 27.7.2000, al saldo, considerato il mancato godimento della somma per tale periodo. Dalla soccombenza deriva che parte convenuto dovrà rispondere delle spese processuali sostenute dall'attore. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: in accoglimento della domanda di L.F., - dichiara la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta BIPIELLE società di gestione credito s.p.a, nella qualità di procuratrice speciale di Banca Popolare di Lodi s.c. a r.l. e la condanna a corrispondere a controparte la somma di € 115.612,010, oltre interessi legali dal 27.7.2000 al saldo; - respinge ogni altra domanda, - condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore degli attori complessivamente in € 5.300,00, di cui € 1.500,00 per competenze ed € 3.500,00 per onorari, oltre IVA, CPA e 12,5% rimborso spese generali. Genova, lì 7.03.2005 Il Presidente Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2005 N.1230 -Se la banca non informa correttamente gli investitori, vi sarà nullità del contratto realizzato. La violazione dei doveri di informativa, secondo l'indirizzo dominante della giurisprudenza, comporta la nullità dei relativi contratti conclusi e ciò in 307 considerazione della peculiare rilevanza degli interessi protetti di natura pubblicistica, identificabili con la tutela dei risparmiatori soggetti deboli e in forte asimmetria informativa rispetto agli operatori abilitati del risparmio pubblico, della correttezza ed efficienza del mercato dei valori mobiliari. Il Tribunale di Palermo III Sezione Civile Sentenza N. 3293-2005 all'esito della discussione orale di cui alla udienza collegiale del 13 maggio 2005, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in parziale accoglimento delle domande proposte da L.C. e L.V., con atto di citazione notificato il 7 maggio 2004, dichiara la nullità dei contratti di vendita di obbligazioni Del Monte al 6,625% con scadenza il 24.5.2006 per il controvalore di € 10.000.00 sottoscritto in data 08.6.2001 da L.V.; e di obbligazioni Cirio Del Monte al 7,75% con scadenza il 14.3.2005 per il controvalore di € 25.000,00 sottoscritto in data 03.4.2002 da L.C. condanna Banca XXX alla restituzione in favore degli attori della somma di € 34.754..52, oltre interessi come per legge dalla data della citazione sino al soddisfo; rigetta ogni altra domanda; Motivi della decisione L.C. e L.V. espongono di ave concluso, su suggerimento di un promotore finanziario dell’istituto di credito convenuto, tale XX, il quale si era fatto garante della sicurezza e del buon rendimento dell’investimento, contratti di vendita di obbligazioni Del Monte al 6,625% con scadenza il 24.5.2006 per il controvalore di euro 10.000,00 (sottoscritto in data o8.6.2001 da L.V.); e di obbligazioni Cirio Del Monte al 7,75% con scadenza il 14.3.2005 per i controvalore di euro 25.000,00 (sottoscritto in data 03.04.2002 da L.C.). Lamentano poi la mancata consegna del documento informativo sui rîschi generali correlati agli investimenti finanziari, del contratto di apertura del dossier titoli, della scheda relativa al profilo dell’investitore. Continuano esponendo che il 3 novembre 2002 uno studio legale inglese ( d. Trustee, organo privato che cura le vicende relative alla sottoscrizione dei titoli), aveva dapprima dichiarato il default (messa in mora) della emittente i titoli in quanto resasi inadempiente alle restituzione dei prestiti alla scadenza e poi il cross default, cioè la dichiarazione di inadempimento di altre prestiti obbligazionari emessi da società facenti parte del gruppo Cirio, ma con sede in Lussemburgo. Fallito l’investimento e compromessa non solo la possibilità di percepire gli interessi ma addirittura di recuperare il capitale investito, gli attori censurano la condotta negoziale della banca, in riferimento tanto a disposizioni di legge (D. Lgs n 24.2.1998 n. 58, c.d. TUF) che regolamentari (delibera Consob 1.7.1998 n. 11522) disciplinanti in materia dell'intermediazione finanziaria e poste a presidio di interessi generali, taluni di rango costituzionale, ed invocando l’invalidità e inefficacia del contratto concluso. In particolare contestano alla convenuta: - di non aver raggiunto un apprezzabile livello di conoscenza dei prodotti finanziari compravenduti; - di aver contravvenuto agli obblighi Preliminari alla prestazione del servizi di investimento proponendo a risparmiatore inesperto - senza renderlo edotto del rischio connesso all'investimento, senza segnalargli l’inadeguatezza 308 dell’operazione rispetto alle sue propensioni ed anzi fornendogli dichiarazioni fuorvianti - l'acquisto di titoli emessi da una società straniera in uno stato estero, ove non vigevano gli stringenti limiti all'emissione di prestiti obbligazionari dettati dal codice civile italiano a garanzia della restituzione, non quotati nei mercati regolamentati e negoziati solo nei servizi di scambi organizzati, privi di prospetto informativo in quanto destinati ad un pubblico di investitori professionali, non assistiti da alcuna valutazione circa il merito di credito della società emittente; - di non aver informato il risparmiatore della precipitosa riduzione del valore dei titoli e dunque del patrimonio investito. Perciò, dopo il rituale scambio di memorie, con l'istanza di fissazione di udienza hanno concluso chiedendo in via principale, accertare e dichiarare la nullità o annullabilità dei contratto di vendita delle obnlioazioni Cirio Dei Monte, stipulati dai sig.ri L. e C. nelle date dell'8/6/2001 e 3/4/200, per violazione del combinato disposto degli arti. 1418 e1343 c.c., art. 21 Dlg . 58/98, artt. 26,27î, 28, 29 del. Consob 1/7/1998; violazione degli artt. 1394, 1395, 1439 c.c.) con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione dei capitale investito in obbligazioni Cirio Del Monte ed al risarcimento danni d liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, dal diritto al soddisfo; in linea subordinata, accertare e dichiarare che nelle operazioni di cessione delle obbligazioni Cirio Del Monte, la Banca XXX ha tenuto per le motivazioni in narrativa, in particolare per l'omissione di informazioni imperative, una condotta violativa dei dovere di buona fede precontrattuale e dell’obbligo di diligenza specifica (artt. 1337, 1375 c.c., art. 21 e art 23 comma 6 D.Lgs 58/98; art. 28 comma 2 e art. 96 comma 2 lett. 3 del Consob 1.7.1998; per !'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi, da liquidarsi in misura pari all’investimento sollecitato, oltre interessi e danni da svalutazione monetaria, dal diritto a soddisfo, ai sensi dell'art. 1224 c.c.: con vittoria delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di averle interamente anticipate. Ritualmente costituitasi, Banca XXX chiede il rigetto delle domande. Deduce in dettaglio: che gli attori espressamente rifiutarono di fornire informazioni sulla loro situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento, come risulta dalla richiesta di apertura rapporti sottoscritta il 28 maggio, 2001 (e prodotta in copia), non consentendo alla Banca di valutare compiutamente la adeguatezza delle operazioni, in ogni caso non rischiose per le conoscenze che potevano aversi dei titoli specifici all’epoca dell'acquisto: di avere consegnato il documento esplicativo dei rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, ed ancora come con i due ordini di acquisto - copia dei quali era stata consegnata ai clienti costoro erano stati resi edotti delle modalità di esecuzione dell’acquisto operate dalla banca per conto proprio. Nega, infine, di aver preso parte al consorzio di banche incaricate dei collocamento dei titoli. E, con la nota ex art. 10 d,lvo 5/2003 ritualmente depositata, ha concluso chiedendo respingere tutte le domande ex adverso formulate nel presente giudizio, in quanto infondate in fatto, ed in diritto e comunque sorovviste di supporto probatorio; per l’effetto assolvere Banca XXX da ogni avversa domanda e pretesa; con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. Dunque, la pretesa attorea si incentra sulla invalidità del negozio di acquisto delle obbligazioni Cirio Del Monte, nonché sull'addebito all’intermediario finanziario 309 di responsabilità precontrattuale; e per la compiuta disamina delle questioni prospettate è opportuno premettere qualche considerazione preliminare. La normativa da applicare è quella del T.U. 24.2.1998 n° 58, disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito TUF), e del successivo regolamento attuativo del 1.7.1998. Quest'ultimo è il regolamento CONSOB approvato con delibera 1 luglio 1998 n° 1152. avente portata integrativa dei superiori doveri, contenente una precisa e dettagliata prescrizione degli obblighi. Esaminando questi ultimi; 1'art. 21 del TUF impone agli intermediari nell'attività di servizi di investimenti ed accessori di: a- comportarsi con diligenza. correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; b- acquisire le informazioni necessarie dei clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati: c- organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento; d- disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi; e- svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati. Dal canto suo il regolamento, per quello che in questa sede interessa, all'art. 28 impone all'intermediario, prima della stipula del contratto di gestione, di chiedere all'investitore ogni notizia sulla sua propensione ai rischio, sulla sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, sulla sua situazione finanziaria, e 1'eventuale rifiuto a fornire le predette informazioni deve risultare dal contratto. Ancora, l'intermediario è tenuto a consegnare al cliente il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari. La tipizzazione dei doveri di diligenza implica l'enucleazione della serie di comportamenti che in concreto l'operatore è tenuto a compiere, al fine di rendere 1'operazíone il più possibile trasparente e comprensibile anche ad un cliente scarso conoscitore dei meccanismi del mercato e degli strumenti finanziari. Certamente, la consegna del prospetto informativo del prodotto che il cliente si accinge ad acquistare unitamente alla descrizione verbale delle sue caratteristiche implica adempimento degli obblighi di diligenza. Ulteriori obblighi di carattere più dettagliato mirano a salvaguardare l’investitore da rischi elevati imponendo al soggetto abilitato: di acquisire un’adeguata conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi e dei prodotti diversi, propri o di terzi: di non procedere all'investimento se questo si rivela inadeguato alla situazione finanziaria dell'investitore di non agire in situazioni di conflitto di interessi, di non effettuare operazioni prima di avere assolto prontamente agli oneri di informazione sulla natura dei rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, di mettere a disposizione dei clienti documenti e le registrazioni che li riguardano. Tutti tali obblighi sono Codificati rispettivamente dall'art. 26 comma I lett. e) reg. consob 11522/98. dagli artt. 21 comma I lett. b) TUF e, 28 comma I lett. a) reg. Consob n. 11522/98 e dall'art. 29 comma 1 reg. Consob 11522/98, ed impongono all'intermediario finanziario di: - raccogliere informazioni necessarie dai clienti, richiedendo all’investitore anche mediante moduli prestampati il cui utilizzo è stato legittimato dalla Consob - informazioni sulla sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, la sua propensione ai rischio, annotando l'eventuale rifiuto del cliente a rendere le risposte; - astenersi dall’effettuare con o per conto degli investitori operazioni, anche se espressamente impartite dal cliente, rispetto a costui non adeguate per tipologia, 310 oggetto, frequenza e dimensione, salvo la ripetizione scritta dell'ordine preceduta dall’esplicazione delle ragioni dell’inadeguatezza. La finalità di tutti tali doveri è il raggiungimento di un fine superiore, configurato nell’interesse degli investitori e dell’integrità del mercato (art. 1 comma 1 lett. a T.U.F. ed art. 26 comma I del. Consob 11522/98), ovvero quello di assicurare correttezza e trasparenza dell'attività di intermediazione: la corretta interpretazione delle preferenze di investimento dei risparmiatori e la ponderata valutazione dei rischi da parte di costoro riducono l'alea connessa agli investimenti finanziari entro quella connaturata, e perciò insopprimibile, alle operazioni eseguite sul mercato dei valori mobiliari, ed elidono, tendenzialmente, il rischio non necessario, evitando che questo sia addossato in modo inconsapevole al risparmiatore. Proprio la violazione di tali doveri comporta, secondo l'indirizzo dominante della giurisprudenza, la nullità dei relativi contratti conclusi e ciò in considerazione della peculiare rilevanza degli interessi protetti di natura pubblicistica, identificabili con la tutela dei risparmiatori soggetti deboli e in forte asimmetria informativa rispetto agli operatori abilitati del risparmio pubblico, della correttezza ed efficienza del mercato dei valori mobiliari (Cass. 07/03/2001 n° 3272; Trib. Mantova 18/03/2004). La sanzione non è posta espressamente dalla norma, ma si ricava agevolmente, secondo quanto con continuità, affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass. 7.3.2001 n. 3272, Trib. Treviso 26.11-16.12.2004, Trib. Mantova 12.11.2004, Trib. Taranto 27.10.2004), in considerazione degli interessi pubblicistici, anche di rango costituzionale (art. 47 Cost.) che l'impianto normativo mira a tutelare, identificabili nella tutela dei risparmiatori uti singoli, del risparmio pubblico, come elemento di valore dell'economia nazionale, della stabilità del sistema finanziario, dell'efficienza dei mercato dei valori mobiliari, con vantaggi per 1e imprese e per la economia pubblica (in questi termini, ancorché con riferimento ad altra norma della disciplina dell'intermediazione finanziaria. Cass. 7..3.2001 n. 3272). Dalla qualificazione in termini di norma imperativa di legge dei precetti comportamentali che sovrintendono all'operato degli intermediari finanziari discende, ai sensi dell'art. 1418 comma I e III c.c., l'affermazione di nullità degli atti negoziali conclusi in loro dispregio. Per evitare ciò, l'onere di provare di aver agito con la dovuta diligenza richiesta dall'operazione conclusa grava sul soggetto abilitato, a norma dell'art. 23 comma VI T.U.F. (norma che può ritenersi specificazione, in questo particolare settore, di quella desumibile dall'art. 1128 c.c.), convenuto in giudizio dal cliente per i danni a questi cagionati. In questo caso, l'intermediario non deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per adempiere l’obbligazione ma deve dar prova di aver agito con la specifica diligenza, da valutarsi con riguardo all'attività professionale esercitata (art. 1176 II comma c.c.). In caso di pretesa ulteriore di risarcimento del danno (come nel caso di specie) sull'investitore permane 1'onere di provare il danno e il nesso di causalità con la violazione dei doveri allegata. Tornando ai doveri imposti alla banca, esaminandoli in ordine temporale, essi si sostanziano, intanto, nel dovere di informarsi e nel dovere di informare. Nel caso concreto, dall’istruttoria espletata è emersa la violazione da parte della convenuta di tali doveri, ed in primo luogo delle regole generali di comportamento sancite dall'art. 21 co. 1 lett. D) TUF: "disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi" e dall'art. 26 D. Consob 11522/98, tra le quali alla lett. e) 311 è previsto che "Gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare.., acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dai servizi nonché dei prodotti diversi dal servizi di investimento, propri o di terzi, da essi offerti, adeguata ai tipo di prestazione da fornire." Detta norma, in dettaglio, pone a carico degli intermediari e nell'interesse degli investitori un obbligo di conoscenza, che è più della semplice informazione, sui prodotti da loro offerti, conoscenza che si estende alla loro provenienza, alla situazione degli stessi nei mercati, alla loro destinazione tra il pubblico dei consumatori. Va sottolineato che si tratta di conoscenza che il risparmiatore, investitore non professionale, per esperienza, per cultura o per diverso campo lavorativo non potrà mai acquisire. pervenendo ad un giudizio completo sulla operazione finanziaria che si appresta a sottoscrivere. Tanto più, se si considera che la negoziazione in esame è stata posta in essere per un titolo "non quotato" e in assenza di rating, e soprattutto diretto solo al cd. mercato degli investitori professionali (come confermato in sede di interrogatorio libero dal procuratore della Banca - cfr. verbale di udienza collegiale del 28 gennaio 2005 -). Ancora, e potendosi inquadrare lo schema negoziale posto in essere dalle parti nel contratto di mandato, in ragione del profondo divario di informazioni e cognizioni tecniche possedute dalle parti, con il mandante in posizione di netto svantaggio sul mandatario, quest'ultimo è tenuto, usando della diligenza del professionista avveduto, ad indirizzare le scelte del risparmiatore ed a segnalargli l'eventuale inadeguatezza delle operazioni che intenda comunque compiere, illustrandogliene i motivi. E può essere considerato, nello schema del mandato, anche il solo ordine di acquisto impartito dal risparmiatore, sulla base del contratto quadro preesistente a monte con 1'intermediario (cioè quello di apertura del conto titoli presso la Banca, il 28 maggio 2001: cfr. copia detto, versata in atti). In altri termini, il contratto quadro stipulato a monte con la Banca è da assimilare allo schema tipico dei contratto di mandato, rispetto cui gli ordini all'intermediario di acquisto dei bond per cui è causa sono assimilabili alle disposizioni date dal mandante a compiere di volta in volta atti giuridici di acquisto c/o vendita di titoli, nella esecuzione del rapporto di mandato; rapporto per il quale la diligenza richiesta è quella specifica di cui all'art. 1710 c.c.. E anche tale diligenza è mancata: in sede di prova testimoniale, non è emerso che il promotore finanziario abbia compiutamente avvertito, né oralmente né tantomeno (e soprattutto) per iscritto, gli odierni attori delle caratteristiche precise del titolo, che lo stesso (proposto agli attori dallo stesso promotore), per gli elementi che lo caratterizzavano, non era destinato agli investitori-risparmiatori, che perciò la Banca avrebbe dovuto acquistarlo per conto proprio (in contropartita diretta), per poi rivenderlo all’acquirente finale. Dunque, in ragione della tipologia di investimento sino a quel momento preferita dagli odierni attori (essenzialmente. titoli obbligazionari italiani)1'acquisto di bond Cirio Del Monte (indimostrato, ed anzi sconfessato dai dato documentale, è 1'assunto della Banca del contemporaneo acquisto di altri titoli pure rischiosi), in quanto connotati entrambi da una grado elevato di rischio, devono ritenersi operazioni inadeguate per un investitore la cui esperienza prima di allora era maturata solo grazie alla negoziazione di titoli del debito pubblico italiano con l'obiettivo, dichiarato, di costituire la provvista necessaria a provvedere ai bisogni della vecchiaia. L'investimento per cui è causa deve invero ritenersi incongruo rispetto al profilo dell'investitore, sol che si osservi, utilizzando anche le dichiarazioni rese dal 312 procuratore speciale della banca: le obbligazioni Cirio Del Monte erano state emesse da società non soggetta al diritto italiano, avente sede in Lussemburgo; l’emittente non era dunque ristretta, nell’emissione di prestiti obbligazionari, entro i limiti imposti dall'art. 2412 c.c., nel testo allora vigente; in quanto riservate ad un pubblico di investitori professionali, erano sollevate, ai sensi dell'art. 100 TUF, dall'osservanza delle stringenti disposizioni di cui agli artt. 94-99 T.U.F. e degli art. 4-19 della delibera Consob 14.5.1999 n. 11971: la società emittente non aveva avanzato comunicazione alla Consob, non aveva sottoposto i propri bilanci al giudizio di una società di revisione, non aveva compilato il prospetto informativo nel rispetto degli schemi predisposti dalla Consob, né un eventuale nota informativa: - non erano dunque conoscibili le informazioni "necessarie affinché gli investitori potessero pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull'evoluzione dell'attività dell'emittente nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti" che a tenore dell'art. 94 comma T.U.F. costituiscono 1'aggetto del prospetto destinato alla pubblicazione; - non erano state sottoposte ad una delle agenzie di valutazione indipendente per apprezzamento del merito di credito (c.d. rating) della società emittente. Né è consentito alla banca trincerarsi., senza alcuna dimostrazione, dietro 1'allegazione dell'imprevedibilità del crack finanziario dell'emittente e dell'ignoranza delle caratteristiche del titolo; e non avendo dimostrato, come era suo preciso onere, la diligenza profusa nell'acquisizione di cognizioni circa le caratteristiche del prodotto finanziario e, non ultimo, nella sua rappresentazione all'investitore. E' appena il caso di osservare come l'obbligo di fornire le informazioni non può ritenersi assolto per effetto della pur indispensabile, ai fini della validità dei negozio, consegna del prospetto sui rischi generali di investimento predisposto dalla Consob. Peraltro, non si è avuta la prova della consegna di tale documento né in una, alla stipula del contratto cd. quadro, né al momento del primo conferimento dell'ordine di acquisto. Conclusivamente, in ragione di tali considerazioni, va accolta la domanda di nullità dei contratti di trasferimento delle obbligazioni Del Monte 6.625% e Cirio Dei Monte 7,55% che obbliga le parti alla ripetizione delle prestazioni rispettivamente ricevute sia con riguardo all'attribuzione patrimoniale principale che a quelle accessorie. Ne consegue, dunque, l'obbligo per Banca XXX di rifondere la somma di € 34.754.52 (tale in effetti fu l'importo sborsato dagli attori. come emerge dai due fissati bollati prodotti, compresi i costi delle due operazioni), oltre interessi come per legge dalla data della citazione (da intendere quale atto di costituzione in mora) sino al soddisfo; nonché quello del risparmiatore alla restituzione dei titoli obbligazionari (quest'ultima, tuttavia è conseguenza della pronuncia, ma non può essere oggetto di essa, in difetto di espressa domanda della Banca, certamente in via subordinata, di riconsegna dei titoli). Alla sanzione della nullità segue poi, in ossequio alle previsioni dell'art 1453 c.c., 1'obbligo per Banca XXX di risarcire i danni derivati dal proprio inadempimento al contratto di mandato per la prestazione dei servizi investimento. E' appena il caso di evidenziare che ai sensi dell'art. 30 comma 11 D.Lgs 24.2.1998 n. 58, il soggetto abilitato alla prestazione di tali servizi è responsabile in solido verso i terzi insieme al promotore finanziario di cui si sia avvalso per 1'offerta fuori sede del prodotti finanziari. 313 L'entità del danno effettivamente patito deve essere dimostrata dai creditore ed in difetto può essere liquidato equitativamente dal giudice. Seppur vero è, difatti, che, allo stato, è impossibile pervenire ad una "esatta stima dei danni"; è anche vero che la lettura dell'art. 1226 c.c. potrebbe in astratto, offrire una soluzione: va infatti rammentato l'insegnamento del Supremo Collegio, per cui "il giudice adito con azione di risarcimento di danni può e deve, anche di ufficio, procedere alla liquidazione degli stessi in via equitativa nell'ipotesi in cui sia mancata interamente la prova del loro preciso ammontare per l'impossibilità della parte di fornire congrui e idonei elementi al riguardo, ma anche nell'ipotesi che, pur essendosi svolta un’attività processuale della parte volta a fornire questi elementi, il giudice, per la notevole difficoltà di una precisa quantificazione, non li abbia tuttavia riconosciuti di sicura efficacia" (Cassazione civile sez. 119.3.1991 n 2934) Tuttavia, ciò può avvenire solo in ipotesi di impossibilità della prova, e non quando sia mancata del tutto una attività di allegazione o probatoria in tale senso: all'uopo, va evidenziata la estrema generalità della pretesa attorea sul punto, non avendo neppure allegato gli attori se e in che termini, nel primo periodo di godimento dei titoli, abbiano percepito frutti (sotto forma di interessi e/o cedole), e soprattutto se e che rendimento abbiano avuto gli altri titoli acquistati (di cui hanno parlato tutte le parti in sede ai interrogatorio libero, e il teste XX), onde potere accertare esistenza ed entità del danno. Va quindi disattesa la domanda sul punto. Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate per come specificato in dispositivo. Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della III sezione civile il 7 luglio 2005. RETTIFICA DEL CONTRATTO TRACCIA: Tizio è soggetto legalmente incapace a contrarre. Caio è un imprenditore avviato. Caio conclude con Tizio un contratto (senza scrivere alcunché), in base al quale il primo trasferirà al secondo una collana storica dei fumetti di Topolino, costituita da 1000 volumi, a fronte della consegna di una somma di denaro pari a 6000,oo euro. Due giorni dopo, Tizio telefona a Caio, comunicandogli di essersi confuso e che, invero, non voleva vendere 1000 volumi, ma 999 allo stesso prezzo di 6000,oo euro, in quanto tra quelli da cedere c’era un volume a cui era particolarmente legato. Caio in modo comprensivo proponeva di rettificare l’accordo negoziale e Tizio accettava. Un mese dopo, Caio incontrava Tizio chiedendogli di eseguire il contratto; Tizio rispondeva di voler annullare il contratto nonostante la rettifica. POSSIBILE SOLUZIONE SCHEMATICA: In premessa poteva essere utile ricostruire sinteticamente il fatto. 314 Successivamente era necessario accennare alla disciplina giuridica della rettifica; tale figura giuridica, prevista dall’art. 1432 c.c. permette una modifica contrattuale, conservandone la struttura essenziale. A differenza della convalida che elimina il vizio per la volontà della parte che poteva farlo valere, la rettifica elimina il vizio per la volontà della controparte, impedendo la possibilità di un successivo annullamento e rendendo inutile la convalida (in un’ottica generale di conservazione del contratto, ex art. 1367 c.c.). Nel caso di specie viene ad emergere un contratto realizzato da persona incapace e non da soggetto incorso in errore, come richiesto dall’art. 1432 c.c., per cui ci si chiede se la disciplina giuridica del mantenimento del contratto rettificato, idonea ad impedire l’annullamento, è applicabile anche nel caso di incapacità; id est, poiché l’art. 1432 c.c. si riferisce all’errore è, comunque, applicabile, in via estensiva, ad altre ipotesi di annullabilità, come ad esempio l’incapacità? La tesi positiva fa leva sul fatto che l’art. 1432 c.c. non dovrebbe essere interpretato in modo rigoroso, in quanto non conterebbe tanto il riferimento all’errore, quanto al concetto di annullabilità; la ratio della norma, poi, sarebbe quella di evitare di annullare un contratto che, nel complesso (anche a seguito di rettifica), è stato formalizzato in base alla volontà effettiva delle parti, in un’ottica generale di rispetto dell’art. 1367 c.c. La tesi negativa (e prevalente), invece, ritiene di dover interpretare l’art. 1432 c.c. in modo rigoroso, alla luce di un’interpretazione letterale e del rilievo che se il legislatore avesse voluto riferirsi a tutte le ipotesi di annullabilità l’avrebbe detto espressamente (si voluit dixit). Accogliendo tale ricostruzione più coerente con la lettera della legge, allora, il contratto stipulato tra Tizio e Caio potrebbe, comunque, essere annullato, nonostante la rettifica, in quanto realizzato da soggetto incapace, ex art. 1425 c.c. Si consiglia di leggere Bianca, Il contratto, Giuffrè. COMUNIONE TRA CONIUGI E CONTRATTO PRELIMINARE TRACCIA: Tizio e Caia sono in regime di comunione di beni dal 1995; nel 2000 avevano acquistato una villa in Portofino, con il denaro di entrambi. Caia, poi, nel 2002 vendeva la suddetta villa all’amante Sempronio, al prezzo di euro 300.000,oo, senza dire alcunché al marito Tizio. Quando Tizio, nel 2003, veniva a sapere della vendita, si adirava contro la moglie Caia, spiegandole la nullità di tale trasferimento immobiliare, con la conseguenza che Sempronio avrebbe dovuto restituire la villa di Portofino. Caia si recava dal legale Quartus. Il candidato, assunte le vesti del legale Quartus, rediga motivato parere sulla questione giuridica posta alla sua attenzione. POSSIBILE SOLUZIONE SCHEMATICA CIVILE 15BIS 315 In premessa poteva essere utile ricostruire sinteticamente il fatto. Successivamente era necessario chiedersi le conseguenze giuridiche del contratto di compravendita intercorso tra Caia e Sempronio, senza il consenso di Tizio. Vi è nullità del trasferimento patrimoniale, relativo alla villa in Portofino, oppure annullabilità? La tesi della nullità pone l’accento, essenzialmente, sull’indisponibilità del bene in assenza del consenso di entrambi i coniugi, sub specie di assenza di volontà compiutamente formata (essenziale per la validità del contratto). La tesi più condivisibile ed accreditata dalla giurisprudenza, invece, pone l’accento non tanto sulla carenza di un elemento essenziale (la volontà), quanto sul fatto che il procedimento volitivo negoziale non si è formato in modo corretto, proprio per l’assenza del consenso di uno dei coniugi, con il corollario applicativo che vi sarà annullabilità, ex art. 184 c.c., e non nullità. In questo senso, allora, il negozio giuridico traslativo della villa in Portofino sarà valido ed efficace, ma sottoposto ad un’eventuale azione di annullamento (se non prescritta) esperibile da parte di Tizio. Si consiglia di leggere la sentenza che segue. -Il contratto preliminare di vendita di un bene immobile della comunione legale tra coniugi, stipulato da un coniuge senza la partecipazione o il consenso dell'altro, è soggetto alla disciplina dell'art. 184 c.c., per cui è soggetto all'azione di annullamento solo da parte del coniuge non consenziente. Cassazione civile, sez. III 21 dicembre 2001, n. 16177 Pres. Giuliano – Rel. Segreto – P.M. Cesqui (conf.) Bastianelli c. Resi ed altri SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato a Bastianelli Domenico il 19.3.1997, Resi Leonia, Ricci Marco, Ricci Marta e Ricci Emanuela, nella qualità di eredi di Ricci Mario proponevano appello avverso la sentenza del tribunale di Firenze depositata il 13.6.1996, n. 1632, nella causa proposta dall'appellato contro Ricci Mario e con la quale era stato dichiarato l'inadempimento di Ricci Mario all'obbligo assunto nei confronti del Bastianelli con scrittura del 6.10.1988 di trasferirgli un appartamento in Firenze e condannato il Ricci a pagare la somma di L. 10 milioni, pari al doppio della caparra, oltre L. 3.360.394 ed interessi. Assumevano gli appellanti che nessun inadempimento vi era stato da parte del loro dante causa, dovendo, invece considerarsi inadempiente il Bastianelli, che prima della scadenza del termine previsto contrattualmente per la stipula del contratto definitivo, aveva provveduto all'acquisto di altro immobile. 316 Resisteva il Bastianelli. La corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il 25.2.1999, in riforma dell'appellata sentenza, rigettava la domanda del Bastianelli. Riteneva la corte di merito che l'impegno di acquisto, rilasciato dal Bastianelli all'agente immobiliare relativamente all'appartamento del Ricci, essendo stata accettato e sottoscritta da quest'ultimo, già costituiva un contratto preliminare, per cui non vi era la necessità della stipula di un nuovo preliminare davanti ad un notaio, né tanto era previsto nella scrittura del 6.10.1988; che tale eventuale patto, attenendo al preliminare di compravendita, doveva necessariamente risultare per iscritto e non poteva essere verbale, come sostenuto dal Bastianelli. Pertanto non poteva ritenersi che lo stesso Ricci fosse inadempiente, per non essersi presentato davanti al notaio per la stipula di un altro preliminare in data 31.10.1988. Secondo la corte, poiché il bene era in comunione familiare tra il Ricci e la moglie Resi, ben poteva il Ricci effettuare il preliminare di vendita, avendo esso contenuto solo obbligatorio, per cui egli prometteva per il 50% del coniuge (circostanza specificamente indicata nell'atto) l'obbligazione del terzo; che, in ogni caso, con missiva del 5.12.1988 entrambi i coniugi Ricci confermarono espressamente di voler procedere alla vendita; che il contratto definitivo era previsto per il 31.3.1989; che dalle testimonianze escusse non emergeva la volontà dei Ricci di non adempiere al contratto preliminare; che il Bastianelli con missiva del 7.12.1988 dichiarò di non voler acquistare l'appartamento a causa dell'inadempimento del Ricci per la mancata presentazione davanti al notaio per la stipula del preliminare; che il Bastianelli acquistò un diverso appartamento il 20.2.1989, cioè prima della scadenza del termine (31.3.1989) per la stipula del contratto definitivo di compravendita con il Ricci. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Bastianelli. Resistono con controricorso gli appellanti, che hanno anche presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 180, 184 e 1381 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. Assume il ricorrente che nell'ambito della comunione legale o ordinaria, l'obbligazione di vendere un bene immobile da chi non è legittimato a disporne per l'intero risulta inefficace, non trovando applicazione la disciplina dettata dall'art. 1381 c.c.; che, pur rientrando il preliminare di un bene immobile in comunione legale coniugale tra gli atti di straordinaria amministrazione, in caso di consenso di un solo coniuge non è applicabile la sanzione del solo annullamento, che riguarda gli atti di disposizione con effetti reali, per cui gli altri atti, che non comportano la fuoriuscita del cespite dalla comunione, ma solo effetti obbligatori, danno luogo solo all'inefficacia dell'atto stesso. 317 2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che per l'effetto esso vada rigettato, pur presentando la sentenza impugnata - esatta nel dispositivo - errori di diritto, che vanno corretti nei termini che seguono, a norma dell'art. 384, c. 2, c.p.c. Invero è completamente fuor di luogo il richiamo all'art. 1381 c.c., effettuato dalla corte di merito. Va, anzitutto, rilevato, come affermato dalla Corte Cost. n. 311 del 1988, che la comunione legale dei beni tra i coniugi a differenza di quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei. Ne consegue che nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune, ponendosi il consenso dell'altro coniuge (richiesto dal secondo comma dell'art. 180 c.c. per gli atti di straordinaria amministrazione) come un negozio unilaterale autorizzativo, la cui mancanza non rende inefficace o invalido l'atto, ma lo sottopone alla sola sanzione dell'annullamento ai sensi dell'art. 184 c.c., in forza dell'azione proponibile dal coniuge pretermesso entro i termini previsti dall'art. 184 c.c. (Cass. 2.2.1995, n. 1252; Cass. 14.1.1997, n. 284). 2.2. L'art. 184 c.c., costituente il dato positivo in materia, al comma primo stabilisce che "gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'art. 2863"; al comma secondo aggiunge che "l'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro l'anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data della trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non può essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso". La disposizione prevede testualmente, con espressioni chiare ed univoche, l'annullabilità e la convalida. Orbene, l'annullabilità e la convalida suppongono la piena efficacia degli atti. Sul piano politico, nel conflitto tra la tutela del terzo avente causa dal singolo coniuge e la tutela del coniuge pretermesso, la norma sembra privilegiare la prima, in difformità dal favor comunionis, che certamente ispira l'intera riforma dei rapporti patrimoniali tra coniugi. Sul piano strettamente tecnico, poi, la disciplina statuita dall'art. 184 cit. appare in contrasto con l'indirizzo del codice vigente che, per gli atti di disposizione compiuti dai soggetti privi di legittimazione, contempla la sanzione della inefficacia: in particolare, appare in contrasto con il disposto dell'art. 2258 comma 1 c.c., che in caso di amministrazione congiunta richiede il consenso di tutti coloro, ai quali spetta l'amministrazione. 2.3. La statuizione dell'annullabilità per gli atti riguardanti i beni immobili o mobili registrati, compiuti dai soggetti non legittimati a disporre dell'intero senz'altro raffigura un dato nuovo e diverso rispetto alla comunione ordinaria. 318 Ne consegue, anzitutto, che nella fattispecie non hanno rilevanza i precedenti giurisprudenziali richiamati dal ricorrente, poiché essi attengono alla comunione ordinaria. 3.1. Tenendo conto innanzi tutto che la comunione legale dei beni tra i coniugi non costituisce soltanto una situazione di titolarità, o di contitolarità, di beni, ma integra un "regime giuridico" che si riflette con carattere di specialità sia sulla responsabilità (artt. 186-189-190 c.c.) sia, per quanto specificamente in questa causa interessi, sugli effetti degli atti e dei negozi giuridici, nonché dei rapporti che in essi trovino fonte, il primo problema proposto deve trovare soluzione nella correlazione tra la disciplina degli artt. 180, 184 nonché 186 e 189 c.c. Ove si ritenga che l'art. 180 c.c. stabilisce la regola generale in ordine al potere di amministrare la comunione e l'art. 184 indica le conseguenze degli atti compiuti in violazione della regola, deve ritenersi che gli atti posti in essere da un singolo coniuge senza il consenso dell'altro, o rientrano nella disciplina dell'art. 184 c.c., ovvero al di fuori di detta disciplina sono del tutto inefficaci nei riguardi della comunione, salvo ratifica dell'altro coniuge e salvo che un atto sia posto in essere dal singolo coniuge in nome proprio, per cui gli effetti debbono fare capo a lui secondo, peraltro, la previsione dell'art. 189 comma 1 c.c., che coinvolge, con disciplina speciale sussidiaria, la responsabilità anche dei beni della comunione per le obbligazioni assunte dal singolo coniuge. 3.2. Così impostata la questione, si rileva che il primo comma dell'art. 184 c.c. attiene agli atti che, "se riguardano beni immobili", siano compiuti da un coniuge "senza il necessario consenso dell'altro coniuge". Quando il consenso dell'altro coniuge sia necessario, è indicato dalla disciplina generale dell'art. 180/2 c.c. che, in deroga al principio generale - I comma dell'articolo - in base al quale l'amministrazione dei beni della comunione spetta disgiuntamente ad entrambi i coniugi, pone un'eccezione per "il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione" spettante "congiuntamente ad entrambi i coniugi". Ora, un contratto preliminare di vendita di un bene immobile soggetto al regime della comunione, sia che si richiami il criterio di straordinarietà inerente alla gestione del patrimonio dei minori, sia che si richiamino le norme proprie della comunione ordinaria (art. 1108 c.c.) ovvero quelle in tema di società, non pare dubbio che rientri nel concetto di amministrazione straordinaria, in quanto potenzialmente pregiudizievole all'interesse dell'altro coniuge e della comunione stessa ed in quanto eccedente la normalità degli atti da valutarsi sotto il profilo qualitativo e quantitativo. 3.3. Né può sottrarsi a detta qualificazione il contratto preliminare di vendita immobiliare, sulla base della considerazione che da esso derivano effetti obbligatori e non reali, in quanto il preliminare stesso è fonte di obbligazioni consequenziali a catena che, se ed in quanto validamente assunte ed in quanto si realizzino le condizioni di attuabilità, impongono in sequenza l'effetto distrattivo del bene dalla comunione e traslativo della proprietà, sia che esso avvenga con atto spontaneamente esecutivo dell'obbligazione di contrarre assunta, sia che si 319 determini mediante la sostituzione della volontà del contraente inadempiente con la sentenza ex art. 2932 c.c. costitutiva secondo la disciplina dell'art. 2908 c.c. 3.4. Pur senza seguire la tesi di certa dottrina secondo cui il contratto preliminare di vendita sarebbe munito in sé di efficacia traslativa, sia pure condizionata ad una successiva obbligatoria stipulazione e documentazione del contratto, ovvero ad una successiva e necessitata pronuncia costitutiva; pur ritenendo, per contro, che il contratto preliminare abbia effetti obbligatori, non può non rilevarsi che oggetto dell'obbligo è la stipulazione di un contratto definitivo, di tipo e contenuto predeterminato, e con un oggetto specifico o determinabile. Il contratto preliminare di vendita, quindi, si pone come momento originario di una serie obbligatoria consequenziale e successiva, il cui esito conclusivo necessitato è il trasferimento della proprietà del bene. In virtù dell'effetto conclusivo della sequenza, lo stesso preliminare, che alla serie obbligatoria dà inizio, diviene atto eccedente l'ordinaria amministrazione. Ovvia appare, quindi la deduzione che, se il contratto preliminare di vendita di bene immobile in regime di comunione legale costituisce negozio eccedente l'ordinaria amministrazione, esso costituisce altresì atto che può vincolare direttamente la comunione solo se compiuto congiuntamente dai coniugi, e che, se compiuto da un coniuge senza il consenso dell'altro, diviene atto annullabile a norma dell'art. 184 comma 1 c.c. 4.1. Né può sostenersi che, pur rientrando nella nozione di atto di amministrazione straordinaria secondo l'art. 180 c.c., il contratto preliminare di vendita di immobile non rientrerebbe nel regime dell'art. 184/1 c.c., regime che sarebbe limitato, in una interpretazione restrittiva, agli atti dispositivi con effetto reale e non agli atti con effetto immediatamente obbligatorio. In primo luogo l'interpretazione restrittiva non trova riscontro nella lettera dell'art. 184/1 c.c. che sottopone, come già ricordato, all'azione di annullamento gli atti compiuti da un solo coniuge "senza il necessario consenso" dell'altro coniuge; e quando il consenso sia necessario (come già esposto) lo dispone l'art. 180 c.c. citato con riferimento generale agli atti di amministrazione straordinaria, determinando quindi una coincidenza concettuale tra gli atti di straordinaria amministrazione e quelli per i quali la mancanza del consenso determina, come effetto, l'annullabilità, non l'assoluta inefficacia di essi rispetto alla comunione. 4.2. In secondo luogo il primo comma dell'art. 184 c.c. delinea e delimita, tra gli atti di amministrazione straordinaria, quelli soggetti al regime dell'annullamento, mediante una qualificazione oggettiva: "se riguardano beni immobili". Il "riguardare" beni immobili è espressione volutamente generica che non comprende solo gli atti immediatamente distrattivi dalla comunione in conseguenza di un effetto reale immediato, ma gli atti che comunque abbiano un'incidenza potenzialmente pregiudizievole sulla comunione con attinenza a beni immobili, ancorché l'effetto reale non sia immediato, ma conseguenza legittimamente necessitata, e giuridicamente tutelata fino alla costituzione degli effetti del contratto definitivo, in mancanza di volontà dell'obbligato (art. 2932 c.c. in relazione all'art. 1351 c.c.). 320 4.3. D'altronde, la suggerita interpretazione restrittiva non è sorretta neanche dal sistema che dalla disciplina dell'art. 184 c.c. emerge. Basti considerare che, a differenza della comunione ordinaria nella quale la sanzione dell'atto derogante il necessario consenso di tutti i partecipanti è l'inefficacia nei confronti della comunione (art. 1108 c.c.), nel regime patrimoniale della famiglia, retto dalle regole della comunione legale, il legislatore si è posto il problema della tutela bilanciata della comunione e del coniuge non consenziente, da un lato, nonché del terzo, dall'altro. La tutela del terzo è massima quando l'atto "riguardi" beni mobili (art. 184, comma 3) in quanto, anche se compiuto in violazione della regola della congiuntività, l'atto stesso è pur sempre valido ed efficace rispetto al terzo, risolvendosi l'eventuale situazione di pregiudizio con il rilievo di situazioni interne tra i coniugi. La tutela del terzo è attenuata nel caso di atto riguardante beni immobili o mobili registrati, ma pur sempre sussistente, in quanto correlata al conferimento al coniuge non consenziente di un potere di annullamento, in base al quale il coniuge incolpevole deve assumere comunque un atteggiamento attivo e dispositivo per ottenere la tutela del proprio diritto, come emerge dal breve termine prescrizionale cui è ristretto l'esercizio dell'azione di annullamento. 5.1. Riportando questi criteri al postulato di premessa, sarebbe illogico ed incongruo limitare la tutela del coniuge incolpevole ad una condotta attiva da esercitare entro breve termine per gli atti ad effetto reale traslativo immediato (e quindi con potenzialità lesiva maggiore ed immediata della comunione e del coniuge dissenziente), e sanzionare con l'assoluta inefficacia verso la comunione (e quindi con una situazione di maggior rilievo a tutela della comunione) un preliminare di vendita di bene comune, da cui derivano direttamente effetti obbligatori, con una prospettazione di pregiudizio o eguale, o minore, in quanto differito nel tempo. 5.2. E' pur vero che di fronte all'inefficacia del preliminare (nell'ipotesi di assoluta inefficacia del preliminare), l'azione di annullabilità, ed il relativo termine prescrizionale, si riproporrebbero davanti al negozio di esecuzione del preliminare. Non sembra però coerente con la disciplina positiva che un atto munito in sé di efficacia obbligatoria, debba essere sanzionato con l'assoluta inefficacia in un sistema che richiede, invece, una condotta attiva del coniuge non consenziente, e ciò a tutela del terzo, in presenza di un negozio immediatamente traslativo del bene. Così ritenendo, si sottoporrebbero ad un effetto sanzionatorio disuguale due ipotesi che o sono eguali negli effetti pregiudizievoli della comunione, ovvero vi sarebbe un effetto sanzionatorio più rigoroso proprio per l'ipotesi di minore pregiudizio immediato; si realizzerebbe, quindi, una inammissibile discrasia sistematica. 321 D'altra parte per la sottoponibilità di annullamento del contratto preliminare di vendita (ancorché in fattispecie diverse) si è già pronunciata questa Corte (Cass. 19 marzo 1988 n. 3483; 18 giugno 1992 n. 7524). 5.3. Risulta superato il rilievo della tesi restrittiva secondo cui il comma 2 dell'art. 184 c.c. fa decorrere il termine prescrizionale dalla trascrizione dell'atto, e ciò al fine di delimitare il regime dell'annullamento (in contrapposizione a quello dell'inefficacia) agli atti previsti dall'art. 2643 c.c., tra i quali non vi sarebbe il contratto preliminare di vendita, pur ricomprendendosi nella previsione del n. 1 di detto articolo anche vendite con effetto obbligatorio. Infatti, anzitutto, a norma dell'art. 2645 bis c.c., introdotto dall'art. 3 del d.l. 31.12.1996, n. 669 (conv. in l. 28.2.1997, n. 30), anche i contratti preliminari relativi a beni immobili devono essere trascritti. Inoltre non bisogna dimenticare che il termine prescrizionale è, in primo luogo, decorrente dalla conoscenza effettiva dell'atto e, solo con carattere di sussidiarietà, dalla trascrizione ovvero dallo scioglimento della comunione, ed il criterio sussidiario non può comportare la delimitazione del criterio generale che detta delimitazione già non abbia in sé. 6. In definitiva deve ritenersi che il contratto preliminare di vendita di un bene immobile della comunione legale tra coniugi, stip
Scarica