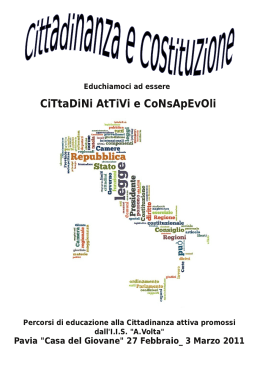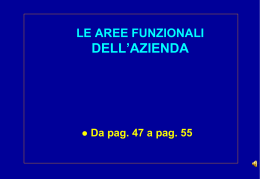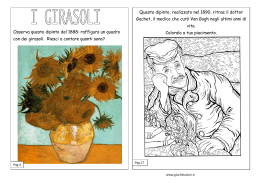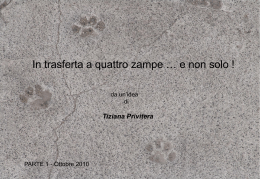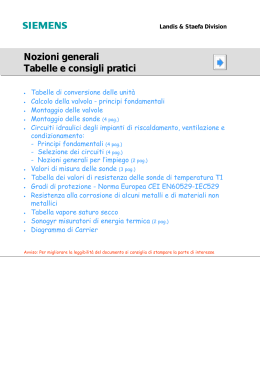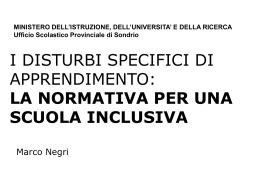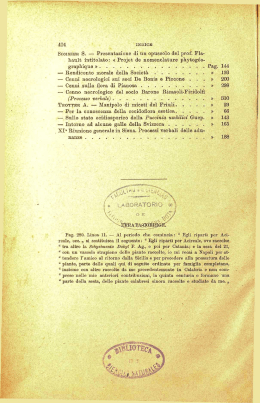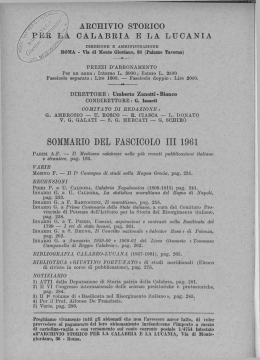Rivista di ricerca e cultura critica Numero 4 Prezzo: 4 euro Maggio 2008 POLISCRITTURE Rivista di ricerca e cultura critica Redazione: Ennio Abate, Marcella Corsi, Luca Ferrieri, Laura Galli, Ornella Garbin, Marcello Guerra, Alessandra Roman, Donato Salzarulo, Antonio Tagliaferri, Pier Paride Vidari (I profili dei redattori si leggono su www.poliscritture.it alla voce: Chi siamo ->Redazione) Copertina: Ornella Garbin Stampa: Cartotecnica Cremasca Sira – Divisioni Arti Grafiche Cremasche Via R. Sanzio, 7 – Crema ( CR) Abbonamenti: Un numero costa 4 euro. Abbonamento a tre numeri 10 euro. Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l’anno successivo. Collaborazioni: I testi proposti vanno spediti a [email protected] o a [email protected]; e, se per posta normale, a Ennio Abate (Poliscritture), via Pirandello, 6 – 20093 Cologno Monzese (Milano) su floppy disk e su carta. Il materiale non pubblicato non sarà restituito. Impaginazione grafica: Ennio Abate, Luca Ferrieri, Ornella Garbin. Le immagini del n. 4 sono di: Giuseppe De Vincenti (pag.70 e 86), Ennio Abate (pag. 72 e 103), Ornella Garbin (tutte le altre), Pier Paride Vidari (pag. 7, 13, 14, 25 e 89). L’inserto fotografico ospita alcuni scatti di Carla Cerati. «Poliscritture» esce come supplemento a «L’ospite ingrato», semestrale del Centro Studi Franco Fortini, aut. Tribunale di Siena N.703 del 22.12. 2000. I testi pubblicati sulla rivista e altri aggiornamenti sono reperibili sul sito www.poliscritture.it Norme grafiche per i collaboratori La correzione delle bozze è a carico del collaboratore, se fornito di posta elettronica. Chi non lo fosse, deve comunque adeguarsi ai seguenti criteri redazionali: 1) Note. Ridotte al minimo, vanno a piè di pagina. 2) Citazioni. Se lunghe (oltre tre righe) vanno fuori testo, senza virgolette e in corpo minore. Se interne al testo si usano le virgolette basse (« ») e, per eventuali citazioni interne alla stessa citazione quelle alte (“ “). Le omissioni vanno indicate con tre puntini tra parentesi quadra [...]. 3) Titoli. Per i libri: Nome (intero o con iniziale puntata) e Cognome dell’autore in tondo con l’iniziale maiuscola, Titolo in corsivo, Editore, Città e data (non separata da virgola), pagina (p. o pp. se più d’una). Per i saggi su rivista: Nome e Cognome dell’autore in tondo, Titolo del saggio in corsivo, «Titolo della rivista (in tondo tra virgolette basse)», numero, anno, pag. Altre indicazioni. Le virgolette basse (« ») vanno solo per le citazioni; le alte (“ “) per dare enfasi o indicare attenuazioni. Per gli accenti distinguere ‘perché’ da ‘cioè’ e usare la ‘È’. Le parole straniere non entrate nell’uso vanno in corsivo. Secoli e decenni vanno in lettere con l’iniziale maiuscola (Es. l’Ottocento, gli anni Settanta). Indice l’editoriale Quadro vivo e mosso sul disagio di ieri e di oggi 5 1 Samizdat Malinconie Luca Ferrieri Sul disagio ieri e oggi e qualche sua causa. Conversazione con Vincenzo Loriga Ennio Abate [Critica dialogante] Epifania dell’ombra e del fuoco Michele Ferrara degli Uberti 8 10 14 15 Disagi d’oggi: pratiche e interrogativi di uno psicanalista. Pietro Andujar intervistato dai redattori di «Poliscritture». 16 Distruggere quello che ti distrugge Giacomo Conserva 26 “Arsenio Lupin” e il “dominio delle cose” . La difficoltà di mentalizzare le emozioni Marina Massenz 27 La forma inquieta Giorgio Bedoni 30 L’Atelier di Cologno Carla Girardi e Laura Tonani 34 Due poesie Ferrrucio Brugnaro 36 Nuove Strategie di libertà. Ritornando su Ceti medi quale futuro? di Sergio Bologna Ennio Abate 37 2 Latitudini (Esterno con alberi) Anna Cascella Luciani 43 Rodoviaria brasiliana Alessandro Teruzzi 44 3 Esodi E ti dolzura che te vorressi Marcella Corsi [Critica dialogante] 47 47 L’eroe del giorno Fabio Ciriachi 48 Gli animali, la morte, il tempo, la memoria, la letteratura, il suicidio Giorgio Mannacio 50 Due voci su Die Reise (Il viaggio) di Bernward Vesper Considerazioni su Il viaggio Fabio Ciriachi 52 52 4 Storia adesso La pseudorivoluzione e la pseudonovità dei neocon Franco Tagliafierro 61 5 Zibaldone Figure dolenti Donato Salzarulo 66 Nannìne. Reliquario materno Ennio Abate 71 “Ma chi è quel signore che mi sta sempre attorno?” Ornella Garbin 72 Balletto Mario Fresa 74 Colomba Claudia Iandolo 75 Nel sottile filo di ragnatela: zia Marsiella e altri Anna Maria Celso 76 Scrittura come terapia del dolore Sonia Scarpante 79 6 Letture d’autore Raccontami un altro mattino Marcella Corsi 82 Appunti su Verbale di Michele Ranchetti Ennio Abate 84 Mondi che finiscono Massimo Cappitti [Critica dialogante] 87 89 7 Sulla giostra delle riviste Storia della rivista «Fogli di informazione» Paolo Tranchina con la collaborazione di Maria Pia Teodori 90 8 Riprese Ripensando alla concezione borghese della convivenza fra i popoli: in margine al “caso armeno” Giulio Toffoli 97 9 Giochi di specchi Il sito di «Poliscritture» 103 l’editoriale Quadro vivo e mosso sul disagio di ieri e di oggi Q uesto numero di «POLISCRITTURE» va in stampa ad urne elettorali aperte, col Partito Democratico che non ha sfondato al centro, con la scomparsa della Sinistra Arcobaleno dal Parlamento e coi risultati politicamente insignificanti di chi ha riproposto sulla scheda elettorale la falce e il martello. La sinistra critica (comunista, femminista, ecologista, ecc.) rischia di apparire, elettoralmente parlando, animale in via di estinzione. Fauna carismatica, come la definirebbero gli esperti, da conservare e proteggere per garantire la biodiversità. Che rapporto abbiamo noi con questa fauna?, noi che con le nostre scarsissime forze abbiamo cercato, fin dal numero zero, di affrontare temi e problemi importanti e urgenti per reinventare e ridefinire le armi della critica e per contrastare l’egemonia culturale e politica della destra? Non possiamo chiamarci fuori e far finta di niente. Non possiamo mostrare indifferenza per quanto è successo. Il rischio è che noi stessi sembriamo dei panda. È vero che laddove la nostra redazione ha dei legami territoriali, questa sinistra, ridotta a nomenclatura senza popolo, fa di tutto per escluderci, per non riconoscerci, per continuare ad affibbiarci, come accadeva nella peggiore tradizione stalinista, l’epiteto di “intellettuali”. Ma tutto ciò non ci consegna al rancore e alle dinamiche di rivalsa. Il nostro lavoro intellettuale (di scrittura, di organizzazione, di tessitura sociale di legami, ecc.) vorremmo che entrasse in rapporto con le idee, le emozioni, le visioni, gli atteggiamenti dei molti. Dovrebbe modificare e lasciarsi modificare. Altrimenti contribuiremmo ad affollare la galleria del narcisismo contemporaneo. Cultura non è cristallo puro. Per dirla con un antropologo americano, Clifford Geertz, è insieme ibrido di “modelli di” e “modelli per”. Mappe le prime che aiutano a descrivere eventi, processi, fenomeni; le seconde, che forniscono istruzioni per costruire realtà. E’ ciò che esattamente continuiamo a fare in questo numero, un numero quasi doppio, ricco di pensieri, riflessioni, poesie e storie, capaci di descrivere, raccontare ma anche di costruire eventi psichici, rinnovate percezioni di facce e figure sociali. I n che misura il tema affrontato in questo numero entra in rapporto con la cultura e la politica di una nuova sinistra critica degna di questo nome? Nelle pagine seguenti si narra e argomenta del disagio nelle sue varie forme: esistenziale, psichico, scolastico, sociale, politico. È la malattia che irrompe nella nostra quotidianità, la malattia del non riuscire a cambiare, a rompere le gabbie, a distruggere ciò che ci distrugge. Spesso è malattia mentale. Ebbene, proprio nel mese di maggio, cade il trentennale dell’approvazione della legge 180, più nota come legge Basaglia che decretò la chiusura dei manicomi. Fu una battaglia di libertà e di liberazione, sostenuta da un movimento antistituzionale e antipsichiatrico. Nel saggio di Paolo Tranchina e Maria Pia Teodori, Storia della rivista «Fogli d’informazione», è possibile cogliere qualcosa dei fermenti d’allora. Consapevoli degli attacchi condotti continuamente da destra e da molti settori dei mass-media a questa cultura e a questa legge, abbiamo pensato di tornare ad esplorare, per certi versi, la questione. L’abbiamo fatto dialogando sui disagi di ieri e di oggi con due psicoanalisti, Vincenzo Loriga e Pietro Andujar. Il primo, è vero che dal 2006, non riceve più pazienti. Ma li ha incontrati per quasi quarant’anni e questa lunga esperienza rende preziose le sue parole. Il secondo, in piena attività, lavora con pazienti di tutti gli strati sociali e sottolinea come, rispetto al passato, nelle sedute si abbia a che fare con disagi molto più complessi, tanto da rendere discutibili, se non poco attendiPoliscritture/Editoriale Pag. 5 bili, le valutazioni diagnostiche. «Oggi il falso me stesso è merce assolutamente comune» e il cambiamento in atto, secondo Andujar, «è gigantesco e abbastanza totalizzante». È in primo luogo un cambiamento mediatico che scompone tutto il collettivo sociale quasi rendendolo virtuale. Abbiamo chiesto anche il contributo di alcuni psichiatri: di Giacomo Conserva che con semplicità, ma con molta consapevolezza e lucidità, verso la fine del suo articolo, dichiara di non avere, in quanto psichiatra, «nessuna lezione da insegnare, nessuna normalità da difendere» e di Giorgio Bedoni che ci guida sulla strada della «forma inquieta», verso alcuni percorsi stimolanti tra arte e psichiatria. Il quadro che ne risulta è vivo e mosso. Giacomo Conserva, oltre che in Samizdat, è presente in Esodi con un fitto scambio di riflessioni tra lui ed Ennio Abate a proposito di Die Reise (Il viaggio) di Bernward Vesper. Ne nasce, in chiave prevalentemente esistenziale, un’attenta riflessione sul fenomeno della lotta armata. In critica dialogante coi due leggiamo le considerazioni di Fabio Ciriachi. Ritornando al tema centrale, appare importante l’intervento di Marina Massenz, pensato a partire dal suo parziale osservatorio sul mondo dell’infanzia; si tratta di mettere a punto adeguate strategie terapeutiche a favore di un Arsenio Lupin di cinque anni. «Il disagio infantile si esprime a volte in modi “terrificanti” per gli adulti; il bambino “ladro” a cinque anni terrorizza i genitori, perché il mondo adulto fa spesso fatica a guardare il mondo dell’infanzia usando, come si dovrebbe, occhiali diversi». Sul versante delle risorse terapeutiche, può essere anche letta l’esperienza raccontata da Carla Girardi e Laura Tonani sull’Atelier di libere attività espressive destinate a pazienti affetti da una delle tante forme di soggettività frammentata e divisa. Oltre alle varie tecniche artistiche, terapeutica appare a Sonia Scarpante anche la scrittura. Il suo saggio si può leggere in Zibaldone. Scrittura suggestiva, letterariamente raffinata, con sguardo e commenti affilati è quella delle «Malinconie» contenute nelle pagine d’avvio di Luca Ferrieri. Sempre sul versante letterario, lucide e intelligenti le considerazioni di Giorgio Mannacio sugli «animali, la morte, il tempo, la memoria, la letteratura, il suicidio». Le pagine di Zibaldone, aperte da «Figure dolenti» di Donato Salzarulo, rappresentano una galleria narrativa, il «cantiere dell’innovare scrivendo», che contiene i tanti racconti interessanti di Ornella Garbin, Mario Fresa, Claudia Iandolo, Anna Maria Celso. Tante le poesie presenti in questo numero, tutte molto ricche e stimolanti: «Epifania dell’ombra e del fuoco» di Michele Ferrara degli Uberti, «E ti dolzura che te vorressi» di Marcella Corsi, «(Esterno con alberi)» di Anna Cascella Luciani, le «Due poesie» di Ferruccio Brugnaro e «Nannìne. Reliquario materno» di Ennio Abate. Proprio a partire dalla congiuntura politica evocata all’inizio, da segnalare i saggi «Nuove strategie di libertà» di Abate (che discute il libro Ceti medi, senza futuro? di Sergio Bologna) e «La pseudorivoluzione e la pseudonovità dei neocon» di Franco Tagliafierro, che sviluppa una limpida tesi: «la Nuova Destra neocon altro non è che una versione aggiornata della Vecchia Destra posteriore alla I Guerra mondiale». Infine, nella rubrica Letture d’autore: «Raccontami un altro mattino» di Marcella Corsi, che recensisce il libro omonimo di Zdena Berger, «Mondi che finiscono» di Massimo Cappitti, che riflette su un testo di Ernesto De Martino e una serie di appunti di Ennio Abate su Verbale, un libro di poesie di Michele Ranchetti, autore recentemente scomparso e particolarmente caro alla rivista. Il numero s’avvia alla fine con l’importante contributo di Giulio Toffoli sul “caso armeno” e Giochi di specchi. Qui il lettore trova un veloce vademecum per scoprire e visitare il nostro sito, alter ego virtuale della rivista cartacea, che avete in mano e che al centro - ve ne siete accorti - contiene un inserto di foto “storiche” scattate da Carla Cerati negli ospedali psichiatrici agli inizi dell’esperienza di Franco Basaglia. Non vorremmo apparire eccessivamente ambiziosi. Ma forse tutte queste pagine, se lette con attenzione e “critica dialogante”, aiutano a orientarsi e a collocarsi con intelligente e sfaccettata consapevolezza nell’attuale, difficile momento storico. Poliscritture/Editoriale Pag. 6 «E questo è il sonno ... » Come lo amavano, il niente, quelle giovani carni! Era il 'domani', era dell"avvenire' il disperato gesto... Al mio custode immaginario ancora osavo pochi anni fa, fatuo vecchio, pregare di risvegliarmi nella santa viva selva. Nessun vendicatore sorgerà, l'ossa non parleranno e non fiorirà il deserto. Diritte le zampette in posa di pietà, manto color focaccia i ghiri gentili dei boschi lo implorano ancora levando alla luna le griffe preumane. Sanno che ogni notte s'abbatte la civetta affaccendata e zitta. Tutta la creazione ... Carcerate nei regni dei graniti, tradite a gemere fra argille e marne sperano in uno sgorgo le vene delle acque. Tutta la creazione ... Ma voi che altro di più non volete se non sparire e disfarvi, fermatevi. Di bene un attimo ci fu. Una volta per sempre ci mosse. Non per l'onore degli antichi dèi né per il nostro ma difendeteci. Tutto è ormai un urlo solo. Anche questo silenzio e il sonno prossimo. Volokolàmskaja Chaussée, novembre 1941. «Non possiamo più, - ci disse, - ritirarci. Abbiamo Mosca alle spalle». Si chiamava Klockov. Elaborazione grafica da Lei, lui e i fantasmi di Vidari Rivolgo col bastone le foglie dei viali. Quei due ragazzi mesti scalciano una bottiglia. Proteggete le nostre verità. Poliscritture/Editoriale (Franco Fortini, Composita solvantur, Torino, Einaudi, 1994, p. 63-64) Pag. 7 1 Samizdat critiche, dissensi, piraterie Malinconie Luca Ferrieri Atrabile Nella dottrina ippocratica, e poi aristotelica, degli umori, la malinconia è caratterizzata da un eccesso di produzione di uno dei quattro fluidi, la bile nera, che ha sede nella milza. Questo squilibrio produce una serie variamente graduata di disturbi e di manie, che vanno dalla depressione (cui la malinconia fu a lungo accomunata), alla nostalgia (il “dolore del ritorno”, una malattia di origine militare, che colpì nel ‘700 alcune guardie svizzere del Papa, fino a condurle alla morte), alla monastica accidia, il “demone meridiano”, che ebbe l’onore di finire compreso tra i nove peccati capitali, e che si presentava nella forma di una languida spossatezza in grado di indurre i migliori cristiani alle peggiori tentazioni della carne e dello spirito. La malinconia è una tristezza di tipo molto particolare: mai disunita da una sorta di straniamento, e quindi dalla capacità di vedersi dal di fuori, perfino con una piccola dose di (auto)compiacimento e compatimento, essa nasce non tanto da una sofferenza diretta, ma dal dolore indotto dalla fine di uno stato piacevole, dalla sua sparizione, e dalla sensazione di caducità che ne deriva. Può quindi manifestarsi come una forma quasi soave di consustanzialità con l’universale deperire del mondo e del cosmo, con l’alternanza delle stagioni, con i cicli dell’inizio e della fine, come una forma di saggezza complice che a volte sconfina deplorevolmente con il disincanto e l’abitudine al peggio. Ma in molte situazioni può farsi lancinante e scavare come un punteruolo nel petto: ciò avviene soprattutto quando essa misura l’incolmabile distanza tra le nostre capacità e le altrui esigenze, tra il possibile e il necessario, quando avverte nello stesso tempo il bisogno dell’azione e la sua inanità. In questa forma la malinconia è una forma altissima di coscienza e di autocoscienza, e per questo dagli antichi e dai moderni fu spesso avvicinata alla genialità. A differenza di questa, però essa non trova facilmente, anzi spesso non trova quasi mai, la via dell’espressione condivisa. Rimane introversa, chiusa, arroccata, isolata. Quando sconfina ormai nella disperazione, la sua intelligenza terragna e terrestre le indica, come unica prospettiva, la dolcezza del naufragio: come nei versi di due grandi malinconici, Leopardi (e il naufragar mi è dolce in questo mare) e Rilke (… noi, che pensiamo la felicità come un’ascesa, ne avremo l’emozione, quasi sconcertante, di quando cosa ch’è felice, cade). Poliscritture/Samizdat Folies Bergère ieri La ragazza delle Folies Bergère (sì, quella del famoso quadro di Manet) è davanti a me: il suo sguardo malinconico di lavoratrice del bar attende la chiusura del locale, o forse non attende più nulla. Il vuoto del lavoro e dell’attesa è tutto in quello sguardo. Dietro di lei, o davanti, visto il gioco di specchi, brillano le luci della festa, del consumo e del corteggiamento. Ma neppure da quello sguardo di tristezza l’amore è escluso: nello specchio appare un cappello a cilindro, un baffo e un pizzo. Dunque è anche nella desolazione dell’amore e nell’incomunicabilità con l’amato che quello sguardo si specchia e si spezza. Folies Bergère oggi In questo negozio di borse lei, la commessa, parla al telefono incurante della folla del centro commerciale e della clientela che si ammassa nel negozio. Parla, e dal tono sussurrato, da alcune frasi sconnesse che mi giungono all’orecchio, dal suo sorriso che a tratti si spalanca dolcissimo, capisco che è una telefonata d’amore, uno dei pochi fini che giustificano il mezzo (telefonico). Sto un po’ a guardarla, stupito della sua serafica indifferenza a ciò che le accade d’intorno. Lei non mi vede, non vede nessuno. Il suo sguardo è perso nella cornetta. Per un attimo, in questo centro commerciale anonimo e volgare, lei mi pare l’unica persona vivente. Come la cameriera delle Folies Bergère, lei guarda dall’alto il luccichio delle falsi luci. Se quella era malinconica, questa è sorridente, ma esprimono lo stesso altrove. E sullo sfondo, qua e là, il cappello a bombetta dell’uomo che guarda – o che ascolta. Non c’è vita senza il più abusato dei sogni, senza che l’amore, per un attimo che è un sempre, riscatti il luogo comune ripagandolo con la stessa moneta. Malinconie amorose François Truffaut è uno dei grandi cantori d’amore del Novecento. Ma non è dell’amore a tinte rosa e a lieto fine, non è di un tranquillo quadretto familiare che lui è perennemente innamorato. A lui interessa l’amore che passa i confini, che gioca e esce dal gioco, che mescola pericolosamente i colori e inclina di volta in volta al nero, al giallo, al rosso. Così se in Jules e Jim tratteggia l’utopia gioiosa del menage a trois, e poi il suo inabissamento finale, in Adele H è l’amour fou che fa vacillare gli equilibri mentali e in La signora della porta accanto la relazione che va in scena è clinicamente definibile come quella tra un ciclotimico e una depressa cronica. Di questo amore stupendamente abbietto e reietto Truffaut non si stanca di tessere l’elogio. E indica nell’amore stesso la cura migliore per le sue malattie. In due direzioni, apparentemente contrapposte: il dongiovannismo kierkegaardiano de L’uomo che amava le Pag. 8 donne in cui l’amore è una forza della natura cui è irragionevole opporsi, ed è tanto mortale quanto innocente, e la fedeltà assoluta, gioiosa e cieca, cieca fino alla lungimiranza, di Luis Mahé in La sirène du Mississippi. Questo è il film meno conosciuto di Truffaut, tradotto in italiano con l’insipido e ammiccante titolo La mia droga si chiama Julie, ed è uno dei pochi (insieme, forse a L’ultimo metro, una rivisitazione positiva del menage a trois) che potremmo definire tecnicamente a lieto fine. Ma chi lo avrebbe mai detto che quei due che cercano di passare il confine tenendosi per mano, in una tempesta di neve, hanno bevuto il veleno dell’amore fino al punto di uccidere e di tentare di uccidersi? La notte “La notte scende non prima, non dopo: è straordinaria mente puntuale. Anche la tristezza è puntuale: né prima, né dopo. Il cuore lo sa” (Ferruccio Masini, Aforismi di Marburgo). La notte ha almeno due facce. Una è quella indagata da Levinas e da Blanchot: una notte puramente negativa, in cui l’io perde il suo potere diurno, in cui la sua presa sul mondo declina, la coscienza si rattrappisce e il pensiero si abbandona all’automatismo e alla passività. L’altra è quella che appare, per esempio, nelle pagine di Manguel (La biblioteca di notte): la notte si caratterizza per uno stato di sospensione della legalità diurna, che permette di liberare il mondo di fantasmi, di immaginazioni e di ossessioni che ci abita. Non è la notte in cui tutte le vacche sono nere, è quella dei mille chiaroscuri repressi dalla solarità, schiacciati dalla illuminazione coatta del giorno. E’ la notte che si nutre di letture ed è nutrita dalla lettura, soprattutto dalle letture che si fanno a letto (non a caso Duras diceva: “Leggo di notte. Non ho mai potuto leggere se non di notte”). Tutte e due queste modalità notturne sono spesso visitate dalla malinconia. Nella prima modalità la malinconia si esprime nella forma dell’insonnia: il silenzio si riempie di rumori, di ricordi, di bagliori, di paure; tutto si ingigantisce; il pensiero entra nel loop della ripetizione e dell’angoscia. Secondo Lévinas è l’anonimo brusio dell’esistenza che ci parla nel silenzio della notte, che ci impedisce di dormire, è l’esserci senza scopo e senza progetto che congela la temporalità in un eterno presente. La malinconia dell’altra notte, della notte brava, della notte trasgressiva, della notte onirica, è invece molto diversa. Non a caso irrompe con le luci dell’alba, quando la notte si chiude, la luce è crudele, rivela le piaghe, le rughe, le ferite, la durezza del risveglio. Quando rapidi passano quei sogni rivelatori, più reali del reale, che ci lasciano una sensazione agrodolce per tutto il giorno. E’ la malinconia del ritorno all’ordine, alla serialità, al lavoro. E’ la malinconia della perdita. L’incompiuta In momenti notturni o stranieri càpita di esser presi dal terrore dell’incompiuto... “Ecco, se morissi ora, in questa stazione, in questo paese (come se cambiasse qualcosa, contasse qualcosa, la localizzazione della fine), le Poliscritture/Samizdat mie carte, gli appunti, i lavori interrotti, tutto resterebbe così, a metà, sospeso...”. E’ un terrore umano e diffuso, ma così assurdo e così mortuario. Solo la morte è compiuta. Tutto il resto è soggetto a uno statuto provvisorio, perfettibile, correggibile. Se muore uno che è vivo (ma spesso gli uomini muoiono già morti, e non so se sia un bene o un male) tutta la sua vita resterà interrotta. Sulla sua scrivania un libro a metà lettura, nella tasca della giacca l’appunto della spesa; una conversazione che occorreva riprendere, una lettera senza risposta; e vagante nello spazio chiaro del mattino uno sguardo appena sfiorato e lasciato in balia del dubbio. Per sempre. Morire di ferragosto Sto per celebrare il lutto dei sogni che si rivelano incubi. La dannata metamorfosi, l’astuzia del cinismo, la rivincita della norma. Per esempio, il ferragosto: la deliziosa sensazione di essere padroni della città, andare e venire senza gente tra i piedi, passare con il rosso in mezzo a radi passanti. Quante volte nel corso di un anno affollato hai sognato queste vacanze in città. Poi ci sei e se ti capita per sbaglio di passare un ferragosto da solo in città può capitarti di svegliarti nel silenzio con una fitta al cuore. Non è rimasto in città nessuno che ti conosca (almeno così credi). Sei l’unico sopravvissuto di questa piccola catastrofe. E se volessi vedere qualcuno? Gli amici sono in vacanza, la fidanzata è dispersa, la madre persa. Allora ti mescoli alla scarsa folla residua che si accalca come per farsi forza, per farsi ancora più caldo. Ma non c’è luogo dove si è più soli come nella folla anonima. La sindrome ferragostana (che si ripete a natale e, in piccolo, a tutte le feste comandate) ti proietta in un futuro in cui tutte le persone care saranno morte, il che è molto peggio della morte. Ti vedi anziano, in mezzo ad estranei, a sconosciuti. La società “fondata sulla famiglia” non ha saputo non dico creare, ma nemmeno immaginare (se non per una minoranza privilegiata) al tri luoghi di condivisione, di scambio di esperienze, di affetti. Dove tu possa sentirti amato, compreso, comunque accolto. E’ così giusto morire di contrappasso. Annegare nelle illusioni più innocenti per sperimentare come sarà quando crolleranno quelle maestre, le architravi del tuo occhio bendato. Fragili come siamo Fragili come siamo, basterebbe un colpo di vento a portarci via. Ma il peggio non è la realtà, sono i pensieri. La cura dei cattivi pensieri sono altri pensieri. E allora pensavo: a lui – nel romanzo di Giuseppe Berto, Il male oscuro – lui che ha paura di tutto, ha paura di guidare, ha paura di viaggiare, ha paura di stare da solo, ha paura di stare in mezzo alla gente, e la moglie che è in montagna gli parla per ore e ore al telefono cercando di tranquillizzarlo e lui prende l’auto e guida come un pazzo dalla città alla montagna, sui tornanti, al lato dei precipizi, e ce la fa, e quando arriva ci sono sua moglie e sua figlia che lo aspettano, e si abbracciano tutti e tre sul ciglio della strada. E poi pensavo a uno dei racconti Pag. 9 di Ali Smith - nella raccolta Altre storie (e altre storie), Roma, Minimum Fax, 2005 - che si intitola Questione di energia. Ci sono due donne. Si amano teneramente. Mentre stanno per andare a dormire (secondo me sono le stesse che nell’altro racconto si raccontano storie prima di addormentarsi), lei dice all’altra: pensa un po’ se in questa stanza ci fosse un masso grandissimo, che viene addosso a noi lentamente e ci schiaccia… Non è una robetta da nulla, il masso nella mente di lei c’è davvero, è un’ossessione vera, e il libro ne è infarcito, come la nostra vita, solo che nel libro, e qualche volta anche nella vita, qualcuno ci indica la strada per uscirne. L’altra le prende la mano, intreccia le dita con le sue, le dice: dov’è uno scalpello?, dammi uno scalpello, e lo facciamo in mille pezzi. Lei pensa: “Basta questo. Basta una tua occhiata, un tuo colpo di traverso, e una roccia grande come una stanza esplode in una miriade di pietruzze”. Vincenzo Loriga in conversazione con Ennio Abate Sul disagio ieri e oggi e qualche sua causa Comincerei dall’esperienza del disagio che lei ha conosciuto nella sua attività di psicanalista. Io mi sono trovato ad operare con un certo tipo di pazienti, più donne che uomini in generale, persone che andavano più o meno dai venti ai cinquant’anni. Non ho lavorato con persone più giovani e quasi mai con persone più vecchie. Noti che ho cominciato a lavorare come analista nel 1968 e ho interrotto l’attività nel 2006. Avevo, dunque, già fatto una serie di esperienze professionali e personali. Nella maggior parte dei casi ho avuto a che fare con quella che veniva chiamata allora nevrosi di carattere, e cioè una difficoltà ad avere rapporti buoni o decenti o col partner amoroso o sul lavoro. Posso dire di aver avuto anche qualche giovane che faceva molta fatica ad entrare nel mondo sociale… Può accennare a qualche caso? Paura. Disegno infantile Ho avuto, ad esempio, alcuni casi di nevrotici coatti abbastanza interessanti; e me li ricordo in quanto il nevrotico coatto è, diciamo, più nevrotico degli altri. E, infatti, Freud, parlando della nevrosi di coazione, la chiamava «la regina delle nevrosi». Ma forse lei desidera qualche Poliscritture/Samizdat Pag. 10 dettaglio? Se possibile… Lei adesso parla con uno che non fa più l’analista e che quindi ha maturato un distacco da queste cose. Comunque, ci sono stati dei casi in cui la patologia diventava quasi divertente. Per esempio, ho avuto un paziente – premetto che il nevrotico coatto è di solito molto intelligente – il quale riteneva che le distinzioni che noi facciamo tra un oggetto e l’altro (io, ad esempio, mentre le parlo al telefono, ho di fronte a me la scrivania, poi una lampada, una libreria, una finestra…) erano irreali, perché lo spazio è unico. E questo paziente aveva anche paura di non seguire con sufficiente attenzione il battito del cuore, pensava che in mancanza d’attenzione si potesse fermare. Le faccio un altro esempio. Ho avuto un paziente che era un comunista doc, uno stalinista. Beh, quando avvenne il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro, il giorno in cui ci fu la manifestazione, qui a Roma, in piazza S. Giovanni, sia del popolo comunista che del popolo democristiano, io ero solo a casa mia – era un mercoledì pomeriggio e non lavoravo. A un certo momento questo giovane mi telefona spaventatissimo, dicendomi che mi vuol vedere. Arrivò da me in taxi. Di cosa aveva paura? Di mettersi a gridare in mezzo alla folla in piazza S. Giovanni «Viva le Brigate rosse!». L’inconscio lo spingeva potentemente dalla parte dei “cattivi” dell’epoca… Sì, comunque lui ce l’aveva con tutti. Temeva anche di finire per dare uno schiaffo al suo superiore, col quale aveva almeno in apparenza rapporti cordiali. E soprattutto non tollerava l’immagine della debolezza. E una volta, mi ricordo, ebbe un atteggiamento aggressivo nei miei confronti, perché, avendo io da poco subito un’operazione chirurgica, gli apparivo più debole. Tra gli inizi e la fase finale del suo lavoro di psicanalista quali differenze ha notato nei suoi pazienti o in lei stesso? Il mio atteggiamento è cambiato sicuramente nel corso degli anni. Secondo me, un analista non fa che cambiare. Un analista passa il tempo a liberarsi delle cose che gli hanno insegnato a scuola o ha appreso dai suoi maestri. Poi quando si è liberato del tutto, ha finito anche di fare…l’analista! Lei, dunque, oggi s’è staccato dalla psicanalisi? Beh, non la pratico più… Perché s’è stancato o per altre ragioni? Il primo motivo è che mi sono stancato. Il secondo motivo è forse più penetrante… Secondo me l’analisi ad un certo momento deve cessare. Finché uno resta impigliato nella rete analitica, tende a vedere le cose dell’animo umano - suo o anche dei pazienti - con occhio scientifico. Ma c’è un elemento di libertà o, se vogliamo, di arbitrio, che, secondo me, nella visione scientifica propria di quasi tutta la psicologia viene sacrificato. Credo che l’unico che in qualche modo abbia reso ragione a quest’elemento sia Lacan. Io non Poliscritture/Samizdat mi sono mai sentito particolarmente vicino a Lacan, ma su alcuni punti sono d’accordo con lui. Ne ho parlato in un dibattito assieme ad altri nel volume della rivista “La ginestra” che risale al 1994 ed ha come titolo Castrazione e autocastrazione. Lì diciamo che, per “guarire” (orrenda parola!), cioè per sentirsi se stesso, il paziente deve essere capace di un atto d’arbitrio. Senza questo, si rimane sempre lì a rigirarsi sui propri problemi. Insomma, uno diventa se stesso, quando non pensa più a se stesso. Abbandonare o oltrepassare dunque la psicanalisi per altre attività? Io attualmente scrivo. Scrivo di fantasia. Ma uno può anche fare, che so, l’imprenditore… Beh, se ci riesce! Non è così alla portata di molti come scrivere… Ma insisto, si deve proprio abbandonare la psicanalisi per “essere se stessi”? Se devo essere schietto, sì. Posso chiederle quale attività svolgeva prima di fare lo psicanalista? Come no! Dunque, per un certo periodo ho fatto il bohemien, il poeta. Poi ho lavorato nell’industria. E poi, a un certo momento, abbastanza tardi come ho detto, nel 1968 sono diventato psicanalista. La sua scelta di dedicarsi alla scrittura, abbandonando la psicanalisi, farebbe pensare che lei sia ritornato a un desiderio della sua giovinezza… Diciamo che essermi occupato di analisi e aver fatto io stesso l’analisi mi ha permesso di vivere meglio. Vivere meglio con se stessi, vivere meglio con gli altri: questa è una cosa abbastanza importante. Però poi in questo vivere meglio si finisce per sacrificare una cosa alla quale personalmente tengo molto; e che potrei chiamare la potenza della parola. La parola, quando in qualche modo viene condizionata da una visuale scientifica, perde il suo vigore perché non ha più un rapporto diretto con l’esistenza. Eppure esiste un disagio anche dei cultori per eccellenza della parola, quali i poeti o gli scrittori. Sì, c’è questo disagio. Ma lei sa che spesso il poeta soffre d’insonnia? Non solo d’insonnia. Ho letto di recente su Internet un’intervista del 2005 rilasciata al “Corriere della sera” da Elio Gioanola. Trattava delle nevrosi di scrittori come Svevo, Tozzi, Campana e Gadda. Non la voglio condurre sull’annoso dibattito dei rapporti tra psicanalisi e letteratura, ma le chiedo: sfuggendo il disagio che può venire dall’attività psicanalitica e scegliendo la via della scrittura, non si passa comunque da un disagio a un altro? Beh, in realtà non parlo di disagio procurato dalla pratica della psicanalisi. Se uno non ha un problema di Pag. 11 espressione, ma di espressione vera (penso all’arte o alla filosofia) non c’è a mio avviso disagio. La psicanalisi lo può aiutare a viver meglio, favorendo fra l’altro, oltre che un rapporto migliore coi propri simili, anche una migliore armonia fra mente e corpo (cosa fondamentale; non dimentichiamo che l’inconscio freudiano, specie nella prima fase del pensiero di Freud, è in gran parte fisicità). Ma, se ci poniamo su un altro piano, la psicanalisi può essere d’ostacolo a un linguaggio vero. E per linguaggio vero intendo linguaggio libero. In che senso è di ostacolo? il suo punto di riferimento è l’Ego: quello che appunto beneficia dei vantaggi della nuova visione del mondo che la psicanalisi gli offre, ma che non ha alcuna possibilità di accesso a un linguaggio che prescinda dall’utile. La parola vera è quella che si propone quando il senso dell’utile viene a cadere. O meglio ancora: il linguaggio, in sé, non appartiene all’uomo, semmai lo domina. In fondo io ripeto cose già dette, ma che spessissimo vengono dimenticate. Le aveva dette Rimbaud (L’Io è un altro! Giusto, giustissimo, perché l’Io vero, che è in stretto rapporto col farsi del linguaggio, non è certo l’Ego, e i suoi movimenti per lo più ci sfuggono). Le ha ridette Lacan. E sa chi altri le aveva dette? D’Annunzio. Non so se lei conosce, di D’Annunzio, il Di me a me stesso, un libro postumo, che contiene frasi folgoranti: «Lo stile è l’Incosciente», scritte negli anni Venti. E ce n’è un’altra che dice: «Il discorso è pieno di pericoli», perché – spiega D’Annunzio - uno sa come lo comincia, ma non sa dove e come finirà. Ma potrei citare anche Aristotele, del quale, nell’Etica Eudemia, c’è questo singolare pezzo, che stupisce poi alcuni, che a torto lo considerano un pensatore troppo aridamente razionale. Traduco alla meglio: «Muove tutte le cose il divino che è in noi. E il principio del Logos non è il Logos, ma qualcosa di più forte». Per poi aggiungere che, spesso, il poeta e il veggente vedono prima, e più rapidamente, cose che un cervello razionale elaborerà col tempo. In proposito vorrei ricordare questa importante, felice frase di Lacan: «I poeti non sanno quello che dicono, ma lo dicono prima degli altri». Io però vorrei andare oltre e rifacendomi al detto di D’Annunzio («Il discorso è pieno di pericoli») osservare che anche un filosofo autentico, quando comincia il suo discorso, non sa dove questo lo porterà. Se lo sa, è un buon volgarizzatore; tutto qui. Ma così la ricerca non si chiude all’interno della parola o del discorso? Voglio fare un’eccezione per Freud, che in qualche modo sta a mezzo. Da un lato fa lo scienziato, tratta o cerca di trattare il materiale psichico come un oggetto, poi però la forza del discorso lo trascina e lo porta a concepire idee – vedi per esempio la pulsione di morte – che ai suoi più burocratici allievi risulteranno sgradite. C’è una libertà in lui - la psicanalisi non per nulla è stata per più lustri una disciplina d’avanguardia - che non ritroviamo più nei suoi seguaci e nei suoi imitatori. A me non dispiace affatto che Freud ogni tanto lavori di fantasia. Con la fantasia ogni tanto si scoprono verità importanti che spesso sfuggono al pensiero cosiddetto onesto. L’importante è che la fantasia sia tua, proprio Poliscritture/Samizdat tua, non condizionata da altri né per compiacere altri. È un po’ come con l’attore, che recitando sembra mentire, ma in realtà mette in luce punti dell’animo che di solito restano nascosti. E il corpo, in tutto questo, non c’entra? Ecco, l’aspettavo al varco. Vorrei cominciare con un’osservazione che potrà sembrare un po’ singolare. Ho notato che medici e poeti tendono a trascurare il loro corpo. Gli psicanalisti meno, stanno più attenti. E sa perché lo psicanalista in genere bada di più alla propria autoconservazione di quanto non faccia il poeta o il medico? Perché la saggezza gli consiglia di risparmiarsi. Ma la saggezza non è la libertà dello spirito, rientra nella categoria dell’utile. Mi sono chiesto spesso perché il poeta trascuri il proprio corpo. Le confesso però che non sono arrivato a una conclusione sicura. Io credo che la parola forte in qualche modo agisca contro la corporeità. Contro? Sì, la parola forte è corporea, prende forza dal corpo e gliela sottrae. Non così la parola piatta, o la parola segno, quella che adoperiamo negli scambi utili. Secondo lei, la parola che si fa corpo o carne, come afferma la dottrina cristiana, ha a che fare con questi discorsi? (Pausa) Non le so rispondere. A me pare di cogliere due processi: uno di spiritualizzazione che trascura il corpo (e gli esempi di poeti - ma non soltanto - potrebbero essere numerosi); l’altro che cerca di riportare in evidenza il corpo, la carne, la materialità. Io sul fatto che il poeta spiritualizzi ho qualche dubbio. Il poeta fa diventare idea la cosa, ma ama – e come – la cosa. Ma in cambio può dimenticare se stesso. Quanto alla chiesa essa parla sì di un verbo che si fa carne, ma il suo atteggiamento fondamentale è sempre stato di ostilità verso la carne. La chiesa è sempre stata contraddittoria su un punto, perché in certi casi si propone come gelosa custode della natura, mentre in altri la rifiuta recisamente. Le dirò che io non ho fatto lo psicanalista a caso. L’ho fatto perché volevo una riconciliazione con la mia corporeità. E qui mi permetto di ricordare il saggio di Freud del 1908, La morale sessuale “civile”, che poi è ripreso ne Il disagio della civiltà. È un atto violentissimo d’accusa contro una civiltà repressiva. Freud osserva che la repressione della sessualità com’era attuata nella società ottocentesca fino alle soglie del primo Novecento finiva per danneggiarla. Tutto il Novecento è stato agitato dal bisogno di riscoprire il corpo. Basti pensare alla fortuna di D’Annunzio, poi ai futuristi, a Freud, all’epoca del jazz in America; e poi negli anni Sessanta i Beatles, la rivalutazione del corpo anche nel modo di abbigliarsi. Siamo stati tutti travolti da un’ondata di giovanilismo. Oggi però si sostiene che la psicanalisi, che pur ha contribuito a rivalutare il corpo, non serva più. La spinta liberatoria della “rivoluzione psicanalitica” sarebbe stata capitalizzata e deformata dalla commercializzazione. È Pag. 12 [mc] l’opinione di Eli Zaretsky, un docente di storia alla New School University di New York espressa nel recente Secrets of Soul (I segreti dell’anima). Di certo non si può contestare che, almeno in Occidente, i paradigmi forti del pensiero siano caduti e ci ritroviamo in un tipo di cultura informe. Mi colpisce il passo della conversazione di Vincenzo Loriga in cui afferma: «Mi sono chiesto spesso perché il poeta trascuri il proprio corpo. (..) credo che la parola forte in qualche modo agisca contro la corporeità. (..) la parola forte è corporea, prende forza dal corpo e gliela sottrae». Stiamo in una cultura che sta a metà del guado, che non è né carne né pesce. C’è un livellamento dei gusti e dello stile di vita. In questo le industrie hanno il loro peso. Ma il suo peso l’ha anche l’orientamento generale, perché poi l’industria cerca di corrispondere a delle richieste. Condivido, in linea di massima. Tuttavia, più che contro la corporeità, credo che la parola del poeta agisca come prolungamento della sua corporeità. Ma le manipola un bel po’ queste richieste. Non crede che all’inizio esse abbiano una spinta autentica che viene tradita? La parola forte di cui parla Loriga è quella gratuita e necessitata della poesia. Una parola che ha passione di verità. Il discrimine sembra essere proprio nella passionalità e nel non utilitarismo della parola poetica (che non è l’utile, cui tende la parola segno citata nell’intervista). È parola poetica in questo senso anche l’espressione grafica o fotografica (o la scrittura in prosa…) cui l’autore si senta necessitato come a parte essenziale del suo vivere, così come non lo è la scrittura in versi originata da motivazioni di mera scrittorialità o altro utilitarismo. Questa parola forte o poetica, ampliando la corporeità del poeta, trasferendola fuori del limite fisico del corpo, in qualche modo, certo, fa diminuire il peso specifico della sua attenzione corporea. Ma assume anche, trasformandola in parola, quella capacità di adesione passionale alla realtà che il poeta, suo malgrado talora, detiene. Capacità che è insieme il suo dono e la sua fatica. Da un lato dunque gli sottrae forza, dall’altro lo libera di quel surplus di partecipazione che di necessità (in quanto poeta) lo lega a quanto, ben oltre il limite fisico del suo corpo, gli si fa carne e sangue. Quasi un meccanismo di compensazione, per chi sopporta una corporeità che è già tanto anche fuori di sé. Non a caso chi è in questo senso poeta e non produce poesia corre il rischio di impazzire (o di morire). Pur entro qualche consapevolezza ‘poetica di tale dinamica: tu quando scrivi preghi) io quando scrivo vivo e prego forse quando chiedo alle parole di farsi sulla carta immagine durevole forma che viva nonostante la distanza dalla vita. Viene anche tradita. Ma penso anche che non ci sia – come spinta autentica – in troppe persone. Mi spiega, ad esempio, perché in Italia la televisione è così volgare? E non parlo dei programmi politici. Le sembra un caso, d’altronde, che certi programmi interessanti li si veda solo dopo mezzanotte? <-- --> Per una critica dialogante Perché a dirigere la Tv ci sono quelli che sollecitano i gusti più bassi. Ma la Tv si potrebbe usare in altri modi. Talvolta succede. Ha visto Benigni recitare Dante? Un professore può storcere il naso, ma non c’è paragone con il livello dei programmi involgariti. Ma sono seguitissimi anche questi… Ciò prova ancor più la potenza del mezzo. Secondo me, c’è una corresponsabilità. Non mi addentro in dettagli. Se ci fosse una rivolta da parte del pubblico, certe cose non verrebbero più trasmesse. Basterebbe chiudere il video. Resta il fatto che anche io rimprovero alla televisione italiana di non svolgere nessuna funzione educativa. Di solito vengono rimproverati soprattutto gli utenti della Tv. E l’élite dirigente che tollera trasmissioni di basso livello? Beh, capisco… La cosa andrebbe fatta con una certa gra- P.D.Vidari, Potere assoluto E poi… Sì, forse la “parola che si fa carne” dei cristiani ha qualcosa a che fare con questo discorso. Chissà che Cristo (qualcuno degli estensori della dottrina cristiana) non fosse un poeta! Poliscritture/Samizdat Pag. 13 dualità. Non è che si può imporre alla gente di mettersi a leggere Aristotele. E sul disagio dei giovani oggi, qual è il suo punto di vista? Glielo dico subito. Fino agli inizi del Novecento, ma anche più oltre, il principio della castrazione patriarcale funzionava. Naturalmente facendo anche dei danni agli individui più deboli psicologicamente. Adesso non funziona più. Da un certo punto di vista è stata una liberazione. Però non c’è stato nulla che abbia sostituito quel principio. Noi abbiamo una figura di padre indebolitissima e manchiamo quindi di un’etica condivisa. Ciascuno ha le sue ideologie, che sono ideologie private o di un gruppo ristrettissimo. Però non esiste più un’etica condivisa a livello di sentire. E allora succede che la maggior parte dei giovani si trovano nell’impossibilità di farsi un progetto. Ora non è che tutti siano in grado di farselo Questo richiede già una personalità. Però la società un progetto prima glielo poteva dare. Adesso quello che la società gli può dare per i più è privo di fascino. È vero. Le trasformazioni del lavoro costringono a lavori flessibili, precari, intermittenti. Un giovane è costretto a dividersi tra varie occupazioni o va incontro a periodi imprevedibili di disoccupazione; e non riesce spesso a lasciare la famiglia. Figuriamoci a costruire un progetto di vita. Quando si uscirà da questo disagio? Secondo me ci vorranno decenni. Sono pessimista a breve termine, non a medio o lungo termine, anche se penso che quelli che erano i valori della civiltà occidentale è difficile ricostituirli in qualche modo, perché l’Occidente è in declino. Sul Corriere del 23 dicembre 2007 c’era un’intervista, sul tema del declino dell’Italia, allo storico inglese Denis Mack Smith, che in passato scrisse una storia d’Italia con dati interessanti, anche se aveva qualche tratto superficiale. Lui trova miope quest’accusa, perché, se è vero che c’è un declino, visto che i centri dinamici della nuova civiltà si trovano nel Pacifico, esso tocca tutto l’Occidente. nascerà un’altra e sarà cinese. E, in tal caso, sarebbe meglio o peggio a suo avviso? Mah, io i cinesi li stimo; e li stimo molto, ma la loro psicologia è così diversa dalla nostra, e così i loro valori. Forse ci sentiremmo un po’ spaesati. Ma conta ancora la matrice culturale nazionale di un popolo o contano di più i nuovi poteri sovranazionali? La cultura nazionale conta. Gli americani sono diventati quelli che sono anche perché erano fatti in un certo modo. Pensa che la cultura americana sia migliore delle altre? No, guardi… io sono molto legato alla cultura europea. Ma ritengo che attualmente la cultura europea non sia in grado di farcela da sola. Lo si vede a livello politico: non riescono a decidere. Io in America non ci sono mai stato e preferisco vivere nel vecchio mondo. Però mi rendo conto che probabilmente sono un sopravvissuto. In fondo io credo ancora nell’arte, ma temo che l’arte, o almeno un certo tipo di arte (non certo il cinema che per altro è un’arte) non abbia un grande futuro. Ha scarse possibilità. Lei non è d’accordo? Non so davvero come pensarla. L’arte oggi non ha la risonanza sociale che ebbe in passato nelle dimensioni cittadine o nazionali. Ma potrebbe essere un seme di “altro”. Ma posso sbagliare. No, no. È legittimo pensarla così. Tutte le comunità che avevano un’etica condivisa, come prima lei diceva, sono oggi sotto pressione e catapultate nel vortice della globalizzazione del mercato. Commerci, migrazioni, ma anche guerre avvengono in una confusa dimensione planetaria. È un mondo che poi, secondo me, è minacciato dall’entropia. Tutto sembra livellarsi, ma in realtà ci sono spinte centrifughe e gli uni sviluppano sentimenti molto aggressivi nei confronti degli altri. Il politologo Samuel Huntington parla senza esitazioni di “scontro di civiltà”. Due per il futuro sembrano le prospettive: o l’arroccamento dell’Occidente, che dovrebbe reimporsi con la forza alle altre civiltà: oppure un mondo multiverso, multietnico. Su quest’ultima ipotesi sono pessimista. Io sono convinto che, se viene meno l’egemonia degli Stati Uniti, ne Poliscritture/Samizdat Pag. 14 Epifania dell’ombra e del fuoco Michele Ferrara degli Uberti A Sharon mia diletta ombra nella forza dell’eros e della vita, e del mito dell’origine dedico questa epifania dell’ombra e del fuoco. Finirò, la stanza terminerà di essere arredata distratta fermezza, rigida notte, al limite degli alberi sulla pianura, precocemente adornata dai soffi del vento, quando cadrò ultimo frutto dell’ira, piangeranno vortici di luce chiesti dal padre, spina sul muro dov’è appesa una croce Volete volete, figlie inermi lacrime di mirto, ramoscelli di olivo per vivere per domandare quando vedrete, la ruota fermarsi l’officina chiudere le porte e mandare via gli abitanti follie lunari, vesti, della mente disabitata. * A Sofia Dal domani, sconosciuta, ambasciatrice di fierezza, verrai sul mio petto pieno dei sapori dell’alba tu spirito inquieto forgiato per gli antichi maestri cantori del mattino. Poliscritture/Samizdat * Con una cura paziente assolvo i compiti dell’ospite entrando nei cerchi della pietra sotto le città, distese come enormi dormienti in sacche oscure disseccato il tempo nelle mie mani respira attento materia dei corpi, rapide consistenze rapide bruciature sul legno carico d’occhi silenzioso enorme spaccatura, futura, vedrà consumarsi gli eventi e il confuso rito delle voci e la danza del libero mattino. * A Olivia Circondami di cure stella solitaria negli spazi del mattino abbraccia la mia carne voce mai narrata frammento, di una nascita tra la nudità delle pietre e il responso futuro, della sera ospite insana dietro la finestra scagliata nel firmamento spazio di luce, inascoltata energia del fuoco. * Perché io sono solo e non c’è giustizia in questo altalenare dell’edera sul muro e lo spaccarsi della luce nello specchio. Lontano nel paese dove brucia il sole passano gli uccelli, nel cielo in un basso volo e mi rapisce il suono delle onde che battono sulla terra entrando nella stanza frangendosi, Pag. 15 immaginaria rocce su alberi di vetro. * Brucia il canto sterminato dei campi. La luce richiede il conforto della tua opera, le sazie ginestre, come ferme pietre nel silenzio ascoltano antiche premonizioni stanche di assecondare il girare del vento che traccia cerchi sulla terra inquieta sottratta al respiro di colei, impazzita andata a cercare il suo assassino nei boschi. * Tu, che al mio disagio offri asce potenti reca la chiusa innocenza del risveglio, debole lume in tutte le terre considerate sacre, acceso. Sono venute pallide signore dalla veste di piombo la bocca spalancata a spargere foglie e la parola dei vangeli, caduta cancellazione dagli alberi per l’arbitrio delle forme; la danza, sui cerchi disegnati da abilissime mani; varrà il dubbio, la mutevole conseguenza dell’acqua che sfiora il corpo lingua griderà il suo terrore ai cieli il torrente. Pietro Andujar intervistato dai redattori di «Poliscritture» Disagi d’oggi: pratiche e interrogativi di uno psicanalista Cominciamo dalle esperienze di disagio che approdano al tuo studio. Sono cambiate rispetto al passato? Le esperienze di malessere, da dieci quindici anni a oggi, sono cambiate in modo molto netto, se devo riferirmi a dei criteri ortodossi, classici. Una volta al nostro studio arrivavano richieste d’aiuto da parte di pazienti cosiddetti ‘nevrotici’ che, secondo le vecchie categorie, avevano sofferenze più o meno riconducibili al tema edipico piuttosto che alle strutture familiari. Dominava l’opinione che il paziente potesse essere catalogato secondo la triade tipologica di perversione, psicosi o nevrosi. Questi erano gli atti di lettura, di derivazione sicuramente psichiatrica. Si pensava che la cura potesse essere di ordine relazionale, o più propriamente rivolta alla rilevazione di contenuti inconsci, o anche di supporto, perché con certi pazienti psicotici a volte si trattava di fare un lavoro più di sostegno, nel quale lo psicoterapeuta assumeva spesso una funzione di io vicario, come si usava dire allora. Fin da allora io non ero dell’idea che la divisione imposta dalla trilogia patologica fosse opportuna. Oggi sono assolutamente convinto che sia una tipologia insufficiente, perché i pazienti che ci si presentano adesso manifestano modalità di disagio molto più complesse. Non abbiamo una specie di psicogenesi del sintomo, di storia sintomatica che possiamo far risalire a un inadeguato tipo di sviluppo nel decorso della crescita del giovane, del ragazzo, della ragazza, ecc. Né possiamo pensare che siano avvenuti eventi traumatici specifici; oppure che ci siano fatti sociali, condizioni economiche scatenanti che giustificano il malessere psichico. Vediamo invece situazioni di patologie molto complesse, dove appaiono elementi psicotici abbastanza importanti e gravi: grosse fissazioni, deliri, componenti paranoiche abbastanza marcate o componenti maniacali molto forti: quelli che una volta potevano rientrare nella vecchia patologia psichiatrica e che costituivano, magari, il nucleo del sintomo cosiddetto psicotico e avrebbero potuto portare a una sorta di invalidità la persona sofferente. Oppure vediamo spesso persone che hanno una sofferenza abbastanza grave, però non innestata in quella che si pensava fosse una struttura di disturbo grave, ma Poliscritture/Samizdat Pag. 16 su una personalità magari perfettamente adattata alla realtà; e che, secondo i criteri sia sociologici - che io non ho mai amato molto - sia psicologici - che amo ancora di meno - può corrispondere alla definizione di personalità normale. E cosa sarebbe una personalità normale? Quando dico normale, non lo dico per una mia personale valutazione ideologica, ma mi attengo alle letture della sintomatica quotidianamente in uso. Se uso, ad esempio, il DSM IV, che è il sistema di diagnosi ufficializzato in tutto il mondo e condiviso dagli psicologi così come dai medici, e seguo i criteri ad albero, le diramazioni, le molteplicità patologiche, potrei riscontrare che i pazienti hanno dei disturbi di una certa gravità su un asse, ma non hanno affatto dei disturbi corrispondenti su un altro asse. Posso quindi ipotizzare che ci sia stato un particolare disturbo familiare, di conflittualità, e quindi presumere che ci siano delle carenze, dei disturbi, su un altro piano; ma non ci sono affatto. Vediamo la composizione di questa psicodiagnosi, usando magari la SWAP 200, una scala che in Italia ha divulgato Vittorio Lingiardi (uno psichiatra e psicoanalista junghiano molto vicino alla psicanalisi della relazione) nel tentativo di ridurre la vaghezza e l’approssimazione del DSM IV. Da pochi anni si usa in Italia questa specie di tecnica complementare di valutazione, composta da 200 item della scala, che lo psichiatra, lo psicanalista, lo psicoterapeuta, lo “psico-qualche-cosa” deve sottoporre a se stesso in relazione a ciò che ha rilevato del suo paziente, dopo che ha fatto una batteria di almeno quattro o cinque colloqui con lui. Se voglio fare una valutazione anamnestica, diagnostica e prognostica di un paziente, dovrei, dopo che l’ho visto per un mese, rispondere a queste domande e provare a pianificare una valutazione. La cosa curiosa è che gli esiti del protocollo della SWAP 200 debbano essere parametrati in modo tale che le patologie dei pazienti vengano commisurate secondo certi canoni quantitativi. Ancora più interessante è, per esempio, che tra gli elementi di valutazione compaia la dicitura di «buon funzionamento» che può, come dire, compensare, e ri-parametrare la nostra patologia. Tu hai adottato questo sistema di diagnosi? Dato che per scelta ho sempre lavorato con una vasta gamma di pazienti - persone di tutti gli strati sociali, economici culturali e di tutte le età - ho provato per conto mio a guardare cosa succedeva applicando questi nuovi e “più raffinati” modelli diagnostici. Dunque, per esempio, ho avuto anni fa tra i miei pazienti un uomo di scienza con una componente altissima di malessere narcisistico grave, un intelletto sicuramente di alto funzionamento (come si suol dire) con trascorse patologie di dipendenza, con un malessere evidente. Questa persona, parametrata con la SWAP 200, risultava con tre o quattro aree patologiche significative; però, ri-parametrando la diagnosi con l’altissimo funzionamento intellettuale, il grado di inserimento e di capacità di auPoliscritture/Samizdat toaffermazione, la patologia presunta viene ri-normalizzata. Un’altra paziente, una ricercatrice universitaria, era stata diagnosticata schizofrenica da alcuni colleghi: appariva come una pseudo anoressica. Dico ‘pseudo’, anche se pesava 32 chili, perché ritengo che la patologia conclamata grave non fosse il sintomo anoressico, dal quale si è riavuta in un tempo relativamente breve. Applicando i criteri di lettura della SWAP 200, ne risulterebbe una patologia media trattabile. La patologia media trattabile corrisponde a questa persona, che, quando è venuta da me si somministrava 20 clisteri al giorno, oltre a mangiarsi un vasetto di marmellata lassativa di tanto in tanto, oltre a prendere cinque ordini di farmaci diversi, perché non sapendo come diagnosticarla, i medici le avevano prescritto un neurolettico (perché psicotica?), un S.S.R.I. - il classico farmaco antidepressivo - (perché bipolare?), uno stabilizzatore dell’umore, che è un vecchio antiepilettico (perché depressa organica?); e un paio di Benzodiazepine diverse, una per l’ansia e una per il sonno (perché nevrotica e ansiosa?). Con questo tipo di patologia la paziente ha avuto una polidiagnosi, potendo risultare relativamente poco o molto malata, secondo la valutazione. Quindi questi criteri di valutazione sono discutibilissimi… Quello che noi vediamo è che arrivano persone, che sono magari relativamente ben inserite nel loro lavoro, non hanno particolari difficoltà scolastiche, possono essere studenti, possono essere lavoratori che fanno piccoli corsi di vario tipo per imparare qualcosa, fanno lavori interinali, ecc. Queste persone riescono a funzionare, però possono avere delle fissazioni di matrice psicotica, dipendenza da sostanze come la cocaina, che è diffusissima, o polidipendenze; e, soprattutto, non sono più rispondenti alle categorie di struttura mentale che noi consideravamo fino a pochi anni fa. Se noi pensiamo, ad esempio, a quello che era considerato da Freud il tema classico dell’isteria, il desiderio inconscio rimosso, come veniva chiamato, o consideriamo l’aspetto ossessivo (oggi lo chiamano compulsivo), non vediamo più nel compulsivo un fobico nascosto, un soggetto immerso nell’angoscia, una paura profonda nascosta che agisce con reazioni di contenimento o di controllo (perché c’è una possibile dimensione “inconscia” censurata), ma riscontriamo magari un delirio visibile, non criptato. Ci fai un esempio? Ho un paziente - una persona di grande intelligenza giovane e relativamente bravo nel suo lavoro, che si presenta dicendo: - Io ho dei disturbi del pensiero... È vero che ha dei disturbi, ma ha un pensiero perfettamente funzionante. Per essere preciso, intervengono nel suo pensiero dei disturbi. E cosa succede? Vedete questi tendoni, che non ho messo per dare un’aria particolarmente importante e barocca allo studio. Le due tendine centrali non coprivano bene il vetro. Allora ho montato Pag. 17 questi due tendoni laterali. Così, quando lui arriva, è tutto chiuso e assolutamente invisibile all’esterno. Arriva sempre almeno 5 minuti in ritardo, perché teme che qualcuno possa vederlo entrare. Poi qui oltre ad oscurare, a volte devo togliere quel panno, se si stende sul divano, perché gli può dar fastidio. Oppure le forme circolari gli rimandano vissuti inquietanti. Questa persona è una perfettamente funzionante. Altre persone che fanno dei lavori di servizio o che hanno attività di una certa importanza, invece, fanno uso costante di cocaina. Ce n’è una diffusione fitta, non sono poche. Si parla di persone giovani? Anche giovani. Un ragazzo che considero giovane - ha 28 anni - e una ragazza di 25 anni, anche questa cocainomane. Lei dice di non esserlo, perché, secondo il suo parere “una volta alla settimana, non si è cocainomane”. Invece, l’emivita della cocaina nel sangue è di circa sette giorni. Quando uno ne fa uso una volta alla settimana, è già dipendente. La persistenza della sostanza – non dell’effetto - è di una durata analoga a quella degli antidepressivi serotoninergici. Gli americani avevano chiamato il Prozac “Bye-bye Blues” e ne facevano uso nei week-end: lo prendevano a fine settimana, quando iniziava a calare la concentrazione della sostanza attiva. Non avevano neanche tutti i torti a chiamarlo “addio, tristezza!”, perché l’effetto di ripresa dal malessere melanconico funzionava veramente nei fine settimana! Purtroppo la droga, invece, non è un regolatore dei neurotrasmettitori, e non si può liberarsene con la stessa semplicità e rapidità con cui ci si separa dal Prozac! Questa cosa è diffusissima tra i pazienti che vanno dai 25 ai 35 anni e, attualmente, credo di averne cinque che ne fanno uso. Puoi farci ancora degli esempi? Ho due pazienti che stanno proseguendo un lavoro psicoterapico in qualche misura vicino alla psicoanalisi: cocainomani abusanti per molto tempo, con delle componenti che si potevano definire indirettamente perverse, mirate semplicemente a disturbare per telefono delle donne. La loro terapia è sostenuta o autorizzata dal tribunale. Sono persone che svolgono attività di gestione e di servizio veramente importanti e di una certa responsabilità. Un altro paziente, con una diagnosi di schizofrenia è una persona entrata in uno stato di dipendenza molto forte dalla cocaina. Poi ha virato la dipendenza soprattutto su un abuso di hashish. L’hashish oggi è fortissimo, a volte viene proposto tagliato, a volte anche con la cocaina. Può produrre una dipendenza molto forte, anche perché contiene una quantità di sostanza attiva, il delta-9-tetraidrocannabinolo, molto alta, dato che vengono coltivate piante selezionate allo scopo. Rispetto agli “spinelli” degli anni andati, la concentrazione di sostanze attive è altissima e il grado di dipendenza viene soprattutto dai tagli che contiene. Questo ragazzo, ad esempio, è stato scoperto dalla madre. Sono persone con mezzi economici proprio minimi: Poliscritture/Samizdat lei fa la domestica, lui lavorava in un grande magazzino; e quindi si fa presto a rimanere senza i soldi per pagare la bolletta della luce o del gas! La mamma se n’è accorta e ha chiesto aiuto per il figlio. Contravvenendo alle regole psicoanalitiche, seguo la madre da un lato e il figlio dall’altro. Il ragazzo è uscito dalla cocaina ed è arrivato ad un uso moderato dell’hashish, ha quasi ottenuto un lavoro stabile. Prima c’era anche un’instabilità lavorativa. Però si è dovuti passare attraverso il piano terapeutico psichiatrico per non pagare i farmaci costosissimi; e la diagnosi psichiatrica, che a mio avviso è stata incongrua - “schizofrenia latente”- è stata consegnata, per iscritto, nelle mani del paziente. In realtà, la madre è una schizofrenica, paranoide però. Una schizofrenia paranoidea abbastanza complessa, secondo alcuni clinici, non coinciderebbe con la schizofrenia. Il figlio ha degli elementi deliranti di stile paranoideo, ma, secondo me, non ha assolutamente la cosiddetta Spaltung, la scissione emotiva e intellettuale che di solito in uno schizofrenico di un certo tipo si può rilevare. Ha un grado di adattabilità molto forte, di relazione con l’altro, che non è poi finta o artificiale; ha un investimento di tipo ideale nelle figure maschili che si rivela in una serie di questioni che io conosco, avendo seguito la madre; però viene diagnosticato schizofrenico. C’è una componente di fragilità… In questo caso c’è una fragilità forte e questo figlio è cresciuto da solo con la madre che definiamo schizofrenica. Accenno a un altro caso trattato una decina di anni fa. Letizia Jervis Comba mi inviò una paziente già diagnosticata da altri psichiatri come schizofrenica. Con Christopher Bollas1 fummo invece d’accordo di riconoscerla come una psicosi isterica. Qualcuno la diagnosticava una psicotica conclamata. Aveva un’incapacità di stabilire dei rapporti, nonostante fosse stata aiutata tentando di inserirla in attività lavorative, assegnandole una pensioncina d’invalidità e fornendole tutta una serie di servizi che cercavano di coinvolgerla. Eppure questa persona si assentava da qualunque attività. Non era in grado di stabilire dei rapporti con il mondo esterno, se non con personaggi molto importanti. Ricordo che un giorno ricevetti una telefonata da Franca Rame, esasperata da questa persona, che la tormentava e che le aveva lasciato il mio recapito. La paziente aveva stabilito contatti con Dario Fo, con Franca Rame, con l’avvocato Pisapia, perché era stata molto attiva nell’area culturale e di ricerca della Libreria delle Donne di Milano. Pur essendo una piemontese, gravitava su Milano, tormentava il povero professor Franco Fergnani - dicendogli che anche lei era un’ebrea perseguitata come lui e cose di questo genere. Però un rapporto comune con persone di pari grado, orizzontale, non esisteva assolutamente. 1 Christopher Bollas è membro della “British Psychoanalytical Society”, del “Los Angeles Institute and Society for psychoanalytic Studies” Honorary Member dell’ “Institute for Psychoanalytic Training and Research”. Membro dell’ESGUT: “European Study Group of Unconscious Thought”. La supervisione e il dibattito su questo caso si svolse a Milano nel 1999, grazie alla disponibilità del dr. Mariano Enderle, già allievo e collaboratore di Bollas. Pag. 18 In tutti i pazienti gravi che io ho non ce n’è uno invece, oggi, che non abbia una possibilità di correlazione orizzontale con altre persone, per cui è chiaro che tendenzialmente si dice che il disturbo non è lo stesso, non c’è. Ma che immagini, che modelli hanno in testa questi pazienti? È una grossa questione che implica delle identificazioni con svariati modelli e immagini precostituite: quello che una volta si chiamava falso Sé. Oggi si dovrebbe aggiungere un nuovo capitolo alla “Psicopatologia della vita quotidiana”, che è improntata soprattutto al tema della perversione. Io credo che oggi la difesa che si può ben osservare nella psicopatologia della vita quotidiana è quella che Freud chiamava la “Verleugnung”, la negazione del perverso: io nego pur sapendo di negare, posso negare come se non sapessi. È una struttura di negazione, una difesa di negazione perversa, che fa parte della vita quotidiana - quello che noi banalmente tanti anni fa chiamavamo falso Sé. Va ricordato che il termine è di derivazione inglese e potrebbe essere tradotto come un falso me stesso, non un Sé metafisico. Oggi il falso me stesso è merce assolutamente comune. Anzi che uno non abbia una serie di falsi Sé è quasi raro. È il Sé del commercio insomma (generalizzando il concetto, quest’ultimo lo chiamerei un Sé metafisico in senso filosoficamente proprio!). Questo favorisce, secondo me, tutto un frullare di vortici di falsa identità talmente fitta, che genera ovviamente una identificazione di falsa immagine, quella che il vecchio Lacan chiamava falso sembiante, che è quasi impossibile frenare Il cambiamento nel tipo di sofferenza quale problema pone a uno psicanalista? Il problema che abbiamo noi psicanalisti si è moltiplicato cento volte. Sul piano tecnico è difficilissimo oggi lavorare e le persone giovani sono formate malissimo. Anche quelle della mia generazione a volte sono formate proprio male, non capiscono assolutamente niente della contemporaneità. È difficilissimo lavorare, perché il cambiamento in atto è gigantesco e abbastanza totalizzante. Mediatico in primo luogo. Quello è il primo grandissimo cambiamento, che fa sì che qualunque cosa virtuale possa essere scambiata per reale. Ho la possibilità di aprire Internet sul mio computer, dialogare con un’altra persona, prenotarmi un aereo piuttosto che comperarmi all’Outlet l’ultimo paio di Superga, che invece di costare 150 euro ora ne costano cinquanta, oppure posso sapere attraverso un blog cosa succede, oppure posso comunicare attraverso questi mostruosi aggeggi continuamente. Ciò ha prodotto una serie di estensioni, se vogliamo comunicative, ma anche di fraintendimenti fra ciò che è immaginario e ciò che è reale. Tu come ti poni rispetto all’attuale invadenza del virtuale? Non si può dare una disdetta al virtuale, che appartiene di fatto al piano di realtà. Qualche anno fa assieme a Poliscritture/Samizdat Marco Riva, uno psichiatra che ha anche una formazione psicanalitica, avevamo condiviso una ricerca sull’immagine virtuale e i suoi effetti, anche positivi. Marco aveva proposto di proiettare dei video nelle sale d’attesa dell’ambulatorio psichiatrico dove lavorava. Le proiezioni erano concepite per passare gradevolmente i tempi morti in alcuni luoghi-nonluoghi (come le sale d’attesa delle stazioni, degli aeroporti, degli ospedali, degli uffici pubblici, le fermate del tram, ecc.). Questi cortometraggi avevano semplicemente una valenza estetica e un libero flusso associativo caratterizzava il montaggio. C’era anche l’intenzione di stimolare i pazienti, per incoraggiarli a prestare attenzione a qualche cosa di soggettivo, che le circostanze un po’ fuori dal senso comune a volte ci aiutano a trovare. Non molti colleghi avevano capito bene di cosa si trattava. I colleghi medici, ad esempio, non riuscivano a capire cosa c’entrasse con la psiche, con la sofferenza questa cosa. Però, secondo noi, vedere in questo virtuale qualche cosa che può fare un effetto e accorgersi (e poter pensare) di gestirlo o di capire quali sono gli effetti o d’interagire con queste cose ci sembrava un motivo molto importante [per tentare l’esperimento]. È più attuale fare una cosa del genere che provare a vedere se lo psicotico è ancora psicotico, oppure se lo psicotico è un po’ perverso. Questo però ci porta - almeno ha portato me personalmente - alla questione che ritengo fondamentale, la questione del soggetto. Una questione centrale nella filosofia moderna e contemporanea, ma tu - crediamo - l’affronti da psicanalista… Per me, come psicanalista con una formazione filosofica di partenza - vengo da un’area umanistica, non medica è la questione oggi più complessa e più difficile. Pensiamo a cos’è il soggetto nella psicanalisi, pensiamo al vecchio Freud, che io considero continuatore della tematica hegeliana dell’autocoscienza. Poi pensiamo a Lacan, che è stato l’altro che ha fatto, secondo me, un passo importante sul tema del soggetto: il soggetto sbarrato, lo stadio dello specchio1, lo scritto del ’49, dove in qualche modo parla di questo soggetto illusorio, nel quale io m’identifico. Si scatena tutta una serie di strutturazioni, assieme all’impedimento al soggetto di raggiungersi in modo onnipotente e totale. Lì c’è la prima visione lacaniana del soggetto. Oltre a Freud e Lacan chi ne ha parlato? Franco Fornari, negli anni ’70, era stato molto bravo da questo punto di vista: aveva scritto delle belle cose sui codici familiari, i codici affettivi, le parentele, tutte questioni che poi aveva esteso anche alla politica. Parlava, per esempio degli Usa come struttura psicopolitica dominata dal codice paterno, della Russia dominata dal codice materno, dell’Europa come zona della tragedia di Tieste2. E però, se parliamo di soggetti, non possiamo 1 “Le stade du miroir comme formateur de la function du Je “ telle qu’elle nous est révélée dans l’experience psychanalytique. Communication faite au XVIe congrès international de psychanalyse à Zürich, le 17 juillet 1949. 2 Tieste è personaggio mitico in feroce conflitto col fratello Pag. 19 più pensare che il soggetto sia riducibile alla mamma buona, alla mamma cattiva, al papà, al codice fraterno, ecc. Oggi ci troviamo di fronte a una grossissima difficoltà a dare una fondazione del soggetto riconoscibile, perché con questa mediatizzazione grossa, con questa scomposizione di tutto il collettivo sociale, che è completamente scomparso, tu non hai più nessun polo di riferimento, di rispecchiamento, non hai più alcuna possibilità di deliberare con un riscontro convincente da parte dell’altro (il che sarebbe ciò che ti fa un po’, tra virgolette, innamorare dell’altro!). Ma hai continuamente delle protesi d’identificazione possibile, delle sembianze di similitudine, dei falsi noi che si creano e che sono anche difficili e a volte pericolosi da smantellare. Perché a volte ti ritrovi di fronte a persone che hanno come strutturato un loro modo d’essere su quello che Lacan chiamava «sembiante». Ma un sembiante complesso, con la sua quota di realtà e che ti mette in una posizione di interazione abbastanza gravosa, dove io credo che si dimentichi per es. tantissimo il corpo. C’è qualcuno che affronta oggi la questione in modi interessanti? Christopher Bollas ha scritto nel 2002-2003 un libro interessantissimo e non ancora tradotto, “Free Association” dove riprende il tema della libera associazione freudiana. Lo tiene buono come principio, ma fa vedere come su di esso ci siano stati dei fraintendimenti colossali. Sostiene che la libertà di pensiero associativo del soggetto sia una caratteristica indispensabile, per considerare correttamente la mente umana. Bollas di formazione è un letterato, è docente di letteratura inglese, è stato allievo di Donald D. Winnicott ed è membro ordinario della British Psychoanalytical Society. Ha pubblicato nel 2007 un libro nuovo, The Freudian Moment (Il momento freudiano). Può sembrare una tematica di vecchio stile, però i titoli dei capitoli sono molto significativi (uno è Identificazione percettiva e qui il corpo c’entra qualche cosa). E il sapere inconscio, a cui lui si riferisce, viene chiamato Unconscious Known, cioè il conosciuto inconscio, il saputo inconscio. C’è anche un gioco letterario, senz’altro, in questa cosa, perché il vecchio inconscio freudiano Unbewußt in tedesco, scomparirà poi nella seconda topica freudiana, dove farà capolino l’Es. In inglese abbiamo “Unconscious known” cioè “Unbewußt- Bewußt”. Fa pensare a quello che il poeta Giancarlo Majorino chiama l’ignoto del noto… Si può chiamare anche così. Bollas sottolinea soprattutto l’aspetto inconscio dell’ identificazione percettiva, perché è di cultura molto inglese. Pensa che lo stesso Winnicott ha scritto un saggio di psicoanalisi dal titolo Human Nature (La natura umana), tema tipico inglese. Siamo a Locke, ma più ancora a Hume, alla tradiAtreo. Fra I numerosi libri detti di “Psicopolitica”, Franco Fornari pubblicò “La Malattia dell’Europa. Saggio di psiocopolitica sulla struttura diabolica del potere segreto”, Feltrinelli, Milano, 1981. Tra di noi, allievi del gruppo di metodologia clinica, questo testo si chiamava “Tiestopa” Poliscritture/Samizdat zione classica inglese, che è sempre stata molto vicina alla percezione come fondamento della stessa coscienza. Qui, secondo me, andrebbe fatta fuori tanta cultura accademica, soprattutto italiana e anche francese. Gli inglesi pongono molto in luce l’aspetto percettivo della coscienza. La coscienza non è composta di solo pensiero. Per noi - e i francesi forse peggio di noi - la coscienza è pensiero. Direi, con l’evidenza della contemporaneità, che la coscienza è, forse prima di tutto, percettiva. Bollas mette in luce questa cosa e molto bene, secondo me. È la prima volta che sentiamo nominare Bollas. Ci puoi dire qualcosa di più? Christopher Bollas è uno dei più importanti psicoanalisti della British Psychoanalytical Society, allievo di Winnicott, aperto alla pluralità delle teorie psicoanalitiche, “Independent” , cioè libero dalle costrizioni più ortodosse. Ha sostenuto potentemente il valore della creatività soggettiva e ha criticato duramente alcuni canoni stereotipati della pratica psicoanalitica. Nel suo ultimo libro, The Freudian Moment, ad esempio si trovano capitoli intitolati Cos’è la teoria?, oppure Sull’interpretazione del transfert come resistenza alla libera associazione. Cosa va dicendo? In sostanza, che l’analista che comunica un’interpretazione del transfert al paziente, impedisce e pone una resistenza alla potenzialità di associare liberamente. In altre parole, se io interpreto, ad esempio, che tu ti stai comportando così, perché evochi attraverso il rapporto con me un rapporto conflittuale col padre, piuttosto che un’altra qualsiasi area inconscia attivata, blocco ogni lavoro di libera associazione, che è il pensiero creativo, che è la parte più significativa del soggetto. Nonostante la sua rigorosa formazione kleiniana, l’analisi con il grande Winnicott e la conoscenza di Wilfred Bion hanno forse aiutato Bollas a spingersi oltre nelle critiche ai dogmi di certa psicoanalisi ufficiale. Sempre in questo testo afferma una cosa molto semplice e molto vera, che abbiamo sempre saputo tutti: il libero pensiero è una modalità tipica, strutturale dell’essere umano. Non è cioè un’acquisizione della psicanalisi o di chi ha fatto l’analisi; e dunque teniamo conto che il soggetto umano è dotato di una capacità di libero pensiero! Certi filosofi l’hanno sempre detto, ma gli scienziati sono d’accordo? La teorizzazione di Bollas, o di alcuni sostenitori della psicoanalisi relazionale, è abbastanza in sintonia con certe acquisizioni delle neuroscienze. Pensiamo ad Antonio Damasio, al suo bel testo, Emozione e coscienza, dove ha la capacità di sostenere che esiste un soggetto biologico. Come esiste un soggetto nel senso filosofico comune del termine, c’è una soggettività, un’individualità biologica. Secondo me, il passaggio teorico necessario in questo momento impone – sia dal punto di vista di un determinista, che di un costruttivista pluralistico, o di uno strutturalista, o di qualunque altra posizione intellettuale si voglia sostenere - che non si neghi più come indeterminato ciò che è invece soggettivo, individuale, peculiare. C’è un diritto di esistenza specifica, particoPag. 20 lare del soggetto. È questa, dunque, anche la tua posizione? Il mio scopo personale coi pazienti da un po’ di anni a questa parte, ma particolarmente adesso, è proprio quello di essere su questa posizione etica di assoluta tutela, di diritto ad essere del soggetto, di potersi inventare, di essere qualche cosa che non sia determinato da meccanismi. Per cui in qualche modo penso che anche il vecchio Edipo, per esempio, sia da considerare un po’ alla stregua di una strutturazione archetipica. L’archetipo è come una struttura: d’accordo che io ho il cuore, i polmoni, lo scheletro, l’apparato muscolare, ma non posso essere ridotto a questa dimensione, perché, se no, mi spiego che sono così perché ho questa struttura. Oggi questa è una cosa talmente palesemente falsa, inadeguata, che non si può fare altro che passare a una legittimazione di un soggetto che va facendosi, pur non avendo delle identificazioni sostenibili all’esterno. E questa è la contemporaneità freudiana autentica. Ma allora non c’è più una teoria psicanalitica, ce ne sono varie? Bollas è assolutamente pluralista rispetto alle teorie psicoanalitiche: ritiene che siano integrabili l’una con l’altra, o meglio, che debbano essere coesistenti. Fra i colleghi milanesi ritengo che Carlo Viganò, allievo diretto di Lacan, sia pluralista e molto tollerante: è stato molto vicino a Basaglia e mantiene uno stile di psichiatria democratico. Bollas è forse più “ecumenico”, perché ritiene che oggi è impensabile che un analista abbia una formazione limitata a una scuola. È anche molto critico rispetto alla rigidità delle ortodossie. Ma sostiene che non puoi pensare di avere letto Freud e di non avere letto nulla di Winnicott o di Melanine Klein, di Jacques Lacan o di Wilfred Bion. È necessario appropriarsi di una vasta gamma di concezioni dell’inconscio per poter sostenere la teoria del soggetto. E ciò non significa nemmeno che si debba rinnegare una teoria dell’attaccamento, pensa a Bowlby e ai suoi seguaci. Bisogna far proprio ciò che proviene da questi punti di vista… Ma il riconoscimento della pluralità nella psicanalisi è assodato? Poco, poco…Diciamo, per esempio, che ci sono psicoanalisti come Carlo Viganò che sono aperti da questo punto di vista. Lavoro con lui all’ex O.P. “Paolo Pini” da sei anni. Da dieci vi si tiene un seminario sulla costruzione del caso clinico. Il gruppo che ha organizzato il lavoro ha avuto la direzione di Salvatore Freni, uno psicoanalista della S.P.I. (Società Psicoanalitica Italiana), di impostazione bioniana, psichiatra e docente universitario, che ha dato spazio a Viganò, pur essendo lui un rappresentante della leva lacaniana. Ha dato la parola anche a me, che considera abbastanza vicino all’area inglese winnicottiana, nonostante in Italia io mi senta forse più vicino all’area lacaniana. Sapete che io ho percorso anche un lungo tratto di analisi con un analista junghiano. C’è anche qualche junghiano che partecipa alla discussione… Su queste rigidità di scuola rimango tuttora molto perPoliscritture/Samizdat plesso. Però diciamo che a Milano c’è questa realtà del Paolo Pini. E lì si può praticare ancora una forma di psicoterapia quasi gratuita, pagando semplicemente un ticket. Ciò vale per molte persone, per cui si può dire che c’è ancora quest’area pluralistica e aperta che continua. Però dire che c’è un’apertura alle varie scuole è molto azzardato. E tu come ti muovi in questa situazione? Personalmente mi considero un po’ un poliglotta perché, avendo avuto la formazione di base con dei freudiani ortodossi, la prima formazione clinica con Fornari, che allora era più bioniano che kleiniano, avendo poi frequentato per molti anni gli junghiani e altrettanto i lacaniani, so qual è il registro da cambiare quando tu vuoi parlare. Una cosa interessante è successa con Bollas. Gli ho presentato un caso di un paziente, figlio di madre suicida quando lui aveva 16 anni. Manifestava una serie di malesseri gravissimi, ai quali si è aggiunto l’alcoolismo, insomma una situazione allarmante. Un mio amico psichiatra voleva ricoverarlo, ma abbiamo convenuto di aspettare un po’ di tempo e il paziente ha accettato di assumere un dosaggio moderato di antidepressivi, perché era il caso, anche se ho fatto fatica a convincerlo. Siamo riusciti a non farlo ricoverare e a lavorare insieme. Dopo tre anni di lavoro con lui, tante cose sono andate decisamente molto bene, anche se su alcune questioni c’è ancora molto lavoro da fare. Per mia curiosità intellettuale ho presentato proprio questo caso a Bollas. Volevo sentire lui che cosa mi diceva. E la cosa interessante è stata questa: secondo lui la conduzione di questa psicoanalisi era assolutamente coincidente con la psicanalisi della relazione d’oggetto. Certo era stata condotta in modo rigoroso dal punto di vista del setting, delle regole analitiche. Ma il registro di lavoro da me adottato con il paziente era assolutamente diverso da quello che Bollas poteva riscontrare nel mio lavoro. La caratteristica comune era la scelta decisamente non interpretativa, il paziente stava steso sul divano, veniva due volte alla settimana e attraversava una serie di contenuti associativi liberi. Perché la cosa è interessante? Perché indipendentemente dal riferimento teorico adottato, effettivamente fai parlare il soggetto! Ha importanza il soggetto non la teoria. E, se conosci le lingue in cui si parlano le varie teorie, la traduzione dall’una all’altra è possibile! Sul piano teorico a me interessa il fatto che si possa passare da un linguaggio all’altro, perché – e qui riprendo Bion – i vertici sono tanti: puoi cambiare vertice e guardare da un altro punto di vista l’oggetto. L’importante è ricordare che l’oggetto ha una sua esistenza di soggetto e che non prevalga la teoria. La nostra psicanalisi, in generale, è ancora molto dogmatica: adotta una vecchia meccanica ‘metafisica’. Nella fase di preparazione di questo incontro almeno alcuni di noi si sono segnati una serie di libri (“Le nuove malattie dell’anima” di Julia Kristeva, “L’indifferenza dell’anima” di L. Russo, “Intimità fredde. Le emozioni nella sociePag. 21 tà dei consumi” di E. Illoux), atti di convegno (“Itinerari del rancore”, “Forme contemporanee del totalitarismo”, “Paranoia e politica”), legati al disagio della civiltà. È arduo orientarsi nel dibattito tra neuroscienze, cognitivismo, psicanalisi e psichiatria fenomenologica. Tu sembri dirci: ragazzi il viaggio non è finito, la società cambia, dobbiamo assumere atteggiamenti più complessi…Ma che importanza dai a tutte o ad alcune di queste teorie? Sulla questione delle varie psicologie e psichiatrie che hai nominato, la cosa più importante da dire sarebbe che non si legge più la clinica. Tu trovi molte formulazioni teoriche - forse le hai nominate tutte - che portano esemplificazioni di “vignette” cliniche (adesso si usa chiamarle così) per comprovare l’attendibilità della teoria o della tecnica psicoterapica utilizzata. In questo senso, ripeto, le psicologie e le psicoterapie (psicoanalisi compresa) sono delle metafisiche dogmatiche e incongrue. Mi pongo in modo un po’ marxiano in questo: prassi e teoria. La psicanalisi non può assolutamente, e non deve, evitare di basarsi sulla pratica. Le cliniche nominate spesso sono teorizzazioni e astrazioni formali che non si fondano sulla casistica clinica. Ti porto, invece l’esempio di due casi clinici di psicosi che sono stati presentati di recente1. Nel trattamento si espongono le complicazioni del caso, ciò che succede. Perché è importante prestare attenzione alla clinica? Da un certo punto di vista rimango molto vicino alla posizione lacaniana del cosiddetto après coup, quello che succede dopo, l’evento. Ogni trattamento clinico procede per eventi e accadimenti. Non si può pensare che io prevedo e predico l’accadimento. Ma queste teorizzazioni non procedono così? No, perché incasellano tutto. Detto in parole povere, eliminano il concetto di inconscio completamente, eliminano la lettura della terza topica lacaniana - il nodo dei tre anelli R.S.I. - quella del Reale, del Simbolico, dell’Immaginario, che sono sempre interconnessi. Perché il Reale è l’ineludibile, ciò a cui non mi posso opporre, il Simbolico è il linguaggio, l’Immaginario è il come se. Bene, se guardiamo la questione da questo punto di vista, le teorie s’incistano sul Simbolico o sull’Immaginario o sul Reale. I cognitivisti, i comportamentismi, i biologisti sul Reale. Gli psicanalisti di stile iperteorico – compresi molti lacaniani - sul Simbolico. Li ho criticati e me ne sono in parte allontanato, perché non ne potevo più di questa mitizzazione del simbolismo linguistico: la parola, la parola, il ragionamento sulla parola. Sì, il dominio del Simbolico, che diventa un’assolutizzazione di quell’anello topico. Gli junghiani e i kleiniani: Immaginario allo 1 Al IX Joint Meeting fra l’AAPDP (American Academy of Psychoanalysis and Dynamic Psychiatry) e OPIFER (Organizzazione di Psicoanalisti Italiani. Federazione e Registro) dedicato alle strategie della psicoterapia dinamica ho presentato uno scritto intitolato Free thinking: la psy-chose prochaine. Ovvero il libero pensiero e la follia vicina di casa. Poliscritture/Samizdat stato puro, il come se (i cosiddetti desideri che affollano l’immaginario) posto come uguale al Reale. Poi ci sono i fenomenologi che a furia di parlare di soggetto lo rendono oggetto all’estremo. Ci sono lavori interessantissimi di varia provenienza, ormai sono dei classici. Prendete Ronald Laing, che ha scritto il testo più bello, L’io diviso, che è un esempio di fenomenologia straordinaria, ma anche di psicanalisi. Lui era allievo di Winnicott. In Lacan ci sono cose splendide negli Écrits e, soprattutto, in alcuni dei Séminaires . Anche alcuni colleghi hanno scritto cose eccellenti, ma indipendentemente dalla “scuola” di appartenenza. Per esempio ci sono delle cose intelligentissime scritte da qualche junghiano (si pensi a Vincenzo Loriga, ma anche a Cesare Viviani, o a Peter Schellenbaum). Non voglio dire che gli psicoanalisti oggi siano stupidi o che siano da svalutarsi i loro scritti. Ma, quando estrapoli da queste teorie provvisorie delle teorizzazioni e ne fai un sistema, tu fai un tipo di riduzione alla logica sbagliata. La logica della psicanalisi è una logica clinica. Non è una logica della teoria. Da questa chiusura in una cultura molto vecchia, noi italiani non usciamo e pure i francesi fanno molta fatica a venirne fuori. La teoria chiude tanto, non ti dà modo di avere un’interazione libera, soggettiva e intersoggettiva, dico io. Le teorie psicologiche o psicoterapiche sono veramente scatole cinesi. E però una teoria che fosse attenta alla varietà, pluralità e singolarità dell’esperienza non potrebbe suscitare una maggiore attenzione verso di essa? Non è che la teoria di per sé chiude soltanto… Per chiarezza, vorrei dichiarare i pochi dogmi del mio ‘catechismo’: primum Freud. Allora, due cose. In Analisi Terminabile e Interminabile (1937), [Freud] nomina tre azioni la cui realizzazione corretta è impossibile, ma a cui non si deve rinunciare: «Sembra quasi che quella dell’analizzare sia la terza delle professioni “impossibili” il cui esito insoddisfacente è scontato in anticipo. Le altre due, note da molto più tempo, sono quelle dell’educare e del governare». Sono d’accordissimo che non possiamo portare la bandiera del valore etico o intenzionale di ciò che stiamo facendo come giustificazione del nostro lavoro, eppure non possiamo prescindere dalla necessità etica di praticarlo. L’altra cosa che Freud scrisse nell’Introduzione alla psicoanalisi (1932), ultima serie di lezioni, è che la psicanalisi non è una Weltanshauung (concezione del mondo). Importantissimo: la psicanalisi non è un modo di guardare al mondo, non è una visione del mondo. La psicanalisi è innanzitutto una pratica. L’errore protratto molto a lungo è stato quello di innescare questa continuità tra il pensiero accademico, filosofico e la psicanalisi. Il connubio tra filosofia e psicanalisi sarebbe dannoso? Guarda che cosa hanno scritto i vari psicanalisti (Lavagetto, Orlando, ecc.) che si sono occupati di letteratura o di arte. Franco Fornari stesso ha scritto un bruttissimo Pag. 22 libro su Agostino di Moravia. Soprattutto la psicanalisi degli anni Settanta ha cercato di attestare una sua attendibilità teorica. Invece che ispirarsi in modo creativo e curioso all’arte e alla letteratura, cogliendone gli stimoli preziosi e la capacità di intelligenza e di rappresentazione, certa brutta psicoanalisi ha cercato di spiegare i tratti psicopatologici nascosti dell’artista o della sua opera. Per fortuna, filosofi come Gilles Deleuze hanno fatto giustizia e chiarezza sull’arte di Francis Bacon; semiologi come Roland Barthes ci hanno aperto gli occhi sulla lettura dell’immagine! Sembra che la psicanalisi si senta sempre sorella minore della medicina, della filosofia delle scienze positive. E c’è ancora chi cerca di dire che è scienza, che è vera, è giusta e cura; e poi non ci credono davvero a quest’effetto di cura. È come sentirsi né carne né pesce e rimanere schiavi della medicina e fratelli minori della cultura filosofica e intellettuale. Quindi per te la psicanalisi non è una teorizzazione? E non ha bisogno di teoria? Ha bisogno di una pluralità di teorie. Non possiamo dire che c’è una teoria psicanalitica, ma è anche sbagliato dire: c’è quella freudiana, quella kleiniana, quella lacaniana. Ripeto: si può virare da una all’altra, se si conoscono i punti di snodo, ma la psicanalisi ha bisogno di una quantità molto vasta di teorizzazioni. E deve guardare di più alle scienze? Pensiamo ad Antonio Damasio o ai neuroscienziati che, spiegando la funzione dei neuroni a specchio, permettono di convalidare l’importanza dei processi inconsci di identificazione. Ciò significa, ad esempio, che guardando un paziente, ascoltando la sua voce e sentendo lui la mia, muovendomi e pensando certe idee, attivo un’area di arricchimento di comprensione e di conoscenza possibile che si potrebbe chiamare banalmente creativa. La scienza oggi mi dice: quello che fai è attendibile, è vero che funziona. Come psicoanalisti l’abbiamo dato sempre per scontato, ma dirlo non è così facile. Per questo compaiono la famosa empatia o le relazioni affettive rimosse, quasi a giustificare che fra due soggetti qualcosa di nuovo accade! E come potrei negare le funzioni di neurotrasmettitori, come la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, ecc.? Devo sapere che un individuo sottoposto a una fatica, a uno stress, al dolore, o a qualche cosa di molto grave, andrà accudito, magari aiutato ad accettare un aiuto farmacologico stabile o temporaneo adeguato. Dovrò poter telefonare a un collega psichiatra e dirgli che questo neurolettico per questo paziente è troppo, lo fa star male. Oppure: guarda che questo neurolettico non va bene, non si può sostituirlo o somministrargliene un po’ meno? Se non so queste cose, non so curare il paziente. La teoria mi può dire quello che vuole, però io sono presente anche per riconoscere che un farmaco a una persona fa bene ma all’altra fa malissimo, che una cura tipica può essere straordinaria per un’anoressica ma inutile o dannosa per un’altra, che solo un ottavo del dosaggio standard di un farmaco neurolettico è sufficiente a quello psicotico cosiddetto delirante: è semplicemente preda Poliscritture/Samizdat di un’angoscia tremenda e quel farmaco che non lo stordisce gli fa recuperare un grado di calma e magari poi smetterà anche di prenderlo. Ora io non posso teorizzare che i farmaci non servano, che la serotonina non è così importante. Alla stessa stregua, un cognitivista così come un fenomenologo su certe cose hanno ragione. Se lo psicanalista interpreta come atto mancato un comportamento inconsueto che in realtà dipende da un’anomalia dell’amigdala, sta facendo un abuso teorico, ignorando le conoscenze che ci hanno portato le neuroscienze. Allora da un certo punto di vista bisogna dire con chiarezza che la psicanalisi non è una teoria unitaria. L’attenzione dello psicanalista verso le scienze non significa rifiuto della filosofia, vero? No, anche dalla filosofia possiamo trarre insegnamenti preziosi. Io trovo interessanti ad esempio le questioni del tempo, del tempo inconscio, del non tempo dell’inconscio (una questione importante in sospeso) da Husserl ad Heidegger a Emanuele Severino, un uomo di grande intelletto secondo me: la questione dell’eterno presente, del tempo presente è una vera spiegazione teoretica del modulo logico del tempo. Da psicoanalista non posso affermare che il senso del tempo è quello che dico io e non è quello che dice Emanuele Severino… Possiamo dire che la psicanalisi è un sapere o una scienza aperta… È una scienza aperta. Riprendiamo ancora Freud, che segnalò quello che la psicanalisi non deve fare: negare. Perché non deve avere una funzione negativa? Perché la funzione negativa si legge, in psicoanalisi, come meccanismo difensivo rispetto al reale, e al sapere che si produce. Non mi posso permettere, come psicanalista, come essere pensante, come essere umano, di negare a priori un dato del sapere solo perché scombina la mia teoria. Prendiamo l’esempio di alcuni pazienti citati da Damasio. Potrebbe capitare che uno di loro, portatore di una lesione all’amigdala, dia una risposta assolutamente serena e non aggressiva davanti a chi lo insulta o lo malmena, anzi è sorridente e bonario. Come psicoanalista, o psicologo, o psichiatra, potrei pensare che probabilmente il paziente ha un tratto masochistico, o forse ha una componente d’identificazione con il proprio aggressore, o forse interpreta l’attacco in modo metaforico. Potrei dire un sacco di sciocchezze! Perché chi ha una microlesione nell’amigdala può essere assolutamente capace di vivere, di amare, di lavorare di fare una vita comune, ma non riesce ad individuare i segnali aggressivi (tono di voce, alterazione motoria, ecc.) di un altro come minacciosi, non codifica questo come un attacco, si comporta in modo non reattivo. Allora, se dieci anni fa potevamo pensare che fossero fissazioni dello scienziato, oggi dovremmo imparare qualcosa di più dalla metodologia filosofica: sospendere il giudizio, fare “l’epochè”, la sospensione del pre-giudizio, in attesa delle rilevazioni fenomeniche adeguate al giudizio. Se no, si fanno delle operazioni assolutamenPag. 23 te criticabili. Come psicanalisti dobbiamo interrogarci: perché mai dobbiamo negare qualche cosa? La psicanalisi oggi è sottoposta a molti attacchi. Nel 2005 è uscito Il libro nero della psicanalisi e, in risposta a quel testo, Elisabeth Roudinesco ha scritto Pour quoi la psichanalyse. Qual è la tua opinione? La Roudinesco fa una serie di osservazioni sulla legittimità del lavoro analitico, sul fatto che il soggetto umano non può essere ridotto a certe categorie e dà una risposta anche abbastanza attendibile. Però penso anche che la psicanalisi dovrebbe abbattere la propria presunta onnipotenza. Noi stessi siamo stati psicanalizzati da quelli che abbiamo considerato maestri, ma credo che oggi il mito sia sfatato, che forse vada preso atto che un’umiltà rispetto agli altri saperi dobbiamo averla, perché altrimenti rischiamo di ideologizzare, di confezionarci “vestiti di idee” (l’Ideenkleid che Husserl ci ha insegnato a riconoscere). Eppure tutti parlano di epoca post-ideologica… Quest’anno mi hanno colpito molto alcuni colleghi americani. In modo pregiudiziale spesso li avevo considerati poco stimolanti sul piano intellettuale. Invece ho conosciuto Eric Plakun, che lavora da trent’anni all’Austen Riggs Center, dove sono ricoverati i pazienti suicidali o con rischio suicidale alto e con un alto grado di rifiuto di ogni forma di trattamento psicanalitico o psicoterapico. Lui è responsabile da trent’anni di quest’ospedale. È di una semplicità, di un’umiltà assolute. Ha scritto un saggio bellissimo (ci ha lasciati tutti con tanto di naso!) che riflette sugli errori dei terapeuti, che non sanno affrontare il fallimento della propria terapia né la paura di parlare di morte o la mortalità possibile del paziente. Ciò implica che a volte i terapeuti non sanno usare costruttivamente quell’aggressività che viene sollecitata dai pazienti. Plakun pone la questione in questi termini: tu, analista che lavori con una persona che si può ammazzare e rifiuta la terapia, sai che cosa ti sollecita, sai che controtransfert – diremmo noi negativo - sollecita in te, sai che parti tue di rigetto, di furia, di rabbia, di non accettazione, di negazione, sollecita? Ha fatto un’indagine sugli errori nel processo, quando non si guarda e a volte non si parla col paziente di questa problematica. Ora all’Austen Riggs hanno una bassa percentuale di pazienti che si suicidano lo stesso. Ma un’altissima percentuale di pazienti riesce a superare questa impasse. L’altra cosa intelligentissima è che, se un terapeuta in supervisione non riesce ad affrontare la questione distruttiva ed è in qualche modo quasi complice del paziente, il team che segue il paziente darà il compito di elaborare il nucleo distruttivo a un altro terapeuta, che interviene magari col gruppo, anziché con la terapia individuale piuttosto che con la terapia farmacologia. Sarà quest’ultimo a svolgere la funzione necessaria, senza bloccare l’altra funzione utile che il terapeuta connivenPoliscritture/Samizdat te in qualche modo sta svolgendo. Da un americano non mi aspettavo tanto, francamente. Ed è un insegnamento che ti fa pensare. Per esempio quando noi generalizziamo e non prendiamo atto che abbiamo delle difficoltà, dobbiamo affrontare delle cose che non ci piacciono proprio e ci troviamo di fronte a questioni abbastanza complesse… ecco, loro fanno una clinic, dove c’è questa gente che lavora insieme e si integra in uno scopo comune. Per noi è una cosa abbastanza strana e di là da venire… Con questa pluralità di approcci e, diciamo pure, di eclettismo e d’incertezza come fa l’analista a sciogliere i nodi più difficili? Quando ha dei dubbi, a cosa, a chi ricorre? Ci sono dei supervisori? Non ce n’è quasi nessuno. Io vado a Londra da Bollas, magari anche solo per una supervisione. Lavoro con lui e procediamo in un lavoro di ricerca a tempo indeterminato. Grazie al cielo ci capiamo bene. Ho anche degli scambi con alcuni colleghi di Parigi, posso confrontarmi abbastanza frequentemente coi colleghi americani, c’è qualche collega milanese col quale è possibile uno scambio di punti di vista. Devo dirvi se a Milano c’è qualcuno che mi capisce? Pochi e poco. Molti non capiscono neanche di cosa sto parlando. Se sono chiusi in una teoria, sono io che mi devo sforzare di parlare il loro gergo, i miei riferimenti pluralistici sono faticosi! Allora un analista, che s’accorge della complessità dei nuovi disagi e dei rischi che corre nell’affrontarli, su cosa può contare? Secondo me su un lavoro d’équipe. L’ex Ospedale Psichiatrico “P.Pini” in qualche modo lo fa: sono una rete di persone che possono collaborare. In primo luogo ci vorrebbe un lavoro d’équipe organizzato principalmente dallo psicanalista. In secondo luogo una collaborazione stretta con le altre figure terapeutiche (non un’esclusione come se una fosse la figura utile e le altre figure accessorie). A volte la figura psicoterapica più efficiente può non essere affatto quella dello psicoanalista, ma lo psicoanalista deve supportare adeguatamente la figura designata e favorire un’armonizzazione dei compiti dell’équipe. L’altro discorso è la supervisione. Sì, la supervisione posso chiederla ad alcuni. Per carità, se c’è una persona che mi può illuminare! Però a volte sono pochissimi quelli capaci di lavorare su piani complessi. Ormai con queste scuole esplose dovunque, non c’è più psicoanalisi che si sofferma a pensare! L’altro discorso è che io ho in supervisione alcuni colleghi. Cosa faccio, quando prendo in supervisione casi gravi? Una comunicazione almeno settimanale; e poi prendo in carico assieme al collega il lavoro che sta facendo, segnalandogli chiaramente quello che non vede. Viene da me una collega che a volte lavora con casi gravi e si è trovata nel panico. Allora, per es., quando tu fai un quadro molto dettagliato e preciso con un collega che supervisioni, prima di tutto devi sapere fino a che punto Pag. 24 il collega ha lavorato su di sé. come uno dei migliori analizzanti! Ho avuto una collega in analisi per due anni e mezzo, perché aveva bisogno di capire delle cose che non aveva mai analizzato per continuare in quest’area di supervisione. E allora era importante che prendesse contatto con delle aree psicotiche di sé, che non aveva mai tenuto in considerazione e che quindi interagivano male con quelle del paziente. Non poteva essere così pacata da lasciarlo tranquillo se aveva bisogno di catalogarlo, di collocarlo, di applicare la tecnica - questa cosa di applicare le tecniche è mostruosa! Anche la questione del vecchio dispositivo delle quattro o cinque sedute alla settimana, della neutralità dello psicanalista, dell’accettazione indiscutibile delle regole e dei tempi, della frequenza e dei pagamenti non può essere attuata al giorno d’oggi. Pensa che a New York è rimasto un solo allievo psicoanalista che procede nella formazione tradizionale dell’Internazionale Freudiana. Vorrà pur dire qualcosa rispetto ai cambiamenti necessari. Imparate queste cose, allora, il lavoro può essere: “stiamo vedendo quello che succede!”. Non è che io preveda esattamente quello che succederà, ma devo avere una mappatura molto precisa, come un piano cartesiano che ti permette di individuare il punto, l’oggetto. È un lavoro davvero difficile… Secondo me, quando ci sono grosse difficoltà col collega in supervisione che ha un caso difficile da trattare, devi disporre tanti occhi che guardano, devi tenere presente una serie di dinamiche che si muovono. A volte ci vuole pazienza da parte del terapeuta o dell’analista, perché pare che per molto tempo non succeda niente... E magari nell’analista si coltiva l’angoscia, si annida un malessere, non dorme di notte: ti porti dentro dei mattoni pesanti, incredibili. E devi reggere. A volte quello che fa succedere qualche cosa è proprio il fatto che tu riesca a tenerti tutta questa carica mostruosa di angoscia, di malessere, portartela dentro; e a volte vedi il paziente che esce alleggerito dal tuo studio e tu ti senti pieno di pesi, di lividi, di insuccessi… Un paziente che aveva delle fissazioni gravi mi era stato mandato da un reparto psichiatrico importante di Milano. Aveva delle gravi situazioni deliranti. Ho notato che aveva bisogno di un tempo della seduta completamente fuori da quello del setting, fuori da certi canoni. Perciò fa una seduta di due ore. Tutte le volte, per un anno abbondante, due ore alla volta, perché per sentirsi a proprio agio, per sciogliersi verbalmente, per poter instaurare un rapporto sufficiente, ha bisogno di almeno una mezz’ora. E adesso che si sente a proprio agio, il tempo è quello, un tempo lungo. So che sarebbe dovuto venire non meno di due tre volte la settimana. Ma ci sono più problemi. Primo: secondo lui due, tre volte è troppo e non se lo può concedere. Poi economicamente non se lo può permettere. E poi per lui venire più volte sarebbe un segno di gravità. E allora cosa ho fatto? Ho lasciato l’accordo di una sola seduta alla settimana, una seduta che occupa il tempo di tre sedute che si tengono in giorno solo. È fortemente antieconomico, dal punto di vista del denaro che guadagno. E però a volte un tempo antieconomico è indispensabile… Il tempo prolungato così, per questo paziente, è indispensabile. Se confronti il mio comportamento con un rigido setting, si può dire che io mi comporti in modo selvaggio! Ma il paziente è guarito, se così si può dire, dalla propria patologia psicotica e sta lavorando ora come ogni normale nevrotico, anzi Poliscritture/Samizdat Pag. 25 Distruggere quello che ti distrugge 1 Giacomo Conserva Lo statuto della follia è sempre stato dubbio: dono degli dei; espressione della fragilità umana e suo specchio; pura negatività; chiave verso un futuro. Apro casualmente un testo appena scaricato dalla Rete (Typography, di Lacoue-Labarthe), e leggo l’inizio: “Quasi dappertutto è stata la follia ad aprire la strada per l’idea nuova, a rompere l’incantesimo di una abitudine venerata e della superstizione. Capite perché è stata la follia a far questo? Qualcosa dalla voce e dall’atteggiamento inquietanti e incalcolabili come i modi demonici del tempo e del mare, e perciò meritevole di un uguale rispetto e attenzione? Qualcosa che portava altrettanto visibilmente il segno della totale non libertà delle convulsioni e della bava dell’epilettico, e che sembrava designare il folle come la maschera ed il portavoce degli dei? Qualcosa che nel portatore di una nuova idea risvegliava reverenza e timore per sé stesso - non più i tormenti della coscienza - e lo spingeva a divenire il profeta ed il martire della sua idea?” Altre letture sono state fatte. Il problema sono i ‘sani’, la ‘normalità’: tutte le formulazioni di Laing etc. E che la ‘normalità’ incorpori un alto tasso di repressione sociale interiorizzata mi pare difficile da contestare. Ma è stato pure detto: fare della malattia un’arma (l’SPK, collettivo socialista dei pazienti- Heidelberg inizio anni ’70): gruppi di discussione con ‘pazienti’, utilizzando sullo sfondo Marx e la Fenomenologia dello Spirito - gruppi di discussione e rottura dell’ordine psichiatrico (e non solo) - ben al di là della rivendicazione del proprio diritto alla devianza dalla norma. Naturalmente, la ‘follia’, in quanto tale, non esiste. O almeno, non esiste più, in quanto le categorie percettive, ideologiche, teoriche sono cambiate. In questo c’è una lunga storia, non conclusa (per es. all’inizio degli anni ’70 in USA l’omosessualità venne ufficialmente non più considerata una malattia). Ora abbiamo psicosi, depressione, ansia, disturbi di personalità… Abbiamo persone 1 Letture: Gloria Anzaldua, Borderlands /La frontera, The new mestiza, Aunt Lute Books 2007 (1987). - Saskia Sassen, Una sociologia della globalizzazione, Einaudi 2008 ( 2007).Neil Brenner e Roger Keil, a cura di,The Global Cities Reader, Routledge 2006.- G. Deleuze e F.Guattari, Millepiani. Capitalismo e schizofrenia, Castelvecchi 2003 (1980).- Allen Ginsberg, Kaddish (1961), in Poesie scelte 1947-1995, testo inglese a fronte, Net 2005.- F. Lyotard, Il dissidio, Feltrinelli 1985 (1983). - R.D. Laing, L’io e gli altri. Psicopatologia dei processi interattivi, BUR 2002 (1961). Poliscritture/Samizdat che a volte chiedono aiuto; altre rispetto alle quali viene chiesto aiuto (e anche questa è una categoria vastissima: si pensi all’uso a suo tempo in URSS della categoria ‘paranoia’ - delirio di persecuzione e di grandezza - contro non pochi oppositori). Inoltre, il problema non riguarda solo ‘gli altri’, ma ciascuno in prima persona: io, che scrivo queste righe (come te, che le leggi), posso avere avuto (o avere, ora o in futuro) periodi di alterazione e sofferenza estrema; di me (di te) può venire detto - a un certo punto - che sono strambo, bizzarro, patologico. A torto o ragione. (Non solo nessuno è senza colpa, ma nessuno è esente dai rischi della conditio humana). La globalizzazione e la rivoluzione tecnico-scientifica comportano sovvertimenti cognitivi e sociali. L’ambiente di lavoro e di vita cambia senza tregua (e spesso senza preavviso). Flussi di denaro, di merci, di immagini e suoni e parole, di persone, di tecnologia si intrecciano vorticosamente. Il caos ha anche i suoi lati positivi, certo. Era stato detto: non avere una identità fissa (contro la società patriarcale, autoritaria, fallocentrica); ma vi sono anche gli aspetti di violenza, disgregazione, distruttività pura, diffusa, o interpersonale nei piccoli gruppi, o contro sé stessi. Le nostre menti e i nostri corpi hanno a volte difficoltà a fare i conti con tutto questo. Tutto ciò è particolarmente evidente se esaminiamo le storie di stranieri ‘con problemi psichiatrici’ (o psicologici). Se si scava appena sotto la superficie, ci troviamo proiettati in luoghi come Kushab, perso nelle campagne del Punjab, ove c’è un reattore per il plutonio; o Souk Sebt (un vecchio piccolo mercato settimanale, come dice il nome), Marocco, regione di Beni Mellal (povera, ad altissimo tasso di emigrazione): leggendo un blog nel sito del municipio scopro (da un migrante che scrive furioso dalla Germania) della recente apertura lì, contro ogni tradizione e contro la legge coranica, di una vineria (a Beni Mellal, d’altro canto, stanno per aggiungere un moderno reparto psichiatrico all’ospedale distrettuale). Un russo-italiano mi parla (è ben al di là della fase acuta dei suoi problemi), per diverse variabili della sua storia, di una città chiusa russa specializzata in produzioni strategiche e militari, di un porto sul mare Artico, di una città dell’Australia, di un sito elettronico che permette di contattare i suoi compagni di liceo variamente dispersi per il mondo, oltre che di Parma, dove vive; da una piccola città della Moldavia mi giungono storie di aggressioni di strada, e della guerra con la Trans-Dnistria all’inizio degli anni ’90. Posso discutere di Al Jazeera (trasmessa dal principato del Dubai) con un operaio di Fornovo (a Fornovo si svolse nel 1495 una famosa battaglia contro Carlo VIII di Francia e nell’aprile 1945 una altra battaglia contro divisioni tedesche e della Repubblica di Salò in ritirata: si arresero alla fine in 15.000) … e tutte le variabili e intrecci di storia - familiari, sociali, economiche - possibili e immaginabili. Lo stesso, naturalmente, vale per gli italiani nativi (ammesso che p.e. non siano nati in Germania, come non poche volte capita di vedere). Era stata la lezione di Deleuze e Guattari: indagare e seguire i flussi, le ramificazioni, i concatenamenti - fare linea, non punto - mettersi dal punto di vista dei processi, e delle strutture e dei gruppi in trasformazione. Pag. 26 In quanto psichiatra non ho nessuna lezione da insegnare, nessuna normalità da difendere. Posso solo aiutare le persone a fare quello che cerco di fare io: muovermi in questo oceano, essendo il più lucido possibile su dove mi trovo e cosa sto facendo e cosa ciò implica; e il meno rigido possibile davanti agli eventi interni ed esterni, alle situazioni, alle emozioni, ai rapporti. Naturalmente, è molto più facile da dire che da fare. Ma, come è stato pure detto - wir sind nicht allein - non siamo soli: si può, nel corso del tempo, chiedere aiuto, riceverlo, pure darlo. “Arsenio Lupin” e il “dominio delle cose” la difficoltà di mentalizzare le emozioni Marina Massenz Scena I All’uscita dalla terapia, S. dice che vuole andare in bagno. La mamma chiede: “Hai bisogno d’aiuto?”. “No, no… faccio da solo.” Sento subito una nota “stonata” in quest’affermazione, peraltro apprezzabile in un bambino di cinque anni in cerca di una sua autonomia; è una sfumatura, un tono di voce… Che però mi torneranno in mente, suonando come un campanello d’allarme, quando, per tutto il pomeriggio, il Centro presso cui lavoro vive il disagio della scomparsa delle chiavi della porta dei servizi. Sapevo già che il bambino aveva l’abitudine di “rubare” i soldi dal borsellino della madre, uno dei sintomi del suo malessere che aveva convinto i genitori a chiedere un aiuto terapeutico per comprenderlo e aiutarlo. Ma fino a quel momento non avevo incontrato che un bambino molto bello, intelligente e vivace che si limitava a giocare con me alcune partite sul tema oppositivo-provocatorio; eravamo all’inizio della terapia. Il dialogo telefonico con la madre, il giorno seguente, si sviluppa intorno al fatto avvenuto al Centro: ha preso S. le chiavi del bagno? Il bambino, da lei interrogato, prima nega, poi ammette; dove sono ora non lo sa, forse le ha perse… Nel nostro incontro successivo, racconto a S. (come fosse solo un fatto che riguardava me) quanto fossimo stati “disperati” non trovando più le chiavi; faccio un racconto realistico, dettagliato, ma non gli chiedo nulla. S. è molto partecipe emotivamente e subito mi offre il suo aiuto: “Cerchiamole…”. Esce, guarda in bagno, poi dice: “Forse sono cadute… forse nello zainetto di un bambino (e fruga nel suo). Forse sono cadute nelle tasche del cappotto (e guarda nella tasca del suo)”. Purtroppo, esprime un certo dispiacere, non si trovano! Scena II Ornella Garbin, In cerca di aiuto Alcuni mesi dopo, S. termina la sua seduta con molta fatica; il gioco che stavamo facendo lo coinvolgeva molto, stavamo bene insieme… Sono comunque costretta a richiamarlo all’orario, alla conclusione del nostro incontro. Esce con un certo sforzo, si adatta alla “regola” stabilita, ma noto che osserva con intensità F., il bambino che entra nell’ora successiva alla sua. Poi, dopo che Poliscritture/Samizdat Pag. 27 l’ho salutato e richiuso la porta per iniziare il mio lavoro con F., vedo la sua testa che fa capolino dalla porta; “ciao!” mi dice. “Ciao S., ci vediamo la settimana prossima!” Capisco la sua fatica, cerco così di rassicurarlo sulla continuità della nostra relazione. Ma… quando F. esce dalla stanza non ci sono più le sue scarpe! Il bambino va nel panico, vive con angoscia questo attacco ai suoi oggetti personali, le scarpe poi! Gli dico che forse qualcuno le ha nascoste, cerchiamo! Infatti, troviamo una scarpa di F. nascosta nella cesta dei panni. Ma l’altra? Anche il nonno, molto in ansia perché non può portare a casa F. senza scarpe e lo aspettano per una data ora, ci aiuta nella ricerca. Niente. Telefono alla mamma di S., che, molto prontamente, mi dice: “Adesso torno subito lì con S.!”. S. nega fermamente di aver fatto sparire lui la scarpa di F., finché la mamma, frugando quasi senza più speranza nel suo zaino, la trova lì. Quando arrivano al Centro, la scena è inquietante; lei è imbarazzatissima e mortificata per il comportamento del figlio, F. è furibondo e, pur essendo timido, è rosso in viso e lancia saette dagli occhi, anche se non dice nulla apertamente a S.; il nonno, molto saggio, ma ora alterato, in ansia e in ritardo, cerca di metterci una buona parola, ma con scarsi risultati. S. osserva la scena con apparente indifferenza, anzi noto in lui un sorrisino trattenuto. Dopo avere gestito come potevo questo momento difficile un po’ per tutti, con la bambina dell’ora successiva che mi tirava per la mano sollecitandomi ad andare nella “nostra” stanza, mi richiudo la porta alle spalle. Mi resta in testa, come una foto istantanea, l’immagine della mimica del viso di S.; un insieme complesso di espressioni, dallo scherno (il sorrisino), alla paura (nello sguardo), all’apparente indifferenza del resto del volto. Come se lui fosse lì per sbaglio e guardasse da lontano tutto quel parapiglia e l’affanno delle persone intorno a lui; come se il “fatto” non lo riguardasse più di tanto. Scena III Proprio pochi giorni prima S. era arrivato da me accompagnato dalla signora che fa i servizi a casa sua; così, in seduta, avevo avuto l’opportunità di parlare con lui dell’affetto che nutre nei confronti di questa persona, la cui bravura nel cucinare è molto apprezzata dal bambino. Parla invece della sua baby-sitter in termini assolutamente diversi; è arrabbiato con lei perché, quando va a prenderlo all’uscita da scuola, non gli permette di fare la merenda prima dei compiti. Lui invece è molto stanco e ha fame! Questo racconto (che rimanda forse non tanto alla stretta verità dei fatti, ma piuttosto al suo vissuto emotivo-affettivo di questa relazione) mi pare una prima apertura al “pensiero sugli affetti” e quindi un momento importante di transizione verso il percorso di “mentalizzazione delle emozioni” che ho ipotizzato come strategia terapeutica. Purtroppo però questo inizio di elaborazione dei propri vissuti da parte del bambino non è sufficiente ad impedire un ulteriore “fattaccio”; infatti sparisce il portafoPoliscritture/Samizdat glio della baby-sitter. Il fatto è grave, perché vi erano contenuti anche documenti, carta di credito e soprattutto il permesso di soggiorno, dato che la ragazza è straniera; quindi la scena che si svolge in casa è drammatica. Lei piange, si dispera; la madre di S. l’accompagna in questura a denunciare il furto del portafoglio, ma prima interroga S., spiegandogli la gravità del fatto e mettendolo di fronte al dispiacere della sua baby-sitter. Niente! S. assicura in maniera fermissima che no, non ne sa proprio nulla! La sera anche il padre lo prende da parte e con parole calme e accorate lo invita a dire la verità, a restituire subito il portafoglio, gli spiega che più tempo passa più il fatto si fa grave, che poi risulterà essere anche bugiardo ecc. Ma il bambino, che io immagino ormai sopraffatto dalla vergogna e dal dispiacere per quell’azione, non ce la fa proprio a parlare; si trincera dietro una negazione insormontabile. Il fatto accade il venerdì; il martedì successivo, l’altra giornata in cui la ragazza viene a casa loro, S. compare sventolando il portafoglio e dicendo alla baby-sitter sorridendo: “Ho un regalo per te!...”. Arsenio Lupin Dopo il secondo atto comincio a chiamare dentro di me S. “Arsenio”; del famoso ladro ha non solo l’abilità, ma anche la capacità di predisporre piani infallibili. Una mente che programma il “danno”, che studia le mosse e le parole giuste, che sa colpire in modo imprevisto e imprevedibile. Però, questa è la mente di un bambino di cinque anni. Di un bambino che soffre. Perché “ruba”, Arsenio? Ruba affetto, che sente di non avere ricevuto in misura adeguata ai suoi bisogni, che pensa sia stato dato in misura maggiore alla sorella gemella; esprime gelosia, verso di me, che anziché occuparmi solo di lui dopo un’ora lo lascio per giocare con un altro bambino; manifesta rabbia, verso la baby-sitter, che non gli lascia fare la merenda come lui vorrebbe, prima dei compiti… Le emozioni non sono pensabili, la sua piccola mente non riesce a contenerle, elaborarle o dare loro degli sbocchi più immediati e leggibili, che consentirebbero anche agli adulti che gli sono intorno di comprenderlo meglio e magari, quando è possibile, accogliere i suoi bisogni, sintonizzarsi sui suoi vissuti. Arsenio utilizza tutta la sua intelligenza per studiare “piani” che portino queste emozioni “ingestibili” fuori dal contesto relazionale, per renderle fatti, per commerciare emozioni con cose. Nella confusione e nel panico generale che il suo comportamento genera - collera e sgridate, castighi e “ramanzine” - egli si trova poi sopraffatto da sensi di colpa e sinceramente pentito e forse disperato; l’ha fatta così grave che è impossibile rimediare! Quindi il circolo vizioso tende a riprodursi; al “danno irrimediabile” succede un ulteriore danno, quasi a confermare l’immagine di bambino cattivo e pericoloso che sta costruendo intorno a sé. Pag. 28 Un’altra modalità che S. utilizza per “provocare” gli adulti è quella di fare la cacca, senza che nessuno sulle prime se ne accorga, nei posti più improbabili: in mezzo al giardino della scuola materna, nel salotto di casa, nella camera che divide con la sorella (presso le cose di lei), a volte “spargendola” con cura sul suo tavolo… Per questo l’attitudine terapeutica che mi sembra più utile per aiutarlo è quella di evitare la colpevolizzazione (“Hanno preso le chiavi del bagno… chi sarà stato?), puntando a rimettere in moto le parti “buone” e “capaci”di S., esprimendo indirettamente fiducia nelle sue possibilità di “aggiustare il danno”. Entro in sintonia con il bambino che segretamente soffre per avere così crudelmente attaccato l’oggetto (gli oggetti) d’amore e che si sente incapace di risollevarsi dalla situazione emotiva (dolore, colpa, immagine negativa di sé, vergogna…) in cui si trova; lo sviluppo di capacità “riparative” è infatti quello che consente ai bambini di accettare la propria aggressività, le proprie parti “cattive”, proprio perché integrate come meno pericolose e distruttive. Insomma, posso anche fare un cattivo scherzo, un dispetto, un capriccio con la mamma, ma sapere anche in fondo che non soccomberà a questo mio attacco e che attivamente potrò (un abbraccio, una parola dolce, un sorriso…) recuperare il suo affetto, solo temporaneamente (nel vissuto del bambino) perduto. Se il potenziale aggressivo e i sentimenti negativi possono essere vissuti dal bambino come “non troppo minacciosi” egli potrà giocarseli apertamente nella relazione con l’altro, fiducioso nella propria capacità di farsi perdonare e di essere perdonato. Spesso durante le sedute lo gratifico per le sue abilità, le costruzioni meravigliose che sa fare, la capacità di “giocare bene” con me; gli occhi azzurri e profondi di S. si illuminano di vera gioia in questi casi, e posso vedere attivarsi un bambino molto dotato e di buoni sentimenti. Il rapporto tra S. e Arsenio è però molto complesso e difficile da sbrogliare; infatti il crinale che divide queste due diverse modalità di essere del bambino è ancora molto sottile. La strada, in salita, è quella di rendere mentalizzabili le emozioni, di poter pensare ed esprimere anche quelle negative, di rinunciare progressivamente a questi agiti per lasciar posto ad una loro circolazione all’interno della comunicazione con l’altro. Su questa strada ci stiamo avviando, faticosamente; è quasi un percorso archeologico, nel senso che con la paletta del nostro secchiello - la relazione affettiva che si è creata tra noi - stiamo cercando di disseppellire queste indicibili emozioni per renderle meno violente ed accedere alla possibilità di “giocarle” sul piano simbolico (la scena è spesso quella del duello, che si svolge tra noi senza morti e feriti grazie a bastoni di gommapiuma), per poterle anche poi esprimere verbalmente. Considerazioni generali Il disagio infantile si esprime a volte in modi “terrificanti” per gli adulti; il bambino “ladro” a cinque anni terrorizza i genitori, perché il mondo adulto fa spesso fatica a guardare il mondo dell’infanzia usando, come si dovrebbe, occhiali diversi. Per S. il furto è un’azione lesiva, è senz’altro un’aggressione all’adulto, ma non è assimilabile al codice delle leggi e dei comportamenti adulti. Per S. si tratta di agire il suo impulso, come potrebbe fare un altro bambino dando un calcio o spaccando un giocattolo; paradossalmente, le sue stesse doti (l’intelligenza) gli hanno reso la vita più grama. Infatti, la capacità di sviluppare una “strategia” complessa per esprimere i suoi sentimenti nascosti lo rende ancora più difficile da capire e gestire di quanto lo è un bambino che tira un calcio. Inoltre, questa strategia è anche in grado di “nasconderlo ai suoi stessi occhi”: per un po’, finché non lo scoprono, S. può dimenticarsi di “essere cattivo”. Spesso, anche scoperto, nega l’evidenza, come se fosse possibile fare in modo che, come l’ha dimenticata lui, possano scordarla anche gli altri. La negazione è quindi la seconda trappola che si costruisce, la cui fragilità lo espone poi a reazioni ancora più pesanti da parte dei genitori e dell’ambiente che lo circonda. Insomma, ladro e pure bugiardo. Ornella Garbin, Capriola sull’erba Disseppellire le emozioni prima che Arsenio se ne appropri e le agisca dentro a un suo piano “diabolico” è quindi per me come una strana gara con il tempo e le situazioni. Il dominio delle cose Ma perché rubare? Le cose stanno al posto di altro… come possiamo vedere intorno a noi, come avviene anche nel mondo degli adulti. Oggetti al posto di amore, soldi per valore di sé, chiavi per bisogno di esclusiviPoliscritture/Samizdat Pag. 29 tà, cibo per nutrimento affettivo ecc. Spesso non è più possibile ricondurre il disagio infantile, o almeno il suo modo di esprimersi, all’interno di una visione che comprende unicamente quel bambino, quella famiglia; si tratta di comprendere forse come anche i bambini siano ormai allenati al “commercio delle merci”, da cui sono inondati sia direttamente che indirettamente, attraverso le immagini pubblicitarie. Ricostruire non è più solo un compito che attiene agli affetti, alla buona circolazione degli stessi e alla risoluzione dei conflitti; si tratta anche di ricostruire un “linguaggio”, che non è solo la parola, ma anche i simboli, le metafore attraverso cui ci esprimiamo. Dal mio parziale osservatorio sul mondo dell’infanzia osservo con tristezza un generale impoverirsi dei mezzi d’espressione; emerge un diffuso analfabetismo sulle metafore espressivo-corporee e sulla parola sentita, che dice e viene ascoltata, mentre si diffonde una generale difficoltà nel vivere emozioni, così forti per i bambini da risultare pertanto spesso inesprimibili; vengono così trasferite su sistemi di comunicazioni o più primitivi o materiali. Come se al posto dello sguardo che chiede o della parola che, magari incespicando, sussurra bisogni e desideri, avanzasse prepotentemente la mano che afferra, prende, ruba, nasconde; la bocca che ingoia, mai satura, senza masticare, alla ricerca del latte primario, l’unico digeribile se nel frattempo non sono cresciuti i denti, oppure, se anche sono cresciuti, non sono stati integrati nell’immaginario del corpo come mezzo per “masticare” le emozioni e gli affetti. La forma inquieta Percorsi tra arte e psichiatria1 Giorgio Bedoni Non bisogna credere che tutto è vero, ma che tutto è necessario, scrive Kafka nel Processo. L’aforisma, che sconcerta e sembra scompaginare le carte, ben si presta a cogliere quell’urgenza insita nel lavoro dell’artista: necessità che supera tutte le altre, attraversando con forza sorprendente esistenze fragili, proprio nel punto in cui si è aperto uno iato tra l’io e la vita. Ossessioni/simboli Artisti e psichiatri del Novecento hanno dialogato con insistenza sul “bisogno d’espressione”, sulla sua natura primaria e pulsionale, come la definiva negli anni venti lo psichiatra e storico dell’arte Hans Prinzhorn. “Necessità interiore” nelle parole di Wassily Kandinsky, quando nel caleidoscopico laboratorio dello “Spirituale”, che registra il percorso compiuto per giungere all’astrazione, invitava l’artista “a fissare gli occhi e tendere l’orecchio sulla vita interiore”. Urgenza, dunque, che possiamo meglio comprendere alla luce di una nozione antica e socratica, Daimon, parola che ci richiama al mito e individua la nostra peculiarità, il nostro particolare destino quando entriamo nel mondo. E’ questo, indubbiamente , uno dei filtri possibili attraverso cui leggere l’opera e i processi creativi, la loro dimensione unica ed irripetibile, percorsi che trovano un senso nell’ossessione inventiva, nelle sue tensioni e disarmonie. L’esperienza artistica, ha scritto recentemente Mario Perniola, vive di conflitti e fratture e, per certi versi, si rende infine irriducibile a quelle istanze che intendono normalizzarla. In questa prospettiva il Novecento accoglie storie disarmoniche e tuttavia esemplari: storie di outsiders, di irregolari, di malati mentali i cui linguaggi, talvolta oscuri, irrompono sulla scena per mano delle avanguardie artistiche. Ferdinand Cheval, il “postino costruttore” dedicherà la sua esistenza all’edificazione” di una straordinaria babele morfologica e iconografica” ( Tosatti, 2000): “ Ho lavorato per anni ininterrottamente”, scrive Cheval, “soprattutto la notte, con una candela in testa…”. 1 Riferimenti bibliografici: Bedoni G., Tosatti B. (2000), Arte e psichiatria. Uno sguardo sottile. Milano, Mazzotta. Bedoni G. (2004). Visionari. Arte, sogno, follia in Europa. Milano, Selene. Poliscritture/Samizdat Pag. 30 Ossessione inventiva che non lascia tregua e tuttavia necessaria, dal giorno in cui, continua Cheval, “ mentre facevo il mio giro di consegna delle lettere….inciampai in qualcosa che mi fece ruzzolare per qualche metro. Scoprii che col mio piede avevo fatto uscire dalla terra una pietra di forma strana e attraente e che il luogo ne era pieno; l’avvolsi allora nel fazzoletto e con molta cura me la portai a casa, ripromettendomi di cercarne altre nei momenti liberi dal lavoro. Da quel momento non ebbi più riposo né pace: potevo fare anche cinque o sei chilometri col mio carico di pietre in spalla”. I surrealisti dedicheranno grande attenzione all’opera di Cheval, al suo Palais Idéal di Hauterives: Andrè Breton, collocherà queste forme d’espressione sotto l’ala del surrealismo. In un saggio del tutto particolare, molto caro a Breton e pubblicato per la prima volta nel 1957 così scrive: “ Tutta una corrente trovava la sua rivincita e la sua giustificazione gloriosa nell’appello al funzionamento reale del pensiero, quello dell’arte dei naif, dei pazzi, dei bambini, dei medium. Il palazzo meraviglioso del postino Cheval e le architetture deliranti di Gaudì… tutto questo dilettantismo geniale testimoniava contro l’arte ufficiale europea”. Funzionamento reale del pensiero, dunque: ogni riferimento è all’automatismo, che verrà proposto come l’essenza stessa della poetica surrealista. Surrealismo, scrive Breton nel 1924, “ è automatismo psichico puro… è il dettato del pensiero con l’assenza di ogni controllo esercitato dalla ragione...”. L’automatismo diviene così la via maestra per accedere ad una realtà “altra”, assoluta: surrealtà. riviste e dalle immagini di atlanti che Morgenthaler gli mette a disposizione: luoghi reali, carte geografiche per viaggi straordinari eppure necessari nel vuoto di una esistenza deprivata. Non c’è terapia nell’esistenza di Wolfli: l’arte tuttavia, arte che nasce dal conflitto, è formazione di compromesso che salva dalla catastrofe e permette forme embrionali di ricostruzione di sé. Morgenthaler leggerà nel linguaggio formale di Wolfli una funzione regolatrice; un sistema originale per reintegrare la realtà in via di dissolvimento: qui il processo creativo, prima ancora di essere individuato come l’area illusionale che soddisfa l’espressione del delirio, è un dispositivo che consente di reinvestire gli oggetti esterni di fronte al progressivo allentamento del rapporto di realtà innescato dalla psicosi. L’arte si configura così come il luogo del molteplice, dei linguaggi e delle tecniche; dell’ altrove e del sintomo, del progetto e del desiderio. Una breve storia clinica, nondimeno segnata dalla sua eccezionalità, ci introduce ulteriormente in questo campo, dove il contatto bruciante con la differenza provoca l’estetica, la riflessione psicopatologica e l’istanza terapeutica sul terreno dei metodi e dei ragionamenti. Corpi/figurazioni Su questa strada il surrealismo sarà fecondo sul piano della sperimentazione e delle tecniche, irrinunciabili nel portare alla luce contenuti inconsci, per accedere al profondo. E’ un giorno d’estate del 1939 quando Serge Lifar si reca all’ospedale psichiatrico di Munsingen, dove dal gennaio di quello stesso anno è ricoverato il grande ballerino russo Vaslav Nijinski. I diari clinici descrivono un uomo assente alla vita, serrato in un silenzio assoluto, inerte: l’immagine di uno stato catatonico schizofrenico. Negli stessi anni altri labirinti simbolici catturano lo sguardo di artisti e di psichiatri: nell’universo indifferenziato dell’asilo manicomiale un giovane psichiatra svizzero, Walter Morgenthaler, restituisce un nome ed una storia a uno schizofrenico istituzionalizzato da più di vent’anni e in termini espliciti ne eleva l’opera al rango di vera arte. Nel 1921 pubblica infatti Ein Geisteskranken als Kunstler ( un malato mentale come artista), una monografia dal titolo inconsueto per l’epoca e la prima dedicata a un malato asilare che viene consacrato come artista. Serge Lifar ha deciso di danzare per lui, davanti a lui, nonostante l’inconsueta stranezza di Nijinski lo intimorisca. Prepara dunque un fonografo, ha con sé alcuni dischi del Fauno, dello Spettro della Rosa: inizia a danzare il Fauno, Nijinski lo osserva con attenzione, sembra spaventato. Si allontana, il ritmo del Fauno non sembra stimolare alcuna risonanza. A quel punto Serge Lifar s’interrompe, riprende a danzare, questa volta sulle note dello Spettro della Rosa: il ritmo avvince il danzatore russo, “ rispondendo all’appello dei miei salti”, scrive Lifar, Nijinski inizia a saltare,senza alcun sforzo, senza preparazione. Il complesso e labirintico linguaggio di Adolf Wolfli segna in profondità l’esperienza psichiatrica di Walter Morgenthaler: come Cheval, Adolf Wolfli edifica senza tregua la sua grande opera narrativa, più di 20.000 pagine a carattere autobiografico con migliaia di illustrazioni: opere in bianco e nero e a colori, ordinate e precise, spesso con simmetrie, forme geometriche e ornamentali in gran parte astratte, nelle quali vengono introdotti motivi figurativi, mandalas e collages. Wolfli è un costruttore, la sua opera si configura come il tentativo, intenzionale, di ristabilire un contatto con la realtà. Un lavoro nutrito e sostenuto dalla lettura di Poliscritture/Samizdat La musica finisce, Nijinski è affannato: “ preso dall’estasi”, ricorda Lifar,” mi getto in ginocchio davanti a lui, ed è allora che il genio della danza rispose una volta ancora al mio richiamo, al mio slancio, si mise in ginocchio da davanti a me e disse, indicando il mio piede: bon! Oui! Tres bien! »1. Il celebre, ultimo salto di Vaslav Nijinski conferma quanto l’arte sia necessaria allo sguardo psichiatrico, laddove restituisce un senso ed un linguaggio ad espe1 Tratto da: Der letze Kontinent. Bericht einer Reise zwischen Kunst und Wahn, Limmat Verlag, Zurich, 1997. Pag. 31 rienze ritenute ormai perdute alla vita. Per certi versi l’arte dei malati è l’oggetto ritrovato della psichiatria, sospeso, come la vicenda di Nijinski insegna, tra perturbante alterità e possibilità terapeutica. Forma di cura dunque, quando consente, come scrive Paul Ricoeur, “ la capacità di riaprire” quello spazio di contingenza un giorno appartenuto al passato. La dimensione estetica, aldilà dello specifico scenario della cura psichiatrica, si configura così come un dispositivo che riavvicina ad esperienze infantili precoci, attiva ricordi, fantasie e intrecci narrativi: è dunque un’esperienza affettiva e cognitiva intensa che restituisce, in determinati casi, l’ombra e l’immagine del racconto originario, quelle prime relazioni d’ogni storia individuale che, per essere elaborate, richiedono un contesto facilitante e tuttavia solido, sicuro e continuo nel tempo. “Non opera che è, ma opera che diviene”, osserva Paul Klee negli scritti che raccolgono la straordinaria lezione didattica del Bauhaus di Weimar: qui il racconto originario si dipana nel divenire dinamico della forma; è il mondo delle forme in fieri, della Gestaltung, un concetto chiave che, con singolare coincidenza1, utilizzerà negli stessi anni lo psichiatra Hans Prinzhorn di fronte alle opere dei malati che daranno vita alla grande collezione della clinica psichiatrica di Heidelberg. Altre coincidenze richiamano analogie tra il processo della messa in forma descritto da Klee e certe caratteristiche del lavoro psicoterapeutico: In certi quadri, scrive l’artista bernese, “ si può, in questo o in quell’elemento, scorgere un’allusione alla forma originaria. A volte la distanza rispetto all’immagine originaria è assai grande; è stato percorso un lungo cammino nell’elaborazione di un’esperienza. E in tal caso la coerenza è maggiore, poiché non esiste alcun legame a determinati concetti”. Si è detto in precedenza come il “fare” dell’arte definisca un campo di polarità aperto a costanti relazioni tra memoria e progetto, tecniche e linguaggi. Gli scritti degli artisti documentano direttamente queste intersezioni e confermano il valore delle esperienze primordiali. Ne sono un esempio le pagine autobiografiche di Man Ray, che sottolineano gli stretti rapporti tra ricordi infantili e invenzione. Nello scritto di Man Ray si rammenta una 1 Il dialogo tra arte e psichiatria vive di infinite coincidenze. Coincidenze temporali,che intrecciando eventi rivelano lo spirito del tempo. Così nel 1907 Les Demoiselles D’Avignon di Pablo Picasso annuncia una rivoluzione formale,il Cubismo, che si nutre dell’arte nera e del primitivismo, cioè di quell’ “altrove “ espressivo che sarà accostato, anche in termini discutibili, agli oggetti estetici prodotti dai malati mentali. Nello stesso anno, sempre a Parigi, lo psichiatra francese Paul Meunier aveva posto le basi per un riconoscimento delle opere dei malati, pubblicando sotto lo pseudonimo di Marcel Réja un saggio pionieristico e inusuale per i tempi, L’art chez les fous. Ma il 1907 è anche l’anno in cui Sigmund Freud presenta al pubblico viennese “Il poeta e la fantasia”, saggio che stabilisce una serie di connessioni rivoluzionarie per l’epoca tra l’esperienza del gioco infantile e l’immaginario adulto impegnato nel processo creativo. Secondo Freud, infatti, quest’ultimo costituisce un vero e proprio sostituto “del primitivo gioco dei bimbi”, necessario all’adulto perché indirizza gli investimenti affettivi entro uno spazio illusionale separato dalla realtà. Poliscritture/Samizdat serata parigina del 1922: “ Di nuovo, quella sera, sviluppai le lastre che avevo impressionato. Un foglio di carta sensibile intatto, che era finito inavvertitamente tra quelli già esposti con su il negativo era stato sottoposto al bagno di sviluppo. Mentre aspettavo invano che comparisse un immagine con un gesto meccanico poggiai un piccolo imbuto di vetro, il bicchiere graduato e il termometro nella bacinella sopra la carta bagnata. Accesi la luce; sotto i miei occhi cominciò a formarsi un’immagine; non una semplice silhouette degli oggetti, ma deformata e rifratta dal vetro, a seconda che fossero più o meno in contatto con la carta, mentre la parte direttamente esposta alla luce spiccava come in rilievo sul fondo nero. Mi ricordai di quando ero bambino e sistemavo su un telaietto da stampa un rametto di felce e un foglio di carta per bozze; passavo sopra con il rullo e ottenevo un negativo bianco delle foglie. Il concetto era lo stesso, ma con l’aggiunta di un effetto tridimensionale e d’una gradazione dei toni. Affascinato dall’esperimento esaurii in una serie di tentativi la mia preziosa provvista di carta. Prendevo tutti gli oggetti che mi capitavano sotto mano….non era necessario immergerli nel liquido, bastava posarli sulla carta e poi esporli per pochi secondi alla luce. Ero molto eccitato e mi divertivo enormemente. La mattina esaminai i risultati e appesi alla parete un paio di rayogrammi, come decisi di chiamarli. Avevano un aspetto sorprendentemente nuovo e misterioso”. In questo campo gli esempi sono pressoché infiniti: Jackson Pollock, la cui esistenza è attraversata dalla depressione e dall’alcolismo, amava ripetere di aver appreso la tecnica specifica del dripping ( sgocciolamento, una tecnica che già Max Ernst utilizzava, seppur diversamente, dagli anni quaranta) dalle popolazioni indiane che vivevano nella sua terra originaria; una tecnica rituale, che permetteva di tracciare segni complessi sul terreno. Questa particolare procedura consentirà a Pollock di rinunciare al cavalletto e alla parete; la tela verrà infatti posta direttamente sul pavimento e l’artista danzerà attorno ad essa, lasciando sgocciolare il colore con una “controllata “casualità2 : una tecnica, dunque, che enfatizza la dimensione corporea, gestuale. Qui , in assenza di un contatto diretto tra pennello e tela si modificano i punti di vista percettivi ( un utile suggerimento per terapie a mediazione artistica) visualizzando così in altri termini il noto concetto di regressione al servizio dell’io coniato dallo psicoanalista viennese Ernst Kris, che riscontrava nel processo creativo spostamenti progressivi di livello psichico, contrassegnati da stati di fusione e di differenziazione dalla materia. 2 “Jackson usava dei rotoli di cotone da vela”, ricorda la moglie Lee Krasner, “ne srotolava un pezzo sul pavimento…..venti piedi circa…. Poi usando delle stecche o dei pennelli induriti e delle siringhe per spruzzare, iniziava il lavoro. Il suo controllo era sorprendente, usare una stecca era già abbastanza difficile, ma la siringa era come una grande penna stilografica. Doveva controllare il flusso dell’inchiostro, oltre che il proprio gesto…”. In: C. Ross ( 1990), Abstract Expressionism. Creators and Critics, Harry N. Abrams, New York. Pag. 32 Ritorna, dunque, il tema del corpo: il corpo di Nijinski, fissato dall’obiettivo fotografico nel suo ultimo slancio, il corpo di Pollock nel ritmo esecutivo dell’Action Painting. rienza dai confini mobili, che individua i propri elementi costitutivi nel delicato equilibrio tra procedure tecniche e libertà espressiva, tra la cornice dello scenario e le dinamiche relazionali sollecitate dal processo creativo. Il corpo come luogo dell’opera, ormai oltre i confini spazio temporali della tela: negli anni cinquanta questo processo di estensione porterà il corpo al centro dell’azione pittorica e dell’invenzione. Nelle performances del Wiener Aktionismus e quindi, negli anni sessanta, con le vicende della Body Art, il corpo verrà proposto come opera, oltre la mediazione dell’immagine. Le intuizioni del pensiero psicoanalitico sono in questo settore disciplinare di grande interesse perché contribuiscono a definire i caratteri costitutivi del setting artistico. Arnulf Rainer, esponente di spicco dell’azionismo viennese, sarà uno di quegli autori che in termini programmatici salderà il tema dell’identità, del corpo e delle tecniche ad esperienze di pratica artistica durante l’uso di allucinogeni. Non solo: negli stessi anni si accosta alle opere dei malati mentali, nel solco di una lunga tradizione di rapporti tra arte e psichiatria che attraversa in modo particolare la storia del Novecento. Il corpo, dunque, come testo, come plus espressivo e comunicativo che connette l’esperienza artistica alla vita stessa dell’autore: è nel più, scrive Roland Barthes, che “abita la differenza”. Per certi versi la distinzione tra Korper e Leib, tra “corpo organico” e il corpo che vive l’esperienza del mondo, viene ricomposta nell’attività artistica. Paul Valery ricorda che il pittore “si dà con il suo corpo”, affermazione perentoria, che Maurice Merleau-Ponty riprende per tracciare un percorso esemplare sul valore della sensorialità nell’esperienza estetica, considerando come, prestando il proprio corpo al mondo, l’artista trasformi il mondo stesso in pittura. Arte/cura E’ questa, indubbiamente, una prospettiva importante per interventi di cura che privilegiano medium artistici: l’attenzione al corpo,infatti, un corpo spesso coartato e bersaglio di agiti distruttivi, permette di meglio osservare e comprendere tutti quegli indispensabili contatti con la materia e con la dimensione spaziale del setting artistico che non solo precedono, ma già sono, ( ricordiamo la lezione di Klee sul processo della messa in forma) processo creativo. Il dialogo con la materia, l’attenzione alle dinamiche relazionali ed ai bisogni che nascono dall’esperienza estetica, e dunque le stesse ipotesi interpretative , sono, per certi versi, gli organizzatori dell’esperienza rispetto ad inopportune, quanto “selvagge” e non richieste incursioni nell’immagine prodotta che troppo spesso vengono propagandate in nome della decodifica dei linguaggi. L’esperienza estetica non può essere ridotta entro griglie “psicologistiche”, qualunque sia la loro origine: la pittura, ha detto Robert Rauschemberg, “è un buco nero tra l’arte, la vita e l’avventura”; al suo interno, nelle sue alchimie s’accendono più eventi di quanti ne preveda la vita stessa. Il setting artistico, dunque, definisce un campo d’espePoliscritture/Samizdat Nello specifico il contributo di Donald Winnicott , così come quello di autori contemporanei che si rifanno alle sue note teorie ( Christopher Bollas, ad esempio), è di grande rilevanza culturale oltrechè terapeutica e offre tuttora stimoli all’impianto complessivo dell’arte come forma di cura: si pensi, tra gli altri, alla valorizzazione della dimensione ludica e ai fenomeni illusionali ad essa correlati; alla nozione di oggetto mediatore nelle terapie a mediazione artistica, che evoca l’oggetto transizionale. Già Winnicott considerava necessario allo stesso dispositivo terapeutico un dialogo con la materia: per lo psicoanalista britannico ogni forma di cura doveva, infatti, offrire l’opportunità “di una esperienza informe”, ricca di stimoli corporei e sensoriali. Egli riconosceva il valore trasformativo di queste esperienze, capaci di attivare le parti creative della personalità. La creatività, diversamente dall’essere apprezzata come un plus, è qui considerata una risorsa umana difficilmente eliminabile, “ anche nei casi più estremi”, come ricorda Winnicott in un celebre passo dei suoi scritti. Essa coincide con “l’essere vivi” e si alimenta dall’incontro con la realtà. La fiducia nelle qualità espressive si conferma così un paradigma necessario, quando individua nell’esperienza creativa e nell’arte stessa quegli elementi capaci di attivare processi generativi anche nelle forme psicotiche più gravi e nel più istituzionalizzato dei malati. L’arte, tuttavia, non è riducibile ad una semplice questione comunicativa: l’opera, per certi versi, ridefinisce i confini dell’agire psichiatrico e psicoterapeutico. Essa, qualunque sia il contesto da cui trae origine, anche nel più accogliente ed esposto alle migliori correnti empatiche, conserva sempre un suo statuto segreto e contraddittorio. Scriveva Winnicott nel 1963: “ Al centro di ogni persona c’è un elemento incomunicato, inviolabile, che è sacro e che va preservato”. Un segreto forse custodito in quell’ombra sul muro nell’ultimo salto di Vaslav Nijinski. Ombra che ci è compagna discreta, il “raggio invisibile” che Andrè Breton1 rammenta nell’ultima pagina di un celebre scritto, prima di chiudere con queste fulminanti parole: “ vivere e cessare di vivere sono soluzioni immaginarie. L’esistenza è altrove”. 1 Si tratta del testo “ Segreto dell’arte magica surrealista”, in: De Micheli M., Le avanguardie artistiche del Novecento, Milano, Feltrinelli, 1966. Pag. 33 L’Atelier di Cologno Carla Girardi e Laura Tonani Esiste uno spazio creativo a Cologno che da anni opera intorno ad un progetto di grande rilievo culturale e sociale. Stiamo parlando del LIBERO ATELIER DI ATTIVITÀ ESPRESSIVE DI COLOGNO MONZESE, in Villa Citterio, inaugurato il 2 ottobre 1999 e nato dalla sinergica collaborazione tra il Comune di Cologno Monzese e il C.P.S. di Cologno dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Vimercate. Frequentano con costanza il laboratorio circa una ventina di utenti, ma, dall’inizio dell’attività, ben una settantina di persone hanno potuto fruire di questa esperienza che ha contribuito alla loro crescita personale e ha favorito il bisogno di risocializzazione. Per ognuno di loro entrare a far parte di un gruppo sollecita aspettative e timori complessi sia verso l’altro che verso sé stessi. L’incontrarsi insieme in uno spazio sul territorio cittadino, vicino ai luoghi della cultura e lontano dai simbolismi tipici dell’istituzione medicoassistenziale, uno spazio che piano piano si è costruito come luogo simbolico della creatività, ha rappresentato l’aprirsi di una possibilità altra per dare espressione alla propria personalità. Una soggettività spesso frammentata e divisa, scissa tra mente e corpo, può trovare nell’espressione artistica gli strumenti per manifestarsi ed integrarsi oltre la parola ritrovando il piacere di raccontarsi e anche di mostrarsi, una possibilità protetta e facilitata dalla relazione di fiducia e collaborazione creativa tra arteterapeute e operatori sanitari che nasce dalla condivisione dell’idea della sofferenza. Il nostro atelier opera utilizzando i linguaggi propri dell’Arte, dalla pittura al disegno fino a quelli contemporanei, come la performance, l’installazione, la poesia visiva e le tecniche care ai surrealisti, come il frottage e il collage. Ogni persona esplora i materiali e i diversi linguaggi liberamente, scegliendo poi la dimensione espressiva più congeniale. Nella prospettiva di una possibilità di Cura del disagio psichico anche attraverso l’arte, si sono sviluppati, in tempi abbastanza recenti, una serie di interessanti esperienze di ricerca. I temi proposti agli utenti rappresentano tappe fondamentali per la conoscenza della loro personalità e spesso creano un “ponte” attraverso il quale il mondo interiore si fa strada e si mostra ai nostri occhi. Per esempio l’esperienza dell’autoritratto, argomento di grande complessità psicologica e ricco di illustri riferimenti nel mondo dell’arte, ci consente di capire il rapporto che ognuno di loro ha con la propria immagine corporea che spesso non coincide con ciò che vediamo con occhi ingenui. Nell’autoritratto le pulsioni autobiografiche racPoliscritture/Samizdat contano trame esistenziali che prendono corpo in segni, colori e parole, accompagnando lo sviluppo del lavoro in un intreccio di significati. L’arteterapeuta segue, con sguardo sottile, il processo creativo, aiutando la persona nei momenti d’incertezza, facilitando l’espressione grazie al suggerimento delle tecniche idonee, calibrate su ogni singola necessità. La tecnica infatti non è un fatto secondario; essa è linguaggio, possibilità di comunicare emozioni, è la voce dell’immaginazione. Come sottolinea Dino Formaggio “La tecnica non è legge statica, cieca disciplina, regola inesorabile; non è monologo. La tecnica è dialogo; come tecnica artistica, poi, è linguaggio più che lingua, cioè parola e comunicazione. È dialogo e linguaggio non banale, non decaduto alla ripetizione idolatria del discorso comune, ma riportato alla sua origine, all’atto che ritorna su se stesso per rilanciarsi più lontano, all’azione vivente nel corpo delle materie viventi; al gesto che domanda, che risponde, che qualitativamente crea dall’interno e a seconda dell’intima vita del tempo e delle cose nel tempo”.1 Affinché l’immagine interiore affiori in superficie e possa diventare forma, figura, occorre alimentare le pulsioni creative che spesso giacciono assopite in qualcuno di noi. Non è semplice spiegare come e perché si riesca ad “innescare” tale processo, ma tra i molteplici aspetti, approfonditi nel corso del lavoro in atelier, ci siamo resi conto che alcuni materiali e argomenti hanno una loro capacità di tipo maieutico, cioè facilitano l’atto creativo. I nostri frequentatori non hanno alcuna formazione artistica di tipo accademico, perciò il loro approccio all’arte è spontaneo e motivato dalla voglia di intraprendere un’esperienza gratificante, piacevole. La sensibilità all’ascolto degli operatori, l’accoglienza, l’atmosfera luminosa, serena che l’atelier offre crea il setting, il luogo ideale per la libera espressione di una creatività felice. Da queste premesse s’intuisce come possano nascere straordinari sviluppi e sinergie, in ambito riabilitativo e preventivo, e la collaborazione con gli arteterapeuti ha comportato l’integrazione di un diverso linguaggio, nonché di uno sguardo, nei progetti di cura delle équipe psichiatriche. L’arteterapia è territorio interdisciplinare dove Arte e Psiche dialogano mantenendo i propri ruoli, le proprie competenze, ma ritrovando la comune prospettiva di comprensione della creatività. La terapeutica artistica è il luogo dove corpo, espressione e idea tornano ad integrarsi superando, a volte solo occasionalmente, il blocco determinato dalla malattia. Certo è che il linguaggio espressivo artistico comunica aspetti che la parola a volte tace. Il problema, come abbiamo già illustrato, è quello di strutturare, attraverso strumenti efficaci e cioè le tecniche dell’arte, il messaggio interiore. Perciò i conduttori dell’atelier devono prima di tutto essere artisti, conoscere le proprietà maieutiche insite nella materia, devono guidare il soggetto dell’esperien1 Dino Formaggio, Fenomenologia della tecnica artistica, Pratiche Editrice, Parma-Lucca, 1978, pag .265. Pag. 34 za creativa con grande sensibilità e abile regia. I nostri utenti sono seguiti e affiancati nel processo creativo in modo delicato, sensibile, e ad ogni loro richiesta, domanda di aiuto, trovano sostegno. Molti di loro hanno acquisito nuove capacità, rafforzando la propria autostima, hanno ritrovato il piacere di creare “qualcosa di bello” per sé e per gli altri: una dimensione creativa che è fondamentale per il benessere dell’individuo. Tempo fa qualcuno di loro ci ha detto che “dipingere fa bene al cuore”; in questa semplice frase è racchiuso un significato molto profondo, e forse il senso della nostra esperienza. Il gioco creativo è espressione di libertà per l’individuo. Del resto arte e gioco sono intimamente legate: “…l’arte ha inventato il gioco dell’animo, il cui maggior pregio è quello di conservare all’animo la sua freschezza e la sua giovinezza. “L’arte - scrive Delacroix – ricolloca l’uomo sulla via dalla quale l’utilità biologica e sociale l’avevano allontanato, e risveglia una potente virtualità che la vita ha spento. […] L’arte è prima di tutto liberazione, disinteresse e rottura degli interessi pratici, per cui si arriva alla formazione di un’attività accessoria, di un’attività « di lusso », che si prodiga per mera potenzialità, per desiderio di esercizio: questo è quanto c’è di vero nel paragone tra arte e gioco, il quale ultimo è anch’esso libertà, sogno che cerca la sua realizzazione, azione fedele al sogno”.1 Questo è in sintesi il progetto silenzioso, ma dalla forza dirompente, che si svolge nell’atelier colognese. Annualmente il nostro lavoro “si mostra” durante rassegne aperte alla cittadinanza che hanno sempre avuto un buon riscontro di pubblico. Nell’estate 2005, l’atelier ha realizzato le scenografie per due opere liriche, I pagliacci e Il Barbiere di Siviglia, messe in scena dall’Associazione musicale città di Cologno, interagendo così con il tessuto cittadino e dando prova di grande capacità organizzativa interna. Un gruppo di lavoro felice si legge, infatti, dall’armonia che caratterizza l’opera costituita. Le fasi di realizzazione del lavoro hanno permesso agli utenti dell’atelier di provare l’esperienza pittorica sul grande formato, l’incontro totale, corporeo, con il colore e l’utilizzo di tecniche pittoriche e materiali inusuali rispetto alle tipologie classiche degli atelier arteterapeutici, il tutto affidato all’esperienza dei conduttori del gruppo. Anche nello scorso ottobre durante la rassegna L’isola a Colori, il nostro gruppo ha incontrato la cittadinanza nell’isola pedonale, proponendo una serie di attività artistiche, dalla pittura al teatro, dalla musica alla performance, coinvolgendo il pubblico a partecipare ad una festosa giornata creativa, realizzando insieme ai nostri utenti una grande opera corale. riflessione su alcune esperienze particolarmente significative. L’occasione ha consentito al gruppo di operare intorno al progetto del libro, dagli aspetti grafici alla scelta dei temi, discussi e approvati insieme. L’utilizzo del computer, di alcuni programmi che alcuni utenti in parte conoscevano, ha contribuito a creare nuovi interessi assolutamente imprevisti. La scrittura, l’immagine elaborata digitalmente e l’idea di realizzare un video in collaborazione con l’atelier di teatro terapia, che da circa quattro anni, si è affiancato all’atelier di attività espressive, ha ampliato le possibilità espressive degli utenti. L’aspetto straordinario è la capacità del gruppo di accogliere le novità con entusiasmo: sicuramente tutto ciò è motivato dalla sua forte coesione, ma anche dalla fiducia che i nostri ragazzi e ragazze hanno in noi. Fiducia che ci sprona continuamente a fare meglio, ad impegnarci con passione e dedizione in ciò che crediamo essere una funzione sociale dell’arte, argomento fuori moda, forse, ma che ancora affascina tanti giovani artisti. Il nostro atelier ha molti sostenitori, primi fra tutti gli studenti di Brera che chiedono costantemente di realizzare tesi, tirocini e progetti con noi. Spesso ci è stata richiesta la presenza in prestigiosi convegni, dove la nostra esperienza ha potuto dialogare con quella altrui e riflettere sui propri contenuti scientifici. Tutto ciò ci gratifica molto in quanto sappiamo, nel nostro piccolo, di alimentare una corrente molto più grande di noi, quella che ha ancora il coraggio di vedere nella creatività la via verso il benessere personale e sociale. Tra i nostri futuri progetti vi è anche quello di creare altri spazi per l’anima, citando James Hilmann, offrendo ad altri cittadini l’opportunità di accostarsi alla dimensione terapeutica dell’arte. Attualmente siamo impegnati nella realizzazione di una pubblicazione che sta rappresentando per tutti noi un momento di grande 1 Charles Baudouin, Psicoanalisi dell’arte, a cura di Arnaldo Ceccaroni, Guaraldi editore, Firenze, 1972, pp. 248-249. Poliscritture/Samizdat Autoritratto. Disegno infantile Pag. 35 Due poesie Ferruccio Brugnaro Menzogne insopportabili Mi sento in pezzi stasera. Mi sembra di avere sul petto enormi scavatrici. Alla televisione ora un volto torvo sta parlando con enfasi di morale di pudicizia di amori peccaminosi. Mi si rivolta lo stomaco. La terra non ne può più di queste iene. I giorni sono stanchi di questi corvi di sventura. Basta basta con le invenzioni che uccidono. Mi si parli di libertà di liberazione. Mi si parli di vita di amore di tanto amore l’amore che riproduce di continuo il mondo e il nostro cuore. Poliscritture/Samizdat Non vedono più nessuno, niente Sono sempre gli stessi. Tengono in pugno tutto sempre allo stesso modo. I loro discorsi sono pieni di democrazia, libertà e continuano ad opprimere, a calpestare con cinismo. Disseminano guerre atroci tra i popoli nascondendosi dietro grandi ideali. Mettono Dio in mezzo a ogni parola. Hanno raggiunto in questi giorni culmini di follia omicida che non so, non so chi potrà mai dimenticare. Non vedono più nessuno, niente. Il loro obiettivo è denaro tanto denaro; potere grande potere dentro montagne di chiacchiere sul bene della nazione, sulla civiltà sul popolo. Il loro obiettivo è denaro tanto denaro; potere grande potere dentro montagne di chiacchiere sul bene della nazione, sulla civiltà sul popolo. Non importa se poi a mille metri di profondità, nelle miniere più infernali una tenace umanità crolla colpita a morte continuamente, non importa se nelle fabbriche vite e vite umane vengono lentamente, inesorabilmente disfatte; non importa se uomini e uomini muoiono dissanguati in tutte le trincee della terra aggrappati a un sogno schernito fino all’ultimo. Pag. 36 Nuove Strategie di libertà Ritornando su Ceti medi quale futuro? di Sergio Bologna Ennio Abate Su www.poliscritture.it, nella rubrica dialogare, criticare, polemizzare, si possono leggere le pepate risposte di Sergio Bologna a 6 mie domande su Ceti medi, quale futuro?. Proprio perché il valore culturale e politico del libro è per me fuori discussione e credo di muovermi in una prospettiva di libertà democratica non dissimile dalla sua, vorrei, secondo il metodo della «critica dialogante», insistere a scavare le mie gallerie di dubbi e obiezioni dentro questo suo terreno così ricco di spunti e dati economici. Ecco allora per punti le mie osservazioni: 1. Conricerca Nella mia prima domanda a Bologna insistevo sul bisogno d’integrare il necessario ascolto (chi non ascolta come può dialogare o confrontarsi realmente?) «con uno sforzo anche teorico e immaginativo». Non parlavo di teoria tout court. Bologna mi ricorda che nelle esperienze da me richiamate (inchiesta operaia, storie di vita montaldiane, storia orale) è la «conricerca che produce teoria». Ed è certo più esatto dire che «Geiger e Lederer [da lui studiati e fatti conoscere in Italia1] più che dei teorici in senso stretto [sono stati] dei maestri d’analisi».2 Non credo però che in quelle loro analisi siano state del tutto irrilevanti «né la visione cattolica di Geiger né quella austro-marxista di Lederer» (come non lo è la teologia di S. Tommaso per la Commedia di Dante). Le teorie o le “visioni generali” possono essere esplicite o implicite, ma non mancano anche nel più piatto positivismo, altrimenti sarebbero tutte intercambiabili o forse irrilevanti. Non lo penso: credo invece che anche l’ascoltatore (S. Bologna) che ha raccolto nella blogosfera storie tanto significative non sia stato soltanto “orecchio”. E d’altronde i giovani che lì raccontano di sé non hanno la mente sgombra da «idee politiche bislacche» o ingenue, come egli annota ma mette tra parentesi. Secondo me, esse non sono tanto secondarie, ma in1 Cfr. S. Bologna in «L’ospite ingrato», Anno primo, Quodlibet, Macerata1998 2 Bologna, risposta 1. Poliscritture/Samizdat Pag. 37 SCHEDA DEL LIBRO [E.A.] Allora io con questo primo post porterò la bandiera delle milioni di Nuove Imprese che sono sorte in Italia. Detta così ci si immagina un quadretto assolutamente rassicurante ed esaltante: tanti piccoli imprenditori che aprono il loro laboratorio (capannoncino per gli emiliani, la fabbrichetta un po’ più a nord), gente che stanca di stare sotto padrone cerca l’emancipazione aprendo nuove ditte, lavorando, assumendo ... E invece ... le tante neonate Nuove Imprese, orgoglio dei programmi di governo sia di destra sia di sinistra, non sono altro che milioni di persone che per non farsi sfruttare dai contratti di collaborazione si sono aperti la fatidica Partita Iva. Siamo stati COSTRETTI a creare queste nuove imprese. Più che nuove attività, ci hanno costretto ad avventurarci nell’impresa di diventare liberi professionisti, ai “quali chiedere più del 40% di tasse (non è una fandonia chiedete ai vostri amici con P.Iva). lo sono uno di questi nuovi liberi professionisti, io sono una nuova impresa. Perché l’ho fatto? Perché con una partita iva ho qualche possibilità in più di far valere i miei diritti mentre con i contratti a progetto ho solo doveri. O almeno non c’è nessuno che vigili sull’uso quasi criminoso che i datori di lavoro fanno di questa formula contrattuale. Diversamente ricattati, senza soluzione alternativa: o te la cavi da solo con la tua Iva, o ti obblighiamo a lavorare alle nostre condizioni senza tredicesima, senza malattia pagata (e non si parla di un’influenza da 5 o 6 giorni, chiedete a chi ha dovuto affrontare una degenza ospedaliera o semplicemente a chi è rimasta incinta/o). (S. Bologna, Ceto medio, quale futuro?, pag. 18, DeriveApprodi, Roma 2007) Questa è la testimonianza di Rufus, un lavoratore “autonomo”. È una delle tante che circolano su Internet e Sergio Bologna la cita come esempio emblematico dell’esasperato e motivato disagio delle nuove figure di lavoro, alle quali, forse tra i primi in Italia, si è interessato da vicino e dall’interno, essendosi egli stesso, come racconta, trasformato dopo vent’anni di insegnamento universitario in «ricercatore libero professionista». Si tratta dei «lavoratori autonomi di seconda generazione» che egli distingue nettamente da quelli tradizionali1. Viaggiando nella cosiddetta blogosfera, ha trovato testimonianze di vario tipo: la trentenne romana che «si offre per una notte d’amore in cambio di un lavoro decente», chi spera nella tutela del magistrato e non più del sindacato, chi immagina o pratica espatri e fughe in altri paesi, chi denuncia le truffe dell’offerta di falsi «stage di formazione», chi organizza le prime rivendicazioni dei lavoratori autonomi e dei precari. Le storie si somigliano. Dicono che il lavoro precario – che per Bologna va considerato un modo «strutturale» di organizzazione della società del lavoro di oggi e non temporaneo e riassorbibile in quello a tempo indeterminato, come sostengono i sociologi accademici del lavoro (Accornero, Reyneri) con cui polemizza - sta stravolgendo la vita, gli affetti, le relazioni familiari o amicali di milioni di persone, senza che ci si decida a sanare la situazione con un serio intervento giuridico: «Così siamo arrivati al punto che il 47% circa degli occupati nell’economia di mercato oggi non gode delle tutele sociali previste dallo Statuto dei lavoratori del 1970, che si applica soltanto alle imprese con più di 15 dipendenti». (p. 183) A ingrassare sul lavoro dei precari e degli autonomi non sono solo imprese marginali o microimprese in difficoltà, ma i grandi gruppi e soprattutto la Pubblica Amministrazione. S’è creata così una divisione tra lavoratori con prerogative e tutele garantite dalla legge e lavoratori «flessibili» con zero diritti. L’impresa su tale divisione ci marcia, mentre il sindacato ha optato per una strategia di difesa corporativa dei soli lavoratori già tutelati, contribuendo così ad esasperare le differenze (che non sono quindi solo generazionali, come si dice). Questa grave situazione, «non più compatibile con un paese civile» come rileva Bologna, non è cascata dal cielo: sono stati gli accordi sindacali con la Confindustria del luglio 1993 che, centralizzando la contrattazione sindacale hanno impedito ai lavoratori a tempo indeterminato di negoziare alcunché sul proprio salario con le imprese e incentivato le forme “atipiche” del lavoro nelle «imprese individuali» o microimprese. Ne è conseguito un «mutamento genetico» nella mentalità stessa dei lavoratori: la stragrande maggioranza degli autori di queste testimonianze – una “folla solitaria” di giovani e meno giovani, prigionieri del «circolo vizioso della precarietà»e che tirano su per alcuni mesi, quando tutto fila liscio, dai 433 euro mensili ad un massimo di mille, è convinta che «bisogna cavarsela da soli». La fiducia nella possibilità e utilità di coalizzarsi con persone che vivono in condizioni di lavoro simili, che ha caratterizzato la storia dei lavoratori per tutto il Novecento, è stata estirpata. Per lo più domina la rassegnazione. Poche perciò sono per ora le spinte associative tra i lavoratori autonomi e precari. Bologna le paragona a quelle che nell’Ottocento portarono alla formazione delle prime associazioni artigiane o alle prime società operaie. Allora i “senza voce” si riunivano in qualche osteria per sfuggire alla polizia o alle spie del padrone. Oggi lo fanno nello spazio del web, gettando le basi di una «coalizione virtuale», che Bologna giudica «una delle forme moderne di democrazia, forse una delle ultime rimaste», visto che «i sindacati non rappresentano più questa forza lavoro, non hanno voluto rappresentarla» (p. 20). In altri paesi la situazione è più promettente: in Francia nella primavera del 2006 si sviluppò un movimento contro la legge sul «contratto di prima assunzione» (CPE) del governo Villepin; negli Usa sono nate le «Frelancers Unions» di New York, organizzate dall’avvocatessa Sara Horowitz, che ha costruito un sindacato dei lavoratori autonomi di seconda generazione con 40mila iscritti e la «United Professional» della sociologa Barbara Ehrenreich che si rivolge ai lavoratori autonomi e ai colletti bianchi. In Italia, a Milano, sulla spinta di questi modelli sono sorti «l’ascoltatoio» sulle forme del lavoro postfordista presso la Libreria delle donne, che si propone di «raccogliere testimonianze di persone che raccontano semplicemente le loro esperienze di lavoro» e, nel 2004, Acta (Associazione di consulenti nel terziario avanzato), di cui Bologna è uno degli animatori, mentre si va facendo strada l’«evento» Mayday, la manifestazione quasi carnevalesca, sullo stile dei gay pride o dei love party, dei «devoti di San Precario». Promossa dai centri sociali autogestiti, dal 2001 contrappone simbolicamente il significato originario del Primo Maggio (dignità e necessità del riscatto e della liberazione del lavoro) al rito stanco e forzato dei sindacati. In Italia uno dei massimi ostacoli all’organizzazione dei lavoratori autonomi e precari sta per Bologna nei partiti e nei sindacati, che definisce «professionisti della sconfitta». 1 Bologna li chiama così perché li considera differenti e per certi versi opposti a quelli di «prima generazione», rappresentati dai tradizionali professionisti tutelati dagli Ordini (architetti, medici, avvocati, ecc.) o dai lavoratori autonomi del commercio o dell’agricoltura (p.127) e, in un passo precisa: «questa gente, cui io appartengo, cui appartengono altri 6 milioni di persone, è gente che lavorano poggiando esclusivamente su mezzi propri, su proprie risorse umane, intellettuali, economiche, relazionali, è gente comune, un po’ middle class un po’ proletariato, un po’ Lumpen del postfordismo» (p. 220). Poliscritture/Samizdat Pag. 38 terferiscono nella presa di coscienza dei nuovi bisogni e della realtà al momento in cui, ad es., poniamo il problema cruciale di «cosa possiamo fare perché quella ragazza se lavora possa lavorare in maniera decente».1 Accolgo perciò solo in parte il consiglio di lasciar stare (per evitare sterili litigiosità, per non perdere di vista l’essenziale) «le diatribe sull’operaismo, il marxismo, il comunismo, il concetto di classe, il femminismo»2, che oggi capirebbero in pochissimi. Tuttavia, per cogliere l’importanza di fatti, dati e misure che Bologna espone con tanta chiarezza, bisogna pur districarsi nella selva delle nuove forme assunte oggi dall’individualismo e dalla legge del mors tua, vita mea (p. 15), per ritrovare (forse!) tracce di quella «solidarietà» che egli stesso vede ormai estirpata dall’animo e dalla mente dei lavoratori. Dire che una “teoria” o, almeno, una cornice, un lessico, un linguaggio comune, una qualche tradizione ripensata ci aiuterebbe, non mi pare volgere le spalle ai fatti, ai dati, alle misure (e alle scelte etiche che la loro conoscenza impone). Se ci fosse, darebbe sia agli studiosi “in ascolto” che ai narratori che “si sfogano” la possibilità di capirsi di più e magari di agire assieme. 2. Anarchismo e comunismo: sfondi dell’attuale conricerca Una “cornice” (non voglio chiamarla “teoria implicita”) a me pare sia presente anche in questo libro di Bologna. L’idea di una «coalizione» del «lavoro autonomo di seconda generazione» non nasce, infatti, come Venere dal mare o solo dalla conricerca svolta da Bologna nella blogosfera, ma attinge alla memoria, alle «buone rovine» (Fortini) della tradizione anarcosindacalista, cara a lui e in buona misura pure a me. Però – ecco la mia seconda (fraterna) obiezione – oggi a me pare necessaria ma insufficiente. Non perché, abbindolato da quelli che Bologna chiama «professionisti della sconfitta» e in particolare dalle «componenti che si richiamano alla tradizione comunista e quindi a un’immagine del lavoro di stampo fordista», coltiverei il «retaggio del gene stalinista» (p. 25). Ma per una considerazione storica, che mi fa vedere anarchismo e comunismo comunque intrecciati in tutta la storia del movimento operaio. Trascurare tali intrecci e non attingere – come credo si debba fare – sia alle «buone rovine» della tradizione anarcosindacalista che a quelle della tradizione comunista mi pare un gesto unilaterale, che tra l’altro cancellerebbe una lezione, quella di Danilo Montaldi, che Bologna stesso è impegnato a preservare.3 1 Bologna, risposta 6. 2 Bologna, risposta 6. 3 «Danilo […] ti dice solamente che la dimensione nuova con cui lui ha letto la storia del comunismo gli ha consentito di acquistare un’autonomia di giudizio e una possibilità di pratica non eterodiretta. Se t’interessa, puoi provarci anche tu. In pratica significa che puoi fare politica, puoi agire pensando di cambiare l’ordine delle cose anche senza un Partito alle spalle. […] Danilo non ti diceva di partire da una condizione di “ta- Poliscritture/Samizdat La storia del comunismo o dei comunismi o dei comunisti a cui penso non è quella devastata dal «gene stalinista». È la stessa per la quale Bologna mostra gran rispetto ed enorme interesse: «quella che le versioni ufficiali amavano mettere in ombra».4 Quei comunisti messi in ombra dal partito piacciono a lui, ma piacciono anche a me; e bisognerà pur spiegare perché rimanevano comunisti, malgrado le persecuzioni dei loro “compagni”. A parte poi il fatto che anch’io non sono mai stato iscritto al PCI e ho imparato qualcosa da Montaldi, il suo invito sarcastico a «comunisti o post-comunisti o ex comunisti o neocomunisti a rivitalizzarsi»5, sembra una scorciatoia un po’ contraddittoria con quel gran rispetto e interesse per la storia del comunismo. Come se essa dovesse interessare solo a chi ritiene «più importante il governo della società» e non – direi - altrettanto a chi giudica «la società più importante del quadro politico», che sono le due formule in cui Bologna riassume di fatto storia del comunismo e storia dell’anarchismo.6 Non mi pare, insomma, utile mettere ancora in primo piano qualcuno dei tanti momenti tragici e mortali della contrapposizione frontale di anarchici e comunisti7 e rimuovere, fossero pure pochissimi, i momenti, “aurorali” se si vuole, di avvicinamento e di solidarietà almeno tra i militanti di base (i soviet, i consigli), che rappresentarono “il meglio”, soffocato ma prezioso, di quelle due tradizioni. E dico questo pur riconoscendo che anche a me la «coalizione» di matrice anarcosindalista oggi sembra più realistica della forma «partito comunista», che ha agonizzato per tutto il Novecento e che, come Bologna dice a proposito dell’ultimo Luigi Pintor, ha forse chiuso il suo ciclo storico, imponendo a chi in essa aveva pensato un pezzo del Novecento a rifugiarsi poi in un «vocabolario millenarista» (p. 176). Eppure, malgrado tutto, ripensare (e ritentare) ancora la mai riuscita “quadratura del cerchio”, che sotterraneamente trapela dall’intera storia conflittuale delle due tradizioni, non mi pare un’ingenuità. Forse è giusto ripartire dall’idea di «coalizione» dei lavoratori, ma evitando i rischi di una “coalizione ristretta” e correndo quelli di una “coalizione larga” (ma dirò ora….). Un movimento capace di non farsi vampirizzare dai “politici”, di sostituirsi ad essi, espropriandoli della politica che hanno professionalizzata e resa continuamente fenomeno d’èlite (o di casta, come oggi si dice) non s’è bula rasa”, da un’assenza di memoria, da una verginità politica artificiosa. Al contrario, ti diceva che non facevi un passo avanti se non avevi fatto i conti con la storia del comunismo, anzi, dei comunismi, meglio, dei comunisti (Bologna, Sulla figura di Danilo Montaldi come crocevia di generazioni, in Ceto medio quale futuro?, p 229, Derive Approdi, Roma 2007). 4 Bologna, risposta 3. 5 Bologna, risposta 3. 6 Bologna, risposta 3. 7 Bologna, risposta 3: «Fossi stato in Spagna nel ’36 i comunisti mi avrebbero fucilato». Pag. 39 mai realizzato, ma non è mai impossibile. 3. Coalizione “stretta” e coalizione “larga” Torno al presente e al libro. Se l’attuale «rivoluzione capitalistica» ha accentuato, anche grazie alle burocrazie sindacali e partitiche, una divisione tra lavoratori “tradizionali” e lavoratori collocati nei punti dove avvengono le trasformazioni più dinamiche e sconvolgenti del lavoro (che da fordista va facendosi postfordista), non mi pare «meglio per tutti che ciascuno marci per conto suo».1 Come si passerebbe da un “esodo d’emergenza” (minoritario o persino individuale) a un esodo costruttivo e vasto? Alla politica sempre più corporativa dei sindacati negli ultimi decenni e allo svuotamento della democrazia si sta già rispondendo “marciando ciascuno per conto suo”. Come non vederne i limiti? Non ho nessun dubbio sull’obiettivo proposto da Bologna: i nuovi lavoratori autonomi devono ottenere quella tutela che governi e sindacati s’incaponiscono a riservare solo ai lavoratori a tempo indeterminato.2 Eppure la sua ipotesi di «coalizione» è rivolta innanzitutto e soprattutto (se non esclusivamente) ai «lavoratori autonomi di seconda generazione» ed ha – lo riconosce egli stesso - un «sapore fortemente elitario».3 Non so se per orgoglio o rassegnazione («È la caratteristica storica dell’operaismo»4) questo sapore rischia di diventare permanente. Il che potrebbe a mio parere spingere i lavoratori autonomi di seconda generazione a guardare dall’alto in basso non solo i lavoratori dipendenti, ma anche i precari più generici; e questi ultimi a “invidiare” i lavoratori dipendenti, perché “al sicuro”, o i lavoratori autonomi meglio professionalizzati, perché hanno più opportunità e vantaggi economici di loro. In questo elitarismo per me si annida un rischio: la nuova figura dei lavoratori autonomi di seconda generazione rischia di essere pensata dai suoi concreti rappresentanti secondo una logica purista. Avremmo una replica storica delle vecchie “aristocrazie operaie”. La nuova coalizione si ridurrebbe a una “coalizione dei più vicini”, che scarterebbe o vedrebbe come fumo negli occhi ogni possibile coalizione più ampia ed eterogenea, sicuramente oggi difficile da immaginare e da costruire, ma secondo me irrinunciabile. Ammetto il “realismo” della proposta di Bologna. Sì, i lavoratori autonomi, se coalizzati, potrebbero «creare non pochi fastidi all’assetto dominante», azzeccare «il punto sensibile del potere, il suo nervo scoperto e lì [premere] fino a fargli male».5 Ma ciò basta? 1 Bologna, risposta 2. 2 «Uno ha il diritto, se vuole, di vivere di lavori alla giornata, ma ha anche il diritto di pretendetere di non essere trattato da cittadino di serie B per questa scelta» (p.163); «la richiesta politica è un’altra: chi lavora per scelta o per necessità in maniera intermittente non deve essere discriminato sul piano delle tutele previdenziali e assistenziali. I diritti sociali, la tutela della salute, della maternità, della vecchiaia debbono essere garantiti a tutti e non soltanto alle categorie di lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato» (p. 191) 3 Bologna, risposta 6. 4 Bologna, risposta 6. 5 Bologna, risposta 6. Poliscritture/Samizdat Il fatto che oggi nessun altro, tantomeno l’attuale sinistra, sappia offrire una (indispensabile o no?) «”rappresentanza generale” degli interessi di classe» non abolisce il problema, trascurato dai sindacati o gestito dai “politici di professione” nelle forme mistificate della «postdemocrazia» (Marramao6). Non vedo perciò perché la ripresa della conricerca non debba implicare fin dall’inizio gli esponenti dei vari settori dell’attuale forza lavoro (lavoratori della conoscenza, lavoratori “tradizionali”, informe “galassia” degli immigrati), tutti coinvolti in varie misure e forme dal mutamento postfordista. 4. Gli esclusi dalla «coalizione»: gli immigrati Per dirla tutta lealmente, mi chiedo: conricerca e coalizione devono essere limitate ai soli lavoratori autonomi di seconda generazione per mancanza di forze capaci di «ascolto» o per sfiducia degli attuali “ascoltatori” verso lavoratori privi di «quelle risorse di capitale umano possedute da coloro che occupano posizioni di relativa forza sul mercato»?7 Propenderei per la seconda ipotesi quando m’imbatto nel giudizio un po’ censorio che Bologna dà di quelli che oggi si occupano “caritatevolmente” degli immigrati.8 È vero che questo volontariato è quasi sempre cattolico e bloccato nella logica paternalistica del filantropismo (e sul n. 3 di «Poliscritture» lo avevo rilevato io pure, parlando dell’ipotesi di «villaggio solidale» a Cologno Monzese promossa da don Colmegna). Che i marxisti (del resto azzittitisi o da tempo trasformatisi per lo più in para-cattolici) siano latitanti verso questo settore di forza lavoro (in parte “debole”, in parte dinamicissimo) o non siano in grado di costruire pratiche e narrazioni alternative al «gran parlare di “accoglienza”, di “civiltà multietnica” e bla bla filantropico»9 (o svelare l’illusione dell’acconto di «eterno» che le religioni offrono attingendo alla rendita del sacro) non significa che la «coalizione» non vada cercata anche con le fasce degli immigrati. E bisogna, comunque, riconoscere al volontariato cattolico almeno il merito di sapersi accostare a condizioni di vita pesanti e di misurarsi a suo modo con i “diversi” che ormai sono in mezzo a noi europei ex-colonizzatori. Esso, specie nelle sue forme di “militanza di base”, non è perciò tutto riducibile alla “colonizzazione” che denunciava Fanon. E, di sicuro, l’oscuramento dei problemi del lavoro non è tutto ad esso imputabile. Se – come ricorda un po’ polemicamente Bologna - i bruciati alla Thyssen Krupp non sono immigrati, quella sorte atroce toccò nel 2000 al rumeno Cazacu cosparso di benzina e dato alle fiamme da un piccolo imprenditore di Oggiona S. Stefano perché chiedeva un’assunzione regolare. Sarebbe meglio, insomma, parlare di «una situazione disastrosa del lavoro» non soprattutto 6«Nella postdemocrazia non vige uno stato d’eccezione reale, ma uno stato d’eccezione «formattato», creato ad arte per rendere indiscernibili i profili dei veri conflitti, delle effettive linee antagonistiche» (il manifesto, 18 marzo 2008). 7 Bologna, da me citato nella domanda 6. 8 Bologna, risposta 2. 9 Bologna, risposta 2. Pag. 40 o soltanto per i «cittadini italiani»,1 ma del lavoro in generale. Così non si rischia di scivolare nella difesa dell’ ”italianità” del lavoro. Vedo, insomma, nel discorso di Bologna, così concentrato sulla middle class o che si spinge al massimo verso la lower middle class, una trascuratezza verso le condizioni di vita di fette consistenti di “neoproletariato” o “moltitudine”.2 5. La “città invisibile” nascosta dalla Milano «città del capitale» Anche nell’immagine che Bologna delinea di Milano, la «città che dipende dal mercato dei segni e delle immagini, città dell’industria dei media e dell’intrattenimento, della moda con le sue infinite articolazioni, del design, della pubblicità, dei servizi alle imprese, dell’informatica» (p. 26) e che attira dal suo hinterland o vi disloca forza lavoro, a me pare manchi qualcosa. Non voglio accentuare più del dovuto una contrapposizione tra Milano e il suo hinterland (tra l’altro la LUMHI3 ha nel suo nome stesso il termine hinterland). Eppure, oltre agli interlocutori di riferimento di Bologna - quei lavoratori che operano nell’industria dei media, dell’informatica e dei settori affini -,4 ce ne sono tanti altri: quelli che agiscono nelle strutture statali (scuole, etc.), gli stessi «devoti di San Precario», che secondo lui mostrano una nostalgia tutta fordista del «posto fisso» (p. 93), i ricercatori universitari, che, avendo chiesto l’abrogazione della legge 30, hanno mirato, sempre secondo Bologna, a «un’illusoria abolizione della precarietà piuttosto che [puntare] sui sistemi di tutela per conviverci» (p. 28). A questa massa di figure più “tradizionali” andrebbero aggiunte quelle marginali o alla deriva in quartieri degradati, che io, vivendo a Cologno Monzese, noto di più. In queste sezioni della società il dinamismo del postfordismo sembra spento o inafferrabile o sperimentato solo nei suoi aspetti di deriva. 5 Vorrei che proprio da parte 1 Bologna, risposta 2. 2 Un altro esempio: l’attenzione prestata al movimento francese degli intermittents du spectacle a scapito della rivolta dei giovani delle banlieues (p. 22). E ancora: perché la giusta esigenza di «guardare anche dentro casa nostra» occupandosi del «disagio delle classi medie» non dovrebbe essere integrata con i dati che vengono dalle discussioni sulla «povertà dei paesi dell’Africa, dell’America Latina, dell’Asia, dei paesi dell’ex Unione Sovietica», anche se «molto si parla ma ben poco di concreto si fa» per eliminare questi gravi problemi? (pag. 156) 3 La LUHMI è la Libera Università di Milano e del suo Hinterland intitolata «Franco Fortini e fondata nel 1995 da S. Bologna. 4 «quelli che rappresentano la forza lavoro del mercato dei segni e dei simboli, cioè dell’industria dei media, dell’informatica e dei settori affini… forza lavoro dotata di skill professionali, spesso senza titoli universitari, uscita da scuole tecnicospecialistiche o da corsi di formazione professionale, capace di tenersi bene a galla nel mercato districandosi tra occasioni saltuarie, periodi di lavoro all’estero, gelosa della propria autonomia e pertanto senza il miraggio del posto fisso» (27). 5 Leggo su «il manifesto» del 23 marzo 2008 la recensione di Agostino Petrillo a Milano ai tempi delle moltitudini di Aldo Bonomi. Mi pare interessante (nella recensione, non nel libro di Bonomi che non ho letto) il richiamo un po’ boccioniano al «rumore di fondo che sale dalla “città invisibile”, ossia dalle cerchie di coloro che sono spremuti ed espulsi dal Poliscritture/Samizdat di chi si trova nei punti alti del postfordismo si riuscisse a considerare tutto questo insieme di forza lavoro, sicuramente percorso da contraddizioni interne non solo oscure ma quasi ingovernabili. È utopia? Non credo. Si “sentirebbe” e si comprenderebbe meglio la condizione di chi è costretto a dibattersi tra prospettive (lavoro autonomo, posto fisso) spesso entrambe illusorie e non veramente alternative non così disgiunta da quella, quasi invisibile, dei tanti “alla deriva”. 6. Il lavoro precario come “scelta” E torno, infine, su un punto per me decisivo, che avevo affrontato nella domanda 5 e che non ha trovato, secondo me, una risposta da parte di Bologna. Egli ha scritto: «Mai dimenticare che il postfordismo è stato il prodotto di una doppia spinta: da una parte la riorganizzazione capitalistica e dall’altra il rifiuto del lavoro normato, così come si manifestò, per esempio, nel movimento del ’77. La precarizzazione l’abbiamo voluta anche noi! E pertanto deve essere cancellato ogni accento vittimista»» (p. 31). Io dubitavo che il movimento del ’77 avesse puntato proprio alla «precarizzazione» e esprimevo perplessità verso le critiche al cosiddetto “vittimismo” e scetticismo verso la qualità delle attuali «strategie di libertà» costruite «anche attraverso il lavoro intermittente o indipendente».6 Ora torno a chiedermi: ma perché chi muove delle critiche (anche “vecchie” ma fondate su fatti e esperienze) a queste sia pur relativamente nuove «strategie di libertà» farebbe del “vittimismo”? Giusto sfuggire ai vecchi ideologismi, ma perché sostituirli con nuovi ideologismi? Chiedersi (caso per caso, se si potesse) quanto il lavoro “autonomo” di cui andiamo parlando sia davvero «indipendente» o quanto potrà magari diventarlo (e a me pare importante stabilire anche per quanti potrà diventarlo) è domanda seria e non dovrebbe infastidire i sostenitori di un lavoro autonomo, quando la loro visione è fondata su esperienze reali e non su ideologismi. Non credo perciò di dire una cosa campata in aria se affermo che «strategie di libertà» limitate, quali sono per me quelle stesse qui delineate per il «lavoro autonomo di seconda generazione», sono state possibili, e forse lo sono ancora, con altre modalità, anche nel lavoro dipendente. Del resto, anche se Bologna sostiene con forza le «opportunità di liberazione e di autonomia che la condizione del precario offre», nelle pieghe del suo complesso e documentatissimo discorso si trovano molte affermazioni che dimostrano come non gli sfuggano né l’incertezza né la drammaticità né la pesantezza del mutamento in corso. Accenna, infatti, alle spinte e controspinte che portano i giovani ora verso un lavoro autonomo per necessità (pag. 61), perché esiste una reale impossibilità di accedere al mercato del lavoro dimercato del lavoro, da chi paga i costi umani e sociali della trasformazione[di Milano, e cioè dei] “naufraghi del fordismo” di vario genere:: migranti impiegati nei nuovi lavori servili, giovani disoccupati o precarizzati, manodopera ipersfruttata dal ritorno del caporalato e dal dilagare del lavoro nero, soprattutto in settori come l’edilizia». 6 Intervista, domanda 5. Pag. 41 pendente, ora a tentare l’avventura a volte piena di illusioni del lavoro indipendente.1 Né tace, col richiamo a Sennet2, gli effetti deleteri sulla psiche almeno di un certo lavoro precario. Come non gli sfugge una situazione ancora peggiore: «la condizione di quelli che lavorano per niente, gratis».3 Ecco perché non mi pare inutile o reazionario chiedersi: le offre davvero e per quanti queste occasioni di “libertà” il lavoro precarizzato? Se esse stentano ad essere afferrate, forse vuol dire anche che spesso non ci sono o ci sono solo per pochi più fortunati. E allora, ci vorrebbe una maggiore prudenza: messianica può risultare non solo l’attesa del posto fisso, ma anche quella delle opportunità di lavoro “autonomo”, proprio perché «i confini dell’insicurezza sociale vanno ben al di là del rapporto tra «posto fisso» e lavoro precario» (p. 94). Certo, «il lavoro occasionale, il lavoro flessibile è stato anche scelto, cercato, dalla forza lavoro così come la fuga dalle campagne è stato un movimento spontaneo durante certi periodi dell’industrialismo dell’Ottocento e del Novecento, non è stato soltanto un esodo forzato» (p. 191), ma non sarebbe più realistico parlare di lavoro dipendente e flessibile come di due varianti all’interno di una costante che è il lavoro comunque sottoposto al controllo del capitale? E tenere a mente l’obiettivo della liberazione del lavoro nel suo complesso, anche se questa ipotesi allo stato attuale appare scandalosa o addirittura pazzesca? certi vantaggi interstiziali si trovano nel lavoro autonomo, in forme diverse si trovano – ripeto - pure nel lavoro dipendente. I liberti ci sono sempre stati, ma senza che venisse abolita la schiavitù. Il problema che nessuno mi toglie dalla testa è quale tipo di libertà si può/si deve cercare (nel lavoro? o anche oltre il lavoro?). È, insomma, sulle «strategie di libertà» e su come misurarle che dovremmo intenderci. Bologna ammette che il lavoratore autonomo è «una figura di compromesso», che «non rovescerà il sistema». Di più non si può fare: chi ne è capace si faccia sotto» (p. 36) . Sarebbe, dunque, infantile intestardirsi su un desiderio di libertà “assoluta”? Qui si dovrebbe aprire un lungo discorso “teorico”, ma né lo spazio disponibile né il rispetto che sento di dover portare al libro di Bologna permettono in questa occasione di cominciarlo. Insomma un breve richiamo non alla sinistra d’oggi, ma all’idea gramsciana di «rivoluzione passiva» gioverebbe ad approfondire la questione. O questa sarebbe ideologia? Sì, «una visione puramente pessimistica e catastrofista del postfordismo non ci aiuta nemmeno a capire perché certe persone continuano a difendere certi stili di vita», ma perché «il primo punto da mettere in discussione è proprio quello del «posto fisso», dell’occupazione a vita, dell’accettazione di un sistema gerarchico, di un’organizzazione del tempo e dello spazio secondo criteri definiti da una volontà superiore, al tempo stesso dispotica e protettiva» (p. 166)? Come se il lavoro autonomo fosse – qualcuno forse lo vive così con qualche buona ragione - un’alternativa piena che già sfugge del tutto al sistema gerarchico del capitale. Non sono convinto, cioè, che la libertà (quella vera) sia più tangibile o a portata di mano nel lavoro autonomo e meno nel lavoro dipendente, proprio perché entrambi - qui sarò “veterissimo” (ma anche Bologna, quando si propone di demistificare il falso potere liberatorio del lavoratore autonomo e del personal computer,4 parrebbe esserlo…) - sono lavori sottomessi al capitale; e se Poliscritture/Samizdat L’urlo. Disegno infantile 1 «Il soggetto abbandona la sfera simbolica del lavoro ed entra in quella dell’impresa, da lavoratore pensa di essere diventato imprenditore, di essere passato al proletariato alla borghesia. In realtà, molto spesso, non è né l’uno né l’altro» (p. 181). 2 R. Sennet, L’uomo flessibile, Feltrinelli, Milano 1999. 3 «regalando a un signor X, sconosciuto, il loro tempo e le loro competenze. Li chiamano stage […] Da noi succede di frequente presso gli studi delle professioni tradizionali. Grossi studi di avvocati o architetti dove i giovani lavorano gratis anche per anni (p. 180). 4 Bologna, risposta 4. Pag. 42 2 Latitudini ovunque e con ogni mezzo (Esterno con alberi) aria fuoco acqua terra i quattro elementi lontani - un passero picchietta emettendo i suoi suoni il centro di piccoli fiori - mandorli o peschi piantati - infruttuosi - sul marciapiede di via Settembrini - Roma vicino piazza Mazzini - i petali cadono sul tavolino del bar è un 20 di febbraio del 2008 - Ippolita ed io beviamo qualcosa - mi parla d’una vacanza lontana - lei ed un uomo si avventurano in macchina - all’inizio una pista visibile - poi all’improvviso la sabbia confonde - li perde non sanno più dov’è l’est - dove è l’ovest - sorpresa degli elementi natura - paura - a fatica un villaggio - gli adulti stupiti li ospitano - qualche bambino li attornia - il giorno dopo - con carri di buoi e con funi - portano macchina e i due alla città più vicina (che era lontana) e con grazia seria gli dicono “jamais le désert” Ippolita ringrazia - lascia delle scarpe - una giacca - qui passano macchine - motorini ai tavolini poche persone nel pomeriggio - il tronco del mandorlo - o pesco - è scuro nerissimo - si salvano dalla pece dell’aria le radici - quelle ancora respirano - ancora avviene la fioritura - annuso i petali - li prendo - caduti Poliscritture/Latitudini Anna Cascella Luciani dal tavolino - pendici di colli - di prati altrove - li conservo dentro una carta poi il cellulare di Ippolita squilla - il campo dei fili invisibili ha avuto il suo corso - una donna anziana - italiana - discreta - pudìca ha chiesto qualcosa - offriva piccoli porta-fortuna o portachiavi - l’economia tira avanti per la sua strada senz’occhi - il prezzo della benzina oggi ancora salito - noi poveri troveremo domani ancora rialzate frutta verdura ma oggi è il mio compleanno di festa - dieci euro ai tavolini del bar - gentili le ragazze al servizio - i lindi capelli scuri o più chiari in ordinati chignon - aprono un varco tra le sedie quando andiamo via - compio 67 anni - [da Incisioni, inedito] Pag. 43 Rodoviaria brasiliana Alessandro Teruzzi Quelli che seguono sono alcuni estratti del libro I diari della rodoviaria, nel quale vi sono il racconto, le riflessioni, le emozioni che io e Gigi (il mio compagno di viaggio) abbiamo vissuto in 45 giorni on the road (ma anche on the river) in Brasile. Il termine ‘rodoviaria’ è una parola portoghese che indica la stazione degli autobus. Agli occhi più attenti non potrà certo sfuggire una certa somiglianza tra questo titolo e quello di un altro diario: I diari della motocicletta, film del regista Walter Salles, che portò al cinema i diari che Ernesto Guevara raccolse in Latinoamericana. L’idea è quella di sottolineare come questo nostro viaggio rappresenti un momento di conoscenza e di maturazione, sia come persone che come cittadini del mondo. Buona lettura […] MANAUS, capitale dello stato dell’Amazonas, nel cuore della foresta, alla confluenza tra Rio Negro e Rio delle Amazzoni Dopo solo 40 ore di viaggio siamo arrivati da padre Riccardo1 a Manaus. Elias2 ci ha accompagnato dall’aeroporto a Novo Israel, il bairro dove abitano Riccardo, Pedro3 e gli altri. Il quartiere è costruito su una discarica che è stata occupata dai dannati di Manaus per reclamare il loro diritto ad avere una casa. Pare che sia stata una suora indigena (Elena) a guidarli nella lotta. Spero vivamente di conoscerla. Venendo nel Bairro abbiamo subito visto la miseria e la fatiscenza delle “case”. Dopo poco siamo entrati nella casa dei missionari, un’abitazione che non ha nulla da invidiare alle nostre. Non possiamo fare a meno di pensare se sia giusto che esista un’oasi di relativo benessere in un mare di miseria. E se fosse sbagliato, non saremmo forse noi ancora più colpevoli? Padre Enzo4 ci ha accolti e abbiamo scambiatoquattro chiacchiere. Parlando di Lula5, la sua posizione è sembrata piuttosto moderata: non era molto convinto che nel PT6 ci fossero stati episodi di corruzione e giustificava le scelte (non abbastanza di sinistra) di 1 Padre Riccardo è il capo della comunità presente a Novo Israel, una delle favelas di Manaus. Il centro vive grazie ai soldi che arrivano dall’associazione “Groppone Missionario”, un gruppo attivo tra Verona e Venezia. Padre Riccardo ne è un po’ l’“amministratore delegato”. 2 Elias è uno degli educatori del gruppo. Non molto alto, pelle olivastra, in carne ma non grasso, capelli corti, crespi e neri. Faccia simpatica, sorridente. È sui 20 anni. 3 Pedro è un altro educatore: fisico asciutto, abbastanza sornione, anche lui sui 20 anni. Studia filosofia in università. 4 L’altro prete che dà una mano a Riccardo. È in Brasile solo da 6 mesi. 5 L’attuale presidente del Brasile. 6 Partido dos Trabalhadores . È il partito di Lula. Poliscritture/Latitudini Lula con il fatto che il presidente del Brasile non ha la maggioranza nei due rami del parlamento. È un punto di vista ragionevole? Oppure quando uno REALMENTE vuol fare le cose, le fa, e tutto il resto sono scuse? Il viaggio è solo all’inizio, ma le domande sono già tante: sarà un viaggio di interrogativi più che di risposte. D’altra parte, siamo qui per cercare, non per trovare. L’accoglienza di Pedro nei nostri confronti è cambiata radicalmente non appena ha saputo che siamo amici di Adriana: da apatico/quasi annoiato a entusiasta/ loquace. Che Adriana gli abbia rubato il cuore? […]Durante la visita della favela di Novo Israel E adesso (dopo la teoria) arriva il piatto forte (la pratica), la botta, il pugno nello stomaco che ti stende senza appello. Signore e signori, benvenuti al giro delle meraviglie nella favela di Novo Israel: baracche, vita inumana, madri trentenni logorate da 10 figli, una vita di ingiustizie e violenze e padri/mariti assenti, ubriachi e violenti7. La situazione più forte l’ho vissuta dalla penultima famiglia del “giro”. Un buco voncio e pieno di resti di cibo e di animali, un 3x3 sul lato di una collinetta a strapiombo sul pattume. Tra un divano, un mobile, un materasso disteso a terra e una amaca c’erano otto bambini, una madre e un marito ubriaco che dormiva su un materasso in terra. Quando siamo entrati Eleite (la mia “autista”) mi ha presentato come un missionario. Nessuno mi rivolgeva la parola e i bambini (soprattutto la ragazzina, quella più grande, forse 8 anni) mi guardavano con degli occhioni neri che se avessero potuto parlare avrebbero riempito un libro. Erano bambini bellissimi: vedere tanta bellezza in una simile condizione grida vendetta. Chissà cosa avrebbero voluto chiedere dietro quegli occhioni: come ti chiami, da dove vieni, cos’è l’Italia, anche tu vivi in una casa come la nostra... La cosa più incredibile è stato quando ho chiesto di fare una foto. La madre ha acconsentito. Quando ho tirato fuori la macchina, si è affrettata a chiedere che NON fotografassi la casa, ma le persone. Anche in questa situazione, questa madre ha un amor proprio, un senso della dignità. Questa donna si vergogna del posto dove vive. I volontari del centro, con il loro lavoro educativo mirano proprio a questo: far capire alle madri che valgono, che hanno diritti da reclamare. Che è colpa di altri, non loro, se sopravvivono in una favela. Quando vivi una cosa del genere i sentimenti che provi sono RABBIA e poi frustrazione, perché non vedi un modo per combattere la situazione. Allora ti siedi a pensare per trovare una soluzione. Solo la consapevolezza e la lotta politica possono essere i detonatori per la liberazione dei dannati della terra. Ma la vera domanda è: noi occidentali siamo colpevoli? Ma, soprattutto, IO sono colpevole? Colpevole di vivere da ricco in un mondo di poveri? Colpevole di essere parte di un meccanismo che ruba ai poveri per dare ai ricchi? A questa domanda NON ho ancora una risposta, una risposta dalla quale dipendono le scelte di tutta una vita. 7 Io e Gigi ci dividiamo e due ragazzen del Movimento ci accompagnano su è giù per il bairro a far visita a diverse famiglie legati a progetti di adozione a distanza. Pag. 44 Un’altra riflessione che deve trovare posto in questo diario è senz’altro il contrasto tra alcuni volontari (Marzia, su tutti) e i preti/volontari italiani. I primi sembrano usciti da un film di Ken Loach1: duri, incazzati, combattivi, con idee chiare e un lavoro sul campo, nella merda. I secondi, al massimo, sono usciti da un film dei Vanzina con Abatantuono2: parlano in dialetto veneto, fanno discorsi da “volemose bene, diamo una mano a sti poveracci”, sembra che sono qui a fare villeggiatura, che non capiscono la realtà sociale che li circonda. Effettivamente, padre Riccardo è un uomo d’affari, un direttore di impresa, un manager. Qua, con lo stipendio da prete, fa una bella vita: bella casa, cene al ristorante, poco lavoro. Non condivide nulla con gli abitanti della favela. Sicuramente è meglio di niente, ma è abbastanza? Di sera abbiamo parlato con Pedro: ci ha detto che lavora (in nero) per padre Riccardo per pagarsi gli studi. È giusto? È sbagliato? Padre Riccardo è uno stronzo? Una cosa è certa: Pedro non se la passa bene. Dopo siamo andati, con Elias, in un quartiere di lusso e molto turistico di Manaus (Ponte Negra) a cenare. È stato incredibile come nell’arco di pochissimo tempo siamo passati dalla miseria più disperata al lusso. Il fatto suscita parecchie riflessioni. […] Lasciamo Manaus e cominciamo la navigazione sul Rio delle Amazzoni in direzione Belem A questo punto del rio, le coste si popolano di baracche, palafitte di legno tra il fiume e la foresta. Quando il barco passa, decine di canoe con a bordo madri e bambini si avvicinano alla nave nella speranza che qualcuno getti soldi e vestiti. Altri, soprattutto ragazzi, “abbordano” il barco con canoe piene di cocco, banane, gamberi e li vendono ai passeggeri. Questa gente probabilmente sta peggio di quelli nelle favelas: niente luce, niente acqua, niente fogne, niente scuole, collegamenti con la città. Però, ogni tanto, si vedeva qualche casa col tetto in cotto, le pareti dipinte: qualcuno che aveva “fatto fortuna”. Qualche casa aveva anche il campo da calcio sul retro. La cosa che più colpiva eravamo noi, i turisti, che senza capire la tragedia e la miseria di questa gente, ci divertivamo a vederli e a fotografarli, come se fossero una attrazione per i visitatori. A pensarci, è come se uno svizzero venisse a Milano e si mettesse a fotografare i lavavetri ai semafori. […] Cambio di scenario: Teresina, capitale del Piauì. Siamo ospitati nella sede del Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) Jesus ci spiega il rapporto tra MST e Lula. Se lo devono tenere, perché di meglio in giro non c’è niente (o forse è il meno peggio) ma sono delusi e non si fanno problemi a dargli addosso a parole e a fatti (la marcia di 300 km tra aprile e maggio). Il nodo fondamentale, lo stesso per tutta la Latino- America è sempre il medesimo: la riforma agraria. Da cento anni a questa parte questo è stato l’oggetto principale di tutte le lotte, rivoluzioni, movimenti in questa parte del mondo (e non solo). 1 Per Ken Loach un film a scelta tra “Terra e Libertà”, “Paul, Mick e gli Altri”, “Piovono Pietre” o “Brad and Roses”. 2 Per Abatantuono non può mancare “Il barbiere di Rio”. Poliscritture/Latitudini L’analisi dei Sem Terra è molto semplice: il latifondo è la causa principale della grande povertà che c’è in Brasile. Se le terre fossero ridistribuite non solo i contadini avrebbero di che vivere, ma anche il problema delle città si risolverebbe, perché la gente potrebbe avere il suo pezzo di terra in campagna. Non ci sarebbe più, quindi, il fenomeno di urbanizzazione di massa che c’è ora e che alimenta le favela e quindi la povertà e la violenza. Inoltre, il problema del Brasile non è che è una nazione povera, anzi. La questione è che la ricchezza è tutta nelle mani di pochi. “Chi ha la terra non la lavora e chi la lavora non ha la terra” diceva il campesinho indio nel film di Salvatores “Puerto Escondido”. È sempre questo il nocciolo della questione. Il governo Lula in questa direzione ha fatto pochissimo: in due anni ha dato la terra a sessantamila famiglie. Con questo ritmo, per provvedere ai 4,5 milioni di famiglie senza terra gli ci vorranno cent’anni! Meno severo il giudizio di Jesus su Lula per quanto riguarda gli scandali economici del governo. Secondo lei c’è una macchinazione, un complotto per screditare il governo. Infatti, tutti rubano e comprano i voti, ma si parla solo del PT. Mah... […] Cambio di scenario: Recife, capitale del Pernambuco. Il mattino dopo un’indimenticabile notte. Al mattino, dopo una bella colazione con anche un ovetto strapazzato per reintegrare, Liliany mi porta a fare un giro per il paese. A un certo punto lasciamo la strada principale e saliamo su una collinetta, a ridosso della foresta, dove abita un suo amico. Credo che sia uno spacciatore: mi fa vedere dove coltiva la maria, mi dice che è stato in viaggio per sei mesi in Spagna con un narcotrafficante. Per concludere in un degno crescendo, mi dice che se vivesse in Italia si affilierebbe subito alla mafia, perché con la mafia girano un sacco di soldi. Mi chiede anche perché io non sia ancora entrato in cosa nostra. Mi rifugio in un ”não gosto”.3 Poi mi racconta della sua collezioni di insetti, e per finire in bellezza mi porta una scatoletta, la apre, ed esce una tarantola grigia e pelosa. Appena la vedo faccio un salto di un paio di metri e mi allontano. Il tipo se la tiene tranquillamente in mano. Mi spiega che ha così tanto veleno che con un solo morso può zazzare4 cinque uomini, ma che lui non ha nulla da temere perché la tarantola è stata raccolta quando era ancora piccola nella foresta e quindi conosce il suo odore e non gli farà niente. Mi dice anche che il ragno è in grado di saltare per oltre 5 metri: a questo punto faccio un altro salto e mi allontano di altri due metri. C’è da dire che il ragazzo è simpatico e gentile: prima di andare via mi regala un braccialetto, di quelli che si trovano sulla spiaggia, fatti di corda, ninnoli e conchiglie. 3 “Non mi piace”. 4 Espressione colloquiale che significa, a seconda del contesto, segare, uccidere, bocciare. Pag. 45 […] Lungomare di Copacabana, Rio de Janeiro Sulla via del ritorno ci fermiamo a bere qualcosa in un bar. È pieno zeppo di ragazze. Mentre bevo incrocio lo sguardo con una di loro. È molto carina e mi sorride. Ricambio. Accade un’altra volta. Allora io prendo il mio succo d’arancia e vado verso di lei. Come ti chiami? Lohane. Lavori o... Lavoro. E sorride. Quanti anni hai? Diciannove. E a me quanti me ne dai? Ventiquattro. Brava! Si vede che hai ventiquattro anni, ma con la barba sembri più vecchio. Non ti piace la mia barba? Penso che staresti meglio senza. Dopo un po’ che parliamo noto che non sta bevendo niente. Vuoi qualcosa da bere? Mi vuoi offrire qualcosa? Eccome, no!? Mentre siamo al bancone le chiedo che lavoro fa. Lavoro qui, dice ridendo. Ah, lavora qui, ma non fa la cameriera... Ah, ho capito. Ti piace il tuo lavoro? Più o meno. A un certo punto mi chiede che vogliamo fare. Le dico che mi piace molto, ma non mi piace molto pagare. Le dico che forse è meglio se vado, se lei deve lavorare. Sorride. Sì, penso di sì. Ci salutiamo. Mi dice che spera che la prossima volta che ci vedremo sarà in un posto diverso: un ipermercato, una spiaggia, un ristorante. Lo spero anch’io. E spero che non dovrà più fare questo lavoro. Esco dal locale e aspetto Gigi che sta parlando con una collega di Lohane. Gigi, dimostrandosi ancora una volta molto più sveglio di me, ha capito subito il mestiere della sua interlocutrice. Mentre aspetto passa una tipa che vende rose. Ne compro tre bianche e le regalo a Lohane. Avevo voglia di fare così. Spero che le faccia piacere. Non tanto per le rose. Quanto per il fatto di sapere di non essere (per tutti) un oggetto di piacere, ma una persona, una ragazza. Torno in albergo con una grande tristezza. Non so perché. Forse perché vedere una ragazza così carina, così dolce (a me è sembrata così, non so se fosse parte del suo lavoro) a 19 anni, che fa la puttana, e che forse, addirittura, non le dispiace più di tanto, mi fa male. In questo viaggio abbiamo visto moltissima gente che se la passa molto (molto molto) peggio, però... non so, fa male. Il giorno dopo… Alla mattina si va al Cristo del Corcovado. Ovviamente, essendo dei duri, ce la facciamo a piedi. Ci vogliono due ore e mezza, camminando sui binari del trenino che porta in cima i turisti meno volenterosi. Il percorso è quasi tutto nella foresta che avvolge la collina. Oltre metà strada, incontriamo “un uomo della foresta”, una sorta di eremita della montagna, intento a far fare una visita naturalistica a un gruppo di turisti. L’incontro avviene nei pressi di una fonte: gli chiediamo se l’acqua è potabile (abbiamo una sete porca). Ci risponde che è molto più pulita di molte acque in bottiglia. Ci sono dei batteri, ma sono “di montagna” (giuro, ha detto così!), fanno bene. A lui. Speriamo sia così anche per noi. Alla fine, vediamo che l’attrazione simbolo di Rio è molto sopravvalutata. In cima è pieno di turisti merdoni che smaniano solo dalla voglia di farsi fotografare sotto il Cristo. Non sanno un cazzo del Brasile. Per loro il Brasile è una merdosa collinetta con una altrettanto merdosa statua. Alle 3 del pomeriggio siamo di nuovo a Copacabana per l’ultimo bagno. L’acqua è fredda e sporca. Una delusione. Ci dicono tutti che il periodo migliore per Rio è tra gennaio e marzo. Nota per il prossimo viaggio. Andiamo a fare l'ultimo pasto (cena) del Brasile. Poliscritture/Latitudini Troviamo un posticino inculato che ci fa mangiare a piacere per 10 Reais in due. Torniamo in spiaggia per l'ultimo giro. Sta cominciando a fare buio, ma la spiaggia è ancora affollata e illuminata dai fari. Ci si avvicinano due tipi (come era già successo un sacco di volte) e ci offrono della maria, ci chiedono dell'Italia e bla bla bla. Ci chiedono se possiamo dar loro un dollaro per mangiare. Intanto, senza che ci facessimo molto caso, i tipi diventano sei. La situazione butta male: infatti, quando facciamo per alzarci e andarcene ci saltano addosso e uno di loro tira fuori un coltello e mi minaccia. A Gigi saltano addosso in due. Ci portano via i soldi (euro e reais), la mia macchina fotografica e la chiavetta MP3 di Gigi. Ci lasciano documenti e carte di credito. Alla fine, ho solo un taglietto sul dito e il bottone di una tasca dei pantaloni rotto. Poteva andare molto peggio. Per un paio di ore non mi va molto di parlare. Man mano che realizzo cosa è successo una rabbia feroce e furiosa mi monta dentro. Quando arriviamo alla rodoviaria sono in piena fase esplosiva. Tiro una media di una bestemmia ogni 15 secondi. Credo di essere abbastanza intrattabile. Dei soldi non me ne frega niente. Della macchina un po' me ne frega, ma non molto. Ma sono incazzato nero per le foto che c'erano. Una cinquantina. Da Fortaleza in poi. I catadores, Marina, le favelas, Liliany. Tutto perduto. Come mi fa incazzare. Porco D.... Saliamo sull'autobus per San Paolo. Sono le 23. Il giorno del ritorno. Arriviamo a S. Paolo molto presto, verso le 5. Cominciamo a camminare verso la sede dei Sem Terra. Ci fermiamo in un bar-pasticceria e facciamo colazione. Arriviamo alla sede verso le sette. L'obiettivo è comprare un po' (un bel po') di roba da rivendere a casa per finanziare il Laboratorio. La sede apre alle otto. Ci aspettavamo di trovare camion e camion di magliette e bandiere. Restiamo molto delusi. Avevamo preventivato di spendere 2000 R. con tutta la buona volontà che ci mettiamo arriviamo solo a 350 R. Intanto il tempo passa, ma l'incazzatuara per la rapina rimane. Se mi facessero votare adesso per il referendum, voterei NO e poi andrei a comprare un bazooka. Però il tempo dirada anche le emozioni e cominciano a farsi strada anche delle riflessioni più razionali. Così credo di capire cos'è che mi fa tanto arrabbiare. La rabbia che provo è una forma di risentimento, perché mi sono sentito indifeso, impotente, alla mercè dei capricci di altre persone. Credo che sia per questo che provo tanto rancore. Oltre che, naturalmente, per le foto che sono andate perdute. Porca troia! Ci andiamo a imbarcare all'aeroporto e succede il delirio. Come da accordi, chiediamo alla tipa di fare il doppio check-in, in modo da ritirare i bagagli a Milano e non dover andare fino a Parigi. La tipa ci dice che non è possibile, dobbiamo per forza arrivare fino alla capitale francese. GELO. Cominciamo a dirle che non è possibile, che avevamo già chiesto e che ci era stato assicurato che non ci sarebbe stato alcun problema. Allora la tipa ci gira all'ufficio Alitalia. Lì, un'altra tipa, dopo essersi consultata col suo capo, ci dice che non è possibile. Al che, riparte la pantomima (“ma non è possibile, ci avevate garantito....”) Alla fine, come nei migliori film di Totò, le chiediamo: “ci faccia parlare col direttore”. E, anche con quest'ultimo, ripetiamo la sceneggiata. Alla fine ce la facciamo e ci fanno il doppio check in. Grazie a dio/buddha/visnù/ allah/manitù/! Pag. 46 3 Esodi passare i confini E ti dolzura che te vorressi Marcella Corsi E ti dolzura che te vorressi rinverdire e dolzemente avere loco e permanere e rindolzire noi pure e liberare de nostre durisie più dure ti dolzura sì minuscola e ‘nnascosa ‘ndoleita de tanto nasconderse in tra durisie nostre grandi, ti picolisia impertinente de frescura intima mente pura, de nullo indolente – donde te prende forsa e duratura come te ‘ntrighi ne la tera nostra dura e nuda de le piante che sole te nudre donde te prende forsa che te dure noi nonostante e tutta intiera la durisia nostra contra la vida vera E tu dolcezza che vorresti rinverdire e dolcemente avere luogo e permanere ed indolcire noi pure e liberarci delle durezze più dure tu dolcezza così minuscola e nascosta indolenzita da tanto nascondersi tra le durezze nostre grandi, tu piccolezza impertinente di frescura intimamente pura, di nulla indolente – da dove prendi la tua forza duratura come t’impasti con la nostra terra dura e nuda delle piante che sole ti nutrono dove prendi forza che ti duri noi nonostante e tutta intera la durezza nostra contro la vita vera Poliscritture/Esodi <-- Per una critica dialogante (…) È stata scritta in una strana lingua, insieme intima, passionale e arcaica, alla quale il contenuto, almeno in fase di creazione, soggettivamente la costringeva. Questo linguaggio mi è sembrato poi non del tutto proponibile in lettura e ne ho dato una ‘traduzione in italiano’ più leggibile oralmente ma nella quale qualcosa almeno mi sembra si perda in pregnanza di significati (per esempio quel “te ‘ntrighi” tradotto con t’impasti, ma non ho trovato di meglio). Quesiti: la prima versione è proponibile? O, nonostante la sua soggettiva necessità, risulta un po’ ridicola o comunque troppo strana o non comprensibile? Sulla pagina potrebbe essere accostata alla sua ‘traduzione’. Ho pensato di proporla per il prossimo numero di Poliscritture: è uno dei maggiori motivi di disagio, che sento in questa fase della mia vita e in questo periodo storico, che non ci sia spazio per l’innocenza, l’intenerimento... Ma... i dubbi sul testo li ho già espressi. Forse la pagina di una rivista potrebbe aiutare, consentendo di contemperare la stranezza della versione in lingua d’emozione con la maggiore comprensibilità di quella in italiano, che a sua volta riceverebbe maggior senso dall’accostamento all’altra. Mi farebbe piacere sapere che ne pensi... Un abbraccio Marcella (…) non so scegliere tra le due versioni, quella in “lingua” è bella, comprensibile, da leggere in una “lettura” ma..... la prima è sincera, forse dura, ma sentita molto di più, la seconda è “acculturata”, la prima è vera (…). Secondo me non dovresti avere remore a presentarla come la hai scritta, se ti va aggiungi la seconda per accontentare coloro che non accettano il fatto che il “dialetto” possa essere altrettanto poetico come la lingua italica. (…) “te intrighi” non ha traduzione e proprio per questo è più bello. (…) Resto dell’ idea che vadano scritte e comunicate entrambe le versioni (…) ciao Marco … è un bel problema. (…) Non è stata scritta in un dialetto ma nella lingua consueta del sentire che stavolta, a causa di una particolare intensità, è andato a Pag. 47 cercarsi le parole negli angoli più riposti della lingua italiana prendendo in prestito parti di dialetti esistenti e creando ex-novo parole con suono e senso più convincenti di quelle codificate. Stando così le cose non avrebbe bisogno nemmeno di una traduzione in italiano. Tanto si capisce, o comunque, quel po’ d’incomprensibile che rimane non è superiore a quello che qualunque testo poetico contiene. Potresti invece aggiungere una nota in cui racconti dei tuoi dubbi circa il da fare a proposito di una così insolita (e per te stessa sorprendente) forma espressiva. Insomma, voglio dire che le traduzioni si fanno da una lingua all’altra e non all’interno della stessa lingua, altrimenti è parafrasi, spiegazione, esegesi, quello che vuoi ma non poesia. Un abbraccio Fabio (…) La mia opinione è che la prima versione nella “strana lingua” debba avere il risalto della poesia e la seconda deve adattarsi al ruolo di traduzione di servizio (per cui non mi dannerei per ‘te ‘ntrighi’ tradotto con ‘t’impasti’). Il dialetto ( a me pare cogliere qualcosa di veneto, ma non sono certo) ha una sua forza, che va rispettata e non messa in competizione con l’italiano. Sul tuo cruccio per l’assenza di spazio a innocenza e intenerimento vorrei seguirti. Non ci riesco, se non nel senso che mi sento di proteggerla in chi la vive o la esprime (anche in poesia). Ma siccome penso che comunque questi sentimenti, per sussistere in un mondo così caotico e tragico, abbiano bisogno di un bel po’ di rimozione, mi sento abbastanza imbarazzato a dirlo (e a dirtelo). Sembra sempre che voglia rimproverare o non sia in grado di capire … Un caro saluto Ennio (…) È con questi versi e con l’immagine di un pruno (che selvatica e tenera pianta!) che vorrei augurare a tutta la redazione (vicina e lontana) una buona Pasqua. Sì, Ennio, lo so. In questo momento sugli schermi scorrono le immagini dei Tibetani oppressi e uccisi. Io non rimuovo niente. Vorrei augurare anche a loro “dolzura” e forse hanno bisogno di liberarsi “de nostre durisie più dure” anche gli oppressori cinesi... Nel ‘68 - i lottarmatisti son venuti dopo! - c’era anche chi sosteneva di “dirlo coi fiori”. Ad ogni buon conto, buona Pasqua e un carissimo abbraccio a tutti Donato Poliscritture/Esodi L’eroe del giorno Fabio Ciriachi Quelle che seguono sono le ultime pagine di un racconto, dal titolo L’eroe del giorno, inserito nella raccolta omonima in corso di pubblicazione presso l’editore Gaffi. A fare da filo conduttore, le vicende di Ivan e di Giggi-stecco che, sul finire degli anni Cinquanta, vivono le loro adolescenze in quel punto di attrito tra fantasia e realtà (ma anche tra natura e storia) che è l’estrema periferia romana del quartiere africano, dove un’urbanizzazione in continuo sviluppo divora, assieme a fette sempre più consistenti di campagna, anche gli ultimi residui di mito che su di essa ancora aleggiano. […] Ora che Lillo non c’era più, Ivan, il Moretto e Giggistecco si sentivano più grandi, più seri, più cattivi di prima. La morte fa di questi scherzi; strappa dal calendario un sacco di foglietti insieme, leva di colpo la voglia di ridere, fa provare piacere per il dolore degli altri. Dopo Lillo era toccato alla sorellina del Moretto. Difterite. Per giorni e giorni, finché il destino non si decise a lanciare i dadi, il palazzone trattenne il fiato per la vita di Rossella. La speranza era consentita, e siccome non costava nulla (o costava solo dolore, che era come nulla) scorreva a fiumi. Tutti speravano e molti pregavano. La primavera aveva appena imbiancato di margherite i pochi campi rimasti al di là di viale Somalia quando i lamenti della signora Santulli echeggiarono per le scale ponendo fine alle novene delle vecchie. Andarono tutti alla veglia funebre. Davanti all’appartamento del terzo piano c’era un via vai di gente che bisbigliava e scuoteva la testa. Rossella giaceva sul lettone dei genitori con l’abito bianco della prima comunione e le mani giunte poggiate sul petto. Tra le dita, la coroncina del rosario. Ornata di veli trasparenti, sembrava una sposa in miniatura. Aveva anche i calzini bianchi e le scarpe dello stesso colore con le suole quasi pulite. Il Moretto non sapeva bene che atteggiamento assumere. Non aveva mai provato una spiccata simpatia per la sorellina ma a forza di vedere gente commossa gli venne spontaneo spargersi un po’ di dolore sulla faccia. Al funerale la bara bianca fu preceduta da una doppia fila di bambine col vestito della comunione e un giglio bianco in mano. Don Angelo, col suo discorso a braccia larghe e testa inclinata, ricordò che un’innocente era andata in cielo e che i gigli bianchi ne rappresentavano la purezza. Ripensando al racconto del Moretto, Ivan immaginò don Angelo che leccava la lingua dell’amico attraverso la grata del confessionale. Che schifo, esclamò tra sé e sé rallegrandosi che non fosse toccata a lui quella penitenza. Si sentivano grandi e cattivi dopo la morte di Lillo, e camminavano con la testa fra le spalle e la schiena curva come James Dean nel film Il gigante. Erano terribili, o almeno così volevano apparire alla banda di Jimmy l’americano che dettava legge nel quartiere scorrazzando qua e là su moto di grossa cilindrata, in giacconi di Pag. 48 pelle nera e cinte con le borchie di metallo. Si diceva che Jimmy l’americano fosse capace di entrare in una tabaccheria con la pistola in pugno, di farsi consegnare una stecca di sigarette, poi di pagarla e andarsene. Sembrava che fosse anche pieno di donne. Ivan e gli altri non lo avevano mai visto, e l’unico vero contatto con la sua banda avvenne nel cinema Trieste dove i tre amici andavano di tanto in tanto per guadagnarsi qualche liretta facile. Sulla scia di Giggi-stecco, anche Ivan e il Moretto avevano cominciato a fumare e avevano bisogno di soldi per il vizio. I soldi guadagnati al cinema, Ivan non li metteva nel salvadanaio - come gli spiccioli che gli dava sua madre se lavava i piatti, lustrava gli ottoni col Sidol, faceva le commissioni da Aronne - ma li spendeva subito per non farseli trovare in tasca. Come avrebbe potuto giustificarli altrimenti? Non era certo il caso di dire a sua madre che andava coi froci. Le sarebbe venuto un colpo; e poi chissà che idea si sarebbe fatta di lui. Mentre invece non c’era niente di strano in quel lavoro, e oltre tutto poteva vedere un sacco di film. L’orario migliore per incontrare i froci al cinema Trieste era il primo spettacolo, con la sala quasi vuota e pochi ficcanaso in giro. Ivan prendeva posto per conto suo, come anche il Moretto e Giggi-stecco, si accendeva una sigaretta e si metteva a guardare il film. Dopo un po’ un signore gli si sedeva accanto e cominciava a fare ginocchietto finché Ivan gli diceva “Quanto mi dai?”. Stabilito il compenso - cinquecento lire, un doblone, come chiamava la bella moneta d’argento da poco in circolazione - se il frocio era d’accordo pagava in anticipo; poi, accertatosi che non ci fossero presenze indiscrete, gli apriva la bottega dei calzoni e cominciava a smaneggiare. Ivan doveva sempre chiedere aiuto alla fantasia per dargli soddisfazione. Ne approfittava per concedersi avventure mozzafiato con la madre di Giggi-stecco, la vedova, che da un po’ gli piaceva più delle signore che abitavano nel palazzone. Immaginava di andare a casa sua con un pretesto. Pomeriggio torrido d’estate, la palazzina nuova dormiva, silenzio ovunque. Lei era da sola in casa, accaldata, febbrile, vestaglia nera e trasparente mezz’aperta. Non verrà nessuno gli diceva muovendo le labbra rosse e umide, e intanto si sfilava la vestaglia e restava in reggiseno e mutande e calze con le giarrettiere. Ivan sentiva il sangue battergli nelle tempie, e da lì precipitarsi verso l’inguine dove i peli erano cresciuti abbondanti, e gonfiargli il pisello e farglielo diventare duro e lungo come quello di Franco Picchioni. Le guardava la pancia, le cosce, lo spacco tra i seni, il gonfiore della fica il cui pelo straripava dalle mutande. L’abbracciava furioso e la leccava, mordeva, toccava come avesse avuto dieci bocche e cento mani. Lei si sdraiava tirandolo su di sé, gli frugava nella bottega dei calzoni e a quel punto tutto si confondeva e una delizia indescrivibile gli faceva piegare la testa all’indietro. A cose fatte il frocio tirava fuori dalla tasca il fazzoletto, gli puliva con cura il pisello e se ne andava. Tutto lì. Quando all’uscita gli amici si ritrovavano, a Ivan sembrava che Giggi-stecco avesse sempre una faccia beata e un’espressione furba da presa in giro che non gli piaceva affatto. Cominciò a sospettare che mentre immaginava di farsela con la bella madre dell’amico, quel paraculo ne approfittasse per intendersela con la sua. Non poté mai saperlo con certezza. Le fantasie sessuali erano l’unico argomento di cui non facevano Poliscritture/Esodi parola, il territorio inviolabile della vera libertà. Niente di più facile, quindi, vista la propensione di Ivan a fare certe visite alla madre di Giggi-stecco, che questi gli rendesse pari pari la cortesia. Il giorno in cui si scontrarono con gli uomini di Jimmy l’americano Franco Picchioni aveva portato una ragazza che gli piaceva al cinema Trieste, dove Ivan, il Moretto e Giggi-stecco erano appena arrivati. Il metodo John Vigna gli aveva sviluppato muscoli degni della sua eccezionale forza fisica, una forza che metteva sempre al servizio di qualche nobile causa. L’avevano soprannominato il Nembo Kid del quartiere perché dove c’era un sopruso arrivava lui e a parole o a cazzotti faceva giustizia. Aveva la faccia angelica, e questo sorprendeva sempre gli avversari incautamente tentati da soluzioni manesche. Franco Picchioni non sapeva che la sua ragazza piaceva anche a uno della banda di Jimmy l’americano, un energumeno sfregiato che quel giorno, con due guardaspalle, l’aveva seguita fin nel cinema. Furono subito scintille. Nonostante l’energumeno si fosse infilato il pugno di ferro, Franco Picchioni fu più veloce. Lo colpì al viso con due ganci brevi e secchi e mentre a gambe larghe lo guardava cadere, con una mossa di judo si liberò di uno dei due guardaspalle che aveva provato a colpirlo da dietro. L’altro, vista la malaparata, rinunciò a combattere e aiutò gli amici sanguinanti a filarsela dal cinema. Il Trieste era una specie di tritatutto capace di accogliere e digerire qualunque avvenimento. Così, malgrado la rissa, la proiezione andò avanti come niente fosse, i froci continuarono ad aggirarsi in cerca di pischelli, e il poliziotto sullo schermo non smise di far fischiare le ruote della sua auto lanciata a cento all’ora dietro quella dei banditi. Euforici per la scazzottata vittoriosa, Ivan, Giggi-stecco e il Moretto, anziché sedersi uno qua uno là in attesa dei froci, decisero di vedere il film e basta. Così, dopo essersi accesa una sigaretta, si misero tutti e tre vicini, alle spalle di Franco Picchioni e della sua ragazza che adesso quasi gli sveniva tra le braccia per l’ammirazione e per le tante carezze che lui le dava. Nel buio fumoso della sala Ivan staccò gli occhi dall’eroe dello schermo e li posò su quello in carne e ossa che gli sedeva davanti. Voglio diventare forte come lui, pensò con la solenne serietà del giuramento, e mentre carezzava con lo sguardo la schiena e la testa di Franco Picchioni, capì che proprio quella sagoma massiccia era il ritratto fedele della forza che cercava, come se il segreto delle cose abitasse semplicemente nella loro forma. Pag. 49 Gli animali, la morte, il tempo, la memoria, la letteratura, il suicidio Giorgio Mannacio I. Negli ultimi due anni di lunghe marce e di aspri combattimenti, Lola Ribar era stato visto quasi sempre in groppa al suo cavallo. L’animale aveva sempre mostrato strani segni di angoscia se veniva separato, anche per un solo istante, dal suo padrone. Dopo la morta di Lola, diventò incontrollabile e nessuno poté più avvicinarglisi. Il senso della perdita subita portò il cavallo alla pazzia; alcuni giorni dopo, con selvaggia determinazione, si uccise gettandosi in un burrone . ( F.W. Deakin : La montagna più alta – Einaudi 1972, pag. 262-263 ) Questo episodio non è stato inventato da un poeta; non fa parte di un racconto fantastico e non è neppure l’interpretazione di un fatto proveniente da persona intenta a speculazioni religiose, esoteriche, filosofiche o scientifiche. Si tratta di un’annotazione, incidentale all’interno di un resoconto storico – politico, di un militare inglese impegnato in una rischiosissima azione di guerra ( stabilire i contatti tra i rappresentanti del Governo inglese di stanza al Cairo e le formazioni partigiane jugoslave comandate da Tito ). È proprio l’uso improprio ed ingenuo dei termini che ne garantisce l’autenticità. II. Si coglie subito, in questa vicenda, un rapporto tra assenza temporanea/segni di angoscia e assenza definitiva/ salto nel burrone ma questo rilievo mette in luce, immediatamente, alcune difficoltà concettuali. Secondo quali criteri si può parlare di assenza temporanea e di assenza definitiva di una persona? Quest’ultimo evento, nel mondo degli uomini, si relaziona alla morte e vede in essa il suo paradigma più significativo. Anche se nessuno ha esperienza della propria morte, è sufficiente per noi, per la definizione di essa, considerare la morte degli altri ed arrivare, attraverso la relativa constatazione, alla conclusione che essa costituisce un territorio inesplorabile dal quale nessuno è mai tornato ( Amleto : Atto III, scena I ). In questo senso la memoria della morte diventa elemento necessario perché la si descriva – concettualmente – Poliscritture/Esodi come fine dell’individuo, di ogni individuo e si diventi tragicamente consapevoli che ciascuno di noi è coinvolto in tale comune, irreversibile destino di scomparsa. Ma si propone, a questo punto, un’altra difficoltà. Non basta, a questa singolare esperienza la memoria del singolo. Una persona morta non ha ricordo della propria morte ed esso è solo l’ombra lasciata ad altri che le sopravvivono. I viventi che sognano i defunti non fanno che ritrovarsi di fronte ad una memoria collettiva. Ma il sogno appartiene alla vita. Se immaginiamo la contemporanea morte di tutti e quindi la fine del sogno collettivo siamo portati inevitabilmente a concludere che laddove non c’è memoria non c’è morte. Se, dopo un cataclisma definitivo, nascesse per miracolo un secondo Adamo costui potrebbe sapere della morte solo a condizione di sperimentare un’altra morte o di scoprire “ i segni “ delle morti passate, quale che sia la natura di questi segni. La morte, dunque, nella sua essenza concettuale non è un luogo, né un tempo, ma solo letteratura. III. F.W.Deakin avrebbe forse potuto fantasticare di un cavallo (quello di Lola Ribar ) che – unico tra gli animali – conosce (ha memoria) della morte. Ma questa meravigliosa invenzione avrebbe dovuto accompagnarsi, in una coerenza che non l’avrebbe smentita ma semmai confermata, all’immagine di un cimitero dove i cavalli recitano i loro riti funebri ovvero di una biblioteca dove sono raccolte quelle che furono le vite , più o meno illustri, dei cavalli defunti. Ma non è tanto una astratta convinzione a legarci alla certezza che gli animali non hanno conoscenza della morte quanto l’osservazione concreta (che allo stesso tempo li avvicina e li allontana da noi ) che essi non sono capaci di creare e trasmettere segni su questo evento che resta così confinato in un eterno presente simile a quello che circoscriverebbe il secondo Adamo privo di compagni mortali e di una storia trasmessagli da altri. Dando per scontato ( ma all’esperienza del militare inglese si aggiungono aneddoti troppo numerosi e concordanti per essere falsi) che l’animale avverta l’assenza provvisoria attraverso il sintomo dell’angoscia, possiamo dedurre che come alla assenza temporanea segue un’angoscia passeggera, così all’assenza definitiva segue una angoscia duratura. Ma questi rilievi hanno a che fare, ancora una volta, con la memoria e la creazione e trasmissione di segni. Se la temporaneità si correla alla speranza del ritorno, la definitività è legata alla certezza del non ritorno ma tanto la speranza che le certezza presuppongono una memoria dei termini entro i quali esse vivono e , dunque , ancora una volta creazione e trasmissione di segni. Con questo non si vuole affermare, non si può affermare, che gli animali non abbiano, per così dire, il “ senso del tempo “. Tra lo stato di fame e lo stato di sazietà che segue la golosa ingestione di croccantini di pesce, il mio gatto avverte una differenza. La situazione complessiva - che Pag. 50 Rispetto a questo quadro la vicenda del cavallo di Lola Ribar presente tratti comuni e tratti differenziali che non possiamo descrivere se non con il nostro vocabolario. Certo parliamo di prima e dopo, di causa ed effetto; di stati di quiete e di angoscia che si susseguono e – adattando quella vicenda alla nostra struttura – diciamo che l’angoscia è successiva alla scomparsa del padrone ed effetto di essa. Oggettivamente, se è possibile esprimersi così, anche il cavallo subisce una modificazione. A quella sazietà o sicurezza che si fondava sulla presenza del padrone segue la fame o inquietudine correlata alla di lui scomparsa. Per il cavallo il prima e il poi sono scanditi dalla presenza e dall’assenza di una persona e poco importa rilevare che nell’esempio del gatto il punto di frattura sia rappresentato da un pasto. L’aspetto singolare del caso del cavallo, piuttosto, consiste nel rilievo che la modificazione non riguarda quelli che, nel nostro linguaggio, potremmo chiamare “ bisogni primari o elementari “ ma da bisogni che definiamo “ elevati e nobili “ cadendo, così e ancora una volta nel tranello delle convenzioni. La distinzione, che a questo punto si può chiamare impropria, potrebbe essere recuperata e ridefinita riflettendo sulla diversità degli effetti. Non sono in grado, per mia ignoranza, di dire quali siano le conseguenze immediate del mancato soddisfacimento del bisogno primario di cibo, ma l’esito definitivo è, biologicamente, scontato. La debolezza estrema dell’organismo comporterà l’impossibilità di ogni movimento e dunque la fine, ma se si riflette solo un poco ci si accorge che tutto sembra implicare una questione di tempo. Senza cedere ad alcuna suggestione fantastica ed attenendoci ai fatti, possiamo attestarci, prudentemente, sulla considerazione che ogni modificazione dello stato presente induca ad uno stato di allarme, quale che sia la “ qualità “ delle causa di modificazione. Man mano che ci si addentra nell’analisi di questa modificazione il quadro complessivo diventa più oscuro e complicato. È evidente che la nozione di definitività presuppone una esperienza specifica delle causa modificatrici e che – in particolare – la definitività dell’assenza come morte postula una ragionamento sulla morte che, a quanto ne sappiamo, non appartiene al regno animale. Si può perciò dare per scontato che il termine definitivo usato da Deakin sia trasposto dal nostro ad altro mondo. È però certo che il cavallo ha vissuto in maniera differente l’assenza di Lola Ribar “quanto al tempo“ e che quando l’assenza ha superato un certo limite essa è diventata, in termini biologici, intollerabile. In termini umani potremmo dire che il cavallo non ha saputo elaborare il lutto dell’assenza. In termini fattuali che si è comportato in modo diverso da quello secondo il quale si sarebbe Poliscritture/Esodi comportato prima. Ancora una volta l’uomo Deakin scrive che il “ cavallo si è ucciso “ conferendo ad esso una intenzione di sparire definitivamente dall’orizzonte del mondo. Al di fuori di una meravigliosa fantasia ci è difficile accettare tale conclusione. Attenendoci all’oggettività possiamo limitarci a dire che le modificazioni del quadro di riferimento hanno determinato uno stato di disorientamento radicale, togliendo al cavallo ogni senso del pericolo e portandolo al compimento di un movimento che il suo istinto avrebbe evitato. La definitività si è consumata nella reiterazione del fenomeno dell’assenza, in un accumulo di presenti intollerabili. Non sono in grado di analizzare i meccanismi biologici e neurologici che precedono la “ feroce determinazione “ di buttarsi nel vuoto e mi limito ribadire che la modificazione del quadro di riferimento produce un disorientamento assoluto ( riferibile quindi anche al quadro degli istinti ) IV. Il vero suicidio, quello che non è accompagnato da alcuna spiegazione e giustificazione, presenta qualche singolare analogia con il racconto del militare inglese. Con profonda intuizione Ottiero Ottieri (L’Irrealtà quotidiana, Bompiani 1966) enunciò che il suicidio non si pone come abbandono della vita ma come estremo tentativo di sfuggire alla “morte verticale “, quella presenza che ci si para di fronte, in un certo momento e per cause ignote, come l’unica alternativa possibile (l’unica porta aperta ?). E, altrettanto profondamente, Blanchot ( Lo spazio letterario, Einaudi 1967 ) enuncia, con singolare finezza, che il suicidio non è ciò che accoglie la morte ma piuttosto ciò che vorrebbe sopprimerla come futuro, togliendole quella parte di avvenire che è come la sua essenza, renderla superficiale, senza speranza o senza pericolo. Se ipotizziamo che il cavallo cercasse – nella sua “ feroce determinazione “ – soltanto un altro punto di riferimento, avremmo un motivo per sentirlo in qualche modo simile a noi. Disegno infantile è quasi spaziale ( se si dipinge una ciotola piena, un gatto che mangia e una ciotola vuota) – è divisa, appunto in due parti che chiameremo fame e sazietà in mezzo alle quali porremo il pasto. Vi è in questo tratto lineare dell’esistenza una modificazione che ci consente di parlare di un prima e di un dopo e che, in alcune circostanze, ci impone la costruzione di un nesso causale tra lo stato precedente e lo stato successivo. Pag. 51 Due voci su Die Reise (Il viaggio) di Bernward Vesper1 Parlare oggi in Italia degli anni Settanta e della piega lottarmatista che presero per una parte dei “militanti” di allora - minoritaria, ma politicamente non così trascurabile (come molti allora sostennero; e se ne videro gli effetti, purtroppo tragici, culminati nel rapimento e nell’uccissione di Aldo Moro) è come, fatte le debite proporzioni storiche, parlare del Terrore alla Robespierre nell’epoca del Termidoro o dei mazziniani e di Pisacane nel Piemonte di Cavour o dei soviet in epoca stalinista. Un tabù s’è consolidato – insidioso e non dichiarato – soprattutto nelle menti di quanti quell’epoca l’hanno vissuta, non solo per ragioni anagrafiche ma per coinvolgimento emotivo, intellettuale e pratico nelle varie formazioni partitiche o nella miriade di collettivi sociali. Tanto che persino le storicizzazioni più documentate, come ad esempio quelle di Giorgio Galli,2 stentano ad essere accolte e discusse. Eppure le passioni, i furori e gli incubi di quel decennio si riaffacciano, magari in carteggi privati, come questo tra me e Giacomo Conserva, quasi scaturito “per caso” dal richiamo a un libro che, nella Germania anch’essa attraversata negli anni Settanta dalla parossistica esperienza della RAF e dalla tragedia di Stammheim, fu giudicato «testamento di una generazione». Nel carteggio i problemi d’interpretazione politica e storica sono appena accennati e la piega esistenzialista prevale. I brani del testo di Vesper – così in presa diretta con gli umori più oscuri e forse distruttivi di quell’epoca sommersa – risulteranno a molti quasi indecifrabili (e non basterebbe un solido apparato di note a chiarirli, tant’è vero che alla fine vi abbiamo rinunciato). Si dia atto solo di questo: che la memoria sta “lavorando” e non si contenta di demonizzazioni imposte o delle correnti apologie di una mummia del ’68 tutta sorriso ebete o puerile. [E.A.] 1 Per la biografia di B. Wesper vedi oltre: Carteggio, 12 settembre 2007, Da Giacomo. 2 Si veda Giorgio Galli, Piombo Rosso. La storia completa della lotta armata in Italia dal 1970 a oggi, Baldini Castaldi Dalai, Milano 2004 Poliscritture/Esodi Considerazioni su Il viaggio Fabio Ciriachi Ho incontrato Il viaggio, di Bernward Vesper, all’inizio degli anni Ottanta. Vivevo ad Arezzo, allora, e dopo una lunga assenza dalla pratica della scrittura, stavo lentamente considerando la possibilità di riprendere la penna in mano; questo, per dire che l’ho letto con gli occhi del potenziale scrittore. A interessarmi subito, nella quarta di copertina, era stata la dichiarata intenzione di scrivere un romanzo sotto l’egida, diciamo così, psichedelica. Durante gli anni Settanta avevo accumulato una discreta esperienza diretta con l’LSD. Caratteristica comune ai sempre diversi viaggi fatti in quel periodo, la loro incompatibilità con l’espressione verbale. Dominavano le immagini, travolgenti; e solo di rado pensieri balenavano in profondità (ovvero, il più possibile lontani dalla loro resa in parole), tanto in profondità da sembrare tutt’uno con la violenza delle emozioni. Annichilimento, stupore, espansione, scoperte folgoranti e indicibili. Ecco, indicibili è il termine esatto con cui potrei etichettare quelle esperienze. E Vesper, invece, ci aveva costruito sopra una buona parte del suo lavoro! Devo dire che il libro, poi, mi aveva talmente interessato per la sua cruda incompletezza di opera postuma che la specifica curiosità iniziale si era diluita presto nel piacere delle tante scoperte impreviste offerte in abbondanza da quel suo essere laboratorio a cielo aperto, lavoro in corso che il suicidio dell’autore aveva fissato a metà delle spazio fra intenzioni e risultati. Ulteriore interesse per Il viaggio, la sua ambizione di costituirsi come opera unica e definitiva, onnicomprensiva; desiderio che, nell’intimo, molti scrittori covano, e che raramente si concretizza per le immani difficoltà che comporta. Per anni e anni questo grande e dimenticato laboratorio compositivo - solo relativamente spia di una certa stagione politica in quanto, nel suo estremismo, rappresenta fino in fondo solo l’autore - è rimasto misconosciuto. Qualche mese fa, poi, ne ho letto in un articolo di Franco Cordelli su Uwe Tim3 apparso, credo, sul Corriere della Sera, e ora, questa bella iniziativa di «Poliscritture» che, mi auguro, possa preludere a una ristampa de Il viaggio. Di nuovo - a riprendere oggi in mano la vecchia edizione Feltrinelli, con le pagine dai bordi sempre più ingialliti che assediano il cuore della scrittura - un sentimento di enorme pena per il piccolo Felix (figlio dell’autore e di Gudrun Ensslin) a cui il libro è dedicato e che, immagino, avrà avuto non poche difficoltà a capire la feroce ironia di quel nome in rapporto al tragico destino di sua madre e suo padre. A proposito di Felix: se ne sa qualcosa? È vivo? Ce l’ha fatta? (marzo 2008) 3 Uwe Timm, scrittore tedesco, autore di L’ amico e lo straniero, Mondadori, Milano 2007. Pag. 52 Miniantologia da Il viaggio di Vesper1 a) Ton Steine Scherben: “Macht kaputt was euch kaputt macht”2 Le radio suonano, i dischi suonano, i film vanno, le TV vanno, comprano viaggi, comprano auto, comprano case, comprano mobili. Perché? 1 LIBRI, ED ALTRO: Sulla storia di Bernward Vesper esiste già un film di Markus Imhoof dell’86; un altro è in preparazione adesso, basato un libro di Koenen. - Bernward Vesper, ‘Die Reise. Romanessay’, Ausgabe Letzer Hand, bes. Jörg Schröder und Klaus Behnken, Rowohlt 2003 (1983), - tr.it. ‘Il viaggio’, trad. Bruna Bianchi, Feltrinelli 1980 ( che a me pare largamente insoddisfacente; è comunque basata sulla originaria edizione del 1977, molto più limitata di quella letzer hand del 1983). - C. Pozzoli (a cura di), ‘Germania: verso una società autoritaria’, Laterza, 1968 ( trad. parziale di G.Schäfer, C.Nedelmann hg., ‘Der CDU-Staat’, 1967). - J. Agnoli, ‘La trasformazione della democrazia’, Feltrinelli 1969 ( ‘Die Transformation der Demokratie’, 1968). - Edoarda Masi, ‘Lo stato di tutto il popolo e la democrazia repressiva’, Feltrinelli, 1976. - G. Koenen, ‘Vesper, Ensslin, Baader. Urszenen des deutschen Terrorismus’, Fischer 2005 (2003). -G. Kornen, ‚Das rote Jahrzehnt. Unsere kleine deutsche Kulturrevolution 1967-1977’, Fischer 2002 (2001). -Wolfgang Kraushaar (a c. di), ‘Die RAF und der linke Terrorismus’, Hamburger Edition, 2006 . -Peter Brückner, ‘Ulrike Meinhof und die Deutschen Verhältnisse’, Wagenbach 2006 (1a edizione 1976, 2a edizione ampliata 1995). -Stefan Aust, ‘Der Baader-Meinhof-Complex’, Goldmann, 1998 (1a ed. 1985). -Bommi (Michael) Baumann, ‘Wie alles anfing’, Rotbuch Verlag, 2007 (1975) (‘Come è cominciata’, La Pietra, 1977). Distruggete quello che vi distrugge! Distruggete quello che vi distrugge! I treni girano, i dollari girano, costruiscono fabbriche, costruiscono macchine, costruiscono motori, costruiscono cannoni. Per chi? Distruggete quello che vi distrugge! Distruggete quello che vi distrugge! Bombardieri volano, dollari girano, poliziotti picchiano, difendono titoli, difendono il diritto, difendono lo stato. Da noi! Distruggete quello che vi distrugge! Distruggete quello che vi distrugge! (1970) b) “Scriverò un libro”, ho detto a Burton. “Il libro si chiamerà ‘L’odio’. Odio Dubrovnik. Odio la Germania. Odio queste verdure ambulanti. Odio le auto. Odio le strade. Odio Berlino. Odio i bambini. Odio mio padre. Odio tutti quelli che hanno fatto di me un maiale. [Odio i miei insegnanti] e così via per 150-200 pagine…” -Alois Prinz, ‘Disoccupate le strade dai sogni. �������������� La vita di Ulrike Meinhof’, Arcana 2007 (‘Lieber wütend als traurig. Die Lebensgeschichte des Ulrike Meinhof’, 2003). “Un bel libro”, disse Burton.3 -Bettina Röhl, ‘So macht Kommunismus Spaß! Ulrike Meinhof, Klaus Rainer Röhl und die Akte Konkret’, Europäische Verlagsanstalt, 2006. c) -Inge Viett, ‘Nie war ich furchtloser’, Rowohlt, 1999. -Hermann Glaser, ‘Deutsche Kultur 1945 – 2000’, Ullstein 1999 (1997). -Martin Heidegger, ‚Hölderlins Hymne „Der Ister“ (Sommersemester 1942)’, Klostermann, 1982. http://www.infopartisan.net/archive/1967/index.html http://www.zeitgeschichte-online.de/site/40208724/default.aspx http://www.bewegung.in/mate.html http://www.riolyrics.de Poliscritture/Esodi Orfeo è rimasto troppo a lungo agli Inferi. (Ho attraversato l’Inferno. [Ho disimparato la paura, mentre arrostivo nelle ondate di fuoco dell’Inferno. Odisseo è rimasto troppo a lungo nell’isola di Circe. Tannhäuser troppo a lungo sul Venusberg. L’esercito del Faraone è stato troppo a lungo sotto lo specchio nuovamente ri2 Una famosa canzone dalla Berlino autonoma-anarchica dell’inizio degli anni ’70 si può facilmente scaricarla da eMule. Un gruppo di movimento, un cantante - Rio Reiser- oggetto di culto. Uno slogan che giunse anche in Italia: ‘distruggi chi ti distrugge’- Toni Negri 3 Da Bernward Vesper, ‘Die Reise. Romanessay’, Ausgabe Letzer Hand, bes. Jörg Schröder und Klaus Behnken, Rowohlt 2003 (1983), pag. 20 passim. Poi verrà usata la formula: DR, pag. 20 passim. Pag. 53 chiusosi del Mar Rosso. Robert Musil è rimasto troppo a lungo sotto la tenda guardando la strada che scuriva.] Ma mi era impossibile esprimere tutto questo, mentre sedevo nell’OMBRA delle tapparelle abbassate vicino davanzale della stanza di Gerd Conradt o sulla seggiola nell’ombra e così via?)1 bera vita selvaggia. Attenti! Non ci sono neutrali nella guerra genetica… Uccidere un poliziotto robot assassino, per difendere la vita, è un atto sacro…”4 g) SOL INVICTUS d) Burton mi rovina il trip. Posso concepire Ulrike, quando vedo le sue ginocchia piegate (e considero lei, rimpicciolita, accovacciata sulle ginocchia), mentre sfoglia carte dai faldoni al tavolo dell’Istituto, e i due guardiani, la pistola nella cintura, seduti lì vicino che non capiscono nulla della conversazione, solo se collego tutto questo con il balzo dalla finestra del 1° piano, pochi secondi dopo, mentre i poliziotti sono già stesi sul pavimento e quell’idiota si è buttato in mezzo come poliziotto ausiliario, e adesso è per terra davanti alla porta, sanguinante. E via sull’auto, e l’azione ‘riuscita’ e Baader ‘libero’. Un silenziatore ed una Beretta italiana, rimasti sul ‘luogo del delitto’, portano i poliziotti sulle tracce di Voigt… …adesso potevi piangere solo a piccoli tratti. Non c’è Nessuno cui tu possa dire che ti hanno lasciato solo, ma è una cosa buona saperlo, per te stesso. È un Punto Fisso. Non ti sposti di lì. Lontano dal balzo, dal suo splendore, dalla sua audacia, alle 11 di mattina in un quartiere di ville di Berlino, Voigt…2 e) Aspetta ancora, finché mi avrai tutto, quando arriverà l’estate, quando torneremo dal tempio al mare, il mare santo, che nostra madre mentre ancora ci attende il dio che ci ha creato, che noi abbiamo riconosciuto come la giustizia e l’amore. Rallegrati, presto riavrai il mio corpo intatto indietro dall’inferno, ed è solo poco tempo che ci conosciamo felici in noi come in lui: dappertutto c’è luce, e anche là dove non c’è, la vediamo! 3 f) Mentre scrivo questo mi cade giù dal tavolo Love n. 5, con il comunicato di Leary, carcerato n° 26358 dello stato di California- che era prima già volato, proprio davanti a due carri armati, sopra il muro di una delle prigioni degli imperialisti. “Fratelli e sorelle! Non parliamo più di pace! Fratelli e sorelle! Questa è una guerra per la sopravvivenza. Dichiaro che adesso è in corso la Terza Guerra Mondiale. Viene condotta da robot dai capelli corti che, con l’introduzione di un ordine meccanico, vogliono distruggere la rete complessa della li1 DR, pag. 192 2 DR, pag. 158 passim. 3 DR, pag. 573 (dal frammento di poesia‚AUS EINER ANDEREN SPRACHE’, pagg. 572-3). Poliscritture/Esodi E i passi andavano nel vuoto, andavo senza andare, una ruota che girava e girava, un viaggio nell’abisso, in cui il tempo è immobile, lo spazio…non ne salti fuori…Si attende l’aeroplano, la gente nella sala d’aspetto guarda le tabelle, i segnali rossi e verdi: partenza- atterraggio- ma tu [non atterri, tu] vieni meno, decadi, già fra duemila anni sarai completamente dimenticato [come se tu non fossi mai esistito, già domani, quando morirai]… Il freddo mi dava i brividi- andavo senza meta (e poi con una unica meta [, disfare la separazione]… In fondo al giardino, dietro al monumento equestre, la facciata vuota dell’edificio e improvvisamente un piegare il capo- IL SOLE! Un’arancia con strisce verdi, ma cresce, si stacca dai verdi banchi di nuvole andando verso l’alto- con lentezza, invicibilmente. IL SOLE! Un nuovo torrente di lacrime, di felicità, di stupore. Il piccolo sole! [Nel mio più profondo abbandono,] E improvvisamente ho capito, ho spalancato le braccia. Il segreto, il mio segreto: [il nostro segreto: Felix]. FELIX È IL PICCOLO SOLE. Mi sono girato dietro, ho chiamato Burton, che procedeva dietro siepi alte fino alla vita, più lontano due giardinieri con rastrelli e grembiule blu. “Corri qui”, gli ho gridato. C’è voluto molto prima che sentisse: “Guarda, il sole!” Burton si avvicinò in silenzio, diede un’occhiata e si voltò dall’altra parte. Io ero calmissimo, felice, guardavo come il sole saliva in alto, come il rosso diventava sempre più chiaro, come la luce si diffondeva sul disco, costruiva uno spazio rossastro, diventava più chiara, BIANCA, BIANCA. “Fa male agli occhi”, disse Burton. Oh sì, e forse non si tornerà più indietro, quando il BIANCO riempie tutta la corteccia del cervello e ci si rifiuta di ritrarsi da questo stadio, dalla zona di enorme luminosità- per tornare alle vecchie condizioni… (“Non mi disturba affatto” dissi io. Non prestavo attenzione a quello che ancora stava borbottando. Creai 4 DR, pagg. 497-8 passim (in Italia il testo di Leary apparve inizialmente su RE NUDO; diceva pure: ‘C’è il tempo del ridente Krishna e il tempo del torvo Shiva. Il conflitto che abbiamo cercato di evitare incombe su di noi’). Pag. 54 una linea di confine. Quando il bordo inferiore del sole si libererà del tutto dalle nuvole, mi volterò. Un meraviglioso, luminoso, splendente viaggio. Felix, il dio del sole sorge dalle ombre, percorre un cammino diritto nel maestoso cielo blu…) FELIX È IL PICCOLO SOLE. (Burton vuole rovinarmi il viaggio…) È sicuro: il sole non può volar via. Arriva. Continuerà a salire, scalderà i miei occhi, la fronte, mitemente, senza febbre. [(Felix dorme. È tanto che non lo vedo! Ma oggi sì, o domani.)] FELIX. (Viene da te e dice: Papà, me l’hanno preso via, fammelo restituire per favore. Ed io risi e piansi. “Il leone mi ha morso il dito” disse Felix. L’ho preso in braccio e ho detto: “Vieni qui da me, non me ne vado via, ci sono sempre…” e sono tuo Padre e resto con te fino alla fine del mondo, il tuo mondo. Smette di esistere quando anche tu smetti, e lui rise. Voglio vederlo! Devo vederlo! Non lo lascerò mai! Ci avevo pensato, di rinunciare a lui, per esempio, per intraprendere un viaggio, per sempre…) Sono andato da Burton, che aspettava un paio di passi indietro. (Felix è il piccolo sole. A lui non potevo dirlo. E tutto il giorno ho cercato qualcuno cui poterlo esprimere. La pura Verità!) //(Nulla è più come era nel 1969. In Inghilterra non governa più un governo laburista, ma i conservatori. In Francia non è più De Gaulle l’interlocutore, e nella Repubblica Federale Tedesca la CDU è stata sostituita dall’SPD come partito di governo.)//1 h) Il nuovo Stato Sono passati solo sei anni- e come una meraviglia è sorto dalle rovine un nuovo Stato, uno Stato di pace, uno Stato in armi, da uno solo voluto e da uno solo costruito, una cittadella di forza, nel centro del mondo collocato su un buon terreno, dalla fiducia e dal coraggio di un popolo, da pura volontà e puro sangue, su una fede che fa miracoli! Chi ha occhi aperti e non è traditore o stupido vede quello che è avvenuto e come tutto si è risolto in bene grazie a colui che ci ha mandato Dio: tutte le ruote in movimento, i pistoni in azione, gioiosi al lavoro vecchi e giovani. Il pane ben guadagnato rende luminosi gli occhi, rossa la schiena, e nessuno più soffre la miseria in Germania! E la discordia civile, l’antica peste, è finita per sempre! … il Führer posa lo sguardo… 1 DR, pag. 110-112. Poliscritture/Esodi Will Vesper- Per il 50° compleanno del Führer2 i) 7 maggio 1969: assalto a ‘Konkret’3 …Konkret: sugli spari di Berlino. Vomita tutto, amico mio! E lui ancora a vomitare: ‘L’anarchismo porta al fascismo’. E Klaus Rainer sbrodola per tre colonne, fa finta di non essere stato sposato per tredici (?) anni con Ulrike. Non ne sa niente. Non ha niente a che fare con lui- è uno sviluppo tra le cui cause Röhl non è trovabile. Ci mettiamo in moto di notte. I rocker con i loro elmetti d’acciaio, giacche di cuoio, le croci di ferro al collo. Un paio d’auto, un furgoncino VW. Di mattina, al Gänsemarkt il fotografo furtivo che di nascosto scatta foto verso il nostro tavolo.”Tira fuori la pellicola”- Tomayer, sex bomb fuori testa, eccola qui! E lo accompagnamo giù dalle scale, mentre l’oste crepa di paura. Così, dammi la macchina, fuori il rullino, e poi fila! Ci guardava con gli occhi sbarrati, sembrava aspettarsi che lo ammazzassimo di botte. “Chiamo la polizia!” Togliti di mezzo! Corri dai poliziotti, maiale! E poi iniziò l’assalto a ‘Konkret’. Qualche troia il giorno dopo ha blaterato qualcosa sui rossi in famiglia. Röhl tremava nell’appartamento di Rühmkorf, armato di una pistola a gas lacrimogeno. Sì, ci è sfuggito per un pelo, lui, il Capo, il piccolo imprenditore, il due volte sfruttatore, che ruba soldi dalle tasche dei rossi e giudica idiozia le loro idee, che ha cacciato via i rivoluzionari, ha rifiutato la collettivizzazione e infine, pieno di rabbia come un matto, ha levato il culo- lui che due dozzine di persone hanno trascinato via dall’ingresso della sede della rivista sbarrato dai poliziotti. Poi fuori dalla città, alla villa. La Volvo con i freni guasti, e poi una discussione con Astrid: Cazzo, Vesper, stai calmo! Incisioni francesi finivano per terra, oggetti liberty an2 Will Vesper era il padre di Bernward. 3 Ulrike Meinhof lasciò nel 1968 il marito, Klaus Rainer Röhl, editore di ‘Konkret’ (la rivista della sinistra radicale tedesca, con una tiratura a un certo punto giunta a 100.000 copie); abbandonò la lussuosa villa di Blankenese, vicino ad Amburgo, e si trasferì a Berlino. Vi erano problemi interpersonali, e grosse differenze politiche nella valutazione del movimento extraparlamentare. A un certo punto fondò una redazione alternativa (’rivoluzionaria’) della rivista, di cui da un decennio era la principale editorialista. Da Berlino il 7 maggio del ’69 partì una spedizione diretta ad Amburgo: prima alla sede di Konkret, in centro, presidiata dalla polizia, poi alla villa. C’era pure la Meinhof. La Volvo ricordata sopra era l’auto di Vesper. Cfr. Aust (‘ Der Baader-Meinhof- Complex pagg. 52-55 e 83-85 ), J_Seifert (pagg. 363-4 in Kraushaar ed. ‘Die RAF..’), Koenen (211 ).- Le 2 bambine finirono nel ’70 in una comune in Sicilia (da dove pare la Meinhof, passata intanto alla clandestinità, intendesse farle giungere ai campi palestinesi in Giordania); in modo rocambolesco Stefan Aust, suo amico e collega, le riportò dal padre ad Amburgo, sfuggendo poi di poco alla vendetta della RAF.- Da aggiungere che marito e moglie erano stati per anni iscritti al partito comunista clandestino, e che la rivista era stata originariamente finanziata dalla DDR (come si scoprì dopo il crollo di questa). Su tutto questo si dovrebbe pure leggere il libro di Bettina Röhl dedicato ai suoi genitori ed al loro mondo. Pag. 55 davano in frantumi. La pisciata si allargò ai lati della rivista sul ‘letto matrimoniale’, Dio lo sa, e il compagno veloce che proprio allora doveva urinare sporcò le belle lenzuola, cambiate di fresco. Vicino c’era Ulrike. “Per te deve essere un momento da ricordare” disse Benjamin. vario di quanto a volte ci si immagina che sia (e pieno di possibilità, dunque, anche). Era la sua casa, lei l’aveva messa su, abitata, lasciata assieme alle bambine. La percorreva come una rovina, una baracca che sta per essere sacrificata ai picconi, e guardando la quale tutto sembra ripetersi, le sequenze del film, la ricerca di una casa, le ipoteche, le trattative, il lento, mortale accumularsi di oggetti, che rapidamente riempiono tutte le stanze, coprono i muri, si annidano nella coscienza, diventano pietra, un guscio di morte, che blocca qualunque rottura, barricate che ostruiscono il futuro. Da Giacomo È questa tutta l’offerta abitativa di un’unica casa? Sono gli scaffali delle porcellane, i letti, TV e stereo, tappeti orientali, stuoie, lampade, quadri, stanza da bagno, cucina, libri di arredamento? Bello, ma non è ancora tutto!// Adesso volano attraverso la finestra chiusa nel giardino, adesso bruciano parole Blu sulla facciata (e noi, “ mentre già il BLU riempie le valli da sud a nord a 10000 metri d’altezza. Silenzio fra i braccioli del sedile del jet”) 1 Carteggio 6 agosto 2007 Da Giacomo Continuo, fra le altre cose, a lavorare attorno a quel libro di Vesper, Il viaggio, e alla Germania degli anni attorno al ‘68 e post. Sicuramente ci scriverò qualcosa sopra. A parte le cose di fondo, ci sono tanti particolari almeno per me totalmente inattesi: la scuola di Francoforte è quasi diventata negli anni dal ‘90 in poi la filosofia di stato; un ex avvocato di Ulrike Meinhof e degli altri della RAF, a suo tempo vicino all’SDS,- a suo tempo accusato di complicità con i detenuti di StammheimOtto Schily, ben noto allora, è stato per anni ministro dell’Interno nel governo Schroeder; Horst Mahler, invece, l’avvocato di Berlino che fu fra i primissimi fondatori della RAF, è da anni un nazionalista molto vicino ai nazi; Klaus Croissant, un altro avvocato della RAF, arrestato a Parigi fra clamore e proteste nel ‘74, fu a lungo un informatore della STASI (come si è detto anche del notissimo giornalista e scrittore Guenther Wallraff, cognato di Heinrich Boll); d’altra parte, una delle mie figure mitiche di gioventù, Bommi Baumann, fu nel ‘73 per oltre 10 giorni minuziosamente interrogato dalla STASI sullo stato del movimento- legale e illegale- in Germania (sono stati ritrovati gli atti completi dell’interrogatorio). Ma queste sono minuzie, anche se sono il tipo di cose che non avrei mai pensato potessero succedere (ricordo ancora, detto per pura associazione, il mio sconfinato stupore quando venne annunciata la ‘fuga’ di Lin Piao e la sua morte, o il viaggio di Nixon a Pechino). Tanto per ricordare che il mondo è molto più vasto e 1 DR, pp. 199-201. Poliscritture/Esodi 12 settembre 2007 ‘E Baader libero’: un libro dalla Germania (‘abbatto il muro del suono del delirio in tuo onore’-) Bernward Vesper era figlio di un poeta sentimental-nazionalista, un poco kitsch e celebre già prima della I Guerra Mondiale, che negli anni ’30 divenne nazista. Nacque nel 1938, con il padre già sessantenne; crebbe in una tenuta semifeudale nel Nord della Germania, vicino alla brughiera di Lüneburg. Naturalmente, nei discorsi del padre e dei suoi amici, la storia girava attorno alle vicende dei prigionieri polacchi e russi che lavoravano nei campi e nella torbiera, alla fine della guerra nel rombo di bombardieri e carri armati nemici e dell’antiaerea. Da ragazzo si impegnò, seguendo il padre, nei movimenti di destra. A 20 anni andò all’Università di Tubinga, ove a un certo punto incontrò Gudrun Ensslin, una dei sette figli di un pastore protestante progressista legato agli ambienti neutralisti e pacifisti. Insieme, nel corso degli anni, furono presi dal processo di trasformazione e radicalizzazione che investì una significativa porzione della società tedesca negli anni ’60 (con una serie di tappe: il movimento antiatomico; l’affare Spiegel del ’62, la Grande Coalizione e la lotta contro le leggi per lo stato di emergenza, la guerra del Vietnam, la morte di Benno Ohnesorg il 2 giugno 1967 a Berlino, l’esplosione dell’SDS, il movimento delle Comuni, l’attentato a Dutschke, etc). Da sempre impegnato nell’editoria, fondò una piccola casa editrice, la Voltaire Verlag, che divenne uno dei portavoce del movimento antiautoritario e della opposizione extraparlamentare. Nel 1967, appena nato il loro bambino (chiamato Felix in segno d’augurio), Gudrun lo lasciò per Andreas Baader e per una attività politica sempre più dura (che inarrestabilmente la portò alla RAF, la Rote Armee Fraktion - ovvero ‘Banda Baader-Meinhof’, a anni di prigionia, a una tragica e oscura morte dieci anni dopo). Rimase solo e disperato (dopo averla prima innumerevoli volte tradita), combattendo una perdente lotta per tenere con sé il bambino (su cui non aveva la patria potestà, sulla base della legge tedesca di allora, non essendosi i genitori sposati). Musica, hashish e altro, vagabondaggi, sogni di lotta armata (e forse collaborazione alla lotta armata), tentativi infine falliti di tenere in piedi la casa editrice- che perse definitivamente all’inizio del ’69, fluttuanti storie d’amore- di cui la più insensata con Ruth Ensslin, la sorella 14enne di Gudrun. Nell’estate del ’69 portò il figlio a una coppia di Undingen (cristiano-democratici, classe media, Pag. 56 conservatori, amici degli Ensslin), che ricorrentemente se ne faceva carico. Proseguì nel Sud della Germania per il campeggio rivoluzionario di Ebrach. Infine, mentre diversi suoi amici e amiche stretti andavano in Giordania - su un furgone Ford pare fornito da Feltrinelli- per adddestrarsi alla guerriglia nei campi palestinesi, scese in auto in Italia, e quindi in traghetto giunse a Dubrovnik per incontrare Ruth, che vi si trovava in vacanza con i genitori. Il pastore Ensslin ancora gli ingiunse e lo supplicò di lasciare in pace la sua famiglia. Riuscì a trascorrere una notte con Ruth, che però lo respinse. Nel pomeriggio, disperato, ripartì in auto, risalendo la costa jugoslava. A Rijeka incontrò un giovane ebreo americano che faceva l’autostop (pieno di hashish lui, tutto il tempo, e avendo con sé un trip, un acido, datogli da una sua amica prima che lei, invece di recarsi in India come aveva progettato, salisse sul Ford Transit diretto in Giordania). Bernward e Burton tornarono insieme in Germania. A Monaco di Baviera all’inizio di agosto presero insieme l’LSD. ‘Da allora niente è più stato uguale’, scrive a un certo punto. Dopo qualche giorno, nella tenuta paterna, iniziò a scrivere a tempo pieno un romanzosaggio-autobiografia, un enorme frammento. Si incrociano viaggi reali, il trip di Monaco ed altri con peyote, fumo sempre, un ‘semplice resoconto’- sempre più lungo e penosamente dettagliato- della sua infanzia, la Germania di quegli anni, innumerevoli figure reali (i membri della Kommune 1 di Berlino, il fondatore dei Tupamaros West Berlin, Günther Grass, l’editore di Konkret e marito di Ulrike Meinhof Röhl, Ulrike M., Ingeborg Bachmann, Lena Conradt e suo marito il regista Gerd, Gudrun, Ruth, Petra, Elken…), polemiche con Günther Wallraff sulla lotta armata, con Martin Walser sull’LSD, scene del celebre congresso di Londra sulla Dialettica di Liberazione organizzato da Laing e Cooper nel ’67 (cui lui aveva partecipato), un diario (immaginario?) di viaggio nel Nord dell’Italia all’interno della sinistra extraparlamentare e delle Brigate Rosse allora in formazione, un dettagliato racconto di una guerrigliera tedesca in Giordania, frammenti di giornali vari, lettere all’editore con cui era in contatto per la pubblicazione del suo libro in fieri, - perfino un fattualmente accurato resoconto della liberazione di Andreas Baader nel maggio ’70 (l’inizio ufficiale della RAF), visioni insight sogni incubi con LSD hashish mescalina anfetamine, innumerevoli citazioni e richiami (Sartre, Camus, Genet, Pavese, Reich, Laing, Marcuse, Leary, Stokely Carmichael, Eldridge Cleaver, Guevara, etc etc)1. 1 Alla fine del 1977 in una assemblea teorizzai che bisognava uscire dal provincialismo, che la germanizzazione era la tendenza dominante- con stato autoritario, caccia agli oppositori, sfrenato dominio delle multinazionali, assorbimento dei sin- Poliscritture/Esodi 12 settembre 07 Da Ennio […] Così come lo presenti, un personaggio come Vesper m’incuriosisce e respinge. Non riesco a capire come avvicinarlo. Rappresenta per me il lato del ’68 più frenetico e romantico che - devo riconoscere a posteriori - mi sfiorò soltanto come discorso “per sentito dire” o per immagini intraviste (sui giornali o in persone del movimento incrociate ma non frequentate). Mi viene in mente un certo S., uno studente di filosofia conosciuto tra 1966 e 1967, quando avevo ripreso alla Statale di Milano i miei studi universitari interrotti. Da lui avevo cercato di farmi spiegare un articolo di Badaloni su Althusser che trovavo incomprensibile. Ricordo di averlo poi rivisto “fatto” (ma allora nulla sapevo di droghe), dondolante in piedi e con lo sguardo smorto, davanti all’ingresso della Statale occupata. Lo incrociai settimane dopo sotto la Galleria accanto a Piazza Duomo con Allen Ginsberg (sì, proprio lui). S. mi diede un indirizzo, forse quello una comune, e un appuntamento. Mi presentai puntuale, bussai più volte alla porta indicata sul biglietto. Nessuno mi aprì. Dietro l’uscio sentivo bisbigliare persone. Forse mi scrutavano dallo spioncino e– suppongo - diffidando di uno sconosciuto, non mi aprirono. Oppure penso a D., uno che aveva organizzato agli inizi degli anni ’60 i primi scioperi operai “a gatto selvaggio”. Lo ricordo durante una riunione di studenti che, abbandonando la Statale chiusa e presidiata dalla polizia, erano dopo gli scontri confluiti al Politecnico. Lui si offrì di buttarsi da solo contro i poliziotti per provocare uno scontro. Di recente, quasi per caso, ho trovato un sito a lui dedicato: è morto nel 1996. Ho visto sue foto, letto suoi scritti, saputo qualcosa della sua tormentata giovinezza e degli scontri feroci con un padre socialmente molto in vista. E poi c’è P., col quale ho avuto sempre un rapporto/non rapporto e una comunicazione mai veramente sintonizzata: come fra due universi che sembrano in continuità ma nei fatti si svelavano distanti. Anche lui, al di là degli incontri/scontri nel contesto preciso della scuola dove insegnammo tra ‘70 e ‘78 o delle lettere che ci siamo scambiati, aveva una zona di esperienza politica ed esistenziale “altra” dalla mia. So che me l’ha sempre occultata. Credo per una valutazione da parte sua d’incompatibilità politica, ma anche umana con me (una volta mi disse che io parlavo ancora «come un contadino»). Un diaframma tra noi è rimasto. Ho sentito sempre in lui un intento strumentale, come di chi collochi il rapporto con te su un piano delimitato e subordinato ad altri ben più importanti per lui. Da lì tu non devi uscire: o ci stai o si rompe. Detto questo sulle mie reazioni alla storia di Vesper e al retroterra che mi evoca, mi chiedo cosa spinge te a esplorare oggi la sua figura. Mi dici che nel ’77 avevi teorizzato che bisognasse sprovincializzarsi e “imparare il tedesco”. Io, per vari motivi, non ci sono mai riuscito. Ma - non prenderla come una provocazione - mi sentirei alleato della dacati, trasformazione della socialdemocrazia, utilizzo della manodopera straniera, lotta per la conquista di nuovi mercati e campi di investimento; che ‘bisogna imparare il tedesco’. Pag. 57 tua ricerca, se capissi cosa hai già imparato dalla tua esplorazione della Germania, cosa ricavi dai materiali sulla vita di Vesper, cosa e come potremmo riproporre tutto ciò su Poliscritture. 15 sett 2007 Da Giacomo Per un aspetto, l’idea era di utilizzare le sostanze psichedeliche per accedere a un più profondo contatto con sé stessi, la propria storia, il mondo; usarle per superare le rigidità, distruggere la corazza caratteriale, disfare quanto di disastroso famiglia, educazione, Germania avevano depositato dentro di lui («mi avete reso un maiale», dice a un certo punto); e, nello stesso tempo, viene sviluppata una tecnica del ricordo, del ripercorrere infinite volte il passato biografico- tolto alla banalità, alle identificazioni o controidentificazioni acquisite, sollecitato come da una lente dalla luce spietata, capace di focalizzare, ristrutturare, annientare. Lottare contro le ‘verdure’, gli integrati, i nazisti del mondo esterno e del mondo interno; passare dall’odio all’energia grazie all’esperienza (riprendendo a modo suo una formula di Che Guevara). (E ricordi di William Blake , quello delle «porte delle percezione»: la Strada dell’Eccesso che conduce al Palazzo della Saggezza). E muoversi intanto nella realtà delle comuni, dei piccoli e grandi gruppi in trasformazione, delle discussioni e lotte collettive, sullo sfondo di un mondo dove l’ordine imperialistico-patriarcale era ovunque in crisi. Da tutto ciò non solo il legame con le tematiche di protesta e resistenza del movimento antiautoritario, ma la tensione (allora di tanti) ad innalzare il livello di scontro, ad attaccare invece di difendersi soltanto. Il libro è così al centro di spinte laceranti. Fare i conti con il nazista dentro di sé non è così semplice, comporta una serie di rischi (Bernward Vesper ebbe all’inizio del ‘71 una crisi psicotica, per esempio; e più tardi morì suicida); costruire rapporti “diversi” con compagni e compagne non è banale; e quanto alla guerra rivoluzionaria di liberazione, al “distruggi chi ti distrugge”, si sa bene quanti labirinti, sofferenze, disastrose sconfitte e a volte disastrose vittorie comporti. E poi: osare lottare, osare vincere- è stato scritto tanto tempo fa, e la cosa ha un senso e la questione resta aperta, anche se a volte una spessa nebbia oscura il campo di battaglia, stravolge le fisionomie dei contendenti e degli astanti, a volte ne modifica la natura più interna; ma la questione resta aperta appunto, comunque; e il merito di questo libro è di porla con forza, in tutta la sua complessità e il suo caos (e a volte tutto il suo orrore e il suo squallore). Così, come scrisse Heinrich Böll nel ‘77, è un libro non benefico, ma necessario. Infine messo insieme dai manoscritti e dalle note di Vesper, il libro uscì in quell’anno, l’anno di Stammheim, e trovò una grande eco e un enorme ascolto. «Testamento di una generazione», venne chiamato; in effetti tratteggia tutto il travaglio della generazione del ‘68 tedesco, il suo tentativo di fare i conti con un passato atroce e di costruire, oltre il fascismo quotidiano ed i rapporti di potere di una società autoritaria, un nuovo mondo; e testimonia pure senza dubbio la terriPoliscritture/Esodi bile violenza messa in campo in questo sforzo. Dopo il maggio ‘71, in cui morì Bernward Vesper, tante cose sono avvenute in Germania e altrove. Di molti eventi, emozioni, concatenazioni di quel periodo storico si è cancellato il ricordo, di altre si diffonde una versione unidimensionale e rosé- come se p.e. il ‘68 a livello mondiale sia stato solo un glorioso momento di modernizzazione e democratizzazione, o inversamente di nascita e avvento di una nuova borghesia, o di ascesa del sistema a più alti livelli di complessità ed efficienza. È tutto vero, ma c’è di più in quegli anni: un di più che va indagato e pensato- non solo per amore della verità, ma anche per aiutare a restituire al reale la sua dialettica e il suo colore, la sua sofferenza, ma anche il suo campo di possibilità. Così Die Reise può servire- una specie di esercizio di meditazione su sé stessi e sul proprio mondo: è esattamente quello che Bernward Vesper aveva in mente quando decise di dedicarsi alla sua ricerca. 15 settembre 2007 Da Ennio Sì, il tuo pezzo su Vesper scrosta i depositi di rimozione ammucchiatisi sul ’68, respinge le sue letture accomodanti, e, partendo da una sorta di autobiografia di un concreto militante, evita discorsi generali e generici su quegli anni. Ma il «di più» di quegli anni dev’essere pur valutato e chiarito. E la verità, allora raggiunta o intravista, andrebbe non solo riconosciuta, ma anche riproposta ad altri/e, ai giovani, ecc. Perciò chiedo: cosa c’è da portare ad esempio nella vicenda di Vesper? La sua (e d’altri) idea di «utilizzare le sostanze psichedeliche per accedere a un più profondo contatto con sé stessi, la propria storia, il mondo» è riproponibile? Quella «tecnica del ricordo, del ripercorrere infinite volte il passato biografico- tolto alla banalità, alle identificazioni o controidentificazioni acquisite» non manca di qualcosa (del contatto con gli altri, secondo me) per fruttare sia individualmente che socialmente? Tutto sta poi a vedere quale obiettivo uno persegue. Forse è vero che «la strada dell’Eccesso conduce al Palazzo della Saggezza». Ma non a “cambiare il mondo”, come si pretendeva allora (e, per me, si dovrebbe ancora pretendere). Anche «muoversi intanto nella realtà delle comuni, dei piccoli e grandi gruppi in trasformazione, delle discussioni e lotte collettive» a me pare sia stato proposito insufficiente e generico. Quanto e cosa quelle comuni mettevano… in comune e quanto, invece, si chiamavano fuori da altre trasformazioni snobbate o sottovalutate? Fare «i conti con il nazista dentro di sé» non è così semplice. Per questo – vado per approssimazioni – quel tipo di lotta dev’essere almeno contiguo ad altre lotte. Se no, si rischia di assolutizzare e interiorizzare tutto senza più scambiare davvero con gli altri/e. Troppi sono stati i cortocircuiti tra i due piani (interno ed esterno). Ed essi hanno danneggiato il lavoro su entrambi e sulle loro specifiche caratteristiche. Per cui l’«osare lottare, osare vincere» è stato più spesso un azzardo soggettivo e disperato che un atto maturo di coraggio. Mi spiego. Per me ‘coraggio’ significa una visione realistica almeno del Pag. 58 Ornella Garbin, Sogni 70% di quella che chiamiamo “realtà” e un azzardo del 30%; e non viceversa. Ho in mente il Lenin delle Tesi di aprile che convince i suoi compagni titubanti a prendere il potere. Altrimenti, non solo non si vince neppure per un attimo, ma non si fa un passo avanti; e la sconfittà stronca le spinta liberatrici, anche le più elementari. Vorrei capire poi bene in che senso Böll riteneva «non benefico, ma necessario» questo libro di Vesper. È forse nel senso che intendeva Fortini quando nella poesia «Stammhein» scriveva: «Essi hanno fatto quello che dovevano / secondo gli ordini della città non visibile. /… Sono stati uccisi. / Nessuno fu più obbediente di loro.»? Posso anche arrivare a capire che in quella Germania, con quel passato, quella generazione doveva attraversare quella prova. Ma tutti i passi o i più significativi fatti da Vesper vanno iscritti in quel contesto o no? La mia impressione è che Vesper abbia vissuto poco politicamente e molto esistenzialmente gli eventi in cui fu coinvolto. E la vera “scoperta” per lui più che il mondo politico ( il movimento studentesco, etc.) in conflitto con la Germania d’allora pare sia stata quella dell’LSD, che gli apre le porte di una scrittura convulsa e di genere misto («romanzo-saggio-autobiografia» tu dici). È proprio questo suo «semplice resoconto – sempre più lungo e penosamente dettagliato» che andrebbe valutato. Quanto è delirio? Quanto corrisponde a fatti accertati? Merita davvero la definizione di «testamento di una generazione»? Sulla base di quanto tu ne scrivi, io, pur con tutta l’attenzione che porto al singolo e alle sue sofferenze, ho dei dubbi. Per essere un vero testamento, bisognerebbe – credo – che in quel «semplice resoconto» i nuclei di verità soggettiva fossero in qualche relazione abbastanza precisa con i nuclei di verità politica della Germania di allora. Altrimenti – mi azzardo a dire - credo che possa interessarti come psichiatra. È il resto che a me preme e per meglio avvicinarmi al singolo. È il divario tra quella soggettività e le altre, che fecero esperienze diverse, che va colmato. Comunque il tema è interessante. insisterò a fare l’avvocato del diavolo (o dell’angelo in questo caso). Tu lavoraci e poi lo proponiamo anche agli altri. Poliscritture/Esodi 30 settembre 2007 Da Giacomo Scusa il tempo trascorso […]. Non ho comunque smesso di pensare alle questioni poste da te, che sono quanto mai appropriate. Proverò a spiegarmi un poco. In primo luogo, dopo le morti di Stammheim facemmo una dimostrazione rabbiosissima a Parma - la più soggettivamente violenta cui io abbia mai partecipato (a parte il 12-377 a Roma- in cui però ero stato molto più passivo). Poi. De Il viaggio mi parlò il mio migliore amico nell’’80, quando uscì; lo presi in mano, ma lo trovai ECCESSIVAMENTE cupo e angoscioso, e totalmente respingente. Non me ne scordai però. Molti anni dopo, occupandomi variamente di cose tedesche, cominciai a trovarne tracce molteplici in Rete. Finché quasi due anni fa lo comperai, e lentamente cominciai ad entrarci dentro aiutato in modo decisivo infine da un libro di G.Koenen, autore di una ben nota storia del Movimento in Germania fra il ‘67 e il ‘77, e di un luttuoso «Vesper, Ensslin, Baader. Alle origini della lotta armata in Germania». Intanto c’era l’aspetto intellettuale: decifrare un testo superstratificato-caotico, mettere in rapporto le pagine e pagine di testo con una sensata serie di eventi (solo-individuali, e storici in senso stretto). Poi: ci sono pagine di un valore estremo: le scene in contemporanea sono vive, di un linguaggio diretto e forte e semplice (meglio di quello di Handke, senza la sua deformazione elegiaca). Poi, più rilevante (e qui vengo a una domanda esplicitamente posta da te): più ci entravo dentro, più Vesper mi ricordava (completamente diverso, sì) il me fra i 15 e i 35 anni, più o meno: un mix (nomadico? Io direi caotico) di padre autoritario e distante- amato/odiato, provenienza in qualche modo alto-borghese (decaduta), rovine attorno nel dopoguerra, ricerca di liberazione individuale utilizzando ogni scorciatoia immaginabile, fascinazione per l’idea di un sovvertimento TOTALE (ben al di là della percentuale di irrealismo che tu, giustamente, ritieni gestibile/utile), ricerca della libertà emotivo-sentimentale accopPag. 59 piata a uso a volte del tutto irresponsabile delle altre persone (e, in ultima analisi, di sé stessi), mantenimento non detto di tutta una serie di dipendenze decisive. Come ti ho scritto, ritengo il libro anche la cronaca di una malattia. Non mi ci sono trattenuto, perché (e probabilmente sbagliavo) mi sembrava evidente: un tale stile di comportamento e di scelte, l’uso sfrenato di sostanze, l’instabilità di rapporti, la eccessiva disarmonia interna e violenza interna (e a volte esterna: vedi p.e. la cronaca dell’attacco alla villa di Rohl, ex-marito di Ulrike Meinhof e direttore di Konkret- una rivista di sinistra estrema molto importante-, che si era distanziata dalla sinistra extraparlamentare nel ‘69- che penso tradurrò prossimamente e inserirò nel testo). La cronaca è appunto francamente agghiacciante, come p.e. erano stati agghiaccianti i comunicati sul fratello di Peci, o un messaggio di Gudrun Ensslin a Kurt Wagenbach della fine del’76, che ho letto pochi giorni fa:- come ho pure letto da un’altra parte, la lotta armata e la violenza sono spesso molto più affascinanti viste da lontano che da vicino). Vi era comunque in Vesper (e in quegli anni in senso lato) una energia estrema, che mi interessa riconsiderare. Per quanto mi riguarda, a un certo punto (inizio dell’’80, grosso modo) mi sono quasi completamente azzittito su troppi temi: un po’ perché non condividevo, o non condividevo più, i prncìpi portanti; un po’ per paura (paura della polizia, paura dello sguardo degli altri, paura), un po’ per pura angoscia. Mi ci sono voluti anni - difficili- per venirne un poco a capo. Quando ho ricominciato a occuparmi di politica in senso lato, la struttura del silenzio è stata elusa, non affrontata (il massimo di formulazione è stato del tipo: quelle cose avvenivano allora- senza dettagliare a me stesso in primo luogo di cosa esattamente parlavo-, ma adesso i tempi sono diversi, possiamo tutti insieme occuparci in modo più irenico di altro - di qui l’interesse per i Verdi p.e. È una soluzione, ma non ottimale; troppo rimane fuori). A ogni modo: occuparmi di Germania (che per una serie di motivi mi ha sempre interessato: all’origine p.e. le copie della «Illutrazione italo-germanica» bilingui degli anni dopo il ‘43 trovati nella soffitta della casa di campagna di mia madre; e la scia della Seconda guerra mondiale, con sigle e nomi che mi affascinavano: OKW, Rommel, Von Keitel, Stuka etc etc etc- tieni conto che per me bambino i tedeschi erano i perdenti assoluti, dotati comunque di una forza del tutto superiore a quella dei fascisti italiani) (mio padre era liberale, con un passato antimonarchico e non-fascista; mio nonno materno, morto suicida nel ‘44, era un medico importante e gerarca di medio livello, per quel poco che sono riuscito a capire)- occuparmi di Germania è un modo che ho trovato per fare un po’ i conti con il mio passato (e il passato di un po’ d’altri); tieni conto, per concludere, che nel ‘75 dedicai il libro di Blake ad Anna Maria Mantini, dei Nuclei Armati Proletari; che poco dopo scrissi una lunga poesia su Margherita Cagol (che certo non ho più fatto girare, ma che ancora trovo molto bella); che poi nel ‘78 scrissi ‘Ziggy Stardust’ sognando sognando sognando di essere lontano dalla semiguerracivile che infuriava attorno. Per dire che ero un po’ confuso, come tanti. Credo non fosse scontato che mi salvassi dai vari rischi (crollo mentale, licenziamento, arresti per motiPoliscritture/Esodi vi veri o presunti, etc). (NON HO MAI PARTECIPATO ALLA LOTTA ARMATA ). 30 settembre 2007 Da Giacomo Mi accorgo di non avere concluso una frase- preso da una lunghissima parentesi: mi sembrava dunque evidente che lo stile di comportamento di Vesper diventasse sempre più idiosincrasico, pericoloso, infine del tutto patologico; e una psicosi maniacal-delirante, come quella in cui entrò francamente all’inizio del ‘71, e che lo portò a mesi di ricovero psichiatrico obbligatorio, con suicidio infine il giorno prima della dimissione, è quanto di più patologico si possa immaginare; pur mettendoci dentro l’AntiEdipo e Laing etc è evidente che dal suo ‘viaggio’ lui non è riuscito a uscire in condizioni decenti e accettabili (anche se quanto vi ha scoperto e vissuto può essere estremamente significativo PER GLI ALTRI). 5 aprile 2008 Da Giacomo …ho pensato a lungo alle note che proponi di mettere: ma come si fa? Lin Piao, Mao, Klaus Croissant, Rudi Dutschke, l’affare Spiegel, la Grande Coalizione, la Stasi, gli Stukas…: è come dovere spiegare passo passo la storia di 50 anni- o una sua porzione significativa. E poi la spiegazione è sempre unilaterale e per forza parzialmente falsa, e fuorviante. È al di là delle mie capacità. Diciamo che sono un sopravvissuto (che vive ancora, sottolineo), o che bisogna studiare (come ha detto Fortini, appunto: le Chinois, ça s’apprend). Le uniche cose che mi sento in dovere di aggiungere sono bibliografiche, e ad personam. “Right on. Per Mara (e per Ulrike, NdR)” apparve sull’’Erba voglio’ nel 1976; “Ziggy Stardust, i Ragni di Marte ed il rapimento di Aldo Moro” su ‘A/traverso’ all’inizio del ’79. “Poesie” di William Blake, con scelta e traduzione mia, è stato stampato dalla Newton Compton nel ’76 (e poi ristampato almeno altre due volte). E poi che, naturalmente, la Germania è per me anche Hölderlin e Brecht e Goethe e Adorno e Fassbinder e Wenders e… Pag. 60 4 Storia adesso del passato che resta e del presente che si fa storia La pseudo rivoluzione e la pseudonovità dei neocon Franco Tagliafierro Neoconservatorismo, neoconservazione, neoconservatore ecc.: sono termini pesanti, perciò ci si avvale preferibilmente di neocon con funzione di sostantivo o di aggettivo, e alcuni giornalisti, quando si riferiscono agli esponenti del neoconservatorismo americano, o alla pletora dei loro imitatori europei, formano il plurale come esige la grammatica inglese e scrivono neocons. Ormai la moda si è appropriata di tutto ciò che è neocon o che aspira a esserlo, vuole farci credere che esista ben poco di teorico e di praticabile al di fuori del marchio neocon, rende così intrinseca alle nostre esigenze umane e civili la visione neocon del mondo, che solo per un ghiribizzo da pedante si possono rievocare le circostanze in cui le parole neoconservatism e neoconservative irruppero nei media degli Stati Uniti. I responsabili morali dell’irruzione si affrettarono a spiegare che quelle parole non attestavano un semplice rinnovamento nella dinamica del conservatorismo americano, come suggeriva il prefisso neo-, ma un evento di portata molto più vasta, addirittura epocale, al punto che ritenevano legittimo parlare di Neoconservative Revolution. L’opinione pubblica non fece molto caso all’ossimoro che l’evento epocale recava in sé. Il termine “rivoluzione”, nonostante alcuni storici fallimenti della sua applicazione pratica, ha ancora un certo fascino romantico, è semanticamente duttile, perfino “trasversale”, ed è per questo che può continuare ad attribuire titoli di intraprendenza e creatività a chi ne fa la propria bandiera. All’inizio degli anni Ottanta i media inglesi si compiacquero di battezzare con il nome di “Rivoluzione conservatrice” il programma politico di Margareth Thatcher che governò dal 1979 al 1990. Ovviamente non ci fu alcuna rivoluzione, non si sovvertirono le istituzioni del Regno Unito. Il cambio della guardia nel palazzo del potere non dovrebbe essere chiamato “rivoluzione” quando il partito che assume la guida del paese ha già governato in un passato abbastanza recente e mantiene invariati il programma e l’orientamento ideologico, sia pure con qualche adattamento ai tempi... Non dovrebbe, ma, come dicevo, la parola ha il suo fascino, e perPoliscritture/Storia adesso tanto “funziona” propagandisticamente più di qualsiasi termine corrispondente a verità. Dopo quella della Thatcher ci furono altre due clamorose riconquiste del potere da parte dei conservatori: una si realizzò grazie al senatore repubblicano Ronald Reagan che diventò presidente degli Stati Uniti nel 1980, dopo la parentesi democratica di Jimmy Carter; l’altra fu quella del Partito Repubblicano, sempre degli Stati Uniti, che nelle elezioni di medio termine del 1994 ottenne la maggioranza nella Camera dei Rappresentanti e nel Senato, dopo 40 anni di attesa nella prima e 8 anni nel secondo. Ambedue le riconquiste furono salutate come “rivoluzioni”, e poiché sia gli artefici della prima (che erano i grandi elettori di Reagan), sia gli artefici della seconda (che erano i “cervelli” del Partito Repubblicano) non volevano più essere chiamati conservatori bensì neoconservatori, sia all’una che all’altra si applicò l’etichetta di “Rivoluzione neoconservatrice”. Probabilmente Ronald Reagan si considerava un conservatore “puro e duro” e non sentiva il bisogno di farsi precedere da un neo-, però si adeguò. Ma era appropriato il termine “rivoluzione” per le due riconquiste? E soprattutto: era giustificato il prefisso neo- per i conservatori che le realizzarono? Il termine “rivoluzione” si impose entrambe le volte perché il Partito Repubblicano e i milioni di cittadini che condividevano il suo programma credevano di fare qualcosa di rivoluzionario mettendo al bando - tramite la politica di un presidente nel primo caso, e del Congresso nel secondo - il sentimento laico della vita, il femminismo, il controllo statale sull’economia, il concetto ecologico di sopravvivenza, le rivendicazioni imperniate sull’egualitarismo, e tutto quel complesso di ideologie e comportamenti sessantotteschi che in qualche modo aveva “rivoluzionato” (qui il termine è appropriato) la vita e la visione del mondo di tante persone e aveva influito anche sulle scelte politiche (una fra tutte: la ritirata dal Vietnam). Normalmente non siamo propensi a chiamare “rivoluzione” fenomeni come l’amplificazione del nazionalismo, dell’individualismo, del fondamentalismo religioso, del tradizionalismo, della discriminazione sessuale e razziale ecc. Semmai, in questi casi, dovremmo usare il termine “controrivoluzione”, riconoscendo come rivoluzionari rispetto alla tradizione statunitense il pacifismo dei “figli dei fiori”, la politica del welfare e l’estensione dei diritti civili alle minoranze emarginate. Oppure potremmo parlare di “restaurazione”, e questo è il termine che più si attaglia al ritorno dei conservatori al potere. Lo chiama restaurazione, infatti, Juan-Ramón Capella nella sua ricognizione delle fasi caratterizzanti della seconda metà del secolo scorso, anzi, considerando che si è trattato di un fenomeno con implicazioni internazionali, Pag. 61 non esita a classificarlo come “Grande Restaurazione”1. Dunque, non era il caso di scomodare il termine “rivoluzione” per indicare una semplice riconquista del potere e una applicazione dei vecchi metodi di governo, sia pure con più aggressività, da parte di chi nel frattempo non aveva rinnovato radicalmente, né tanto meno “rivoluzionato”, il proprio orientamento ideologico-politico. Ma sia chiaro che la retorica del nominalismo può sempre essere tirata in ballo per giustificare l’uso improprio di un termine. Anche del prefisso neo-. Il termine neoconservative esisteva come neologismo inerte in qualche dizionario. Chi involontariamente gli diede una vitalità duratura fu Michael Harrington, che nel 1973, in un articolo su “Dissent” (rivista liberal di New York), lo usò per bollare idee e atteggiamenti di alcuni intellettuali allontanatisi dalla sinistra liberal del Partito Democratico. Vitalità duratura perché a quei transfughi il termine piacque e ne fecero la propria divisa. Però di nuovo c’è gente, a detta di Francis Fukuyama, che lo usa come insulto. La paternità del neoconservatism spetta soprattutto a Irving Kristol. Secondo lui, il neoconservatorismo è la prima variante del conservatorismo che sia pienamente conforme con il “carattere americano” (American grain)2, che è un carattere fortemente anticomunista, fortemente filocapitalista, fortemente antistatalista, fortemente tradizionalista e devoto al culto della proprietà privata, della famiglia e della patria. Dice questo come se la Vecchia Destra (Old Right) avesse elaborato, a suo tempo, un conservatorismo conforme al “carattere” dei tedeschi o dei francesi, o come se in precedenza il carattere degli americani fosse stato debolmente anticomunista, debolmente filocapitalista, debolmente antistatalista ecc. Dice anche che il neoconservatorismo non è un movimento ma “una ‘persuasione’, che si manifesta di tanto in tanto, ma in modo discontinuo, e il cui significato profondo viene compreso solo in retrospettiva”. Tradotto in parole meno alate, il neoconservatorismo americano è una rete articolatissima di ideologi, accademici, leader sindacali, opinionisti, lobbysti, dirigenti politici, che si adattano mimeticamente ai più svariati contesti per diffondere “una ideologia di destra piuttosto raffinata, gratificante per le élite e comprensibile per le masse”3. Su questioni marginali possono essere in contrasto gli uni con gli altri, così come possono essere differenti le elaborazioni programmatiche dei vari think tank (“serbatoi di pensiero”) a cui fanno capo, ma ciò che conta è che tutti perseguano gli stessi scopi. 1 Juan-Ramón Capella, La nuova barbarie. La globalizzazione come controrivoluzione conservatrice. Dedalo, Bari, 2008, p. 151. 2 Irving Kristol, The Neoconservative Persuasion, The Weekly Standard, Volume 008, 25 agosto 2003; trad. it.: Irving Kristol spiega chi sono i neocon, Il Foglio, 19 agosto 2003; cfr. Irving Kristol, Neoconservatism: The Autobiography of an Idea, The Free Press, 1995, trad. it.: Neoconservatorismo: autobiografia di un’idea, Nuove Idee, Roma, 2005. 3 Mario Proto, I due imperi. Ideologie della guerra tra modello prussiano e neoconservatorismo americano, Lacaita, Manduria-Bari-Roma, 2005, p. 224. Poliscritture/Storia adesso Nella seconda metà degli anni Sessanta, prima ancora di chiamarsi “neoconservatori”, i transfughi dal Partito Democratico già elaboravano delle strategie finalizzate a influire sulla opinione pubblica e sulle decisioni del governo. Le elaboravano su invito delle organizzazioni che avevano allestito i think tank, e queste erano la Rockefeller Foundation, la Hoover Institution, la Ford Foundation, la Heritage Foundation, l’American Enterprise Institute ecc., ossia entità create dalle massime corporation affinché, sotto la copertura di attività culturali e benefiche, preparassero con la dovuta lungimiranza i piani per il dominio del mondo da parte della economia americana, dominio che doveva essere conquistato provocando il crollo della Unione Sovietica e inducendo i governi dei paesi amici a non porre limiti alla libera circolazione delle merci e dei capitali. Per raggiungere più in fretta tali obiettivi David Rockefeller fondò nel 1973 la Trilateral Commission, che doveva rendere più stretti i legami politici ed economici fra i tre blocchi del mondo occidentale, cioè fra Stati Uniti, Europa e Giappone, con il fine - stando alla sua storica precisazione - di “sostituire la sovranità dei popoli con una élite mondiale di tecnici e di finanzieri che governi nell’ombra”4 . Il progetto della futura globalizzazione nacque da lì. I neocon della prima generazione non erano nati conservatori. Erano stati giovani negli anni Trenta e le loro simpatie erano andate al New Deal, al sindacalismo battagliero, in qualche caso alla rivoluzione permanente propugnata da Trotzky, o alle tesi marxiste di un suo amico, Max Shatchman. Le conversioni dagli ideali superprogressisti al superconservatorismo furono determinate dalla insoddisfazione per la politica degli anni Sessanta, giudicata troppo accondiscendente nei confronti dell’Unione Sovietica, troppo tollerante nei confronti dei ribellismi pre e post sessantotteschi e inefficiente nel Vietnam. Parallelamente alla conversione ideologica ci fu la adesione, pur con qualche differenza tra adepto e adepto, alle teorie di tre patriarchi del liberismo novecentesco: Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek e Milton Friedman. I primi neocon liberatisi dall’influenza di Max Shatchman passarono sotto quella di Leo Strauss, un filosofo dell’autoritarismo e dell’elitismo che insegnava nell’università di Chicago e avviava gli allievi più dotati a brillare nei think tank. Furono gli straussiani e i loro seguaci quelli che insistettero affinché si inasprisse la politica antisovietica. Tra l’altro affermavano che era necessario sostenere dovunque i governi di destra, compresi i regimi dittatoriali, perché erano baluardi sicuri contro il comunismo (ricordiamoci di Pinochet in Cile e di Marcos nelle Filippine). I neocon “sono un potente partito di intellettuali” scrisse Peter Steinfels nel 19795. Infatti, già allora potevano contare su centinaia di organizzazioni di simpatizzanti sparse per tutto il territorio. La prima dimostrazione della loro potenza fu l’elezione di un presidente come Ronald Reagan che garantiva l’attuazione di un pro4 Bruno Cardeñosa, El gobierno invisibile. Think tank. Los hilos que manejan el mundo, Espejo de tinta, Madrid, 2007, p. 86. 5 Peter Steinfels, I neoconservatori. Gli uomini che hanno cambiato la politica americana, Rizzoli, Milano, 1982, p. 14. Pag. 62 gramma preparato dai “cervelli” neocon della Trilateral Commission, della Hoover Institution, dell’American Enterprise Institute e della Heritage Foundation, al fine di contrastare, con il rilancio dei “valori tradizionali”, la cultura democratica dominante fin dai tempi di Franklin Delano Roosevelt. Al centro delle “proposte” neocon c’era una politica estera più aggressiva, il massimo di libertà per le imprese e campagne di spoliticizzazione delle masse6. L’amministrazione Reagan (1981-89) attuò una sostanziosa riduzione delle imposte dirette, la abolizione della progressività fiscale, e applicò il principio dello “Stato minimo”, cioè limitò il controllo statale sull’economia mediante una serie di provvedimenti che rientravano nella “filosofia” della deregulation lanciata dalla Scuola Economica di Chicago nel 1970 e in parte avviata da Carter. In conformità con l’esaltazione dell’individualismo e della libera iniziativa si ridussero i fondi per il Social Welfare State, ma il disavanzo e il debito pubblico non decrebbero, perché si provvide ad aumentare le spese per gli armamenti fino a cifre record. I neocon che facevano parte dello staff di Reagan premevano, in conformità con i disegni delle corporation, per una politica più spregiudicata in difesa degli interessi degli Stati Uniti. Il rispetto di tali interessi, aldilà della realpolitik alla Kissinger e di ogni possibile appeasement, doveva essere imposto al resto del mondo anche con la forza, e gli Stati dovevano essere distinti in “amici” e “nemici”, con l’implicito avvertimento che contro i nemici ci si doveva sentire permanentemente in guerra. Inoltre era opportuno che in materia di politica estera e di armamenti l’esecutivo acquisisse maggiori poteri, sottraendo potere al Congresso, alle leggi esistenti, e in generale al “controllo dal basso”. Si applicava, insomma, con la formula di un “unitary executive”, il Führerprinzip di Carl Schmitt rimodernato da Leo Strauss. Con l’occasione si rivitalizzarono vecchi miti come quello dell’“eccezionalismo americano”, della “frontiera”, del “destino manifesto”, e così il neoconservatorismo, trasformato mediaticamente in “reaganismo”, si affermò come ideologia di massa (non a caso Reagan fu definito il “grande comunicatore”). Il passaggio di consegne dalla prima alla seconda generazione dei neocon si ebbe tra il 1994 e il 1997. Nel ’94 il candidato repubblicano Newton Gingrich presentò agli elettori il famoso “Contratto con l’America”, un programma politico totalmente liberista che consentì al Partito Repubblicano di riconquistare la maggioranza nel Congresso, come detto sopra, e di dichiarare definitivamente attuata la “Rivoluzione neoconservatrice”. Nel ’95 William Kristol (il figlio di Irving) fondò insieme ad altri e poi diresse “The Weekly Standard” (un settimanale finanziato da Rupert Murdoch), che fin dall’inizio entrò baldanzosamente in collisione con tutto ciò che si opponesse alle concezioni neocon. Nel ’97 lo stesso Kristol, assieme a Wolfowitz, Cheney, Rumsfeld, Perle e altri, costituì il gruppo del Project for the New American Century il cui obiettivo era rendere operante a tutti gli effetti la leadership mondiale degli Stati Uniti. La seconda generazione proclamò che era arrivato il momento di consolidare il trionfo degli ideali america6 Juan-Ramón Capella, op. cit., p. 169. Poliscritture/Storia adesso ni, riconosciuto ormai dal mondo intero dopo il crollo dell’Unione Sovietica, mediante nuove dimostrazioni di forza, e in breve tempo riuscì a far accettare dalla maggioranza dei cittadini il rifiuto di ogni ipotesi di pacificazione, dimostrando che non la pace, bensì le guerre avrebbero garantito la loro sicurezza. Ora che non c’è più il pericolo di uno scontro frontale con una potenza dotata di forze pari o quasi pari, non la guerra per reazione, come in passato, ma quella preventiva diventa il mezzo per tutelare gli interessi degli Stati Uniti. Dovunque si creino i presupposti per un conflitto tra Stati o si attui all’interno di uno Stato una politica “inaccettabile”, è dovere del governo degli Stati Uniti intervenire: dovere, non arroganza. Così si espressero, a nome dell’intero apparato neocon, William Kristol e Robert Kagan. Al fine di evitare fraintendimenti Michael Ledeen, ex eminenza grigia fluttuante per la Casa Bianca dai tempi di Reagan agli attuali, condensò il suo pensiero in questa frase: “The best democracy program ever invented is the U.S. Army” (“Il miglior programma di democrazia mai inventato è l’Esercito degli Stati Uniti”). C’è stato un crescendo nella aggressività dei neocon: durante la Guerra Fredda avevano dovuto raffreddare il proprio bellicismo dato che l’orientamento prevalente era favorevole al rispetto delle regole, ma dal crollo dell’Unione Sovietica in poi non si stancarono mai di ripetere che bisognava instaurare un “nuovo ordine mondiale” (espressione coniata dal presidente Bush Sr.) e bollarono come “paleoconservatori” e “pessimisti di professione” i conservatori liberali che ancora ritenevano doveroso rispettare le “convenienze” vigenti nell’ambito dei rapporti fra gli Stati. Nuovo ordine mondiale significa che agli Stati Uniti compete la “responsabilità” di agire militarmente, con o senza il beneplacito dell’ONU, per instaurare regimi formalmente democratici dovunque sia possibile e debellare gli “Stati canaglia”. Significa che il multilateralismo, nonostante abbia garantito per decenni un certo equilibrio internazionale, deve essere relegato fra le strategie obsolete e che oggi non è “obiettivamente” concepibile altra logica che quella dell’unilateralismo: perché oggi gli Stati Uniti sono l’unica superpotenza: the lonely superpower7. Irving Kristol e compagni sostengono che il neoconservatorismo è un movimento diverso dal vecchio conservatorismo americano, e quindi nuovo, perché basato sul pragmatismo e non sul liberalismo utopistico caro ai vecchi conservatori. Ma le cose stanno davvero così? La loro azione, in conformità con quanto richiesto dalle corporation, tendeva a imprimere un indirizzo imperialista più deciso alla politica degli Stati Uniti, dato che tale imperialismo sarebbe stato la protezione più idonea per il mercato finanziario globale. E bisogna dire che hanno raggiunto lo scopo, essendosi inseriti nei posti chiave dell’amministrazione ai tempi di Reagan ed essendo riusciti a mantenervisi durante la presidenza Clinton. Però bisogna dire anche che sul piano ideologico i neocon non sono stati degli innovatori, non hanno 7 Samuel Huntington, The Lonely Superpower, Foreign Affairs, marzo/aprile 1999. Pag. 63 “superato” affatto le vecchie correnti del conservatorismo americano. Vediamo qual era la situazione fino alla seconda metà degli anni Sessanta, cioè fino al formarsi del primo “serbatoio” di neocon. Gli storici distinguono fra una Vecchia Destra conservatrice anteriore, e una Vecchia Destra posteriore alla I Guerra Mondiale. La anteriore era caratterizzata da un nazionalismo esclusivo, dal culto dell’”eccezionalismo americano”, dal tradizionalismo, dal fondamentalismo religioso, nonché da un orientamento libertarian (il libertarianismo è il liberalismo classico depurato da ogni ascendenza razionalista o illuminista e proiettato verso un antistatalismo estremistico). Dopo la guerra il conservatorismo diventò l’asse portante del Partito Repubblicano e poi, dal 1921 fino al 1933, della politica di presidenti come Warren Harding, Calvin Coolidge e Herbert Hoover. Sui principi base si innestò il mito dello sviluppo economico indefinito, che la crisi del ’29 provvide a demolire, però i conservatori insistettero nel loro arroccamento sui postulati del liberismo puro, quindi nel rifiuto dell’intervento statale nell’economia. Nel 1943, in piena guerra, fu fondato l’American Enterprise Institute per svolgere un’azione di contrasto al New Deal e difendere la libertà delle imprese. Nel 1944, Friedrich August von Hayek pubblicò The Road to Serfdom (trad. it.: La via della schiavitù, Rusconi, 1995) una requisitoria contro marxismo e socialismo e soprattutto contro la cultura liberal. Del libro si fece un riassunto che fu pubblicato nel “Reader’s Digest” e se ne vendettero milioni di copie. Hayek non ammetteva l’intervento statale neanche in una situazione catastrofica come quella generata dalla crisi del ’29: secondo lui il ruolo dello Stato deve consistere nel creare le leggi che agevolino la libera concorrenza, e basta. Illustri rappresentanti del pensiero conservatore furono Richard Weaver (1910-63), filosofo platoneggiante campione del tradizionalismo più intransigente, e Russel Kirk (1918-94), anche lui campione del tradizionalismo, oltre che dell’antiegualitarismo e dell’antiprogressismo (come risulta dalla sua opera più famosa: The Conservative Mind. From Burke to Santayana, 1953), tanto che sarà considerato il padre del neoconservatorismo culturale. Albert Nock (1870-1945) e Henry Mencken (1880-1956) furono per un trentennio la coppia libertarian più autorevole degli Stati Uniti, sostenitori dell’individualismo e dell’antistatalismo anche durante il New Deal. Grandissima diffusione ed enorme importanza per la divulgazione della visione libertarian del mondo ebbero negli anni Trenta e Quaranta i romanzi “filosofici” di Ayn Rand (alias Alyssa Rosenbaum, 190582), nei quali veniva esaltato l’individualismo e il diritto naturale in un’ottica anticomunista, antisocialista, antistatalista (uno di quei romanzi, We, the Living, del 1936, fu tradotto anche in Italia)8. Più accademico ma non meno importante per la formazione di intellettuali 8 Il titolo italiano è: Noi vivi, Baldini & Castoldi, Milano, 1938. Nel 1942 il regista Goffredo Alessandrini ne trasse un film in due parti intitolato: Noi vivi - Addio Kira, che doveva fungere da supporto alla propaganda antisovietica. Era in corso la Campagna di Russia. Poliscritture/Storia adesso e politici conservatori fu Murray Rothbard (1926-95), un altro strenuo difensore del diritto di proprietà illimitato, di una economia del libero mercato integralmente anarchica, di un antistatalismo spinto fino al punto di accusare lo Stato di “ladrocinio” non solo quando impone tasse, ma anche quando batte moneta e gestisce la banca centrale: è considerato l’ideologo del moderno libertarianismo. Non meno significativo fu Robert Taft (1889-1953), che concorse per la nomination di candidato del Partito Repubblicano nelle primarie del 1940, del 1948 e del 1952, e che è riconosciuto come il principale ideologo del conservatorismo americano moderno: propugnava l’antistatalismo, l’individualismo, e la opposizione al welfare e al sindacalismo. Grande importanza per il pensiero conservatore ebbero le riviste “National Review” e “Modern Age”, fondate rispettivamente nel 1955 e nel 1957, che contribuirono a preparare le nuove generazioni di conservatori. Una roccaforte del conservatorismo anteriore e posteriore alla II Guerra mondiale fu la Hoover Institution on War, Revolution and Peace, fondata nel 1919 da Herbert Hoover, il futuro presidente. Si impegnava in una costante propaganda per rivendicare il massimo di libertà per l’economia e il minimo di potere per lo Stato. Altrettanto faceva la Fondazione Rockefeller che era stata creata sei anni prima della Hoover, e che si era distinta per i suoi interventi filantropici come la lotta contro la tubercolosi, il tifo, la febbre gialla e la malaria (per combattere la malaria fu presente anche in Italia nel periodo fascista). Nel 1960 Frank Meyer scrisse: “Negli ultimi anni il pensiero conservatore è cresciuto e si è diffuso in America più che nell’ultimo secolo”9. L’anticomunismo dei vecchi conservatori non ammetteva cedimenti e fu bellicoso già prima della II Guerra Mondiale, ma ancor più dopo, quando esigeva da ogni presidente che esacerbasse gli scontri con l’Unione Sovietica o vincesse quotidianamente la Guerra fredda. Da quel tipo di anticomunismo si originò la famigerata caccia alle streghe del senatore repubblicano Joseph McCarty, che tra il 1950 e il 1954 fece della “paura rossa” lo strumento della persecuzione nei confronti di ogni essere umano sospetto di filocomunismo. Negli anni kennedyani il conservatorismo non venne mai meno, anzi poté vantare nel senatore repubblicano Barry Goldwater il suo grande campione, da molti considerato il fondatore del conservatorismo moderno. Tanto fondatore non fu, perché non c’era alcun bisogno di rifondare un sistema di idee già compiutamente stabilizzato, ma propulsore lo fu senz’altro, nonostante il suo insuccesso nelle elezioni presidenziali del 1964, quando fu battuto clamorosamente da un Lyndon Johnson favorito dall’essere stato il vice del martire John Kennedy. Era un liberista estremista, proponeva una drastica limitazione del welfare, la riduzione delle imposte, la abolizione della progressività fiscale, la abrogazione delle leggi che consentivano il controllo dello Stato sulla economia: proponeva tutto ciò in nome del diritto naturale di arricchirsi 9 Frank. S. Meyer, Only Four More Years to 1964, National Review, 3 dicembre 1960, cit. in Giuseppe Mammarella, Liberal e conservatori. L’America da Nixon a Bush, Laterza, Bari, 2004, p. 31. Pag. 64 o di difendersi da soli dalla povertà e dal bisogno. Era ovviamente un tradizionalista, esaltatore prima di tutto dei principi di patria e famiglia, e anticomunista viscerale, così come visceralmente era contro l’estensione dei diritti civili e contro l’emancipazione delle donne e delle minoranze di colore. L’Unione Sovietica era il suo incubo, ma lo era anche per tutti i gruppi della Vecchia Destra, i quali sollecitavano costantemente ulteriori sforzi per accrescere gli armamenti. Logicamente avevano diviso il mondo in Stati “amici” e “nemici”. In conclusione, tenendo conto di tutti i “contributi” offerti dai vari personaggi alla causa del conservatorismo prima del 1970, appare chiaro che quanto i neocon teorizzarono e affermarono in seguito non costituisce una novità né una innovazione, ma solamente un ricalco di quanto era stato teorizzato e affermato in precedenza. Pertanto la Nuova Destra neocon altro non è che una versione aggiornata della Vecchia Destra posteriore alla I Guerra mondiale, che era già di per sé antistatalista, antidirigista, antikeynesiana, antiwelfare, antimodernista, antifemminista, tradizionalista, sessuofobica e profondamente fondamentalista per tutto ciò che riguardava la patria, la famiglia e la religione. Insomma, cambiano i nomi ma la sostanza, anche se viene presentata sotto una nuova forma, rimane pressoché la stessa: ciò comincia a essere riconosciuto anche da alcuni neocon, segno che si sentono sicuri nelle posizioni conquistate. I più coscienziosi già non gradiscono più che li si chiami neocon. Dunque il neoconservatorismo non ha elaborato nulla di nuovo? Non ha nulla di nuovo da esibire nell’ambito della realtà politica americana? O. Garbin, L’aquila prigioniera Sì, qualcosa ha elaborato, che però non ha nulla a che fare con il concetto di conservazione. Il nuovo che può esibire è la enunciazione di un presunto diritto degli Stati Uniti alla guerra preventiva in difesa degli interessi degli Stati Uniti o con lo scopo di prevenire ipotetiche guerre future. Nuova è anche l’enunciazione del principio secondo il quale gli Stati Uniti devono essere liberi di agire secondo la propria visione del mondo, all’occorrenza prescindendo dall’ONU e da qualsiasi convenzione internazionale, perché sono l’unica superpotenza, e ad essa spetta esercitare l’egemonia. Che è una “benevolent hegemony”, a detta di William Kristol e Robert Kagan10. 10 William Kristol, Robert Kagan, Toward a Neo-Reaganite Foreign Policy, Foreign Affairs, luglio/agosto 1996. Poliscritture/Storia adesso Pag. 65 5 Zibaldone i cantieri aperti della scrittura Figure dolenti Galleria di ricordi tra racconto e riflessione stò per terra immobile diversi minuti con noi, intimoriti, a cercare di prestargli soccorso. Poi arrivò il padre e il fratello più grande. Donato Salzarulo In seguito seppi che si trattava di crisi epilettica. In seguito, andato via da più di un decennio dal paese, seppi della morte di Michele. Non so se per epilessia o per qualche sua complicazione. Oggi mi pare che per questa malattia non si muoia e che il “mal caduco”, come popolarmente si chiamava una volta, è tenuto abbastanza sotto controllo dai farmaci. Credo si chiamasse Michele. Aveva un anno o due più di me. Si era adolescenti. A Michele ho sempre ripensato, quando ho avuto in classe alunni epilettici, quando ho acquisito parenti dichiarati sofferenti di questo male, quando un po’ di anni fa ho letto L’idiota. Dostoevskij soffriva di epilessia e come lui il principe Myškin, eroe del romanzo. O. Garbin, Piazza del convento Stavamo un giorno affacciati sul parapetto di piazza Convento, quella che, come la siepe leopardiana, apre allo sguardo l’ultimo orizzonte. Si stava lì a godersi il pomeriggio di sole appenninico, quasi in silenzio o raccontandosi, come spesso si faceva, donne e sogni. Un urlo ci colpì. E due secondi dopo vedemmo Michele crollare per terra e il suo corpo farsi elettrico, tremare, sbattere, sussultare. «Tenetegli la testa, tenetegli la testa» ingiunse una voce adulta proveniente dalla panchina sotto il tiglio della piazza. «Tenetegli la testa… Potrebbe farsi male». Ma noi si era paralizzati, terrorizzati. Una manciata di secondi ancora e quel corpo in preda a se stesso, alla sua crisi si calmò. Il viso pallido, funereo. All’angolo delle labbra una striscia di bava. Re- Poliscritture/Zibaldone La malattia irrompe nella quotidianità, è dentro. Da ragazzi si stava in bande. A scuola terminata, bel tempo o maltempo, si andava per le strade a sfidarci, a lanciarci sassi, a bussare alle porte, a rovesciare conche d’acqua piovana raccolta dai canali, a giocare al piattello, a figurine, a salta la cavallina. Tra di noi, ai margini, si aggirava un mio omonimo. Ben più grande, però. Sui vent’anni forse. Non frequentava quelli della sua età, ma non frequentava neanche noi (come avrebbe potuto?). Ciondolava silenzioso, guardando furtivamente, orecchiando. A volte si allungava sui sedili, su un parapetto di muro, sulle scale di una loggia. Inoperoso come un buono a nulla. Parlava spesso da solo. Qualche volta qualcuno lo mandava a riempir barili alla fontana. E lo si vedeva trascinare litri d’acqua sulle spalle. Non era cattivo, ma noi lo rendevamo tale. Quando lo vedevamo aggirarsi disadattato tra l’una e l’altra età, col cranio rasato a zero, cominciavamo a prenderlo in giro, a chiamarlo col suo nomignolo, a tirargli sassi. E lui ci rincorreva, ci minacciava, ce ne diceva di tutti i colori. Un po’ paura di lui ce l’avevamo, un po’ ce la procuravamo. Donato col suo pantalone di tela e la giacca scura e sdrucita faceva da spettro alla nostra fanciullezza. Un giorno non l’abbiamo visto più. «L’hanno portato ad AverPag. 66 sa, al manicomio.» dicevano concordi le voci del paese. Quando a Torino, tra il ’67 e il ’68, tra l’occupazione di Palazzo Campana e il primo esame di pedagogia generale, ho letto alcuni libri di Laing, mi sono chiesto di cosa soffrisse il mio omonimo. Io diviso? Psicosi? Schizofrenia? Boh. Donato non mi sembrava così pericoloso da dover essere rinchiuso. Cosa era successo? Cosa aveva fatto di tanto grave? Boh. Forse avevamo voluto semplicemente togliercelo dall’anima. A legge Basaglia approvata, col decreto di chiusura dei manicomi, tornando in vacanza al paese, ho spesso sperato di rincontrare il mio sfortunato omonimo. Nulla. Una voce un giorno mi disse che aveva dei parenti in Puglia. Forse stava lì. O forse era morto. Non posso testimoniare. Non ho visto coi miei occhi. Il racconto, però, mi è stato fatto da gente fidata: mio fratello, mia sorella, mia madre, mio padre…Erano lì, erano in casa. C’erano anche zio Antonio e zia Maria. Lo facevano spesso, dopo cena. Si raccoglievano intorno al camino per chiacchierare, spettegolare, litigare. Io avevo altre esigenze ed ero a caccia di sguardi femminili nella piazza del paese. Tornando a notte fonda, ad occhi e mani vuote, come quasi sempre accadeva, mia madre che riordinava: «Figlio mio, non puoi immaginare cosa è successo stasera!...Tua zia!...La sarta!...Due uomini non riuscivano a mantenerla. Urlava come una pazza contro di me. Rossa in faccia. Invasata. Completamente invasata. Coi capelli che ognuno se ne andava per i fatti suoi. Ha avuto una crisi.» La zia sarta era una cugina di mia madre. Sposata a un calzolaio, non aveva potuto coronare il suo sogno di maternità. Ce l’aveva così con tutte le donne, soprattutto le parenti, che di figli ne avevano almeno tre e non erano certo più “intelligenti” di lei. Su questo punto la zia non transigeva. L’intelligenza ce l’aveva tutta lei e lei poteva fare ben altro che la sarta, se…Insomma, delirava un po’. E siccome sembra che torni a piovere dove già piove, la zia, oltre alla sfortuna di non avere figli, visse la tragedia di un unico fratello morto in Germania ancora giovane e in circostanze tutt’altro che chiare. Il corpo fu ritrovato in un lago e non si capì se ci finì coi suoi piedi accidentalmente o intenzionalmente. Si congetturò anche che qualcuno ce l’avesse spinto. Con la sua morte lasciò una vedova e un figlio. Come si può immaginare il pargoletto venne risucchiato dalla zia. Ecco, la malattia ha questa capacità di risucchiare. Per questo probabilmente la si teme. Quale fosse la diagnosi per la zia non so. Quasi certamente quella sera in casa nostra ebbe una crisi psicotica. Fu ricoverata in una clinica ad Avellino. In quelle camere tornò, mi pare, altre volte, quando la sofferenza e il dolore dell’esistenza l’avvolgevano in un vortice. Finché abitava nella piazza del paese, sempre, nel periodo delle vacanze, andavo a salutarla. Di lei, dei suoi occhi guardinghi e stralunati, del suo passo felpato, della sua figura bassa e fragile, non ho mai avuto paura. Poliscritture/Zibaldone L’ho guardata, invece, sempre con attenzione e affetto, curiosità e gentilezza. Soprattutto dopo l’ingestione di testi psicanalitici e di “anti-psichiatria” consumatasi a partire dal movimentato anno torinese. La zia ora è morta. In famiglia ogni tanto ne parliamo. È quasi inevitabile quando vediamo il suo unico nipote, nostro parente, anche lui ormai cinquantenne e orfano ormai di tutti (padre, madre, zia), passeggiare sulla piazza del paese. Solo, non sposato e ovviamente senza figli. Ogni tanto scherzo con mio fratello e mia sorella. «Stiamo attenti – dico – in famiglia abbiamo una bella riserva di folli, sia sulla linea materna che su quella paterna». Infatti, oltre alla zia sarta, un’altra cugina di mia madre è ricorsa di tanto in tanto alle cure degli “psi”. Avevano lo stesso nome. Ma per il paese era “la rossa”. Inutile dire che penso al Verga di “rosso malpelo” e che lo stigma se lo portava già nel nomignolo. Poi abitava vicino al cimitero. Da bambini, quindi, doppia paura. Meno male che mia madre non era una grande frequentatrice di tombe e le capitava di portare un lumino sulla lapide di suo padre, morto relativamente giovane, soltanto in occasione della ricorrenza annuale. Allora ci teneva e dovevamo andare con lei. Impossibile non fermarsi a casa della zia. Nel quarto d’ora di conversazione ci tenevamo ben stretti alle sue ginocchia. Del resto era stata proprio lei a metterci in guardia sull’imprevedibilità dei comportamenti della cugina. Se devo dire quel che penso, mia madre esagerava. La zia era a mio parere innocua. Indubbiamente segnata. Nubile, forse senza amori. A disagio nella sua esistenza o nel suo stato sociale. Il paese poi sapeva essere istituzione totale. Per cui la zia, avendo avuto la madre fuori di sé per il figlio morto in Russia e altre tragedie, non poteva non essere anche lei un po’ fuori di sé. Tra le famiglie si facevano strani ragionamenti sulle eredità delle malattie. Se ti capitava di appartenere a una “famiglia di pazzi” eri messo piuttosto male. Il pregiudizio funziona sempre. Anche oggi la pressione contro la legge 180 e la richiesta di tanto in tanto sbandierata di riapertura dei manicomi si nutre più di pregiudizi che di argomenti razionalmente fondati. La follia non sta di casa soltanto tra i folli dichiarati tali. E ve ne sono di diverse specie. Quella delle zie era, tutto sommato, innocua. Quella di certi capi di stato, invece, andrebbe forse più denunciata, contenuta, bloccata. Comunque, questa era la linea materna. Sulla paterna, c’è la storia di zio Cecco, la birba di famiglia. Il giorno che doveva sposarsi mia nonna andò a ritirarlo in una cantina. Se ne era dimenticato. Il matrimonio, si dice, è la tomba dell’amore e forse mio zio non voleva cascarci. Peccato che non animasse solo sequenze di questo tipo che oggi potrebbero apparire, per certi versi, simpatiche. Nel suo corpo germogliavano aggressività varie, violenze, azioni nocive e insopportabili. Fu meno fortunato delle zie. Finì in manicomio. Ero ancora bambino quando la sua esistenza si concluse. Ammetto: la follia piace ai romantici. C’è chi sostiene Pag. 67 che vada a braccetto con la genialità. Può darsi. Ma quando una mattina del 1978, varcato il cancello della scuola in Viale Lombardia, mi vedo venire incontro il custode allertato: «Attento! – mi dice – in Direzione, c’è uno che pensa di essere il vero direttore», beh, in questi casi, un brivido percorre il tuo corpo e non pensi più agli aforismi, ai giudizi, alle tesi più o meno fondate. Che faccio? La scuola è tutta in allarme. Dalle aule viene un mormorio, una finta indifferenza, un tramestio di maestre che provano a tener buoni i bambini e a continuare la lezione. Il compagno di viaggio è una persona alta e allampanata. Sedendosi, continua a ripetere quei versi di una pubblicità dell’epoca, se non sbaglio. Ha in testa un copricapo alla Napoleone e indossa un vestito sbrindellato. Da dove sbuca questo?!...Accidenti a lui! Certe volte si è egoisti non per partito preso. Semplicemente perché qualcuno ci fa saltare, con la sua sola presenza, il nostro piccolo o grande piano. «Ooliooo cuooore!...Si beeevee con amoooree!» «Oh, buongiorno! – dico – come va?». L’uomo sulla quarantina, in giacca e cravatta, installato alla scrivania, neanche mi sente e continua a dare ordini all’applicato che gli sta di fronte. «Io sono il direttore!...Io!...Non quel coglione!. Quello è un usurpatore, in combutta col Provveditore…Questo posto è mio!...E tu stai zitto e obbedisci!..» Non risponde. Dopo pochi minuti di silenzio e di sguardo mio ben rivolto al suo, si alza e se ne va. Ci rimango male. Ormai m’ero distratto e incuriosito. Parlare un po’ con lui non mi sarebbe dispiaciuto. Avevo probabilmente commesso qualche errore. Forse lui poteva pensare di essere Napoleone, io dovevo considerarlo, invece, soltanto una persona. Come si fa a non obbedire? Così io e Nino, l’applicato, cerchiamo di conservare la calma, ingiungendoci con gli occhi il sangue freddo. Presidiamo intanto le porte; che non gli venga voglia di recarsi nelle aule; che si limiti a parlare con noi. Proviamo a capire. Ma c’è poco da capire. La canzone è sempre la stessa. Quel posto di direttore è suo e il titolare glielo avrebbe soffiato. Ascoltare e dialogare con chi sta male e soffre non è facile. Si va avanti così per una decina di minuti. Poi arrivano due infermieri. Non appena li vede, li riconosce e si alza. Non fa resistenza. I due lo chiamano per nome, lo prendono sottobraccio e lo portano via. Successivamente veniamo a sapere che abitava nel palazzone di fronte alla scuola, che era un emigrato, che viveva solo. Scherziamo col direttore (io allora facevo il vice): «Usurpatore di posti!...». Racconta di averlo incrociato, in provveditorato, una sola volta in vita sua. «Ah, quindi, un legame c’è!...» Chissà quante volte quell’uomo s’era affacciato al balcone e aveva visto maestre e bambini entrare ed uscire. Chissà quante volte aveva immaginato di poter essere altro da quel che era, rimediando, magari, a qualche suo fallimento. Direttore per un quarto d’ora. Meglio che niente. Sessione d’esame autunnale. Mattina presto. Viaggio in una carrozza per Torino. Me la sono scelta vuota. Ho con me il pacco di libri. Ci sono capitoli da ripassare, pagine da tornare a leggere, mappe da ripercorrere, concetti da fissare. Frenetico ruminare della memoria. Ho lavoro e famiglia, politica e passioni. Studio negli intervalli. Che nessuno mi disturbi in carrozza! A nessuno venga in mente di rivolgermi domande o di accendere frammenti di conversazione! Il mio capo calato sulle pagine aperte sarebbe di per sé un segno di chiusura, di barriera. Così rannicchiato sul sedile e concentrato, sento una voce altissima provenire dal corridoio: «Ooliooo cuooore!...Si beeevee con amoooree!». La voce, mio Dio!, si avvicina. Entra, è finita!, nella carrozza. Poliscritture/Zibaldone «Come è andata la battaglia?», gli domando, «Quanti soldati sono morti?» Altre figure potrei “sistemare” in questa galleria. Conosciute personalmente o raccontatemi da altri: dalla mia alunna, in prima media, affetta da autismo alla madre depressa di un collega, dall’amico che in una crisi psicotica andò in giro nudo vicino alla Croce alla maniaca che raccoglieva carte per le strade fino a rimanerne sommersa. I vigili dovettero svuotarle l’unica stanza in cui abitava, un sottano, per il rischio elevato d’incendio. Poteva restarne bruciata. Giorni fa ho chiesto ad un amico poeta se avesse un contributo da proporre per questo numero di POLISCRITTURE sul “disagio”. Mi ha riposto, mica tanto scherzando, che, se volevo, poteva mandarmi la sua foto. Ecco, nella galleria, potrei mettere, oltre alla sua, anche la mia foto. Non solo per l’album di famiglia al quale ho accennato. Ma perché tutti soffriamo di malinconia e stati momentaneamente depressivi. Come evitare la morte di un nostro caro o di una nostra cara? Come non pensare alla nostra? Tutti manifestiamo manie, ingorghi psichici, indifferenze, invidie, rancori, nevrosi, stati schizoidi, paranoici, psicotici. Vorrei non aver nulla a che fare con Olindo e Rosa, i due rei quasi confessi di Erba. Giuridicamente non ho nessuna responsabilità per quanto è successo. Non c’ero neanche! Se televisione e stampa non mi tempestassero con le loro immagini fredde e assenti, non saprei nulla della loro esistenza. E, tuttavia, posso credere che il “funzionamento mentale” (cognitivo, affettivo, emotivo, neuronale ) di un folle e/o di un assassino sia così diverso dal mio? Se lo è, in cosa lo è? Dove, in quale punto, in quale momento, ogni storia si ramifica e singolarizza ed ognuno diventa un “caso” a sé? Perché Abele e perché Caino?... Domande da milioni di dollari si dirà. Argomenti inesauribili, buoni ad impegnare decine e decine di esistenze. Centinaia, migliaia. Però, noi siamo fatti così. Cerchiamo il senso. Non ci basta essere presenti in questo monPag. 68 do, respirare, percepire, nutrirsi, lavorare, riprodursi. Vogliamo chiarirci e spiegarci, afferrare e comprendere. Siamo affamati di significati. Vogliamo capire ciò che ci accomuna e ciò che ci divide, ciò che ci rende simili e ciò che ci differenzia. In fondo, anche un assassino ha una testa (magari, non ben fatta come la vorrebbe Morin), un cuore e uno sguardo (magari, di ghiaccio), una doppia circolazione sanguigna, un funzionamento digestivo, metabolico e neuronale. Anche un assassino vede, sente, percepisce, parla, immagina, sogna, pensa. Vorremmo che fosse mostro, omuncolo o ciclope proveniente da un mondo totalmente altro. Belva, ad esempio, o marziano non di Marte. L’estraneità spaventa e, nello stesso tempo, rassicura. In fondo non siamo degli Hitler, non siamo impiegati anonimi e banali della fabbrica dello sterminio. Sì, forse sì. Per certi versi, sì. Non lo siamo. Non possiamo dimenticare, però, che folli, assassini, aguzzini, sterminatori sono impastati con la stessa farina degli Abeli, appartengono alla stessa specie di homo sapiens e/o insipiens. Questo, per la biologia almeno, per le neuroscienze. La biologia molecolare ci rende astrattamente uguali, la storia concretamente ci divide, differenzia, distingue. L’un contro l’altro armati. Due anni fa, a fine marzo, visito il museo di Art Brut di Losanna. Il suo teorizzatore è Jean Dubuffet, artista e collezionista francese. Nell’anno torinese tra le mani mi era capitato un suo libretto, «Asfissiante cultura». Ma allora per me la cultura non era asfissiante e non ne ricavai granché. Ecco un altro pregiudizio: gli studenti del ’68 non erano contro la cultura. Erano contro l’autoritarismo e la cultura delle classi dominanti. Erano contro la maschera della “neutralità”. A Losanna riscopro Jean Dubuffet e la sua voglia di libertà e sovversione dei valori filosofici ed estetici dominanti. La cultura si fa asfissiante quando paralizza l’immenso patrimonio di creatività e intelligenza presente in ognuno di noi, quando blocca la forza dell’esistenza, la sua irriducibile base istintuale e “selvatica”. Il bisogno di espressione è incomprimibile. E, quando viene compresso, la malattia può dilagare meglio. I tantissimi normali, per lo più, soffrono d’impotenza creativa. Quante persone, dopo aver trascorso anni ed anni sui banchi di scuola, non prendono più in mano una penna, una matita, un libro? Quante persone si fanno prendere dal panico se devono scrivere un bigliettino d’auguri? A Losanna vado con un gruppo di studentesse e alcuni docenti dell’Accademia di Brera. Accompagno Lucia, la seconda figlia. Ha finalmente deciso l’argomento della sua tesi. Si concentrerà sulla vita e sulle opere di un artista “irregolare”, uno di quelli che Dubuffet amava: Aloïse Corbaz. Ha visto alcune sue tavole nel catalogo «Figure dell’anima. Arte irregolare in Europa» e ne è rimasta affascinata. È anche intenerita dalla storia d’amore di questa donna. Nata a Losanna nel 1886, a 27 anni, dopo essere stata costretta dalla sorella primogenita a rompere la sua relazione con un prete spretato, si trasferisce come istitutrice in Germania, nel castello Poliscritture/Zibaldone di Potsdam. Qui investe affettivamente, come si direbbe oggi, niente meno che sul principe Guglielmo II. Sogno d’amore fiabesco, ardente e impossibile. Quando per lo scoppio della prima guerra mondiale, torna a Losanna e vede il suo sogno crollare, comincia a dare segni di squilibrio, ad assumere comportamenti strani, a fare dichiarazioni visionarie e deliranti. Sostiene, ad esempio, di essere stata messa incinta da Cristo; va gridando per le strade che le stanno rubando il fidanzato. In breve, finisce in manicomio a trentadue anni e vi rimane fino alla morte. Tra quelle mura lotta per esprimersi. Comincia a disegnare, raccogliendo furtivamente carte tra le immondizie da scarabocchiare nel gabinetto, scrive pagine di una sua cosmogonia e attraverso un processo di proiezione permanente, sostituisce il mondo antico di un tempo che la nega con il suo universo immaginario, molto complesso e strutturato. Da vittima si trasforma in creatrice. Nel 1941, la dottoressa Jacqueline Porret-Forel va ad incontrarla nella saletta di stiratura del manicomio, diventata suo feudo. Ne rimane affascinata. Comincia a portarle regolarmente carta e matite colorate. L’ascolta, comprende la sua attività, raccoglie i frammenti della sua storia, ne parla e scrive. Per compilare la sua tesi, Lucia non può non studiare gli scritti di questa dottoressa. Uno per tutti, la monografia «Aloïse et le théâtre de l’univers» pubblicata dall’Edizione d’Arte Skira di Ginevra. Ma la figlia non conosce il francese. Dovrò tradurre per lei. Ecco, tra l’altro, perché sono a Losanna. «Dai, papà, perché non dici che questi argomenti piacciono anche a te!...». Edipismi? Probabile. Fatto sta che da oltre due anni finisco col leggere storie di matti diventati artisti e storie di artisti diventati matti. Buon ultimo, Adolf Wölfli. Pochi mesi fa è stato tradotto in italiano il libro di Walter Morgenthaler del 1921 centrato sulla opera di questo artista che non sapeva di esser tale. Acquistandolo (titolo:«Arte e follia in Adolf Wölfli», ALET, 2007), guardo a lungo, nel retro di copertina, la sua foto. La mano destra è alzata, con l’indice rivolto verso un suo quadro. Ha in testa un basco nero, i pantaloni tenuti su con le bretelle, rigirati fino al ginocchio. Una camicia senza colletto, bianca, a mezze maniche e dei calzettoni da contadino, di lana ruvida, ripiegati sulla caviglia. È ritratto nella cella in cui si trovava nel 1920. In primo piano, nell’angolo a sinistra dell’osservatore, la pila dei suoi quaderni. Totale: 25.000 pagine scritte fittamente, contenenti la sua autobiografia. Sulla colonna di fascicoli, in inchiostro rosso granato, il grafico ha sovrapposto un giudizio di André Breton: “L’opera di Wölfli è una delle tre o quattro più importanti del Novecento.” È possibile farsene un’idea guardando le 25 tavole poste al centro del libro. In appendice, la cartella clinica: «Ospedale psichiatrico Pag. 69 di Waldau. Numero di ricovero: 4224 D 3. NOME: Wölfli Adolf. Data di nascita: 29.02.64 [1864, ovviamente]. Stato civile: celibe. Professione: contadino. Paese di origine: Schangnau. Residenza: Berna. Domicilio: Carcere giudiziario, Bühlstr. 27, Berna. Indirizzo dei familiari: Ufficio del Giudice istruttore II, Berna Marzo 1922. Nipote: Rudolf Wölfli, fochista, Bellevue Palace, Berna. DIAGNOSI PROVVISORIA: Caso in fase di analisi. DIAGNOSI DEFINITIVA: Dementia paranoides. Ricovero: 3 giugno 1895. Dimissione: 6 novembre 1930», giorno della sua morte. Oltre alle 25.000 pagine dell’autobiografia, l’opera ciclopica di Sant’Adolf, come ad un certo punto comincia a firmarsi, comprende qualcosa come 1500 illustrazioni e 1560 collage. Racconto ad un’amica di Wölfli finito in manicomio, in totale isolamento, anche per alcuni suoi tentativi, non riusciti, di pedofilia: «Non parlarne – mi fa – non parlarne.» Il conformismo sociale è una cappa di piombo che avvolge ognuno di noi, è lo smog delle nostre anime. Quante volte, girando per le classi, inibisco manifestazioni d’affetto nei confronti dei bambini per paura che possano essere equivocate o male interpretate? Sono, come dubitarne?, dalla parte delle vittime non dei pedofili, delle stuprate non degli stupratori, degli oppressi non di chi opprime, degli assassinati non degli assassini. E, tuttavia, perché non abituarsi a valutazioni differenziate, a giudizi articolati? In fondo una persona non si esaurisce in un atto, in una scelta, buona o cattiva che sia. Una volta con termine forte, teologico, si diceva “redenzione”. In giurisprudenza mi pare si dica “ravvedimento”. L’importante è non schiacciare noi stessi e i nostri simili in un’identità-prigione, in una modalità di presenza che ci sottrae qualsiasi altra possibilità. Spesso ci imprigioniamo da soli e gli altri non fanno che rafforzare le sbarre invisibili edificate col nostro stesso contributo. Nella lista dei tuoi nemici, metti il tuo nome, recita, all’incirca, un verso di Fortini. Ogni tanto mi capita sotto gli occhi la cartella clinica di mia madre. Era una cardiopatica. Avevo quattro anni quando ebbe il primo scompenso. Lei ne aveva trenta. Mi ricordo bambino confuso e scombussolato dall’andirivieni di parenti e vicini di casa che si affollavano al suo capezzale. Mi tenevo stretto all’inferriata di un balcone con dei vasi di piante grasse pungenti, piangevo spaventato e chiedevo: «Cosa avete fatto a mamma mia!... Cosa avete fatto!...».Un medico le praticò un salasso, per fortuna superò la crisi, e il ricordo sbiadì. Avevo, però, ventitrè anni quando ebbe il secondo scompenso. Ricoverata d’urgenza, fu ripresa per un soffio. In una pausa, con gli occhi appena aperti e temendo forse di doversi congedare per sempre, chiese: «Ho fatto tutto quello che dovevo fare?...Mi sono comportata bene con voi?...Sono stata una brava madre?...». La rassicurammo. «Sei stata e sei bravissima!...Devi stare ancora qui con noi. ». Riconoscimento. Bisogno d’amore. Emozioni, affetti, pensieri che s’accendono quasi certamente con neuroni e sinapsi ma che hanno senso e significano qualcosa soltanto “tra”: nelle relazioni “tra” madre, padre e figli, “tra” amici e amiche, “tra” persone. In un luogo e in un tempo, in una comunità, in una società. In breve, in un mondo. G. De Vincenti, Il matto di Maduria “Tra” è anche tra sé e sé, tra lo spazio interiore, una sorta di teatro che giorno dopo giorno ci cresce dentrofuori, e il campo di relazioni fuori-dentro che manteniamo aperte, facciamo stagnare o chiudiamo. Chissà poi se chiudiamo davvero! Quante relazioni ci rimangono dentro in una specie di vita fantasmatica, spettrale. Relazioni fatte d’incontri visibili, con persone in carne e ossa (e non solo con esse), nutrite di parole, pensieri, fantasie, emozioni, immaginazioni, progetti più o meno realizzabili. Storie di vite interiori e di esistenze sociali. Probabilmente essere presenti a se stesso non significa nient’altro che porsi il proprio sé davanti e chiedersi quali possibilità si hanno. Questo vuol dire forse trascendersi, oltrepassarsi. Ci sono momenti, situazioni, eventi che possono mettere in crisi questa presenza di noi a noi stessi. Quando non si vede via d’uscita, quando ci si sente in trappola, quando ci crescono dentro vortici, spirali incontrollati, voci invadenti che non si riescono a tenere a bada. Poliscritture/Zibaldone Uscire fuori di sé è necessario. Se ho capito qualcosa, sono le modalità di uscita che possono diventare incontrollabili. O forse bisognerebbe dichiarare il proprio scacco fin dall’inizio. Il re è nudo, l’Io è nudo. Non è padrone in casa propria. Abbandonarsi con la propria zattera corporea agli eventi - che rappresentano il modo ora lieto ora minaccioso, ora prevedibile ora imprevedibile, attraverso cui il mondo si apre a ciascuno di noi Pag. 70 - e guidare-lasciarsi guidare tra derive momentanee e momentanei approdi. Tenere tra le mani il filo della propria esistenza è un lavorio quotidiano. “Mestiere di vivere” diceva Pavese. Era proverbiale. Se una donna, giovane o vecchia, mostrava un comportamento un po’ strambo: «E che sei diventata Maria la pazza?!...», si sentiva apostrofare. Abitava in una via per la Valle. La porta sempre aperta. Dovendo passare vicino, in quel punto, si diventava silenziosi e guardinghi, si buttava sospettosi l’occhio dentro, si valutava il pericolo. Maria vestiva, dicevano le voci, da zingara: gonne larghe e vivacemente colorate, camicie bianche e sbuffanti, grembiali frasche e foglie, fazzoletto in testa smeraldo, annodato sulla nuca. Questo, in un paese in cui prevaleva il nero delle vedove o il blu carbonella delle donne con mariti e figli. Se non era blu, era grigio o avana. In certe occasioni verde scuro. «Dove te ne vai così sfarzosa?!...». Lo sfarzo che le donne si rimproveravano poteva essere rappresentato da un vestito turchese o verde chiaro. Saranno pure stati anni di boom economico, ma i colori del nostro mondo erano freddi, scuri. Senza dire dei tanti papà, a volte con intere famiglie, costretti ad emigrare. Maria la pazza era imprevedibile, vociante, sbalestrata. Se la si vedeva arrivare alla fontana, col suo barile da riempire in perfetto equilibrio sul capo, le donne preferivano darle la precedenza. Per quanto possibile, la scansavano. La temevano persino gli uomini. Con qualcuno venne alle mani e portò per giorni il volto pieno di graffi. Aveva figli, e noi non si voleva essere nei loro panni; marito, e questo ci importava di meno. Anche se, ogni tanto, lo si immaginava, poveretto!, costretto a tacere e sopportare. Lui che andava quasi quotidianamente in campagna. Non ricordo se la situazione precipitò con la luce o col buio. Le voci dissero che minacciò con l’accetta marito e figli. O non minacciò soltanto. Addirittura provò ad affondarla nel corpo dei malcapitati. Raccontarono pure che se la portarono i carabinieri, a fatica. Finì dove in quegli anni finivano tutti gli strambi, i disadattati, i fuori di giro, i violenti. Di Maria non ho saputo più niente. Nessuno ha raccolto la sua storia. Poliscritture/Zibaldone Pag. 71 Nannìne. Reliquario materno Ennio Abate Figlie, hai raggione. Nì ncoppa spiaggia vicin’o mare, nì dint’o giardine chine r’ombre addurose e soreme Assuntine; e manche dint’a stanze e liette cue mobile e mogane, ca me facette frateme Vicienze o falegname, me putive purtà a murì. O munne e ‘na vote nun ‘ngera chiù; e o cirvielle mie perse nu vereve cae palazze re ricche s’erene mangiate e spiaggie, e geranie russe ro giardine erene bruciati e re ccose e casa noste parient’e mariuole, accuncianne e arraffane, s’erene regniute e borse. Sule dint’a chella pianura mai viste, addo te n’ire fuiute, dint’a ‘na città manicomie, fatte ra fatiche e chill’e ca po’ ngi finiscene chiuse, miezz’a chilli muri e nebbie, me putive purtà. E ie là te puteve lascià sule st’ombra mia, ca mò cresce e mò se fa piccirella; ma te vene arrete t’e chiama e t’e rice: a vite ca te riett’e puortale pe vvie chiù chiene e sole, ma nun te scurdà l’ombre, l’ombre ra morte mie. Poliscritture/Zibaldone Figlio, hai ragione. / Né sulla spiaggia / vicino al mare, / né nel giardino / pieno d’ombre odorose / di mia sorella Assunta; / e neppure nella stanza da letto / coi mobili di mogano, / che mi costruì mio fratello Vincenzo / il falegname, / potevi portarmi / a morire. Il mondo di una volta / non c’era più; / e la mia mente persa / non s’accorgeva / che i palazzi dei ricchi / avevano invaso / le spiagge, / [che] i rossi gerani / del giardino /erano bruciati / e [che] delle cose di casa / parenti avidi / riordinando e arraffando / s’erano riempite le borse. Soltanto in quella / pianura sconosciuta, /dove eri fuggito, / in mezzo a una città manicomio, / costruita con la fatica di quelli / che poi ci finiscono prigionieri, / in mezzo a quei muri di nebbie, / potevi portarmi. E io là / potevo lasciarti soltanto questa mia ombra / che ora s’espande / ed ora diventa minima; / ma ti segue / ti chiama / e ti dice: / la vita che ti ho dato / portala per vie più soleggiate, / ma non dimenticare / l’ombra, / l’ombra della mia morte. Pag. 72 “Ma chi è quel signore che mi sta sempre attorno?” Ornella Garbin Mia madre era “una ragazza degli anni Quaranta”, gli anni della guerra. Angela era romantica o le piaceva crederlo, alla fine della sua vita ha confessato di essere una pessimista, era vissuta facendoci credere il contrario, a nostro beneficio. È morta in casa, curata da noi familiari con tutta la tenerezza e la pazienza di cui siamo stati capaci, ma ogni tanto mi accuso di non esserlo stata abbastanza, paziente. Nel rapporto già complesso come quello fra madre e figlia, la malattia mentale (Alzheimer) senza una preparazione adeguata, può essere un elemento devastante. Tutto viene buttato all’aria, i sentimenti, la propria e l’altrui nozione d’essere, tutto ciò che si pensava di conoscere diventa caos e la fatica maggiore sta nel dover riordinare in continuazione questo caos. La malattia aveva in mia madre radici più lontane, ma vivendo con mio padre in un paese in collina, in un piccolo mondo conosciuto, la progressione era stata lenta e accettabile. Nel momento in cui le loro condizioni di vita erano diventate inaccettabili, soprattutto per l’alimentazione e l’igiene, ho dovuto prendere la decisione di farli tornare nella loro casa di città, vicino a me, che avevo la possibilità di aiutarli.( Fra l’altro anche mio padre era malato, del morbo di Parkinson). Continuo a dirmi che non c’erano altre soluzioni, le ave- vo vagliate tutte, ma questo trasferimento ha accelerato il deterioramento cognitivo di mia madre. Il cambiamento di ambiente, di abitudini, aumenta il senso di estraniamento proprio di questa malattia. La mancanza di memoria progredisce ampliando inesorabilmente il suo raggio. Ho avuto mia madre sotto gli occhi tutti i giorni e l’osservavo molto, capivo che dovevo imparare molte cose per poter affrontare le sue aggressività, (per fortuna solo verbali) e il suo spaesamento. La cosa più difficile era il dover sostituire la sua attività di casalinga, prima io da sola e poi con una badante, senza farla sentire inutile. La sua lotta quotidiana cosciente era con la perdita di memoria , inizialmente si aiutava scrivendo tutto,( amava scrivere, da ragazza racconti per riviste femminili, poi molte poesie), ho appena ritrovato grazie ad un trasloco diversi suoi quaderni e notes pieni di annotazioni giornaliere, su di una copertina c’è scritto: “Da conservare” e “Messaggio di tenerezza”e dentro, ad esempio: ”Sono stata in Ospedale a Melzo per 16 giorni…il viaggio di andata mi è costato 115.000…sono tornata con Marcello, Edmondo, Ornella.- Regalato a Pia fiori di seta e saponetta fatta con petali di Fiori.- Regalato poesie a Clementino.- Lauretta Masiero avuto un figlio da Gionni Dorelli.- Oggi 9 dicembre sono caduta in piazza davanti alla Patarini per la retromarcia di una macchina. Sembrava una cosa da poco invece ho dovuto chiamare il medico e ora ho molto male speriamo che vada tutto bene..” e più avanti:” ore 10 Il Signore della macchina mi ha Soccorso con gentilezza ma mi sembrava di non avere tanto dolore. Ora invece ho dovuto chiamare il Medico. A Federica ho regalato il libretto delle mie Poesie. Tutte le poesie sono nel terzo cassetto del comò.Bacia una bimba buona e una bimba vivace…ma non ritorna l’uomo dalla Fornace. Bacia una testa bionda e una testa nera ma non ritorna l’uomo della ferriera “ e così via, tutte le pagine sono piene della sua scrittura che pian piano andava perdendo forma , e l’insieme visualizza bene il suo stato mentale. Poi perse anche la capacità di scrivere, ripeteva ossessivamente tutto ciò che per lei era importante non dimenticare, ad esempio il nome dei suoi figli. Perfino sui rumori c’era la perdita di conoscenza,se non vedeva l’oggetto che li produceva, anche quelli più comuni, come il motore di una macchina per strada. Poi si dimenticò il nome di mio padre, e alla fine che era suo marito …ma questo fatto drammatico riuscì perfino a farci sorridere: “Ma chi è quel signore che mi sta sempre attorno ?” –detto con una punta di malizia femminile- “Ma è tuo marito, mamma…”- rispose: “Così vecchio…?! “ I sui racconti, i suoi ricordi, già da tempo simili a delle registrazioni, poco a poco cominciarono a cambiare… cambiavano i personaggi, si confondevano i ruoli. Ricordi dolorosi, come la morte di un giovane nipote, si trasformavano in racconti fantastici, o così grotteschi da risultare comici. Un altro aspetto curioso della malattia, il più piacevole, è stato per mia madre lo sblocco della voce, amava mol- Poliscritture/Zibaldone Pag. 73 to la musica e anche cantare, ma era stata da sempre considerata stonata, negli ultimi mesi invece aveva cominciato a cantare a voce chiara e ferma le canzoni della sua giovinezza ed infanzia, si ricordava perfino quelle dell’asilo…. ne fu veramente felice. Era una persona molto ordinata,per lei il senso dell’ordine, che appartiene alla sfera psichica, era diventato maniacale, come per contrastare il disordine mentale. Tutto doveva essere in fila, meglio se in numero pari e simmetrico. Richiedeva anche un ordine uditivo, una voce alla volta e non alta. Quando ho scritto per la prima volta un articolo, per una rivista medica, sulla sua malattia, mia madre era ancora viva, ora dopo sette anni dalla sua scomparsa, i contorni dell’esperienza sono cambiati, più sfumati, forse meno idealistici; allora la ringraziavo dell’esperienza di vita che mi offriva…poi però c’è stato l’ultimo terribile mese con il problema della piaga da decubito e la perdita della capacità, della sua straordinaria capacità di comunicazione, ma a dire il vero anche con la perdita del linguaggio, anche con lo scollegamento del linguaggio con la realtà, ci sono stati pochi ma importanti, preziosi momenti di comunicazione senza parole. Non posso provarlo con descrizioni esatte, ma sia io che mio fratello,e anche mio padre, abbiamo avuto dei momenti con lei di vero contatto, non siamo credenti, ma la parola più esatta forse è “fra anima e anima”. In ogni caso come scrivevo nel vecchio articolo, si trattava per me di ascolto con il cuore, credo di averlo imparato con lei e poi con mio padre, vissuto ancora cinque anni dopo di lei, gli ultimi due immobile in un letto , anche lui senza più parole. Balletto Mario Fresa Voglio dire che mi picchiano, i miei genitori, tutti e due, proprio adesso, me l’hanno dato: proprio uno schiaffo, qui. Ci sono stati i testimoni gli scheletri degli alberi, anche il fogliame, l’albergatore ha vinto la scommessa i gesti sembrano incredibili il caffè si raffredda. Voglio dire che mi hanno picchiato, proprio qui. Dunque io, come avrete capito, ho soltanto risposto. Ho dovuto difendermi. Infatti: mio fratello abbandonò il ferito sulla spiaggia io non ho visto niente; la voce del microfono era uscita distorta e così per risposta allegramente gli lanciai la moneta e mi pentii subito, appena, cioè, la vidi ricadere sulle mani del suo amico; tra poco, dicevo, sarò io, davvero, a dover chiedere l’elemosina (e giù un altro schiaffo, ancora). Sai tagliare la mela? Mi dice l’infermiera e se la ride, come gli altri. Quando sono venuto la prima volta nel manicomio, il medico più giovane era così bravo ed era proprio così bravo che ho avuto voglia di abbracciarlo ( «Ma un po’ ! Ma un po’ di contegno, su!»). Invece la prima volta (mia madre: devi infilarti presto i pantaloni) sono scappato; però è stata la prima volta che ho visto il mio paese dall’alto con le luci che tremano ecco il negozio le torri dei conquistatori la battaglia partita per la guerra il tè con poco zucchero ti prego. Mi carezzano a gara, tutti. Non è mica un brutto posto sa niente nessuno amiamoci. Ho mostrato al primario che mi fa male qui: il mio ventre è diventato (e lui sorride, sfido io!) come una polpa grande. Però nessuno mi risponde: è che i matti non li vuole nessuno, mi dice sorridente: carezzandomi, caro; la voce rotta, inquieta. Mi chiedono sempre di ricostruire, di spiegare: ma la vicenda, reclusa qui, proprio dentro, poi tormentando si restringe si fa come una mosca immensa, vieni. I racconti pigolano ancora, velocissimi, attraverso le corsìe; e poi l’affanno, l’abbracciarsi (tutti infelici, allora?); e il caldo amore interessato delle orazioni pronunciate, sudando, sottovoce. Poliscritture/Zibaldone Pag. 74 Perché mi avete impedito quel salutare volo? Ma questo gelo: e questo ansioso muoversi «devi calmarti un poco». Pensavo di scamparla, di porre fine a questi anni innumerevoli qual è la forza che ci spinge a uscire, a colpire? Anche scendere dal letto è un incredibile sfida agli eventi: e noi, loro, nel fumare lamentoso delle notizie che già vibrano «ce la farà»; Qualche volta, la mattina, ci scortano severi uomini in divisa, aprendo le celle con violenza; la nuova compagna osserva la scena con attenzione, girando il latte che bolle: grida che si raffredda, tu ci rimarrai due anni. Ci hanno trattato bene: gli altri pazienti, e anch’io, noi siamo stati bravi, nessuno ha pianto. Lanciamo insieme la moneta nell’acqua niente da fare hai perso; ancora un po’ noi ci tocchiamo. Allora gli infermieri mi accompagnano immersi nella luce bassissima: così lo sguardo cade ovunque, ansiosamente osserva le grandi stanze i rettangoli fitti le austere proporzioni; Caronte alita, esperto, qualche parola strana al suo collega e così osservo da lontano la campagna notturna mentre spazzano violentemente agiscono insensibili raccattano batuffoli gettati con malagrazia le macchie scure sorridono sul pavimento largo; veloci poi traghettano i corpi sospirosi sulle grigie barelle seminuove. Ma voi sapete, amici, che il sonno non mi aiuta; e voi, parenti amati, lasciate pure i vostri cari bimbi qui; ve li farò trovare teneramente scuoiati e appesi ai rami di questa dolceverde pineta: parola d’onore qua la mano. O. Garbin, Collage Il medico inietta frasi di conforto e voi, fintifelici: «a domani»; e queste parole saranno cancellate, dimenticate presto; o finiranno in miele appiccicoso o in un terribile segreto. Poliscritture/Zibaldone Colomba Claudia Iandolo Colomba, che aveva visto il diavolo, non sarebbe mai potuta ingrassare. Perciò se ne andava in giro vestita di nero, per una serie di lutti sempre più stretti che si erano stratificati negli ultimi trenta, trentacinque anni, con i panni che si gonfiavano, anche quando non c’era vento, e che sembravano trasportarla. Ma come non era riuscita a mettere carne su quel corpo fermo all’inizio dell’adolescenza, così non aveva più saputo sedersi. Poteva sdraiarsi e dormire, per poche, pochissime ore la notte, ma sedersi no. Colomba restava in piedi, pronta ad andare, per giri misteriosi, qualunque cosa c’era da dire o da sentire. Che avesse visto il diavolo era chiaro, e infatti chi lo vede resta così, un po’ sbandato, con un’ansia di corpo e di anima, un soffio inquieto in più che non spengono né il matrimonio né i figli. Dicevano senza malizia Chi? Ah, Colomba! E qualcuno aggiungeva come a suggellare, Quella che ha visto il diavolo. A quei tempi, quando Colomba era bambina, ed era da poco passata la grande guerra, certe cose succedevano ancora. Al lavatoio coperto, per esempio, il fantasma di una donna piangeva e si lamentava che era uno strazio, perché mentre lavava si era distratta e il figlio, figlio bastardo, di prete, era caduto in acqua ed era annegato neanche il tempo di rendersi conto. Ora, la madre lo cercava ogni notte, ma avrebbe preso chiunque al suo posto, qualunque ragazzino dopo il tramonto si fosse trovata di fronte. Oppure giù, al muraglione, dove tra i cespugli incolti e i fiori di sant’Antonio le serpi facevano l’amore, ce n’era un’altra, con una mano lunghissima, che nessuno ricordava più perché e quando avesse cominciato ad afferrare gente e a farla precipitare sul vecchio deposito di legname. Anche il ragazzino delle biglie, quello fantastico, che vinceva sempre, e avrebbe vinto tutte le biglie del mondo se fosse vissuto, era caduto un giorno senza vento, mentre forse guardava, chissà, anche lui, due vipere che facevano l’amore. Colomba sapeva come comportarsi ai crocicchi, cosa dire, velocemente, passando davanti al lavatoio e cosa fare lungo il muraglione. Sapeva molte altre cose, e molte ne faceva, per precauzione, prima di scendere dal letto e di chiudere gli occhi la sera, davanti al fuoco se fosse rimasta sola e la lingua di fiamme si fosse allungata all’improvviso in una contorsione poco naturale che era, anche questa, segno del maligno, di fronte ad un mal di testa o ad un mal di pancia senza spiegazione, se un’ombra le avesse attraversato la strada, eppure il diavolo lo vide così, in pieno giorno, come dire, in carne ed ossa, uno qualunque, pantaloni e cappellaccio, uguale a chi va in montagna a lavorare. E per questo all’inizio non ne ebbe paura, per questo, lei, col diavolo ci parlò pure, prima di capire. Il diavolo si avvicinò lentamente, come uno che ha qualcosa da fare, e che sa dove andare, ma non ha Pag. 75 fretta. Colomba era sotto un castagno, e aspettava che suo padre e gli altri venissero per mangiare. Colomba lo vide e lui vide Colomba: Sei la figlia di Antonio, disse, e non era una domanda. Colomba fece segno di sì, e non riusciva a mettere a fuoco quella faccia, che era la faccia di un forestiero, ma con qualcosa di già visto, di familiare. Il diavolo si sedette pure lui, a terra sotto il castagno e si tolse il cappello: Mettiti comoda, disse, tuo padre farà tardi. Si asciugò la fronte, proprio come fanno i contadini, con un fazzoletto uguale ai pochi che aveva suo padre e di cui tutta la famiglia era orgogliosa. Il diavolo la guardò e sembrava pensieroso, sembrava che volesse dire altro dalle parole che invece pronunciava. Poi Colomba non ricordò più niente, e non riuscì a ricordare per tutta la vita, anche quando ci pensava e si sforzava, chiudeva gli occhi e cercava di pensare ma non riuscì a dire mai quanto tempo e cosa fosse successo, nel frattempo. Quello che il diavolo le aveva detto doveva essere una cosa importante, perché le rimase un’espressione pensierosa, una vaghezza incantata, solo che lei lo aveva dimenticato. Nel sottile filo di ragnatela: zia Marsiella e altri Anna Maria Celso Per un periodo non troppo breve della mia giovinezza, ha diviso con noi la casa estiva dei nonni, zia Marsiella, Marzia in realtà era il suo bellissimo nome. Abituate ad avere la casa dei nonni paterni tutta per noi nipoti, quella nuova inquilina risultava un po’ scomoda. Non si capiva bene da dove fosse sbucata, ora che, vedova, era diventata ospite di suo fratello maggiore, nostro nonno. E poi questa zia era proprio strana: già anziana, piuttosto taciturna e con uno sguardo a tratti allucinato e a tratti perso nei suoi pensieri. E lei, che aveva perso i suoi due giovani figli nella guerra del 1915-’18, di pensieri doveva averne tanti e sicuramente tristi. La sua voce era spesso in falsetto e lei, riconoscente verso mio padre e mio zio, i suoi nipoti, che non avevano obiettato al suo arrivo, si sottoponeva volentieri alle loro richieste di recitare filastrocche o canti spesso infantili. Spesso le genuine risate di cuore che suscitava in chi l’ascoltava, avevano un suono amaro e facevano crescere in me un senso di inquietudine: non capivo o forse intuivo il filo sottile che divideva la compassione dalla bonaria presa in giro. Ai miei occhi di ragazzina, Zia Marsiella non sapevo come e dove collocarla. Le dovevo rispetto, questo era l’insegnamento dei miei, ma mi faceva anche un po’ paura, soprattutto quando la ritrovavo addormentata sul pavimento nelle calde giornate di agosto o quando scoppiava a piangere improvvisamente. E lei lo aveva capito, tanto che a volte si divertiva ad assumere il ruolo attivo della zia un po’ matta che faceva spaventare me e i miei cugini con piccole ed ingenue grida. Sentivo che dovevo volerle bene, ma non era facile. O. Garbin, Collage E poi un anno con quei bianchi capelli tagliati a caschetto e tenuti fermi da un cerchietto, per essere più ordinata, il suo aspetto assunse ancora di più la forma della sofferenza e del disagio psichico. La morte precoce dei figli e poi del marito aveva fatto saltare il suo equilibrio ma, ho scoperto più tardi, forse lei era nata già con le sue difficoltà mentali, in seguito esasperate ed era andata in moglie a più di un marito, forse perché costituiva comunque un peso ed una responsabilità troppo grande per i suoi. Quello che più mi è rimasto dentro di lei era il suo bisogno di essere amata e come si fosse affidata con totale dedizione a chi l’aveva accolta in casa e le dava un tetto sotto cui stare e un piatto caldo da mangiare. Ma chi l’aveva amata veramente? Come è diverso ora il mio sguardo su di lei! Il suo ricordo suscita in me grande tenerezza e rimpianto di non Poliscritture/Zibaldone Pag. 76 averla conosciuta abbastanza ed aver scoperto, al di là delle apparenze, la sua anima bella, quella nascosta dalle sofferenze e dal suo disagio. Forse adesso sarei capace di stabilire con lei una relazione autentica e perciò salvifica. Ma forse questo hanno fatto, ciascuno a modo loro, gli adulti che si sono presi cura di lei. Senza il legame con i suoi cari o con quelli che lei riteneva tali, si sarebbe persa del tutto. Ma non è proprio il rapporto con le persone ciò di cui abbiamo bisogno tutti, ciò che ci conferma o disconferma di fronte agli altri? Il contatto affettivo costante ci nutre e ci alimenta, permettendoci di costruirci nella nostra identità e personalità. Nel mio master sul disagio nascosto in classe il focus è stato ripetutamente messo sugli aspetti affettivi del processo di apprendimento. Lì si parlava di quel disagio sottile e spesso celato che con occhi sempre più esperti, se vigili, si riesce a scorgere nei nostri alunni. Non è la difficoltà certificata di chi è autistico, epilettico o psicotico, piuttosto quella sofferenza di chi è sempre un po’ al margine, border-line, mai completamente adeguato, che comunque comunica ripetutamente la grande difficoltà di imparare e la sua incapacità a vivere nel gruppo. La strettissima interdipendenza che esiste tra imparare ed insegnare trova, in alcuni autori di ispirazione psicoanalitica come Bion, la sua centralità nella fatica e nello sforzo di mettere in gioco energie e capacità di sostenere il dolore e la sofferenza mentale che da questo processo si genera. Tanto per l’alunno che per l’insegnante. Ad una prima lettura dolore e sofferenza mentale mi sono sembrate espressioni eccessive da attribuire all’apprendimento ma poi, man mano che proseguivo nello studio, mi sono ritrovata ad annotare, al margine del testo, il nome di qualche mio scolaro: Luca, Antonino, per esempio, ormai alle scuole medie. Sì, Antonino aveva proprio un mal di pancia da piangere davanti ad alcuni concetti per lui troppo impegnativi da afferrare; e quando Luca partiva per la tangente e si faceva prendere dalla sua ansia e senso di impotenza di fronte ai simboli scuri e oscuri della matematica, potevo percepire e toccare il suo dolore. Mi trascinava con lui nel suo vortice e non sempre riuscivo a contenere tutta la sua emotività dirompente ed esplosiva. Mi serviva un grandissimo sforzo per controllare la mia frustrazione, perché non si accumulasse alla sua, e diventasse conferma della sua incapacità. Dove avevo sbagliato? Come era possibile che in quinta elementare ancora non fosse sicuro delle quattro operazioni di base sulle quali avevamo lavorato fino allo sfinimento? Imparare significa concedersi di tollerare la frustrazione, le ansie e i problemi che nascono dall’incontro con il nuovo, con l’ignoto, con ciò che ancora non ci appartiene e comprendere che è possibile sostenere emotivamente questo carico: bisogna attraversare uno spazio indefinito che ci separa dal sapere. Ma Luca aveva energie per poter compiere questo salto nel buio? I suoi si erano separati, e in malo modo, quando lui aveva 7 anni. Poliscritture/Zibaldone Ricordo che il giorno in cui me lo disse, disastrosa mattinata di matematica, alla mia domanda se avesse riposato bene, mi rispose candidamente che aveva aspettato di salutare suo padre che andava via di casa. -Perché, sai maestra, pare che abbia un’ altra! Poi suo padre andò a vivere, con la nuova compagna e la nuova figlia, prima a Roma e poi a Cagliari e Luca si ritrovò a viaggiare da solo sugli aerei, quasi ogni 15 giorni, accompagnato solo dalle hostess. Poteva avere risorse ed energie da riversare nella scuola o doveva essere sempre all’erta per tollerare lo sfascio della sua famiglia e capire quale fosse ora il suo posto? Quando riuscivo a tenere tutto nella mia mente, a tenere presente tutta la storia di questo ragazzino e a rielaborare i miei sensi di fallimento e tutte le sue sensazioni di inadeguatezza, le cose andavano decisamente meglio per tutti. Coglievo fino in fondo il senso da attribuire all’espressione promuovere la funzione psicoanalitica della mente dell’insegnante: si chiede a me, come ad ogni altro docente, la disponibilità a considerare il bambino non solo tutto testa, ma nella sua integralità con emozioni e sentimenti per ascoltarlo, accogliere, tutte le sue istanze, riconoscerle ed essere in grado di aiutarlo ad ordinarle. I temi legati all’aspetto disciplinare e didattico spesso diventano marginali rispetto allo sviluppo relazionale, affettivo ed emotivo degli alunni. I tanti Non sono capace e Non lo so fare, in alunni perfettamente normali, sono il segno di questa inquietudine un po’ diffusa, legata alla paura di stare da soli, quasi sospesi nel vuoto, in una fase ancora di non conoscenza. - Maestra, ho finito, cosa faccio? chiedono ripetutamente gli alunni in una smania di dover agire, ma in modo esecutivo, solo se qualcuno detta le regole del gioco. Tutto sùbito ed ora e le cadute diventano sempre più frequenti. Le mamme buone, che aiutano i figli a sostenere lo sforzo di crescere e di diventare gradualmente autonomi e capaci di scelte responsabili, sono oggi sostituite da madri troppo buone, che eliminano in partenza anche l’ipotesi di un ostacolo per il proprio figlio e ,in quella grande palestra di scambi sociali e culturali che è la scuola, i ragazzi si sentono spesso persi e senza riferimenti. Mi viene in mente Alessia, forte e scontrosa bimbetta di seconda elementare. Ai primi no sentiti, reagiva addirittura voltando le spalle a noi maestre e aprendo i suoi quadernetti personali che teneva nello zaino. E poi, più avanti, sempre spavalda, copiava perfettamente dai compagni per non ammettere a sé stessa e alle maestre le sue grandi difficoltà. Ci è voluto un anno e mezzo per farle sentire che le sue maestre erano lì accanto a lei, poteva fidarsi e aprirsi alle conoscenze, non sarebbe stata sola, gli esiti non sarebbero stati solo negativi, lei le capacità le ha da mettere in gioco! Penso ora a Marco, ma anche ad Andrea o a Mattia. Pag. 77 Quanta confusione nella loro mente e spesso nel loro animo! Nelle giornate in cui sono incontenibili e scombinano la classe, dovrei essere capace di fermarmi e ribaltare la situazione con un’attività in grado di scaricare tutta quella tensione. Delle volte mi sembrano burattini mossi da fili invisibili. -Ma perché fai così? Te ne rendi conto? Dai loro occhi sbarrati e dispiaciuti, capisco che ho sbagliato le domande. Sono io che devo aiutarli a capire di più tutta quella agitazione emotiva che li governa, a dare una interpretazione e insieme a loro trovare le strade di uscita. Allora li rassicuro, dico che sto chiedendo qualcosa che è loro nota, che sono certa che l’hanno capita, devono solo tirare fuori la conoscenza. Basterà avvicinarmi di più e annuire, magari sedendomi accanto, suggerire una piccola cosa, dare loro fiducia, far capire che possono procedere da soli e che comunque la maestra è lì come loro sostegno. Ho attivato e valorizzato, in maniera assolutamente controcorrente, la capacità di pensare. Allora nei loro occhi, con le mille gratificazioni, si intravede un sorriso: bene questa giornata è andata, un pochino di più sono cresciuti nella fiducia e stima di sé. Ma quanta fatica e so che non sarà sempre così facile! È per questo che si esce stremati dalle classi, noi e gli alunni? Perché dicono che il lavoro dell’insegnante è comodo e leggero? Non importa: vedere poi che gradualmente i ragazzi imparano a pensare, ad essere critici, ad avere opinioni personali, a fidarsi e a diventare affidabili, ad essere attenti ai compagni è un’emozione che vale la pena di vivere, soprattutto se, con un pizzico di presunzione, ci si ritiene un po’ artefici di questo prodigio. Pochi giorni fa un’amica, con la quale ho un fitto scambio di libri, mi ha proposto la lettura di Lunatica di Alessandra Arachi. Sai- mi ha detto- per me che lavoro con i matti, questo è un libro interessante. Roberta è un’insegnante di una scuola speciale di Milano e si occupa di persone affette da patologie mentali medio-gravi. È vero, il romanzo si legge in poche ore e l’autrice, giornalista del Corriere della Sera, racconta in forma accattivante, della sua esperienza di malata affetta da disturbo bipolare. Malattia strana questa che attacca l‘umore e riduce la persona in completa balìa di stati di grande euforia ed eccitazione e poi di profonda depressione. È un momento, e la mente fa clic e non si recupera più. Leggo con avidità il libro e più mi inoltro nella lettura più ritrovo la narrazione di un’altra amica che più volte mi ha confidato con amarezza della malattia di sua cognata, senza mai però definirla. Quando nel testo trovo, tra le varie terapie, il ricorso all’assunzione del litio, un sale stabilizzatore dell’umore che modula la trasmissione dei segnali tra le cellule cerebrali e all’interno delle cellule stess., ho la conferma che si tratta dello stesso disturbo. Quando Teresa sta male e riesce ad accorgersene, deve iniziare a prendere il litio. Se arriva in tempo evita l’acuirsi dei sintomi, l’altalena tra gli alti e i bassi e il recupero è più veloce. Vado subito alla fine del libro, dove cerco di trovare le cause di questo fenomeno. È a carico del sistema nervoso centrale e pare si tratti di un disturbo dell’energia vitale che non riesce ad essere controllata dai sistemi regolatori di cui dispone il nostro cervello ed altera perciò il nostro equilibrio psichico. Se tutti gli organismi viventi sono sensibili ai cambiamenti dell’ambiente prodotti dall’ orbita della terra intorno al sole, della luna intorno alla terra, alle variazione di luce e di calore, ai campi elettromagnetici, non fa eccezione il cervello umano. I ritmi di vita frenetici, l’uso e abuso di droghe e di sostanze stupefacenti, la riduzione delle ore di sonno, eventi drammatici o traumatici diventano elementi scatenanti in personalità più fragili o dotati di sistemi regolatori meno efficienti. Dio mio, ma allora siamo tutti a rischio!? È solo un sottilissimo filo di ragnatela quello che segna il confine tra la normalità e la possibile malattia mentale!? Forse mi sto autosuggestionando…o forse no. Certo è che Alessandra è potuta guarire, o meglio tenere sotto controllo la sua malattia anche grazie alla presenza e sostegno continuo della sua famiglia, di chi l’ha saputa seguire ed accompagnare nel suo percorso di risalita. Anche il medico della clinica psichiatrica che ha finalmente diagnosticato la malattia e che la sta curando con una terapia farmacologia appropriata lo sa e nei momenti più cupi, quelli nei quali il paziente deve essere attivo e dare il suo consenso alle cure, non esita ad abbracciarla e tenerla in braccio con la tenerezza d un padre. Il rischio di poter perdere improvvisamente la propria integrità di uomo, il controllo sulla propria mente e su di sé, fa veramente paura e pensare che nessuno forse è immune da questo pericolo spinge a guardare gli altri con occhi diversi. Con maggior generosità e magnanimità, ma soprattutto e sempre con grande amore e compassione, come condivisione della condizione degli altri perché insieme è possibile, non eliminare il dolore e la sofferenza, ma rendere più tollerabile e dignitosa ogni condizione umana. Difficilissima da diagnosticare, ancora poco conosciuta, ha come epilogo, per 15% dei suoi malati, il suicidio. Poliscritture/Zibaldone Pag. 78 Scrittura come terapia del dolore Sonia Scarpante Depressione. Una parola che si teme, che fa molta paura. Un cancro della mente a cui non sappiamo dare confini, limiti. Il volto del depresso lo leggi nel vuoto di relazioni che non tendono alla speranza, al futuro, al cambiamento. Il volto del depresso langue in un deserto di emozioni che il cuore tende a nascondere, sopraffatti come siamo da una vita irrefrenabile. Un moto perpetuo che inabissa la nostra condizione interiore perché la società nega il diverso, il depresso, la persona melanconica. Mentre la vita si svolge su quel confine labile dove l’amarezza si alterna alla serenità, la sofferenza alla giocosità, la rabbia alla calma. Molti associano la depressione alla malattia, alla pazzia, a ciò che rende l’uomo passivo, privo di coraggio e di volontà. Spesso subentra ad un sentimento a cui facilmente ci accostiamo nel percorso vitale: la noia. Quel non senso del vivere quotidiano che viene enfatizzato da ruoli resi scarni da un’ abitudine che vuole mancare di progettualità, di estro e di creatività. Ruoli obsoleti che osserviamo in conoscenti smarriti, in educatori persi in un’illusione caotica che non ha tempi per fermarsi sui tempi dell’anima. Ruoli consumati in professionisti evanescenti come si avverte nelle figure di medici, politici, professionisti rinchiusi nel loro super-ego. E la distanza aumenta incontrovertibile senza prevedere una cura che possa riparare a quei danni che la mente sottende. E la relazione in una società sempre più tecnica perde sempre più di valore, il rapporto medico-paziente, il rapporto educatore-studente, il rapporto politico-cittadino sconfinano nei meandri della incapacità dialettica e dell’insostenibilità empatica. Tutto diviene moto allucinante. È il ritmo frenetico della vita che ci ingabbia in una via senza soluzione? E come possiamo intervenire per incanalare verso la speranza quelle forze che la depressione emana per tentare di sanare un percorso che rischia di sprofondarci nell’abisso? Come porgere aiuto a quelle persone, a quei volti scarni senza rimanere intrappolati in un delirio di onnipotenza salvifico che può mettere a rischio la nostra vulnerabilità? La nostra vita dipende sempre da quel sottile equilibrio in cui barcameniamo le nostre esistenze : quel perdersi per poi ritrovarsi con il coraggio di sentirsi unici ed insostituibili in un tragitto che non ci vuole vinti. È quell’essere, poi, disponibili ad affrontare le “ miserie” dell’altro imparando a tutelare la nostra parte sana che viene costruita giorno per giorno, e che va necessariamente rinvigorita ed impreziosita. In questo lavoro non facile , gioco-forza esige che sia essenziale imparare ad amare prima se stessi. Nella logica di questo divenire per amarsi si deve intendere lo stato della ricerca interiore, dell’approfondimento finalizzato a porre in luce la propria autenticità, quell’intePoliscritture/Zibaldone riorità creativa che spesso rappresenta l’antitesi ad uno stato del mondo che ci sommerge nei suoi valori avulsi: il potere, il dio-denaro, la carriera atrofica. L’arte, il lato creativo, il sogno appartengono ad una sfera più intima che, solitamente, siamo soliti temere perché esprimere l’interiorità cruda nella sua nudità ci mette a rischio, ci espone, ci rende più soli. Solitudine intesa come trasparenza del sé attraverso quei segni della mente che ha bisogno di ispirazione, fiducia, passione, per espandere le proprie possibilità. Nell’alternanza di questa vita che tenderebbe a renderci mediocri a quell’altra che, invece, ci spinge ad essere più coraggiosi e vitali, si intesse quella trama che sta a noi forgiare giorno per giorno. Il bagaglio culturale di chi accompagna il nostro percorso formativo può ingabbiare queste energie o, altrimenti, sostenere questa ricerca finalizzata alla tutela di una speranza comune. Il nostro bagaglio culturale deriva da chi cammina con noi accompagnandoci negli anni e spesso anche solo la funzione di un educatore aperto alla vita promuove comportamenti attivi e positivi; spesso anche un legame affettivo felice può definire quella maglia di riflessioni e di valori che l’anima ha bisogno di reperire per darsi un senso profondo. L’educatore in tal senso può reperire la sua funzione volta alla cura dell’altro, non rinunciando al vincolo di una sua professionalità affidataria, ma qualificando la sua capacità propedeutica in quella direzione dove l’impeto assume la forma della passione fiduciaria. Fiducia nel paziente che traslata dal medico diviene fulcro in una prospettiva futura di guarigione e di speranza verso la salute salvifica. Un senso è dato reperire in queste direzioni se come individui crediamo nelle nostre possibilità, nelle nostre capacità di iniziativa volte alla conoscenza interiore e alla sua tutela. Pensando al mio bagaglio culturale desidero valermi della forte testimonianza di una cara persona con cui sono cresciuta: lei ha segnato i miei pensieri oltre le mie possibilità obbligandomi ad un confronto dove lei emergeva come parte lesa ed io come parte salvata. Sono la nipote a cui la cultura, la conoscenza ha dato maggiori possibilità per imparare a sondare qualcosa che la mente difficilmente riesce a identificare nel suo significato. La narrazione come forma di conoscenza della realtà e costruzione di significati ci insegna ad affrontare l’incerto, il non conosciuto. La forte valenza formativa della narrazione consente al soggetto di riflettere sui vissuti cognitivi e affettivi. Credo di aver desunto la semplicità dell’arte di raccontarsi e di dire attraverso le emozioni proprio da quella nonna che, mi dicono, avesse da giovane il dono dello scrivere con fluidità, la scioltezza dell’espressione in lettere che nascondeva anche a se stessa. Era riuscita a dare poche svolte nella sua vita, ma quelle che era riuscita a realizzare scaturivano da quell’indole originaria che, ponendosi magistralmente in contatto con l’arte e la creatività interiore, analizzava i moti dell’anima, mediava gli intenti, cesellava, intrepida anche nel chiedere giustizia. Un esempio della sua meritoria capacità mi venne raccontato da adulta. La figlia, mia zia, era solo una bimba e si ricorda la madre mentre chiedeva, tramite lettera, alle autorità ecclesiaPag. 79 stiche un aiuto per le ristrettezze economiche che pesavano prepotentemente sulla famiglia e per la mancanza di un lavoro che non permetteva al marito di rispondere alle necessità primarie di sussistenza. La zia mi raccontò che quelle parole furono talmente profonde e dirette che a distanza di pochi giorni alcuni delegati della curia bussarono alla loro porta. La nonna non assecondò questo suo spirito indomito, troppo presa dall’educazione dei tre figli, dal ruolo di madre e moglie, poco consapevole del dono ricevuto. E credo fortemente, oggi, che quel moto dell’anima avrebbe potuto risollevarla, rinvigorirla, se coltivato nei suoi risvolti più autentici; solo se avesse avuto la possibilità di esercitare quella sua peculiarità che, forse, intravide appena. Quella scrittura poteva divenire la sua forza. Io, questo percorso, sono riuscita ad affrontarlo perché la forte esperienza della malattia di 9 anni fa mi ha dato la spinta iniziale. Lo scrivere di sé nasce da una domanda della mente. Chi sente di aver vissuto qualcosa che deve essere raccontato, attraverso la scrittura riesce a riconciliarsi con eventi dolorosi, traendone emozioni di pace, mitigando la propria soggettività, per aprire la mente ad altri orizzonti. Credo che la nonna non sia stata in grado di riconciliarsi con se stessa perché la strada che aveva reso inaccessibile e non conforme alla sua natura emozionale non le permetteva di mettere a fuoco il suo lato creativo. Certamente la scrittura come arte curativa e strumento terapeutico, per cultura, non aveva spazio fra i suoi pensieri. Mentre nei miei sì: l’esperienza della sofferenza mi ha permesso di esprimere la mia interiorità, mitigando quel conformismo di vita a cui siamo legati tutti per difesa, arricchendo quegli iter formativi già resi obsoleti dalla omologazione imperante. Due generazioni di distanza hanno permesso questa riconciliazione. Come scrive spesso Duccio Demetrio nei suoi libri (e la mia sottolineatura, accompagnandosi al suo dire, diventa sempre più verità): “ Raccontando ci riempiamo di cose e di senso”. Mia nonna ha sofferto e non è riuscita a dare spessore alla sua sofferenza: ha introiettato il suo dolore massificandolo nel tempo come una pietra tombale. Mentre io ho fatto un percorso diverso: ho voluto recuperare l’esperienza del dolore per consentirmi l’opportunità di dare nuove risposte alle domande che mi sono posta nel momento in cui ho deciso di vivere appieno la mia vita. È stata una ricerca personale del mio senso che passava prima attraverso la ricerca del senso della malattia per arrivare a cogliere quello dell’intera esistenza. Se alla sofferenza, alla malattia, si riesce a dare un senso, allora tutto può diventare più accettabile; assume un ruolo, un significato. La conoscenza di noi stessi è sempre mediata dal racconto autobiografico, poiché il testo che creiamo ci rispecchia e ci invita a reinterpretarci. “Mi sto aiutando”, scrivevo, per sottolineare l’importanza del tragitto interiore, che se tutelato, può aprire Poliscritture/Zibaldone nuovi varchi alla conoscenza terapeutica. Il mio incontro con il tumore alla mammella è stato dirompente. Venivo da un periodo difficile e sofferto. La crisi matrimoniale mi ha messo a dura prova e non ho avuto forze per contrastarla. Le mie autodifese si sono isterilite e ho immagazzinato eccessivo dolore per poter uscire indenne da una situazione che psicologicamente non mi dava tregua. Solo oggi riesco a descrivere quei giorni di sofferenza, perché voglio aiutarmi per superare quel dolore. Credo che il male si possa attenuare solo parlandone, cercando di esternare quelle emozioni forti che si sono attaccate addosso e da cui ci possiamo salvare, se lo vogliamo in un cammino di speranza. Se dovessi confrontarmi con una donna che è passata o che attraversa simili vie, credo che le consiglierei di trascrivere, con parole dettate dal cuore, la sua esperienza, il dolore, l’angoscia che ha provato in quei momenti. Penso che la migliore terapia risieda in quelle parole, in quel vissuto esternato. Le parole descrivono, trasformano, creano emozioni, indagano, evocano, colpiscono e fanno bene, parlano di se stesse, eccitano il pensiero. Chiunque abbia tenuto un diario, in cui esprime i propri pensieri più profondi circa un’esperienza di sofferenza, sostiene che il tempo e lo sforzo ad esso dedicati, sono stati ampiamente ricompensati dai benefici ottenuti nella propria salute. Come scrive Isabelle Allende nella sua autobiografia “ Paula”: «La mia vita si fa nel narrarla e la mia memoria si fissa con la scrittura; ciò che non riverso in parole sulla carta lo cancella il tempo. Ma il racconto mi aveva preso e non potei più fermarmi, altre voci parlavano attraverso di me, scrivevo in trance, con la sensazione di andar dipanando un gomitolo di lana, e con la stessa urgenza con cui scrivo adesso. Alla fine dell’anno si erano accumulate 500 pagine in una borsa di tela e capii che non era più una lettera; allora annunciai timidamente alla famiglia che avevo scritto un libro. Quel libro mi salvò la vita. La scrittura è una lunga introspezione, è un viaggio verso le caverne più oscure della coscienza, una lenta meditazione». Questo ascoltarsi interiore, dando vita al processo che ci ha costruiti come donne ed uomini, non può che sollecitare, anche, una maggiore cultura dell’ascolto che diviene, oggi, sempre più necessaria e meritoria. Educati come siamo alla cultura dell’applauso non sappiamo neanche dove sta di casa la cultura dell’ascolto. Scrive Umberto Galimberti: «Distribuiamo farmaci per contenere la depressione, ma mezz’ora di tempo per ascoltare il silenzio del depresso non lo troviamo mai. Con i farmaci, utili senz’altro, interveniamo sull’organiPag. 80 smo, sul meccanismo biochimico, ma la parola strozzata dal silenzio e resa inespressiva da un volto che sembra di pietra, chi trova il tempo, la voglia, la pazienza, la disposizione per ascoltarla? Tale è la nostra cultura». E ancora: «Non si può parlare neppure di disperazione, perché l’anima del depresso non è più solcata dai residui della speranza. Bisogna avere il coraggio di vivere fino in fondo anche l’insignificanza dell’esistenza per essere all’altezza di un dialogo con il depresso. E solo muovendosi intorno a questa verità, che è poi la verità che tutti gli uomini si affannano a non voler sentire, può aprirsi una comunicazione. Comunicazione rischiosa, non perché ci può trascinare nella depressione, ma perché può tradire la nostra insincerità. Il depresso, infatti, è sensibile al volto che smentisce la parola, e il suo silenzio smaschera la finzione e l’inconsistenza. Per questo i volti dei depressi sono rigidi e pietrificati». avvertita dal nostro cuore e sepolta dalle nostre parole. Questa verità, che si annuncia nel volto di pietra del depresso, tace per non confondersi con tutte le altre parole. La depressione chiede ascolto. Si può spezzare questo cerchio tragico e perfetto? Sì, se siamo capaci di ritrovare l’essenza dell’uomo che Holderlin indica là dove dice: «Noi siamo un colloquio». Il colloquio è fatto di parole, ma le parole non si dicono solo, si ascoltano anche. Ascoltare non è prestare l’orecchio, è farsi condurre dalla parola dell’altro là dove la parola conduce. Se poi, invece della parola, c’è il silenzio dell’altro, allora ci si fa guidare da quel silenzio. Nel luogo indicato da quel silenzio è dato reperire, per chi ha uno sguardo forte e osa guardare in faccia il dolore, la verità Poliscritture/Zibaldone Pag. 81 6 Letture d’autore incontri e confronti con gli autori che ci parlano Raccontami un altro mattino * Marcella Corsi Il freddo stringeva la città. Ma nella piazza orlata di luci al neon i giovani, passata la statua, voltavano e tornavano, sorridendo a quelli che andavano in giù. La madre preparava gulash o frittelle di patate per la cena. La sera il padre portava a casa il giornale, piegato in modo che si vedeva solo il titolo CORTINE DI FUMO PER PROTEGGERE LA CITTA’. «Forse la guerra non scoppierà subito». In piazza S. Venceslao nera di gente i cannoni sono lunghi come i tronchi degli alberi caduti. Oltre il Giardino delle rose, vuoto d’uccelli, le campane della chiesa mi rimbombano nello stomaco. «Non la voglio portare… Proverò giusto per una volta». Per la strada un’altra stella mi viene incontro. È un ragazzo che abita dall’altra parte della strada. Mi piace ma lui non mi degna mai d’attenzione. Oggi mi fa un gran sorriso e un cenno del capo… Vicino alla fermata del tram un’altra stella: saliamo sull’ultima vettura. Perché non abbiamo il permesso di entrare nella prima e nella seconda. Solo nella terza. La vettura è piena di stelle. Parlano e ridono e leggono il giornale come qualunque altro giorno. E penso: non si sono mai viste tante stelle di giorno. E di notte nessuno le può vedere – non abbiamo il permesso di girare per strada dopo il tramonto. Cambio le stelle. Dalla camicetta al maglione al cappotto. E poi ancora… Più stelle da portare e sempre di meno a portarle. Mi domando dove è finito il tempo e dov’è finita tutta la gente che conoscevo. Una volta alla settimana, e talora più spesso, una processione riempiva le strade della città. La luce del mattino avvolgeva l’oro battuto delle torri, ma le strade infossate erano buie. Camminavano per le strade con i bagagli numerati per la partenza definitiva. Non sapevano dove stavano andando né quando sarebbero tornati. Non capivano perché dovessero lasciare una città dove c’era abbastanza posto per loro. Tutta di pietra azzurrina, la città scorreva davanti ai loro occhi. Dietro le imposte chiuse la gente stirava le braccia, la bocca aperta in uno sbadiglio… gli uomini sollevavano appena la tapparella e guardavano giù in strada. Poi la lasciavano ricadere e si allontanavano dalla finestra. La processione Poliscritture/Letture d'autore Pag. 82 seguitava a camminare. Prima di entrare nella stazione i prescelti giravano ancora una volta gli occhi scuri sulla città. Coglievano attraverso un velo di lacrime l’ultimo scintillio delle torri. Sentivano aprire le prime serrande… Era come se la città si svegliasse solo allora. Quelli dietro le finestre alzavano le tapparelle. La città era più chiara adesso nella luce brillante del mattino. Era un giorno come qualunque altro, ora che la gente in marcia se n’era andata. Qui ci sono le cimici. Arrivano ogni notte in una lunga fila. Le aspetto e loro vengono. Abito in una fortezza e quella è una pattuglia di soldati. Mi pizzicano tutto il corpo con cento morsi. Ogni mattina seguo nel loggiato le altre donne con le coperte. Lì le battiamo per scuoterle via. Le cimici cadono al piano di sotto, sulle coperte che vengono arieggiate lì – e noi riceviamo altre cimici dal piano di sopra. «Se non faccio quello che fanno loro sono libera. Loro fingono di fare una vita normale, qui. E ogni settimana mille sono spediti chissà dove e ne arrivano altri mille…Non è una vita normale e non intendo fingere che lo sia. Con Ivan non voglio farlo. Non qui. Non ho più niente da perdere. Ma questo l’ho ancora». Durante la sosta ci stendiamo su uno dei tavoli ed Eva si addormenta… è distesa dritta sul tavolo ed è così che vive: dritta. In tutte le strade contorte di questa cittadella, Eva segue una linea bianca… l’ha tracciata lei così dritta e non riesco a immaginare nulla che possa farla deviare. Nemmeno un pezzo di pane. Eva si sveglia, ammicca verso di me e dice: «Sai una cosa? Lo amo. Ci sposeremo quando sarà finita». La sera aspettiamo mio padre. Di ritorno dalla selezione. Prima nel pomeriggio abbiamo visto Eva tornare dalla selezione; ci ha salutate con la mano da lontano e ho capito che era finita a destra. Ora aspettiamo mio padre. La mamma è sempre in piedi. Io mi sono seduta da un pezzo. Da quando se n’è andata Eva. Sono molto stanca – da quando se n’è andata Eva. «Non ti vuoi sedere, mamma?» «No. grazie. Lo vedo prima se sto in piedi». Ora la vedo sussultare. Mi alzo. Lo vedo che viene verso di noi… come uno che non ha fretta e non ha dove andare. «Da che parte sei andato?» Mio padre solleva un piede sulla caviglia, a testa china; poi col tallone smuove il terriccio. Lo pareggia col piede, guardando per terra. Alza la testa, stringe le labbra. «Ah…» come se l’avesse scordato. «A sinistra… sono andato a sinistra». * Zdena Berger, Raccontami un altro mattino, Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2007 [annusato per via di Fusini su «La Repubblica», letto d’un fiato. Ma perché una traduzione dall’inglese? Che sia stato scritto in inglese? Si spiegherebbe la scrittura così semplice… L’autrice, nata a Praga, vive negli U.S.A. da molto tempo.] Poliscritture/Letture d'autore Pag. 83 Appunti su Verbale di Michele Ranchetti Ennio Abate Ora già tutto è diventato breve: la luce, il passo e lo stesso mio corpo e breve è il tempo e breve la distanza tra me e la fine se anche la durata della vita è immensa (Ranchetti, Verbale, pag. 23) Michele Ranchetti (1925-2008), studioso di storia della Chiesa, di Wittgenstein, Heidegger e Freud, saggista, poeta, traduttore di Celan e Rilke, è morto il 2 febbraio. L’avevo intervistato nel 2005 per «Poliscritture» (Cfr. n. zero, maggio 2005 o su www.poliscritture.it) su Non c’è più religione (Garzanti 2003), libro in cui svolgeva un discorso drastico e spietato su quello che più tardi avrebbe chiamato «il disagio nella civiltà cristiana» (Cfr. il numero monografico de «L’ospite ingrato», 2, 2006, da lui curato). Con questi appunti sull’immagine che mi sono costruita di lui e la poesia del suo Verbale (Garzanti 2001) qui lo ricordo1. 1. Ranchetti, uomo cresciuto interamente nell’epoca del Libro, espone in Verbale una verità quasi insopportabile. Ci cozzo contro quando leggo versi come questi: «Tu vivi, viviamo, nell’altro lato del foglio che riceve il senso dal suo contrario e quando tu lo vedi è tardi per la vita, hai compiuto tutto il tragitto, sei al di là di te stesso, sei te stesso morto».2 Tale verità egli la coglie in quei «momenti di un giro a vuoto mentale»3 permessi solo dalla poesia e non è «trasmettibile, né convertibile in una forma diversa (filosofica, religiosa, estetica)».4 Non può dunque essere “narrata” o “spiegata” (il che comporterebbe una distensione temporale decisa ad arbitrio). Per lui può essere fissata soltanto in «momenti (frammenti)»5. E perciò Verbale non è il rendiconto di uno scienziato: quella verità, rimuginata dentro per una vita intera e tutta interiore, ha 1 Questi miei appunti su Verbale sono visibili in una stesura più ampia su www.poliscritture.it : (Cerca: Ranchetti> L’ombra in poesia). 2 M. Ranchetti, Verbale, pag. 96, Garzanti, Milano 2001 3 M. Ranchetti, La mente musicale, pag. 7, Garzanti, Milano 1988 4 Verbale, pag. 133. 5 Verbale, pag. 133. Poliscritture/Letture d'autore solo in superficie tratti oggettivi; va sentita; a descriverla sfugge o appare ovvia, banale. 2. So cosa incontrerò in questa raccolta: nube (ombra), malattia, morte dell’animale (dell’uomo). Vado incontro a una scarnificazione del mondo, alla sua assenza. Lo spirituale esclude il secolare: Il gioco è fermo: il mondo se il bambino delira: exivi da saeculo dove corrisponde alla mia morte solo la mia morte il vuoto nelle reti fra chi vive e chi precipita.6 In poesia - e in maniera ancora più decisa che nei suoi scritti in prosa - la storia, la politica, l’industria, la lotta di classe, la “realtà” (ciò che ha occupato - ancora occupa - la mia mente e logora i nostri corpi) - sono abolite. Qui Ranchetti volge ancora più decisamente le spalle a quotidianità, cronaca e storia. Da lui, che ha continuato attivamente a pensare e ad agire nell’habitat del pensiero religioso cattolico, noi che ci siamo voluti adulti e moderni, rimaniamo separati. 3. Ranchetti è rimasto “cattolico”, dunque? Credo di sì. Ma con un cattolico che, scrivendo Praevalebunt7 o Intellettuali e Chiesa cattolica: tesi (ora in Non c’è più religione8), ha svelato il nichilismo del«cattolicesimo di questi inizi del terzo millennio»,9 atei, agnostici o non credenti possono, se non intendersi, confrontarsi al di fuori dai mille equivoci presenti nei discorsi su “ritorno della religione”, “ateismo devoto”, “teocon”. 4. Per la sua “nostalgia di cristianesimo”, Ranchetti sta su un altro piano rispetto a un Fortini o a un Ernst Bloch, che, prospettando un possibile e reciproco inveramento utopico sia del dramma religioso che di quello mondano, hanno avuto il merito ai miei occhi di spingersi più di lui verso un possibile punto di confluenza tra cristianesimo antico e marxismo moderno. La sua a-mondanità è così netta che, al confronto, la religiosità di un Bloch o di un Fortini non possono apparire che “teatrali”, il che – credo – spieghi la sua disattenzione al primo e le sue rimarcate riserve nei confronti del secondo. Non c’è posto in Ranchetti per la contraddizione nella storia. Il dramma in lui resta solo religioso. E perciò, coerentemente, anche in poesia egli respinge una «poetica [che non abbia] carattere di esperienza particolare», com’è quella fortiniana, fino a trovarla «risultato di un esercizio di ragione, sia pur di ragione poetica» che preclude «quelle cadute verticali nell’immaginazione poetica (e 6 Verbale, pag. 55. 7 Cfr. La rivista del manifesto, n. 10 ottobre 2000. 8 M. Ranchetti, Non c’è più religione, Garzanti, Milano 2003. 9 M. Ranchetti, Non c’è più religione, pag. 14, Garzanti, Milano 2003. Pag. 84 sia pure un Grand Hotel Abgrund)» che per lui sono l’essenziale in poesia.1 Quando la spinta poetica si affaccia nella mente di Ranchetti, il dramma storico, da lui pur indagato sul versante della storia della Chiesa, è del tutto accantonato e vanificato: «l’assenza / si introduce ed è l’essenza – egli scrive - e la luce è «luce del morto in te, luce / luce perpetua del compito, luce / precipua d’ombra, contro luce».2 che Mengaldo chiama «”metafisica”»7. L’antivitalismo di Ranchetti si coglie in questi versi: Sottrae, erode, distrugge per una ragione di morte, per un assillo che ostenta d’essere priva mentre altri vivono come immortali nel nulla di cui lei, lei sola, è consapevole. 5. Nella Postfazione Ranchetti parla di figure che hanno agito nella sua esperienza e con le quali ha stabilito «un’alleanza affettiva e teoretica»3. Sono le fonti del suo sentire: familiari, amici, conoscenti (le allusioni più chiare paiono quelle riferibili ai genitori, ai figli) già fattisi però pensiero. E quindi sapere i nomi di alcuni suoi reali interlocutori– come aveva lui stesso precisato nella precedente raccolta, La mente musicale - non aggiunge molto di più a quanto i versi passano. 6. Per chi verbalizza Ranchetti? Sento nella sua poesia l’assenza del noi, diciamo pure del fantasma che tanto ha agitato fra Otto e Novecento almeno la parte dei poeti e degli intellettuali che mi sono scelto come riferimento. Ranchetti era estraneo ad ogni retorica del noi o della “fraternità”. Quindi mancano in questi versi l’intento didattico, la volontà di colloquio, la fiducia nel cercare assieme agli altri. Manca pure la spinta a persuadere qualcuno della verità che egli vuole, scrivendo, salvare dalla distruzione del tempo. Non dico che c’è solipsismo nella sua scrittura, ma, soprattutto nella poesia, una solitudine vissuta in modi estremi nel pensiero e nel linguaggio. 7. In poesia, Ranchetti abbrevia: Vivo in una cassa da vivo: morto sarò risorto.4 In modo rigorosamente intellettuale l’ansioso suo percorso di vita (termine da lui svalutato, se non dileggiato) e d’esperienza (termine non assente dal suo lessico ma accompagnato da una forte consapevolezza del «limite», e cioè della morte incombente come sua conclusione) viene contratto e accorciato.5 Sappiamo che esso è stato lungo e multiforme, ma, in coerenza con il princìpio religioso della sua poesia, egli riassume la vicenda («le origini / i parenti modesti, la severa / pratica di pietà religiosa e civile»6) nel nulla, nella morte, in quella 1 M. Ranchetti, Scritti diversi II, pag. 236, Edizioni di storia e letteratura, Roma 1999. 2 Verbale, pag. 98. 3 Verbale, pag. 133. 4 Verbale, pag. 60. 5 Verbale, pag. 39: : «Non si può immaginare / come del lungo itinerario resti / solo la fine». 6 Verbale, pag.39. Poliscritture/Letture d'autore Cerca di persuadere tutti qui e ora a morire senza perdere tempo ancora a vivere. Spettro immortale domini il presente con la tua cenere fragile tra gli arti dell’esistente e distruggi il presente perché lo escludi dal principio, dal prima del tuo vivere assente. 8. In questo «percorso conoscitivo, fissato in punti di illuminazione e di ombra» a me pare che Ranchetti si sia misurato soprattutto con le ombre, con «i punti morti di luce», fiducioso che, connettendosi tra loro, essi diano luogo (non dice: possono o potrebbero…) a «momenti (frammenti) di chiarezza». Di ombra, di oscurità (del linguaggio stesso), sin dalla prima lettura delle sue poesie ne ho trovata tanta. E mi sono chiesto quanto ciò fosse dovuto a mia ignoranza o al distanziamento dal mondo cristiano-cattolico-borghese di Ranchetti. Ma è davvero più “intelligibile” oggi questa sua poesia a un cattolico o a un cristiano? Tanta ombra non sarà dovuta al suo sporgersi (ricorro a Giudici8) «nell’aldilà di ogni oltranza dell’esserci» che l’ha portato in Non c’è più religione? alla stessa negazione o messa in dubbio del pensare religiosamente? Chi afferma, comunque, che Ranchetti rientrerebbe interamente in «quella grande tradizione mistica (che ebbe, da noi, in Clemente Rebora il suo estremo grande testimone)» mi pare che addolcisca l’intero suo percorso.9 Davvero l’”oscurità” ranchettiana è apparentabile a una «laica noche oscura», come hanno scritto in occasione della sua morte vari commentatori? 9. Non sono in grado di intendere la qualità di quest’ombra ranchettina (e – lo ammetto – della stessa oscurità per me di tanti suoi versi). Eppure da questa difficoltà non ho tratto alcun sentimento di rifiuto nei confronti di 7 P.V. Mengaldo, Op. cit. pag. 433. 8 Verbale, seconda di copertina. 9 Ancora Giudici nel risvolto di copertina di Verbale. Secondo me, il percorso di Rebora è inverso a quello di Ranchetti, tant’è vero che per il primo si conclude con il sacerdozio, mentre Ranchetti nella Prefazione di Non c’è più religione arriva a questa conclusione sicuramente antitetica: «Di fronte a queste autorità religiose e civili l’unica virtù che può forse recuperare un senso religioso alla vita, se mai un senso religioso fosse necessario, e non è affatto detto, è la disobbedienza “cieca e assoluta” perinde ac cadaver. Letteralmente. Forse il resto verrà da sé» (pag. 14). Pag. 85 questa poesia. Anzi, proprio perché tanto ostica (sicuramente più dei suoi Scritti diversi1), mi spinge a fissare con precisione i miei «non capisco» (i miei “limiti”). 10. Ranchetti, a differenza di tanti poeti che in poesia vogliono metterci la vita, ci mette la morte. Non è il primo. Dante da vivo ha immaginato un viaggio di purificazione e di rinascita (alla vita, a una vita ancora umana, ma più consapevole del divino) nel mondo dei morti. Ma quello di Ranchetti non è un viaggio. Non c’è «tragitto» né «progetto»: «Potestas interpretandi»: ciascun uomo io prima della fine ho ancora il compito almeno di capire la perdita del senso. Qui, perduto il carattere del qualsiasi progetto, riconosco solo l’assenza di un tragitto»: fine uguale a fine perenne riconquista grado a grado il suo corso e corrisponde al mirabile.2 1 M. Ranchetti, Scritti diversi, Edizioni di storia e letteratura, Roma 1999. 2 Verbale, pag. 30. 3 Verbale, pag. 91. 4 Cfr. M. Ranchetti, Scritti in figure, Edizioni di storia e letteratura, Roma 2002. Poliscritture/Letture d'autore L’ombra dell’uomo di G.De Vincenti La sua mi pare un’operazione più drastica anche di quella che fece Leopardi. Nel poeta di Recanati, il sentimento di morte e la disperazione lasciavano intravedere la vita (che spettava magari agli altri più che a lui). Qui no. Il “piacere della vita”, ogni piacere, è negato. Ranchetti non si finge morto (come ad es. fa Giudici in una nota poesia). Non pensa da morto la vita, come fa Leopardi. Nella vita sta da «sasso», da «albero».3 Mi pare che egli pensi da morto la morte. Ci dà una poesia mortificata, rinsecchita, scheletrica (come lo sono le immagini di corpi umani e di animali – specie alcuni gallinacei - che egli fissò in disegni tanto vicini al primo Paul Klee4). Avrà accolto – come dicono - quasi solo Rebora, ma sottoponendo la sua lezione a un’ulteriore depurazione (delle immagini ad es.). La sua distanza dai modi poetici più consueti è enorme: dove un poeta di solito mette un’immagine, Ranchetti mette un pensiero. E non credo si sia mai occupato di poetica o di tecniche poetiche. La biografia, la sociologia, almeno nel suo caso, aiutano fino ad un certo punto. Sì, è un borghese, è un cattolico, ma ciò non spiega questo tipo di poesia. E davvero queste sono ancora poesie? La domanda non è provocatoria, perché qui la letteratura viene cancellata. Egli le volta le spalle, guarda altrove, neppure “l’attraversa”, come si dice. Si tratta, invece, di una stenografia dell’anima che delira e, per afferrarne il codice (se si ha la tenacia o la fiducia di poterlo afferrare...), bisognerebbe rifare tutto il «percorso conoscitivo» che l’autore afferma di aver abbreviato e «fissato in punti di illuminazione e di ombra». Pag. 86 Mondi che finiscono Massimo Cappitti In un breve scritto intitolato Furore in Svezia Ernesto De Martino si chiede perché, inaspettatamente, i giovani svedesi diano vita - «senza premeditazione e senza organizzazione senza capo e senza scopo»1 - a manifestazioni caratterizzate da un inesplicabile «furore distruttivo». Questi episodi di violenza, infatti, non sono diretti in particolare contro qualcuno o qualcosa. Non esistono un piano o un progetto entro cui si inscrivono, né sono finalizzati al raggiungimento di un obiettivo, qualsivoglia sia la sua natura. Sembrano, piuttosto, rispondere a un «richiamo misterioso» come se quei giovani ubbidissero ad una religione le cui regole fossero note solo a loro e che, per consolidarsi, richiedesse epifanie così clamorose. Vi è, nel prodursi di questi atti, una gratuità radicale e assoluta, determinata a restare tale, senza la ricerca di mediazioni o di istanze destinate a rappresentarla. In effetti «questi ribelli senza causa non si propongono rapina o vendetta nel senso comune di queste parole: sono mossi da un impulso di annientamento delle persone e delle cose».2 Li anima, cioè, il desiderio di «ridurre in cenere il mondo», ovvero di trascinare la realtà apparentemente ordinata e consolidata nel nulla da cui proviene. Eppure, come cercherò di mostrare, credo che non solo di questo si tratti, ovvero di una esplosione di cieca e immotivata violenza, come sembra sostenere De Martino. Ritengo, infatti, che, di quegli eventi, De Martino evidenzi soltanto il carattere distruttivo, trascurando, invece, il fatto che quelle manifestazioni, al di là delle intenzioni di chi vi prende parte, determinano, anche, una rottura nell’ordine dominante, portandone così alla luce, insieme alla sua infondatezza, la sua revocabilità. Svelano, in tal modo, seppure in maniera inconsapevole e confusa, la fragilità e la contingenza del fondamento su cui la realtà si regge e dal quale trae la pretesa di vigere e di valere, come se, inamovibile, essa potesse, immune dagli «strappi del tempo», durare per sempre. Il reale, allora, in quegli istanti di furore, appare, finalmente, come effettivamente è: una costruzione di senso labile e infondata perché si affaccia sull’abisso da cui, con fatica, ha preso forma, pronta a rientrarvi perché preda del potere corrosivo che sempre la insidia.3 1 E. De Martino, Furore in Svezia, in Furore simbolo valore, Feltrinelli, Milano 2002, p. 167. De Martino si riferisce, in particolare, a un episodio di violenza urbana avvenuta la sera di capodanno del 1956 a Stoccolma. 2 Ivi, p. 168. 3 Riprendo, a questo proposito, le intuizioni di Castoriadis a Poliscritture/Letture d'autore L’ordine dei significati, pertanto, appare rovesciabile e le concrezioni di senso – salde solo all’apparenza – perdono la loro presa, cosicché i possibili inespressi e latenti nelle pieghe della storia tornano, leibnizianamente, a rivendicare il loro diritto ad esistere. Si produce, così, una sospensione nel corso ordinario del tempo grazie alla quale nuove forme potrebbero affermarsi. Allora, le manifestazioni di violenza parossistica e gratuita rivelano, seppure in modo contraddittorio, insieme all’infondata pretesa dell’esistente a porsi come unico e definitivo, altre prospettive capaci di scardinarne l’univocità. All’improvviso, accostati, appaiono, l’uno accanto all’altro, il vecchio mondo destinato a morire e il nuovo ancora di là da venire. La «potenza di eversione», però, altrettanto repentinamente come è sorta, si esaurisce e declina senza che da essa nascano legami significativi: la sua opera resta incompiuta. «Le bande temporanee si sciolgono così come si sono formate, senza lasciare traccia di rapporti oltre la scarica distruttiva».4 Tutto, allora, si ricompone come se nulla fosse accaduto, come se fosse impossibile a quegli eventi di raccogliersi e precisarsi in un’esperienza. In questa enigmatica repentinità – di formazione prima, poi di disgregazione – risiedono, contemporaneamente, la forza e la «vulnerabilità» della massa, l’ebbrezza dello slancio e del superamento dei limiti e, insieme, la stanca e rassegnata caduta, accompagnata dal presentimento della fine imminente che non tollera ulteriori differimenti, perché gerarchie e ruoli devono essere ripristinati e le differenze ribadite. Cose, persone, rapporti, istituzioni riacquistano i loro profili rassicuranti e l’ordine, che finalmente sembrava capovolto, riprende la sua abituale configurazione. Nel momento della «scarica» - quando, cioè, la massa, come scrive Canetti, davvero esiste perché i suoi componenti «si liberano dalle loro differenze e si sentono uguali»5 - proprio nel punto più alto della sua potenza, inizia il suo declino. Rimangono, allora, solo «l’angosciata esplosione di puro furore distruttivo»6 e la forza di negazione esercitata a caso. De Martino, però, sembra non considerare il valore liberatorio di questa esperienza, intravisto, invece, da Canetti. Non solo, quindi, un furore estremo ma anche «l’attacco a tutti i confini» e la distruzione del potere vincolante delle immagini, espressione di gerarchie prive, ormai, di ogni legittimità. Se la «rigidità» granitica di quelle immagini rappresentava il contrassegno della loro «permanenza» e stabilità, ora, invece, «travolte», cui rinvio per un approfondimento di questo tema. Tra i libri di Castoriadis si vedano L’immaginario capovolto, Elèuthera, Milano 1987; L’istituzione immaginaria della società, Bollati Boringhieri, Torino 1995; L’enigma del soggetto, Dedalo, Bari 1998; Finestra sul caos, Elèuthera, Milano 2007. Cfr. anche i libri di Mario Pezzella, Narcisismo e società dello spettacolo, Manifestolibri, Roma 1996; Il volto di Marilyn. L’esperienza del mito nella modernità, Manifestolibri, Roma 1999. 4 E. De Martino, Furore in Svezia, cit., p. 168. 5 E. Canetti, Massa e potere, Adelphi, Milano 1981, p. 21. 6 E. De Martino, Furore in Svezia, cit., p. 168. Pag. 87 «giacciono in rovina».1 De Martino scorge in quella violenza giovanile soprattutto l’emergere dell’angoscioso sentimento di «essere afferrati dalla violenza del non umano»,2 l’attrazione per il caos magmatico che soggiace ad ogni costruzione. I giovani di Stoccolma, nel momento in cui accettano di spegnere «il lume della coscienza vigilante» e di «annientare» tutto ciò che «testimonia a favore dell’umanità e della storia», sembrano ispirati più dalla freudiana pulsione di morte che dallo spinoziano desiderio di vita. Risuona, pertanto, nella loro «abdicazione» alla «persona», intesa come «centro di decisione e di scelta secondo valori»,3 il cupo fascino dell’indistinto e la «nostalgia del nulla». Gli eventi svedesi, dunque, mettono in scena la fine del mondo, la possibilità che questi, senza remissione, rovini definitivamente. Balena, in quel momento, il «rischio radicale» - che mina ogni cultura, destinandola alla morte - «di non poter iniziare nessun mondo possibile»,4 di non intravedere un «oltre» capace di ricomporre i frantumi in una nuova formazione di senso. De Martino distingue, a questo proposito, tra l’esperienza della fine di “un” mondo, «esperienza salutare, connessa alla storicità della condizione umana»,5 segnata da passaggi temporali – le età della vita, ad esempio – e la fine “del” mondo, possibilità mortale per una cultura o un individuo quando non includa «un progetto di vita» in grado di «mediare una lotta contro la morte». Allora «l’energia morale che sopravvive alle catastrofi dei suoi mondi»6 si inaridisce, chiudendo culture e singoli nella loro incomunicabile privatezza. Se De Martino è inquietato dalla rinuncia all’esercizio critico della ragione, dall’immediatezza che, di là da ogni forma, si manifesta deflagrando, tuttavia sa bene che eventi simili hanno, da sempre, accompagnato nelle società il delicato – perché potenzialmente letale – passaggio dal caos al cosmo. Nelle culture tradizionali, però, la sovversione dei valori condivisi veniva, attraverso il rito e il mito, imbrigliata e incanalata in forme riconoscibili che ne impedissero lo scatenamento incontrollabile. Il rito, facendo coincidere «aspetti di distribuzione e di annientamento dell’ordine sociale vigente» e «l’opposto momento della reintegrazione dell’ordine e del ripristino dei valori sociali e morali»,7 permette di attribuire un sembiante rassicurante all’«inatteso» che minaccia di fluidificare i confini e rendere indeterminate le appartenenze e le identità. Non solo, nel momento in cui il rito consentiva di asse1 E. Canetti, Massa e potere, cit., p. 23. Scrive Canetti: «Sono i forti suoni di vita di una creatura nuova, le grida di un neonato. La facilità con cui si suscitano li rende ancora più graditi; tutti si uniscono nel grido, e il fracasso è l’applauso delle cose». ( p. 23) 2 E. De Martino, Furore in Svezia, cit., p. 169. 3 Ibidem. 4 E. De Martino, La fine del mondo, Einaudi, Torino 2002, p. 630. 5 Ibidem. 6 Ivi, p. 631. 7 E. De Martino, Furore in Svezia, cit., p. 170. Poliscritture/Letture d'autore gnare un senso all’«angoscia della storia», alla frattura che ne interrompeva lo svolgimento lineare, contribuiva a trasformare le tendenze distruttive in strumenti di rinnovamento dell’esistenza e di una «nuova fondazione simbolica». Come scrive Balandier, il rito «fa di ciò che provoca conflitto, lacerazione sociale e decadimento individuale un fattore di ricostruzione e di coesione».8 Garantisce, quindi, la rielaborazione collettiva del culto e, contemporaneamente, la possibilità di sperimentare, nel momento stesso in cui viene meno un mondo, un nuovo inizio. Quell’antica modalità religiosa, tuttavia, è scomparsa e con essa le narrazioni capaci di fornire un orizzonte allo sfaldamento delle forme e di «offrire una risoluzione culturale all’impulso di distruzione».9 Appare, però, sterile – nonché equivoca e pericolosa come ogni «gergo dell’autenticità» che indichi nell’origine immutabile, nel tempo prima dei tempi, la pienezza del senso poi perduta negli smarrimenti della storia – ogni nostalgia per un mondo ormai tramontato. D’altra parte, la «democrazia laica», secondo De Martino, non ha ancora trovato narrazioni sostitutive altrettanto efficaci di quelle tradizionali, sebbene paia profilarsi un «nuovo umanesimo» che, da un lato, potrebbe restituire alle vite una nuova chance di raccogliersi in unità dotate di senso e, dall’altro, portare a compimento «un piano di controllo e di risoluzione culturale della vita istintiva»10 che consenta ai mondi di finire senza che il mondo finisca. Posizione fragile perché inscritta ancora in una concezione progressiva della storia, fondata sulla convinzione che i nuovi valori umani si affermino irresistibilmente grazie alla loro ragionevolezza riconoscibile, nel tempo, da tutti. Resta la lucidità profetica di De Martino che ha saputo cogliere i segni della possibile catastrofe del mondo – della sua fine definitiva e immedicabile – presagio del furioso attacco capitalistico condotto in questi anni al vivente. 8 G. Balandier, Il disordine. Elogio del movimento, Dedalo, Bari 1991, p. 49. 9 E. De Martino, Furore in Svezia, cit., p. 171. Scrive De Martino: «Furore e impulso distruttivo erano dunque, attraverso la iniziazione stimolati a esplodere, ma al tempo stesso ricevevano uno schema mitico e cerimoniale che li trasformava in simboli della possessione da parte di un nume, in visibili testimonianze di una nuova esistenza, e nell’acquisto di un ruolo sociale definito nel quadro di un rinnovamento totale della comunità nel suo complesso». (p.172) 10 E. De Martino, Furore in Svezia, cit., p. 174. Scrive De Martino: «Si è verificata una crisi delle credenze tradizionali, ma gli individui non trovano ancora nella società i modi adatti per partecipare attivamente alla esperienza morale che alimenta la democrazia laica, e per sentirsi protagonisti del suo destino». (p. 174) Poco sopra si legge: «È da tempo che una cupa invidia del nulla, una sinistra tentazione da crepuscolo degli dei, dilaga nel mondo moderno come una forza che non trova adeguati modelli di risoluzione culturale, e che non si disciplina in un alveo di deflusso e di arginamento socialmente accettabile e moralmente conciliabile con la coscienza dei valori umani faticosamente conquistata nel corso della millenaria storia dell’Occidente». (p. 173) Pag. 88 Rimangono inevase, per il pensiero critico, alcune questioni fondamentali che riguardano, ad esempio, la ridefinizione del rapporto tra democrazia e capitalismo o il profilarsi della democrazia autoritaria come forma di governo della società attraverso la produzione, come scrive Marx, di stati di eccezione. Altresì resta aperta la domanda come possa il novum «sorgere dall’ordine e a sfuggire ai vincoli che questo impone».1 Domanda tanto più urgente quanto più insistenti i diversi poteri fanno sentire le loro voci. Allora, diventa tanto più necessario riabilitare il pensiero e la pratica del conflitto contro il pensiero dell’ordine e del disciplinamento, poco importa se imposto con la forza o attraverso il «totalitarismo morbido» e il potere seduttivo e ipnotico delle merci nel mondo ridotto ormai, come ha sottolineato Anders, a pura «esposizione pubblicitaria». Occorre, intanto, - e non è poco - «produrre una diversa descrizione del mondo nella quale la considerazione del movimento e delle sue fluttuazioni prevalga su quella delle strutture, delle organizzazioni, delle permanenze».2 Si tratta, infine, di salvaguardare, del reale, quella felice e feconda ambivalenza irriducibile ad ogni formalizzazione definitiva, ad ogni identità costrittiva, a ogni rigida “naturalizzazione” che condanni l’umano a un destino di soggezione irriscattabile e insuperabile. <-- Per una critica dialogante [mc] Ernesto De Martino ha stimolato un altro commento (era già accaduto sul n. 3, a partire da La terra del rimorso). Non mi meraviglia che uno dei padri della demoantropologia italiana possa suscitare interesse. Quel che risulta fuorviante è il fatto che entrambi i commenti trascurino di segnalare che i testi sui quali si esercita la loro lettura, pur ripubblicati nel XXI secolo, furono scritti quasi cinquant’anni prima. In particolare Furore in Svezia fu pubblicato nel 1959 e nel ’62 incluso in Furore simbolo valore (Milano, Il Saggiatore). Alla luce di questa puntualizzazione, l’ultima parte del testo di Massimo Cappitti sembra almeno in parte ingenerosa: chi avrebbe potuto nel ’57 o nel ’58 (quando presumibilmente fu scritto Furore in Svezia) porsi il problema della ridefinizione del rapporto tra democrazia e capitalismo o quello del profilarsi della democrazia autoritaria come forma di governo? Credo poi che il testo demartiniano da cui Cappitti prende le mosse, breve com’è, andrebbe compreso e presentato entro l’insieme degli scritti che nell’edizione lo accompagnano, e forse anche a partire dal complesso della produzione dell’autore sull’argomento. Ernesto De Martino fu uno storico delle religioni e scrisse tra gli anni ’40 e i primi anni ’60 del secolo passato (morì nel maggio del ’65) focalizzando la sua attenzione soprattutto sul Meridione d’Italia. Sulla problematica al centro dell’articolo di Massimo Cappitti può essere letto molto largamente: da Il mondo magico a La fine del mondo, passando attraverso Morte e pianto rituale nel mondo antico, Sud e magia, La terra del rimorso e Furore simbolo valore (tutti, mi sembra, ripubblicati di recente). E certo l’efficacia delle analisi, la tensione etica e sociale, il valore anche letterario della scrittura gli conferiscono interesse, anche dopo cinquant’anni e anche al di fuori dell’area disciplinare d’origine. Dedicandogli l’attenzione che il complesso dei suoi scritti merita, contribuiremo anche a sfatare la convinzione – erronea ma abbastanza diffusa – che la demoantropologia sia disciplina di facile assunzione e praticabilità. I giovani di Vidari Proprio la possibilità di lettura plurale di un autore ne dimostra fecondità e grandezza: questo è il caso di De Martino. [Massimo Cappitti] 1 G. Balandier, Il disordine, cit., p. 19. 2 Ivi, p. 18. Poliscritture/Letture d'autore Pag. 89 7 Sulla giostra delle riviste per capire chi s’allontana e chi s’accosta Storia della rivista «Fogli di informazione» Paolo Tranchina con la collaborazione di Maria Pia Teodori Premessa La rivista «Fogli di Informazione» nasce a Milano, nel 1969, figlia della contestazione e delle lotte antistituzionali, dall’incontro cioè tra il “Collettivo di intervento nelle istituzioni”, e l’équipe dell’ospedale psichiatrico di Gorizia, allora diretto da Agostino Pirella. Dopo circa un anno di incontri, il gruppo, alla fine del 1970, inizia la pubblicazione di un bollettino ciclostilato. Ne seguiranno 13 numeri, fino al settembre 1972, quando esce il primo fascicolo a stampa, il N° 01, firmato da Vittorio Gregotti e Luca Petrella. È la prima serie stampata, con la copertina marrone, di carta da pacchi, e il numero grosso, in alto a destra, che dura nove anni, fino al N° 70 nel 1980. Ad essa seguono, dall’anno dopo la morte di Franco Basaglia, altri 116 numeri, fino al N° 205. È la seconda serie stampata, con il bordo superiore colorato e il labirinto in prima pagina, la grafica è di Giovanni Troni. Nel 1984 comincia la collana dei «Fogli di Informazione», che da allora ha stampato 35 libri. La grafica è di Giovanni Anceschi. L’editore è stato, fino al 2006, il Centro di Documentazione di Pistoia. Il nuovo editore è la DBA di Firenze, una associazione informatica no-profit. La nuova grafica è di Luca Marzi che ha elegantemente integrato le precedenti copertine. Con Zurigo avevo scelto di andare direttamente alle fonti di un sapere che mi affascinava, la psicologia analitica, lavorando con un gruppo di docenti molti dei quali erano stati diretti allievi di Carl Gustav Jung. Gli analisti dell’Istituto erano estremamente colti e attenti allo sviluppo di ogni singolo allievo, portando avanti una cultura capace di spaziare oltre il provincialismo, il bigottismo nostrani, approfondendo sistematicamente l’ermeneutica simbolica e tenendo insieme l’universale e il particolare. Per questo è con profonda riconoscenza che ricordo Adolfo Guggenbuhel-Craig, Marie Louise Von Franz, Dieter Baumann, Dora Kalff, per non citare che alcuni dei docenti che hanno preceduto il successivo lavoro con Norman Elrod. A Milano vivevo in una comune in cui c’era anche Mario Mariani, da poco entrato alla televisione come regista. L’atmosfera della casa era ricca e stimolante: politica, cinema, cultura, psicanalisi, e anche psichiatria alternativa, ovviamente. Avevo infatti letto “Che cos’è la psichiatria ?”, edito nel 1967 dall’Amministrazione Provinciale di Parma, curato da Franco Basaglia. “Quando ho finito a Zurigo, è con questi qui che voglio lavorare”, avevo pensato, per cui seguivo con attenzione l’evolversi delle esperienze alternative italiane. Frequentavo anche il Centro di Piazza Sant’Ambrogio, dove Pierfrancesco Galli portava avanti il suo discorso antiaccademico di rottura con il monopolio della cultura analitica delle società di psicoanalisi. Era un ambiente ricco e stimolante, frequentato da giovani psichiatri e psicoterapeuti che il giovedì confluivano al Centro da tutto il Nord Italia per lavorare con Silvia Montefoschi, Enzo Codignola, Emanuele Gualandri, Giambattista Muraro, Giampaolo Lai, Berta Neumann, per fare l’analisi di gruppo con Enzo Morrone, seguire i seminari di Gaetano Benedetti e Joannes Cremerius. In quella sede, avevo organizzato un gruppetto di giovani operatori appassionati che si riuniva cercando uno sbocco operativo alla loro voglia di cambiare il mondo. Frequentavamo anche la casa di Giorgio Galli, dove confluivano intellettuali di diversa matrice e dove la psicoanalisi e la psicologia analitica incontravano la politica, la letteratura, la sociologia, la storia, sotto lo sguardo attento, ospitale, della padrona di casa: Anna Guerrieri. Eravamo poi in contatto, tra gli altri, con Tito Perlini, Mario Spinella, che aveva da poco fondato “Utopia”, Aldo Rovatti, giovani filosofi che facevano capo ad “Aut Aut”. La nascita dei «Fogli di Informazione»: Milano, Zurigo Londra, Edimburgo Verso la fine dell’estate del 1969 frequentavo il secondo anno dell’Istituto Carl Gustav Jung di Zurigo, e dividevo il mio tempo tra la Svizzera e Milano, dove avevo cominciato a lavorare come analista privato e militavo in Lotta Continua. A ripensarci erano veramente formidabili quegli anni, come ha scritto Mario Capanna, sembrava praticamente che non ci fosse quasi bisogno di dormire, e che ognuno di noi fosse indispensabile, almeno in due o tre posti, sempre, contemporaneamente. Agli inizi di settembre del 1969, Mario Mariani ritorna dal Festival del Cinema di Venezia, con una notizia bomba. Ha conosciuto Franco Basaglia, hanno discusso a lungo di psichiatria e informazione, psichiatria e politica, di prospettive di comunicazione a largo raggio. Sembra che finora Basaglia abbia avuto una certa diffidenza rispetto ai media per la loro capacità di distorcere ogni messaggio. Con Mario però si sono piaciuti, per cui alla fine lo ha invitato a fare un film con lui sulle esperienze Poliscritture/Sulla giostra delle riviste Pag. 90 antipsichiatriche inglesi. Si deve infatti recare a Edimburgo per un congresso di psichiatria sociale, in cui verrà festeggiato Maxwell Jones, uno dei fondatori della comunità terapeutica, che lascia l’Inghilterra per tornare negli USA, il suo paese d’origine. Sulla via di Edimburgo, ed eventualmente anche al ritorno, Basaglia si fermerà a Londra, per riprendere le esperienze di Laing, Cooper, Kingsley Hall, il loro network. Mario mi offre di accompagnarlo nel viaggio come interprete e parte per Londra con una équipe della TV. Due giorni dopo lo raggiungo. A Londra avevamo una base operativa da una signora che conosceva bene sia la situazione italiana che quella inglese. È stato lì che ho conosciuto Franco Basaglia, che scherzava in dialetto veneto sulla leadership, sul potere, sui miti, con un gusto infantile e arguto, prendendomi e prendendosi in giro. Da allora sono cominciate due settimane frenetiche. A Londra abbiamo intervistato il network del gruppo di Laing e Cooper: Sidney Briskin, Leon Redler, Roy Battersby, persone molto colte, appassionate, che credevano in quello che facevano. L’impressione era quella di un gruppo estremamente capace, critico, differenziato, che sapeva prendere in carico efficacemente la follia, anche se aveva problemi di inserimento nelle strutture pubbliche. Ronald Laing era una persona dall’intenso fascino e un profondo carisma. Con la sua sciarpa nera intorno al collo, gli occhi penetranti, una gestualità e una mimica allusive, ricordava un noto ritratto di Dickens giovane, i capelli lunghi ordinati. Nel suo interloquire, costruiva tesi su tesi, antitesi, fino a giungere a domande inequivocabili. Altre volte, invece, continuava ad aprire nuove frasi dipendenti fino a perderne il senso, la consequenzialità possibile, per ritrovarli poi, all’improvviso, da un dettaglio che sembrava dimenticato, con un “Ah, ah” liberatorio e arguto: l’intuizione, il nuovo punto di coscienza critica raggiunto, di cui lo stesso Laing gioiva, sembrando piacevolmente sorpreso. Il suo studio era arredato con una semplicità che generava fiducia, un gusto che ispirava confidenza. Con lui, come con gli altri, Franco non lesinava domande, approfondimenti, specificazioni, anche se nel rapporto non cercava lo scontro. Si sentiva che stavano dalla stessa parte della barricata. Al gruppo si era aggiunto Angel Fiasche, uno psicoanalista argentino e le verifiche con Franco si facevano sempre più raffinate, profonde, con Franco che puntava sempre dritto, intransigente, all’aspetto sociale, collettivo, istituzionale, che cercava di cogliere il senso politico delle esperienze, il loro valore collettivo, le ideologie implicite o esplicite che le caratterizzavano. David Cooper ci ha ricevuto in una stanza estremamente confortevole, in cui ci si sentiva subito a proprio agio. La stanza, odorosa di incenso, aveva le pareti dorate e il pavimento, coperto di tappeti, era cosparso di cuscini di diversa forma e colore, con una delicata luce soffusa. Le risposte di Cooper erano precise, articolate, consequenziali. Non c’erano lacune nella sua costruzione del discorso, partiva da un punto e arrivava ad un altro, su tragitti logici, razionali. Per entrare a Kingsley Hall, la prima casa famiglia della storia, credo, abbiamo chiesto, non solo formalmente, il permesso agli ospiti. In fondo a una stanza, non molto illuminata, una bellissima ragazza alta, con lunghe trecce curate, Poliscritture/Sulla giostra delle riviste accudiva con dolcezza un bambino. Tutta la situazione era molto semplice, modesta, al limite della povertà, ma non era mai sciatta. Abbiamo anche incontrato Mary Barnes, una donna dagli occhi sfavillanti, il volto forte, risoluto, che ha fatto per noi un bellissimo quadro. Un sole coloratissimo, a rilievo, giallo, rosso e arancione si stagliava nell’azzurro chiaro del cielo sopra l’azzurro carico, profondo, del mare. Nonostante l’aspetto modesto, si respirava a Kingsley Hall un intenso senso di tranquillità, di accettazione, come di un posto dove si può stare in pace, ritrovare la pace con se stessi. Proprio un luogo “dove andare a ritrovare se stessi, in caso di bisogno”, come ci aveva detto Cooper. Solo la casa di Dora Kalff, l’inventrice della terapia della sabbia, a Zollikon, vicino a Zurigo, mi ha dato un simile vissuto di accettazione. Anche Franco era stato colpito dall’esperienza e discuteva animatamente delle sue possibilità di diffusione, di utilizzazione pratica. Riportava, infatti, ogni proposta terapeutica all’interno di tematiche istituzionali, politiche. La passione che ci metteva, il fatto di avere alle spalle l’esperienza di superamento del manicomio, tutto il ribollire di tematiche politiche, antistituzionali, di quegli anni in Italia, davano al suo discorso uno spessore critico, una incidenza concreta, che spesso mancavano ad altri. Per sentire meglio il polso della gente ha voluto anche che facessimo delle interviste agli hippies che bivaccavano a Piccadilly Circus, ad altre persone che frequentavano quell’ombelico del mondo. Microfono in mano, seguiti passo passo dalla telecamera, lui faceva le domande e io le traducevo: “Crede che la psichiatria abbia qualcosa di sociale?”. “Ci sono rapporti tra psichiatria e politica?”. “Cosa è la follia?”. “Cosa è la normalità?”. A Edimburgo, al congresso di psichiatra sociale abbiamo trovato Franco molto in forma, abbiamo fatto molte interviste, a Jurgen Ruesch, ad americani, inglesi, non sembravano molto consapevoli dei rapporti tra psichiatria e politica, o almeno non quanto Franco che, però, non infieriva. Con Maxwell Jones è stato molto affettuoso, deferente, mi sembra proprio che lo considerasse un padre positivo, e anche Maxwell Jones gli parlava con affettuoso rispetto. Non a caso, infatti, Franco aveva voluto che uno dei suoi primi collaboratori di Gorizia, Lucio Schittar, facesse una lunga esperienza in Scozia. Evidentemente Franco lo apprezzava molto, sentiva che la sua esperienza era stata molto importante per la deistituzionalizzazione in Italia, anche se insisteva, nella critica, sulla necessità di recupero di forza lavoro, dopo la guerra, che aveva determinato quelle esperienze di apertura e sul pericolo che si trasformassero in gabbie d’oro, se non si procedeva a creare strutture territoriali diffuse. L’atmosfera del Dingleton Hospital, l’ospedale psichiatrico di Maxwell Jones a Melrose, in Scozia, a pochi chilometri da Edimburgo, era interessante e aperta al confronto. Oltre che sulla messa in questione delle gerarchie istituzionali, per creare una terapeuticità orizzontale, nel dibattito Pag. 91 sull’apprendimento sociale si metteva molto l’accento sul problema emozionale, fondamentale per i nuovi rapporti terapeutici. Su questi aspetti Maxwell Jones aveva giocato molto e un episodio successivo conferma la centralità della dimensione affettiva nei processi di apprendimento sociale. Qualche anno più tardi, nel 1976, ero con Agostino Pirella a Palo Alto, negli USA, al Mental Research Institute, per una verifica della situazione italiana e la presentazione dei primi risultati delle esperienze del Soteria Project, con Alma Menn e Loren Mosher. C’era anche Maxwell Jones, molto vivace e in forma. Come è noto, il progetto Soteria, ripreso in Europa da Luc Ciompi a Berna, si articola sulla gestione delle crisi di giovani psicotici in piccole comunità residenziali con personale addestrato di non profess ionisti. A Palo Alto, in una riunione a cui partecipava anche Jones, gli operatori del Soteria Project hanno illustrato la loro pratica, arricchendola con la proiezione di diapositive. Parlando dell’orario di lavoro hanno riferito che consisteva in 48 ore consecutive, seguite dai cinque giornate di libertà. Jones si è meravigliato di questi turni e ha chiesto come potevano gli operatori metabolizzare collettivament e le emozioni di particolari momenti, come potevano cioè mantenere una continuità affettiva, oltre che relazionale, se tutto il gruppo si rivedeva solo dopo cinque giorni. Gli operatori hanno glissato sull’argomento e Maxwell Jones dopo aver ribadito altre due volte la necessità di tempi minimi entro cui elaborare emozioni e comunicazioni, senza razionalizzarle, non ricevendo il debito ascolto se n’era andato. Ripensandoci, il tema dell’affettività è sempre stato centrale nel pensiero di Basaglia, nelle sue pratiche, nella sua capacità di coinvolgere, indignarsi, implic arsi in prima persona. A Melrose, in Scozia, comunque, avevamo avuto modo di visitare e di filmare anche alcune case famiglia fuori dall’Ospedale di Dingleton. Alcune simpatiche vecchiette erano state molto contente di mostrarci le loro casette linde e ordinate, offrendoci gentilmente il tè, per nulla intimorite dall’armamentario delle riprese. A differenza di Kinsgley Hall, che era promossa dal gruppo privato della Philadelphia Association, questa case famiglia erano una emanazione dell’ospedale, e le signore che le abitavano, il frutto di intensi processi di riabilitazione della lungodegenza. Ero veramente felice di essere andato in Inghilterra. Avevo visto in prima persona alcune delle esperienze più avanzate nel nostro campo, alle quali, pur criticamente, le nostre esperienze si rifanno, godendo della irripetibile opportunità della costante critica radicale di Franco Basaglia, arricchita anche della dialettica del sistematico confronto psicanalitico con Angel Fiasche. Cosa potevo sperare di più? La notte prima di lasciare Londra ho fatto un sogno. Ero in una specie di cattedrale gotica dalle volte altissime e sottili, soffuse di una luce verde. Davanti all’altare mi inginocchiavo e Franco Basaglia con una spada, mi investiva cavaliere Poliscritture/Sulla giostra delle riviste toccandomi, con la punta, le spalle e la testa. Per il rapporto con i media, però, purtroppo, Basaglia non aveva avuto ragione. Non solo il film di Mario Mariani non è mai stato programmato in televisione, ma negli archivi della Rai-TV se ne sono perse addirittura le tracce. Tutto ciò che resta, oltre alle interviste pubblicate sulla “Maggioranza Deviante” 1 , è un metro e mezzo di pellicola da 16 millimetri della ripresa di una mia intervista a Ronald Laing. L’avevo tenuta come souvenir, prendendola durante il montaggio della pellicola. Gorizia Tornato a Milano il rito di iniziazione londinese ha cominciato a sortire i suoi inevitabili effetti. Ho rafforzato il gruppo di riflessione critica tra psichiatri e analisti disponibili. Con Guido Medri e altri abbiamo contestato, cosa non semplice, Pierfrancesco Galli per certi aspetti della sua gestione del Centro di Piazza Sant’Ambrogio, ho cominciato la mia lunga marcia nelle istituzioni al Reparto Rigola del manicomio di Mombello. A dicembre ero a Gorizia, due settimane di full immersion nelle dinamiche coinvolgenti e inaspettate di quell’ospedale, diretto allora da Agostino Pirella. Altri membri dell’équipe goriziana erano Domenico Casagrande, Vincenzo Pastore, Vieri Marzi, Nicoletta Goldschmidt, Ernesto Venturini. Non è stato difficile innamorarmi di Gorizia, cogliere la novità assoluta del suo messaggio antistituzionale, partecipando quotidianamente a situazioni, atteggiam enti, risposte che rovesciavano punti di vista consolidati, paradigmi di rapporto apparentemente intoccabili, il tutto alimentato dalla presenza stimolante, ricca dei pazienti, dalla attenzione critica, riflessiva, continua dell’équipe, le interazioni tra volontari, il giudizio analitico, articolato, di Agostino Pirella. Ho avuto modo di apprezzare la calma e la profonda saggezza della signora che dirigeva l’assemblea generale e che mandava avanti una piccola trattoria all’interno dell’ospedale, cosa che mi ha poi dato, quando lavoravo ad Arezzo, lo spunto per mettere su la tavola calda sul Colle del Pionta 2. Mi sono lasciato trasportare nella realtà di Grado, da Dosolina, una vecchia pescivendola che conosceva tutti. Mi aveva scelto durante un’assemblea nel reparto di Casagrande, con altre pazienti eravamo andati a trovare le sue amiche, la sua famiglia. Viaggiando, avevo scoperto il significato della frasca appesa lungo le strade. Erano mescite di vino. La cosa che mi aveva più colpito era stata però la capacità di gestione dell’équipe, l’acutezza nel decodificare la follia rispondendole senza colludere coi suoi aspetti regressivi, lo spessore dell’impegno terapeutico. In particolare, mi aveva impress ionato la gestione 1 Vedi: Franco Basaglia, Franca Ongaro Basaglia, Paolo Tranchina, Mario Mariani : L’impossibile strategia, in: F. Basaglia, F. Ongaro Basaglia : La maggioranza deviante: l’ideologia del controllo sociale totale, Einaudi, Torino, 1971, pag. 103-129. 2 Vedi P. Tranchina: La tavola calda, un momento antistituzionale di coinvolgimento collettivo, «Fogli di Informazione», N° 14 , 1974 p. 215-220 Pag. 92 di una giovane paziente: Bruna M.. La ragazza, che era stata dimessa, doveva iniziare il giorno dopo un lavoro a Trieste. Sin dalla mattina si era presentata in ospedale cominciando una serie di provocazioni, atti di rottura. All ’azienda agricola aveva tirato una pala a Vieri Marzi, senza colpirlo, vicino alla portineria aveva tirato un flacone di medicine contro Vincenzo Pastore che era finito contro le vetrate. Prima di sera, entrata nella direzione di Pirella, aveva stracciato alcune lettere del suo tavolo. Il problema era di resistere alle sue provocazioni cercando di mitigare la sua ansia, senza colludere con la sua distruttività. Pensavo al setting, agli orari rigidi, e li confrontavo con la disponib ilità di tutta una istituzione di continuare a gestire la crisi, senza reprimere, fino a che non si trovava una soluzione adeguata. Durante la riunione con i volontari che, a Gorizia aveva luogo tutte le sere, Bruna si era presentata, sempre in crisi, dicendo che voleva essere seguita da Pirella. Pirella le aveva risposto con fermezza che poteva scegliere chiunque volesse nell’équipe, ma non lui. La sera tardi, infatti, ho visto Bruna che andava a dormire con una volontaria nello stesso albergo dove risiedevo, e, in seguito, ho saputo che le cose a Trieste erano andate bene. Oltre all’insieme dell’ospedale e dell’équipe, è stata specialmente la figura di Agostino che mi ha colpito, le sue capacità dialettiche, la ricchezza della sua cultura, l’incisività che lo portava immancabilmente alla radice delle contraddizioni. In particolare, mi aveva affascinato la sua coscienza politica, l’estrema raffinatezza delle sue analisi istituzionali, in grado di collegare il particolare al generale, e poi quel suo modo di pensare che, per ogni problema, lo portava prima a generalizzare, allineando situazioni, aspetti simili, per poi raggiungere improvvisamente la conclusione, confermando o contraddicendo, in modo indiscutibile, le tesi iniziali. Della sua disponibilità, della sua sensibilità empatica rispetto alle psicosi, avrei fatto esperienza ad Arezzo, nel lavoro di deistituzionalizzazione. Ad Arezzo la porta del suo studio era sempre aperta, il suo atteggiamento sempre disponibile all’ascolto. Anche se sapeva perfettamente come metterti di fronte alle tue responsabilità. Alcune volte veniva in un reparto in crisi e con la verifica rovesciava totalmente la situazione. Altre volte ci diceva: “Andate a discutere con gli infermieri finché non trovate qualcosa”. Prima di lasciare Gorizia, nel gennaio 1970, con Pirella abbiamo cercato qualcosa da fare insieme, per dare corpo ai nostri discorsi: un ponte tra Milano e Gorizia che continuasse, allargandolo, il nostro incontro, il rapporto affettivo, culturale, politico, che si era instaurato tra noi. I membri dell’equipe di Gorizia sarebbero venuti mensilmente alla Casa della Cultura di Milano, presentando la loro esperienza e discutendone collettivamente. Il gruppo informale di psichiatri, psicoterapeuti, volontari che avevo organizzato al Centro di Piazza S.Ambrogio, aveva finalmente trovato le persone giuste e stava accingendosi a diventare, trasformandosi profondamente, “Il Collettivo di Intervento nelle Istituzioni”. Poliscritture/Sulla giostra delle riviste II Collettivo di Intervento nelle Istituzioni di Milano e i «Fogli di Informazione» ciclostilati Le prime riunioni con i goriziani, nel 1970, che purtroppo non abbiamo registrato, sono state molto ricche, entusiasmanti. C’erano psicanalisti svizzeri, psichiatri, scrittori, operatori del Centro Nord, studenti, volontari. Tra gli altri ricordo lo psicanalista Bernard Rotschild, di Zurigo, lo scrittore Ottiero Ottieri. Il centro di discussione era Gorizia e le pratiche alternative, la deistituzionalizzazione, ma il discorso si allargava sul disagio psichico nei suoi rapporti col sociale, i rapporti tra tecnica e politica, psicanalisi e istituzioni. Dalla fine del 1970 abbiamo cominciato a registrare le riunioni formalizzandole. Abbiamo iniziato a raccogliere l’elenco degli indirizzi dei partecipanti. Sono così nati i «Fogli di Informazione» ciclostilati, tredici numeri per circa 300 pagine. In ogni fascicolo, insieme al resoconto dell’ultima riunione, mettevamo uno o due articoli che costituivano l’argomento di discussione per la riunione successiva, di cui si indicava data e luogo. Sfogliando quelle pagine emerge una enorme ricchezza: la psichiatria in Vietnam, le carceri in Usa, la repressione in Sudamerica, si affiancano ad accesi dibattiti sulla situazione psichiatrica di Torino, Milano, Udine, Gorizia, Arezzo, Firenze, Napoli, ai nuclei essenziali della deistituziona lizzazione, della lotta contro l’esclusione, dibattiti sui centri di riabilitazione per gli handicappati, riflessioni sulla scuola media a tempo pieno, le classi differenz iali, l’educazione antiautoritaria, interventi contro i licenziamenti al carcere minorile Beccaria di Milano, riflessioni sull’uso alternativo della psicoanalisi nella scuola, verifica del lavoro dell’analista nelle istituzioni psichiatriche, i prodromi delle dimissioni dell’equipe di Gorizia per l’impossibilità di allargare l’esperienza sul territorio, il ruolo dei partiti, del sindacato. Ripercorrendo queste pagine ciclostilate sono stato sorpreso dalla loro pregnanza narrativa, dalla forza della critica, gli abbozzi di teorie, la freschezza delle nostre passioni. A volte traspare anche una certa ingenuità, cortocircuiti tra speranze e pratiche, semplificazioni, ma senza quella passione i manicomi continuerebbero a dettare legge, a fare scempio di identità, sofferenze, non avremmo mai scritto “Manicomio ultimo atto” 1. Eravamo ossessionati dai rapporti tra tecnica e politica, dalla paura che le nostre battaglie fossero riassorbite dal sistema, che fossero inutile riformismo. E come continuità, sostanza, c’era tutta una cultura alternativa che faticava ad affermarsi e cercava alleanze, riconoscimenti, i fondamenti teorici della propria identità. La riflessione sul potere in rapporto all’operatività possibile investiva sia i tecnici che occupavano i massimi livelli delle gerarchie psichiatriche, sia specialisti isolati e controcorrente, sia i volontari che operavano come potevano, dove potevano, con minimi livelli di potere. 1 Vedi P. Tranchina, M. P. Teodori: Manicomio Ultimo Atto: bilanci, rischi, prospettive della chiusura definitiva degli ospedali psichiatrici in Italia, Editrice Centro di Documentazione, Pistoia 1996 Pag. 93 1 Vedi: Relazione del gruppo dell’Ospedale Psichiatrico di Gorizia, in: Pierfrancesco. Galli (a cura): Psicoterapia e scienze umane: Atti dell ‘ VIlI congresso internazionale di psicoterapia, Feltrinelli, Milano 1973 p. 161-184 2 Vedi: P. Tranchina: Il potere in psicoterapia. «Fogli di Informazione» N° 7, 1973, p.247-252 3 Gli altri membri erano: Marina Saviotti, Almachiara Dusi, Lilia D’Alfonso, Alfonso D’Alfonso, Giuseppe Miccolis, Annamaria Fabbrichesi. Cecilia Morosini. Poliscritture/Sulla giostra delle riviste sistematicamente abbiamo approfondito la nostra cultura politica, facendo tesoro delle capacità di Mario Spinella 4. Nel 1987 il Centro di Via Giussano si è trasformato in Associazione di Studi Psicanalitici, e attualmente, come scuola riconosciuta di psicoterapia, continua una intensa attività di formazione. Intanto, nell’estate del 1971, Pirella si era spostato da Gorizia all’Ospedale psichiatrico di Arezzo, Basaglia era andato a dirigere l’ospedale psichiatrico di Trieste. I dibattiti del Collettivo di Intervento nelle Istituzioni, sempre estrema mente vivaci, critici, si aprivano su orizzonti pratico-teorici nuovi, raccoglievano nuove sfide antistituzionali. Anche il numero di partecipanti si allargava, si differenziava, nuovi operatori come Gianfranco Pittini, Arcadio Erlicher, Fausto Matteini, Veniero Galvagni. Agostino Contini si O. Garbin, Ritratto di Basaglia In quegli anni, infatti, il gruppo di volontari che lavorava a Mombello, nome corrente che si dava all’OP Antonini di Limbiate, e in altri ospedali, si era molto rafforzato. A Mombello con una psichiatra che ci appoggiava, Zenaide Malavasi, cercavamo, tra l’altro, di opporci alle lobotomie, convincendo i parenti a non firmare il consenso scritto che era indispensabile perché si potesse fare l’intervent o. Sostenevamo poi il lavoro di apertura che con fatica il dr. Orsi portava avanti nel suo reparto. Al gruppo dei volontari di Mombello partecipava anche Cristina Lanni, compagna di Vittorio Gregotti. Spesso ci riunivamo a casa loro. È stato quindi naturale, quando abbiamo deciso di fare i «Fogli di Informazione» stampati, chiedere a Gregotti di disegnarci la copertina. Anche in campo analitico, non mancavano fermenti. Francesco Ruffini, compag no di Silvia Montefoschi, discutendo con i suoi pazienti privati, era giunto alla conclusione che l’analisi non bastava, per cui aveva favorito la creazione di un piccolo centro dove i pazienti potevano incontrarsi tra di loro. Nei seminari di casistica, con Emanuele Gualandri, oltre che gli aspetti psicodinamici cercavamo di decifrare le componenti che potevano collegare struttura e sovrastruttura. Enzo Morpurgo aveva organizzato un ambulatorio psicanalitico gratuito nel quartiere di Niguarda. Pier frances co Galli e membri del PSIUP avevano lavorato a una ricerca per cercare di cogliere le motivazioni psicodinamiche profonde del qualunquismo. Nel 1970, dopo l’VIlI congresso internazionale di psicoterapia - in cui i goriziani hanno avuto un ruolo importante 1 e anche io, presentato da Sergio Piro, ero intervenuto 2 - il Centro di Piazza S. Ambrogio aveva cessato la sua attività. Pierfrancesco Galli, infatti, aveva deciso di trasferirsi a Bologna. Coordinandoci, in dodici, Guido Medri, Mariella Loriga, Ciro Elia, Teresa Corsi e altri 3, abbiamo fondato il Centro Studi di Psicologia Clinica e di Psicoterapia di via Alberto Da Giussano, di cui sono stato presidente dal 1970 al 1972. Il Centro era veramente, in quegli anni, un momento di riflessione alta e interdisciplinare. Oltre a Benedetti, Cremerius, Morrone anche Mauro Rostagno ci ha fatto dei seminari, e affiancavano ai goriziani, ai primi frequentatori come Giampaolo Guelfi, sempre particolarmente attivo, Enrico Pascal di Torino, Ponte di Genova, Simone Wender e Allegri di Pavia, Sergio Piro di Napoli, Alberto Parrini di Firenze, Milly Fumagalli e Dinni Cesoni, di Milano. Con alcuni di loro, Guelfi, Parrini, Piro, ecc., ci eravamo anche scontrati vivacem ente con Diego Napolitani e il suo gruppo, contestando duramente le pretese egemoniche della psicoanalisi, e obbligandolo a diffondere a tutti i partecipanti al I seminario su ‘’psichiatria comunitaria e socioterapia” una nostra relazione “ analisi sociopolitica delle istituzioni”, discutendola in una apposita riunione. Dato, però, che Napolitani, molto democraticamente, non l’ha pubblicata negli atti del seminario, l’abbiamo pubblicata 4 Vedi, per esempio l’interessante dibattito con Mario Spinella, Norman Elrod, Giovanni Jervis, ecc. sul problema della soggettività, rispetto alla classe in Marx. In: A A VV: Resoconto dell’ultima riunione, Milano 7 ottobre 1972, «Fogli di Informazione» N: 2 , p.44-62 1972 Pag. 94 noi insieme ad altri documenti che criticano gli interventi di Fornari, Pagliarani, Perruzzotti, Resnik, Shiller, Charmet, ecc. Mi sembra quindi chiaro che il “Collettivo di Intervento nelle Istituzioni”, nonostante l’organizzazione “debole”, informale, era dotato di grande capacità di coinvolgimento, alleanze, incisività critica e operativa sugli obbiettivi che sceglieva di darsi e che perseguiva con efficacia. Come molti gruppi a quei tempi, era estremamente curioso, radicale, dotato di grande mobilità, e spirito di inventiva. Solo adesso, riflettendoci, mi sembra di cogliere questa sua estrema plasticità, questa capacità di lottare su tanti fronti aggregando interessi, ideali, affettività, e disaggregandosi, appena necessario, per ricostituire nuovi campi d’azione. Era proprio questa, credo, la nostra forza, questo “noi” collettivo estremamente sensibile e attento, etico, intransigente ma plastico, che, nonostante tutto, sembra continua re a trasmetterci energia, voglia di fare, se dopo quasi 40 anni siamo ancora qui a rifletterci. Nell’estate del 1972, Giuliano Capecchi del Centro di Documentazione di Pistoia ci ha proposto di stampare il bollettino fino allora ciclostilato, dato che la domanda era aumentata. I «Fogli di Informazione» stampati Dal 1972 a oggi abbiamo stampato 186 numeri. In essi tra l’altro abbiamo discusso delle nuove facoltà di psicologia a Roma (n. 16), dei soggiorni estivi a Trieste (n.23-34) e a Firenze (n.35-36), della situazione psichiatrica di Napoli (n.25-26) e di Ferrara (n.27-28), di tossicodipendenze a Verona (n.30), di sessualità e condizione operaia a Terni (n.31-32), di servizi territoriali a Reggio Emilia (n.33-34) e a Settimo Torinese (n.3536), di superamento dell’ospedale psichiatrico a Volterra (n.39-40), dei rapporti tra psichiatria e terremoto a Gemona (Udine), (n.41-42). Il loro contributo di documentazione, riflessione critica, ricerca, è davanti agli occhi di tutti. Numero dopo numero i Fogli hanno puntualmente verificato l’applicazione della legge 180, i suoi successi, i suoi ritardi, denunciando prontamente ogni tentativo di snaturamento dei suoi contenuti fondamentali e battendosi attivamente contro tutti i tentativi di controriforma. Linee fondamentali della rivista Possiamo così riassumere le linee fondamentali della rivista: I) Documentazione meticolosa delle pratiche nella loro complessità. 2)Confronto sistematico con le tecniche, psico anal isi, terapia familiare, psic of arm aci. 3) Collegamento continuo tra istituzioni e società, tecnica e politica. 4) Critica della scientificità degli strumenti e delle istituzioni in rapporto alle deleghe, ai processi di es clus ione. 5) Attenzione alla quotidianità, alla convivenza, al gruppo, al fare collettivo, alla critica all’erg ot e Poliscritture/Sulla giostra delle riviste rap ia e quindi valorizzazione del lavoro e imp res a sociale, (19) autoaiuto e reti sociali. 6) Rigoroso, intransigente, atteggiamento etico che ha sempre cercato di porre al centro, col massimo rispetto, la dignità degli psichiatrizzati, degli esclusi, la loro soggettività. 7) Tentativo di approfondire sistematicamente i processi di riproduzione della normalità insieme a quelli della devianza, della follia. 8) Attraverso atteggiamenti di empatia allargata, l’identificazione con gli oppress i, la cultura dei Fogli si è incentrata sul paradigma dell’ultimo. In questo senso, particolarmente importanti sono stati i libri della collana dei Fogli. Fondamentale è stata anche, negli anni, la collaborazione con Norman Elrod e il suo gruppo di Zurigo-Kreuzlinghen 1. Importante anche il lav or o del gruppo di Psicoterapia Concreta di Firenze che ha fatto corsi e incontri, riflettendo in particolare sul concetto di inconscio istituzionale, un ponte lanciato tra psicanalisi e pratiche di deistituzionalizzazione. Come si può notare, i rapporti tra il movimento e la psicoanalisi sono ben più ricchi e articolati di quant o a volte non appaia. E ben lontani da semplici negazioni, dettate a volte dall’urgenza del fare 2. In questa sede non posso passare sotto silenzio l’enorme sforzo della redazione del “Portolano di psicologia”, realizzato insieme a Enrico Salvi, Maria Pia Teodori, Sandra Rogialli 3 che ha sintetizzato in un volume la totalità delle tematiche essenziali delle pratiche alternative (130 autori, 111 articoli) arricchend ole con quan to di più importante, vivo ha visto la luce in campo psichiatrico, psicoterapico, psicologico, psicanalitico. II CD ROM dei “Fogli” Per il convegno di Trieste del 1998 “Franco Basaglia: la comunità possibile” (20-24 Ottobre), abbiamo realizzato un CD rom che costituisce una banca dati consultabile in linea, una volta inserita nel computer. Sono quasi 2000 articoli, quasi tutti con l’abstract italiano, molti con abstract anche in inglese, tutti con le parole chiave (descrittori maggiori e minori, indicatori). Ho caricato anche i «Fogli di Informazione» Ciclostilati e il “Portolano”, e il mio libro di Supervisioni: Un sagittario venuto 1 Per la collaborazione con Norman Elrod e il suo gruppo, l’Istituto di psicoanalisi di Zurigo Kreuzlingen, Vedi: Fogli di informazione № 107 ( gennaio 1985) 2 Il gruppo di Psicoterapia Concreta, attivo a Firenze dal 1990, di cui faccio parte insieme a Vieri Marzi, Mario Santini, Annibale Fanali, Maria Pia Teodori, Sandra Rogialli, Enrico Salvi, Maridana Corrente, Sandro Ricci, Alfredo Lo Cigno, Cesare Bindioli, attraverso momenti di riflessione e seminari di formazione, lavora a una ricerca approfondita sul problema delle psicosi, la loro terapia, riflettendo in particolare sul concetto di “inconscio istituzionale”, un ponte tra inconscio individuale freudiano e inconscio collettivo junghiano. 3 P. Tranchina, E. Salvi, M.P. Teodori, S. Rogialli, Portolano di psicologia: esperienze prospettive convergenze di una professione giovane, Editrice Centro di Documentazione, Pistoia, 1994 Pag. 95 male, Editrice Centro di Documentazione Pistoia, 1997, e qualche altro libro 1. Da sottolineare anche il fatto che il CD contiene un thesaurus di termini controllati e rappresenta, credo, la prima esperienza informatizzata nel nostro campo. Ultimi sviluppi Nel 2006 si conclusa la lunga collaborazione con il Centro di Documentazione di Pistoia. Il nuovo editore è la DBA di Firenze, una struttura informatica no-profit, che, tra le altre cose, ha distribuito ISIS, il sistema informatico gratuito dell’Unesco, ai paesi in via di sviluppo. INDIRIZZI Direzione: Paolo Tranchina, Viale don Minzioni 29, 59129 Firenze tel. 055570842 e-mail: [email protected] Editore: DBA Associazione, Via Santucci 1 50127 Firenze tel. (39) 055435777 fax 0554376833 e-mail: fogli@dba. it POSTSCRIPTO Ritengo utile concludere questo intervento con il postscripto al testo di Serrano e Pini, scritto in collaborazione con Maria Pia Teodori. A pochi mesi dal trentennale della legge 180, che i Fogli d’Informazione celebreranno con un numero speciale: 180 XXX Anno, al quale stiamo lavorando intensamente, questo testo rappresenta un momento alto di maturità e di sintesi del movimento che dalla chiusura dei manicomi ha investito il territorio con interventi sempre più efficaci e partecipati, dalla istituzione negata alle istituzioni inventate. Protagonisti 12 utenti che, addestrati all’eccellenza dall’Università, intervistano mille persone lavorando sullo stigma e, approfondendolo, ne minano i lineamenti, ne intaccano lo spessore, la coriacea immutabilità normativa, insieme alla propria sofferenza psichica. Ritratto di Costantinopoli Firenze 7 marzo 2008 1 Per le supervisioni vedi anche: Paolo Tranchina: Forme di Vita, supervisione, psicoterapia, lavoro di equipe, Editrice Centro di Documentazione, Pistoia 2002 Poliscritture/Sulla giostra delle riviste Pag. 96 8 Riprese temi da non perdere di vista Ripensando alla concezione borghese della convivenza fra i popoli in margine al “caso armeno” Giulio Toffoli …Non è mai un documento della cultura senza essere insieme un documento della barbarie. E come non è esente da barbarie esso stesso, così non lo è neppure il processo di trasmissione per cui è passato dall’uno all’altro. Il materialista storico, quindi, prende le distanze da esso nella misura del possibile. Egli considera suo compito spazzolare la storia contropelo» (W. Benjamin, Sul concetto di storia, VII, Einaudi, Torino, 1997, pag. 31) Fra le testimonianze della millenaria storia anatolica, che dimostrano come quella regione sia stata terra di continue migrazioni, di inesausti conflitti e di sovrapposizioni di culture, certo meritano particolare menzione quelle costituite dalle rovine della città di Ani, la capitale dell’antico regno armeno che fra il IX e il X secolo d.C. ebbe il controllo di una fetta significativa dell’Anatolia orientale1. Le grandi dinastie dei Bagratuni, degli Artzrouni, dei Kamsarakan, dei Siouni dominarono, in diversi periodi, l’Armenia feudale. Si è trattato di un’egemonia, che si è estesa su un territorio che dalla catena del Caucaso scende fin nella parte profonda dell’altopiano anatolico, caratterizzata da una costante labilità dei confini. Quella degli Armeni è stata una storia di continui scontri che si sono declinati nelle più diverse forme: ostilità familiari e tribali, conflitti sociali ed economici, contrapposizioni tra fondamentalismi religiosi e infine soprattutto conflitti razziali. Un coacervo di scontri di potere che non ha trovato una soluzione, se non molto parziale, per tutta la fase del plurisecolare dominio ottomano. Il caso della famiglia dei Bagratuni, anzi, può essere considerato esemplare di questa storia davvero particolarmente intricata, visto che questa possente famiglia della nobiltà caucasica, ed è solo un esempio fra i vari possibili, era divisa in due rami, con estesi domini feudali, uno di discendenza armena e uno di discendenza georgiana, che in momenti diversi hanno governato sullo stesso territorio contendendosi la leadership delle stesse genti, degli stessi villaggi, degli stessi pascoli, de- 1 In generale per la storia armena dall’antichità alla realtà contemporanea risulta utile la silloge curata da Gerard Dedeyan, Histoire des Armeniens, Privat, Paris, 1982 e Claire Mouradian, De Staline à Gorbatchev. Histoire d’une rèpublique soviétique: l’Arménie, Editions Ramsay, Paris, 1990. Poliscritture/Riprese Pag. 97 gli stessi commerci. Parlare della questione armena ci pare possa in questa prospettiva, se non si assume un forte distacco critico, diventare la premessa per avvilupparsi in un ginepraio difficilmente districabile. Il rispetto dovuto alla complessità della storia, all’analisi attenta e critica delle fonti, capace di liberarci da qualsiasi forma di pregiudizio, è l’unica strada per poter affrontare questa tematica senza trasformare, ancora una volta, la storia da disciplina che cerca faticosamente di individuare e difendere un suo statuto di scientificità in una tragica ideologia al servizio delle peggiori cause. Nella zona caucasica il rischio che la storia sia manipolata per interessi che potremmo definire, in modo eufemistico, di parte, ci appare particolarmente evidente. Non è possibile infatti dimenticarsi del tragico riemergere dopo il 1989 delle più imbarazzanti tendenze nazionaliste, di un nazionalismo sciovinista che ha visto contrapporsi, contendendosi lo stesso territorio, spesso a suon di obsolete citazioni medievali, i diversi nazionalismi, in un crescendo che si è espresso attraverso guerre interregionali, guerre civili e guerriglie più o meno sanguinose e criminali. Sul finire del XX secolo la storiografia occidentale, parallelamente al tracollo del mondo sovietico, ha ripreso la sua attività ideologica trasformandosi, almeno in alcune sue frange, in una potente lobby impegnata a fornire patenti di verità, in un modo che non è granché diverso da quello che, nel tardo XIX secolo, la storiografia positivistica utilizzava per stabilire ciò che era civile e ciò che non lo era. Questa frangia della storiografia si è ritagliata uno spazio particolarmente importante, almeno dal punto di vista della sua visibilità di fronte all’opinione pubblica, dando vita a un’originalissima ricerca fondata sulla individuazione di una specie di «hit parade» dei massacri e dei genocidi, che senza andare tanto per il sottile, basandosi su una risoluzione dell’ONU del 1948, ha iniziato a operare in modo retroattivo, secondo una strana metodologia di verità che trova, si afferma, nella stessa civiltà occidentale il suo parametro di indiscutibile certezza.1 L’intervento di Ottavio Rossani, «La Turchia di fronte alla “questione armena”»2, ci pare impostato proprio secondo un modello di tipo ampiamente apodittico che ha la premessa in questa «scienza del massacro». Cerchiamo di vedere perché. 1 Un esempio di tale tendenza ci pare rappresentato dall’attività svolta recentemente da Marcello Flores con il suo Tutta la violenza di un secolo, Feltrinelli, 2005 e il successivo Il genocidio degli Armeni, Il Mulino 2006 che si rifanno complessivamente al dibattito, che ci pare ampiamente ideologico, sul XX secolo come secolo del male, più o meno assoluto. Su problema più generale della creazione di una logica della «contabilità del terrore» si veda il lavoro di Domenico Losurdo, Il peccato originale del Novecento, Laterza, 1998, cui rinviamo come riferimento complessivo sull’intero problema della ricostruzione storica basata su una selettività ideologica che potremmo definire eufemisticamente «conservatrice». 2 Facciamo esplicitamente riferimento al saggio presente nel Numero 3 della rivista «Poliscritture», novembre 2007. Le citazioni in corsivo sono tratte dall’articolo di Rossani. Poliscritture/Riprese Partiamo dal primo tragico dato, quello dei numeri. Una strana moda si è consolidata dopo l’89 e tende ad affrontare le tragedie del XX secolo secondo una logica quantitativa. Verrebbe da dire, se non risultasse forse un poco blasfemo: chi più ne ha più ne metta! Sappiamo che la burocrazia ottomana non era certamente fra le più capaci di realizzare un censimento obbiettivo della popolazione dell’impero. Comunque secondo i dati della Sublime Porta, che non si capisce perché dovrebbero essere pregiudizialmente considerati falsi, la popolazione armena dell’impero doveva, intorno al 1914, assommare a circa 1,2 milioni di sudditi. I dati del patriarcato armeno parlavano invece di 2,1 milioni di Armeni presenti all’interno dei confini dell’impero. Già qui si evince la difficoltà di un’analisi oggettiva su quale delle due valutazioni fosse quella esatta3. Non ci addentreremo neppure nell’analisi tecnica delle diverse vicende, delle violenze contro la popolazione armena e riconosciamo senza ombra di dubbio che qualsiasi sia stata la cifra ben poco conta il numero, si è trattato sempre di una tragedia inaccettabile, un massacro come tanti innescati dalla guerra, anzi dalle guerre imperialistiche. Aggiungiamo solo che non vorremmo che l’enfatizzazione di parte delle cifre (1,5 milioni o addirittura 2 milioni di morti) non sia altro che un’amplificazione ideologica che vuole nascondere il vero problema, ovvero quello di individuare quali siano state le cause di questa come di altre tragedie che segnarono il tramonto dell’impero ottomano e che non si possono semplicemente risolvere parlando di una «geopolitica dell’Ottocento ormai inattuale». Per inciso forse può essere interessante ricordare che uno storico del valore di A. Toynbee fu costretto ad ammettere che il Libro blu, da lui preparato per conto del governo inglese e che raccoglieva le denunce delle violenze turche, altro non era che «propaganda di guerra»”4. Non di meno ci lascia perplessi sentir parlare per la realtà dell’impero ottomano all’inizio del XX secolo di minoranze che «si proiettavano verso l’indipendenza nazionale» e ci chiediamo se è vero che «si proiettavano» o se, più esattamente, erano «proiettate» da una serie di rivolte fomentate da vari soggetti con una politica imperialistico-coloniale, quali erano allora Inghilterra, Francia, Russia, Italia e Austria-Ungheria, con la finalità ben chiara di dividersi le spoglie dell’impero. Alcuni movimenti nazionalisti presenti nelle varie regioni del medio oriente trovarono sostegno nell’attività diplomatica delle potenze straniere; altri movimenti vennero fomentati ad arte rispondendo così alle esigenze strategiche delle nazioni europee che ambivano alle spoglie della Sublime Porta. Ciò ovviamente generò azioni di rivolta che trovarono voce soprattutto nelle ali più radicali, ad esempio fra gruppi di Armeni che si 3 Per il problema demografico si veda: Gerard Dedeyan (a cura di), Histoire des Armeniens, cit., pag. 492/493. Merita però di ricordare che nelle varie provincie orientali dell’impero gli Armeni rimanevano ovunque una, più o meno ampia, minoranza. 4 Cfr. Robert Mantran (a cura di), Storia dell’impero ottomano, Argo Editrice, Lecce, 1999, pag. 671. Pag. 98 rifacevano a logiche di crociata anti-islamica1. Vennero avviate azioni di lotta armata (tutti sapevano che le armi circolavano fra i gruppi di combattenti armeni, provenendo dal confine russo) che si svilupparono diventando azioni di vero e proprio terrorismo, che era combattuto dal governo centrale di Istanbul con grande violenza. Ma tali affermazioni corrono il rischio di rimanere su un terreno di palese vaghezza. Forse il più prosaico ritorno alla storia, con l’individuazione di alcune date, può essere utile per farci uscire da quella indeterminazione in cui, per dirla con un «vecchio» grande maestro, si corre il rischio di trovarsi nella «notte in cui tutte le vacche sono nere». Mentre attraverso la cosiddetta «rivoluzione» del 1908 il mondo turco era alla ricerca di una nuova identità politica di tipo più «democratico», proprio attraverso l’azione riformatrice di quei militari che furono il nucleo del movimento dei Giovani Turchi1 da cui, ben diversamente da chi ne sottolinea in modo unilaterale le presunte nefandezze, emersero leader come Enver Bey, Gemal Pascià, Mehemed Cavid, Mehemed Talt e lo stesso Mustafa Kemal, senza i quali non vi sarebbe stata una Turchia moderna, l’Occidente avviava una serie di azioni che puntavano alla dissoluzione del mondo ottomano2. Si tratta di interventi che andavano dalla decisione unilaterale dell’Impero d’Austria-Ungheria di incamerarsi la Bosnia Erzegovina nel 1908, alla guerra di aggressione italiana in Libia del 1911-12, all’esplosione delle guerre balcaniche del 1912-13. Ci chiediamo: si può parlare allora di «processo di disfacimento» per l’impero ottomano o piuttosto sarebbe più onesto dire che si trattava di un disegno di smem1 Varrebbe la pena analizzare il problema della presenza all’interno del mondo politico e culturale armeno, all’inizio del XX secolo, di due anime quella nazionalista e quella classista marxista in lotta fra di loro. Anche qui, come nel resto dell’Europa, lo scoppio della Grande Guerra elimina la contraddizione dando spazio a forme di acceso nazionalismo, reso ovviamente ancora più tragico dalla peculiarità della condizione della popolazione armena. Sul problema della guerriglia armena si legga Guenther Lewy, Il massacro degli armeni. Un genocidio controverso, Einaudi, 2006, pag. 39 e segg.. 2 La «rivoluzione» dei Giovani Turchi è tematica storica degna di ben altra considerazione, rinviamo in generale a: A.M. Porciatti, Dall’impero ottomano alla nuova Turchia, Alinea Editrice, Firenze,1997. Si aggiunga, per meglio comprendere la complessità dei giochi che si svolsero in quella tragica estate del 1914, quanto scritto da Stanford J. Shaw: «In realtà, la maggior parte degli ottomani, e quasi tutti i Giovani Turchi, simpatizzavano per le democrazie liberali dell’Intesa, sulle quali contavano per essere aiutati nei loro programmi di riforma. La maggioranza preferiva tener fuori del tutto l’impero da una guerra in cui si confrontavano ambizioni e interessi quasi solo europei. Quando però l’odiata Russia si schierò con l’Intesa e l’Inghilterra confiscò due corazzate ottomane…l’ammirazione per il genio militare prussiano… e la direzione del ministro della guerra Enver Bey permise(ro) a quest’ultimo… di firmare un accordo segreto con la Germania, che trascinò gli ottomani… nella guerra appena iniziata». S.J.Shaw, La rivoluzione turca e il crollo dell’impero ottomano, in La storia I Grandi problemi dal Medioevo all’Età Contemporanea, vol. 9, L’Età Contemporanea, 4 – Dal primo al secondo dopoguerra, UTET, 1986, pag. 143/144. Poliscritture/Riprese bramento che aveva come naturale esito finale proprio la scomparsa del mondo turcoottomano come entità statale autonoma? Siamo inoltre proprio convinti che vi fu un preciso disegno politico militare che coordinò lo sterminio degli Armeni? Come non tenere conto piuttosto dello stato di grande difficoltà militare e di disorganizzazione che l’impero stava vivendo in quel momento e che l’autenticità dei documenti secondo i quali il governo dei Giovani Turchi avrebbe ordinato nella primavera del 1915 lo sterminio sistematico degli Armeni è da molti studiosi giudicata per lo meno dubbia? Inoltre come dimenticare che dalla Russia venivano precisi inviti alla ribellione? Lo zar Nicola II non aveva perduto il suo tempo e il 17 settembre 1914 aveva indirizzato ai suoi sudditi armeni un appello che era palesemente diretto anche ai loro «confratelli» d’oltre confine: «Armeni, i popoli di tutta la grande Russia si sono levati al mio comando. Armeni dopo cinque secoli di giogo tirannico, durante i quali voi e i vostri fratelli avete subito e alcuni ancora subiscono i più abominevoli oltraggi, l’ora della libertà è infine suonata per voi…»3. Proprio in quel momento nella zona del confine caucasico le armate dello zar, dopo il tragico inverno del 1914 che aveva visto le truppe turche sbaragliate dai russi e annientate dalla disorganizzazione interna alle forze armate del Sultano4, stavano avanzando, trascinando sulla loro scia una serie di battaglioni costituiti da volontari armeni dell’intero Caucaso5. In tale frangente decine di migliaia, anzi più probabilmente alcune centinaia di migliaia di mussulmani, ma anche di cristiani non armeni, se non ebbero la fortuna di trovare salvezza nella fuga, furono sterminati senza pietà. L’avanzata russa continuò per parte dell’anno successivo, il 1916, portando all’occupazione temporanea, fino allo sbandamento delle truppe russe sul finire dell’inverno 1916-17, di un largo territorio nell’Anatolia centrale fino a Trabzon e Erzincan. Le popolazioni mussulmane di 3 A.Debidour, Histoire diplomatique de l’Europe. Depuis le congrès de Berlin jusqu’à nos jours, II Vers la Grande Guerra (1904-1916), Librairie Félix Alcan, Paris, 1918, pag. 274 . 4 Questo aspetto meriterebbe un’analisi più approfondita, che facesse i conti con la mentalità dei ceti dominanti dell’epoca. Una disfatta militare che comporta l’occupazione di una parte significativa di un territorio nazionale e viene vissuta come un’azione cui contribuisce o può contribuire una quinta colonna interna può generare reazioni, più o meno violente, sia pure eticamente difficili da giustificare? Si pensi per esempio alle parole usate, nel momento dell’ingresso degli USA nel primo conflitto mondiale, da una personalità di spicco come l’ex presidente Theodor Roosevelt: «…non c’è posto per una doppia lealtà; colui che dice di professarla «è necessariamente un traditore nei confronti per lo meno di un paese» ed è «da abbattere senza pietà»», Domenico Losurdo, Il peccato originale del Novecento, cit., pag. 38. Certo militarmente la campagna caucasica dei Turchi fu a dir poco tragica, vide la distruzione del IX e dell’XI corpo d’armata, generando il timore di un tracollo militare complessivo del fronte orientale e lo spettro di una rivolta alle spalle delle popolazioni armene. Palesemente l’argomento rimane aperto e non è nostro fine risolverlo in queste poche righe. Fra l’altro si veda anche Robert Mantran (a cura di), Storia dell’impero ottomano, cit. pag. 668. 5 Questo tema presenta un certo interesse per ciò che riguarda il contributo delle unità di volontari armeni per il successo della offensiva d’inverno scatenata dai Russi. Il problema è trattato da Guenther Lewy, Il massacro degli armeni. Un genocidio controverso, cit., pag. 129/140. Pag. 99 quelle contrade in quei mesi pagarono un pesante tributo di sangue di cui troppo spesso nessuno si ricorda. È certo infatti che i censimenti del dopoguerra mostrarono in modo irrefutabile che proprio in quei mesi, fine 1914inizio 1917, non solo le popolazioni armene ma anche le altre genti anatoliche, insomma le masse dei ceti popolari, contadini e urbani, delle varie etnie, furono vittime di violenze, in cui certo ebbero la loro parte le tragiche misure repressive turche ma anche le vendette su larga scala operate dalle truppe armeno-russe1. Rossani aggiunge che «per molti decenni del genocidio degli Armeni nessuno parlò», ma è poi vero2? Ci sembra impressionante, leggendo queste parole, come venga falsificato il processo storico e schiacciato il problema della drammatica realtà vissuta da quell’intera regione in quella frenetica fase storica. Come dimenticare che nel 1917 i rivoluzionari russi smascherarono i giochi delle diplomazie occidentali e fecero conoscere al mondo ciò che le cosiddette «potenze democratiche» avevano deciso di fare dell’intera Anatolia e più in generale del Medio Oriente? Forse merita di essere rammentato che accordi segreti del maggio 1916 (si noti la data!) avevano diviso l’impero fra Inghilterra, Francia e Russia e la zona di Erzurum, Trabzon, Van e Bitlis, insomma la zona cosiddetta armena, era stata ceduta, senza nessun particolare patema morale, a Nicola il Sanguinario. In seguito l’opera di smantellamento sistematico dell’impero ottomano era continuata a livello diplomatico con un’ulteriore divisione che cedeva una fetta meridionale dell’Anatolia persino all’Italia e si era conclusa con la famosa dichiarazione di Balfour del novembre 1917, che apriva la strada a un quasi secolare contenzioso arabo-ebraico e a una breve, ma non meno tragica, guerra greco-turca del primo dopoguerra3. Nel contempo l’Office of War Propaganda, segretamente installato dal Foreign Office britannico a Wellington House, sul Buckingham Gate di Londra si impegnò con grande solerzia, nel tentativo di dare un senso a una guerra che vedeva l’opinione pubblica sempre più scontenta e delusa, a raccogliere notizie per propagandare l’immagine, accanto alla barbarie tedesca, della barbarie turca4. Tale propaganda ebbe come esito l’arresto nel 1918 di ben 120 fra politici e intellettuali 1 Si legga, ad esempio, Robert Mantran (a cura di), Storia dell’impero ottomano, cit., pag. 670. 2 Cfr. O. Rossani, cit, pag. 48. Inutile sottolineare che la tragedia armena fu ben conosciuta, si ricordi solo la pubblicazione dell’opera di Franz Werfel, I quaranta giorni del Mussa Dagh, 1933 che ebbe vasta risonanza mondiale. Per un approfondimento su questo tema, con una articolata bibliografia, si rinvia al testo completo presente sul sito della rivista. 3 In tale prospettiva meriterebbe forse di essere ricordata anche la guerra turco-greca del 1919-22, con il suo tragico fardello di massacri, stimolata dal disegno politico delle forze dell’Intesa. In questo caso la storiografia dominante ha cercato di sorvolare sull’argomento, solo i Greci se ne ricordano, forse perché viene messo in forse il facile schema della «logica del terrore». Fu infatti l’azione delle nazioni vincitrici dell’Intesa a stimolare i Greci alla guerra e poi li abbandonarono al loro destino. Rimane il dubbio: la costa ionica dell’Egeo è «storicamente» greca o turca? I Greci hanno diritti a ritornare in possesso di quelle terre? Ci chiediamo però se ciò non inneschi un meccanismo che annienta lo stesso paradigma nazionale dando via a un contenzioso infinito. 4 Su questo tema si può approfondire il discorso con la lettura di Robert Mantran (a cura di), Storia dell’impero ottomano, cit., pag. 680 e segg. e Guenther Lewy, Il massacro degli armeni. Un genocidio controverso, cit. Poliscritture/Riprese turchi di primo piano, internati a Malta e liberati dopo il 1922 senza che si fosse arrivati a nessuna imputazione formale5. Il tentativo di smembrare la Turchia venne bloccato dalla lotta dei Turchi di Mustafa Kemal, che riuscirono ad espellere dal territorio dell’Anatolia gli invasori europei. D’altronde solo la cecità «revisionista» oggi tanto di moda può parlare del popolo armeno come di un popolo senza patria. Infatti dopo il 1918 gli Armeni hanno avuto non solo una patria ma anche un luogo dove è stata difesa la peculiarità culturale e linguistica della loro tradizione. Per quel che ci è dato sapere proprio la tanto deprecata Armenia Sovietica aveva creato, per conservare il ricordo della civiltà e della storia armena, una grande biblioteca dove sono stati custoditi i più preziosi capolavori della arte della miniatura e della cultura di quel popolo. È forse qui che si vede la differenza con l’enfasi della nuova Armenia e il suo impressionante e, ci si consenta, «retorico» braciere! Quel fuoco è paradossalmente mantenuto vivo, fra l’altro, da una legione di storici statunitensi, francesi e armeni, contro cui ben poco possono le argomentazioni degli storici turchi che debbono essere «stolte» di principio, oppure di color che hanno intenzione di indagare questa tragedia con la maggior obiettività possibile6. Oggi tutto è organizzato affinché all’opinione pubblica mondiale venga rammentato non tanto il dramma dei popoli coinvolti nella criminale assurdità di una guerra imperialistica per la spartizione del mondo ma l’esistenza di un Olocausto Armeno. Tale impostazione favorisce lo spostamento del paradigma storico dalla responsabilità delle borghesie imperialiste occidentali al presunto primitivismo culturale e civile islamico. In questo modo il revisionismo storico si trasforma in un giustificazionismo etico e in uno strumento politico. Fin qui le cosiddette problematiche storiche; ora passiamo al versante «politico» che ci permettiamo di credere sia quello che sta alle fondamenta di tanto interesse storico revisionista. Cosa chiede il governo della moderna Repubblica «borghese» dell’Armenia? Che la Repubblica nazionalista della Turchia prenda le distanze dal paese dell’epoca del 5 Tale opera di internamento e il tentativo di creare un tribunale internazionale tipo «Norimberga» ci pare un segnale esemplare. Una tale azione non venne effettuata infatti nei confronti del sovrani di Germania o Austria-Ungheria, per i quali vennero fatte deboli pressioni diplomatiche per sottoporli a processo, subito bloccate da una specie di solidarietà conservatrice fra le forze della reazione borghese europea. Contro la Turchia, in quanto realtà nazionale extraeuropea, che era evidentemente in una condizione gerarchica inferiore, era lecito agire con quella violenza che non si poteva usare con Guglielmo II o Carlo I. 6 Ovviamente ciò non vuol dire schierarsi dalla parte di coloro che difendono l’odierna legislazione turca che tende a difendere dogmaticamente il primato dell’etnia turca. Su questo tema, che sottolinea come la repressione contro le minoranze etniche si unisca a un più ampio discorso di intolleranza politica nei confronti di chi si fa portavoce di una superiore speranza di costruzione di una società più giusta, si vedano gli articoli pubblicati sul numero di Alias, l’inserto de il Manifesto, di sabato 26 gennaio 2008 sotto il titolo di «Siamo tutti Hrant, siamo tutti armeni Un’altra Europa è nata a Istanbul, il 19 gennaio scorso. Rifondata dal basso, dai 10 mila turchi scesi in piazza per ricordare il giornalista di origini armene Hrant Dink, ucciso un anno fa da un fanatico nazionalista, e per abrogare gli articoli liberticidi e anticomunisti del codice penale e della costituzione…». Pag. 100 genocidio1, che «il popolo turco chieda scusa al popolo armeno»! Ma chi chiederà scusa ai turchi? Forse più semplicemente, come cittadini di questa strana realtà, con la sua traballante legittimità, che è l’Europa delle borghesie di questi primi decenni del XXI secolo, ci possiamo chiedere cosa voglia dire questo continuo «chiedere scusa», questa moda del pentitismo a tutti i livelli? Si risarcisce in questo modo qualcuno o qualche cosa? In più, in questa paradossale Europa, in cui facciamo sempre più fatica a riconoscerci, cosa vuol dire che la Francia ha votato una legge secondo la quale negare il genocidio armeno è reato? Nessuno di noi discuterà mai che una violenza di qualsiasi tipologia sia sanzionata2, ma ci chiediamo: come si comporteranno le istituzioni francesi di fronte ai vari «genocidi» degli Algerini, dei Marocchini, delle genti del Sahara, delle popolazioni della Cocincina, dei Vietnamiti, di fronte alle infinite violenze e gli infiniti stupri che hanno caratterizzato la storia della Francia coloniale dalla seconda metà del XIX secolo in poi? A quando delle leggi che riconosceranno quelle violenze, le trasformeranno in reato e condanneranno coloro che hanno fatto della Francia uno spietato strumento di inciviltà per oltre un secolo? Domande che rimangono inevase, ma la questione armena pare essere ora di gran moda… Esiste infatti una borghesia internazionale, una diaspora armena, una lobby estremamente potente che fa sentire il proprio peso. Questi esponenti sono quelli che ci informano, ci dice Rossani, che «i Turchi non cambieranno mai »(?) e che saranno il «il cavallo di Troia dal quale usciranno i mussulmani che conquisteranno il continente» (ovvero l’Europa n.d.r.). Di fronte a «tanta preveggenza» ci viene da chiederci: ma questi «sapienti» non sanno che abbiamo già in Europa, se questo fosse il problema, almeno due enclave islamiche, l’Albania e il Kosovo, che se non sono già entrate in Europa, nel dissennato disegno che si sta apprestando, ci entreranno prima o dopo? È davvero triste, ci si conceda la povertà del dire, che all’inizio del XXI secolo si chieda, ben sappiamo con quali mezzi, la «conversione» (si noti il termine!) di qualcuno alla democrazia. Ma da quale pulpito? Proprio mentre questi primi anni del nuovo secolo sono insanguinati da chi ha deciso, costi quel che costi, di farsi piazzista della democrazia, non sarebbe forse il caso di iniziare a ragionare in modo più onesto e rispettoso delle diversità, riconoscendo le colpe del nuovo tipo di neocolonialismo, dello sfruttamento del terzo e del 1 Rimane un dubbio che ci appare difficile da risolvere: se il regime kemalista e poi la realtà politica turca successiva sono oggettivamente ben distanti dal sultanato ottomano (c’è di mezzo la caduta di un impero universalista!) come può il nuovo regime assumersi le colpe di un sistema politico precedente, totalmente diverso sia dal punto di vista istituzionale che culturale? 2 Ci sia consentito un’ulteriore dubbio sulla liceità che le istituzioni politiche possano intervenire d’autorità nelle polemiche culturali. La falsità di una teoria, il fatto di essere più o meno aberrante, dovrebbe emergere dai dati obbiettivi e divenire parte dell’acquisizione di coscienza dell’opinione pubblica senza bisogno di censure. L’azione censoria ci pare faccia emergere, nonostante tutto, un pericoloso clima di caccia alle streghe che pone chi afferma di aver ragione, o ha ragione tout court, su una posizione non dissimile da chi ha palesemente torto. Poliscritture/Riprese quarto mondo, della creazione di sempre maggiori e tragiche diseguaglianze che hanno favorito una reazione che forse, certo l’argomento meriterebbe ben altro approfondimento, trova delle sue giustificazioni. A questo livello però il problema si fa più intricato: è ancora una volta il tragico gioco delle diplomazie che vede gli USA, l’Europa, la Russia e, in prospettiva, le emergenti potenze orientali confrontarsi per controllare una regione, il Medio Oriente, che rimane strategica e dove grandi masse vivono in condizioni di incredibile povertà mentre producono le materie prime che consentono all’Occidente opulento di mettere in mostra il proprio arrogante sfarzo. La creazione di «commissioni miste di conciliazione»3 appare in tale prospettiva davvero un prodotto originale di questi anni, di una volontà di riscrivere la storia secondo la nuova glossa che crede di aver esorcizzato lo spettro dell’«Ottobre» e di essere tornata a rivitalizzare, quasi nulla fosse successo nel XX secolo, ideali ormai consunti, anche se potenzialmente ancora portatori di violenza e morte, come quello di patria. Ci si dirà: ma i diritti umani? Non ci rimane di fronte alla pelosa pietas di tante «anime belle» che rimandare alle parole che Edoarda Masi scriveva due decenni fa con ineguagliabile efficacia e preveggenza: «A mascherare le contraddizioni e le diversità, la socialdemocrazia propone messaggi unificanti. Il più universale è l’appello alla tutela dei diritti umani... È la base elementare del civismo e della buona educazione. È uno degli strumenti più potenti di esorcismo e di anestesia». Settant’anni di guerre ininterrotte, rivoluzioni e controrivoluzioni, aggiungeva la Masi, hanno creato una situazione di disillusione, con una caduta della tensione etica, quasi un timore per l’azione politica, tanto da: «far scompare la differenza fra combattenti consapevoli e innocenti sacrificati, e tutti si vedono accomunati nella condizione di vittime. Sono sentimenti che implicano comprensione… Ma implicano una diminuzione della dignità umana e si accompagnano all’assunzione di una coscienza di servi. Si lascia ad altri l’onere di fare la Storia e si chiede di vivere indisturbati la propria piccola storia personale… si favorisce la polarizzazione verso un popolo di pecore contrapposto, e soggetto, a un potere esercitato da professionisti e identificato con la violenza in ogni sua forma… Quelli che esercitano la violenza come potere vogliono sotto di sé pecore con coscienza di vittime, e per mezzo dei loro pubblicitari diffondono l’etica umanitaria che dice a occhi chiusi «abbasso la violenza» e non vuole sapere altro.»4 Non è forse il caso di modificare la nostra prospettiva e volgerci ancora una volta verso il domani guardando, come ci diceva Benjamin, il passato, anche il passato prossimo, facendo un’opera di «spazzolatura contropelo»? Allora potremo vedere come, all’interno del disegno di riorganizzazione dello sfruttamento del mondo da parte dei diversi imperialismi, le borghesie e i ceti militari, sia caucasici che anatolici, pur con modalità diverse, puntano tutti all’affermazione delle 3 Cfr. O. Rossani, cit, pag. 49, che ci parla della costituzione di una «Commissione di riconciliazione turco/armena» composta da una ventina di intellettuali di entrambe le parti. Sarebbe forse il caso di domandarsi se gli «intellettuali» abbiano ancora questa funzione maieutica e se la democrazia abbia bisogno di delegare all’intellettuale funzioni di questo tipo. 4 E. Masi, Il libro da nascondere, Marietti, Casale Monferrato, 1985, pag. 73/74. Pag. 101 loro egemonie locali, dei loro privilegi e, all’interno delle diverse realtà statali, alla conferma di una stabilizzazione sociale ed economica fondata su una precisa gerarchia, che ha la finalità di conservare vantaggi e benefici a favore delle lobby di potere locali e reprimere con ogni mezzo qualsiasi forma di protesta di coloro che non partecipano al banchetto della storia e debbono accontentarsi delle briciole. È più che mai necessario, in questa situazione di grave regressione storica e intellettuale, liberarsi dall’ideologia borghese e dai suoi paradigmi falsamente umanitari e di ritornare a porre con forza all’ordine del giorno l’indicazione che Bertolt Brecht pose ai partecipanti al I Congresso internazionale degli scrittori in difesa della cultura del 1935: “…Personalmente non credo alla brutalità per la brutalità. Bisogna proteggere l’umanità dall’accusa di essere per la brutalità indipendentemente dal fatto che essa sia un buon affare. È una spiritosa distorsione quella del mio amico F. quando afferma che la volgarità vien prima dell’interesse personale. La brutalità non viene dalla brutalità ma dagli affari che senza di essa non si possono fare…Non parliamo soltanto per la cultura! Si abbia pietà della cultura ma prima di tutto si abbia pietà degli uomini!... Compagni, parliamo dei rapporti di proprietà!”.1 Ritratto di Costantinopoli 1 Si legga il fondamentale intervento di B. Brecht riportato nel volume di F. Fortini, La verifica dei poteri, il Saggiatore, 1965, pag. 176. Poliscritture/Riprese Pag. 102 9 Giochi di specchi sguardi e correzioni C’è un sito che vi attende: www.poliscritture.it “Poliscritture” ha da tempo attivato un sito che si propone come “laboratorio” della rivista e nello stesso tempo come spazio per la pubblicazione e la discussione di scritti e di opinioni. In questa puntata di “Giochi di specchi” vi offriamo un indice ragionato di quello che, in questo momento, sul sito si può trovare, invitandovi a visitarlo. Tanto per cominciare, naturalmente, sul sito trovate tutti i numeri arretrati della rivista, scaricabili in formato pdf. Questa è la home page al 21-4-2008: Sulla colonna di destra c’è un articolo che resta in evidenza per un po’ di tempo. Ora è: Poliscritture/Giochi di specchi Pag. 103 Se esaminate la colonna di sinistra ci trovate: Se cliccate su: • POLISCRITTURE Rivista trovate gli articoli pubblicati nelle varie rubriche. 1. Editoriali 2. Samizdat 3. LATITUDINI 4. Esodi 5. Storia adesso 6. Zibaldone 7. Letture d’autore 8. Sulla giostra delle riviste Se andate alla colonna di centro: Poliscritture/Giochi di specchi Pag. 104 Cliccando su: COSA C'E' DI NUOVO trovate ad es: 940. Dialogare, criticare, polemizzare e cliccando su questo titolo potete scegliere di leggere, ad es.: ________________________________________ Milano da bere e Milano dabbene dicembre 2005 di Ennio Abate che comincia così: Le passioni di Milano: undici pagine con foto grandi, raffinate e inconsuete, sei articoli e due interviste (la prima allo storico dell’arte Giovanni Agosti; la seconda - fatta nel 2003 - al compianto Giovanni Raboni). Tema: il confronto tra ieri e oggi, tra «una certa Milano» di una volta e la «Milano da vomitare piuttosto che da bere» di oggi. Ed ecco, sempre dall’home page, altri articoli in evidenza: Poliscritture/Giochi di specchi Pag. 105 Provate a cliccare su: • Dieci poesie di Vincenzo Loriga e leggerete: Passione Ascolta te stesso che mangi. Ascolta le fauci che cantano, allegre, la loro canzone. Le viscere stanno in silenzio, raccolte: son pronte al lavoro. Goditi la linda parete, le sedie in vacanza, la tavola appena imbandita. Verifica se la materia sia fredda più di un rimorso. Se andate invece su: • 29 foto negli ospedali psichiatrici attorno al 1968 di Carla Cerati trovate questa immagine solo apparentemente d’altri tempi: Se infine, per non farla lunga, volete collaborare con noi, ritornate nella colonna di sinistra in basso e cliccando su : PER CONTATTI [email protected] potete scriverci, darci suggerimenti, criticarci, farci sapere in quali specchi vi ritrovate di solito e magari anche abbonarvi ( 3 numeri 10 euro) spedendo per il momento a Ennio Abate (Poliscritture), via Pirandello 6 -20093 Cologno Monzese (Milano). Ciao La redazione di POLISCRITTURE Poliscritture/Giochi di specchi Pag. 106 I collaboratori del numero 4 Pietro Andujar. Psicoanalista non medico, socio fondatore de “La Ginestra. Associazione di cultura psicoanalitica” e per molti anni redattore della rivista omonima. Si occupa di terapia psicoanalitica delle psicosi e di psicopatologie contemporanee. Collabora con Christopher Bollas nell’E.S.G.U.T. European Study Group of Unconscious Thought, ha contatti con gruppi Freudiani e Lacaniani a Parigi (Société de Psychanalyse Freudienne e “Insistance”) e con l’American Academy of Psychoanalysis And Dynamic Psychiatry in U.S.A. È anche collaboratore stabile del “Gruppo sulla costruzione del caso clinico”, presso l’ex O.P. “Paolo Pini” di Milano. Giorgio Bedoni. Psichiatra e psicoterapeuta, lavora presso l’Azienda Ospedaliera di Melegnano, è docente al corso di perfezionamento in teoria e pratica della terapeutica artistica, Accademia di Belle Arti di Brera e presso il Centro di formazione nelle arti terapie “La linea dell’arco” di Lecco. Ferrucio Brugnaro. È nato a Mestre nel 1936 e vive a Spinea (Venezia). Operaio a Porto Marghera dai primi anni Cinquanta, ha partecipato attivamente alle lotte del movimento operaio. È stato uno dei primi in Italia a diffondere la poesia ciclostilata in forma di volantino. Ha pubblicato diversi libri ora tradotti in inglese, spagnolo, francese. Sue poesie sono apparse e appaiono frequentemente anche in molte riviste letterarie internazionali. Massimo Cappitti. Insegnante. Fa parte del Comitato del Centro Studi Franco Fortini di Siena. Collabora a diverse riviste ed è nella redazione de «La società degli individui». Anna Cascella Luciani (Roma 1941). Poeta, ha pubblicato: Le voglie in Nuovi Poeti Italiani 1, Einaudi, 1980; Tesoro da nulla, Scheiwiller All’insegna del pesce d’oro, 1990 (premio “Laura Nobile”, premio Mondello opera prima); Piccoli campi, Stamperia dell’Arancio, 1996 (premio Sandro Penna, premio “Procida, Isola d’Arturo-Elsa Morante”); i semplici, Il Bulino, 2002. Tra gli scritti di critica: I colori di Gatsby-Lettura di Fitzgerald, Lithos, 1995. Anna Maria Celso. Nata a Milano, abita a Cologno Monzese e insegna in una scuola elementare. Laureata in Pedagogia, ha conseguito in seguito un master su “La gestione educativa del disagio nascosto in classe”. S’interessa di disagio e disabilità scolastiche e ha svolto attività di consulenza pedagogica, di formazione per docenti e vari corsi di aggiornamento professionale. Ama la danza, il teatro, la lettura. Carla Cerati. Nata a Bergamo, è fotografa dal 1960. I suoi temi vanno dal teatro, al ritratto, al reportage sul paesaggio urbano e le più varie figure sociali (giovani, intellettuali, emarginati). È anche narratrice, finalista al Premio Strega nel 1973 con Un amore fraterno e autrice di numerosi romanzi, tradotti in diverse lingue. Fabio Ciriachi. È nato e vive a Roma. Ha pubblicato le raccolte di poesia L’arte di chiamare con un filo di voce (Empirìa, 1999) e Il giardino urbano (Empirìa, 2003), il volume di racconti Azzurro-cielo e verde-pistacchio, (Edimond, 2008). Ha tradotto dal francese l’opera di David Mus Qu’alors on ne se souviendra plus de la mer Rouge (RagageEmpiria, 2005). Ha collaborato come recensore alle pagine culturali de “la Repubblica” e “il manifesto”, collabora a quelle de “l’Unità”. Una seconda raccolta di racconti, L’eroe del giorno, è in corso di pubblicazione per l’editore Gaffi. Giacomo Conserva. Nato a Parma nel 1948, lì ancora vive. È stato nel ’68, nel ’77, e così via. È medico nel Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) di Parma, una figlia di 32 e uno di 3 anni. Nel ’75 tradusse per la Newton Compton William Blake, tuttora ristampato. Ha fatto molti viaggi e scritto molte poesie, diverse apparse qua e là nel lento corso degli anni. Nel ’91 pure un piccolo libro, Derive Metropolitane, per «A/traverso». Michele Ferrara degli Uberti. È nato a Roma nel 1971. Sue poesie sono uscite su varie riviste e antologie. Ha pubblicato le seguenti raccolte di poesie: I richiami della luna nuova, Fermenti, 1998; Il compagno invisibile, Liberi Editore, 2004; L’amato viaggio, il ritorno, Liberi Editore, 2006. Mario Fresa (Salerno, 1973). È autore di due raccolte poetiche, di un libro di aforismi e di un volume di prose. Ha collaborato e collabora a varie riviste, nazionali e internazionali. Cura per le edizioni di Nuova Frontiera una collana di poesia. Carla Girardi. Psicologa psicoterapeuta, docente e formatore della Scuola di formazione psicoanalitica “Il Ruolo Terapeutico” di Milano. È redattrice dell’omonima rivista. Dal 1988 opera presso il CPS di Cologno Monzese e dal 2004 svolge attività di supervisione e di riflessione con il Libero Atelier di Atiività Espressive di Cologno Monzese. Claudia Iandolo. Nata a Milano nel 1961, laureata in lettere classiche, insegna italiano e latino nei licei. Ha pubblicato per il teatro Rossa luna di Novembre e altri ( Grafic Way, Avellino 1995), per la poesia Aegre (Elio Sellino Editore, Avellino 2004), saggistica per il Centro di Ricerca Guido Dorso di Avellino, i romanzi Il paese bianco di Isidora vecchia (Mephite, Avellino 2005), Qualcuno Distratto (Palomar, Bari 2007). È apparsa sulle riviste L’Indice, L’Area di Broca, Zeta, Interpretare e Gradiva ed è presente nell’antologia Ti bacio in bocca- antologia di poesia erotica al femminile (Edizioni LietoColle). Vincenzo Loriga. Psicoanalista e scrittore. Ha pubblicato un volume di saggi, L’angelo e l’animale (Raffaello Cortina, 1990), uno di racconti, L’igrone (Zone Editrice, 2002), e tre libri di poesia: Materia (Rebellato, 1958), Regina degli inganni (con prefazione di Cesare Viviani, Crocetti 1985) e Sulla punta delle dita (Book Editore 2004) Giorgio Mannacio. È nato in Calabria nel 1932 ma è sempre vissuto a Milano. Sue poesie sono uscite su “Il Verri”, “Il Caffè”, “L’Almanacco dello Specchio”, “Alphabeta” e altre riviste. Ha pubblicato cinque libri di poesie. L’ultimo è Visita agli antenati (Ed.Philobiblion, 1996). Marina Massenz. Terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva e formatrice, è docente presso l’Università Statale di Milano per il Corso di Laurea di Educatore Professionale. Dirige la rivista “Psicomotricità” e lavora in ambito terapeutico ed educativo-preventivo con i bambini. Ha pubblicato quattro libri e molti articoli sul suo lavoro. È autrice di un libro di poesie, Nomadi viandanti filanti (Amadeus, 1995). Altre sue poesie e prose sono apparse su diverse riviste, fra cui “QUI - Appunti dal presente”, “Il Monte Analogo” e “Poliscritture”. Sonia Scarpante. Nata a Milano nel 1958, laureata in Architettura. Si interessa di etica, salute e ambiente. In particolare è fiduciaria dell’associazione “Attive come prima” che si occupa di terapie di gruppo per malati oncologici ed è volontaria all’Istituto Europeo di Oncologia. Una sua testimonianze su tali temi ha avuto la prefazione di Umberto Veronesi. Ha scritto due raccolte di poesia: Tracce e Le dimensioni perdute, quest’ultima con prefazione di padre Bartolomeo Sorge. Collabora a riviste culturali milanesi e fa parte del gruppo teatrale “Le Griots”. Franco Tagliafierro (Teramo 1941). Risiede a Milano ma da qualche anno soggiorna per lunghi periodi a Madrid. Ha pubblicato due romanzi storici: Il capocomico (1991) e Strategia per una guerra corta (1999). Maria Pia Teodori. Psicologa, psicoterapeuta, ha lavorato a Pesaro e a All’ U.S.L.28 di Grosseto, occupandosi in particolare di strutture intermedie. Redattrice della rivista “Fogli di informazione”. Attualmente è direttore di unità operativa asl 10 di Firenze. Alessandro Teruzzi. Vive a Cologno Monzese, dove, dopo aver partecipato ai fatti di Genova durante il G8 del 2001, ha fondato nel 2002 assieme ad altri un collettivo politico. È stato presente anche ai diversi Social Forum europei e, da ultimo, alle proteste a Heiligendamm (Rostock) durante il G8 del giugno 2007. Laureatosi nel frattempo in ingegneria informatica al Politecnico di Milano, coltiva la speranza di tornare in Brasile tra i ragazzi di strada per portare avanti un sogno di cambiamento e di giustizia. Giulio Toffoli. Docente in un liceo a Brescia e storico. È autore di Giacomo Matteotti. Una tragedia di ieri, una lezione per il domani (Rezzato, 2004). Laura Tonani. Pittrice e docente all’Accademia di Belle Arti di Brera dal 1985. Da anni opera come artista terapista in riabilitazione psichiatrica e dal 1999 è coordinatrice del Libero Atelier di Attività Espressive di Cologno Monzese. Si occupa anche di formazione nelle arti terapie ed écoordinatrice,con Tiziana Tacconi, del corso biennale di Perfezionamento in Teoria e Pratica della Terapeutica Artistica dell’Accademia di Brera, Milano. Paolo Tranchina. Psicologo analista, specializzato all’istituto jung di Zurigo, ha lavorato a Milano, Arezzo, Prato, Torino, Firenze. Ha insegnato psicoterapia alla Clinica psichiatrica dell’università di Verona.Dirige la trivista “Fogli di Informazione”.Presidente della Società Italiana di psicoterapia concreta. Autore di Norma e Antinorma (1978), Il segreto delle pallottole d’argento (1984), Psicanalista senza muri (1989), La rinascita delle dee (1991). Si occupa di formazione e supervisione nei servizi pubblici.
Scarica