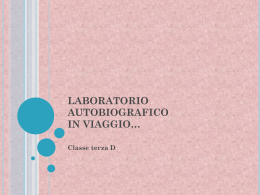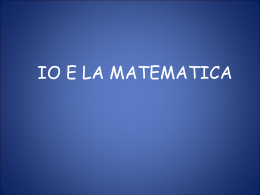Racconti autobiografici Raccolta di alcuni scritti dei partecipanti ai laboratori del Partenariato PASSAGGI (2007-2009) A cura di Guglielmo Malaspina e Liviana Petrini Raccolta di alcuni scritti dei partecipanti ai laboratori del Partenariato PASSAGGI (2007-2009) Progetto realizzato dallo SPI CGIL Provinciale Fermo (FM) Con il contributo del programma comunitario Lifelong Learning Programme, Grundtvig 2009 2 INDICE Introduzione Guglielmo Malaspina e Liviana Petrini 1 Una storia di vita Annalisa Scarpetta 2 Quando ho scelto il primo lavoro…e quelli successivi Clara Clementi 7 Prove di scrittura Daniela Maglianesi 16 Nonno, io ommo, tu ommi? Giorgio Ripani 20 Comunque sia Laura Latini 28 La merceria Lucia Interlenghi 41 Pepe, noce moscata e zenzero Maria Nives Piazza 46 A pugni stretti Valeria Palmitesta 56 I nonni, ricordi di una giovane vecchia nonna, ancora e sempre entusiasta della vita Annamaria Frezzotti 72 Appena diciotto anni Anonima 78 Viaggiare e scrivere Eva Alberti 83 Prima di arrivare al mio nome Giovanna Gaetani 87 Il lavoro, che passione! Liviana Petrini 92 Lessico di cucina familiare Marina Santinelli 98 Solo Margherite e Tulipani per me, grazie! Silvia Tacchetti 109 3 Introduzione Il progetto Passaggi, finanziato dal programma europeo LLP Grundtvig Educazione degli Adulti, volge al termine, e questa piccola pubblicazione rimarrà una delle testimonianze. Il Sindacato Pensionati della CGIL di Fermo, e in particolare il suo coordinamento femminile, sono stati felici della partecipazione al progetto di un largo numero di propri iscritti/e. La vita degli associati di un Sindacato è sempre piuttosto densa di esperienze significative, grazie agli impegni sociali e politici che le hanno caratterizzate, una volta in pensione molti di loro mantengono una cittadinanza molto attiva. E’ tempo, però, di bilanci, l’esigenza dei quali si presenta soprattutto nei momenti di cambiamento. Un grande cambiamento è quello del termine del lavoro retribuito, il passaggio al pensionamento. Allora la vita sociale può essere significativa in maniera ancor più allargata, quando la famiglia ha molto meno bisogno di noi, il lavoro retribuito e organizzato non ci chiama quotidianamente. La vita sociale rimane molto ricca se si accetta di sviluppare una nuova riflessività su di sé, e ci si educa a un pensiero riflessivo, in risposta a richiami pronti a ricevere piuttosto reazioni riflettenti. Il progetto Passaggi ha dato allo SPI CGIL di Fermo una buona occasione per formarsi ad essere cittadini responsabili verso la comunità, verso i più giovani, verso le differenze. Gli scritti qui contenuti danno un poco conto della ricchezza portata dal progetto Passaggi nella vita di chi vi ha partecipato, e servono per ricordare l’impegno che ha comportato dedicare tempo a conoscersi, a costruire un patrimonio personale che arricchisce le possibilità progettuali. Si è condivisa l’esperienza acquisita da persone adulte e anziane con quella delle giovani generazioni, alla ricerca di percorsi di senso che collegano il passato al futuro, per rinforzare l’affettività necessaria alla trasmissione. Grazie al programma comunitario LLP Grundtvig, grazie a tutte coloro che hanno reso disponibili i propri lavori autobiografici. Guglielmo Malaspina Segretario SPI CGIL provinciale di Fermo Liviana Petrini Coordinatrice donne dello SPI CGIL provinciale di Fermo 1 Una storia di vita raccontato e scritto da Anna Lina Scarpetta Sono nata nel 1938, gli anni neri e tristi, c’era la guerra. I primi ricordi risalgono a quando vedevo tutte quelle luci nel cielo e pensavo ci fosse una festa, però quando la notte mia madre ci portava sotto il rifugio e vedevo tutte le madri che piangevano, io cominciavo a capire che le cose non andavano bene. Eravamo una famiglia di quattro figli e la miseria cominciava a farsi sentire. Una cosa mi ha toccato il cuore, quando mia madre ha fatto uno scambio con un soldato polacco: lui le da dato tute e coperte e mia madre gli ha dato un prosciutto. Io ero terrorizzata vedendo quel soldato con il fucile in mano, lui guardò mia madre e chiese anche un po’ di pane, era pallido, stanco, allungò una mano, le diede un sacchetto e disse: “anche io ho una mamma come te. Tieni, io, io da lontano pregherò per te”. Dentro quel sacchetto c’era una collana, mia madre non l’ha mai messa, la tengo io come ricordo e la custodisco gelosamente. Mio padre ci raccontava quello che succedeva, lui leggeva il giornale. I vicini di casa lo prendevano in giro perché … un contadino cosa poteva capire? Io ero molto arrabbiata per questa cosa. Venne l’età della scuola e i miei genitori litigavano perché mia madre diceva che alle femmine non serviva la scuola, mio padre invece era molto contento che Mussolini avesse messo l’obbligo della scuola per tutti, anche se a lui non piaceva Mussolini. A me diceva “devi andare, così quando sarai grande potrai difendere anche i tuoi diritti”. Feci la terza elementare. All’età di 10 anni la scuola era finita, eravamo quattro figli, e andare avanti era dura. I miei genitori nei mesi estivi mi mandavano a casa della sorella di mio padre a pascolare pecore e maiali, il compenso era tutto quello tiravo con i denti. Più di questo potevo solo pregare che la trebbiatura del grano andasse bene per avere almeno un piccolo regalo. Mi sentivo molto a disagio quando la zia, per la trebbiatura del grano, comperava vestiti nuovi ai suoi figli e io restavo a guardare. Facevo ragionamenti sullo sfruttamento del mio lavoro, perché mia zia non mi dava nulla e mia madre litigava con mio padre che mi aveva messo in testa di far valere i miei diritti, con quel giornale che lui leggeva. Lei diceva che mi davano da mangiare e per loro era già tanto. In quel periodo ho avuto un’esperienza che poi ho chiuso in un cassetto, non pensavo che l’avrei mai detta, mi sembrava di aver trovato la formula di chiuderla senza traumi e senza disonori per me e per la mia famiglia. Quando andavo a pascolare pecore e maiali da mia zia, la sera mio cugino, molto più grande di me, mi accompagnava a casa e, per la strada, ha 2 tentato più volte di abusare di me, così io non volevo andare più, ma non ho mai detto la verità a mia madre. Finalmente mio padre parlò con un vicino e riuscì a ottenere che, per gli stessi lavori, mi pagava diecimila lire per dieci mesi di lavoro, oltre il cibo, e la sera mio padre veniva a riprendermi. E’ stata la prima vittoria della mia vita, e una vittoria doppia perché ho potuto chiudere definitivamente quella cosa di mio cugino dentro di me, e ho potuto portare a casa un compenso, mi sembrava di toccare il cielo con un dito! Sentivo mia zia che diceva a mia madre che ero una bambina ribelle e capricciosa, mia madre si difendeva dicendo che adesso almeno prendevo un compenso, e la zia rispondeva che, però, stavo a casa di altre persone e invece le figlie femmine era meglio che stessero con le famiglie di fiducia. Racconto questo fatto, che risale a quasi 60 anni fa, perché si dice che ora le cose sono cambiate e nei confronti dei bambini si fanno cose così brutte, e invece ci sono state sempre. A quel tempo sentivo disprezzo per mia zia e per mio cugino, e sono sempre rimasta fredda nei loro confronti. Però quando mi sono sposata mia zia mi ha fatto un bel regalo, e mi ha detto che mi aveva sempre voluto bene, ma si comportava così verso di me per via di suo marito, con il quale non aveva avuto una bella vita e litigava spesso. Lui non pensava al domani dei figli, ma solo per sé, e diceva che non voleva lasciare niente a nessuno. Io e mia sorella indossavamo vestiti che mia madre confezionava con le tute dei polacchi, e gli altri bambini ci prendevano in giro e ci chiamavano “polacche”. Mia sorella una volta si è messa a piangere, io ho preso un pezzo di terra e ho colpito in testa una bambina, sanguinava, e io, presa dalla paura, sono salita sopra una pianta di fico e sono restata lì fino le dieci di sera. I miei genitori erano disperati perché non mi trovavano e i vicini, invece, si lamentavano perché dicevano che mio padre non aveva educato i suoi figli, nonostante facesse il moderno e leggesse il giornale, infatti lo chiamavano “lo contadino scafato”. Per la prima comunione e per la cresima io ho indossato lo stesso vestito e lo stesso paio di scarpe delle mie sorelle. Le scarpe non mi entravano e mia madre tagliò la punta, così avevo le dita fuori dalle scarpe. Da piccola e da giovanissima ero molto timida, questo mi faceva venire una rabbia dentro, avrei voluto far uscire tutto quello che sentivo dentro. A 15 anni ci siamo trasferiti in paese e io sono andata a imparare a orlare le scarpe, lì mi trovavo a stare tra la gente con tutta la mia timidezza. Però sul lavoro ero molto determinata, davo tutta me stessa e dentro di me cominciava a scattare qualcosa, mi dicevo “cos’è la dignità di una persona se quello che pensa non riesce a dirlo?” La mia famiglia era tutta casa, 3 campagna e chiesa, più di quello non c’era, l’unico divertimento era quello di andare a messa, c’era una grande serenità nella mia famiglia, i miei genitori non litigavano mai. Mia madre, alle prime elezioni votò Democrazia cristiana. Mio padre era socialista, mia madre diceva che i comunisti mangiavano i bambini, e mio padre rispondeva “la tua democrazia cristiana non li mangia perché li fa morire di fame”. Infatti a quei tempi i contadini dovevano dare polli, uova, verdura, tutto ai padroni, come una tangente. Un giorno mio padre lesse sul “suo giornale” un articolo che diceva di una legge per i contadini, il famoso 51%, erano gli anni ’50. un suo amico gli disse di andare a Macerata che c’era un sindacato al quale poteva chiedere. Lui partì da Morrovalle a piedi e quando finalmente a Macerata trovò l’ufficio del sindacato, lui entrò parlò della legge e la persona che era lì gli chiese come l’aveva saputo. Alla risposta di mio padre che l’aveva letto sul giornale, questa si fece una risata e disse che il giornale non bastava leggerlo, bisognava capire il significato. Mio padre uscì, ma, camminando, pensava “questi mi prendono in giro, non posso tornare a casa senza aver risolto nulla”, continuando a camminare vide una scritta “Fedelterra”, lui si ricordò che sul giornale quella parola c’era, entrò e loro gli dissero che aveva ragione, che quella legge c’era. Cominciò la sua battaglia, che vinse e ricavò 23 mila lire. Mia madre le usò, in parte, per comperare cotone e canapa per il corredo per me e le mie sorelle. Era preoccupata lei quando mio padre vinse la sua battaglia, temeva che ci avrebbero cacciato dalla terra per questa azione che avevamo fatto. Invece non andò così, anzi, il nostro padrone lo ringraziò perché aveva anche lui un padrone, così chiese a mio padre come aveva fatto, andò anche lui da questo sindacato e prese una somma molto maggiore perché il suo terreno era più grande. E pensare che mio padre leggeva il giornale nella stalla delle bestie e quando veniva il padrone lo nascondeva. Questa esperienza di mio padre mi ha dato una grande forza e volontà di fare qualcosa per la giustizia, anche con la mia terza elementare, che a quei tempi era qualcosa. Dovevo, però, uscire dalla mia timidezza. Un giorno ho conosciuto un giovane, che poi è diventato mio marito, veniva da una famiglia di sinistra, dove c’erano sempre discussioni, i genitori non andavano d’accordo e i figli ne soffrivano. La madre era una donna molto risoluta a pensare all’avvenire dei figli. A quel tempo famiglie come questa, di sinistra, facevano un po’ rumore, ma io non avevo nessuna paura perché pensavo che avevo trovato un modo per poter venire fuori da quelle ingiustizie che vedevo. Il padre di mio marito per esempio mi raccontava di quando fu confinato a Lampedusa dai fascisti perché lui era comunista e, all’età di 19 anni, fu bastonato e gli furono rotti tutti i denti. Mi sono sposata a 21 anni, con una semplice festa, siamo andati a vivere in una misera casa, però eravamo felici perché avevamo la nostra 4 libertà di decidere e di fare. Quando mio marito mi disse che andava a prendere la patente mi feci una risata perché mi sembrava un sogno. Comprammo la topolino che ci costò 85mila lire, un’auto usata, ci pioveva dentro, ma a noi sembrava un aereo. Mio marito diceva che era meglio della lambretta. La domenica andavamo a casa dei genitori con il bambino piccolo e ci sembrava un sogno. Dopo abbiamo lavorato tanto per farci una piccola casa, mio marito era tagliatore di scarpe e io lavoravo in fabbrica e orlavo le tomaie, otto ore al giorno, e quando tornavo a casa avevo da fare tutto quello che c’è da fare in una casa, stirare, cucinare, lavare, pulire, fare i compiti con il bambino, ma tutto questo non mi pesava perché serviva a realizzare un desiderio che avevo dall’età giovanissima. Ma io avevo anche una gran voglia di gettare via quella timidezza che mi portavo dietro da anni, avevo desiderio di andare alla sezione del partito, ma per una donna in quei tempi era quasi una vergogna, perciò mio marito andava e io rimanevo a casa, io non volevo accettarlo. Poi è nato il mio bambino e questo mi ha fatto mettere tutto nel cassetto. Quando il bambino aveva tre anni sono andata a lavorare in fabbrica, era il periodo del ’68, gli anni caldi degli scioperi e mi sono iscritta al sindacato. In una elezione di una commissione interna alla fabbrica dove lavoravo sono stata eletta con 38 voti su 40 donne votanti. Da lì è cominciato il mio cammino all’interno del sindacato. Quando mi arrivava la lettera con il permesso sindacale mi sentivo male perché avevo la volontà di andare, ma sentivo l’ostacolo della timidezza e della paura nei confronti del datore di lavoro. Quando ho cominciato ad andare alle riunione del partito e del sindacato ero lì attenta ad ascoltare, sentivo dire tante cose, mi prendeva il batticuore e stavo molto male quando tornavo a casa senza aver detto quello che pensavo. Nei giorni successivi continuavo a pensare a quello che avrei voluto dire. Un giorno dissi a un’altra sindacalista “non verrò più perché non mi sento in grado di parlare, in mezzo agli altri, ho paura di sbagliare e non dico le tante cose che avrei da dire”. La sindacalista, che era Silvia Silvetti, mi disse “non è il modo di dire le cose che conta, ma la sostanza di quello che dice”. Da lì ho preso il volo e ho cominciato a parlare, ad andare alle riunione anche di partito e ho capito che per venire fuori ci vuole una grande determinazione e volontà. Il mio terrore era quello di dire cose che io pensavo e che però non fossero giuste, per le quali potevo essere presa in giro. Stavo molto attenta a sentire gli altri, ma quando non ero sicura di aver capito bene, chiedevo spiegazioni. Ancora qualche volta è successo che tornavo a casa dalla riunione e mi dicevo “non ci vado più”, ma quando arrivava un altro invito mi tornava anche la carica di voler sapere , e mi sono resa conto di quanto sia importante la scuola e la buona volontà. Con questo non voglio dire che mi sono montata la testa, mi sento una persona semplice e mi sento bene con tutti, e quando incontro persone che non si 5 sentono bene con me, perché loro si sentono più importanti, io le guardo, le osservo e penso: “che, troppa cultura…. fa pure questi effetti?” Io sono felice così, con la mia semplicità. Negli anni ’70, quando siamo riusciti ad ottenere il contratto nazionale dei calzaturieri, tutti compatti, con grandi scioperi, e ci furono anche condannati con la condizionale, il sindacato ottenne grandi successi. Però ci fu il rovescio della medaglia, alcuni furono comperati dai datori di lavoro, e questi stessi cominciarono a parlare male del sindacato. Io non mi sono venduta, sono stata chiamata anch’io e mi hanno detto che gli operai non mi seguivano più e loro (i padroni) erano disponibili a pagarmi qualcosa di più se lasciavo il sindacato. Io risposi che se non mi seguivano più, io comunque guardavo avanti a me, con determinazione e con fiducia. Il sindacato mi ha dato tanto per stare dentro la politica, con il mio modesto contributo sono stata sempre attiva, anche nelle feste dell’Unità. Mi sono impegnata anche nei comitati del direttivo del partito, sia di sezione che di federazione, poi sono venuti tutti questi cambiamenti di nomi che amaramente abbiamo dovuto digerire. I tempi cambiano, ma il cuore batte sempre a sinistra, con la speranza che questa nuova fase del partito democratico sia una speranza nuova. Io credo di sì, perché nel nuovo millennio non si può ragionare con il paraocchi e dobbiamo dare spazio ai giovani, alle loro idee nuove, sostenute dalle nostre esperienze di lotte di altri tempi. Io e mio marito avevamo un desiderio forte, di fare un viaggio in Russia, ai tempi in cui il partito sembrava tutto oro. Avevamo messo da parte i soldi, lira su lira, ma il viaggio non è mai stato fatto perché abbiamo fatto altre scelte su come utilizzare gli stessi soldi. Inoltre io ho cominciato a ragionare diversamente, non mi quadravano più quei discorsi, andavo al partito, e tornando a casa con mio marito spesso litigavamo perché le mie vedute erano più aperte delle sue. Un grande passaggio nella mia vita è avvenuto quando è morto mio marito. Ho vissuto con mio figlio, poliziotto, lui si è sposato con una straniera di origini italiane. La loro mentalità giovane, la cultura e le abitudini diverse mi hanno chiesto di fare una passaggio più radicale, un grosso cambiamento. Poi, quando sono andata in pensione, mi è rinata la voglia di fare cose diverse, ancora con il sindacato. 6 Quando ho scelto il primo lavoro…e quelli successivi scritto da Clara Clementi Dedico questo racconto a mio marito Gaetano, l’unica persona che mi ha accettato come sono e che mi fornisce sempre nuovi stimoli alla vita attiva. Sulle note di “Pasqualino marajà”: Se potessi far l’hostess E volando su per l’aria Diventare miliardaria Conquistando un marajà Cosi in India me ne andrò Tra leoni ed elefanti Ricoperta di diamanti I teoremi scorderò Ulla ulla ulla la la…. Questa era la canzone che cantavo, in una recita di fine anno, a scuola. Non so se è stato per caso o per mia volontà, ma il mio primo impiego è stato, come hostess, presso un’agenzia di viaggi a Tripoli. (Hostess di terra e non di volo, ma pur sempre hostess). Mi sentivo orgogliosa di appartenere allo staff di una grande compagnia aerea come la T.W.A e grazie alla scuola, presso l’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma ho conseguito il titolo di “Reservation sales agent”. Questo lavoro mi ha permesso di conoscere gente di tutto il mondo, con l’aiuto della lingua inglese. Ricordo con nostalgia e passione i corsi di preparazione, a Roma, sotto la guida del Signor Guido Nimmo, Senior sales representative della Compagnia. In quell’occasione ho avuto, come compagne di corso, quattro ragazze che provenivano dai vari continenti. Una dalla Rhodesia, una dalla Tanzania, di cui non ricordo i nomi; le altre due Susan Lobo da Bombay e Duenchai Ampunant dalla Tahilandia. Eravamo un’allegra brigata. Il corso si svolgeva presso gli uffici della TWA, 7 all’interno dell’aeroporto e ci teneva impegnate molte ore durante la giornata. Il nostro istruttore era bravissimo nell’insegnarci il lavoro ed anche molto gentile nell’intrattenerci durante le serate. Una volta ci ha invitato a casa sua dove ci ha comunicato che il suo hobby preferito era la fotografia, e che se volevamo ci avrebbe mostrato il suo studio fotografico che era situato in una soffittino molto accogliente. Naturalmente ci mostrò una serie di fotografie, in bianco e nero con effetti speciali. Ce n’era una che sembrava raffigurasse un mazzo di spaghetti aperto; invece quella foto l’aveva ottenuta fissando un filo dal soffitto al pavimento, dopo di che aveva teso questo filo per poi lasciarlo andare. Nello stesso momento la macchina fotografica è partita con scatti multipli e ripetuti, cosicché quello che risultava nella foto, era l’oscillazione del filo… .molto originale! Ci ha offerto degli enormi fragoloni affogati in uno sciroppo di arance e ricoperti di zucchero. Era la prima volta che mi trovavo al cospetto dei fragoloni e per giunta interi! Io conoscevo le fragole piccole, che, siccome costavano care, mia madre ne metteva quattro o cinque nella macedonia, giusto per colorarla un po’. Il signor Nimmo ci portò pure a visitare Ostia Antica, ho alcune foto ricordo di questa esperienza. Alloggiavamo in un albergo lussuoso e antico in Via Cavour, l’Hotel Danieli, con il fattorino che ci accompagnava in ascensore fino al nostro piano. Avevo una camera molto confortevole, ed il momento più bello era il bagno serale quando, dopo aver vuotato mezzo flacone di bagnoschiuma nella vasca, ed averla riempita di acqua, calda al punto giusto, mi immergevo, come le attrici nei film, in quella meravigliosa schiuma e ci rimanevo fino quasi ad addormentarmi in quel misto di fragranze orientali …bello, bello, bello! Quanto lusso a cui non ero abituata! L’autista pronto ad attenderci al mattino per condurci in aeroporto e poi ci riportava indietro la sera. Il nostro fattorino, con il quale avevamo familiarizzato, ci portava a spasso nei night club, in piccoli locali caratteristici dove c’era buona musica, minuscole poltroncine, fumo di sigarette, luci soffuse…Tutto nuovo e tutto bello per me che non ero avvezza a questi ambienti. Poiché sono sensibile al bello e mi piacciono le comodità, mi compiacevo di aver scelto questo lavoro. Con le ragazze ci scambiavamo informazioni sui nostri rispettivi paesi, curiosità e modi di vivere. La ragazza della Tanzania, per esempio ci raccontò un aneddoto a sfondo sessuale molto particolare: si trattava scegliere gli uomini in base ai loro attributi, ma come facevano? Le ragazze del villaggio si riunivano spesso per parlare di uomini, su come scegliere il compagno, e la loro selezione avveniva osservando i maschi del circondari durante i raduni tribali. Oltre al visibile aspetto esteriore erano piuttosto interessate al loro sesso nascosto. I maschi, per coprirsi, usavano dei piccoli parei, a guisa di gonnellini, e per poter sbirciare 8 sotto questi ci voleva un aiuto della natura, il vento. Si stendevano a terra, come fanno i pellerossa, a debita distanza per non essere viste ed aspettavano che il vento facesse la sua parte sollevando scompostamente i gonnellini e qui, in tutta la loro naturale bellezza potevano ammirare, tra uno sventolio e l’altro, l’oggetto del desiderio in tutta la sua naturale bellezza oscillante a riposo. Si divertivano così. A Tripoli, in ufficio con me c’erano due impiegate, Nerina Tartaglini e Drazica Bebek. Nerina era la tutto fare responsabile della biglietteria, Drazica era la segretaria del Direttore, una donna molto speciale era di Zagabria. Conservo delle foto che ritraggono momenti belli quando il lavoro era gioia e piacere. Andando avanti nel tempo si aggiungeva la parola dovere e questa privava il lavoro della sua originale bellezza. La TWA era inserita , insieme ad altre compagnie aeree, presso la Arab Trading & Contracting Co. Il direttore della Saudi Arabian Airlines all’inizio si mostrò come una persona gentile per poi rivelarsi, nel tempo, ambiguo e restrittivo nei miei confronti. Il 31 Agosto del 1069, il Colonnello Gheddafi fece la rivoluzione per destituire il Re Idris che fu esiliato in Egitto. Gheddefi voleva far pulizia degli stranieri, anche di quelli nati lì. Il Colonnello rivoleva tutto ciò che, secondo lui, gli italiani al tempo del fascismo, avevano rubato agli arabi. Le persone che lasciavano la Libya dovevano lasciare tutto, ma proprio tutto. Le famiglie partivano lasciandosi dietro il lavoro, la casa, il cuore. A me non era concesso partire perché, poiché lavoravo in una compagnia aerea, era mio compito restare a disposizione delle altre persone. Racconto tutto ciò per dire del sentimento di rabbia che cresceva dentro di me. Iniziai a fare delle ricerche per trovare dove, il mio amato capo, aveva nascosto il mio passaporto. Lo trovai nel terzo cassetto in basso della sua scrivania, me ne appropriai, anche se non era stato un bel gesto l’andare a ficcanasare nella scrivania del mio superiore. In agenzia ferveva l’andirivieni dei clienti che, in prossimità del Natale, partivano per mete lontane o per raggiungere i propri familiari. Dentro di me c’era solo delusione e voglia di andarmene, dovevo e volevo partire a tutti i costi prima della fine dell’anno. Partii con una piccola valigia, e la mia collana a cerchietti piatti da cui non mi separavo mai. In quel momento non sapevo che non sarei più ritornata. Ricordo la lunga pista deserta, prima del decollo. C’era solo quell’aereo in partenza a quell’ora. Non ricordo se era mattina o pomeriggio. Comunque sia, partivo. Allacciai le cinture di sicurezza, chiusi gli occhi e già immaginavo l’aeroporto Leonardo Da Vinci.. Non ricordo perché scelsi Roma e non Catania, come destinazione, visto che dovevo recarmi in Sicilia. Probabilmente non esisteva un volo diretto Tripoli-Catania. 9 Non ricordo l’atterraggio, ma ricordo il mio incontro con Silvana, una delle mie più care amiche. Andavamo per le strade di Roma: Via Nazionale, Via del Corso, autobus n. 64, Largo di Torre Argentina; n. 46, San Pietro. Era il 23 dicembre del 1969, avevo 21 anni, mi sentivo sicura di me. Non so quando partii per Siracusa, li c’erano i miei parenti ad attendermi. La data che ricordo bene è quella del 5 gennaio quando, anziché partire per andare a Tripoli, rimasi a letto, feci scadere il visto sul passaporto e rimasi a poltrire e a respirare aria di libertà. Se ripenso alla mia condizione posso paragonarmi ad un esule, dato che non mi è più concesso di rientrare nella mia terra natale. Per questo mi sento di definirmi nomade, vagabonda, Tuareg. Mi sento veramente in una situazione di non poter mettere radici. Sono sempre una turista. Ancora adesso. Bisognava cercare un lavoro. Il mese di gennaio trascorse normalmente, la nuova casa, l’inserimento nella città e si svolse come un periodo di transizione. Quando pensavo al lavoro che avrei dovuto svolgere, nella mente mi turbinavano dubbi, incertezze e domande. L’Italia non era la Libya; mentre li si poteva scegliere un lavoro fra una rosa di offerte da parte di banche, compagnie petrolifere, compagnie aeree, qui il discorso di approccio era un altro, completamente diverso: qui ci voleva la raccomandazione! Ed accettare quello che c’era. A volte il posto di lavoro si comprava dando il tuo primo stipendio a chi aveva fatto da tramite, a volte si pagava in natura. Una mia cara amica per il posto di lavoro aveva pagato due milioni di lire, quarant’anni fa erano una bella cifra. Io rimasi inorridita e lei mi disse sorridendo : “è così che va la vita”. Io, che non intendevo sottostare a nessun tipo di compromesso, ero decisa a starmene a casa, senza lavoro, piuttosto che sottostare a questi ricatti. Tony era il marito di Olga, la prima persona che conobbi a Siracusa all’età di tredici anni, quando venivo in vacanza da Tripoli. Lei lavorava al reparto bigiotteria e profumi della Standa, ed io tutti i giorni trascorrevo un po’ di tempo a rovistare fra anelli, fermagli, collanine, pettini ed ombretti. La mia casa era al terzo piano del palazzo della Standa, quindi quello era un rito a cui non sapevo e potevo sottrarmi. Dopo giorni e giorni, una sera, per festeggiare non so che cosa, andammo al Bar Di Trapani e bevemmo, tutto d’un fiato una Amaro Cora. Euforiche salimmo sull’autobus per raggiungere Ortigia, il centro storico di Siracusa. Alla prima frenata dell’autobus, finimmo, lunghe distese per terra, nel corridoio. Eravamo le uniche passeggere, che figura! Alzarsi fu comico e complicato perché ondeggiava tutto. Stavamo parlando di lavoro. Ed ecco che Tony fu la persona che mi trovò un lavoro, senza raccomandazione, ma solo 10 presentandomi il Sig.Luigi Ghione, capo cantiere della ditta Foster Wheeler Italiana. Il Sig. Luigi cercava una segretaria che sapesse la lingua inglese. Inizio della storia del mio lavoro in Sicilia, come segretaria del capo cantiere della Foster Wheeler Italiana. Fu una bella esperienza, gli uffici erano ospitati in costruzioni prefabbricate, sobrie ma molto funzionali, situate lungo le aree di costruzione degli impianti. C’era tanta polvere sollevata dai mezzi pesanti che transitavano con i materiali di vario genere. C’erano tanti operai che saldavano tubi con i cannelli infuocati e gli elettrodi, sotto un sole impalcabile e li vedevo sudare, anche se un ombrellone da spiaggia era messo li, per ripararli dai raggi più cocenti… Era tutto in inglese, la corrispondenza con i capi della Raffineria Esso, e io mi sentivo importante. Lì ho imparato a parlare a bassa voce, sì, perché ero abituata a parlare a voce molto alta, a casa mia si parlava così dato che mia nonna non sentiva molto bene. Ci ho impiegato un anno e mezzo, però che soddisfazione quando il mio interlocutore mi diceva: “scusa, puoi ripetere perché non ho sentito bene ciò che ha detto?” Capite, ero arrivata al bisbiglio! Alla chiusura del cantiere ci fu una grande festa ad Augusta, in un Locale all’aperto. All’epoca Fiorello faceva l’animatore turistico al villaggio Valtour di Brucoli. Non entro nei dettagli della magnifica festa. Durante la serata nacque un amore fra Claudio, mio collega e Silvana, la mia cara amica incontrata a Roma il 23 Dicembre del 69. Claudio e Silvana si sono sposati e io, naturalmente, sono stata la Commare di Nozze. Alla ricerca di un nuovo lavoro…..Dopo pochi giorni ricevetti una telefonata dal responsabile amministrativo dello stabilimento Liquichimica. Mi invitava per un colloquio in vista di un’assunzione. Che colloquio! Andai, accompagnata da mio padre, perché non avevo ancora una automobile mia, per tre volte. Mi chiesero di tutto di più. Tradussi un telex lungo quasi due metri dall’inglese all’italiano. Fui assunta come segretaria del Direttore, Dott. Licio Ferrara, una persona meravigliosa, che ricordo ancora oggi con stima e affetto. Col passare degli anni, la denominazione della società cambiò molte volte, con cambio anche di proprietari. Nell’arco di 26 anni ho svolto diverse mansioni e ho fatto esperienze lavorative di vario genere, nei vari ambiti, dove era necessario, ma soprattutto ho fatto esperienze umane che mi hanno aiutato a crescere professionalmente e come persona, attraverso la conoscenza degli operai, compagni di lavoro e dirigenti aziendali. Sono nate delle amicizie fraterne che ancora durano nel tempo, e ci sono state situazioni spiacevoli su cui tralascio di scrivere, situazioni di mobbing, che allora non sapevo si chiamasse così. Tornando alla lingua inglese, mia compagna di vita, sono stata in grado di partecipare a convegni, riunioni, cene di rappresentanza ed ho dato un valido contributo alla vita aziendale. 11 Durante questi anni di lavoro ho fatto, contemporaneamente, l’esperienza nel sindacato di categoria, la FILCEA – CGIL. E’ stato molto interessante e formativo partecipare alla lotta dei compagni di lavoro, per la conquista dei diritti. Il nostro Segretario era Sergio Cofferati, una persona splendida per quel ruolo ed io ero molto orgogliosa di appartenere al Sindacato. In questo periodo facevo parte del Consiglio nazionale delle donne ed ebbi la possibilità di frequentare un corso sulla comunicazione ad Imbersago, in Brianza. Fu un’esperienza culturale e umana di grande rilievo, per me. Sia per gli argomenti trattati, sulla comunicazione, sia per le persone con cui condividevo questa esperienza. Durante la nostra permanenza ho conosciuto una gentile signora, di nome Marisa e con tre cognomi . Nobile di animo e particolare nell’abbigliamento e per l’attività che svolgeva. Aveva un negozietto minuscolo, pieno zeppo di oggetti di famiglia, di pizzi e merletti e cristalli che vendeva ai turisti ed era il suo modo per comunicare con le persone. Lei si intratteneva volentieri a parlare della sua vita. Ci fece conoscere Monica, l’allora compagna del cantante Mario del Monaco, ed un’altra donna che era una medium. Ci venne a trovare di sera alla scuola, durante il nostro tempo libero e noi, per ringraziarla, la invitammo a cena. Questo episodio lo voglio raccontare perché mi impressionò molto. Il ristorante dove andammo a cena, ci disse che era stato suo e le era stato tolto da parenti poco riguardosi, non le piaceva la donna che gestiva il locale e si prese il gusto di metterla a disagio. Ordinò una colomba pasquale ed alcune bottiglie di Berluti. Ci fu servita la colomba , già affettata sui vassoi, portarono le bottiglie di spumante a tavola, aperte. Ebbene, fece riportare indietro la colomba e le bottiglie, pretendendo che la colomba fosse servita intera e tagliata a tavola, lo spumante sigillato, anch’esso da stappare a tavola. La Contessa Marisa, mi regalò una cintura di cuoio indiana ed un paio di racchette da neve, che tengo sempre in vista a casa dentro un cestino, e quando le guardo sono capaci di riportarmi alla memoria quella esperienza. Durante il periodo lavorativo mi sono sposata e sono nati mia figlia Valentina e mio figlio Lorenzo, figli programmati in base alle esigenze del lavoro. Valentina è nata subito, per Lorenzo ho scelto un periodo in cui l’Azienda era in crisi, per cui la mia assenza per maternità avrebbe inciso di meno nell’andamento del mio lavoro. L’esperienza di avere dei figli e crescerli, lavorando a tempo pieno, è stata per me molto dolorosa poiché mi hanno sempre accompagnato sensi di colpa perché trascorrevo poco tempo con i miei figli. Mi davo delle giustificazioni dicendo che non contava la quantità, ma la qualità del tempo che trascorrevo con loro, ma stavo male ugualmente. Quando i miei figli avevano l’influenza o tutte quelle malattie che accompagnano i bambini nell’età scolare, mi rivolgevo alla 12 nonna o alle baby sitter o alle amiche. Era doloroso sentirsi dire dal figlio che sono le mamme che devono stare vicine quando si sentono male. Non voglio ripensare a quegli stati d’animo che mi facevano piombare in uno stato di depressione e di impotenza. Dovete sapere che per me il lavoro era molto importante e la disciplina e la presenza erano collegate ad esso. Non facevo assenze per malattia. Ricordo che quando dovevo rimanere a casa, chiedevo dei permessi non retribuiti e chiedevo di effettuare orari strani, in ingresso e termine del lavoro. Devo dire che i miei superiori si sono mostrati molto comprensivi e mi accordavano i permessi richiesti. C’è stato un periodo in cui abbiamo iniziato a vivere in campagna e per questa scelta, mio marito, compagno di vita sensibile e partecipativo, ha cambiato lavoro per poter rimanere, di pomeriggio, a casa con i figli. Anche questa situazione mi faceva soffrire. Vicende familiari mi portarono a prendere una decisione che cambiò la vita della mia famiglia. La morte di mia zia Matilde, seguita da quella di mio padre, mi misero nella condizione di prendere la decisione di smettere di lavorare. Era rimasta ad accudire la zia Elvira, malata di oligofrenia grave. Non avrei dovuto occuparmi di lei solamente io, ma in quel periodo mia sorella aveva il marito molto malato ed era da escludere una sua partecipazione all’assistenza, mio fratello non aveva l’appoggio della moglie per questa incombenza ed allora che fare? Decisi che me ne sarei occupata io insieme con la mia famiglia. A questa mia decisione si presentò una situazione ottimale: la “cassa integrazione”. La mia azienda ebbe la necessità di mettere sei persone in cassa integrazione, per solidarietà nei confronti di altre società del gruppo che erano in crisi. Mia figlia Valentina aveva terminato gli studi della scuola media ed aveva bisogno di socialità, mal sopportava l’idea di continuare a vivere in campagna. Mio marito ed io ci consultammo sul da fare ed eravamo desiderosi di cambiamento, pensammo di non ritornare a Siracusa ma di spingerci oltre lo stretto, in una regione accogliente, e non aggiungo altre motivazioni. Accettai la proposta dell’Azienda di mettermi volontaria in cassa integrazione e ciò mi permise di avere, per qualche anno, uno stipendio, seppur decurtato del 30%. Dopo diversi sondaggi esplorativi di posti dove vivere, la nostra scelta è stata quella di vivere a Jesi nella regione Marche. Il 27 agosto del 1992 cominciò la nostra esperienza marchigiana. Mio marito lavorava presso una carrozzeria rinomata della zona, dove tutt’ora è. I miei figli iniziarono a frequentare la scuola ed io vivevo a casa con il compito di accudire la zia Elvira e di occuparmi della casa. 13 La cassa integrazione durò poco, ma io finalmente potevo fare la casalinga. Mio marito, ancora oggi, dice che io non sono fatta per la casa e che mi trovo meglio fuori, fra la gente, impegnata in molteplici attività. Quando ricevetti dall’Azienda la comunicazione che la cassa integrazione veniva sostituita per me dalla mobilità, mi attivai ad effettuare tutte le pratiche inerenti questa nuova situazione, e trovai collocazione presso il Comune di Mergo, come animatrice scolastica. Non potevo più dedicarmi a tempo pieno alla zia Elvira e, d’accordo con i miei fratelli, trovammo una soluzione presso una casa di riposo a carattere familiare nella zona di Siracusa Il mio nuovo lavoro mi appassionava e mi coinvolgeva in un settore dove avevo sempre desiderato lavorare, quello della scuola e dell’infanzia. Trovai terreno fertile, la mia presenza incuriosiva i bambini e le bambine perché si sa che una persona nuova e diversa è oggetto di domande, indagini, richieste. Per farla breve, mi trovai a parlare del Medio oriente, della religione musulmana, durante le lezioni di geografia del maestro Peppe (grande poeta), ad insegnare i caratteri dell’alfabeto della lingua araba, i numeri. Si era innescato un percorso culturale interessante, gli allievi erano sempre più curiosi e desiderosi di sapere di questa scrittura morbida, con segni armoniosi e che si svolgeva da destra verso sinistra, che i libri e i giornali si sfogliavano al contrario, dall’ultima alla prima pagina. Questo nuovo modo di proporre la cultura diede fastidio a qualcuno. Premetto che a Mergo ha due Scuole, una a valle e una a monte. Si sparse la voce delle attività che facevamo e altri bambini volevano frequentare la scuola dove c’era Clara che portava tutte queste novità, la lingua araba, la lingua inglese, l’intrattenimento. Ma questo non fece piacere a qualcuno, c’era il rischio di chiudere una scuola elementare di Mergo, e così subii il più squallido mobbing della mia vita. Fui chiamata da un’insegnante delle elementari che mi disse che, da quel momento, non mi era più permesso di entrare nelle classi, al mio posto la bidella avrebbe intrattenuto i bambini, e io avrei dovuto trascorrere il mio tempo per i corridoi della scuola. Potevo sistemare qualche quadro appeso male alle pareti, spolverare…….Questo, e solo questo. Come è mio carattere, accettai, mio malgrado, questa decisione, ma trovai il modo di trasmettere ai bambini, in altro luogo ed in altro orario, la cultura, le lingue, l’arte del ricamo e del bricolage. Il Sindaco mi concesse l’uso dei locali della biblioteca e nei pomeriggi di alcuni giorni incontravo i bambini per fare cose nuove, fuori dagli schemi. 14 Poi, un altro STOP! Avevo completato 35 anni di attività lavorativa. Era giunto il momento della pensione, non c’era più l’obbligo di presentarsi puntualmente, tutte le mattine sul posto di lavoro. Il Lavoro era T E R M I N A T O. Adesso che vivo da pensionata posso dire che l’unica cosa che mi dice che sono pensionata è l’assegno dell’INPS che mi viene corrisposto a fine mese, ma il lavoro continua sotto altre forme, più impegnativo di prima perché non è obbligato, è una mia scelta, e posso spaziare dall’impegno nel sindacato dei pensionati all’UDI, dal promuovere iniziative socioculturali allo studio, tutto questo in libertà e con i tempi che decido io. Non intendo fermarmi e riprogetto la mia vita giorno dopo giorno. Sessanta anni. E’ per me il momento in cui riassaporare le emozioni, riuscire a rivedermi bambina, adolescente, adulta e avviarmi verso il completamento di questo viaggio, in un passaggio dove tutto è esperienza e attualità. La mia curiosità è sempre attiva, voglio sapere della gente che incontro le abitudini, le gioie i desideri. Si cresce sempre, a tutte le età, e scrivere per me è significato mettere ordine, darmi un metodo di ricerca e di riscoperta della vita che non è mai la stessa, ricercare verso nuove vie per realizzare i miei sogni. Mi sono sentita più libera dentro, anche in uno spazio limitato si possono progettare grandi cose, se non si ha timore di avventurarsi verso l’ignoto. Non ho la pretesa di lasciare ai posteri le mie memorie, ma, se i miei pronipoti saranno curiosi come me e vorranno sapere come è stata la mia vita, come potevano andare le cose un tempo, lo potranno sapere dalle mie parole scritte. 15 Prove di scrittura, scritto da Daniela Maglianesi Com’è difficile. Esco un pomeriggio per andare a lavoro, al solito posto e alla solita ora, un pomeriggio come tanti, credevo. Invece ad un tratto tra la pioggia si avvicina un volto nuovo, una signora sta cercando un mio collega. Ma la curiosità e la propensione al dialogo non riesco proprio a controllarli, dovrò lavorarci sopra… Inizio a conversare con lei. Che bello, si occupa di scrittura autobiografica. Non posso crederci, mi chiede di ricordare un qualunque fatto e una volta focalizzato di scriverlo. “Nessun problema” ho pensato su due piedi, non ci vorrà molto. Inizio a pensare, a riflettere, cerco di ricordare qualcosa che valga davvero la pena di riportare, di scrivere. Come è possibile non riesco proprio ad iniziare. Non è stato proprio per nulla così facile. Inizio a scrivere, rileggo e strappo tutto, ogni frase o parola sembrano non avere alcun senso. Poi penso a com’è strana la vita: certi giorni credi che trascorreranno normali, che come ogni altro giorno il pomeriggio lascerà spazio alla sera con i soliti ritmi, i soliti fatti, persone. Poi un incontro, un volto nuovo, un fatto insolito e tutta la propria percezione si stacca dall’abitudine, dalla routine, di colpo i pensieri possono rinnovarsi, seguono nuovi stimoli. La giornata diventa una novità. Proprio questo mi è successo questo pomeriggio, un’attività che è lo scrivere ripiomba dopo molto tempo nella mia vita, come per magia. Pensando riaffiorano ricordi, ma non riesco a pensare a nulla tranne a tutte le emozioni che scrivere di me dopo tanto tempo comporta. Sì, mi viene in mente proprio quella volta che, aprendo un regalo di compleanno, vi ho trovato al suo interno un diario, un diario segreto da scrivere. Bello, ma allo stesso momento troppo impegnativo e costoso per scriverlo. Come iniziavo a scrivere mi sembrava di rovinare ogni sua pagina, così decisi di lasciarlo intatto, nuovo, di non sciuparlo. Poi un pomeriggio la mia migliore amica, proprio lei che per me era proprio una sorella, per l’ennesima volta non è riuscita a trovare due secondi per cercare di capirmi, la sua vita sempre così perfetta, la mia dovrebbe essere uguale ma mi sembra mi manchi sempre qualcosa, sarò una bambina viziata come dice la mamma, pensai! Così quel pomeriggio, per puro caso, mi ritrovo tra le mani lo stesso diario e di getto ho iniziato a scrivere e scrivere senza più esitare. Rimasto per molto tempo abbandonato in una mensola, quel giorno in cui credevo che proprio nessuno avrebbe potuto capirmi, quando pensavo che la 16 tristezza non mi avrebbe più abbandonata, mi sono ricordata di lui. Non so come mi è venuto in mente, so solo che ho iniziato a scrivere, scrivere, a narrare e a narrarmi e tutto piano piano diventava più chiaro, più semplice, più felice. Ogni parola scritta diventava per me un sollievo, dopo ogni parola mi sentivo molto più sollevata, meno sola e meno incompresa. Da quella volta infinite sono state le occasioni in cui il foglio e la penna sono stati i miei più grandi e efficienti confidenti, infinite volte presa dallo sconforto, dalla delusione o dalla gioia totale ho scritto. Proprio oggi ho letto che “scrivere è un modo di parlare senza essere interrotti”, è proprio così, ci si guarda dentro senza distrazioni, si inizia a capire se stessi e ci si sente molto più felici. Nel narrare interponiamo tra noi e il resto del mondo una bella distanza che ci aiuta a tollerare meglio ogni frustrazione, a superare un dolore. Il foglio contiene ogni nostra angoscia, paura o gioia, siamo felici perché dopo aver scritto ciò che di più bello ci è capitato sappiamo che potremmo riviverlo col rileggere, se invece narriamo ciò che di più brutto proviamo o ci è capitato ci sentiremo piano piano risollevati, come se il peso dato dalla situazione si stia pian piano alleggerendo. Un inno alla scrittura? Che abbia funzioni terapeutica? Certamente si. La mia prova a tale affermazione è proprio ciò che provo mentre scrivo in questo momento. Quando la signora mi ha invitata a scrivere per lei, tutta la mia felicità e gioia che sapevo di provare nello scrivere sono crollate lasciando spazio a mille problemi, mille censure, appena mi concentravo per trovare un punto da cui iniziare la mia mente, la mia anima si svuotava, non sapevo proprio da dove iniziare. “Basta! non riesco più a pensarci, abbandono il progetto” pensavo. Poi, un giorno mi sveglio e, senza una causa ben nota, il mondo per me è tutto da rifare, la mia vita non ha un senso, qualunque cosa mi circonda è inutile, è solo un peso, non c’è proprio niente che riesca a rianimarmi, che mi entusiasmi, nulla riesce ad attirare la mia attenzione. Rimango una lunga ora da sola, circondata solo da oggetti inanimati, nessun essere dotato di vita mi avvicina. Proprio, ma proprio niente, oggi ha un senso, com’è possibile? Poi ripenso a quando da bambina ho iniziato ad avere giorni simili, ci ho pensato molto… poi il diario, quel diario che poi non ho più lasciato ed è stato il primo di una lunghissima serie. Voglio riprovare la stessa sensazione di leggerezza e di rinascita, prendo carta e penna e provo dopo tantissimo tempo a raccontare me stessa. Capisco subito che narrarsi è come imparare ad andare in bicicletta, una volta distrutta la paura, l’imbarazzo verso se stessi tutto viene automatico e non ti puoi più dimenticare come si fa. Tutto oggi come allora è oscurato ai miei occhi da una lente di negatività, oggi come allora scrivere è l’unica 17 soluzione per comprendere me stessa, per vedere tutto da un'altra ottica… Fantastico! finalmente provo una nuova serenità, la mia bocca si apre in un sorriso, la terapia si sta realizzando, sta avendo i suoi frutti, tutto ora è più chiaro, più positivo, più rosa. Il peso e l’angoscia che sentivo stanno lasciando spazio all’entusiasmo e alla passione per la vita e per questo mondo che di solito vivono in me. Rileggere ciò che si scrive, ho detto un giorno ad una mia amica che rileggendo le sue parole ha provato un grande imbarazzo, può essere come risentire la propria voce registrata, ci può far provare vergogna, disagio, ci può far pensare “no…non è possibile che queste cose le ho scritte io…”. Invece sì, si è solo svelato, tirato fuori da sé tutto un mondo interiore che troppo spesso non ci soffermiamo ad ascoltare. Inizio a scrivere e si verifica tutta una lunga analisi di se stessi, sembra che i pensieri intrappolati in un grosso groviglio possano finalmente trovare pace e serenità. Proprio lo scrivere mi ha svelato molte paure che avevo, molti lati oscuri di me stessa e tramite scritti altrui mi sono avvicinata al Centro di Aggregazione, in cui svolgo attività di servizio civile, a tutto un mondo nuovo, il mondo dell’intercultura. Un mondo che ci porta verso terre lontane e nuove scoperte. E’ forse questo l’incontro più particolare avvenuto nel corso di questo anno, trovarmi a contatto con delle narrazioni pazzesche sull’India e su tutto il peso che un ragazzo migrante può portare. Trovare un punto di incontro è stato molto difficile ma poi proprio il narrarsi, il narrarmi ha portato a far aprire i nostri universi l’uno all’altro. Sentirmi impotente davanti le loro storie e differenze per poi tentare il tutto per tutto facendo scrivere a ciascuno la propria storia, esperienza, le proprie sensazioni. Anche questa volta scrivere di sé, delle proprie emozioni ha funzionato, ha portato ad un viaggio nella propria psiche che ha alleviato, se anche solo per un’ora, un po’ della tristezza provata. In questo mondo che un minuto mi da tantissimo, e in un altro mi sembra mi abbia snobbata per sempre, vorrei sempre trovare un rimedio per risollevarmi, se proprio la fortuna non inizia a girare, se proprio i miei sogni non vadano per la direzione in cui voglio, intanto inizio a scrivere, a riflettere, cerco di capire cosa c’è che non va e cosa invece sta andando. In un mondo in cui non so bene se conta di più quello che sei o quello che hai, chi conosci, in un mondo che a volte ho accusato di non essere proprio l’ideale per me, poi però, in un modo o nell’altro, ha fatto sempre sì che tutto si aggiustasse, l’impegno, il sacrificio e la determinazione saranno sempre ripagati? Non lo so più, ma non ci penso. 18 In queste generazioni a confronto poi chi ci avrà rimesso, noi della nuova era o tutti coloro che la loro giovinezza l’hanno già vissuta? Non so dare risposta neanche a questo, so solo che certi giorni quando mi affaccio al nuovo mondo con le mie paura è dura. So che magari oggi il mondo offre di più e noi siamo conseguentemente più ambiziosi o meno volenterosi, ma l’importante è provare, insistere e non tornare mai indietro. 19 Nonno, io ommo, tu ommi? Racconto scritto da Giorgio Ripani Era così che nei primi anni della vita, ero solito rivolgermi a mio nonno, quando mia madre mi metteva vicino al nonno, che era già andato a letto, per il sonnellino pomeridiano, per garantirmi quel minimo di attenzione, mentre Lei avrebbe continuato le sue faccende, per riordinare la cucina e pensare a far chiacchiere con la zia E. La nonna era mancata da due anni e quindi il nonno a volte aveva bisogno di non pensare troppo al passato e, per questo, intristirsi. Solo molto più tardi avrei saputo che nonno straordinario avevo avuto. E solo qualche anno fa, ho potuto conoscere qualcosa di più sulle gesta di questo Socialista ante litteram, che era stato mio nonno, all’inizio del secolo XX°. Mia madre mi raccontava di come suo padre, nel pomeriggio dei suoi giorni trascorsi nella Farmacia dell’Ospedale di Recanati, era solito salire su un piccolo tavolo, che tirava fuori dalla Farmacia, per arringare le filandaie, nel mentre queste rientravano a casa, ed esortarLe a ragionare sui propri Diritti calpestati e a darsi da fare per prendere coscienza che si poteva assumere un atteggiamento di ribellione, forse, ma sicuramente di richiesta di un rispetto che doveva esserci comunque per delle donne, che dovevano essere considerate, non già come bestie da soma, alle quali si poteva aumentare sempre di più il carico, ma come persone con una dignità, come lavoratrici, che non volevano più sopportare oltre le angherie che il Padrone della Filanda soleva usare con loro. A motivo di queste più che giuste sollecitazioni, essendo venuta meno la fiducia dei maggiorenti, componenti di diritto del Consiglio di Amministrazione degli Istituti Riuniti di Cura e Assistenza, da cui dipendeva la gestione dell’Ospedale, verso quel giovane ed irrequieto Farmacista, questi veniva licenziato e rinviato ai suoi luoghi d’origine. Fortunatamente il nonno aveva un cognato, fratello della nonna, ingegnere e gestore di diverse esattorie nel centro e nel sud d’Italia, che intervenne economicamente e permise l’acquisto di una Farmacia in quel di Porto S. Giorgio. Qui la nonna però aveva bloccato ogni ulteriore velleità politica-sindacale dello sconsiderato padre, allora, di tre figlie, (sarebbero poi nati altri due figli, nel 1906 e nel 1909) ed il nonno, raccontava la mamma, si era adattato ed aveva abbassato il capo. All’avvento del Fascismo, ad ogni manifestazione politica, venivano ricordate le sue gesta di stretto stampo socialista e quindi obbligato a passare la giornata dell’evento, in camera di sicurezza, presso la locale Stazione dei Carabinieri. Questi erano gli unici racconti riferiti al Nonno e alle sue idee socialiste, che la mamma soleva raccontare: forse lo faceva con una punta d’orgoglio, o forse erano cose che non si potevano raccontare, senza subire i rimproveri della nonna. 20 Indubbiamente costituirono per me il germe di quell’attività di ribellione ai soprusi, alle violenze gratuite, all’ingiustizia, ai diritti Umani calpestati, che hanno, in un certo senso, condizionato le mie scelte lavorative, una volta raggiunta l’età d’inizio della mia attività di Medico. Quando venni al mondo la nonna non c’era più da qualche mese ed il nonno, con il quale dormivo spesso, visse per altri tre anni e poi, anche lui se ne andò. Noi piccoli però fummo tenuti all’oscuro degli ultimi momenti di vita di quel personaggio così straordinario che era stato il nonno. Solo molto più tardi, capii che il nonno si era fatto voler bene anche dalla popolazione locale per la sua simpatia e la sua generosità: le sue battute mi venivano raccontate dai tanti conoscenti come espressione di saggezza e di misurata larghezza di vedute, nell’ambito delle esigenze economiche. Spesso le ricette dei medici di base, di allora, venivano interpretate in modo adeguato se erano prescrizioni per disturbi seri, ma a volte, se si capiva che erano relativi ad evidenti richieste del paziente, il nonno consigliava di andare a prendere delle belle bistecche dal macellaio di fronte, piuttosto che sprecare soldi da lui. Altre volte, di fronte alla difficoltà di poter pagare sino all’ultimo centesimo, accettava di buon grado quanto gli si dava, e commentava “Tutto guadagno !” Altre volte ancora, poiché la nonna non voleva che la clientela segnasse continuamente, quando non poteva arrivare a coprire la spesa con moneta corrente, e, per questo motivo, aveva dato disposizioni rigide al marito, alle parole del nonno che non si poteva segnare più, le popolane rispondevano, essendo ben accolte dalla simpatia del nonno, “Ah non si può più segnare, allora sa come si può fare, tienilo a mente!” La mamma poteva raccontare tante cose di quanto accadeva in Farmacia, perché, essendo tra le sorelle, la più sottomessa e buona di carattere, non era stata spedita a Grotta dagli zii, o in collegio a Falerone, ma era rimasta a casa con i genitori e, date le circostanze, quando aveva risolto i suoi compiti di scuola, dava una mano in Farmacia, facendo le cartine (che all’epoca sostituivano nelle prescrizioni, le attuali compresse) o le pomate e gli unguenti che venivano prescritti in forma galenica. Così le zie avevano da raccontare delle loro gesta presso gli zii, o dalle suore con episodi che rappresentavano per noi bambini come racconti delle favole. In questi la zia A. era particolarmente affascinante per la sua capacità di ricordare tutti i particolari e di arricchirli spesso con cose che non si è mai capito se potevano essere vere o inventate, tanto erano fantastiche. La zia era laureata in Farmacia, ma in realtà non aveva che solo saltuariamente svolto quel lavoro. La mamma era molto critica verso la sorella che avrebbe potuto e dovuto lavorare in Farmacia, e a noi dispiaceva un po’ perché, in fondo, subivamo il grande fascino della Zia che ne aveva sempre una da raccontare, con risvolti sempre divertenti o intriganti. Sembrava che la Zia si fosse molto divertita sia nell’adolescenza, 21 sia successivamente, quando andò a studiare ad Ancona per le Tecniche, ed era ospite di una sorella del nonno, la zia M., sia quando, poi, andò a Napoli all’Università. Era stata la prima sorella a sposarsi con zio N, che era un valente geometra, molto attivo al tempo, che era stato anche podestà, negli anni del Fascismo. Aveva due figlie V. e P. che erano le più grandi tra le cugine. Abitavano in una bellissima villa che aveva costruito lo zio, per la sua famiglia, che allora era composta anche dai genitori dello zio N. Il padre di zio N. era anche Lui farmacista ed aveva fatto una guerra al nonno, quando questi si era impiantato al Porto. Ma, raccontava la mamma, il nonno si era saputo imporre con la bonomia e la qualità delle sostanze che erano tutte provenienti dalla Germania, tutte targate Merck, e quindi purissime dal punto di vista organolettico; le altre Farmacie, che si servivano da produttori Italiani, non potevano vantare la stessa alta qualità. Della Zia D., che era la prima figlia dei nonni, sapevamo meno perché viveva ad Ascoli: la mamma raccontava che era bravissima nella cucina, e che aveva voluto sposare un vedovo, un Preside, che aveva altre figlie. Queste erano morte per ragioni complicate, quando erano signorine. La zia D. aveva avuto tre figli, e la più piccola aveva la mia stessa età; i nostri cugini li vedevamo soltanto d’estate, per le vacanze, o nelle occasioni importanti, in cui gli zii raggiungevano anche loro la casa “paterna”. Lo zio aveva la passione dello scrivere, ed era dietro ad un romanzo, di cui spesso soleva leggere alcune pagine ai figli e a noi piccoli, che potevamo restare solo se fossimo stati zitti, senza ridere, e attenti; noi, per lo più, rinunciavamo da subito, perché tutte quelle richieste di disciplina non ci piacevano. I figli, invece, loro malgrado, erano costretti a restare, e lo zio di fronte ad un buon bicchiere di vino e al suo sigaro toscano, si lanciava nella lettura delle sue pagine, cercando la loro approvazione. Tornando a quegli anni che mi vedevano bambino e che vedevano anche l’evolvere di un conflitto Mondiale, che vide la rapida e facile conquista di mezza Europa, da parte dei Nazisti, e l’illusione Fascista di potersi affiancare al carro del vincitore, dovendo coniugare, insieme a quelli, tutte le nefandezze che menti prive di scrupoli e di qualsiasi pietas potevano immaginare, nei confronti di milioni di persone innocenti, non ritengo che potessimo avere coscienza piena di cosa stesse accadendo. Fortunatamente l’intervento degli Alleati scongiurò il peggio; ma nel frattempo, molti avvenimenti si sovrapponevano anche nella nostra famiglia. Mio padre che lavorava in banca, si era appena trasferito da Ancona a Macerata, dove per il momento, stando con la sua mamma, la nonna N., veniva da Lei assistito nelle faccende domestiche; ci raggiungeva nel fine settimana e così la nostra micro famiglia si riuniva sotto il tetto della casa “paterna”, come la chiamava la mamma. 22 Mio fratello, più grande di me di due anni e mezzo, aveva già una certa autonomia e legava molto con mia cugina L. Era un bambino che, a differenza di me, aveva una carnagione scura e i capelli neri, la mamma forse non aveva giocato da bambina con le bambole, e così anche mio Fratello, aveva i capelli pettinati con dei boccoli che gli pendevano ai lati; io invece avevo capelli biondi, molto ricci, con la “banana” al centro. La mamma era anche molto brava nel cucire vestiti; aveva, probabilmente, sempre desiderato avere una figlia femmina per poter sfogare la sua creatività e fare apparire al meglio i propri figli: rimediava però facendo vestiti per le nipoti e piegandosi a creare, anche per noi maschietti, pantaloncini e camicette da qualsiasi stoffa poteva rimediare in casa. Raccontava che, per questa passione di fare vestiti, aveva fatto la costumista delle grandi recite che si svolgevano nel Teatro, con la partecipazione dei giovani più belli e bravi del Porto. In casa c’erano poi, oltre al nonno, lo zio G con la moglie E. che era in attesa dell’altro cugino M. e una bambina, la cugina L; c’era poi un fratello del nonno, zio V. che era rientrato dall’Argentina, dove aveva lavorato, come Perito Meccanico. Aveva fatto il disegnatore industriale ed aveva fatto una discreta fortuna, ma non aveva trovato moglie; e, quindi, scapolo, aveva pensato di rientrare in Italia. Alcuni anni prima, aveva investito i suoi risparmi comprando carati di alcune barche da pesca, ma l’affare non era stato particolarmente felice. Si dedicava alla parte delle pratiche commerciali e sbrigava la posta; aveva, allo scopo, una sua scrivania, vicino alla finestra della Farmacia che dava sulla via laterale, verso la collina, rispetto all’ingresso. La scrivania aveva un cassetto sempre chiuso a chiave, dove teneva tutte le sue magnifiche penne, le matite sempre ben appuntite le boccette di china con pennini diversi, dei libretti di un editore di Milano dal nome straniero, forse Hoepli, con disegni di ogni tipo, anche relativi alle singole lettere dell’alfabeto, con cui ci faceva le sigle dei nostri nomi e cognomi, e gli arnesi che gli occorrevano per il suo vecchio mestiere di disegnatore, righe, squadre e compassi. A volte quando apriva quel cassetto, il poterci mettere gli occhi e scoprire quante cose c’erano, costituiva per noi bambini come mettere gli occhi su un tesoro, che non potevamo toccare in nessun modo. Era molto geloso delle sue cose e a nessuno di noi bambini era concesso di poter mettere mano al suo cassetto, così come di poter andare nel suo mini appartamento che era di sopra, salendo le scale del piano superiore. Era una stanza, dove si entrava con un ingresso un po’ curvo; la stanza aveva due finestre, una sulla strada e l’altra sul retro della casa. Lui dormiva lì, ed aveva il bagno, accanto alla porta d’ingresso; la porta del bagno e quella dell’ingresso alla camera dividevano il lato Est del pianerottolo. Questo zio era più giovane del nonno, ma era per noi un 23 vecchio signore con il panciotto, l’orologio con la catena, la cravatta sempre scura, i capelli bianchi e lisci che avevano un buffo ricciolo sulla fronte. La mamma, a noi piccoli che ci chiedevamo curiosi il perché di quel buffo ricciolo, ci diceva che si chiamava il “baciami qui” suscitando le nostre risate. Lo Zio appariva severo e poco avvezzo ai giochi e agli scherzi e quindi, come spesso succede, era la persona preferita, oggetto delle nostre sottili crudeltà, che naturalmente venivano interpretate come innocenti leggerezze infantili dalle nostre mamme, quando volevano giustificarci, e delle sciocche e gravi mancanze di rispetto, quando avevamo esagerato e non era più il caso di chiudere un occhio. Tuttavia lo Zio dopo un primo momento in cui si rabbuiava e ci urlava dietro qualche epiteto, lasciava correre e si poteva quindi ricominciare da capo a giocare con Lui. Forse non era così severo come appariva ed in fondo non gli dispiaceva avere dei nipoti così vivaci. Successivamente, finita la guerra, lo zio era addetto anche agli approvvigionamenti giornalieri di frutta e verdura: il compito veniva in genere svolto al mattino presto, nel vicino mercato delle erbe, in piazza del Mercato. Quando lo zio rientrava, poneva tutto quello che aveva comprato negli scaffali del magazzino. Spesso io che ero magrissimo, ma ghiotto di frutta, percepivo quel suo deporre la frutta nel magazzino come un tentativo di nasconderla ai miei occhi golosi. Succedeva così che mi arrampicassi sugli scaffali e facessi scorpacciate di quella frutta appena colta dagli alberi. Grande era la sua rabbia, quando, a pranzo, la frutta non era mai nella quantità che ricordava di aver acquistato: si chiedeva chi avesse potuto mangiarsi tutta quella frutta e naturalmente, il giorno successivo, cambiava di posto alla frutta, spostandola in un altro scaffale; ma lo stimolo era sufficiente a caricarmi a sufficienza nella ricerca, che si concludeva di nuovo con la scorpacciata di frutta. Il ripetersi di questi episodi costituiva il leitmotiv di tutta l’estate, ed era per me un divertimento poter dare battaglia nel ritrovare e mangiare la frutta. D’altra parte, visto che mangiavo poco, questa vivacità alimentare era ben vista dalla mamma e dalla zia, che sopportavano, tacite, le mie “mancanze di rispetto” verso l’anziano zio V. Tornando al periodo di guerra, le nostre giornate, allora, trascorrevano abbastanza serene. La guerra non la sentivamo vicina, e quindi non ci turbava più di tanto. La casa dei nonni era molto solida e grande, su tre piani, con una soffitta ed un terrazzino finale, su cui diverse bacinelle di acqua marina, costituivano, esposte al sole estivo, una possibile riserva del prezioso sale. Eravamo un po’ più grandicelli, qualche anno dopo, quando quei luoghi, un po’ isolati dal controllo dei grandi, avrebbero incentivato la nostra fantasia, nel riprodurre un ideale mondo dei grandi. Lo zio P., fratello della nonna, era intervenuto al rientro della famiglia, dopo le avventure “socialiste” di Recanati, ed essendo ingegnere aveva progettato questa casa, dotandola di tutte le esigenze antisismiche che si 24 conoscevano all’epoca (visto che c’era appena stato il terremoto di Messina). La casa aveva a piano terra, nella facciata verso il viale della Stazione, l’ingresso della Farmacia, il portone della casa al centro, ed un altro negozio che era stato dato in affitto ad una tabaccheria; entrando nel portone, c’era un ingresso abbastanza ampio che veniva chiuso da una porta a vetri smerigliati, con disegni liberty, che si apriva su uno spazio da cui si accedeva da un lato alla Farmacia, dall’altro ad una stanza che era adibita a piccolo magazzino, con un tavolo in mezzo e diverse scaffalature alle pareti; proseguendo, questo spazio dava accesso alle scale che portavano ai piani superiori, e, di fianco alla scala, si accedeva ad un ulteriore spazio che costituiva il vano della tromba delle scale, e subito di lato a questo, sulla destra, un ulteriore vano che dava su uno studiolo; nel vano di accesso a questo c’era il telefono. La mamma raccontava che inizialmente il telefono funzionava come servizio pubblico; vi era addetta una signora P. che svolgeva il compito di centralinista che era divenuta sua amica. In fondo al vano “tromba delle scale” c’era una porticina che dava su un sottoscala dove lo Zio teneva gli attrezzi, e dove poteva sviluppare le fotografie, che ci faceva con la sua Leica; aveva una camera oscura con una lampada che emanava una luce rossa che stuzzicava spesso la nostra curiosità. Naturalmente la presenza degli acidi e la delicatezza delle apparecchiature facevano sì che questo spazio fosse proibito per noi. Salite le scale, si accedeva sul pianerottolo, a sinistra in un gabinetto con water e lavandino e, di fianco a questo, un bagno ampio con vasca, lavandino e bidet e nello spazio attiguo uno sgabuzzino in cui era posta una grande stufa a legna per l’acqua calda, tanti scaffali per le scarpe, e le varie cose che potevano servire in bagno. A destra, sul pianerottolo c’era un’ampia vetrata che dava accesso all’appartamento in cui c’erano due camere da letto, la sala da pranzo, il salotto, il tinello e la cucina. Dalla cucina, che era sul retro della casa, si accedeva, tramite una vecchia porta ed una scala in legno, in un ampio magazzino che serviva da dispensa per la cucina, ma soprattutto da deposito per le varie sostanze che servivano in Farmacia. Questo magazzino era costituito da due vani ampi con scaffalature in legno grezzo , ed un’altra stanza laterale più bassa che conteneva le damigiane. La casa pur essendo moderna, non aveva ancora il riscaldamento con i termosifoni; c’erano delle efficientissime stufe Becchi, in coccio, del solito color rosso mattone, che quando erano accese diffondevano il loro calore per tutta casa. Intanto la guerra procedeva, e i bollettini che lo Zio e il Nonno ascoltavano quasi ogni sera, ci avvertivano che i Tedeschi stavano risalendo in ritirata verso il nord, incalzati com’erano dagli alleati, che avevano iniziato a bombardare dal mare e dal cielo. I grandi (le mamme e i papà) decisero di farci sfollare a Lapedona, ed una notte quindi, con un carro a cavallo, tutta la famiglia, con i relativi bagagli, si trasferì in una casa di un vecchio signore di Lapedona, che non avendo figli, e avendo 25 disponibilità di diversi spazi liberi, poteva ospitare tutti. Il trasferimento notturno avvenne con estrema cautela; dovevamo stare tutti zitti, per evitare che i soldati tedeschi ci potessero fermare, e questo non era difficile, vista l’ora che ci vedeva tutti immersi nel sonno; fummo particolarmente in tensione quando dovemmo superare il ponte sul Fiume Ete, che si temeva potesse essere lesionato. A Lapedona, essendo un po’ più lontana dal mare, si pensava di poter stare più tranquilli, tuttavia questa idilliaca condizione ricordo che veniva interrotta da un fuggi fuggi generale quando un uomo solo si presentava a mo’ di sfida, in paese; questi pur armato come un bravaccio manzoniano, era solito arrivare in piazza e a volte accompagnava il suo arrivo con degli spari in aria: tutti scappavano impauriti nelle loro case, anche se erano più numerosi di quell’unico personaggio, e la cosa mi appariva incomprensibile. Per il resto la vita era abbastanza tranquilla. Una mattina poi, all’alba, venimmo svegliati da bombardamenti che tentavano di colpire i ponti sul fiume Aso, forse per impedire o complicare il ritiro dei Tedeschi; svegliato di soprassalto da quel frastuono, mi lamentai che erano venuti anche lì “a bombaldale” : venimmo riuniti tutti insieme in un'unica stanza dalle cugine P. e V., figlie della Zia A., che erano più grandine di noi, e che erano comunque sfollate anche loro a Lapedona in un appartamento attiguo a quello abitato da noi. Lo stare tutti insieme costituiva motivo di felicità. Oggi che, con la mia famiglia, abbiamo acquistato una casa a Lapedona, mi sembra come di aver chiuso il cerchio di una vita. Molto vicino alla casa che abitavamo, c’era la chiesa parrocchiale di Lapedona, che era dotata di un grande organo, almeno ai miei piccoli occhi di bimbo: io potevo arrivarci attraversando la strada e spesso, al mattino, c’era un giovane che suonava. Quel suono così profondo ed intenso mi affascinava allora e mi affascina ancora oggi: mi è sempre rimasto nel cuore. Io salivo pian piano, orgoglioso delle mie pantofoline rosse ai piedi, quelle scalette strette che portavano davanti a quello strumento con tutte quelle canne così alte e lucide e rimanevo in silenzio nell’ascolto; venivo spesso accolto da quel giovane, che mi faceva partecipe del suo suonare e, avvicinandomi alla tastiera, mi faceva accoccolare sulle sue gambe. Quando lui finiva di suonare e richiudeva la tastiera, io me ne tornavo a casa, con in testa tutti quei suoni profondi e dolci al tempo stesso. Avrei voluto che i miei mi facessero imparare a suonare uno strumento, ma i tempi e le circostanze lo hanno impedito allora, come nel tempo successivo. Il sogno l’ho rinviato all’età della mia pensione, dicendomi “quando sarò grande, lo farò”; non so ancora se riuscirò a trovare il tempo utile per la realizzazione di quel desiderio infantile, sul quale mi sono soffermato ogni qualvolta la musica mi ha coinvolto al punto tale da farmi sognare e da darmi tanta pace e serenità. Oggi le amarezze politiche sono sicuramente elementi di turbativa che distolgono dai dolci ricordi dell'infanzia. E' tempo di fare una 26 pausa e di rimboccarsi le maniche, pensando alle tante soluzioni possibili e alle utopie realizzate: in fondo, quando si pensava all'impossibilità di venir fuori dal guado melmoso delle Istituzioni totali, malgrado il nostro dibattere ed il nostro agire a favore di quei dimenticati da Dio, è venuta una Legge come la 180 a sancire che i diritti degli Ultimi dovevano essere rispettati come i diritti di Tutti. Oggi sono passati trent'anni e questa Legge, ancora giovane, trova difficoltà di applicazione nelle tante parti d'Italia dove si pensa che i diritti non debbano essere applicati per tutti. Ma questa è un'altra Storia, estremamente importante da raccontare. 27 Comunque sia, scritto da Laura Latini 30 dicembre 1990, domenica. Il vagito d’una bimba appena nata allieta ostetriche e ginecologi, una mamma stanca e una famiglia che si allarga. È uno scricciolo, appena tre chili, capelli neri e occhi azzurro-grigi. Si aprono nuove porte, una nuova vita a cui badare, e con cui s' intrecceranno i destini di molte altre vite, in uno scambio continuo e in un apprendimento infinito, la conoscenza è illimitata, specialmente a sedici anni. Ora infatti ne ho sedici e, benché mi porti già dietro un bagaglio piuttosto pesante, mi rendo conto di quanto le sue proporzioni siano destinate a crescere esponenzialmente, o almeno lo spero. Vivo in un paesino sperduto “in un greppe dell’Appennino dove risuona fra gli alberi usata e semplice tramontana” come diceva Guccini, e passo la vita a guardarmi indietro e a cercare di ricordare i milioni di volti che hanno costruito la mia persona. Il primo è quello di mio nonno che quand’ero piccolina passava le sue giornate a viziarmi mentre giocavo a casa di mio zio, e poi ci sono quelli di miei compagni di scuola e di gioco, le loro voci e le ore passate sugli sgabellini di una scuola elementare in cui ho appreso la maggior parte di quello che so. Proseguendo mi imbatto nella scuola media, anni nei quali credo di aver fondato le radici della mia persona. L’adolescenza alle porte, la prima immagine del mondo e i miei genitori che avevano appena aperto un ristorante. Un ristorante, un posto di lavoro in cui sei imprigionata proprio nei giorni in cui tutto il mondo festeggia, un mare di problemi che sommerge un direttore senza esperienza e il più adatto asilo per una dodicenne innamorata della vita. Un esercizio commerciale è per sua natura una fonte inesauribile di emozioni, le persone vengono da te per dar vita ad uno scambio di informazioni e di esperienze. Ho passato la maggior parte del tempo, tra i dodici e i quindici anni, nel ristorante dei miei e proprio da lì è nata la mia passione per i comportamenti delle persone: mi incuriosiscono le loro reazioni davanti a stimoli diversi, e i rapporti interpersonali che ognuno intreccia. Inoltre, grazie proprio a quel ristorante, ho incontrato una delle persone che più mi hanno fatto riflettere: un cestista, un omone alto più di due metri, con un accento sfacciatamente emiliano e una superbia alquanto altezzosa, una persona adorabile insomma. Si chiamava, pardon si chiama, Massimo ed è la personificazione, a prima vista, dell’uomo ricco e di successo che sa di potere più di quanto gli altri riescano a sognare, ma dietro a quella facciata, 28 vi giuro, si apre una persona completamente diversa. In due anni ho scoperto che il suo amore per i bambini è di gran lunga maggiore di quello per le donne, ho scoperto quanto sfacciataggine possa corrispondere a insicurezza e dolcezza, e quanto una persona libera possa avere un disperato bisogno di legami. Ho intravisto, e più tardi capito, la paura che gli uomini hanno gli uni degli altri, e quella che hanno dei sentimenti. Ma tutto ciò purtroppo è frutto di considerazioni postume, a dodici anni sei troppo impegnata dal ragazzo cui, per un motivo o l’altro, non piaci. Mi accorgevo già allora di volergli un gran bene, ma l’ ho ammesso soltanto quando nel cuore della notte ho iniziato a piangere perché di lì a breve se ne sarebbe andato. Credetti di non poter andare avanti senza lui e me ne convinsi anche, ma, come si suol dire, il tempo aggiusta le cose o per lo meno t’illude che tutto sia andato a posto. Arrivai alla fatidica scelta dell’indirizzo superiore, e mentre tutti erano ben decisi riguardo le loro attitudini e le loro passioni, io vivevo l’insidioso dubbio: liceo scientifico PNI o alberghiero? Poi risolsi: liceo socio- psicopedagogico e cioè una scuola che non ha nulla a che vedere con nessuna delle precedenti ma per la quale i miei professori credevano fossi tagliata. Ora, a distanza di quattro anni, giunta perciò quasi alla fine, posso sperare che avessero ragione e credere che l’abbiano avuta; ma in questo abissalmente piccolo lasso di tempo molti dei miei sogni sono andati persi, molte speranze sono state disattese e ho raggiunto la consapevolezza che tutto ciò è accaduto per mia fortuna. Fosse per me, avrei trovato già tre o quattro uomini della mia vita, diciannove o venti professioni in cui avrei uno spiccato talento e una decina di città in cui vivere contemporaneamente. È sorprendente quanto mutevolezza e vulnerabilità la facciano da padrone nell’adolescenza! Comunque sia, continuo a vivere la mia vita in preda a passioni lancinanti che alternano la più tenebrosa depressione a quel senso di felicità che hai anche quando fai la cosa più inutile al mondo. Se mi guardo intorno vedo molti volti familiari e altri che vorrei lo fossero. Uno è quello di Mery, una ragazza straordinariamente intelligente che ho conosciuto l’anno scorso e che onestamente a primo impatto non sopportavo. Mi somiglia molto, autoritaria e tanto tanto insicura. Anzi , pensandoci bene, assomiglia molto a mia mamma, la donna che più amo al mondo, anche se lei, per colpa mia, non lo sa. Mery sa quasi tutto di me, anche se non mi conosce poi così bene come sembra. Poi c’è Sara, l’altra mia migliore amica, una secchioncella che aspira a diventare pilota e che per un motivo o l’altro ho iniziato ad apprezzare dopo il primo ciao. È una ragazza molto dolce e se non fosse per lei avrei fatto molti più sbagli del mare che già ho fatto. Il volto di Valentina è il terzo che vedo, da quello che 29 so è l’amica di Mery ma per me è soltanto una simpatica e carina di cui, nonostante non abbia la più pallida idea di chi sia davvero, mi fido. Se continuo a guardare mi accorgo degli occhioni azzurri di Alessandra, la ragazza di mio fratello, a cui voglio un gran bene e che credo sia la persona che meglio mi conosce. Poi ci sono Federica e Federica, il magnifico duo di pazzoidi che per prime hanno avuto la mia fiducia anche se ne hanno fatto carta straccia. Dio! Dio quanta gente intorno a me! Migliaia di nomi che porto dentro: Luca e i suoi 99 Posse, Stefania e Mirko, una delle coppie più buffe mai incontrate, Alessandra e la sua infinita dolcezza, Milena, Silena, Vanessa, Sara, Francesco, Patrick, Alessandro, Daniele, Marco…potrei continuare all’infinito. Molte delle persone che ho nel cuore sono davvero importanti per me, altre lo sono meno, ma tutte in un modo o nell’altro sono autrici della persona che sono; non che ci sia d’andarne orgogliosi. Oltre ai visi, però, nel mio cuore, porto anche gli attimi, porto anche quelle emozioni che mai passeranno perché qualora lo facessero il mio cuore finirebbe di battere. Ricordo il mio primo bacio e la prima volta che mi sono innamorata, ricordo le lacrime spese per una ragazzo che non valeva poi granché, ricordo di aver creduto che il mondo mi stesse cadendo addosso e il sollievo nel vedere che “dopo una grande salita, c’è sempre una grande discesa”, come dice mio padre, ponendo la frase con accezione contraria. Sono memorie abbastanza recenti, vista la mia giovane età, eppure talvolta guardandomi indietro mi sembrano passati secoli. Effettivamente sono nata nel lontano 1990 e il cambio di secolo c’è stato, quando mi tornano in mente la pizzeria addobbata con i palloncini per il compleanno di una mia compagna di classe, la mia presentazione ai suoi amici e tutto il pomeriggio passato a fumare sigarette e bere tè ho l’impressione di non essere più la stessa, rivivo tutto come il racconto di una favola, di una storia non mia e mi accorgo che la mia esistenza monotona in cui ogni giorno è uguale a quello precedente, sia invece intervallata da ostacoli che mi hanno cambiata impercettibilmente e, allo stesso tempo, completamente. Alle volte mi basta guardarmi allo specchio per vedere che il mio visino tondo ora è più definito e più simile a quello di una donna. Tuttavia non so ancora cosa sono, né che cosa voglio diventare. Studio psicologia per otto ore settimanali e forse mi illudo di capirla, o forse ci riesco davvero, quindi, e ripeto il forse, il mio futuro si delineerà lungo la strada che già ho intrapreso. L’unica cosa quasi certa del mio domani è lo sfondo: non credo che resterò qui, non che non ami il mio paese o la mia gente, ma adoro viaggiare, e credo che altrove ci siano più opportunità per me. Attualmente sono in una fase di attesa, non so ancora cosa stia aspettando, ma so che prima o poi ci sarà un segno che mi indicherà la strada da seguire. Il solito discorso dell’ adolescenza! 30 In ogni caso credo molto al destino e sono sempre attenta ai dettagli, magari ai più insignificanti, che, tuttavia, credo potrebbero essere lo stimolo per qualcosa di nuovo. E poi, lo so già, aspetto l’ estate. I tre mesi estivi sono quelli che più amo, mi piace soffocare sotto il sole cocente e mi piacciono gli umori che provoca in me. L’estate, e come tutte anche quella passata, è sempre un grande silos di novità e di esperienze. Credo che il cardine dell’ultima sia stato il mio incontro con un ragazzo di venticinque anni, una persona molto particolare e con delle abitudini tutt’altro che comuni, ma un vero maestro, o per lo meno uno stimolo valido. Lo ritengo l’incarnazione del maestro delle teorie psicologicoumanistiche sulla personalità, ovvero colui che riesce a tirar fuori dall’allievo quanto di migliore c’è, insegnando nel modo e nei tempi giusti. Grazie alla sua persona ho avuto molte volte l’obbligo di riflettere sulla mia vita, sul mio modo di rapportarmi agli altri e su ciò che il mondo mi complica o semplifica. Lui come molti altri. Guardando chi mi circonda, cercando di vedere attraverso chi ha personalità, provo a dar forma al mio essere. Ascoltando i miei desideri e le mie passioni sperimento la vita e il mio modo di viverla, in proposito ho sviluppato una specie di “psicologia negativa” ovvero, seppure non ho un modello da imitare, credo di sapere ciò che non voglio essere. Se guardo indietro riscopro ideali politici per cui il mio cuore si è commosso, riascolto discorsi o parole che mi hanno resa cinica e distaccata ma mi sento in colpa verso me stessa. Non voglio essere il modello di qualcuno, non mi curo di fama o gloria ma so di dovere essere giusta verso di me e verso gli altri, di dover vivere le mie passioni dando tutto ciò che posso agli altri. So che tra un anno o due ripenserò a tutto ciò con gli occhi nostalgici per una perduta ingenuità ma per ora voglio pensare che tutto questo affannarsi sui libri e sulle persone non sia stato vano. Se non potessi essere un giorno una persona onesta a cosa sarebbe servito leggere di filosofia o di storia? Se un giorno non fossi giusta avrei buttato al vento le mie emozioni e tutto il dolore che, anche solo per un attimo, è riuscito a farmi toccare davvero la mia anima. Ma, siamo alle solite, tutto ciò è il frutto soltanto della mia adolescenza. Eppure, infatti credo ci sia sempre un “però”, sento ancora il mio cuore soffrire quando il mio sguardo torna su qualcuno con cui le cose non sono andate come avrei voluto e, quel qualcuno, ha tanti volti. A volte mi sono scoperta “persona di passaggio”, sono qualcuno che costringe chi ha intorno a cambiare; non è una cosa che controllo o che riesco a volgere a mio piacimento ma non posso evitarla. Ho visto, nel corso degli anni, il mutare delle persone o, come preferisco chiamarlo io, il vendersi. Già perché così ha fatto Francesca, l’amica di vecchia data, a cui troppo hanno fatto gola la popolarità e la moda; così è stato per il duo, 31 attirate dalla sregolatezza del rock ‘ n’ roll e dal fascino di una “vita spericolata”; così sta facendo Mery che, da studentessa, scivola lentamente tra le braccia del corpo docenti per diventare “una che crede di poter insegnare”. Le sole persone che mi accorgo essere rimaste le stesse sono quelle della mia famiglia, forse perché le uniche che non mi sostituirebbero. Io intanto aspetto, aspetto di trovare qualcuno che non cambi, qualcuno che, anche lui, non mi sostituirebbe. Tornando alla mia vita, quella in termini reali, potrei dire ancora di aver fatto comunione e cresima, di credere in Dio e un altro paio di cosette che non sono poi importanti. Potrei parlare del mio primo giorno di scuola, dei miei sogni o delle speranze ma, disgraziatamente, appoggio Sant’Agostino nel dire che l’unica dimensione di cui facciamo esperienza è il presente e, seppure memoria e desiderio ci portino a credere in un passato e in un futuro, noi non potremmo mai viverli per confermare la loro esistenza. Quindi, perché parlarne? Perché parlare di un tempo nel quale nulla può più essere cambiato e di un altro in cui, allo stesso modo, dobbiamo sperare impotenti? L’importante è il presente, l’essenziale è dare un senso all’attimo che ora stiamo assaporando e all’emozione che ora ci dà voce. Non metto di certo in dubbio il ruolo dell’esperienza e il peso degli errori, ma posso solo “far la conta degli amici andati e dire ‘Ci vediam più tardi’ ” ( il solito Guccini che esprime ciò che di meglio so pensare). O forse, e qui ritornano i dubbi adolescenziali, se non è così che andasse davvero il mondo, il senso di tutto sta nell’accumulare saggezza e serbarla per costruire un futuro in cui sbaglieremo allo stesso modo che se non l’avessimo. Onestamente attualmente non ho emozioni che mi diano voce, e per questo scrivo, ma, come ho già spiegato, aspetto che il mio treno arrivi per iniziare il viaggio; intanto passo il tempo a fantasticare su ciò che non sarà e su ciò che non è stato. Il più chiaro sapore, di ciò che sarebbe potuto essere, lo ritrovo planando a cinque, sei anni fa: estate torrida, ingenuità vergine e sorriso dolce, i miei capelli ricci e scompigliati come sempre, qualche chilo di miele in più nei modi di fare e un ragazzo di ventiquattro anni che ai miei occhi luminosi era perfetto. Certo, i dodici anni di differenza tra me e lui erano un po’ complicati da gestire, ma i suoi occhi azzurri e i suoi sorrisi sinceri non lasciavano spazio né alla razionalità né alla gelosia di mio padre. Credo che, più che gelosia, fosse consapevolezza, era l’unico dei tanti che non si fosse bevuto il cervello, comunque, era sempre molto attento alle mani che si incrociavano, così come gli sguardi e i sorrisi. Stavo vivendo il primo sogno adolescenziale, quello che ancora sa di latte seppure sogni rossetto rosso e tacchi dodici, in ogni modo quello dolce e per niente malizioso, quello capitato per caso e, senza dolore, ovviamente finito. 32 Sono convinta che quello sia uno dei più dolci ricordi che ho, una delle storie di cui ti ricordi i migliaia di momenti fantastici, in cui non c’è l’ombra di lussuria o desiderio, l’unica storia, forse, senza eccessi né esasperazioni, la storia che porti a compimento consensualmente perché sai che è finita, sai che è giusto così, non vuoi cercare di continuarla né lo farai. Il primo amore, quello di cui ti accorgi solo guardandoti indietro e rivendendoti più donna di quanto tu non sia ora. Ricordo la maggior parte dei profumi e dei sapori di quel tempo, ricordo le sensazioni sulle mani e le voci, la mia e quella di Filippo. Quel tempo poi finì e tristemente ritornò l’inverno, cominciai le scuole superiori: il primo giorno mi presentai spavalda e sportiva entrando quasi per ultima. Mi misi al primo banco, l’unico ancora libero, e con mio rammarico mi accorsi che la classe era interamente femminile. Che trauma! Dietro di me sedevano due ragazze sul genere alternativo/rock e il mio provincialismo e i loro visi mi fecero credere per un attimo che, di lì a breve, si sarebbero divertite a bruciarmi i capelli. Si smentirono dopo la prima frase, erano soltanto due cuccioli di gatto che tentavano di far paura tirando fuori le unghiette. I primi due giorni, tempo di presentazioni, ripetei sempre la stessa frase “mi chiamo Laura Latini, vengo da Montegranaro e mi piace giocare a basket e ascoltare musica reggae”, a tal punto che ancor oggi le mie compagne talvolta me la ripetono ridendo. Già dal primo anno trovai la mia “cricca”, come si usa dire da noi, e cioè le classiche ragazze che stanno sedute in fondo alla classe e dettano legge mentre, durante l’ora di psicologia, sono intende a copiare tutti i compiti per le ore successive. Eravamo io, Micol, Emily e Daniela ma purtroppo, Micol ha cambiato scuola e Emily e Daniela sono state rimandate, quindi della mia compagnia iniziale nella mia classe poco resta. In compenso però durante il secondo e il terzo ho trovato il duo, che inizialmente era un trio (oltre a Federica e Federica c’era anche Milena) e devo ammettere che non ho mai riso tanto come nelle ore passate con loro, ero serena, per la prima volta in vita mia ho avuto la terra ben salda sotto ai piedi, ma la sensazione è svanita di pari passo con l’amicizia. Ma per quei brevi secoli posso quasi confessare di essere stata felice, di aver ripreso il respiro necessario per affrontare la salita che ora sto percorrendo. Sì, ora sono nel bel mezzo di una salita: dopo la fine dello scorso anno scolastico, il mondo sembra essersi capovolto anche se, i primi segni di quest’incrinatura, devo confessare di averli avuti già in primavera. Insieme con i fiori sono sbocciati infatti i dissensi e le amarezze in alcuni dei miei rapporti e ora ne sto vivendo il frutto. Vivo in bilico tra rapporti falsi e vere menzogne, tra chi mi mente con la mia approvazione e chi mi dice la verità che, una volta tanto, preferirei non sentire. L’incontro con Daniele mi è scivolato fra le mani degradando lentamente, le mie “amicizie” non sono poi così autentiche e sono in una tappa glaciale della mia vita, una tappa in cui non c’è amore. Tirando per un attimo la testa fuori dalla sabbia devo 33 ammettere di star continuando a errare in mare, seguendo miraggi di isole lontane e stelle che non possono indicarmi il cammino, perché anche loro si muovono disorientandomi e, soprattutto, perché di astronomia non né capisco un bel niente. Spero ancora nella discesa, seppure ancora non scorga la fine della salita, ma se smettessi di credere di aver la possibilità di sciogliere i muscoli, anche solo per un attimo, crollerei e mi fermerei col naso all’insù fissando le nuvole che avvolgono la cima del monte che sto scalando. A volte mi rendo conto di quanto sia precario sognare, causa il fatto che i miei sogni non sono definiti e lo scenario non mi è d’aiuto. Non si può far progetti contando solo su se stessi, c’è bisogno di sapere che anche nel giorno in cui me ne andrò da qui, in cui le cose cambieranno, qualcosa, fosse anche la più insignificante, resterà uguale e vicina a me. Ma tutto ciò è pura follia, come posso sperare che qualcosa resti vicino a me se questo qualcosa non c’è già ora? Il mio problema è la sterilità della vita degli ultimi mesi, ho scordato cosa mi faccia accelerare il sangue nelle vene ma non sono ancora diventata tanto fredda da poter convivere con questa perdita di memoria. Vivo così, tiepidamente nel corso di un autunno che sta diventando inverno, sapendo che, seppure sia ancora l’inizio di questa stagione, arriverà sempre prima il caldo che una nuova ondata di freddo. Mi diverto a far progetti e a studiare, fingo di impegnarmi e di essere stanca. Mi piace recitare, mi ha sempre divertito vedermi persa nell’illusione di me stessa e perché negarsi un po’ di sano autolesionismo? Ora, mentre scrivo, fuori piove. In realtà il cielo è stellato, ma voglio credere che piova perché ciò mi darebbe la possibilità di aprire un nuovo capitolo. Un capitolo che non c’è, la vita non è divisa in capitoli ma a volte ho l’impressione che sia così. Durante la giornata, nel corso di ogni giorno, mi accorgo che ci sono elementi ricorrenti, episodi che in modi e tempi diversi si ripetono, così la sera quando mi infilo sotto le coperte mi diverto a dare un nome al giorno che ho vissuto. Riflettendo su questo mi rendo conto di quanto dolore ci risparmieremmo se davvero sapessimo dire “domani è un altro giorno”, credo che questa frase sia l’ingrediente segreto della felicità, spiega come niente sia eterno e questo è il più grande dono che abbia ricevuto l’uomo. Ma di questo non devo preoccuparmi, ho sedici anni e alla mia età si è sempre felici, non si hanno problemi, non si deve far altro che divertirsi; anzi, se non fosse per l’adolescenza che ti annebbia il cervello rideresti da mattina a sera, come il perfetto imbecille che già sei. L’adolescenza è quasi come una malattia, come una droga che ti costringe a comportarti in modo innaturale, del tutto estraneo al tuo carattere: basta una canzone per scombussolarti le idee e alle volte basta addirittura addormentarsi felici per poi risvegliarsi con un incredibile voglia di piangere. 34 A volte provo a capovolgere le cose, penso ai problemi che hanno gli adulti e alla spensieratezza dei bambini e mi chiedo se sono davvero gli adulti quelli consapevoli e i bambini a non capire; per questo lato sono edonista e sono fermamente convinta che “i problemi ce li ha chi se li fa” e quindi ragiono sul fatto che gli adulti troppo spesso vedono problemi anche la dove non ce ne sono e torno a ragionare su ciò che sono e sulla persona che vorrei diventare. Riguardo a ciò che sono, posso gridare il mio rammarico: il continuo altalenare di stati d’animo, il mio brusco modo di viverli, la confusione delle idee, l’incapacità di prendermi ciò che mi spetta e quella di mostrare ciò che sono. Riguardo a ciò che vorrei diventare, torno a pensare ai modelli che eviterei per amor mio e dei miei genitori e cerco di immedesimarmi in alcuni altri che mai raggiungerò per mancanza di talento o forza di volontà. Non sono comunque pessimista per il futuro, non credo di avere il potere di stravolgere gli eventi ma spero di poter, un giorno, esser fiera della mia persona per la consapevolezza di aver fatto tutto ciò che avrei potuto fare. Ora poi credo di essere tanto vicina a ciò che sto aspettando che quasi ne sento l’euforia, non so ancora cosa sia, ma mi sento vicina ad un cambiamento, ad una novità. Certamente non sarà il mio stile di vita a cambiare o lo sfondo, ma qualcosa sta per trasformarsi o per lo meno la mia fantasia dipinge questo. Mi piacciono i cambiamenti, anche se sono terribilmente nostalgica e ogni volta dico che avrei preferito che le cose restassero com’erano prima, però ora più che mai voglio che qualcosa cambi. Certo, i cambiamenti che vorrei sono lontani ancora, ma non utopie, spero un giorno di poter rimanere in una città il tempo che basti per farmi capire cos’è il mondo fuori da qui, spero di poter viaggiare e capire l’uomo conoscendone tanti e diversi, sogno i poter essere una persona gentile e disponibile e che la vita non mi costringa mai a dover far del male agli altri. Forse sono solo fantasie di una sedicenne ma Gabriella Ferri diceva “la speranza nun costa niente” e rinunciare a sperare è ammettere la sconfitta, è arrendersi di fronte a quelle che poi non sono delle vere difficoltà e io non voglio. Comunque andrà ne sarà valsa ugualmente la pena di aver provato, sognato, sperato, pianto, riso, urlato, sussurrato, di aver passato notti e giorni col naso all’insù cercando la mia buona stella. Quindi sia qui o altrove, sia fortunata questa stella o no, il gioco varrà sempre la candela. Per ora non devo certo preoccuparmi di mirare così in alto, c’è da pensare a lunedì o martedì, quando avrò interrogazioni e compiti in classe e tutto quello che dovrò fare, sarà sedermi dietro ad un banco e scrivere su un foglio ciò che ritengo un mezzo per vivere e non il fine ultimo. Mi piace studiare, credo che dia un senso alla vita o forse m’illudo che sia così per non dover ammettere che il mondo è più triste di come 35 dovrebbe essere a sedici anni, cioè il mondo è sempre lo stesso, a sedici anni o a sessanta, ma la consapevolezza dovrebbe essere propria di chi ha disatteso più speranze di quante non né abbia sognato io. È incredibile, la mutevolezza delle cose, il rapido evolversi di qualsiasi situazione e l’illusione, ancora più assurda, di qualcosa che possa durare per un istante che vada oltre il presente. Ieri, o qualche giorno fa, la mia vita stava riprendendo forma, dopo quel periodo di stasi durato alcuni mesi, stavo ricominciando a muovermi nel mondo, avevo ripreso a cercare il mio posto, qualcosa mi muoveva, come i fili che muovono una marionetta; e sembrava che, come per magia, ciò che mi circondava rispondesse al mio modo solare di guardarlo, agli occhi dolci e innamorati di una sposa che ha scelto l’amore per la vita. Come un tuono, poi, qualcosa che non si vede, non si tocca, ma c’è perché puoi sentirlo, quel fragile equilibrio che hai costruito si spezza, crolla tra le mani, scivolando e gli occhi di quella sposa lasciano trasparire l’amarezza dell’illusione e la nuova sconfitta dell’impotenza. Non so di preciso cosa sia avvenuto, ma d’un tratto, le porte che sembravano aperte si son chiuse. Forse una corrente d’aria è stata più veloce di me, della mia insicurezza e del mio stupore nel ritrovare qualcosa di ciò che speravo potesse essere, per l’ennesima volta devo ammettere di non essere tagliata per questo mondo, di essere diversa. E poi di nuovo, come per mano di una corrente incessante, le porte si riaprono e si riinizia a respirare, e ricominci a credere che, in realtà, quelle porte non si siano chiuse mai del tutto ne lo faranno. Ripensi al mondo e quel nero, che lo aveva dipinto fin l’attimo appena fuggito, s’è fatto d’un grigio più chiaro. Ovviamente non sarà mai del tutto bianco, a meno che non decida di bere tanto da non ricordare nemmeno chi sia, ma si avvicina, alle volte, a quel pallore etereo che, nella cupa scala cromatica, tanto gli somiglia. Forse, quest’insorgere di animi contrastanti è dato dagli anni, forse dalla cultura a cui appartengo, in cui si lotta per costruire il futuro, in cui gli adulti ripetono “voi siete il domani”, senza capire che anche al domani seguirà una nuova aurora e non avrà, allora, avuto senso l’affannarsi, dimenticando chi siamo oggi, per costruire un futuro che tanto non sarà tessuto dai fili che abbiamo intrecciato. E poi c’è la pace, anche nella vita adolescenziale, quella fase di stasi divisa tra il silenzio più assoluto e la riconsiderazione di ciò che si sta vivendo. Ed ecco, come forse avrebbe detto Dante, che tutto quel trambusto che ti agitava, come d’incanto, tace e credi di essere fermo, in piedi sul marciapiede, in mezzo alla folla di viandanti che si muove con gesti iperbolici e urla assordanti; da quel marciapiede mi sono accorta che la madre di tutto e la sua cagion d’essere è il dolore, aver qualcosa che urla dentro ti spinge a muoverti, con occhi bendati, brancolando, nuoti nel buio 36 ma continui pur a camminare. “D’anime, che movieno i piè vèr noi, E non pareva, si venian lente.” (Divina Commedia, Purgatorio canto III), così descrisse Dante le anime che pie camminavano nell’antipurgatorio e così, riorientandoti nella parte di tragitto verso la nuova meta, comprendi di non esser fermo ma, soltanto, di camminare sì lentamente, immersa nel mondo frenetico. Capisci di aver smesso di muoverti nel buio e di star vedendo i primi raggi di luce, quelli fievoli dell’aurora che pur bastano a discernere la strada. E ora, drizzando le orecchie, riscopri la voce tenue che, dentro di te, non ha mai smesso di guidarti ma era soltanto sommersa dalle altre che prepotentemente si impongono: voci come il dolore, il disorientamento; chi spinge nell’andare non è la voglia di gridare o il bisogno di farlo, ognuno ha un proprio perché, e ha bisogno di cercarlo dentro alla propria vita e al proprio modo di viverla se vuole arrivare alla fine con la consapevolezza dell’inizio. E quindi si torna al passato, si riconsidera la strada fatta e quella che si sta percorrendo e si ha uno sguardo più sereno, la serenità di un attimo, spenta appena dopo aver ripensato a quel ragazzo che, sbagliato, ti portava via da ciò che ritieni giusto, ma che trascina la tua vita più di qualsiasi tuo ideale. Perché in quei brevi istanti riconsideri più d’ogni altra cosa l’amore, quella pulsazione tanto vicina al dolore ma ancora di più alla felicità. Io, spartana di carattere, non curante di usi e costumi, della vanità nelle sue diverse forme, dell’ipocrisia e soprattutto di tutto ciò che avanza all’essenziale, ho riconsiderato quanto amare ed esprimere i propri sentimenti sia la metà di ogni azione degna di nota. Ma quella che vivi continua ad essere chiamata adolescenza, fase di vita in cui la lucidità è un lusso, specie al giorno d’oggi. I sogni, le speranze, gli ideali ti portano via dalla vita reale e da ciò che sai, ti fanno sognare e fanno accelerare il cuore per la paura di non poter raggiunge la persona in cui t’immagini ma che è tanto lontana da te quanto te stesso da un’altra. E poi l’amore, il dolore, o comunque lo si voglia chiamare, quella cosa che tanto stringe la tua anima ti confonde ancora: rianneghi nelle tue turbe, sciocche, superficiali ma da cui non riesci ad avere il distacco sufficiente per poterle capire, affrontare, mettere a tacere. Purtroppo però, nell’adolescenza non c’è un elemento dominante, direi che piuttosto vieni trascinata, come una bandiera dal vento, dalle paure che si alternano. La cosa che più temo ora è quella di star lavorando sodo, su di me e fuori di me, per poi non poter raggiungere nemmeno lontanamente le mie aspirazioni; mia madre mi ha detto che nonostante si abbia il presentimento di non poter ottenere ciò che si vorrebbe un domani, non ci si deve arrendere ma che, anzi, se smettessi di sognare la vita non avrebbe alcun senso; ma a che serve sognare se tanto tutto ciò a cui aspiriamo resterà sempre un miraggio? Questo mi spaventa tremendamente, a morte. Non voglio correre tutta la vita dietro a qualcosa per poi rendermi conto, un giorno, di essere troppo vecchia e stanca per continuare a correre. 37 A volte mi capita di ricevere complimenti per la mia intelligenza, per la serietà e per tutte le altre cose che, almeno in teoria, danno alle persone la sicurezza del futuro; ma io ne sono spaventata, so di avere delle potenzialità, me ne rendo conto in virtù proprio della mia intelligenza, ma guardando la vita di chi mi circonda, capisco che la volontà di una persona è ben poca cosa nella decisione della strada che percorrerà; spesso, le nostre effimere opere devono lasciare il passo ad esigenze, evenienze e volontà esterne insormontabili, che ci costringono a vestire i panni di qualcun altro, magari molto diverso da noi. E allora le mie tanto lodate capacità dovrebbero essere tali da poter volgere a mio favore gli eventi, da saper rafforzare il lato buono di ciò che mi viene dato, limitando e contenendo danni effettivi o eventuali, ma io non so fino a che punto i miei pregi potranno sostenermi, non so ciò che posso. Molti a questo punto mi direbbero di affidarmi a Dio, come fanno loro, o piuttosto alla Divina Provvidenza, ma per quanto io creda in Dio, non ho proprio la forza di sperare in qualcosa che potrebbe anche non essermi concessa. In altre parole, il mio spirito appartiene a Dio e a Dio deve tendere, ma la vita deve fare il suo corso, deve avere il suo svolgimento e per questo non ci sarà alcun Dio, ci dovrò essere io, la mia forza, il mio carattere, la mia intelligenza. E se non bastassero? Tempo fa ho letto da qualche parte, francamente non mi ricordo neppure se l’ ho letto o se qualcuno me lo ha detto, che essere coraggiosi non vuol dire non avere paura ma vuol dire ammetterla e trovare il modo migliore per affrontarla. Ho sempre creduto di essere coraggiosa ma a volte non posso fare a meno di dubitarne. Perché poi c’è la paura, quella di cui non riesci a farti una ragione, quella che non razionalizzi e da cui, quindi, non nasce il coraggio. Perché se hai solo la minima coscienza di ciò che sei, di far parte dell’umanità e delle misere capacità che hai in quanto animale non puoi sottrarti alla paura, non puoi credere di vincere una battaglia contro i mulini a vento. Ma, ma dev’esserci una soluzione, tanto vaneggiare non può essere sterile: molti uomini non sarebbero ciò che sono. Il cammino che hanno fatto per arrivare dove sono però non lo conosco, non conosco del tutto la loro storia, le loro consapevolezze, i loro intenti, come posso allora trarne insegnamento o speranza? Vorrei avere qualcuno accanto, un Virgilio dantesco magari, che abbia le spalle più larghe delle mie e un ombrello aperto sotto cui ripararmi. Vorrei qualcuno di cui potermi fidare che mi dicesse qual è la cosa giusta da fare, qual è il comportamento migliore da tenere, qualcuno che abbia più confidenza con la vita di quanta non ne abbia io. Forse questo qualcuno è Dio. Luciano Liagabue ha scritto “Perché? Ci dovrà essere un motivo o no? Forse la vita la capisce chi è più pratico.” (Hai un momento Dio) ed io avrei bisogno proprio di quell’intimità con la vita che ancora non riesco a raggiungere o, per lo meno, avrei bisogno di qualcuno che l’ ha raggiunta e che sappia indicarmi il cammino. 38 Sono disorientata e lo continuerò ad essere, credo di aver capito il percorso di questa vita: una reazione a catena che t’illude che prendendo strade diverse e diversi forse porterai a termine il cammino che hai scelto; fatto è che ci è data una spinta iniziale e un punto d’arrivo ed è assurdo credere che cambiando il sentiero cambi la meta. Mentre scrivevo………ho pensato a cose che erano successe da molto tempo, e non mi era chiaro come andare avanti, cambia completamente la riflessione. Un conto lo sguardo al passato, un conto quello che stai vivendo adesso, la sento ora e riesco ad andare più a fondo. E’ come quando studi storia, la storia del ‘700 sai che è già avvenuta la guardi con tranquillità, la storia di adesso non sai cosa avverrà, le scelte che fai cosa comporteranno un giorno. Pensare a quando ero piccolina ai sentimenti molto più semplici, eterei, ti porta a vederli in modo molto più dolce, quelli che provi adesso non riesci, dici “mi fa male” e basta, non riesci a vederne la dolcezza. E’ come una mamma che partorisce, quando lo fa pensa di morire, poi è passato e pensa magari anche di farne un altro, però dopo, al momento non senti di essere felice, il dolore non riesci a sopportarlo. Mi serve come persona scrivere, anche del passato, per andare a vedere qual è il comportamento che ho dovuto tenere, magari hai sentito qualcosa ma non l’hai manifestato perché il contesto non te lo permetteva, non te ne dava la possibilità, ma dopo, andare a rivedere, riparlare con te stessa ti fa ricordare anche cose che al momento avevi dimenticato perché dovevi rispondere ad altro. Quando vai a scrivere ti tocca fare i conti con quello che hai provato, e dici “questo è avvenuto per questo o questo motivo, allora io sono così, quella persona è così”. Il valore qual è? Ti dà la possibilità di vedere onestamente i rapporti, con te stessa e con gli altri. Ti mette di fronte onestamente perché non hai qualcuno che giudica, o che potrebbe avere una reazione, puoi essere sincera. E’ un modo per raccontarsi da soli, più che agli altri, per poter dire “io sono così”. All’inizio pensavo che venisse una cosa enciclopedica, avevo tante cose da dire, “oddio ci metterò sei anni”. Invece, forse tanti cambiamenti…. La realtà solo in parte cambia a seconda dei miei punti di vista, per un’altra parte sono più le scelte che subisco, perciò io giro intorno a quello che penso io, ma non posso gestire, scegliere la realtà. Ad esempio la nuvola, la sua forma dipende dal vento, è forma sua ma non parte da lei. Mi piace, se lo guardo dall’esterno, pensare al dinamismo, alla vita che assume aspetti simili ma non è mai uguale, mi piace pensare di aver sofferto, gioito, vissuto, guardare il caos, le cose che cambiano data l’età è bello vederle, come guardare un corso d’acqua che cambia con il letto del fiume è bello, ma essere acqua non è facile. Camminare lenti e credersi fermi in mezzo alla gente che cammina e che a volte ti travolge. 39 Stare sul marciapiede e guardare gli altri mi fa sentire, mi porta nella realtà, però con il mio mondo, mi piace avere visione di una strada affollata dove c’è chi va più veloce, chi va più lento, ognuno con il proprio mondo, ma tutti sullo stesso marciapiede. La cosa che mi ha sorpreso di più è stata la mia capacità di rivedere e descrivere gli avvenimenti recenti, sui quali credevo di avere ancora tanta confusione, e invece ho momenti di lucidità e riesco a vedere cosa mi è successo con chiarezza, dando un ordine. Quando parlo di un ragazzo che ho incontrato quest’estate e che si è rivelato uno specchio incredibile su cui vedermi crescere. Mentre lo vivevo non riuscivo a rialzare la testa dalle turbe, a volte credo di avere ancora dei buchi su ciò che ho vissuto, ma se riesco ad entrare dentro il rapporto e posso vederci insieme, vuol dire che ci sono dei capisaldi che non credevo ci fossero. 40 La Merceria racconto scritto da Lucia Interlenghi Tra le esperienze dolorose ma importanti, rientrava anche quella fatta nel mondo del lavoro. Se pensava a sé e alla sua vita si immaginava da sempre disoccupata e disinteressata a svolgere un lavoro vero, o meglio si concepiva impegnata in altre faccende, a disposizione della sorte, in una specie di mobilità esistenziale a seconda delle situazioni che le si sarebbero presentate. Così era stato nel corso dell’ unica esperienza lavorativa che aveva fatto e anche da essa aveva tratto giovamento. Dopo la morte di suo padre aveva preso una decisione importante per la sua vita e per quella della sua famiglia. Rilevare la piccola attività commerciale che fino ad allora aveva gestito sua madre, trasformandola in una attività redditizia con l’apporto di nuove idee ed energie. Non aveva ancora terminato i suoi studi ma era sicura di poter conciliare le due attività. Si ritrovò a fare la commerciante nel quartiere dove aveva abitato da sempre. Conosceva tutti e tutti la conoscevano. Le piaceva molto stare a contatto con la gente e quel posto era frequentato esclusivamente da donne, soprattutto casalinghe, e imparò tante cose durante gli anni trascorsi in quella che lei chiamava la sua “tana”. Si trattava di una merceria dove si vendevano fili, bottoni, filati, abbigliamento intimo, accessori e tanti articoli che lei prima neanche conosceva. La cosa che più l’appassionava erano i gomitoli di lana colorata. Il lavoro a maglia era stato da sempre il suo hobby preferito e trasformare quella passione in un’attività lavorativa le era sembrata un’idea geniale. Amava intrecciare in mille modi diversi i fili che scorrevano velocemente tra le sue dita e, giro dopo giro, prendevano forma maglioni, magliette, vestiti, sciarpe, guanti, cappelli, scarpine da notte. Un mondo di colori e di calore in cui la pazienza era la virtù principale e poi la fantasia e la creatività si esprimevano liberamente. Si trattava di un’attività prettamente femminile, antica come quella del tessere. Tessere tessuti, filati di ogni tipo, ma anche storie, relazioni, rapporti interpersonali, con costanza, precisione e fantasia. Un’attività che dà il senso del divenire, della cosa che cresce, grazie ad un lavoro continuo ed instancabile, un lavoro manuale che scarica ansie e tensioni, libera la mente e favorisce la meditazione. Un lavoro che evoca la regola benedettina dell’”ora et labora” perché nella sua ripetitività induce alla preghiera, al silenzio e alla pace. Sviluppa pensieri gentili e fa del futile un’arma di lotta per tante donne che resistono con la “calza” in mano agli attacchi di uomini prepotenti, di ritmi di lavoro invadenti, di attività domestiche vuote ed alienanti. 41 Quanti veleni si scaricano tra quegli intrecci così complessi e ricercati! Quanta rabbia viene trasformata in graziosi golfini e tendine a filet! Quante lacrime versate su metri quadrati di punto croce e sulla condizione femminile nei secoli! Quanti abitini confezionati con il disprezzo nel cuore per non poter essere considerate cittadine di serie A, solo perché la storia ha deciso che il posto delle donne è la casa! E allora giù a cucire, intagliare, sferruzzare, agucchiare per produrre senza sosta centrini e quadretti per abbellire le case ed ingentilire gli ambienti. Un circolo vizioso perverso ma in fondo “sano”. Quanta violenza sedata dopo aver lavorato chilometri di filo? Quanti baci e abbracci ai bambini per non piangere sul senso di fallimento che spesso opprime le donne e le spinge alla depressione? In questo momento storico non c’è posto per tutti nel mondo del lavoro. Ma non è lavoro anche quello che si svolge dentro casa? Non è lavoro allevare i figli? Non è lavoro prendersi cura degli anziani? Non è lavoro sapersi districare tra offerte e mercatini? Non è lavoro aver cura di se stesse? E’ lavoro, eccome! E non finisce mai, non si và in vacanza, non ci sono turni. Certo, a volte ci si sente delle nullità, ma poi si ammirano con soddisfazione le tendine appena stirate, i merletti nelle credenze, le lenzuola fresche di bucato e ben riposte nei cassetti e si pensa che hanno la stessa dignità dei manufatti delle fabbriche, o dei registri contabili o di una relazione per un consiglio d’amministrazione. Il locale era molto piccolo ma c’erano sempre tante persone, molte delle quali si fermavano solamente per salutare e per chiacchierare. Era una specie di club della maglia e del cucito e lei imparava a conoscere un mondo femminile che le era quasi del tutto estraneo. Fino ad allora l’unica casalinga che aveva conosciuto da vicino era stata sua madre, ma in quegli anni incontrò tante donne diverse da lei e tra di loro che le insegnarono che la casa è un luogo importante e non è solo una prigione per le donne. E’ un luogo dove si esercita una sorta di potere, dove si può essere libere e sentirsi imprenditrici di se stesse senza provare frustrazione. Ha conosciuto casalinghe tranquille e sagge che non hanno mai rimpianto di non aver lavorato fuori casa e professioniste isteriche e confuse incapaci di acquistare un paio di calze, pesci fuor d’acqua fuori dal loro ufficio. Insegnanti snob incapaci di tenere in mano un ago o di interpretare le spiegazioni delle riviste di maglieria, orgogliose della loro incapacità e anziane contadine analfabete espertissime nell’intrecciare sottili fili di cotone e produrre virtuosissimi lavori all’uncinetto, veri concentrati di pazienza, volontà, resistenza e calcolo matematico. Madri, figlie, zie, nonne, nipoti, suocere, nuore un universo femminile che si apriva ai suoi occhi e dal quale attingeva informazioni e consigli che si rivelarono preziosi per la sua vita. Il dolore legato a questa esperienza fu provocato dal clima di recessione che si verificò all’inizio degli anni ’90, quando il mercato decretò un 42 cambiamento nel mondo del commercio, favorendo la grande distribuzione. I grandi centri commerciali, decentrati nelle periferie, cancellarono definitivamente migliaia di piccole aziende, molte a conduzione famigliare, che erano il cuore pulsante dei centri storici e che svolgevano un ruolo importante nei quartieri come centri di ritrovo, crocevia di informazioni, anelli di raccordo tra piccole realtà sociali che attraverso le botteghe comunicavano tra di loro. I piccoli esercizi erano anche fonte di illuminazione per interi quartieri che, da quando le saracinesche sono state abbassate e le vetrine spente definitivamente, sono diventate zone spettrali buie ed intransitabili a piedi, parcheggi infiniti senza più vita. Il libero mercato aveva fagocitato centinaia di migliaia di posti di lavoro, lasciando al loro posto il nulla e tante mine vaganti in cerca di risposte. Ricordava degli anni passati in merceria il calore e i sorrisi delle persone, ma anche le preoccupazioni e gli imbarazzi che le procuravano esimi direttori di banca che le ricordavano di primo mattino che era già scaduto il pagamento della tal rata, o il responsabile dell’ufficio protesti che la invitava gentilmente a provvedere al pagamento della “cosa che lei sapeva” quanto prima, o le lettere di sollecito delle ditte fornitrici alle quali erano tornate indietro ricevute bancarie, tratte e quant’altro fosse intestato a lei. Ricordava anche l’ottusità dei responsabili delle associazioni di categoria, impegnati più a salvaguardare il proprio posto di lavoro che a cercare di ottenere condizioni di lavoro più agevoli e pressioni fiscali mano asfissianti per i loro associati. La crisi si abbattè senza clemenza sul piccolo commercio e sulle piccole imprese in generale e al loro posto fiorirono centri commerciali e ipermercati che si scalzavano a vicenda. Quei luoghi divennero i nuovi punti di incontro di giovani e di tante donne che si ritrovarono con i carrelli della spesa pieni di ogni ben di Dio a parlare con competenza esasperata di marche e sottomarche, di etichette, di prezzi e di qualità dei prodotti, a fare comparazioni tra punti vendita distanti tra loro decine di chilometri. Luna park di luci e di musica in cui i dipendenti erano per lo più giovani assunti a caso e con scarse tutele sindacali, vetrine che cambiavano in continuazione articoli e titolari, in un viavai di personaggi strani e sconosciuti. Intere zone erano diventate terreno di conquista per mercanti senza scrupoli, che dissuadevano i giovani dal lavoro in fabbrica per poi lasciarli disoccupati dopo pochi mesi. Peggio ancora per alcuni ex commercianti, dapprima costretti a chiudere il proprio esercizio e poi assunti come dipendenti dal supermercato, con gli occhi bassi e rassegnati all’evidenza della legge del più forte. Per chi aveva sempre vissuto onestamente del proprio lavoro, investendovi denaro e speranze, quel Nuovo Mondo era un insulto alla libertà e alla dignità. Una realtà di plastica, di neon e di frastuono aveva prepotentemente soppiantato un mondo di tradizioni, di capacità 43 imprenditoriali acquisite giorno per giorno, generazione dopo generazione, un sano rapporto umano tra gestore e cliente, un rapporto di fiducia nei confronti degli istituti di credito che si acquisiva con la conoscenza diretta tra le persone. Il senso del rischio e l’assunzione di responsabilità, il singolo con le sue capacità sostituiti da anonime compagnie d’affari con esigui capitali sociali, senza scrupoli e senza alcun progetto se non la speculazione ed il saccheggio del mercato e del mondo del lavoro. Si sentiva conservatrice da questo punto di vista, molto conservatrice, ma anche molto sincera e aveva accettato di uscire a testa bassa da quell’esperienza lavorativa solo perché nel frattempo era nato suo figlio. Ad una donna–madre-commerciante era negato qualsiasi tipo di tutela sociale significativa. Chissà perché tra le dipendenti statali fare figli era ed è tuttora molto più diffuso che tra le lavoratrici autonome? Intanto i costi lievitavano, la minimum tax e i conteggi fatti sui redditi presunti prosciugavano ogni risorsa e allontanavano ogni speranza di ripresa. Più volte dovette ricorrere alla pensione (minima) di sua madre (vedova) per far fronte al pagamento di scadenze improrogabili! Che umiliazione, che disdetta! E pensare che, tutto sommato, il piccolo negozio funzionava! Aveva clienti e aveva fornitori con i quali aveva un ottimo rapporto di fiducia. Era un’attività così piccola che non avrebbe dato alcun fastidio al grande mercato. Le sue clienti erano per lo più donne anziane che non potevano recarsi a fare i loro acquisti lontano e anche andare a fare la spesa al mercato delle bancarelle era per loro troppo faticoso. Lei offriva quindi una specie di servizio sociale. Acquistava della merce che quasi sempre rivendeva, perché aveva imparato a conoscere i gusti delle sue clienti, pagava i fornitori, pagava tutto ciò che lo Stato le imponeva di pagare, tutti gli interessi che le banche le richiedevano ed era disposta ad andare avanti anche senza guadagnare nulla per sé, perché era giovane, perché aveva entusiasmo ed energie da investire in quel suo lavoro tanto amato. Ma i lacci cominciarono a stringersi troppo e non sopportava più, dopo anni di duro lavoro, di essere vessata ingiustamente da chi le imponeva di raggiungere almeno un certo reddito se voleva mantenere la sua dignità di lavoratrice e contribuente. A lei il suo lavoro bastava ma allo Stato no, non era abbastanza competitiva perciò il mercato la invitava a farsi da parte. E’ aberrante che allo Stato convenga di più avere tanti disoccupati anziché tanti piccoli imprenditori contenti di occupare piccoli spazi di mercato, autosufficienti e capaci di contribuire a loro volta alle casse pubbliche. C’è un’anomalia in tutto ciò, una perversa logica economica che ci rende tutti esseri insignificanti e svilisce il lavoro inteso come valore fondante di ogni società civile. Si esortano le giovani generazioni ad arrangiarsi e a non credere più nella possibilità di riscattarsi attraverso il lavoro onesto. Si preferisce illuderle con il Bingo o il Superenalotto e con il miraggio di lavori occasionali precari e sottopagati, interinali. Si sono 44 mortificate le intelligenze di coloro che hanno investito in anni di studio a favore di coloro che si sono improvvisati mananagers esperti di finanza. Sono state costrette le donne a scegliere tra lavoro e famiglia, a valutare la nascita di un figlio come impedimento per un’impresa e non come un’opportunità di vita. Si è svilito il lavoro riducendolo semplicemente a fonte di guadagno per la sopravvivenza e non valutandolo come occasione di promozione della persona umana, fonte di autostima e benessere. Si spingono i giovani ad accettare qualsiasi proposta di lavoro e a ringraziare chi glielo offre come se si trattasse di un privilegio e non di un diritto. La New Economy ci ha fatto credere che il mercato si regge da solo, che le regole degli uomini e la politica, non servono, che i tassi di interesse che si abbassano bruciando ogni volta miliardi di risparmi e risorse economiche sono un bene, una garanzia perché tanto prima o poi torneranno ad alzarsi. Sì, ma intanto quelle risorse sono andate irrimediabilmente perse e si sono perse altre occasioni di investimento. E mentre l’Occidente gioca con la Borsa e specula sugli sprechi il Terzo Mondo preme alle sue porte e invoca attenzione e rispetto. C’è dunque un sottile filo conduttore che unisce la vicenda di un piccolo esercizio commerciale, costretto a chiudere perché ritenuto un esubero dal mercato ufficiale, e i grandi sprechi di risorse economiche che dividono il mondo tra ricchi e poveri. C’è una follia consumistica che spinge a produrre di tutto ad ogni costo, a consumare di tutto ad ogni costo e a guadagnare per poter spendere ad ogni costo, anche a costo di fagocitare se stessi e sovvertire tutte le regole del buon senso comune. Prima o poi tutto questo finirà e allora ci ritroveremo senza più luci, senza più griffes, né antenne paraboliche, senza competenze lavorative, senza mestieri da tramandare, senza tradizioni cui attingere, senza storia. Ci sarà un nuovo Medio Evo che costringerà l’Occidente a fare il mea culpa dopo essere finito anch’esso a far parte del Terzo Mondo. 45 Pepe, noce moscata e zenzero, racconto scritto da Maria Nives Piazza L'immagine che ho del tempo è un susseguirsi di stanze comunicanti, una volta passati le porte si chiudono ed è impossibile tornare indietro e riprovare le sensazioni di allora. Le cose sono tutte là, fissate in quegli istanti, ma non ci è permesso ripercorrere all'indietro le stanze del tempo. A volte il miracolo avviene. L'odore penetrante della noce moscata e dei chiodi di garofano, l'aroma avvolgente della cannella, quello fresco dello zenzero, il piccante profumo del pepe nero appena macinato... L'odore delle spezie è per me una magica chiave delle stanze del tempo, mi fa ritornare al passato, alla mia infanzia a Jesi. Il ricordo riemerge dalla memoria e diventa sempre più nitido e distinto nei suoi particolari. Sono nella cucina di mia nonna Maria: ci sono due credenze, un tavolo, sedie bianche, un mobile di noce scuro che contiene la macchina da cucire, un mobiletto di vimini a due ripiani con pezzi di stoffe e attrezzi da cucito, un orologio a cucù al muro che scandisce le ore. In uno dei due mobili c'era uno sportello ribaltabile e nel vano erano contenuti barattoli di vetro di varie forme e altezze, contenenti le spezie profumate, mi piaceva molto aprirlo e sentire il loro aroma inebriante. L'odore è anche legato al momento della merenda: tra le mie preferite c'era il pane raffermo, appena bagnato con acqua, insaporito con olio sale e pepe. Mia nonna me ne preparava anche un'altra versione dolce, nella quale il condimento era vino rosso (poco e mescolato con acqua) e zucchero oppure burro e zucchero. L'armadio delle spezie conteneva per me, piccola bambina di 3 o 4 anni, altre meraviglie: un cassetto pieno di bottoni di tutte le fogge, misure e colori, che mi divertivo a svuotare . Il tavolo della cucina aveva infilata sotto il piano, in una apposita fessura, la tavola per fare la pasta. Mia nonna la tirava fuori a metà ed io seduta sulla sedia mi trovavo a mio agio con quel tavolo tutto per me e alla mia altezza: lì, nei lunghi pomeriggi d'inverno, quando non si poteva giocare in giardino, passavo ore a sistemare i miei preziosi bottoni in file e mucchietti. Osservavo incuriosita quelli per me più preziosi e unici: alcuni con strane forme simili a fiori, altri ornati di pietre brillanti, alcuni, per abiti di bimbi, a forma di orsetti, fiorellini, piccole matite colorate, farfalline. Alla fine del gioco mia nonna, con mio grande disappunto, rimetteva alla rinfusa in due scatole tutti i bottoni da me faticosamente suddivisi e li richiudeva del cassetto, pronti per la mia prossima revisione. Nella parte centrale del mobile c'era un incavo con una bilancia di ottone, che mia nonna provvedeva spesso a lucidare con il Sidol, e vicino 46 ad essa una fila decrescente di pesi di varie misure, altro oggetto dei miei desideri. La parte superiore dell'armadio era chiusa con due vetri che scorrevano, decorati da una serigrafia rappresentante un cesto di frutta: lì, accanto a tazze e bicchieri, c'erano sempre monete e foglietti di carta paglia con i conti della spesa. Nell'altro lato della stanza c'era un altro mobile simile al primo, che conteneva piatti e tegami con un altro sportello “interessante” dove si trovavano liquori usati per la preparazione dei dolci : rum, rosolio, marsala all'uovo, alchermez, vermuth… Anche da lì uscivano profumi inebrianti che attiravano la mia attenzione. Nello spazio vuoto nel centro dell'armadio c'era un cestino di vimini rosso pieno di frutta di gesso, dipinta così bene da sembrare vera, che la nonna mi vietava di toccare. Mia nonna Maria era sempre vestita di nero. Quando ero molto piccola pensavo che tutte le nonne e le donne di una certa età fossero vestite di nero e mi meravigliavo molto quando vedevo persone anziane vestite con abiti colorati. Da giovane era stata una bella donna, anche se raccontava sempre di essersi sentita brutta: era alta più di un metro e 75, capelli biondi ricci e occhi azzurro cielo, lunghe gambe, un fisico che oggi sarebbe da modella, ma che non corrispondeva ai canoni della bellezza del tempo in cui era vissuta, prima metà del 900, periodo in cui erano particolarmente apprezzata donne more e formose. Aveva zigomi alti, belle labbra carnose e un bel sorriso. Io la ricordo però vestita di nero e incurvata, già vecchia, anche se quando sono nata aveva meno di 60 anni (poco più della mia età). Mia nonna aveva perso una figlia, morta a soli 23 anni, che portava il nome che poi è stato dato a me, Nives. Il suo dolore fu profondo e insopportabile, si vestì a lutto e non volle più toglierselo. A casa mia fino a grande non venivo mai chiamata con il mio nome, per non risvegliare il dolore in mia nonna, ero per tutti “Cicci” o “Mavetta”, nome che era stato coniato da mia madre come diminutivo di Maria Nives , il mio vero nome. La nonna non usciva quasi mai di casa. Usciva la domenica, prestissimo, andava alla messa delle 7 alla chiesa dell'Ospedale e poi al Cimitero, percorrendo diversi chilometri a piedi con il suo passo veloce. Una volta a settimana, nel pomeriggio, andavo con lei e mia madre a trovare due sue sorelle che non si erano sposate e vivevano insieme nella vecchia casa che era stata dei suoi genitori. Per me era una festa andare a trovare le zie, abitavano non molto distante dalla nostra casa, ma mi sembrava di entrare in un altro mondo. La strada dove io abitavo era un largo viale alberato con due file di ville o case a più piani circondate da giardini, le zie abitavano in quartiere popolare, una fila ininterrotta di case che davano direttamente su una via in discesa dalla quale poi si usciva dalla città. Davanti ai portoni, quando non era troppo freddo, c'era sempre 47 gente seduta all'aperto sulle sedie a chiacchierare ed osservare le persone che passavano e lanciare saluti e battute scherzose. C'erano anche diverse donne anziane con piccoli banchetti di legno pieni di mercanzie davanti ai portoni spalancati sulla strada. Quando ero molto piccola mi facevano un po' paura, acquattate nell'oscurità degli androni mi chiamavano con voce suadente e in dialetto per offrirmi le loro merci. Erano piccole cose, soprattutto dolciumi, caramelle che costavano una lira, mentine, i lupini, le “becche”(semi di zucca), i ”sorcetti”, ovvero piccole liquirizie a forma di animaletti.....Mia nonna mi comprava sempre qualche cosa e mi dava in mano il piccolo cartoccio di carta paglia . Arrivati al portone nella casa delle zie salivamo una rampa di scale, si sentiva un odore di chiuso e di muffa, a metà c'era un pianerottolo con una piccola porta che dava su un minuscolo orto dietro la casa. Ricordo la strana sensazione quando la porta, così bassa che i grandi si dovevano chinare per passare, si apriva e dalla penombra delle scale si usciva fuori, alla luce abbagliante del sole e all'aria aperta. Anche la casa era molto piccola, si entrava nella cucina e poi c'era un'altra camera con un letto matrimoniale e un divano, nella cucina si apriva anche la porta del “cesso”. Mia zia Vittoria somigliava molto a mia nonna, anche lei alta e magra, occhi azzurri, non si era mai sposata anche se aveva avuto molti prendenti, trovava sempre qualche cosa da criticare negli uomini. Mia nonna mi raccontava che, quando erano giovani, nel quartiere le avevano soprannominate “le signorine inglesi”. Mia zia Gigiola (Luigia) invece era più bassa e robusta, capelli castani e occhi tra il grigio e l'azzurro, aveva avuto, ancora giovane, un ictus ed era rimasta paralizzata , la ricordo sempre su una sedia, sempre a tentare di farci capire quello che voleva dirci, con un vecchio quaderno davanti, dove faticosamente cercava di scrivere quello che non riusciva a pronunciare. Il piccolo piacere che le era rimasto era ascoltare la musica alla radio. Qualche volta trovavamo anche l'altra sorella di mia nonna, la zia Italia. Abitava con il marito in un piccolo paese in collina, non avevano avuto figli, erano una coppia molto eterogenea: lei religiosa in maniera quasi fanatica, lui uomo molto intelligente ed aperto, entusiasta delle idee anarchiche e socialiste, grande e appassionato lettore di libri di politica e di scienze. Mio zio Domenico sembrava un vecchio gentiluomo dell'Ottocento, veniva a casa nostra a trovare mia nonna elegantemente vestito con un abito scuro gessato a doppio petto, gli occhialini a pince-nez con la catenella, l'orologio a cipolla nel taschino del panciotto e un cappello a tuba nero in testa, la barba grigia ben curata. Con mia nonna discuteva di politica e dei grandi interrogativi dell'esistenza, con grande gusto da parte di entrambi. Con la moglie non era possibile parlare di simili argomenti senza che lei non iniziasse a farsi grandi segni di croce e a dire il rosario per allontanare lo spettro dell'inferno, evocato dai discorsi di quel marito ateo e eretico. 48 Quando trascorrevano un periodo in città si sistemavano nelle due stanze al piano terra che di solito rimanevano sempre chiuse. Ricordo della casa delle zie la penombra, il lavandino di graniglia con lo scolapiatti di legno e uno analogo per i bicchieri, dove mia zia Vittoria mia aiutava a mettere il bicchiere dopo che avevo bevuto, il gusto dell'acqua, che mi sembrava diversa da quella di casa mia, gli odori di muffa, di chiuso, di cose vecchie, ma anche il profumo inebriante dei bianchi gigli di S.Antonio, che fiorivano nell'orto, tra il prezzemolo e le foglie di bietola. Un'altra delle rarissime uscite di mia nonna era alla fine di settembre per la fiera del paese: ci andavo con lei e mia madre, la nostra meta principale era una piazza dove si trovavano tutte le bancarelle che vendevano stoviglie. Con grande fracasso gli ambulanti mostravano la qualità della loro mercanzia facendo ruotare rumorosamente pile di piatti. In quella occasione venivano acquistati nuovi piatti da usare tutti i giorni in sostituzione di quelli che si erano rotti durante l'anno. Mia nonna aveva una grande tristezza di fondo, una visione tragica della vita, anche se in lei non mancava una sottile vena di umorismo e una grande capacità di cogliere sempre il lato comico della situazione. Era una donna molto intelligente e interessata a tutto quello che avveniva intorno a lei e nel mondo, anche se non aveva studiato molto, costretta, per la morte prematura del padre, a interrompere la scuola poco dopo le elementari: leggeva tutti i giorni il giornale, le piaceva sottolineare le cose più interessanti e tagliare i trafiletti delle notizie che l'avevano più colpita: ogni tanto tirava fuori dalle sue tasche pezzetti di carta di giornale e leggeva a noi le cose che le erano sembrate importanti, in cima al foglietto metteva a volte il nome della persona per il quale aveva ritagliato la notizia. I nomi erano tracciati con la sua grafia inclinata e regolare, perfetta, ricordo dello studio della calligrafia fatto a scuola. Mia nonna amava molto scrivere bigliettini per tutte le occasioni: non solo per le feste o per i regali che faceva ai compleanni, anche nell'armadio e nei cassetti della sua camera le cose erano riposte, in perfetto ordine, in buste di plastica ognuna recante un pezzetto di carta di quaderno con l'indicazione del contenuto: “maglie vecchie”,”calze nuove”. C'era anche una busta “cose pulite da mettermi quando sarò morta”. Vivevamo in una casa a due piani con grande giardino intorno; al piano inferiore vivevano i miei nonni e di sopra la mia famiglia: io, mio fratello e i miei genitori. Passavo gran parte della giornata fuori o al piano inferiore, mio padre tornava dall'ufficio verso le tre del pomeriggio e quindi noi ragazzi e mia madre pranzavamo di sotto insieme ai nonni. Mi piaceva molto stare nella cucina con mia nonna, particolarmente quando cucinava, e soprattutto quando preparava qualche dolce. La tavola della pasta veniva 49 tirata fuori e anche io avevo un piccolo angoletto dove potevo divertirmi a pasticciare e a stendere il mio pezzetto di pasta con un piccolo matterello. A casa mia venivano fatti dolci di molti tipi: la”potizza”, il “presniz, il “kuguluf” di origine friulana (mia nonna era vissuta a Trieste per molti anni e anche mia madre è nata là) ma anche dolci dell'altro estremo dell'Italia, la Sicilia, terra di mio padre: cannoli di ricotta, ”sfingiuni”, “pignolata”. Ma il dolce che mi piaceva più di tutti era la famosa “Torta Royal al Tropical Aroma”, come si leggeva sul libretto delle ricette che mia nonna ogni volta tirava fuori per ricontrollare gli ingredienti, una torta nella quale venivano utilizzate alcune delle mie amate spezie, credo noce moscata, cannella, zenzero e un po' di pepe, farcita poi con una sontuosa e ghiotta crema di burro e cacao. Mio nonno Mariano aveva il suo posto fisso alla tavola da pranzo, aveva una poltroncina rossa di vimini con un cuscino damascato, mentre gli altri sedevano sulle sedie bianche della cucina. Ricordo mio nonno con una giacca da camera rossa e blu a righe, legata con un cordone di raso, che, per farmi divertire, inventava giochi di prestigio facendo comparire un uovo dalla manica oppure dal piccolo pezzo di canna di bambù che mia nonna utilizzava, infilato nella cintura del grembiale nero, per tenere meglio i ferri da calza quando faceva la maglia. Rimanevo estasiata a guardare le meraviglie che mio nonno faceva per me. Mio fratello nacque quando io avevo quasi sei anni e fino ad allora fui la principessa indiscussa della casa. Mio nonno mi portava spesso al cinema, a vedere soprattutto film storici sull'antica Roma . Devo aver visto un film su Pompei, ricordo che ero terrorizzata da vulcani e terremoti, mi svegliavo di notte in preda ad incubi e mia nonna veniva a prendermi nella mia camera al piano di sopra e mi portava a dormire nel suo letto. La paura dei terremoti mi è rimasta ancora oggi. Un'altra grande passione di mio nonno era il giardino, faceva venire piante e fiori anche dai famosi vivai di Padova, aveva realizzato aiuole di forme geometriche diverse, a stella, a cuore, a goccia sempre curatissime e piene di fiori. C'era anche una grande vasca con i pesci rossi e un puttino al centro che spruzzava acqua. L'arrivo della primavera era ufficializzato dalle operazioni per tirare fuori dalla cantina e rimontare per me e per gli altri nipoti una bellissima altalena verde con due sedili. Ci divertivamo tanto a mandarla sempre più veloce e più in alto, fino a sfiorare una pianta di rose bianche che si arrampicava su una palma lì vicino. Mio nonno si occupava personalmente della cura del giardino, ma per i lavori più pesanti e impegnativi c'era un giardiniere che veniva spesso da noi. C'era sempre da potare, vangare, mettere a dimora nuove piantine, dare il verderame e lo zolfo alle rose e alle viti. Il giardiniere era un omone grande e grosso con radi capelli grigi, l'aria burbera, una camicia a quadri e 50 grandi bretelle che gli reggevano i pantaloni sformati e polverosi, grandi e ruvide mani. Era un tipo taciturno e solitario, ma con me era molto gentile ed io ero particolarmente affezionata a lui. Lo seguivo interessata, osservavo tutto quello che faceva, ho imparato da lui ad amare le piante e anche a fare innesti.. Per me era una festa quando doveva andare a vuotare la vecchia carriola di ferro, piena dei residui delle potature, al fosso in fondo alla strada di fronte a casa mia: lo accompagnavo camminando accanto a lui e, una volta vuotato il contenuto, era il mio momento: ”Vuoi salire principessa?”, mi diceva, e mi tirava su a sedere nella carriola. Tornavo così sulla mia carrozza, accompagnata dal rumore cigolante della ruota, felice e fiera del mio cavaliere. Oltre al giardiniere, c'erano spesso altri personaggi che, diretti da mio nonno, traducevano in realtà i suoi continui progetti di rinnovamento di casa e giardino. Ricordo un ometto piccolo e magro, che faceva il falegname, di soprannome “Centurello”, che con un metro di legno ripiegabile infilato nella cintura, martello, chiodi e altri attrezzi nelle tasche, cercava di accontentare il “Sor Mariano”. Io piccolina, lo identificavo con San Giuseppe, forse per la sua aria umile e per il mestiere che faceva. C'era anche un altro uomo di piccola statura, ma questa volta piuttosto rotondo e con le guance rubiconde per le abbondanti bevute dal fiasco di vino che si faceva dare da mia nonna appena arrivava, perché ”non si può lavorare con la gola secca”. Il suo soprannome, “Grappì”, era certamente dovuto alle sue abitudini. Era spesso in giardino per fare i lavori più pesanti: “Cocca ne vuoi un goccetto?”, mi diceva strizzando l'occhio e mostrandomi il fiasco del vino. Mio nonno era tutto preso dalla direzione di quella squadra di strani personaggi, che non riuscivano quasi mai a realizzare alla perfezione le sue idee ardite. Nel pianerottolo del balconcino su cui si apriva il portone di casa mio nonno aveva costruito, con l'aiuto di Centurello, una grande voliera verniciata di azzurro: era abitata da pappagallini gialli, azzurri e verdi, che chiacchieravano incessantemente. Avevano altalene e altri giochi e due nidi di legno con uno sportellino apribile alle due estremità della gabbia; spesso salivo su una sedia per curiosare dentro e vedere se avevano deposto le uova. La cosa che più mi incantava però era il fondale dipinto che, protetto da una parete di rete, stava dietro alla gabbia e rappresentava una casa con le finestre ornate da tendine e piccole piante grasse, anch'esse dipinte, sui davanzali. Il nonno aveva anche realizzato per me una bellissima casa per le bambole, formata da tre stanze comunicanti: il salotto, la camera da letto e la cucina, arredate con piccoli mobili di legno e di vimini, le tendine di stoffa alle finestre e minuscoli quadri alle pareti ricoperte da carta da parati. La mia vita trascorreva tranquilla e felice. 51 Era la Pasqua del 1962, avevo 11 anni, avevo fatto da poco la prima Comunione. Avevamo ospiti a casa, amici di mio padre di Roma, una coppia di siciliani con una figlia di circa 20 anni, Carmelina. Mio nonno soffriva di cuore, si sentì male, fu chiamato il medico. Io ero nell'appartamento di sopra insieme ai nostri ospiti, ricordo il tramestio, aprire e chiudere il portone, le voci affannate, poi l'urlo disperato di mia nonna. Scesi le scale di corsa, una porta a vetri in fondo alle scale divideva i due appartamenti, di fronte, nell'ingresso del piano inferiore, c'era un grande specchio rotondo. Dallo specchio vidi la porta aperta della camera dei miei nonni e nonno Mariano riverso sui cuscini. Ritornai di sopra con il cuore che mi martellava nel petto, come impazzita mi buttai in ginocchio per terra e, con le mani giunte, chiesi perdono a Dio, quasi sentendomi responsabile, per qualche mio non confessato peccato, della morte di mio nonno: Carmelina cercava di confortarmi e mi tirava su, ma io continuavo a ripetere gli stessi gesti. Ricordo lo specchio in fondo alle scale coperto con un drappo scuro per un lungo periodo, il silenzio rotto solo dal lamento di mia nonna che aveva perso il compagno della sua vita, il suo ”compagno di sventura“, come lei lo chiamava. La cucina era diventata fredda e silenziosa, gli scuri delle finestre socchiusi, mia nonna seduta nel solito angolo, lo sguardo perso nel vuoto, un fazzoletto stropicciato stretto fra le mani. L'orologio a cucù che batteva le ore era l'unico rumore che si sentiva. Piano piano riprese la solita vita, ma il posto di mio nonno a tavola rimaneva sempre vuoto. Un giorno, al ritorno da scuola, non ricordo quanto tempo fosse trascorso dalla morte del nonno, presi la decisione di sedermi sulla poltroncina rossa. Mia nonna sollevò lo sguardo, mi fissò per qualche attimo; avevo paura di un rimprovero, invece piano piano le sue labbra si aprirono a un sorriso, anche se i suoi occhi erano pieni di lacrime: ”Ti voleva tanto bene ....” sussurrò. Da allora quello fu il mio posto a tavola. La poltroncina rossa è ancora con me, mi ha accompagnato all'università e, dopo il matrimonio, mi ha seguito in quattro traslochi. Ci sono seduta sopra anche ora mentre sto scrivendo. Sono passati tanti anni da quegli avvenimenti. Ho finito da poco 57 anni. Ho passato parecchi anni della mia vita lontano dalla mia regione e poi dalla mia città: ora son tornata ad abitare dalle mie parti. Sto in campagna a meno di dieci chilometri da Jesi, mio paese di nascita. Sono andata via come molti della mia generazione con un certo senso di liberazione, come una fuga da qualcosa che ci stava stretto, dalla vita di provincia che ci sembrava immobile e soffocante. Ora invece mi sembra tutto così 52 piacevole, una dimensione più umana della vita. Certamente sono cambiata io, ma anche il mondo è cambiato, tutto ora è più vicino, e abitare nelle grandi città è davvero molto stressante. Vivo in una grande casa in collina, con mio marito e due figli di 31 e 26 anni, uno lavora nel campo dell'informatica e l'altro è laureato in scienze forestali e ambientali, ed è in partenza per un dottorato di quattro anni in Canada . Il sogno di andare a vivere in campagna l'avevo da un sacco di tempo, ma sembrava destinato a rimanere tale, poi il destino si è messo in moto. Ho visto che era in vendita una casa che mi aveva da tempo affascinato, poi in realtà abbiamo comprato un'altra casa, e piano piano ho convinto mio marito, che all'inizio era molto scettico, soprattutto per l'aspetto economico. Ora anche lui è molto felice per la scelta. In campagna la dimensione della vita è molto diversa, si ha un contatto diverso con le cose: i ritmi delle stagioni, il passare delle ore del giorno ti danno un senso nuovo della vita, si riesce a entrare meglio in contatto con le cose più importanti, tante altre che prima sembravano contare diventano superflue. Il mio amore per animali e piante ora ha spazio per svilupparsi: ho un giardino con tante piante ancora da sistemare, in questo momento undici gatti (ne ho avuti fino a quindici) e due cani che convivono con grande amicizia, anche stamattina la gattina tigrata Chicca dormiva al calduccio per ripararsi dal freddo di questa prime mattine di primavera sopra la fitta pelliccia della mia cagnetta Missy (incrocio tra una barboncina e un ignoto seduttore). La mia gatta più vecchia ha sedici anni, e fa parte da sempre della mia famiglia, ha cambiato con noi tre case e vissuto insieme a noi tanti avvenimenti, non dimostra assolutamente la sua età, è una bella e piacente gattona a tre colori con ancora tanta voglia di giocare e di saltare. Se a volte mi vede triste si preoccupa per me, mi gira intorno miagolando come se volesse parlarmi e consolarmi. La vita in campagna non è così “idilliaca” come pensavo, ci sono sempre tante cose da fare, tra animali, orto, frutteto, olivi, giardino, gli impegni della casa e della famiglia, ma non mi pento assolutamente della scelta fatta. Qui il cielo nelle notti limpide è uno splendido arazzo blu tessuto di stelle e la luna quando è piena illumina a giorno le campagne. E' così piacevole, in queste mattine di aprile, alzarsi presto, infilarsi un giaccone di lana sopra il pigiama e uscire in giardino poco dopo l'alba, sentire i canti d'amore degli uccelli, scoprire i fiori che stanno per sbocciare, alzare lo sguardo alle colline intorno con le vigne che stanno svegliandosi dal letargo invernale, i paesi in cima alle alture, il verde del grano, le macchie di bosco più scure in lontananza e la linea argentea del mare in fondo all'orizzonte. Certo anche il lavoro si prepara: la nuvola bianca del mio grande ciliegio di qualche giorno fa già sta scomparendo, tra poco più di un mese sarà ora di preparare barattoli e barattoli di gustose, e faticosissime, marmellate per la famiglia e gli amici. 53 Nonostante tutti gli impegni sto riuscendo a trovare spazio anche per nuove e vecchie passioni che fino ad ora avevo lasciato da parte: disegnare, dipingere, e anche scrivere...... A 57 anni di vita non mi sento “saggia”, e credo che l'esperienza non si possa trasmettere, ognuno deve farla sulla propria pelle, mentre si cerca di essere se stessi, al di là dei legami e dei condizionamenti della società, della famiglia e del lavoro. Tuttavia quello che mi sento di dire ai ragazzi è di non essere troppo rigidi con gli altri, e con se stessi, di non aver paura di mettersi in gioco e di affrontare le sfide che la vita continuamente ci presenta e di non lasciarsi condizionare dal giudizio degli altri. Anche le imprese più difficili, quelle che ci sembrano impossibili, possono essere realizzate, passo dopo passo, con pazienza e costanza; se si desidera veramente qualcosa, quasi sempre si riesce ad ottenerla e le cose più difficili sono quelle che ci danno le più grandi soddisfazioni. Il desiderio di scrivere è da tanto tempo nascosto in fondo all’animo, rimandato, si fa vivo e poi la paura, l’affrontare il foglio bianco (o lo schermo bianco del computer), non riuscire ad iniziare: poi l’avviso del corso, un piccolo foglio, ma l’occhio rimane subito colpito, il cuore fa un tuffo, è il momento di mettersi in gioco e di provare. Un momento di evasione dalla pressione dei doveri quotidiani, ma anche spazio per ritrovare se stessi, rivivere ciò che è passato, riprovare emozioni, rivedere colori, riascoltare sensazioni. Forse è il momento giusto per guardarsi dentro, quando si fa un po’ il bilancio di ciò che si è fatto e dei sogni rimasti nell’aria. E poi conoscere nuove persone con i miei stessi interessi e desideri, con le quali condividere nuovi percorsi, nuove esperienze. All’inizio questo “compito” di scrivere di noi è stato faticoso. Sono stata parecchi giorni a rimandare, di nuovo la paura del foglio bianco. E’ che scrivere è scrivere per essere letti, in ogni caso. E’ uno scoprirsi che ti mette a nudo, anche con te stesso, momenti in cui ti senti debole e svuotata, ma credo che sia una sensazione che è necessario provare, per poi ricostruirsi nuova e più forte. Poi, una volta superato il blocco, la piena dei ricordi ti spinge sempre più avanti, foglio dopo foglio e provi un senso di liberazione, le cose sono tutte pronte a venire fuori a definirsi sul foglio, è come un parto che non si può fermare, doloroso ma bellissimo. Non mi era chiaro se in fondo desideravo rendere così pubbliche le mie pagine di ricordi. Mi sentivo lusingate dal suo interesse e dall'apprezzamento che aveva espresso per quello che avevo scritto. Poi ho iniziato a pensare che cosa avrei potuto narrare e la prima cosa che mi è venuta in mente è la mia infanzia, i ricordi felici della mia vita con i nonni. Mi sono immersa totalmente in quei lontani giorni, ho rivissuto veramente tante sensazioni che in parte avevo ancora vive nella memoria, in parte sono riemerse via via che scrivevo. E' stata una esperienza molto emozionante anche se 54 faticosa, non avrei voluto più uscire da quella sensazione di sogno ad occhi aperti, dal rivivere situazioni di tanti anni fa, presenti di nuovo in tutta la loro nitidezza, colori, odori. Non ho rivissuto questa storia come uno spettatore esterno, io sono stata di nuovo là, ero di nuovo la bambina di allora, e sento che questo mi dà più potere, più forza e sicurezza e quindi credo che sia positivo per la mia crescita personale. 55 A pugni stretti, scritto da Valeria Palmitesta Quando ho accettato la proposta che mi era stata fatta di scrivere un racconto autobiografico per una pubblicazione l’ho fatto, come sempre, senza pensarci troppo su, come ogni volta che mi trovo davanti a qualcosa che mi entusiasma o mi incuriosisce particolarmente. Non pensavo potesse rivelarsi così difficoltoso. In fondo sono sempre stata attratta dalla scrittura, dal racconto, dal raccontarsi in particolare, ho sempre avuto un occhio aperto su me stessa ed ho sempre usato la penna ed il foglio per fermare impressioni, emozioni, avvenimenti, descrizioni di persone o eventi che mi colpivano in particolare. Ma in questo caso è diverso, e raccogliere le idee e focalizzare l’attenzione su pochi aspetti particolari, raccontare rivivendoli dei momenti della propria vita richiede uno sforzo che non pensavo potesse essere così profondo. Sono mesi che cerco di capire cosa voglio raccontare, su chi o cosa è meglio incentrare il racconto…mi sono passate davanti esperienze, persone importanti, incontri, contesti di lavoro, ma alla fine ho scelto ciò che più mi ha coinvolto. Tutto risale a qualche anno fa, era il 2002. Non era un bel momento per me, e quello stato confusionale, un po’ patito in cui ero, si sarebbe protratto ancora per molti mesi, ma in quel momento non potevo saperlo. Qualche mese prima avevo commesso un errore di valutazione che mi aveva spinto ad iniziare una storia, che credevo potesse essere la storia con il grande amore della mia vita. La persona in questione era un caro amico in realtà, una persona con cui, per tutti gli anni delle scuole superiori, e poi per i primi anni di università, avevo condiviso una forte intesa intellettuale, “di testa”, come si usa dire…una totale vicinanza di pensieri, di idee, ed una totale comprensione dell’anima. Ci attraevamo a vicenda e ci proteggevamo dal mondo, chiudendoci spesso in lunghe conversazioni in cui, già prima di iniziarle, pregustavamo la totale affinità che le avrebbe condotte, e le conclusioni unanimi che avremmo raggiunto. Questo credo non abbia nulla a che vedere con l’amore, ma evidentemente è stato facile sbagliare. Lui era una persona molto decisa e da anni aveva accanto una ragazza dolce che viveva per lui, e chi anche io conoscevo. Quando la loro storia è andata in crisi io mi sono trovata nel mezzo del vortice e non sono stata abbastanza furba da tirarmi indietro. 56 La cosa più normale che potesse accadere è che lui si aggrappasse a me, cercando delle spiegazioni razionali al perché dovessi essere io la donna per lui, quando in amore la razionalità c’entra sempre poco. Abbiamo forzato la mano e abbiamo entrambi confuso quello che ci aveva sempre uniti, la famosa attrazione psicologica e mentale, con l’amore. Dire cosa rappresentasse lui per me non è affatto facile...per anni l’avevo usato come termine di paragone per valutare tutte le persone che incontravo, la stima che avevo di lui era superiore a quella che avevo per chiunque altro…in fondo lo avevo idealizzato, non era difficile da capire. Ricordo chiaramente mia madre, alla quale mi trovo puntualmente a dover dare ragione, che, abbandonata l’abituale freddezza, dimostrava inquietudine e mi guardava con apprensione. Lei non ci credeva, non credeva che le cose fra noi sarebbero andate per il verso giusto, o forse aveva presentito la enorme batosta che avrei preso. La verità è che nei pochi mesi in cui siamo stati insieme io sono cambiata. Quello di cui mi facevo forte quando ero la sua amica, mi rendevo conto che come ragazza non andava più bene. Il suo carattere forte non voleva accanto una ragazza altrettanto forte… mi stavo trasformando nella sua ex, in quella ragazzina tranquilla e fragile che lui aveva avuto Accanto per anni…mi rendevo conto che io e lei eravamo state complementari, ma non potevamo essere sovrapponibili, io avevo un altro ruolo. Presto se ne accorse anche lui, che scelse di allontanarsi da me e di tornare da lei. E fece sicuramente la cosa più giusta per tutti e due, anzi per tutti e tre, solo che per me fu difficile da accettare, ed i segni mi sono rimasti dentro per anni. In qualche modo ebbi una sorta di perdita di identità. Mi sono auto punita per quella storia, rendendomi colpevole agli occhi di tutti gli amici in comune che avevamo avuto per tanto tempo…come se la colpa fosse stata mia, e soprattutto come se l’aver iniziato quella storia fosse stato un atto di egoismo mio nei confronti della ragazza che lui aveva lasciato. Vedevo le mie e sue amiche pettegole che con odio pensavano di me “lo avevamo detto noi che prima o poi ci avresti provato”…in effetti il nostro rapporto aveva destato per molto tempo sospetti nelle teste maligne delle persone che ci circondavano, ed io sono stata l’unica che ne ha pagato le spese. Rancori a parte, e quelli purtroppo restano ancora oggi, forse trasformati in indifferenza, all’epoca mi tramortirono. Ma ancora non capisco quanto fosse reale e quanto sia da imputare alla mia testa, che si condanna sempre e quasi mai si concede di dare spazio e forza ai sentimenti. 57 Comunque, quello che è successo dentro di me in quel periodo mi ha cambiato letteralmente la vita, ha distrutto la mia personalità, il mio modo di essere, e ci ho messo anni a ricostruire i pezzi e a riprendere la strada che era mia e di nessun altro. Sono stata insieme a questo ragazzo pochi mesi , ma questi pochi mesi sono bastati a farmi perdere di vista quello che ero stata per anni. Come se l’essere rifiutata da lui mi avesse fatto perdere in qualche modo valore, e come se il mio non essere brava a gestire quella relazione mi avesse portato a diventare simile alla ragazza che lui aveva amato. Anche il mio corpo cambiò, e diventai fisicamente fragile, come lo ero nella testa. Diventai magra, io che non lo ero stata mai. Mi sentivo forte se riuscivo ad occupare poco spazio, ad essere stretta, piccola, richiusa in me stessa. Questo è stato il mio atteggiamento verso la vita per alcuni anni. Sono piombata in una solitudine profonda. Mi sono messa in condizione di essere sola, forse perché non mi perdono le cose. Non sono stata in grado in quel momento di guardare a testa alta chi mi stava davanti, mi sono sentita colpevole e sbagliata. Ed ho iniziato silenziosamente a punirmi. Il dolore che provai al momento in cui lui mi lasciò, e nei giorni seguenti, era davvero profondo…avevo perso i ricordi di quasi dieci anni, non solo quelli di pochi mesi…mi era crollato un mito, un punto di riferimento, che non potevo più avere perché il solo pensiero di lui mi faceva soffrire . Guardare alla mia vita fino ad allora era ricordare un’infinità di momenti trascorsi con quella persona accanto, una delle poche con cui mi ero davvero confrontata, identificata, aperta e confidata. E legato al suo c’era il ricordo di tante altre persone che avevano fatto da contorno alla nostra amicizia, e che forse tanto amiche mie in realtà non erano state mai…non fu difficile per me allontanarmi da loro, prendere le distanze dalla mia vita passata…solo che questo significava prendere le distanze anche da quello che ero stata fino a poco tempo prima. Con pazienza e dedizione cominciai a demolire a piccoli pezzi me stessa, e diventare un'altra. Così, senza pensare più di tanto, senza guardarmi dentro come avevo fatto assiduamente per anni,…senza volermi più bene, senza più sorridere. Per alcuni giorni ho creduto che lui sarebbe tornato e tutto sarebbe tornato come prima, ma la cosa sorprendente è che quell’attesa, quella speranza è durata poco. Il mio corpo stava cambiando come la mia anima, e io stavo diventando un’altra. 58 Iniziai a lavorare quel mese d luglio, ad un progetto del Comune di Fermo per l’animazione dei bambini del territorio. Le risate, i giochi, gli scherzi con i più piccoli mi facevano dimenticare per qualche ora le mie sofferenze…scendevo a livello dei bambini e guardavo il mondo con i loro occhi, mi sentivo un po’ meglio in quei momenti. Così la mattina presto percorrevo in bici il lungomare di Porto San Giorgio, …alle 7.30 c’era una bella luce, leggera, soffusa, il lungomare era silenzioso, e quello per me era il momento più bello della giornata. Mi svegliavo al mattino sperando che quel giorno potesse essere diverso dagli altri, pensando che ogni giorno che passava era un po’di tempo che si accumulava sui ricordi attutendone la loro spietata forza emotiva. Prendevo la bici, l’asciugamano da mare, e uscivo di casa. Ricordo il silenzio, le poche persone che passeggiavano sulla spiaggia, qualcuno che sostava sul marciapiede…persone anziane per lo più. Le persone anziane mi hanno sempre dato un senso di tenerezza e di serenità, come se il loro essere lì rappresentasse in qualche modo la forza e le esperienze che la loro lunga vita aveva messo da parte…ora si godevano un meritato riposo passeggiando la mattina preso sul lungomare. Fu una mattina di luglio che iniziai a sentire qualcuno, che all’altezza del centro del paese, davanti allo chalet più animato dell’estate, cominciò a salutarmi tutte le mattine. “Buongiorno!!!” Sentivo quella voce allegra ogni giorno ed io pedalando spedita rispondevo ridendo al saluto. Non sapevo chi fosse in realtà, ma mi faceva piacere sapere che qualcuno si accorgeva di me e mi salutava. Sospettavo di qualcuno ma in fondo non mi interessava davvero sapere chi fosse, anche perché avevo da fare con l’immagine del mio amore perduto che continuava ad affacciarsi nei miei pensieri, ed ero sempre impegnata a cacciare nel fondo dell’anima, sotto ai pensieri degli impegni quotidiani, quelle brutte e angosciose sensazioni che quella perdita mi provocava. Passavano i giorni, il lavoro mi piaceva e capii allora che strare con i bambini mi riusciva facile ed ero capace di dare molto di me nel rapporto con loro. Mi ispiravano un senso di protezione, di tenerezza, di ilarità…mi facevo delle gran risate a guardarli mentre parlavano fra loro, mentre giocavano e sorridevano, e mi affezionavo presto a molti di loro, anche se quell’estate, andando in giro per i gruppi delle colonie e durante il pomeriggio visitando ogni giorno un paese diverso, ne ho incontrati molti. Lavoravo con molti altri ragazzi, eravamo più o meno una decina e ci dividevamo per gli chalet del paese a piccoli gruppi di tre o quattro. I 59 bambini ci vedevano arrivare con i nostri “strumenti “ di gioco, palloni, corde, fazzoletti colorati, e sulle prime titubanti ci guardavano, come a dire” perché venite a distoglierci dai nostri discorsi e dai nostri giochi con la sabbia” ? Rapidamente la loro diffidenza si trasformava in curiosità e piano piano si raccoglievano attorno a noi, ascoltavano le nostre proposte e si mettevano tutti a giocare a ruba bandiere, si dividevano in gruppo per le staffette e con le loro risate contagiavano anche i meno socievoli, che alla fine si univano al gioco. E queste erano le mie mattine ed i miei pomeriggi, che trascorrevano veloci in un clima allegro. Il pomeriggio ci spostavamo , sempre a gruppi di tre o quattro animatori, con il ludobus, un pulmino pieno di giochi che portavamo in giro per i piccoli paesi dell’interno. I ragazzini ci aspettavano a gruppi nelle piazzette assolate e si stupivano sempre allo stesso modo quando tiravamo fuori l’armamentario . Adoravano un tappeto gonfiabile su cui saltare, e dovevamo farli salire a turno per evitare che tutti insieme si gettassero in quel bosco di gomma colorata..anche io una volta mi sono gettata lì dentro con loro, era davvero troppa la curiosità di vedere cosa si provava a rimbalzare in mezzo a fiori ed alberelli gonfiabili… Capitava però spesso che quell’anno di pomeriggio piovesse…la mattina c’era un gran sole, ma verso l’ora di pranzo nuvole grigie turbavano il colore limpido del cielo e già si iniziava a sentire l’odore di pioggia che riempiva l’aria…salivamo sul nostro ludobus e delle grandi gocce d’acqua iniziavano a rigare i vetri…ed in quei momenti mi sentivo di nuovo invadere dalla tristezza, guardavo fuori e pensavo alla mia situazione, alla mia solitudine, venivo invasa da qual senso di smarrimento e di stanchezza che mi toglieva la forza di ridere e di parlare…volevo solo tornare a casa in quei momenti, e mi auguravo che quella pioggia battente continuasse impedendoci di incontrare i bambini e di tirare fuori tutti i nostri giochi. Iniziai a pensare che nonostante avessi perso un amore, un amico e parte dei ricordi degli ultimi anni,e nonostante mi sentissi in colpa, ero io l’unica a soffrire…seppi che lui sarebbe a breve tornato con la sua ex. Non mi fece male sapere questo, me lo aspettavo in fondo…ma sentii aumentare il senso di colpa per essermi intromessa in quella storia che non poteva finire. Perché senso di colpa è difficile dirlo. In realtà interpretavo la mia colpevolezza attraverso gli occhi degli altri, ma sapevo in cuor mio che non avrei potuto comportarmi diversamente. Ero stata trascinata in quella storia ed avevo faticato a cambiare il mio punto di vista cercando di immaginare l’amico di una vita come un compagno…ma non potevo dimenticare chi c’era prima al posto mio, ed ho condiviso sempre la sofferenza di quella ragazza, ho sempre pensato a lei immaginando quanto difficile potesse essere per lei vedere una sua rivale accanto all’amore della sua vita. Anche se io non mi sono mai sentita una sua rivale, e mai avrei 60 immaginato che le cose sarebbero andate così. Era una gara a chi soffriva di più in fondo, a chi era più fragile la realtà è che chi ne è uscito forte è stato solo lui. Non l’ho più visto e sentito per molto tempo, ho cercato di cancellarlo e per anni non ho parlato di lui. Ho allontanato tutto e tutti quelli che potevano in qualche modo ricordarmi quella situazione, quella sconfitta che avevo subito. Continuavo a percorrere il lungomare…ormai mi restavano pochi giorni, il lavoro era estivo ed al 31 luglio il progetto sarebbe finito…e continuavo a sentire i saluti mattutini da sotto lo chalet. Una mattina mi misero in mano un mucchio di volantini che pubblicizzavano l’animazione che stavamo facendo e mi chiesero di lasciarli negli stabilimenti e nei bar lungo il tragitto che percorrevo in bici per tornare a casa. Non ricordo a quanti li ho lasciati, ricordo solo quando ho sceso le scalette dello chalet da cui ogni mattina sentivo la voce che mi salutava. Il rumore dei miei sandaletti di legno sulle scale, pochi passi, giro l’angolo e…mi imbatto in un viso bruciato dal sole e in due occhi azzurri che spiccavano sull’abbronzatura. “Domani mattina ti fermi però!” mi disse la stessa voce che mi salutava e che ora improvvisamente aveva anche un viso. Era Federico, ed il sapevo perfettamente chi era, lo ricordavo dai tempi delle medie, anche se in tanti anni non ci eravamo mai parlati. Non mi aveva mai attratto a dire la verità, anche perché era sempre stato un tipo piuttosto noto nel paese, e questo per me era sempre stato un deterrente piuttosto forte… ma quella mattina ne fui folgorata. Era bellino, lo è ancora, ma non è quello il punto. Ricordo ancora l’impressione che mi fece quando lo vidi in faccia…ed ancora oggi lo ricordo diverso, come se in quel momento avessi visto un’altra persona rispetto a quella che poi ho conosciuto. Forse solo perché in quell’attimo isolai solo un aspetto di lui, e vidi un viso illuminato dalla gioia dello sguardo. Occhi vivissimi, felici, mi colpirono molto. Fu uno scambio di battute rapidissimo, risposi solo che mi sarei fermata la mattina dopo. Lasciai i volantini e scappai via. Tutto il giorno ripensai a quell’incontro, ma la decisione l’avevo presa subito, nel momento in cui incontrai quello sguardo. Sì, mi sarei fermata, non avevo nulla da perdere. E così fu, la mattina dopo arrivai davanti allo chalet, accostai, chiusi la bici e scesi. Lui era seduto ad un tavolino, leggeva il giornale, gli occhi assonnati e la pelle scurissima. Mi guardò sorpreso, non si aspettava che mi sarei 61 fermata. Abbiamo fatto poche chiacchiere, tranquillamente. Faceva il bagnino e lavorava tutto il giorno sulla spiaggia…io avevo ancora pochi giorni di lavoro e poi avrei smesso di passare ogni mattina sul lungomare. Mi fermai ancora una volta durante i miei passaggi mattutini e poi per qualche giorno tirai dritta. IL mio lavoro finì, e mi trovai di fronte alla scelta. Come facevo ora a rivederlo se non avevo più il pretesto per passare di là? Feci solo una cosa, senza sapere nemmeno bene il perché… il mio primo giorno di ferie mi alzai presto e lo raggiunsi…era sulla spiaggia , lo vidi da lontano, mi avvicinai. Vide la mia ombra sulla sabbia, si girò, sempre sorpreso. Coi piedi in acqua scambiammo ancora due parole, ci abbracciammo, nulla più. E da lì iniziammo a frequentarci, anche se la storia non prese subito il volo come si poteva immaginare. Ero io in realtà che stavo sulle mie, che non sapevo bene cosa volevo…dopo la delusione che avevo preso il mio schema mentale mi imponeva di continuare a soffrire ancora un po’, non capivo come approfittare realmente di una meno che mi veniva tesa inaspettatamente per uscire dalla situazione scura in cui mi trovavo…e poi sapevo che le mie amiche più care mi avrebbero biasimata, o più probabilmente in quel modo, gettandomi in un’altra storia così presto, avrei vanificato la sofferenze dei giorni passati, a cui invece avevo assolutamente bisogno di dare un senso, seguendo la mia stupida attitudine a voler razionalizzare sempre tutto. Comunque non ebbi molta scelta, diciamo che feci il minimo indispensabile e che Federico aveva già deciso per tutti e due. Una sera sulla spiaggia c’era uno spettacolo di danza brasiliana, andai allo chalet con una mia amica, Silvia, l’amica di una vita, che mi conosceva meglio di chiunque altro ma che in quel periodo cominciava a guardarmi e non essere tanto sicura che tutto fosse come lei lo ricordava. Ero in mezzo ad un sacco di gente, guardavo le movenze forti ed aggraziate ad un tempo di quei ballerini brasiliani, e all’improvviso mi sentii cingere alla vita e avvertii un viso che si appoggiò alla mia guancia. Era Federico, mi aveva vista. Questo era il suo atteggiamento, così espansivo, diretto, ed io restai perplessa di fronte a tanta decisione. Non ci ero abituata, ed io stessa non ero troppo espansiva, anzi, sono sempre stata piuttosto introversa, riservata, quasi fredda…l’unica cosa che mi tradisce è il sorriso, che nasce dagli occhi ed esplode sul viso in un attimo…è quello che mi rivela e che fa sì che la gente possa sentirsi autorizzata ad avvicinarsi a me. 62 Mi ritrovai dentro ad una storia senza sapere come, e tante volte Federico mi ha spiazzata con i suoi modi a volte troppo irruenti per me, che avrei avuto bisogno di un po’ più di calma. Infatti improvvisamente, dopo qualche giorno mi tirai indietro…”non ce la faccio”, gli dissi, “non sono tranquilla ed ho preso un brutto colpo, non posso iniziare nulla ora”. Una telefonata, ero sulla spiaggia, nel primo pomeriggio, ad un passo dal mare. Lui chiuse il telefono, io non provai nulla di particolare…quello che volevo era solo quiete, fuggire da tutto, ero sempre più chiusa in me stessa. Ed ero sempre più magra, l’unica cosa che tradiva all’esterno quello che mi stava succedendo dentro. La sera ero a cena a casa di una mia amica, pochi isolati distante da casa mia. Vanessa, altra amica storica, angelo custode di quell’estate, anche lei che mi guardava perplessa e che aveva condiviso la grande delusione che avevo preso. Facevo lunghi discorsi con lei, ma quello che mi stupiva era che non avevo più nemmeno la forza di parlare…a cosa serviva? In fondo avevo l’impressione che nessuno potesse capire, che ciò che si vive è personale, privato e che parlarne all’esterno non serve a nulla. Mi chiudevo sempre di più, e all’esterno sempre un’apparenta tranquillità, una sicurezza innaturale per chi mi conosceva. Una chiamata di mia madre, tornai per un momento a casa. Un grande mazzo di fiori in sala mi aspettava, il dubbio mi colse per un attimo soltanto …di chi potevano essere? Per un attimo la paura mi colse e rividi il passato tornare, ma cancellai immediatamente quell’idea, sapendo che non sarebbe mai accaduto. Aprii il biglietto, poche righe “non posso fermare l’emozione che provo ogni volta che ti vedo”, qualcosa del genere. Era Federico ovviamente. Ma perché tanta insistenza? Non mi conosceva neppure e cosa poteva spingerlo tanto verso di me? Io sempre a razionalizzare… Fui colpita e mi sentii speciale…un po’ di imbarazzo forse, ma isolai una bella sensazione ed ebbi ancora una volta la certezza che non potevo sottrarmi, e che in fondo non avevo motivi per farlo…tanto valeva gettarsi in questa cosa senza chiedersi nemmeno troppo cosa fosse. Così tornai a cercarlo, lo trovai in mezzo alla gente, sempre al solito chalet dove si svolse la nostra vita per quell’estate. L’ennesima festa, la confusione, la gente che mi urtava e mi passava accanto, davanti. Lo vidi e mi avvicinai, e lui sapeva già il perché… L’estate andò avanti così, apparentemente tranquilla. Lo raggiungevo la sera, verso le sette quando la spiaggia era quasi vuota e lui metteva a posto i lettini, stanco, ma sempre felice di vedermi. 63 In quel periodo lui viveva a Milano durante l’inverno, ed io sapevo che a breve sarebbe tornato il momento, per lui ,della partenza. Non me ne curavo, vivevo la nostra vicinanza momento per momento, senza chiedermi nulla. Chissà perché credevo che con l’inverno e la distanza la nostra storia sarebbe finita, ognuno avrebbe ripreso la propria strada. Una sera sulla spiaggia mi chiese perché ero così magra…fu l’ unica volta in cui fece apertamente riferimento a quell’evidenza, lui che si ricordava di me da anni, e che aveva notato la trasformazione. Risposi in modo evasivo e con leggerezza, e la verità è che nemmeno io avevo chiaro il motivo, non me ne ero mai curata…era successo e punto. Ancora mi riconoscevo nel mio corpo, ancora riuscivo a farlo, in fondo mi piacevo così, anche se capivo che prima o poi avrei dovuto dare delle spiegazioni, soprattutto a me stessa, di quello che mi stava accadendo. Arrivò l’inverno, Federico partì, ed io decisi di finire l’ultimo anno di università a Macerata. Avevo cambiato due case, poi ero stata un anno a Porto San Giorgio, seguendo le lezioni da pendolare, e quell’anno ritornai a fare la vita universitaria, con l’accordo dei miei genitori, ai quali dissi che mi sarebbe stato più comodo vivere vicino alla facoltà per seguire le lezioni e dare gli esami. Andai a vivere in una nuova casa, con un’amica, con la quale avevo diviso già i precedenti appartamenti, ed altre ragazze che non avevo mai visto. La situazione non volse a mio favore. Mi ambientai subito nel nuovo contesto, ripresi i contatti con le amiche che avevo conosciuto negli anni precedenti, ma soprattutto legai con la gente nuova di casa mia. C’era spesso via vai in quella casa, sempre gente, gente che non avevo mai visto. Persone con cui potevo permettermi di mantenere rapporti sempre piuttosto superficiali, con cui non ero tenuta a parlare di me, che non interferivano con i miei orari, con le mie cose e con i miei pensieri. Mi chiudevo sempre più in me stessa, e avanzava in me la percezione di stare diventando qualcun altro. Ormai facevo fatica a riconoscermi e dovevo abituarmi a vivere in un corpo che non era il mio. Ero combattuta fra quello che ero e quello che ero stata, vedevo quello che mi era appartenuto, quello che ero stata nel corso della mia vita e non riuscivo più a trovare nulla dentro di me che mi ricordasse il passato e che mi desse la spinta per tornare indietro. Eppure mi piacevo, lo specchio mi rimandava un’immagine graziosa, minuta, ricordavo con orrore il mio corpo di prima. Non mi importava molto degli altri, la gente non mi interessava più, spesso vivevo la vicinanza eccessiva come un’invasione della mia privacy. Difendevo il mio mondo, esteriore ed interiore soprattutto, da tutti e rivelavo pochissimo di me. 64 Le mie coinquiline, con le quali avevo rapporti cordiali ed affettuosi, non sembravano sospettare nulla , non credo trapelasse il mio malessere. Anche perché il mio corpo non tradiva nulla agli occhi di chi non mi aveva mai conosciuto. Non ho mai capito come vivesse questa trasformazione la mia compagna di stanza, che mi conosceva da anni ma dalla quale non fui mai costretta a parlare. Mi limitavo a fingere serenità, a dimostrare di avere grande forza fisica, a farmi vedere che mangiavo…ovviamente quello che dicevo io. Insomma, ormai iniziavo ad ammettere anche davanti a me stessa che ero anoressica. Fortunatamente la mia razionalità mi fece da scudo. Non arrivai mai a livelli preoccupanti, e nonostante mia madre avesse pensato di ricoverarmi ciò non fu necessario, ed io seppi solo dopo che c’era stata nell’aria quella decisione. Ho pensato molto a cosa mi è accaduto in quel periodo, ne ho parlato, ho ripercorso le tappe e gli stati d’animo, e l’unica cosa che ho dedotto è che per un po’ ho messo in standby la mia vita. Ho smesso di vivere, ho rinunciato a provare emozione, ne ho avuto paura. Quando non ho più potuto controllare gli eventi ho cominciato a controllare me stessa, i miei sentimenti, e i miei ritmi. Il cibi rientrava in questo controllo, decidere cosa mangiare e non abbandonarsi, non faceva altro che rispecchiare il controllo ossessivo che ponevo alle emozioni, ai sentimenti, ai sensi di colpa. Quell’inverno è stato difficile, e spesso nella mia solitudine ho provato infelicità profonda, senso di mancanza…non avevo più una vita. E allo stesso tempo non volevo uscire da quella gabbia immaginaria in cui mi ero chiusa. Federico risentì della situazione. Era a Milano, e divenne per me una voce che mi chiamava al telefono. Appena partito tutto sembrava normale, andai da lui a Milano una settimana, e nulla sembrava cambiato dall’estate appena passata. Tornava lui in genere, una volta ogni due , tre settimane, ma le nostre vite erano molto lontane e molto diverse. E a lui dovevo rendere conto delle mie azioni, era il rapporto più profondo che avessi in quel momento, quello che mi costringeva a provare sentimenti troppo forti da controllare. Presi le distanze, non sopportavo di sentire che qualcuno fosse tanto legato a me, avvertivo il peso della storia e non avevo la forza di portarla avanti. Mi sentivo legata a lui, ed ero certa che in fondo al cuore provavo amore per quel ragazzo dolce che mi aveva mostrato affetto e mi aveva fatto paura. Stavo bene da sola, rifiutavo di chiedere aiuto e mi chiudevo ogni giorno di più. Non permettevo a nessuno di avvicinarsi troppo, mantenevo sempre le distanze e non parlavo mai di me. Eppure ridevo, scherzavo, mi occupavo di me, del mio corpo, di tutte le mie cose. 65 Insomma, vivevo la vita di un’altra persona, una vita di carta, fasulla, apparente. Non c’era più una vita interiore, quella che ti spinge verso il mondo, fuori da te stesso e ti proietta all’esterno. Io non facevo altro che implodere, collassare su me stessa, vivere meccanicamente. Il ricordo più forte che ho di quel periodo è la nebbia dei sentimenti. Da qualche parte c’erano, si muovevano sul fondo dell’anima ma erano affogati dall’apatia, dalla freddezza, da una calma piatta e vischiosa in cui nulla riusciva a muoversi ed a venire fuori. Avevo paura che se avessi parlato qualcuno sarebbe arrivato a costringermi ad uscire dal mio mondo, a ricominciare con la vita. Volevo restare così, finchè sarebbe stato possibile. Aspettavo. Vivevo una dimensione provvisoria in attesa che qualcosa cambiasse. Facevo ogni tanto qualche tentativo disperato di ribellarmi ma non era possibile. Provare a mangiare qualcosa di diverso, liberarmi a forza dalle catene in cui ero, urlare in faccia a qualcuno di aiutarmi…lo chiesi a Federico, durante l’inverno, aiutami…ma non riusciva a farlo, ed in fondo io non glielo avrei mai permesso. Contro la volontà di tutti mi misi a lavorare in un pub orribile, un posto strano che fino a mezzanotte ospitava ragazzini e cene di classe e a notte fonda si trasformava nel posto peggiore della zona, gente malfamata, ubriaconi, risse. Io impassibile, qualche spavento lo ebbi, una volta mi riaccompagnarono a casa i miei colleghi perché ero terrorizzata da un tipo che aveva ricevuto una spintone ed era venuto a sbattere la testa sotto i miei occhi, sul bancone…credetti che fosse morto. Ma continuai ad andare in quel posto tutti i sabati, fino alle sei del mattino. Quello potevo controllarlo e decidere io quando smettere. Se ripenso ora a quell’esperienza la vedo con gli occhi di chi guarda. Rivedo un’altra persona che si muove fra i tavoli, che prende ordinazioni, che saluta gente e sorride…e mi sembra di non conoscere più nessuno. Provo imbarazzo ad incontrare le persone che ho conosciuto in quel periodo, e per un po’ di tempo ho avuto anche l’istinto di scappare di fronte alla gente che avrebbe potuto capire, a distanza di tempo, che quella ragazza era in realtà malata. Ad un tratto ho iniziato a temere che la gente potesse percepire il mio malessere, che in qualche modo qualcuno potesse pensare di me che non stavo bene. Ho iniziato sempre di più a rifugiarmi fra gente nuova, che non avesse collegamenti col passato. Federico ormai rappresentava il passato, non ci sentivamo più, ormai da più di una mese. Conobbi un ragazzo a Macerata, amico di una mia coinquilina, e con quella persona credevo di poter in qualche modo rinascere nella mia nuova 66 vita. Ho trascorso del tempo con lui sperando che mi tirasse fuori da me, ma capii subito che la situazione non faceva altro che proteggermi dalla realtà, e lui, ignaro di tutto, non poteva in nessun modo aiutarmi. Era un ragazzo carino, amava la musica e sognava di fare il musicista. Lo guardavo e mentre stavo con lui mi rendevo conto di quanto fosse simile a Federico. Non avrei mai potuto replicare i sentimenti, voler bene a qualcuno se quel qualcuno altro non era che un pretesto per stare lontana dai sentimenti veri. Sentivo che una parte di me restava legata a Federico, e che c’era una vita, da un’altra parte, che non avrei potuto ignorare per sempre. C’erano i miei affetti, le mie amicizie storiche, la mia famiglia e c’ero io. E prima o poi avrei dovuto tornare. Quell’anno a Macerata è stato scuro, ricordo l’inverno, un gran freddo…ora che ci penso io non sono mai stata freddolosa e da quell’anno in poi lo sono diventata…strano a pensarci, ora il freddo è la sensazione che sopporto meno. Improvvisamente ebbi notizie di Federico, un lutto lo colpì. Misi da parte tutto, anche lui, e tornammo di nuovo vicini. Ero sicura che i sentimenti per lui non erano cambiati, erano rimasti lì in attesa di essere vissuti. Mi strinsi a lui, ci prendemmo la mano ed in qualche modo ricominciammo a vivere la nostra storia, traballanti tutti e due, e forse non ancora pronti ad appoggiarci l’uno all’altro. Senza dirci troppe parole, tramortiti tutti e due dagli eventi. Per me lui rappresentava l’unica certezza che avevo, era l’unico punto fermo, l’unico appiglio fra il prima ed il dopo. Ragiono così la mia vita, esiste un prima e un dopo…il momento che separa è la paralisi dei sentimenti che ho vissuto, la presa di distanza dalla mia vita. La sua situazione in qualche modo mi risvegliò dal sonno, un fatto grave che in quel momento mi scosse dal torpore in cui ero, e che mi costrinse per un attimo a sconcentrarmi da me stessa ed a guardare fuori da me, a lui. Mi sentivo in colpa, per l’ennesima volta, per quello che avevo fatto, in colpa verso di lui, mi sentivo responsabile di quello che era successo fra di noi, e volendo razionalizzare come sempre, non sapevo cosa dire a mia discolpa per ricucire gli strappi. Lasciai la casa a Macerata, mi staccai da quello che mi aveva tenuto protetta e lontana dalla realtà, tornai a casa mia, con i miei genitori, e tentai una timida risalita. Stavo con Federico, cercavo come potevo di stargli vicina intuendo la grande sofferenza che provava, anche se non era facile leggergliela negli occhi, né sentire da lui parole di dolore o di sconforto. Lui non è uno che parla molto, sviscerare le questioni non gli corrisponde affatto e all’epoca neanche io ne avevo più di tanto la forza. 67 Fatto sta che tante questioni sono rimasta irrisolte, e dopo poco tornarono ad esplodere, e ci separammo di nuovo. Un’altra estate alle porte, di nuovo il caldo, il mare, l’apparente serenità delle vacanze. Io andavo al mare con mia madre, nel primo pomeriggio, mi stendevo al sole e restavo a lungo a pensare…Federico a volte mi raggiungeva, si metteva vicino a me, dicevamo due parole. Lo guardavo con affetto ed avrei voluto in tutti i modi abbandonarmi a lui, a quella storia…non ce la facevo però. Una sera fu lui a dirmi che non potevamo andare avanti, ero fredda e distante e la mia malattia lo impauriva. Gli diedi ragione, capii che doveva allontanarsi di nuovo da me, non potevamo stare insieme ed ancora non ero pronta a vivere sentimenti troppo forti. Non volevo la stabilità, ero ancora in una situazione provvisoria, di attesa. Aspettavo di ritrovare me stessa, ripresi i contatti con le mie amiche di sempre, con le quali durante l’inverno gli incontri si erano fatti rari, ed anche loro non avevano saputo bene come prendermi. Cercavo di ritrovarmi attraverso di loro, attraverso i racconti, il ripetersi di momenti che per una vita avevamo trascorso insieme. Ricominciai a sorridere, piano piano, ripresi anche qualche chilo, non troppi, ci tenevo alla mia forma, perché in fondo, ecco il grande conflitto, mi piacevo. Iniziai però a sentirmi meno sola, a sentire il bisogno di ricominciare a vivere, a riprendere il gusto del divertimento, la voglia di provare emozioni. Federico lo vedevo sempre, anzi, lo seguivo e lo tenevo d’occhio. Quello fu il primo colpo di reni che diedi, il primo gesto di forza che feci per tornare alla vita. Mi resi conto che ero innamorata di lui e che dovevo fare il possibile per recuperare quella storia, che prometteva così bene all’inizio e che sempre mi ero rifiutata di vivere. Dovevo dimostrargli che stavo cambiando, che qualcuno dei nodi che avevo in testa cominciava a sciogliersi. Mi venne il terrore che lui potesse essersi scordato di me, paura che fino ad allora non avevo mai provato, come se la chiave delle cose fosse solo in quello che provavo io…avevo paura che la mia malattia potesse allontanarlo, fargli pensare che non voleva una ragazza come me, così instabile e sofferente…iniziai di nuovo ad avere paura dei sentimenti degli altri, in senso buono stavolta, mi sentivo di nuovo pronta a riprendere in mano le redini della mia vita. A piccoli passi, ero disposta a soffrire di nuovo per amore di qualcuno, e non per strane turbe che affliggevano solo me. E soffrii quell’estate, ma dimostrai tutti i miei sentimenti senza paura. Lo seguivo ovunque, gli mandavo messaggi col cellulare, lo chiamavo al telefono, e cosa strana…piangevo…da quanto tempo non lo avevo più fatto!! Non mi era più successo di essere così presa dai sentimenti, di 68 desiderare così tanto qualcosa che non poteva dipendere solo da me..stavo tornando a vivere, stavo tornando ad avere voglia di divertirmi, passavo quelle serate estive in giro con le mie amiche e non avevo più paura della gente. Mi sentivo a mio agio, più tranquilla, semplicemente più disposta a condividere le cose con chi mi era intorno. Timidamente iniziavo anche a parlare di quello che avevo vissuto, e sapevo bene che non ero affatto fuori dalla situazione. Quello che contava però era che mi stavo risvegliando…non mi importava quanto sarebbe stata lunga la strada per ritornare in me, basti pensare che dopo cinque anni sto ancora camminando…contava che avevo voglia di intraprendere il cammino, che la mia vita ritornava ad essere mia. Ero contenta di mostrare i miei sentimenti, e da quell’estate in poi non ho più smesso di farlo…magari esplodo e lo faccio con una grande irruenza, ma sono rasserenata perché sento che nulla mi lascia più indifferente. Oggi non sono più capace di farmi scivolare le cose addosso, tutto mi resta impresso e lascia il segno. Può sembrare una cosa negativa, che mi rende vulnerabile, ma non credo sia così. E’ il mio modo di essere, che mi rende viva. Dimostro i sentimenti, i desideri, la gioia e il dolore e questa è una grande conquista, anche se a volte sembro sopraffatta da ciò che succede, anche se mi capita di avere paura di non avere la forza emotiva per far fronte alla realtà. Sono i postumi che mi porto dietro, insieme a tanti altri, ma che fanno parte di me, e che rappresentano il cedimento da parte mia di fronte al controllo ed alla eccessiva razionalità. Non tutto si può controllare né spiegare, l’importante adesso è vivere le cose come vengono, senza proteggersi troppo e senza scappare, anche se a volte l’istinto di mettere la testa sotto la sabbia e di alzare la barriera c’è. Ho dei ricordi belli di quell’estate. La più calda che io ricordi. Federico ha sempre avuto la passione per la musica, chiunque lo conosce lo sa. Quell’estate capitava spesso che suonasse con i suoi amici negli chalet di Porto San Giorgio. Cercavo di esserci sempre perché sapevo quanto fosse importante per lui, era il mio modo di fargli capire che c’ero anche se lui non mi voleva più. Non era facile per me vederlo in mezzo a tanta gente, ora che avrei voluto sentirlo mio e non potevo,avevo paura di condividerlo con troppe persone, e che la mia immagine andasse in qualche modo persa fra visi che gli stavano di fronte. Non mi arrendevo e continuavo…una sera sentii la sua voce che cantava mentre tornavo a casa in bici. Era tardi, sentii un tuffo al cuore…come era possibile che lui era lì ed io non sapevo nulla? Allora 69 davvero non gli importava più nulla di me e non diceva più le cose…quello chalet era quello dove andavo al mare di giorno ed il più vicino a casa mia, come facevo a non sapere che lui sarebbe stato lì quella sera? Restai di sasso, scesi dalla bici e mi buttai fra la folla. Aspettai che finisse di cantare, ma ormai era notte fonda e non attesi molto. Parlammo a lungo quella sera, e versammo anche un sacco di lacrime, ma dissi tutto, tutto quello che provavo e tutto quello che avevo taciuto per troppo tempo. Lui non mi fece ben sperare, e tornai a casa con la percezione che la sua vita sarebbe andata avanti benissimo anche senza di me, forse aveva anche un’altra ragazza, o forse avrebbe potuto trovarne una a breve. E questo mi terrorizzò, perché in fondo non avevo mai immaginato una cosa simile, come non era potuto succedere a me, che anche di fronte all’eventualità di una storia con un altro avevo capito che l’unica storia possibile era lui. Non ricordo come ho passato il resto della notte, il ricordo si ferma su quella spiaggia a notte fonda. Il giorno dopo era il 15 di agosto del 2003. Era caldo, le due di pomeriggio più o meno. Mio zio, che sempre veniva d’estate a casa nostra, affacciato al balcone mi fa” non è Federico questo ragazzo che arriva in bici”? Il sangue mi si è gelato e mi sono precipitata alla finestra. Mi ha guardato “scendi”. Sono scesa ed ho ricominciato da lì la mia vita. L’estate è stata bellissima, calda da morire, ma piena di vita. Ho ricominciato da lì a piccoli passi, cercando di ricominciare a vivere proiettata all’esterno. L’inverno mi ha portato delle novità, uno stage in un’agenzia stampa , e poi l’esperienza toccante del Servizio Civile, da cui ho avuto conferme di quello che avrei voluto fare nella vita. L’isolamento non fa più per me, anche se ho un carattere sempre molto introspettivo. Vivo bene in mezzo agli altri, ho grande curiosità per le persone. Mi piace esprimermi e dire la mia…resta però sempre una gran paura che al felicità sia qualcosa che dura un momento, e che il passato possa tornare. Chissà perché ho sempre paura che quando sono felice qualcuno o qualcosa arrivi a potarmi via la quiete, come se un po’ di serenità io non me la possa meritare. Ho capito anche che la serenità è uno stato dell’anima e non è troppo vincolata ai fattori esterni, è piuttosto un modo di affrontare la vita in generale, qualcosa che ha a che fare con l’equilibrio di ciascuno di noi. Questo racconto l’ho scritto diversi mesi fa. E nel rileggerlo ho capito davvero quanto vale scrivere di sé, raccontarsi. Significa ritornare al 70 passato, rivivere momenti, esperienze, incontri, sentimenti, che ci fanno essere ciò che siamo. La vita ci cambia giorno per giorno, e all’improvviso soltanto ci si accorgere di portare dentro di sé qualcosa di cui non si sospettava minimamente l’esistenza…o forse improvvisamente ci balena davanti agli occhi in totale chiarezza ciò che era avvertito in modo nebuloso e confuso. Mi sono data la possibilità di rivivere un periodo doloroso, di cui portavo ricordi nell’anima ed immagini come lampi. Ora capisco bene quanto sia stata influenzata dalle mie stesse scelte, quanto le mie esperienze mi hanno portato ad essere quella che sono. Tornare indietro, immergermi di nuovo in una realtà che mi ha attraversato, alla quale non ho più pensato perché il flusso di vita che ho continuato ad assecondare mi ha portato lontano, mi è servito a conoscermi meglio. A guardare di nuovo indietro, profondamente, riconquistare delle parti di me che si erano confuse con tutto il resto. Una bella fatica in verità, soprattutto perché ciò che ho scelto di rivivere raccontandolo è forse quanto di più misterioso mi sia successo. Le esperienze venute dopo mi fanno pensare che dentro ciascuno di noi è insita una forza tale da farci attraversare tanti momenti difficili restando comunque in piedi. Andando avanti le cose si dimenticano, si confondono, e riviverle per raccontarle ad altri ci permettere di recuperare dei pezzi che si rischiava di perdere. Parlare di me, raccontarmi, è servito a chiarirmi, a conoscere dei processi dello stato emotivo che in qualche modo avevo rimosso, focalizzando l’attenzione solo su alcuni particolare, alcune sensazioni dominati. Da quelle sensazioni dominanti ho ricostruito una realtà intera, fatta di persone, luoghi, parole, sentimenti, tornando alla vita passata e recuperando tanto di ciò che mi apparteneva in quel momento. Dura un attimo l’impressione di rivivere quei momenti, appena alzo lo sguardo dal foglio mi ritrovo ancora a chiedermi “ero io?”…e mi rendo conto di quanto sia cambiata senza nemmeno rendermene conto. Eppure sono le esperienze che ci cambiano, quelle che sembrano dimenticate…scrivere di sé per me è stato come andare in trance, quando mi sono svegliata ho avuto l’impressione di aver vissuto la vita di qualcun altro. E invece era la mia…ed è bella quella dolce ipocondria che prende quando si pensa ad un giorno lontano, all’interno di una intera vita di eventi, e si cerca di ricordare come si stava in quel preciso momento, per poterlo raccontare a qualcuno… 71 I nonni, ricordi di una giovane vecchia nonna, ancora e sempre entusiasta della vita, scritto da Annamaria Frezzotti Ho conosciuto soltanto i nonni paterni, perchè quelli materni erano già morti prima della mia nascita. Nei miei lontani ricordi di bambina, quando venivamo a Jesi, mi sembravano già molto vecchi. Il nonno Giuseppe, soprannominato “Peppe Gallina”, era un uomo non molto alto, con un viso triangolare e vivacissimi occhi azzurri. Aveva mani ruvide e screpolate e sul mento i peli della barba erano così duri ed ispidi, che nell'abbraccio del benvenuto, sentivo il mio viso fortemente punzecchiato. Il nonno era leggermente claudicante e si appoggiava ad un grosso bastone, aveva la voce forte e parlava in stretto dialetto iesino. Spesso non capivo bene quello che diceva, ma non avevo il coraggio di chiedere spiegazioni, mi sentivo fortemente intimidita e mio padre non faceva niente per farci comunicare. Anche mia madre stava zitta e mi sembrava non sapesse cosa dire. La nonna Angelina era una donna più alta del marito e piuttosto snella, aveva i capelli tutti bianchi tenuti indietro da un vellutino nero, il viso piuttosto lungo, gli occhi marrone smorti e la bocca con le labbra sottili sempre piegate all'ingiù che le facevano assumere un'espressione eternamente scontenta e contrariata. Peppe e Angelina si erano voluti molto bene e il nonno amava tanto la moglie e la riteneva così bella da paragonarla alla Madonna. Quando il nonno a mezzogiorno smetteva di lavorare ed arrivava a casa prima della moglie, accendeva il fuoco e con farina ed acqua impastava i “quadrelli” e i “taiolì” per la minestra e li cucinava nell'acqua con il lardo a pezzettini. Le malelingue dicevano che i “quadrelli” e i “taiolì” erano erti un dito e sporchi di calcina, ma Angelina e i figli gradivano assai la minestra e la succhiavano avidamente e rumorosamente. Per il giusto, spontaneo ed affettuoso aiuto nelle faccende domestiche, il nonno veniva criticato e chiamato “donnì”. In quel periodo gli uomini dovevano fare soltanto lavori maschili, le faccende di casa e i figli erano completamente ed esclusivamente compito delle donne, anche se avevano già lavorato molte ore nelle fabbriche o nelle filande. Il nonno amava fumare. Quando, appena arrivati, mio padre gli dava in regalo diversi pacchetti di sigarette, i suoi occhi vispi ed azzurri sprizzavano una tale fanciullesca felicità che per un attimo lo sentivo piccolo e bambino come me. La nonna Angelina, con le pieghe della bocca rivolte sempre più in basso, lo sguardo contrariato, con voce cupa rimproverava il marito per il colpevole attaccamento al vizio del fumo. La figlia più piccola, la zia Maria, che, dopo la separazione dal marito, era ritornata a vivere con i genitori, si univa istantaneamente alle critiche della madre. Il povero uomo, contestato dalle due donne, rivolgeva lo sguardo umiliato verso mio padre, che sorridendo furbescamente sotto i baffi, essendo anche lui un irriducibile 72 fumatore, con solidarietà contraccambiava lo sguardo sostenendo e rassicurando il padre. I nonni abitavano in una piccola casa ad un solo piano. C'era intorno un bel pezzo di terra, una vigna, alberi da frutta, un piccolo orto e un recinto per le galline e i conigli. Quella casetta semplice e con tanto verde intorno mi piaceva moltissimo: nelle tante fiabe che avevo letto c'era sempre una casetta nel bosco e quella dei nonni, tra gli alberi e il cinguettio degli uccellini, mi sembrava uscita da una meravigliosa favola. Nelle mie visite quotidiane non trovavo quasi mai il nonno, mentre, all'ombra di un grande albero di pere, seduta su una poltroncina di vimini, stava la nonna, con il vestito grigio ben accomodato, i capelli bianchissimi pettinati e tenuti in ordine da un vellutino nero, la zia Maria era di solito nella salettina a lavorare con la macchina da cucire. Gironzolavo un po' nel giardino, la nonna non parlava ed io non sapevo cosa dire. Entravo in casa e salutavo la zia Maria. C'era in casa un particolare odore di legno antico, dalla madia aperta in cucina lo stuzzicante profumo caratteristico delle grosse pagnotte di pane casereccio senza sale si mescolava a quello invitante dei pomodori e delle melanzane arrostite sulla brace, sul tavolo della cucina un cestino con la frutta dell'orto e una caraffa piena d'acqua coperta da un tovagliolino bianco. Nella mia mente di bambina anche l'interno della casetta assomigliava veramente a quello delle fiabe, ma la figura della nonna, immobile, muta e con l'espressione sempre cupa e scontenta, mi sconcertava profondamente: non assomigliava né ad una fata, dolce e sorridente, nè ad una strega cattiva con i denti aguzzi pronti a mordere, era una strana figura enigmatica del tutto sconosciuta nelle mie favole. Annunciato da un forte fischio ritornava il nonno, con una “cicca” in bocca, il berretto sulle ventitrè e gli occhi allegri e furbeschi. Salutava affettuosamente la moglie che ricambiava il saluto, ma non mutava la sua indecifrabile espressione pessimista. Assieme ai miei nonni abitava la figlia, la zia Maria. La zia era una donna bassa e grossa, con un viso lungo, occhi scuri e piccoli, una bocca sempre piegata all'ingiù, una barba ispida e resistente che lei accorciava con il rasoio del padre, capelli scuri lisci stretti in una treccia. Aveva le gambe corte e massicce, un grosso sedere diritto e sporgente e un seno quasi invisibile. Il carattere era forte e deciso, la voce metallica e battagliera. Faceva la camiciaia ed era sempre seduta davanti alla macchina da cucire. La zia Maria valutava le persone secondo quanto erano brave nel risparmiare, non si sentiva affatto “rospa”, ma saggia e sicura di aver capito il vero scopo della vita. Per dimostrare questa sua virtù e per convincermi ad entrare a far parte del piccolo numero eletto dei “saggi risparmiatori”, mi faceva vedere i suoi vestiti rimediati senza alcuna spesa, con stoffette di diverso tipo e colore. Un paio di grosse mutande attraevano particolarmente la mia attenzione: avevano la parte anteriore ricavata da un pezzo di lana grigia e la parte posteriore fatta con un ritaglio di cotone 73 azzurro con fiorellini rossi. La zia Maria era molto orgogliosa di questo indumento, non era costato niente ed aveva una meravigliosa funzione: teneva calda la pancia e fresco il sedere. Pensavo alle mutande triestine di mia madre e a quelle di noi figlie e giungevo alla conclusione che la mia famiglia era senz'altro molto inferiore nella grande arte del risparmio, quindi una vera famiglia “sprecona”. Un altro obbiettivo della zia Maria era quello di riuscire a dimostrare a tutti che “donna più disgraziata e misera” di lei non poteva esistere sulla terra. Aveva quasi sempre un'espressione tra l'arrabbiato e l'angosciato, gli occhi smorti, gli angoli della bocca piegati all'ingiù mentre un flebile “iè,iè,iè” le usciva spontaneo e ininterrotto dalla bocca. Spesso si raccomandava alle “anime sante del Purgatorio” ed io pensavo che fosse in diretto contatto con loro. Quando mio padre andava a far visita ai genitori e alla sorella, un vero coro di lamentele e di gemiti lo sommergeva. Mio padre cercava di rimanere impassibile, ma la sua solita sicurezza di uomo di mondo cedeva e rimaneva un figlio e un fratello angosciato e partecipe al torrente di lamentele rovesciate su di lui. Quando usciva respirava a pieni polmoni, mi prendeva per mano e ritornava quello di sempre, sicuro di sé, con la testa alta ed il petto in fuori. C'è un ricordo particolarmente impresso nella mia memoria: ero ancora una bambina, all'ora di pranzo poiché dovevamo ritornare a Trieste, ero andata a casa loro a salutarli. La porta della cucina era socchiusa e avevo visto il nonno, la nonna, la zia che stavano mangiando un po' di gallina lessa. Prima di entrare avevo bussato e fulmineamente mia zia aveva preso i piatti con la carne e li aveva nascosti nella madia. Sul tavolo erano rimasti un po' di pane e dei bicchieri con acqua vino. “Anche oggi solo un po' di pane e acetello” erano state le sue parole: il suo viso era tristissimo e tutti avevano un'espressione misera ed affamata. Ne ero rimasta sconcertata: avevo raccontato l'episodio a mia madre, al racconto della gallina nascosta, nel viso asciutto ed intelligente della mamma era esploso il suo caratteristico sorrisetto ironico, e negli occhi azzurri un'ilarità a stento repressa. Non aveva detto neppure una parola, ma nel suo viso era rimasta per un bel po' quell'espressione allegra e divertita. Quando, a causa delle malattie di noi bambine, veniva chiamata in aiuto una parente di Iesi, per noi era una vera gioia. Le zie arrivavano con il treno e con le borse cariche di barattolini di melanzane, peperoni sott'olio e ciliege sotto zucchero. Mia madre era felice per la loro compagnia e il loro aiuto. Appena arrivata la zia di turno, mia madre, dopo averla fatta sistemare nella camera degli ospiti, provvedeva agli indispensabili cambiamenti nella pettinatura e nell'abbigliamento della nuova arrivata. I capelli dovevano essere meno, tirati un lieve strato di cipria sul viso: ecco, la zia non era più una iesina semplice e di paese, incominciava a trasformarsi in una donna più cittadina ed emancipata. Mia madre aveva a questo scopo diversi suoi cappellini: davanti allo specchio li faceva provare 74 alla nuova arrivata e sceglieva quello più adatto. Io assistevo alle prove: con la zia Maria il cambiamento era molto difficile. La zia bassa, con il corpo tozzo e il sedere duro e sporgente mi ricordava tanto la “Tordella, moglie del Capitan Cocoricò e madre dei gemelli Bibì e Bibò”, personaggi del Corriere dei Piccoli. Mia madre prendeva dal cassetto del comò un cappellino e una sciarpetta di seta che annodava delicatamente intorno al collo corto della cognata. La zia Maria si guardava nello specchio e si ammirava compiaciuta, forse pensava al marito Mario così sciocco da non aver saputo apprezzare tutta la sua graziosa attrattiva femminile, ma per me la figura riflessa continuava a sembrare sempre e soltanto un grosso e simpatico barattolo vivente, completo di cappellino e sciarpetta. D'estate, per molti anni continuai ad andare a casa dei miei nonni. Il nonno Peppe morì durante la guerra a 90 anni dopo una vita serena e tranquilla. La nonna Angelina, sempre scontenta e di malumore, avendo avvertito da oltre 50 anni tutti i parenti, che le restavano ormai soltanto tre giorni di vita, festeggiò in piena salute i 97 anni e serenamente chiuse gli occhi ponendo cosi fine al malcontento della sua vita. 23 marzo 2008. E' Pasqua ed ho compiuto 80 anni. Una grande torta ricoperta di panna e otto roselline rosse. Intorno a me tutta la famiglia: il camino acceso illumina dolcemente la stanza e diffonde un piacevole calore. L'atmosfera è serena, colma di affetto sincero e di reciproca stima e rispetto. Sono commossa e felice, guardo i visi dei miei figli e dei miei giovani nipoti e un'onda di grande amore li raggiunge e li avvolge. Da 58 anni abito in un bel viale di Iesi. Appena il tempo lo permette mi piace molto stare in giardino, spargo i semi, pianto e guardo con tenerezza e gioia le nuove piantine: è la conferma della continuità della vita che scorre e si rinnova. Due merli sono diventati miei amici, si avvicinano, mangiano le briciole che offro loro e fanno il bagno in una vaschetta piena d'acqua. Una vecchia pianta di peonie rosa appoggiata al muro sfoggia orgogliosa i suoi meravigliosi fiori. C'è silenzio e pace nel mio giardino: una vera oasi dove il delicato profumo delle glicine si mescola a quello penetrante dei piccoli e bianchi fiori del gelsomino. Anche nella mia casa sento un'atmosfera positiva e di grande serenità, i mobili sono antichi, gli stessi della mia infanzia, il pianoforte è quello sul quale a cinque anni ho preso le mie prime lezioni e sul quale continuo a suonare, nella libreria numerosissimi libri, tutti molto amati. Sento intorno a me gli spiriti rassicuranti dei miei genitori, di mia sorella e di mio marito, mi aiutano e mi sostengono in qualche momento di difficoltà. Vivo da sola con Camilla, una gattina di 13 anni, non sono triste: penso che la solitudine, come ogni condizione umana, ha il lato positivo e quello negativo, positivo è la constatazione di autonomia, la libertà, il saper convivere bene con noi stessi ed avere il tempo e la lucidità per riuscire a 75 dare il giusto valore alle vicende umane, il lato negativo è quello per il quale, proprio per la debolezza della natura umana, a volte un'irrazionale ed inutile angoscia attanaglia e tormenta il nostro animo. Nel silenzio che mi avvolge, dal cassetto della memoria fresche immagini di gioia, improvvise difficoltà, dure sofferenze, avvenimenti piacevoli e spiacevoli, dubbi, incertezze si presentano nella mia mente e scorrono veloci ed inarrestabili. E’ un fiume di ricordi che, dopo aver passato e superato bufere, tempeste, vortici, strettoie, si sta ora incanalando nell'ampiezza e nella calma del grande mare. Ripensando al percorso fatto, alle illusioni, alle angosce, alle difficoltà legate alle inevitabili battaglie quotidiane, ora tutto mi sembra ammorbidito, addolcito, sfumato. Naturalmente oltre ai rapporti molto affettuosi con tutta la mia famiglia, con i figli e i nipoti, uno dei quali spesso rimane a mangiare e a dormire da me, ho anche la gioia di avere piacevoli amicizie e contatti con molte persone. Sia frequentando l'Università della terza età, sia nelle lezioni del corso tenuto dall'intelligente e gentile dottoressa Maria Teresa, dove ho avuto modo di conoscere meglio me stessa e di trasmettere anche a nuovi amici qualche breve frammento della mia vita, del mio pensiero e delle mie emozioni. Con l'aiuto e le spiegazioni di mio nipote Carlo ho imparato ad usare il computer, ora ho la possibilità di trascrivere le mie memorie e di soddisfare con internet nuovi interessi e curiosità. Spesso vado a fare la spesa al supermercato; nelle belle giornate, seduti sulle panchine del viale dove abito, gruppetti di pensionati si godono il calore del sole e chiacchierano animatamente tra loro. I vecchi platani, saggi e silenziosi, guardano con comprensione e forse con un po' di tenerezza le persone che passano, i bimbi che corrono, le coppiette chiuse nel loro mondo d'amore, tutta un'umanità raramente felice, più spesso insoddisfatta e piena di problemi, a volte reali, a volte del tutto immaginari. L'ambiente ed il territorio che mi circondano mi sembrano accoglienti ed ospitali. Qualche giorno fa assieme a mio nipote Carlo ho avuto la possibilità di ritornare a Portonovo e a Numana. La vista del mare azzurro che io amo moltissimo, i levigati sassi bianchi della spiaggia, il verde intenso del Conero, tutto era così bello e perfetto che una grande pace è scesa nel mio animo. Così in pace con me stessa e con il mio prossimo, mi avvio a chiudere il cerchio della mia vita, con ancora e sempre tanto interesse e curiosità per tutto ciò che mi circonda, ambiente, animali, uomini dai quali, specialmente se molto diversi da me, penso di poter imparare insegnamenti, saggezza ed idee utili e nuove. Molti anni fa ho inteso la necessità ed il desiderio di incominciare a scrivere qualche episodio della mia vita. Svariate e molteplici sono state le ragioni di questo mio bisogno. 76 Fin da bambina ho sempre avuto grande desiderio e curiosità di conoscere un po' meglio l'infanzia e la giovinezza dei miei genitori. Ed è proprio per questo interesse verso la vita passata di mia madre e di mio padre che ho deciso di narrare ai miei figli ed ai miei nipoti la mia infanzia, la mia adolescenza, tutto ciò che loro non possono sapere di me. Un semplice foglio di carta ed una matita sono stati il mezzo, silenzioso e disponibile, pronto ad accogliere l'inarrestabile fiume di ricordi, sensazioni e sentimenti di un mondo ormai passato e lontano. Dinanzi alla mia mente emozionata e commossa, uscite dalla polvere del tempo, si sono ripresentate scene gioiose, amate figure scomparse, episodi tristi e dolorosi. Venuti alla luce del sole e trascritti sul foglio bianco, anche i neri mostri della sofferenza e dell'angoscia, analizzati, razionalizzati e ridimensionati hanno perso il loro malefico potere e la loro potenza distruttiva: l'insensata ed assurda gelosia di un marito che per tutta la durata del matrimonio ha sconvolto e tormentato la mia vita, la conseguente spirale di violenza psicologica che mi ha tenuta prigioniera, la sofferenza per le tante operazioni subite..... sono diventati ricordi, tristi, dolorosi, ma solo ricordi. Le ore belle e gioiose, la nascita degli amatissimi figli e nipoti, la confortante luce della fede, i sentimenti d'affetto, d'amicizia, di comprensione hanno acquistato maggiore importanza e più profondo valore. Molte ferite dell'anima, causate da errati e colpevoli comportamenti umani, descritte e narrate con grande sincerità e franchezza , si sono cicatrizzate ed i piccoli gesti di tenerezza e di comprensione, a volte non completamente valorizzati, hanno assunto una nuova ed impensabile dolcezza. Sento che lo scrivere e il narrare sincero hanno portato nel mio animo una grande leggerezza, serenità e gioia; ho inoltre la sensazione che aver fissato sulla carta ricordi e pensieri salvati dall'oblio, abbia creato nuovo spazio nella mia mente e mi abbia dato la possibilità di incamerare altre memorie, avvenimenti e sensazioni degni di essere ricordati. Ogni vita, ogni essere umano è sacro, unico ed irripetibile; ogni storia narrata è fonte di grande conoscenza ed indispensabile arricchimento, è un piccolo modesto contributo, un utile giovamento e sostegno per il raggiungimento della maturità, saggezza e serenità nostra e degli altri. Lo scrivere e il narrare sincero di sé è una vera rappresentazione della nostra anima, una radiografia della personalità e del nostro modo di essere. Io, adesso, una giovane vecchia nonna ancora e sempre entusiasta della vita. 77 Appena diciotto anni, scritto da anonima Come ogni Estate lavoravo presso una piccola aziendola famigliare che produceva scarpine per neonati. Sembravano piccoli giocattoli di peluche, che io riponevo, dopo un accurato controllo, paio paio, dentro le scatoline di cellophane trasparente. Quell’estate del 1966 si prolungò quasi per tutto l’autunno, in quanto per me non sarebbe ricominciato l’anno scolastico ‘66/’67. La scuola era una parentesi chiusa. L’inesorabilità di questa decisione famigliare mi rendeva scontenta, non avrei avuto più alcuna altra possibilità di riscatto. Avevo portato avanti gli anni di scuola in modo indecente sciupando quella grande opportunità toccata a me e non ai miei due fratelli. C’era stato il lutto di mio padre nella primavera di quell’anno, ed era mamma che, da sola, pensava a tutto, risparmiandoci qualsiasi lavoro faticoso o fastidioso. Sapeva soffrire in silenzio, sapeva perdonarci tutto, anche quella mia leggerezza negli studi che sicuramente le ha procurato una grande delusione. Prima dell’inizio dell’inverno accadde una cosa sorprendente nella nostra famiglia. Ebbi, da parte di un mio cugino, figlio di un fratello di mia madre, una proposta di lavoro come segretaria in un ufficio, che avrebbe aperto nella sua grande azienda, di cui era comproprietario insieme ai suoi fratelli. Ho visto mia madre ringraziarlo sorridente, contenta della possibilità che, almeno uno dei suoi figli, avrebbe svolto un lavoro prestigioso. Cominciai così, con tanto entusiasmo, a sedermi dietro una scrivania e a cercare di capire quella grande novità, che erano i costi di produzione. Un tecnico era venuto appositamente da Milano per insegnarceli. Si trattava di una materia troppo all’avanguardia, sia nel tempo che nel luogo, dove gli operai, in certi pomeriggi di belle giornate, decidevano di sospendere il lavoro per andare a fare merenda in un bel posto all’aperto. Però questo tizio Milanese si seppe un po’ imporre, mise delle regole che fecero contento il capo, e un po’ meno gli operai, i quali si adattarono, ma cominciarono a fare sberleffi al suo indirizzo, a deriderlo, e ad imitarlo nel suo strano accento del Nord. Io avevo appreso qualcosa delle sue teorie, ma nei confronti degli operai e delle due ragioniere mi sentivo una nullità, finita lì perché aiutata dai propri parenti. Per fortuna tutto questo finì presto. Il Milanese se ne andò dopo qualche mese, ed io fui inserita nella contabilità insieme alle due impiegate. Dovevo fare un po’ di pratica in attesa della consegna di una macchina semielettronica dell’Olivetti, di cui avrei dovuto imparare il 78 funzionamento, ed in cui avrei dovuto inserire i dati della prima nota della contabilità, le bolle di consegna per la fatturazione, e l’elenco degli effetti attivi e passivi. Accarezzavo con gioia l’idea di avere un incarico tutto mio. Certo, dovevo imparare una cosa che non conoscevo per niente e che non avevo mai visto, ma sarei stata finalmente utile all’azienda. Questa volta però dovevo mettercela tutta, perché finalmente mia madre potesse essere contenta di me, considerando, inoltre, che non stava bene. Riusciva sempre a farci trovare il pranzo pronto, ma i suoi mal di testa diventavano sempre più frequenti e si protraevano per giorni. E quando le raccontai di questo cambio di lavoro futuro, non le vidi quella gioia che mi sarei aspettata. Per cui dedussi che stava male più di quanto potesse sembrare. Rimase a letto per giorni, aspettando che il feroce mal di testa se ne andasse. Allora, mi sono attivata vicino a lei con i miei piccoli e semplici modi, come metterle la mano fredda sulla fronte e dopo un po’ l’altra e poi cambiarla di nuovo, oppure acquistare i ghiaccioli, farli a pezzettini, metterli in uno sparrone pesante, cercando di fare in modo che non fuoriuscissero le gocce appiccicose dal fagottino che le mettevo sopra il capo dolorante. Se questo non funzionava mi restava ancora qualche altra cosa da fare, andare in farmacia, acquistare una cialda “UT”, per poi passare subito dopo nella vicina chiesa e pregare intensamente affinché il dolore se ne andasse. Ho fatto questo per alcuni giorni, ripetutamente, perché in passato aveva sempre funzionato molto bene: dopo un giorno di calvario, si rialzava e tornava ad essere in forma. Ma questa volta il male l’aveva intrappolata in quel letto senza abbandonarla. Era indebolita e prostrata dal dolore alla testa, e si teneva in piedi a malapena quando era costretta ad alzarsi. La situazione mi preoccupava molto, per cui cominciai a proporle la visita di un medico, che purtroppo lei rifiutava. Ma insistetti tanto, anche grazie all’aiuto dei miei fratelli, che fu costretta ad accettare. Il dottore, dopo un’attenta visita, le prescrisse un ricovero immediato, in considerazione della pressione altissima. La preoccupazione che mi attanagliava ed il tempo dedicato alla sua assistenza, non mi esoneravano certamente dal lavoro. Avrei tanto voluto che la consegna della nuova macchina “Olivetti”, ritardasse il più possibile. Era mio fratello maggiore il referente con i medici, ed era lui che ci informava sulle condizioni di nostra madre. Tutte le mie speranze pendevano dall’oracolo delle sue labbra, fino a quando un giorno decise di dirci che di lì a pochi giorni la mamma non ci sarebbe stata più. Io dovevo stare di giorno con lei, mentre lui, alternandosi con mia sorella, doveva starci di notte. 79 La notizia mi tramortì, ma mi consolai subito pensando che si erano sicuramente sbagliati. Perché no? Non cominciavo del resto a vedere anche nel lavoro tanti errori, taciuti e non? Ma il dubbio che forse potevano non essersi sbagliati si stava facendo strada. Vista la situazione famigliare, e la mancata consegna dall'Olivetti, ero stata momentaneamente allontanata dal lavoro. Ora l’assistenza era continua, e la realtà della sua malattia contrastava sempre più spesso con le mie aspettative. Arrivò il primo collasso, e, una volta ripresasi, cominciò con voce fioca a farmi le raccomandazioni di come portare avanti la mia vita senza di lei, come comportarmi con mia sorella Giulia, dal carattere molto difficile, e che soltanto lei riusciva a neutralizzare. Capivo che quelle non erano le solite raccomandazioni di una madre ad una figlia, ma ciò nonostante, le dicevo che si stava sbagliando, e pensavo, che in fondo anche lei, come me, nutriva quella piccolissima e fioca speranza chiamata “miracolo”. Riuscivo di giorno a trovare la forza di starle accanto. Mi dicevo “vado da mamma”, quindi lei c'era, e tanto mi bastava. Ma la notte piangevo disperata al pensiero di perderla. Trascorse così quella manciata di giorni, fino al mattino quando ritornammo a casa con l’ambulanza, io e lei, ormai vicinissima al coma, che con quel suo pesante respiro mi spogliava di ogni ultima residua speranza. Ricordo tutto di quel giorno, i miei fratelli intontiti dal sonno, e lo strazio che ho provato in quel pomeriggio nell'ascoltare il suo ultimo respiro. La gelida carezza che le ho dato il giorno dopo ha chiuso il mio cuore assieme alla sua bara. La mia gioia di vivere se ne era andata con lei, e niente, proprio niente, mi distraeva dal pensiero atroce di non rivederla più. Quando mi dissero dell’arrivo della macchina Olivetti, mi stupii del fatto che loro potessero pensare che io fossi in grado di poter portare avanti quel progetto, nato solo un mese prima. Non ero più la stessa persona, e nulla era più come prima. La mia vita era totalmente cambiata, e, tra l'altro, mio fratello volle cambiare casa, con una più piccola e più confortevole. E tutte quelle solite frasi di circostanza, non facevano altro che acuire quel mio dolore invisibile, ed affondare ancora più la lama in mezzo al petto, che continuamente faceva sanguinare il cuore e serrava la gola. Tutto continuava ad esserci anche senza mia madre. Ero soltanto io a non essere più la stessa. Dovevo lavorare, in quanto mio fratello disse che ciascuno di noi avrebbe messo, in una cassa comune, una quota di denaro uguale per tutti, necessaria per vivere. Tornai malvolentieri in fabbrica, dove dopo un paio di 80 giorni fecero venire i tecnici istruttori ad insegnarmi il funzionamento di quella maledetta o benedetta Olivetti. Pensavo che con quel dolore non ce l'avrei mai fatta a concentrarmi, ad apprendere cose nuove. Mi facevo ripetere le stesse cose per quattro ed anche cinque volte; mi sono tanto sforzata, ma niente, non riuscivo a venire a capo di nulla. Mi fecero riposare due giorni. Ero disperata, all'idea di dover fare, mentre avevo dentro di me solo la voglia di non fare niente. L'unico mio desiderio era quello che venisse presto la sera, per andare a letto, ma non per dormire, ma per poter soffrire liberamente. Ero straziata dallo sforzo che facevo ogni mattina per recarmi nel posto di lavoro, con sopra le spalle quel macigno doloroso. Mentre mi spiegavano i sottoconti, i mastri ed il giornale, io sentivo dentro di me ancora più forte l'inutilità di quanto dovevo apprendere, lo spreco di tempo verso cose che non mi avrebbero portato via da quel dolore feroce ed invisibile, senza cerotto o fasciatura, e tanto meno ingessatura. In quegli anni il vento ha soffiato molto forte nella mia vita ed ha alzato l'onda molto in alto, ed io ogni giorno, nel cercare di superarla, non sapevo se le forze mi avrebbero abbandonata. Riuscivo a trovarle, nel pensare che anche lei, la mia cara mamma, ha dovuto resistere al vento forte, in quanto ricordavo i suoi racconti della guerra, la perdita di un fratello, il tirare avanti i figli, l’ incomprensione trovata in mio padre, assieme a tante altre pene. Tutto questo non le aveva impedito di essere una persona simpatica, che raccontava storie divertenti e soprattutto di essere una madre amorevole. Ecco, è stato questo confronto, che ad un certo punto, non so valutare esattamente dopo quanto tempo, ha fatto si che venissi sputata e abbandonata da quell’onda, e catapultata, come un impaurito e sfinito animaletto, sulla spiaggia della vita. Dopo alcuni mesi mi resi conto dell'unicità del legame che c'è tra figlio e madre. Dopo alcuni mesi mi resi conto che tutto ciò che mi aveva detto riguardo a mia sorella era verissimo. Dopo alcuni mesi mi resi conto di fare molte cose, che faceva lei e che io non approvavo. Dopo alcuni anni mi resi conto di fare gli stessi errori che faceva lei. 81 Dopo diversi anni mi resi conto che nel lavoro, le cose belle e brutte da lei annunciate, erano successe. Dopo molti anni mi sono accorta che sono riuscita in gran parte ad attraversare l’oceano della vita, perché quel dolore ha abbassato il livello di tutte le onde che sono venute dopo, e che l’essere riuscita a superare quella altissima, mi ha dato in premio un’altra vita. L’esperienza della scrittura è cominciata per me nel periodo ideale: i figli sono diventati grandi e autonomi, i vecchi se ne sono andati per lasciare il tempo d'invecchiare a quelli dopo di loro. Mi sento, adesso, ancora giovane e forte per desiderare un piccolo e attivo futuro, in questo tempo dovrò preparare la mia vecchiaia, e la narrazione mi serve per dialogare con me stessa. Ho cominciato giocosamente a scrivere il mio passato, poi, nell'addentrarmi, ho iniziato a provare tanta sofferenza, ma, alla fine, ho sentito una sensazione di ordine e di pulizia nei miei pensieri. Ho conosciuto meglio me stessa, e mi sono sentita più tranquilla, più disposta all'ascolto e più tollerante verso gli altri. Narrarmi, mi ha alleggerito il dolore e soprattutto accarezzato l'anima. 82 Viaggiare e scrivere, scritto da Eva Alberti Un convegno europeo di donne organizzato a Dublino, in occasione del cinquantesimo anniversario del Trattato di Roma della Comunità Europea, nel giugno 2007 ha fatto sì che io mettessi piede per la prima volta in un aereo. La “Older Women’s Network”, potente e agguerrita associazione di donne irlandesi, presenti su tutto il territorio nazionale, ci ha ospitato. Ero in compagnia di alcune coetanee e rappresentavamo l’Italia. Quel viaggio è stato per me una manna dal cielo, per due ragioni. La prima: erano più di quindici anni che non mettevo il naso fuori casa per partecipare ad eventi politici e sociali che, a seguito della nascita dei figli, mi ero preclusa. Infatti, per la paura di non riuscire nell’impresa di madre, mi sono licenziata dal lavoro, negandomi ogni possibilità di partecipare attivamente alla vita sindacale che aveva caratterizzato la mia vita sociale con un impegno prevalente sulle rivendicazioni delle lavoratrici, ma più in generale dei diritti sociali e civili delle donne. La seconda ragione si lega alla prima: questo viaggio doveva rappresentare a me stessa la prova che ero pronta al distacco dalla mia famiglia, per vivere la mia vita piu liberamente recuperando quella sensibilità che mi faceva “sentire” prima che “capire” il mondo circostante e che si era cristallizzata fra le mille difficoltà, del faticoso vivere quotidiano. Il distacco dal mondo del lavoro è stato doloroso: ho attraversato momenti di grande sconforto a causa di una depressione strisciante che mi ha isolato dalle mie passioni , mi sono incuneata in una specie di delirio cercando disperatamente una nuova filosofia di vita a cui aggrapparmi, ma che stentava a materializzarsi, sentivo di aver rinunciato alla felicità, perchè la nuova condizione di mamma e moglie, reclamando tutte le energie, non mi lasciava altre chances. Poi per fortuna un processo di “scongelamento” si è innescato qualche tempo fa a fronte di un mio desiderio di risalire la china. Dopo la morte dei miei genitori, per sfuggire al sentimento di grave perdita, ho frequentato corsi di apprendimento per adulti , in cui avuto modo di aprirmi, soprattutto in uno in particolare, ho trovato l’input di cui avevo bisogno. Ed io qui a Dublino, in mezzo a queste donne gioiose, mi chiedo che cosa è rimasto di quella persona che ha cavalcato un ventennio mischiando vita pubblica e privata, facendo scelte coerenti o meno, sposando l’ambiente politico della sinistra e usando il femminismo come strumento di 83 affermazione. Se non fossi quella che sono, cioè una rompiscatole, potrei dire a me stessa di sentirmi protetta, oggi, qui, da queste donne venute a convegno da diversi Paesi dell’Europa, cosi determinate nell’analisi della condizione femminile e speranzose per un futuro più ”rosa”, eppure un sottile scetticismo misto ad indefinibile malinconia mi accompagna per tutta la durata dell’evento pubblico. Sono passati trent’anni da quando entrai nella politica credendo vivamente che avrei contribuito a modificare la vita di noi donne dopo secoli di silenzio. Poi le cose sono andate in un certo modo... Io penso che in Italia non è bello essere donna, troppi dati negativi ci distinguono dalle altre donne europee, che sento più battagliere e orgogliose del loro genere; ma io purtroppo in questo momento non mi sento ancora pronta per ributtarmi nella mischia, qualche ferita brucia ancora, gli attacchi che riceviamo su più fronti necessitano di un grande impegno e, se le donne stesse, soprattutto le giovani, non corrono ai ripari sostituendosi nelle lotte alla mia generazione, un grande ventennio di conquiste verrà spazzato via, e c’è il rischio di tornare ad essere cittadine di serie B, soprattutto per chi non ha i mezzi culturali ed economici. Ho bisogno di fare pace con me stessa, di costruire un terreno di cambiamento, di recidere qualche ramo secco per poter vivere intensamente le mie giornate con un ritrovato protagonismo dove gli altri abbiano un giusto peso. Adoro i miei figli, ma d’ora in poi devono incominciare a prendersi le loro responsabilità. Con la scrittura autobiografica, e l’essere a Dublino ne è una conseguenza, perché se non avessi intrapreso prima il viaggio dentro me stessa frequentando i laboratori di scrittura autobiografica, non sarei stata pronta per questo viaggio geografico, ho messo e sto mettendo ordine nella vita, ho imparato ad organizzarmi, relazionarmi, selezionare le priorità, desiderare di nuovo, rimettermi a studiare, insomma riprogettare il mio avvenire. Scavando nella memoria, attingendo ad episodi, mettendo in luce situazioni rimosse, ho recuperato una visione di me completamente diversa da quella che avevo. Ripercorrere la mia vita mi ha fatto accorgere di quanto coraggio ho messo in campo nell’affermare le mie scelte, quel coraggio che ora sento mancare, qualche volta, man mano che i ragazzi crescono e le loro esigenze aumentano, tutto questo in una società complessa e che sento aggressiva nei confronti dei più deboli . Mi sento spiazzata quando penso alla tana che si sta svuotando e alla gioventù persa irrimediabilmente, però sedermi e mettere questo su carta bianca con le opportune riflessioni , oltre che essere un piacere, sento che è un dovere nei miei confronti, ma anche nei confronti delle persone che 84 amo e che ho amato. Nello scrivere ho ritrovato il mio passo e sono di nuovo in movimento. E ora qui a Dublino, lontano dai condizionamenti, mi regalo pensieri fluenti e benèfici nella convinzione di avere avuto una grande fortuna nella vita. Nel fare un bilancio, oggi penso di essere in attivo, l’amore che io ho riversato negli altri, e che piano piano mi è ritornato indietro, ha fatto di me sicuramente una persona sensibile, disponibile nei confronti della comunità che frequento e da cui attingo gli spunti per il mio agire e nella quale sento di partecipare con tutta la mia esperienza. Quel senso di perdita che avvertivo, volgendo lo sguardo al passato, si sta affievolendo, mentre sono qui, lontana, e provo per i miei cari un ritrovato amore. Naturalmente non sono state tutte rose e fiori, e come tutte le cose che producono un cambiamento, c’è voluto impegno e sacrificio ma per me ne è valsa la pena. Recentemente ho iniziato un diario dove annoto stati d’animo, riflessioni sulle cose che succedono, soprattutto in rapporto ai mass-media. ....Dopo un anno di scritti autobiografici, percorro la mia giornata con passo spedito, il tempo scorre secondo il mio ritmo, ho tante cose da fare... Dublino è testimone inconsapevole di questa rinascita emotiva e spirituale. Fin da subito mi sono innamorata di queste casette con le tendine ricamate, di questi portoncini compatti e colorati .Lo sguardo vaga attento e rispettoso sui monumenti eloquenti di una cultura piena di segni e simboli di civiltà remote che evocano in me racconti letti tempo fa quando il mondo anglosassone mi attirava in maniera totale. Passeggiando per il Trinity College sento lo spirito dei grandi scrittori irlandesi che mi spingono ad una riflessione profonda sull’importanza della conoscenza che dà veramente il senso alla vita. Il merito di questi grandi è quello di portarti, attraverso i loro racconti, là dove tu vuoi andare. Si diventa così prigionieri di luoghi che una volta che li incontri realmente, si ha la senzazione di esserci già stati, che ti appartengono. Così ho scelto fra quelle casette , la mia dove mi sono immmaginata di vivere felicemente, oppure allungandomi sul meraviglioso parco cittadino e ascoltando bambini che parlavano nella loro lingua, mi sono immaginato un altro destino e chissà perchè ho pensato ai Vichinghi. I giovani provenienti da tutto il mondo che pullulano la città di Dublino, con il loro fare tranquillo, mi hanno fatto pensare a mia figlia Alice che vedrei bene qui in mezzo a loro. Il contributo straordinario della mia amica del cuore Clara, con il suo fluido ed ottimo inglese, mi ha permesso di vivere appieno questa esperienza. Percorrendo la baia, respirando il vento del nord, che ho trovato diverso dal nostro, i miei sensi hanno percepito una forte tensione: non mi sentivo così viva da molto tempo . 85 Ho camminato per ore senza stanchezza e in questo stato di quietezza ho sentito dentro di me una presenza fortemente rassicurante, mi sono immaginata mia madre quando era giovane e sorrideva come nella foto che ho in camera. Ho scansato tutte le tristezze e ho desiderato fortemente un cambiamento radicale della mia vita. Scrivere di queste cose può essere il mio impegno per il futuro, ma è anche una bella sfida. Da un po’ di tempo, in questo descrivere emozioni, pensieri, riflessioni su come mi sento, sento il bisogno di rapportarmi a persone desiderose come me di raccontarsi. Unica condizione: sincerità e coraggio, nell’eterna indecisione che mi ha caratterizzato nel rapporto con gli altri, mi chiedo ora se essere me stessa, seguendo il cambiamento che è cominciato, può essere accettato, e in alcuni momenti condiviso, dalle persone a cui tengo di più Ma se questo non fosse, ho deciso di non scoraggiarmi, insegnerò agli altri a rispettarmi; è un mio diritto, come sarà mio dovere ricercare tutti i mezzi per una buona comunicazione. 86 Prima di arrivare al mio nome racconto scritto da Giovanna Gaetani Non voglio usare una formale presentazione, vorrei..… concedetemi di farlo, cercare di avvolgervi nelle mie più forti e radicate fragranze, vorrei usare un’anomala via di conoscenza, che vi arrivi prima del mio nome comune, conosciuto o sconosciuto. Qualcosa di forte, il mio dire elaborato nell’animo con nostalgia, con eleganza piena di emozioni e con disinvoltura vorrei farvi giungere oggi, attraverso questa memoria scritta. In confidenza non vi nego che sto pregando affinché questo mio racconto non vi resti noioso e faticoso da interpretare, nel rubarvi il tempo di una lettura vorrei regalarvi il mio e, chissà, un po’ dei vostri ricordi. Oggi, nei 40 anni, ritrovo in questa mia nuova casa tutte le cose vissute, sebbene mai ne avessi dimenticata una. L’effettivo trasloco è avvenuto il 10 agosto del 2008, per l’occasione dell’onomastico del mio bambino. Era un pensiero già deciso da tempo, non poteva essere altrimenti, a lui devo il mio coraggio, la mia forza. In questo mio immaginario sogno, oggi divenuto realtà, ho avuto la fortuna di aver ritrovato cose, sensazioni, emozioni sommerse da tempo. Di questo piccolo giardino, che decora questa mia piccola dimora, amo la terra, le fatiche che richiede, le bellezze che regala, dopo che le mani si sono stancate a lavorarla. Sono trascorsi quasi tre mesi, ho attraversato l’estate e adesso viene l’inverno. Come di consuetudine, al sorgere del giorno, quando ancora tutti sonnecchiano nei caldi letti, io mi avvio nel mio giardino, guardando con cura che nulla possa mancare ai miei piccoli ortaggi piantati, non nego, con paura, perché l’inesperienza non manca. Questa constatazione non mi onora, né mi scoraggia, perché da ciò che amo così tanto parte l’interesse di informazione, non trascurando i più futili consigli, o trascurabili dettagli, affinché tutto cresca come è giusto. Credetemi, non c’è maggior soddisfazione che vedere che i propri sacrifici danno i loro frutti. Da qui iniziano le mie fragranze…. Il mio giardino è suddiviso in tre angolature, me ne servirò per descrivere, con poche note, i passaggi della mia vita, piena come un’anfora, ricca di una bellezza estrema, assediata da mille colorazioni. Molto spesso i nostri occhi si soffermano sulla superficie della bellezza che abbaglia, senza osare andare oltre, laddove essa mostrerebbe i sacrifici, i dolori, e quanto porta all’allontanamento di vero aiuto. Oggi, insieme, apriamo l’anfora della mia vita. La prima nota del mio giardino mi richiama ad un’infanzia struggente e incompleta. Avevo solo tre anni quando i miei genitori presero la decisione 87 di lasciarmi in collegio. Sì, lasciarmi, questo è il termine giusto, magari con un velo di tristezza che non traspariva. Ho usato quella frase con precisa motivazione e constatazione, dal momento che passavano mesi prima che si avvicinassero ad una piccola visita. Questo avveniva quando riuscivano a trovare il mezzo di un amico, loro non avevano la patente e il taxi non rientrava economicamente nella loro vita. Il ricordo riemerge ancora oggi come allora, quella tristezza mentre aspettavo con ansiosa speranza, soffermandomi a guardare fuori dai grandi finestroni, guardavo lontano, oltre le case e le colline, e pensavo che magari quello poteva essere il giorno giusto, non allentavo le mie speranze fino al calar della sera, quando sentivo lo stridio delle grandi serrate al quale si aggiungeva il suono cupo di serrature che bloccavano il piano inferiore dell’istituto. Solo in quel preciso momento il mio pensiero ritornava, come un’eco instancabile: “anche oggi si son dimenticati di me”. Qualche volta capitava che il suono del grande portone ci richiamasse l’attenzione, come un allarme risuonava in tutto l’edificio, magari in un orario improprio e inadeguato, perché già alle 21.30 venivano chiusi i cancelli, mentre noi ragazze eravamo nelle camerate. Io sapevo chi poteva essere, scendevo dal letto e a piedi nudi mi avviavo nei corridoi per sedermi sui primi gradini della lunga scalinata che conduceva all’ingresso principale. Mi esponevo il minimo necessario che mi permetteva di vederli almeno da lontano. Erano i miei genitori, noncuranti delle regole, si presentavano quando volevano, mio padre insisteva per vedermi, ma la suora, “giustamente” ferrea, lo richiamava all’orario, alle regole imposte dall’istituto. Con garbo ed educazione faceva notare che quell’ora, per la visita, era inappropriata, e quindi lo invitava a ritornare negli orari stabiliti. Io così piccola e minuta, seduta sui freddi gradini, mi aggrappavo alla ringhiera per cercar di vederli ancor più da vicino, avrei volevo gridare, comunicare che io ero li, che li aspettavo da tanto, che mi mancavano, e, se solo alzavano lo sguardo, potevano vedermi. Li vedevo arrivare, e poi andar via da quell’abbraccio che avevo desiderato per mesi e che mi veniva negato, e nessuno lo ha mai saputo. Sentivo che qualcosa di importante si impadroniva di me, ma non sapevo ancora dargli un nome, ero troppo piccola per capire, in seguito ne scoprii il nome, e fu terribile. Provavo dolore, tristezza, quelle lacrime senza singhiozzo per non far rumore. Nonostante la mia piccola età capivo che la suora era nel giusto, non ci si può ricordare dei propri figli solo quando i cancelli si chiudono. Fra uscite ed entrate passavano gli anni, il ricordo più bello che mi riporta in quel luogo è il profumo dei fiori, dell’erba che giocava col vento, dei pini giganti che ci regalavano pigne da adornare, arricchire con gli acquarelli, a nostra ingenua fantasia. 88 Il mio primo giardino l’ho vissuto lì, amavo rincorrere la libertà di quell’area immensa, se affondo i miei pensieri, ogni volta che guardo il mio giardino riesco ancora a riconoscere i profumi di allora. La seconda nota è un piccolo orto dove ortaggi di stagione aspettano il primo saluto del mattino, e il suono dell’acqua è richiamo per un dolce riposo. Giorno per giorno si rilevano contrasti di colori che variano dal rosso vivo dei pomodori e dei peperoni, al verde intenso della verdura, per concludere con l’acqua di mare di una tenera lattuga. Tutto ciò mi riporta a ricordi preadolescenti, quando, per diversi, penosi motivi, si cambiava spesso casa, fino ad arrivare ad un abitazione assegnata dal Comune, l’unico vantaggio per i miei genitori era che non si pagava l’affitto. Eravamo iscritti alla lista dei poveri del Comune, e questo ci dava priorità per le nuove costruzioni che loro chiamavano “case popolari”. Non so se potrei definire onorevole la mia povertà, unita a rinunce, sacrifici obbligati, oblio della propria vita. Mi son sempre fatta mille domande, ma non so se le mille risposte siano state sufficienti e giustificate. La casa colonica era, lo è ancora, decadente più che mai, situata nel mezzo di una campagna coltivata a dovere che non apparteneva al Comune, ma a contadini distanti un chilometro, c’era una stradina confinante con la strada secondaria alla statale. I ricordi che conservo sono immensi, straordinariamente indelebili. Il terreno calpestabile dalla nostra famiglia, che circondava la casa, era ben esteso, e scosceso, c’erano piante d’olivo disordinatamente posizionate, un’enorme pianta di fico dai rami che sembrava volessero abbracciare parte della casa. Quella casa colonica enorme aveva un bagno mal funzionante e piccolo piccolo, da entrarci una persona alla volta, non avevamo riscaldamenti, niente acqua calda, solo un grande camino, anch’esso mal funzionante, nessuno, tanto meno il Comune, si era mai attivato per farlo ripulire, il fumo che ne usciva invadeva tutta casa. Allora non capivo perché i soldi mancavano sempre, per tutto, quando arrivava il grande inverno non avevamo legna. Tra tante cose inutili c’era una carriola, più vecchia che mai, che io avevo riportato a un riutilizzo forzato, senza vergogna facevo il giro dei falegnami racimolando di tutto, cartone, segatura, cassette della frutta, ma non era legna, quindi tanta fatica per tanto fumo intorno, il tempo di allungare le mani per riscaldarsi un po’, poi tutto finiva lì. Molto spesso mancava il gas, disponevamo dei pentoloni sulla cenere rimasta, quando c’era, era l’unico modo che avevamo per lavarci un po’ decentemente, naturalmente stringevi i denti perché il calore non arrivava mai e l’acqua si colorava di cenere affumicata. Nel periodo delle raccolte correvo ad aiutare i contadini, si riempivano enormi cassette, e con giusta ricompensa e gran soddisfazione ritornavo a casa con smisurate braccia aperte, stanche e ferite, ma cariche di orgoglio e ammirazione per il lavoro svolto. Oggi in me rimane un ricordo amaro e 89 pesante che mai potrò dimenticare, tutta quella euforia durava ben poco, il tempo di aprire la porta di casa e tutti si avventavano come affannati, avvalendosi di un diritto prioritario al mio, senza curarsi della mia stanchezza, senza chiedermi se quelle ginocchia sanguinanti avessero bisogno di cure, solo parole povere, e ricche di ignoranza: “così si guadagna da vivere, che t’hanno detto, domani ci ritorni, vero?” Io rimanevo in silenzio, annuivo con la testa, un sì indegno di tutti . Alla sera, dalla mia finestra, in compagnia di quel piccolo lume di candela, unica fonte di luce disponibile, con la quale riuscivo persino a riscaldarmi, nacque la mia passione per la poesia, la scrittura, una comunicazione che mi permetteva di esprimere le mie emozioni, la mia rabbia, il mio dolore. Sognavo una vita lontana, uguale a quella delle mie coetanee, sognavo diritti negati e umiliati da tanta ignoranza. Col passar degli anni la mia adorata campagna svanì, strade e palazzi ne avevano preso il posto portando con loro i miei vissuti. Di lì a poco mio padre, con voce possente, mi obbligò a lasciare gli studi, diritto a me negato. Quando andai a lavorare avevo appena undici anni, il mio primo stipendio, dopo due mesi, permise il riallaccio della luce e quant’altro poteva servire. Ultimo angolo, non visibile dall’entrata, che confina ad est del salone, dove una porta finestra permette di entrare evitando il giro principale. Questa è una parte che raccoglie la mia vita attuale, un gazebo articolato di un colore panna un po’ invecchiato, mattoni di pietra che circondano quasi simmetrici l’area assegnata, il tavolo in legno color noce, allungabile, ancora intatto, un ricordo di un camper venduto due anni fa, sedie in plastica di un verde scuro, nell’insieme i colori sono inadeguati, non in sintonia, ma l’essenza temporanea si dilegua nella più totale serenità. Ne ho gioito nelle calde serate, mentre assaporavo la stanchezza di un lungo trasloco con la mia attuale famiglia. Questo era l’ultimo capitolo, frazionato da fragranze indimenticabili. Ho imparato molto, da tanti e da ognuno, un ringraziamento, togliendo almeno per una volta la modestia, lo devo a me, poi a mio padre che, malgrado tutto, ho amato tanto e che una gravissima malattia ha spento all’età di 46 anni, a mia figlia quasi quindicenne, il primo regalo della mia vita, al mio attuale compagno che è riuscito con la sua semplicità, il suo calore, la sua immensa disponibilità a guarire parte delle mie ferite, al mio bambino Lorenzo, di sette anni, affetto da una gravissima disabilità. A lui devo parte della mia vita e della mia più totale coscienza di questa realtà ancora lunga da raccontare. 90 Spero di non aver annoiato, e spero che chi legge accetti il regalo di una parte di me che un po’ gli/le assomiglia: il coraggio, la forza, l’onesta, l’altruismo, e anche i difetti, che hanno dato anima ad una vita speciale. La vita speciale di ognuno, e in particolare di chi si sente incompreso, sconfitto, isolato, ultimo, fino a perdere ogni speranza. Basta aprire gli occhi, perché qualcuno sta guardando noi, apriamo le mani perché c’è chi aspetta da una vita un invito, avviamoci al primo passo perché poco distante l’amore attende da sempre chi apre il suo cuore, chi offre le fragranze di una vita speciale che mai dovrai dimenticare. 91 Il lavoro, che passione! racconto scritto da Liviana Petrini Infanzia, Adolescenza, e il peso di vivere Nella mia vita tutto mi sembrava provvisorio, privo di interesse, senza importanza e la frase che mi dicevo spesso era: “ Ma ne vale la pena? Imparare a cucire, vale la pena? Imparare a ricamare, imparare a cucinare, imparare l’italiano, la fisica, la matematica …. fare la fatica di alzarsi al mattino!”. Gli anni passavano e io mi sforzavo di vivere senza sapere che farne della mia vita e perché dovevo farlo. Imitavo le azioni degli altri, facevo quello che gli altri mi dicevano di fare, perché è così che ci si comporta, e non avevo ragione di comportarmi diversamente. L’abulia annullava il pensiero delle scelte. Quando non dovevo agire ero “contenta”, mi mettevo a letto e aspettavo che il tempo passasse. Ancora meglio se riuscivo ad addormentarmi, mi svegliavo che era buio, la giornata era finita, oh che sollievo! Non era sempre così, ma la percentuale del non agire o dell’agire perchè obbligata, al fine di non sentire rimproveri, era molto alta rispetto ai momenti piacevoli e desiderati. La “Noia”, così come la percepiva un personaggio in un libro di Moravia, descrive bene lo stato d’animo della mia adolescenza. Il senso di inadeguatezza era un virus incistato in tutte le mie cellule e sembrava minare la mia sicurezza alla radice della mia essenza. Una forte pulsione di morte aleggiava nella mia mente e nel mio cuore. Avrei voluto che lo stato di quiescenza della notte si perpetuasse all’infinito e spesso facevo finta di sentirmi male per poter rimanere a letto, per poter prolungare di vivere (o meglio non vivere) in quell’oasi del mio dolce far nulla. Purtroppo non potevo mentire all’infinito, le suore del collegio, dove vivevo nel periodo scolastico, si sarebbero insospettite e quindi dovevo far finta di vivere. L’estate non era migliore, l’aspettavo con impazienza, ed ero contenta quando arrivava, così non ero più obbligata ad andare a scuola, ma, dopo i primi giorni, il piacere della novità lasciava nuovamente il posto all’accidia, anzi nel periodo estivo era ancora peggio. Le giornate erano troppo lunghe e non passavano mai, la notte non arrivava mai. La notte era bella perché si poteva dormire e tutto spariva. Purtroppo tornava il giorno con la sua luce insopportabilmente luminosa, mitigata appena dalle imposte chiuse ed io rimanevo a dormire mentre mio padre e mia madre andavano al lavoro. Verso le 9 cacciavo un piede fuori dalle lenzuola, lo appoggiavo a terra e subito lo ritiravo, perché mi alzavo? Dove dovevo andare? Cosa mi aspettavo da quel nuovo giorno? Non mi 92 dava nulla. Tutti i giorni noiosamente uguali, resi ancor più tediosi dall’assenza di sogni. Niente. Tanto valeva rimanere a letto dove però mi annoiavo mortalmente, non c’era il dolce far nulla delle mattine d’inverno a letto. No, c’era un’orribile giornata fatta di nulla, da cui non mi aspettavo nulla e in cui non m’interessava niente. Anche la decisione di fare ragioneria l’aveva presa mia madre. Io ero una “malatina” e non potevo andare in fabbrica, quindi dovevo studiare. Si preoccupavano per il mio futuro, dovevo essere riconoscente, invece quel calcare la mano su quello che non potevo fare era come voler dire: “Tu non puoi fare meglio di così. Tu non vali molto”. Questo era il messaggio che percepivo. Ero passiva perché ribellarsi significava subire ancora più umiliazioni e frustrazioni di quante già ne subivo ascoltando affermazioni poco lusinghiere su di me, e ricordando a me stessa i miei fallimenti. Tutto questo fino all’età di circa vent’anni. Come sono arrivata a parlare di tutto questo? Io volevo scrivere del mio amore per il lavoro! Per tale ragione mi ero seduta davanti al computer e… la prima parte del racconto mi è salito su quasi inconsapevolmente seguendo un percorso subliminale ed ho iniziato a raccontare dell’assenza di luce nei primi anni della mia vita, ma non ho cancellato quello che avevo scritto, ho semplicemente spento il computer. Dopo qualche tempo il rifiuto del mio scritto si è trasformato in accettazione, una considerazione nuova mi ha permesso di approvare quello che avevo scritto. Quella era una parte della mia vita che ritornava alla memoria con tutto il suo contenuto emotivo, quella ero, e sono, io. Un ennesimo rifiuto non andava bene, era giunto il momento di integrare quella parte per acquistare una piccola nuova porzione di autenticità. Inconsapevole cambiamento Non so quale magia si sia verificata. A un certo punto, ma non all’improvviso, piano piano, il mio corpo si è aggiustato, si è snellito, ha acquistato anche una certa forma gradevole e attraente, ho scoperto il piacere di esistere e di fare le cose, come uscire con le amiche, marinare la scuola, essere corteggiata, parlare e civettare con i ragazzi fregandomene del giudizio delle comari, andare a ballare, desiderare… È accaduto tutto inavvertitamente e lentamente, e all’improvviso ho scoperto che mi piaceva vivere. Ho scoperto che la vita non era più un peso, ma anche gioia. Mi svegliavo al mattino ed ero contenta semplicemente di vedere la finestra illuminata dal sole, spalancavo la finestra e gioivo del canto degli uccellini sugli alberi che ancora esistevano di fronte a casa mia, ora non più, hanno ceduto il passo al cemento e all’asfalto. 93 In inverno le cose andavano un po’ diversamente, le notti troppo lunghe, le giornate fredde ed il sole coperto dalle nuvole influivano sul mio umore e sulla volontà di iniziare la nuova avventura, ma tutto sommato reagivo abbastanza bene e ben presto mi mettevo in moto e decollavo. E’ in questo nuovo clima mentale che “ho preso la decisione” di frequentare il corso di terapista. Papà non voleva, avevo preso il diploma e, secondo me, lui vedeva questa mia richiesta come un ennesima scappatoia per non assumermi le mie responsabilità: “Basta cacciare soldi, vai a lavorare”. Così mi feci appoggiare dalla mamma. Dentro di me temevo che mio padre avesse ragione, che io non avrei combinato mai niente di buono nella vita, che non avrei mai saputo fare niente, che ero solo un’incapace. Non era cosa da poco mantenere la mia posizione, oltretutto, per quel che mi riguarda, la novità stava nel fatto che avevo espresso un desiderio, ed era presente una certa autodeterminazione, per la prima volta sapevo quello che volevo fare, forse. Frequentai il corso per tre anni. Terminati gli esami con il titolo di fisiokinesiterapista ero pronta per cercare lavoro. Mi presentai in vari presidi sanitari per offrire le mie competenze lavorative. Avevo fatto domanda anche presso l’istituto dove avevo frequentato il corso. Una delle tante mattine in cui sarei dovuta andare al mare con mia sorella, suo marito e il mio nipotino, zitta zitta sono andata ad offrire il mio lavoro al centro “Casa Papa Giovanni” di Capodarco che ospitava disabili. Un amico mi aveva detto che stavano cercando una professionista ed io colsi l’occasione al volo. La Comunità di Capodarco era considerata la punta di diamante della lotta all’emarginazione dei diversamente abili. Mi vestii elegante, indossai una gonna di gabardine in cotone con un ricamo ad intarsio sul lato sinistro che rappresentava una rosa e in fondo un merletto in macramé che guarniva l’orlo, la camicia di seta, la collana di perle, capelli mesciati biondi e truccata di tutto punto. Mi presentai in ufficio e parlai con la segretaria la quale a sua volta mi presentò la responsabile del servizio di riabilitazione. La signora, che per comodità chiamerò Clelia, si mostrò gentile e mi chiese cosa sapessi fare, le dissi che avevo frequentato il corso all’istituto di Porto Potenza Picena ma mi sentivo insicura, priva di esperienza, a parte l’anno di tirocinio. L’immagine sicura che avevo creato con il mio look era svanita di fronte alla mia imbranataggine. Nonostante tutto si mostrò comprensiva e mi disse di frequentare per qualche tempo il centro per conoscerlo, per fare esperienza, era sottinteso che così lei avrebbe potuto valutarmi. Tutto agosto frequentai il centro di Capodarco, bevendo tutto quello che mi veniva insegnato dal punto di vista dell’inserimento sociale del diversamente abile, del rispetto della diversità, della deistituzionalizzazione, 94 del lavoro che avevano organizzato all’interno (serigrafia, ceramica, lavorazione dei metalli, maglieria), delle loro battaglie per l’inserimento sociale, della loro vita comunitaria e di quella precedente all’incontro con Don Franco. Alcuni mi raccontarono come la comunità fosse stata per loro un modo per uscire dall’emarginazione se non addirittura dalla segregazione, come mi raccontò un ex ospite di un manicomio, messa lì dai suoi perché era poliomielitica e non la volevano. Altri ragazzi con handicap motorio erano stati abbandonati al Cottolengo. Ed altre infinite storie di emarginazione. Don Franco, contattato in qualche modo da loro, andava a trovarli per poi ospitarli immancabilmente nel centro, e intanto operava insieme a loro per rivendicare il loro diritto di esistere, di vivere e il diritto alla dignità umana. Respiravo un’aria di libertà e di fermento creativo le cui radici affondavano nella rivoluzione culturale sessantottina. Poco tempo dopo arrivò un manager molto pragmatico ed efficiente, con una bella testa che dominava sul cuore, il quale riorganizzò il Centro Casa Papa Giovanni secondo un criterio più razionale. I tempi stavano cambiando e lui ne era il segno tangibile. Ma per il momento non me ne curavo. Dopo un mese fui assunta parttime e dopo due mesi a tempo pieno ed indeterminato. Mi sentivo bene in quella realtà così diversa da quella che avevo conosciuta fino ad allora, mi sentivo un po’ sicura, un po’ insicura, un po’ in ansia e un po’ felice, un po’ importante e un po’ scema. Una sintomatologia conflittuale e dualista, forse frutto del giudizio interiore e degli eventi esterni piacevoli e contrastanti. Il rapporto informale con la gente, le innovazioni auspicate e il privilegiare l’aspetto sociale alla burocrazia, mi mettevano a mio agio. Si prospettava un mondo a misura mia. Negli anni a venire in altri posti di lavoro non mi sono sentita più così a mio agio. Mi piaceva alzarmi al mattino perché andavo a lavorare, mi piaceva fare tutte quelle nuove conoscenze, mi piaceva il rapporto confidenziale che si instaurava con le persone che trattavo. Mi sentivo importante perché lavoravo, mi sentivo viva perché lavoravo, mi aspettava un bel futuro perché lavoravo. Non è sempre stato tutte “rose e fiori”, ho avuto momenti di crisi, momenti in cui mettevo in discussione il valore del mio lavoro, le mie competenze, e poi ricominciavo con un nuovo modo di percepire la mia realtà, non grandi cambiamenti, ma nuove piccole prese di coscienza che mi inducevano a ripensarmi e a modificare il mio comportamento relazionale e professionale. Il lavoro per molto tempo ha costituito per me un punto fermo. Poi, per svariate ragioni, non ultima la salute precaria, è divenuto un peso. Divenne tanto faticoso che al mattino mi alzavo contro voglia, facevo un grande sforzo e piangevo mentre guidavo la macchina. 95 Finalmente si è presentata l’occasione di andare in pensione, ero infelice e nel contempo mi sentivo leggera. Potevo pensare solo a me stessa senza sensi di colpa, senza senso del dovere. La paura del futuro ed il senso di fallimento erano tuttavia presenti. Mi ritrovai pensionata, inconsistente, inesistente, non avevo più radici, non avevo più identità. Da allora sono passati molti anni in cui mi sono impegnata a prendermi cura di me stessa, mi demoralizzavano gli insuccessi e cercavo di capire cosa potevo fare nonostante tutto. Non era facile accettare i miei limiti, di qualunque natura essi fossero, ma avevo deciso di vivere, avevo ancora delle risorse da spendere. Man mano si è fatto chiaro in me che non avrei più potuto lavorare, ma mi sarebbe piaciuto dirigere i miei interessi nel sociale. E così, tra alti e bassi, continuo… a vivere la mia vita e a nutrirla. Se penso alla mia vita finora, vedo l’immagine di un vaso sigillato, che mi è stato donato alla nascita. Nessuno mi ha insegnato ad aprirlo, anzi mi è stato inculcata la paura di quello che avrebbe potuto accadermi se avessi osato farlo. La paura e la sfiducia hanno accompagnato la mia vita. Poi il vaso si è rotto e sono venuti fuori dei semi. Alcuni di essi hanno cominciato a fiorire, altri sono ancora li che non riescono ad attecchire. E’ importante, per il mio futuro, che io mantenga viva nel mio cuore una promessa che mi sono fatta in un momento di estremo sconforto: “Se sono nata e ho vissuto queste esperienze (anziché altre più gradevoli secondo il mio personale parametro), se la vita mi ha messo di fronte a queste prove, ci sarà pure una ragione e io voglio scoprirla”. Desiderio di scrivere, piacere di scrivere, scrivere per gioco, scrivere per passatempo… scrivere per raccontarsi. Ecco, debbo confessare che per me raccontarmi è un piacere narcisistico. Leggere il racconto scritto da me, su di me, è come guardare allo specchio le mie emozioni, il mio cuore, la mia anima, il mio vissuto. E’ come affermare la mia esistenza e l’importanza della mia esistenza: “Io merito di esistere e merito attenzione e considerazione solo perché esisto”. Io scrivo per me, ma nell’atto di scrivere non posso fare a meno di pensare che qualcuno potrà leggere il mio racconto personale e questo aumenta il piacere dell’atto, ma anche l’impegno di fare bene per rispetto di me stessa e dell’altro. Negli anni passati scrivere per me erano sporadici atti di sfogo, di confidenza fatta alla carta, poi lasciata lì, qualche volta leggevo a qualcuno, che mostrava di prestarmi attenzione, per condividere e chiedere sostegno, altre volte stracciavo e bruciavo come a voler annullare una realtà che non mi piaceva. Poi un giorno mi viene detto “C’è un corso di autobiografia vuoi partecipare?” Perché no? Mi piaceva l’idea di stimolare la primitiva voglia di scrivere di me e di poter condividere con gli altri questo sogno. E così il mio desiderio di scrivere si è trasformato in atto che ha mantenuto i 96 caratteri di una certa continuità. All’inizio credevo di non avere niente da dire, adesso penso, invece, che sia stato l’eccesso di criticità a frenare la mia spontaneità. Quando richiamo alla memoria un momento della mia vita e lo scrivo, io ricontatto, rinnovo e spesso integro una parte di me dimenticata, isolata, e qualche volta allontanata. Si verifica in me un processo di armonizzazione che mi riconcilia con me stessa e con il mondo. Io penso come un dono quando posso scambiare queste mie scritture con quelle di altre persone. Dopo aver fatto per diversi anni un lungo percorso di ricerca introspettiva, l’intento pedagogico di questa scrittura autobiografica ha un impatto simile, ma molto graduale, è un lento procedere, cercare, ritrovare, rimettere a posto, riordinare e, perché no, restaurare. E’ un diverso e interessante modo di rafforzare la mia sicurezza …ovviamente tutto dipende da me. Mentre rifletto sulle modalità con cui affronto questo gioco impegnativo, vale a dire con incostanza, ma con continuità, penso che potrei trasferire il mio modello comportamentale in altri ambiti della mia vita. Forse non è accettato dall’ortodossia sociale, ma mi permette di migliorare la qualità della mia vita seguendo criteri personali. Col tempo saprò se ho ragione, se debbo aggiustare il comportamento, se debbo cambiarlo. Per ora sento che può essere un metodo per migliorarmi senza costrizione. Scrivere mi ha portato ogni volta un’emozione diversa, persino insensibilità verso alcune parti del racconto, o atteggiamento critico verso altre. Ho cancellato tante pagine, ne ho scritte altre. Le ripensavo mentre attendevo ad altre incombenze, oppure a letto, quando il pensiero vagava libero, qualche volta prendevo un foglio e vi fissavo un pensiero, o una modifica da fare. Il raccontare di me agli altri mi ha impegnata a cercare parole e frasi per essere compresa e per vedere con più chiarezza in me stessa. Il mio attuale atteggiamento è di gratitudine: GRAZIE! 97 Lessico di cucina familiare scritto da Marina Santinelli Molte cose belle ci sono al mondo, per me. Tra queste, io amo tanto le parole. Mi piace osservare come si concatenano, come si corteggiano in una frase che mi fa emozionare. Le parole mi stupiscono, mi sorprendono quando le scopro, in una frase, usate con originalità o con tutta la forza poetica che, dietro a una parola, fa spalancare l’inaspettato. Ed è in questo modo che la semplice parola svela i segreti più profondi delle storie, quei segreti che la mente comprende con la parte più sottile e intuitiva. E’ per questo che mi piace leggere: non solo per star dietro alle storie ma per seguire storie raccontate con parole emozionanti. Qualche tempo fa tutta questa passione ha preso una piega imprevista. Un amico o, piuttosto, un mio maestro, mi ha invitato a scrivere una parte in un libro da lui curato. Ho accettato con contentezza, fondamentalmente perché sono impulsiva e scavezzacollo e mi pareva una passeggiata perché le idee ce le avevo in testa tutte belle in ordine. Naturalmente, le cose non sono andate così lisce e la fatica non è mancata ma neanche il piacere di scrivere quello che volevo nel modo che volevo, cioè con parole che mi piacessero e che fossero coerenti con lo spirito di quello che stavo scrivendo. Tutto è andato bene, visto che adesso quel libro lo studiano in tre università e la mia parte è molto apprezzata dagli studenti. Ancora non mi capacito, però, che sia piaciuto il mio modo di scrivere, che a volte susciti sorpresa il mio modo di usare le parole. Io non mi ritengo una persona brava a scrivere e ci rimango male di fronte ai complimenti per come scrivo le cose che scrivo. Una mia amica con cui ho lavorato a scuola venti anni fa, ancora conserva alcune note scritte da me mentre osservavo il lavoro dei bambini: dice che sono tutte a modo mio. Non mi riesce di mettermi nei suoi panni e pensarla allo stesso modo, ma se lei lo dice, qualcosa di vero ci sarà. E poi non dice che scrivo bene ma che ho il gusto delle parole: questo mi piace. Per un po’ ho scritto di argomenti educativi, con divertimento e mettendoci sempre qualcosa del mio modo di sentire le cose, oltre che di pensarle. Poi è arrivata una proposta di scrittura autobiografica. Giravo intorno all’autobiografia già da un po’, pigramente, per curiosità ma questa opportunità mi ha mosso verso azioni più dirette: perché non usare le parole per me? Perché non cercare il segreto che le parole svelano della mia storia? Se il gusto delle parole lo usassi per sentire il sapore della mia memoria? Ancora una volta, mi sono buttata con contentezza in questa nuova impresa, inconsapevole che le parole che avrei affrontato sarebbero state un viaggio alla ricerca di un linguaggio per i miei ricordi e che tante di esse ne avrebbero portato alla luce altri ancora, rimasti polverosi ad aspettare 98 nel fondo della mia memoria. Alcune parole ed alcuni ricordi sono stati anche dolorosi ma tutti hanno resa più limpida la mia storia. Le parole sono il lessico del linguaggio; i miei ricordi sono il lessico della mia storia. Ho scoperto che non sono importanti solo i “grandi ricordi”, ma che anche quelli delle azioni ricorrenti, o dei piccoli fatti, o delle azioni che passano inosservate possono scatenare parole piene di significato, scoperte piene di significato, così come, in una frase, anche la parola più breve ha la sua grande importanza e usare “e” piuttosto che “o” può fare una differenza decisiva. Scrivere autobiograficamente, per me, è una ricerca di coerenza tra le parole e ciò che racconto: quando i due piani si sovrappongono e coincidono e a me pare che quasi non ci sia differenza tra ciò che narro e la parola con cui narro e, allora, mi si apre davanti un panorama che mi leva il fiato. Quando mi affaccio a guardare, mi rendo conto di quanto ampia è la mia storia e quanto ci sia di mai narrato che aspettava una parola per sé. Non so se il senso di liberazione che sento sia proprio il mio o quello della mia storia che si rivela. Ma, probabilmente, non c’è differenza. Sicuramente sono mie la leggerezza e la quiete che mi restano dopo avere scritto. Le persone hanno un infinito spazio dentro di sé, fatto dalla loro stessa vita che si raccoglie in volute a volte così spiraleggianti che se ne vede solo la parte più esterna e questo infinito spazio si sovrappone a quello delle altre persone con cui, tanto o poco, si vive. La parola è una navicella con cui mi lascio andare ad esplorare questo mondo, come se fossi un eroe dei libri di Verne, i primi che ho amato da piccola. La mia avventura lessicale, in questo momento, mi spinge verso la ricerca degli elementi di fondo della mia storia, delle memorie a cui tanto mio presente si radica, di un linguaggio di azioni e parole che mi fanno sentire legata alle generazioni prima di me e a quelle dopo, che mi colloca in un continuum in cui sono un anello di congiunzione. Sarà la mia età ma ho desiderio di agire perché ciò che ho ricevuto di buono non vada perduto e vada in dote al futuro. Una delle memorie fondamentali nella mia storia, una di quelle che costituiscono il mio lessico esistenziale, è la vita di cucina che ho vissuto e visto vivere quando ero in campagna da piccola. Sono ricordi pieni, corposi, del genere che ti fa sentire amata anche se è passato tanto tempo. E’ anche un ricordo che mi lega a due donne importantissime della mia vita familiare, ad un tempo della mia famiglia di cui ho tuttora nostalgia, al più bel momento della mia infanzia, quello che ancora vuole vivere dentro di me, rustico, avventuroso e pieno di aria e alberi. I ricordi si presentano ai miei occhi interni come un dipinto ottocentesco, nelle sue scene rurali quasi ovattate. Ma qui, le immagini si svolgono tutte in interno, nella cucina. La cucina è la stanza più bella della casa. Secondo me. Quantomeno, lo è stato per tutto il tempo dell’infanzia e della giovinezza. Con l’età adulta credo che la dispensa si collochi ex aequo con la libreria. Questo dice tanto 99 della mia vita: pane e lettura. I libri me li mangio, sono un sostentamento della mia esistenza; di pane ne mangio meno, perché, piuttosto, il pane a me piace farlo. Se mi penso alle prese col cibo, non sono intorno al desco, ma davanti ai fornelli. Il cibo non significa mangiare, per me, ma cucinare. La cucina è la mia stanza dei giochi; gli alimenti i miei giocattoli. Cucinando, gioco. Questo gioco non somiglia al nascondino o all’acchiappatutti (gran risate, corse, movimento, compagnia), ma alle costruzioni (concentrazione, sperimentazione, sorriso tra se e se) che da bambina era il mio gioco preferito. Tra fornelli, piano di lavoro e lavandino passo tanto tempo, perché cucinare sul serio richiede tempo: anche un semplice brodo vegetale ha bisogno della sua attenzione. Certo: brodo vegetale, perché cucino di tutto, dalla brodaglia più semplice al manicaretto più complicato. Tutto dipende dall’umore, dalla disponibilità della dispensa e dalle persone a cui è destinato. Ho un modo tutto personale di decidere cosa preparerò: guardo quel che c’è, poi ci cavo fuori qualcosa. E’ come il gioco cinese del Tangram. Un quadrato di legno è tagliato in otto diversi pezzi geometrici con i quali si può comporre una figura: noi occidentali abbiamo manuali di figurine e proviamo a riprodurle coi pezzi; i cinesi stanno a vedere che cosa succede provando a mettere i pezzi in modo casuale e lasciando che la figurina emerga da sola. Io cucino come i cinesi giocano a Tangram: cerco di capire cosa si può cucinare se metto insieme in una pentola un po’ di quel che c’è nel frigo. E mi diverto. A volte, assomiglia al pasticciare dei bimbetti ma qualcosa viene fuori: mangiabile sempre, quasi sempre apprezzabile, talvolta sopraffino. Questo modo di cucinar-giocando non è rassicurante per chi mi chiede consigli, perché non riesco, poi, a definire le quantità, o i tempi, e questo non soddisfa chi cucina con metodo scientifico. Io vagheggio e, proprio per questo, difficilmente riesco a ripetere due volte un piatto perché non ricordo quasi mai con precisione come ci sono arrivata la volta precedente. Il mio stile è assai ludico ma anche assai effimero, proprio come il gioco che mai è uguale a sé stesso. Sono inaffidabile, dunque, per le ricette precise e ordinate. Tranne che per la cucina di famiglia. Per quella vige la legge più intransigente e sono ammetto solo variazioni minime e in casi di disperazione. E’ una specie di obbedienza alle divinità familiari della cucina. La mia famiglia e la cucina sono elementi indissolubili, tanto che mi sento un gradino di una scala generazionale femminile che si tramanda il piacere di cucinare per gli altri come se fosse nel sangue, come se il nostro DNA avesse un gene ad hoc. Questa linea femminile appartiene tutta alla mia famiglia materna: non ho potuto conoscere mia nonna, ma so che prima di me mamma e zia Marì, poi mia sorella ed io, e ora anche mia figlia Letizia, tutte noi possediamo questo gene di donne che amano cucinare e veder mangiare. 100 Le cucine che ricordo da bambina erano tutte molto grandi: negli anni ’60 si cucinava e mangiava nello stesso ambiente e le stanze erano abbastanza grandi. Mi ricordo che le cucine si sporcavano parecchio per il continuo muovere ciotole e pentole dal lavandino al tavolo, al fornello; la cucina era un campo di battaglia, visto che tutto era preparato a mano. Il gene di famiglia contiene anche questo allele di manualità che più che biologico è culturale ed educativo. La mia storia culinaria si è forgiata in campagna, nella Vallesina, a Castelbellino Stazione, tra campi, stalle, alberi da frutto e cucina col focolare. Non ho memoria del nostro desinare quotidiano, ma ricordo i pranzi della domenica. Non c’era tanta varietà ma era una festa: di solito tagliatelle col sugo, carne arrosto e pizza dolce. Ognuna di queste parole (tagliatelle, sugo, arrosto, dolce) nascondono una storia mitica, fatta di tutte le sensorialità sperimentabili e, più che di sapore, parlano di legami, di aspettative, di promesse. Non so in quale modo, ma il cibo che ho mangiato nella mia famiglia oltre a nutrirmi mi ha trasmesso il senso di appartenenza; la mia lingua materna è il cucinare e so che è quella la lingua che ho parlato anche con la mia Letizia e con quelli a cui voglio bene. Le catene dell’amore, in casa mia, da piccola, erano fatte di pasta di casa, di tagliatelle. La pasta fatta in casa è, spesso, l’emblema della genuinità e della qualità di quello che viene cucinato in casa: è un simbolo di tradizione. In campagna erano il piatto della domenica, erano il segno che si mangiava tutti insieme. Le donne di casa dedicavano più tempo alla cucina e meno ai campi perché era giorno di festa, il tempo della mattina scorreva scandito dai tegami. Non che si lavorasse di meno: zia Marì, mamma e nonna Annetta (la nonna dei miei cugini che lo era anche per me) si alzavano presto e cominciavano a indaffararsi di prima mattina. La cose da cucinare erano tante, perché il pranzo domenicale era completo dal primo al dolce e qualcosa doveva cuocere a lungo. I preparativi erano impegnativi: l’arrosto andava insaporito con il lardo battuto con l’aglio e il rosmarino e spalmato sulla carne che si impregnava di profumi erbosi e si inteneriva col grasso mentre si cuoceva nel forno a legna. Prima della carne, andava cotta la pizza dolce, profumata di mistrà e tutta coperta di confettini minuscoli, colorati e dolci. Ad accompagnare entrambi questi momenti, c’era la lunghissima cottura del sugo, che diventava denso e scuro a forza di bollire e dentro cui nonna Annetta metteva degli ingredienti strani, degni della fattucchiera più efferata, come i grigilii (le interiora di pollo) e le più raccapriccianti zampe di gallina o di papera che nonna usava per dare sapore (in verità se le rosicchiava pure, ed erano una prelibatezza per lei). Le zampe di papera mi facevano pena (mi erano simpatiche, le papere) ma quelle di gallina mi impressionavano, con quelle dita sottili e l’unghia arcuata: un film dell’orrore in pentola, sottolineato dal rosso della conserva 101 di casa che, bollendo, tendeva al marrone. Nonna Annetta era la detentrice dei ricordi più antichi della cucina: aveva imparato a fare il sugo alla fine dell’ottocento e non c’erano motivi plausibili per contestare la tradizione. Noi bambini lo trovavamo fatto, praticamente ne avevamo contatto diretto quando era già ad esaltarsi sulle tagliatelle, ma avevamo piena consapevolezza della sua presenza grazie al profumo che si spandeva per tutta la casa. Era la gioia del naso, a dispetto del raccapriccio delle zampe. Le tagliatelle erano l’ultima cosa che veniva fatta. Allora non lo capivo, ma adesso, quando penso a zia e mamma che si mettevano a impastare giusto un’ora prima di cuocere la pasta, provo meraviglia e ammirazione per quella tempestività e quel lavorare fino all’ultimo minuto prima di mangiare perché le cose non si sciupassero. Solo un elemento andava anticipato: la raccolta delle uova. Proprio questa era l’unica cosa richiesta a noi bambini, altrimenti esclusi dal rito del cucinare domenicale . Andavamo nel pollaio la mattina stessa o il sabato a rovistare tra le cove delle galline. Non mi piaceva molto il pollaio, che per me puzzava, e i polli non mi erano simpatici, perché ogni tanto mi inseguivano quando venivo spedita a spargere un po’ di pisto sul praticello dove razzolavano; non avevo simpatia neanche per quel praticello che confinava col grasciaro che non sprigionava buon odore neanche lui. Io, poi, in particolare, ero il cruccio di famiglia giacché spesso, pur senza farlo apposta, ero avvezza a scivolare sulle cacche dei vari animali, sporcandomi dalla testa ai piedi. In famiglia, ancora viene ricordato un mio passaggio di corsa nella stalla delle vacche con caduta a pelle d’orso su una cacca fresca che mi guadagnò una bella lavata a secchiate d’acqua presa direttamente dal pozzo sull’aia. Mamma non disse una parola ma scosse piano la testa tutto il tempo. Nonostante questo episodio increscioso, le mucche mi stanno ancora simpatiche, i polli invece no. La cosa bella dell’andare a raccogliere uova era il tepore che sentivo quando ne prendevo in mano una: era una sorpresa sentire il calduccio di quelle palline in mezzo alla paglia. Anche se erano fatte dalle galline, non avevano cattivo odore, erano una specie di sasso fragile e caldo da trattare con delicatezza e noi bambini cercavamo veramente di non romperle quando le prendevamo su e le riponevamo nel cesto di vimini – ce n’era uno apposito per le uova. Al contrario, era molto meno delicato il nostro ingresso nel pollaio. Noi bambini eravamo: i miei cugini Giorgio e Paolo, a volte alcuni bambini del vicinato (mi ricordo una ragazzina coi capelli rossi, Marisa), io e mia sorella Graziella, che avrà avuto due anni e ci zampettava dietro come poteva (all’epoca non avevo molta confidenza con lei: c’era, e questo era tutto). La nostra era una calata barbarica, volutamente rumorosa, di corsa, spalancando la porticina del pollaro in modo che le galline si spaventassero. Infatti succedeva un gran guazzabuglio strepitoso di svolazzo di galline, penne fluttuanti, schiamazzo disperato di “coccoccoccooooo!”(era quello che mi piaceva di più: anche 102 adesso mi fa ridere). Le galline avevano gli occhi di fuori ed il becco aperto per protestare, qualcuna batteva le ali furiosamente, altre correvano senza direzione col collo che guizzava avanti e indietro. Era uno spettacolo, una confusione generale che aumentava, paradossalmente, quando zio Attilio ci veniva a sgridare perché smettessimo di mettere paura alle povere galline e quelle si impaurivano di più alle sue grida: “Se je mettede paura,non fa più l’ovi! Gide a giogà fori! Mannaggia, monelli!”. La parola “grida” per zio Attilio non è proprio adatta, perché la sua voce era sempre bassa, roca e gentile: vociava più forte, piuttosto. Era un uomo mite di voce e di natura, col faccione scuro e gli occhi piccoli e gli piaceva portarci a spasso sul trattore: era il nostro eroe delle avventura campestri. Mamma e zia, invece, avevano gli occhi tondi e vivaci, ma anche loro non le ho mai sentite gridare, neanche nei momenti in cui avrebbero potuto farlo. La loro voce era naturalmente incline al tono sorridente che si dichiarava tutto nella loro tipica chiusura di frase, l’appellativo affettuoso universale per noi figli :“lè”. Questa sillaba minuscola va pronunciata con la è larga, proprio come il verbo essere, e significa tutto il vocabolario amorevole di nomi per chi hai nel cuore; ha una declinazione particolare al femminile con “lelletta” , ma è, di per se, un nome neutro. E’ ancora in uso in casa e lo uso per mia figlia, per mio marito e mia sorella mentre ne beneficio ancora da parte di zia Marì. Un saluto seguito da lè è una piccola dichiarazione d’amore, è solo per te e lo dici solo a quella persona lì e traduce pudicamente in una sillaba un discorso affettuoso di persone troppo timide per osare parole dichiaratamente dolci. Mamma era così. Zia è così. Io sono così. “I preso l’ovi, lè?” e sapevi che era un lavoro da grandi quello delle tagliatelle, ma dentro ci sarebbe stato un sacco di affetto per te. Il segreto della cucina di quelle donne di casa era proprio questo, che sapeva di affetto, collettivo e personale: era per tutta la famiglia al completo e anche per te personalmente. Sicuramente era buono di sapore (come è il cucinare genuino), ma in più c’era il condimento della contentezza di prepararlo per le persone di casa, perché in due lo preparavano, ma ciascuno lo sentiva suo e sentiva di far parte di una famiglia in cui c’era sempre posto, a partire dalla tavola. Zia Marì e mamma si preparavano per le tagliatelle verso la fine della mattinata, dopo aver provveduto alla casa e a quello che del pranzo richiedeva maggior tempo come, ad esempio, la cottura al forno. Zia indossava una vestina, un abitino di cotonina che si allacciava dietro a mò di scaldacuore, e sui capelli, anche in casa, teneva sempre il fazzoletto legato dietro, sulla nuca; mamma usava, invece, il sinale o parnanza, il grembiule classico da cucina. Tutte e due erano rotonde di forme, zia un po’ più alta, e davano una impressione di solidità e quieta forza fisica ( e per fare la sperna ce ne vuole) visibile nelle braccia toniche e nelle gambe salde. 103 Prima di tutto, mettevano le tavole di legno, le spiendole, poi esaminavano i rasagnoli che non avessero residui secchi della spernata precedente. Veniva, poi, il turno della farina, che non era nei sacchetti di carta, ma nei sacchi di tela bianca tessuta stretta, dove veniva messa dopo la molitura del grano raccolto dal campo di casa: la farina non mancava mai e a me era completamente oscuro che i mucchi in granaio così odorosi di polvere ed erba e quella farina appartenessero alla stessa terra. Dosavano ad occhio la quantità di farina, perché la pasta di casa si quantifica a uova, non a chili di farina: per quattro persone ci vogliono tre uova. Poi facevano la conca: la farina formava un monticello appuntito che scavavano con le dita in un movimento rotatorio morbido e deciso che allargava la base in un argine esattamente rotondo entro il quale c’era lo spazio giusto per il numero di uova che dovevano andarci. Era una specie di geometria e di matematica delle quantità che apparteneva alle mani e agli occhi: tante uova, tanta farina, tanto diametro della conca, in una applicazione di equivalenze completamente fondata sull’esperienza. Ancora, come allora, vivo con stupore e ammirazione questa loro intuitiva conoscenza che, forse, è la radice della mia propensione a trovare le relazioni matematiche dentro le ricette. Quella loro matematica era naturale, spontanea: mamma e zia SAPEVANO e sapevano impastare da quando erano piccolissime (allora, più o meno il 1966, non avevano ancora trent’anni e avevano imparato quando ne avevano otto o nove). Mescolare uova e farina era una questione di precisione e rapidità: con movimenti rapidi delle dita di una mano battevano le uova, mentre con l’altra accompagnavano la farina a mescolarsi, in un modo che ricorda una madre che, gentilmente ma con dissimulata fermezza, spinge alla schiena un bambino riluttante. Le uova battute non uscivano mai dalla conca di farina, che si stringeva pian piano intorno al composto sempre più denso che si andava formando, misteriosamente uniforme, finché tra le loro mani sbucava una palla liscia e gialla, la massa. Era una metamorfosi rapida, che non durava che pochi minuti, poi per la massa veniva il tempo di una vigorosa massaggiata. Dopo la fase della tattica, veniva quella della forza. avevano Le maniche arrotolate, le mani incrostate di impasto con cui stringevano la palla, le dita affondavano nella pasta, i palmi che la premevano e spingevano con per farla rotolare sulla tavola. Le braccia di mamma e zia esprimevano una energia decisa e, al contempo, una leggerezza femminile come un andare e venire di onde, mentre la massa rotolava avanti e indietro sotto le loro mani. Il ritmo dell’impastare era regolare, una musica definita dallo sfregare della pasta sulla spiendola, un frinire delicato che faceva da sottofondo alle chiacchiere delle donne. L’impastare aveva una sua importanza e doveva durare abbastanza, in modo che la pasta non venisse troppo languida e, quindi, refrattaria a lasciarsi permeare dal sugo. Erano le mani a stabilire quando la pasta era 104 pronta: lo sentivano al contatto della pelle sulla massa. Allora veniva il momento della poccia: mamma e zia coprivano la massa con una sola mano e le imprimevano un movimento rotatorio sulla sperna da cui risultava una palla ben rotonda dalla parte della spiendola, e leggermente conica dalla parte della mano: la massa era pronta per essere spernata. Continuando a chiacchierare tra loro come se niente fosse, mamma e zia prendevano i rasagnoli, all’unisono, con una intesa consumata (non si mettevano d’accordo a voce). Poi infilavano la mano nel sacco della farina e la spargevano sulla spiendola: era il gesto che mi piaceva di più. L’aria diventava bianca intorno a loro, con la farina che volteggiava cadendo sulla tavola, come una nevicata leggera che si posava uniforme sulla superficie. Durava un attimo, ma a me sembrava un rituale magico, come una fata che sparge una polverina misteriosa. Mamma e zia agitavano morbidamente in aria la mano chiusa in un pugno appena accennato, col gesto che ricorda un sacerdote che sparge acqua santa per la benedizione, e la farina ricadeva volteggiando con un turbino appena accennato. Sembrava si formasse una estesa nuvola e che la sua pioggia polverosa si spandesse ben oltre la spiendola e, invece, cadeva proprio dove doveva. Uno strato impalpabile era pronto per stendere la pasta, né troppa farina, né troppo poca. Poi le mani tornavano a tuffarsi nel sacchetto della farina, riemergendone cosparse, la farina attaccata alle ruvidità delle mani. Allora tornavano a prendere la poccia per strofinarla e infarinarla e prepararla per spernarla. I primi passaggi erano una pressione energica dal centro in avanti, ruotando la poccia ogni volta per mantenere la forma rotonda; ogni tanto qualche sosta per pescare un pizzico di farina dal sacchetto e aspergerla sulla nascente sfoglia. Quando lo spessore era quello giusto, ed erano gli occhi ad accorgersene, cominciava la manovra più delicata. Mamma e zia arrotolavano l’arco superiore della sfoglia sul rasagnolo e facevano scorrere i palmi delle mani dal centro verso il fuori, ritmicamente ma a scatti e, ad ogni andirivieni, impercettibilmente, arrotolavano ancora la sfoglia, finché tutta era avvolta sul rasagnolo. I corpi erano fermissimi, saldi, nel movimento scandito delle braccia; solo gli orli dei vestiti fluttuavano impercettibilmente sulle gambe ben piantate a terra, ondeggiando poco poco, quasi a rammentare la femminilità di quel lavoro. A quel punto, appoggiavano il rasagnolo e, lanciandolo di lato, srotolavano la sfoglia diventata più sottile, più larga e su cui erano impressi i semicerchi lasciati dai bordi durante l’arrotolamento. Questo passaggio era essenziale per mantenere la sfoglia rotonda, che veniva, alla fine, grande quanto una tovaglia e senza neanche un buco, che era la mortificazione peggiore. La questione dei buchi sulla sperna è la causa per cui io, oggi non la so fare, ed è il più grande rimprovero che potrei fare a mamma. 105 Quando la sperna era pronta, bisognava proteggerla dall’aria, per non farla seccare e, perciò, la coprivano con un telo finché prendevano i coltelli per tagliare le tagliatelle. Arrotolavano la sfoglia da un lato fino a metà, poi dall’altro lato fino a metà in senso contrario, sovrapponendo alla fine i due rotoli piatti: era un espediente pratico geniale. Il taglio era un’arte artigianale: con le punte delle dita tenevano ferma la sperna arrotolata, con la lama del coltello alla distanza esatta della larghezza della tagliatella tagliavano e le due mani viaggiavano spedite una dietro l’altra fino al fondo del rotolo. Prendevano su un mazzetto di fili dal mezzo rotolo posto sopra e le tagliatelle si srotolavano in un “oplà” per essere poi adagiate sulla spiendola. Nonna Annetta aveva già messo a bollire l’acqua e aspettavamo zio Attilio per cuocere, perché ci voleva giusto un attimo. Zia e mamma approfittavano per rassettarsi: non che facessero tanto, giusto lavarsi e togliersi il sinale, perché solo noi bambini mettevamo il vestito della domenica (il mio era a scacchetti bianco e giallo, col fiocco dietro, corto che spuntavano i ginocchietti secchi di allora). Seduti a tavola, eravamo sicuri che il nostro piatto non sarebbe mancato, che da mangiare sarebbe stato buonissimo e, soprattutto, che le zampe di gallina se le sarebbe mangiate nonna Annetta. Una cosa mi era chiara: le donne impastavano ed era importante saperlo fare, era nella costituzione femminile. Mia madre, tuttavia, sentì di contestare questo principio, non tanto per convinzioni femministe ma per la sofferenza che era costata a lei. Mamma più volte ha enunciato a me e mia sorella questo suo incontestabile principio educativo: mai e poi mai ci avrebbe insegnato a tirare la sfoglia. Era inutile contrastarla ed è sempre stata irremovibile.Capita, a volte, che le madri raccontino alle figlie la loro vita passata e la generazione di mamma di storie ne aveva raccolte anche dense nel dramma delle famiglie durante la guerra. Mamma era la decima di dieci figli; nonno Ezio era prigioniero in Germania; nonna Anna non poteva tirar su da sola tutti i figli che andavano a lavorare presto: zia Marì andò “a servizio” a nove anni in una famiglia di contadini un po’ più agiati e finì che ne sposò il figlio, zio Attilio. Nonna Anna, come spesso succedeva allora, si ammalò e qualcuno doveva pur occuparsi della più piccola, Santa, che aveva nove anni: così, mamma andò in collegio dalle suore. Non si è mai concessa altro racconto di quel periodo, che questo: in collegio imparava a fare i mestieri di casa, tra cui cucinare. Non era un ambiente improntato alla tenerezza e mamma ricordava che le suore erano assai esigenti con le bambine e le davano le frustate sulle mani quando tirava la sperna coi buchi. Lei ha imparato a farla alla perfezione, ma ha odiato le suore per tutta la vita e si è sempre categoricamente rifiutata di insegnarci, benché Graziella ed io lo chiedessimo. Si vive bene anche senza saper fare la sperna, ma a me manca questo pezzetto della eredità di mamma; è come se la linea familiare femminile si fosse spezzata. Al di là della 106 concreta capacità, è la sensazione di non poter tramandare una parte della tradizione di famiglia e del significato che essa ha avuto per me e per la generazione di donne prima di me. Penso che questo accada in tutti i passaggi, che sia naturale che qualcosa si perda. Molto altro riesce ad essere trasmesso. Ma sento lo stesso un po’ di dispiacere. Però so di aver tenuto stretto il significato di quei gesti ed è questo che conta. Come mi sia riuscito, non lo saprei descrivere ma adesso guardo mia figlia Letizia che prova piacere a cucinare e mi riempie di emozione. Non è solo la soddisfazione che sappia cucinare da sola, che ci tenga a scegliere cibo buono, coltivato con rispetto, che abbia il gusto del cucinare con cura. E’, invece, la consapevolezza che lei prova quello che provo io, che è stato quello che hanno provato le donne della generazione prima di me. Allora penso che pure i suoi occhi da bambina possono aver visto qualcosa che assomiglia a quello che ho visto io da bambina, e che le nostre emozioni, in anni e luoghi diversi, sono state le medesime, come se avessero la pazienza di attendere anni per ripresentarsi col passare delle generazioni. Sono strati che si sovrappongono, in parte si confondono, e che costituiscono lo spessore della nostra storia comune, conseguente, continuante. La percezione di sentirmi in un continuum che nasce assai prima di me e di cui io sono un passaggio mi emoziona sempre tanto, perché mi racconta di come ognuno di noi sia parte di un flusso di vita che scorre. E’ ciò che provo di fronte alle testimonianze storiche in cui si respira ancora la presenza di chi ha vissuto. Ma sperimentare questa stessa sensazione dentro la mia famiglia mi commuove e mi dà fiducia, perché so di possedere la memoria del passato ma posso guardare il futuro che si costruisce; io stessa posso percepirmi come “passato” ed è una dimensione del mio vivere da adulta che mi sostiene e mi dà stabilità. Mi sento proprio come mamma e zia ben piantate nel fare la pasta di casa ma con tutta la leggerezza di quella monella che le guardava. Il fil rouge della mia famiglia è fatto di tagliatelle col sugo; tra me e mia figlia, piuttosto, è di pasta frolla e di ripieno per piccioni. Ma Letizia è proprio come questi piatti: dolce come l’una e consistente come l’altro. Nel passaggio del patrimonio di cucina da me a lei, ho scoperto una figlia estremamente ligia alla tradizione ortodossa di famiglia, a fronte di una madre (io) in odore eretico dietro ad ispirazioni e fantasie di variazioni. Io gioco; Letizia cucina. Abbiamo una ricetta di famiglia per la pasta frolla che Letizia chiama pasta della crostata, perché è la sola che riconosce come canonica. Quando ha voglia di sentirsi coccolata, quando torna a casa dopo un periodo passato a casa sua, a Siena, mi chiede una crostata con la pasta o lei stessa ne prepara una quando cucina per un momento speciale. Il patrimonio di famiglia è di moneta ancora spendibile. Mi piacerebbe, un giorno o l’altro, sentirle raccontare i suoi ricordi di cucina: cosa ha visto di me, di zia Marì (Letizia e mamma non si sono conosciute, 107 ma zia le ha fatto da nonna, come nonna Annetta per me). Chissà se ha memoria di quando, da piccola, mi aiutava a pulire gli spinaci, a spuntare i fagiolini (era così piccola e saliva sulla sedia per tagliare con un suo coltellino senza punta)…di quando abbiamo preparato i vincesgrassi insieme per la prima volta … Ciò che Letizia ed io ci siamo costruite, soprattutto per gioco, è la disponibilità a cucinare insieme, con amore e odio, come capita a tutte le coppie di madre e figlia, ma con il desiderio di preparare qualcosa di buono da mangiare, dopo, insieme. I nostri stili sono diversi ma, di nuovo, questo è un valore che condividiamo, avendolo avuto in lascito: è bello cucinare per condividere, per non lasciare segrete quelle parole amorose passate in pentola. Quando cucino, gioco. Quando cucino, dico parole affettuose per rallegrare, consolare, far riposare. Quando cucino sento il legame speciale con le donne della mia famiglia, nel passato e nel futuro. Quando cucino, tutto questo mi emoziona, mi rende il cuore sorridente e si intreccia leggero come il vapore che esce da una pentola. 108 Solo Margherite e Tulipani per me, grazie! raccontato e scritto da Silvia Tacchetti Quante storie ci sono capitate sotto gli occhi, illuminate dalla luce bassa prima di addormentarci o sotto un sole splendente nel giardino di casa nostra. Alcune di queste storie erano molto lontane da noi, ecco perché le abbiamo cercate, altre si sono insediate nella nostra libreria per puro caso, ci piaceva semplicemente la copertina del libro, ma poi ci siamo ritrovati come immedesimati, ed ecco che ci siamo sentiti rassicurati, stare al di fuori, ma provare delle emozioni, come uno spettatore, ha i suoi vantaggi. Ma la nostra storia? Come possiamo essere pronti a vivere i vissuti degli altri se prima non abbiamo letto la nostra di storia? Non per forza la nostra sarà come la storia di Zeno, contorta e così clinica… La nostra storia è ciò che siamo, ciò che siamo diventati, ma anche quello che al nostro pensiero così fugace sfugge. Ogni giorno la nostra mente rivive un po’ della nostra vita, anche quando non ce ne accorgiamo, ma non ha mai cosi tanto tempo e coraggio per ricordare tutto. C’è selezione anche lì.. Ecco invece che quando hai di fronte un foglio bianco, che sia elettronico o cartaceo, il pensiero smette di premere l’acceleratore ed inizia un’operazione simile a quella del pc quando de-frammenta il disco, tutto sembra in disordine e alcuni file nuovi, pur meno importanti, sovrastano quelli più vecchi, ma più pesanti. Inizio pian piano a togliere queste sovrapposizioni che nascondono alcuni volti, o emozioni…. inizia la paura. Non vedo tanto chiaro, sembra che sia colpa del numero degli anni, ma ne sono solo 21...e forse nemmeno mi rendo conto che ne abbia vissuti così tanti. Può darsi che siano stati vissuti a volte in modo troppo superficiale, senza consapevolezza al momento, ma d’altronde ammetterlo vuol dire che un po’ si sta crescendo no?….. La verità è che a me pesa l’avanzare degli anni, soprattutto quando mi guardo sempre indietro, con la speranza di poter rivivere ancora il passato e magari poter cambiare alcune cose. Non riesco a guardare avanti con coraggio e chiarezza, mi affaccio, ma ecco che ho già paura. Forse si deve ancora chiudere qualche cerchio. Il distacco con l’infanzia è atroce, ma prima o poi deve accadere come qualunque cambiamento, fa parte della vita di tutti. Devo cercare di rendermi conto che non grava solo su di me questo male!!! L'infanzia per me è un punto di partenza ancora da concludere, tante mie amiche quando parlano si proiettano sempre in avanti, io non ce la faccio ancora, preferisco vedermi ancora al gradino sotto. Non sapere cosa ci sarà domani mi mette molta paura. I cambiamenti, le novità, che cosa orrenda!!! 109 L’infanzia è un Pomeriggio passato senza far niente, però si è a casa propria, è il nido!!! Inventando i giochi e stando sempre all'aria aperta… il tempo passava proprio bene, sebbene a quel tempo non te ne rendevi conto. Credo che ora non sia troppo tardi per riconoscerlo. Apprezzo ogni singolo giorno, ogni singola ora in cui si era veramente spensierati. il periodo delle elementari e medie, il più bello, ho continuato a giocare con Flavia fino alla terza media. Adesso con le mie cugine piccole che fanno le elementari mi rendo conto che non è possibile rivivere certi momenti attraverso la loro di infanzia perché è completamente opposta la loro, non si sognano neanche di passare un pomeriggio come lo passavamo noi. Ho avuto un'infanzia molto libera e semplice….. che poi in pratica è finita quasi per forza perché mi dicevo: "ma che fai ancora…". Silvia è nata in campagna…lì è facile trovare qualcosa da fare, non ricordo che sia mai esistito un giorno in cui mi annoiavo, il bello era proprio che bastava un po’ di fantasia, la voglia di stare insieme…..e tutto era possibile. Palla a volo fuori, passeggiate in bicicletta, le Barbie, qualunque stupidaggine serviva a star bene, anche aiutare nonna in campagna. Il periodo fine agosto-settembre, fantastico!!! quando ci sono le barbabietole!! (mi commuovo, uno non ci è abituato a lasciarsi andare….) è il periodo in cui tutti raccoglievano le barbabietole ed oggi posso dire che erano bellissimi quei due o tre giorni, stavamo tutti in giro per i campi, c'eravamo io, Flavia, Laura e Anna e finalmente avevamo tutto il giorno per giocare. Infatti non c'era mai nessuno a casa che potesse scandire il nostro irrefrenabile desiderio di giocare e stare insieme, monopolizzavamo la cucina dell'altra casa, quella dove stavamo prima, facevamo un paese delle barbie, non bisognava cucinare e quindi sulle scale, sotto il tavolo, sotto la tv, ogni minimo spazio era per giocare, ci volevano tre ore per preparare il tutto.. Flavia era sempre quella che mandavamo su e giù per le scale a prendere le cose e in cambio le garantivamo le bambole o i vestiti più belli. Il massimo era quando arrivavano le quattro del pomeriggio, le mamme preparavamo una cesta che portavamo a babbo, a zio, ai nonni. Erano merende con il pollo arrosto, le patate arrosto, portavamo anche i piatti di coccio, bibite, limonate, e con la macchina andavamo al campo, facevamo tipo pic nic con la tovaglia, con loro, con nonna e nonno, forse una ventina di persone in tutto. Il lavoro durava due o tre giorni e queste merende si portavano ogni pomeriggio!! Ci mettevamo per terra, era una merenda cena, quello che oggi chiameremo un aperitivo tra la natura, con tutte le formiche che saltellavano, tutti lì, per terra, senza badare agli animaletti che ci potevano stare. Dare una mano a preparare tutte le cose da portare via, vedere il volto felice di nonno o zio appena ci vedevano, perché stavamo portando da mangiare!! Questa è la vita!! La loro giornata continuava fino a tarda sera, quindi noi bambine tornavamo a casa e ci rimettevamo a 110 giocare, magari fino le undici di sera, tutto un seguito! Se ci penso bene ricordo ancora le voci di sottofondo…. e forse non sono passati così tanti anni come voglio far credere. Ricordando queste cose, però un po’ rattristo perché non c’è mai la consapevolezza che qualcosa possa finire, anche il raccolto con le barbabietole. Quando si è piccoli forse si vive bene proprio perché si pensa a quel che si fa al momento, senza troppi pensieri e paure. La bellezza di tutto la scopro anche ora, mentre ricordo quei momenti, perché inevitabilmente capisco che sono stata molto fortunata a poter condividere certe esperienze che i miei stessi nonni mi raccontavano, credo che le mie cugine, e i miei figli un giorno, non potranno mai ricordare un pomeriggio passato sotto una pianta di olive a mangiare patate arrosto insieme alla famiglia… oggi, anche volendo, non si potrebbe mai ricostruire una situazione simile, stanno sempre tutti davanti al computer, si cresce davanti al computer, alla televisione, è lo schermo che ormai accompagna la crescita di queste generazioni, anagraficamente non molto lontane da me, ma distanti per altri versi di secoli. Mia cugina abita in campagna anche lei, ha spazi verdi intorno, ha nonno che si dà ancora da fare intorno casa però….a volte quando andiamo da lei, mi viene voglia di proporle di fare le stesse cose che facevamo noi, egoisticamente è per me un modo di rimettere in scena uno squarcio di vita passata, con loro.. ma non c’è soddisfazione per me. Qualche minuto e già sale in lei la noia. Durante l’estate, quando avevo forse nove o dieci anni, già la passione per il mestiere del barista mi aveva portato a cercare un piccolo spazio dietro casa in cui con dei mattoni trovati avevamo messo su un piccolo bar, il “Flanasi” (contiene le lettere dei nostri nomi, Silvia, Flavia, Anna), lo ricordo come fosse oggi. Nonna ci regalò delle porcellane che ormai non usava più, i campioncini di liquori che si usavano a quel tempo, tante piccole pentolini, soldi finti, un registro di cassa, sedie, c’era tutto. Era il nostro bar. I nostri clienti fissi erano nonno e nonna!!! Il divertimento non è durato qualche minuto. È rimasto su un’estate intera, poi la pioggia e l’arrivo dell’autunno ci ha costretto ad abbandonarlo. Un altro ricordo che attraversa tutta l’infanzia è il giorno di Natale, che è stato, fino all'anno dopo che è morta nonna, un'occasione per riunire tutta la famiglia. Ma non la famiglia di tutti i giorni, quella che vivi meno quotidianamente, ma che basta poco per sentirla parte integrante di noi dieci della casa. Era la famiglia del fratello di nonno, era un giorno bello che ricordo sempre con piacere. Qui non ci sono ore intere a giocare, è semplicemente il Natale in famiglia. Non rinuncerei per nulla al mondo a questo giorno, perché basta poco per rendere un momento indimenticabile e sentirlo attaccato a come te come parte integrante. 111 Insieme agli episodi che hanno segnato questi anni passati, in maniera cosi dolcemente violenta, ci sono anche delle persone che con la loro mano e la loro presenza continuano a lasciare dei segni non indifferenti e che quindi fanno per forza parte del mio racconto. D’altronde in qualsiasi storia che si rispetti c’è il contesto, ci sono gli eventi .. ma sappiamo bene che ci sono i personaggi che aiutano o disturbano il protagonista. Di antagonisti ce ne sono sempre e ovunque, ma non sono questi che meritano di essere ricordati, se non l’insegnamento che ne è scaturito dal loro male. A lungo termine posso essere felice di rendermi conto che la mia mente tende a cancellare alcune persone o fatti che nel loro piccolo sono stati negativi per me e per la mia vita. Gli aiutanti, loro sì che devono essere ricordati e portati sempre con me. Euro lo definirei il mio aiutante, in tutto e per tutto. Euro è un signore che ha fatto tante cose nella vita, ne ha provate tante e forse ancora oggi non ha trovato la sua strada, sa quello che vuole fare, lo ha ben chiaro in testa però, per tanti motivi, si sa che non è sempre possibile fare quello che si desidera. È sposato con la sua dolce compagna a cui dedica tutta la vita e non ha figli, mi correggo, non ha figli che portino il suo stesso cognome, io e mia sorella Flavia ci ha considerate da sempre sue figlie perché sin dove arriva il ricordo, la sua figura si è imposta in maniera prepotente quasi come sostituto di mio padre per tanti piccoli aspetti. Quando ero piccola questa figura non la accettavo perché la vedevo troppo invadente, cercava di entrare in ambiti e affari che secondo me non erano quelli che gli competevano, e, sebbene si sia reso conto di questa mia iniziale ostilità, ha sempre continuato ad essere presente nella nostra vita, nella crescita e nei consigli, e io ero sempre ostile nei suoi confronti. Poi è iniziata ad apparire un po’ di consapevolezza in me, e capisco di esser cresciuta quando ho iniziato a cercarli i suoi consigli e le sue opinioni sincere. La cosa che mi fa più piacere, e mi fa essere quasi orgogliosa di avere a fianco una persona simile, è che ha sempre continuato ad esserci nella mia vita anche se io mi dimostravo una persona indifferente, le sue parole mi entravano da un orecchio e mi uscivano da un altro. È l’aiutante di cui tutte le persone come me hanno bisogno. Quando c’è un problema, ecco che mi chiudo e immagazzino le angosce. Lui capisce ancor prima di me se c’è qualcosa che non va, e anche se non vuoi parlare lui ti obbliga a un dialogo, anche se alla fine rischia di essere un monologo perché la mia testardaggine quando scende in campo non si placa facilmente. Ma lui continua a parlare, sa che ascolto. È la persona che sa sempre cosa dire, e che può darti una mano quando ne hai bisogno e quando non hai il coraggio per chiedere aiuto. Lui crede in me, anche se ho commesso vari errori, ho sempre sentito il suo appoggio, sempre. Credo che chiunque nella vita abbia bisogno di una persona così, una persona che va oltre la figura di un genitore perché non 112 essendo tale, vede le cose da fuori e so che se mio padre dice una cosa e la stessa la ripete Euro…. è della parola di Euro che mi fido. Trovare una persona che è al di fuori dell'ambito familiare che però ti sta dietro in questo modo è importante e dunque penso che tante cose ho imparato da lui. Prima tra tutte è la riflessione.. anche se poi non sempre è stata messa in pratica. La carriera scolastica di Silvia non sarebbe stata la stessa senza di lui, senza una persona che ha provato tante cose e che può permettersi di volere per me il meglio e soprattutto tutto ciò che non ha avuto lui perché magari privo di qualcuno che stesse sempre li dietro a ricordargli che di vita ce n’è una sola e che quindi non va sprecata dietro cose apparentemente importanti, ma in fin dei conti inutili. È sempre pronto a ricordarci : “mi raccomando, non perdete tempo! Selezionate le cose che sono utili, per le quali bisogna dedicare un po' più di tempo e fare sacrifici”. Mamma ovviamente ripete le stesse cose, ogni giorno, però la mente umana è strana si sa, e sentirselo dire da una persona che ha studiato e che quindi sa cosa significa studiare ti fa fermare un attimo di più a riflettere, ripenso alle sue parole nei momenti difficili ed ecco che mi sento una marcia in più. Per me lui è anche una figura in più, insieme a quella dei miei genitori da non deludere, una persona in più a cui devo dare soddisfazione….anche se alla fine dovrebbe bastarmi pensare che è la mia di soddisfazione e che tutto ciò che faccio è solo per me, in futuro non ci sarà sempre qualcuno che mi darà la spinta per andare avanti. Sentire questi 21 anni miei, significa anche capire che, nel corso degli anni, molte scelte e comportamenti che si facevano perché qualcuno ci obbligava e ci indirizzava verso il meglio, oggi le continuo a fare perché lo scelgo io, perché ho condiviso l’insegnamento che mi è stato regalato. Certo, l’adolescenza ha colpito anche me, sebbene dietro avessi sempre qualcuno pronto a dirmi che ero ridicola, che non aveva senso quello che dicevo o facevo, purtroppo in quei due tre anni il cervello è sotto incubatrice, pronto per nascere sotto nuova vita. Non credo di aver commesso grandi errori sotto assuefazione di questo male giovanile, era solo molto diverso il mio modo di reagire agli eventi e di rapportarmi con questi. Sentirsi in continua lotta con il mondo è dura, si crede che non c’è nessuno che possa capirti e aiutarti quando siamo noi stessi che non vogliamo farci aiutare perché ce ne stiamo al di sopra di qualsiasi razionalità. Oggi come oggi non so come sarebbe stata la mia adolescenza con dei genitori diversi, senza Euro, e senza aver avuto delle sbarre davanti a me che mi potessero impedire di commettere errori. Evidentemente loro sapevano che a me servivano quei limiti. Nel frattempo però non credo di essere mai stata una persona inconsapevole, la nebbia nel cervello c’è stata, ma sicuramente è stata meno fitta di molte altre persone, e poi è andata via, aiutata dalle nuove compagnie al liceo. È 113 inutile negarlo, è l’ambiente che ci circonda che può renderci migliori, ma anche provocare molti problemi ovviamente. Quello che noi siamo nessuno ce lo porterà via ma, durante un’età in cui siamo carenti di uno spirito forgiato, basta poco per deviare la nostra persona. Come sarebbe stata Silvia oggi se fosse cresciuta con persone diverse? Non penso di poter stare con persone diverse da quelle con cui sto ora. Esser cresciuta significa anche stare con le persone con cui scelgo di stare. Fino ad una certa età mi rendo conto di esser stata in compagnia di persone che la vita mi aveva messo di fronte, la scuola ti fa stringere amicizie quasi per forza, sei portato naturalmente a condividere la vita con loro. È anche la paura di restare da soli, di non avere nessuno con cui uscire quando si vuole staccare la spina che porta a condividere la vita anche con chi la vede nel modo opposto al tuo. Ma poi l’importante è sapersi staccare, quando capisci che sono solo le poche ore quotidiane che ti accomunano, e nel frattempo c’è chi cresce e chi invece rimane allo stesso punto di quando si era alla scuola media, ecco che le strade si devono dividere se non si vuole rimanere ancorati ad un passato poco spontaneo. Ho trascorso la fase centrale della mia adolescenza forse con le persone sbagliate, senza i limiti che mi imponevano i miei genitori e senza i problemi che mi ponevo io stessa, la paura di restare soli a 14 anni ti può anche portare a mettere una maschera e tenerla con te anche la notte, poi però per fortuna ho capito che era meglio stare da soli che continuare a stare con persone che non ammiri e che consideri fuori luogo. A 21 anni voglio continuare a scegliere con chi passare il mio tempo libero, posso permettermelo e me lo merito perché è con quelle persone che voglio rapportarmi e crescere. Voglio vicino persone da cui posso imparare cose nuove, grazie alle quali posso migliorare e vedere la vita sotto vari punti di vista. Non basta solo la famiglia per superare certi momenti o per condividere le piccole gioie quotidiane. Se sono scappata dal disastro adolescenziale però, non è solo grazie alle nuove amicizie e alla mia voglia di uscirne viva, sin dal liceo infatti, durante le vacanze estive, nei mesi di luglio e agosto, invece che andare in vacanza o passare giorni interi al mare spensieratamente ho sempre lavorato. Con l’esempio di mia cugina Laura, i miei genitori mi iniziarono a questa esperienza molto presto, in un bar vicino casa. Da allora, se questa esperienza è iniziata un po’ forzatamente, oggi per me è diventata indispensabile e insostituibile. Ho usato due aggettivi così forti forse per auto convincermi che credo in quello che faccio, ma in realtà non posso negare che mi pesa essere una persona responsabile. Ho lavorato più per coltivare i doveri nella mia vita , non i doveri verso una persona in particolare, e riconosco che una persona più ribelle, con un carattere più forte avrebbe forse fatto qualcosa di diverso, magari si 114 sarebbe imposta contro quel suggerimento e avrebbe passato tutte le estati a riposarsi e non far niente, proprio come quando ero piccola. Ho sempre saputo riconoscere ciò che è possibile fare, e ciò che non lo è, ciò che si deve, e ciò che non è necessario fare. Questo mio atteggiamento, un po’ duro direi, mi ha portato anche a vivere da lontano i miei sogni, i desideri, perché c’era sempre qualcosa di più concreto da portare avanti. Ecco quindi che piuttosto che non averne per niente, ho cambiato l’oggetto dei miei sogni, non ho sogni che possono avere mille miei coetanei, come quello di fare una vacanza in Grecia o di avere un auto nuova, i miei sono desideri molto più concreti, come quello di arrivare un giorno alla laurea, consapevole di aver fatto la scelta giusta. Una volta concluso il liceo infatti già sapevo che il sogno che si faceva sentire dentro di me era poco concreto, la mia passione per l’insegnamento mi avrebbe portato poco lontano, ho scelto quindi un settore diverso e non rimpiango di aver fatto quella scelta. La lettura, la scrittura, i poeti eterni e i loro messaggi, ho deciso di continuare a tenerli con me, in modo strettamente personale, e coltivare questa passione la sera, se possibile, dopo aver studiato come si calcola il rendimento di un’obbligazione. Non avevo mai fatto nulla prima dell’università che potesse avvicinarsi all’economia, ma la mia scelta è stata proprio questa. Insieme ai consigli di mio padre, che non ho mai preso per buoni, e a tante riflessioni mie ho fatto questo passo verso il vuoto, senza sapere se sarei mai stata capace di trattare con i numeri e non più con le parole. Questa scelta è stata forse la più importante, difficile e paurosa della mia vita. Sapevo sin dall’inizio che avrei potuto scoprire di non essere adatta per quella facoltà e a quel punto avrei dovuto rivedere tutte le mie scelte e rimescolare le carte. Io credo molto nelle situazioni casuali che ci troviamo davanti nel corso della vita, e proprio l’estate in cui avrei dovuto fare questa scelta, mentre lavoravo alla SADAM, mi è capitato di incontrare quattro persone, due che facevano la facoltà di Economia e due Lettere. Ebbene sì, le due letterate avevano la passione nel cuore ma erano disoccupate, in attesa di deviare verso strade alternative, i due economisti avevano un futuro meno precario e sembravano soddisfatti, forse c’è stata anche l’autoconvinzione, però sembrava che tutto quello che mi succedeva intorno in quel periodo in cui avevo bisogno di un pizzico di coraggio per firmare l’iscrizione mi portava verso quella strada. Ecco che la titubanza-paura si è trasformata in decisione e curiosità, nonché voglia di cominciare questa nuova vita!!!!! Ad oggi, sono passati tre anni, e il mio bilancio (anche il mio vocabolario è diventato economista) è positivo. Lo ammetto, l’anno scorso non so se avrei dato questo stesso giudizio, è stato duro. Il primo è di ambientamento, gli esami sono accessibili per tutti e ti fanno credere che ce la puoi fare. Il secondo anno ti fanno scegliere, continui, o smetti. Molte persone non sono arrivate in terzo perché il secondo anno lascia tutti un po’ provati, qui 115 vengono a concentrarsi le materie più importanti e gli studenti vengono sottoposti alla selezione naturale darwiniana. Molti pomeriggi sopra i libri e molte notti sono stata presa dallo sconforto perché studiavo e, ahimè, mi rendevo conto che gli esami si stavano accavallando e basta che ne rimandi uno e magicamente diventano 3, 4, 5 quelli che devi lasciare indietro. Poi vedevo che c’era chi trovava difficoltà come me, ma c’era anche chi ne usciva meglio. Io ho conosciuto i miei limiti in questi anni, l’unica cosa su cui potevo contare era il mio metodo di studio da liceale, gli altri avevano altre cose, nozioni degli anni passati, ma non mi sono lasciata abbattere. Non mi laurererò in tre anni, ce ne vorrà uno, magari due in più, però quello che conta per me è arrivare alla fine, e non mollare prima. Sarebbe la sconfitta più grande della mia vita. Oggi come oggi preferisco arrivare un po’ dopo ..ma arrivare ed essere felice di quello che faccio. Sono passata da uno stadio in cui non capivo quello che studiavo, ad uno in cui sono curiosa di sapere quello di cui tratterà la prossima materia, sapendo però che troverò sempre difficoltà e che dovrò metterci il doppio dell’impegno che ci mette un altro studente. Ma non importa. Quando hai un obbiettivo dinanzi a te si deve iniziare a non far caso a troppi dettagli negativi altrimenti ci si ferma in mezzo alla strada. Il mio cammino verso questo terzo anno, in cui sono serena e positiva, non sarebbe stato lo stesso senza tre anni di esperienza fuori casa, seppur a soli 50 km da Casa. Vivere a Macerata, nel nostro fantastico appartamento nel centro storico, a due passi da tutto ciò che un universitario ha bisogno, 5 giorni su 7 da sola, con le tue migliori amiche, è bellissimo. Il primo anno ci si trova un po’ spaesati, è tutto nuovo, anche un paese di 50.000 abitanti ti sembra una metropoli ed ecco che ci si perde anche dentro un centro storico così piccolo, ma anche cosi incantevole. Il primo anno fuori casa, senza i genitori, senza nessuno che ti prepara la cena, che ti dice cosa e come fare il pranzo, qualcuno che ti controlli e abbia cura di te. Ebbene si, il primo anno è questo. C’è la paura e il timore di queste novità ma c’è anche la curiosità e la sensazione che non basti mai il tempo per vedere cose nuove, conoscere gente nuova e uscire la sera. Passa troppo velocemente il primo anno di università, e già hai voglia di iniziare quello successivo, rivedere l’argentino dentro al suo alimentari di 20 metri quadri, la barista sotto casa e la “vecchia” che si affaccia per controllare chi viene a trovare queste quattro ragazze. Nel secondo anno accade una cosa importantissima, capisci che quelle che vivi dentro quell’appartamento sono le tue abitudini, e non quelle imposte da un genitore. Ecco che diventi padrona della tua vita, è stupendo sentirti te stessa e capire che senza qualcuno che vigila su di te sei una 116 persona normale, civile e responsabile, e allora pensi dentro di te che evidentemente quella che chiamano educazione, gli insegnamenti esistono sul serio e vengono fuori proprio quando ci si sente meno controllati. Le case degli universitari sono famose per le sorprese che si trovano sotto i letti, per le cucine disordinate e incrostate, per i frigoriferi che proliferano di batteri e soprattutto.. muri affumicati e stanze puzzolenti. Il nostro holbaum giallo.. l’esempio supremo di pulizia e ordine (escludendo quei giorni che precedono gli esami o dopo una cena tra amici) !! chiunque è entrato in casa nostra ha capito come fare per sprecare quattro euro in cartolibreria, un pacchetto intero di post it colorati attaccati in giro per casa, in ogni stanza, con le rispettive regole !!! Il bagno… chiunque entrava lì si trovava spaesato nel dover rispettare ben cinque regole solo per lavarsi le mani. Non sarebbe possibile vivere serenamente e civilmente senza regole, ecco perche sono state inventate, queste ci hanno evitato quei tipici litigi e incomprensioni che caratterizzano ogni casa che si rispetti!! Mai un litigio tra noi, siamo quattro persone sulla stessa lunghezza d’onda, abbiamo condiviso tutto insieme, ma proprio tutto! Le paure, gli esami, le gioie, le uscite, la pasta che si scuoce e il bagno che si attappa. Nel secondo anno nell’olbaum giallo eravamo veramente tanti, io, Irene, Claudia, Rita, la sorella di Claudia e il suo ragazzo, Jim, la persona piu simpatica che io conosca e forse l’uomo che ogni donna vorrebbe al suo fianco. Abbiamo avuto il privilegio di avere anche lui come coinquilino, il coinquilino ideale che ci ha preparato un “american breakfast” con i fiocchi, su quella tavola c’era proprio di tutto, dal dolce al salato, le pupille gustative ringraziano! Ebbene sì, anche sotto il punto di vista culinario abbiamo sfatato quello che si dice sugli universitari, che mangiano solo pizza e pasta. Abbiamo assistito a vere e proprie prove di cucina riuscite in maniera eccelsa. Chiunque ha mangiato da noi mai è andato via affamato o insoddisfatto!! Ovviamente non è che si è vissuto sempre nell’oro, perche questo avrebbe significato tornare a casa con 20 kg in più, però…. il lunedì in particolare era una festa per il nostro frigo, ognuno dopo il fine settimana si portava ciò che era avanzato dalla domenica o quello che le nostre mamme ci preparavano. Scoppiavano sia le dispense che il frigo, la cena del lunedì era un trionfo di piatti misti. Forse non abbiamo mai saputo razionalizzare le scorte perchè poi si arrivava al giovedì sera a mangiare minestrina e un petto di pollo rinsecchito, ma non importa, il lunedì non sarebbe stato lo stesso. Abbiamo festeggiato tutti insieme, in quella casa, due lauree, prima quella di Alessandra poi quella della sorella, Claudia, l’anno dopo. Quella di Ale è stata la laurea di tutti. Tutti abbiamo sofferto con lei per quell’ultimo esame che non arrivava mai, tutti siamo stati in ansia la sera prima del fatidico giorno e insieme abbiamo festeggiato dopo quel meritatissimo 108! Quando si vive insieme accade proprio questo, la vita di chi ti sta accanto è 117 come se fosse anche la tua ed è stato stupendo organizzare tutto per lei, per farla felice. Svegliarsi la mattina alle 5 per cercare un bar aperto per poterle far trovare la mattina una colazione fantastica, quello che ci vuole per affrontare al meglio la fatidica giornata. Tra lauree e cenette arriva purtroppo il terzo e ultimo anno. Quest’anno è stato completamente diverso dai precedenti, ma forse il più bello e quello che ricorderò con più tenerezza. Da una casa di 6, 7, tendenti a 8, persone è diventata una casa di tre amiche. È passata la foga di uscire, di fare tardi. Il terzo anno.... pantofolaie al massimo. Film, film e ancora film hanno scandito le nostre serate. Chiacchierate, la biblioteca vicino casa, il caffè, Acutil fosforo, soap opera, e.. il pensiero che tutto stava per finire, anche solo un minuto a giorno, il pensiero c’è sempre stato quest’anno, e appena ci pensavi, abbracciavi chi ti era vicino per non sprecare nemmeno un minuto di quell’esperienza fantastica. Tutto ciò e molto altro ancora ha reso questi anni di università più piacevoli e spensierati, senza però far mai perdere di vista il proprio obiettivo, quando è finita l’ora di scherzare basta chiudere la porta della camera.. Un abbraccio la mattina appena svegli, uno prima di andare a letto, riscoprire nel proprio carattere quella dolcezza che non si credeva di avere. Le persone che voglio vicino a me sono proprio queste, quelle che sanno tirare fuori da te lati che erano rimasti nascosti e non riuscivano a venire fuori, sia quelli più belli che quelli che era meglio che restavano dove erano. Ma così deve essere. Credo che in questi miei 21 anni l’amicizia sia uno dei valori a cui sto dando più importanza, e che voglio tenere stretto a me, e che custodisco anche gelosamente. L’amore c’è stato, e custodivo anche quello, l’ho custodito per ben quattro anni, anche quando ormai non c’era più nulla da custodire, e continuavo a farlo solo perché ero gelosa di quello che avevo costruito io, da sola, con una persona diversa dalla famiglia. Ma iniziare qualcosa quando non si è ancora maturi, può succedere che nel frattempo si cresce e uno dei due rimane indietro, mentre l’altro va avanti, oppure, semplicemente, si cresce insieme e le strade non riescono più a stare vicine. Come è difficile per me chiudere quel cerchio dell’infanzia, è ancor più difficile chiudere questo cerchio più piccolo. Ho la presunzione di dire di aver vissuto questi ultimi anni in modo molto intenso e anche se oggi o domani mi alzerò la mattina per chiudere quel cerchio definitivamente, e sarò pronta a guardarmi intorno e mai più indietro, dietro un velo di tristezza e delusione sarò comunque felice perché, seppure un po’ più fragile, ho capito come è Silvia. Non mi vergogno di ammettere che non sono mai stata una persona troppo ambiziosa, nella mia scala di valori al primo posto non c’è il lavoro, c’è altro…. sono terribilmente romantica, la vita non va vissuta da soli, e le amicizie non bastano purtroppo. Voglio vivere bene e serenamente, insieme ad un’altra persona. Aver vissuto in un ambiente 118 pieno di nonni, bisnonni e genitori insieme per tutta la vita mi fa desiderare che tutto sia cosi, che tutto non abbia mai fine e che, prima o poi, troverò la persona che sia in grado di essermi vicino nel bene e nel male. Ma questo mio desiderio si scontra spesso con il presente, a volte mi sento un po’ fuori tempo. La scala dei valori oggi so che devo invertirla, per lo meno qualche posizione va rivista. È molto difficile far essere gli uomini e le donne meno individualisti. Eppure io continuo ad illudermi e continuo a sperare. Non voglio arrendermi. Mentirei quindi se dicessi che i miei problemi e le mie paure riguardano solo gli esami, c’è altro che gira intorno a quell’obbiettivo, il mio futuro. E so che a volte lo condiziona molto, ma non sarei mai capace di proibirmi queste sfumature della vita e andare avanti con i paraocchi. Non voglio rinunciare a nulla perché accade nel momento sbagliato, basta bilanciare le cose e cercare di essere sempre pronti a scendere sulla terra. Un quarto d’ora sulle nuvole è concesso a tutti. Il senso del dovere non fa parte di me solo quando si tratta del lavoro. So cosa può deviare il mio cammino, Euro me l’ha spiegato mille volte e se non sarò in grado di riconoscerlo io, c’è sempre qualcun altro che mi farà aprire gli occhi o, nel peggiore dei casi, ci sbatterò la testa e riconoscerò da sola che quel muro era assai duro. Passare un esame è bello, sono soddisfatta ogni volta che succede ma.. ci sono cose che ti fanno sentire un pochino più viva, e credo che valga la pena accettare di provare altri tipi di emozioni, anche se durano poco o addirittura pochissimo. Mi fa paura sbagliare ma.. sembra che ci piacciono quei piccoli sbagli quotidiani. L’importante è avere sempre qualcuno pronto a consigliarti e riportarti con mano sulla strada giusta. Non consiglierò mai a nessuno “fai quello che ti piace adesso, vivi al momento”, non ha senso consigliare a qualcuno ciò che lui stesso vorrebbe sentirsi dire, voglio sempre dare il consiglio che credo più giusto, anche se difficile. Per ottenere i risultati migliori bisogna nella maggior parte delle volte sacrificarsi, ad esempio per fare un esame migliore. Ma non per forza si devono fare sacrifici perché si avrà un riscontro nel breve termine. Anche fare un lavoro stancante e poco retribuito può portare insegnamenti per il futuro. Mi capita spesso di fare, durante l’inverno, la baby sitter, ho sempre guadagnato pochissimo e magari avrei potuto usare quelle ore per uscire. Però ho imparato come stare con i bambini, cosa significa, e di quante cose hanno bisogno. La formazione è facilmente applicabile, a meno che la persona non sia debole di carattere, faccia le cose in maniera molto superficiale, questa è una cosa insita nella persona. Fare oggi quello che domani ti aiuterà, porterà un vantaggio a livello affettivo, ma anche a livello pratico, tecnico, troverà un riscontro. Dopo cena uscire o studiare? Scelgo studiare, perché uscire lo posso fare domani. C’è il duello dovere – piacere. Il piacere non può sempre 119 avere la meglio, anche perché il piacere è effimero. Io stessa ho ripensato ai momenti con le amiche, alla spensieratezza, ma poi ritorno sulla terra quando si tratta di scegliere, quando in ballo c’è il mio obiettivo. Mai perdere di vista l’obiettivo. Ricordo che la Silvia liceale vedeva dinanzi a sè solo il desiderio di realizzarsi nell’ambito lavorativo, e addirittura di vivere all’estero. Sentivo questa città troppo stretta, e un desiderio che ho sempre avuto è quello di stare un po’ di tempo a Londra. In un diario di otto anni fa c’era già scritto questo desiderio di visitare Londra, forse perché l’inglese è la prima lingua che ho studiato, e per racconti che ho sentito da amici che ci sono stati. Oggi penso che potrei farlo, una volta conclusa la triennale, vorrei conciliare il mio desiderio di stare qui con quello di fare più esperienze, e ritornare a casa consapevole che non c’è posto migliore. Non sarà facile perché non troverò appoggio dai miei genitori, per il tenore di vita molto più costoso e anche per la preoccupazione, loro sono preoccupati anche quando sono a Macerata! E forse sarei un ostacolo io stessa per me, non sono abituata, anche all’Università sono andata con qualcuno che conoscevo. Avrei molta paura, dovrei fare i conti con me stessa, se poi tu vuoi stare bene lì ce la fai, se vuoi farti vincere dalla paura, torni a casa. A 21 anni voglio raccontare anche del posto in cui vorrei tanto vivere il resto degli anni, sento il dovere di ricordarlo perché quando ancora non tutto è chiaro in testa, vorresti scappare e cercare un posto per te lontano da dove sei nata. Fermo. Ha la particolarità di essere un territorio arretrato, non ci sono molte differenze rispetto a dieci anni fa, anche dal punto di vista urbanistico, lo ricordo adesso come 10 anni fa. A livello globale il mio giudizio è negativo, se faccio paragoni con altre situazioni, però a me piace tanto e spero di restare a vivere qui. Tutte le altre città che ho avuto la possibilità di visitare e rimanerci un po’, come Milano o Roma, mi hanno fatto apprezzare ciò che trovo qui, a casa mia. Qualche anno fa avrei detto “ma che palle, sempre tutto uguale…”, più giovane, più attaccata alle novità, dicevo “no, non resterò mai qui”, poi mi sono resa conto che in città non trovi l’identità, quando sei per strada sei sballottato, non ragioni. In futuro vorrei restare qui, anche se è una realtà molto semplice, forse ti rende ingenua perché non fa emergere il lato del carattere più combattivo. A Bologna mi è successo che qualcuno mi ha puntato un coltello per avere i soldi e io non sapevo come reagire, spaesata, non sapevo come fare per affrontare. E del quartiere racconterei le feste, le sagre, dove persone di tutte le età portano avanti un’identità culturale. Ad esempio la sagra della polenta, esiste da 12 anni, la sento mia perché è vicino a casa, altra gente non ci si ritrova in questo, non la conosce, non l’ha vissuta. Poi racconterei il palio 120 perché accomuna ogni fermano che si rispetti, infatti è anche un’attrazione turistica, ma per me, spontaneamente, se dovessi scegliere, racconterei la sagra. Scrivere di Silvia è stato più difficile di quanto pensassi, è stata dura, ma è anche stata un’occasione per pensare, il cervello mi porta sempre a ricordare ciò che più mi fa comodo, senza cogliere gli aspetti che potrebbero mettere molte cose in discussione. Invece raccontarsi con stimoli ben specifici, seguendo un filo logico, mi ha fatto rivivere tutto quello che c’è stato sino ad ora, anche gli spazi più nascosti, è stato un modo per poter raccontarmi, non solo agli altri, ma soprattutto a me stessa. La riflessione interiore è meno possibile nelle situazioni più comuni, come una chiacchierata con un’amica, dove si filtrano le cose soprattutto quando sappiamo che chi abbiamo di fronte non è molto disposto o capace di ascoltare. Tanto è vero che mi successe di conoscere una persona in treno e di averle raccontato in due ore molte più cose di quante ne avessi raccontate ad una persona fidata. Esternare i pensieri e rendere visibili certe emozioni mi ha dato consapevolezza del perché oggi sono cosi, del motivo per cui rimango male per molte cose nella vita, per quali motivi ho paura del domani. Ma soprattutto, leggendomi di nuovo, mi accorgo che non è giusto che abbia tante paure, tanti pensieri negativi e pessimisti. A 21 anni, il mio sarebbe dovuto essere un racconto di spensieratezza, di novità, di sorprese e di voglia di crescere. Ci sono pochi sogni, e quelli ci sono sembra che siano sogni doverosi. Oggi, allora, me lo do da sola un consiglio: solo se i miei sogni saranno belli e se crederò in questi, potrò dire di essere padrona del mio futuro. Come immagine del mio futuro vedevo una strada grigia, diritta senza molte curve, ai lati niente e niente orizzonte, l’importante è che sia diritta! Ma, diamine, un po’ di colore ci vuole!!!!! Voglio tanto prato intorno alla strada, con tante margherite e tulipani!!!!! 121
Scarica