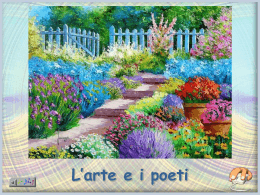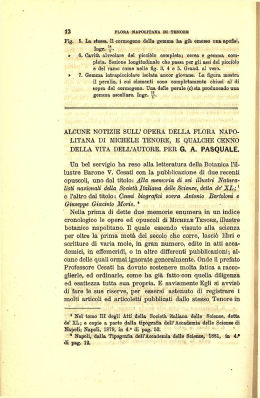Place Vendôme (15) ANCORA TENORI E POETI: FINO ALL’ULTIMO DO DI PETTO Una caustica risposta epistolare ad un illustre critico innominato. Poi la piazza si riempie di grandi voci d’opera, svariando per lungo un gremitissimo catalogo che va dal leggendario Giacomo Lauri-Volpi ai fasti (e nefasti) del trio Pavarotti-DomingoCarreras. Il sistema delle terne si potrebbe applicare anche alle voci poetiche: Ungaretti-Montale-Cardarelli oppure Sanguineti-Giuliani-Balestrini. Ma lo “Zanz’8” con chi metterlo? Sarà uno “Zanz’8 e ½”? (Del resto con Fellini ci collaborò). ________________________________________________________________________________ di Marzio Pieri Saltem vos, amici mei. Tenete spente le luci stanotte, notte stelle non dileguate. Fra tre ore debbo far addormentare la mia Gatta. Metto in una giornea quindici anni di amore e di scoperte e di fedeltà, ben sapendo fin da principio che sarebbe stata l’ultima volta. Certi credenti dicono che così è idolatria. Ma non sanno nulla. Se sapessero non sarebbero ‘credenti’ e non direbbero di queste cazzate. Se questo è un ‘vincerò’, è come un Cabaret schoenberghiano. A luci spente, stanotte, ascoltate i passi della Micia che torna al suo paradiso. L’ultima delle notti che siamo usciti insieme, pioveva ma lei chiese di non sottrarsi al nostro uso della passeggiate, fra il giardinetto condominiale e gli alberi che a Reggio resistono più che in altre città che ho conosciuto. Si mise al riparo di certe fronde, io stavo allo scoperto con un cappuccio calato da sembrare il Nocchilìa. Ma le gocce d’una pioggia calduccina e greve certo la riportavano all’inizio della sua vita fra i boschi e i campi d’Appennino donde aveva imposto che la menassimo con noi. Certo non sarebbe sopravvissuta all’inverno, in quell’infame borgo dove scontai le pene di un paio di fughe dalla caldana estiva. Quando entrò nella casa di Parma sembrò che la conoscesse da sempre. Io ne sono convinto. Solo i Gatti appartengono all’eterno. Gli altri, i fondatori di religioni, i loro rappresentanti pessimi e fattucchieri, non sono che una truffa, un millantato credito. (8.x.2010) Volete che vi parli di poeti? Parlerò prima di tenori. Riprendo qualche notte più avanti. L’ultima notte della mia Gattona è stata tremenda; non poteva toccare cibo da trenta giorni. Solo qualche gocciolina d’acqua. Quando il veleno iniettatole ebbe fatto il suo rapido effetto, dal nasino e dalla bocca, coi suoi baffi ancora superbi, piovve una fonte liquida che invano la veterinaria pietosa cercava di asciugare. Pure dormiente per anestesia, la mia Gatta seguitava a guardarmi, finché gli occhi non le si invetriarono e mi guardava ancora. L’ho tradita, lasciata sola nel suo viaggio, lei che non era Laura e senza di me non poteva stare. *** Poeti, tenori; e critici. A casa mi aspettavano due lettere di aggressione: una, non mascherata, di tre consiglieri del condominio copertisi di ridicolo in un loro goffo tentativo di avvalersi del piccolo, quasi simbolico ruolo alle spalle della nostra ingenuità. Hanno avuto la loro. Ma questa me l’aspettavo. (Dieci giorni dopo hanno mosso un avvocaticchio e ho pianto sul degrado, un sindaco di Parma diceva solennemente dègrado!, dell’arte di Cicerone). L’altra, del tutto a sorpresa, di un illustre critico giornaliero, uno dei tre più attivi e più poderosi dell’età che lascio, ― questa più insidiosa, dico la lettera (l’età va da sé, che la ritengo pessima) a rimproverarmi di mie passate colpe. Non pubblico certo una lettera privata e non svelerò nemmeno sotto tortura il nome del chiarissimo mittente, ma i suoi richiami hanno il tono magistrevole di certi conduttori televisivi, che solo loro sanno le maniere, e costituiscono un fatto di costume che mi pare utile far tralucere ai lettori di questa piazza, così buia, così buia, visto che di essa, nella missiva del resto benevolentissima, si tratta. Ma non fate pettegolezzi. Ho risposto così, chi creda aggiunga questa mia lettera, e l’enormità di esporla, pure sotto velame, ai miei delitti. L’Innominato non se ne senta leso; intanto ombra lo copre (sia reso omaggio almeno alla mia sullodata discrezione ombrellara) e poi potrà rallegrarsi che la lettera sua abbia in me mosso l’idea che il caso, nella sua esiguità tuttavia esemplare, non si fondesse nel giro breve di uno scambio, di un botta-e-risposta, privato. Caro ..., che onore: e che fortuna: e che piacere (ricevere una lettera con francobollo anziché una odiosa telefonata). C’è una lettera di Verdi, mi pare dei tempi dell’Aida: “Che un critico come Filippo Filippi mi scriva...”. F. F. era il più autorevole e severo critico musicale dei tempi della Scapigliatura. Io potrei esordire lo stesso, con te, per questa tua lettera. Stamani ho dovuto far uccidere la mia Gattona, un amore da 15 anni, dunque perdonerai la brevità un poco tranciante nel rispondere. Non ho il pollice della verità, dunque la mia opinione sfavorevole sulla “Parola plurale” [una antologia di 64 poeti italiani fra due secoli edita cinque anni fa dall’ottimo luca sossella editore e, mettendo avanti le mani, faccio notare che così, con iniziali minuscole, luca sossella scrive il proprio nome, il che mi è caro, ché lo faccio anch’io; e voglio anche sia chiaro che degli otto compilatori, da Alfano a Cortellessa, da Cecilia Minciacchi a Zublena, non potrei avere altro che stima, ché nel nostro lavoro discrepanza di opinioni non è disistima, e il dichiararla, anzi, piuttosto stima, [o gran bontà di cavalieri antichi] è opinione di critico, e che critico!, lo sai, ― bizzoso, ignorante, insondabile, imbrianattato, ― soggetta ad errore; se sbaglio io, meglio per tutti gli altri. Il giudizio nacque, non preordinatamente, quando ebbi il libro e mi ci addentrai; forse furono certe presenze, certe autorità precoci, certe pastette fra poeta e rappresentante del poeta. V’era forse del nuovo, ma a me sfuggì, coperto da quella che a me pare una coltre molto greve, molto grigia di costanza nelle abitudini, nella prassi d’indagine a libertà vigilata. Sossella [scritto da me] minuscolo? Mi verrebbe voglia di scherzare. Esco da una full immersion nel Pulci nel Morgante e nel Cyriffo e me ne è rimaso il vezzo di scrivere perloppiù i nomi in minuscole e, talora, in maiuscole, indifferentemente. Alla stessa maniera ricorre ora troppo spesso nella mia ortografia l’errore di scrivere: inpresa, inportante, come: anchora inparo. Fra venti giorni vado in pensione e smetto di fare danni col mio cattivo esempio agli studenti. E riimparo l’ortografia se solo posso. O potrei dirti: scherzavo sul nome (s’oss’ella; s.o.s.-sella, ovvero aiuto ai poeti che non sanno che non sanno che non sanno cavalcar; come nei lancieri del bengala). Ma forse hai dimenticato che io mi firmo, quando non mi tradisca il proto: marzio pieri. Per fano, immagini male [immaginando che fosse un refuso un mio fano delle vanità; anziché falò]; intendendosi proprio fano, tempietto: ed era una rete tesa per chi vi inciampasse, come vedi ti è capitato. Io ho inciampato sul fatto della data (dal 1945 in poi [ossia l’antologia in tiro dichiarava programmaticamente di includere poeti solo nati da quella data, o dato, in avanti]). Il tempo è una cosa per me delicatissima e tenersi a quello anagrafico, burocratico, per me è un partire su basi sbagliate. Allora vidi e mi irritai; aprij le coscie [dico del libro, honny soit qui mal y pense; avevo scritto che l’antologia apriva le coscie a cani e porci e l’Insigne castigatore aveva avuto facile gioco nel rimproverarmi l’“innecessaria volgarità tremendista (proprio da Ardengo Boreo)” della metafora e aggiunto il necessario sarcasmo che “se io avessi voluto schiudere le coscie di P.P.”, mi sarei reso edotto della stanga temporale di cui sopra] e le richiusi; poi mi ero dimenticato e chiedo scusa. Metti [fosse stata fissata] la data 1940: io mi troverei, per due o tre mesi, separato da coetanei e amici fraterni come Nanni Cagnone o Franco Cardini. Una stronzata. Vedi che non uso solo lo stile lemmonio; in realtà finora mi davano carico (fin dai tempi dell’università) di essere papiniano. Lemmonio scrive meglio (‘è un dono...’) ma io sto con Papini. Qui però l’ho tradito optando per Pierinolapeste; o per il benigni o verdone dei tempi che non si ripetono. I comunisti invecchiano. Altro che cadute di stile [“questa tua caduta di stile (nonché di attenzione) mi ferisce assai”]; l’ultima delle cose che mi abbia preoccupato mai. Le vedo, le vedo; anche nell’uso quotidiano di chi si serve di parole polite e tanto aborrisce dall’ironia che non sa più neanche riconoscerla. Lasciamoci dunque da buoni amici, come siamo o eravamo, e da diversi. Se ho ferito il SOSSELLA, raglio d’asino non sale in cielo e comunque vedi che ha esaurito la tiratura. I miei libri non escono nemmeno dai magazzini. Così s’osserva in me lo contrappasso. L’amico che mi rimprovera ha una marea di lettori; questo significa avercela l’influenza! La giusta causa. Io fui fino dai nastri di partenza un deflusso di natura; per questa via ci si rifugia in una place vendôme dell’immaginazione, notturna, negra, splenetica; e nemmen parigina. Né pari siamo né gina lollobrigida. E come potrei essere pari con uno che mi scrive la tua caduta di stile mi addolora? Io fui fino dai fiocchi d’avviamento una caduta irrefrenata. Non seppi mai usare la stilografica senza sporcarmi le dita e rompere il pennino; ma non c’è stata tastiera (tranne quella del pianoforte) che mi abbia detto di no: dalla erculea macchina da scrivere pre-bellica sulla quale scrissi i miei primi romanzi a sei anni (e dopo il titolo scrivevo: ‘romanzo postumo’, avendolo letto sul frontespizio di certuni romanzi salgariani) alla piccola olivetti lettera, alle eleganti macchine elettriche, docili come una troja ben azzimata, dagli occhi dolcigni (grazie Dino), da una delle quali, presa in prestito, uscì la mia tesi di laurea in due volumi, ai primi computer non personal, impraticabilissimi, a questi tavolieri comodi & banali sui quali muovo ora le dita, non mai state così poco agili. Ho vissuto come dentro un romanzo da cameriere, una capsula da bar periferico, mica stratosferico, una capanna indiana di fuscelli e cacchedipollo; poveri di accadimenti di narrabile spicco, fin troppo fitti di idiosimboli, di regole templari di maniacale eterodossia. Nel mio romanzo uno scrive caduta di stile di cui mi addoloro, esce e si suicida. Come scrisse il troppo colpevolmente umiliato Quasimodo, in uno dei più bei titoli del Novecento? Il falso e il vero verde. M’illumino di vero; ed era ora. Anche il Nobel lo accolse con dignità; e morì fra poeti disperati, ancora dopo tanti anni quando me lo raccontarono, di non averlo potuto salvare. E Verga, nel suo romanzo più bello? La sua vera ossessione è l’essere o non l’essere liberi. Non lo si è quando si è presi in un ingranaggio: quello dell’eros (cui il romanzo che dico si intitola) e quello dell’epos (familiare: dai lupini alla barca Provvidenza, dalla casa del nèspolo alla disgrazia di Lissa, dal rosario dei proverbî alla cognizione della irreparabile estraneità del figliol prodigo alla ostrica Sicilia). Per questo non piglia moglie. Il falso e il vero al verde. “Si udì un colpo di pistola”. Il marchesino Alberti era incapace d’amore ma ricco di stile e di dobloni; educato al Collegio Cicognini: come l’imminente orfano Rapagnetta ‘in’ d’Annunzio. Sellava e cavalcava, discavallava e mutava di sella, come natura vuole, pure ho sempre sentito che era femmina. Lui la moglie e la Duse l’uomo: non è un giudizio di merito, è la constatazione di un rapporto spaziale. Non è morale, è pura geometria. *** Ed eccoci al tenore. È la voce dell’uomo quando è invasa dall’isteria o dall’elegia della femmina. Pensate al nuotare sott’acqua, alle virtù richieste per tenere il fiato fino all’estrema soglia dopo la quale i polmoni scoppiano e si muore. Il paradosso tenorile è che identico rischio e identiche virtù consistono per lui non nel discendere al fondo dell’elemento liquido ma nel salire, ascendere all’elemento aereo, a gara con gli uccelli. Per la voce femminea è naturale (è la vendetta del sesso sulla radicale corporeità di esso). La grande età del tenore va di pari passo con quella del pianoforte. Come questo cresce di protagonismo e di aggressività, invasivo anche nelle piane melodiose di certi andanti lunari, di certi impaludamenti aquatili o estasi stellari, così questo. Rare, prima dell’Ottocento, e del Romanticismo, le grandi, protagonistiche parti tenorili. Dalle Origini dell’Opera e per due secoli, la grande sfida è con la voce sopranile e il cantante riesce competitivo, magari in casi insigni addirittura vittorioso, facendosi donna; sale agli astri, addirittura, patteggiando, negando il proprio sesso, con le forbici del chirurgo. Blocca la muta e resta sul trono dell’Androgino. Quando, nelle musiche del secolo XVIII, si legge: ‘tenore’, di norma ci s’imbatte in tessiture naturali, centrali (quelle che noi attribuiamo, semplicemente, al baritono, come tessitura, non come colore, che nel baritono ottocentesco, e soprattutto in quello verdiano, è l’uomo al naturale, il maschio, lo sposo nobile). Perdurando l’incantesimo, progressivamente sempre più vicino alla sovrastruttura, di un mondo artificiale, prezioso, emblematico, ereditato dal Barocco, una voce così indecorosamente ovvia non eccita certo alle grandi ‘parti’. A fronteggiare la DivaPavonessa (ossia: Circé le Paôn) si fanno avanti prima voci virili baritonali; basta una occhiata alla distribuzione vocale di un’opera esemplare del trapasso dal Barocco al Moderno come il Don Giovanni, per avere una specie di radiogramma della situazione: Don Giovanni è (nei termini attuali) più vicino al baritono che al basso (ma grandi Don Giovanni novecenteschi son stati bassi puri come Ezio Pinza o Nicolaj Ghiaurov; e, valga solo da curiosità, ancora all’inizio dell’Ottocento non erano vietati per principio investimenti della parte, fra le supreme del repertorio, da parte di tenori o di mezzosoprano en travesti); Leporello dovrebbe essere un basso pieno, piuttosto rotondo e potente (male a quelle esecuzioni dell’opera in cui la voce di Don Giovanni, nei pezzi d’insieme, prevalica su quella del suo alter ego; che non deve, comunque, mai ridursi a un impusillamento da baritonino ‘comico’, forse adatto al contadin/Tramaglino fatto cornuto dall’Eroe, Masetto, in coppia con la ‘stellina’ da intermezzo o opera ‘buffa’, Zerlina); il Commendatore (la Statua) è basso profondo: fa parte dell’Universo Allegorico Barocco, ha la voce di Plutone o di Nettuno o di Zoroastro. Don Ottavio è tenore in parte già proiettato, vocalisticamente, verso il futuro; ma, realisticamente, il côté femminile della sua tessitura ha il compito di inoltrare più che un sospetto di scarsa, vanesia, imbraghettata carenza di virilità. Benché oggi abbia prevalso, nel ruolo, la tendenza degli esecutori a farne quant’è possibile un espada intralciato dai lacci degli scarpini d’onore e di retorica feudale. Basta, ed è stata conquista, coi Don Ottavio seminaristi, infiochiti e culani, il personaggio resta, ogni volta successiva, da ridefinire, concertandolo in relazione agli altri tutti quanti. Per le due donne, Anna la Grande Tragica, Elvira l’Avventurosa, si sa che la prima ha bisogno urgentissimo di uno psicanalista; e la seconda di una spolverata, di una camicia di forza. Dietro la prima, una Irraccontabile, Irrappresentabile Storia. Per la seconda, non basterebbe De Foe, con le sue scorridrici dei sottoportici e dei misteri di Londra. Lo aveva capito bene (e non son poi stati in tanti) Otto Klemperer, vecchissimo e con un lobo solo di cervello, nella favolosa, solenne come un rito sacrificale o un funerale vikingo, registrazione londinese applaudita, a suo tempo, dallo stesso Th. W. Adorno. Poi orchestre, cantanti e maestri sarebbero stati anche più perfetti, più ‘filologici’, si perfezionano già da mezzo secolo, ma nel solo rispetto della musica come carriera e mestiere, non della musica figlia prediletta delle Muse. Dicono che il pubblico si sia rarefatto ma non osano chiedersi il perché. Quando ero bambino, non si è mai rintracciata la causa, ero in montagna e mi si gonfiò mostruosamente un ginocchio. Mio padre salì per riportarmi in una Firenze estiva e deserta, si andò da un medico che era malvisto nel rione perché ateo e convivente con una signora; infatti poi dovette scappare, alla faccia della carità cristiana. Ma aveva fatto la guerra; palpò il ginocchio, seppe il da farsi, mi disse due parole per rendermi coraggioso, e incise la tumefazione col bisturi. Ebbi un giorno di febbre a 40 e la mattina dopo già leggevo i fumetti, indimenticabili, di Kansas Kid. Oggi non mi guardano nemmeno, gli occhi fissi sul video del computer; e 90 volte su 10 segue il puntualissimo ‘vada-da’. È capitato che finita la sequenza delle deviazioni uno tornasse, incurato, e col conticino in banca esausto, a bomba. Ben lontano dalla speranza di poter guarire. *** Non vale che io vi racconti in ogni particolare, a rischio oltre tutto di inesattezze o approssimazioni, la storia delle trasformazioni del canto melodrammatico. Basti che dall’universo di Farinelli, il mirabile dei Castrati, ci si collega abbastanza in diretta con quello di Rubini o di Nourrit, complici del rinnovamento teatrale dei Bellini e dei Rossini, il primo non indifferente alla pratica del travesti che l’Ottocento borghese avrebbe poi limitato a qualche ambiguità di paggio o garzoncello; il secondo dichiaratamente nostalgico del mondo surreale dei castrati. Gente come loro non componeva come si lasciano le volontà notarili, ma puntando sulle qualità distintive degli esecutori. Anche quando (sarà un paradosso) non fossero un granché. Lessi d’una volta che Rossini doveva scrivere un’aria per un mezzosoprano balordo, forse una protegée dell’impresario, che aveva fra tutte le altre note, fésse e fusche, una nota soltanto ma quella d’oro. Su quell’oro Rossini costruì la sua aria, e fece il bene della poveretta, che ne ottenne un bel successo, e il proprio, d’avere aggiunto alle altre cose belle una cosa bella. Perfino in questo spiazzo dove, se cedo al sonno, i fantasmi-ricordi mi vengono a tirare per i piedi; dovrò spiegare ai lettori non addetti al melodramma che senso vorrebbe avere questo buscar l’Oriente del Poeta navigando a Occidente, per le Isole del Canto? Intanto, una avvertenza: tra la metà degli anni Cinquanta dello scorsissimo secolo, e non molto più avanti che la fine degli anni Ottanta, ci fu nella cultura occidentale una esplosione dell’Opera. Sarà stato, magari, un patto peloso, un Ribbentrop-Molotov fra Cultura, una dépendance filosoficoletteraria, ed entusiastico antiquariato operistico. Nelle astuzie della storia ci sono anche le doppie (improgrammabili) provenienze, od interferenze: agì la filosofia (e sociologia) della musica di Adorno, imponendo ai lettori informati di non sostare ai Minima moralia; la Musica ‘c’era’. E agì l’effetto Callas, la nera farfalla greca che si bruciò le ali, povera Crista, sulla candela della jet society. Onorata da un bruttissimo film e adolescenziali poesie di Pasolini, sull’orlo di passare al peggior sesso. Ci sono i libri di Arbasino, ci furono Auden, c’è Fernandez. Ascoltare la Beatrice di Tenda cantata dalla Sutherland diventava più distintivo che scazzottarsi per Intolleranza (1960) alla Fenice. Il 13 aprile del 1961 l’opera-manifesto di Nono, che ha lasciato per strada l’ideatore fantastico (e “liberale”) Angelo Maria Ripellino, cade al teatro dove un secolo prima era caduta la Traviata. La formula di Verdi era: puntare su un personaggio per processare una società. Quella di Nono: processare una società ma senza individuazione di personaggio. A meno che il personaggio non fosse lui Nono, l’infante d’oro di una Venezia ancora dogale, ma quel suo primitivismo probabilmente ingenuo e scosceso non era esso stesso un déjà-vu? Viene a mente Gauguin, il Picasso d’Avignone rue Damoiselles. E poi alla Fenice giocava in casa. Dieci anni dopo, una visita di Cacciari lo avrebbe indotto a riporre il costume hawaiano e ad indossare quello del professore americanoide di mistica medievalorientalistica. Va detto (e non mai dimenticato) che lui e la Musica erano tutt’uno; forse per questo non sapeva bene dove trovarla, andando fuori di sé. La rinascita del Barocco (a opera della cantatrice australiana ― e, più tardi, del suo colto marito Richard Bonynge ―; allora, a Venezia, di un regista immenso come Zeffirelli, e battisolfa il Rescigno italo-americano, che sempre con onore si prestava e si presterebbe a operazioni del genere – ossia: ‘il Direttore Scomparso’ ― con la Callas o con la Horne più più pomeridiane) era accaduta, per l’Italia, già in ritardo, sulla Laguna, qualche mese prima. Così si aprivano almeno tre fronti: (i) (ii) quello potremmo dire Scala-Met-Salisburgo di Karajan, [IL REGNO DEGLI ARCHI; E DEL LEGATO] cioè la Conservazione, per spettatori fedeli alla Medusa Mondadori e, per l’ultima volta, a Papini Bacchelli Bontempelli D’Annunzio e Pascarella (e la contesa Tebaldi-Callas è tutta all’interno di questa zona di operazioni, con su i vessilli il Cuore Sanguinante o il Cruento Pugnale); quello Glyndebourne/(leppard)―Aix-en-Provence/(rosbaud) [apre la strada alla Parigi del fenomeno Christie]―Colonia [radio non teatro! la Capella Coloniensis con Leitner, oggi finalmente recuperata anche commercialmente sulla base di sontuosi nastri d’epoca]―Zurigo/(harnoncourt-ponnelle), che non senza interni dissidii e paradossi si sposta dalle parti del Barocco (intendi, da Monteverdi a Mozart) e da strani segnali, intermittenti, finisce per l’aggregare alla eredità del ‘recitar cantando’ e della ‘meraviglia’ lo stesso Wagner, desemantizzato (e debayreuthizzato) [IMPERO DEI VÈNTI; O LO STACCATO]; (iii) e quello della Avanguardia, più occupata a riempire le fosse del ritardo culturale sul Novecento, sul Novecento intiero / misterioso e altero... che non a inventare in assoluto della musica nuova. La musica nuova [POLINESIA DELLA BATTERIA; O IL BIG BANG ] era e sarebbe andata per conto suo, dal jazz (‘selvaggio’ e ‘classico’) al rock delle miriadi sculeggianti al rock progressivo per F.M. (‘felici meno’), dai Beatles (regressivi) a/o John Cage, da stockhausen a jimi hendrix, da pierre henry (Psiche-Rock) a Zappa o Cornelius Cardew, richiedeva due cose difficilissime a trovarsi in rei veritate: o una assoluta ignoranza o una super-cultura. Dove Musica tornava a identificarsi (vedi sopra) con le Muse e non con la tradizione di ‘una’ musica e di ‘certi’ strumenti o riferimenti simbolici. Dove i letterati en titre si arresero alla svelta, volentieri, e a discrezione ― dico raccogliere l’eredità di Finnegan ―, John Cage lo fece per loro, con una costanza che si fece genio. Disatteso dai musicisti che si sentirono mancar la passarella sotto piote. *** Il lettor-letterato ingenuo probabilmente ha l’unico riferimento (dico circa il tenorismo, opus lubionorum maxime) per lui certo nella Tradizione dei Tre Tenori. Reagirà come il cane di Pavlov, secondo che creda di stare dalla parte della ‘gente nuova’ o da quella di ‘color che sanno’. Guardiamoci dentro, a quei concertoni. Confesso che a inventarne l’espediente penso sia stato il manager di Pavarotti; quello di Domingo, che deve avere avi genovesi, forse qualche nipote di Colombo aggregatosi alle frotte dei conquistadores, subodorò l’affare piattoriccomicificco; il povero Carreras, non ricordo le date, ma doveva essersi già trasformato in San Leucemico Miracolato: o stava per farlo. L’Inconscio ne sa sempre una dipiù, e la tremenda malattia servì a coonestare quello che, per un tenore, è perdita più grave che della vita: il perdere la voce. La Terna, dunque, o Trio (come c’era già stato un Trio Lescano) fu un miracolo che funzionasse, nella leggenda delle masse cui se non gliela dài col contagoccie non ritengon neanche la farinatella. Sapete, quell’impasto d’acqua, un po’ di cacio e acqua o latte annacquato sbattuti, che le mamme dell’Italia popolana davano alle figliole pallidicule e troppo nervose. Pavarotti, a quell’epoca, aveva anche lui perduto il meglio della voce: non solo il trono (anche per lui effimero, e un poco pubblicitario, com’era stato per il Corelli lungagnone nella generazione canora precedente) dell’High C (‘il re del do di petto’), ma la ricchezza ginnastica e corporale dell’intera sua gamma. Quella bestia di Domingo, in un disco che voleva buttarla dalla parte della raffinatezza (OPERN~GALA: Lui, Giulini, e l’Orchestra philarmonica di Los Angeles: brutto ed avaro disco, malissimo inciso, col vocione ‘falso’ del tenorissimo nella Bocca degli altoparlanti: e l’orchestra lontana, forse elegante certo mogia-mogia e disinteressata, come del resto The Big Voice, a un minimo di dialettica), insinuò un largo foglio (il disco uscì prima dello scoppio del compact, registrato il novembre del 1980, con un tenore di quarant’anni, come me allora) con una intervista chiaramente preparata ad hoc; sapeva che la voce gli si era mutata, non in meglio. Ma era un caso anomalo (mi viene in mente, in altro tipo di tenorismo, solo il tenore-letterato Giacomo LauriVolpi, la cui leggendaria durata ― cantava ancora a ottant’anni suonati e, con tutte le càccole e gli smottamenti, dava ancora dei punti a quelli venuti anche molto dopo di lui, almeno per conoscenza della retorica melodrammatica, agghiacciante ascesa ad acuti fulminei, magari presi e lasciati, ma alle volte tenuti come stelle filanti, e baldanzoso spicco del dettato in fondo tragicomico dei poeti di libretto ― si dovette sì ― come lui che se n’era andato a vivere in Ispagna, fra preti sgherri e franchisti pervicacemente millantava ― a interventi mariani, mediazioni angeliche, e agnusdei di padre Pio; ma anche di più alla attenzione sagacemente portata alle diverse stagioni di una voce che fu sempre, insieme, la più portentosa probabilmente del secolo, e la più esposta alla stecca. LauriVolpi le chiamava: cedimenti della carne; del resto, come a Caruso, pare gli capitasse, a volte, di sculacciar la compagna di duetto, si désse il caso di lieta giumenta. Dunque, Domingo, nel micidiale dépliant, richiesto dall’intervistatore come andasse... il do di petto; figurarsi, in uno ch’era salito ai ruoli tenorili da una voce (non un animus!) schiettamente baritonale, densa, sonora, e corta: “In realtà [il do acuto] non [mi] è mai venuto facilmente. Adesso viene più facilmente di prima. Ma non mi sono mai vantato di avere un do acuto che venga schiacciando un bottone. Per fortuna la prima cosa che se ne va, nella voce, non è il registro acuto: è quello medio”. Pochi fecero vista di essersi accorti che questo era uno strale lanciato crudelmente al concorrente più temibile, Pavarotti; più ‘anziano’ di qualche anno. I guai, per un tenore come il Luciano da Modena, si erano addensati come nuvoloni scuri dopo uno dei suoi maggiori successi discografici, i Puritani incisi con una compagnia (come dicono) “stellare”, per la Decca, nel 1973, più o meno dopo un decennio di carriera in ascesa internazionale. Qui, verso la conclusione, Pavarotti aveva preso alla lettera una nota della partitura, una nota non da tenore ma da soprano acutissimo, e che i primi tenori, nell’Ottocento, avevano eseguito, si dice, ‘di testa’, i dischi non c’erano ma si pensa a una sorta di falsetto o falsettone ‘rinforzato’. Parve un miracolo, anche se i più noiosi, come me, pur ammirando (e spendendo un patrimonio che non c’era per procurarsi il prima possibile quella scatola di gioia), si interrogavano con qualche perplessità sulla incompatibilità che si produceva, nell’insieme, fra questo funambolesco filologismo e il fraseggiare di Pavarotti, con quella sua voce preziosa in natura (sempre colpevolmente e spiacevolmente ingrossata dai microfoni), un fraseggiare che tirava a ‘O sole mio’. C’era poi la notizia, in controtendenza, del fatto che giovane lui, e giovanissimo il direttore, Riccardo Muti al suo esordio radiofonico in un’opera intera, registrata in presenza del pubblico; nella medesima scena (il concertato di Arturo avviato al supplizio) e senza essersi complicata la vita (Muti certo lo avrebbe fulminato) con osar quella nota astrale (sempre un po’ imbarazzante ad ascoltarsi, tanto simile al lagno di uno cui recidano vigliaccamente i testicoli), era stato lo stesso costretto a fermare l’esecuzione (e, il direttore, l’orchestra) perché anche la nota ‘normale’ gli era andata di traverso. Io lo sapevo; in un superbo Rigoletto del Maggio musicale, una delle ultime opere dirette in teatro da Carlo Maria Giulini, ritenuto allora una specie di... di Grace Kelly o Audrey Hepburn dell’Opera, insomma un arbitro delle eleganze e del pensiero nobile in salsa rotary, il tenore poco più che esordiente ci aveva esposti a una doccia scozzese fra acuti che gli entravano prodigiosi (“La donna è mobile”) e momenti di pre-panico, quando la macchina stupenda andava in tilt anche su tessiture che di solito non metterebbero un tenore ‘normale’ alle corde. Ma la voce era una festa e non si stava a recriminare. Andò, così, che il Pava si avventurò, complice Abbado, in un disco di arie verdiane ‘alternative’, in genere scritte dal Bussetano compiacendo alle pressioni di cantanti superdotati che gli avevano chiesto dei pezzi ‘nuovi’ in cui brillare meglio. Erano sempre sghèi. Il disco ci mise un tempo incredibile a entrare in porto, prevedeva diversi virtuosismi falsetteggianti come quello di Arturo puritano e, quando finalmente la torta fu scodellata in tavola, qualcuno si mise le mani nei capelli. Che Pavarotti era quello? Un Abbado sempre meno convinto (ma erano anni in cui Verdi ancora tirava, io stesso confezionai un pasticcio di lusso per la Electa celebrante) non capì o subì la crisi del tenore; per andare all’insù, il Modenese avea assottigliati i centri e spolpata la carne della voce. Il timbro si era fatto sgradevole e l’accento, un tempo quanto meno baldanzoso, seppur in genere fuori stile (i meglio informati avevano siglato il caso tirando in ballo il nome di Beniamino Gigli, il tenore di “Mamma”; e purtroppo ci ebbero azzeccato), non andava punto perfezionandosi. Per colmo delle disgrazie, c’era anche in ballo un Guglielmo Tell da registrare a Londra; è l’Himalaya del tenorismo. Nella versione italiana e con quello stile, non c’era da presumere una esecuzione antiquariale; e la Decca, per una operazione costosa quanto un Ring di Wagner, cominciò a oscillare nei suoi propositi. La ghiotta occasione di un Tell francese, diretto dal competente Bonynge (Bonynge non è certo mai stato un virtuoso della bacchetta, ma certo era il più preparato per dare un senso non parziale alle molte danze dell’operona), con un Pavarotti ben consigliato nei passi più esposti, confermando il binomio con la Sutherland, fu mancata, forse per beghe nate fra gli artisti auspicabili, e fu chiamato il giovane Chailly, destinato a prove ben altrimenti mature. Diciamo che il ragazzo non aveva una idea che fosse una dell’opera rossiniana. La Casa tentò l’escamotage di una prima registrazione delle parti più salienti del capolavoro, poi parve che la cima fosse a portata di mano e si scalò a oltranza, con mediocre convinzione seppure con nomi importanti meno convinti o scarsamente preparati che mai; i dischi uscirono con in copertina un Füseli, un demonangelo con la balestra visto di sotto dalle palle in sù, che con quel Rossini piuttosto confligge. Va bene, non sono che dischi. *** Povero Pavarotti; intervistato quando ormai doveva avere più che un sospetto del destino che lo attendeva, con la malattia in corpo, disse che sperava che almeno la registrazione del Guglielmo Tell gli sarebbe sopravvissuta. Meglio gli sopravvivano il suo primo recital, la Fille du regiment, la Lucia di Lammermoor, il primo Rigoletto, un incantevole Mefistofele ‘alla Gigli’ che basterebbe da solo a riaprire il caso Boito. Ma intanto lui si era dato alla masse sceme adoranti e, se i due altri tenori rischiavano meno di lui, lui ci giocò tutta la sua reputazione. Divenne un’altra cosa, al teatro cantava sempre meno e non tanto bene, il sorriso furbesco che gli fioriva di mezzo al barbone ogni volta che centrava un acuto o quasi ci faceva pensare: ‘ma non lo pagano per questo?’, e insomma si finiva a vino e tarrallucci. *** Luciano Poveretti; in realtà, il campione dell’ammassamento piccolo-borghese, il ritorno del diopatria-famiglia. Plácido Domingo è lo scudo della intraprendenza capitalista; quando il mercato è saturo di utilitarie, buttiamoci sulle superlusso megaccessoriate. O viceversa: o fai frigoriferi. Il primo è la furbizia di Bertoldo, il tenore messicano un eroe della finanza. Carreras? Un Hidalgo; da giovane scapato (noblesse oblige), poi, da precoce invecchiato, un melanconico memorialista. Ma dei tre, l’unico a non barare. L’Unico. Rinomanza e carriera ‘reale’ lo fermarono Cavaradossi, Don Josè, anche Don Carlos; così bello e virile com’era. Ma il meglio lo diede io credo con un Rossini raro (Otello, Elisabetta d’Inghilterra), con l’Edgardo della Lucia di Lammermoor (andava anche visto, nelle sue entrate ammantellate alla Errol Flynn), con altri Donizetti poco visitati (Roberto Devereux, Maria Stuarda, e specialmente l’eroico Poliuto, riprendendolo dalle mani del nonno, Lauri-Volpi ― la Spagna ci sarà pure entrata qualcosa ―, che non dalle manone del fratello maggiore, Corelli, che sparava gli acuti al fulmicotone ma era come al solito a disagio, incerto su chi fosse e cosa dicesse il Poliuto, salvo tirare bòtte o filare pianissimi fuor di misura; nonno e nipote scoprivano la dorsale corneliana del dramma, Corelli stava fra Pollione e Manrico, che c’entrano poco o nulla). Del resto, certi Verdi, dai Lombardi al Ballo in maschera, dal Trovatore alla Forza del destino, e alla incarnazione di Stiffelio, prete protestante e cornuto, a gara con un Domingo otelleggiante, non lo videro mai soccombente; la voce era carnale ma sapeva farsi come d’un angelo un poco cresciuto. *** Che, coi tenori, si vada per terne? Dopo Caruso/Tamagno/De Lucia: Gigli, Lauri Volpi, Schipa. Oppure, nei teatri specialmente fuori d’Italia, il dotatissimo Martinelli, che Montale rievoca in una delle sue poesie veneziane, con De Muro Lomanto (marito della Toti, l’usignolo, rievocata da Zanzotto) e Giuseppe Lugo (“Vento, vento, portalo via con te”... tutti capivano chi...). O il belga Ansseau, il norvegese Roswaenge, idolo del Führer che di musica se ne imtendeva, il nostro Francesco Merli; gente da Otello, da Trovatore. O Tauber, il preferito di Lehar, Thill, idolo dei francesi, il nostro Pertile; dicitori stupendi. Nel dopoguerra, Del Monaco, Di Stefano e (un poco tardi fiorito) Corelli. O, negli USA, Bjoerling, Tucker, Jean Peerce, che tutti variamente collaborarono con Toscanini. O Poggi, Penno, Campora o Raimondi (Gianni, affogato nelle sue pigrizie bolognesi ma svettante e ‘moderno’). O, anche al cine, Jan Kiepura. Mario Lanza, Ferruccio Tagliavini. E gli sbrana-loggioni, Filippeschi, unico erede dello squillo (ma di quello soltanto) di Lauri-Volpi, Salvarezza (la voce del Trovatore nel film di Carmine Gallone), Annaloro o Formichini o Achille Braschi. E poi Borsò, Labò, Zambon, ras di tutti i teatri di provincia. Mancava solo il tenore Penuria. Negli anni Sessanta, Bergonzi, Vickers, Gedda (si presentano inedite esigenze stilistiche e ‘culturali’). I sicurissimi: Cossutta, robusto, Martinucci, incensurabile, Bonisolli cavallo pazzo (e gli insicuri: Giacomini, Ciannella, Cècchele, che alternavano serate magiche a veri disastri). Dalla Russia Vladimir Atlantov, Otello anche all’arena di Verona (il migliore dopo Del Monaco, sulla linea che non esclude l’atletismo), dall’Ungheria lo squillante musicalissimo Nagy, dalla Slovacchia il solido Dvorsky. Il più dotato sarebbe stato Jaime Aragall, ma gli mancarono nervi e ambizione per competere col prudentissimo Kraus, con l’esuberante Bernabé Marti, che non fu solo el señor Caballé. Poi i Tre Tenori per antonomasia. Nel declino patente di due su tre di essi (come si è visto), una serie frenetica, a cavallo dei due secoli, di false partenze: Chris Merritt, rossiniano, con altre ambizioni (svociato, restò in carriera passando alle più pesanti e incensurabili vocalità proto-novecentesche) e, più rossiniano di lui, Rockwell Blake: meteore. Il tenore Leech; si era fatto un nome in Francia con certi Huguenots affrontati alla spavalda, ma quando venne a Parma se la fece sotto e cantò al risparmio, aiutandosi con grandi sorsate d’acqua fra una nota e l’altra. Il tenore Hadley, bellino e cinematografico, perfetto tipo di newyorkese, cantava Puccini come Strawinskij, quando vide le ombre del tramonto si tirò una fucilata al volto e ci mise dei giorni a morirne. Il dotatissimo Neill Shicoff, russo-americano, attore superbo, capace di dare dei punti allo stesso Domingo, ma frenato da indiscipline, scarsa pieghevolezza della voce pure a prova di màcina, e da un volto occhialuto (come a suo tempo il russo-svedese Gedda) tendente troppo alla burocrazia. Non fecero terna. Oggi, passato Domingo alla chiave di fa (e magari lo avesse fatto da dieci anni, che non gli entrava più neanche un sibemolle), teatri e discografici ci riprovano. Promesse sùbito tramontate, come il maltese Calleja (voce pavarottesca fino ai centri; oltre il passaggio di registro, nulla), o travolte da un fuoco di vita, come Villazon, ch’era apparso proprio l’uomo giusto al momento giusto. Ma oggi un tenore che riesce a far decentemente una Bohème o un Elisir d’amore, pare miracolo! Ai miei giorni si spiavano gli Otelli, gli Arnoldi, gli Arturi... Vacche magre sta bene. Ora che difficilmente l’erculeo Cura, frequentatore di palestre, si riprenderà dalla perdita irreversibile degli acuti (scrisse una volta il Nepote del Gattopardo: “giocare all’italiana sta bene, ma poco serve se non scendi a rete”), ed è gran peccato davvero; ora che il tenore siculo-parigino Alagna piace solo, nazionalisticamente, ai francesi: qui non gli si perdona la tendenza a spingere gli acuti al di sopra della nota esatta, per eccesso d’armonici mal controllato; ora che il tenore Àlvarez riesce a ‘passare’, come Manrico, perfino dal loggione di Parma; ma son dieci anni almeno ch’è in carriera, anche lui: sicuro o quasi e simpatico di certo, ma privo di quel ‘distintivo’ che crea le vere glorie; e che il tenore Vargas, passato dal belcantismo leggero alle batoste verdiane, è sempre più bravo ma non trova la via di una vera e diffusa popolarità, quella che esaurisce i biglietti al solo apparire del nome: le case discografiche scommettono su due estremi polari, il tedesco Kaufmann e l’italiano Grigòlo. Il primo, ottimo attore e con tutto per essere anche un sex-symbol, ma severo e ‘poetico’ una misura in più del consueto (e spazia sul repertorio francese, tedesco con tanto di Wagner, ed italiano); voce che sembra non potersi rompere e ferma intenzione di riportare tutto il repertorio ai modi di canto del Lied, ora che si è scoperto che per cantarlo averci una voce sonora non è affatto vietato. Il secondo, versione gigolò dell’amoroso, quasi un brazzirossano con una vocina intonata, zuccherina; e presentato senza mezzi termini come una sorta di pavarottino. Ma canta quasi tutto, si sente, dopo una indigestione di dischi; e dunque la gelida manina come, sì, Pavarotti, la furtiva lacrima come Tagliavini, la donna è mobile come Bjoerling, ... di quella pira come... Come Bocelli. Perché il tenore nuovo è proprio stato lui. E lo è proprio perché la voce non ha la potenza del tenore lirico in foro et in plàtea, a dirla col pedante Manfurio. Ma l’intonazione è suadente, la tecnica compita, il fraseggio scandito e perfino nobile, mai sdolcinato (tallone d’Achille del Grigolo), il rispetto dei segni puntuale senza pedanteria (ascoltate la sortita di Manrico del Trovatore, “Deserto sulla terra”, con tutti gli abbellimenti prescritti e mai prima ascoltati se non per un altro tenore che preferiva il microfono o il cinema alla scena tonitruante, lo sventurato Schmidt ucciso dalla ottusità svizzera in un campo profughi durante la guerra; e valga lo stesso per l’aria dei “dragoni d’Alcalà”, ugualmente cantata fuori scena, dal Don Josè della Carmen: con tutte le fioriture; o certe frasi di poesia del poeta Chénier secondo Giordano & Illica). Vero, ci vogliono i microfoni in tasca; ma pare che oggi al microfono nessuno dica di no. E poi Bocelli non illude di poter strafare. Grigòlo è un tenore lirico che canta da canzonettista e mi ricorda i vini del MacDonald, stucchevoli: Bocelli un canzonettista che canta la lirica con tutti i mezzi del tenore lirico, tranne la potenza plateale di suono. Decisivo, però, per la mia non nascosta simpatia (i talebani di casa me ne fanno rimprovero, a partir da mia moglie), è che questo cantore popolarissimo si avvale di una strategia in assoluto opposta a quella di Pavarotti. Pavarotti portava le masse al teatro o al disco d’opera per lasciarle sulla loro fame o saziarle di surrogati: distribuiva scatolette; bidoni. Chi amava Dalla o Zucchero si compiaceva di ritrovarseli sul palcoscenico insieme con un (ex-grande) Tenore ma guai se costui declinava da mamma son tanto felice o da un vincerò degradante. Guardate i dischi di Bocelli: sempre direttori illustri o di chiara eccellenza (Mehta, Stephen Mercurio, Chung), sempre compagnie delle migliori che si possano mettere in campo. Non viene in mente la Scala (modello nefasto, da cui urge la liberazione), piuttosto certe cose di Spoleto, o di Firenze, o della Fenice, o del San Carlo di giorni più lieti. Si sentivano tutte alla radio. Magari era la via della perfetta letizia necessaria per veder di riavviare, se si potesse, la macchina della passione melodrammatica, in modi più maturi e anche più umani. Già; ripartendo senza Tradizione. *** Quei lettori che ho seminato per strada, fermo la carrozzella ad aspettarmeli, che risalgano nel vano viaggiatori e s’arrampichino in serpa a farmi compagnia. Sappiano intanto che so bene, che i medesimi ragionari si potrebbero fare sui pianisti (Gieseking-Kempff-Backhaus... Busoni, Casella, Zecchi o Benedetti Michelangeli... Horowitz Rubinstein Van Cliburn... Richter-Gilels-Gould, dal Freddo con Amore... Ashkenazi Pollini Martha Argerich... Brendel Brendel Brendel... il pianismo a brendelli... e Cascioli Bahrami De Maria... tutte le feste la le portavia...), sui giocatori di calcio (per me ce n’è uno solo: Maradona, il Tamagno del football), sui panettoni (Motta, Alemagna, o “Specialità del Fornajo”), sugli scrittori di romanzo (Balzac-Flaubert-Zola... Verga De Roberto Capuana... Gogol Maupassant o Petruccelli della Gattina... Svevo-Moravia-Bacchelli... ProustJoyce-(Thomas, Heinrich und Klaus) Mann... Aragon Soffici Céline... de Amicis-Gotta-Calvino... Hemingway-Steinbeck-Faulkner... de cèspedes bassani umbertoeco... gadda pizzuto testori d’arrigo... Ma fanno 4!!), sulle belle donne da tirassegno (la Garbo, la Marlène e la Claretta, qui si va sull’orrido... gli occhi al cielo della martire cristiana, le calze della p... respectueuse, le mutandine della ducessa, più scapata di Katia Ricciarelli), sui giochi di carte (lo scopone canasta o il solitario? Bellissimo questo) &c &c &c &c &c &c &c &c.... *** E sui poeti. Questi furono, anzi, il modello. Ungaretti Montale Cardarelli; o ci sta meglio Saba? Sanguineti Giuliani Balestrini; o ci starebbe meglio Manganelli? o Ripellino? o lo Zanz’8 / Zanz’8 e 1/2? Col Fellini ci collaborò. Da La Beltà a Pasque, un palmo sopra la testa d’ogn’altro poeta della peninsula, sicuramente. Poi ― nevrosi e arcadia si pagano, anche corrette o viziose d’ironia ― te lo trasformano in un prigioniero del Caucaso o nella maschera di ferro guardata a vista da folkloristi veneti e glossolalisti. Son belle le sue lagrime (‘son Zanzoto... şanşòto...’) ma è un tempo che ha smesso di visitare le nostre notti. Verrebbe voglia di salvarlo, speranza, ancora, di poter salvarlo. Come disse Rossini al tenore che aveva inventato il do-di-petto: ‘entri pure ma lasci quella roba all’attacapanni...’ (Quella roba; i linguisti i glossomani le glosserìe... Hanno fatto lo stesso con quello Zanzotto del Lago Maggiore, minore e sanguigno, il gurgandino Sandro Sinigaglia, trasformato in blackboard da esercizî in corpore vivo per le matricole di Pavia...) In due mesi dall’estate ho ricevuto tanta poesia. Temo che ormai i poeti, che un tempo si celavano riottosi, facciano come i venditori per posta; si trasmettono un indirizzo dall’uno all’altro, ordini un libro d’occasione o per internet e sei perduto. Anche a volersi servire dell’avviso in calce (“se non desidera più ricevere da parte ns. esegua le seguenti esecuzioni...”) passeresti metà della giornata a eliminare eliminare eliminare. Io, di cuore, vorrei anche leggerli tutti e tutti lodarli. Tanta fede in una merce che non dà mercato né gloria se non di retrobottega (mi ricordo, dalla mia infanzia, il poeta Arcidiacono, fiorito come un fungo nelle periferie fiorentine, che andava da mio padre a comprarsi qualche povero capo di vestiario, da pagarsi a rate distanziatissime... ma mio padre era un commerciante sui generis, desiderava i soldi per togliersi le grane i grattacapi le scadebze ― lui, per un lapsus digitale, batteva sempre così: “scadebza”, col b in luogo della enne ― ma di fatto ne aveva paura o ribrezzo, li faceva colare fra le dita tabaccose... So che nell’altro mondo lo ritroverò sulla scia dell’odore di tabacco che ne impregnava i vestiti, il corpo, la fantasticheria). *** Ché poi le strade si incrociano, come si azzuffino. In rei veritate, ogni poeta fa terna da sé; o non vale di leggerlo. Dal mio passato è riemerso Alberto Cappi. Mi arriva un fascicolo di “Testuale” e vedo che è morto da un anno. Si era coetanei. Non ci incontrammo mai, anche se Mantova era a due passi da Parma, e ne apprezzavo la serietà e il rigore rilassato, pudico. Se solo un pochino avessi meritato dal lettore, vorrei si procurasse il Libro dei materiali, allegato all’ultimo numero della rivista di Gio Ferri. “La poesia abita la luce. Dunque è invisibile”. Ne tirino le conseguenze i critici pennajuoli. Credo che il ‘segno’ del poeta sia che ce lo sentiamo due, tre dita al di sopra del capo. E anche rispunta il Roffi bolognese, il cui madrigalismo sembra ricongiungerci ai poeti che scrissero poesia, all’ombra degli Asinelli, al tempo dei Carracci e Guido Reni. Col mio Archivio Barocco ne abbiamo rimessi parecchi a prender aria, come vecchie toghe rispolverate, ma a Bologna nessuno se n’è accorto. In accademia vige: se non lavori non sei nessuno, ma quando sei qualcuno che cosa dovrebbe indurti a lavorare? Basta la damnatio silentii. “Scendendo la scala a cavalcioni della ringhiera ruppi una boccia di vetro che troneggiava in fine alla discesa. Nessuno aveva visto, dunque non ero stato io” (Paul Klee, diario d’infanzia). Da altra, superattiva e quasi frenetica, fornerìa di poeti, quella dell’amico Flavio Ermini, ho in dono L’equivoco del punto, di Gaetano Ciao. Ciao, lo vedo, è classe 1923, dunque che lo minacciano sono i novanta anni. Esterina gli faccia un inchino. Fu dirigente scolastico e ottenne premii ministeriali, due dati che sconforterebbero. Ma è di Eboli e la sosta di Cristo frutta sempre. Si vale di forme assicurate (sonetto o para-sonetto) e di una sottile arte del ‘rubato’ endecasillabico, su spartiti antiquariali e volontieri citatorii per ironia. In limine appare Eraclito, insomma il libro sarà letto con vantaggio di chi, nella poesia, non cerca solo effimeri diletti. Un mio allievo giovane, il modenese Guido Mattia Gallerani (mi vanto di averlo salvato dalla cerchia ‘padana’ dei Bertoni e di simili addetti della provincia), mi presenta, con sua bella prefazione, Colette Nys-Manzura (tradotta da Chiara De Luca, edizioni Kolibris di Bologna) ― Il grido dell’alba: “non poème en prose, ma poème de prose” ― e Pierre Bonnasse (Soif de Soleil/Sete del Sole, traduzione e presentazione del Gallerani e di Roberto Capuano, per il medesimo editore). Il Bonnasse è poeta “d’inspiration maçonnique” (JeanLuc Maxence) piacerà ai patiti di Daumal, di Onofri il Grande (per distinguerlo dal massimo) e, perché no, dell’ultimo, lasciato indecifrato Bigongiari. Siamo pigri e distratti; unica, parca, giustifica, il tempo dei poeti è altro dal nostro, quotidiano. Noi siamo sudditi dell’Orologio. Poi ci sono le interferenze, i ritorni del rimosso o del seppellito: scopro su una bancarella Dal ponte dell’Ariccia di Enrico Tobia, con esso completo, mi sembra, la collezione dei poeti messi insieme da Giorgio Bassani per un Feltrinelli non ancora ‘andato verso la vita’. Gian Carlo Conti Antonio Barolini Paolo Volponi. E se Bassani, nei suoi limiti mai celati di cerchia classicistico-liceale, avesse avuto miglior naso da direttore di collana che non da romanziere? Primum (per lui) andare sul sicuro; ma coi poeti, poi, non si sa mai. Poi ci sono le piccole, non discare famiglie. Che, marinista, io abbia da sempre un debole pe’l manierista torinese Roberto Rossi Precerutti non può sorprendere. L’unica sorpresa, per me, è che questo poeta intrepidamente (ma non sfacciatamente) virtuosista non abbia intero il riconoscimento nazionale che gli compete. Del resto anche il Marino non ce l’ha, prima non lo vedevano affatto, ora si valgono del vario lavoro di una generazione passata o ben ormai provetta (Marziano Guglielminetti, Marie-France Tristan, io stesso, in misura minore seppur con dedizione che sfiora la caricatura) per fare a lui o ai restauratori le piccole pulci. Tiriamo lo sciacquone, Kill All Them, un gesto semplice e l’orizzonte tornerà lucente. Ma, dicevo: ora ricevo versi anche di Giacomo Rossi Precerutti. Il giovane fa tesoro della eccellenza formalista del padre e si muove con agio in una gamma vasta di letture e parole perfette. Ma è la poesia che rende le parole poetiche e sono le parole in se stesse poetiche a rendere il poetico poesia? Sospetto tuttora una mancanza di ironia verso i proprii materiali, da parte del poeta novello, per cui, dotato com’è, parecchie volte pare riportarci ai tempi del quarto o quinto, mai primo!, ermetismo postermetico ― infestissimo ― dei fiorentini. Su questo il puledro, così promettente, dovrà giocare tutte le carte buone; ma il jolly sarà poi, come sa chi sa, la carta cattiva. Il banco salta per il due di briscola. Impossibile dite? Poi qualche sorpresa: l’amico Maurizio Cecchetti, scrittore dei più ricchi di umori anche graziaddio pessimi (è romagnolo, di nascita) che oggi mandino in giro i loro libri (non di poesia!), salva per me un remoto libretto (I vasi) fatto di un breve prefazio (di Giancarlo Bojani) e di xxiv foto a colori di plastiche di terra dell’ottimo artista cesenate Ilario Fioravanti. Il libro (di quasi scheiwilleriana discrezione) uscì a spese dell’autore a Cesena, nel 1988, nei paraggi di una mostra con cui Cecchetti (che di professione è critico d’arte, oltre che anima delle edizioni Medusa) fece scoprire il Fioravanti a Testori. Ora, mi si dice, Fioravanti (ch’è della stessa classe del sunnominato Ciao, nato com’è nel 1922) è riscoperto da molti che volentieri si scordano di Cecchetti, ma è bene essere scordati così. Non si sta sui manifesti ma nelle viscere, come granchi o borborigmi. Il pensiero fa un poco paura ma non è facile un vero che paura non faccia. Solo i poeti della classe più alta lo sanno. Un libro, dunque, di poesia non verbale, non però alla maniera dei post-futuristi o di Gianni Fontana, quando dirama dal suo fondamentale fortilizio della sound poetry tecnologica e, sottosotto, crepuscolare. (Spengler! non marinomoretti). E ci furono altri Novissimi. Sempre una traccia visuale di alto volo si ritrova nell’ultimo libro di Giovanni Tamburelli, Zooarius (Associazione Culturale il Fondaco, Bra, anche editorialmente un libro di rara bellezza) foto di Amedeo Tosi e testo di Gillo Dorfles. Largo ai Giovani! Tre paginette dove respiri una cosa perduta: la Competenza Non Esibita. Con Tamburelli facemmo un libriccino, temo a sue spese, Naturklang (La Finestra editrice) dove commentavo con epigrammi o baci-perugina una sua cartella di mostri e aborti e pesci e tarocchi allegrissimi. L’Occhio è positivo, ottimista (a differenza dell’Orecchio, che si appaga in vaghezze). Feci come il Marino nella Galeria e certo non riuscii all’altezza dell’arte felice cui ero chiamato a dar segni in parole. Ma a volte mi chiedono: ‘non credo di aver capito bene le tue posizioni estetiche generali...’, ebbene lì le ho squadernate con un minimo d’agio e d’umore. Vero è che entrai nell’università dalla porta di servizio (vincitore di concorso per assistente di ruolo di estetica) e dalla porta di servizio ne esco (letteratura generale contemporanea per gli studenti di pedagogia). Quando mi leggerete ne sarò uscito e forse andrò per panchine, tornando a comprare il giornale per compitare l’elenco dei morti del giorno prima. In breve, o cari, in breve. Del resto Tamburelli è anche poeta e, almeno un tempo, non rifuggiva da temi che fanno tremare il pene e i gelsi. La Creazione, ad esempio. Qui c’è il torto della amicizia, se non ci dessimo del tu ci prenderemmo più sul serio. Ferma la debolezza di questo Giovanni (l’essere piemontese, altra ostrica opposta alla verghiana), il poeta scompare solo perché l’artigiano del ferro, del legno, dei colori, troneggia. D’Annunzio lo chiamava peritissimo e si sarebbe fregato le mani: un altro nel carniere. Ma anche uno scrittore di Francia, il grande Frédérick Tristan, ha un dichiarato amore per questo artista affettuoso e fanciullesco. Fra arte verbale e figurativa ( questa pensatrice aforistica ha il dono della bella visualità) un libretto di Luciana Rogozinski, Dizionario Metaforico (editrice la Libria di Melfi). Siamo, inopinatamente, dalle parti del Naturklang. Vedo che già nel 1991 la scrittrice aveva vinto il Premio Montale, questo premio un poco mondano lo si dà anche a genti che con Montale poco spartiscono (non parlo di valore). Qualcosa di Montale, absit iniuria... (si sa che citare Montale, affossato dal duo fattucchiero Cima-Bettarini, è cosa oggimai fuori uso, lievemente insolente e certo controproducente), nella Rogozinski permane, a quanto sembra. Probabilmente quello che ad altri parve (esagerandone importanza e natura) di matrice dannunziana: la parola esatta, in sé visiva. Nell’ultimo Montale prevaleva il vezzo di farsi vedere veggente ma con gli occhiali neri parasole. La Luciana porta belle lenti aristocratiche (ha confidenti Kubin, Celan, Dylan T., Jean Paul, e l’irraggiungibile Lucrezio, ma non è, ripeto: non è, una cristinacampo dionescampi) e allo sberleffo ci arriverà più avanti, magari. Ma che bellezza queste storie del deserto, macchie, storie dell’età del pavone, architetture di piuma. “C’è la macchia solitaria, la grande macchia, la macchia che illumina e spegne la luce del mondo, la macchia, dunque, come destino: Scarafaggio o Scorpione, i caratteri indeclinabili, i messaggeri dei due regni che insidiano i giardini dello spazio: l’ottusità incoerente dello sporco, l’intelligenza distruttiva”. Non siamo distanti dalla perfezione di scrittura e pensiero ― che sembrano impossibili in Italia, terra di convergenze parallele ― di Frédérick Tristan. Védine, in Italia, il suggestivo piccolo libro di versi e pitture, Encres et écritures / Inchiostri e scritture, versione italiana di Marco Albertazzi, per la sua Finestra editrice. *** Mi par ora di chiudere. La notte è stata lunga. I tempi che traversiamo sono tempi di riscoperte, di ripensamenti; di meaculpa. Hanno ritrovato Emilio Villa, Spatola (ma manca si ripubblichi L’Oblò). Domani ritroveranno Germano Lombardi, Màgdalo Mussio (1925-2006), Alberto Faietti, Aldo Dramis, Leonetti. Non fanno terna ma lume nebulosico. Vedi le terne? occhiali senza occhi. Tutto previsto. Ho sul tavolo tutte le poesie di Carlo Bordini (I costruttori di vulcani. 1975-2010, luca sossella editore, le minuscole sono sue, con un invio di Roberto Roversi e una sugosa prefazione di un giovane critico di Sicilia, Francesco Pontorno). Non conoscevo Bordini, che, vedo, ha una bella legione di garanti, da Berardinelli a Sebaste, da Ferretti ad Aldo Rosselli a Filippo La Porta, e, fra i traduttori in francese, un mio amico dei tempi antichi, l’italo-svizzero Vince Fasciani. Ma Fasciani, che mi ha sempre viziato col dono dei suoi libri, giudicò inutile, suppongo, farmi conoscere il Manuel d’autodestruction (Genève 1995). Un caso? una dimenticanza (più decisiva, sappiamo, di una scelta oculata)? Penso sia stato come quando Campana vendeva i suoi Orfici ai caffè di Firenze ma strappava, per ciascun acquirente, qualche foglio, asserendo che quelle poesie quell’acquirente non le avrebbe potute capire. Dicono che, con uno, strappasse tutte le carte del libro. Bordini. Quasi tutti i poeti si servono della poesia per coonestare le proprie vite. Lui, invece, per innescarle. Raro poeta che dentro di sé porta un critico e un conoscitore, rinuncia in partenza a una ricerca strenua di una forma in divenire. Credo che fra i suoi idoli non ci sia Goethe. Secondo le occasioni, riconosce l’involucro che conviene, ma senza manierismi. Per questi bisogna essere l’unica cosa che Bordini sicuramente non è: un letterato. “Denuda e mostra come un moralista classico contemporaneo” (Pontorno). Non è un Fortini, se paresse a qualcuno, che si aggiri per quei paraggi. A fronte e per concludere, uno che non è ancora, e forse nemmeno vorrebbe esserlo, un classico. Marco Ceriani, classe 1953. Il suo recente Memoriré (Lavieri edizioni, S. Angelo in Formis CE, collana a cura di Domenico Pinto) a me ricorda certi quaderni di studî pianistici. Meditazione, gusto, ed essere esemplari almeno a sé. A volte può rammentare il Montale degli Ossi; ma non v’è traccia di imitazione. (Del resto non abita le Giubbe rosse di una Firenze sbragata e letteraria, ma sta rinchiuso in Uboldo... cazzo! dov’è? è in provincia di Varese ma nulla dichiara in Ceriani un leghista; e cazzo ce l’ho messo per essere sicuro che uno di centro-sinistra a questo punto smetterà di leggermi. Loro programma: chiesa, famiglia e scuola elementare... Pierinoooo! ma quelle dita... nel naso...! Ma Pierino va per una via di relativismo e pluralismo religioso aconfessionale, di porte aperte e di vigorosa autodidassi... vanno in pensione i preti, i conciliatori e le maestrine... Ma è la rivoluzione permanente!!!) *** Stamani, in vasca, ho provato a ricantare la Paloma, ma la mia voce non è più la mia. Ora mi arriva sgradevole come quella di un estraneo malvoluto. Allor che lasciai l'avana dal Tabachier Rimasi senza fumar per un mese intier Ci volle molto coraggio ma non bastò Nel sonno mi s’affacciava una cicca al suol Se sotto la mia suola spuntasse un giorno Prestami un fulminante di cortesia È il sigaro lontano che nel soggiorno Ci siamo fatti insieme con allegria Tutto intero o piccin Sulla terra o sul muro Con te solo mi sento sicuro Fumo del mio destin. O versi, luogo delle infinite impossibilità. Io nei miei panni ‘reali’, non ho mai messo fra le due labbra ― mai ― nemmeno una cicca spenta. Dicevo di mio padre ― dei fumatori il principe, il mio regno per un pacchetto di marlboro, la vie en fumèe ―: PIANSE E FUMÒ PER TUTTI. Così rimasi ― come dire ―: astemio. Forse perciò fui solo un cortallasse.
Scaricare