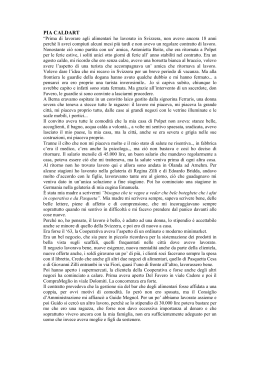CLAUDIO COLOMBO SOLO Era un tardo, freddo pomeriggio di febbraio. La nebbia si levava in morbide volute dal canale, avvolgendo, in un silenzio ovattato, la casetta di legno costruita sulla riva. La casa era quasi completamente al buio. Solo nel piccolo studio l’oscurità era attenuata dalla debole luminosità diffusa dallo schermo del PC posto sulla scrivania, dietro la grande finestra che dava sul canale. Sullo schermo, il testo di un racconto aspettava, paziente, che mi riscuotessi e gli trovassi un finale; mentre, accanto alla stampante, dove l'avevo dimenticata, una tazza di caffè finiva di raffreddarsi. Immerso nel silenzio, me ne stavo seduto sulla poltroncina girevole davanti alla tastiera, con lo sguardo perso nella nebbia fuori dai vetri, la mente lontana, intenta a seguire sogni vaghi, un po' sfuocati e malinconici, su ciò che era stato e avrebbe potuto essere, su quello che avrei voluto e non ero mai stato capace di diventare, sui desideri, le speranze, le delusioni e la solitudine di una vita. Come mi succedeva sempre più spesso, mi perdevo nei ricordi, rivivendo le sensazioni, le emozioni e i sentimenti, come attraverso un filtro, che, in qualche misura, ne attutiva e addolciva l'impatto. Fino a due anni fa mi guadagnavo da vivere progettando sistemi di automazione industriale. Ero anche bravo. Lavoravo per una piccola società, così che le soddisfazioni erano più che altro morali, ma non mi serviva molto. Poi, una piccola eredità, da un parente che non sapevo nemmeno di avere, mi regalò una possibilità. Acquistai questa casetta sul delta del Po; cinque chilometri dal paese più vicino e una trentina da Ravenna: zanzare, umidità, caldo atroce d'estate; nebbia fitta e freddo pungente d'inverno. Ma era ciò che desideravo. Ed eccomi qui, ancora una volta a inseguire un sogno. Scrivere, esprimere, fissare per sempre il bisogno di amare e di essere amato, l'affetto che ho dato e ricevuto, il dolore e la gioia che ho provato, il vuoto che mi sono sentito dentro quando sono rimasto solo. Scrivere, per non essere vissuto invano, per lasciare una traccia, per dire "Ci sono stato anch'io", perché qualcuno, un giorno, possa sentire un'eco dei suoi pensieri nelle mie parole. Sono cresciuto riempiendomi l'anima delle gesta di Artù e dei suoi cavalieri, di Sandokan, di Yanez, dei tre moschettieri. Sognavo di incontrare anch'io la mia Ginevra, la mia Surama, sognavo di compiere grandi imprese per amor suo, sognavo un lieto fine che fosse l'inizio di una nuova vita… e l'ho trovata! 1 Sono stato fortunato. Per tre volte l'ho incontrata. La prima quando eravamo ancora troppo giovani, mi ha lasciato quando ha incontrato uno più bello e in gamba di me. La seconda mi ha sposato, mi ha lasciato quando la leucemia è riuscita a batterla. Di lei mi restano sedici anni di ricordi e una figlia che le somiglia da star male. La mia piccola, ha diciotto anni ormai, passa qui i mesi estivi, durante il periodo scolastico, invece, resta a Ravenna, e insieme trascorriamo solo i fine settimana. Non parliamo molto noi due, abbiamo imparato a rispettare i nostri spazi, i nostri silenzi, però, quando è necessario, sappiamo essere presenti. Alla morte di mia moglie, sono dieci anni ormai, mi sembrò che una parte di me morisse con lei, che niente avesse più senso. Lei era stata lo scopo della mia vita, il perno su cui l'avevo costruita. Avevo voglia di arrendermi e di lasciarmi morire; ma non ne avevo il diritto, c'era nostra figlia ed era mio dovere aiutarla a crescere, ad affrontare la vita, che, per lei, era ancora tutta da scoprire e assaporare. Mi sono buttato a capofitto nel lavoro, nell'impegno sociale e nel mestiere di padre. Ho fatto del mio meglio per dimenticarmi di me, dei miei bisogni, del dolore che mi accompagnava in ogni istante, del vuoto immenso che avevo dentro. Per sei anni ho lasciato che il tempo e la vita mi scorressero attorno, fingendo serenità e coraggio, e morendo ogni giorno un po' di più. Poi, all'improvviso, come in un romanzo, quando ormai non mi aspettavo più nulla, l'ho incontrata di nuovo. Tutte le barriere, tutte le difese sono cadute, e mi sono ritrovato vivo. Mi sono sentito amato e desiderato, mi sono accorto di potere ancora donare e ricevere gioia. Pur sapendo che il nostro sarebbe stato un rapporto difficile, che forse non sarebbe durato, che i nostri mondi erano troppo lontani e che le nostre strade andavano in direzioni diverse, mi sono innamorato di lei. Un amore con poche speranze il nostro e, forse per questo, ancora più intenso. Mi aveva detto, fin dal primo incontro, di aver assunto impegni che non potevano essere disattesi, che c'erano scadenze che non poteva ignorare, così, quando mi disse che era giunto il momento e che doveva andare, annuii in silenzio. Non avevo voce per parlare e non c'era nulla che potessi dire, qualsiasi cosa sarebbe stata banale e inutile. Ci abbracciammo e lei, d'impulso, mi disse che sarebbe tornata, se avesse potuto. Sono passati quattro anni e non ho più saputo più nulla di lei. L'ho aspettata, per qualche tempo ho anche cercato di rintracciarla, poi ho smesso. Di nuovo, ho lasciato che il silenzio invadesse la mia vita, ma non ho mai smesso di aspettare e di sperare, contro ogni speranza, in un suo ritorno. Poi, una mattina, circa otto mesi fa, squillò il telefono e mi trovai proiettato in una di quelle avventure che avevo sognato da ragazzo. Era il mio vecchio datore di lavoro, un sistema di produzione, installato in Egitto, si era bloccato; nessuno, tranne me, lo conosceva a sufficienza per poterlo riattivare. Mi si chiedeva di tornare, per un poco, al mio vecchio lavoro, e di intervenire. Non stavo scrivendo nulla in quel periodo e, in 2 fondo, mi annoiavo un po', accettai. Dopo due giorni ero sul posto. In una giornata di lavoro riattivai il sistema ed eseguii tutti i test funzionali. La sera stessa fui accompagnato al Cairo e lasciato all’albergo in cui avrei trascorso la notte, in attesa di imbarcarmi, il mattino successivo, sul volo per Milano. Fui svegliato, all'alba, dallo schianto della porta che si abbatteva contro il muro. Due energumeni, armati di mitra e di coltello, si precipitarono nella stanza e mi buttarono giù dal letto, urlando in una lingua che, dato il luogo, e il fatto che non ci capivo un tubo, supposi fosse arabo. Non era necessario capire le parole, il senso era decisamente chiaro: o mi muovevo alla svelta, o ci lasciavo la pelle. Mi fecero indossare i calzoni e gli stivali, poi fui trascinato, sospinto, pungolato con la canna del mitra, colpito alla schiena col calcio del fucile e preso a pedate, finché mi ritrovai sul cassone di un camion, insieme ad alcune altre persone. C'erano due ragazze sui venticinque anni, una coppia di persone anziane e una famigliola con due bambini, un maschio e una femmina. Erano tutti di nazionalità americana, facevano parte di una comitiva che partecipava a un viaggio organizzato. Ero l'unico estraneo al gruppo, l'ultimo ad essere stato caricato, e anche il più malridotto; non dovevo essere molto simpatico ai rapitori. Il camion partì, viaggiammo per ore, torturati dal caldo e dalla sete, sballottati in tutte le direzioni dai continui scossoni, semi soffocati dalla polvere e brutalmente malmenati se osavamo muoverci o lamentarci. Ad un tratto, uno scossone più forte degli altri, mi gettò addosso la bambina, che piangeva silenziosamente. Senza pensarci, allungai una mano per darle una carezza, ma la cosa non piacque ad uno dei nostri guardiani che mi colpì alla testa con un calcio. Quando mi svegliai, il camion era fermo, e i miei compagni erano già tutti a terra. Non feci in tempo a riscuotermi che venni scaraventato giù dal cassone, mi trascinarono in una tenda dove fui legato, seduto contro il palo centrale. Mi diedero un paio di ceffoni, così, tanto per gradire, e mi lasciarono. Sono un tipo abbastanza robusto e ho una buona ripresa, negli ultimi anni, poi, mi ero mantenuto in forma con molta ginnastica. Avevo incassato un po' di botte, ma, in realtà, non ero ridotto male. Con il passare del tempo, il dolore alla testa diminuì e, malgrado la posizione decisamente scomoda e la tortura della sete, cominciai a sentirmi meglio. Avevo la sensazione di vivere in un film, e nemmeno uno dei migliori, mi scoprii a sorridere. Cercai di riposare, cambiando spesso posizione alle gambe. Infine mi appisolai. Quando mi svegliai era buio, ero tutto indolenzito, ed ero sempre solo. Attraverso il telo della tenda, scorgevo il riflesso di alcuni fuochi da campo. Dall'esterno giungevano risa e schiamazzi, inframmezzati, a tratti, da gemiti e urla, che non mi lasciarono dubbi sulla sorte toccata a una delle ragazze del gruppo. Fu come se avessi ricevuto una doccia fredda. Fino a quel momento non mi ero realmente reso conto della situazione. Come ho già detto, mi era sembrato di assistere ad uno spettacolo cinematografico di serie B. Il film, mi ero detto, sarebbe finito, e io, 3 un po’ deluso, me ne sarei tornato a casa. Ora, finalmente, mi rendevo conto che quella era la realtà e che, se non avessi fatto qualcosa, probabilmente, a casa non ci sarei tornato. Insieme alla consapevolezza, crebbe in me una altro sentimento: rabbia, una rabbia cieca, bestiale, ero furioso! Avevo sempre pensato alla morte come a una liberazione, ma volevo morire a modo mio; non così, non ammazzato di botte e torturato da un gruppetto di bestie travestito da uomini, da dei vigliacchi che si divertivano a spese di persone indifese. Se proprio dovevo morire, pazienza, ma avrei cercato il modo di fargliela costare cara la mia morte. Cercai di calmarmi, di mettermi a riflettere. Per prima cosa, dato che ancora non si era visto nessuno, dovevo scoprire se mi era possibile liberarmi. Il palo, cui ero legato, non era piantato nel terreno, ma solo appoggiato; di conseguenza, il peso che vi gravava era solo quello della tenda. Non doveva essere impossibile riuscire a sollevarlo un poco, quel tanto che sarebbe bastato per sfilare i polsi dal di sotto. Non era nemmeno facile però, lo scoprii in fretta! Sollevarlo dal terreno non era un problema, ma, una volta sollevato, diventava impossibile sfilare i polsi senza lasciarlo andare, e così ricadeva a terra. Ancora una volta mi imposi la calma. A furia di contorcimenti, riuscii a mettere un piede accanto alla base del palo. Sorrisi tra me, pensando che ci sarebbe stato da divertirsi se fosse entrato qualcuno in quel momento. Sollevai il montante ancora una volta e, con uno sforzo, riuscii ad infilarci sotto, in parte, la punta del piede. Adesso il palo stava su, lentamente feci scivolare i polsi fino a portarli sotto la sua base, poi, con un colpo di sedere, lo spinsi indietro, liberando, finalmente, le braccia. Ero libero di muovermi, ma le mani erano ancora legate dietro la schiena. Mi sedetti, poi, con parecchia fatica e molti tentativi andati a vuoto, riuscii a far passare le gambe tra le braccia, portando così le mani sul davanti. La corda era robusta, neanche da pensarci di usare i denti per troncarla, per metà li avevo finti e si sarebbero rotti loro. Mi guardai attorno, ma non riuscii a trovare nulla che potesse servirmi. C'era solo una grossa anfora appoggiata su una cassa e, a terra, in un angolo, giaceva, abbandonata, una piccola pala da campeggio. Fuori le urla continuavano e nessuno, a quanto pareva, si era accorto delle mie manovre. Muovendomi molto lentamente, cercando di non far rumore, mi avvicinai all'ingresso della tenda; ne scostai leggermente il telo, per sbirciare fuori. Seduto, a nemmeno un metro di distanza, c'era un uomo armato, voltava le spalle alla tenda e non capivo cosa stesse facendo, forse sonnecchiava. Feci un po' di rumore, grattando leggermente la stoffa, ma non ottenni alcuna reazione. Tornai dentro, afferrai la pala e mi accostai di nuovo all'ingresso. Di nuovo, tornai ad aprire impercettibilmente il telo. La sentinella, o quello che era, non si era mossa. Mi accucciai, poi, sempre molto lentamente, cominciai ad avvicinarmi. Quando fui a un passo dalla guardia, mi alzai di scatto e le calai la pala in testa; con tutte le forze che avevo. Devo ammettere che il rumore che fece mi diede una certa soddisfazione! Mi chinai sulla mia vittima, usai il suo coltello 4 per liberarmi le mani, poi le presi velocemente le armi: oltre al coltello, recuperai un fucile mitragliatore, le munizioni e due bombe a mano. A terra, c'erano: una ciotola di cus-cus, un pezzo di pane e una borraccia piena d’acqua. Avevo fretta, ma pensai che mi conveniva rischiare ancora un po' e rifocillarmi. Divorai il cus-cus, mi ficcai in tasca il pane, agganciai la borraccia alla cintura e mi allontanai, in direzione opposta a quella della luce dei fuochi. Camminavo da una decina di minuti quando cominciai a rendermi conto che, in realtà, non sapevo cosa stessi facendo. Avevo agito con la vaga idea di fuggire e chiedere aiuto, ma, ora, mi rendevo conto che non sarebbe stato così facile. Non avendo la minima idea di dove mi trovassi, non potevo nemmeno stabilire in che direzione cercare i famosi aiuti. Il terreno era sassoso, non avrei lasciato tracce, ma, a piedi, avrei fatto ben poca strada, prima che i rapitori si accorgessero della mia fuga. Quei delinquenti si sarebbero messi in caccia, e, temevo, non ci avrebbero messo molto a individuarmi. Avrei potuto affrontarli, quando sarebbe accaduto, avrei potuto combattere fino a farmi ammazzare, ma non avrei aiutato gli altri prigionieri. Mi serviva un piano, possibilmente buono. Mi sedetti su un masso, mi sforzai di ragionare. Avevo letto centinaia di libri di avventure, visto decine di film; possibile che non mi venisse un'idea? Dovevo fare qualcosa di imprevedibile, di talmente assurdo da risultare inconcepibile per i miei avversari. Mentre mi allontanavo, avevo notato, nel campo, nei pressi di una delle tende, un grosso e irregolare cumulo di rocce. Ne ero stato colpito perché mi aveva ricordato, in formato gigante, un mucchio di quei mattoncini che usano i bambini per le loro costruzioni. Mi era sembrato anche parecchio alto, almeno una quindicina di metri. Mi alzai, e tornai sui miei passi. Mi era venuta l'idea che mi serviva. Invece di allontanarmi, avrei trovato un nascondiglio tra quelle rocce, e sarei rimasto ad attendere la scoperta della mia evasione. Nessuno, speravo, avrebbe immaginato che, invece di fuggire, mi ero limitato a nascondermi nel campo. Quando gli inseguitori si fossero allontanati, per gettarsi alla mia ricerca, avrei valutato la situazione e deciso la prossima mossa. Non era il massimo come piano, ma era quanto di meglio fossi riuscito a escogitare; mi accontentai. Trovai un nascondiglio a circa metà altezza dell’altura, sotto due immensi lastroni che, poggiando l'uno sull'altro, formavano una specie di nicchia in cui potevo stare sdraiato, completamente invisibile dal basso. Una sottilissima fenditura mi permetteva, inoltre, di vedere buona parte del campo. Non potevo chiedere di meglio. Bevvi un sorso d’acqua, cercai di mettermi il più comodo possibile, e mi addormentai. Giunse l'alba e, con essa, la scoperta della mia fuga. Dal basso giungevano urla e rumore di motori. Diedi un'occhiata, vidi gente correre in tutte le direzioni, afferrare le armi, salire sui camion. Contai almeno una cinquantina di persone, in tuta mimetica e turbante. In mezzo al campo, legato a un palo, c'era il corpo nudo, martoriato e senza vita, di una delle due ragazze. Gli altri 5 prigionieri non si vedevano da nessuna parte. Sentii, di nuovo, montare in me quella rabbia, cieca e assoluta, che avevo già provato la sera precedente. Avrei voluto uscire, cominciare a sparare, ammazzarne più che potevo di quei porci. Sapevo, però, che così non avrei avuto alcuna possibilità. Mi imposi di restare calmo, di aspettare il momento buono. Sollevando nuvole di polvere, i camion partirono. Attesi ancora una mezzora, poi cominciai a scrutare il campo, per scoprire segni di attività, per stabilire in quanti, di quelli che ormai consideravo terroristi, vi fossero rimasti. Era tutto molto tranquillo. Dalla mia posizione riuscivo a vedere quasi tutto il campo; con qualche contorsione, e spostandomi di lato, potevo osservare anche la parte che, normalmente, mi era nascosta. Dopo un'ora di attenta, e paziente osservazione, fui ragionevolmente sicuro che al campo fossero rimasti solo in quattro. Non sembravano particolarmente all'erta. Erano seduti, tutti insieme, accanto a uno dei fuochi ormai spento. Parlavano, di tanto in tanto guardavano verso una delle tende, facendo gesti osceni, sghignazzando sguaiatamente. Gli altri prigionieri dovevano essere li, pensai. Continuai a osservare il campo, per fissarmi nella mente la sua disposizione, per individuare l'ubicazione di ciò che avrebbe potuto essermi utile. Non c'erano altri veicoli, ma una tenda, a giudicare dall'antenna, doveva ospitare un'attrezzatura radio. Un'altra, mi sembrava l'armeria. Era giunto il momento di agire, e, per prima cosa, avrei eliminato i guardiani. Devo essere sincero, nemmeno per un momento pensai di catturarli, avevo deciso di ucciderli, se ci fossi riuscito. Ho sempre avuto una buona mira, e ,una volta, mi piaceva sparare al bersaglio. Non conoscevo l'arma di cui mi ero impadronito, ma non mi fidavo troppo della sua precisione, così decisi di avvicinarmi il più possibile prima di mettermi a sparare. Strisciai fuori dal mio nascondiglio, cominciai a scendere lungo il pendio, tenendo sempre i massi tra me e lo spiazzo. Quando fui quasi alla base, azzardai un'occhiata. Ero a meno di venti metri dalle guardie, temevo che potessero persino sentirmi respirare. Dovevo essere più bravo di quanto pensassi, però, o loro particolarmente disattenti, perché rimasero seduti a parlare, non mostrarono di essersi accorti di me. Sperando di aver bene interpretato i simboli, misi il selettore di sparo sul colpo singolo. Mirai al più lontano degli uomini, poi decisi l'ordine che avrei seguito per abbattere gli altri. Tirai un profondo respiro e cominciai a sparare. Fu perfino troppo facile! Caddero, senza nemmeno capire da che parte arrivavano i colpi. In pochi secondi fu tutto finito, e tornò la calma. Rimasi immobile per alcuni minuti, volevo essere certo che non ci fossero altri guardiani. Non ci fu alcun movimento, perciò mi avventurai allo scoperto. Raggiunsi la tenda dei prigionieri. Erano legati mani e piedi, gettati per terra l’uno sull'altro, mi fissavano con occhi pieni di terrore, senza riconoscermi. Col mio inglese di sopravvivenza, cercai di spiegare loro che ero un amico. Li liberai. La situazione era ancora disperata: non avevamo mezzi per fuggire, e i terroristi potevano tornare da un 6 momento all'altro. Erano trascorse circa due ore dalla loro partenza. Calcolavo di averne al massimo altre tre prima che, non riuscendo a trovarmi, tornassero al campo. Per allora dovevamo aver trovato una via di fuga. Entrai nella tenda che mi era parsa un deposito d'armi. Vi trovai alcune casse di munizioni, una di granate a mano, un discreto numero di fucili e pistole, un paio di bobine di sottile filo elettrico e, in una cassa oblunga, il regalo di natale: un lanciarazzi portatile a canne multiple, uno di quelli che possono sparare quattro razzi in sequenza, uno per canna. Lo riconobbi subito perché lo avevo visto in un film. C'erano anche i razzi e il libretto delle istruzioni in inglese. Nel frattempo Mike, il signore più anziano, era entrato nell'altra tenda e vi aveva trovato un'apparecchiatura radio in ottime condizioni. Incaricammo Kitty, appassionata di CB, di restare alla radio e di chiedere aiuto in continuazione su tutte la frequenze possibili. Noi, nel frattempo, avremmo tentato di trasformare in un fortino l'ammasso di rocce che mi era servito da nascondiglio. Vi trasportammo tutte le armi, le caricammo e le disponemmo insieme alle munizioni rimanenti, in modo che fosse possibile raggiungerle senza esporci agli spari che sarebbero giunti dal basso. Contai le granate, scoprii che ne avevamo parecchie a disposizione, circa duecento, così mi venne un'idea. Controllai l'ora, eravamo stati veloci, se le mie previsioni erano attendibili avevamo ancora un paio d'ore. La signora più anziana si prese cura dei bambini, li portò in esplorazione nelle altre tende, alla ricerca di un po' di cibo. Noi, nel frattempo, disponemmo le granate tutte intorno alla nostra piccola altura. Le piazzammo a scacchiera, a una distanza di una decina di metri l'una dall'altra, le ricoprimmo di sassi e terriccio. Legammo le linguette a strappo con il filo elettrico, unendo le granate in gruppi di quattro. In questo modo, tirando il capo del filo si sarebbe tolta la sicura e provocata l'esplosione, più o meno simultanea, di tutto il gruppo. Facendo molta attenzione, posammo poi i fili, mimetizzandoli alla meglio, in modo che giungessero fino alla base della collinetta. Infine cercammo di individuare una buona postazione da cui usare il lanciarazzi, ma non riuscimmo a trovare nulla di soddisfacente tra i massi. Lo avremmo dovuto utilizzare, praticamente allo scoperto, stando alla base dell'altura. Decidemmo che io avrei sparato, mentre il padre dei bambini mi avrebbe fatto da servente. Tanto per non perdere tempo cominciai a studiare le istruzioni, scoprendo che, in realtà, ammazzare la gente con quell'affare era più facile del previsto. Qualche tempo dopo, Kitty si precipitò fuori dalla tenda della radio gridando e saltando di gioia. Quando, finalmente, si calmò e cominciò a parlare più lentamente, riuscii a capire che aveva trovato aiuto. Il servizio di sorveglianza radio dell'aviazione Egiziana era stato in grado di localizzare la nostra emittente, entro mezzora, un'unità elitrasportata dell'esercito sarebbe giunta a salvarci. Il nostro, però, fu un sollievo di breve durata. Erano trascorsi solo pochi minuti, quando, una colonna di polvere all'orizzonte, ci instillò il dubbio che, forse, quella mezzora non l'avremmo avuta. 7 Portammo i bambini nel mio nascondiglio notturno, e prendemmo posizione per difenderci. Non ci avrebbero catturati un'altra volta! La colonna di polvere si avvicinava velocemente, presto fummo in grado di scorgere, alla sua base, la sagoma di tre camion lanciati a tutta velocità. Li riconobbi per quelli che avevo visto partire poche ore prima e, imbracciato il lanciarazzi, mi mossi per trovare la postazione migliore per sparare. Speravo di riuscire a bloccare gli automezzi il più lontano possibile dalla nostra posizione, in modo da avere più tempo in attesa dei soccorsi. Gli autocarri procedevano in fila indiana, perciò, se avessi centrato il primo, avrei bloccato, almeno momentaneamente, anche gli altri due; però avrei anche dato il tempo ai loro occupanti di scendere e di sparpagliarsi sul terreno, rendendo più difficile la nostra situazione. Volevo eliminarne il più possibile di quei bastardi, mentre erano ancora lontani, così mirai all'ultimo dei tre camion. Speravo che ciò inducesse gli altri due conducenti a non fermarsi per far scendere i passeggeri, dandomi così il tempo per mettere a segno altri colpi. Quando furono a circa trecento metri, feci fuoco. Ci fu una tremenda esplosione e, in una vampata di fuoco, il camion saltò, letteralmente, in aria, si avvitò su se stesso, poi ricadde, incendiato, con le ruote in alto. Come avevo sperato, gli altri due non rallentarono nemmeno, ma si aprirono a ventaglio, per aggirare la mia posizione. Non persi tempo ad ammirare lo spettacolo, spostai la mira e, ancora una volta, sparai al più lontano. Nel frattempo, gli occupanti del primo automezzo, ormai a tiro, avevano cominciato a spararci addosso una valanga di piombo. Un dolore terribile, al fianco sinistro, mi tolse il fiato, poi, un colpo alla testa mi annebbiò la vista. Meccanicamente, come in trance, assecondai il mio compagno che cercava di trascinarmi al coperto, tra le rocce. Il terreno intorno a noi era devastato dai proiettili che alzavano zampilli di polvere. Il camion si fermò, gli occupanti balzarono a terra, sparando e urlando come belve ferite. Mike si dimostrò all'altezza della situazione, al momento buono tirò cinque o sei fili, provocando l'esplosione contemporanea di una ventina di bombe a mano. Anche il terzo automezzo fu distrutto e una buona metà dei suoi occupanti restarono sul terreno. I superstiti si appiattirono tra i sassi e cominciarono a tempestarci di colpi, obbligandoci a restare al riparo. Nella foga della lotta, non ci eravamo resi conto che mancava un automezzo, erano partiti in quattro al mattino, ne erano tornati solo tre! L'ultimo autocarro si era avvicinato, non visto, dalla parte opposta, mentre noi eravamo impegnati ad affrontare la colonna. I suoi occupanti erano ormai a pochi passi dalla base dell'altura, i più vicini stavano già iniziandone la scalata. Fu solo per caso che Kitty li scorse e lanciò un grido di allarme. Ancora una volta Mike tirò un buon numero di fili. Una serie di esplosioni scosse il lato posteriore della collinetta, gettando a terra parecchi avversari. Nel frattempo mi ero un po' ripreso. La vista mi si era snebbiata e, malgrado perdessi sangue da una ferita al fianco sinistro, potevo 8 ancora muovermi abbastanza agevolmente. Risalii, il più velocemente possibile, tra i massi, verso la postazione di Kitty. Sul lato anteriore, il padre dei bambini e sua moglie sparavano brevi raffiche verso gli attaccanti, cercando di trattenerli. Kitty era leggermente ferita alla spalla destra, un rivolo di sangue le colava lungo il braccio, respirava affannosamente, ma aveva lo sguardo deciso, e non sembrava soffrire molto. Guardai giù, erano sette od otto, salivano riparandosi tra i massi. Erano degli esperti, si coprivano l'un l'altro quando dovevano attraversare qualche tratto scoperto, sparavano raffiche brevi, precise, che scheggiavano la roccia attorno alle nostre teste. Cominciarono una manovra di aggiramento che, entro breve tempo, li avrebbe portati vicino al nascondiglio dei bambini. Fu in quel momento che sentimmo gli elicotteri. Erano due, il primo si librò al di sopra degli assedianti, sul lato anteriore della collina; li spazzò via con alcune raffiche e atterrò. Ne balzarono fuori alcuni soldati in tenuta da combattimento che corsero verso di noi. Il secondo velivolo ci sorvolò a bassa quota. Alla sua comparsa, alcuni degli attaccanti si volsero e fuggirono. L'elicottero li inseguì. In quattro,però, non fuggirono. Cercarono, anzi, di accelerare la salita. Ancora un istante, e avrebbero raggiunto i bambini. Guardai verso i soldati, erano ancora troppo lontani. Gli attaccanti erano ormai proprio sotto di me, circa tre metri più in basso. Mi faceva male il fianco, la testa mi pulsava, avevo paura. Inserii un caricatore nuovo, strinsi il calcio del mitra, e misi il selettore di sparo sull'automatico. Inspirai profondamente, ormai avevo perso il conto delle volte che l'avevo già fatto quel giorno. Chiusi gli occhi, solo un istante, poi, con un "Cazzo", urlato con tutto il fiato, saltai. Atterrai, malamente, sulla gamba destra, che cedette sotto il mio peso, trasmettendomi una lancinante fitta di dolore. Mentre mi accasciavo cominciai a sparare. Ero piombato proprio in mezzo al gruppo degli assalitori, sconcertandoli per un istante; riuscii ad abbattere uno di loro, prima che gli altri pensassero a reagire. Poi fu l'inferno. Mi sentii colpire alle spalle con un urto terribile, all'addome, alle gambe, sentivo solo dolore, rabbia, e ancora dolore. Sparai, girando su me stesso, stringendo convulsamente il dito sul grilletto, senza mirare, senza nemmeno vedere a chi stessi sparando, urlando come un pazzo. Il caricatore si esaurì, ancora una volta fu il silenzio. Tentai di guardarmi attorno, ma avevo lo sguardo velato da una nebbia rossastra. Avevo freddo. Ero in ginocchio. Il mitra mi scivolò dalle mani sudate. Provai ad alzarmi, caddi a faccia avanti. Sentivo ancora dolore, un dolore sordo, pulsante, diffuso. Non riuscivo a stabilirne l'origine e, in fondo, non mi importava. Ero sdraiato sul morbido. Sopra di me un soffitto bianco, attorno penombra e silenzio. Muovendo gli occhi, l'unica cosa che mi riuscisse di muovere, scorgevo un intrico di tubicini e di fili che sembravano uscire dal mio corpo, finendo, chissà dove, alla mia sinistra. 9 Una stanza d'ospedale, ovviamente. Alla fine ero ancora vivo. Richiusi gli occhi e mi addormentai. AI successivo risveglio, il dolore era un po' diminuito. Tentai di cambiare posizione, ma non ci riuscii. Me ne stetti buono a guardare il soffitto, fantasticando. La porta si sarebbe aperta e Lei sarebbe apparsa, mi avrebbe abbracciato piangendo, e avrebbe giurato di non lasciarmi più. La porta si aprì ed entrò un'infermiera, chissà cosa mi credevo. Era carina, però, e aveva un bel sorriso. Mi augurò il buon giorno, poi mi chiese come mi sentissi, così, come se nulla fosse. Provai a parlare, la voce era un po' fioca e rauca, ma c'era. Le risposi che: prescindendo dal fatto che non sapevo quale parte del corpo, ammesso fosse ancora tutto intero, non mi facesse male, che non riuscivo nemmeno a muovere un dito, e che mi sembrava di avere la testa come un tamburo, stavo bene, grazie. Aggiunsi anche che non mi avrebbe fatto schifo essere informato sul mio stato attuale di salute. Mi fece ancora un bel sorriso, disse che, se avevo voglia di fare lo spiritoso, dovevo proprio star meglio; sarebbe andata a chiamare il medico. Tornò di li a poco, sola, il medico era in altre faccende affaccendato, dovevo avere pazienza. Nel frattempo, sarebbe rimasta a farmi compagnia. Venni così a sapere che ero l'eroe del momento. Un terzo elicottero, che io non avevo nemmeno visto, trasportava, oltre ad una équipe medica, una troupe della CNN che aveva ripreso le immagini del mio ultimo scontro con i terroristi. Il rapimento del nostro gruppo aveva fatto scalpore e riacceso le vecchie polemiche sul terrorismo e la sicurezza internazionale. I mass-media erano alla caccia disperata di notizie fresche da dare in pasto al pubblico. Quando si seppe della nostra probabile liberazione, la CNN fu la più rapida a inviare una sua troupe sul posto. Le immagini girate dall'elicottero erano state trasmesse in diretta da molte reti. Le registrazioni avevano, ormai, fatto il giro del mondo, erano state trasmesse da tutti i telegiornali, con tutti i commenti possibili e immaginabili. L’infermiera mi raccontò che, dopo avermi prestato i primi soccorsi, i medici mi avevano fatto trasportare all'aeroporto, e da li, con un volo speciale, direttamente in un ospedale militare americano. Ero stato sottoposto a tre lunghi e difficili interventi chirurgici, avevo trascorso una settimana tra la vita e la morte, poi, cessato il pericolo, mi avevano trasferito qui, al S. Carlo di Milano. Era trascorsa un'altra settimana da allora, ed erano ormai tre giorni che mi era stata ridotta la dose di sedativi cui ero stato sottoposto. Seppi che mia figlia e i miei genitori erano stati avvisati del mio risveglio, che sarebbero giunti tra poco, e che c'era un gruppo di giornalisti che attendeva impaziente di incontrarmi. Smise di parlare solo quando entrò il medico, che, dopo avermi visitato, si decise a informarmi. Il mio corpo, sebbene parecchio danneggiato, era ancora quasi tutto intero. Avevo la gamba destra rotta in tre punti, la spalla sinistra e due costole fratturate. Le ferite più gravi, che mi avevano tenuto a lungo in pericolo di vita, erano quelle ai polmoni, perforati da cinque proiettili. 10 Avevo perso un pezzettino di fegato, piccolo però, ed ero stato ferito, leggermente, alla testa. Il proiettile nel torace invece, a due centimetri dal cuore, non era stato un problema. Avevo poi una quantità di tagli, abrasioni ed ematomi, ma erano quisquilie. La ripresa sarebbe stata lunga e difficile, avrei dovuto subire un'altro intervento per sistemare la spalla, e avrei dovuto fare molta fisioterapia. Gli chiesi se mi stesse prendendo in giro, ma mi rassicurò, era proprio tutto vero. Avevo ancora una domanda, dove avrei preso i soldi per pagare tutte quelle cure? Anche su questo fui rassicurato. La mutua avrebbe coperto quasi tutto, del resto si sarebbe fatto carico un comitato istituito da parenti e amici delle altre vittime del rapimento. Non dovevo preoccuparmi del fattore economico, inoltre, sfruttando bene l'interesse nei miei confronti di giornali e reti televisive, avrei potuto incassare dei bei quattrini. Non ci avevo ancora pensato, ma non era un'idea da buttare. Finalmente lasciarono entrare mia figlia, era pallida, si vedeva che aveva pianto, mi baciò su una guancia, attenta a non pesarmi addosso, per non farmi male. Si sedette sulla sedia accanto al letto, e mi strinse la mano. I miei genitori erano in piedi sulla soglia, mia madre col volto solcato di lacrime, mio padre un po' rigido, a disagio nel tentativo di apparire impassibile. Si avvicinarono anche loro, dopo avermi baciato, delicatamente, si sedettero accanto a me, senza parlare . I successivi cinque mesi furono un calvario di cure, visite, fisioterapia, interviste e interrogatori. Dei miei compagni d'avventura seppi solo che stavano bene, che desideravano soltanto dimenticare. Soltanto Kitty si fece viva, mi scrisse una lettera in cui affermava di essere felice di avermi conosciuto e che mi avrebbe sempre ricordato con affetto. Mi fece piacere. La mia ripresa fu lenta, ma costante. Finalmente potei lasciare l'ospedale, per tornare qui, nel mio rifugio sul canale. Erano già passati tre mesi da allora, tre mesi tranquilli, soddisfacenti, fatti di lavoro e di lunghe passeggiate. Chissà perché, allora, quella sera, stavo ricordando tutto. Chissà perché mi sentivo così vuoto, solo e inutile. Perché la gola era stretta da quel nodo, e avevo quella voglia di piangere indegna di tanto eroe. Il rumore di un'auto che accelerava sulla strada, mi fece tornare alla realtà. Strano, non l'avevo sentita arrivare; non tanto, in fondo, con quella nebbia, e perso, com'ero, nei miei pensieri. Beh, ormai, tanto valeva cercare di lavorare un po'. Dei passi sul vialetto richiamarono la mia attenzione. Era solo giovedì, non aspettavo nessuno, e mia figlia sarebbe arrivata solo sabato sera. Sperai, ardentemente, che non fosse successo nulla di grave, poi, rispondendo al suono del campanello, andai ad aprire. Lei era li, un po’ più alta di me con quei tacchi. Più bella di come la ricordavo, i capelli un po' più lunghi che ricadevano sul 11 bavero alzato del giubbotto di pelle nera. Una grossa borsa sulla spalla, il sorriso dolce mentre diceva: - Mi fai entrare amore? fa un po' freddo qui fuori Ancora una volta, non avevo parole. Mi feci da parte, tenendole la porta aperta. Depose la borsa a terra e mi abbracciò. Ci baciammo, tre volte sulle guance, e una, leggermente, sulla bocca; come sempre, nel salutarci. Mi strinse le mani. Deglutii, finalmente riuscii a parlare: - Hai le mani gelate, ti faccio un po' di tè Tenendola per mano, la guidai in cucina. La feci sedere al tavolo e mi diedi da fare con l'acqua e le bustine . Ci guardavamo in silenzio, mi riempivo gli occhi della sua presenza, se era un sogno non volevo che finisse. Le versai il tè e le sedetti di fronte. Ne bevve un sorso, posò la tazza e mi guardò - Sei bravo, è buono il tuo tè Allungò una mano attraverso il tavolo a stringere la mia. Era come se quei quattro, lunghi anni non fossero mai trascorsi. Trattenni il respiro, in attesa della sua risposta, quando le chiesi: - Resti? Mi guardò per un istante, in silenzio, abbassò lo sguardo sulla tazzina - Se mi vuoi, se puoi amarmi ancora - Non ho mai smesso! - riuscii solo a sussurrare. Certo, non fu una grande conversazione la nostra, ma non c'era altro da dire, ci sarebbe stato tempo per le spiegazioni e i ricordi; in quel momento era tutto ciò che contava. Finì il te, ci alzammo ed entrammo in soggiorno. Le braci nel camino covavano ancora sotto la cenere. Riattizzai il fuoco, aggiunsi altra legna. Mi sedetti sul tappeto, con le spalle appoggiate al piccolo divano, le gambe distese e leggermente divaricate. Vi si sedette in mezzo, la schiena appoggiata al mio petto, la guancia contro la mia. - Ho ancora freddo – Presi il plaid dal divano, lo drappeggiai in modo che ci avvolgesse entrambi, poi la strinsi fra le braccia. Coprì le mie mani con le sue e restammo così, in silenzio, il suo respiro che si fondeva col mio, finché scivolammo nel sonno, abbracciati. 12 Le sette e mezza, piove. L'aria che penetra dalle fessure fa accapponare la pelle. La barba, un caffè. Ho un nuovo sistema da installare oggi. Stringendomi nelle spalle, do uno sguardo al letto che non ho il tempo ne la voglia di rifare. Solo un sogno, ma era bello; e oggi, forse, per qualche ora, avrò un po' meno freddo. 13
Scarica