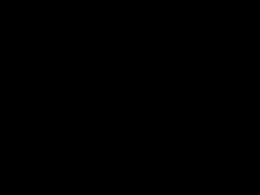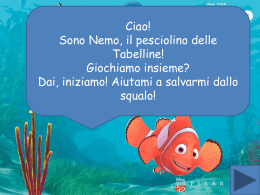Domenica La di DOMENICA 23 OTTOBRE 2005 Repubblica il reportage Il culto sfregiato del Raìs BERNARDO VALLI l’inchiesta Nella Mosca malata dei nuovi ricchi SANDRO VIOLA VIRUS FOTO MATTHIAS KULKA/CORBIS Repubblica Nazionale 31 23/10/2005 In Cina c’è una regione da dove sono partite le più grandi epidemie della storia, in Russia c’è un laboratorio che custodisce i germi più pericolosi. Siamo andati a visitarli per raccontare la nuova paura: la febbre aviaria FEDERICO RAMPINI I cultura GIAMPAOLO VISETTI GUANGZHOU l vassoio in mezzo a noi trabocca di pezzi di pollo con la pelle gialla spessa e grassa. Testa zampe viscere non si butta niente. Per il caldo umido soffocante che ancora a ottobre opprime questa regione, nonostante il ventilatore in pochi minuti il pollo brulica di mosche. Impossibile sottrarsi al banchetto, dopo il privilegio che mi è stato concesso di penetrare in questo luogo. Al padrone di casa gli occhi luccicano golosi mentre afferra cosce, ali e zampe con le sue manone unte e mi riempie il piatto per cortesia. Mastica rumorosamente, sputa ossicini in mezzo al tavolo e intanto descrive la sua ricetta favorita: questo pollo è lesso ma prima di addentarlo ogni pezzo deve essere affogato a lungo nella scodella comune di olio denso allo zenzero che sta in mezzo al tavolo. «La febbre aviaria non spaventa i miei consumatori — biascica tra un morso e l’altro —. Neppure i clienti di Hong Kong che sono i più schizzinosi. Quando le loro autorità sanitarie bloccano le importazioni di pollame dalla Cina continentale, quelli prendono il treno e vanno fino a Shenzhen a fare la spesa, tanto gli piacciono i nostri polli». Il Signor Tan Ju Tian che mi ospita nella sua mensa aziendale sa di cosa parla. Dirige la Kwangfeng, un maxiallevamento di polli a Baiyun, periferia di Guangzhou (Canton). Trenta milioni di polli escono da qui ogni anno, vivi o morti. Venduti sulle bancarelle in Cina o esportati a Hong Kong e nel mondo. (segue nella pagina successiva) L MOSCA a collezione più blindata dell’ex Urss è invisibile anche ai suoi padroni ed ai loro inconsapevoli guardiani. L’impalpabile tesoro, vegliato da un pugno di reduci dell’Afghanistan e di agenti segreti in congedo, è custodito in migliaia di provette allineate dentro incubatrici a temperatura controllata. L’arsenale capace di spazzare via milioni di vite, distinto da sigle in codice note a non più di una ventina di persone, è contemporaneamente un tempio biologico che in silenzio, ogni anno, ci salva dal delirio delle febbri. Non possono fuggire, i virus che Mosca isola e conserva dai tempi di Stalin. Soltanto loro, gli infetti assoluti, possono guarire gli infettati. E solo i terroristi, oltre agli scienziati che consumano i loro giorni al microscopio, sono attratti dai microrganismi che sospendono oggi le previsioni sul futuro dell’umanità. Per questo il giallastro Istituto Dmitrij Ivanovskij, intestato al padre della virologia mondiale, presenta le difese di una centrale nucleare. È il più antico e avanzato del pianeta, uno strato di impenetrabile mistero lo circonda nel quartiere di Kurchatov, a nordovest della capitale. Alcune migliaia di virus, il numero esatto viene mantenuto segreto dal direttore Dmitrij Lvov, da oltre sessant’anni mutano costantemente e si riproducono al riparo di un doppio sistema di sicurezza. (segue nella pagina successiva) Il giro del mondo con Camilleri FRANCESCO MERLO e ALESSANDRA ROTA spettacoli Isabelle Huppert allo specchio NATALIA ASPESI e LAURA PUTTI la scienza Squalo, il predatore più antico CLAUDIA DI GIORGIO e MARCO LODOLI le tendenze Neo-gotico, catturati dal lato oscuro JACARANDA CARACCIOLO FALCK e PHILIPPE STARCK 32 LA DOMENICA DI REPUBBLICA la copertina Allarme pandemia DOMENICA 23 OTTOBRE 2005 Qui l’uomo 4500 anni fa addomesticò e allevò per la prima volta un’anatra, da qui sono partiti i virus di molte malattie che hanno colpito il mondo: la peste bubbonica, la “spagnola”, le influenze devastanti e la Sars. Siamo andati nel Guangdong, regione nel sud della Cina, per raccontare e spiegare l’ultima paura globale: la febbre aviaria Nella culla delle grandi epidemie FEDERICO RAMPINI (segue dalla copertina) Repubblica Nazionale 32 23/10/2005 Q uesta è la provincia meridionale del Guangdong, la più ricca e una delle più popolose della Cina con 83 milioni di abitanti. Secondo gli archeologi è proprio in questa zona del pianeta che 4.500 anni fa l’uomo addomesticò per la prima volta un bipede pennuto, l’anatra, per allevarla. Secondo i biologi questa culla primordiale dell’agricoltura cinese è anche il più antico brodo di coltura delle epidemie del pianeta, soprattutto influenze. Da quando la medicina moderna è stata in grado di ricostruire i percorsi dei virus, le origini di gran parte delle malattie che hanno devastato il mondo sono state individuate qui, nel fertile Guangdong, sotto questa umidità quasi tropicale, nell’affollamento e nella promiscuità tra uomini e animali nelle fattorie e nei mercati, nelle metropoli e nei porti. Da qui ebbe inizio nel 1894 l’ultima grande epidemia di peste bubbonica che dall’India alla California seminò 12 milioni di morti. Forse qui nacque il primo virus della “spagnola” che fece più vittime della prima guerra mondiale. Con certezza si sa che partirono dal Guangdong le due ultime pandemie del dopoguerra, le grandi influenze del 1957 e del 1968 (tre milioni di morti). Qui sono apparse per la prima volta sia la Sars nel 2002, sia la febbre aviaria che è dilagata nel Sud-est asiatico e ha raggiunto l’Europa. Prima che il signor Tan mi aprisse i cancelli della Kwangfeng non immaginavo che esistessero così tanti polli ammassati in un unico luogo sulla terra. Soltanto una nazione con un miliardo e trecento milioni di esseri umani e con addensamenti urbani come Pechino e Shanghai poteva concepire degli allevamenti di queste dimensioni. Kwangfeng è la megalopoli delle galline: in mezzo alla campagna sorge come una città-satellite con schiere di caseggiati popolari. Sono in realtà file sterminate di grandi hangar con le finestre a rete. Ogni capannone contiene lunghi corridoi di gabbie allineate con le mangiatoie. E dentro ogni gabbia sono pigiate sterminate folle di galline, galletti e pulcini, avvolti nell’insopportabile calore umido, circondati dalle mosche, immersi in un fetore onnipresente di escrementi. Il pigolio è meno assordante del previsto: per evitare che gli uccelli, resi aggressivi dalla convivenza forzata nelle gabbie, si feriscano tra loro, gli vengono tagliati becchi e creste e sono quasi muti. Contadini-operai seminudi In mezzo ai capannoni si aggirano seminudi e in mutande settecento contadini-operai. Vivono in simbiosi con le galline, le loro casupole con la biancheria stesa fuori ad asciugare si distinguono a malapena dagli hangar degli animali. Un palazzone al centro della mega-fattoria contiene la catena di montaggio del macello. Appesi ai ganci che penzolano da una grande giostra meccanica, i polli sfilano davanti a file di operai che a mani nude li eviscerano delle interiora, poi con coltellacci e punteruoli tagliano e incidono. Le interiora rotolano nell’acqua di un fiumiciattolo artificiale che le convoglia lungo la catena di montaggio. Ventimila polli al giorno escono cellofanati e impacchettati. «Questi domani sono già nei supermercati a Hong Kong» gongola il signor Tan. Ma è solo una parte del pollame a uscire da qui defunto. «Noi cantonesi siamo degli intenditori, la gallina preferiamo comprarla viva al mercato, portarcela a casa e ucciderla con le nostre mani solo all’ultimo momento prima di metterla in pentola. In queste terre umide ci sono enormi allevamenti di galline Il sapore si conserva meglio». Dall’allevamento di Kwangfeng è un viavai di camion che caricano il pollame vivo. Schiacciate alla rinfusa dentro gabbie metalliche o compresse a forza in ceste di plastica, le galline riescono a stento a muoversi e a respirare. I tir stracarichi partono verso l’autostrada e i mercati generali di Guangzhou, Shenzhen. La produttività è alta, i profitti pure: questa marea di galline frutta 60 milioni di euro all’anno, per ispezionare la proprietà Tan Ju Tian gira su un fuoristrada Mercedes. I medici considerano con sospetto questi allevamenti intensivi, potenziali fabbriche di infezioni: la densità di animali facilita la trasmissione delle malattie, l’aggiunta di antibiotici nei mangimi industriali crea assuefazione e fa nascere nuovi virus più resistenti. Eppure la Kwangfeng è un’azienda modello. Le condizioni igieniche sono molto migliori che nelle piccole fattorie contadine. Non a caso è alla Kwangfeng che sono stato “ammesso” dopo settimane di trattative con le autorità del Guangdong. Il governo cinese, sotto accusa nel 2003 perché censurò le notizie sulla Sars per alme- Il boom economico rende altissimo il pericolo di contagio ESSERI VIVENTI? Non tutti classificano i virus tra i viventi: non sanno riprodursi da soli, ma hanno bisogno di penetrare in una cellula e usarne i meccanismi di divisione TRENTA MILIONI DI POLLI L’allevamento Kwanfeng lavora trenta milioni di polli all’anno GIAMPAOLO VISETTI (segue dalla copertina) a difesa fisica consiste nella pressione più bassa che ristagna nei laboratori, tale da impedire una fuoriuscita delle particelle. La protezione fisiologica assicura invece l’inaccessibilità umana agli agenti di aids, poliomelite, vaiolo, rabbia, encefalite, influenza, epatite, raffreddore, febbre gialla e centinaia di altri veleni che nonostante i farmaci, i loro ostili cugini, uccidono dieci milioni di persone all’anno. Solo i ricercatori, intabarrati in bianchi camicioni bolliti, dopo estenuanti perquisizioni accedono alle stanze della collezione, dove si lavora con le sole mani guantate affondate nelle ve- L no sei mesi, non ama che i giornalisti stranieri vengano a curiosare sulla situazione sanitaria. Malgrado le loro precauzioni, basta lasciarsi alle spalle i cancelli della Kwangfeng e imboccare l’autostrada Guangzhou-Qingyuan per vedere un altro tipo di allevamenti. Proprio in parallelo all’autostrada stessa, a pochi metri dal traffico dei tir, tra fabbriche officine e cantieri si alternano campicelli di contadini con dei bacini artificiali pieni di anatre e oche imprigionate da reti. Certe casupole contadine poggiano su palafitte nell’acqua. Altri piccoli allevatori hanno casa su fazzoletti di terra dove razzolano galline e maiali. Inquinamento delle fabbriche, detriti e discariche di immondizia, fumi tossici: il Guangdong è la fabbrica del pianeta ma la sua nuova industrializzazione convive con la vecchia agricoltura dove uomini e uccelli, cani e maiali si contendono una terra sempre più stretta. Non c’è più un pezzo di suolo libero da queste parti, sicché durante le grandi migrazioni che sorvolano il Guangdong, fra la Siberia e l’Indonesia, gli uccelli selvatici sono costretti a posarsi negli allevamenti, a contatto con galline e anatre, a scambiarsi malattie da trasportare lontano. Seguo in autostrada per cinque ore il viaggio dei polli sui tir fino alla frontiera. L’ultima tappa in territorio cinese è Shenzhen, il grande porto rivale di Hong Kong sul Delta delle Perle, da dove partono le navi portacontainer. Shenzhen vent’anni fa era un villaggio di pescatori, non esisteva sulle carte geografiche. Adesso è una città più grande di Roma Milano e Napoli messe insieme, con selve di grattacieli, un aeroporto internazionale e un traffico portuale superiore a Los Angeles. Una bolgia infernale di tir paralizza la sua tangenziale a tutte le ore del giorno e della notte. Ma nelle viscere di Shenzhen i mercati generali offrono ancora lo spettacolo di una Cina antica. Sono un’altra città sotterranea, estesa per qualche ettaro nei seminterrati dei grattacieli, che palpita di una vita febbrile, eccitata, tra sporcizie organiche e odori fortissimi, come se lì sotto si stesse agitando e fer- SCASSINATORI DEVASTAZIONE Le proteine che si trovano alla superficie del virus si legano alla membrana esterna della cellula La arpionano e vi inseriscono il proprio genoma Alcuni virus (Ebola) devastano in fretta gli organismi ospiti Altri più sornioni (epatite C) mettono in atto sfruttamenti ragionati. Possono passare vent’anni prima che la malattia emerga PARASSITI Il virus è un parassita per eccellenza. Entra nel nucleo della cellula e inizia a usare i suoi strumenti per costruire nuovi filamenti di genoma e replicare tutti i suoi componenti LA FORMA DEL VIRUS IL CONTAGIO I virus hanno forma sferica, poligonale o a bastone. La struttura è semplice, con una capsula esterna e il genoma formato da una catena di Dna o di Rna Un virus quando incontra la cellula bersaglio si aggancia alla sua membrana con gli uncini che sporgono dalla capsula Il fortino delle provette con i killer del passato trine. Una coltivazione storica di cellule mortali, un impressionante allevamento di infezioni, l’unico sistema per contrastare l’estinzione della specie. Strumenti monouso, sterilizzati da microbarriere ad alta temperatura, scongiurano il rischio di un contagio universale. Nato nel 1944 per alleviare le devastanti epidemie che scrollavano un’Unione sovietica allo stremo per la guerra, rilanciato da Stalin per studiare un’ipotetica arma biologica da sbandierare quale presunta «soluzione finale» della Guerra Fredda, l’Istituto di virologia di Mosca è oggi il laboratorio di punta nella corsa contro il tempo per un vaccino anti-H5N1. Nell’era comunista gli scienziati dell’“Ivanovskij” erano in gran parte dissidenti, ridotti in schiavitù e isolati in attesa dei gulag. Nella cittadella della scienza studia invece ora il meglio della ricerca mondiale, in contatto con i grandi istituti americani, cinesi, svedesi e francesi. L’originario “Museo dei ceppi virali” si articola ora in 19 basi scientifiche regionali e in 6 centri patrocinati dall’Oms. In 10 dipartimenti operano virologi molecolari e clinici, immunologi e infettivologi, ingegneri della genetica. Il livello della ricerca è tale che da un paio d’anni sembra essersi arrestata la fuga all’estero dei cervelli migliori. La tecnologia consente di lavorare a distanza e di essere pagati in dollari anche in Russia. Non si ferma invece la mutazione dei virus e dunque prospera la loro quotazione di mercato. Le particelle si moltiplicano e si rinnovano, adattandosi agli antidoti ad ogni cambio di stagione. Un esercito sommerso di spie, faccendieri e scienziati criminali al soldo delle multinazionali farmaceutiche, è così pronto a mettere all’asta l’identità rinnovata dei microrganismi coltivati. In Asia centrale, in alcune repubbliche europee dell’ex Unione sovietica, in Africa, il commercio dei virus è una tragica quanto ignorata realtà. «In questo modo malattie considerate estinte nell’uomo — dice il professor Lvov, accademico delle scienze e allievo di Sabin — tornano a scatenarsi anche in paesi ritenuti ormai sicuri. Mutano e tornano a diffondersi in forme resistenti agli antidoti esistenti». Non è il caso della cosiddetta “influenza aviaria”, sparsa come ogni altro virus dagli uccelli migratori. Dentro i tre edifici dell’“Ivanovskij” una schiera di studenti, da 35 anni, alleva con sapienza contadina un piccolo esercito di animali da cortile. Galline, oche, maiali, topi, conigli, ma pure le no- DOMENICA 23 OTTOBRE 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 33 GLI INCUBI ATOMICA CLIMA AIDS SARS TERRORISMO Guerra fredda e paura atomica. Dopo Hiroshima il terrore di una guerra nucleare permea il mondo fino agli anni ’90, con il picco di Cuba nel ‘62 Effetto serra, buco dell’ozono, riscaldamento globale, ghiacci che si sciolgono. Il cataclisma non avverrà domani, ma la paura incombe Il panico nasce negli anni ’80 e si alimenta per tutti i ’90 con la previsione di milioni di morti. È la prima paura globale legata a un virus Sindrome respiratoria acuta. Il primo caso in Asia nel 2003. Nel primo anno ottomila infettati in più di venti paesi. Un malato su dieci muore L’11 settembre fa esplodere una nuova forma di psicosi: quella del terrorismo islamico. Panico alimentato dalla catena di attentati successivi PROFILASSI Manifesti invitano la popolazione cinese alla profilassi durante l’ultimo allarme legato all’epidemia di Sars Repubblica Nazionale 33 23/10/2005 FOTO IMAGECHINA/CONTRASTO mentando tutto ciò che di commestibile si produce in Cina: pesci, carni macellate e sangue rappreso, frutta e verdure tropicali, spezie ed erbe medicinali. Nella zona degli animali vivi ritrovo a migliaia i polli, spremuti nelle loro gabbie, sbattuti assieme a oche e anatre starnazzanti. Il pollo incellofanato al supermercato costa 14 yuan (1,4 euro) al chilo, ma la gente si accalca qui e paga fino a 26 yuan al chilo per portarsi a casa il pennuto vivo. Lunghe file di clienti si soffermano a guardarli uno per uno, li tastano da tutte le parti prima di scegliere. I venditori afferrano le bestie dalle gabbie, stringono le zampe e le passano agli acquirenti a gran velocità. Uomini polli e banconote si incrociano in una chiassosa confusione. Per un cinese questa è un’immagine di benessere. «Si ricordi — mi ha detto il Signor Tan — che vent’anni fa i miei contadini guadagnavano 300 yuan al mese (30 euro, ndr) e il pollo se lo sognavano. Oggi mangiano pollo anche tutte le sere. Per i cinesi il fast-food preferito, prima ancora di MacDonald, è Kentucky Fried Chicken, la catena del pollo fritto all’americana. Il mio allevamento le sembra grande coi suoi 30 milioni di polli all’anno? In tutto il Guangdong tra galline anatre e oche il consumo è di un miliardo all’anno». Mezzo miliardo di cinesi in più Se questa zona da tempi immemorabili è il laboratorio di incubazione delle grandi epidemie planetarie, oggi il boom economico ha ingigantito il pericolo. Per sfamare una popolazione sempre più numerosa accorsa a lavorare nelle metropoli, si è creata una concentrazione senza precedenti di masse umane e animali, un ambiente ideale per lo scambio di malattie fra “noi” e “loro”. Nella storia dell’umanità non era mai accaduto che così tante persone e così tanti animali vivessero assieme in così poco spazio. All’epoca dell’ultima pandemia di influenza che partì dal Guangdong, nel 1968, la Cina aveva 800 milioni di abitanti. Oggi ne ha mezzo miliardo in più. Allora aveva cinque milioni di maiali, oggi 508 milioni. I polli allevati nel 1968 erano 12,3 milioni. Oggi sono 13 miliardi. Aumenta in misura esponenziale la probabilità statistica che in questi grandi numeri nasca il prossimo flagello epidemico, e che dall’animale passi all’uomo. Considerati i veri gourmet della Cina, i cantonesi non si accontentano di divorare anatre e galletti in ogni salsa e condimento. Da buongustai amano le carni rare. In tutto il Sud-est asiatico fiorisce il bracconaggio per rifornire i mercati alimentari di Guangzhou di porcospini e armadilli, zibetti e procioni. Bestiole selvatiche e animali domestici nel Guangdong finiscono sulle stesse bancarelle dei mercati, nelle cucine dei ristoranti o nei pranzi familiari delle feste. E i virus viaggiano. La Sars — è stato scoperto di recente — prima di contagiare l’uomo nacque nel pipistrello, un’altra prelibatezza nei menù cantonesi. I contadini di qui, quando gli ispettori sanitari decretano distruzioni di bestiame infetto, protestano con un vecchio detto: «Quando il maiale è malato è il momento di mangiarlo». Il mio viaggio con i polli del Guangdong si ferma di fronte al porto di Shenzhen, dove le maestose navi portacontainer salpano verso l’Europa e l’America. «L’anno scorso — mi ha detto raggiante il signor Tang — ne abbiamo esportati due milioni, ed è solo un inizio. I nostri polli sono i più buoni del mondo. Lei può confermarlo, dopo quel che ha mangiato». NELLA CELLULA MUTAZIONE La cellula infettata diventa una fabbrica che lavora a pieno ritmo al servizio del virus. Tutti i suoi macchinari vengono sequestrati dal parassita: dal sistema di trascrizione del genoma che costruisce copie identiche di Dna o Rna del virus, fino ai mitocondri. Solo dopo aver costruito nuove copie del virus la cellula esausta muore Una mutazione casuale del genoma potrebbe modificare il virus e cambiarne l’ospite. H5N1 oggi prospera nei polli. Una nuova versione potrebbe scegliere l’uomo stre sorelle scimmie: i corridoi sono impregnati di un odore da cascina, fuso ai disinfettanti e al noto tanfo delle mense russe. Cavie e molecole, mangime e colture alcoliche, letame e vetrini: è l’intuizione degli scienziati-contadini ad arginare la forza dei veleni che consumano la vita. Così per le sentinelle delle pandemie, nell’indifferenza generale, l’allarme era scattato già tre anni fa. I collaboratori di Lidia Fadeeva, direttrice della collezione dei virus, avevano scoperto in Russia il nuovo ceppo H5N1. I richiami di Lvov, in un convegno in Giappone e quindi a San Francisco, sono stati ignorati. Fino al maggio scorso, quando i primi contagi hanno mietuto vittime tra i volatili selvatici in partenza dal lago Tsi-Nghaj, in Cina. Nel giro di cinque giorni l’istituto moscovita aveva già isolato il ceppo della “peste dei polli” ed era assediato dagli scienziati di tutto il mondo. Il premio Nobel David Davenport, l’australiano Gren Lever, lo statunitense Rod Webster e il cinese Malik Peiris hanno contattato Lvov. Il Centro di biotecnologia Vektor, nella regione siberiana di Novosibirsk, e l’Istituto dell’influenza di San Pietroburgo, su indicazione dei ricercatori di Mosca, si sono messi al lavoro per individuare un antidoto per l’uomo. «Le sole a tacere per settimane — dice la professoressa Fadeeva — sono state le autorità internazionali. I grandi laboratori dipendono degli Stati, non producono nulla e non creano consenso: i burocrati considerano la ricerca uno spreco, più tagliano i fondi e più fanno carriera. Hanno cercato di minimizzare il pericolo: solo ora che il rischio di una pandemia minaccia di far crollare econo- mie e borse, si ricordano di noi e ci chiedono di neutralizzare il virus». Una richiesta insensata, secondo gli scienziati dell’“Ivanovskij”. Da diecimila anni, periodicamente, la natura si trasforma nel primo bio-terrorista. Nessun virus, fino ad oggi, è stato estinto. L’incubatrice globale, attingendo alla dispensa mobile di animali domestici e selvatici, rifornisce di nuovi veleni la cucina rappresentata dalla Terra. Le epidemie zootiche si scatenano nell’Asia sud-orientale, dove nidifica e sverna l’ottanta per cento dei volatili. Nelle paludi si generano virus ibridi e gli uccelli-camerieri servono gli ignoti mostri nei piatti dei diversi continenti. Per questo, spiegano i ricercatori russi, non esistono influenze epidemiche che non siano aviarie e non esiste virus che non venga trasmesso all’uomo dagli animali. L’influen- za dei polli, scatenata in Cina, per la prima volta venne isolata alcuni anni fa in Italia, vicino a Brescia. «Il fenomeno — dice Lvov — si chiama infezione naturo-focale e sfugge al nostro dominio. Il problema dell’H5N1 è l’altissima virulenza. Fa strage e in fretta. Non può essere trasmesso alle persone dai volatili, ma dai maiali. Se questi prenderanno l’influenza dal pollame, lo scenario può essere catastrofico. I suini contraggono anche l’influenza umana e un tale ibrido, in sei mesi, può uccidere un miliardo di uomini. La malattia, così modificata, sarà trasmissibile da uomo e uomo, la mortalità è stimata nel cinquanta per cento dei contagiati». Le migrazioni degli uccelli, ma pure i trasferimenti aerei, sono in grado di trasportare l’infezione in un giorno da Mosca a Roma, a Londra e a New York. La messa a punto di un buon vaccino per l’uomo può richiedere settimane. «Troppo tardi — sostiene Nikolai Vlasov, responsabile del controllo veterinario del governo russo — anche senza considerare i tempi della produzione industriale e della distribuzione». Per questo, nella banca dei virus di Kurchatov, domina oggi un «fiducioso pessimismo». Sette gruppi di scienziati studiano il virus, la possibilità di una rapida diagnosi, di una profilassi e di una cura. Nelle provette vengono riattivati i veleni collezionati in mezzo secolo. Virus, cavie, luminari della scienza e banditi dell’industria escono dalle tane in cui li avevano cacciati gli antibiotici. «Ma in fondo si è solo risvegliata la natura — sorride Lvov —, se l’Occidente è paralizzato dal panico è perché si era dimenticato della sua esistenza». TESTI A CURA DI ELENA DUSI ILLUSTRAZIONE MIRCO TANGHERLINI VIROLOGO Il professor Lvov, virologo moscovita 34 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 23 OTTOBRE 2005 il reportage Sotto processo Nell’aprile 2003, quando gli americani entrarono nella capitale, una delle loro prime mosse fu quella di abbattere il monumento di Saddam davanti all’hotel Palestine. Molti iracheni li imitarono gettando nella spazzatura e danneggiando i ritratti onnipresenti del dittatore, ma altri si limitarono solo a nasconderli. Un altro simbolo della transizione difficile Bagdad, il culto sfregiato del Raìs BERNARDO VALLI hi gli ha stretto la mano, quando era il Raìs onnipotente, dice che era «morbida e umida». Era una strana sensazione. Quel contatto epidermico molle, appiccicaticcio, contrastava con lo sguardo duro, metallico, che uno incrociava stando al cospetto di Saddam Hussein. Un quarto di secolo fa, nel luglio 1980, l’inglese Robert Fisk era tra i giornalisti riuniti in una sala dell’Assemblea nazionale, qui a Bagdad, per un’interminabile conferenza stampa, protrattasi fino alle prime ore del mattino. Saddam era presidente a pieno titolo da appena un anno, aveva già eliminato (spesso di suo pugno) molti nemici dichiarati e altrettanti amici sospetti, e aveva tante cose da dire alla stampa internazionale. A quell’epoca aveva o pretendeva di avere due ruoli politici di portata mondiale. Agli occhi degli occidentali appariva in effetti come il “nuovo scià”. Nel vicino Iran, il sovrano, Reza Pahlevi, alleato dell’Occidente, e in quanto tale prezioso guardiano del Golfo ricco di petrolio, era stato spodestato dall’ayatollah Khomeini, e il Raìs iracheno, musulmano laico, era visto come un provvidenziale campione da opporre alla rivoluzione integralista islamica trionfante a Teheran. La cosa non dispiaceva affatto a Saddam, il quale aspirava però ad essere al tempo stesso una specie di reincarnazione politica di Gamal Abdel Nasser, vale a dire il nuovo grande leader panarabo. Questo ed altre cose ancora, per ore ed ore, disse o fece capire Saddam Hussein ai giornalisti, quel 21 luglio 1980. Nell’abito a doppio petto troppo largo, con una giacca lucida e una cravatta sgargiante, il Raìs era apparso a prima vista impacciato, ed anche minuto in quell’enorme sala. Ma quando si accostò al microfono e cominciò a parlare, il personaggio si rivelò tutt’altra cosa. Il volume era stato messo al massimo e la voce usciva potente, assordante dagli amplificatori. L’oratore la modulava come se usasse una frusta e l’abbattesse con impeto e sadismo sull’uditorio, quando affrontava un argomento che gli stava a cuore. Robert Fisk trovò più veleno che passione in quel discorso. Poi Saddam strinse la mano a tutti, e Fisk annotò che era «morbida e umida». (Lo racconta nel suo ultimo, ottimo libro, The Great War for Civilisation, 2005, Fourth Estate, London). Morbida e umida era anche la mano di Stalin. Richard Pim, collaboratore di Winston Churchill a Downing Street durante la Seconda Guerra mondiale, ha usato gli stessi aggettivi di Fisk, descrivendo gli incontri che ebbe con il capo del Cremlino. Sul quale Saddam Hussein cercò di modellarsi come Raìs. Si sa che leggeva con passione le biografie di Stalin. Tra Gorki, città natale del georgiano Stalin, e Tikrit città natale del sunnita Saddam, ci sono circa FOTO ABBAS / MAGNUM PHOTOS C BAGDAD alla cintola stile Arafat; con lancia e scudo, a cavallo, come un condottiero leggendario. Voleva essere amato. Ed esigeva che la gente glielo dimostrasse. I suoi ritratti appesi in tutte le case ne erano per lui la prova. Aveva l’abitudine di interpellare a caso gli iracheni, nelle loro abitazioni private, per sapere se gli volevano bene. Naturalmente tutti gli esprimevano la più profonda devozione. Tony Clifton, del settimanale Newsweek, gli chiese durante un’intervista se avesse paura di essere assassinato. L’interprete esitò a tradurre, ma Saddam, che forse conosceva un po’ di inglese, capì la domanda e scoppiò in una fragorosa risata, dette una pacca sulla spalla di Clifton, e gli gridò: «Esci subito da questa stanza. Vai per la strada e chiedi a chiunque incontri se mi ama». Tutti i presenti imitarono Saddam, si misero a ridere anche loro, e continuarono fino a quando lui smise. Così dimostrarono che lo amavano come tutti gli iracheni, e che Clifton aveva fatto una domanda sciocca. Nell’aprile 2003, quando i marines arrivarono all’hotel Palestine, dove mi trovavo, la loro prima iniziativa fu di abbattere la statua di Saddam, al centro della vicina piazza. Le televisioni di tutto il mondo trasmisero le immagini della demolizione, dando l’impressione che gli iracheni si fossero affrettati a ripulire il paese dai ritratti del dittatore. Molti sciiti e curdi in effetti li gettarono nella spazzatura. Pochi sunniti fecero altrettanto. Adesso non li mettono più tanto in mostra, ma li hanno conservati. Non sono più appesi nell’ingresso, come una volta, sono stati relegati in qualche angolo. Un piccolo commerciante, con un negozio a Karradieh, lo tiene in un cassetto. Lo distruggerà, dice, quando sarà sicuro che Saddam sia morto. Neppure tra coloro che hanno ancora la fotografia dell’ex Raìs accanto al letto sono molti a sperare sul serio in un suo ritorno al potere. Capita che i vari gruppi dell’insurrezione armata si richiamino a lui, lo considerino ancora il Raìs nei comunicati, ma si tratta di una fedeltà simbolica. Saddam non ha mai guidato la guerriglia. Non l’ha animata, nei mesi precedenti alla sua cattura, avvenuta nel dicembre 2003, non lontano da Tikrit. L’opposizione armata si è formata indipendentemente da lui. Gli omaggi resigli e i ritratti conservati come reliquie più che esprimere attaccamento alla persona di Saddam sono segni di protesta contro la presenza delle truppe straniere, e la loro incapacità di far ritornare il paese a una vita normale. La sua comparsa in tribunale, mercoledì scorso, ha acceso le passioni: da un lato l’odio per il Raìs sanguinario dall’altro il ricordo di un Iraq “ordinato”. Il nazionalismo conta: non sono in pochi, anche tra coloro che hanno bruciato le immagini di Saddam, a rimproverare agli americani di avere frantumato l’Iraq, che lui, Saddam, teneva unito. Sia pure col terrore. ottocento chilometri. Due mondi lontani uno dall’altro, ma nelle vicende familiari dei due personaggi ci sono alcune somiglianze. I biografi sottolineano che hanno avuto entrambi madri di forte carattere e padri che li maltrattavano. E più tardi entrambi hanno tradito i potenti all’ombra dei quali erano politicamente cresciuti. Negli anni Settanta, ormai al potere, Saddam fece un pellegrinaggio nell’Unione Sovietica: visitò con religiosa attenzione le ville sul Mar Nero in cui Stalin spesso soggiornava e i palazzi monumentali del regime, alcuni dei quali dell’epoca zarista. A quei grandiosi edifici si è probabilmente ispirato quando ha fatto costruire i palazzi imperiali ed inutili sulle rive del Tigri. Un commerciante tiene l’immagine dell’ex dittatore in un cassetto: la butterò via solo quando sarà morto LE FOTOGRAFIE Qui e nella pagina accanto una serie di foto delle icone del Raìs sfregiate dopo la caduta del regime. Gli scatti sono dei reporter delle agenzie Abbas, Magnum e Contrasto Saddam imitò anzitutto il culto della personalità di cui si circondava Stalin. All’inizio si fece osannare come una nuova versione di Haroun al -Rashid, il califfo dell’epoca d’oro degli Abbassidi. Lui era venuto a resuscitare la defunta gloria della Bagdad antica. Poi cercò via via di imporsi nella più inquietante veste di un guerriero arabo. I suoi ritratti hanno invaso il paese: le banconote, le piazze, gli edifici pubblici, le scuole, le abitazioni private più lussuose o più umili, esibivano la figura del Raìs nelle più diverse fogge e posizioni: vestito da curdo, come un moderno Saladino; con la kuffiah araba; in doppio petto come un uomo moderno; in divisa da guerrigliero intento a scavare trincee; con la pistola NELLA STORIA NERONE LUIGI XIV MUSSOLINI STALIN MAO La gigantesca statua di Nerone, detta Colosso, che per Svetonio era alta 36 metri e sorgeva vicino al Colosseo, fu abbattuta dai barbari Una delle prime vittime della Rivoluzione francese fu la statua equestre di Luigi XIV, simbolo del Re Sole, distrutta dalla furia popolare Tra due ali di folla in festa, il 25 luglio 1943, un’enorme testa di Mussolini viene staccata da una statua, che viene abbattuta e issata su un camion Nel 1956, con la rivoluzione, una colossale statua di Stalin viene tirata giù a Budapest: la testa rotola, le scarpe restano sul piedistallo Nel giugno ’89, durante una manifestazione in piazza Tienanmen, un barattolo di vernice blu viene lanciato contro il ritratto di Mao Repubblica Nazionale 35 23/10/2005 FOTO ABBAS / MAGNUM PHOTOS DOMENICA 23 OTTOBRE 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 35 36 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 23 OTTOBRE 2005 l’inchiesta I grattacieli più alti d’Europa, tre milioni di auto in un ingorgo di Bmw, Rolls e Lamborghini, venti ristoranti inaugurati ogni mese con marmi e rubinetti d’oro: è il fiume di denaro che investe la Russia di Putin. Con un’emergenza malavita Mosca senza regole SANDRO VIOLA col record di 33 super ricchi Un inizio secolo da ricordare Tutto vero. Eppure i russi ricorderanno questo inizio di secolo, gli anni di Putin. Il mare di soldi che si riversa in Russia col petrolio oltre i 60 dollari, le riserve della Banca Centrale vicine a 160 miliardi di dollari, altri 50 miliardi accumulati in un “fondo di stabilizzazione” per il giorno che i prezzi del petrolio dovessero calare. Durerà? Forse sì, forse no. Il quadro russo (con 25 milioni di persone sotto la linea di povertà, e 40 in case senza acqua corren- FOTO LAIF/CONTRASTO Mai in nessuna parte del mondo si erano visti nascere patrimoni tanto grandi in così poco tempo: a detta di Forbes la città è in testa alle classifiche FOTO MAGNUM /CONTRASTO Qui a destra, dall’alto l’apertura della Fiera del lusso, un campo di polo a Mosca, un’altra immagine della Fiera e la discoteca “Titanic” durante una festa. Nella foto grande, l’icona di Vladimir Putin che domina la cerimonia di apertura della Fiera del lusso Nell’altra pagina, l’interno di uno dei ristoranti della capitale russa FOTO AFP I NUOVI PADRONI enerdì, le nove di sera. Siamo seduti in quattro dentro una Bmw ultimo modello: io, un amico italiano che lavora qui da anni, un suo conoscente russo che ci ha invitati a cena, e al volante l’autista del russo. Abbiamo lasciato il mio albergo sulla Tverskaya quasi un’ora fa diretti all’Arbat, sì e no quattro chilometri in linea d’aria, e siamo ancora intrappolati nel traffico. Il traffico di Mosca è ormai l’inferno in terra. I moscoviti lo chiamano “probka”, che significa sughero, immagino per dare l’idea dell’imbottigliamento. Procediamo infatti molto più lenti che a passo d’uomo, in un continuo strombettìo di clacson, e guai ad aprire il finestrino: l’aria che entra è puzzolente, irrespirabile. Mattina, pomeriggio e sera è sempre così. Sempre “probka”, sempre smog. Fiumi d’automobili, quasi tutte grandi automobili straniere, e moltissime di lusso o di gran lusso. Davanti alla nostra auto c’è stasera una Rolls Royce bianco latte, alta come un grosso furgone, sulla sinistra arranca una Porsche Carrera. E infatti tra i tanti che a Mosca stanno facendo affari d’oro ci sono gli agenti delle grandi case automobilistiche europee. Di Bentley, per esempio, quest’anno ne sono state già vendute 260 a 230mila euro l’una. E il nostro ospite russo racconta: «Il rappresentante della Porsche ci diceva l’altra sera che è come un tempo con i principi sauditi. Quelli che vanno da lui a comprare un’automobile, non si soffermano neppure per un attimo sul prezzo: il tempo di guardare, scegliere, e già hanno in mano il libretto degli assegni…». Il russo è proprietario d’una delle maggiori aziende di pubblicità della capitale. Molti dei giganteschi pannelli che stiamo a poco a poco fiancheggiando nelle strade sfavillanti di luci — cosmetici, elettronica, abbigliamento, birra — sono usciti dai suoi studi. Com’è ovvio, dell’ondata di prosperità che ha investito Mosca non si lamenta. Ma viaggia molto, ha una casa a Vienna, e questo lo porta a guardare le cose con occhio critico. Così, mentre procediamo lentissimi nel traffico, mi indica tre o quattro degli orribili palazzi d’appartamenti che stanno spuntando come funghi nel centro di Mosca. «Vede?», dice il pubblicitario: «È come se i nostri architetti lavorassero ubriachi: non c’è una linea riconoscibile, una decorazione accettabile, l’ombra d’un gusto. Noi lo chiamiamo “realismo capitalista”. Ma Mosca è strapiena di danaro, e nel momento in cui s’avvia la costruzione d’uno di questi palazzi di lusso (garage sotterraneo, palestra, portieri notturni), tutti gli appartamenti sono già venduti in partenza ad almeno novemila euro il metro quadrato…». Una brusca frenata dell’autista, una pausa, poi il nostro ospite conclude: «D’altronde, parlare di gusto in Russia non ha senso. I settant’anni del comunismo hanno cancellato, incenerito il senso estetico dei russi…». FOTO AFP MOSCA te che vanno ad attingere l’acqua nel laghetto più vicino) è ancora troppo vacillante per consentire previsioni attendibili. Ma per ora Mosca è una specie d’Eldorado. Uno sviluppo urbanistico impetuoso, i grattacieli costruiti a tempo di record (uno dei quali, il Triumph, è l’edificio più alto d’Europa), tre milioni d’automobili in una città dove cinque anni fa ce n’erano appena 700mila. Venti nuovi ristoranti inaugurati ogni mese (due o tre dei quali sfarzosi, con toilettes arredate di marmi, cristalli e rubinetterie dorate), i negozi del centro aperti sino alle dieci, le undici di sera. In nessuna parte del mondo mai s’era mai visto nascere delle grandi ricchezze in così poco tempo. Non nell’Ottocento dei “baron robbers” in America, e neppure sullo sfondo della prodigiosa crescita cinese. Secondo la rivista Forbes, specialista in questo tipo di calcoli, a Mosca ci sono infatti 33 miliardari in dollari, più che in qualsiasi altra metropoli dell’Est o dell’Ovest. E i milionari sono molte migliaia. Tutti contraddistinti da un tratto che li rende diversi dai ricchi del resto del mondo, e da ogni borghesia in formazione: l’impulso alla spesa. Una febbre, una frenesia dello spendere. Tanto che una grossa finanziaria internazionale come la Merril Lynch, ne parla diffusamente in un suo rapporto del mese scorso: i russi ricchi sembrano “unwilling to save”, senza la minima voglia di risparmiare. Certo, i ricchissimi non riescono a spendere tutto quel che hanno accumulato. Trasferiscono i loro capitali all’estero (oltre 30 miliardi di dollari l’anno scorso), comprano palazzi a Londra e ville sul lago Lemano. Ma i nuovi milionari gareggiano gli uni con gli altri nella corsa ai consumi di lusso, investono in un modo di vivere: i sigari più cari, gli orologi di platino, le Bentley e Maserati, le vacanze a Saint Moritz o a Montecarlo. «Un po’ come bambini che non hanno mai avuto un giocattolo», mi diceva ieri un sociologo intelligente, Gheorghij Satarov, «e un giorno vengono fatti entrare in uno stanzone colmo d’ogni tipo di giocattoli. Vorrebbero prenderli tutti, non lasciarne neppure uno…». Quando finalmente arriviamo al ristorante, do un’occhiata intorno. Stranieri ne vedo pochi, due o tre tavoli in tutto, il resto sono russi. E il perché lo capisco guardando la carta: i prezzi sono piuttosto alti, anche se non quelli dei quattro o cinque ristoranti più costosi della capitale. Quando l’avevo visto un paio di giorni fa, il più autorevole gastronomo moscovita, Serghieij Cernov, me l’aveva preannunciato. «Gli stranieri stanno diventando rari, nei ristoranti alla moda. Per loro, tolta la trentina di dirigenti delle compagnie petrolifere internazionali che operano in Russia, sono ormai troppo cari. Solo i russi, infatti, spendono senza alcun rammarico 200 euro a pasto». Ma al tavolo di fianco al nostro, mi fanno notare i miei due commensali, si sta spendendo forse più di 200 euro a persona. Al tavolo sono seduti un uomo e tre donne. L’uomo è robusto, pletorico, con una camiciola a maniche corte. Le donne sono maltruccate e malvestite, i gesti eccitati, la sigaretta sempre accesa. Stanno spen- FOTO ITAR-TASS La fiera dei miliardari nella capitale malata V dendo molto, perché da quando siamo arrivati hanno bevuto due bottiglie d’un famoso vino rosso italiano, e col dolce, più tardi, ordineranno la terza. Il mio amico si fa dare la lista dei vini, scorre i prezzi: quelle bottiglie costano 270 euro l’una. Miliardari, milionari? «No, non credo», risponde il pubblicitario: «Direi piuttosto che l’uomo è un funzionario provinciale o regionale, e il gruppo si trova a Mosca in gita. Di stipendio ufficiale, l’uomo non avrà più di 5-600 euro al mese. Ma i suoi introiti possono essere molto DOMENICA 23 OTTOBRE 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 37 Repubblica Nazionale 37 23/10/2005 MAGNATI IN ASCESA Controllano petrolio, banche, materie prime. Nell’elenco dei paperoni di tutto il mondo, i giovani leoni russi sono passati da 17 a 33 e continuano a fare miliardi anche in prigione. Come Mikhail Khodorkovsky, l’uomo più ricco della Russia, salito al 16esimo posto nella classifica mondiale. Il fatto che sia stato arrestato per evasione fiscale e frode non ha impedito alla compagnia Yukos, nucleo del suo impero economico, di continuare la sua ascesa. Intanto, l’eterno numero due, Roman Abramovich, tenta il sorpasso e, non contento di aver comprato il Chelsea e strappato Crespo all’Inter, continua a investire nel mondo del calcio e non ci pensa nemmeno a tornare in Russia per non correre il rischio di finire pure lui in prigione. Ma c’è anche chi dirotta la ricchezza verso la cultura, come il magnate dell’alluminio Oleg Deripaska; oppure l’azionista di maggioranza dell’acciaieria Novolipetsk, Vladimir Lisin, che tra tutti ha compiuto il maggior balzo in avanti con i suoi 3,8 miliardi di dollari di fortuna. Il re dei diamanti, Lev Leviev, vive in Israele, mentre alla larga dalle guardie di frontiera, in esilio forzato, si tengono Boris Berezovski e l’ex magnate televisivo Gusinski (ilaria zaffino) genti richieste ai piccoli-medi imprenditori russi, e una miriade di esazioni illecite imposte quotidianamente ad ogni angolo del paese. I 23.000 dollari che i funzionari degli organi di controllo (sanità, vigili del fuoco, polizia fiscale) estorcono con la minaccia d’una denuncia a commercianti, costruttori edili, ristoratori eccetera, i 6-700 dollari che servono a corrompere i medici d’un ospedale per ottenere un ricovero, i medici militari per esentare un giovane dagli obblighi di leva, gli insegnanti per facilitare una promozione. Nelle classifiche internazionali sui paesi più corrotti, la Russia figura infatti a fianco del Niger, della Sierra Leone e dell’Albania. E questo nell’indifferenza non solo dell’uomo della strada, ma anche di quella borghesia in formazione, il settore più moderno e intraprendente oggi sulla scena, ancora incapace di darsi i lineamenti e il minimo di rigore d’una società civile. «Il fatto è che la Russia», conclude Satarov, «è così abituata alla corruzione degli apparati burocratici, che la gente non si rende conto dell’effetto disastroso che essa produce sull’economia. Tanto è vero che quando i nostri sondaggisti domandano quali siano i problemi più gravi del paese, la corruzione figura al nono o decimo posto. Mai più avanti». alti. E sto parlando, si capisce, d’introiti illeciti…». Nel suo ufficio all’Indem, il centro di ricerche sociologiche che dirige, Gheorghij Satarov m’aveva illustrato le dimensioni mostruose, la crescita irrefrenabile della corruzione in Russia. Una sua inchiesta pubblicata due mesi fa (rimasta senza alcuna smentita da parte del governo e pressoché ignorata dai maggiori organi d’informazione, che sono sotto tutela del Cremlino) sostiene infatti che nel corso del 2004 sono illecitamente passati di mano 310 miliardi di dollari. Dieci volte di più che nel 2000, l’anno dell’insediamento di Putin. Questa cifra impressionante comprende ogni tipo e misura di concussione: dalle poche migliaia di rubli pagati per tacitare la polizia stradale nel caso d’una infrazione, alle tangenti da 100-120mila dollari che un’impresa straniera deve versare agli alti funzionari della burocrazia statale o regionale per ottenere una concessione, una licenza, i diritti su un terreno edificabile. In mezzo ci sono poi le tan- Alla sorgente del lusso È dunque questa la sorgente d’una gran parte del tumultuoso fiume di danaro che scorre ogni giorno a Mosca, e si configura nei ristoranti, per esempio, in forma di bottiglie di vino da 270 euro ciascuna, o sulle spiagge italiane, spagnole e francesi con falangi di piccoli burocrati delle amministrazioni locali e statali i cui stipendi non permetterebbero neppure un fine settimana a Pietroburgo. Introiti illeciti, dunque, i frutti d’una corruzione che pervade l’intero corpo sociale in ogni angolo del paese. E contro la quale il potere politico non riesce a reagire, o non ha interesse a farlo. Di quando in quando Putin tuona contro la burocrazia corrotta, e nel 2002 aveva addirittura varato una commissione ad hoc. Ma inchieste e processi esemplari non se ne sono ancora visti, e quanto alla commissione mi dicono che si sia distinta solo per la profondità del suo letargo. Resta da domandarsi quali siano i motivi che spingono i russi ricchi all’ostentazione continua, come ossessiva, dei loro soldi. Ai modi sfrontati, al limite dell’inverecondia, con cui li spendono. E qui la risposta è complessa. C’è un carattere nazionale, la tendenza alla dissipazione di aristocratici, borghesi e contadini così com’è descritta in tanta letteratura russa. Impossibile dimenticare, infatti, che la prodigalità dell’aristocrazia russa (i Dolgorukin, gli Stroganov, i Demidov, gli Sheremetvo) sbalordì tra Ottocento e primissimo Novecento le altre aristocrazie europee. E poi ci sono i traumi. Unici nella storia, i russi hanno visto dissolversi in un solo secolo due imperi, quello zarista e quello sovietico. E le generazioni di cui stiamo parlando, gli arricchiti d’età tra i quaranta e i cinquanta, hanno conosciuto lo sbandamento ideologico e morale prodotto dal crollo della superpotenza comunista. Così, il ricordo della vita di privazioni, di semi-miseria condotta sino a quindici anni fa, mischiato all’improvvisa ricchezza dell’oggi, si traduce in un sentimento di precarietà, in un timore del futuro, che li porta, come dice Satarov, a riempirsi le braccia di giocattoli. Purtroppo non l’ho vista, perché l’avevano chiusa un paio di giorni prima del mio arrivo a Mosca. Ma alla fine di settembre, racconta il pubblicitario russo mentre pranziamo, s’era aperta una Fiera dei milionari in cui si sono accalcate per quattro giorni folle enormi. Non tutti erano lì per acquistare, beninteso: la maggior parte c’era andata soltanto per vedere le Bentley e le Rolls Royce, le Ferrari, le Maserati, le Porsche e le Lamborghini. E oltre alle automobili, i diamanti, le pellicce, gli elicotteri e le foto delle isole in vendita. «Ci sono rimasto un’ora», dice il russo, «con un leggero senso di nausea. Tutto era davvero incredibile. Comprare una Lamborghini in un paese che ha poche strade su cui si possa guidarla, e guidarla solo pochi mesi perché poi le strade si coprono di neve, è assurdo. Un’idiozia. Ma c’era anche di peggio. Vari completi, da donna e da uomo, fatti con banconote da 500 rubli cuciti insieme. Se qualcuno li abbia comprati, non lo so. Ma basta pensare che gli organizzatori della fiera abbiano avuto l’idea di esporli, per cogliere la volgarità dell’iniziativa e di tutti quelli che l’hanno apprezzata». Questa è la “slivki obshchestva”, la migliore società, nella Russia d’oggi. E a volte mi tornano alla memoria le riviste per famiglia dell’era sovietica, che sfogliavo sempre per vederne le fotografie. Rabotnitsa, la donna che lavora, oppure Krestyanka, la contadina. Inutile dirlo, lo squallore di quelle riviste era tale da stupire e intristire chi giungeva da Occidente. Ma è vero che neanche la Fiera dei miliardari dà allegria. Uno studio sostiene che nel 2004 sono passati di mano illegalmente 310 miliardi di dollari, dieci volte di più del 2000, l’anno dell’insediamento di Putin 38 LA DOMENICA DI REPUBBLICA i luoghi DOMENICA 23 OTTOBRE 2005 Labirinti d’Oriente Alla scoperta della capitale siriana con una guida straordinaria: il più grande poeta arabo vivente che ci accompagna a interrogare minareti, rovistare mercati, esplorare strade e vicoli, sfogliare la storia scritta su archi e colonne. Fino a farci travolgere e spiazzare dai giochi di prestigio di una città dove “l’immaginario si trasforma in realtà e la realtà in immaginario” Adonis e la magia di Damasco ALIX VAN BUREN N DAMASCO Repubblica Nazionale 38 23/10/2005 on si dice no a Adonis, a quella chioma scompigliata da “poète maudit”, da Rimbaud siriano. Lui, poeta errante, panteista mistico, cantore massimo del mondo arabo, non contempla un rifiuto. Anche quando, col suo sguardo da sfinge, antico e spericolato, propone di scalare il cielo, perché da lassù — e guarda in alto verso la mezzaluna sfavillante nel cielo sopra Damasco — là dove albergano i semidei, Gilgamesh, Venere Ishtar, Ba’al, gli eroi e la memoria, si osserva con più chiarezza la sorte dell’uomo. «Alle quattro del pomeriggio, al Caffé al-Nawfara, sotto il minareto grande». Stargli dietro sarà un’impresa. Lui lo chiama un «gioco edenico». Si tratterà di interrogare minareti, rovistare mercati, sfogliare vicoli, ribaltare archi e colonne, pietre disperse sull’ombelico di Damasco come «lettere di un alfabeto antico». E in ogni piega e fossato rintracciare la presenza dei suoi maestri: Ibn ‘Arabi, il divino mistico andaluso; Al-Niffari, il derviscio ramingo; e sui nostri passi sempre lui, Gilgamesh-UlisseAdonis, l’eroe del dubbio, dell’inquietudine universale, che fa svaporare ogni confine fra Oriente e Occidente. Inutile porre domande. Lui non conversa: scaglia versi. «Qui spesso l’immaginario si trasforma in realtà, e la realtà in immaginario», annuncia il poeta col suo riso argentino e infantile. «Ma questo lo dice il bambino che è in me. L’anziano mi ripete da tempo che i pensieri hanno una vita effimera. Cadono come frutti, senza che alcuno vi presti attenzione». Il Caffé al-Nawfara Per raggiungerlo si costeggiano le mura biancheggianti della Cittadella e siepi di fantasmi: emiri morti per difenderla, crociati e mongoli per conquistarla. Si supera la Grande Moschea, una meraviglia del mondo dei califfi. Lasciandosi a destra l’imboccatura del sûq al-Hamîdiyya — i budelli dei mercati coperti da una volta di metallo traforata dai proiettili della rivolta del 1925 contro i francesi — si curva a sinistra fra mercanti di tappeti, di antichi quadranti e astrolabi, facendosi largo fra bottegai accovacciati su sgabelli di cuoio e infervorati nel gioco del tric trac, il backgammon siriano. Ed eccolo: incorniciato dall’arco di Giove compare lui, Adonis, sigaro cubano, jeans e giacca blu. Lo possiede la stessa flemma con cui riceve a Parigi al Flore o ai Deux Magots, esule da quarant’anni coccolato dalla Senna: il suo rifugio dalle tirannidi del mondo arabo. Soffia il khamassin, lo scirocco, rabbuffa gli alberi, fa volare palloncini e preghiere, e alza muri di sabbia fino a trenta metri. Però l’oasi del Ghouta, che fa da corona alla città coi suoi frutteti, li ferma. Il khamassin vela il cielo, bigio. «Il cielo non è né azzurro né grigio. Non ha colore. Il cielo ha un odore», s’accosta lui, serafico. Sopra al Nawfara il cielo ha l’odore del tabacco di Lattakya bruciato dai narghilè, o del massel speziato alla mela (una moda, lui s’imbroncia, importata dall’Egitto) e degli infusi di fiori. Sa delle pietre millenarie di calcare che troneggiano dai muri della moschea, dei tappeti beduini rossi e neri cotti dal sole, e del kaak bisoumson, i pani tondi al sesamo, caldi di forno, impilati sul vassoio di un garzone che caracolla fra matrone, barbieri e bottegai. Si mescola agli effluvi delle carovane, che dalla Cina, dall’India, dalla Persia arrivavano al Caravanserraglio, dietro l’angolo, per distribuire il carico fino a Venezia. Il rumore dei loro passi, «tenda l’orecchio», fa Adonis, «continua a risuonare nella polvere del sole». «Oggi il cielo, se vuole, è un nettare. È dolce. Indolente come il tempo, come l’eternità: ha una bocca che non smette di sbadigliare». «Ma ora sediamoci qui, sieda anche lei. Guardi: s’è seduto anche il sole. Qui, sul bordo delle tazze, sul tavolino di ferro scrostato dalle braci, sul narghilè. E lassù, guardi: s’è seduto anche in cima al minareto». Già, il minareto, quella «parola verticale» che s’innalza nello spazio sopra di noi, a creare il primo spaesamento. Infatti è il minareto di Issâ, cioè di Gesù. Qui, secondo l’Islam, avrà luogo la battaglia apocalittica: Gesù, giunto il Giorno del Giudizio, ridiscenderà da questa torre per combattere l’Anticristo. Adonis, cantore dell’amore assoluto e testardamente laico, fa spallucce: «Il sacro si mescola al profano», indirizza lo sguardo verso la soglia del ristorante all’ombra della santa cuspide: «Dio è un affare e la religione un grande mercato». Sussurra: «Noi crediamo tutti in un solo Dio, e però ciascuno pretende che il proprio è migliore, e proclama guerre per difenderlo. Siamo precipitati tutti assieme, musulmani ebrei e cristiani, nei tempi più bui dell’umanità: incolonnati dietro un dio armato, che scaglia missili nel mondo. Questa è una guerra fra dei; anzi, in seno al monoteismo». Si scalda: «Noi poeti, noi pensatori, noi filosofi abbiamo un compito urgente: immaginare una nuova spiritualità per il terzo millennio. Dobbiamo partire da lontano: da Abramo. Interrogarci se il monoteismo sia stato storicamente un progresso rispetto all’uomo — in termini di pensiero, di filosofia, di arte — o piuttosto una regressione, portatrice di violenza». Conclude: «Fa tremare quel dio che, in senso religioso, non ha più nulla da dire perché la verità è stata rivelata una volta per tutte, e resta nulla da scoprire. Un mondo sbarrato per sempre. Infatti, dov’è l’uomo? Eccolo, guardi, il capo prostrato a terra. Nel misticismo invece l’invisibile continua a parlare, all’infinito...». Dal balcone del minareto i muezzin chiamano alla preghiera dell’Asr, del pomeriggio; il coro piomba sul Caffè, dilaga fra i tavolini: «Andiamo, su venga. Prima che s’alzi la sera corriamo a salutare Muawiyah. Poi torneremo, per ascoltare il cantastorie». ‘‘ Adonis Il rito della bellezza, solo, fonda la voluttà su questa terra. A Damasco la casa è stata costruita perché il paradiso scenda sulla Terra e vi resti, e la consideri un altro paradiso Da ALEP Imprimerie Nationale Editions IN LIZZA PER L’ULTIMO NOBEL Ali Ahmad Said Esber, più noto come Adonis, è considerato tra i maggiori poeti contemporanei di lingua araba ed è stato tra i favoriti all’ultimo premio Nobel. Nato a Qassabin in Siria nel 1930, nel 1957 pubblica la prima raccolta di poesie. Attivissimo nel dibattito culturale, fonda il gruppo Tammez. I suoi ultimi libri pubblicati in Italia sono Cento poesie d'amore, Guanda, Libro delle metamorfosi e della migrazione nelle regioni del giorno e della notte, Mondadori Il segreto del Califfo Muawiyah ibn Abu Sufyan era un califfo; anzi, il primo degli Omayyadi, il quinto dell’Islam, nel 661. Fece Damasco grande e bella, qui fondò il primo Stato arabo, e ne riversò le glorie, la scienza, la poesia, oltre la catena del Tauro, lungo le sponde del Mediterraneo, fino a Cordoba e Siviglia, e a est fino all’India e all’Asia centrale. «Però, vedrà che sorpresa la sua tomba». Con quel mistero ci infiliamo nei vicoli di Haraj Anna Kachate. Fra mura cieche d’argilla, esplodono le risa dei bambini scalzi. Qui avrà camminato Muawiyah. Beveva vino, come i siriani oggi, delle uve dolci di Hawran e di Saidnaya. Riempiva le coppe di nettare al tempo in cui le coppe dell’Islam già si colmavano del fiele dottrinario. Divise l’Islam della vita dall’Islam della morte, in questa città che da più di mille anni oppone al fondamentalismo i versi dei suoi poeti. Ma cos’è il tempo? «Cosa sono le parole? Non chieda: imiti la rosa, e se deve parlare, pronunci soltanto il profumo». L’oggi si rispecchia tal quale nel passato. Infatti, superata un’ansa, dalla calle affiora una cupola pallida. È la tomba di Muawiyah, solitaria e disadorna. Si direbbe dimenticata. Dietro un cancelletto scardinato mostra promossa e realizzata da sbuca una famigliola che fa da guardia al califfo. «Mamnouo! Vietato!», si scalmana la donna per sbarrare il passo. Cinque bambinelle le sgusciano di sotto le vesti, dai triangoli d’ombra che il sole disegna all’interno della soglia. Le monelle alzano un tale incomprensibile baccano, uno stormo di uccelli starnazzanti, che presto ripieghiamo sui nostri passi. Svanisce il viso ambrato della donna, una Balkis, una regina di Saba. «A Salomone-Suleiman lei domandò: “Di che colore è Dio? ”. Lui restò confuso». «Voilà, ha visto anche lei», commenta Adonis: «Così giace il padre dell’impero: inviso ai tiranni». In realtà attorno alle lastre sconnesse del sepolcro divampa ancora, dopo 1350 anni, l’inconciliabile inimicizia fra sciiti e sunniti: da quando Muawiyah fu nominato califfo al posto di Ali, il genero del Profeta, il quale riparò a Kufa, in Iraq, dove fu assassinato e viene ancora pianto martire. L’autorità nel mondo islamico fu per sempre divisa fra le corti secolari dei califfi-monarchi, e la severa teocrazia degli imam sciiti. Sicché capita che i pellegrini sciiti si rechino a questo misero tumulo per scagliarvi sassi e manciate di terra. Ora Adonis tuona: «Sì, la mia società è tutta da rifare, dalla A alla Z. Si dice confessionalismo, ma sotto il manto dell’Islam si camuffano le tribù. Il padre tribale e il dio si sono fusi in uno. Tutti i leader arabi sono cattivi padri, piccoli dei: è un dispotismo antichissimo. Però l’Occidente è complice: ama avere di fronte a sé un despota, un oscurantista arabo. Si sente a disagio di fronte a un interlocutore al suo livello. Quasi volesse che il mondo arabo vegeti, al di fuori della Storia». L’oceano dei sûq Tra il brontolio di un camion e i richiami dei contadini che vendono pistacchi, sfociamo nel sûq al-Hamîdiyya, tra i più antichi al mondo. Poco distante c’è il sûq Madhat Bâchâ e più in là quello della lana, delle spezie, delle donne coi mercanti d’ambra, e poi ancora dei flauti, delle sete... Camminiamo fra strade, «campi di piante carnivore». I visi, «farfalle senza ali». La faccia di una beduina, «ben più che un giardino da guardare». Un negozio dove propongono piante medicinali, unguenti, fortificanti e stimolanti, sciroppi di saggezza per la testa, sciroppi d’amore per il cuore... «Qui si apprende la saggezza dell’eternità». Adonis appare e scompare. Si dilegua nelle ombre, la sua voce chiama dal fresco di un antro profumato di gigli. Eccolo, beato, porge il lembo di un tessuto. «È un abito ricamato dalle mani di una donna di Sarakeb, nel nord». Dal lampo che gli attraversa gli occhi si capisce che in quell’arabesco il poeta ha indovinato l’essere umano: «Nessuno parla mai della grandeur della mano araba, che ha creato capolavori meravigliosi. Si parla di cervello creativo, ma la mente ha binari rigidi. Negli arabi la testa è imprigionata, ma la mano è libera. Tutte le ideologie detestano il corpo, ignorano il piacere di quell’essere straordinario che è l’uomo». Ci siamo, si rivela il Sufi: «I mistici arabi dicevano che lo spirito è il corpo, e il corpo è la libertà totale. In particolare, il corpo femminile. Solo attraverso di esso si accede all’invisibile». william congdon 1912-1998 analogia dell’icona un cammino nell’espressionismo astratto Vicenza, contra’ Santa Corona 25 3 settembre - 13 novembre 2005 da martedì a domenica dalle 10 alle 18 L’atelier del pittore La ricerca dell’“uomo universale” esige un ultimo saluto: qui dietro è nascosto lo studio di Moudarres, pittore, musicista e poeta, astro nell’olimpo dell’espressionismo mondiale, complice di Adonis da sempre. Lo cerchiamo dietro mura in mattoni crudi seccati al sole, fra case aperte verso l’interno su giardini dove fioriscono il limone, l’arancio amaro, il gelsomino d’Arabia. Oltre gli usci tutto è fresco, silenzio e piacere degli occhi: quadrati di basalto e marmi, fontane fruscianti, il canto degli uccelli. «In queste case dubiti del nulla», è soave Adonis: «Quasi che l’uomo sia capace d’abitare i suoi sogni». E qua e là, lungo la corsa, si schiudono hammâm coi bagni dai nomi profumati: bagno al muschio, alle rose, della bellezza, della porcellana, della regina... unguenti di zenzero e cannella... Naeeman, «che la pienezza del paradiso sia su di te», ti dicono i siriani quando esci dal bagno, anche dalla vasca di casa. Quanto è lontano l’Occidente. Ed ecco, svicolando in un budello, si apre su via al-Marioud l’atelier di Moudarres. Sulla porta di legno sono scomparsi i foglietti spillati coi suoi aforismi: «L’uomo è più bello della ragione». Qualcuno li ha raccolti per comporne una summa letteraria. Via le fotografie di Sartre e di Moravia, lui cresciuto alla Scuola romana, tornato a Damasco a elaborare la sua corrente di “espressionismo musicale”. Non s’odono più le musiche sufi. Moudarres da cinque anni è sepolto a Bab Assahir. Ma le sue opere, Il Derviscio e i Gitani, I profughi, sono esposte in città alla Galleria Atassi (e a Parigi, Berlino, New York). «Allunghi la mano, tocchi gli spettri che si alzano nel suo spazio»: dalla tela vengono incontro sguardi di sacerdoti, oranti, turiferari, antichi copricapi, i colori della terra di Aleppo. «Da questo si riconosce un capolavoro: quando, appena posati gli occhi, i colori cominciano a cantare». Si naufraga nell’immensa memoria siriana: l’uomo ridiventa assiro, babilonese, mesopotamico, discepolo di Ba’al e Bèl, Ashtar e Adonis, Gilgamesh e Goudèa. Il cantastorie S’alza il crepuscolo e dal cielo arriva il coro del Maghrib. Di corsa. Abu Shad, l’ultimo hakawati, il cantastorie pubblico, sta per salire sulla pedana del Nawfara. «Non cerchi di capire: osservi». La sala è calda delle braci dei narghilé. Sotto le lucerne arabe, inizia la lettura delle notti del passato. È un’epopea l’anno divisa in 365 libretti, ogni notte un libretto. Quest’anno, per ironia, è la saga di Saladino e i Crociati. Abu Shad si calca il tarbush in testa, si aggiusta il corpetto e il séroual, poi prende a recitare gli appellativi di Dio. «D’un sol colpo di spada spiccò cinquanta teste». È il duello fra il crociato Sama’an e l’emiro Assaid. L’emiro si lancia al galoppo, rotea la spada, e andaha... e a quel punto... Abu Shad impugna la sciabola di latta, la rotea, la sbatte con gran frastuono sul piano di metallo. «Com’è ostinato il sogno della vittoria!», bisbiglia Adonis. Il cantastorie, aggrappato a quel sogno, dice: «Damasco non è mai caduta in mano ai Crociati. Se verranno, mi farò calpestare per fermarli. Meglio un oppressore di casa, che uno straniero». Ma anche il sogno fatuo del cantastorie, come dice Adonis, resta appeso a queste pareti. Dalla Moschea sta per piombare il canto dell’’Isha con il profumo della notte. «La notte, Damasco non dorme», è sereno Adonis. «Si dice: “quando dorme, il suo sonno è leggero come il sogno”». Arrivederci, as-Salaamu ‘alaykum, Monsieur Adonis, uomo del Mediterraneo, della Senna e dell’Eufrate. «Ci rivedremo, ci rincontreremo. Mi aspettano a Berlino, poi a Madrid, Parigi, Siena e Beirut. Prima o poi tornerò. Ma non so se è così. Quando credi di farti incontro a Cham, Damasco, è lei ad avanzare verso di te, dopo una lunga traversata dei secoli». «Però si volti, presto»: dalla moltitudine escono due occhi roventi su una giovane faccia a triangolo e un sorriso smagliante. «Visto? Era Gilgamesh anche lui». Il ragazzo guizza via sulla bicicletta, una cesta traboccante di erbe agganciata al sellino. Sulla scia s’alza una sbuffata di menta. E le eterne domande di Gilgamesh/Adonis: cos’è l’universo, c’è ancora spazio in questo mondo per la poesia? FOTO REUTERS DOMENICA 23 OTTOBRE 2005 FOTO CORBIS / CONTRASTO IL PALAZZO. Nella foto sopra, l’interno di un antico albergo del centro di Damasco FOTO CORBIS Repubblica Nazionale 39 23/10/2005 LA MOSCHEA. Qui sopra il cortile della stupenda moschea Umayyad di Damasco FOTO GRAZIA NERI IL MERCATO. Qui sopra, il sûq al Hamidiye. Sotto, la preghiera nella moschea Umayyad LA DOMENICA DI REPUBBLICA 39 40 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 23 OTTOBRE 2005 Lo scrittore siciliano ha compiuto ottant’anni e Sellerio Editore gli ha regalato un piccolo, prezioso libro con la collezione di tutte le sue copertine: trecento, stampate in venticinque paesi. Un’occasione per smontare i meccanismi di uno straordinario successo editoriale e per mettere in discussione l’immagine dell’isola che questi romanzi hanno diffuso ovunque Il giro del mondo ndrea Camilleri ha maritato i suoi figli, ma certamente non ha scelto le loro mogli. Per ogni libro-figlio c’è una copertina-nuora che Camilleri si ritrova in casa o, se volete scambiare i generi, per ogni pubblicazione-figlia c’è una copertina-genero. Ma Camilleri non è le sue copertine. Ad esempio, la bella copertina turca della Gita a Tindari, Tindari Gezisi, giocata soprattutto sul bianco e nero con l’aggiunta del rosso del sangue, non rimanda certo a Camilleri, ma alle gerarchie dei colori che, in ogni Paese, sono diverse. Per noi il bianco significa l’eccellenza, il candore e la purezza mentre il nero è l’oscurità. Per i turchi è esattamente il contrario, forse perché era Nero il mare attorno al quale svilupparono la loro potenza ed era invece con disprezzo liquidato come “Mare Bianco” quel Mediterraneo che fu la nostra apertura, la nostra fantasia, la nostra vita. Così gli antichi greci non conoscevano l’azzurro perché, spiegava Nietzsche, mancava loro la profondità dell’infinito e neppure nel mare e nel cielo riuscivano a vedere il blu. Perdersi dunque nei codici di queste belle trecento copertine, che Sellerio ha raccolto in un volume omaggio agli ottanta anni di Andrea Camilleri e ai suoi 35 romanzi, significa imbarcare gli occhi e dimenticarsi dei libri che spesso i grafici neppure leggono. Sempre le copertine sono un’altra cosa rispetto ai libri. Le copertine seducono il lettore con le linee, con i colori e con la tattilità. Sono come i vestiti che da tempo non sono più sudditi del corpo che li indossa, ma rimandano agli stilisti e al loro linguaggio. In copertina, lo stesso autore diventa estraneo al suo libro, la copertina non è la droga che ne potenzia la lettura. È come la pubblicità: ci sono straordinari spot di prodotti che nessuno poi verifica, e si può giustamente dire che il prodotto è un pretesto per la pubblicità come il libro è un pretesto per la copertina. Capita dunque di sentirsi sedotto da un intimo femminile, ma di non sopportare il corpo della donna, — la moglie, un’amica, una detestabile zia — che lo indossa. Con Camilleri la faccenda si complica, perché non solo ci piacciono queste copertine, prova fisica dello straordinario successo internazionale di un autore tradotto in ben 25 lingue. Ma ci piace anche lui. Ci piace tutto di Camilleri, tranne la sua scrittura. Intanto ha la voce calda e pastosa, il felicissimo tormentone del Fiorello radiofonico. Ed è un uomo all’antica, un incrocio arabo-normanno che ha reso la Sicilia più incomprensibile ma più popolare. Di Camilleri sono simpatici anche il suo essere di sinistra come un ragazzino, la sua ironia, e soprattutto l’intramontabilità del talento, la disgiunzione tra il talento e l’anagrafe, quell’esser diventato in tarda età lo scrittore italiano più prolifico, più venduto e più letto in Italia e nel mondo; quell’essere un ottantenne bravo nell’inventare trame e nel produrre gialli a ritmo industriale, nel farsi “tragediatore” delle anime perse. Camilleri insomma è l’anziano che tutti vorremmo essere. Ci piace, dunque. Ma come ci piacevano i nostri nonni dei quali detestavamo la “nonnità”: la loro fede politica monarchica per esempio, la devozione ai santi e ai miracoli, i proverbi, i malocchi, i pregiudizi... Insomma, di Camilleri non ci piace la sua Sicilia che è dialetto finto, è marginalità, è caricatura, è surrogato, è l’eco di una voce, è l’ombra di una terra. Agli stranieri Camilleri piace perché è poeticamente pittoresco, e perché grazie a lui misurano la distanza tra la loro presunta “Übermensch” e l’umanità lenta, antica, attardata, bloccata, implosa. E molti siciliani sono contenti di essere descritti come un’umanità a statuto speciale, amano la cortina che li nasconde, li protegge e li tiene fuori dalla storia che, purtroppo, è pesante. Il siciliano adora ricoverarsi nella “cameretta” descritta da Brancati. C’è insomma una complicità più o meno dichiarata tra il genio di Camilleri e gli ignavi di Sicilia, perché è molto comodo stare dentro un cliché definito una volta per tutte, cittadini di una isolatissima isola arcaica senza ponti, isolani per caratteristiche biologiche e per qualità del liquido seminale, titolari di una separatezza che ovviamente non esiste se non come ste- Repubblica Nazionale 40 23/10/2005 A Camilleri di C’è complicità tra il genio dell’autore e gli ignavi di Sicilia, perché è molto comodo stare dentro un cliché, in una isolatissima isola senza ponti Lo strano caso delle Due Sicilie ‘‘ Andrea Camilleri La Sicilia per me è il villaggio di Tolstoj, quando diceva: “Descrivi bene il tuo villaggio e avrai descritto il mondo” ‘‘ FRANCESCO MERLO reotipo, come pregiudizio che raccoglie, in disordine, malanni personali e banalità di ogni genere. In Sicilia una finestra chiusa significa paura, un uomo che ride è Liolà, un cittadino che vuol farsi i fatti propri è omertoso, il vestito nero di una donna non è un segnale sexy come a Parigi, ma è un sospetto di lutto, un indizio di reato, l’allegoria di una lupara. E il velo sulla testa di una signora è il segno ancestrale di una cultura araba. Un uomo che si appisola nel pomeriggio è don Giovanni in Sicilia. Un pranzo è una mangiata. Un amico è un complice. Un amore è una tragedia. Un bacio è un tradimento. Uno sguardo è un ingravidamento. E non c’è fondo senza sottofondo, non c’è salsa di pomodoro che non sia unica, inimitabile, irripetibile. Il tutto descritto con la lascivia sentimentale di certe orrende cose di noi stessi che ci piacciono tanto, quasi fossero anacronistiche virtù, elisir da paradiso perduto. Attenzione: è vero che la Sicilia è anche delirio, patacca, finzione, dialetto masticato, mafia e orrore. Ma non è questa la Sicilia delle professioni moderne, delle università, dei licei, e neppure dei famosi mercati, la Vucciria di Palermo e la Fera o luni di Catania, che ormai sono mercati internazionali. I venditori sono senegalesi, arabi, cinesi... E gli acquirenti sono maltesi, brasiliani, marocchini, tunisini, dello Sri Lanka, indiani, mauriziani... Chi pensa di trovare la cosiddetta “autenticità” della Sicilia di Camilleri nei mercati-simbolo di Palermo e di Catania, rimane subito spiazzato perché vi trova invece la globalizzazione e la babele. Così le università siciliane nulla hanno di diverso da quelle francesi o londinesi, senza ovviamente misurarle con i punti di eccellenza, ma con l’umanità che le frequenta: gli insegnanti, gli studenti, i bidelli. Chi parla oggi il dialetto di Camilleri in Sicilia? Dov’è la Sicilia di Camilleri in Sicilia? Certo, Camilleri non è il responsabile di quest’idea di separatezza che ha trovato già confezionata nella cultura sicilianista, e alla quale persino Sciascia ha fornito il suo contributo. Camilleri eredita la sua Sicilia dalla letteratura sulla Sicilia, ed è vero che la letteratura è sempre ficiton. Nessuno pensa di conoscere la verità dei comites palatii di Carlo Magno attraverso l’Orlando furioso, che è un documento, ma non è un manuale di storia e di sociologia. Nessuno vuole applicare alla letteratura il criterio zda- DOMENICA 23 OTTOBRE 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 41 Parla Niccolò Ammaniti “Una melodia che conquista” ALESSANDRA ROTA ho conosciuto nel’99. Eravamo a Catania, lui e Fausto Bertinotti dovevano presentare il mio libro Ti prendo e ti porto via. In quell’occasione ho scoperto due cose: che il leader di Rifondazione Comunista è un vero critico letterario e che Camilleri è un narratore da tavola, nel senso che ha un pensiero narrativo, sempre». Niccolò Ammaniti è anche l’autore di Branchie (Ediesse, poi Einaudi), di Io non ho paura (Einaudi), dal quale è stato tratto il film di Gabriele Salvatores. Ora il popolo dei suoi fan (121mila siti in rete) è in attesa dell’annunciato romanzo dal titolo provvisorio Meno 273 (Mondadori) che dovrebbe uscire nei primi mesi del 2006. Ammaniti che tipo è Andrea Camilleri? «Affettuoso, come può esserlo un lettore. Quella prima volta in cui ci siamo incontrati mi ha molto colpito». Come mai? «Ha un modo di fare speciale e poi entra nel vivo del tema, senza preamboli. È schivo, apparentemente introverso ma è anche diretto, disponibile. Vive in un mondo suo, molto forte, che può sembrare inaccessibile, ma la sua capacità di raccontare apre ogni porta. È un uomo che ha sempre espresso i suoi pensieri, ha scontato la sua sincerità, basta ripensare alla vicenda della Rai. Quelli come lui sono davvero pochi». Ha anche una fantasia infinita. «È vero, anno dopo anno scrive storie. In questo assomiglia ad un altro grande affabulatore, Georges Simenon. Dentro di lui c’è un fatto narrativo che non si spegne. In genere, dopo una certa età ci si ripete, ma Camilleri è all’interno di una corrente di narrazione. Fa lo scrittore con tranquillità. Gli studenti dell’Accademia di arte drammatica ricordano che quando insegnava riusciva a “prendere” le persone e a portarle fino dove voleva». Se dovesse scegliere: meglio il commissario Montalbano o i romanzi? «Preferisco la sua parte immaginativa, io faccio parte di quelli che non amano seguire le trame che si dipanano lungo il filo di un’indagine». E il linguaggio di Camilleri? «Per me non è stato facilissimo seguirlo. Anzi, ho dovuto fare i conti con quella lingua, addirittura ogni tanto saltando qualche parola incomprensibile. È una strana melodia, puoi non capirla a fondo, ma ne sei catturato; è un suono aspro, quasi cacofonico». Come si spiega tanto successo, nonostante la difficoltà? «L’ho detto prima: Camilleri racconta storie semplici alle quali è facili appassionarsi: costruisce con le parole l’affresco di un mondo apparentemente immobile che ti cattura». Repubblica Nazionale 41 23/10/2005 «L’ noviano del realismo. Sempre la letteratura inventa, deforma, aggiunge, amplifica. Ma Camilleri riduce. Il segreto del suo grande successo è nella ripresa facile, nella volgarizzazione e nell’offerta di tutti i vecchi cliché, di tutti i vecchi luoghi comuni presentati con la semplicità compiaciuta del realismo, quasi fosse il Simenon della piccola gente di Sicilia. La letteratura postgiudizio diventa con lui letteratura pregiudizio. Se la buona letteratura è sempre surreale la sua è “sottoreale”. Mi è persino accaduto, a me che sono siciliano, di incontrare dei tedeschi che erano stati in Sicilia dopo avere letto Camilleri. «Ma voi non siete così» dicevano, felicemente sorpresi di non avere trovato i siciliani camillerianeschi. Erano contenti che non ci fosse corrispondenza tra la scimmia e la gabbia. E a loro volta i siciliani erano felici di riaccreditarsi, di liberarsi della scimmia, della separatezza e della diversità, ma ciascuno rifugiandosi ancora una volta nel più vieto dei luoghi comuni della separatezza, così rinchiudendosi di nuovo nella gabbia: «Eh sì, anche io sono siciliano. Siciliano sì, ma diverso». LE IMMAGINI Le copertine dei romanzi dello scrittore siciliano (foto sopra) riprodotte in queste pagine sono tratte dal volume “I libri di Andrea Camilleri” di Sellerio Editore, in cui sono raccolte circa 300 copertine pubblicate in 25 differenti paesi 42 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 23 OTTOBRE 2005 Con i capelli lunghi, corti, ricci. Il viso sorridente, imbronciato, sexy. Il corpo rimasto quasi infantile, fragile e nascosto oppure mostrato come punizione e rinuncia: sono i ritratti dedicati alla Huppert dai più grandi fotografi in trent’anni di carriera. Scatti d’autore raccolti in un libro, che racconta - senza riuscire a svelarlo - il fascino enigmatico di una delle più brave e intriganti attrici del cinema contemporaneo NATALIA ASPESI areva quasi sconveniente darle il premio come miglior attrice, all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, dove del resto in passato lo aveva già vinto tre volte; a parte il fatto che bisognava assolutamente onorare un’attrice italiana per non creare guai (e infatti fu scelta Giovanna Mezzogiorno), che senso aveva dichiarare per l’ennesima volta che lei è la più brava, quando la sua bravura è imparagonabile e forse non è neanche bravura, ma un suo segreto maleficio che mette a disagio lo spettatore, lo relega in un angolo, se ne impossessa, lo trafigge, lo svuota, lo incanta? Così con somma condiscendenza Isabelle Huppert ritirò il premio appositamente inventato per lei in quel momento, il Leone Speciale all’insieme dell’opera: un insieme quasi inumano, oggi che le attrici arrancano in una manciata di film e appena la luce della giovinezza si annebbia e il sedere non ha più quella opprimente spavalderia, vengono scansate come la peste, a meno che si adattino a ruoli horror o comici, in cui come donne vengono irrise e maltrattate. Gabrielle di Patrice Chéreau, il film presentato a Venezia, è per la Huppert il suo settantesimo, e nel frattempo ne aveva già girato un altro e altri registi questuanti erano in fila ad aspettare la sua generosa disponibilità. Non è solo il cinema francese a non poter fare a meno di questa cinquantenne piccolina e incorporea, esangue e severa: e infatti si è appena aperta (sino al 23 novembre) al MoMA di New York una retrospettiva del suo cinema, e i curatori hanno dato spazio soprattutto ai film in cui è diretta da grandi registi internazionali, dal polacco Wajda all’italiano Ferreri, dall’americano Cimino al tedesco Schroeter, dall’ungherese Meszaros all’austriaco Haneke. Lei è per gli autori una calamita, un’attrazione fatale, una icona salvifica, quasi un vizio, in fondo una mancanza di fantasia: appena uno immagina un personaggio femminile travagliato, oscuro, maledetto, eppure rubacuori, pensa subito a lei, e questo ormai da trent’anni, da quando cioè lo svizzero Claude Goretta la volle protagonista di La merlettaia, nel ruolo drammatico di una giovanissima parrucchiera anoressica avviata alla follia. Da allora, Huppert, prostituta, ha avvelenato i genitori (Violette Noziére); cortigiana, è morta di consunzione (La storia vera della signora delle camelie); abortista clandestina nella Francia occupata dai nazisti, è stata condannata a morte (Un affare di donne); scrittrice nevrotica, si è data fuoco (Malina); adultera, si è suicidata col veleno (Madame Bovary); è stata una postina infanticida e pluriassassina (Il buio nella mente); un’imprenditrice omicida (Grazie per la cioccolata); una sadomasochista efferata (La pianista); una madre incestuosa (Ma mere). Ha molto turbato ma mai scandalizzato, perché il suo talento straziante riscatta ogni orrore e ogni nequizia, come se i suoi personaggi feroci o dal destino crudele, avessero comunque diritto alla comprensione, alla pietà, al perdono, perché l’umanità è anche questa, fatta di errori, orrori, strazio, violenza, tragedia. Attorno al mistero del suo viso si sono accaniti anche i fotografi, alla vana ricerca della sua verità: e adesso Contrastopubblica in Italia (in Francia lo ha fatto Editions du Seuil) una raccolta di suoi ritratti tentati da grandi artisti che vanno da maestri come Cartier-Bresson e Jacques-Henri Lartigue, a star della fotografia di moda come Richard Avedon o Helmut Newton, agli esponenti del ritratto contemporaneo come Ange Leccia ed Antoine d’Agata. Il libro è curato da Ronald Chammah, produttore e regista cinematografico, fotografo amatoriale, libanese d’origine, italiano d’adozione, parigino di vita: tra l’altro marito di Isabelle che ha diretto in un film del 1987, Milan Noir, mai arrivato in Italia. Pare non esistere un filo conduttore, né cronologico né alfabetico dei foto- P Isabelle allo specchio grafi, nella successione dei ritratti, che invece deve esistere, segreto, nel modo di guardarsi e pensarsi, di condividere memorie e pensieri, della coppia. Ma è questa apparente casualità e addirittura caos, che rivela la capacità mimetica e sorprendente di un viso e di un corpo continuamente mutevole eppure immutabile. Nelle fotografie come nei film, Huppert è sempre se stessa e sempre un’altra, è lei e il personaggio che sta incarnando: di sé non vuole si sappia nulla, del ruolo che offre tutto. In questo alternarsi di ritratti di fotografi diversi e in anni diversi, c’è il segreto della sua bellezza inquietante, incompleta, che si fa più magica quando sfiora la desolazione, il brutto. A trent’anni pare ancora un’adolescente, imbronciata e chiusa, e in Una donna pericolosa di Christine Pascal è già stata violentata dal poliziotto Richard Berry; a quaranta la sua sapienza erotica sboccia irresistibile e in Rien ne va plus di Chabrol è una ladruncola che seduce e addormenta le sue vittime. E intanto le sue guance rotonde si sono affinate, la sua bocca piena si è assottigliata, i suoi occhi azzurri si sono oscurati, il suo corpo quasi infantile è rimasto tale, fragile e nascosto, oppure esposto come punizione, come rinuncia, come offesa. La carnagione candida delle rosse è diventata più fragile, ogni piccola ruga, mai nascosta, un mistero in più, il disegno delle efelidi è ancora oggi un labirinto in cui chi la guarda si turba e si perde. I capelli si accorciano, si allungano, si appiattiscono, si arricciano, la rendono sexy, la imbruttiscono, incorniciano la sua rabbia e la sua dolcezza, la sua desolazione e la sua cocciutaggine. Docile, l’attrice espone il suo viso nudo all’occhio della macchina fotografica: non ride mai, talvolta sorride, quasi sempre offre nel suo apparente rifiuto di ogni espressione tutte le possibili interpretazioni: basta un po’ di trucco e diventa Greta Garbo o Renée Falconetti, Rita Hayworth o Kate Moss. Era più bella nel ‘78, a ventitrè anni, quando vinse il premio di miglior attrice al Festival di Cannes con Violette Noziéredi Chabrol o lo è ora, a cinquanta, dopo il Leone d’Oro veneziano? Adesso, certamente, perché il suo talento l’ha spogliata da ogni fisicità, dalla prigione implacabile della giovinezza perduta che avvelena la maturità di tante donne ma non la sua. Quando in Gabrielle si materializza dal buio e dal silenzio, in una casa patrizia Belle Epoque, il viso celato da una veletta sotto un grande cappello nero, fa DOMENICA 23 OTTOBRE 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 43 IL LIBRO Le immagini in queste pagine sono tratte dal volume “Isabelle Huppert, la donna dei ritratti”, edito da Contrasto e in uscita in Italia a fine mese, con prefazione di Serge Toubiana e testi di Elfriede Jelinek, Patrice Chéreau, Susan Sontag (168 pp, 35 euro). La foto grande è di Sylvia Plachy (1986). A sinistra, uno scatto di Henri Cartier-Bresson (1994). Qui sotto i ritratti di Leonard Freed (1992), Nan Goldin (2004) e Jeanloup Sieff (1985) Parla l’attrice francese FOTO NAN GOLDIN/CONTRASTO FOTO LEONARD FREED/CONTRASTO FOTO HENRI CARTIER BRESSON/CONTRASTO “Io e le mie mille verità come dentro un film” intuire al marito, allo spettatore, la tragedia femminile che sta attraversando, senza uno sguardo, senza una parola. È una donna sposata da dieci anni con un uomo che l’ama come un prezioso oggetto; lei se ne è andata lasciando una lettera al marito incredulo e disperato, ma poco dopo ritorna, e non sa dire perché. Nel lungo, spietato scontro verbale tra i due, in cui lei scende nel fondo della loro ipocrisia e lontananza, offre il suo corpo senza carnalità nella desolazione più umiliante per lui; e sono una prova sconvolgente di attrice la violenza trattenuta che anima la sua elegante compostezza, le emozioni e i sentimenti che raggelano e infiammano il suo viso immobile, spento. Sulla televisione satellitare hanno riproposto in questi giorni La pianista, regia di Haneke, tratto dal romanzo del premio Nobel Elfriede Jelinek, che con Patrice Chéreau e Susan Sontag ha scritto i saggi di Isabelle Huppert, la donna dei ritratti. Pluripremiata per il ruolo più sgradevole della sua carriera in un film di erotismo umiliato e soffocante, la Huppert trasmette agli spettatori un malessere autentico, che il cinema, or- FOTO JEANLOUP SIEFF/CONTRASTO FOTO SYLVIA PLACHY/CONTRASTO Repubblica Nazionale 43 23/10/2005 La donna del mistero che cattura l’arte In queste fotografie, lei è sempre sé stessa e sempre un’altra, come nei ruoli che interpreta sul grande schermo. Lei è sempre il suo personaggio, la vita privata rimane al riparo protetta da un muro invalicabile mai confezionato soprattutto per le famiglie e per i passaggi sulle televisioni generaliste, non osa più affrontare. Malvestita, spettinata, brutta, nevrotica, spenta, furente, masochista, disperata, violenta, malata, vendicativa, autolesionista, giustifica con i suoi silenzi cocciuti, il suo viso raggelato, quel corpicino monacale, gli sguardi imperiosi, i gesti sconnessi e bruschi, l’amore appassionato di un suo allievo giovane, bello, sincero cui chiede, disgustandolo e perdendolo, di essere picchiata, umiliata, annientata. Parrebbe che il lavoro di attrice sia tutta la vita di questa donna che accumula film su film e in più gira i palcoscenici del mondo, portando in scena personaggi drammatici e testi tragici, come la Medea di Euripide, l’Orlando di Virgina Woolf, la Maria Stuarda di Schiller, la Hedda Gabler di Ibsen, e il monologo Psicosi delle 4,48 di Sarah Kane, suicida nel ‘99 a 28 anni, che sta recitando adesso a New York e porterà al teatro Strehler di Milano in dicembre. Invece Isabelle ha una sua vita privata, un marito, tre figli, di cui la maggiore già attrice. Un muro impenetrabile la difende, non esistono sue foto di famiglia, giornalisti di tutto il mondo non le hanno cavato una sola parola che non riguardi il suo lavoro. E questo ormai da quando, appena sedicenne, la sua grazia infantile e altera incominciò a interessare il mondo del cinema non solo francese. Certo oggi il suo atteggiamento di intransigente segretezza può apparire una bizzarria, un eccesso di snobismo. Non si sa quindi se la compiangono, o forse la invidiano, certe nostre donnine arrivate alla celebrità perché senza mutande negli show televisivi, certe nostre bellissime star impietrite da chirughi estetici ostili alle donne, che si innamorano, litigano, annunciano concepimenti, si separano, fanno le corna, divorziano, piangono, tra le fauci di conduttori-corruttori televisivi. Il privato viene confuso con il peggiore dei mali, l’anonimato: e l’esibizionismo dei sentimenti e del corpo diventa una professione, anzi la sola accessibile per chi non sa cosa siano il talento e la passione che hanno fatto grande Isabelle Huppert. LAURA PUTTI D PARIGI a dove nasce questo libro, signora Huppert? «Dalla voglia di rendere omaggio ai fotografi con i quali ho lavorato. Poi dal lavoro di Ronald Chammah e di Jeanne Fouchet che hanno scelto e riordinato le fotografie senza che neanche me ne accorgessi». Però ora le vede (e da oggi le vedranno anche al Moma del Queen, poi dopo New York, Parigi, Berlino, Londra e Tokyo la mostra arriverà a Roma in settembre). E che cosa pensa? «Che è, come si dice per l’arte moderna, una performance di ottanta persone che guardano lo stesso soggetto. Che, alla fine, è un lavoro d’attrice». Ma un’immagine fissa non è cinema, non è teatro. In tre ritratti (Scianna, Freed, Vanden Eeckhoudt) lei si riflette addirittura in uno specchio: non è una foto anche uno specchio? «Non direi. Per un’attrice è una cosa naturale la capacità di moltiplicarsi, di trasformarsi. In tutte queste trasformazioni può esserci qualcosa di vertiginoso, perché più ci si trasforma e meno si afferra la verità. Il libro gioca con questo paradosso, e così i film. A forza di essere multipli, non si è». Nella sua prefazione, Patrice Chereau lo spiega bene: definisce le fotografie «manifestazioni di un io multiplo, carnivoro e irriducibile», e il libro «di un narcisismo sfrenato e necessario». «E allo stesso tempo è anche il contrario, è anche annullarsi. Essere attrice è partecipare a un gioco; è come un gioco questa capacità di trasformazione che io so di avere». La femme aux portraits inizia con un close up sfocato (anonimo, 1968) e termina con lei di spalle, una piccola testa lontana davanti a un enorme schermo bianco (Hiroshi Sugimoto, 2005). Perché, alla fine, un annientamento di sè? «Non lo so. Questo è il lavoro di Chammah e Fouchet, sono loro che hanno scelto l’ordine delle foto». È facile per lei essere fotografata? «Mi piace molto». Ogni ritratto le ricorda i sentimenti con i quali si è mostrata al fotografo? «Non credo che si provino sentimenti durante una seduta fotografica. Io, almeno, non ne provo». Neanche quando, a poco più di vent’anni, ci si trova davanti a Cartier-Bresson, Ritts, Lartigue, Avedon, Kudelka, Doisneau, Newton? «Assolutamente no. Però certe volte davanti a fotografi come Cartier-Bresson o Newton ho provato lo stesso sentimento di fiducia che ho davanti a un grande regista. Il fatto di essere diretta da Godard incide in maniera misteriosa e sotterranea nella mia maniera di essere. La personalità del regista agisce in modo inconscio su di me. Non c’è pensiero, al contrario: c’è un’assenza di pensiero». Si sente al suo posto davanti all’obbiettivo di un fotografo? «Mi sento più rilassata, senza paura, forte». Il pudore? «È una parola che mi fa orrore. Non vuol dire niente. Non posso neanche pronunciarla, tanto la detesto». Qual è la Isabelle che preferisce? La ragazzina con il gatto di Boubat? Quella di Kudelka, che passa attraverso la vita? O la femme fatale di Lindbergh e Newton? «Non riesco a scegliere. C’è talmente di tutto in queste fotografie. In alcune mi cancello; altre hanno più verità; altre ancora sono molto posate come quella di Nick Knight o quella con il cappello di Len Prince. C’è di tutto perché con un viso e un corpo si può fare di tutto: restituirlo nella sua verità o travestirlo, trasformarlo». Soprattutto quando si scivola in universi molto personali come quelli di Lise Sarfati, Nan Goldin o Philip-Lorca DiCorcia... «Loro immaginano qualcosa che li riguarda, qualcosa che è la loro storia e io sprofondo nello spazio immaginario che vogliono raccontare. Anch’io con il mio immaginario. Per esempio Lorca DiCorcia ha messo su una finzione che è durata tre giorni e io ci sono entrata senza problemi. Quando si entra nell’universo dell’altro si ha più libertà di essere se stessi». E chi invece l’ha mostrata cruda, dolente, quasi senza trucco? Roni Horn e Patrick Faigenbaum, per esempio? «È la stessa cosa. È sempre incontrando l’altro che posso incontrare me stessa». C’è un’unica foto rubata, non posata. Lei sta scendendo le scale… «A Cannes. È una foto di Jérome Brézillon. Una bella foto ha anche qualcosa di invisibile, di incosciente che traspare. Ha un suo mistero. E in quel caso, scattando da lontano, il fotografo ha catturato un’atmosfera, un’armonia tra la vita, la scala, l’abito. La fotografia è questione di fortuna e di momenti rubati. È un incidente. Come in tutte le forme di espressione c’è il calcolo, la preparazione e allo stesso tempo qualcosa che sfugge a ogni previsione». DOMENICA 23 OTTOBRE 2005 spettacoli Arte e politica LA DOMENICA DI REPUBBLICA 45 Da sempre in America tra film e potere c’è un rapporto strettissimo, che però anche nei momenti di maggior crisi non ha influito sul valore artistico delle pellicole Dopo l’11 settembre due libri raccontano i retroscena di una storia ricca di sorprese: la caccia alle streghe e i summit tra consiglieri della Casa Bianca e produttori Hollywood segreta da Mc Carthy a Bush L’ ANTONIO MONDA NEW YORK Repubblica Nazionale 45 23/10/2005 annuncio che dietro il finanziamento di 150 milioni di dollari di un film dall’esplicito messaggio cristiano come Le Cronache di Narnia si nasconde il miliardario Philip Anschutz, conservatore sia nelle scelte politiche che nel modo di vivere la sua fede presbiteriana, ha riaperto il dibattito sulla coloritura politica di Hollywood e su come artisti, agenti, produttori e mogul riescano a conciliare incasso e ideali. Nella città degli angeli il rapporto cinema-politica esiste dagli albori, ma negli ultimi vent’anni, in particolare con George W Bush presidente, ha acquisito elementi inediti e contraddittori. Nella storia del cinema americano accanto a una larga predominanza liberal c’è sempre stata una significativa presenza conservatrice che ha assunto ripetutamente accenti reazionari. L’uscita parallela di due testi sul rapporto cinema-politica ci accompagna in un viaggio appassionante, e rivela che questo intreccio non ha limitato i risultati di un’arte dagli imprescindibili aspetti industriali. Sia Red Star over Hollywood di Ronald e Allis Radosh, che Hollywood il Pentagono e Washington, pubblicato in Italia dalla Fazi, chiariscono che non esiste film hollywoodiano, di qualunque idea politica o convinzione religiosa, che sia stato messo in cantiere senza una accurata valutazione di marketing. Il tycoon Louis B. Mayer spiegava che per inviare messaggi lui utilizzava i telegrammi, ma il messaggio forte dei suoi film stava proprio nell’atmosfera escapista e priva di messaggi evidenti. La sua casa di produzione fu identificata più di ogni altra con la destra hollywoodiana ma, al di là di un approccio che invita al disimpegno e al lieto fine sin dai titoli (da Cantando sotto la pioggia a È sempre bel tempo), l’analisi dei film offre poco di identificabile con un’ideologia conser- vatrice. Speculare il discorso sui film della Warner Bros, che prima del crollo dello studio system e l’avvento degli indipendenti è stata considerata la casa di punta della sinistra hollywoodiana: tra i film ce ne sono molti sensibili alle istanze sociali, ma parlare di sinistra è un’esagerazione. Un film impegnato come Il sale della terradi Herbert J. Biberman fu realizzato solo grazie all’intervento di due case di produzione indipendenti (una aveva il nome eloquente di International Union of Mine, Mill and Smelter Workers), mentre a poche settimane di distanza una major come la Columbia lanciava Fronte del porto, dove Elia Kazan ribadiva l’esigenza di denunciare chi corrompeva le fondamenta dello stato sociale americano. L’anno era il 1954, e si era all’apogeo dell’era maccartista. Fu il teatro più del cinema a raccontare con sdegno e passione quel periodo (in particolare Arthur Miller con Uno sguardo del ponte e Il Crogiuolo), ma quegli anni segnarono il momento in cui Hollywood scoprì di non avere mai avuto l’età dell’innocenza, e cominciò a formarsi una coscienza che portò alla rivoluzione fine anni Sessanta. Ciò che distinse la generazione che ha dominato il cinema americano fino ai nostri giorni è un approccio naturalmente liberal, senza tuttavia alcuna colorazione ideologica. Ma anche in questo caso è errato generalizzare. È ad esempio uomo dichiaratamente di destra un protagonista di quella generazione come John Milius, a cui si deve la regia di Un mercoledì da leoni e la sceneggiatura di due classici come L’uomo dai sette capestri e Apocalypse Now. Per chi ama l’aneddotica hollywoodiana, è ispirato a lui il personaggio interpretato da John Goodman in The Big Lebowski, film diretto da cineasti di sinistra come i fratelli Coen, che di Milius sono amici. GLI ALIENI A sinistra, la Casa Bianca distrutta dagli alieni di “Independence Day”. Sopra, il produttore Louis B. Mayer e l’attore Harrison Ford nella parte del presidente Usa in “Air Force One” Ugualmente complesso il rapporto con il mondo politico e con il Pentagono. Da sempre Hollywood va fiera della sua indipendenza, ma nello stesso tempo ascolta le indicazioni di Washington. Questa ingerenza non si è limitata alle censure o al famoso Codice di decenza Hays, che dal 1934 al 1967 decise cosa fosse lecito proiettare sugli schermi, ma a volte ha prodotto vere pressioni sulla linea editoriale. Ci sono almeno due momenti in cui il potere politico e militare si è rivolto direttamente ad Hol- lywood: allo scoppio della Seconda guerra mondiale, quando Roosevelt si affidò al talento di maestri quali John Ford e Frank Capra per una serie di film di propaganda; e due mesi dopo l’11 settembre quando si svolse a Hollywood una riunione tra Karl Rove, Jack Valenti e i principali dirigenti degli studios per coordinare la guerra al terrorismo lanciata da Bush con le produzioni in cantiere all’epoca. Rove ribadì la richiesta della Casa Bianca: evitare lo schemaHuntington dello scontro di civiltà e promuovere una buona immagine della integrazione dei musulmani d’America. Così dall’11 settembre i film che hanno trattato il tema-terrorismo sono diminuiti radicalmente, ed è innegabile che sia prevalso un atteggiamento politically correct nella descrizione del mondo musulmano, anche se le motivazioni sono da trovare, ancora una volta, piuttosto nella volontà di conquistare un pubblico più largo. Oggi sarebbe accolto con fastidio il personaggio di un presidente eroico che combatte in prima persona chi minaccia il mondo (ma avveniva nel 1996 in Independence Day dopo una spettacolare distruzione della Casa Bianca); e susciterebbe sarcasmo la sua vittoria personale su una banda di terroristi sanguinari pronti a rapirlo (Air Force One, 1997). La maggiore vicinanza al pericolo reale e il rifiuto della dottrina Bush da parte della maggioranza dell’establishment hollywoodiano ha paradossalmente annullato la possibilità di un approccio mitico e celebrativo. Se si va indietro nel tempo si ritrova invece questo tipo d’approccio: il “pericolo rosso” era trattato costantemente sia in maniera esplicita che metaforica; e lo stesso si può dire riguardo al nazismo. Con rare eccezioni — segnate anche da grande successo come ad esempio Farenheit 9/11 — la Hollywood odierna sembra orientata su scelte di correttezza politica. Tuttavia è sintomatico quanto è avvenuto negli ultimi anni nella rappresentazione della Francia: se in Independence Day viene completamente dimenticata, in Armageddon viene distrutta da un asteroide, mentre i francesi risultano complici dei neonazisti in Al vertice della tensione o campioni di doppiezza e inaffidabilità in The Patriot. 46 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 23 OTTOBRE 2005 la scienza Le ultime ricerche dicono che sta “imparando” a mangiare carne umana eppure i morti non sono più di quindici all’anno. Basta una pinna per rovinare una stagione turistica anche se è quasi sempre inoffensivo. Perché lo squalo incarna le nostre paure ataviche, ricordando agli uomini che fanno ancora parte della natura e quindi nella lotta per la sopravvivenza possono anche soccombere Padroni del mare SQUALO ELEFANTE PALOMBO Arriva a 12 metri, vive in acque temperate e artiche Lungo un metro e mezzo, è comune nel Mediterraneo SQUALO VOLPE SQUALO GRIGIO Vive nell’Adriatico e nello Ionio, è lungo da 2 a 5 metri Fino a 2,5 metri, vive in acque tropicali e temperate Il predatore venuto dalla preistoria F CLAUDIA DI GIORGIO FOTO CORBIS/CONTRASTO orse sono i denti, affilati come rasoi. Forse è lo sguardo vitreo e maligno, oppure le fauci, che si spalancano all’indietro fino a contenere un uomo intero. Fatto sta che, pur essendo mille volte meno micidiali del “placido” ippopotamo, gli squali sono ancora una delle grandi paure dell’umanità, ed esiste persino una forma di panico, l’elasmofobia, che riguarda solo loro. Ma forse, la ragione principale per cui basta l’avvistamento di una pinna a rovinare un’intera stagione turistica è che lo squalo è il più misterioso tra quella manciata di grandi carnivori che compongono il club esclusivo dei “predatori alfa”. Non si tratta di una classificazione scientifica, ma dell’invenzione di David Quammen, giornalista e scrittore americano, che ad essi ha dedicato un libro intero, intitolato per l’appunto Alla ricerca del predatore alfa, e pubblicato da poco in Italia da Adelphi. Al club appartengono quei pochi predatori abbastanza grossi, feroci e famelici da nutrirsi, di tanto in tanto, di esseri umani. Un elenco oggi ormai molto breve (ne fanno parte tigri, coccodrilli, orsi e leoni) di belve selvagge, aggressive e imponenti quel che basta per farci regredire di millenni, riportandoci a quando eravamo soltanto una preda, e la paura di essere mangiati dominava la nostra esistenza. I predatori alfa, secondo Quammen, ci ricordano che facciamo ancora parte del mondo naturale, che siamo anche cibo. Hanno lasciato una traccia nel mito, nell’arte e nella nostra psiche, segnando con la loro presenza la nostra evoluzione, e accompagnando il formarsi della nostra identità di specie. Sono, insomma, un archetipo psicologico, la cui sintesi ideale è il mostruoso e implacabile Leviatano della Bibbia: che emerge dalle profondità del mare e, oltre a vomitare fiamme, ha lunghi denti e pelle corazzata. E da cui è impossibile difendersi. Con qualche aggiustamento, non è difficile applicare il ritratto del Leviatano a Charcarodon carcharias, il grande squalo bianco, il meno noto e il più cattivo di tutti, quello che, assieme allo squalo tigre, allo squalo toro e al mako, guida il ristretto gruppo di specie responsabili degli attacchi contro l’uomo. Di questi attacchi (o “interazioni con l’uomo”, come dicono i biologi marini) ne avvengono in media tra settanta e cento ogni anno, da cinque a quindici dei quali con esito fatale, in gran parte nelle acque costiere di Stati Uniti, Sudafrica e Australia. Ma anche il Mediterraneo è un mare a rischio, tanto che esiste un archivio specifico dedicato agli attacchi che vi sono segnalati, e in Italia si registrano casi mortali in Sicilia, nell’Adriatico e nel Mar Ligure. Le modalità dell’attacco sono grosso modo tre. C’è quello, ed è il più diffuso, in cui lo squalo morde una volta sola e se ne va, probabilmente perché ha attaccato per sbaglio, e lascia quasi sempre una ferita modesta. Molto più serio è invece l’attacco in cui il morso è preceduto da una forte spinta, ma soprattutto da una serie di movimenti circolari intorno alla vittima, a dimostrazione che non è un erro- re ma un comportamento predatorio intenzionale. Molto simile è l’ultimo tipo di attacco, che avviene però più di sorpresa, senza la spinta; in tutti e due questi casi, attacchi e morsi sono ripetuti, e le chance di sopravvivenza sono scarse: lo squalo è a caccia, deciso a uccidere e mangiare. Ed è particolarmente ben attrezzato per farlo. Gli squali sono una delle specie evolutivamente più antiche e longeve, il cui adattamento ottimale all’ambiente è provato dal fatto che, sebbene i loro antenati risalgano a oltre quattrocento milioni di anni fa, negli ultimi cento milioni di anni non sono cambiati moltissimo. Hanno conservato, per esempio, lo scheletro di cartilagine e la capacità di sostituire continuamente i denti rotti o consumati. Uno squalo può cambiare fino a 30mila denti nel corso della vita, e questo contribuisce parecchio alla sua straordinaria efficienza di predatore, insieme alla flessibilità delle mascelle, in grado di allargarsi a dismisura, e allo sviluppo eccezionale di alcuni sensi secondari, tra cui la strana abilità di percepire il campo elettrico di una preda. Preda che potrebbe appartenere sempre più spesso al genere umano. È la tesi del biologo australiano Scoresby Shepherd, secondo il quale la ragione per cui gli attacchi degli squali sono divenuti più numerosi non è che oggi ci sono più uomini in acqua, e quindi maggiori probabilità di incontro, ma che ci sono meno pesci nel mare. In particolare, sono molto diminuiti i tonni, pasto favorito degli squali, che reagirebbero alla scarsità di loro prede tradizionali cer- IL SESTO SENSO L’OLFATTO I DENTI LE DIMENSIONI Sul muso lo squalo bianco possiede piccolissimi organi sensoriali chiamati “ampolle di Lorenzini”: sono canali pieni di una sostanza gelatinosa che gli permettono di percepire il campo elettrico delle prede Come tutti gli squali, anche lo squalo bianco ha un olfatto sensibilissimo (i lobi olfattivi occupano quasi un terzo del cervello), che gli permette di distinguere l’odore del sangue a cinquecento metri di distanza I denti triangolari seghettati dello squalo bianco (23-28 nella mascella superiore e 21-25 in quella inferiore) sono disposti su più file e vengono sostituiti da una nuova fila di denti quando sono consumati o rotti Può raggiungere i 5-6 metri e un peso di due tonnellate. Alla nascita, i piccoli sono già lunghi un metro e pesano venti/trenta chili. Si nutre di mammiferi marini (foche e leoni marini), pesci, calamari, testuggini e crostacei candone di nuove: per esempio, noi. Shepherd ritiene che per ora gli squali ci stiano solo assaggiando; la nostra carne, non abbastanza grassa, non è la loro dieta ideale. «Ma gli squali sono animali pratici» aggiunge. «Mangiano quello che arriva in tavola». Tuttavia, la maggior parte degli squali per noi non è affatto una minaccia. Delle circa 375 specie conosciute, quelle ritenute potenzialmente pericolose sono meno di trenta. Gli squali più grandi, inoltre, non sono nemmeno predatori: lo squalo balena (Rhincodon typus), che arriva anche a 18 metri di lunghezza ed è il pesce più grande del mondo, e lo squalo elefante (Cetorhinus maximus), che arriva fino a 10 metri, si nutrono entrambi di plancton. E molte specie di squali non sono neanche grandi: il gattuccio, che è una delle più diffuse, è lungo al massimo un metro e pesa non più di tre chili. E come accade ad altri suoi confratelli, le sue interazioni con l’uomo lo vedono soprattutto come protagonista di gustose ricette. In effetti, come si affannano a ripetere biologi e conservazionisti, sono gli squali ad aver ottime ragioni per temere noi. A causa della pesca e dello sfruttamento delle risorse marine in generale, la popolazione di gran parte delle specie negli ultimi anni è calata del 50 per cento, e addirittura dell’80 nel caso dello squalo bianco, tanto che si parla sempre più spesso di creare riserve naturali tutte per loro. Per gli squali si prepara insomma lo stesso destino degli altri predatori alfa: li incontreremo a distanza, in qualche tipo di zoo. E i brividi di paura ce li faranno venire solo al cinema. L’HABITAT LE ABITUDINI Lo squalo bianco vive nelle acque temperate di quasi tutto il mondo, ma in inverno si spinge anche in acque tropicali. Dal ‘96, è classificato come vulnerabile nella “lista rossa” delle specie a rischio di estinzione Non è solitario: recenti studi hanno dimostrato che si tratta di un animale sociale, con comportamenti complessi e una gerarchia di gruppo DOMENICA 23 OTTOBRE 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 47 I FILM LO SQUALO NEMO SHARK TALE Il film di Spielberg del ‘75, ambientato sulla costa atlantica degli Stati Uniti, ha alimentato il terrore per gli squali ed ha avuto numerosi seguiti Nel film a cartoni animati del 2003, i protagonisti Marlin e Dory incontrano tre squali che cercano di diventare vegetariani Uscito nel 2004, assimila un clan di squali a una famiglia mafiosa. Il protagonista, è un pescecane che non mangia carne SQUALO TORO Supera i 3 metri: è fra i più pericolosi per l’uomo PINNA NERA Misura fino a 2,8 metri: comune nel Mediterraneo SQUALO MARTELLO È un vorace predatore che arriva anche a 6 metri Ma i veri pescecani sono in mezzo a noi MARCO LODOLI ra l’estate del 1951 quando una cugina tedesca di mia madre venne a farle visita a Roma. Lavorava come maestra in un paesetto nel centro della Germania, aveva vent’anni, si chiamava Marlene, era bionda e del vasto mondo non sapeva ancora quasi nulla. I miei genitori la portarono a cena in un ristorante vicino al Pantheon e poi a prendere un gelato a piazza Navona. Marlene rimase incantata, tutta quella meraviglia le si riversava a fiotti negli occhi giovani e speranzosi, rideva come una bambina. Il giorno dopo partì per Napoli, nuova tappa del suo viaggio studiato a tavolino nel freddo di un inverno tedesco. Da lì si spostò sulla costiera amalfitana: sole, mare, spaghetti con le vongole, canzoni d’amore, felicità. Una mattina volle fare un bel bagno nell’acqua azzurra e fresca del Mediterraneo. Prima nuotò vicino alla riva, poi l’entusiasmo la spinse al largo. E chissà cosa pensò quando tra le onde serene intravide quella pinna grigio-acciaio puntare verso di lei. Forse cercò di rimanere calma, forse provò ad allontanarsi senza alzare troppa schiuma. Aveva traversato incolume la guerra, i bombardamenti, la distruzione, non poteva morire così, tra le zanne crudeli e stupide di un pescecane. In Europa nessuno muore sbranato da uno squalo, sono tragedie tropicali, pagine di libri d’avventura. Eppure pare che la breve esistenza di Marlene si concluse proprio così, divorata in quattro morsi: di lei non rimase neppure un brandello di carne da chiudere in una bara, solo la valigia posata accanto al letto in un alberghetto di Amalfi, un cappello di paglia, un articolo sul giornale, questa storia che da sempre sento raccontare a casa mia. Le andò proprio male, povera ragazza, perché in effetti gli squali assassini sono più uno spauracchio che naviga nei nostri incubi sudaticci che non una realtà con cui fare i conti. Sono, o forse erano, l’effigie favolosa del male assoluto, lo spettro della morte più spaventosa e ottusa, fantastici killer più terrificanti di qualsiasi pazzo con il rasoio in mano. Quand’era ancora un regista emozionante, Steven Spielberg seppe descrivere perfettamente l’arrivo improvviso del mostro, colse in pieno la sua natura solitaria e furibonda, o forse piuttosto l’idea agghiacciante che nuota nelle vasche del nostro inconscio. Per anni ogni madre, anche sulla spiaggia di Ladispoli o di Tortoreto Lido, ha temuto che d’improvviso, a venti metri dalla riva, apparisse la pinna fatale, e che il suo marmocchio venisse inghiottito con tutti i braccioli colorati da quelle fauci atroci. «Chi sono gli animali che compaiono nei nostri sogni, e perché vengono a noi, proprio a noi, che abbiamo trascorso gli ultimi due secoli a sterminarli regolarmente, a un ritmo E VERDESCA Arriva a 3,8 metri ed è fra gli squali più comuni SQUALO TIGRE ILLUSTRAZIONI DI MIRCO TANGHERLINI È un ferocissimo predatore che supera i 5 metri 5-15 I morti provocati ogni anno dagli squali. Stati Uniti, Sudafrica e Australia le zone più colpite 100 milioni Repubblica Nazionale 47 23/10/2005 Gli squali che vengono uccisi ogni anno per mano dell’uomo La causa principale è la pesca LE CURIOSITÀ I PIÙ GRANDI Le due specie più grandi, lo squalo balena, che raggiunge i 18 metri di lunghezza, e lo squalo elefante, che arriva a 12 metri, si nutrono di plancton I PIÙ PICCOLI La specie più piccola è lo squalo pigmeo spinoso (Squaliolus laticaudus), che non supera i venti centimetri di lunghezza e vive a grandi profondità LA FOBIA La paura degli squali si chiama elasmofobia (gli elasmobranchi sono la sottoclasse di cui fanno parte squali e razze) e rientra tra i disturbi da panico sempre più rapido, specie per specie, in ogni parte del mondo?» scrive James Hillman nell’introduzione al suo libro Animali del sogno. Chi è lo squalo che ci minaccia da sempre, che si struscia contro la nostra paura, che cosa rappresentano nell’immaginario collettivo la sua bocca insaziabile, i suoi occhi gelidi, il suo moto perenne e instancabile? Forse è la bestia irriducibile che nessuna educazione morale, nessuna legge, nessun padre o prete possono addomesticare fino in fondo, anche se ci provano di continuo? Per dare forza ai nostri invisibili e affilati arpioni, abbiamo bisogno di concentrare il Male in pochi punti precisi, in figure losche e brutali alle quali nessuna pietà è concessa. Balene, tigri, pantere, serpenti, un tempo nemici temutissimi, sono stati riassorbiti dalla sfera del Bene, resi simpatici compagnoni nel Grande Circo della Natura e serenamente massacrati. Ma fino a poco tempo fa lo squalo non si prestava facilmente a questo gioco di furba riduzione, non ci stava a farsi incastrare in un proverbio o in una favoletta: scodava, ringhiava, mostrava la faccia più cattiva che aveva, non si voleva inchinare servilmente al progetto finto amichevole degli umani. Lo squalo di Alla ricerca di Nemo dimostra ancora tutta la sua incoercibile essenza: ci prova anche a dichiararsi pentito, a intraprendere una dieta vegetariana, a fare il giovialone con i pescetti, ma basta una goccia di sangue per riportarlo alla sua natura criminale. Va peggio a Lenny, il protagonista di Shark Tale, un giuggiolone pacifista che rifiuta il suo ruolo naturale, fino a sottomettersi all’amicizia di aringhe e sardine e accettare addirittura di travestirsi da simpatico delfino con tanto di fazzoletto al collo per ingannare i parenti, all’inizio squali mafiosi e sanguinari, alla fine bestioni innocui. Insomma, se non riusciamo a sconfiggerlo con la forza, vogliamo ammorbidire il Male rendendolo ridicolo o patetico. Abbiamo già trasformato il tremendo pescecane del Pinocchio di Collodi in un balenone un po’ fesso, una sorta di anonima caverna di carne pronta a raccogliere naufraghi e cianfrusaglie e a risputare fuori tutto con un mezzo rutto. E vi ricordate Joe Jordan, il centravanti inglese del Milan degli anni Ottanta? Era arrivato a San Siro con il soprannome de “lo Squalo”, e ci si aspettava che azzannasse il pallone e le caviglie degli avversari, sfondasse le reti, creasse panico nelle difese. Poveraccio, prima di entrare in campo si levava la sua protesi dentaria, le zanne dell’odontotecnico, e vagava per il campo a bocca semiaperta, con quel buco nero al posto degli incisivi e dei canini. Era a fine carriera e segnava pochino; la gente lo incitava: vai Squalo, mangiateli tutti, vai! e lui sorrideva sdentato e malinconico. E i cinici pescecani del mondo degli affari, quelli che s’arricchivano alle spalle dei soldati della Prima Guerra Mondiale, che sempre hanno lucrato sulle disgrazie altrui, dove sono finiti? Loro sì che erano delle bestie senza cuore da temere e odiare. Siamo passati a Sbardella, Squalo democristiano della specie dei Maneggionis Capitolini, forchettone bonario, grasso e pelato. E ora ci sono i Raider, squaletti azzimati della finanza, col capello da parrucchiere di periferia e le giacche firmate che tirano un po’ sotto le ascelle. Somigliano troppo ai furfantelli che incontriamo ogni giorno qua e là, a certi compagni di scuola che barattavano e vendevano un po’ di tutto, anche la roba degli altri: sembrano una nuova puntata di qualche cartone animato, disegnati in pochi tratti dalla matita di un umorista senza ispirazione. Non ce la fanno a metterci veramente paura, hanno già gli occhi dei pesci fradici. Ricordo un carrozzone zingaresco che girava per i paesi della mia regione. Una ex-bellona vestita con una succinta divisa d’oro e d’argento gridava in un microfono: «Venite a vedere l’assassino degli oceani, il mostro infernale dagli occhi di ghiaccio, la belva degli abissi! Venite, proverete il vero orrore, vi sognerete lo squalo divoratore per tutta la vita!» I bambini esitavano tra l’attrazione e il terrore, quindi pagavano il biglietto ed entravano. E anch’io li ho seguiti e sono entrato nel carrozzone per guardare negli occhi la Bestia. Prigioniero di un acquario ombroso nuotava un piccolo pescecane, così lontano dall’Oceano e dalla libertà da fare sinceramente pena. I bambini gli ridevano in faccia, e lui li fissava come un vecchio ergastolano che non spera più nella grazia. Di tremendo non aveva proprio nulla, era l’emblema dell’impotenza e della sconfitta, un povero Zampanò senza neanche la sua Gelsomina. Insomma, gli Squali ormai partecipano alla decadenza generale, sono ridotti, come i cantanti, i comici, gli scrittori e i politici a fenomeni da baraccone, a occupare una poltroncina nel Megaspettacolo Universale, finché dura. Mostrano i denti per un gettone di presenza, fanno i cattivi in un film di quart’ordine. E infine vi devo confessare una cosa: alcuni anni dopo la tragedia della cugina tedesca, affiorò dal mare un’altra verità, più banale. Forse non era stata sbranata da un feroce pescecane, forse era fuggita con un uomo sposato, piccolo squalo di terra. 48 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 23 OTTOBRE 2005 i sapori È nei fine settimana di ottobre che si celebrano le tante sagre dei marroni, proposti in mille varianti di ricette: dal salato all’agrodolce passando per i dessert. Siamo da anni i primi produttori europei ma solo oggi abbiamo imparato ad apprezzare il cibo principe delle antiche comunità di montagna Tesori del bosco Marron glacé I marroni, cotti al vapore e sbucciati con attenzione perché restino interi, vengono bolliti e raffreddati per tre volte con sciroppo di zucchero e vaniglia. Si lasciano riposare per tre settimane Castagne secche La tecnica di conservazione più diffusa necessita di un calore moderato (sotto i cento gradi) e costante che sottrae umidità. Per utilizzarle, si lasciano in ammollo in acqua tiepida una notte Tra dolci, zuppe e glasse l’autunno esce dal riccio Castagnaccio LICIA GRANELLO Mezzo litro di acqua fredda, 250 gr di farina di castagne, due cucchiai di olio e un pizzico di sale: versare la pastella in teglia unta con uvetta sultanina, pinoli e rosmarino. Cuoce circa un’ora a 200 gradi 78.432 Le tonnellate di produzione annua nazionale di castagne «M angiamo pane e castagne», cantava De Gregori, simbolo di un passato povero e per niente rimpianto. Deve essere trascorso un tempo lunghissimo, se è vero che oggi comprare castagne — e peggio ancora i marroni! — costa quanto la frutta più preziosa. In realtà, chi abita la montagna, dal Piemonte alla Calabria, ha ricordi vivi e dolenti di quel menù obbligato, tanti carboidrati e poche, pochissime proteine. Eppure, il fascino di zuppe e caldarroste è un’onda lunga che torna puntualmente sulle nostre tavole quando i vetri si appannano e le temperature di colpo ostili ci obbligano a frettolosi, forzati cambi di guardaroba. Così, il mese di ottobre, al primo affacciarsi dell’autunno meteorologico si popola di sagre, fiere, percorsi monodedicati che 40% È la quota di produzione che si consuma fresca attraversano l’Italia intera: solo in questo fine settimana, da Civitella Licinio (Benevento) a Aritzo (Nuoro), da Marradi (Firenze) a Rocca di Papa (Roma), decine di borghi celebreranno il mito di un finto frutto — quello vero è il riccio, di cui la castagna rappresenta il seme ben pasciuto — addobbato e lavorato in mille modi. Difficile trovare una “materia prima” più malleabile, trasversale, da declinare in tutte le accezioni possibili: salata, dolce, agrodolce. Sontuoso ingrediente-principe di leccornie assolute ma anche contorno suadente delle carni più difficili, sotto forma di purè, crocchette, glassate intere. La tradizionalissima zuppa di castagne — da sola o in combinazione con patate, fagioli, riso — si può gustare come minestra corroborante o come dolce della memoria. Perfetta nelle farciture: dalla 160 Le calorie contenute in 100 grammi di castagne Monte Bianco Caldarroste Crema di marroni Castagne bollite Zuppa di Castagne Il dolce prevede doppia cottura delle castagne, in acqua e latte, zucchero e vaniglia. Limitando a 20 minuti la prima bollitura è più facile sbucciarle La cupola di filamenti ottenuti si rifinisce con panna montata La padella di ferro forata va preferita al forno perché la scorza (incisa) bruciacchiata regala aroma e sapore. Se a fine cottura si avvolgono in un canovaccio umido d’acqua o di vino rosso, risulteranno più morbide I marroni bolliti, sbucciati e rimessi in pentola con latte, zucchero, cacao, vaniglia, si passano a fine cottura. Il composto, con l’aggiunta di un cucchiaio di panna liquida, si serve freddo, anche con salsa di cioccolato È la cottura-base (45’) di molte ricette dolci e salate. Ma vale anche come cibo a se stante: basta aggiungere nella pentola – con acqua e un cucchiaio di sale – qualche foglia di alloro, o i semi di finocchio È base dell’alimentazione povera di montagna Si prepara con castagne secche rinvenute in acqua o fresche, coperte di latte e lasciate bollire a fuoco lento per almeno un’ora Si consuma salata, zuccherata o con riso DOMENICA 23 OTTOBRE 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 49 itinerari Romano, ma toscano di adozione, Fulvio Pierangelini è il talento più rigoroso della cucina italiana Ha tra i suoi piatti-culto la pernice con castagne, erbe e zucca Chiusa Pesio (CN) Marradi (FI) Centro sciistico immerso nel parco naturale dell’Alta Valle Pesio e Tanaro, alle falde del Marguareis, vanta la produzione dei bellissimi marroni dalla buccia lucida e striata, grandi e regolari, perfetti per i marron glacé Situata nella valle alta del Lamone, terra famosa per la qualità delle castagne, varietà “marrone” della Castanea Sativa, protetta dall’Igp come Marrone del Mugello. È comune fondatore della “Strada del Marrone” Appoggiata in una vallata della bassa Irpinia, circondata dalla catena appenninica, rappresenta il cuore della produzione di castagne di alta qualità - Palummina e Verdole protette a livello europeo da vent’anni DOVE DORMIRE DOVE DORMIRE DOVE DORMIRE B&B LE CABANE Borgata Tetti Caban Frazione Vigna 57 Tel. 0171-338207 Doppia da 50 euro, colazione inclusa B&B SARTONI Cardeto Val Stefano 38 Tel. 339-8728226 Doppia da 40 euro, colazione inclusa AGRITURISMO PERICLE Località SottoMonticchio Tel. 0827-609161 Camera doppia da 50 euro colazione inclusa DOVE MANGIARE DOVE MANGIARE DOVE MANGIARE AL RODODENDRO Via San Giacomo 73, San Giacomo Tel. 0171-380372 Chiuso domenica sera e lunedì menù da 42 euro MULINO SAN MICHELE Via Perisauli 6, Tredozio Tel. 0546-943677 Chiuso a pranzo e lunedì, menù da 25 euro LOCANDA DI BU Vicolo dello Spagnuolo 1, Nusco Tel. 0827-64619 Chiuso domenica sera e lunedì menù da 33 euro ‘‘ Il canto «Castagne e pinoli caldi caldi!», cantava. Le castagne e l’uomo si davano calore a vicenda FOTO OLYMPIA Da La mia vita con Pablo Neruda di Matilde Urrutia Castagne le Repubblica Nazionale 49 23/10/2005 faraona alla pernice, la sua profumata consistenza è garanzia di un ripieno coi fiocchi. I dessert, poi, meritano un discorso a parte: il gelato di castagna, il sensuale Monte Bianco, ma anche il “povero” castagnaccio occupano posti di rilievo nella gerarchia dolciaria. Su tutti, ovviamente, domina il marron glacé, massima espressione della golosità pasticciera applicata ai fratelli maggiori delle castagne. Il recupero della cucina delle castagne è una benedizione anche dal punto di vista ambientale. Abbiamo perso così tanti boschi di castagne nell’ultimo quarto di secolo — pressoché dimezzati, da oltre 140mila a 74mila, gli ettari votati alla castanicoltura — che quasi ci si stupisce di essere ancora i più importanti produttori europei e i terzi al mondo, dietro Corea del Sud e Cina. Per fortuna, l’inversione di tendenza, nel totale smarrimento della nostra cultura agricola, sta irrobustendo la Montella (AV) quota di esportazione e rimpinguando l’elenco delle aziende dedicate. Una pratica spesso ripensata in modo da coprire l’intera filiera produttiva, dalla raccolta alla trasformazione. Se andate a rallegrarvi in uno dei tanti paesi delle castagne, scoprirete che l’unico limite alla preparazioni elaborate nelle cucine locali è davvero solo la fantasia: c’è il pane, morbido e insolito, ma guai a sottovalutare i tortelli ripieni, la torta soffice, le tagliatelle, le polpettine, le crèpes, gli gnocchi. Ai turisti in trasferta francese, invece, non dovrebbe sfuggire la zuppa cremosa di castagne con foie gras creata da Yves Camdeborde, uno degli chef che ha più nobilitato e innovato l’offerta gastronomica dei bistrot di Parigi. Andateci — lì e altrove — con una castagna in tasca. Dicono i nonni che aiuta a difendersi dal raffreddore. Che ci crediate o no, con la pioggia fredda di questi giorni un aiuto in più non guasta. La fortuna dei marroni attraverso i secoli Così nacque sull’albero il pane della povera gente MASSIMO MONTANARI «L e castagne sono il pane della povera gente», recita uno Statuto toscano del Quattrocento. Due secoli dopo, l’emiliano Giacomo Castelvetro osserva: «Migliaia dei nostri montanari si cibano di questo frutto al posto del pane, che non vedono mai, o molto raramente». La fortuna dei due prodotti, le castagne e il pane, procede parallela. C’è un momento nella storia italiana ed europea — i secoli centrali del Medioevo, tra il X e il XII — in cui la crescita della popolazione non consente più di vivere sull’economia forestale. Quel che ne deriva è una vera mutazione ambientale. Nelle regioni di pianura, progressivi disboscamenti spazzano via gli alberi per far posto ai campi di grano. Nelle regioni di montagna, dove il grano fatica a crescere, i boschi non scompaiono, ma si trasformano. I querceti, grandi produttori di carne suina, che dominavano nei secoli precedenti, vengono in gran parte sostituiti da boschi “coltivati”, che danno un frutto diverso dal chicco di grano, ma in fondo simile: anche la castagna, una volta seccata, si può macinare e diventa farina. Il sapore è diverso, gli usi alimentari si rincorrono: pane, polente, dolci… Per questo, nei paesi mediterranei, il castagno è detto “albero del pane”. La castagna è il pane di quell’albero. Oggi le castagne sono un tipico frutto di stagione. Un tempo, il loro consumo era meno legato al tempo della raccolta. Accurate tecniche di conservazione consentivano di farle durare a lungo, o semifresche nel loro riccio, o seccate al calore del fuoco. «Nelle nostre montagne», scrive nel XVI secolo l’agronomo bresciano Agostino Gallo, «gran parte della popolazione non vive d’altro che di questo frutto». Nel 1553 il capitano della montagna pistoiese nota che gli abitanti di Cutigliano sono «poverissimi, e i sette ottavi di loro tutto l’anno non mangiano che castagnacci». Nelle zone meno povere e negli anni meno difficili, questa particolare «serbevolezza» del prodotto dava luogo anche a un fiorente commercio. Castagne e marroni finivano su mercati lontani (anche oltremare) e restavano in vendita per molti mesi, fino a primaverainoltrata.VincenzoTanara,nelXVIIsecolo,osservache i marroni si possono servire anche d’estate «per stranezza». Dalla fame allo sfizio, il passo è più breve di quanto non sembrerebbe. La gastronomia della castagna pare essere stata, nei secoli passati, più ricca e fantasiosa di oggi. Castore Durante, nel XVI secolo, ricorda l’uso di cuocerle «in un tegame con olio, pepe, sale e sugo d’aranci». Il succo d’arance ritorna in Giacomo Castelvetro, che vuole sale e pepe sulle castagne arrosto e riferisce l’uso di farcire con le castagne (dopo averle bollite nel latte) le carni di volatili: «E sono molto buone, e ne riempiono i capponi, le oche e i tacchini che vogliono arrostire, con susine secche, uva passa e pane grattugiato». Una ricetta europea che avrebbe trovato particolare fortuna nel continente americano. Vincenzo Tanara raccoglie molte ricette locali (come quella, piemontese, dei marroni cotti in vino «con finocchio, cannella, noce moscata o altri aromi») e si dilunga sui dolci, castagnacci e frittelle di varia composizione. Per parte sua, dice di preferire i gusti semplici: «I castagnacci fatti tra le sue fronde, e cotti tra le tegole rotonde di pietra cotta, grosse un dito, ben calde, anzi roventi, quando si mangiano, fatti da poco e ancor tiepidi, sono una vivanda squisita, accompagnati col companatico del buon appetito». L’autore è docente di Storia medievale all’Università di Bologna 50 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 23 OTTOBRE 2005 le tendenze Mutazioni chic È un riflesso automatico nei periodi di crisi: il revival del nero. Ha cominciato l’alta moda rilanciando il colore classico dell’eleganza. Ma la tendenza al dark è presto dilagata in altri ambiti creativi: il mercato degli accessori, il design d’arredamento, l’architettura. E perfino il cinema, con film come “Sin City” e “Il cadavere della sposa” Gotico neo Sedotti dal lato oscuro degli oggetti “Era necessario - dice Miuccia Prada - porre fine a una serie troppo lunga di stagioni colorate, frivole, superficiali” JACARANDA CARACCIOLO FALCK ccade ciclicamente nei periodi di crisi. Quando qualcosa, l’incertezza politica o un’economia traballante, comincia a infiltrarsi nella vita di tutti i giorni. E a creare preoccupazione. Ecco allora che i creativi rispondono a modo loro, rispolverando il colore più simbolico del mondo: il nero. Quella tonalità-icona che, da sempre, evoca immagini diverse. Ma, da sempre, molto intense. Di revival della moda black l’universo della moda è pieno. Accadde nella cupa Inghilterra vittoriana, nel ‘29 dopo il crollo di Wall Street, nell’Italia fascista. E così via fino a epoche più recenti. Eppure oggi il fenomeno è diverso. Molto più ampio. Perché non coinvolge solo i grandi couturier. Ma tutti i tipi di creativi: arredatori e artisti d’avanguardia, cuochi e designer, registi e scrittori. Uniti dall’improvvisa passione per la cultura del nero. Da esplorare in modi diversi. Per qualcuno il colore delle tenebre è semplicemente quello dell’eleganza. Indossato dalle grandi star di ieri, come la Rita Hayworth che balla sensuale sul set di Gilda. Per altri ha una valenza più profonda. Perché è la massima espressione di quello stile neogotico che, ispirandosi al medioevo, ne riprese i simboli più tetri. Una via di mezzo, per intenderci tra le favole dei fratelli Grimm e lo stile funereo della famiglia Addams. Gothic o semplicemente dark, una cosa è certa: anche questa volta i primi a lanciare la tendenza sono stati gli stilisti. A cominciare da Miuccia Prada. Che commenta: «Un ritorno al nero era necessario per porre fine a una serie ormai troppo lunga di stagioni colorate, leggere, frivole, superficiali». E aggiunge: «Il nero, poi, esprime un desiderio di vera femminilità, anche se dolente, di bellezza e di eleganza». Per rendersi conto di quanto Prada ami il nero basta entrare in una delle sue boutique: vestiti e pantaloni, scarpe e pellicce sono rigorosamente monocromatici. Addolciti, in qualche caso, da un dettaglio luminoso, una spilla di brillanti o un bordo di pizzo. Niente più. Il contagio della nero-mania si è diffuso: da Marc Jacobs, che ha spiegato di essersi ispirato, per la sua collezione, ai macabri disegni del fumettista di Chicago Edward Gorey; alla belga Ann Demeleumesteer che ha realizzato i suoi tailleur decostruiti in stoffa rigorosamente nera. Da Celine, che ha optato per uno stile da signora anni Cinquanta con gonne sotto al ginocchio e scolli all’americana; a Lanvin, che ha risposto con una serie di severi tailleur dal taglio vintage. Perfino Roberto Cavalli si allinea: «Io amo il colore e le fantasie ma non riesco a rinunciare mai al nero perché è il colore della seduzione, della notte e rappresenta il mistero delle donne. Il nero può essere anche la più forte forma di colore perché esalta la silhouette ed evidenzia i dettagli». Il nero, poi, spopola, tra gli accessori: le borse con fiori di pelle applicati di Bottega Veneta, gli scarponcini con zeppa di Hogan, la pochette in coccodrillo firmata Roger Vivier, o gli stivali sexy di Gucci. Dalle passerelle la passione noir è approdata al design. «Nei paesi del Nord Europa il nero è sempre stato usato, da noi invece veniva guardato con ostilità», spiega Tommaso Ziffer, l’architetto preferito del magnate dell’hotellerie Rocco Forte e autore dell’hotel de Russie a Roma e dell’hotel de Rome a Berlino, che verrà inaugurato tra qualche mese. «Invece è molto più facile del bianco ed anche più elegante». Non è finita qui. Il revival dark è arrivato anche al cinema con il nuovo Il cadavere della sposa di Tim Burton o con il capolavoro black and white Sin City. Perché oggi il nero non ha più confini. Repubblica Nazionale 50 23/10/2005 A SERATA SPECIALE Un’idea per una serata speciale? La gonna a sirena bordata di pizzo di Gianfranco Ferrè Si porta con giacca smoking e camicia di raso. All black L’ODORE DEL CUOIO Evoca atmosfere dark la sedia in pelle Buré di Antidiva. In ferro curvato con seduta in cuoio nero UN’IDEA DA SALOTTO Il nero trionfa in salotto con il tavolino e le sedie Blow up del designer Xavier Lust per Moroso L’OMBROSO CALICE Il cristallo vira al nero. Merito di Philippe Starck che per Baccarat ha realizzato calici dal nome evocativo: “Exploring your dark side…” DOMENICA 23 OTTOBRE 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 51 C’ERA UNA VOLTA IL LAMPADARIO Ricorda i lampadari delle case di caccia di una volta il modello in vetro nero, con bracci a calice. Di Gallery vetri d’arte SOGNI NOIR È brunito e laccato il legno del letto decisamente noir della catena d’arredamento britannica The Conran shop SI CHIAMA ZOE Il lampadario diventa moderno: Zoe, firmato La Murrina, è ideato con steli che si aprono a raggiera È disponibile in due misure (diametro 65 o 90 cm) e in 4 colori UN FIORE AL DITO Fa parte della collezione Camelie di Chanel l’anello in oro e onice nera Perché preferisco gli angeli del buio ISPIRAZIONE RETRÒ Ispirazione vagamente retrò anche per i sandali da gran sera di Ferragamo Con tacco alto e nappe PHILIPPE STARCK l nero è il colore degli ultimi due secoli. E la ragione per la quale oggi possiamo permetterci di vestirci con questa tonalità è, in realtà, tecnica. Nel Medioevo, infatti, le classi abbienti vivevano in grandi e tetri castelli. Illuminati solo da minuscole finestre e da centinaia di candele. Il risultato? Si trascorrevano le giornate nell’oscurità. In filosofia si usa dire che noi esistiamo solo se qualcuno ci guarda. I nobili medioevali dunque, per esistere dovevano fare in modo di essere visti e per essere visti, dovevano indossare colori sgargianti, lustrini e ricami. Altrimenti sarebbero scomparsi. In tutti quei secoli dunque solo gli ecclesiastici vestivano di scuro proprio per marcare la loro non appartenenza a un certo tipo di società. La black mania, come la intendiamo noi, è cominciata in maniera esplosiva negli anni Ottanta del secolo scorso quando tutti vivevano in stanze super illuminate. In quel periodo fanno la loro comparsa in modo massiccio la nuova lampada alogena e il neon: sono gli anni più luminosi della storia. E quindi vestirsi di nero diventa un modo per farsi notare in una realtà dove il bianco tende ad apparire sbiadito. Questa relazione tra nero e luce mi ha sempre affascinato molto. Per quanto riguarda la mia personale relazione con questo colore, ho cominciato a utilizzarlo per dare un messaggio. Quando creo, uso sempre dei simboli, tutti i miei oggetti sono il frutto di una serie di riferimenti che vogliono comunicare qualcosa. Nella vita di oggi tutti devono apparire al loro meglio: perfetti, sorridenti, belli. L’unico lato della nostra personalità che viene preso in considerazione nel mondo contemporaneo è quello bianco, luminoso. La nostra è la società della felicità a tutti i costi. Ma il mondo in realtà è composto da due tipi di angeli, quelli bianchi e quelli neri. Il lato bianco non può esistere senza quello nero. Che anzi, spesso, è più interessante. Io per esempio, sono perfettamente conscio che la mia metà bianca non è molto divertente. Tutto quello che ho creato nella mia vita arriva dal mio subconscio, da mio istinto, dal mio lato oscuro. Ecco allora che la linea di calici che ho disegnato per Baccarat, chiamata appunto “Exploring your dark side…” è un invito a cominciare un viaggio esplorativo in un’altra dimensione della nostra personalità. Per me dunque il nero è il simbolo di un nuovo territorio del nostro subconscio. Anche perché, da sempre, preferisco l’eleganza della melanconia, rispetto alla volgarità della finzione. (testo raccolto da Jacaranda Caracciolo Falck) I GIOIE DA REGINA Un gioiello particolare: il collier dalle forme liberty con brillanti chiari e scuri, rubini e platino Christian Dior jewellery Repubblica Nazionale 51 23/10/2005 LE FORME DEL LEGNO Legno tornito laccato nero per il tavolino della serie New Antiques, design Marcel Wanders per Cappellini LOOK DI GALA Look bon ton rivisitato e corretto per la signora di Vuitton che indossa un abito passepartout con guanti, e stivali VIVA LE PASSAMANERIE A Prada ora piacciono le passamanerie nere che ricordano molto quelle d’epoca vittoriana Onnipresenti sulle borse DETTAGLI HARD Per le donne che vogliono un’immagine aggressiva: le scarpe a punta di Guess con cinturino alla caviglia IL FASCINO DEI QUARANTA Si rifà ai modelli in voga negli anni Quaranta la borsa da sera con frange in perline di vetro firmata Armani 52 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 23 OTTOBRE 2005 l’incontro Ha costruito un nuovo genere teatrale e ha portato sulla scena scandali e misteri,memorie civili, saghe generazionali. E ora torna a raccontare se stesso, la famiglia proletaria, gli amici dei bar di provincia, la rocambolesca gavetta sulle piazze d’Italia, la sofferenza amorosa e creativa. E così, a sorpresa, si scopre un uomo che, dopo aver sparso sulle platee infinite parole, in fondo fra sé e sé crede all’emozione del silenzio One man show Marco Paolini di lotta. Un’impresa didattica ma divertente. Replicammo nelle feste, al primo maggio, o nei raduni di quartiere. Io, fin dalle prove, avevo la tendenza di mandare in vacca il copione, storpiandolo, facendo ridere gli spettatori, rendendo furibondi quelli che erano in scena con me. Covavo secondi di immenso piacere prima di dire cose micidiali. Mi sentivo idealmente sostenuto dalle correnti alimentate da Santarcangelo e dalla rivista Scena di Attisani che faceva ponti audaci tra gli acrobati sui trampoli e Laurie Anderson». E qui Paolini è testimone delle mutazioni, delle contraddizioni, degli estremismi, delle poetiche del corpo. Le ha passate tutte. Fino a potersi permettere qualche rispettosa ironia. «Non so, forse c’è stato un momento in cui m’ha persino rovinato una certa lettura del teatro povero di Grotowski, una nuova Bibbia che raccomandava di disimparare le battute e fare le capriole. Il teatro, d’accordo, è anche questo, e la ventata servì a “sessualizzare” attitudini che altri- Io mi sento artigiano non artista, il senso di quel che faccio oggi c’era già tutto nel girovagare col furgone, come gli ambulanti dei mercati FOTO GERALD BRUNEAU Repubblica Nazionale 52 23/10/2005 «I terie di altri, a locali dove bighellonava il mio giro. Ho ritratto con immenso affetto il bar della Jole, perché sede e meta collettiva della Jole Rugby Trevigi. Il mio passaggio dall’infanzia all’adolescenza, dalla terza media al primo liceo, ha semmai a che fare con la socialità di un tavolo: smettendo di stare con un compagno di giochi, passavo al contatto con un gruppo di persone che in genere chiacchieravano di politica attorno a un tavolo. Ragazzi poco più grandi di me, che discutevano di cose interessanti come il Vietnam o la situazione in Portogallo, o di straordinarie svolte come il ‘68, che capivo essere una rivoluzione visto che la categoria dei giovani, fin lì inesistente, s’era presa la scena senza aspettare l’eredità degli anziani, apprendendo tutto dai coetanei. Con i rischi relativi». I rischi della seduzione che subisce chi vive lontano dal centro e sconta tempi più lunghi, con le novità che arrivano come un’eco, col complesso di doversi mettere in pari. Magari arrancando, magari non afferrando il cuore esatto di ciò che avviene. «Pasolini dice che c’è un’età in cui è casuale che ti schieri da una parte o dall’altra, dietro le idee proletarie o quelle di destra. Dipende da un niente. Da un buon maestro o da un cattivo maestro. Io sedetti al tavolo accanto a quelli che mi fecero scoprire Kerouac, Hemingway, Pavese, e i dischi di Dylan». Gli amici divennero un modello cui Paolini è rimasto legatissimo, anche se non ha più incontrato i compagni di strada. E gli servirono da termine di confronto. «Stando con gli altri t’accorgi che non sei sempre il più bravo. Che ci sono cose che sai fare e cose cui devi rinunciare. Mi riferisco allo sport, al calcio. C’è chi tocca il pallone e “vede” il gioco, e fa il passaggio perfetto, mentre io dovevo alzare la testa, e perdere tempo. Ero un calciatore mediocre, smisi. Mi riferisco alla musica. Ho scoperto con dolore che, mentre tutti se la cavavano piuttosto bene, io ero negato a suonare la chitarra. Però mi rifacevo e mi rifaccio tutt’oggi cantando. Negli anni Settanta sono partito con cose popolari, canzonieri politici, il folk di Woody Guthrie, le creazioni di Giovanna Marini (me le “bevevo”), ogni tipo di tradizione». Da questa cultura dell’impegno alla pratica del teatro il passo è breve. Paolini converte la politica sul territorio e i circoli di apprendistato sociale in voglia di comunicazione scenica, e il festival di Santarcangelo di Romagna è l’utopia che diventa raduno, coscienza, cantiere di progetti, piattaforma di spettacoli. Ma prima che Paolini diventasse Paolini, qual è stato il tirocinio? «Al principio fu Brecht. Mettemmo in prova per un anno e mezzo un Galileo, senza venirne a capo. Impararlo a memoria era un inferno. Invece ci riuscì, nel ‘74 al liceo, l’allestimento de L’eccezione e la regola, con un prologo e un epilogo di canzoni popolari di lavoro, menti, soprattutto nel Veneto oberato da sensi di colpa, procedevano in modo formale e castrante. Io trovai la spinta per aderire ad alcune realtà del teatro di gruppo: Pontedera, il Teatro del Tamburo di Genova, e César Brie a Milano dove trovai Danio Manfredini. Nel frattempo m’ero piuttosto dedicato al teatro ragazzi, costituendo con altri due attori il Teatro degli Stracci». Giorno dopo giorno le ossa si facevano con la clownerie, con tracce di testo, con l’allenamento grotowskiano. «La mappa italiana era costituita dalle sedi delle altre compagnie di ricerca, un circuito del mutuo soccorso. Io facevo un’imbarcata disordinata di esperienze strane ma utili. In certi casi lavoravo senza aprire bocca. Eravamo comunque ostili alle gerarchie accademiche. Io ho fatto un solo provino in tutta la mia vita, quasi un omaggio affettuoso a Glauco Mauri che mi “bocciò” e aveva ragione: anziché portargli un monologo, gli raccontai una storia, e lui rimase interdetto ma mi fece lo stesso i complimenti. Per fortuna, in parallelo, senza scalzare l’edificio delle regole, s’affermava un’altra prospettiva del teatro, quello delle piazze, del “passare una sera assieme”, dei festival». In questo ieri l’altro che ha recato emozione e nuovi linguaggi al teatro, lui restò folgorato dai danzatori balinesi, dalle scuole di mimo, dal contatto con Bolek Polivka, dal carisma dell’argentino Brie. In materia di origini personali, a quale tribù appartiene Paolini? «Mio padre era ferroviere e sindacalista della Cgil, mia madre proveniva da un ceppo che trattava il legname. La mia famiglia era proletaria. Ma quando ho detto, al quarto anno di Agraria, che lasciavo tutto per il teatro, mi risposero con infinita fiducia e immensa generosità: “Fai quello che credi di fare”. Ecco, quel loro assecondarmi è stata una lezione di vita. E sono stato libero di mettere le mie economie in comune coi compagni di lavoro per bollette, benzina, mangiare. La formula che ho sempre messo a punto è quella dell’artigianato. Io non mi sento artista. Il senso di quello che faccio oggi c’era già tutto nel girovagare col furgone come gli ambulanti dei mercati, stracarichi noi come loro». Poi bisognerebbe dire come e quando l’uomo-artigiano Paolini è caduto da cavallo, è incappato in una visione che gli ha cambiato la vita. «Il riferimento è uno, fortissimo. Quando ho assistito alla Classe morta di Kantor ho avuto uno shock, sono rimasto disarmato, e ho pianto e riso. Una cosa rara che ti si mette nel cervello per sempre, che in mezzo a tanta noia ti produce l’effetto di un innamoramento». Già, l’innamoramento. Adesso la parola l’ha pronunciata. Sembrerebbe che Paolini corteggi solo i problemi, gli scandali, le tragedie corali, i sentimenti duri. Ma dietro quella sua scorza da pubblico ministero cordiale o da personaggio angosciato, ci saranno pure gli affetti, o no? «Il teatro è stato an- che, ovviamente, una meravigliosa scusa per darsi da fare. Viaggiare e avvicinare donne che sai che non vedrai mai più. Innamorarsi di tutte. Sentirsi autorizzato ad approcci di tipo artistico, e non negarsi poi il resto. Le affinità sono il motore di ricerca maggiore. E un paio di occhi di cui innamorarsi te li aspetti, quando giri». Un teatrante che mette il corpo nel documentare le ingiustizie, crea anche per sofferenza propria? «Credo di sì, ma forse non è importante parlarne. Direi comunque che la sofferenza c’è quando ti ostini a far funzionare qualcosa che non funziona più, e allora solo il rimanere da soli ti può aprire la testa. La solitudine è ferocemente creativa, rinascono energie. Quando, all’ennesima volta, ho capito il meccanismo, mi sono chiesto se era necessario riattendere il dolore, o se non fosse sufficiente (come lo è) staccare e farsi un viaggio da soli. Produrre il vuoto senza fratture». Ora, uscito a settembre il secondo volume de Gli Album nell’Einaudi Stile Libero, riposerà e studierà sino a fine anno, e a gennaio riprenderà la tournée col Sergente e con Song n. 32. «Stratifico, mi vorrei concedere il lusso dell’extratemporalità e dell’anacronismo, vorrei mettere a frutto il “live”, quello che ricevo dal pubblico, perché il paese vitale è diverso dal paese reale rappresentato dai media. L’ispirazione più bella nasce da un coro vigoroso fatto di storia, poesia e passioni, da una Costituente di identità. E nasce anche dalle frequentazioni: imbattersi in Meneghello o Zanzotto, discutere qualche volta all’anno con Erri De Luca con cui ho lavorato in concerto, sono doni che ti lasciano idee. Ma sto bene anche con amici che lavorano in fabbrica, con chi coltiva i campi, con chi fa il tassista. Mai, è la regola, abusare delle confidenze. Le cose durano se sono rare. M’è bastato un concerto di Bruce Springsteen, e la bellezza m’è rimasta». ‘‘ RODOLFO DI GIAMMARCO o non sono cresciuto con le favole dei miei, coi racconti domestici di vita vissuta. L’unico piacere infantile dell’ascolto che m’è rimasto in mente è un’immagine sonora: mio padre che mi legge Topolino con l’intercalare dei gulp e dei gasp accentuati in modo abnorme grazie a un cambio di tono e di volume. Ne uscivano fuori astrazioni, onomatopee, rumori corporei che davano una scossa a tutto il fumetto. E questa cosa mi piaceva, mi rimaneva impressa. Molto. L’altra “parola”che nella prima gioventù ebbe una risonanza diversa fu quella della televisione, che da me, a Treviso, entrò in famiglia nel 1967, quando io avevo undici anni. A dire la verità non ne sentivo il bisogno. Fin lì avevo saltuariamente rubato qualche pezzo di discorso dagli apparecchi installati nei bar». La voce è fluida, bassa, orientata a un’intimità corretta da disincanto. Dopo aver ricostruito testimonianze epocali, memorie civili e saghe e apologhi di generazioni di coetanei, Marco Paolini ora racconta se stesso. Non è stato facile, convincerlo. Ha l’aria d’un montanaro che preferirebbe descrivere paesaggi piuttosto che tragitti personali. Ha sempre, a ribadire un’indole da soggetto fuori del mucchio, quella lieve barba incolta da esploratore di uomini, e di storie. Ha il sorriso candido e schivo d’un jazzista che dal suo strumento, la bocca, vomita infinite parole ma che poi fra sé e sé crede all’emozione del silenzio. Ha citato il bar, luogo paradigmatico dei suoi Album teatrali, parlatorio dei ragazzi di provincia. Il bar come mitico crocevia, come seconda casa, come rifugio degli sportivi... «Ma lo vuol sapere? In realtà io non avevo un mio bar. Mi riferisco a caffet-
Scarica