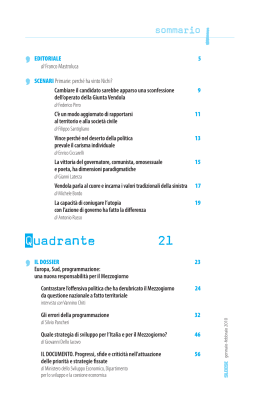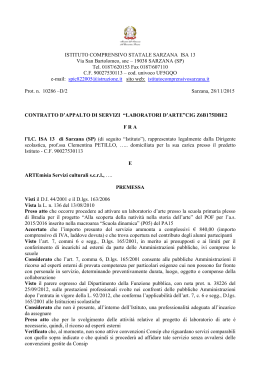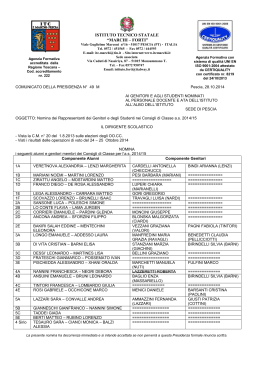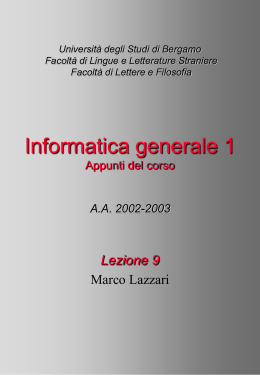Davide Mosca IL PROFANATORE DI BIBLIOTECHE PROIBITE © 2012 Newton Compton editori s.r.l. Per Dada Prima di correre a cercare risposte vivi bene le tue domande. RAINER MARIA RILKE Le parole sono azioni. LUDWIG WITTGENSTEIN Tu, Dio, che conosci il nome mio. Canto popolare 1 Lazzari aveva inaugurato l’enoteca già da due giorni quando entrò il primo cliente e con voce risoluta ordinò una bottiglia di Falerno. Era un vino che non si produceva più da almeno millecinquecento anni, a quanto poteva saperne. Non si era preoccupato di pubblicizzare la nuova apertura e all’inaugurazione di due sere prima aveva invitato soltanto poche persone: la dipendente del Comune che lo aveva seguito nelle pratiche amministrative, un paio di fornitori locali, il muratore e l’elettricista che si erano occupati dei lavori, la sua eclettica padrona di casa, una di quelle donne capaci di risollevarti il morale con una sola parola, il portalettere della zona e il commercialista. Il commercialista non era venuto e al suo posto aveva mandato la segretaria con un mazzo di quindici rose blu. Il cliente si chinò rigidamente sul decanter che fungeva da vaso, per sentirne il profumo. Indossava un abito tagliato su misura e, appuntato sulle spalle, un abito tagliato su misura e, appuntato sulle spalle, un cappotto di taglio militare. Si muoveva con la lentezza evasiva e puntigliosa di chi sta per prendere possesso del suo nuovo ufficio e ha tutta l’intenzione di spostare i mobili e modificare ogni cosa. «Forse intende un Falerno del Massico», gli disse Lazzari, grattandosi la guancia. Non poteva credere che quell’uomo gli stesse davvero domandando un Falernum, il rosso più amato dagli antichi romani. «Capita sempre così». «Capita sempre cosa?» «Si tratta di un comportamento tipico. Speriamo sempre di non avere capito bene, che ci sia stato un malinteso, un errore, che la cartella clinica con la diagnosi fatale non sia la nostra, che il nome chiamato dall’ufficiale sia quello di un altro. Ma non è così, non è mai così». Lazzari spostò la mano dietro l’orecchio. «Ah no?» «Sa qual è il punto debole dell’uomo?», domandò lo sconosciuto. Poi, senza concedergli il tempo di rispondere disse: «La prevedibilità». «Non capisco». «Ha capito benissimo ciò che ho ordinato». Fuori passò una bicicletta. Poco lontano il mare rumoreggiava contro il molo e il legno del pontile rumoreggiava contro il molo e il legno del pontile anneriva sotto le onde; oltre il porto-canale, sull’arenile, compattato dalla pioggia della mattina, una banda di surfisti scaricava le tavole e le mute da due fuoristrada. «Il vino che mi chiede non esiste più». «Dice bene, professore». «Non sono un professore». «Dice bene per la seconda volta, assistente», confermò l’uomo e si sedette su una seggiola. Poi si tolse l’ingombrante cappotto, lo ripiegò con cura e se lo mise sulle ginocchia. «Non è mai andato oltre quel ruolo, vero?». Lazzari afferrò una dele bottiglie esposte sul bancone. «Posso offrirle un Aglianico? La provenienza è più o meno la stessa di quel Massico di cui le parlavo». L’uomo inforcò un paio di occhiali con la montatura di tartaruga e tirò fuori da una delle tasche del soprabito un’agendina rivestita di cuoio. In un angolo, sotto un taglio superficiale, erano cucite in filo d’oro le iniziali C.V.R. «Lei si iscrive alla facoltà di lettere e filosofia di Genova a diciotto anni e in appena un triennio sostiene tutti gli esami», attaccò a leggere. «Dopo la laurea, vince una borsa di studio per un dottorato in storia romana una borsa di studio per un dottorato in storia romana presso l’Università degli studi di Milano. Lo completa in tre anni circa con una tesi intitolata Il nome di Roma. Il celebre professor Casini le offre un ruolo da assistente presso la cattedra di storia romana e le fa assegnare tramite una fondazione un’ulteriore borsa di studio. Nel frattempo, infatti, partendo dai dati raccolti durante la tesi, lei ha cominciato a lavorare a un saggio sulla nascita di Roma. I pochi che hanno potuto visionare i materiali di supporto ne parlano in toni entusiastici. Professori di altre facoltà vengono a trovarla. Riviste specializzate ne scrivono. Il clima di attesa cresce». Si interruppe lasciando intendere a gesti che saltava dettagli e traversie secondarie. «Sedici anni dopo lei interrompe di punto in bianco la stesura del saggio, prende la clamorosa decisione di ritirarsi dall’università e...». L’uomo si tolse gli occhiali, chiuse l’agendina e allargò le braccia. «...Apre che cosa?» «Un’enoteca», terminò Lazzari. «Un’enoteca», ripeté l’uomo marcando la parola con disprezzo. «Credo che lo berrò io, quel bicchiere di Aglianico», disse Lazzari e ne versò un paio di dita in un calice. Poi ci ripensò e colmò il bicchiere fino all’orlo. «Posso ripensò e colmò il bicchiere fino all’orlo. «Posso conoscere il suo nome?» «Gli amici mi chiamano Colonnello». «E i nemici?» «Non ne ho». «Viene da parte dell’università? È un agente del consiglio economico o roba del genere? Volete indietro i soldi delle borse di studio? Non li ho più, li ho impiegati per studiare e ricercare...». «Anche questo è tipico», lo interruppe il Colonnello. «Ah sì?» «Non indoviniamo mai perché veniamo convocati. Immaginiamo sempre un motivo diverso da quello reale. Ti arriva una convocazione dall’ufficiale giudiziario e tu pensi a quella volta in cui non hai pagato le imposte». Lazzari posò la bottiglia che emise un rintocco sordo sul marmo che rivestiva il bancone. «Già, non pensiamo mai a un vino aromatizzato al miele in voga due millenni fa. Siamo davvero privi di immaginazione...». «Non sono qui per il vino». Lazzari non sapeva più che smorfia opporre a quelle insensatezze. Ormai non tratteneva neppure il suo sarcasmo. «Ah no? Mi aveva quasi convinto». «Sono qui per un sogno». «Lo ha fatto lei?» «Lo ha fatto lei?» «No, lo ha fatto lei». «Ah sì?» «Sì, un sogno di nome Roma». Lazzari rimase in silenzio alcuni secondi. «È stato tanto tempo fa», disse infine e spinse lontano da sé il calice. «Duemilasettecentosessantaquattro anni fa, per la precisione. Secondo la leggenda, Roma fu fondata proprio il ventuno aprile del 753 avanti Cristo. Per molto tempo gli studiosi hanno tenuto in scarsa considerazione i racconti tradizionali, ma gli ultimi ritrovamenti archeologici hanno rimesso in discussione tutto. I misteri sulla fondazione della più grande città di tutti i tempi hanno ossessionato lei e migliaia di altri che l’hanno preceduta». Il Colonnello tacque alcuni istanti, studiando l’espressione di Lazzari. Infine riattaccò in tono ancora più suadente. «Perché lei non crede, vero, che si tratti soltanto di una leggenda... Lei crede che davvero qualcuno fondò Roma in un certo giorno a metà dell’ottavo secolo avanti Cristo. Non è così?». Lazzari distolse lo sguardo. Al di là della vetrina un vecchio con un cappello di carta in testa e una tuta bianca sdrucita e tempestata di gocce colorate verniciava bianca sdrucita e tempestata di gocce colorate verniciava una fila di assi. Le pennellate avevano un ritmo costante: rassicuravano, raccontavano di un mondo solido, stagioni che si avvicendavano. «Sì, lo credo», ammise Lazzari con un sospiro. «Anche le persone che rappresento lo credono». La voce di Lazzari risuonò assente. «E chi sarebbero?» «La sua è una domanda non funzionale al nostro discorso. Le basti sapere che le persone che rappresento possono vantare un particolare primato: realizzano sempre i propri sogni. E lei è la persona adatta al nostro scopo». Lazzari scoppiò a ridere, una risata di gola, cattiva e disturbante. «Stia bene a sentire quello che le dirò...», cominciò, ma si bloccò all’improvviso, perché non esistevano parole da opporre a quel delirio. «All’inferno! Ho ascoltato abbastanza. La prego di uscire. Non abbiamo nient’altro da dirci». Senza attendere l’eventuale replica si chiuse in bagno e aprì il rubinetto al massimo, affinché il rumore dell’acqua coprisse ogni altro suono. Non voleva sentire nemmeno lo scatto della porta che si apriva e chiudeva. Si frizionò la faccia con vigore. Come faceva quell’uomo Si frizionò la faccia con vigore. Come faceva quell’uomo a conoscere tutti i particolari della sua vita? Certo, non c’era niente di segreto, e chiunque con un po’ di impegno si sarebbe potuto procurare quelle semplici informazioni. Ma perché? Inoltre l’idea di vedere i suoi fatti personali appuntati su quell’agendina lo disturbava. E disturbato doveva essere anche quell’uomo. Quando uscì lo ritrovò seduto nello stesso identico posto. «Allora non ci siamo capiti». «Lo faremo, non si preoccupi». «Io non so chi diavolo lei sia...». «Il vero nome di Roma non è Roma, come lei sa bene», lo interruppe il Colonnelo. «Tutti conoscono la città più famosa di tutti i tempi, eppure nessuno conosce il suo vero nome. Quello che possiamo chiamare il primo giorno dell’Urbe rappresenta uno dei più strabilianti misteri della storia. Le persone per cui lavoro desiderano venire a conoscenza di questo mistero ed entrare in possesso di un particolare oggetto usato durante il rituale di fondazione di Roma». «Se queste persone desiderano mantenere immacolato il primato di cui si vantano, quello di vedere compiuti tutti i loro sogni, gli dica di scegliersene un altro. Questo è irrealizzabile». Questo è irrealizzabile». Il Colonnello indicò con gli occhiali la finestra incorniciata dagli scaffali in legno di betulla. Lazzari seguì il gesto e vide che su alcune bottiglie si era già depositata una lieve pellicola di polvere. «Siamo venuti a conoscenza di una pista che può farci risalire indietro fino a quel giorno fatidico. Abbiamo bisogno di qualcuno che la ripercorra per noi, una guida esperta, la migliore disponibile sul mercato». Lazzari prese uno strofinaccio e iniziò a passarlo nervosamente sul banco. «Tagliamo corto. Mi sta dicendo che avete un indizio?» «È curioso di sapere qual è? Glielo dirò». «No, glielo dirò io», disse Lazzari, che cominciava a detestare quel modo di fare. «Qualcuno è saltato fuori dicendo che se scavate in un tale posto troverete quel tale reperto, la prova inconfutabile che state cercando. Sono centinaia di anni che succede così. Scavate pure, non troverete nulla. E ora sarò felice di offrirle da bere». «Non è nemmeno curioso di sapere cosa le offriremmo per questo compito?» «Ho appena rifiutato». «Sì, ma noi non ritiriamo la nostra offerta», precisò il Colonnello e mise via l’agendina. «Avremmo potuto Colonnello e mise via l’agendina. «Avremmo potuto offrirle un’ingente somma di denaro, una cattedra di storia romana in una delle università più prestigiose d’Europa, la direzione di un potente gruppo editoriale, perfino la conduzione di una trasmissione televisiva di divulgazione scientifica. Ma non avrebbe accettato». Lazzari smise di strofinare. «Ah no?» «No», garantì il Colonnello, come se Lazzari fosse un paziente con vaghe pretese di autodiagnosi e lui un medico specialista. «Per questo le offriamo di realizzare il suo più grande desiderio. Ha dedicato i suoi anni migliori a investigare sul mistero di Roma, studiando giorno e notte, rinunciando a una famiglia, sacrificando ogni cosa, senza però giungere alla sospirata scoperta. Ora noi le mettiamo a disposizione gli strumenti tecnici e finanziari per riuscirci, per realizzare il sogno della sua vita. Non si può rifiutare la vita, chi la rifiuta muore». «Già», si limitò a mormorare Lazzari. Il Colonnello si alzò e si sistemò il soprabito con un gesto disinvolto. «Ci rivedremo, assistente». «Cercherò quel Falerno, promesso», fece di rimando Lazzari con tono sarcastico. «Invocherà il mio ritorno, glielo assicuro». Lazzari si infilò le mani in tasca, stringendosi nelle Lazzari si infilò le mani in tasca, stringendosi nelle spale. «Come no, ma nel frattempo mi tolga una piccola curiosità Colonnello. Ammesso che non sia tutta una montatura, davvero pensavate di convincermi con quella storiella sul sogno della mia vita?» «Sì». «Un po’ poco, non le pare?» «Ora che mi ci fa pensare, forse ha ragione», ammise il Colonnello, mentre il suo sguardo si illuminava di colpo, come se avesse visto la preda infilarsi nela trappola. Quindi aggiunse in tono vagamente allusivo: «Credo che useremo qualcosa per... come posso dire... rendere il sogno più credibile». 2 Lazzari chiuse l’enoteca alle nove, e mentre girava la chiave nella toppa sorrise al ricordo di quello strambo personaggio e delle sue fantasticherie. Si guardò attorno con un senso di sollievo. Amava la fine di una giornata di lavoro, quando restavano soltanto piccole incombenze piacevoli per riempire la sera, come il viaggio di ritorno, il preparare la cena e poi, perché no, un buon bicchiere di vino. Il Colonnello, dopotutto, gli aveva portato fortuna. Appena se ne era andato, erano entrati un uomo e una donna in abiti eleganti ma stazzonati che si erano scolati una bottiglia di Verdicchio, e poi due muratori a cui aveva offerto un paio di bottiglie di birra artigianale per farsi perdonare l’assenza della spina. Ne avevano prese altre tre a testa prima di ritornarsene alla pensione in cui soggiornavano. Saltò sulla sua Olmo rossa e fece una puntata fino al canale per controllare il livello del’acqua: si tranquillizzò nel vedere che nonostante gli acquazzoni degli ultimi nel vedere che nonostante gli acquazzoni degli ultimi giorni il rischio di esondazione era ancora lontano. Poi si diresse verso la spiaggia. Nel buio ingiallito dai lampioni montava la mareggiata: le onde rilucevano per pochi istanti prima di abbattersi in una tempesta di schizzi sulla battigia invisibile. Intanto il cielo rotolava verso la città. Era una sera da fine del mondo. Respirando a pieni polmoni, con la sabbia e la salsedine sulle labbra, pedalava lungo le strade deserte e intanto pensava a come sarebbe stata più godibile la sua vita se non avesse perso così tanti anni dietro ai suoi sogni. Gli anni non si perdono ma si investono, gli avrebbe fatto notare il suo professore di esegesi delle fonti antiche, un uomo che negli anni Settanta si era beccato una pallottola in un piede e ora, chissà che fine aveva fatto. Ecco il guaio di invecchiare. Non chiedersi più cosa potrebbe esserne di tutte le persone che abbiamo conosciuto, ma cosa ne è stato. Da pochi mesi viveva in affitto in un appartamento a Villa Marina, a un chilometro esatto dalla foce del Rubicone. La padrona di casa si era stupita di un affitto annuale anziché mensile o stagionale, come accadeva nella stragrande maggioranza dei casi da quelle parti. Lui nella stragrande maggioranza dei casi da quelle parti. Lui aveva obiettato che non era un bagnante, e che lontano dal mare non voleva più vivere, ma al suo mare non poteva tornare. Poi, in modo ancora più goffo, come chi finisce per allargare una macchia che vuole cancellare, si era scusato per la frase oscura. Ma lei aveva capito. Aveva capito che era uno di quelli che tutt’a un tratto decidono di mettere un punto ala propria vita e cambiare pagina. Il portone scheggiato del piccolo edificio a due piani era incastonato tra un negozio che affittava risciò e una piadineria con un sole camuffato da padella infuocata per insegna. I due locali sarebbero stati aperti dal mese successivo. L’anno iniziava a Pasqua e finiva al più tardi a Natale, da quelle parti. Appena entrò, qualcuno lo bruciò sul tempo accendendo la luce delle scale: lasciò la bicicletta nell’atrio e salì guardando in su. «Lazzari sei tu?», sentì gridare dall’alto. Riconobbe la voce. «Sì, signora Fattori». «Grazie al cielo. Si è presentato un uomo oggi pomeriggio». Lazzari fece di corsa le ultime due rampe. «Per caso un signore anziano ed elegante?» «No, giovane», rispose la donna. Poco più bassa di «No, giovane», rispose la donna. Poco più bassa di lui e di corporatura giunonica, dava l’idea di poterlo sollevare con facilità. «Grande e grosso. Portava la barba, gli occhiali scuri e un cappello con la visiera, di quelli che usano i ragazzini». «Tipo baseball?» «Baseball? Non so, può essere. Mi sono affacciata dal terrazzo e gli ho domandato cosa voleva. “Niente signora Fattori”, mi ha risposto, “volevo solo scusarmi per il disturbo”. Be’, mi sono chiesta come facesse a sapere il mio nome, ma a lui ho chiesto solo di quale disturbo stesse parlando. “Quello che ci sarà presto”, mi ha risposto toccandosi il cappello. Allora gli ho chiesto che volesse dire, ma lui mi ha sorriso e se ne è andato. Gli ho gridato di fermarsi, ma quello niente. Ma ti pare possibile? Dimmi te». Lazzari, con un gesto impacciato le posò una mano sulla spalla per tranquillizzarla. «Non mi rompo mica», fece lei. «Non si preoccupi per quello sconosciuto. Forse era solo uno dei lavori pubblici. Probabilmente voleva avvertirla». «Non aveva la faccia di uno dei lavori pubblici». Lazzari aprì la porta del suo appartamento e accese Lazzari aprì la porta del suo appartamento e accese immediatamente la luce. Guardò in giro affacciato sulla soglia, ma la sala sembrava in ordine. Entrò con circospezione e controllò anche il bagno, la cucina e la camera da letto, lasciando ovunque le luci accese. Infine si abbandonò a un sospiro di sollievo. Prese una Modelo Especial dal frigo e ne bevve una lunga sorsata. Mentre stava per posarla sul muretto che divideva la cucina dalla sala, si accorse che le pile di libri appoggiate contro la parete erano state spostate. I libri d’arte erano accanto alla finestra e la colonna dei romanzi, invece, più vicina all’angolo. Era sicuro di avere disposto al contrario le due pile e ne ricordava pure il motivo: aveva pensato che se in un giorno di pioggia si fosse dimenticato la finestra aperta, o se il vento l’avesse spalancata, o se gli infissi non avessero retto a dovere, si sarebbero bagnati i romanzi e non i libri fotografici. Con il cuore che gli batteva all’impazzata, si avvicinò per controllare. Non riusciva a spiegarsi come poteva essere successo. Pensò di chiedere alla signora Fattori se fosse per caso entrata a pulire, ma la avrebbe soltanto spaventata. Di certo non era stata lì, non lo aveva mai fatto in sua assenza in quei quattro mesi. E poi, perché mai avrebbe dovuto invertire le colonne dei libri? Ispezionò ancora una volta l’appartamento, ma per il Ispezionò ancora una volta l’appartamento, ma per il resto tutto era come lo aveva lasciato al mattino: sul tavolino c’erano ancora i rimasugli delle matite temperate. E se avesse chiamato la polizia per segnalare lo strano spostamento? Probabilmente si sarebbero messi a ridere. Buttò giù il resto della birra per ricacciare indietro l’ansia che sentiva salire, poi aprì una scatola di fagioli e li mise a cuocere. Cercò il telecomando con gli occhi, poi si ricordò che il suo televisore non era predisposto per la ricezione digitale e adesso era scaduto al ruolo di soprammobile ingombrante e rétro. Soltanto l’anno prima avrebbe messo su della musica, magari Coltrane, e avrebbe riletto un capitolo di un romanzo, forse un russo, uno di quelli per cui l’ironia e la fede sono le sole cose serie della vita, ma in quel momento non ne sentiva il bisogno. Era in una fase di disintossicazione dai libri, dalla musica, dal cinema, dall’arte, da tutto quanto potesse allontanarlo da quello che si stava sforzando di fare. Vivere, finalmente. In strada un cane abbaiò per un minuto buono, prima di uggiolare e infine azzittirsi. Rare macchine tracciavano il silenzio di quella sera infrasettimanale: l’unico rumore era quello dei fagioli che sfrigolavano sul fuoco. Mentre li era quello dei fagioli che sfrigolavano sul fuoco. Mentre li teneva d’occhio, si domandò come sarebbe stata la stagione estiva e se sarebbe riuscito a resistere con i debiti e gli scarsi incassi fino a maggio. Era perfino contento di avere quel genere di problemi, qualcosa che si potesse toccare con mano e su cui, bene o male, esercitare un potere effettivo. Che non abbia potere su di me ciò su cui non ho potere! Così aveva declinato la sua filosofia di vita da quando si era reso conto di aver convissuto per troppo tempo con fantasmi e illusioni. Scoprire il mistero di Roma non doveva essere il suo destino. Gestire un negozio, però, era tutta un’altra faccenda, e lui sentiva di potercela fare. Quanto ai soldi, avrebbe fatto più economia. Si disse che poteva mangiare anche con due euro al giorno, e che non avrebbe preso più bottiglie dal negozio. Qualche minuto dopo si alzò per prenderne una dalla credenza, all’inferno le promesse! Era un Barbaresco del millenovecentonovantasei della cantina Giacosa, una bottiglia speciale che aveva tenuto in serbo per festeggiare l’inaugurazione del suo locale. La sera dell’apertura, però, si era detto che ci sarebbero di certo state altre occasioni. Eccone una. state altre occasioni. Eccone una. Fino ai venticinque anni non aveva mai assaggiato un sorso di vino, e ora non poteva passare giorno senza berne almeno un paio di bicchieri. Ma d’altronde, alle trasformazioni si era dovuto abituare. Appena un anno prima sarebbe scoppiato a ridere se qualcuno gli avesse detto che di lì a poco avrebbe lasciato il suo lavoro all’università per aprire un bar. E oggi era padrone di un’enoteca. Certo, era pieno di debiti, ma era convinto di aver fatto la scelta giusta. Non doveva preoccuparsi: i clienti sarebbero arrivati prima o poi e forse un giorno anche una donna. Sì, al diavolo Roma e i suoi sogni. Controllò l’etichetta per la centesima volta accarezzandola con le dita. Stava ragionando se fosse davvero il caso di stapparla, quando nel silenzio esplose uno sparo. «Oh merda!». Lazzari sussultò per lo spavento e lasciò cadere la bottiglia, che si frantumò a terra. Balzò indietro d’istinto e per un istante guardò le scarpe e i pantaloni chiazzati, poi si lanciò verso il terrazzo. Gli parve di udire passi affrettati in uno dei vicoli che reticolavano il quartiere, ma non vide nessuno. La strada era deserta. Il campanello, intanto, suonava con insistenza. Picchiò i palmi sul davanzale e rientrò. Mentre Picchiò i palmi sul davanzale e rientrò. Mentre raggiungeva la porta afferrò una bottiglia vuota che si era dimenticato sul tavolino la sera prima e la impugnò per il collo. Aveva le mani sudate e il respiro corto. Si calmò soltanto quando nello spioncino distinse il volto oblungo della signora Fattori sormontato da uno strano copricapo. Sembrava una portatrice d’acqua di ritorno dal fiume. Lasciò cadere la bottiglia nel portaombrelli e aprì. La donna fece due passi dentro: indossava un accappatoio verde di spugna e sulla testa un asciugamano acconciato alla maniera di un turbante. «Hai sentito? Ero appena uscita dalla doccia, cos’è stato?». Lazzari si schiarì la voce: «Una bottiglia, ho fatto cadere una bottiglia». «Ah sì, mi sembrava più uno scoppio...», stava dicendo, quando si accorse del lago di vino sulle piastrelle. «Dove tieni gli stracci?», e si diresse a grandi passi verso la cucina. «Sotto il lavello, ma non c’è bisogno». «Sì, che c’è». In pochi minuti la signora Fattori raccolse i vetri e lavò il pavimento. Poi si asciugò le mani sull’accappatoio e, come se si fosse accorta solo in quel momento del suo e, come se si fosse accorta solo in quel momento del suo déshabillé, si affrettò verso la porta. «Perché uno di questi giorni non mi lasci le chiavi? Potrei sistemare un po’ e dare una pulita in giro». «È troppo gentile». «Ma no... Vorrei solo evitare che la polvere mi mangiasse la casa...», rise la donna. Il senso di paura le era completamente scivolato via di dosso, mentre Lazzari fremeva tendendo l’orecchio ora alla porta ora al terrazzo. «L’ho promesso a mia nipote, l’appartamento. Per quando si sposa. Magari una volta te la presento. Alora, affare fatto?» «Per le pulizie o per sua nipote?» «Una cosa per volta burdèl, prima la polvere». Lazzari, dopo un’occhiata alle pile invertite dei libri, le domandò: «Ma lei non ha un mazzo di chiavi?» «No, ho dato a te tutti e due i mazzi. Ah dì, non li avrai mica persi?». Lazzari si toccò la tasca e poi lanciò un’occhiata al gancio sopra il frigo. «No, ce li ho ancora entrambi». La signora vide la delusione sul volto dell’uomo e la interpretò a suo modo: «Una donna è quello che serve a un uomo. Ma avrai occasione... non ti preoccupare». «Già». «Già». I fagioli si erano bruciati. Lazzari versò la parte ancora intatta in un piatto fondo. Stava prendendo un cucchiaio quando un tuono rumoreggiò in lontananza. Non si era mai liberato della paura dei fulmini. Fu quella a costringerlo a fare il giro delle stanze per spegnere tutte le luci. Ma almeno quel timore aveva una spiegazione. Che cosa poteva invece dire degli strani episodi di quella sera? I libri spostati, lo sconosciuto che annunciava problemi ala signora Fattori e lo sparo avevano un nesso o era solo la sua mente suggestionabile a collegarli? Mangiò in piedi davanti alla finestra, mentre i lampi accendevano la notte mostrandogli per pochi istanti il suo volto sul vetro picchiettato di ditate e aloni. Appena il tempo di riconoscersi, ma per fortuna, non quelo di giudicarsi. Scoppiò un altro tuono, questa volta molto più intenso, e fu come se qualcuno avesse gettato un petardo nella stanza. Il temporale si era avvicinato all’improvviso con un balzo da gigante e adesso la pioggia saltava sulla strada come un esercito brulicante di cavallette. Gli sarebbe piaciuto correre fuori per scrollarsi di dosso la paura. Pregò che il pericolo fosse soltanto nella sua paura. Pregò che il pericolo fosse soltanto nella sua mente. Al mattino trovò due persone in attesa davanti alla porta dell’enoteca. Mentre legava la bicicletta si scusò per averle fatte attendere con quella pioggia. «Non mi aspettavo clienti così presto», disse sfilandosi la mantellina gocciolante. «Infatti non siamo clienti», disse la donna mostrandogli un tesserino. «Siamo ispettori sanitari». «Ah». Lazzari tolse le mollette dai calzoni, le infilò in tasca, aprì la porta e fece segno di entrare. I due ispezionarono con meticolosità il piccolo negozio, soffermandosi con particolare attenzione sul bagno e il retrobottega. La donna gli rivolse qualche domanda, sempre sorridente, mentre l’uomo che era con lei, in silenzio, prendeva appunti su un taccuino. Ala fine gli consegnò un verbale compilato minuziosamente. «Troverà elencate qui tutte le modifiche che deve apportare per mettersi in regola con le disposizioni in materia igienico-sanitaria. Ha quindici giorni di tempo. Poi scatteranno le sanzioni», gli spiegò la donna. Lazzari scorse velocemente la lista. «Ma sono ben quindici punti!». «Uno al giorno», disse l’uomo, e uscì, seguito dalla «Uno al giorno», disse l’uomo, e uscì, seguito dalla donna, lasciandosi alle spalle una scia di impronte fangose. Lazzari scorse un’altra volta la lista. Non riusciva a capacitarsene, era convinto di aver fatto fare i lavori a regola d’arte. Chiamò in Comune e si fece passare Antonella Fiori, l’impiegata dell’ufficio tecnico che era andata anche all’inaugurazione. «Antonella, scusa se ti disturbo...». «L’avrei fatto io. Sono saltati fuori dei problemi con la licenza che hai rilevato... Un dirigente comunale ha preso in mano la pratica e dice che ci sono grosse irregolarità». «Non è possibile! Abbiamo fatto tutto secondo le rego le!». «Questo lo so, ma non so che dirti. Si faranno vivi, anche molto presto, temo. Mi spiace». Lazzari non fece in tempo a riagganciare che il telefono squillò. Era il commercialista. Era la prima volta che parlava con lui direttamente. Aveva una voce autorevole e carica di rimprovero. «Lazzari, ma che razza di nemici si è fatto? Ho avuto una perquisizione della finanza. Si sono occupati solo della sua pratica ed è davvero insolito, considerando che della sua pratica ed è davvero insolito, considerando che lei è il cliente più piccolo che ho». «Ma è tutto in regola, no?» «In teoria sì», rispose il commercialista, lasciando la frase pericolosamente in sospeso. «Ma sa come funzionano queste cose». «No, per la verità non lo so». «Quando vogliono colpirla, il modo lo trovano. Temo che avrà presto visite. La prossima volta si scelga meglio i suoi nemici». Era incredulo. Avrebbe voluto scagliare il telefono contro le bottiglie, un gesto eclatante, con cui dare sfogo a tutta la sua rabbia. Proprio come quel giorno di dodici mesi prima, all’università, quando aveva lanciato la sedia contro la porta, sotto gli occhi terrorizzati del direttore del fondo che finanziava la sua ricerca. Quel burattino lo aveva messo di fronte a un aut aut: finire il suo libro sulla fondazione di Roma o raccogliere le proprie cose e andarsene. Quando il postino arrivò al negozio, lo trovò che passeggiava avanti e indietro parlando da solo. «Oggi posta», annunciò con il tono di chi sa di portare finalmente una notizia gradita, e lasciò un plico di lettere su uno dei tavoli. «Metto una sigla io per te, va bene? Ci si vede stasera per un bicchiere». A parte una raccomandata dell’ufficio delle Entrate, che mise da parte senza leggere, le altre arrivavano da biblioteche italiane. Dalla Braidense, l’Estense, la Nazionale di Firenze, l’Apostolica Vaticana. Chiedevano tutte la restituzione immediata di volumi presi in prestito anni prima e mai restituiti. Alcune precisavano il valore di quei libri da corrispondere in caso di smarrimento. Ammontavano a migliaia di euro. Non era la corrispondenza che aveva sognato. «Merda!». Come avevano potuto risalire fino a lui? Tutti i prestiti li aveva fatti a nome del dipartimento di Storia antica dove lavorava e non si era mai sognato di mettere la sua firma su qualche modulo. Forse qualche suo ex collega aveva fatto la spia. E come era possibile che tutte le biblioteche si fossero decise a recuperare i volumi nello stesso identico momento? Qualcuno le aveva per caso invitate a farlo? Tutte le lettere erano arrivate in contemporanea. Controllò i timbri postali. Erano partite tra i cinque e i dieci giorni prima dalle rispettive città. Non aveva alcun senso, ma nulla di quanto gli stava capitando aveva una spiegazione logica. Si accorse di avere gli occhi umidi: la rabbia stava a Si accorse di avere gli occhi umidi: la rabbia stava a poco a poco cedendo il posto alla rassegnazione, come gli era capitato altre volte in passato. Si sentiva schiacciato da tutti quegli imprevisti e non sapeva da che parte iniziare per provare a risolverli. Non sapeva nemmeno se ne avrebbe avuto la forza. Il padrone dei muri dell’enoteca lo sorprese mentre bruciava le missive nel lavello. «Dottor Lazzari, la disturbo?», gli chiese tenendo d’occhio con aria preoccupata il fumo che si sollevava dal lavandino. Indossava un giaccone da boscaiolo e una camicia a scacchi sbottonata sul petto villoso. «No», mormorò Lazzari aprendo il rubinetto. «In ogni caso... Be’, vede, sono qui perché ho ricevuto la telefonata del direttore di una banca... Hanno intenzione di aprire una filiale in questa zona». «E perché lo dice a me?» «Pare che vogliano prendere in affitto proprio questo locale». «Sono impazziti? Non gli ha detto che il locale è affittato a me?» «Certo. Gli ho detto che lei ha rilevato da poco il negozio con l’annesso contratto di locazione, che ha ancora un anno di durata. E gli ho pure detto che alla ancora un anno di durata. E gli ho pure detto che alla scadenza a lei spetta per legge il diritto di opzione per il rinnovo. Ma il direttore mi ha detto che la legge è un’altra in questo caso». «Che diamine significa un’altra?» «Mi ha detto che le banche vantano un particolare diritto di prelazione, che viene prima di qualsiasi altra opzione. Ho chiamato il mio legale e me lo ha confermato. Si informi lei stesso. Purtroppo glielo confermeranno. Tra un anno, alla scadenza del contratto, lei sarà costretto a liberare il locale. Le verseranno una buonuscita. Non sarà granché, ma comunque... E così... Sono mortificato», disse allargando le braccia. «Non è colpa mia capisce? Sa come vanno queste cose...». «Comincio a farmene un’idea», sussurrò Lazzari piangendo. 3 Il Colonnello arrivò alle cinque. Entrò in silenzio, richiuse la porta a vetri, girò il cartello con la scritta da aperto a chiuso, scostò una sedia da uno dei tavolini e si sedette al centro del corridoio. Lazzari non si voltò. Se ne stava tutto ingobbito su uno degli sgabelli piazzati davanti al bancone, con la schiena rivolta verso l’ingresso e in mano una tazza bianca di porcellana piena di caffè. Il bollitore era ancora acceso ed emetteva un fastidioso fischio di sottofondo. Pensava spasmodicamente a come sarebbe potuto uscire da quella situazione, i controlli, le multe, le grane burocratiche, lo sfratto imminente, e non vedeva altra soluzione se non quella di mollare tutto. E poi? D’improvviso si sentì stupido: perché si ostinava a pensare razionalmente quando era chiaro che sotto quella situazione c’era qualcosa di inspiegabile e di losco? Qualcuno intendeva rovinarlo. Sollevò gli occhi e il volto del Colonnello riflesso nello specchio fu la risposta che cercava. «Sì», disse infine agitando la tazza. cercava. «Sì», disse infine agitando la tazza. «Sì, accetta la mia proposta?», domandò il Colonnello. «No». «Allora cosa intende?» «Sì, ho pregato per il suo arrivo». «Desiderava ringraziarmi?». Lazzari fu costretto a voltarsi per capire se davvero lo stesse prendendo in giro. Il Colonnelo teneva il soprabito ripiegato sopra le gambe, sfoggiando un completo grigio di fattura sartoriale e scarpe di pelle nera lucidate di fresco. Non c’era traccia alcuna di ironia sul volto tatuato dalle rughe. «Desidero ucciderla». «L’hanno desiderato in molti prima di lei», disse il Colonnello liquidando la faccenda con una smorfia. Lazzari si costrinse a posare la tazza. Aveva una gran voglia di lanciarla. «Pensavo non avesse nemici». «Infatti, non più», confermò il Colonnello con voce neutra. Quindi, come se non volesse lasciare all’altro il tempo di riflettere su quella frase, aggiunse con rapidità: «Sa qual è il punto debole dell’uomo? Non sa mai quale sentimento provare». «E ora, di certo, lei saprà dirmi invece cosa dovrei prova re». prova re». «Gratitudine. Dovrebbe essermi grato, dottor Lazzari. La sto liberando di un peso. Questa vita non è per lei», disse accennando al locale. «Ci sono migliaia di persone più in gamba di lei per questo mestiere. Se ne faccia una ragione». Tirò fuori l’agendina in pelle e aggiunse: «Vogliamo cominciare a parlare di affari?» «Parliamo del mio locale invece». «Mi pareva di aver già esaurito la questione, ma se ci tiene. Mi sono bastate due o tre telefonate alle persone giuste per mettere in moto le cose. Ho amici zelanti in molti ambienti, guardia di finanza e amministrazioni pubbliche comprese». «Le lettere», sbottò Lazzari saltando giù dallo sgabello che si rovesciò a terra. «Sono arrivate oggi. Significa che erano già in viaggio. Come è possibile?». Il Colonnello richiuse il libricino sospirando e in tono paziente rispose: «Sapevamo che lei avrebbe rifiutato la nostra proposta». «Ah sì?». «Comportamento tipico. Un uomo che, dopo aver aspettato per sedici anni il proprio treno, rinuncia e se ne va, non ritorna verso la stazione solo perché sente un fischio in lontananza. Bisogna portarcelo di peso». fischio in lontananza. Bisogna portarcelo di peso». Lazzari represse un conato di vomito. Era senza parole, incapace di articolare un discorso compiuto. «È proprio vero, allora», disse infine. Il Colonnello si schiarì la voce, visibilmente infastidito. «Che cosa?» «Che dentro ogni grande burocrate c’è un piccolo poeta...». «Vede, assistente», riprese il Colonnello, calcando sulla parola “assistente” con un’intensità che Lazzari aveva udito poche volte, un’intensità che voleva ricordargli che nela vita era stato una promessa mancata, un uomo a metà, e che non poteva permettersi di impartire lezioni. «Nel mio lavoro sono abituato a parlare con due generi di persone: quelle che si rivolgono a me e quelle a cui io mi rivolgo. Alle prime, di solito enormemente ricche ed eccentriche, concedo la licenza di scherzare; non creda, segno tutto sull’onorario. Ma dalle persone a cui mi rivolgo io, non accetto simili confidenze». «Mi sta minacciando?» «Non ho fatto altro da ieri. Se ne è accorto, finalmente?». Chiusero l’enoteca e se ne andarono allo Sloppy Chiusero l’enoteca e se ne andarono allo Sloppy Joe, il bar ristorante sul pontile. Un gabbiano vegliava sopra l’insegna con la faccia dipinta di Hemingway, un volto da pescatore saggio. Il suo viso invece, doveva sembrare quasi contratto per la tensione. In che razza di guaio si stava lasciando trascinare? Si fregò gli occhi con vigore per cacciare quelle visioni. Stare nel presente, essere il più possibile lucido, capire chi diamine fosse davvero quell’uomo: ecco i suoi imperativi. Entrò per primo nel locale e si sedette accanto alla vetrata. Non voleva perdere di vista la spiaggia e il mare. Gli ricordavano la possibilità della fuga. Il Colonnello ordinò un tè e un tramezzino senza alcun tipo di salsa, dopo una rapida occhiata alla vetrina dei panini accanto al bancone. Lazzari si accorse che aveva gli occhi chiari, probabilmente verdi, e che un tempo doveva essere stato biondo. Era ancora un bell’uomo, anche se sembrava voler nascondere il suo fascino nella fredda compostezza dei suoi gesti. «Non ho mai capito il piacere che le persone provano per il cibo. L’ho sempre trovato animalesco». La voce del Colonnello suonava come un’unghia su una lavagna alle orecchie di Lazzari. «Come ha fatto a scatenarmi contro quel’inferno di burocrazia? Chi è lei? scatenarmi contro quel’inferno di burocrazia? Chi è lei? Per chi lavora?» «Se io le chiedessi come ha fatto a diventare il più importante esperto al mondo della fondazione di Roma, lei cosa mi risponderebbe? Un misto di talento, studio e passione. Io ho fatto lo stesso nel mio campo». «E quale sarebbe il suo campo?» «Sicurezza e operazioni segrete. Diciamo che esaudisco i desideri dele persone che possono permetterselo». Lazzari appoggiò la testa contro la vetrata. «E per riuscirci è disposto a tutto?» «Ritengo che a questo punto dovrebbe già essersi fatto un’idea a riguardo...». «E comunque non è vero», fece Lazzari. «Cosa non è vero? Le confesso che questa sua abitudine di rispondere a vecchie domande comincia a seccarmi. È un vezzo. I vezzi diventano rapidamente vizi». «Non è vero», proseguì Lazzari incurante del commento. «Non sono affatto il maggiore esperto delle origini di Ro ma». «Certo, c’è sempre il suo mentore, il professor Casini, ma un vecchio di ottant’anni non faceva al caso Casini, ma un vecchio di ottant’anni non faceva al caso nostro. Questo lo capirà anche lei». La cameriera posò sul tavolo la birra per Lazzari e il tè per il Colonnello, che alzò una mano per farlo tacere. «Il tempo delle sue domande è terminato. Ora penso sia arrivato il momento di illustrarle la situazione. Il committente di questo incarico è un illustre membro della Fondazione SigmaPiTau. Immagino che la conosca». «Immagina male». «Può trovare tutte le informazioni che desidera su internet. In ogni caso, per le nostre esigenze immediate, le è sufficiente sapere che è una sorta di cenacolo di mecenati, persone oltremodo ricche che hanno deciso di impegnarsi attivamente per la società. Lei ha un’idea anche approssimativa di cosa significhi l’espressione “oltremodo ricco”?» «Posso immaginarlo», fece Lazzari con una smorfia. «Non può, invece. Cercherò di dargliene un’idea io, anche se a grandi linee. Sappia che un quarto della ricchezza complessiva del continente è posseduto da appena l’uno per cento della popolazione europea. Diciamo che il Committente fa parte di questa esigua cerchia. Lei ha idea di cosa sognino questi miliardari?» «No, non lo posso immaginare e non me ne frega «No, non lo posso immaginare e non me ne frega niente». «Aerei personali, ville, auto, yacht? Ne possiedono in quantità. Squadre sportive, giornali, e altri passatempi sociali? Non gli mancano. L’arte ha soddisfatto per molto tempo i loro bisogni: la singolarità delle opere d’arte. Ma anche di queste ne possiedono ormai a bizzeffe». Poiché Lazzari non dava cenno di voler intervenire, riprese: «Inoltre gli artisti sono soggetti alle mode. Anni fa tutti compravano Van Gogh, poi è venuto il turno di Pollock, ora Modigliani». Il Colonnello bevve un sorso di tè prima di proseguire: «E veniamo dunque al nocciolo della questione. Quale opera d’arte può davvero definirsi unica? Di tutti gli artisti più quotati esistono lavori in quantità disponibili sul mercato. È solo una questione di prezzo. E invece ecco ciò di cui queste persone sono alla ricerca: qualcosa che non sia misurabile con il denaro», disse rimarcando ogni singola parola. «Capisce?» «Capisco». «Perciò ora le chiedo: cosa esiste di unico?» «Gli uomini, forse?» «Non sia sciocco». Il Colonnello spostò il tovagliolo con fastidio. «Gli uomini non solo si comprano, ma si con fastidio. «Gli uomini non solo si comprano, ma si controllano con facilità proprio perché sono simili gli uni agli altri nei pensieri e nelle pulsioni». «Allora cosa esiste di unico?» «I segreti», rispose il Colonnello. «I segreti sono la cosa più preziosa del nostro mondo. I segreti fanno la fortuna degli uomini di potere. E a ogni segreto storico corrisponde un oggetto unico e inestimabile: pensi al Sacro Graal per la vicenda di Gesù, o all’Arca dell’Alleanza per il patto tra Dio e Mosè. Poi pensi a quante persone hanno dedicato la loro vita per ritrovarli. Sto parlando di qualcosa capace di suscitare grandi invidie». «L’invidia?» «Sì, qualcosa che attiri l’invidia non di molte altre persone, ma di tutte le persone». «E tutto questo cosa c’entra con Roma?» «Roma è la città per eccelenza», rispose il Colonnello piegandosi verso il tavolo. «Nessun’altra città ha rappresentato tanto nel’immaginario collettivo. Qualsiasi impero o potentato o democrazia sia venuto dopo, si è ispirato e confrontato con Roma. Gli inglesi dicono di avere avuto l’impero più potente, dopo quello romano. Lo stesso affermano i turchi, gli americani, i romano. Lo stesso affermano i turchi, gli americani, i cinesi. Cambiano i soggetti, ma non il termine di paragone: Roma, per tutti. Ebbene, esiste un segreto sulla sua fondazione, un segreto custodito da millenni». Se veramente il Colonnello fosse stato desideroso di imparare, avrebbe potuto insegnarli che i segreti erano tre, ma quell’uomo non aveva fatto altro che impartirgli lezioni e lui si sentiva troppo stanco e sfiduciato per salire su qualsivoglia cattedra. «Un mysterium tremendum, un mistero che fa tremare», disse soltanto, recitando sottovoce l’antica formula. Il Colonnello si avvicinò ancora. Negli occhi verdi brilavano piccole pagliuzze dorate. «Un mistero che ha condotto alla morte molte persone. Stiamo parlando del nome segreto di Roma. Noi vogliamo quel nome. E il lituo. E lei li ritroverà per noi». Lazzari batté le mani sul tavolo. Le stoviglie tintinnarono. La cameriera si voltò per dare un’occhiata e poi tornò alle sue occupazioni. «Il lituo? Il bastone sacro con cui Romolo fondò la città? Voi siete pazzi». «Così vengono chiamati coloro che vedono una cosa per primi. Non vorrà dirmi, proprio lei, che il bastone non esiste?» «Non esiste più. È esistito senza dubbio, ma non c’è «Non esiste più. È esistito senza dubbio, ma non c’è più: bruciato, perduto, distrutto. Scelga lei». «Lei ha una prova che non esiste più?» «No, però...». «Il però capovolge un’affermazione... dottor Lazzari. Ripeto: lei possiede una prova incontestabile che il lituo sia andato distrutto? Risponda sì o no». «No, ma...». «Io, invece, possiedo un indizio sulla sua esistenza», sentenziò il Colonnello. «Lei sta scherzando?» «L’ultima volta che ho scherzato ero alto come questo tavolo. Mio padre mi spiegò con parole di cuoio che le facezie sono le armi dei perdenti». Lazzari si portò il bicchiere alle labbra, ma la birra era finita. «Quale sarebbe questo indizio?». Il Colonnello scostò il piatto con il tramezzino. Lo aveva appena assaggiato. «I segreti che riguardano la fondazione di Roma sono custoditi da quasi tremila anni da una setta. Noi abbiamo ragione di ritenere che custodiscano un libro sacro e occulto e siano in possesso anche del lituo». «Lei mi stupisce. Come può credere a queste cose?» «Lei avrebbe creduto, ieri sera, quando mi ha «Lei avrebbe creduto, ieri sera, quando mi ha salutato, di potersi trovare seduto, oggi, allo stesso tavolo con me e di essere pronto ad accettare l’incarico che le propongo a prescindere dal compenso?». Lazzari guardò il mare. La burrasca si stava ritirando lasciandosi dietro una scia di acque livide. La spiaggia era disseminata di rami e tronchi scuri. Aprì la bocca, ma non disse nulla. Che cosa poteva fare? «Abbiamo i nostri mezzi per verificare le informazioni», riprese il Colonnello. «Quello che lei ha visto dispiegato stamattina è solo un assaggio della guerra che possiamo scatenare». «Quale gusto può esserci nel rovinare la vita delle persone?» «Quando tutto sarà finito, le garantisco che mi ringrazierà». «Ringraziarla?», ripeté Lazzari come se fosse la cosa più improbabile che avesse mai udito. «Le confesso che lei mi ha terribilmente seccato. Per fortuna non sarò io ad accompagnarla». «Ad accompagnarmi dove?» «Una persona di fiducia della Fondazione la attende al Grand Hotel di Rimini. La scorterà durante la missione e le offrirà le restanti informazioni. Come finalmente avrà e le offrirà le restanti informazioni. Come finalmente avrà capito, non è stato previsto un suo rifiuto. In quel caso la rovineremo davvero, con o senza soddisfazione. Questa persona si occuperà anche delle spese. A lavoro terminato riceverà un compenso commisurato ai risultati ottenuti. Provvederò anche a sistemare la faccenda dei libri con le biblioteche. Inoltre potrà riavere indietro la sua bettola, senza pendenze, si intende. Non credo, tuttavia, che a quel punto la rivorrà». Quell’uomo sapeva tutto, pensò Lazzari mordendosi le labbra; ma esistevano altre cose nella vita oltre alla conoscenza, forse più importanti, cose che lui non intendeva più ignorare... «Non accetto...». «Non accetta?», lo interruppe il Colonnello come se non credesse alle proprie orecchie. «...Non accetto per l’eventuale ricompensa», terminò la frase Lazzari. «O per salvare il locale o per...». «Quello che lei racconta alla sua coscienza non è affare mio», lo interruppe il Colonnello. «Invece glielo dirò, se non altro per seccarla. Lo faccio per rimediare al’errore di aver abbandonato la ricerca soltanto perché mi ero accorto di non poter trovare ciò che cercavo. Avevo dimenticato che possiamo solo cercare e porre domande, ma non possiamo solo cercare e porre domande, ma non trovare... Ogni conclusione a cui giungiamo non è che un semplice indizio per una scoperta ulteriore...». Poi, come se si fosse accorto di essersi messo a nudo, Lazzari cambiò tono: «Sa cosa scrisse un mistico medievale di nome Antonio da Alba Docilia?». Il Colonnello intrecciò le mani e sollevò i pollici. «Se ci tiene a dirmelo, faccia pure». «“Niente che può essere trovato è degno di essere cercato. Nulla che può essere catturato è degno di essere cacciato. Saggio è colui che cerca l’introvabile e insegue l’inafferrabile”». 4 Lazzari passò da casa, infilò qualche indumento in una sacca, chiuse il gas, staccò il contatore dell’elettricità, mise i due mazzi di chiavi e una busta con l’affitto del mese successivo nella cassetta postale della signora Fattori poi prese il primo autobus per la stazione. Il Colonnello gli aveva ordinato di non perdere tempo, avrebbe pensato lui all’enoteca, a regolare i conti e sistemare le pendenze amministrative. Era più facile ubbidire a quell’uomo che ribellarsi. A eccezione della bicicletta e dei libri, portava con sé tutti i suoi pochi beni materiali: mille euro in contanti, la collanina della madre, un codice miniato del Vangelo di Giovanni, e il suo paio di pantaloni preferiti. Arrivò alla stazione senza guardare neppure una volta dal finestrino dell’autobus, tanto era immerso nei suoi pensieri. Prese il regionale per Rimini e una volta arrivato decise di non andare subito in albergo. La fretta degli altri non era la sua. Inoltre, aveva ancora troppa ansia da smaltire. Inoltre, aveva ancora troppa ansia da smaltire. Percorse il ponte romano e si fermò all’incrocio tra il cardo e il decumano, le attuali via Garibaldi e via IV Novembre. Si guardò attorno come se in quel punto preciso potesse sopraggiungere un’illuminazione. E se fosse stata tutta una montatura?, si domandò lasciandosi alle spalle il Tempio Malatestiano. Forse all’hotel avrebbe trovato i suoi vecchi amici, gli avrebbero detto che erano stati loro a organizzare quell’incredibile scherzo, ad assoldare un bravo attore di teatro per interpretare il Colonnello e poi a coinvolgere anche tutti gli altri, l’impiegata del Comune, i falsi ispettori, le biblioteche... No, sembrava assurdo. Quei vagheggiamenti lo fecero camminare più spedito di quanto desiderasse e senza accorgersene si ritrovò sotto l’albergo. Un uomo in galloni gli aprì il portone. L’atrio era come se lo aspettava, un salone asburgico con i lampadari di cristallo, il pavimento in marmo lindo, le colonne di candido rosa, i tavolini di legno con le zampe arcuate e le tende in tinta con i divani. Se fosse stato ricco, pensò, gli sarebbe piaciuto vivere spostandosi da un albergo all’altro. Si guardò attorno indeciso sul da farsi. Nessuno Si guardò attorno indeciso sul da farsi. Nessuno sembrava accorgersi di lui. Alla reception, due impiegati in giacca e cravatta confabulavano tra di loro: quello più basso e anziano sembrava impartire lezioni all’altro. Si sentiva come a una di quelle feste dove non si conosce nessuno se non il festeggiato, e non si sa bene cosa fare di se stessi. «Il suo bagaglio, signore», lo sorprese un altro portiere comparendo alle sue spalle. Era alto, con le sopracciglia unite sopra il naso aquilino. «Sono solo di passaggio», balbettò Lazzari. «Non è nostro ospite?» «È mio ospite», si intromise una ragazza. Lazzari non l’aveva mai vista prima, ma era convinto di aver già sentito quella voce, roca, suadente e allo stesso tempo stanca, come se fosse abituata a farsi ubbidire e quell’abitudine le fosse venuta a noia. Indossava un paio di sneakers, jeans sbiaditi, grandi occhiali scuri e una felpa verde che portava impresso il logo di un’università americana. Dal cappuccio spuntavano alcune ciocche di capelli. La maglia le lasciava scoperto un tratto di schiena all’altezza della cintura, mentre sul davanti un lembo della T-shirt penzolava sopra la tasca sinistra dei pantaloni. penzolava sopra la tasca sinistra dei pantaloni. Il portiere annuì, fece due passi indietro, poi si voltò e se ne andò. «Grazie», le disse Lazzari. «Aspetta a ringraziarmi. Il viaggio è lungo». Lazzari lasciò cadere il borsone. «Sei tu?» «Il Colonnelo non ti ha detto niente? C’era da aspettarselo. È fatto così, pensa che siano gli uomini a dover viaggiare e non le informazioni». «Pensa a sproposito». «A proposito, mi chiamo Artemisia». «Avevano terminato tutti i nomi?», le domandò Lazzari stringendole la mano. Artemisia si sistemò con calma gli occhiali. «Se fossi stato attento alle lezioni di storia greca, invece di giocare con i soldatini o guardare gli slip della tua compagna, avresti imparato che Artemisia è stata una grande regina dell’Asia Minore: quando morì suo marito Mausolo, di cui era perdutamente innamorata, fece costruire ad Alicarnasso un mastodontico sepolcro, una delle sette meraviglie del mondo antico. Da allora ogni tomba monumentale porta il suo nome: mausoleo per l’appunto...». Lazzari si grattò l’orecchio. «Pensavo che cercaste Lazzari si grattò l’orecchio. «Pensavo che cercaste un esperto di storia romana, e non di storia greca, scusate tanto». «Spero tu sia esperto anche di altre cose. Dovremo passare del tempo insieme e io mi annoio facilmente. Sai guidare?» «Guidare? Certo che so guidare». Era un’Audi station wagon grigia. Lazzari infilò le borse nel bagagliaio e salì al posto di guida. Impiegò qualche minuto per regolare gli specchietti e il sedile, mentre Artemisia lo osservava in silenzio scuotendo il capo. Infine si immisero sula via che costeggiava il mare e sfilarono sotto gli alberghi vuoti e silenziosi. «Mi dispiace per la battuta sul nome, non volevo offenderti», le disse Lazzari. L’ironia era sempre stato il suo modo per avvicinare gli altri. Con il tempo aveva imparato a disprezzare quell’approccio, ma quando si sentiva in difficoltà o in imbarazzo non riusciva a farne a meno. «L’ha scelto mio padre. Ha una fissa per l’antichità. Pensa che il passato sia un bel posto dove vivere, se capisci cosa intendo». «Lo capisco». «È un terribile egocentrico, ma ha anche i suoi pregi...». pregi...». «Ecatomno, intendi?» «Chi?», saltò su Artemisia. Lazzari staccò la mano dal cambio per indicare qualcosa oltre il parabrezza. «Se avessi studiato con più attenzione storia greca, invece di fissare le gambe dei tuoi compagni che giocavano a calcio, avresti imparato che Ecatomno era appunto il padre di Artemisia, moglie e sorela di Mausolo». «È ora che mi racconti qualcosa di questa vicenda, non trovi?», gli domandò Artemisia. Avevano appena imboccato l’autostrada e Lazzari pensava a tutte le città che erano disseminate davanti a loro – si trattava solo di proseguire sempre dritti, magari su fino al Mare del Nord. «Io?», fece sorpreso, ridestandosi di colpo dai suoi pensieri. «Credevo che sarei stato io quello che avrebbe ottenuto informazioni da te. Tu non lavori per questa fantomatica Fondazione?» «Tu, semmai, lavori per la Fondazione SigmaPiTau, che non è affatto fantomatica. A questo punto dovresti essertene accorto. Io sono qui solo per impedirti di metterti nei guai o di mettere nei guai la Fondazione». Lazzari fece un gesto con la mano come a dire che era lo stesso. «Che cosa vorresti sapere?» era lo stesso. «Che cosa vorresti sapere?» «Tutto». «Tutto è troppo. Come faccio a spiegarti in due minuti quello che ho cercato di imparare in vent’anni di studio?» «Abbiamo tre ore fino a Milano, o forse cinque se insisti con questa andatura da vileggiante della domenica». «Ci proverò. Partiamo da quello che sai tu». Artemisia si tolse le scarpe e si mise a gambe conserte. «D’accordo. Il Committente, come lo chiama il Colonnello, vuole a tutti i costi conoscere il vero nome di Roma e il segreto sulle sue origini; e vuole quel benedetto bastone da far vedere agli illustri ospiti che frequentano abitualmente casa sua per poter dire a ciascuno di loro: “Lei è il presidente di quel bellissimo Stato, o di quella potente banca, ma io tengo in mano il legno con cui Romolo fondò Roma, la città delle città”». «Il Colonnello mi aveva parlato di un circolo di mecenati». «Il Committente è il presidente della Fondazione SigmaPiTau. È lui a comandare. Gli altri fanno numero». «È quello che facciamo tutti, in un certo senso», si lamentò Lazzari. lamentò Lazzari. «Ora è il tuo turno». «Parola». «Cosa?», scattò Artemisia. «È un’espressione del poker di un tempo. Mai sentita? Significa che tocca ancora a te parlare. Chi ci aspetta a Milano?». Artemisia scuoteva la testa. «Abbiamo appuntamento con Achille Vento, quello che ha messo la pulce nell’orecchio del Committente. Tramite gente del giro, il Committente è venuto a sapere di questo Vento e della setta di cui fa parte. Pare che custodiscano il segreto su Roma fin dalle origini». «Gente di quale giro?», domandò Lazzari. «Appassionati di oggetti storici, antiquari, galleristi...». «Tombaroli, ricettatori, trafficanti internazionali...». Artemisia sbuffò. «Se sai già le risposte, evita di fare le domande». «Io mi pongo solo le domande di cui conosco già la risposta», borbottò sottovoce Lazzari. «Bel modo di fare per uno studioso». «Come fate a sapere che è una fonte affidabile, questo Vento?» questo Vento?» «La Fondazione ha incaricato il Colonnello di verificare. Lui ha preso le sue informazioni e ha decretato che è una fonte attendibile». «Che cosa vuole questo Vento in cambio delle informazioni?» «Soldi, ovvio. Gli è stato già dato un acconto, ma fino a oggi non ha svelato nulla: pretende di parlare con un esperto, dice che le informazioni in suo possesso sono in codice e vanno decifrate da uno specialista in materia. Quelli della Fondazione hanno fatto le loro ricerche e hanno scelto te. Ora sai tutto quello che so io. È il tuo turno: vuoi parlarmi di questo benedetto segreto che riguarda Roma? Cosa c’è di tanto importante e misterioso da far perdere la testa a uno degli uomini più ricchi d’Italia?» «Passo». «Non puoi passare». «Invece sì, ho bluffato». Artemisia reclinò il sedile, distese le gambe e intrecciò le braccia sul petto. «Ma certo, è come sospettavo», aggiunse dopo un po’, come se parlasse da sola. «Tu devi essere uno di queli che non ha capito nulla della vita». della vita». «Quello che io non so a proposito della vita potrebbe riempire un’intera enciclopedia, hai ragione», disse Lazzari. Non parlarono più fino a quando, poco oltre Parma, Artemisia gli disse di fermarsi al successivo autogrill. «Dove ci aspetta quel tipo a Milano?», le domandò Lazzari. «A casa sua», rispose Artemisia. Si era tolta la felpa e se l’era avvolta intorno al collo. La T-shirt lasciava scoperta la pelle delle braccia, solcata da un’evanescente peluria bionda. A Lazzari faceva venire in mente l’estate e i granelli di salsedine baciati dal sole. «E dove abita?», insistette Lazzari. «In piazza Pompeo Castelli». «Oh cazzo». «Che c’è? Qualcosa non va?» «Ci ho abitato per qualche anno». «E qual è il problema?» «Lo stesso del fantasma dell’uomo che torna nel luogo dove è stato ammazzato». Al bar dell’autogrill Lazzari prese un caffè lungo e Al bar dell’autogrill Lazzari prese un caffè lungo e andò a berlo davanti all’espositore dei giornali. Dopo aver letto i titoli dei principali quotidiani si diresse verso un tavolo per posare la tazza, ma si scontrò con un uomo sui trentacinque di almeno un metro e novanta. Indossava un cappellino verde con una D rossa cucita sulla tesa e un paio di occhiali scuri sopra la barba di un mese. «Scusa», gli disse. Il ragazzone gli posò una mano sulla spalla. Pesava come un mattone. «Man, cerca di stare più attento». Artemisia, già sulla porta, gli fece un cenno spazientito. «Dài, dài, andiamo! È tardi!». «Tardi per cosa?», le domandò Lazzari appena furono ripartiti. «Non vorrei metterci tutta la vita per scoprire questo segreto». «In ogni caso non basterebbe». 5 «Per la verità sono tre i misteri che riguardano la fondazione di Roma», disse Lazzari, quando la ragazza si sve gliò. Si erano appena lasciati alle spalle il casello di Melegnano. La luce dei lampioni ammorbidiva la sagoma della città sullo sfondo. Artemisia sbadigliò, si infilò la felpa e si sistemò sul sedile massaggiandosi le braccia con le mani. «Ti sei deciso finalmente a parlarmene!». «Hai freddo? Accendo il riscaldamento?» «Non mi dispiace avere qualche brivido. Ma torniamo a Roma». «Il primo mistero riguarda il vero nome di Roma». «E allora Roma cosa sarebbe?» «Un semplice appellativo di facciata, utile per mascherare la realtà. Tutte le fonti antiche sono concordi nel ritenere che la città avesse un nome segreto che non poteva essere né pronunciato né tanto meno rivelato. Un nome che nessuno ha mai osato mettere per iscritto». nome che nessuno ha mai osato mettere per iscritto». «E perché mai?» «Nella mentalità arcaica conoscere il nome di una cosa significa poter incidere su quella cosa, modificarla, possederla, dominarla», spiegò Lazzari. «Allora è questo che intende il mio psicologo quando ripete che i nomi dei bambini devono arrivare dalle madri. Dice che devono essere suoni interni, perché nel nome è contenuto il destino del bambino». Lazzari annuì. «Nomen omen dicevano i latini». «E il secondo segreto?», domandò Artemisia. Era incuriosita; non tanto dal contenuto di quelle spiegazioni, che pure la riguardavano, ma soprattutto dall’emozione con cui Lazzari ne parlava. Il suo tono era divenuto basso e in qualche modo sensuale. D’un tratto sembrava un uomo che sapeva quello che diceva. «Il secondo segreto concerne il vero nume protettore di Roma, a cui i latini si rivolgevano con la formula sive mas sive foemina: “sia tu maschio o femmina”. Il nome della divinità patrona della città non poteva essere manifestato per evitare il rito dell’evocatio». «Di che diavoleria si tratta?» «Di una sorta di cerimoniale magico: i pontefici romani evocavano la divinità protettrice della città da romani evocavano la divinità protettrice della città da conquistare prima dell’assedio o della battaglia, promettendole un po sto a Roma in caso di vittoria». «Ruffiani». «È rimasta celebre la conquista di Veio e il trasferimento a Roma del culto principale della città, quello di Giunone Regina». «Come no, celeberrima», fece Artemisia con evidente ironia. «I romani assediavano Veio da molto tempo senza successo. Su consiglio degli aruspici, gli esperti di cose sacre, si rivolsero direttamente alla principale divinità dei nemici, Giunone Regina, promettendole un tempio a Roma in caso di trionfo. Poterono farlo, perché conoscevano il vero nome della dea patrona di Veio, ossia Regina. Le loro invocazioni ebbero successo: pochi giorni dopo presero la città e onorarono l’impegno trasferendo il simulacro di Giunone a Roma, dove le eressero un tempio. Capisci ora? Se i nemici non avessero conosciuto il nume segreto di Veio, non avrebbero mai potuto evocarlo e la città non sarebbe mai stata conquistata». Artemisia si strinse le ginocchia al petto e appoggiò i piedi sul sedile. «Chi conosceva questi misteri? Tutto il piedi sul sedile. «Chi conosceva questi misteri? Tutto il popolo o...». «Soltanto una cerchia ristretta, che li serbò gelosamente. Il terzo e ultimo segreto riguarda la stessa fondazione, per la quale tutti gli autori latini usano il verbo condere. Pensa all’opera dello storico latino Tito Livio, Ab urbe condita, che racconta appunto la vicenda della città a partire dalla fondazione». «Credo di averne letto qualche pezzo al liceo». «Condere significa “fondare”, ma anche e soprattutto “nascondere”. Che cosa nascose la città? Gli studiosi dell’epoca pensavano a un passaggio segreto. Devi sapere che nei resoconti dei riti che accompagnarono la nascita dell’Urbe, le fonti antiche citano incidentalmente almeno due passaggi misteriosi – quello per gli Inferi e quello per le Isole dei Beati – e almeno due possibili localizzazioni per questi ingressi: il mundus nel Foro e la cosiddetta “Roma quadrata”». «Che cosa sono?» «Il mundus era un pozzo scavato nel terreno e costituiva una sorta di porta tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Veniva aperto soltanto tre giorni all’anno: in quelle occasioni gli dèi inferi potevano attraversare la città». città». «E perché mai avrebbero dovuto permetterglielo? Non ha senso». «Per loro lo aveva. I romani credevano che a intervalli regolari occorresse dare sfogo a certe forze, affinché non si scatenassero in modo rovinoso. Per questo permettevano agli schiavi di essere liberi un giorno all’anno, o ai soldati di prendere in giro i generali durante il trionfo». «E la Roma quadrata che cos’è?» «Almeno tre diverse cose. Le fonti a riguardo sono contraddittorie. Roma quadrata indica il perimetro dell’intero Palatino, con entrambe le sue sommità, Palatium e Cermalus; ma anche, secondo altre fonti, un’area dello stesso colle davanti al tempio di Apollo o, ancora, una fossa con annessa una piccola ara, posta sulla sommità del Cermalus, il colle della fondazione». «Un altro passaggio?» «Forse». «Quindi fu su quel colle che venne fondata la città». «Sì. Anche il termine Cermalus deriva dalla stessa radice del verbo condere e significa pertanto sia luogo della fondazione sia luogo del nascondimento. Ma che cosa si nascondesse davvero sotto Roma, questa è a parer mio la questione fondamentale, la chiave con cui parer mio la questione fondamentale, la chiave con cui poter penetrare nel castello dove è custodita la verità». Artemisia si tolse per la prima volta gli occhiali. Nella penombra Lazzari non riuscì a distinguere il colore dei suoi occhi. «Tu pensi di avere una risposta a ciascuna di queste domande, non è così?», gli domandò. «È così, ma non per questo ho smesso di pormele». «E perché mai?» «Perché ogni volta la risposta diventa più nitida, più precisa, più vicina alla verità». Lazzari lasciò la tangenziale alla prima uscita. La detestava: l’eventualità terribile di rimanere bloccato nel traffico senza poter svicolare, la vista su un mondo circolare dove non accadeva nulla, i camion come elefanti in un circo lo disorientavano. Imboccò la circonvallazione interna, guardandosi costantemente attorno. Aveva cenato in molti dei ristoranti che fiancheggiavano i viali, al’epoca in cui per lui la città era ancora un luogo da esplorare. Per ciascuno di essi conservava almeno un ricordo. Come se non volesse soffermarsi sui rimpianti, pigiò sull’acceleratore sfiorando i cento all’ora. sfiorando i cento all’ora. «Ti sei svegliato finalmente?», lo stuzzicò lei. Lazzari si diresse verso la parte ovest tagliando a metà la città e soltanto all’altezza di piazza Diocleziano emerse dal prolungato silenzio. «Scusa se sono stato reticente». «Rispetto a cosa?» «Alla questione del segreto di Roma. Per un attimo, è stato come se mi avessi chiesto il giorno e l’ora della mia morte». Con la mano diede un colpetto sullo specchietto retrovisore. «Ciascuno di noi tende a scegliersi uno specchio e a vedere in esso se stesso e la propria sorte. Il mio è Roma». «Lo dici come se fosse una colpa». «Lo è». Passarono sotto un cavalcavia, superarono il tram numero uno che sferragliava sotto una galleria di alberi e arrivarono a Villapizzone. Episodi di luce frammentavano il quartiere. L’insegna al neon di un bar accendeva un angolo della piazza. Sull’altro lato un gruppo di ombre ciondolava ai margini dei giardini. Ancora oltre, un lampione illuminava un campo di basket deserto. Lazzari lanciò una seconda occhiata, ma sotto il canestro non c’era l’uomo panciuto in tuta grigia che canestro non c’era l’uomo panciuto in tuta grigia che all’epoca, quasi ogni sera, palleggiava metodicamente per ore, destro e sinistro, nell’area del tiro da due punti. «In corso Marcello c’è una pizza al trancio da leccarsi i baffi», disse spinto dall’improvviso desiderio di ritrovare qualcosa del passato. «Mangeremo più tardi. Ora muoviamoci», disse Artemisia. Fece due volte il giro del palazzo e alla fine parcheggiò su un marciapiede tra due passi carrabili. Oltre la stazione di Villapizzone le luci soffuse della Triennale promettevano morbidi divani, beveraggi e belle signore da guardare. Un gruppo di ragazzi senza età sedeva all’imbocco della via. Indossavano larghe canottiere sopra i maglioni e cappelli dalla visiera piatta. Alcuni dondolavano la schiena al ritmo della musica che gorgogliava da un grande stereo posato a terra come un macigno. Artemisia suonò ripetutamente all’interno quindici, ma nessuno aprì. «Ci ha ripensato», disse Lazzari. «Nessuno ci ripensa, quando ballano certe cifre», assicurò Artemisia, e riprovò, premendo con forza il pulsante. pulsante. Un uomo in pigiama e giaccone uscì dal portone insieme al suo barboncino color neve sporca. Artemisia, senza pensarci due volte, scavalcò con un salto il guinzaglio teso e oltrepassò l’ingresso. Lazzari fece un segno all’uomo come per scusarsi e fargli intendere che era tutto a posto, ma la ragazza lo trascinò dentro. «Smettila di comportarti come un bambino», gli disse quando furono nell’ascensore. Achille Vento abitava all’ottavo piano. L’appartamento si affacciava su un ballatoio che correva tutt’intorno al cortile interno, secondo lo stile rivisitato delle case di ringhiera della vecchia Milano. La porta d’ingresso e una finestra davano sul mezzanino. Artemisia suonò a lungo, ma ancora invano. Il suono del campanello rimbombava nell’androne, imponendosi sopra i borboglii che si diffondevano dai televisori accesi negli alloggi. A Lazzari parve di vedere una tenda muoversi nell’appartamento al di là del ballatoio. «Torniamo domani», disse. «L’appuntamento era per stasera». «Allora vuol dire che il tuo amico è fuggito con la certa cifra». certa cifra». «Non si può fuggire da certa gente», disse Artemisia con tono severo, provando a forzare la finestra. «E poi gli abbiamo dato per il momento solo un piccolo acconto». Lazzari scattò per bloccarla. «Ma che diavolo fai?» «Gli infissi sono vecchi e gonfi di umidità. Se spingiamo in due cedono». «Sei matta? Si chiama violazione di domicilio». «Non mi importa nulla di come si chiama. Dammi una mano», insistette la ragazza, alzandosi sulle punte per fare più forza. La finestra cedette all’improvviso spalancandosi verso l’interno. Artemisia sbatté contro il davanzale, le braccia che annaspavano all’interno e le gambe protese indietro. Lazzari allora la spinse dentro e, dopo essere entrato anche lui, la costrinse ad accucciarsi. Poi accostò la finestra e le intimò il silenzio con un cenno, ma nessun rumore proveniva dal pianerottolo. «Non ci ha visti nessuno, vuoi smetterla...», cercò di rassicurarlo Artemisia, ma si bloccò quando si accorse dello sguardo sgomento di Lazzari. Si voltò e vide quel che lui aveva già notato. La finestra opposta era che lui aveva già notato. La finestra opposta era spalancata. Il chiarore che proveniva dai lampioni nella piazza sottostante illuminava un uomo disteso per terra, con le gambe unite e le braccia allargate, quasi a formare una croce. «Dorme», bisbigliò. «Senza respirare, porca puttana! È morto, non lo vedi?». Si avvicinarono carponi verso l’uomo. Doveva avere una trentina d’anni e sembrava piuttosto robusto. Il volto era tumefatto, lividi profondi gli deturpavano il naso e la guancia sinistra. Una ferita gli segnava l’arcata sopraccigliare. Lazzari si chinò per ascoltare il respiro. «No, no, no», non faceva che ripetere, la voce sul punto di spezzarsi. Gli piazzò due dita sula giugulare, ma niente. Cercò ansiosamente di ricordare quello che gli avevano insegnato al corso di pronto soccorso che aveva dovuto frequentare prima di aprire l’enoteca. Da quanto tempo il cuore di Vento aveva cessato di battere? Forse, se fosse riuscito a rianimarlo... Che diavolo stava dicendo? Quello che stava toccando era un cadavere... Per puro scrupolo gli aprì la camicia, ma uno strano tatuaggio sul petto dell’uomo lo colpì e lo paralizzò, come se fosse stato dell’uomo lo colpì e lo paralizzò, come se fosse stato morso da un animale. Artemisia tirò fuori il celulare e fotografò il simbolo. Lo scatto echeggiò nel silenzio. «Cos’è?», saltò su Lazzari. Era un fascio di nervi e non si era accorto del telefono che la ragazza impugnava. Il flash lampeggiò una seconda volta nella modesta stanza. Il tavolo era ribaltato e la vetrina sopra la credenza infranta. Barattoli e oggetti giacevano sul pavimento alla rinfusa. «L’hanno ammazzato», disse Artemisia. «E poi hanno setacciato l’appartamento. Cercavano qualcosa... Questo può significare soltanto che Vento nascondeva qui il libro che stiamo cercando o addirittura lo stesso lituo». «Quale libro dannazione?», ansò Lazzari. «Il Colonnello crede che la setta custodisca un libro millenario sui misteri di Roma». «Lascia perdere e illumina questo punto con il telefono», le disse Lazzari, a cui era parso di notare una scritta sulle piastrelle, in parte nascosta dai capelli del cadavere. S.E. «No, no!», disse Lazzari, appena quelle lettere gli apparvero in modo distinto. Con le mani sulle tempie, scuoteva la testa in preda all’agitazione. «Non può succedere proprio a me, non a me, non a me!». Artemisia lo prese per un braccio. «Che c’è? Che significa?». Da fuori arrivò un piccolo boato seguito in rapida successione da una sorta di crepitio. Lazzari si liberò della presa e si lanciò sul terrazzino. Nella piazzetta sottostante un contenitore cilindrico per i rifiuti aveva preso fuoco, mentre un uomo si allontanava di corsa. Riuscì a intravederlo per un istante quando passò nel cono di luce di un lampione: era alto, con la barba, gli occhiali scuri e un cappellino. Era quasi certo che si trattasse del ragazzo con cui si era scontrato all’autogrill quello stesso pomeriggio. «Oh no, no, no!», fece aggrappandosi al corrimano. Le sirene della polizia si avvicinavano rapidamente. Intanto dalle finestre e dai balconi circostanti si era affacciato un piccolo pubblico: uomini, donne e bambini. Tutti a scrutare il fuoco che illuminava il grande albero al centro dela piazza. Qualcuno, su un terrazzo del palazzo attiguo, lo indicò: Lazzari si agitò e urtò con la mano la attiguo, lo indicò: Lazzari si agitò e urtò con la mano la fioriera legata alla balaustra, che si inclinò cadendo e frantumandosi a nemmeno un metro di distanza dalla prima gazzella. Lazzari, spaventato, rientrò di corsa nell’appartamento e afferrò la ragazza che stava frugando nella stanza. «Andiamo via, sta arrivando la polizia!». Uscirono dalla finestra da cui erano entrati, ma appena imboccarono le scale, sentirono lo scatto dell’ascensore. «Più veloce», fece Lazzari saltando gli scalini tre alla volta. Per poco non cadde. Aveva le gambe molli e tremolanti. A metà dela discesa udirono qualcuno risalire dal basso a passi pesanti. Si guardarono attorno con angoscia. Erano sul punto di tornare indietro quando una porta si aprì e una donna fece segno di entrare. Vedendoli esitare, mormorò: «Non so cosa avete fatto voi, ma so cosa ha fatto la polizia a mio marito. Venite dentro, forza!». Appena furono dentro, si portò l’indice alle labbra, e poi controllò attraverso lo spioncino. Una bambina con i riccioli li guardava a occhi sgranati. Teneva tra le mani una bambola senza un braccio. I passi ritmati si avvicinarono. Distinguevano persino i respiri pesanti. Lazzari, immobile, si teneva una mano sul petto. I rumori fecero tremare la porta di legno leggero, ma passarono oltre lasciandosi dietro un’eco che scemava. La donna aprì, diede una rapida occhiata e poi sussurrò: «Via libera». La ringraziarono e uscirono. Scesero a passi felpati, lanciando occhiate ansiose al’androne. All’ultima rampa si accorsero delle voci. Qualcuno piantonava l’ingresso. «I locali dell’immondizia», disse Lazzari, prendendola per un braccio. «Come lo sai?», mormorò Artemisia. «Ho vissuto in uno di questi palazzi. Sono tutti uguali». Saltarono dalla ringhiera e atterrarono in un mezzanino senza rivestimento. Lazzari spinse la porta di metallo e con Artemisia a rimorchio si inoltrò tra i bidoni di plastica e i cestelli di alluminio. In fondo al locale filtrava una luce, non era possibile distinguere se provenisse da una porta o solo da una finestrella. «Comincia a pregare», le disse accelerando il passo e inciampò sul cemento grezzo del pavimento. Appena svoltato l’angolo videro uno spiraglio pallido sotto la parete. Si precipitarono in quella direzione cercando di capire cosa fosse. Artemisia trovò una cercando di capire cosa fosse. Artemisia trovò una maniglia, la spinse ed esultò vedendola cedere. Attraversarono di corsa il cortile interno e poi il locale rifiuti del palazzo opposto, e finalmente uscirono in strada. «Dall’altra parte!», le gridò Lazzari. I ragazzi con lo stereo erano spariti. Lazzari e Artemisia videro l’Audi, vi si precipitarono senza mai voltarsi indietro e saltarono dentro più in fretta che poterono. “Respira e ragiona e tutto andrà bene”, si ripeté una volta al sicuro. La strada era senza uscita: da una parte la stazione e dall’altra i giardinetti. Sarebbero stati costretti a tornare indietro e passare per la piazza dove erano parcheggiate le volanti della polizia... Ma a quel punto parve ricordarsi di qualcosa. Ingranò la retromarcia e fece tutta la via a ritroso. «Vicolo cieco», lo avvisò la ragazza, con la mano sullo schienale. «Non si passa, ti ho detto», gridò con più energia. «E io ti ho detto che qui ci ho vissuto». Scartò il muro e salì sopra il cordolo; percorse il giardinetto per intero schivando un paio di panchine e sbucò sulla piazza dove c’era il capolinea del tram. Mise sbucò sulla piazza dove c’era il capolinea del tram. Mise la prima e imboccò il sottopassaggio per la Bovisa. I graffiti a tutta parete crebbero, si tinsero di verde e di rosso inferno sotto i fari, infine scemarono di nuovo nell’ombra quando si infilarono nel tunnel. Risalirono verso il lato opposto della stazione, ai margini della zona industriale, e si diressero verso la circonvallazione. Nessuno dei due aveva detto una parola durante il tragitto. Lazzari si sentiva il cuore scoppiare. «Devo bere qualcosa», disse. «Anche io», fece Artemisia annuendo. Lazzari rallentò solo quando furono in centro, dove i fanali posteriori delle auto disegnavano lunghi festoni iridescenti. In piazzale Oberdan svoltò a destra seguendo il percorso guidato per l’inversione. Un tempo avrebbe girato a sinistra senza pensarci, tagliando l’incrocio, ma quella sera intendeva seguire le regole. Probabilmente la polizia li stava cercando, l’avevano visto in molti sul terrazzo di Vento. Sentirsi braccati: ecco una sensazione che non avrebbe mai pensato di provare. E poi il volto pesto di quell’uomo, il suo corpo immobile, e ancora quella scritta sanguinolenta. Cominciava ad e ancora quella scritta sanguinolenta. Cominciava ad avere paura sul serio e a capire il guaio in cui ormai si era infilato. Aveva bisogno di alcool, di una preghiera e una voce amica. Lasciarono l’auto in un’area di carico e scarico e schizzarono dentro il Nottingham Forest. Due sgabelli liberi al bancone sembravano attenderli. Senza salutare si sedettero e ordinarono un paio di Margaritas. C’era un chiacchiericcio compìto nel locale. Ciascuno sembrava badare agli affari propri. Cravatte allentate, pettinature stanche, trucchi sfatti. Un’atmosfera da concerto jazz senza jazz. Soltanto dopo aver bevuto il secondo drink ritrovarono il coraggio di aprire bocca, anche se Lazzari non se la sentiva affatto di parlare di quanto era accaduto. Era ancora troppo frastornato. Artemisia era rossa in viso e scarmigliata, ma la sua era un’agitazione viva, attiva, di chi era pronto ad agire. «Allora vuoi dirmi cosa significava quella scritta che hai visto accanto alla testa di quel cadavere?». Lazzari si portò il bicchiere alle labbra e lo inclinò, ma non c’era più nemmeno una goccia. «Non so come dirtelo». «Dimmelo e basta», tagliò corto Artemisia, facendo «Dimmelo e basta», tagliò corto Artemisia, facendo intanto cenno al barman. «Come si fa a dire con parole semplici che hai preso un abbaglio, che ti sei infilato in qualcosa di più grosso di te, che tutto è diverso da come te lo eri immaginato, che te la stai facendo sotto dalla paura, che non sai da che parte cominciare e tanto meno dove andrai a finire, e che vorresti tirarti indietro... ma che forse è troppo tardi. Quali sono le parole giuste??». 6 Lazzari si sentì mancare il fiato e uscì di corsa. La ragazza pagò il conto e lo seguì. «Tutto bene?». Appoggiato contro il tronco di un albero, cercava di regolarizzare il respiro. «E ora?», le domandò quando si sentì di nuovo in grado di parlare. «Abbiamo due stanze prenotate al Marriott», disse Artemisia. «Io lì non ci vengo». «E perché?» «Mi chiedi anche perché?» «Non urlare». «Te lo dico subito perché», disse Lazzari con fare concitato. «Sotto casa di Vento ho visto lo stesso tizio alto e barbuto che oggi pomeriggio abbiamo incontrato all’autogrill di Parma. Deve essere stato lui a chiamare la polizia, o forse è lui stesso un poliziotto. Ci stava senza dubbio pedinando e quindi conosce anche i nostri nomi. Io non vado proprio in nessun albergo dove c’è una Io non vado proprio in nessun albergo dove c’è una maledetta stanza registrata a mio nome!». Artemisia, il peso su una sola gamba, intrecciò le braccia al petto. «Non ci ha seguito nessuno. Tu hai le allucinazioni... Saranno stati i vicini a chiamare la polizia, avranno pensato a un tentativo di furto». «E da quando per un tentativo di furto si muovono tre volanti?» «Vuoi abbassare questa cazzo di voce?» «E così ora penseranno che siamo stati noi ad ammazzare Vento!». «Nessuno ci ha visti, hai le allucinazioni». «Nessuno tranne le cento persone affacciate ai palazzi vicini», insistette Lazzari. «Era buio». «E poi le allucinazioni non incendiano i bidoni della spazzatura». «Saranno stati i ragazzini». «Non essere ingenua, per favore! Abbiamo dietro quel tizio, la polizia e magari pure quelli che hanno ammazzato quel disgraziato di Achille Vento. In fondo era con noi due che aveva appuntamento. Anche loro conosceranno i nostri nomi. Dobbiamo assolutamente...». «Senti, decido io cosa dobbiamo fare, intesi?» «Senti, decido io cosa dobbiamo fare, intesi?» «Ok, e allora decidi: o lasciamo Milano o dormiamo in auto». «Aspetta», disse Artemisia, di colpo calma. «Forse conosco una persona che potrebbe ospitarci. Provo a chiamarla». Si allontanò di qualche passo con il cellulare in mano. La telefonata durò appena un paio di minuti. «Ennio non è in casa, ma ci ospiterà lo stesso». «E come?», domandò Lazzari. «Vuoi piantarla? Ennio ha detto che avrebbe telefonato ai domestici, ci apriranno loro. Stai tranquillo, è un buon amico del Committente. Abita in corso Colombo». «Va bene», si arrese Lazzari, «chiama un taxi e fatti lasciare davanti alla stazione di Porta Genova, come se dovessi prendere il treno. Da lì a corso Colombo sono quattro passi». «Lo so». «Come faccio io a sapere quello che sai e quello che non sai?», sbottò Lazzari. Si teneva il petto, aspettandosi un attacco di panico da un momento all’altro. L’alcool aveva rallentato ma non bloccato il senso di oppressione che sentiva localizzato all’altezza dello sterno: respirava affannosamente, gli formicolavano le mani e sudava. «Io affannosamente, gli formicolavano le mani e sudava. «Io parcheggio lì intorno e poi ti raggiungo. Ci vediamo direttamente nell’appartamento. Meglio dividerci, perché stanno cercando di certo un uomo e una donna». «La vuoi smettere di vedere fantasmi dappertutto?» «Be’, di fantasmi finora ne ho visto uno soltanto. Achille Vento». Lazzari parcheggiò l’Audi e risalì a piedi corso Colombo. Alla fine l’attacco di panico lo aveva risparmiato, ma sentiva che il pericolo non era del tutto scampato. Avvertiva ancora un nodo alla gola e una dolorosa strozzatura alla bocca dello stomaco, come se qualcuno gli tenesse un dito premuto in quel punto. Al numero undici c’era un palazzotto dalle pretese rinascimentali, con la facciata decorata da effigi, tondi, stucchi, lunette e piante rampicanti a nascondere la parte di muro non ristrutturato. Lo smog, però, aveva già annerito con tratti di carboncino anche il recente restauro. La terrazza dell’attico era scandita da una balaustra di marmo e ornata con un pergolato di legno e alberi di agrumi. L’appartamento dell’amico della Fondazione occupava tutto l’ultimo piano, un quadrilatero che si occupava tutto l’ultimo piano, un quadrilatero che si affacciava sul cortile interno dove vari tipi di piante crescevano tra le lussuose automobili. Un domestico in livrea amaranto andò ad aprire e lo scortò fino alla stanza che aveva preparato per lui. Busti e spesse cornici rifulgevano nella fioca luce del corridoio. Prima di congedarsi l’uomo domandò a che ora avrebbe gradito la colazione l’indomani. «All’ora in cui la fate voi andrà benissimo», rispose Lazzari. «Noi prendiamo servizio alle sette». «Mi troverà in piedi». «Come desidera». «Di cosa si occupa il padrone di casa?», domandò ancora Lazzari accennando ai dipinti. Non gli sarebbe dispiaciuto rubarne un paio. Nel suo locale non avrebbero affatto sfigurato. Ma lui ce l’aveva ancora un locale? «Affari», rispose l’uomo. «Degli affari suoi... certo... Ottima occupazione», approvò Lazzari grattandosi una guancia. «La mia preferita. Buonanotte...?» «Cesar», disse l’uomo. «Buonanotte Cesar». Si chiuse la porta alle spalle. Ai piedi del letto trovò Si chiuse la porta alle spalle. Ai piedi del letto trovò un paio di ciabatte e sulla trapunta un pigiama che odorava di pulito. Curiosò in giro: nell’armadio c’erano giacche, pantaloni e camicie in abbondanza, mentre in bagno ogni genere di nécessaire. Artemisia entrò nella stanza senza bussare. «Vieni di là. Dobbiamo parlare». Lazzari vide i suoi piedi nudi riflessi nello specchio. «Dammi qualche minuto», le disse. «Ok, uno». Ripose lo spazzolino e la seguì per tutto il corridoio fino a un grande salone. Le imposte erano aperte e la luce della strada disegnava i contorni indefiniti di statue, divani e quadri. Un pianoforte a coda biancheggiava nell’angolo più lontano come lo scheletro di un animale preistorico. Lazzari si avvicinò al carrello bar sistemato tra le due finestre centrali. Le intelaiature di legno bianco rilucevano fiocamente. «Nessuno ha detto che puoi servirti», gli disse la ragazza. «Nessuno ha detto nemmeno il contrario», ribatté Lazzari, e porse pure a lei un bicchiere pieno di rum. Artemisia prese il bicchiere e si sedette al centro del divano. divano. «Come lo hanno ammazzato secondo te?». Lazzari, in piedi di fronte alla finestra, guardava fuori e con la mano libera si strofinava il petto. «Secondo me non è la domanda giusta», rispose, pentendosene subito dopo. Una frase simile aveva sentito pronunciarla proprio al Colonnello. Non riusciva a toglierselo dalla testa. «Cosa vuoi dire?» «Niente, lascia stare. In ogni caso, secondo me, prima di ammazzarlo lo hanno picchiato per farlo parlare». «E lui gli ha detto di noi». «Penso proprio di sì». Lazzari si voltò, lasciò il bicchiere su un tavolino a tre gambe e tese la mano verso la ragazza. «Fammi vedere la foto che hai scattato al tatuaggio che Vento aveva sul petto». «L’ho già guardato io», disse Artemisia porgendogli il cellulare. «Il disegno rappresenta un albero tra due collinette, almeno credo». Lazzari studiò lo scatto per qualche secondo, infine sospirò. «Uno su tre». «Che vuoi dire? Vuoi smetterla?», fece Artemisia. «Hai indovinato una cosa su tre. L’albero è un albero, per l’esattezza un fico. Le collinette, come le hai albero, per l’esattezza un fico. Le collinette, come le hai chiamate tu, sono le cime gemelle di un unico colle, ma anche due mammelle». Artemisia premette le mani contro le ginocchia, sporgendosi in avanti. «Un fico tra due mammelle?». Lazzari le restituì il telefono e si infilò le mani in tasca. Era in imbarazzo, come ogni volta in cui doveva spiegare un particolare della sua disciplina a un profano. Si sentiva ridicolo, e ridicole gli apparivano le nozioni che illustrava. «È il fico ruminale che cresceva sulle rive del Tevere, all’epoca chiamato Albula. Si trovava a pochi passi dalla grotta del Lupercale, alla base del Cermalus, una delle due vette gemelle del cole Palatino. Proprio sotto a quell’albero il pastore Faustolo trovò Remo e Romolo in fasce mentre una lupa e una parra, cioè una specie di civetta, li stavano allattando». «E allora? Che cosa c’entra questo con le mammelle?», lo sollecitò Artemisia. «Ruma significa “seno” secondo molte interpretazioni antiche e moderne. Quindi il fico si chiamerebbe ruminale perché al riparo delle sue fronde la lupa allattò i gemelli. Per altri, fermo restando il significato di “mammella”, il vocabolo Ruma si riferisce alla doppia cima del Palatino, simile appunto a una coppia di seni. Per alcuni, infine, il simile appunto a una coppia di seni. Per alcuni, infine, il termine “ruminale” potrebbe riallacciarsi anche al nome della città: in questo caso Roma deriverebbe da Ruma». «E la tua idea qual è?» «Lascia perdere le idee. Per l’ipotesi secondo cui il fico ruminale sia il fico dell’allattamento ci sono ulteriori indizi: uno degli epiteti di Giove era Ruminus, il più importante a sentire sant’Agostino, perché nutriva il creato; mentre la dea Rumilia era la protettrice dell’allattamento dei neonati». «Come erano finiti sotto il fico ruminale i gemelli?» «Erano stati abbandonati in una cesta sul fiume. È per questo che vengono chiamati i “salvati dalle acque”, proprio come Mosè. Vedi, è sempre così che ha inizio ogni storia dello spirito, dall’acqua. Al principio della Genesi lo spirito di Dio aleggia sulle acque, mentre il Vangelo di Marco si apre con il battesimo di Gesù: Gesù esce dalle acque e lo spirito si posa sopra di lui». «D’accordo, ma perché erano stati abbandonati?» «Amulio aveva cacciato dal trono suo fratello Numitore ed era diventato re di Alba Longa, la città latina più importante dell’epoca. Per prevenire il pericolo di una discendenza ostile, aveva costretto la figlia di Numitore, Silvia, a divenire Vestale. Le Vestali facevano Numitore, Silvia, a divenire Vestale. Le Vestali facevano voto di verginità ma Silvia, invece, si ritrovò incinta e partorì due gemelli. Allora Amulio ordinò di ucciderli perché un giorno non potessero reclamare il trono, ma i servi ne ebbero compassione e li abbandonarono sul fiume Albula, che da Alba correva appunto verso il luogo dove sarebbe sorta la futura Roma. Su quel sito, all’epoca, sorgevano i resti di un’importante città decaduta, che si chiamava Settemonti». «Me la ricordavo diversa la leggenda». «Ci sono almeno cento versioni diverse dela stessa leggenda. Vuoi che te le racconti tutte?» «Voglio che mi racconti di quella scritta accanto al cadavere di Vento». «Lo farò... Ma prima devi sapere ancora qualcosa sul fico, che per i romani era un albero sacro. E non solo per loro. In India, per esempio, rappresentava l’asse del mondo e il Buddha ottenne l’illuminazione sotto un fico. In Grecia era considerato divino, gli iniziati ai misteri ne mangiavano i frutti pronunciando la frase: “la verità è dolce”. Inoltre, il fallo utilizzato nei misteri dionisiaci era di legno di fico, e lo stesso Dioniso era detto creatore e protettore di questa pianta. E tieni presente che Dioniso era una divinità legata a un ciclo di morte e rinascita. Nei era una divinità legata a un ciclo di morte e rinascita. Nei Veda il latte di fico è la potenza fecondatrice dell’universo. Siddharta ottiene il Risveglio sotto un fico che diventa perciò asse del mondo perché il risveglio coincide con il ritrovamento del Centro. Per farla breve, il fico ha una forte valenza misterica e rappresenta per la stragrande maggioranza delle civiltà antiche la potenza fecondatrice e il centro del mondo». «Lazzari, la scritta», fece Artemisia, come se non avesse ascoltato una sola parola. Lazzari si lasciò cadere su una poltrona. «Sono le iniziali di un’arcaica formula giuridica latina: sacer esto. Era la frase rituale con cui i pontefici, che in origine erano i custodi di tutto lo ius, sia sacro che civile, stabilivano la condanna a morte dei cittadini romani accusati di aver rotto la pax deorum, il patto di concordia tra gli dèi e la città». «Ma che cosa significa questa formula?» «“Che il colpevole sia consacrato agli dèi”, ossia offerto in espiazione. Chiunque, senza correre il rischio di sanzioni, poteva uccidere un uomo colpito dalla “sacertà”, anzi tutti i membri della comunità erano spinti a farlo: più in fretta lo si toglieva di mezzo e più in fretta si poteva risanare la rottura del patto divino», spiegò poteva risanare la rottura del patto divino», spiegò Lazzari, infervorandosi. «Un cittadino romano condannato a morte aveva il diritto a una fine rapida, e per questo veniva giustiziato con un colpo di spada. Solo nel caso dei cosiddetti crimina maiora, e più in particolare dell’alto tradimento, poteva essere ucciso con i metodi adottati per gli schiavi e per gli stranieri». «Cosa stai cercando di dirmi?» «Pensa a come era messo il corpo di Achille Vento...». Artemisia saltò in piedi. «Era come se fosse in croce!». «Quindi non dovremmo chiederci solo come sia stato ucciso materialmente, ma soprattutto che genere di morte sia toccata al povero Achille. Morte per crocifissione. Io credo che il vostro amico possa essere stato giustiziato per alto tradimento». «Ma è assurdo! Non siamo mica nell’antica Roma!». Lazzari indicò qualcosa fuori dalla finestra. «Il simbolo che portava tatuato sul petto non lascia dubbi... Deve appartenere davvero a una setta: mi pare chiaro il riferimento alla fondazione di Roma, vista la presenza del fico, che ha tutti quei significati esoterici cui ti accennavo prima. Spero di sbagliare, ma temo che gli adepti di prima. Spero di sbagliare, ma temo che gli adepti di questa setta siano convinti di custodire il segreto cardine dell’umanità e che siano pronti a tutto pur di difenderlo. Achille Vento evidentemente ne faceva parte, come vi ha confidato lui stesso. Ma i suoi compagni devono avere scoperto in qualche modo la sua intenzione di vendere il segreto, e a quel punto lo hanno picchiato, lo hanno fatto confessare, e poi condannato e giustiziato». Artemisia preparò altri due bicchieri di rum e ne porse uno a Lazzari. «E cosa dovrebbe avere confessato Vento, secondo te?» «Che intendeva rivelarci dietro pagamento il segreto che custodiscono». «Come fai a esserne così sicuro?» «Il caso più eclatante che si ricordi di cittadino romano crocifisso fu quello di Valerio Sorano. Era un antiquario ed erudito e fu condannato a morte dal Senato nell’ottantadue avanti Cristo, per alto tradimento». «E cosa c’entra con noi?» «Sorano era stato eletto tribuno della plebe, e perciò era un intoccabile. Invece fu condannato senza nessun riguardo per la sua carica, senza nemmeno un regolare processo a sentire le fonti, perché rivelò che esistevano un nome e un nume segreto di Roma. Stai attenta: non un nome e un nume segreto di Roma. Stai attenta: non svelò il contenuto del segreto, ma semplicemente che esisteva». «Esattamente quello che ha fatto il nostro Achille Vento». «Il messaggio della setta è chiaro: morte a chi tocca il segreto». «È chiaro soltanto per chi ne sa qualcosa». «Chi non ne sa niente non può cercarlo». «Forse è così». «Vento e Sorano... Entrambi hanno parlato dell’esistenza del segreto, senza però svelarne il contenuto», ripeté ancora Lazzari, come se evocando le parole potesse avere un’illuminazione improvvisa. «A nessuno dei due è stato concesso il tempo di farlo, a quanto pare». «Già». Artemisia si stirò sollevando le braccia e scoprendo la pancia. «Che cosa suggerisci di fare?» «Suggerisco di dormire», rispose Lazzari andandosene. Quando fu sulla porta del salone si voltò un’ultima volta. Tamburellò con le dita sullo stipite, lo sguardo distaccato di chi si trova già altrove. «Non dare troppa importanza al mio ragionamento. È solo un’intuizione. Lasciamola riposare, come diceva Antonio da Alba Docilia: se il lievito c’è, domattina, con la luce del sole, avremo il nostro pane». 7 Lazzari aprì gli occhi intorno alle cinque, qualche minuto prima che la sveglia suonasse. Disinserì l’allarme e si fece il segno della croce. Seduto sul bordo del letto, si massaggiò lo stomaco e fece gli esercizi per i suoi dolori cervicali. Dopo la doccia, notò un tagliacapelli elettrico sul ripiano del lavello. Gli bastò un’occhiata ai capelli che gli arrivavano quasi alle spalle per decidersi. Si rasò a zero, poi prese dall’armadio una camicia blu e un completo grigio, che valutò a occhio della sua taglia, li indossò e uscì senza più specchiarsi. La notte precedente non si era accorto che il lungo corridoio proseguiva oltre la sua stanza fino a una parete mascherata da una tenda. Si avvicinò spinto dalla curiosità, scostò il pesante tendaggio e si ritrovò davanti a una porta blindata con a fianco una piccola tastiera. Curiosò in giro, ma i domestici non erano ancora in piedi. Trovò un bloc-notes su una scrivania, scrisse un biglietto per Artemisia e glielo lasciò sotto la porta: Vado biglietto per Artemisia e glielo lasciò sotto la porta: Vado da un amico a chiedere consiglio. Resta fuori dai guai. Anzi, resta in casa. A stasera. Una volta in strada, s’incamminò a piedi verso la casa del professor Casini, proprio di fronte alla basilica di Sant’Ambrogio. Casini era stato il suo mentore: gli aveva procurato borse di studio e contatti nel mondo accademico e, cosa ancora più importante, gli aveva trasmesso la sua grande passione per la ricerca. Lazzari prese un caffè e gironzolò per il quartiere fino alle otto, quando suonò e salì. La signora Cecilia sollevò un sopracciglio appena lo riconobbe. «Alla buon’ora, il signorinetto. Chi non muore si rivede», disse prima di farlo accomodare nel vestibolo. Era in servizio in quella casa da oltre quarant’anni e non ne voleva sapere di prendere congedo. Diceva sempre che il professore li avrebbe seppelliti tutti, senza specificare chi intendesse di preciso con quel “tutti”. «La trovo bene, signora Cecilia». «La strada, invece? Quella non l’hai più trovata, eh?». Lazzari sapeva che sarebbe stata una lunga attesa. Lui, d’altra parte, lo stava facendo aspettare da quasi un decennio. All’epoca lavorava al suo saggio già da cinque decennio. All’epoca lavorava al suo saggio già da cinque anni. L’ultimo giorno che lo aveva visto, Casini lo aveva convocato nel suo studio e gli aveva dato un ultimatum: pretendeva la consegna del saggio, finito o non finito, per l’indomani mattina. In caso contrario poteva dimenticarsi il suo sostegno. L’indomani mattina Lazzari aveva preso il primo treno per Roma, dove il rettore di un’università privata gli aveva offerto un incarico, con la promessa di concedergli tempo e risorse per continuare le sue ricerche per il libro sulla fondazione di Roma. Pochi minuti più tardi arrivarono i primi visitatori. Come un patrono romano, Casini aveva l’abitudine di dedicare la mattinata al ricevimento domestico di amici e ospiti. Lazzari riconobbe tra gli altri un giovane docente di filologia bizantina che doveva avere quattro o cinque anni meno di lui. Alle dodici anche l’ultimo dei clientes fu congedato. Lazzari era rimasto solo nel vestibolo dai sedili foderati di cuoio. Si costrinse a inghiottire la frustrazione e a non protestare. Cecilia gli portò un tramezzino e un bicchiere d’acqua. «Ma non dirlo al professore». Verso le due si presentò un cardinale. Lazzari lo conosceva di vista e stava quasi per rivolgergli la parola, conosceva di vista e stava quasi per rivolgergli la parola, ma l’uomo fu subito ammesso alla presenza dell’anziano professore. Un’ora più tardi uscì imboccando senza esitazioni la porta. Al suono delle quattro Lazzari cominciò a dubitare che quell’attesa avesse un senso, ma poco dopo fu convocato. Il vecchio sedeva sulla sua poltrona, con Giasone in grembo: con la sinistra grattava l’orecchio del gatto e con la destra agitava la sua vecchia pipa. A un certo punto la sollevò con un gesto perentorio. «Nemmeno una parola sul passato. Ormai mi interesso solo del futuro. E non mi ricordare quanti anni ho, so benis simo di averne ottanta». «Professore...», balbettò Lazzari senza staccare gli occhi dal pavimento. «Una volta ti avrei fatto attendere almeno una settimana, anziché poche ore come oggi, ma da quando sono malato vivo ogni giorno come se fosse l’ultimo e pertanto non posso permettermelo. Inoltre so che avresti atteso perfino un mese, e questo mi è sufficiente». «Professore, io...». «Se sei venuto per chiedere il mio perdono, sappi che lo troverai un po’ freddo. È pronto da molti anni». Lazzari si avvicinò per abbracciarlo. «Su, su», gli Lazzari si avvicinò per abbracciarlo. «Su, su», gli disse il vecchio. Avevano entrambi gli occhi rossi. «In piedi. Sappiamo che per diventare grandi dobbiamo ribellarci pro tempore prima ai genitori e poi alle auctoritates. E io per te rappresentavo entrambi». «Grazie». «Sì, sì, va bene, prendi la sedia e mettiti qui, al mio fianco. Hai visto quel porporato? Trovo piacevole la sua conversazione. Chi l’avrebbe mai detto? Ho sempre sofferto la presenza dei preti, mentre ora... è la maledizione di noi toscani, o mangiapreti o mistici. A proposito di mistici, ricordami cosa diceva quel tuo Antonio da Alba Docilia sulla grande mietitrice». Lazzari pensò qualche istante prima di rispondere. «Che è come guardare il lato della vita non rivolto verso la luce». «È un pensiero rincuorante, almeno così mi va di intenderlo. Chissà che non finisca per diventare credente, un giorno o l’altro. Sì, sì, lo so, dubitare è credere, non c’è bisogno che me lo ricordi». «Professore...», attaccò Lazzari. «So perché sei qui», lo interruppe Casini. «Alla fine ti ha persuaso, quel Colonnello... Persona sgradevole, con tutte quelle sue certezze. Sì, sì, non fare quella faccia. Sono stato io a indicargli il tuo nome. Dimmi, piuttosto: Sono stato io a indicargli il tuo nome. Dimmi, piuttosto: come ha fatto a convincerti?» «Non mi ha lasciato scelta». «Sì, sì, è il loro modo», confermò Casini senza specificare a chi o a cosa si riferisse. «Perché gli ha fatto il mio nome?» «Mi hanno chiesto quale fosse, a mio parere, il più dotato tra i giovani studiosi che si occupano della fondazione di Roma. Soltanto dopo mi hanno spiegato le loro intenzioni. Mi dispiace, figliolo». «Non importa». «Sei qui per avere il mio consiglio?» «Sì», ammise Lazzari, che intanto pensava a come dare un minimo di senso ala domanda che si accingeva a fare. Sapeva, infatti, quanto Casini fosse suscettibile riguardo a certe derive sensazionalistiche di quella parte della storiografia sensibile alle tematiche esoteriche. Ma si fece coraggio. «Professore, sarò sincero... Lei sa per caso qualcosa a proposito di una setta che potrebbe custodire ancora oggi i segreti sulle origini dell’Urbe?» «Una setta?... Be’, so quello che mi raccontava il mio compagno di studi Umberto Parodi. O almeno, lo saprei se fossi stato ad ascoltarlo», rispose tranquillamente il professore, sorprendendo Lazzari. «I suoi genitori professore, sorprendendo Lazzari. «I suoi genitori avevano fatto i soldi con le macellerie. Ne avevano una dozzina nella sola Genova. Lui, però, aveva altre aspirazioni: si interessava di esoterismo, anche se non proseguì con la carriera universitaria. Invece divenne una sorta di antiquario, con la passione per le anticaglie e gli antichi segreti. Vive a Sarzana... sì, a Sarzana, in Liguria. A Natale ho ricevuto un suo biglietto. È vero che tre mesi sono molto tempo alla nostra età, ma secondo me è ancora vivo... Se vuoi informazioni su queste cose, lui è la persona che fa per te». «Domani stesso sarò a Sarzana». Cecilia entrò senza bussare. «Sono quasi le sette, la cena è in tavola professore». «Mi tiranneggia», sussurrò Casini. «La lascio, professore», disse Lazzari, e lo aiutò ad alzarsi. «Certo certo, ma aspetta ancora un minuto. Prima che te ne vada voglio raccontarti una cosa. Vedi questa pipa?», domandò Casini, e gliela agitò sotto il naso. «Sai, mio nonno si dilettava di archeologia... Forse ti avrò parlato di lui, partecipò negli anni Venti alle campagne di scavo sul Palatino. Durante quei lavori venne divelto un albero secolare, o millenario, se si deve prestar fede alle albero secolare, o millenario, se si deve prestar fede alle leggende locali. Mio padre, quando riferiva il racconto del nonno, sosteneva che si trattasse di un olivo, ma io preferisco credere che fosse un fico. In ogni caso, dal tronco di quell’albero mio nonno si fece intagliare questa pipa. Lui la diede a mio padre, mio padre a me e... Ecco», disse porgendogliela con un’occhiata enigmatica. «Per fumare non vale niente, ma è un buon cimelio. Ora è tua». Lazzari non finse di volerla rifiutare, ma la afferrò quasi con timore. Riuscì a dire soltanto: «Grazie». «Ti ho insegnato, vero, a leggere nella storia?» «Sì», mormorò Lazzari sorpreso. Il professore lo guardò negli occhi ancora alcuni istanti, prima di lasciare la presa sulla pipa. «Se ti capitasse di finire in un ginepraio, soffiaci dentro». «Comparirà una sorta di genio dela lampada?», domandò Lazzari. «No, no, ma ti trasformerai nel pifferaio magico e potrai menare le danze e condurre via i topi». «Grazie, di tutto», ripeté Lazzari, senza avere afferrato il senso di quella frase, ma intenzionato a non chiedere ancora spiegazioni. Forse la malattia aveva indebolito la mente di Casini. Si chiese se lo avrebbe indebolito la mente di Casini. Si chiese se lo avrebbe rivisto. Il professore lo trattenne per il gomito, e avvicinandoglisi sussurrò complice: «Sai qual è il vero segreto di Roma figliolo?». Lazzari avvertì le lacrime. Temendo che la voce gli si spezzasse, si limitò a scuotere la testa. Il professore sorrise. «Che dopo tremila anni, qualcuno se lo domandi ancora». Lazzari si gustò per qualche minuto l’atmosfera vespertina che cala sul centro di Milano dopo le sette, quando il traffico rifluisce, i pendolari ripartono, e in qualche modo si sa che il peggio è passato, e che il sonno o il vino metteranno a posto tutte le cose. Poi scese gli scalini che conducevano al quadriportico della basilica di Sant’Ambrogio, deciso a entrare. Le luci soffuse riscaldavano l’interno bianco e mattone della chiesa. Accese una candela pensando ad Achille Vento e poi si sedette su una panca in fondo, accanto al confessionale, mentre dal pulpito un sacerdote concludeva la propria omelia. «E così i discepoli di Emmaus avevano camminato a lungo fianco a fianco con Gesù, lo avevano ascoltato, ma non lo avevano inteso. E Gesù, lo avevano ascoltato, ma non lo avevano inteso. E quando finalmente lo riconobbero, lui sparì. Come diceva il tragico greco Eschilo: “gli uomini cercano Dio e nel cercarlo lo trovano”». Lazzari uscì durante la benedizione finale. Sentiva di aver con sé qualcosa in più, ma non riusciva a distinguere cosa fosse. Camminava su via Carducci, pensando a tutte le persone che nella vita lo avevano amato e a quanto poco lui avesse fatto per meritarsi il loro affetto, quando una Mercedes scura si accostò bruscamente al marciapiede. Una delle portiere posteriori si aprì di botto e un uomo in giacca e cravatta si sporse per chiamarlo. «Professor Lazzari, salga, presto!». Lazzari non l’aveva mai visto prima. Cominciò a scuotere la testa e a tremare, senza riuscire a trovare le parole. Lo sconosciuto allora si sbottonò la giacca mostrando una pistola. «Salga, professore, per il suo bene». Lazzari fece per muoversi, ma aveva le gambe di piombo. Proprio quando l’uomo dentro l’auto allungò la mano per afferrarlo, un fuoristrada scuro si accodò alla Mercedes senza rallentare e la speronò facendole fare un balzo in avanti di alcuni metri. Il rumore dell’urto e la pioggia di frammenti dei fanali Il rumore dell’urto e la pioggia di frammenti dei fanali scossero dal torpore Lazzari, che si mise immediatamente a correre, infilandosi nei vicoli dove le auto non potevano passare e pregando che le gambe non lo abbandonassero. Pareti di mattoni scorrevano rapide alle sue spalle. Rallentò solo quando non ce la fece più. Si mescolò ai passanti e scese verso piazza XXIV Maggio a passo sostenuto, saettando occhiate allarmate in giro. Il panico lo spinse a correre fino al palazzo dove aveva trascorso la notte. In casa non c’era traccia di Artemisia. «Abbiamo ricevuto una telefonata per lei da un certo Colonnello. Ha lasciato un messaggio. Ha detto che la attende a cena per le nove presso il ristorante Giacomo in via Sottocorno», gli riferì Cesar. «Artemisia dov’è?», domandò Lazzari che andava avanti e indietro lungo il salone in preda all’agitazione. Cesar mosse i muscoli facciali, cercando di assumere un’espressione adatta a quanto stava per dire, e con un cenno del mento gli indicò il ficus beniamino che stendeva i suoi rami frondosi tra le due finestre laterali del salone. «La signorina Artemisia mi ha detto di augurarle buon Natale». Lazzari si avvicinò alla pianta. I resti del biglietto che Lazzari si avvicinò alla pianta. I resti del biglietto che aveva lasciato alla ragazza pendevano come coriandoli e festoni dal ficus. «Merda», disse a denti stretti. «È anche passato un uomo e ha chiesto di voi», disse ancora Cesar. «Chi era?» «Non lo ha detto, e io non l’avevo mai visto prima... Un signore molto alto, con la barba, gli occhiali scuri e un cappello verde». 8 Il Colonnello sedeva al tavolo nascosto dietro la porta d’ingresso: da lì poteva controlare chi entrava senza essere visto. Fu il maître a indicarlo a Lazzari, che si avvicinò a grandi passi con la ferma intenzione di abbandonare l’incarico. Al fianco del Colonnello vide una ragazza che sembrava pronta per un red carpet. L’abito nero faceva risaltare braccia e collo scoperti. Aveva lunghi capelli sciolti, ma la voce, quando disse «Pensavo fossi andato a nasconderti in un buco», si rivelò quella di Artemisia. Le parole piene di rabbia gli morirono in gola. Cercò a tentoni la sedia alle sue spalle mentre prendeva posto. «Signori, arriverò immediatamente al punto», esordì il Colonnello sfregandosi le mani. «Il punto? Il punto è che qualcuno ci sta dando la caccia. Hanno tentato di rapirmi appena poche ore fa! E un bestione con barba e cappello ci sta dietro fin dall’inizio!», sbottò Lazzari, aggrappandosi al tavolo. I bicchieri di cristallo tintinnarono gettando riflessi I bicchieri di cristallo tintinnarono gettando riflessi iridescenti contro il mogano che rivestiva la stanza, simile al coro di una cappella barocca. «Questo è un corollario, non il punto, dottore», precisò il Colonnello senza scomporsi. «La questione centrale riguarda piuttosto la nostra missione, se così vogliamo chiamarla. Il Committente aveva previsto la possibilità che altri fossero sulle tracce del lituo. Ciò che però non aveva previsto era che la concorrenza desiderasse l’obiettivo almeno quanto noi e che fosse disposta a usare strumenti non proprio ortodossi per condurre in porto l’operazione». «Teme la competizione, Colonnello?», intervenne Artemisia, giocando con uno dei suoi orecchini. «Temo l’imprudenza e l’impreparazione», precisò il Colonnello spostando la lama del coltello verso il piatto. «E chi sarebbero questi concorrenti, come li chiama lei? Queli sulla Mercedes che hanno tentato di sequestrarmi? Lo sconosciuto con il cappello? Poche ora fa si è presentato nell’appartamento dove abbiamo dormito!», si intromise Lazzari. «Le informazioni sui nostri concorrenti sono riservate e per giunta non funzionali allo svolgimento del suo compito. A cosa le gioverebbe sapere il nome compito. A cosa le gioverebbe sapere il nome dell’agenzia che è entrata in competizione con noi?», fece il Colonnello con voce di ghiaccio. Poi in tono più morbido: «Ora ascoltatemi. Il mio compito è quello di consigliarvi per il meglio. E il mio consiglio è quelo di abbandonare la missione». Lazzari indicò la parete piena di bottiglie. «Dunque potrò tornare a casa? Potrò riavere la mia enoteca? Intendo senza debiti e fastidi burocratici?». Il Colonnello si pulì gli angoli della bocca con la punta del tovagliolo. «Farò in modo, per quanto è in mio potere, di riportare la sua vita al punto in cui si trovava due giorni orsono». «Per quanto è in suo potere? Che significa?», saltò su Lazzari. «Dottor Lazzari, mi stupisce. Dovrebbe sapere che non basta riportare il pedone indietro di due mosse, per garantirgli la salvezza. Nel frattempo si sono mossi anche gli altri pezzi». «Che cosa sta cercando di dirmi?» «Che se gli agenti della concorrenza venissero a cercarla, come temo, lei si ritroverebbe al di là della sfera della mia protezione». «Insomma, significa che quelli mi daranno comunque «Insomma, significa che quelli mi daranno comunque la caccia? Questo mi sta dicendo? Sono in ogni caso con le spalle al muro?» «Sono tutte parole inutili», intervenne Artemisia. Versò il vino nei bicchieri, alzò il suo per invitare a un brindisi, e bevve senza aspettare gli altri due. «Noi continuiamo. Eravamo a conoscenza degli eventuali rischi fin dal principio. Andremo avanti». Poi si rivolse al Colonnello: «Lei sa quello che deve fare». «Io devo mettervi in guardia». «Lo ha fatto». «Il Committente non gradirà», insistette il Colonnello. Artemisia si strinse nele spalle. «Non sarà né la prima né l’ultima volta». Lazzari si stupì per quell’improvviso cambio di ruoli, ma era troppo frastornato e spaventato per chiedere spiegazioni. Il Colonnelo posò i gomiti sul tavolo, chiuse una mano nell’altra e vi appoggiò contro il mento. Dopo alcuni istanti, aprì i pugni. «Signorina Della Rovere, io non ho detto che il Committente debba rinunciare in modo definitivo al progetto. Propongo semplicemente di organizzare una nuova squadra, con persone più idonee», disse marcando l’ultima parola. disse marcando l’ultima parola. «Persone idonee per cosa?», fece Lazzari. Artemisia, però, era già in piedi. «Non sentirò una parola di più». «In questo caso...». Il Colonnello infilò una mano nel soprabito, tirò fuori una grossa busta di carta marrone e la consegnò alla ragazza. «Dentro troverà le chiavi di un fuoristrada parcheggiato proprio nel vicolo qui dietro, quindicimila euro in contanti, un paio di carte di credito non riconducibili a voi, e due cellulari criptati di difficile identificazione. Le restanti disposizioni rimangono immutate». «Non ho affatto dato il mio assenso», fece Lazzari. «Lo darai per strada, andiamo», tagliò corto Artemisia e si avviò verso l’uscita. Gli sguardi dei clienti la accompagnarono fino alla porta, e solo quando il ticchettio delle scarpe scemò riprese quello delle stoviglie. «Lazzari, lei mi pare l’unico uomo presente in questa sala che non sia ansioso di seguirla». «Io sono ansioso solo di capire: prima ha voluto farmi intendere che se tornassi alla mia enoteca, gli uomini che hanno tentato di rapirmi oggi tornerebbero a cercarmi?» «Rapirla? Non sia drammatico. Intendono «Rapirla? Non sia drammatico. Intendono semplicemente proporle di lavorare per loro. Certo se rifiutasse, non so come la prenderebbero. Vuole scoprirlo?» «Mi sta ricattando in poche parole: se mi tiro indietro mi lascerà alla mercé di quegli uomini». «Di quei paramilitari, sì. D’altronde mi dica, perché dovrei proteggere un uomo che non lavora più per me? Se invece riuscirà a ottenere i risultati sperati, le assicuro che non avrà più di che preoccuparsi». Lazzari tenne gli occhi sulla tavola. Non aveva neppure avuto il tempo di ordinare qualcosa. «È tutto maledettamente assurdo, ma a quanto pare ancora una volta non mi lasciate scelta». «Non se ne pentirà, stia tranquillo», garantì il Colonnello. «La signorina Della Rovere mi ha confidato che lei ha individuato una pista. Mi pare di intendere che lei non ritiene più frutto di fantasia l’esistenza di una setta che custodisce dei segreti su Roma. C’è voluto un morto per convincerla. Ma si sa... è un difetto tipico degli uomini: solo la morte è capace di mostrare loro la verità». «Senta, non può dirmi nulla su questi paramilitari, come li chiama lei, che stasera hanno cercato di abbordarmi?», tornò ala carica Lazzari che non riusciva abbordarmi?», tornò ala carica Lazzari che non riusciva a toglierseli dalla testa. «Nulla che potrebbe giovarle, gliel’ho detto, però posso darle un’ultima informazione», disse il Colonnello tirando fuori un’agendina nera. «Achille Vento è stato ucciso dal Syn-ake, un veleno a base di siero di vipera». Lazzari lasciò cadere la forchetta che aveva allungato verso il piatto di Artemisia, in direzione del pesce che lei non aveva mangiato. «Oh merda». «Che cosa ho detto?», domandò il Colonnello. «La scelta del veleno di vipera non può essere casuale. Ha senza dubbio a che fare con la poena cullei, la “pena del sacco”. Il condannato a morte veniva infilato in un sacco di cuoio insieme a una vipera, un cane, un gallo e una scimmia e poi gettato nel Tevere. Un supplizio terribile, riservato solo ai crimini maggiori, come il parricidio per esempio. Secondo le fonti antiche la introdusse il re Tarquinio per punire il decemviro Atinio, colpevole di aver divulgato alcuni riti sacri. Ci pensi bene... proprio quello che si proponeva di fare Achille Vento». «Ha visto? Grazie a me sta camminando per le strade dell’antica Roma». «Ma a questo punto, non crede sarebbe il caso di «Ma a questo punto, non crede sarebbe il caso di informare la polizia?» «Queste informazioni mi sono arrivate proprio da loro», rispose con aperta ruvidezza il Colonnello. «E mi permetta di chiarire un punto su cui forse non sono stato sufficientemente chiaro. Lei non si rivolgerà mai, e sottolineo mai, alla polizia. Per nessun motivo. Sarò io a occuparmi di tutto, compresa la sua protezione. La riservatezza dell’intera operazione deve essere garantita a ogni costo. Non sto a dirle quale sarebbe la mia reazione nel caso disubbidisse a quest’ordine. È chiaro?». Lazzari annuì. «Mio padre mi ha insegnato che le cose funzionano quando ciascuno svolge il proprio compito. Lei cerchi di portare a termine il suo. Alla sua incolumità penserò io». «Deve averle insegnato molte cose suo padre». Il Colonnello lo studiò per cogliere una qualche ironia, e quando fu certo di non trovarne, disse con voce perentoria: «Una su tutte, che la pregherei di rammentare. La chiamava la regola d’oro del mondo moderno. Diceva sempre che il bravo venditore vende il suo prodotto, ma quello eccezionale riesce a vendere due volte lo stesso prodotto». Trovò Artemisia appoggiata all’auto. Evidentemente doveva essere sicura che la avrebbe raggiunta. Gli lanciò le chiavi e salì dietro. «Guida tu, intanto io mi cambio». Lazzari entrò e sbatté la portiera con rabbia, intenzionato a mostrare tutto il suo fastidio. «Pensi che sappia dove diavolo dobbiamo andare?» «Non lo penso, l’ho visto». «E dove? Nella sfera di cristallo?» «Ce l’hai scritto in faccia». Artemisia si sfilò il vestito rimanendo in mutande e reggiseno. Lazzari distolse lo sguardo dallo specchietto, ingranò la prima e partì. Era troppo stanco, e di colpo affamato, per alimentare la propria rabbia. «Per caso hai letto sulla mia faccia anche il nome preciso del luogo dove intendo andare?» «Piantala... Tu, piuttosto, hai visto in volto quelli che secondo te avrebbero cercato di rapirti?» «Sì, certo che li ho visti, ma non li conoscevo. Hai sentito il Colonnello: secondo lui erano uomini di un’agenzia concorrente», disse Lazzari. «Paramilitari». «Non sei contento? Tutti ti cercano». «A quel disgraziato di Vento hanno fatto ingerire siero di vipera: abbiamo a che fare con pazzi che credono di vivere nell’antica Roma». credono di vivere nell’antica Roma». Artemisia si intrufolò tra gli schienali e prese posto al suo fianco. Indossava dei pantaloni chiari e un ampio cardigan sopra una T-shirt bianca. «Il Colonnello penserà a proteggerci, noi concentriamoci sull’obiettivo. Dove si va?». Lazzari assestò una manata al volante e sbuffò. «Al mare», rispose secco. «Andiamo a trovare un esperto di sette antiche. Forse lui può aiutarci a capire chi siano davvero gli uomini che hanno ucciso Vento e magari fornirci qualche indizio per rintracciarli. So che è una pazzia, ma non saprei proprio da dove altro ripartire». Artemisia gli passò una mano sulla testa. «Che fine hanno fatto i tuoi capelli anni Settanta?» «La stessa fine del mio cervello...». Percorsero i viali interni della città e imboccarono l’autostrada alla barriera sud di Milano. Gli sbadigli di Lazzari erano sempre più ravvicinati e profondi. «Vuoi che guidi io?», gli domandò Artemisia. «Al prossimo autogrill». Nell’area di sosta, sotto i cartelloni pubblicitari illuminati, i camion erano parcheggiati gli uni accanto agli altri, come auto in un drive in. Il locale era deserto, ma caldo. Bevvero un caffè doppio a testa e ripartirono. caldo. Bevvero un caffè doppio a testa e ripartirono. «Pensavi che fosse tutta una pagliacciata, vero? Non ti aspettavi che la setta esistesse realmente e che fosse pronta a uccidere», disse Artemisia dopo qualche chilometro. Lazzari aprì un occhio. Senza rendersene conto si era addormentato. Si sentì a disagio pensando che lo avesse sentito russare. In fondo lei era una perfetta estranea. Si stirò cercando una posizione per alleviare i dolori alla schiena e mosse il collo avanti e indietro, inspirando ed espirando come gli aveva spiegato l’osteopata. «Sapevo che esisteva nei tempi antichi e che ne facevano parte gli uomini dell’epoca, ma francamente credevo fosse scomparsa molti secoli fa, al più tardi con la caduta di Roma». «Roma», ripeté Artemisia. «Perché non mi racconti della sua fondazione?» «Non saprei da dove partire». «Parti da Romolo e Remo». «Dovresti dire Remo e Romolo, allora. I romani citavano sempre Remo per primo; era lui il primogenito». «Non vorrai dirmi che sono esistiti davvero?» «Esiste Roma ed esiste la loro leggenda. Possono cambiare i fattori, ma non il risultato finale». cambiare i fattori, ma non il risultato finale». «Ma tu mi hai detto che ci sono tante varianti della stessa leggenda». «Io credo che ne esista una originale, ed è quella incentrata sul cosiddetto “nucleo albano”, su cui poi sono fiorite le altre narrazioni. I primi racconti greci sull’argomento, ad esempio, risalgono al settimo secolo avanti Cristo. Esiodo racconta che Ulisse e Circe, genitori di Latino e Fauno, da un luogo nell’entroterra del Lazio, verosimilmente Alba, governavano sui tirreni, nelle Isole dei Beati. Stesicoro ed Ellanico, di poco posteriori, raccontano di Enea in Italia. Tutti questi elementi vanno ad aggiungersi e a incrostare la narrazione originaria di Remo e Romolo». «Ieri mi accennavi di Silvia, la madre dei gemelli. È una figura che mi piace... vergine e madre». Lazzari sospirò, in fondo era un modo per non pensare al cadavere di Vento e agli uomini che forse gli stavano dietro. «Silvia era la figlia di Numitore, che era stato re di Alba prima che suo fratello Amulio gli portasse via il trono. Amulio, quando divenne re, costrinse Silvia a diventare sacerdotessa di Vesta. Le Vestali custodivano il fuoco sacro di Vesta, che non doveva mai spegnersi, perché simboleggiava la doveva mai spegnersi, perché simboleggiava la perennitas del patto tra uomini e dèi. Un giorno Silvia era al torrente per attingere l’acqua necessaria alla pulizia degli arredi sacri ma si addormentò e fu presa da un dio, forse Marte». Artemisia sorrise. «Presa?» «Ovidio scrive esattamente: “vista, la bramò. Bramatala, la possedette”». «Non male». «La poesia o la situazione?», scherzò Lazzari, cercando di leggere l’espressione della ragazza nella penombra rischiarata a intervalli dai fari. Artemisia non lo deluse. «La situazione». «Peccato che se una Vestale rimaneva incinta doveva subire la condanna di essere sepolta viva. Agli occhi di Amulio la sua colpa era addirittura doppia, perché i suoi figli avrebbero potuto reclamare il trono di Alba, un giorno. Amulio pertanto ordinò l’uccisione degli infanti. Però i servi, impietositi, li abbandonarono sulle rive del fiume Albula». «Che è il vecchio nome del Tevere, ricordo bene?». Lazzari annuì. «Si chiamava Albula perché era bianco o forse perché scorreva attraverso Alba. Secondo altre interpretazioni, invece, il Tevere era Secondo altre interpretazioni, invece, il Tevere era originariamente chiamato Rumon, che deriverebbe da ruo, “scorrere”». «Lascia perdere il Tevere», disse Artemisia pentendosi di averglielo domandato. «Poi che accadde?» «La cesta viaggiò per chilometri e infine si incagliò davanti a una grotta, che poi sarà detta Lupercale, presso il colle Cermalus, dove i due neonati vennero tratti in salvo e allattati sotto il fico ruminale dalla lupa. Fu lì che li trovò il pastore Faustolo, che li portò a casa dalla moglie Acca Larenzia. Questa Acca secondo alcune versioni era una prostituta e secondo altra una dea». «E poi?» «E poi crebbero, un po’ pastori e un po’ briganti. Quando compirono diciassette anni e scoprirono la loro vera identità, mossero guerra ad Amulio, lo uccisero e rimisero sul trono di Alba loro nonno, Numitore. Poi decisero di fondare una città proprio nel punto in cui erano stati salvati dalle acque». Artemisia suonò il clacson all’indirizzo di un camion che occupava la corsia di sorpasso. «Continua, mi interessa». «I gemelli decisero di affidarsi al volere degli dèi per sapere a chi dei due spettasse il diritto di fondare l’Urbe», riprese Lazzari in modo affannato, sempre tenendo d’occhio la strada. «Remo vide per primo un uccello, o sei secondo altre fonti; Romolo, anche se in un secondo tempo, scorse dodici avvoltoi e pertanto primeggiò. Dopo aver inaugurato la città, Romolo scavò sulla cima del Cermalus la fossa della fondazione per deporvi dele primizie e vi fece edificare un’ara, su cui accese un fuoco nuovo e puro». «Perché?» «Ogni città doveva avere il proprio: rappresentava il legame con gli dèi. Quindi soffiò nel lituo, il bastone cerimoniale che era anche una sorta di piccola tromba ricurva, e proferì i nomi della città: per primo quello vero e segreto, e solo dopo quello di facciata, ossia Roma. Poi tracciò alla radice del monte il solco primigenio, dove successivamente avrebbe fatto costruire le mura». «E Remo?» «Remo, pieno di collera, scavalcò il solco e il pomerium, il sacro limite, violando la sanctitas del luogo e così il gemello lo uccise». «Una brutta fine, ahimè», commentò Artemisia. «E quanto al nome che hai definito di facciata? Roma deriverebbe da Romolo?» «Se ne discute da secoli. Secondo alcuni linguisti è «Se ne discute da secoli. Secondo alcuni linguisti è vero il contrario, ossia che il nome Romolo deriva da Roma. Il suffisso -ulus avrebbe un valore etnico, o addirittura indicherebbe un rapporto di filiazione: come a dire il romano o il figlio di Roma». «Ma tu non la pensi così...». «Come fai a saperlo?» «Perché mi sono accorta che ti piace sempre esprimere il parere altrui, prima del tuo». «Un corrispettivo gentilizio etrusco del nome Romolo è attestato su una lapide del sesto secolo avanti Cristo: il nome dunque esisteva». Artemisia lampeggiò a un’auto, che ritornò prontamente nella corsia di destra. «Ma insomma, il nome “Roma” cosa significa? Almeno questo lo sappiamo?» «No, nemmeno questo. Per alcuni deriva da ruma, ossia “mammella”, che potrebbe essere quella della lupa che allattò i neonati oppure la forma del Palatino. Ricordi che ti dicevo che le cime arrotondate e gemelle del Palatium e del Cermalus formavano due seni? Per altri proviene da Rumon, il nome etrusco del Tevere». «Questa è la leggenda, ma la storia?» «E chi ti ha detto che non siano la stessa cosa?» «E chi ti ha detto che non siano la stessa cosa?» «Be’, pensavo...». «Lo hanno pensato tutti, almeno fino a quando gli scavi non hanno cominciato a parlare. Sul Palatino sono stati trovati reperti dell’ottavo secolo compatibili con il rituale di fondazione descritto dalle fonti: le capanne romulee, le mura, la fossaara di fondazione...». Artemisia non riusciva ad arrestare le domande. «Ma perché...». «...non rallenti?». Erano fissi sui centoventi all’ora da un pezzo e la pianura nera scorreva ai loro lati come un tappeto volante. «Ma perché fondarono la città proprio il ventuno aprile? Mio padre se lo domanda spesso». «Tuo padre?» «Rispondi alla mia domanda». Lazzari annuì. «Perché in quel giorno cadevano i Parilia, una festa pastorale dedicata alla dea Pale. Era una solennità a carattere purificatorio: il rito che si compiva era incentrato sugli elementi di acqua e fuoco e prevedeva prima la lavatura degli stalli e poi l’accensione di un fuoco su cui preparare la mola, una sorta di salsa di cui si cospargevano le vittime dei sacrifici. Quell’anno avvenne nella notte di plenilunio successiva all’equinozio avvenne nella notte di plenilunio successiva all’equinozio di primavera». Artemisia era perplessa. «Che strana scelta...». «Non così strana, se è vero che fu fatta allo stesso modo anche da un altro popolo, per una festa straordinariamente simile, e da un altro uomo per portare a termine la sua missione». «Ma di che stai parlando?» «Della Pasqua ebraica e di Gesù». 9 Sarzana si presentò con il volto di un borgo medievale e onirico: Lazzari avrebbe potuto attraversarla a cavallo da una porta all’altra senza il timore di essere svegliato dal sogno che lo faceva vivere nel dodicesimo secolo. Si erano fermati verso le due e avevano dormito in auto qualche ora, prima di ripartire. Adesso l’orologio del palazzo comunale segnava le sette e trenta. «Non credi sia un po’ presto per citofonare?», gli domandò Artemisia. La casa di Parodi si trovava nel centro storico della cittadina ligure. La piazza era semideserta. Un uomo tirava su la serranda del bar all’angolo, qualche piccione pigolava sotto la torre. I lampioni ancora accesi erano evanescenti. «I vecchi non dormono ed escono presto la mattina. Vogliono assicurarsi che ci sia ancora il mondo reale fuori», disse Lazzari e suonò. «Ultimo piano». Una voce metallica rispose al «Ultimo piano». Una voce metallica rispose al citofono dopo appena una manciata di secondi. Lazzari strizzò l’occhio alla ragazza e spalancò il portone per farla entrare. Non c’era ascensore e i gradini di marmo erano scivolosi e incurvati al centro. Lazzari saliva tenendosi al corrimano osservando ipnotizzato le caviglie di Artemisia. Pensò che sarebbero state bene sopra un palco. «Prima riflettevo su quello che mi hai detto sulla fondazione di Roma e sulle somiglianze con la Pasqua», gli disse la ragazza dopo la prima rampa. «E allora?» «Ce ne sarebbe anche un’altra. Remo fu ucciso subito dopo la fondazione, giusto? Ed era il primogenito, vero? Ebbene, nella Pasqua non era il primogenito a essere consacrato? O ricordo male?» «Durante la Pasqua ebraica Dio uccise tutti i primogeniti, eccetto quelli sulla cui porta di casa trovò il sangue dell’agnello. Nella Pasqua cristiana viene ucciso Gesù, primogenito di Dio. Hai occhio per le analogie». «Ma come si spiegano?» «Semplice, non si spiegano». Erano arrivati in cima. C’era una sola porta e un lucernario che illuminava una scala di ferro che lucernario che illuminava una scala di ferro che conduceva alla soffitta. Venne ad aprire un uomo vestito in maniera impeccabile: completo e cravatta. «Vi aspettavo, ma non così presto». «Ci scusi per l’ora», disse Artemisia dando una leggera gomitata a Lazzari, che aveva il fiatone e si limitò ad annuire. L’uomo colse il gesto e sorrise. «Non per l’ora, signorina, ma per il giorno. L’amico Casini mi ha solo accennato al fatto che mi avreste fatto visita, senza specificare quando. Ma prego, entrate. Ogni momento è buono per parlare di cose belle». Li fece accomodare in un ampio salone scandito da basse volte ogivali. Gli archi erano in mattoni. Spessi strati di vernice mascheravano le tracce di umidità. C’erano molti pezzi antichi sparsi in giro e libri miniati su elaborati leggii. Lazzari avanzò a piccoli passi calibrando ogni mossa fino a che raggiunse la poltrona accanto al camino in ardesia, dentro il quale c’era una quadriga in bronzo. «A proposito, come sta quel terribile vecchio?». Parodi parlò come se avesse vent’anni in meno, mentre il professor Casini aveva detto a Lazzari che erano della professor Casini aveva detto a Lazzari che erano della stessa leva. A vederlo, però, Lazzari non gli avrebbe dato più di settant’anni. Sedeva con i gomiti sulle gambe, leggermente proteso in avanti, offrendo un’impressione di vigore fisico. Pareva ancora capace di saltare su una bicicletta per fare il giro del paese. Senza attendere la risposta Parodi proseguì: «Casini... Chi l’avrebbe mai detto che avrebbe fatto una sì ragguardevole carriera, scorbutico com’era». «La saluta caramente», disse Lazzari. Parodi sorrise come se non ci credesse e disse: «Avete dormito dentro le mura? Il tramonto e l’aurora sono i momenti migliori per una visita. Città incantevole, siete d’accordo? Confesso che quando l’ho scelta, ormai quarant’anni fa, avevo in mente solo l’annuale fiera antiquaria, forse la più importante d’Italia. Invece, una volta qui, la cosa che mi ammaliò più di ogni altra fu la cadenza della parlata, specie delle ragazze, una lingua languida, morbida. Per trentacinque anni ne ho sentita una particolarmente deliziosa ogni giorno, ma poi lei ha deciso che non ne poteva più di me, e così mi ha preceduto sula via dei Campi Elisi. Ma non è di questo che volevate parlarmi, o sbaglio?». che volevate parlarmi, o sbaglio?». Lazzari inspirò, come se si preparasse a un tuffo, e gli porse la fotografia che Artemisia aveva fatto stampare il giorno prima – una mossa che lui aveva molto apprezzato. «Non c’è neppure bisogno che io indossi gli occhiali per riconoscere questo simbolo», rivelò Parodi picchiando le dita nodose contro l’istantanea del tatuaggio di Achille Vento. «Dove l’avete trovato?» «Sul petto di un uomo», disse Lazzari. «Un uomo morto», precisò Artemisia. Parodi batté gli occhiali contro la foto mordendosi le labbra. «Sì, è il genere di uomo più diffuso tra chi si interessa di questi simboli arcani. Come si chiamava?» «Achille Vento». «Mai sentito. Come è morto?» «Non so se è il caso...». «Si può fidare di me. In un certo senso, i segreti sono il mio mestiere». «Prima devono averlo picchiato e poi gli hanno fatto ingerire del veleno. L’abbiamo trovato sul pavimento di casa sua: era disposto a croce e sopra di lui c’erano le iniziali scritte con il sangue della formula Sacer esto», raccontò Lazzari. «È terribile, terribile», fece Parodi con una smorfia di «È terribile, terribile», fece Parodi con una smorfia di disgusto. «Ma purtroppo molti hanno fatto la sua stessa fine nel corso dei secoli». «Allora questo simbolo appartiene davvero a una setta?», gli domandò Artemisia indicando la foto. «A una confraternita, più che a una setta», tenne a precisare Parodi e le restituì l’istantanea. «Una confraternita che custodisce da quasi ventinove secoli il segreto riguardante le origini di Roma. Uno dei più affatturanti misteri della storia universale, a cui si sono interessati illustri personaggi. Pensate a Pascoli, Goethe e Dante per citarne soltanto alcuni dei più noti... Ma lei lo sa bene, vero?», disse rivolto a Lazzari. «Alcuni sono caduti in questa ricerca. Il grande Poliziano, ad esempio, cercò a lungo il vero nome di Roma, ma proprio quando era vicino a scoprirlo, morì assassinato in circostanze misteriose. Forse la Confraternita...». «Sapevo che se ne era interessato, ma non che fu assassinato», disse Lazzari, di colpo diffidente. Era prevenuto verso tutto ciò che aveva il sapore del complotto, e non vedeva l’ora di trovare un appiglio nel discorso di Parodi a cui aggrapparsi per dirsi che erano tutte stupidaggini sensazionalistiche. Ma mentre lo ascoltava, non riusciva a togliersi dagli occhi il cadavere ascoltava, non riusciva a togliersi dagli occhi il cadavere di Vento, il tatuaggio e la scritta col sangue. Quelle non erano invenzioni, come non lo erano gli uomini che avevano cercato di rapirlo a Milano. «È un segreto che ha mietuto numerose vittime», riprese Parodi. «Potrei citarvi vari esempi, ma il più affine al caso di questo Achille Vento è quello di Quinto Valerio Sorano. Credo che lei sappia di chi sto parlando». Lazzari annuì vagamente: aveva deciso di starlo a sentire senza intervenire, come uno straniero che finga di non conoscere la lingua locale e ascolti l’indigeno per vedere se intende raggirarlo. «Questo Valerio Sorano era un uomo dottissimo, filologo e antiquario, spesso citato da Cicerone e Varrone, che avevano più o meno la sua stessa età. Ma anche più tardi lo si trova citato in Agostino e Aulo Gellio, e persino nel buon Servio Mario Onorato, uno che copiò da tutti e scrisse di tutto. Nell’ottantadue avanti Cristo Sorano fu eletto tribuno della plebe, ma il Senato lo fece rapire e crocifiggere per alto tradimento con un giudizio post mortem, poiché aveva tentato di divulgare i segreti sula fondazione di Roma. La procedura sommaria, cui fu sottoposto un tribuno della procedura sommaria, cui fu sottoposto un tribuno della plebe, per di più in un periodo in cui il tribunato godeva di grande forza, significa che il reato fu il più grave che fosse immaginabile, forse il più grave di tutta la storia di Roma». «Ma qual era il potere di questi benedetti tribuni?», domandò Artemisia. «Avevano il diritto di veto su tutti gli organi repubblicani», spiegò frettolosamente Lazzari, prima di giocare la sua carta. «Conosco la vicenda. Servio scrive che Sorano rivelò il nome segreto di Roma». «Non apertamente. Sorano era pur sempre un romano, e nessun romano avrebbe commesso un simile sacrilegio. Scrisse in realtà un libro intitolato Epoptidon, che significa “Svelamento”, in cui trattava velatamente i segreti riguardanti le origini dell’Urbe. Secondo Agostino, scrisse tra le altre cose che Iuppiter e Iuno sono in sostanza la stessa divinità, in quanto il vero Dio è uno soltanto, maschio e femmina nello stesso tempo». «Intende Giove e Giunone, vero?», domandò Artemisia. «Proprio così», rispose Parodi. «Il linguaggio e l’argomento dell’Epoptidon, con le allusioni al monoteismo, fanno riferimento ai culti misterici del monoteismo, fanno riferimento ai culti misterici del periodo, come quello degli orfici, che credevano in un unico Dio e nella risurrezione dei morti. Oh, cosa non darei per leggere quel volume, altro che Libro dei morti o scempiaggini simili. Ma, ahimè, Sorano fu ucciso e il libro fatto sparire. Però anche lei sa bene che...». E si interruppe, quasi si aspettasse che Lazzari proseguisse. «Che cosa?», fece con aria interrogativa. «Che nessun libro, una volta letto, può sparire», terminò Parodi. «La trasmissione orale...», mormorò Lazzari, abbassando gli occhi verso il pavimento di marmo nero. «Sorano faceva certamente parte della Confraternita che custodiva la verità sul nome di Roma, una ristretta cerchia di potenti e dotti che si tramandavano oralmente il segreto fin dal giorno della fondazione. Una confraternita – ho ragione di credere – che fu costituita dagli stessi gemelli e dai loro compagni. Fu questa confraternita segreta a decretare la morte per crocifissione di Sorano». Lazzari gli chiese a bruciapelo: «Dunque lei deve essersi fatto un’idea precisa...». «Di quale idea parla?», si schermì l’uomo. «Di quella che sento premere sotto le sue parole». «Di quella che sento premere sotto le sue parole». Parodi sorrise, come un giocatore il cui bluff è stato infine scoperto e, anziché dispiacersene, se ne compiace. «È molto probabile che quel segreto sia stato tramandato fino ai nostri giorni, e che sia sopravvissuto alla caduta di Roma. Ma le dirò di più. Sono convinto che sia possibile recuperare brandelli dell’Epoptidon». «Ah sì?», fece Lazzari tradendo con la voce il proprio scetticismo. «I morti possono parlare». «Che intende dire?», domandò Artemisia. Parodi annuì, poi si alzò. «Aspettatemi qui». Artemisia abbassò la voce, ma indurì il tono. «Perché gli parli con questo tono di sufficienza? Ci sta aiutando». «Non hai capito nulla. Siamo noi che stiamo aiutando lui. È tutta la vita che non vedeva l’ora di raccontare queste teorie a qualcuno». «Il cadavere di Vento è una teoria?», ribatté Artemisia, infilando il dito nella piaga. Lazzari si alzò per guardare fuori. Due campanili e una torre medievale punteggiavano l’orizzonte. Nella via sottostante una ragazza fumava una sigaretta davanti a un negozio. Poi alzò per un attimo lo sguardo, lo vide, e agitò una Poi alzò per un attimo lo sguardo, lo vide, e agitò una mano. Lui le fece un cenno con la testa. Doveva averlo scambiato per qualcun altro. Si voltò nell’udire i passi di Parodi, che era ritornato stringendo tra le mani un ciondolo. Si trattava di un disco, grande circa il doppio di una moneta. Si avvicinò a entrambi e mostrò loro l’incisione: era il fico ruminale tra due seni, o collinette. L’immagine, non nitidissima, era però ancora ben riconoscibile. Artemisia balzò in piedi. «È identico al tatuaggio!». «Questo arriva da un complesso di tombe, solo parzialmente scavate, nei pressi di Formia», spiegò Parodi. «Il tombarolo che me l’ha venduto è uno dei migliori sulla piazza: lo chiamano il Lupo Marsicano». «Perché quel soprannome?», domandò Artemisia. «Per il suo fiuto nel rintracciare tesori sepolti. L’Italia sotterranea non ha segreti per lui. Ha scavato ovunque, e portato alla luce oggetti greci, etruschi e romani per svariati milioni di euro nel corso della sua carriera». «Presso Formia? Sta parlando di quella che viene comunemente chiamata la “tomba di Cicerone?”» «Nient’affatto. Parlo di tombe che non vedrete mai su un manuale di archeologia. Lei sa meglio di me che soltanto una piccola parte dei reperti rinvenuti in Italia, soltanto una piccola parte dei reperti rinvenuti in Italia, come nel resto del mondo, finisce nei musei». «Quali altri oggetti erano contenuti in questo complesso di tombe?» «Non lo so. Per mio conto, non ho voluto che il Lupo scavasse ancora. Se lui è comunque andato avanti, affari suoi. Ma non credo. Ne abbiamo viste troppe, per non tenere nella giusta considerazione il peccato di hýbris». Artemisia solevò un sopracciglio. «Che cosa intende?» «Superstizione, solo superstizione...», si inserì Lazzari contrariato. Parodi glissò su quella stoccata e rispose ad Artemisia. «La hýbris era considerata dagli antichi greci e latini la colpa massima e consisteva nel violare le immutabili leggi divine. La sua naturale conseguenza è la némesis, ossia il giusto castigo. Violare il nome segreto di Roma è hýbris, amici miei. I misteri sulla fondazione di Roma mi hanno sempre affascinato, ma preferisco guardarli da distante. Seguo il saggio consiglio di Angerona». «Chi è Angerona?», domandò Artemisia. «La dea latina che invitava al silenzio. La sua festa si «La dea latina che invitava al silenzio. La sua festa si celebrava il ventuno dicembre presso il sacello sul Palatino. Il simulacro della dea, depositaria del segreto sul nome autentico di Roma, era rappresentato con la bocca fasciata e con un dito sulle labbra, a suggelare il silenzio e imporlo. I misteri vanno custoditi», salmodiò Parodi. Sembrava di colpo assente, come se l’età o il pensiero della morte l’avessero improvvisamente raggiunto. Artemisia, invece, era tutt’altro che intimorita. «Secondo me questo tombarolo ha comunque continuato gli scavi. Intendo per conto suo», insistette, cercando conferma in Lazzari con lo sguardo. «Si è dimenticato di dire che, secondo l’oroscopo commissionato da Varrone al celebre astronomo romano Lucio Tarunzio, Romolo fu concepito proprio il ventuno dicembre», lo sfidò Lazzari, non riuscendo a trattenersi, ma Parodi ancora una volta non raccolse la provocazione. «Dobbiamo assolutamente incontrare questo Lupo», tor nò alla carica Artemisia. Parodi li studiò entrambi, infine liberò un sospiro che sapeva di resa. L’ombra di poco prima era scomparsa dal suo volto, ora placido e cortese come in principio. dal suo volto, ora placido e cortese come in principio. «Posso mettervi in contatto con il Lupo, ma mi occorrono almeno un paio di giorni. Devo fargli avere il messaggio e poi ottenere un suo riscontro. Ci sono delle consolidate procedure di sicurezza da seguire. È un professionista assai prudente, mai un passo falso. Due giorni, se saremo fortunati». Artemisia annuì. «Perché non dovremmo esserlo?». 10 Quando scesero, capannelli di persone punteggiavano la piazza trapezoidale: i brusii correvano tra di loro come da cavi elettrici difettosi. Dai bar usciva odore di caffè tostato, cornetti e pane abbrustolito. Il sole scaldava il selciato, ma l’aria era fredda e le montagne all’orizzonte non sembravano poi tanto lontane. «A quanto pare abbiamo due giorni da far trascorrere... Ci sarebbe una casa a Paraggi, dove possiamo rilassarci nell’attesa», disse Artemisia. Lazzari volse le spalle alla piazza e si incamminò in direzione del parcheggio dove avevano lasciato l’auto. «Un’altra casa di un tuo amico? Non ci penso nemmeno. Non voglio rimanere in nessun luogo troppo a lungo. Andiamo a pranzo». «Sono le dieci del mattino», fece Artemisia, a cui erano bastati pochi passi per raggiungerlo. «Andiamo a pranzo a Bologna. Conosco qualcuno che può raccontarci quanto è davvero capitato a che può raccontarci quanto è davvero capitato a Poliziano». «Mi era parso di intuire che non credessi alla possibilità che siano stati quelli della Confraternita ad assassinarlo...». «Non lo so più che cosa credo». «Ma perché pensi che sia importante per la nostra ricerca?» «Se davvero avessero ucciso Poliziano perché era arrivato a scoprire il nome segreto di Roma, avremmo un anelo di collegamento tra l’omicidio di Sorano e quello di Vento, una prova in più che la Confraternita è sopravvissuta nei secoli». «Non ci basta sapere che esiste ancora oggi?» «Non capisci? Se la Confraternita non ha mai cessato di esistere, significa che forse davvero custodiscono ancora il lituo!». «Ascolta, so che me ne hai già parlato, ma in concreto cos’è questo lituo? Io non l’ho ancora capito». «Hai presente il vincastro del pastore?» «No». «Il pastorale del vescovo?» «Sì, certo». «Ecco, è molto simile». «Ecco, è molto simile». «Quindi era...». «Un bastone». «Tutto qui?». Lazzari indicò in alto. «Un bastone capace di dividere il cielo». «Che significa dividere il cielo?» «Non puoi capire rimanendo qui». «Che vorresti dire? Che dovrei fare?». Lazzari indicò i boschi sullo sfondo. «Immagina di essere sul Cermalus quel fatidico ventuno aprile. Il rito di fondazione deve essere perfetto per garantirti l’imperium, ossia quello che noi definiremmo l’imprimatur di Giove. Pertanto la futura Urbs viene effata, ossia definita, liberata da eventuali numina, e inaugurata». Artemisia lo prese per mano e lo obbligò a fermarsi. Erano a cinquanta metri dall’auto. «Per me è arabo». «Sono termini del linguaggio sacerdotale. Remo e Romolo, come principi albani, erano àuguri per diritto divino, vale a dire interpreti del volere celeste. Quella mattina, per prima cosa, il fondatore contemplò il cielo, ovvero con il lituo in pugno ne circoscrisse una porzione che diventò sacra. Contemplare, in latino arcaico, che diventò sacra. Contemplare, in latino arcaico, significa appunto dividere, circoscrivere il cielo ed è un verbo formato da cum e templum, che a sua volta deriva dalla radice indoeuropea tem, che esprime il senso di tagliare. Dala stessa radice provengono anche i termini greci temno, taglio, e Temenos, il recinto sacro alla divinità». «Non ti seguo». «Ascolta, la faccio semplice. Romolo con il lituo segnò in cielo i confini di un tempio: i corrispondenti limiti terrestri diventavano allo stesso modo sacri. Capisci?» «Più o meno». «Per fare ciò erano necessarie due cose, tanto semplici quanto onnipotenti per i romani: il lituo e la parola. Le fonti parlano di effari templa, un’espressione del lessico augurale che significa stabilire il tempio mediante la potenza della parola rituale, che per i romani è sempre creatrice. La parola crea. Quindi grazie al lituo e alle formule rituali, Romolo creò un tempio in cielo e uno corrispondente sul Palatino, chiamato auguraculum, ma anche tescum, calvaria, inteso come luogo del cranio, perché doveva essere necessariamente spoglio, libero da qualsiasi presenza». «Perché non mi è nuovo questo nome?» «Perché non mi è nuovo questo nome?» «Perché l’hai già sentito, almeno qualche volta. Forse è un’altra semplice coincidenza, ma il luogo in cui fu crocifisso Gesù è detto Calvaria in latino e Golgota in aramaico. Il significato è il medesimo: luogo del cranio». «C’è di che uscire pazzi». Lazzari passò oltre. «L’augure compiva tutte le operazioni rituali con il lituo, un bastone ricurvo, simile appunto a un pastorale, che non doveva avere nodi, perché al suo interno si incanalava la potenza divina, che non conosce ostacoli. Il termine lituo pare derivare dal verbo litare, che significa “ottenere un presagio favorevole”, ma anche “propiziare un nume”». «Aspetta un momento, ieri mi avevi detto che il lituo è una tromba». «Hai ragione, era anche una tromba rudimentale: era infatti cavo all’interno, con un’imboccatura per soffiare. Dopo l’ inauguratio, Romolo soffiò nel lituo e proferì i nomi della città: prima quello di copertura, ossia Roma, e poi quello segreto e vero. Scavò una fossa-ara, accese un fuoco e concluse con una preghiera a Giove, Marte e Vesta. Ségnati questi due ultimi nomi, perché prima o poi finirà che mi domanderai anche di loro». «Non ne vedo il motivo». «Lo vedrai tra breve». «Lo vedrai tra breve». «E che ne è stato del lituo?» «Fu conservato per secoli nella Curia dei Salii sul Palatino, che era anticamente connessa alla Regia. I Salii erano un collegio sacerdotale consacrato a Marte. È molto interessante il fatto che i Salii...». «Il lituo, Lazzari!». «Certo, hai ragione. Be’, Cicerone scrive che il lituo sopravvisse incolume a un incendio che bruciò l’intero edificio all’epoca dell’invasione dei galli di Brenno, che mise a sacco la città: gli antichi calendari romani in nostro possesso riportano la notizia che il lituo fu ritrovato intatto il ventitré marzo», spiegò Lazzari, intimamente dispiaciuto per non aver potuto raccontarle dei Salii. «Intorno al cento avanti Cristo un certo Lutazio Catulo, uno dei più ricchi politici dell’epoca, acquistò il terreno adiacente a quello dove Romolo aveva scavato la fossa originaria e si fece costruire una grande villa per vegliare le vestigia dela fondazione. Quela villa fu poi acquistata nientedimeno che dall’imperatore Ottaviano Augusto». «Ce la fai a finire il discorso sul lituo?». Lazzari si arrese. «Cicerone fu l’ultimo testimone oculare a scriverne. Da allora se ne sono perse le tracce». tracce». «E tu pensi che sia possibile ritrovarlo?». Lazzari tirò fuori il cellulare. «Penso che inviterò un vecchio amico a pranzo, non ti dispiace?». Pioveva sui viali di Bologna. Il traffico scorreva lento. Impiegarono parecchi minuti per superare la stazione e alla fine, esasperati, lasciarono l’auto e proseguirono a piedi. Il professor Enrico Gianotti li aspettava sotto i portici che riparavano l’ingresso del ristorante bolognese prediletto da Lazzari. Con lui c’era una ragazza in tailleur e tacchi che presentò come la professoressa Veronica Bianchi. Probabilmente era vicina ai quaranta, ma apparteneva a quel genere di donne che dimostrano trent’anni per lo meno fino ai quarantacinque. «Appena mi hai telefonato mi sono subito attivato per trovare la persona che facesse al caso tuo», disse Enrico a Lazzari. Pareva tutto infervorato, anche se Lazzari non ne capiva bene il perché. «La professoressa Bianchi ha partecipato alle ricerche condotte dall’università sulla morte del Poliziano. Nessuno meglio di lei può rispondere alle tue domande». «È un piacere conoscerla, professore. La fama dei «È un piacere conoscerla, professore. La fama dei suoi studi la precede ovunque», esordì Veronica. Lazzari si infilò le mani in tasca e sorrise dondolandosi sui talloni. «Il guaio è che io sono rimasto indietro». Veronica sorrise. «Oh, non sia modesto». «Secondo me potremmo continuare anche seduti, che dite», suggerì Artemisia. Passò in mezzo ai due ed entrò. Nel sedersi all’unico tavolo libero, Artemisia notò stupita l’improvviso mutamento di Lazzari: era a disagio, ma in un modo elegante. «Il professor Gianotti mi ha detto che lei desidera notizie precise sula morte del Poliziano», disse Veronica. «Posso sapere il perché? Non che voglia farmi gli affari suoi, la mia è semplice curiosità». «È per un libro che sto scrivendo», rispose evasivamente Lazzari. «Quel saggio ormai leggendario? Quello che sta scrivendo da... quanti anni?» «Più di quindici anni», fece Lazzari con una scrollata di spale. «Ah bene, contenta di poterla aiutare». Veronica si fece avanti sulla sedia, le mani sui braccioli. Parlava con fece avanti sulla sedia, le mani sui braccioli. Parlava con entusiasmo e si spostava continuamente i capelli che le scivolavano sul volto. «Insegno antropologia. Tra il duemilasette e il duemilaotto ho partecipato al lavoro dell’équipe del professore Gruppioni sui tessuti e sui frammenti ossei prelevati dalle spoglie del Poliziano. Un’esperienza unica». «Immagino», fece Artemisia e si alzò per appendere la borsa all’attaccapanni. Uno solo dei lembi della maglia era infilato nei jeans. Lazzari si accorse che il suo amico non riusciva a staccarle gli occhi di dosso. Si sentiva in imbarazzo per quelle occhiate, quasi fosse lui il responsabile, ma provò a non farci caso. «I risultati sono inequivocabili», proseguì Veronica, senza riuscire a contenere la foga. I capelli non ne volevano sapere di stare al loro posto. «L’alta concentrazione di arsenico conferma la tesi dell’assassinio». «L’hanno ucciso perché aveva scoperto il...», stava dicendo Artemisia, ma Lazzari le mise una mano sul braccio. Ma la ragazza sembrava decisa a ripetere la domanda e solo il sopraggiungere del cameriere la domanda e solo il sopraggiungere del cameriere la interruppe. Un ragazzo magro ed emaciato, i capelli corvini e lunghi rendevano il volto ancora più pallido. Spinse accanto al tavolo un carrello di acciaio, quindi tolse i coperchi rivelando tagli di carne, salse e contorni. «Bolliti o arrosti?» «Misto per tutti, e da bere Lambrusco Vecchia Modena Premium di Chiarli», ordinò Enrico. «Spero non le dispiaccia se ho preso l’iniziativa», aggiunse poi rivolto ad Artemisia. Quando tutti e quattro furono serviti, Lazzari tornò a rivolgersi a Veronica. «Quali sono dunque le ipotesi più accreditate sull’assassinio?». Veronica lasciò subito le posate. «Per comprenderlo è necessario fare una premessa sulla sua vita. Poliziano studiò a Firenze insieme a Marsilio Ficino e ancora giovanissimo entrò nella cerchia di Lorenzo il Magnifico, che lo nominò precettore del figlio e suo segretario personale. Nel frattempo Poliziano proseguì i suoi studi e fu anche ordinato sacerdote. Nel 1478 la città fu scossa dalla congiura dei Pazzi, in cui fu assassinato Giuliano de’ Medici, fratello di Lorenzo e amico di Poliziano». «Scusate», si inserì Enrico riempiendo i bicchieri di vino. vino. Veronica lo assaggiò appena, poi proseguì: «Di lì a poco Poliziano litigò con la moglie del Magnifico, Clarice Orsini, e poi con lo stesso Lorenzo e abbandonò la corte dei Medici. Alcuni anni dopo fu richiamato da Lorenzo, che gli affidò lo Studio Fiorentino. A questo periodo risale l’amicizia con Pico della Mirandola e anche i prodromi di quelle dispute che lo porteranno a litigare, in modo anche violento, con altri intellettuali della cerchia dei Medici». «Una vita turbolenta», ridacchiò Enrico. «E un talento spiccato nell’inimicarsi i potenti!», ammise Veronica. «Nel 1492 morì il Magnifico e come sapete ne seguirono anni di grande apprensione per le sorti di Firenze. A quel punto il Poliziano si affidò al nuovo signore, Piero de’ Medici, figlio di Lorenzo e suo ex discepolo, per ottenere la nomina cardinalizia. Ma si spense nella notte tra il ventotto e il ventinove settembre 1494». «Avvelenato con l’arsenico», disse Artemisia lanciando un’occhiata a Lazzari. «Proprio così», confermò Veronica. «Dal poco che vi ho detto, avrete capito che si era fatto numerosi nemici durante la sua vita. Era celebre per essere un litigioso. Si durante la sua vita. Era celebre per essere un litigioso. Si potrebbe trattare di un omicidio politico, come di una vendetta». «O forse aveva scoperto qualcosa che non avrebbe dovuto scoprire», insinuò Artemisia. «Questo non lo», disse Veronica. «So solo che le voci sull’assassinio circolarono fin da subito, ma soltanto oggi ne abbiamo avuto la conferma grazie agli esami sui resti. La cosa curiosa è che anche il padre di Poliziano, un importante giurista, fu assassinato da un uomo che in passato aveva fatto condannare». Lazzari posò il tovagliolo sul tavolo e fece correre l’indice lungo il bordo del bicchiere di vetro spesso. «La cosa curiosa è che ora so perché fu ucciso il padre di Poliziano, ma non perché fu ucciso Poliziano». Era una semplice constatazione, ma Artemisia volle farla passare per una frecciata e aggiunse: «Sei deluso dalla professoressa? Non te la prendere e guarda il lato positivo. Ti stai gustando un ottimo bollito. Non pensavo potesse essere tanto appetitoso un piatto così osceno». Uscirono dal ristorante quasi due ore dopo. Le bottiglie di lambrusco avevano sciolto la conversazione, e non si era più parlato di assassini e misteri. non si era più parlato di assassini e misteri. «Quando questa storia sarà finita, potrai invitare a cena quella ragazza. Credo che se lo aspetti. Magari sarà curioso con un’antropologa», lo stuzzicò Artemisia e poi lo prese sottobraccio per attraversare la strada. La pioggia si era trasformata in un nevischio che imperlava già le tegole. Da qualche parte suonava una campana. Lazzari si concentrò su quel suono orfano e intanto, con i sensi ovattati dal vino, si lasciava tirare dalla presa forte della ragazza. «Sembra molto in gamba: purtroppo, però, non abbiamo scoperto granché sul Poliziano e la Confraternita». «Io non direi. Ora sappiamo che fu avvelenato, proprio come Vento», disse Artemisia. «E migliaia di altri uomini. Non mi sembrano elementi sufficienti per collegare i due omicidi». «Dimentichi che entrambi avevano a che fare con i misteri di Roma...». Lazzari si accorse che tremava e la abbracciò stretta. Lei non lo respinse. «Hai sentito quello che ha detto la professoressa. Poliziano era pieno di nemici: la nostra Confraternita non c’entra con la sua morte». Erano quasi arrivati sull’altro lato della strada quando Erano quasi arrivati sull’altro lato della strada quando adocchiò un fuoristrada parcheggiato poco distante dalla loro auto. Guardò con più attenzione e si accorse che aveva il muso ammaccato. «Merda!», imprecò riprendendosi di colpo. Spinse velocemente Artemisia in auto, litigò con le chiavi, mise in moto e partì facendo slittare le gomme sull’asfalto viscido. «Ehi!», fece Artemisia che fino a quel momento non aveva proferito parola per la sorpresa. «Che succede?». Lazzari puntò deciso verso il centro, infischiandosene delle telecamere attive. «Credo che faremo il pieno di multe», disse cercando di stemperare la tensione. «Non arriveranno mai a te, non ti preoccupare», disse Artemisia voltandosi a guardare la strada alle loro spale. «Vuoi dirmi chi hai visto?» «Il fuoristrada che a Milano ha tamponato la Mercedes su cui era quell’uomo che mi puntava la pistola. Come è possibile che ci abbiano trovati? Chi sono?» «Stai calmo, per favore. E poi ieri sera dicevi di non averlo visto bene e che non avresti saputo riconoscerlo se lo avessi visto di nuovo». «Sì, lo so, l’ho detto. Ma succede spesso. Pensi di non sapere, poi all’improvviso si accende una luce nella tua mente, ed eccola lì, la cosa che non ricordavi. Il fuoristrada è quello, ne sono certo». «Ti ripeto che la situazione è sotto controllo. Fidati di me». «Sotto controllo un corno». «Lascia perdere e dimmi piuttosto dove stiamo andando. Abbiamo ancora due notti e un giorno prima che Parodi ci chiami». Lazzari guardava costantemente gli specchietti. «In un posto sicuro». «Dove?» «A Sanremo. Ho un magazzino là, in cui conservo tutti i miei libri. Voglio controllarne alcuni. Mi servono delle conferme. Non riesco a capirci più niente, non so più bene cosa credere». «Credere? Pensavo fossi uno storico». Lazzari le lanciò uno sguardo obliquo, ma non disse nulla. Avevano già percorso una ventina di chilometri in autostrada, quando lei interruppe il silenzio: «Senti, ma davvero hai scritto un libro sulla fondazione di Roma per sedici anni?» sedici anni?» «No». «Me lo immaginavo», disse un po’ delusa. «Ci ho lavorato per sedici anni». «E non è lo stesso?», domandò lei, di nuovo appassionata. Da qualche parte scoppiò un tuono. Il cielo era un muro intonacato di fresco dove le scale di grigio arrivavano fino al nero. «Non ho scritto nemmeno una riga». «Non hai scritto nemmeno una riga?» «Soltanto una valanga di appunti, ma alla fine li ho gettati via. Quanto al saggio vero e proprio, nemmeno una paro la». «E perché?». Lazzari indicò qualcosa oltre il parabrezza. «Hai mai visto L’uomo che uccise Liberty Valance? È un film di John Ford». «No, non mi pare proprio». «Nel film, un anziano senatore rivela al direttore di un giornale che tanti anni prima il famoso bandito Liberty Valance non fu ucciso da lui, come tutti hanno sempre creduto, ma dal defunto John Wayne. È stata proprio la fama ottenuta per quell’uccisione a dare il via alla sfolgorante carriera politica del senatore, che ora è sfolgorante carriera politica del senatore, che ora è pentito e vorrebbe che fosse resa pubblica la verità. Il giornalista, però, gli dice che non scriverà neppure una riga di quella storia sul suo giornale. Loro vivono nel West, gli spiega, dove la leggenda vince sulla realtà, sempre». «E questo cosa vorrebbe dire?» «Cosa vuol dire non lo so, ma per me significa che le leggende vivono al di fuori di libri e resoconti, e che esistono cose che non si possono scrivere. La prima volta che ho sentito questa frase ho capito che era su misura per me. Hai presente quelle canzoni in inglese che ascoltavi da ragazzino, senza capire cosa dicessero, ma sapendo che ti stavano parlando? Capisci che intendo?» «Ho fatto le elementari in una scuola dove si studiava italiano, inglese e francese». Lazzari fece un sorriso amaro. «Hai visto quante cose si perdono nell’imparare troppo?» «Sedici anni di lavoro, e poi hai mollato tutto di punto in bianco». «Sì. Ho ammainato le vele e sono ritornato in porto, come si suol dire». «Non ti chiederò il perché, tanto non sapresti rispondermi. Ormai mi sembra di conoscerti». rispondermi. Ormai mi sembra di conoscerti». «Se lo dici tu». «Ma spiegami una cosa però: perché aprire un’enoteca?». Lazzari si strinse nelle spalle. «Ci deve pure essere qualcuno che rimane a riva per raccogliere i racconti dei marinai...». 11 Viaggiarono per almeno due ore senza soste. La neve era tornata pioggia. All’altezza di Parma, anziché svoltare per La Spezia, Lazzari tirò dritto per evitare di ripercorrere la strada dell’andata. Non riusciva ancora a capire come potessero averlo rintracciato a Bologna. L’effetto del vino era del tutto sparito, e ora sentiva nuovamente l’ansia congestionargli il petto. Dopo aver fatto il pieno e preso due caffè in un’area di servizio, Artemisia passò al volante, mentre Lazzari, visibilmente esausto, posizionava il suo specchietto in modo da poter controllare la strada alle loro spalle. Sentiva di essere vicino al limite oltre il quale gli sarebbe stato difficile controllare i suoi nervi. Perché lo stavano seguendo? Quella domanda si ripeteva ossessiva nella sua testa. Senza risposta. «Secondo te chi sono quelli che ci danno la caccia?», chiese Artemisia, intuendo i suoi pensieri. «A me pare che la stiano dando a me». «Avrai la tua medaglia, se è quelo che cerchi... Te lo «Avrai la tua medaglia, se è quelo che cerchi... Te lo richiedo, hai qualche idea?» «Forse sono gli uomini della Confraternita... quelli che hanno ucciso Vento. Oppure i tizi ingaggiati dalla concorrenza di cui ci parlava il Colonnello. O forse entrambi. O magari la polizia. Non lo so... E mi chiedo perché ci stanno seguendo. Fino a qui non abbiamo scoperto nulla. Cosa pensano di trovare?». Poi aggiunse: «O forse è quel tizio con il berretto a seguirci...». «Sei un paranoico». «Paranoico un accidente! E comunque scusami», si affrettò a correggere il tiro Lazzari. «I rischi li stiamo correndo in due. E sinceramente, non capisco proprio chi te lo fa fare». «A farti da balia?» «A correre questi rischi per i sogni di qualcun altro». «Curo gli interessi della Fondazione. Ti è stato già spiegato». «Spero che ti paghino bene». Artemisia sbatté forte una mano sul volante. «Pensi che lo faccia per soldi?». Lazzari intrecciò le braccia e si lasciò scivolare sul sedile. «Non è il tuo lavoro?» «Tu lavoravi all’università per soldi? Solo per soldi?» «Tu lavoravi all’università per soldi? Solo per soldi?» «D’accordo, scusami... Ma una cosa non ho capito. Tu, precisamente, lavori per il Colonnello o per la Fondazione?» «L’hai detto tu, lavoro per i soldi». Lazzari insistette per riprendere la guida. La sera era scivolata nella notte, e ora le gallerie erano isole di luce nella pioggia. Guidava con concentrazione, gli occhi rossi e la bocca contratta. Aveva dormito appena quattro o cinque ore negli ultimi due giorni e la stanchezza gli pesava addosso come un cappotto intriso d’acqua. Abbassava e alzava in continuazione l’aria calda, senza trovare requie, e non perdeva mai di vista lo specchietto retrovisore. Superata Genova si mise sulla corsia di sorpasso e non la lasciò più. Passarono Varazze a centocinquanta chilometri all’ora. «Tieniti forte», disse alla ragazza, mentre superava un camion. Ricordava che il caselo di Celle Ligure era poco dopo la fine del tunnel. Accelerò ancora, poi sterzò all’improvviso tagliando la strada al camion e imboccò per un soffio la rampa d’uscita. Il fuoristrada sbandò, le gomme fischiarono, per alcuni istanti l’auto fu sul punto di gomme fischiarono, per alcuni istanti l’auto fu sul punto di ribaltarsi, ma ala fine completò la curva riassestandosi. Davanti a loro c’era il casello. Oltre, il mare. «Brutto figlio di puttana!!», urlò Artemisia. «Ora almeno siamo sicuri che non ci abbiano seguito». «A momenti ci ammazziamo!». «Calmati adesso, conosco un posto per passare la notte. È sulle alture, a una ventina di chilometri da qui. È una vecchia casa dei nonni di un mio amico, la usano solo d’estate. Domani arriveremo a Sanremo sicuri di non avere nessuno alle spalle». Artemisia gli strinse il collo con una mano, obbligandolo a voltarsi verso di lei. «Fammi un altro scherzo simile e ti consegno io ai tuoi fantomatici inseguitori, a costo di portarti da loro in braccio!». «Nei libri cercherò qualche indizio su questa Confraternita», proseguì Lazzari senza scomporsi. «Conservo importanti cataloghi museali di reperti romani: chissà che non salti fuori un altro di quei medaglioni». Artemisia lo allontanò con un gesto brusco. «E non cambiare discorso! Tu non sai quanto sono incazzata. Non mi piacciono i furbi». Lazzari si strinse nelle spalle. Lazzari si strinse nelle spalle. «Non mi piacciono quando pensano di sapere cosa è meglio per me». Lazzari tacque. «Non mi piacciono quando prendono decisioni senza consultarmi, tanto più che sono io a capo dell’operazione qui». Lazzari continuò a tacere. «Per farla breve non mi piacciono. Capito?» «Comincio a capire che cosa intendi». «Sono nato qui», disse Lazzari quando passarono per Albisola, un paese che come un fermaglio congiungeva il mare alle alture. Artemisia guardò lui anziché il borgo. «Hai ancora dei parenti da queste parti?» «Soltanto ricordi». La provinciale si inerpicava tra le colline. I paesi erano sempre più distanti l’uno dall’altro e sempre più piccoli, pugni di case strette intorno a un campanile. E nel frattempo aveva ripreso a nevicare. Oltrepassato un bivio, la strada cominciò a stringersi e ad attorcigliarsi attorno alla vetta come un serpente sul proprio uovo, alternando secchi tornanti e brevi rettilinei. All’altezza di un casolare in pietra di fiume, Lazzari svoltò un casolare in pietra di fiume, Lazzari svoltò all’improvviso per un viottolo ampio appena pochi passi che, oltre la stalla e l’abbeveratoio, spariva nel bosco. Il fuoristrada sfiorava da una parte all’altra i rami che frustavano le fiancate. «È a senso unico questa strada, vero?», domandò Artemisia. «Falso». «E se incontriamo un’auto?». Lazzari frenò di colpo mentre una massa scura rovinava giù dalla collina sulla loro destra. A pochi centimetri dal muso della macchina videro sfrecciare un cinghiale. La pelliccia irsuta fumava. L’animale si tuffò nel bosco a valle e sparì. «Accidenti!», fece Lazzari portandosi una mano al petto, prima di ripartire. «Hai il dono di fare le domande sbagliate al momento giusto». La strada scollinava tra due formazioni rocciose. Lazzari guidava adagio, con gli abbaglianti in funzione. «È qui», disse indicando il punto dove il castagneto si diradava. Lasciarono l’auto in uno slargo sterrato, raccolsero le loro cose, scavalcarono una catena e proseguirono a piedi. Lazzari faceva strada, mentre Artemisia gli teneva piedi. Lazzari faceva strada, mentre Artemisia gli teneva una mano sulla spalla e con l’altra puntava il cellulare davanti ai loro piedi. La neve nascondeva sassi e radici. Il casolare era una macchia nera oltre le fronde. «Ci siamo quasi», mormorò Lazzari rabbrividendo, ma, mentre finiva di pronunciare la frase, inciampò in una radice e perse l’equilibrio, portando con sé Artemisia. Si ritrovarono entrambi distesi nella neve. «Oh merda!». «Solo neve», ridacchiò lei. Da qualche parte un uccello spiccò il volo in un frullio di ali. «C’è poco da scherzare», insistette lui, ma lei continuava a ridere. Si rimisero a fatica in piedi, cercando di spazzolare via la neve dai vestiti. Discutevano ancora quando raggiunsero il portico di legno. «E ora? Che si fa? Come hai intenzione di entrare, fammi capire», disse Artemisia. Lazzari lasciò cadere la borsa, si avvicinò alla ragazza e la sollevò di peso. «Cerca sopra l’architrave. Un tempo tenevano lì la chiave». «Niente», fece lei rovistando. «Aspetta un momento, però. Tienimi ferma. Ce la fai? Ah eccola». Lazzari prese la chiave che la ragazza gli porse e si Lazzari prese la chiave che la ragazza gli porse e si chinò sulla serratura. «Fammi luce con il cellulare». Finalmente riuscirono a entrare, zuppi e infreddoliti. «Si gela», fece Artemisia stringendosi nelle braccia. «Guarda se trovi qualcosa da mangiare, io vado a prendere la legna e accendo la stufa», gli disse guardandosi intorno. Nella legnaia c’erano ceppi e legnetti in quantità, e anche una buona scorta di pigne. Fece due viaggi, in modo da non dovere uscire durante la notte. Trovò anche un vecchio giornale, lo strappò e ne fece delle lunghe fiaccole. Ma dovette armeggiare a lungo prima di riuscire ad accendere il fuoco. «Mai stato boyscout... mi pare di capire, giusto?», osservò Artemisia che intanto si era avvolta in una coperta impolverata e saltava per il freddo. «Che idea geniale che hai avuto a voler venir qui! C’è solo da sperare che ci abbiano seguiti, almeno qualcuno troverà i nostri cadaveri assiderati...». Aprirono un paio di scatolette di tonno e le divorarono. Frugarono nella dispensa e scovarono anche una bottiglia di grappa e un pacco di frollini scaduto da appena un mese. «Salvezza», esultò Lazzari. «Salvezza», esultò Lazzari. Si sedettero l’uno accanto all’altra su un divano sfondato, un paio di coperte stese sopra la testa, sgranocchiando i biscotti e passandosi la bottiglia. L’unica luce nella stanza era quella rossastra che proveniva dalla stufa. Oltre la finestra senza persiane si intuivano appena le sagome degli abeti carichi di neve. «Oggi mi hai detto che hai lavorato a un libro sulle origini di Roma per sedici anni», disse dopo un po’ Artemisia. «Non avrai scritto una riga, ma ti sarai fatto almeno un’idea su quale possa essere il vero nome di Roma». Lazzari si fece più vicino. «Mille ipotesi, dalla più azzardata alla più semplice. E non è detto che la più semplice sia da escludere, come hanno fatto quasi tutti gli studiosi». «E quale sarebbe?» «Lo stesso nome». «Cioè Roma?» «Leggilo al contrario». «A... Amor? Ma dài, non prendermi in giro». «In fondo l’amore non è la risposta a tutte le domande?», replicò Lazzari con uno sguardo ambiguo, il tono tra il serio e il divertito. tono tra il serio e il divertito. «Ma ci sono delle prove da un punto di vista storico?». Lazzari si strinse nelle spalle. «Il termine ruma, “mammella”, esprime l’idea di un doppio: e se il nome Roma – che secondo alcune interpretazioni linguistiche gli è connesso – indicasse i genitori dei gemelli, ossia Venere e Marte? Leggendo il nome da destra, Roma, si farebbe riferimento a Romolo, che è figlio di Marte; leggendolo invece da sinistra, Amor, ci si riferirebbe a Venere, che secondo un altro racconto antico è la madre di Enea, avo dei gemelli. Forse ci credevano pure i romani dell’età imperiale visto che Adriano fece costruire un tempio dedicato congiuntamente a Venere e Roma». «Ma non era Silvia la madre dei gemelli? Non ci capisco più niente...». «Sì, ma nel contesto mitico dietro ogni personaggio si cela un dio», rispose Lazzari accalorandosi. «Si potrebbe scrivere un intero libro su Rea Silvia, e non sai quante analogie troveresti con la Maria cristiana, non solamente il concepimento verginale. L’etimo del nome proviene dal latino silva, che significa “bosco”, “legname”, ma anche “materia”. Il prenome, invece, deriva da reus che ha due significati: “reo” e “consacrato”. Io scarterei il primo: significati: “reo” e “consacrato”. Io scarterei il primo: Silvia, infatti, non infranse il voto di castità, perché fu un dio a possederla. Reus significa piuttosto consacrato agli dèi: Silvia infatti era Vestale, una sacerdotessa consacrata a Vesta». «Continua», fece Artemisia che lo guardava a pochi centimetri di distanza, attratta dall’intensità inaspettata di quello sguardo. «C’è anche un altro interessante colegamento. La grande dea dell’Asia, Cibele, era detta Rea dai popoli che l’adoravano: i greci la chiamavano invece Idaia, dal monte Ida, che significa proprio bosco, legname, e corrisponde in tutto alla parola silva». «Perché ci tieni tanto a sottolineare questi significati? Cosa hanno di tanto speciale?» «Perché per i romani dietro Silvia si cela il principio femminile dell’universo: la materia che viene informata dal dio, il legname che viene acceso e trasformato in fuoco!». «Quante cose dietro una semplice ragazza». «Quando il simulacro di Cibele fu trasferito a Roma, sai quale luogo scelsero i romani per ospitarlo?» «Scommetto il Palatino». «Esatto! Ruota tutto intorno a quel luogo. Il tempio di Vesta sorgeva all’incrocio delle due principali vie Vesta sorgeva all’incrocio delle due principali vie cittadine, il cardo e il decumano: era l’unico ad avere forma rotonda, con un’apertura sul tetto affinché tutta la città potesse controllare il fumo del fuoco che doveva bruciare all’interno senza sosta, pena la rovina dell’Urbe; ed era anche l’unico il cui culto era affidato a un sacerdozio femminile. Tutti elementi che sottolineano la sua centralità e particolarità. Secondo la leggenda, il concepimento divino di Remo e Romolo avviene mentre la vergine Silvia si reca ad attingere acqua di fonte, ossia pura, condizioni che implicitamente alludono alla disponibilità della ragazza a essere fecondata dalla divinità. Proprio come Maria, che pronuncia il suo fiat alla volontà divina». «Prima le analogie tra la fondazione di Roma e la Pasqua, ora tra la nascita di Remo e Romolo e quella di Gesù. Ma che cosa stai cercando di dimostrare?» «Sollevo semplicemente degli interrogativi», si schermì Lazzari. «Per adesso lasciami finire il discorso sulla dea che si nasconde dietro Silvia. Devi sapere che il fuoco di Vesta veniva acceso una volta all’anno con il rito della terebratio, ossia facendo scoccare una scintilla per sfregamento: il fuoco doveva essere vergine, non figlio di altro fuoco. Questo ulteriore particolare ha fatto figlio di altro fuoco. Questo ulteriore particolare ha fatto pensare a molti che fosse Vesta a celarsi dietro la figura di Silvia». «Quindi era Venere o era Vesta la vera madre dei gemelli?» «Chi dice che fossero due? Secondo il filosofo Macrobio, Valerio Sorano...». «Quello che fu ucciso per aver rivelato che Roma aveva un nome segreto?» «Proprio lui», confermò Lazzari. «Sorano, nell’Epoptidon, svelò pure che tutte le dee non erano che l’espressione di un’unica divinità. C’è poi una terza indiziata. Se il termine Rea si riferisce all’omologa dea greca, come sostengono alcuni esperti, allora la corrispettiva divinità latina sarebbe Opi, la dea dell’abbondanza». «E in questo caso quali sarebbero le prove di un suo collegamento con Silvia e la fondazione di Roma?» «Ce ne sono almeno tre. Primo: nella domus Regia, posta all’interno del santuario di Vesta, erano presenti esclusivamente due sacrari, il primo dedicato a Marte e l’altro proprio a Opi. Secondo: in quello stesso edificio fu conservato il sacro lituo e tutto ciò che apparteneva alla fondazione della città. Terzo: Opi era detta Consivia, la fondazione della città. Terzo: Opi era detta Consivia, la cui radice etimologica è la stessa del verbo condere, ossia “fondare”». Lazzari si arrestò di colpo e le prese la mano. «Che ne pensi?» «Penso solo che non hai ancora risposto alla mia domanda sul termine Amor», fece Artemisia, che ormai gli era molto vicina. Lazzari prese un legnetto e fece un rapido disegno sullo spesso strato di polvere che ricopriva il pavimento: «Questo disegno è stato ritrovato su un muro di una casa di Pompei». «Pompei?» «Vuoi che te ne parli?», domandò Lazzari tracannando l’ultimo sorso di grappa. La bottiglia era finita. «Non stasera», fece Artemisia, sfiorandogli il volto con il suo. con il suo. Lazzari avvertì una vampata di calore. Il cuore prese a battergli così forte che perfino Artemisia se ne accorse. Si avvicinò ancora e lasciò passare le labbra dietro il suo orecchio. «Non ti scoppierà il cuore, vero?», sussurrò Artemisia sfiorandogli gli occhi con la punta delle dita. «Staremo a vedere», e la baciò di slancio per vincere la timidezza. 12 Si svegliarono immersi in una luce bianca. Aveva smesso di nevicare e a sorpresa era spuntato il sole. La stufa doveva essersi spenta da qualche ora e traboccava di cenere: nessuna possibilità di farla ripartire in tempi rapidi. Si sedettero al tavolo della cucina e finirono i biscotti infagottati nelle coperte. Festoni di ragnatele correvano tra le pareti. Nessuno dei due disse una parola. Si sciacquarono come poterono, imprecando sottovoce, raccolsero le loro cose, uscirono e lasciarono la chiave sulla sommità dell’architrave, esattamente dove l’avevano trovata. La campagna era bianca e verde. Si fermarono a prendere un caffè in un paesino deserto e mentre lo sorseggiavano, davanti a un barista giapponese che parlava l’italiano con difficoltà, Artemisia e Lazzari si scambiarono un sorriso impacciato, il primo della giornata. Scesero verso il mare, attraversarono Savona e ripresero l’autostrada. Il sole brillava sull’asfalto bagnato. ripresero l’autostrada. Il sole brillava sull’asfalto bagnato. I grandi occhiali di Artemisia rispecchiarono in successione i bianchi torrioni di Finale Ligure, la piana albenganese e poi la dorsale cespugliosa che correva verso la Francia. Grandi pini pendevano sulle scogliere. «Il tempo è poco», disse dopo un po’ Lazzari. «Ma spero di rintracciare in alcuni autori antichi qualche riferimento all’Epoptidon. Vorrei anche dare un’occhiata alle raccolte epigrafiche». Artemisia si accarezzava il braccio e non dava segno di ascoltare. «Secondo me, sono le iscrizioni tombali il nostro asso nella manica. È così che abbiamo scoperto ciò che conosciamo dei riti misterici antichi, come quelli orfici. Alcuni iniziati, ad esempio, si facevano seppellire legandosi al collo delle piastrine di metallo su cui erano incise formule segrete, dettagli dei misteri e perfino mappe dell’aldilà. E così ciò che non rivelarono da vivi, lo fecero da mor ti». Dopo qualche chilometro si fermarono in un’area di servizio. Lazzari fece il pieno, poi si sedette su un muretto al sole ad attendere Artemisia. Con un gesto automatico si toccò il petto, ma il solito fastidio non c’era. Tastò con le dita tra stomaco e sterno, fastidio non c’era. Tastò con le dita tra stomaco e sterno, ma niente. Non sapeva se esserne lieto o temere invece una ricaduta. Artemisia ricomparve mezz’ora più tardi. Lo cercò con lo sguardo per tutto il piazzale e quando lo vide con gli occhi rossi, il volto scavato e la barba di tre colori, bruno, biondo e grigio, se ne sentì attratta. Forse non era solo un capriccio, come aveva pensato qualche minuto prima. Aveva impiegato alcuni istanti a riconoscerlo: con il mare sulo sfondo e il sole negli occhi, somigliava a un attore francese dalla la carriera andata a rotoli. Si parò davanti a lui, il peso su una sola gamba. «Avrei bisogno di un passaggio...». «Per dove?» «Decidi tu». Uscirono dalla superstrada a Bussana, in prossimità del mercato dei fiori. Di quanto successo la sera prima nessuno dei due intendeva fare parola. Su una di quelle colline dove decine di serre riflettevano, moltiplicandoli, i raggi solari, Lazzari conservava una fascia del terreno appartenuto ai suoi nonni, che per più di mezzo secolo avevano coltivato nonni, che per più di mezzo secolo avevano coltivato fiori. Prima garofani e poi, con il cambiare delle mode, ranuncoli e infine crisantemi. La strada per arrivare al piccolo podere era una stretta e ripida serpentina di cemento grezzo che nel corso degli anni aveva costretto i visitatori a lasciare l’auto a valle e proseguire a piedi. Le curve a destra si affacciavano sullo strapiombo e quella a sinistra erano talmente irte da formare un dislivello di tre metri sulla strada sottostante. E come se non bastasse, il fianco della montagna franava in continuazione rendendo il fondo sdrucciolevole. Durante la salita Artemisia alternò secchi insulti a silenzi tesi. «Smetti di frenare o farai un buco sul fondo», le disse Lazzari, che aveva l’abitudine di sfoderare sicurezza nelle poche cose che sapeva fare bene. «Aspetta che arriviamo in cima, e poi vedrai», fece lei. Quando però raggiunsero la vetta rimase senza parole. Mise piede sul terreno sassoso e corse in avanti fino al ciglio della scarpata. Il suo sguardo spaziò dall’altura, irta di fichi d’india, ale colline terrazzate e punteggiate di fiori e poi giù fino alla battigia e al mare punteggiate di fiori e poi giù fino alla battigia e al mare verde e azzurro. Lazzari indicò una casa poche centinaia di metri più in basso rispetto alla loro posizione, un cubo giallo dal tetto a terrazza accoccolato tra le serre che riflettevano il sole. «Da bambino ho vissuto là per un periodo». «Ho capito dove è nata la tua passione per le cose belle». Il capanno sorgeva a ridosso di una vecchia cisterna per l’acqua. Lazzari aveva venduto la casa e il terreno, ma si era tenuto quel piccolo appezzamento. Nell’orto crescevano spontaneamente asparagi e insalata selvatica. Le gabbie dei conigli erano divelte e fracassate. C’era ancora la vecchia pentola in cui metteva il cibo per Argo, un setter maculato che non era andato a caccia nemmeno un giorno nei suoi quattordici anni di vita. Tolse il fermo alla porta del magazzino. Sulle assi erano schierati in ordine bottiglie e vasi. I vetri si animarono alla luce che arrivò da fuori. C’era ancora qualche barattolo intonso, pieno di marmellata o salsa di pomodoro, e perfino qualche fiasco di vino e di olio. In un angolo era stato piazzato il frigo per i fiori, che Lazzari aveva poi trasformato in quella che definiva la sua cassaforte. Artemisia abbassò gli occhiali. «Tu conservi i tuoi Artemisia abbassò gli occhiali. «Tu conservi i tuoi libri qua dentro?» «Le migliori condizioni possibili di conservazione», rispose Lazzari bussando contro l’acciaio. «Temperatura bassa e costante, e giusto grado di umidità. Inoltre, l’elettricità è gentilmente offerta dal Comune. Un mio amico ha collegato i cavi all’impianto di illuminazione stradale». Artemisia, però, pensava ancora ai libri. «Il Colonnello mi ha detto che li hai rubati alle più importanti biblioteche italiane. È vero? Rubare alle biblioteche è come rubare in chiesa, o ai poveri». «Mi ero messo in testa di riunire una biblioteca specifica sule origini di Roma, e poi di renderla pubblica. Idea assurda. Finita questa storia, provvederò a restituirli». «Il Colonnello può fare in modo che...». «Li restituirò comunque». Lazzari digitò sul display il codice segreto. Quando udì il fischio elettronico, ruotò la maniglia e aprì. «Oh cazzo!», mormorò Artemisia davanti alla cella deserta. Lazzari si portò le mani in testa. Sentì un grande freddo e un’improvvisa debolezza. Poi un vuoto inatteso freddo e un’improvvisa debolezza. Poi un vuoto inatteso e allora scoppiò a piangere senza riuscire a controllarsi. «Li hanno rubati, vero?», domandò Artemisia quando raggiunsero il fondo della discesa. «Tu che dici?? Forse potrebbe averli presi in prestito il pastore della zona...». Lazzari era furibondo. Artemisia continuò nello stesso tono: «Chi può essere stato?» «Qualcuno che di certo ha a che fare con questa storia. Forse quelli della Confraternita o, più probabilmente, quelli che ci stanno seguendo...». «Come hanno fatto a trovarli in questo posto sperduto?» «Be’, evidentemente anche loro dispongono di mezzi “illimitati”, come direbbe il tuo Colonnello». «Forse sono ancora nei dintorni», ipotizzò Artemisia. Il dolore e la rabbia per la perdita dei libri avevano fatto dimenticare a Lazzari la paura, che ora tornò a farsi sentire. «Voglio che telefoni al Colonnello. Ci aveva garantito protezione, maledizione!». «Aspetta un momento, però. Da quanto non venivi qui? Possono averli rubati un mese fa per quanto ne sappiamo». sappiamo». «Voglio che gli telefoni e gli dici di recuperare quei dannati libri! Ne abbiamo bisogno». «Io ho bisogno di una doccia, di mettere le gambe sotto il tavolo di un ristorante e di un letto vero dove dormire dieci ore filate. Cerchiamo un albergo. Dopo, forse, chiamerò il Colonnello». Lazzari si passò l’indice sotto il naso. «Andiamo, conosco un posto dove non ci chiederanno i documenti». «Una bettola in qualche fogna». «È un albergo in pieno centro ma, per così dire, invisibile. Ha una stella, ma ne vale almeno tre. Ogni città ha i suoi segreti». «E tu come fai a saperlo?». La guardò con aria sibillina. «Quello che ho detto per le città vale anche per gli uomini». L’albergo occupava il terzo piano di uno stabile d’epoca, a metà strada tra il teatro Ariston e il casinò. Presero due stanze comunicanti e pagarono in contanti. Il gestore, un uomo basso dala tinta rossiccia e dagli occhi azzurri, non chiese i documenti, ma diede loro il proprio biglietto da visita. «Per qualsiasi evenienza». Ripeté la parola qualsiasi «Per qualsiasi evenienza». Ripeté la parola qualsiasi due volte. Lasciò loro anche le chiavi del portone di ingresso. «Così sarete liberi di andare e venire a vostro piacimento», spiegò, enfatizzando la parola piacimento. Le camere erano spaziose, nonostante la tappezzeria risalisse agli anni Cinquanta. Lazzari lasciò le valigie sul pavimento, scostò le pesanti tende e si affacciò alla finestra. Le palme si slanciavano sopra il traffico del pomeriggio mentre il mare, oltre i binari, ricopriva quasi per intero la spiaggia. Artemisia si lasciò cadere sul letto della stanza attigua. «Io mi riposo un po’, prima di farmi un lungo bagno. Ci vediamo alle sette qui fuori», disse parlando attraverso la porta comunicante che era aperta. «Facciamo nell’atrio». «Allora io scelgo l’orario», disse lei e chiuse la porta con un calcio. Artemisia scese ale otto meno un quarto. Sotto la giacca, indossava un vestito scuro e morbidi stivali. Trovò Lazzari seduto al tavolino di un bar. Nell’attesa si era bevuto un paio di Pastis con acqua e aveva letto nelle pagine locali di un quotidiano un trafiletto che lo aveva inquietato: il giorno prima, in località Bussana, alcuni inquietato: il giorno prima, in località Bussana, alcuni coltivatori, dopo aver udito ripetuti spari, avevano avvisato i carabinieri. Le forze dell’ordine, giunte sul posto, avevano ritrovato un paio di bossoli di due distinti calibri apparentemente non riconducibili ad armi da caccia, ma nessuna traccia di sangue. Le indagini erano ancora in corso. Gli inquirenti non escludevano alcuna pista. «Scusa il ritardo», disse Artemisia, con il tono di chi invece lo rimarca. «Figurati, sono io che sono in anticipo». Lazzari ripiegò il giornale, lo lanciò su una sedia e si alzò. «È tempo del secondo desiderio, genio della lampada. Un ristorante». «Di che tipo?» «Di quelli che piacciono a te, brutti ma buoni». La trattoria occupava un breve pontile sulla spiaggia. Era ancora gestita dalla stessa famiglia di immigrati abruzzesi, buoni amici dei suoi, perfino parenti alla lontana a credere alle parole di sua madre. Lo riconobbero appena aprì bocca e gli diedero il tavolo che preferiva, quello all’angolo sospeso oltre il molo, dal quale sembrava di essere seduti in mezzo al mare. Artemisia passò una mano sulla tovaglia a scacchi Artemisia passò una mano sulla tovaglia a scacchi bianchi e rossi. «Ci portavi le tue fidanzate qui?» «Sì, due alla volta». «Perché non ti rilassi?». E assaggiò uno dei crostini all’olio. Lazzari indicò con il pollice alle proprie spalle. «Tu forse non ti rendi conto! Ieri c’è stata una sparatoria a poche decine di metri dal mio magazzino. Sembra assurdo, ma sono certo che non può essere un caso!». La ragazza impiegò più tempo del solito per replicare: «Non ti hanno insegnato che non si parla di lavoro a tavo la?». Lazzari si accorse che la notizia, nonostante la sicurezza che ostentava, l’aveva toccata e si rimproverò per essere ritornato sull’argomento. In fondo erano a Sanremo e stavano per cenare insieme dopo quello che era successo tra loro la notte prima. La paura guastava ogni cosa. Eppure non riusciva ad allontanare il pensiero di quanto era accaduto. Erano stati gli agenti della concorrenza a prendere i suoi libri? In quel momento potevano essere ovunque, anche lì vicino, senza che loro potessero saperlo. Forse li stavano tenendo d’occhio. Si costrinse a smetterla con le domande e prima di ogni altra cosa ordinò il vino. altra cosa ordinò il vino. Mangiarono brodo abruzzese, una zuppa con bietole, fettucce di frittate, polpettine, fegatelli e poi un incredibile numero di rostelle di capra alla brace. «Sono sorprendentemente buone per avere un odore così repellente», commentò Artemisia che aveva composto una ziggurat con gli spiedini di legno. La prima bottiglia di Rossese di Dolceacqua terminò quando la carne non era ancora in tavola, e così ne ordinarono un’altra. L’alcool aveva stemperato i timori di Lazzari, che ora si meravigliava che quella donna così affascinante fosse davvero seduta davanti a lui, e che davvero stesse ridendo alle sue battute. «Quattro bicchieri di Amaro del Capo», ordinò dopo che ebbero finito il dolce. «Ma noi siamo in due», rise Artemisia. «Tra poco saremo in quattro, fidati». Quando uscirono, mezz’ora più tardi, erano piacevolmente brilli. Si avviarono con calma verso il casinò, appoggiandosi di tanto in tanto l’uno all’altra. Alla vista del palazzo bianco Artemisia sembrò riprendersi e salì la scalinata con disinvoltura, sostenendo anche il compagno. Lazzari indugiò per alcuni istanti davanti alla porta. La via sottostante aveva visto tempi davanti alla porta. La via sottostante aveva visto tempi migliori, le serrande dei bar erano arrugginite, le palme pendevano. Più in basso la vecchia stazione sorvegliava un enorme parcheggio semideserto. Artemisia prese posto a un tavolo da poker. Lui la guardò per qualche minuto prima di defilarsi. Lei ci sapeva fare, la vita le veniva naturale. Lazzari annuì ammirato, poi si infilò le mani in tasca e prese a vagare per le sale. Al piano terra c’erano i tavoli con la puntata minima fissata a pochi euro e un po’ di gente accalcata intorno, di sopra invece si udiva soprattutto la voce dei croupier e il rollio delle roulette nelle stanze semivuote. All’improvviso avvertì un vuoto allo stomaco e subito dopo un’ondata di inquietudine. I pensieri tornarono a galla tutti insieme. Aumentò il passo. L’ansia camminava con lui. Era sicuro di poter scorgere da un momento all’altro lo sconosciuto con la barba e il cappellino che li aveva seguiti fin dal principio. Se lo immaginava con uno smoking scuro, il grande petto strizzato nella camicia, e gli occhiali scuri che ora tanti avevano a causa del Texas Hold’em. Come aveva fatto a non capirlo prima? Quel tizio doveva per forza essere un agente della concorrenza. In pochi secondi sentì le sue mani diventare concorrenza. In pochi secondi sentì le sue mani diventare madide. Camminava avanti e indietro, con occhi febbricitanti e passo malfermo, quando un addetto alla sicurezza gli chiese se stesse cercando qualcuno. «Mi pareva di aver visto un amico», si giustificò Lazzari. «Forse è uscito», disse l’uomo allusivo. «Invece è a quel tavolo», replicò Lazzari, prendendo velocemente posto di fronte alla roulette. Controlò le tasche, tirò fuori cinque biglietti da dieci, tre da venti e uno da cinque, se li fece cambiare direttamente dal croupier e cominciò a puntare sul ventuno. Come il ventuno aprile. Non uscì mai. Furono tra gli ultimi ad andarsene, verso le due. Nessuno aprì loro la porta. L’usciere aveva forse già terminato il suo turno. «Non ho voglia di tornare in albergo», disse Artemisia respirando a pieni polmoni l’aria marina. Scesero verso il mare ed entrarono nel bar ritrovo dei giocatori, un locale di ottoni, legni, specchi, riflessi dorati e whiskey bruniti, in cui fluttuavano come fantasmi attempati camerieri in giacca bianca e papilon nero. Era un posto buono per pensare al passato, a quello che si era perso, a ciò che si era lasciato indietro. Perso o vinto, quella sera non importava. «Ti sei mai sposato?», gli domandò Artemisia. Aveva voluto a ogni costo prendere una bottiglia di Krug, ma dopo il primo bicchiere nessuno dei due pareva intenzionato a versarsene un secondo. Le catene di bolicine risalivano sempre più lentamente. «Una volta, quasi. Ma poi non se ne fece niente». Lazzari agitò la coppa larga in cui gli avevano servito lo champagne, di quelle che ormai non si usavano più da almeno dieci anni. «Non non ti preoccupare, non ti chiederò il perché». Lazzari sorrise. «Non ti preoccupare, non ti farò la stessa domanda». Artemisia colmò le due coppe e brindò: «Ala nostra luna di miele». Ritornarono in albergo a piedi, guardandosi spesso alle spalle. Una volta nella sua stanza, Lazzari rimase a lungo alla finestra per tenere d’occhio la piazza sottostante. «Hai chiamato il Colonnello?», domandò a un certo punto ad Artemisia. «Dice di non preoccuparti per i libri. Ha incaricato un «Dice di non preoccuparti per i libri. Ha incaricato un suo agente di recuperarli». «E di quelli che li hanno rubati? Non gli hai detto che potrebbero essere ancora qui?» «Ha detto che è tutto sotto controllo». «Sì, come no. Non ha detto altro?» «Che è curioso come noi di sapere cosa ci dirà domani Parodi, se è riuscito a rintracciare questo Lupo». Lazzari tirò le tende e accese la TV e Artemisia si accoccolò sul divano accanto a lui. Su un canale satellitare davano Il tesoro della Sierra Madre. «Odio i western», disse lei. «Scommetto che è solo perché non li hai mai visti». «Certo che...». «Non li hai mai guardati come se li stessi vedendo per la prima volta». «Questo di cosa parla? Ehi, ma quello non è Bogart?» «Parla di tre uomini che vanno a cercare l’oro». «E non lo trovano». «Invece lo trovano, ma anche l’oro trova loro. Gli entra dentro, li divora e li divide. Bogart uccide, o almeno ci prova, uno dei compagni e scappa con l’oro. Ma finisce sulla strada di un gruppo di banditi, che lo Ma finisce sulla strada di un gruppo di banditi, che lo ammazzano e lo rapinano. I banditi, tuttavia, pensano che il vero tesoro siano i muli e non i sacchi di tela, che stracciano e buttano via». «E come finisce?» «Come ogni ricerca di questo tipo, con l’oro nel vento». Artemisia era incuriosita da quella luce, emozionata e a tratti perfino fanatica, che ogni tanto si accendeva sul volto di Lazzari. «Che cosa stai cercando di dirmi? Che la nostra ricerca finirà così?». Lazzari si voltò verso di lei. «Lo vedi?» «Cosa?» «Perché non mi sono mai sposato. Ne sapete sempre una in più». 13 Artemisia si svegliò nel proprio letto. Si alzò e senza mettersi nulla addosso sgusciò nella stanza attigua. La porta era aperta. Lazzari era in piedi davanti alla finestra e le dava le spalle. Indossava solo i pantaloni. Pensò che avesse una bella schiena, peccato per quella sua abitudine di tenere le spale curve, come se stesse continuamente dicendo “così va il mondo”. «Ricordo di essermi addormentata sul divano, ma non ricordo come ho fatto ad arrivare fino al letto. Sulle mie gambe?». Lazzari si voltò di scatto, non l’aveva sentita arrivare e quando la vide nuda, con le mani intrecciate sotto i seni e le lunghe gambe scaldate dalla luce zigrinata del sole, abbassò lo sguardo. «Sulle mie braccia». Artemisia frugò sul tappeto con la punta del piede, reclinò la testa e lo guardò dal basso in alto. «Che c’è?» «Mi sono dimenticato di dirti una cosa ieri sera», disse Lazzari. Si avvicinò rapidamente e la baciò. Artemisia lo ricambiò e poi, all’improvviso, lo alontanò e Artemisia lo ricambiò e poi, all’improvviso, lo alontanò e scoppiò a ridere. Fecero colazione al bar sotto l’albergo. Un nastro di sole era posato sull’angolo del tavolino come quello di un pacchetto dono. «Dici che si sentono così gli sposi il giorno in cui finisce la luna di miele? Quando guardano per l’ultima volta l’orizzonte tropicale e pensano al ritorno a casa, all’ufficio, alle rate, ai genitori che invecchiano, alla passione che finirà?». Artemisia inforcò gli occhiali. «Non credo siano queste le cose che pensano i novelli sposi, almeno quelli normali... Forse sono i pensieri che hai fatto tu... Magari quando lei ti ha lasciato». Lazzari non riuscì a nascondere la sorpresa. «Come fai a sapere che è stata lei a lasciarmi?» «Ce l’hai scritto in faccia». Lazzari la guardò a lungo. «Sai, a volte anch’io vorrei un paio di occhiali come i tuoi». Arrivarono a Sarzana nel primo pomeriggio e parcheggiarono a ridosso del centro storico. Non avevano pranzato, ma si sentivano ancora sazi per la cena della sera prima. Passarono sotto le mura medievali cena della sera prima. Passarono sotto le mura medievali e si incamminarono lentamente verso casa di Parodi, scambiandosi di tanto in tanto un’occhiata interlocutoria. «Che dici? È l’ora giusta per suonare alla porta di un ottantenne?», gli domandò Artemisia. Indugiavano davanti al portone, mentre il sole tiepido delle due accarezzava i loro visi. La neve e il freddo di due giorni prima erano solo un ricordo. Lazzari glissò sull’ironia. «Probabilmente a quest’ora si sta facendo un sonnellino». «E che genere di sonno...», sussurrò Artemisia, di colpo pallida. «Che hai?», le domandò Lazzari scuotendola per il braccio. La ragazza gli indicò con l’altra mano la locandina del giornale locale esposta accanto all’ingresso di un’edicola. IL PROFESSOR PARODI TROVATO MORTO NELLA SUA ABITAZIONE. ARRESTO CARDIACO. ALCUNI DETTAGLI DA CHIARIRE. Comprarono il giornale, se lo contesero e ne strapparono un pezzo per la fretta di aprirlo. Lo lessero strapparono un pezzo per la fretta di aprirlo. Lo lessero in piedi davanti all’edicola. L’articolo aggiungeva pochi altri particolari al titolo. Il cadavere del professore presentava segni di corde ed ecchimosi sui polsi, come se fosse stato legato. L’appartamento era in perfetto ordine, e questo sembrava far escludere l’ipotesi del furto, ma nessuno poteva affermare se fosse stato portato via qualche oggetto, vista la vastissima collezione di monili antichi e pezzi d’arte conservati da Parodi, noto e stimato antiquario. «Devono averlo legato e interrogato», disse Lazzari sgranando gli occhi. Aveva le palpitazioni e un dolore diffuso e costante alla bocca dello stomaco. «E lui deve avergli detto quello che ha detto a noi», continuò Artemisia. «E soprattutto gli avrà detto di noi». «Che saremmo tornati». «Forse sono ancora qui». «E ci stanno cercando». «Scappiamo», fece Lazzari prendendola per mano. Schizzarono verso il parcheggio abbandonando il giornale che frullò a terra. Artemisia si bloccò dopo una manciata di passi e lo Artemisia si bloccò dopo una manciata di passi e lo strattonò. «Fermati, forse conoscono la nostra macchina e ci stanno aspettando là». «E che cosa vuoi fare, lasciarla lì?» «Che te ne importa? È solo una macchina!», disse Artemisia. Lazzari annuì. «Alla stazione, allora». «Dov’è?» «Nella parte nuova della città, almeno credo. Non ricordo con esattezza. In ogni caso, non più di un paio di chilometri da qui». «Troppa strada, ci vedrebbero. E poi forse stanno sorvegliando anche la stazione. Prendiamo un taxi». «Sull’altro lato della piazza, via!». Attraversarono a passo sostenuto il campo acciottolato e in lieve pendenza, facendosi largo tra i numerosi passanti. Alcuni bambini avevano accatastato giacche e zaini su una panchina e giocavano a pallone. La palla rotolò fino ai piedi di Lazzari che si fermò e la calciò verso i ragazzi. Fu un tiro maldestro. Rimase a guardare imbarazzato il pallone che schizzava lontano. Quando si voltò scorse un uomo in giacca e cravatta alle spalle di Artemisia. Camminava a passo sostenuto e pareva puntare verso di loro. «Vieni via, corri!», disse ad Artemisia, afferrandola per il braccio. Ma fecero in Artemisia, afferrandola per il braccio. Ma fecero in tempo a compiere solo una decina di passi che si ritrovarono davanti un altro sconosciuto che li bloccò con fare cortese ma deciso, come se fosse un vecchio amico intenzionato a farsi riconoscere. «Signor Lazzari, che piacere», disse l’uomo. Nel frattempo anche l’altro li aveva raggiunti. «Collaborate e non vi succederà nulla», li rassicurò uno dei due, posando una mano sulle loro spalle. Disse di chiamarsi Fazio e presentò l’altro come l’agente Prati. Erano dela stessa altezza, avevano volti dalle mascelle pronunciate, e portavano identici occhiali da sole. Prati sorrise toccandosi il fianco con un gesto allusivo. «Professor Lazzari, la prego di seguirmi. Si tratta di quel famoso caffè. Milano, ricorda?». Lazzari si accorse del rigonfiamento sulla giacca di Prati all’altezza del fianco e quando tornò ad alzare lo sguardo riconobbe l’uomo che dalla Mercedes gli aveva puntato contro la pistola. «Sarà freddo il caffè a quest’ora», si sforzò di dire, ma il tono stridulo lo tradì. Aveva la gola secca, le mani sudate e nel petto il cuore gli scoppiava. «Lo berrà comunque questa volta». Li scortarono fino al bar che dava sull’angolo della Li scortarono fino al bar che dava sull’angolo della piazza. Tavolini di ferro, piante ornamentali e tende bianche. Li fecero sedere tra due pesanti fioriere con le spale contro il muro. I due uomini presero posto di fronte a loro, in modo da bloccare qualsiasi via di fuga. Ordinarono quattro caffè e li attesero senza parlare. Appena il cameriere se ne fu andato, Prati sorrise un’altra volta: pareva il suo modo per anticipare che aveva qualcosa di interessante da dire, come se pregustasse una delizia. «Spero di non avervi spaventato. In guerra, si sa, la paura uccide più della spada, e non vorrei che faceste la fine del vecchio Parodi. Non è stato piacevole vederlo afflosciarsi all’improvviso». «Non è quello che volevamo», si intromise Fazio. «Giusto, non era nel mio interesse. Tutto ciò che desidero è collaborazione», continuò Prati. «Vi chiediamo solo un po’ di buona volontà. E state tranquilli, siete in buone mani», li rassicurò Fazio. «La nostra agenzia, che si occupa di molte questioni riservate e delicate, ha un motto: riuscire o altro». «Che vuol dire “altro”?», domandò meccanicamente Lazzari. Fazio sembrò felice di rispondergli: «Non lo sappiamo professore, non ci è mai capitato». sappiamo professore, non ci è mai capitato». Prati appoggiò le mani sul tavolo e poi le fece scorrere in modo perentorio nei due sensi. «Ho garantito a chi ci ha ingaggiato che se quel vecchio bastone esiste davvero, io lo recupererò. Voi state tentando la stessa operazione. La mia idea è questa: perché non unire i nostri sforzi? Abbiamo a che fare con una banda di pazzi. Mi riferisco agli adepti della setta che nasconde i tesori di Roma: all’inizio non volevo crederci, ma dopo che ho visto come hanno ridotto quel disgraziato di Achille Vento, ho dovuto cambiare opinione. In guerra non c’è peggior nemico dei dilettanti: non sai mai da dove ti possono sparare. Voi non siete preparati ad affrontarli». «Avete bisogno della nostra protezione...», riprese Fa zio. «...E non siete in grado di proteggervi da noi», concluse Prati, i denti bianchi che brillavano nella bocca semiaperta. «Io d’altra parte, caro professor Lazzari, sarei felice di poter contare sulla sua preziosa ed esperta guida per recuperare il lituo». Lazzari, stanco di muovere la testa da uno all’altro, prese a fissare un punto tra i due volti. I bambini sullo sfondo erano chiazze di colore in movimento. Le loro urla erano ricacciate indietro dal fischio che avvertiva urla erano ricacciate indietro dal fischio che avvertiva nelle orecchie. Era così agitato che temeva di essere sul punto di sve nire. «Come vedete le vostre scelte si riducono», riprese Prati. «Quando non si può scegliere, non si può sbagliare». Lazzari sussultò, perché quel modo di fare non era poi tanto diverso da quello del Colonnello e in fondo lui non aveva preso impegni precisi con nessuno. E poi il Colonnello, a quanto pareva, non era in grado di proteggerli. «Ma non siamo dei ricattatori», tenne a precisare Fazio. «Vi propongo un affare», disse Prati. E Fazio specificò: «Il venti per cento del nostro premio». «Tutto qui?», fece Artemisia con un sorrisetto cattivo. Seduta con le gambe accavallate e le braccia conserte, sfoggiava un’altera disinvoltura, come se fosse alle prese con due cacciatori di autografi. Lazzari, invece, era un groviglio di nervi e passava continuamente dalla rassegnazione alla voglia di replicare, la testa piena di ragionamenti e ipotesi che non arrivavano da nessuna parte. parte. Fazio annuì soddisfatto. Lazzari aveva capito che si trattava di uno di quelli che hanno sempre la risposta pronta, che desiderano essere messi alla prova seminando invitanti trappole in frasi all’apparenza chiare. «Stiamo parlando di duecentomila euro». «E non dimenticate l’altro bonus, che non ha valore», aggiunse l’altro. «O, almeno, ha il valore che gli intendete dare», commentò Fazio. «Sto parlando della vostra incolumità», chiarì Prati. «La vostra vita e duecentomila euro: ecco la nostra ultima proposta». Lazzari diede un colpo al tavolo e poi agitò la mano senza riuscire a trattenersi. «E se ci rivolgessimo alla polizia?». Prati si aggiustò gli occhiali sul volto, accennando un sospiro. «Caro professore, quando si inseguono bastoni millenari e segreti epocali, quando si ha a che fare con sanguinarie sette segrete e agenzie paramilitari come la nostra, conviene accettare il fatto che ben pochi sono disposti a darci credito: nessuno vi crederà». Lazzari provò a guadagnare tempo, mentre cercava di ragionare. «I miei libri li avete voi?» di ragionare. «I miei libri li avete voi?» «Siamo andati a prenderli per risparmiarle il disturbo. Li teniamo noi, ma sono a sua disposizione. Ha visto che servizio?», fece Fazio. Lazzari si picchiò i palmi contro la fronte. «E se non dovessimo accettare?» «Vi lasceremo andare», rispose tranquillamente Fazio. «Così potrete andare in caserma e dire che due uomini ben vestiti, ma che non sapreste riconoscere, vi hanno minacciati perché state cercando il bastone magico con cui il signor Romolo fondò la città di Roma, che tra parentesi non si chiama Roma. I carabinieri prenderanno nota, si scambieranno di nascosto sguardi divertiti, poi vi saluteranno garantendovi che faranno tutte le indagini del caso. Ossia nessuna». «Poi uscirete dalla caserma e penserete a un modo sicuro per lasciare la città». «Rinuncerete alla macchina per timore di trovarci là», fece Fazio. «Ed escluderete anche il treno, per gli stessi motivi», concluse l’altro. Lazzari, stupito, guardò Artemisia. Era proprio quanto avevano già fatto. La ragazza, però, teneva gli quanto avevano già fatto. La ragazza, però, teneva gli occhi fissi davanti a sé, rigirando tra le mani il cucchiaino del caffè. Pareva pronta a saltare alla gola di quei due munita solo di quell’arma improvvisata. «Alla fine prenderete un taxi», disse Fazio, «vi guarderete indietro, chiedendovi se vi stiamo seguendo». «Penserete di averla scampata». «Vi rilasserete, dimenticando che vi abbiamo già trovato per ben due volte: a Milano e qui». «Una volta a destinazione, scenderete da quel taxi e riprenderete la vostra vita, fino a un certo giorno». «Quel giorno, di ritorno dal lavoro o da una piacevole serata con gli amici, aprirete la porta di casa». «Vi toglierete la giacca, magari le scarpe, accenderete la luce, e sulla poltrona vedrete uno di noi». «E poi un piccolo bagliore». «Chiuderete gli occhi». «E non li riaprirete più». 14 Il cameriere ritirò le tazzine vuote e pulì sommariamente il tavolino di marmo con una spugna, poi si defilò goffamente, senza sapere dove guardare, e si scontrò con una sedia facendola cadere. Restò indeciso sul da farsi per alcuni istanti, gli occhi neri grandi come biglie; poi, per evitare ulteriori guai posò il vassoio, rialzò la sedia, riprese il cabaret e finalmente si allontanò rientrando nel bar. Appena la porta si richiuse Fazio indicò Artemisia e Lazzari: «Ma voi, signori, non vi alzerete da lì». «E invece lo faremo», disse Artemisia saltando in piedi. «E perché dovremmo farlo?», le domandò timidamente Lazzari lanciandole un’occhiata dubbiosa. «Come, perché dovremmo farlo?», lo assalì la ragazza, rossa in viso. Alcuni clienti si voltarono per osservare la scena. Un cane attaccò ad abbaiare senza che il padrone riuscisse a quietarlo. quietarlo. Lazzari allungò una mano verso i due paramilitari, cercando di assumere un’espressione conciliante nei riguardi della ragazza. «Loro mi offrono soldi, e inoltre protezione. Meglio amici in più, che nemici. Mi pare evidente». Artemisia era esterrefatta. Aprì e richiuse la bocca un paio di volte, prima di attaccare: «Ma che cazzo vorresti dire? Sei impazzito?» «Dico solo che dovremmo pensarci», rispose Lazzari facendo un rapido cenno che la ragazza non intese. «Forse non hai capito che...». «Signori», intervenne Prati, ma il compagno gli prese il braccio costringendolo a voltarsi. Si stavano avvicinando due poliziotti in divisa. Un passo avanti a loro camminava un ragazzone in borghese con barba, cappello e occhiali scuri. Lazzari riconobbe il barbuto e lo indicò ad Artemisia. «Ecco la nostra nemesi», balbettò in preda all’agitazione. «Merda, merda, merda! E ora?». Fazio si pulì i pantaloni da immaginarie briciole. «Signori, mantenete la calma. Non sono qui per noi». «Invece sì», obiettò Lazzari che tremava visibilmente. Ma allora era davvero un poliziotto il barbuto? E Ma allora era davvero un poliziotto il barbuto? E adesso? I tre uomini erano a circa venti passi di distanza. Ormai era chiaro che stavano puntando verso il loro tavolo. Prati fece per alzarsi, ma un poliziotto sollevò la mano per invitarlo a sedersi. Poi accadde tutto in un istante. Fazio rovesciò il tavolino e si fiondò con il compagno dalla parte opposta, mentre i due poliziotti si lanciarono all’inseguimento intimando più volte l’alt. Correvano con una mano sulla fondina, i cinturoni che sobbalzavano pesantemente, sotto gli sguardi allibiti di una piccola folla radunatasi davanti al dehors del bar, che vociava e si domandava cosa fosse accaduto. Prima ancora di vedere dove fossero diretti i poliziotti, Lazzari scavalcò con un balzo goffo le fioriere e scattò verso la via che correva perpendicolarmente alla piazza, con Artemisia al seguito. Il barbuto si affrettò dietro di loro. «Fermi!», gridò un paio di volte, ma la sua voce fu coperta dalla confusione generale. «Merda!», imprecò Lazzari. Si sentiva lento e alle sue spalle i passi dell’inseguitore erano sempre più vicini. Ormai erano in trappola. Ormai erano in trappola. Oltrepassò la porta del bar che si affacciava su quella strada proprio qualche secondo prima che uscisse il cameriere spilungone con il conto in mano. Il ragazzo non si accorse dell’uomo con la barba che stava arrivando di gran carriera, né il barbuto riuscì a evitarlo. Persero entrambi l’appoggio, slittarono sull’acciottolato e caddero a terra allacciati l’uno all’altro. «Più veloce!», urlò Lazzari alla ragazza ricominciando a sperare. Artemisia lo raggiunse e lo superò. Guadagnò rapidamente terreno e svoltò per il vicolo che passava sotto le mura; ogni tanto si voltava rallentando per incitare il compagno e non perderlo di vista. «Muoviti», gli gridò, una volta arrivata all’auto. Lazzari annaspava. La tensione e il poco allenamento lo avevano stremato. Quando fu a pochi metri da lei, le lanciò le chiavi. Artemisia le prese al volo, aprì, mise in moto e fece retromarcia. Lazzari saltò su e partirono. «Non prendere l’autostrada, se la polizia conosce la nostra macchina saremmo in trappola», le disse tenendosi il fianco, la milza in fiamme. «E allora dove vuoi che vada?» «Prendi per Santo Stefano di Magra, ecco, di là». «Prendi per Santo Stefano di Magra, ecco, di là». «E dove si va poi?» «Nell’entroterra. Posti sicuri. Mille vie». A ogni frase, faceva una pausa per riprendere fiato. Artemisia alzò la voce: «E poi?» «Poi non so, intanto gira di qui per la provinciale». Artemisia scalò e svoltò. La strada puntava dritta verso le colline. Muri grigi e tetti rossi scorrevano via rapidamente ai lati dei finestrini. In tono nervoso, disse: «Dobbiamo pensare a un nuovo piano, non possiamo limitarci a fuggire». «Lo dici a me? Io volevo solo starmene in pace a vendere vino». «E anche da quello sei scappato alla prima occasione». «Mi avete costretto». «Vuoi fuggire davvero? Va bene, ti accontento subito», promise Artemisia e premette l’acceleratore. Guadagnò rapidamente velocità, superò un furgone e prese la curva successiva a ottanta all’ora. Lazzari puntò i piedi e si aggrappò ala maniglia. «Frena, frena!». L’auto sfrecciò ai limiti della carreggiata sollevando schizzi di ghiaia. Un uomo in bicicletta si fermò per maledirli. maledirli. Lazzari sentì la paura trasformarsi inaspettatamente in rabbia. «Se non vuoi frenare, allora accelera. Forza! Vediamo dove arrivi», disse e con la mano le spinse la gamba con cui pigiava l’acceleratore. L’agitazione gli aveva dato al cervello come il più potente dei vini. «Quei figli di puttana hanno osato trattenerci come fossimo ostaggi», disse infine Artemisia e, liberandosi della mano di Lazzari, rallentò di colpo. «Almeno ora sappiamo per chi lavora il barbuto. È della polizia. Chissà, magari siamo finiti in un’inchiesta sul riciclaggio di opere d’arte e reperti archeologici». Artemisia inarcò le sopracciglia, come spesso fanno le donne di fronte alle ingenuità maschili. «Ma se non abbiamo rubato niente». «Però abbiamo intenzione di farlo». «Vogliamo solo ritrovare il lituo». «O lo custodisce un uomo o la terra: in entrambi i casi si tratta di appropriazione indebita». «Inutile perdere tempo con queste supposizioni. Dimmi piuttosto: davvero volevi accordarti con quei due bastardi?». Lazzari deglutì. «Volevo solo prendere tempo». «Non mi pare... Secondo me eri pronto a calarti i «Non mi pare... Secondo me eri pronto a calarti i pantaloni». «Quando eravamo al bar, avevo visto da lontano i poliziotti avvicinarsi, ben prima che se ne accorgessero Fazio e Prati». «Li hai visti all’ultimo invece». «Se è questa la tua idea, non sarà certo io a fartela cambiare. In ogni caso quei due senza volerlo ci hanno aiutato: se non fossero scappati attirando i sospetti su di loro, i poliziotti avrebbero beccato noi». Artemisia non riusciva a scacciare il fastidio. «E con che accusa?» «Non capisci? Credono che siamo stati noi ad ammazzare Achille Vento». «No, non capisco proprio». «Io sì, invece. Il barbuto ci sta dietro fin dal principio anche se non so proprio il perché. Chissà, forse indagava su un traffico di reperti e oggetti d’arte rubati e magari qualcuno gli ha spifferato delle nostre intenzioni di mettere le mani sul lituo. Non lo so... Ma ora ci bracca anche per l’accusa di omicidio. Lui ci ha visti nell’appartamento di Vento!», disse Lazzari prima di voltarsi di colpo verso la ragazza. «Un momento, e se quell’uomo fosse invece della Confraternita? In questo quell’uomo fosse invece della Confraternita? In questo caso...». «Lascialo perdere, ti ho detto», lo interruppe in modo brusco Artemisia. «Pensiamo piuttosto a quei due bastardi che ci hanno sequestrato». «Ci penso, non ti preoccupare. Quei due ci stanno addosso per costringerci a lavorare per loro. E forse, se dobbiamo fidarci di quello che ci hanno detto, ci stanno dando la caccia pure quelli della Confraternita, barbuto o non barbuto. Siamo braccati, ti rendi conto!». «Della polizia non ti preoccupare. Il Committente può risolvere facilmente il malinteso». «Allora digli di farlo, e in fretta anche!!». «Gli chiederò anche di occuparsi dei paramilitari. Ci sarà pure un modo per sbarazzarcene». «Sbarazzarcene?», disse Lazzari e poi ammutolì. Possibile che lei non si rendesse conto del grosso guaio in cui si erano cacciati? Sembrava quasi che qualcuno la avesse addestrata a non avere paura. O forse non era questione di addestramento. Forse lei era dotata di un istinto e un’intelligenza nell’affrontare la vita che lui non possedeva. Che avrebbe dovuto fare? Raccontarle della paura folle che gli bruciava dentro? Era inadeguato, sempre in ritardo su tutto, ansioso, pieno di inadeguato, sempre in ritardo su tutto, ansioso, pieno di dolori veri o presunti, e di ogni possibile timore... Si guardò attorno, come un cane in gabbia, poi qualcosa colpì prepotentemente la sua attenzione. «Fermati un attimo qui, ti prego Artemisia». La ragazza si stupì di essere stata chiamata per nome: Lazzari non lo faceva mai. Accostò in un piccolo slargo. Sopra di loro si stagliava la sagoma di una pieve medievale. Una costruzione semplice, una capanna di pietre che pareva immutata da mille anni, un posto dove ci si sarebbe aspettati di veder passare un pellegrino con il suo bastone. Lazzari saltò giù dall’auto, imboccò la ripida rampa e si infilò in chiesa. La ragazza si sorprese di vederlo uscire con gli occhi rossi qualche minuto più tardi. Risalì e ripartirono senza una parola. La strada, dopo un paio di tornanti, correva dritta lungo la cresta di una collina. Il sole ravvivava il verde sterile degli arbusti. Il mare si allontanava e si allargava all’orizzonte. «A che stai pensando?», gli chiese Artemisia dopo un po’. Lazzari si morse le labbra. «Che non voglio finire come Parodi e Vento». come Parodi e Vento». Accostarono quasi un’ora più tardi ai bordi della strada e scesero per sgranchirsi le gambe. La provinciale, sotto di loro, era la scia fumosa di un aeroplano che spariva lentamente nell’aria. Tutto sembrava sospeso. Artemisia gli passò una mano sulla nuca. «E ora che cosa facciamo?». Lazzari indicò a sud con la testa. «Cerchiamo il Lupo Marsicano. Quello che ha scavato questo complesso di tombe per Parodi e ha ritrovato il medaglione. È l’unica pista che abbiamo». «Allora tu non sei superstizioso come Parodi». «Com’era... vorrai dire», disse tristemente Lazzari. «Merda, siamo noi che abbiamo portato da lui quei bastardi». «Non farti carico di colpe che non hai. Aveva ottant’anni e gli abbiamo regalato le sue ultime emozioni. Era felice come una Pasqua, sarebbe perfino venuto con noi se avesse avuto qualche anno in meno». Lazzari scosse la testa e cambiò discorso: «Dobbiamo scovare il Lupo prima dei paramilitari». «Ma come? Pensavo volessi abbandonare qualsiasi ricerca...». ricerca...». «Ho scelta?» «In realtà sì», ammise Artemisia. Per la prima volta affiorò un tono di stanchezza nella sua voce. «Posso parlare con il Colonnello e sistemare le cose». Lazzari raccolse un sasso, senza smettere di scrutarla. «Hai questo potere?» «Posso procurarmelo. Non preoccuparti di questo. Il Committente ha un debole per me. Sai come sono gli uomini...». «A dir la verità no. Ho passato tanto tempo lontano dagli uomini. E poi... Se oggi davvero decidessi di mollare e tornare indietro, a Cesenatico, da domani comincerei a guardare la porta della mia enoteca chiedendomi chi sarebbe il prossimo a entrare: i due paramilitari, il Colonnello oppure il barbuto. All’inizio proverei quel misto di paura e ansia che così tante volte mi ha tormentato negli ultimi anni, poi inizierei a svegliarmi nel cuore dela notte, in preda agli attacchi di panico, a vedere fantasmi ovunque, e ad aver paura della mia ombra; e infine, forse, finirei per invocare il loro arrivo». «Quindi mi stai dicendo che intendi proseguire?». Artemisia scuoteva la testa, mentre un sorriso si posava sulle sue labbra. Lazzari adorava quel suo modo sulle sue labbra. Lazzari adorava quel suo modo repentino di voltare pagina, come se ogni minuto non fosse figlio del precedente. «Quando senti chiamare il tuo nome, che altro puoi fare?», domandò Lazzari stringendosi nelle spalle. Artemisia si accigliò di nuovo. «Parli del destino?» «No, parlo di te». 15 Lazzari guidava adagio, aspettando il tramonto, mentre si inoltrava nella Garfagnana, una terra felicemente appartata, incastonata tra Appennini ed Alpi e coperta di alberi. Il posto ideale per nascondersi: anfratti, piste sterrate, sentieri che si perdono nei boschi, fiumi che diventano laghi, paesi chiusi e arroccati, frazioni sperdute. Prese una delle svolte della regionale e scelse un borgo a ridosso del fiume Serchio per passare la notte. Roseti e rampicanti rivestivano le basse case in pietra. Il fumo dei camini vagava oltre i tetti, congiungendosi alla foschia che si sollevava dal fiume, mentre luci dorate si accendevano alle finestre una dopo l’altra. Lasciarono l’auto a un chilometro di distanza dal centro del paese, al principio di una strada in terra battuta che conduceva chissà dove. Evitarono la pensione e presero una stanza in affitto da una signora che non chiese loro i documenti. Aveva modi di fare spicci ma gentili, e a Lazzari ricordò la signora Fattori. spicci ma gentili, e a Lazzari ricordò la signora Fattori. Cenarono in una trattoria con i tavoloni di legno ricoperti dall’incerata, in compagnia di una settantenne azzimata, che ogni tanto usciva a fumarsi una sigaretta, e di una coppia di adolescenti che si strinsero per tutto il tempo la mano. Artemisia provò a conversare con la signora, ma quella si limitava per lo più a sorridere sbattendo le ciglia stillanti mascara. Più tardi passeggiarono per le stradine deserte. I pochi lampioni fendevano la nebbia sempre più fitta. L’aria era fredda, ma nessuno dei due pareva aver fretta di tornare nella piccola stanza dale pareti umide. Si fermarono sul ponte medievale che collegava le due parti del borgo. Artemisia si issò con le mani e si sedette sul parapetto. «Adesso che Parodi è morto, come faremo a scovare quel tombarolo? A quanto pare, è uno che usa mille precauzioni e, una volta che verrà a sapere della morte di Parodi, diverrà uccel di bosco». «Temo non esistano più boschi sicuri dove rintanarsi». «E quindi come pensi di procedere?» «Andiamo a Ocre di Leonessa», rispose Lazzari indicando le montagne che chiudevano la valle a meridione. «Lì conosco un archeologo che potrebbe meridione. «Lì conosco un archeologo che potrebbe aiutarci. Si chiama Mario Foglia, ma tutti lo conoscono come il Maestro. Ha una cultura sconfinata ed è anche una sorta di rabdomante». «In che senso?» «Riesce a individuare la presenza di tombe antiche nel terreno. Non so come faccia». «Magia?» «Non la chiamerei così». «Lavora per i tombaroli?» «Stai scherzando? È il loro peggiore nemico. Li combatte da una vita. Ma sai come vanno le guerre... si finisce con il conoscere i propri nemici». Artemisia allungò le gambe piegandosi all’indietro e Lazzari scattò d’istinto per afferrarla. «Non cado, tranquillo». «Lo diceva anche Icaro». L’espressione della ragazza mutò all’improvviso. «Per te questo non è più un lavoro, vero?» «Non lo è mai stato. E per te?» «Mio padre direbbe che è un capriccio. Ma a me la vita piace così». Lazzari si infilò le mani in tasca e rivolse lo sguardo verso i boschi. La bruma nascondeva i tronchi e le verso i boschi. La bruma nascondeva i tronchi e le chiome tonde parevano fluttuare come verdi meduse. «Mi hai stupito oggi. Corri come un ghepardo». «Da ragazzina ero quel che si dice una speranza dei quattrocento metri. Ho vinto molte gare». «E poi?» «Non ho sentito il bisogno di vincerne altre, ma non ho mai smesso di correre». «Me ne sono accorto». Artemisia balzò a terra e si pulì le mani una contro l’altra. «Non mi pare». Tornarono nella loro stanza. I due letti in ferro battuto erano addossati alle opposte pareti. In mezzo c’era un tappeto logoro e un pesante comodino di legno. Il vetro dell’abat-jour era offuscato da uno strato di polvere. Spensero la luce e si sdraiarono ancora vestiti. «Secondo te ci troveranno?», domandò Artemisia dopo alcuni minuti. Lazzari fu sorpreso dalla domanda. «Qui? In questo posto? No, non credo...», disse ostentando una sicurezza che non possedeva. Ma era stanco della propria paura: lo accompagnava costantemente. Decise propria paura: lo accompagnava costantemente. Decise di continuare a mentire: «Io penso che ci siamo guadagnati un paio di giorni di tranquillità». «Davvero?», fece Artemisia, forse avvertendo la nota insincera nella voce. «Dobbiamo solo trovare il Lupo prima di loro». «Pensi che vorrà guidarci in quelle tombe?» «Non so se vorrà, ma noi possiamo pagarlo abbastanza?» «Possiamo comprarlo». «Allora lo convinceremo a farci da guida. Sappi però che non so cosa troveremo là sotto». Lazzari tese un braccio e Artemisia gli accarezzò le dita, un gesto dal sapore consolatorio: Lazzari avvertì l’assenza di passione e ne fu ferito. «Però sento che lo immagini...». «Lo sai che non mi faccio una domanda prima di avere trovato la risposta», le ricordò Lazzari ruvidamente. Artemisia gli sfiorò il palmo come se potesse leggerlo, poi gli lasciò andare la mano. Intuendo il suo risentimento disse: «Dobbiamo stare concentrati sul lavoro, non siamo bambini. Quello che è successo in quel casolare... è stato un incidente, piacevole, ma pur sempre un incidente». un incidente». «Parla per te», disse Lazzari. «Non fraintendermi... Non intendo che non abbia significato niente, ma...». «Ma?». Non arrivò risposta. Qualche minuto più tardi, con la voce roca di chi parla nel sonno Artemisia aggiunse: «In ogni caso... Se non fosse stato per te me la sarei persa... qualunque cosa sia stata». Si svegliarono all’alba. La luce che penetrava dalle persiane sembrava portare con sé anche spifferi gelati. L’umidità era un’edera incollata alle pareti. Il boiler emetteva un fischio acuto e non funzionava. Si lavarono con l’acqua fredda imprecando a denti stretti. Artemisia si accorse della tensione di Lazzari, molto diversa da quella che aveva imparato a conoscere. Il silenzio non faceva che amplificarla. «Ho fatto un sogno strano stanotte. Posso raccontartelo?», gli domandò con il tono di chi cambia discorso al termine di un’infinita discussione. «No, i sogni hanno significato solo per il sognatore», tagliò corto Lazzari e finì di preparare il bagaglio. Artemisia si avvolse i capelli in un asciugamano e uscì dalla vasca nuda e gocciolante. Con l’aria di una Venere dalla vasca nuda e gocciolante. Con l’aria di una Venere sofisticata e annoiata dall’ingenuità maschile disse: «Mi dispiace che tu abbia pensato a qualcosa d’altro tra noi». «Io non pensavo niente», farfugliò Lazzari. Poi agguantò le valigie e uscì senza chiudersi la porta alle spale. Artemisia lo raggiunse in strada mezz’ora più tardi. Filamenti di nebbia si alzavano dal fiume. I campi che circondavano il borgo erano lucidi di brina. Si strinsero nelle giacche e batterono i piedi intorpiditi. Oltre la foschia le guglie di roccia emergevano come torrioni di spettrali fortezze. Si incamminarono verso la macchina senza parlare. Al centro del ponte che univa le due parti del borgo distinsero una figura massiccia affacciata al parapetto. Erano a pochi passi di distanza, quando l’uomo si voltò. Aveva la barba e indossava un cappellino da baseball verde con una D rossa per stemma. Lazzari lasciò cadere le borse e si voltò per fuggire, finendo a sbattere contro Artemisia, che era rimasta ferma. «Prova a scappare un’altra volta e giuro che ti sparo», gli urlò il barbuto armando il cane della pistola. «Ora seguitemi», aggiunse dopo che Lazzari si fu voltato, «Ora seguitemi», aggiunse dopo che Lazzari si fu voltato, e abbassò l’arma. Lazzari si guardò attorno. Il fiume scorreva su un letto di pietre: buttarsi equivaleva a sfracellarsi. La nebbia, però, si addensava rapidamente intorno al ponte nascondendo il paesaggio circostante. Se fosse riuscito a colpire o a distrarre il barbuto in qualche modo, forse lui e Artemisia ce l’avrebbero fatta a scappare. Avvertì un’inaspettata fiammata di temerarietà e prese per mano la ragazza. Che cosa aveva da perdere ormai? «D’accordo», disse Lazzari, e lasciò scivolare una mano sulla balaustra. Fece pressione e sentì sotto le dita una delle pietre traballare: strinse più forte, la staccò stando bene attento a non produrre il minimo rumore e cercò di impugnarla saldamente senza farsi accorgere. Infine tirò il fiato, pronto a lanciare il sasso. Tutto quello che serviva era un movimento repentino e fluido. «Sei della polizia?», domandò al barbuto per distrarlo, ma non aveva nessuna intenzione di ascoltare la risposta. Quell’uomo, ormai se ne rendeva conto, non era affatto dele forze dell’ordine; la quieta minacciosità che esprimeva faceva pensare a un altro genere di persona, forse apparteneva veramente alla Confraternita. Ma in quel momento non aveva importanza. Ancora un Ma in quel momento non aveva importanza. Ancora un istante, il tempo di un’ultima preghiera, e avrebbe scagliato la pietra, poi sarebbe corso via con la ragazza. Confidava nel fatto che mancare il bersaglio a quella distanza era impossibile e che nessuno, nemmeno quel tizio, sarebbe stato in grado di schivare un sasso e insieme mirare con precisione. Artemisia avvertì l’improvvisa tensione nei muscoli del compagno e lo bloccò con un gesto gentile ma deciso. Lazzari la guardò e si sentì mancare il respiro. Schiuse le labbra, ma non ne uscì alcun suono. «Mi dispiace», sussurrò, e lo costrinse a lasciar cadere la pietra che impugnava. Il rumore con cui colpì l’acciottolato arrivò alle orecchie di Lazzari come l’ultimo rintocco di una campana che si smorzava in lontananza. «Avrete modo di spiegarvi in macchina», tagliò corto il barbuto invitandoli con cenni impazienti a precederlo sul ponte. «Muoviamoci. Non ho intenzione di farmi sorprendere dagli agenti della Tauros». «Tauros?», fece Artemisia. «I due simpaticoni che vi hanno offerto il caffè ieri a Sarzana. Forza, muoversi». Sarzana. Forza, muoversi». Lazzari raccolse come un automa le borse e si avviò con passo pesante. La nebbia gli bagnava le guance. O forse erano solo lacrime. Non sapeva più in quale gioco era finito né chi fossero le persone che camminavano dietro di lui. Le udì scambiarsi alcune parole dure, ma non ne distinse il senso. Provò a concentrarsi: ogni pensiero, però, pareva dissolversi sul nascere. «Il Colonnello me ne dovrà rendere conto», si lamentava Artemisia. «È stata una decisione mia. La situazione è cambiata», tentava di spiegarle il barbuto. Lazzari si accorse di avere anche la borsa di Artemisia in mano: la aprì di colpo, come se l’impugnatura fosse stata rovente, e la lasciò cadere a terra. Sentì qualcuno raccoglierla alle sue spalle e subito dopo la voce di lei: «Si può sapere che ti prende? Ti avevo detto di non preoccuparti...». Ci fu un doppio suono elettronico e poi due luci arancioni lampeggiarono nella nebbia. «Lasceremo qui la vostra auto. Poi manderò qualcuno a recuperarla», spiegò il barbuto aprendo il portellone posteriore del fuoristrada. L’ammaccatura sul muso era stata riparata, ma in modo sommario. C’erano ancora i segni dello ma in modo sommario. C’erano ancora i segni dello speronamento di Milano. Lanciò le borse dentro e lo richiuse. «Tu, man, davanti con me», disse a Lazzari assestandogli sul petto quella che voleva essere una manata amichevole. «Non mi sembri il genere di uomo che si prende la briga di voltarsi per litigare». «Non sottovalutarlo...», disse Artemisia. «Fino a oggi non ho fatto che sottovalutarlo, e per poco io non ci ho rimesso l’ingaggio e lui la testa». Appena saliti in auto, il barbuto si tolse il cappellino e lo gettò fuori dal finestrino. Poi aprì lo sportello davanti alle ginocchia di Lazzari, ne tirò fuori uno blu senza scritte e lo indossò. «È il mio portafortuna», spiegò senza rivolgersi a nessuno in particolare. «Uno nuovo all’inizio di ogni missione». Aveva folti capelli scuri, occhi castani e un ricordo di acne che la barba non riusciva a mascherare del tutto. C’era una forza trattenuta in ogni suo gesto, come se fin da bambino avesse imparato quanto potesse fare male agli altri, anche involontariamente. Lazzari si sentiva un peso piuma accanto a quel’Ercole in occhiali scuri e cappello. «Per chi lavori?», gli domandò Lazzari con voce «Per chi lavori?», gli domandò Lazzari con voce spenta. «Per te, non te l’ha detto?», gli domandò il barbuto indicando con la testa il sedile posteriore. «È lui l’uomo delle spiegazioni», si limitò a ribattere Artemisia accennando a Lazzari, che non si voltò. Stanco di quel gioco, il barbuto si rivolse direttamente a Lazzari: «Per il momento ti basti sapere che sono la vostra guardia del corpo. Parleremo dopo, sulla strada. Prima dimmi quale strada, però». Lazzari indicò la nebbia davanti a sé con una smorfia ambigua. «Andiamo a Ocre di Leonessa, in provincia di Rieti», si inserì Artemisia. «Perché là?» «Andiamo a caccia di lupi», rispose lei. 16 Lazzari si sentiva la penisola di un continente sommerso, mentre sedeva con le guance strette tra i pugni sotto il portico di una locanda sulla cima di un colle perso nella campagna umbra: un posto per centauri, a giudicare dal numero di moto parcheggiate in ordine sparso davanti all’ingresso. La strada era un nastro srotolato verso il basso. Il cielo era terso e orlato da poche nuvole bianche. Dino Vermiglio, così aveva detto di chiamarsi il barbuto, era entrato a ordinare. Artemisia rivolgeva lo sguardo al sole e non parlava. Due motociclisti con la parte superiore della tuta slacciata sorbivano birra seduti sulla staccionata e intanto la tenevano d’occhio. Lei e Lazzari si erano scambiati appena un paio di parole durante il viaggio. Gli pareva che non ci fosse più nulla da dire. A che potevano valere le spiegazioni? Nessuna domanda lo avrebbe avvicinato di un centimetro alla verità. Dino Vermiglio uscì spingendo la porta con un piede, Dino Vermiglio uscì spingendo la porta con un piede, tra le mani un grande vassoio su cui c’erano un filone di pane, un tagliere, un salame, un coltello, due medie chiare e una bottiglia di Coca-Cola. Si sedette a cavalcioni sulla sedia e iniziò ad affettare. «Non ti chiederà nulla, lo conosco», esordì all’improvviso Artemisia. Spostò la sedia e si avvicinò a Dino. «Spiegagli tu come stanno le cose. Ci risparmieremo tempo e fastidi». Dino si ficcò una fetta di salame in bocca e annuì guardando Lazzari, che gli sedeva di fronte. «Lavoro per il Colonnello». «Questo spiega ogni cosa», lo interruppe in modo brusco Lazzari, lasciando intendere che per lui non c’era bisogno di aggiungere altro. «Faccio parte dell’operazione fin dal principio. C’ero anch’io a Cesenatico», continuò Dino ignorando il messaggio dell’altro. «Sono entrato nel tuo appartamento mentre non c’eri e ho invertito le colonne dei libri accanto alla finestra. Il Colonnello era certo che la cosa ti avrebbe per lo meno incuriosito. Poi mi sono fatto vedere dalla tua padrona di casa, e la sera ho sparato quel colpo in aria nel vicolo dall’altra parte della strada. Tutte operazioni di guerriglia psicologica: servivano per Tutte operazioni di guerriglia psicologica: servivano per convincerti». «Si è convinto facilmente», disse Artemisia, mentre con la punta del coltello incideva il tavolo, ricoperto di date e scritte. «L’uccello nascosto nel cespuglio sente il rumore del cacciatore e si spaventa, allora abbandona il riparo per scappare e questo gli è fatale», spiegò Dino, indicando Lazzari con il coltello con cui stava affettando il pane. «Molto meglio rimanere nel cespuglio. Tieni a mente questo consiglio, man». Un paio di Harley ripartirono in uno scoppiettare di motori. Lazzari le seguì con lo sguardo fino al primo tornante. Nel frattempo arrivò la cameriera con un’altra Coca, oltre a un vassoio pieno di carne alla brace e verdure grigliate. Dino si attaccò direttamente alla bottiglia di Coca. «Spero di avere indovinato i vostri gusti». Artemisia e Lazzari mossero entrambi le mani verso le verdure. Lazzari la ritrasse per primo e prese il boccale. La schiuma si era ritirata e ora striava appena la superficie del liquido ambrato. «Vi sono sempre stato appiccicato, giorno e notte, come un angelo custode», proseguì Dino. «Gli ordini del come un angelo custode», proseguì Dino. «Gli ordini del Colonnello erano questi. A Milano ho avvistato per la prima volta i due agenti della Tauros. Tenevano sotto controllo la casa di Achille Vento. Ho occhio, io, per gli ex militari. Hanno tutti un’aria terribilmente professionale, e questo li frega. Non sapevo cosa pensare, ma intuivo che da gente simile non potevamo aspettarci nulla di buono. Quando li ho visti entrare nel portone di Vento ho chiamato la polizia e poi ho dato fuoco al cestino dei rifiuti per avvertirvi. Come immaginavo, i due della Tauros si sono allontanati alla prima sirena. Così vi ho salvato la prima volta». «Per poco non ci arrestavano», borbottò Lazzari facendo scorrere il dito sul bordo del boccale. «Quando stavano per intercettarti davanti a Sant’Ambrogio li ho speronati, e così ti ho salvato per la seconda volta. Nel frattempo il Colonnello aveva svolto le sue indagini appurando che quei due tizi erano della Tauros, un’agenzia paramilitare che si occupa di spionaggio industriale, dossieraggio e altre cosette poco piacevoli. Sono stati ingaggiati da un concorrente. Non si sa come, ma qualcuno è venuto a sapere della nostra operazione e si è messo in testa di impadronirsi del lituo». «Non sappiamo ancora niente su chi siano?», «Non sappiamo ancora niente su chi siano?», domandò Artemisia. «Non ancora, ma vi posso dire una cosa: si tratta di qualcuno di poco raccomandabile. I generali si riconoscono dagli ufficiali che scelgono. Quelli della Tauros sono tipi estremamente pericolosi, gente che lavora sporco. Per questo il Colonnello vi ha consigliato di rinunciare, ma voi avete scelto altrimenti». «Scelto? Io non ho scelto propria nulla», si lamentò Lazzari. Dino continuò imperturbabile. «Vi ho seguito fino a Bologna e poi vi ho preceduti a Sanremo...». Lazzari si riscosse di colpo dal torpore con cui aveva ascoltato il racconto. «Come facevi a sapere che saremmo andati lì?» «Mi ha avvertito Artemisia», confidò tranquillamente Dino. Lazzari la guardò in faccia per la prima volta da quando avevano lasciato la Garfagnana. Lei sostenne lo sguardo con disinvoltura. «Motivi di sicurezza», disse. «Ma sono arrivato tardi», riprese Dino. «Gli agenti della Tauros avevano già ripulito il tuo magazzino. Ho tentato di fermare il loro furgone, ma ho fallito». «La sparatoria di cui hai letto sul giornale...», spiegò «La sparatoria di cui hai letto sul giornale...», spiegò Artemisia a Lazzari. «Perché gli hai detto che saremmo andati a Sanremo?». La voce di Lazzari rivelò tutta la delusione, ormai priva di rabbia, di chi si sente tradito da qualcuno di insospettabile. «Non lo immagini?», fece Artemisia. Dino non si lasciò turbare da quello scambio di battute, che svelava fin troppo la natura del rapporto tra i due, e insistette nel racconto. «A Sarzana la situazione si è fatta complicata, quando vi hanno sequestrato al bar. Pericolo nove in una scala da uno a dieci. Non sapevo come tirarvene fuori. Non potevo certo ingaggiare uno scontro a fuoco in pieno giorno. Allora mi sono rivolto alla polizia dicendo che avevo visto due uomini puntare la pistola contro una coppia di turisti stranieri. Così vi ho salvati per la terza volta». «Come fanno a starci sempre attaccati al culo e addirittura ad anticiparci? Sei tu a passargli le informazioni?», lo attaccò Lazzari. Dino smise di masticare perdendo di colpo l’espressione bonaria: deglutì, bevve un sorso di Coca, si passò il tovagliolo sulla barba e infine si aggiustò il cappellino. «Capisco che tu ti senta scavalcato, man, ma cappellino. «Capisco che tu ti senta scavalcato, man, ma non è colpa mia. Avevo degli ordini precisi da parte del Colonnello: scortarvi senza farmi vedere. Non piacevano nemmeno a me, ma non sono pagato per esprimere il mio parere: sono pagato per tenere gli altri in vita. Il compito, al momento, è assolto. Se non avessimo agito in questo modo forse qualcuno di noi ora non sarebbe seduto a questo tavolo. Il Colonnello è indecifrabile, ma sa il fatto suo. Non ha mai fallito una missione». Lazzari posò il boccale. «Mi stai dicendo che dovrei ringraziarti?» «Man, ti sto dicendo quello che hanno detto a me in Africa: ringrazia ogni giorno di essere vivo». «Cerca di capire», lo incalzò Artemisia. «Io capisco tutto, ma perché non dirmi che avevamo una guardia del corpo al seguito?» «Non è necessario che tu sappia tutto, ricordi?», lo stuzzicò Artemisia. «E poi l’idea è stata del Colonnello: te l’ha detto anche Dino». «Non sapevamo da dove potesse arrivare un eventuale pericolo: con il senno di poi possiamo dire che è stata un’ottima strategia. Se ci avessero visti insieme fin dal principio, io non avrei potuto aiutarvi come ho fatto. A Milano e a Sarzana saremmo finiti in trappola», spiegò A Milano e a Sarzana saremmo finiti in trappola», spiegò Dino. «D’accordo non farci vedere insieme, ma perché non mettermi a conoscenza del piano?», insistette Lazzari. «Il Colonnello non voleva: forse non si fida del tutto di te», aggiunse Artemisia. «Lui non si fida di me? Lui non si fida di me?» «Be’, a Sarzana sembravi pronto a schierarti con quelli della Tauros». «Roba da pazzi!», sbottò Lazzari scuotendo la testa. Poi più calmo: «E ora cosa è cambiato?». Dino ripulì il piatto con un pezzo di pane. «I paramilitari della Tauros hanno scoperto che avete un angelo custode al seguito. Una volta giocato, l’asso non può essere rimesso nella manica. Meglio stare uniti: ora il pericolo aumenta». «Ho fatto da esca in poche parole», li accusò Lazzari, ma qualcosa nello sguardo che passò tra Dino e Artemisia gli fece intuire di avere sparato a salve. Era stato manipolato ancora più di quanto sospettasse. Non aveva capito nulla: non era l’esca, ma il pesce e per di più aveva abboccato fin dal primo giorno. E ora non era che una marionetta nelle mani del Colonnello... «C’è qualcosa che non so, vero?», domandò. qualcosa che non so, vero?», domandò. Artemisia e Dino continuarono a guardarsi, senza che nessuno dei due si decidesse a parlare. Lazzari, allora, sfoggiò un sorrisetto molto simile a una smorfia, e si lasciò andare contro lo schienale alzando gli occhi. «Molto bene, non fa niente», disse infine con fare allusivo. Anche lui era a conoscenza di qualcosa che loro due non sapevano. Appena furono in auto, Lazzari reclinò il sedile, forzò uno sbadiglio, chiuse gli occhi e consigliò ad Artemisia di fare altrettanto. «Svegliami quando saremo a qualche chilometro da Leonessa». «Se mi dici l’indirizzo preciso, ti sveglio direttamente a destinazione», si intromise Dino indicando il navigatore. Lazzari lo studiò con un occhio solo: la sua ironia non era mai chiara. «Il posto dove dobbiamo andare non è segnato su nessuna mappa», spiegò Lazzari a Dino. Dino scosse la testa. «Non ci sono segreti per i satelliti». «Per fortuna esistono segreti impenetrabili anche per «Per fortuna esistono segreti impenetrabili anche per la più sofisticata delle macchine», disse Lazzari. «Che cosa vuoi dire?», gli chiese Artemisia. «Sto già dormendo, mi spiace», sussurrò Lazzari e chiuse anche l’altro occhio. Quando li riaprì, due ore più tardi, impiegò qualche secondo per scavare nella sua memoria e riconoscere la facciata pallida del duomo di Terni. Una serie di palme si sta gliavano contro il porticato del Bernini. «Che ci facciamo qui?», domandò a Dino, che sedeva al suo fianco con le mani sul volante. «I turisti», rispose il barbuto e gli indicò Artemisia che usciva da un bar sull’altro lato della strada. Si era cambiata e ora indossava un giubbotto di pelle sopra i jeans sbiaditi e strappati. La temperatura era decisamente più primaverile da quelle parti. «Pensavo comandassi tu», disse Lazzari. «Pensavi male, man». «Non è una novità». «Possiamo andare», disse lei risalendo in auto. «Non ancora», fece Lazzari e saltò giù. Attraversò la strada sbattendo i piedi per recuperare sensibilità, entrò nel bar e ordinò un caffè doppio. Lo sensibilità, entrò nel bar e ordinò un caffè doppio. Lo bevve, andò in bagno e quando uscì ne ordinò un altro. Quanti ne servivano per svegliarsi da quell’incubo? Si specchiò nei ritagli di vetro che facevano capolino tra le bottiglie. Gli occhi tradivano il vacuo luccichio dello sbandamento, che lo assaliva ogni volta che era a un passo dal mandare al diavolo tutto quanto. Uscì senza prendere il resto. La macchina era sparita. Meglio così. Riparò in chiesa e si sedette nel’ultimo banco. Abbassò la testa e allargò le braccia. Non sapeva nemmeno lui cosa dire: era andato tutto storto, ancora una volta. Ma in fondo era entrato per cercare un’ispirazione e così raggiunse il leggio davanti al pulpito. Il messale era aperto sul brano delle vergini che si addormentano in attesa delo sposo. Tutte e dieci si lasciano andare al sonno, ma cinque di esse conservano olio nelle loro lampade e all’arrivo dello sposo possono accendere le lampade ed entrare con lui. Chi brucia vive. Occorre ardere per vivere. Tornò fuori con un altro piglio. Il fuoristrada era fermo davanti al sagrato con la portiera aperta. Saltò su e ripartirono. Nessuno gli disse niente. Abbassò il parasole per ripararsi dai raggi obliqui del tramonto. per ripararsi dai raggi obliqui del tramonto. «Tieni», gli disse Artemisia dopo un po’ porgendogli un pacchetto. Lazzari lo prese e lo scartò senza dire una parola. Dentro un’elegante confezione c’era un paio di occhiali da sole. Li infilò e si specchiò. Ora almeno non doveva fissare il proprio smarrimento. Poi alzò la testa, per cercare il volto di Artemisia nello specchietto retrovisore e si ricordò di quando a Sanremo le aveva detto che le invidiava gli occhiali... sembrava passata una vita. «Questo non significa che ti sposerò», scherzò la ragazza. Quando oltrepassarono Leonessa, Lazzari si tolse gli occhiali e disse a Dino di rallentare. Scrutava i boschi sulla sua destra con attenzione scrupolosa. Era stato lì soltanto una volta, anni prima, ma era sicuro di riconoscere il viottolo tra gli alberi, non appena lo avesse scorto. «Ecco!», gridò eccitato a un certo punto. Dino controllò gli specchietti, poi scalò e svoltò bruscamente. Imboccarono la strada in terra battuta che si inerpicava per la collina. Il fondo era sconnesso, pieno di grosse buche e punteggiato di pietre e radici. Non di grosse buche e punteggiato di pietre e radici. Non c’erano tracce recenti di pneumatici. Erano in pochi ad avventurarsi lì. Ogni tanto un sasso rivoltato cozzava contro il fondo della vettura producendo un rumore metallico. Ben presto furono costretti ad avanzare con le marce ridotte. Al’altezza di una curva a gomito un torrente tagliava la pista ma l’acqua era alta pochi centimetri. Il fuoristrada lo guadò senza problemi e dopo circa due chilometri giunsero in un piccolo spiazzo circolare. Era impossibile proseguire oltre. «Abbiamo sbagliato strada», constatò Dino lanciando occhiate perplesse a destra e a sinistra. «Niente affatto. Si procede a piedi da qui in avanti», disse Lazzari e uscì senza ulteriori spiegazioni. Artemisia lo seguì immediatamente e Dino, senza perdere tempo a riflettere, infilò due pistole nelle fondine ascellari e indossò il suo piumino. Poi prese un borsone dal bagagliaio, se lo mise a tracolla e li raggiunse a grandi passi sul sentiero che spariva nel bosco. «Vado io per primo. Non sappiamo dove possono essere quelli della Tauros», disse loro. Lazzari indicò qualcosa alle proprie spalle. «Credo che Parodi abbia parlato, prima di morire, rivelando che Parodi abbia parlato, prima di morire, rivelando come mettersi in contatto con il Lupo. A quest’ora saranno sulle sue tracce». Dino lo guardò male. «Ma allora cosa ci facciamo qui? Era meglio seguire loro. Dovevi dirmelo». «Non sono io l’esperto di sicurezza e protezione». Dino incassò con un sorriso a labbra serrate. «Non sono io quello che ha bisogno di protezione». «Già», ammise Lazzari. «Comunque non ti preoccupare. Il Lupo non si lascerà trovare». «Quelli sono specializzati nel trovare chi non vuole farsi trovare». «Che avremmo dovuto fare? Metterci a seguire i nostri inseguitori? Se davvero la Tauros riuscirà a scovare il Lupo prima di noi, non ce lo lascerà di sicuro. Per questo siamo qui: sono certo che il Maestro Foglia può rintracciare il Lupo prima di loro...», disse Lazzari, lasciando all’improvviso la frase in sospeso. «Ma?», lo incalzò Dino. «Ma non sono altrettanto convinto che lo farà». «Lo convinceremo», garantì Artemisia. «Non è quel genere di uomo. Se ha preso una decisione, non potremo farci nulla», disse Lazzari e poi piantò l’indice nel petto di Dino. Un gesto improvviso che sorprese tutti. «Allora, decidi. Vuoi fare un tentativo qui oppure metterti sulle piste di quelli della Tauros?». Dino indicò il sentiero con un cenno del capo. «Mi fiderò del tuo giudizio». Camminarono per mezz’ora prima di abbandonare il sentiero e su indicazione di Lazzari svoltarono verso nord all’altezza di una quercia cava. In pochi minuti di marcia sostenuta raggiunsero una capanna di tronchi: camuffata nella vegetazione, era invisibile anche a due metri di distanza. La porta non era chiusa a chiave. All’interno c’era solo un piccolo camino di pietra e una piramide di ceppi impilati con cura. Sull’architrave di legno annerito erano sistemate due grosse pigne e una scatola di fiammiferi. «Passeremo qui la notte», annunciò Lazzari. «Come qui?», domandò Artemisia guardandosi attorno. Si era fatto buio nel frattempo. Dino accese la torcia elettrica e la tenne puntata verso il camino davanti al quale Lazzari si chinò per accendere il fuoco. «È la regola. Dobbiamo passare la notte in questa capanna, se vogliamo che domattina all’alba il Maestro Foglia ci riceva. Altrimenti ci respingerà. Nessuna Foglia ci riceva. Altrimenti ci respingerà. Nessuna alternativa possibile. Lui abita in cima alla collina». «Ma che cazzate sono queste?», sbottò Artemisia. Continuava a scuotere la testa e a guardarsi intorno incredula. «Lascia che ti aiuti», disse Dino accovacciandosi al suo fianco. Gli bastarono pochi istanti per accenderlo. «Ho imparato in Etiopia», disse quasi per scusarsi dell’abilità dimostrata. «Il fumo gli segnalerà la nostra presenza», spiegò Lazzari posando una mano sul comignolo che saliva fino al tetto e oltre. «Questo Foglia mi sentirà domani», minacciò Artemisia. Dino raccolse la propria sacca. «Vi cedo la suite. Io starò di guardia qui fuori. Non mi piace per niente questa situazione. Pericolo sei. Una baracca in mezzo a un bosco a volte è il migliore dei ripari, altre volte la peggiore delle trappole. E io non voglio svegliarmi sotto le armi di quelli della Tauros». «Non avevi detto di fidarti del mio giudizio?», gli ricordò Lazzari. «Mi fido del tuo, ma scelgo il mio». Artemisia e Lazzari, rimasti soli, si sedettero ai lati del camino, una da una parte e uno dall’altra. La capanna era fredda e il fuoco ancora debole. Dal pavimento saliva intensa l’umidità. Il calore pareva richiamarla, anziché allontanarla. «Ci aspetta una lunga veglia», fece Lazzari. «Che vorresti dire?» «La regola prevede la veglia fino all’alba, non il sonno. Ti avevo detto di dormire in auto». Artemisia emise un verso beffardo. «Il tuo Maestro verrà a controllare?» «Lo farà domattina guardandoci in faccia». «Ce l’avremo comunque distrutta, non ti preoccupare». E in un sussurro nervoso aggiunse: «Questa storia ci è sfuggita di mano». Lazzari si sporse oltre il camino. Cercava di decifrare nella penombra rossastra la sua espressione. C’era rabbia, ma anche altro. C’era sempre qualcos’altro. «Te ne sei resa conto finalmente. Lo vedi che avevo ragione io? Dovevamo ascoltare il Colonnello e rinunciare». «Lo vedi? Non capisci mai niente», disse Artemisia. Poi si voltò e si sdraiò rannicchiata. «Che vorresti dire?». «Che vorresti dire?». Artemisia sbadigliò. «Mi spiace, sto già dormendo». 17 Poteva fidarsi di Dino e di Artemisia? Chi diavolo erano in realtà? Per quanto ne sapeva Lazzari, potevano essere tali e quali ai due della Tauros. In fondo lavoravano per il Colonnello, un uomo che lo aveva messo in ginocchio per costringerlo ad accettare quell’assurdo incarico. Se il Colonnello lo aveva trascinato in quel guaio, Artemisia ce l’aveva tenuto dentro. Certo, con ben altri modi, ma... Inutile, per quanto si sforzasse di ragionare lucidamente, subiva troppo il fascino di quella donna. Non sapeva bene cosa avesse significato quela notte per lei, ma lui invece, guardandola dormire, non nutriva molti dubbi. D’un tratto avvertì un movimento fuori dal capanno. Si acquattò tenendo d’occhio l’uscio. Sapeva che avrebbe dovuto fare scudo ad Artemisia con il proprio corpo, ma la paura lo attanagliava. La porta si aprì senza un cigolio e una sagoma si stagliò nella penombra. I nervi fecero scattare la sua mano: la sentì sollevarsi I nervi fecero scattare la sua mano: la sentì sollevarsi d’istinto a mezz’aria, inutile come una pistola scarica. Solo quando s’avvide del berretto tirò un sospiro di sollievo. Dino gli faceva cenno di raggiungerlo fuori. Lazzari si alzò a fatica, i muscoli atrofizzati, controllò che Artemisia dormisse, rinvigorì il fuoco con un paio di ceppi cercando di regolarizzare il proprio respiro e uscì in punta di piedi. Dino imbracciava un fucile e pareva nervoso. «C’è qualcuno nel bosco», bisbigliò piegando la testa. «Animali?» «Oltre agli animali». Lazzari si morse le labbra. «Che vuoi che faccia?» «Non sei in vacanza, prendi questo». Dino gli passò il fucile con il mirino per la visione notturna e lo aiutò a impugnarlo nel modo corretto. «Tieni d’occhio la parte a monte rispetto al capanno. Appena vedi qualcosa che assomiglia a un uomo, spara». Lazzari tremava. «Ma che dici? Io non ho mai sparato a nessuno». «Non succederà nemmeno stanotte, tranquillo man. Anche se ti capiterà di fare fuoco non beccherai nessuno, non ti preoccupare. Con questo mirino puoi avvistare un uomo a duecento metri. A quella distanza tu non uomo a duecento metri. A quella distanza tu non centreresti nemmeno un elefante. Mi basta che li spaventi, chiunque siano». «E tu?» «Io scendo fino ala macchina. Se sono gli agenti della Tauros, l’avranno di certo messa fuori uso. Quella è gente che segue le procedure. Primo, tagliare ogni via di fuga. Secondo, circondare l’obiettivo». «E terzo?», domandò stupidamente Lazzari, ma Dino era già sparito oltre il sentiero. Come faceva, grosso com’era, a non fare il minimo rumore? Lazzari puntò il mirino verso la scarpata alberata, assaporando la sensazione di poter vedere mentre intorno tutto era buio. Gli pareva di sbirciare da uno spioncino: tremando all’idea di poter essere colto alle spale, ogni tanto si voltava per dare un’occhiata, sebbene senza il mirino non vedesse nulla. Il fucile pesava molto più di quanto immaginasse e faticava non poco a tenerlo sollevato. Sentiva le braccia formicolare dolorosamente e la spalla tremare. I minuti sgocciolavano via con lentezza esasperante. Il silenzio del bosco era traditore: ogni più piccolo rumore veniva amplificato e tutto pareva in movimento. Un paio di volte fu sul punto di premere il grilletto, pur di Un paio di volte fu sul punto di premere il grilletto, pur di allentare la tensione. Non riusciva a smettere di chiedersi come fosse stato possibile finire in quella situazione. Quando fu sicuro di non farcela più, udì la voce di Dino alle spalle: «Terzo, innervosirli per farli venire allo scoper to». «Ma che cazzo!», saltò su Lazzari e si affrettò a riconsegnargli il fucile. Aveva le mani sudate e il battito accelerato. «La macchina è ok. Ho ricontrollato anche la strada: nessuna traccia di pneumatici dopo il nostro passaggio», spiegò Dino, che però sembrava ancora perplesso mentre si passava una mano sotto il cappello. «Che c’è?» «I conti non tornano comunque. Non ci ha seguito nessuno. Eppure qualcuno è venuto a dare un’occhiata qui intorno». Lazzari non dovette impegnarsi troppo per rimanere sveglio per il resto della notte. Per la tensione sentiva le articolazioni indolenzite e i muscoli bruciare, come se qualcuno gli avesse iniettato una sostanza velenosa. Appena il buio cominciò a diradarsi mormorò una preghiera, poi destò Artemisia e allargò le braci per preghiera, poi destò Artemisia e allargò le braci per spegnere il fuoco. Aveva disperatamente bisogno di una persona amica. «Non hai chiuso occhio», gli disse la ragazza, quasi stupita. Il sonno le aveva ammorbidito i tratti e il lieve gonfiore ne accresceva la sensualità. Le labbra apparivano ancora più grandi e i capelli più folti. «Dino è convinto che qualcuno sia venuto a spiarci stanotte. Forse quelli della Tauros sono là fuori da qualche parte». «Se ci sono, sapremo come affrontarli», assicurò Artemisia. «Non so se faccio bene a portarvi da Foglia. E se facesse la fine di Parodi? Quei bastardi ci stanno sempre dietro...». «Non volevano uccidere Parodi, solo farlo parlare. È stato un incidente, al vecchio ha ceduto il cuore». «Foglia non si farebbe mai legare a una sedia, lotterebbe e...». Artemisia gli posò un dito sulle labbra. «La Tauros vuole te. E poi non commetteranno una seconda leggerezza dopo quella con Parodi. Non vorranno certo attirare l’attenzione con un altro morto. Hai visto come sono scappati di fronte alla polizia». «Vogliono me? Già, questo mi rassicura molto», fece «Vogliono me? Già, questo mi rassicura molto», fece Lazzari con evidente sarcasmo. «Di che ti preoccupi? Hai ben due guardie del corpo», sorrise Artemisia alzandosi. Dino li aspettava con il fucile spianato all’imbocco del sentiero, cinquanta metri più in alto rispetto al capanno. «Io procedo in testa. Se gli agenti della Tauros ci hanno preparato una trappola, vi copro la fuga: scendete per la scarpata, raggiungete la provinciale, fermate la prima auto che passa e fatevi portare a Terni. Se non vi dovessi raggiungere entro un’ora, telefonate al Colonnello per ulteriori istruzioni». «È la sua compagnia a renderti paranoico?», gli domandò Artemisia accennando a Lazzari. «Semmai è la tua. Se ci succede qualcosa, io ho chiuso», precisò Dino. Lazzari studiò prima uno e poi l’altra, ma non commentò. Preferiva passare ancora una volta per ingenuo e temporeggiare in attesa di chiarirsi le idee, piuttosto che manifestare il suo interesse per i messaggi ambigui che i due si scambiavano. Si misero in marcia lungo il pendio punteggiato dai castagni e dai faggi. Dopo mezz’ora di cammino, il sentiero si fece irto. Da qualche minuto udivano rintocchi sentiero si fece irto. Da qualche minuto udivano rintocchi e versi sempre più nitidi. Dino fece loro cenno di attendere e andò avanti, ma Artemisia lo seguì e Lazzari, dopo un’esitazione, si accodò. Dino scosse la testa contrariato, ma non disse nulla. Scorsero per prima cosa lo spiovente di un tetto e poi il resto di una casa: era a due piani in pietra, con grandi finestre di legno massello dipinte di fresco. Un uomo, alto quanto Dino, spale larghe, una folta capigliatura grigia e una barba fluente ma curata, spaccava legna nell’aia. «Qui non si viene armati», disse e menò l’ennesimo colpo di accetta. Il tronco si divise in due ceppi. «È lui», fece Lazzari a Dino. Dino posò il fucile e Lazzari si fece avanti. Un senso di timore lo colse. Era trascorso tanto tempo dal loro ultimo incontro e si sentiva studiato. E giudicato, per essere arrivato a quel punto tanto cambiato e ansioso. «Maestro...». «...Ce n’è uno solo e non sono io», tagliò corto Foglia lasciando cadere l’accetta. Si avvicinò a Lazzari, si pulì la mano sui calzoni, gliela porse e lo abbracciò. «Benvenuto, concittadino». «Benvenuto, concittadino». «Siete dello stesso paese?», domandò Artemisia, che li osservava con le braccia conserte e il pollice premuto sul mento. Il tono era al limite del sarcastico, ma qualcosa l’aveva trattenuta dall’affondare i denti fino in fondo. «Della stessa Repubblica», disse seriamente Foglia e li invitò a entrare. «Ho preparato il caffè in previsione del vostro arrivo. Seguitemi». «Eri tu allora stanotte? Ti muovi bene e in silenzio», riconobbe Dino. «Ho imparato dagli indios». Dino si sfilò il cappello e se lo legò alla cintura, prima di entrare. Sul tavolo c’era una grossa caffettiera che sprigionava un forte aroma di caffè e una crostata alla marmellata ancora calda. Il camino in pietra era colmo di braci e in un angolo della stanza faceva bella mostra di sé un antico aratro. Foglia indicò loro le sedie, mentre lui si prese dal frigo una bottiglia di birra. «Anche quello lo hai imparato dagli indios?», gli fece Dino indicando la bottiglia. «Da Ken Shiro Abe, oltre al judo si intende». «Un giapponese?» «Un giapponese?» «Eccelso judoka e anche pilota di aerei. Abbatté ventuno aerei durante la seconda guerra mondiale. Venne in Italia per un periodo negli anni Settanta. Beveva una birra media tutte le sante mattine. “È una colazione completa ed equilibrata”, amava ripetere». Dino sorrise insieme ai compagni, ma fu il primo a ridiventare serio. «Perché sei sceso a controllare la capanna stanotte? Non hai visto il fumo? Lazzari ci aveva detto che è il tuo sistema per ricevere gli ospiti». Il Maestro incrociò le braccia sul petto. «Certa gente ha chiesto di me in paese. Ero in allerta». «Chi sarebbe questa certa gente?», gli domandò Lazzari. Posò la fetta di crostata che aveva già addentato e lanciò un’occhiata ad Artemisia. «Forestieri in giacca e cravatta. Hanno fatto una brutta impressione ai miei amici del paese». Lazzari guardò una seconda volta Artemisia, ma fu Dino a parlare per primo. «Per fortuna dovevano essere sulle piste del Lupo, eh Lazzari?» «Come diavolo hanno fatto a sapere che saremmo venuti qui? Non lo sapeva nessuno oltre a noi tre!», sbottò Lazzari con gli occhi spiritati. «Continui a sbagliare bersaglio, man», gli fece notare «Continui a sbagliare bersaglio, man», gli fece notare Dino. «Non abbiamo a che fare con dei dilettanti. Quella è gente preparata. Come facevano a sapere che tenevi i libri in quel capanno sopra Bussana? Te lo sei chiesto? Di sicuro hanno un fascicolo completo e accurato su di te, conoscono tutto della tua vita: dove hai studiato, chi hai frequentato, i viaggi che hai fatto, le proprietà che possiedi, i tuoi acquisti degli ultimi anni, i libri che leggi, perfino il tuo gusto di gelato preferito. Come lo sappiamo noi lo sanno anche loro». «Che vuoi dire... Che avete un dossier su di me?». Non ci fu risposta. Foglia aveva ascoltato in silenzio la discussione. «Sei nei guai concittadino?», domandò infine. Pareva che la cosa lo riguardasse da vicino. «Posso parlarle con franchezza, Maestro?», gli domandò Artemisia. Foglia annuì. «Non accetterei un altro modo. E dammi del tu, ti prego». «Siamo alla ricerca del nome segreto di Roma e del lituo con cui Romolo fondò la città», rivelò senza giri di parole Artemisia. All’orecchio di chiunque altro quella stessa frase sarebbe risultata folle, ma il maestro non si sorprese sarebbe risultata folle, ma il maestro non si sorprese affatto. Sembrava ancora più assorto e interessato. Annuì invitandola a proseguire. Artemisia, nel frattempo, si era versata una tazza di caffè e ora lo sorseggiava con cura. «Lazzari, vuoi per favore esporre al maestro quanto abbiamo scoperto fino a oggi e perché abbiamo bisogno del suo aiuto?». Lazzari raccontò tutta la vicenda senza omettere nulla se non le sue preoccupazioni circa la SigmaPiTau e i suoi due compagni, spiegandogli che avevano bisogno del suo aiuto per rintracciare il Lupo marsicano. «Mi dispiace di aver messo sulle tue tracce i bastardi della Tauros», terminò infine rivolto a Foglia. «Non possono seguire le mie impronte, non ti preoccupare. La settimana prossima ho un volo per il Perú. Vado a dirigere un importante progetto di scavi per conto dell’università di Lima... Ormai insegno lì, forse non lo sapevi. Il Paese è molto interessato all’archeologia e alle proprie radici, a differenza dell’Italia, dove ho giurato di non scavare più». Artemisia lo fissava con aperta curiosità. «Non sembri un uomo che giura a caso. Che ti è capitato?» «L’ultimo episodio risale a due anni fa. Tenevo d’occhio da alcuni giorni proprio il tombarolo che d’occhio da alcuni giorni proprio il tombarolo che cercate, Massimo De Feudis, che si fa chiamare il Lupo Marsicano. Riuscii ad acciuffarlo poco prima che depredasse una tomba sabina a ipogeo che aveva appena individuato tramite uno dei suoi informatori – ma la segnalazione era arrivata anche a me. Lo misi in fuga e avvertii la sovrintendenza regionale ai beni culturali, ma sapevo che lui mi avrebbe tenuto d’occhio e avrebbe aspettato il momento in cui mi fossi allontanato per saccheggiarla. Così io e Akira vegliammo la tomba per tredici giorni e altrettante notti, senza interruzione, dormendo all’addiaccio e mangiando scatolette. Il quattordicesimo si presentò finalmente un funzionario della sovrintendenza con una squadra di operai». Foglia finì la birra e si pulì la bocca con il dorso ruvido della mano. Aveva la pelle di un uomo che aveva trascorso tutta la vita al sole e al vento, e negli occhi tante cose. «Mi congedarono senza un grazie, quindi delimitarono la zona con del nastro bianco e rosso e appesero un cartello con la scritta: vietato l’ingresso. Poi se ne andarono. La notte seguente, come da copione, il Lupo depredò la tomba». Per quasi un minuto nessuno se la sentì di commentare. «Chi è Akira?», chiese alla fine Artemisia. commentare. «Chi è Akira?», chiese alla fine Artemisia. «La mia katana», rispose Foglia. Si avvicinò alla parete, staccò la spada dal gancio a cui era appesa e la mostrò alla ragazza. «Dunque volete rintracciare il Lupo?», domandò, come se fosse giunto il momento di tirare le fila del discorso. «Be’, non sarà facile. Ma possiamo provarci. Andiamo». «Subito?», domandò Dino. Prese un altro pezzo di crostata e commentò: «Non sei uno che perde tempo». Foglia gli mise una mano sulla spalla. «Un giorno ci sarà chiesto conto del tempo che ci è stato concesso». Aveva una fisicità esasperata, e un evidente carisma. Il tono basso con cui parlava e l’espressione risoluta parevano raggiungere e stringere le persone intorno a lui. «Vieni di là con me», disse poi a Lazzari, che lo seguì. Foglia indossò una camicia di lana, un giaccone a scacchi e prese quello che pareva un bastone da passeggio insolitamente spesso. Infine afferrò lo zaino rigonfio, che era appoggiato tra il guardaroba e il muro. «Ne tengo sempre uno pronto. Per le partenze improvvise». Lazzari si limitò ad annuire. Foglia lo spinse davanti allo specchio che ricopriva l’anta dell’armadio e lo allo specchio che ricopriva l’anta dell’armadio e lo obbligò a guardarsi. «Dimmi, lo sai quello che stai cercando?». Lazzari esaminò il proprio volto. Barba e capelli erano della stessa lunghezza. Le guance scavate e le borse sotto gli occhi gli indurivano l’espressione e mascheravano, almeno in parte, il senso di sbigottimento che traspariva dal fondo degli occhi. Era più che mai consapevole della propria debolezza, ma in qualche modo sapeva di poterla trasformare nel suo punto di forza. Era quella l’unica alchimia possibile. «Sì», rispose infine. «È la stessa cosa che stanno cercando loro?», domandò ancora Foglia indicando con la testa la porta. «No». «Bene, ti aiuterò». Quindi raggiunsero gli altri, che li stavano aspettando davanti alla porta e confabulavano a bassa voce. Foglia alzò le mani per richiamare la loro attenzione. «Io vi condurrò fino al Lupo, ma poi non farò un passo di più. Vi sta bene?» «Va bene», accettò Artemisia per tutti. Lasciarono l’auto all’ingresso del centro storico di Leonessa e proseguirono a piedi. Gli edifici in pietra, alcuni più bassi degli alberi, parevano scaturire direttamente dalla roccia. Lazzari camminava in coda al piccolo drappello e osservava le montagne che incombevano sullo sfondo, disinteressato ai discorsi degli altri. Foglia indossava un cappello di paglia che gli oscurava il viso, e con il bastone segnava ogni passo. «Baiocco lavora per il Lupo da anni. È lui che cerchiamo», spiegò. «È uno dei suoi cani da cerca». «Che cosa fa concretamente?», volle sapere Artemisia. «Batte la zona dela Sabina, frequenta i bar e ascolta». «Ascolta?», fece Dino. «Capita che un contadino scavando un campo trovi un cippo votivo, o un pastore raccolga un’anfora, o un passante si imbatta in una moneta. Che cosa fai in genere quando ti capita una cosa del genere?» «Lo racconti a qualcuno», rispose Artemisia. «E quel qualcuno lo racconterà a qualcun altro. Non c’è nulla che accada in Italia che non arrivi prima o poi in un bar. Quando la voce giunge al suo orecchio, Baiocco per prima cosa prende informazioni, verifica se la notizia ha un fondamento, e se è così va a ispezionare in prima ha un fondamento, e se è così va a ispezionare in prima persona il luogo del ritrovamento. Poi, se il sopralluogo lo soddisfa, avvisa il Lupo». Artemisia camminava al suo fianco e non si perdeva una parola. «E capita tanto spesso di trovare reperti?» «Capita», assentì Foglia e batté il bastone con maggiore forza sul selciato. «Suolo italico...». A un centinaio di passi dalla piazza centrale Foglia ordinò a Lazzari e Dino di fare il giro largo per appostarsi alle spalle del’edificio che indicò con il bastone. «Tu sai cosa intendo», disse al barbuto. Dino annuì e spinse il compagno verso il vicolo che passava sotto un piccolo arco proteso tra due palazzotti e vegliato da un roseto. Il verde e il rosa guizzavano vividi contro il vecchio muro e Lazzari, se non fosse stato per il compagno, si sarebbe fermato qualche istante a osservarli. Il Maestro e Artemisia, invece, proseguirono dritto verso la porta del bar che si affacciava sulla piazza. Il nome dipinto sopra l’architrave era del tutto scolorito. Rimaneva traccia soltanto della S iniziale. Foglia entrò per primo, imboccando uno stretto corridoio lungo una dozzina di passi. «Maestro», lo salutò il barista. «Maestro», lo salutò il barista. Un uomo si affacciò dalla sala che si allargava davanti al bancone e appena li vide si lanciò verso la porta all’estremità opposta del bar, facendo cadere un paio di sedie. Il Maestro e Artemisia attraversarono correndo tutto il locale sotto lo sguardo preoccupato del barista, un tipo magrolino con un paio di occhiali sul volto e l’altro appeso al collo. La porta in fondo al bar si affacciava su un crocicchio incastonato tra le case. Dino aveva agguantato l’uomo che avevano visto scappare dal locale e adesso lo teneva fermo mentre Lazzari, al suo fianco, guardava nervosamente ora nella direzione da cui erano venuti Foglia e Artemisia e ora verso le finestre dei palazzi. «Ti saluto, Baiocco», disse Foglia. Era un uomo sui quaranta, i capelli vaporosi pettinati con cura, e indossava una camicia bianca aperta sul petto, una collana d’oro, jeans rossi stretti e scarpe nere a punta: sembrava appena uscito da una discoteca, ma degli anni Ottanta. «Non scavo da anni», disse Baiocco. «Non sono più in quel giro, non ho fatto niente, niente», ripeteva. «Farai una cosa per questi miei amici», gli disse «Farai una cosa per questi miei amici», gli disse Foglia. «Cosa?» «Dicci dove trovare il Lupo. Ci basta questo». «Non lo vedo da anni». «Non mentire». «Io non voglio problemi». «Camminiamo, non conosco modo migliore per risolvere i problemi», propose Foglia. Quindi si rivolse ad Artemisia: «Consiglio di lasciare un giro pagato per i clienti e cento euro al barista per il disturbo». La ragazza saldò il conto e appena tornò fuori si allontanarono tutti insieme. Foglia li guidò fino alla bottega di un fabbro ed entrò seguito dagli altri. «Possiamo metterci di là, Antonio?». Il fabbro, che indossava spessi occhiali plastificati, arrestò a mezz’aria il martello e annuì, poi lo calò con forza sollevando una tempesta di scintile. Alcune lampeggiarono come lucciole sopra lo scuro camice di cuoio ricoperto di bruciature. «Non vi dispiace se continuo a lavorare, nel frattempo?», domandò con una smorfia. «Tutt’altro», disse Dino, che ora guardava con aperta ammirazione Foglia. aperta ammirazione Foglia. Enrico Baiocco era troppo spaventato per urlare. Lo fecero sedere su uno sgabello e gli legarono le mani dietro la schiena, poi Dino tirò fuori entrambe le pistole. Solo il gesto severo di Foglia lo fece desistere. Il Maestro afferrò il proprio bastone con entrambe le mani, ruotò il manico in un senso e il corpo nell’altro e fece scattare un meccanismo nascosto. Rimosse la parte superiore, che era una copertura mascherata, e sfilò una spada da quello che si rivelò un fodero ligneo. Lazzari si lasciò sfuggire un mormorio di preoccupazione. Non era affatto ciò che aveva previsto. «Il tuo passato non mi interessa. Non mi interessano nemmeno i tuoi sporchi traffici. Questi amici devono trovare al più presto il Lupo», chiarì il Maestro. Baiocco non staccava gli occhi dalla lama. «Ti ripeto che non lo vedo da una vita». «Ma sai di certo dove si trova. Sei uno dei suoi informatori storici. È sempre reperibile per te. Il suo lavoro è tutta una questione di tempistica», insistette Foglia. La sua voce, profonda e pacata, era inesorabile. Non era chiaro se bisognasse temere più quella o la lama che luccicava nello stanzino rischiarato da un’unica lampadina appesa al soffitto. lampadina appesa al soffitto. «Se ve lo dico, posso dire addio al mio lavoro». «Se non ce lo dici puoi dire addio alla tua lingua», si inserì Dino avvicinandosi. «Invece avrai la lingua e il lavoro», promise Foglia, facendo cenno a Dino di calmarsi. «Questi miei amici sono venuti per proporgli un affare importante. Non siamo banditi». Artemisia tirò fuori un rotolo di banconote per sottolineare il concetto. Contò tremila euro e li infilò nella tasca dei pantaloni dell’uomo. «Ho la tua parola?», domandò Baiocco a Foglia. «Ce l’hai». «Troverete il Lupo a Tarquinia. È appena stata scoperta una specie di agorà all’interno dell’area del Tumulo della Regina». «Ne ho sentito parlare», confermò Foglia. «I fondi statali sono quelli che sono: i lavori di scavo vanno a rilento e la sorveglianza fa acqua da tutte le parti. Massimo è convinto di poter sfruttare a suo vantaggio la situazione, per portare via alcuni dei tesori sepolti là sotto. Ci sono pezzi di grandissimo valore, come per esempio...». «Lascia stare le informazioni che non contano. Dicci «Lascia stare le informazioni che non contano. Dicci piuttosto come facciamo a trovarlo», tagliò corto Dino. «Lo troverò io», assicurò Foglia e uscì. 18 Raggiunsero la necropoli di Tarquinia al tramonto. Parcheggiarono l’auto sul ciglio della strada che correva lungo il crinale affacciato sul sito archeologico. Dietro consiglio di Foglia scesero tutti e quattro per decidere come procedere. «Quando ti muovi, le idee piovono come frutti dall’albero percosso», spiegò il Maestro togliendosi il cap pello. Dall’alto osservarono la valle, incisa dai sentieri bianchi come ossa, dove le millenarie costruzioni si mimetizzavano tra i campi delineati con cura. Cespugli e alberi orlavano le morbide colline circostanti, sotto un cielo dalle mille striature. «Sembra un buon posto per riposare», disse Dino. Aveva costretto Baiocco a salire in auto con loro, temendo che gli agenti della Tauros potessero rintracciarlo rapidamente e quindi mettersi sulle loro tracce, ammesso che non avessero già trovato il Lupo. Lo aveva scaricato mezz’ora prima in un punto deserto Lo aveva scaricato mezz’ora prima in un punto deserto sulla provinciale tra Viterbo e Vetralla, minacciandolo di morte nel caso avesse avvertito il Lupo del loro arrivo. Artemisia gli aveva dato altri mille euro per il disturbo. Dino, invece, gli aveva dato un ultimo consiglio: «Sparisci per qualche giorno». Baiocco si era allontanato con i soldi e senza una parola di commiato. «Hai un binocolo per la visione notturna?», domandò ora Foglia a Dino. Il barbuto, stupito, alzò il pollice in segno di assenso e andò a prenderlo dal doppio fondo del bagagliaio. Foglia studiò a lungo le colline circostanti, mentre gli altri, un paio di passi dietro di lui, lo osservavano in silenzio. Dino pensava agli agenti della Tauros: se avessero già trovato il Lupo sarebbe stato costretto a organizzare una missione per liberarlo. Ma non aveva uomini a disposizione. Dopo quasi dieci minuti, Foglia chiamò vicino a sé il barbuto. «Secondo te qual è il migliore punto di osservazione per sorvegliare dall’esterno il Tumulo della Regina?», domandò indicandogli un’area precisa all’interno del perimetro della necropoli. Quindi gli passò all’interno del perimetro della necropoli. Quindi gli passò il binocolo. «Potrei indicarti il miglior punto di osservazione in assoluto, ma non è detto che sia quello preferibile. Bisogna considerare le vie di fuga. Se è davvero così in gamba, il Lupo si sarà piazzato in un posto da cui può osservare anche chi si avvicina, in modo da poter fuggire in caso di pericolo. Dovrei conoscere il reticolo viario della zona». «Andiamo a conoscerlo, allora», approvò Foglia. Saltarono sul fuoristrada e se ne andarono lasciando lì Artemisia e Lazzari, che non avevano avuto neppure il tempo di farsi avanti. Lazzari si avvicinò al margine della scarpata e guardò giù. Gli sarebbe piaciuto lanciarsi per il morbido declivio e correre a perdifiato fino al fondo della vallata, provare l’ebbrezza della velocità e mandare alla malora tutto quanto. «Che cosa farai quando questa storia sarà finita?». All’inizio pensò di averle sognate quelle parole, ma quando si voltò vide che Artemisia lo fissava, a pochi passi di distanza da lui. Gli occhi verdi parevano risucchiare l’ultima luce del giorno. Un gatto non avrebbe potuto sfoggiare uno sguardo più enigmatico. «Non lo so, potuto sfoggiare uno sguardo più enigmatico. «Non lo so, non lo so davvero e mi chiedo se ci sarà una fine. Quanto siete disposti ad andare avanti?» «Fin quando non avremo ottenuto quello che cerchia mo». «E se non dovessimo trovare nulla, nemmeno qualche indizio? Continueremo a fare su e giù per l’Italia come pazzi? Braccati da quei paramilitari e con la minaccia incombente degli uomini della Confraternita?» «Gli indizi li abbiamo. Ora è tutto nelle tue mani». «Io... Io... farò il possibile». «E tu non mi chiedi che cosa farò quando avremo trovato il lituo?» «Dovrei?» «No, certo. Non sono affari tuoi», confermò Artemisia, di colpo indispettita, e si allontanò. Lazzari mosse un passo, ma non il secondo. Non aveva mai capito se le donne se ne vanno per essere rincorse o per essere lasciate in pace. Quella donna gli piaceva. Era tutto quello che non era lui. Gli piaceva l’idea della sua presenza e temeva il momento in cui avrebbe dovuto allontanarsene. «Sai, ci sono parole che dovrebbero essere pronunciate una volta sola nella vita», le disse in tono pronunciate una volta sola nella vita», le disse in tono basso, appena sufficiente per farsi sentire. Lontano udirono il passaggio di un’automobile. In piedi sui cigli opposti dell’avvallamento, a una decina di passi di distanza, si davano reciprocamente la schiena guardando in direzioni opposte. «Le ho sentite mille volte, quelle due parole...», gli rispose senza voltarsi. Foglia e Dino ritornarono quando ormai si era fatto buio. I fari tracciarono due solchi polverosi sullo spiazzo sterrato, prima di spegnersi. «Abbiamo individuato un’ottima ubicazione per una postazione di osservazione. Da qui sarà all’incirca mezz’ora di cammino. Lasciamo l’auto e andiamo a piedi. Lo prenderemo alle spalle. Se ci vede arrivare, quello scappa», spiegò Dino. Prese la sacca dal bagagliaio e richiuse il fuoristrada. Lazzari scuoteva la testa perplesso. «E se non fosse lì, cosa faremo?» «Ci porremo il problema a quel punto», tagliò corto Foglia, mettendogli un braccio intorno al collo e spingendolo in avanti. «Fiducia, amico mio. Fides!». «Dagli retta», gli consigliò Artemisia. «Non avere paura, non fare paura e liberare dalla «Non avere paura, non fare paura e liberare dalla paura: ecco tre buone azioni», sussurrò il Maestro senza rivolgersi a nessuno in particolare. Dino chiudeva la fila, mentre Foglia camminava in testa a passo sicuro. Il buio non pareva avere segreti per lui. Ogni tanto si voltava per guardare se gli altri lo seguivano e per segnalare eventuali ostacoli o buche. «Da qui in avanti nemmeno una parola», li ammonì Foglia quando raggiunsero il fondovalle. Tagliarono per i campi, aggirando il crinale e rallentarono il passo solo quando incontrarono i primi alberi. Avanzarono con cautela cercando di tenersi sempre al riparo. A un centinaio di passi dalla meta che avevano individuato in precedenza si appostarono dietro un gruppo di arbusti. Dino scrutò a lungo con il binocolo. «Non vedo nessuno, ma c’è una macchia nel terreno che mi incuriosisce. Sono quasi certo che si tratti di un capanno mimetizzato. Vado a dare un’occhiata». «Noi copriamo le vie di fuga», approvò Foglia, segnalando agli altri due dove sistemarsi. Dino ricomparve pochi minuti più tardi. Era raggiante. «Una tana con i fiocchi: cibo, attrezzatura varia, macchine fotografiche e l’occorrente per ogni varia, macchine fotografiche e l’occorrente per ogni emergenza. Manca solo il Lupo, ma arriverà. Andiamo a preparargli una sorpresa. Venite». Lo seguirono fino al ricovero scavato nella terra. Foglia e Dino andarono a piazzarsi di vedetta sull’invisibile sentiero che saliva dal basso, nulla più di un’ombra scura tra la vegetazione. Artemisia e Lazzari rimasero ancora una volta soli. La piccola radura era rischiarata dal lucore che filtrava dalle fronde. Faceva freddo. Si sedettero l’uno accanto all’altra con la schiena addossata al tronco di un albero. La ragazza si accoccolò sul suo petto. Fu allora che Lazzari si accorse di avere nella tasca della giacca la pipa che gli aveva regalato Casini. Ne percorse i contorni con le dita, più volte, e alla fine non resistette all’impulso. La tirò fuori e la illuminò con il cellulare. Aveva sempre pensato che fosse una pipa, ma esaminandola con attenzione si accorse che non lo era affatto. Il cannello era più lungo del normale e inoltre presentava sul dorso alcuni piccoli fori, simili a quelli presenti sui flauti di canna. Quello che sarebbe dovuto essere il fornello era in realtà una sorta di appendice ricurva priva di fondo – nessuna possibilità di riempirla di tabacco. tabacco. Toccò la superficie con l’unghia e si rese conto con meraviglia che era stata oggetto di un restauro. Il legno era di certo antico e aveva la sfumatura tipica degli oggetti rimasti a lungo sotto terra. Lo annusò a più riprese. Non si fece scrupolo di leccarlo per cercare conferme. Sotto i componenti chimici tipici della ripulitura aveva infatti distinto aromi di terra. Un oggetto di quasi cent’anni, a sentire Casini. «Che c’è?», gli domandò Artemisia. Si era resa conto dell’improvvisa tensione nel corpo dell’uomo. «Vedi, il lituo è un oggetto straordinariamente simile a questo», mormorò Lazzari mostrandoglielo. La ragazza, dopo una rapida e disattenta occhiata, sollevò gli occhi verso di lui. «Secondo te lo troveremo?» «Qualcosa troveremo, siamo vicini». «Come vicini? Poco fa parevi...». Artemisia non ebbe il tempo di proseguire. Di colpo furono entrambi consapevoli di una presenza. Si acquattarono in attesa. Qualche secondo più tardi Dino comparve da dietro un albero. «È qui», sussurrò portandosi il dito indice alle labbra. labbra. Dopo appena un paio di minuti udirono distintamente un rumore di passi. Trattennero il fiato. Lazzari non sapeva quale fosse il suo compito, ma era troppo tardi per domandarlo e Foglia non si vedeva da nessuna parte. Dov’era finito? Avvertì il movimento di Artemisia e la bloccò tirandola per la mano. Chissà cosa era capace di fare. Un uomo entrò nella radura e quasi in simultanea due torce balenarono nell’oscurità inchiodandolo. «Veniamo in pace», annunciò Foglia facendosi avanti. La luce disegnava un alone intorno alla sua mano. «Ma che diavolo!», imprecò il Lupo facendo un passo indietro e guardandosi intorno come un animale braccato. «In persona», disse Dino afferrandolo per un braccio. Gli era comparso alle spalle e ora lo stringeva in una morsa implacabile. «Ho conoscenze importanti», li minacciò il Lupo. «Siamo noi le conoscenze più importanti che tu potrai mai avere», gli disse Artemisia. Si era liberata dalla stretta di Lazzari, balzando in piedi con agilità. «Non temere, siamo qui per proporti un affare». Il Lupo socchiuse ancora più gli occhi. Pensieri sembravano attraversargli la mente, rapidi come saette. sembravano attraversargli la mente, rapidi come saette. «Siete gli amici di Parodi?» «Proprio così». Il Lupo si sforzò di sfoggiare un sorrisetto. Era il più basso del piccolo gruppo, e magro come un ragazzino, anche se doveva avere almeno una quarantina d’anni, a giudicare dalle rughe che gli istoriavano il viso. «Spero non vi offendiate, ma di amici così io faccio volentieri a meno. Scusate se ve lo dico, ma non vorrei fare la sua fine». «Pensavo che i rischi facessero parte del tuo mestiere», lo incalzò Artemisia. Sebbene non si fossero messi d’accordo in precedenza, nessuno degli altri mise in dubbio che spettasse a lei parlare. Lazzari, ancora accovacciato a terra, la scrutava con attenzione. «I rischi mi stanno bene solo quando sono assicurati», precisò il Lupo. Artemisia si comportava come se non avesse il minimo dubbio sul buon esito della contrattazione, mentre gli passeggiava davanti con la flemma del gatto che studia il topo. Ma quell’uomo non aveva affatto l’espressione della preda, sembrava anzi non avere la minima paura. «Noi abbiamo il brutto vizio di pagare tanto e in «Noi abbiamo il brutto vizio di pagare tanto e in anticipo», disse Artemisia. «Musica per le mie orecchie, ma scusate tanto se insisto: le assicurazioni sulla vita costano». Artemisia liquidò la questione con un cenno della mano. «Ci metteremo d’accordo, non ti preoccupare. E se ci aiuterai concretamente a raggiungere il nostro obiettivo, ti garantisco che la gente responsabile della morte di Parodi non avrà più ragione di cercarti». «Il vostro obiettivo, se il mio fiuto non mi inganna, riguarda oggetti arcani e pericolosi e io, sapete, sono piuttosto superstizioso...». «Aggiungeremo qualche moneta per difenderti anche dalle tue paure ultraterrene», tagliò corto Artemisia. «Le monete sono gli scudi migliori», concesse il Lupo. «Te ne daremo abbastanza da fabbricarti un’intera corazza». Il Lupo guardò con fare interrogativo Foglia. Sembrava chiedergli dove avesse scovato quella donna. Il Maestro, però, rimaneva impassibile e ieratico come una statua dimenticata in una foresta, opera di una civiltà ormai perduta. Alla fine il Lupo annuì piegando gli angoli della bocca Alla fine il Lupo annuì piegando gli angoli della bocca verso il basso in un’espressione che poteva essere interpretata tanto come un no quanto come un sì. «Non è questo il luogo per parlarne. Spegnete quelle torce e andiamocene in paese. Sapete, sono uno di quelli che ragionano meglio davanti a una birra». 19 Dino e Foglia rimasero di guardia fuori dall’Old Times, il pub in cui li aveva condotti De Feudis, che per tutto il tragitto in auto aveva ostentato un sorrisetto indecifrabile. Dopo Sarzana non avevano più avvistato agenti della Tauros, ma il barbuto non si fidava e intendeva tenere alto il livello di attenzione. Non erano certo distanti, se era vero che qualcuno aveva chiesto informazioni su Foglia a Ocre di Leonessa. Avrebbe preferito addirittura uno scontro a quel logorante stato di perenne allarme. La situazione gli ricordava il modo di agire di certe bande di guerriglieri del deserto, capaci di sparire come fantasmi senza lasciare tracce per poi riapparire all’improvviso, armi in pugno. Lazzari, Artemisia e Massimo De Feudis si sedettero in fondo al locale, in un séparé rivestito di legno, e ordinarono tre birre alla spina e un piatto di patatine fritte. «Volete raccontarmi qualcosa, o devo tirare a «Volete raccontarmi qualcosa, o devo tirare a indovinare?», domandò il Lupo, non appena la cameriera si fu allontanata con le ordinazioni. Mentre Artemisia gli riferiva brevemente quanto avevano scoperto, senza menzionare la morte di Achille Vento, Lazzari lo studiò domandandosi se almeno di lui si potesse fidare. I suoi tratti erano spigolosi e le sue guance incavate, indossava un gilet da pescatore sopra una T-shirt nera, che gli lasciava scoperte le braccia percorse da vene spesse. Ogni tanto spingeva in avanti la testa, come fanno i gali o i pugili messicani. Nonostante fosse piccolo, non pareva proprio l’uomo giusto con cui fare a pugni. «Se il mio vecchio cervello non mi inganna, voi volete che vi conduca nella tomba dove ho trovato il ciondolo che ho venduto al buon vecchio Parodi, pace all’anima sua», disse il Lupo. «Che tipo di tomba è?», gli domandò Lazzari con improvviso trasporto. Nonostante la paura e lo scetticismo con cui aveva affrontato quella ricerca, non era capace di arginare la curiosità e la crescente emozione. Il Colonnello aveva ragione: era vicino al suo sogno. Come avrebbe potuto tirarsi indietro? «Scusa compagno, ma queste informazioni le avrai se «Scusa compagno, ma queste informazioni le avrai se e solo se concluderemo l’affare», precisò il Lupo. Artemisia fece una smorfia. «È già concluso, solo che tu ancora non lo sai». Il Lupo stava per replicarle, ma rinunciò e tornò a rivolgersi a Lazzari, un interlocutore che evidentemente sentiva più vicino. «A proposito, ho sentito molto parlare di te. Ci sei rimasto sotto, eh? Succede a chi scava troppo a fondo. Sono in molti a chiedersi che fine hai fatto». «Non ho intenzione di fare nessuna fine». «Bella idea, amico», approvò il Lupo e ordinò un’altra birra con un cenno. Lazzari proseguì: «Voglio scendere in quella tomba. Ci sono iscrizioni sulle pareti, non è vero? Capisco bene che siano cose di nessun valore per te, ma sono molto preziose per noi». Il Lupo annuiva. «Ti sei offeso? Ma è meglio così. Non mi piacciono gli uomini senza palle. Non sai mai come prenderli». «Ci sono ragionevoli motivi per credere che il ciondolo con inciso il fico ruminale appartenga agli iniziati di una confraternita che si tramanda da secoli il segreto sulle origini di Roma», gli spiegò pazientemente Lazzari. sulle origini di Roma», gli spiegò pazientemente Lazzari. «Per questo desidero vedere le eventuali iscrizioni...». «Scusate se mi ripeto, ma sono informazioni confidenziali», rimarcò il Lupo. Artemisia gli puntò il dito contro. «Dicci il prezzo». «Facciamo così», disse il Lupo e schioccò la lingua contro il palato. «Tu pensa a una cifra esagerata, raddoppiala e poi dimmela. E io ti dirò quanto manca». «Cinquantamila», sparò Artemisia. Il Lupo ridusse gli occhi a due fessure ed esaminò a lungo Lazzari, per cogliere un indizio che era sicuro di non poter scorgere nel volto impenetrabile di Artemisia. Infine tornò a rivolgersi a lei: «Nessuno paga una simile cifra per scendere in una tomba già predata. Il tuo Virgilio, qui, non sarà un uomo di mondo, ma non può essere così ingenuo da pensare di trovare qualcosa laggiù, oltre ovviamente alle sue preziose scritte. Quelle, tranquilli, non mancano». Il Lupo sapeva il fatto suo. Come il più esperto dei mercanti, ostentava diffidenza senza tralasciare di far scintillare la mercanzia: da un lato diceva che la tomba era priva di interesse, ma dall’altro ammetteva che erano presenti iscrizioni parietali. Lazzari era più che mai contento che fosse la sua compagna a condurre la contento che fosse la sua compagna a condurre la trattativa. Artemisia sfoderò uno dei suoi sorrisetti di diabolica e affascinante supponenza. «Hai paura?» «Ho paura che mi stiate fregando. C’è qualcosa sotto», disse il Lupo sbattendo una mano sul tavolo. «Le scritte potrebbero nascondere una mappa. Stiamo parlando della tomba di un iniziato», disse Lazzari. «Di cosa stiamo parlando esattamente, eh? Me lo stavo giusto chiedendo. Ho scavato decine di tombe di iniziati a varie sette antiche, specie orfiche... Sapete, quelli che credevano nella rinascita dell’anima, e ho rinvenuto anche numerose mappe di varie fogge e fatture, ma tutte, e sottolineo tutte, indicavano solo e soltanto la via per l’aldilà. Quanto pensi che valga una simile mappa? Eh?» «Io...». «Te lo dico io: non vale niente, a meno che tu non voglia scendere nell’Ade prima del tempo a controllare», alzò la voce Lupo. Poi bevve un sorso della birra che la cameriera gli aveva appena portato e provò a calmarsi. «Scusate tanto la schiettezza, ma rimarrete scottati». «Correremo il rischio», tagliò corto Artemisia e posò sul tavolo cinquemila euro. «Il resto te li accrediteremo sul tavolo cinquemila euro. «Il resto te li accrediteremo tramite bonifico». «Entro domani mattina», precisò il Lupo, ammiccandole. Artemisia non fece una piega e prese il telefono. «Dettami il numero di conto». Il Lupo alzò le mani. Era sorprendente la facilità con cui passava dall’espressione rabbiosa a quella dimessa e accomodante. «Benissimo, siamo d’accordo. Appena riceverò conferma dalla mia banca, partiremo. Immediatamente. Con quella cifra avete diritto a tutta la mia sollecitudine». La porta si spalancò di colpo come se fosse stata colpita da un ariete. Dino entrò con la faccia stravolta e arrossata, come se avesse pianto. «Il Maestro chiede di te», disse ad Artemisia e poi si diresse al bancone, strappò un pezzo di carta dal rotolo lasciato sul marmo, si pulì il volto e poi ordinò un Long Island. Era la prima volta che Lazzari lo vedeva bere alcolici. Appena Artemisia uscì dal pub, che nel frattempo si era svuotato, il Lupo mise la mano sul braccio di Lazzari, e indicandogli la porta in fondo gli sussurrò con decisione: «Il vecchio non lo voglio con noi». decisione: «Il vecchio non lo voglio con noi». «Non verrà, lo sai bene». «Volevo sentirtelo dire. Non mi fido di chi non dà valore ai soldi». «Capisco». Lazzari continuava a guardare verso il bancone, dove Dino sedeva su uno sgabello, dando loro le spalle. La barista, una bionda dal sorriso spigliato, gli ronzava intorno parlandogli in tono vivace, ma lui non sembrava ascoltarla. Il Lupo aumentò la pressione sulla mano di Lazzari per attirare la sua attenzione. Aveva chiaramente voglia di affrontare l’argomento che più gli stava a cuore una volta per tutte, ora che erano soli. Ogni tanto sbirciava alle proprie spalle per sincerarsi che nessuno potesse sentirli. «Come ti hanno tirato dentro?». Lazzari finì la birra e ne ordinò un’altra. «Soldi e una cattedra importante», mentì cercando di fissarlo dritto negli occhi. «Mi pare un’offerta ragionevole», disse il Lupo. «Però, possiamo spennarli di più. Non sei d’accordo?». Lazzari lo studiò per alcuni istanti e infine annuì con lentezza misurata. «E non sto parlando di riempirci le tasche, ma della nostra comune passione», chiarì il Lupo. «Dopo la laurea nostra comune passione», chiarì il Lupo. «Dopo la laurea partecipai a un paio di campagne di scavi, ma entrambe furono sospese per mancanza di fondi. Fu alora che decisi di abbandonare l’archeologia vera e propria e mettermi a scavare per conto mio. I soldi sono soltanto uno strumento: per continuare a scavare, recuperare tesori, portare in vita il passato. Perché è questo che conta per uomini come me e te. O sbaglio?» «Sì», confermò Lazzari. «Il Committente per cui lavorano Artemisia e Dino è il padrone di una Fondazione. Deve essere ricco sfondato e credo sia arrivato a uno di quei punti nella vita in cui i capricci assumono più valore di ogni altra cosa. Penso che tu abbia trovato il migliore dei clienti possibili, un’autentica miniera». «Graditissimo, ma dobbiamo inventarci qualcosa. Tu sai bene quanto me che non troveremo nulla là sotto», disse il Lupo tamburellando le dita sul tavolo. «Dipende da quello che si cerca». «Fratello, la tomba è vuota», insistette il Lupo, non riuscendo a trattenere la voce. Dopo una rapida occhiata alla sala, riattaccò in tono basso ma risoluto. «Nell’arca c’era solo il ciondolo della presunta Confraternita sopra un mucchietto di ossa. Quanto al corredo, è già tutto un mucchietto di ossa. Quanto al corredo, è già tutto venduto: ampolle, anfore, monili, spille, utensili. Mi rimane solo la cassa in pesante legno da piazzare, ma quella è buona giusto per un museo di secondo ordine di qualche sperduta cittadina americana con velleità culturali». Lazzari si mostrò imperturbabile. «Si trattava di un personaggio politico?». Il Lupo raddrizzò di colpo la testa, come se avesse addentato un pezzo di ferro anziché di carne. «Intendi il compratore?» «Intendo il morto». «D’accordo, mi arrendo», fece il Lupo alzando le mani. «Hai capito bene... C’era anche l’anello dell’ordine senatoriale nella bara. Ma ho già venduto pure quello». «Sei riuscito a datare la tomba?» «Ho fatto analizzare i reperti. Primo secolo avanti Cristo». «Parodi parlava di un complesso di tombe». «Alcuni elementi della struttura lo lasciavano intuire, ma a un esame più approfondito si è rivelata per quello che è: una tomba unica». «Però particolare». «Insolita, sì. A ipogeo sul modello etrusco. Sai «Insolita, sì. A ipogeo sul modello etrusco. Sai meglio di me che i romani preferivano altri tipi di sepolture. A differenza degli etruschi non amavano scavare come talpe», disse il Lupo, ma poi si zittì all’improvviso. I nervi del collo parevano i tiranti di una marionetta. «Come sai che si tratta di un senatore e di una tomba insolita? Eh?» «Ho tirato a indovinare», rispose Lazzari. In quel momento la porta in fondo si aprì di nuovo e Artemisia e Foglia rientrarono nel pub. Il Lupo ridusse la voce a un sussurro appena udibile. «Io e te dobbiamo stare dalla stessa parte. Ricordati che siamo semplici strumenti per quella gente. Loro non sono come noi». «Lo so, non ti preoccupare», lo tranquillizzò Lazzari. Artemisia si sedette accanto a Lazzari. Pareva su di giri, come se si fosse tolta un peso. «Troviamo un posto per dormire che non sia l’auto». «Stanotte sarete ospiti miei, in attesa del bonifico di domattina», disse il Lupo. «Ospiti tuoi? E dove?», chiese sospettosa. «Ho preso alloggio presso il casolare ristrutturato di un attore americano, che non viene in Italia da anni. Il custode è un mio amico». custode è un mio amico». «È un posto sicuro?», gli domandò Dino dal bancone. Si era girato di tre quarti e li osservava, con la mano stretta sul bicchiere. «Sicurissimo, altrimenti non lo avrei scelto. Nessuno sa che sto lì», disse il Lupo. «Non sai quante volte ho sentito frasi simili in passato», insistette Dino. «Non so se te l’hanno detto, ma io non faccio il turista di professione». «Magari ti stanno tenendo d’occhio quei figli di puttana della Tauros», disse Dino saltando giù dallo sgabello. Aveva la voce ruvida e gli occhi rossi. «Ci sarai tu a difenderci, no soldato?». Dino strinse i pugni e serrò la mascella. Rimase così per alcuni istanti, infine si aggiustò il cappello. «Muoviamoci». «Comandi», fece beffardo il Lupo e si alzò per seguirlo. «Che è capitato a Dino?», mormorò Artemisia a Lazzari. «Qualcosa che gli ha detto Foglia, credo. Ha parlato anche a te?» «Ha parlato anche a me», ripeté Artemisia evasiva. «Ha parlato anche a me», ripeté Artemisia evasiva. Poi aggiunse lesta: «Che ti stava dicendo il Lupo?» «Niente». «Avete parlato mezz’ora». «Sì, ma... di dettagli... dettagli tecnici». Il casolare occupava la sommità di una collina. C’era un’unica strada per arrivarci, una flessuosa striscia di asfalto protetta in un paio di curve da brevi filari di cipressi. Superarono il cancello elettrico e parcheggiarono in uno spiazzo ricoperto di ghiaia e sormontato da una coppia di pini marittimi potati con cura. Lazzari li guardò con ammirazione chiedendosi a chi fosse venuta l’ispirazione, tanti anni prima, di piantarli lì. Dino prese il fucile e andò a ispezionare il giardino che circondava l’edificio, delimitato a sua volta da uno spesso muro di cinta. «Vi mostro le stanze», disse il Lupo precedendoli sul vialetto di ingresso. Aprì il portone con la chiave che gli aveva lasciato il custode, accese l’interruttore ed entrò seguito da Artemisia. Foglia e Lazzari si fermarono davanti alla soglia, nel rettangolo luminoso proiettato dalle lampade nell’atrio. C’era un lieve sentore di fieno nell’aria e non una sola C’era un lieve sentore di fieno nell’aria e non una sola nuvola a mascherare il cielo stellato. «Vi tradirà, se lo riterrà opportuno», gli disse Foglia alludendo al Lupo senza curarsi di abbassare la voce, ma gli altri due erano già spariti su per le scale. Lazzari si strinse nelle spalle. Nel frattempo si erano accese le luci al piano di sopra e attraverso le finestre si scorgevano i soffitti affrescati. Da qualche parte un uccello notturno fischiava. Foglia insistette: «Il Lupo è uno che si vende». «Sì lo so, ma noi rappresentiamo il migliore offerente sulla piazza. Non essere preoccupato». «Tu lo sei». Lazzari fece una piccola smorfia. Non si poteva nascondere nulla a quell’uomo. Come poteva essersene dimenticato? «Già, ma non è per questo». Foglia annuì come se sapesse esattamente quello che provava l’amico. «È quella donna?» «Sì. Mi chiedo se sono qui per lei o per il nome segreto di Roma». «Che differenza fa?» «Be’... dedichi tutta la vita a cercare di realizzare un sogno, e poi all’improvviso scopri che ce n’è un altro che forse ti sta più a cuore... Non capisco più cosa mi passa forse ti sta più a cuore... Non capisco più cosa mi passa per la testa». Foglia gli mise una mano sulla spalla. Era calda e pesante. Lo ancorava al terreno e al tempo stesso lo faceva sentire leggero. «Non è la rivelazione che si attarda, sono i nostri occhi che non sono ancora pronti», disse il Maestro. Lazzari ammise con voce stupefatta: «Avevi ragione Mario, non so che cosa sto cercando». «Ogni scoperta è in realtà un ritrovamento, una riscoperta: gli antichi avevano ragione. Pensa a ciò di cui senti nostalgia e saprai quello che stai cercando». «Che vuoi dire?». Foglia si mise il cappello. «Sai che in Perú esistono villaggi tra le Ande non segnati su alcuna carta? Nessun turista vi si avventura mai. Nessuna possibilità di essere rintracciati. Sono posti da tenere a mente, specie per chi si trova nella condizione di dover sparire per un certo periodo...». Prima che Lazzari potesse chiedere spiegazioni, Dino spuntò dall’angolo della villa, di ritorno dal giro di perlustrazione. «La zona è tranquilla», annunciò. Lui, però, non lo sembrava affatto. «Prendo la stanza ad angolo, quella più vicina di tutte al muro di cinta che dà sulla strada. Così potrò tenere d’occhio le macchine di passaggio, semmai dovessimo avere visite indesiderate». Era appena rientrato quando udirono sopra le loro teste un rumore di infissi che si aprivano. «Lazzari, vieni!», urlò Artemisia, affacciata al balcone principale. E poi: «Maestro, la tua stanza è in fondo al corridoio». Foglia alzò gli occhi. «Grazie Artemisia, rimango ancora un po’ fuori a guardare le stelle prima di salire». Lazzari gli strinse la mano e rientrò. Dino lo aspettava seduto sulla scalinata che portava al piano superiore. Aveva trovato da qualche parte una bottiglia di whiskey. Ne bevve un lungo sorso e poi la passò a Lazzari. «Come lo hai conosciuto?» «Foglia?», domandò Lazzari prima di sedersi accanto al barbuto. «Allo stesso modo tuo. Qualcuno me lo ha presentato, e poi lui mi ha parlato». «Sì, quell’uomo parla», ammise Dino. Non aveva mai dato a quel verbo tanta forza e importanza come quella notte. «Mi ha detto che ciascuno di noi è una luce custodita in un guscio di creta, e che ci sforziamo in continuazione di rinforzare questo guscio quando invece continuazione di rinforzare questo guscio quando invece dovremmo fare esattamente il contrario... Non credo di aver capito del tutto le sue parole, ma lui mi ha detto di conservarle come semi in una busta. Un giorno, forse, potranno essermi utili...». Lazzari, sorpreso da quello sfogo inaspettato, provò a cambiare discorso: «E tu come hai conosciuto il Colonnello?» «Mi ha reclutato nell’esercito. Poi mi ha contattato quando ha aperto la sua agenzia. Si potrebbe affermare che se ho fatto il soldato, lo devo lui, e che se ho smesso di farlo, lo devo sempre a lui». Bevve un altro sorso, prima di aggiungere: «Ho lavorato alle sue dipendenze in Africa e in Iraq come contractor. Facevo per lo più da scorta a uomini d’affari europei». «Già, ci vuole sempre qualcuno che badi ai cavalli, no?» «Facevo anche altre cose». Fu il turno di Lazzari di bere. «Capisco...». «No, man. Non puoi. Cose orribili, cose che mi tengono sveglio la notte», disse Dino e si guardò le mani. «Però Foglia mi ha detto una cosa, che un uomo non è la sua storia, che seppellire il passato si può, che anche se il tuo cuore ti condanna non devi dimenticarti che Dio è più tuo cuore ti condanna non devi dimenticarti che Dio è più grande del tuo cuore. Tu ci credi?» «Alle parole di Foglia?» «No, in Dio». «Per fortuna è lui a credere in me», disse in un rapido sussurro Lazzari, e senza lasciare al compagno il tempo per una replica aggiunse: «E del Colonnello, invece? Ti fidi di lui?» «È il più fidato degli uomini, per questo è così apprezzato e richiesto. Non ha mai deluso nessuno dei committenti che si sono rivolti a lui». Lazzari si alzò e allungò la mano per aiutare l’altro a rimettersi in piedi. «Mi fa piacere sentirtelo dire». Dino reclinò la testa rivolgendogli un’occhiata interrogativa dal basso all’alto. «Questo significa che ti fidi del mio giudizio?» «Già». 20 Lazzari aprì gli occhi consapevole di una presenza nella stanza. Nei pochi istanti che impiegò per individuarla il suo cuore accelerò fin quando non emise un sospiro di sollievo. Ma sapeva bene che sarebbero serviti diversi minuti al suo corpo per metabolizzare quello spavento mattutino. Artemisia era seduta sulla poltrona accanto alla finestra e lo osservava, le gambe accavallate e l’indice sulle labbra. Aveva aperto le tende di raso e dalle persiane filtrava una luce ambrata che restaurava i pesanti e antichi mobili di legno. «Non ricordo il tuo nome di battesimo», gli disse quando fu certa che fosse completamente sveglio. Lazzari si strofinò la faccia. Gli fischiava l’orecchio sinistro e non sapeva perché. «Non lo hai letto sul dossier preparato dal Colonnello?» «In quel genere di documenti non si usano nomi e cognomi. Il soggetto, così viene chiamato l’interessato», rispose Artemisia. rispose Artemisia. «Mi sento molto più tranquillo nel sentirtelo dire». «Perché?» «A questo punto dovresti averlo capito: se non conosci il mio nome, non puoi incidere sul mio destino. Iside, per farti un esempio, divenne la più potente delle dee egizie perché scoprì il nome segreto di Ra. Conoscere il nome vero del gran dio significava prendere con sé anche tutti i suoi poteri». «E tu che poteri hai?», domandò Artemisia, con il suo registro roco. «Lo scopriremo presto». Lazzari si mise a sedere sul bordo del letto. Con i piedi nudi sul pavimento e i gomiti sulle ginocchia, le dava la schiena. «Ma perché adesso non parliamo un po’ del tuo di nome?» Artemisia si sporse, rimanendo seduta. La fronte corrugata attenuava appena la smorfia di indispettita curiosità con cui lo fissava. «Che vorresti insinuare?». «Non vorrai dirmi che Artemisia è il tuo vero nome... Nessuno si chiama così al giorno d’oggi». «E tu che ne sai?», replicò Artemisia, incapace di nascondere curiosità e fastidio. «Secondo me, Artemisia è il tuo secondo nome ed è il tuo doppio. Alle volte lo indossi, come un vestito il tuo doppio. Alle volte lo indossi, come un vestito diverso o un nuovo look. Gli egiziani, per continuare con l’esempio di prima, inserivano nei corpi imbalsamati, al posto del cuore, uno scarabeo sul quale scrivevano il nome grande del morto, a cui era intimamente legato il ka, ossia il doppio del defunto». Artemisia allungò le gambe e incrociò le braccia. «Stellina, lascia stare le congetture e pensa piuttosto al nome segreto di Roma». «È proprio ciò a cui stavo pensando. Come ti ho già detto, il vero nome di Roma era legato a doppio filo al misterioso nume patrono della città. Nome, potere e divinità sono un tutt’uno per gli antichi, capisci? Gli eruditi romani scrissero cose criptiche a riguardo, ma per fortuna ci aiutano le altre tradizioni a comprendere questo nesso. Secondo la Cabala ebraica, ad esempio, la conoscenza dei nomi segreti di Jahvè conferisce potere sulle cose e sugli esseri. Ogni essere, infatti, possiede un nome vero, un nome che precede la confusione degli idiomi. Adamo, prima della caduta, chiamava per nome gli animali, esercitando così il dominio su di essi», disse Lazzari. Si alzò e si sentì nudo e con un gesto rapido e impacciato infilò la maglietta. «Antonio da Alba Docilia diceva che gli animali vengono verso di noi, se li diceva che gli animali vengono verso di noi, se li chiamiamo per nome; esattamente come gli uomini». «Vediamo dove vuoi arrivare...». «A Roma, come mi hai chiesto tu. Il vero nome della città e quello della divinità tutelare potrebbero essere un tutt’uno. Anche Giove, infatti, aveva un nome segreto. Per questo i pontefici romani nei riti si rivolgevano a lui con una formula dubitativa: “Giove Ottimo Massimo o con qualunque altro nome tu voglia essere chiamato”. E sul Campidoglio era conservato uno scudo dedicato al “genio della città, maschio o femmina”», disse Lazzari. «Ottimo Massimo? Era così che si chiamava Giove?» «All’apparenza, ma il vero appellativo rimase nascosto», rispose Lazzari. «Sia la città sia il dio avevano un nome segreto e ci sono buone probabilità che fosse il medesimo per entrambi, tanto più che i romani intendevano la fondazione della città come una rifondazione del mondo. Ricordi quando ti parlavo del fico come albero della creazione e come centro dell’universo?». Artemisia lo studiò in silenzio qualche secondo prima di parlare. «Ricordo che mi hai detto che il termine Roma potrebbe avere un doppio significato legato agli dèi. Che la parola Roma farebbe riferimento a Romolo, quindi a la parola Roma farebbe riferimento a Romolo, quindi a suo padre Marte se non sbaglio... E se invece leggiamo la parola Roma al contrario otteniamo Amor, che indicherebbe Venere, antenata o addirittura madre dei gemelli...». «Ogni cosa che riguarda la fondazione di Roma è doppia. I gemelli, Remo e Romolo; i popoli delle origini, latini e sabini; le due vette del Palatino, Cermalus e Palatium; gli uccelli che nutrono i neonati, una parra e un picchio; i numi tutelari, Fauno per Remo e Marte per Romolo; lo stesso Marte, identificato ora come Gradivo ora come Quirino; il primo degli dèi, Giano dal doppio volto; i signori di Alba, Amulio e Numitore; le madri dei gemelli, Silvia quella naturale e Acca quela adottiva; la stessa Silvia...». «Finirai la lista un’altra volta», disse Artemisia abbandonando inaspettatamente la stanza. Lazzari rimase ancora un paio di minuti a fissare il pavimento, poi infilò i calzoni e raggiunse il bagno che dava sul corridoio al centro del piano. Mentre si sciacquava la faccia udì il Lupo parlare al telefono nella stanza attigua. «Sì direttore, mi conferma? Settantacinquemila? È sicuro? Settantacinque...». Lazzari chiuse il rubinetto e si mise in ascolto, ma le Lazzari chiuse il rubinetto e si mise in ascolto, ma le parole scemarono all’improvviso. Forse l’uomo era uscito a parlare sul balcone. Restò ancora qualche secondo imbambolato a fissare lo specchio, poi finì di lavarsi e tornò in camera. Quando scese di sotto trovò il Lupo e Dino nell’atrio già pronti alla partenza. «E Artemisia?», domandò il barbuto tradendo nervosismo. L’ombra del cappellino nascondeva solo in parte le pesanti occhiaie. «Pensavo fosse giù». Mentre aspettavano, Lazzari cercò di esaminare di nascosto l’espressione del Lupo. L’avrebbe definita sorpresa, sebbene mal si sposasse con il volto nervoso e spesso sarcastico di quell’uomo. Eppure gli sembrava proprio la faccia di qualcuno che, ricevuta una notizia imprevista, non sa come giudicarla. O forse vedeva solo fantasmi, come al solito. «È tardi», disse il Barbuto sollevando i borsoni non appena vide Artemisia sul ballatoio. «Muoviamoci, mangerete per strada». Il Lupo si rivolse ad Artemisia: «Scusate se ho dubitato di voi. Ho ricevuto conferma dalla banca. Trasferimento già effettuato. Siete persone di parola». Trasferimento già effettuato. Siete persone di parola». «Ma con chi credeva di avere a che fare questo?», disse Dino e uscendo si lasciò sfuggire un verso di disappunto. «Il Maestro dov’è?», domandò Artemisia, guardando interrogativamente le scale. «È partito stanotte», rispose Lazzari. «Come partito?» «L’aveva detto, ricordi? Ci aveva promesso di condurci fino al Lupo, ma non un passo oltre». Artemisia era stupefatta e irritata, come chi scopre che l’ospite d’onore ha abbandonato la festa prima ancora di tagliare la torta e aprire i regali. «Ma che dici? Non è possibile. È assurdo!». «È fatto così». «Meglio, dico io. Mi sento molto più leggero senza il corvo sulla spalla», commentò il Lupo mentre usciva. Artemisia stava per chiedere spiegazioni, ma Lazzari le posò una mano sulle labbra. «Chi ha fatto il bonifico al Lupo?», le domandò a bassa voce. «Il Colonnello, ovvio». «Soldi suoi?» «Soldi della Fondazione». «Quarantacinquemila come concordato?» «Quarantacinquemila come concordato?» «Sicuro. Che cosa te ne importa?» «Niente, andiamo», fece Lazzari e andò fuori seguito dalla ragazza, che non ne voleva sapere di arrendersi. «Lazzari, pretendo dei chiarimenti. Il Maestro...». Artemisia si interruppe di colpo, perché oltre il cancello di metallo intravide due taxi in attesa. «Io e Artemisia saliremo su uno, voi due sull’altro», annunciò Dino. «Che significa?», chiese Artemisia. Lazzari si accorse che era stata colta di sorpresa dalla decisione di Dino, ed era la prima volta che accadeva da quando si era unito a loro. Si erano sempre confrontati su ogni questione e le scelte finali erano sempre state, almeno all’apparenza, compito della ragazza. Dino sembrava in imbarazzo. «Lasciamo il nostro fuoristrada qui. Ora non ho il tempo di controllarlo per vedere se c’è una microspia o un indicatore di posizione a distanza», spiegò in tono rude, come se non sapesse bene come uscire da quella situazione e avesse deciso di appellarsi all’autorità che gli derivava dalla forza fisica. «Che diavolo è successo?», volle sapere Lazzari. «Stanotte ho visto una Mercedes passare per tre «Stanotte ho visto una Mercedes passare per tre volte sulla strada qui davanti. Non mi fido. Non sono riuscito a leggere la targa nemmeno con il binocolo perché era offuscata da quegli spray che si usano contro gli autovelox: nessuna persona raccomandabile si premura di camuffare la targa». «Tauros?», fece Lazzari. Dino annuì. «Tu e il Lupo chiedete al taxista di prendere l’autostrada e fatevi lasciare al primo autogrill dopo Cerveteri. Una volta lì, fate attenzione a chiunque vi si avvicini e soprattutto alle macchine in sosta. Visto il tipo di posto, sarà facile capire se qualcuno vi ha seguito e vi tiene d’occhio. Noi ci procureremo un’auto pulita e passeremo a prendervi lì prima di sera». «Non sai nemmeno dove dobbiamo andare», gli disse il Lupo. «Per il momento non voglio saperlo». All’autogrill il Lupo e Lazzari si sedettero accanto alla vetrina affacciata sul parcheggio. Gli avventori arrivavano a ondate e si accalcavano prima alla cassa e poi al bancone. Lazzari si chiedeva se sarebbe stato in grado di gestire un simile flusso nel suo locale, ma era una gestire un simile flusso nel suo locale, ma era una domanda oziosa. L’enoteca non avrebbe mai avuto così tanta clientela e lui, forse, non avrebbe più rivisto la sua enoteca. Verso le dodici fu approntato il banco di servizio del ristorante e anche i tavoli si riempirono rapidamente. I due uomini furono avvolti da una nube di chiacchiere e di aromi. Mangiarono una bistecca a testa, ma bevvero solo metà della bottiglia di Cerveteri rosso che avevano ordinato. Non avrebbe saputo dire se fosse il vago sentore di tappo, come diceva il Lupo, o piuttosto quello della tensione, come sospettava Lazzari, ma non riuscirono a finirlo. Alle tre erano di nuovo gli unici seduti all’interno della stazione di sosta. Nessuno faceva caso a loro. Quando passò il ragazzo con la scopa si limitarono a sollevare le gambe. Ogni tanto ordinavano una tazza di caffè e a turno si alzavano per andare al bagno o a prendere una boccata d’aria fuori. Le auto nel piazzale si avvicendavano. Soltanto una di quelle già presenti al loro arrivo era ancora lì, ma il Lupo aveva visto una delle ragazze del bar entrarci per prendere qualcosa. «Dato che ora lavoriamo per la stessa squadra, è «Dato che ora lavoriamo per la stessa squadra, è giusto che te lo dica. Tra sodali si fa così», disse a un certo punto il Lupo. Pareva aver riflettuto a lungo sull’eventualità di confidarsi. «Nel nostro ambiente è sempre girata una storia molto attendibile secondo cui il lituo sarebbe stato ritrovato a inizio Novecento. Erano giorni gloriosi per il nostro mestiere, avventurieri e cacciatori di tesori setacciavano l’Italia e ogni giorno poteva essere quello per una nuova scoperta». Lazzari finì il caffè e prese nota mentalmente del fatto che la confidenza del Lupo stava saltando fuori a compenso pagato. «Avvenne durante la campagna di scavi sul Palatino?» «Ne hai sentito parlare anche tu, eh? Lo immaginavo. Non fu una vera e propria campagna di scavi. Diciamo che l’amministrazione mise in piedi una vasta azione di riqualificazione in quella zona dell’Urbe. E furono molti quelli che brandirono la vanga nella speranza di mettere le mani sui tesori del passato. In quel periodo furono riportati alla luce numerosi elementi architettonici delle origini, o almeno ciò che ne rimaneva, come le vestigia delle scale di Caco o i cippi votivi che segnavano il pomerium o...». «O le capanne palatine». «O le capanne palatine». «Una di esse, quasi un secolo dopo, è stata riconosciuta come la Regia di Romolo da alcuni archeologi». «Con gli annessi sacrari di Marte e di Opi». «E fu precisamente nel sacrario della dea Opi che un avventuriero dell’epoca rinvenne uno scrigno di tartaruga che conteneva al suo interno un bastone ricurvo. O, almeno, così si tramanda». Lazzari interruppe quello che stava diventando un incalzante racconto a due voci e con tono disincantato disse: «È solo una storia». «Può darsi, ma di testimoni ce ne furono. E affidabili. E ne hanno parlato per un pezzo», insistette il Lupo. Lazzari si alzò, infilò le mani in tasca e guardò fuori dove i camion sfrecciavano spostando roboanti montagne d’aria. «Si è tramandato anche il nome dell’avventuriero?». Il Lupo intrecciò le dita dietro la nuca e si dondolò sulla sedia in bilico. «Sì. Se la memoria non mi inganna, si chiamava Casini». 21 Dino e Artemisia arrivarono verso le cinque a bordo di una Land Rover verde con la fiancata sporca di fango ancora fresco. La ragazza saltò a terra prima ancora che il fuoristrada si fosse arrestato del tutto. Indossava pantaloni della tuta infilati nelle calze, una felpa con il cappuccio e scarpe da ginnastica, ma quei vestiti dimessi non facevano che accrescerne il fascino per contrasto. Era la prima volta che Lazzari la vedeva con il rossetto, un colore infuocato, molto vicino al rosso, che le accendeva le efelidi sulle guance e, al contrario, le illanguidiva il verde degli occhi. Senza nemmeno salutarli, Artemisia lanciò una borsa a Lazzari. «Dentro troverai un paio di jeans e una felpa». Lazzari, sorpreso, restò fermo. «Non c’è il libretto di istruzioni», lo incalzò Artemisia ammiccante. «Fai presto», lo sollecitò Dino. Lazzari filò in bagno, si svestì e si sciacquò Lazzari filò in bagno, si svestì e si sciacquò rapidamente. I pantaloni erano proprio della sua taglia. Appese l’abito sgualcito che aveva preso a Milano a un gancio e lo lasciò lì: a qualcuno sarebbe forse servito. Gli faceva una strana impressione vedersi con quella felpa sgargiante e voluminosa: assomigliava a uno che si era finalmente reso conto di avere quarant’anni e cercava di vestirsi come un trentenne. Si stava ancora specchiando quando entrò Dino. Era visibilmente nervoso e gli fece segno di sbrigarsi. «La Mercedes di cui ti accennavo stamattina ci ha seguito a distanza, dopo che io e Artemisia abbiamo lasciato il casolare a bordo del taxi. Ma ora dovremmo essere riusciti finalmente a seminarli». Lazzari incassò la notizia senza scomporsi, non voleva più lasciar trapelare alcuna emozione. «Tauros?». Dino annuì. «È una gara contro il tempo: dobbiamo trovare il lituo prima che loro trovino noi». «Sì», mormorò Lazzari in tono distaccato. «Sì», ripeté poi con maggiore convinzione, come se soltanto in quel momento avesse compreso ciò che gli aveva detto l’altro. “Prima di loro”, si disse mentre un’idea si faceva strada dentro di lui. «Mi chiedo come abbiano fatto a piazzarci una «Mi chiedo come abbiano fatto a piazzarci una ricetrasmittente in macchina», fece Dino picchiando la mano aperta contro il muro. «Ma stamattina non hai detto di averla individuata, ma solo che sospettavi ci fosse». «Non vedo quale altro modo avrebbero avuto per trovarci al casolare del Lupo. In ogni caso un uomo del Colonnello controllerà quanto prima l’auto che abbiamo lasciato al casolare e presto avremo un responso», disse Dino. «Tutto ciò che possiamo fare per il momento è agire con estrema prudenza. Gli uomini della Tauros sono agenti maledettamente in gamba, dobbiamo avere cento occhi». «Pensavo che il Colonnello non conoscesse rivali nel suo mestiere», provò a stuzzicarlo Lazzari. «Sta mettendo in atto le contromisure del caso. Tu pensa a condurci fino al lituo. E ora muoviamoci», fece Dino prendendolo per la spalla. Il Lupo e Artemisia erano già in auto. Saltarono su anche gli altri due e ripartirono immediatamente. «Il luogo è sulla via Appia, non distante da Formia», rivelò il Lupo non appena si furono immessi nella carreggiata. «Per una volta tanto siamo sulla giusta strada», «Per una volta tanto siamo sulla giusta strada», commentò Dino. Teneva sulle gambe uno strumento elettronico simile a un tablet e lo controllava ossessivamente. «Vuoi che guidi io?», gli domandò Lazzari preoccupato, ma l’altro non rispose. «Capisco la fretta, e la approvo, però dobbiamo per forza uscire dall’autostrada e fare una sosta per procurarci degli attrezzi», ricordò il Lupo. Artemisia accennò al bagagliaio. «Ci abbiamo già pensato noi. Abbiamo vanghe, torce, picconi e altri strumenti. Tutti doni del Colonnello». Lazzari sobbalzò e si voltò di scatto. Il tentativo di mascherare le proprie emozioni era già falito. «Il Colonnello è qui?». Dino lo prese per una spalla obbligandolo a rigirarsi. «Abbiamo avuto un incontro per pianificare le prossime mosse. Ha deciso di seguire l’operazione da vicino. Te l’ho detto: qualcosa non torna». Lazzari cercò ansiosamente di scovare qualche indizio nella sua espressione, ma gli occhiali scuri e la barba lunga che saliva verso gli zigomi lo rendevano una sorta di Zeus sibillino e ieratico. «Nuovi problemi?», gli domandò infine. domandò infine. La voce, però, tradiva tutta la tensione di Dino: nulla avrebbe potuto mascherarla. «Gli ho chiesto rinforzi. Le contromisure di cui ti parlavo, ricordi? Gli agenti della Tauros ci stanno addosso e a quanto pare non hanno nessuna intenzione di abbandonare la caccia». «Come fai a esserne così sicuro?» «Te l’ho detto, man. Su quella Mercedes c’era gente loro». «E se fossero gli uomini della Confraternita? Chi ci dice che anche loro non siano sulle nostre tracce? Tu non hai visto come hanno ridotto Achille Vento, ma io e Artemisia sì». «Riconosco un mio simile quando ne incontro uno. Le procedure e i metodi sono gli stessi in questo mestiere. Su quella Mercedes c’erano agenti della Tauros». «Se davvero ci avevano scovati al casolare dell’amico del Lupo, perché diamine non si sono fatti vivi? Perché non hanno tentato un colpo di mano come a Sarzana?», domandò Lazzari. Dino aprì il finestrino e sputò la gomma che stava masticando. Il rumore del vento scavò una pausa nella conversazione. «Io la risposta non ce l’ho», ammise infine dopo averlo richiuso. dopo averlo richiuso. Lazzari si morse le labbra per non tradire un sorrisetto isterico. Lui pensava di averla. Era quasi buio quando arrivarono a Formia. Gli alberi sul lungomare erano schizzi di inchiostro spruzzati contro il cielo, mentre gli aloni dei lampioni brillavano come tanti piccoli falò agitati dal vento. Le candide case intorno alla torre sembravano disegnate da un bambino. Abbandonarono la regionale che costeggiava il mare e puntarono verso l’interno. Superato un bosco di pini, svoltarono per un vialetto sterrato e raggiunsero un casolare in rovina. «Fermiamoci qui», disse il Lupo indicando i cardini superstiti di quello che doveva essere stato un grande cancello in ferro. L’aia era circondata sui tre lati da una costruzione in pietra e malta, con ogni probabilità la stalla, sormontata da un fienile diroccato. Del tetto di travi rimanevano pochi monconi anneriti. A Lazzari fece la bizzarra impressione di un oggetto del suo passato. Lasciarono la Land Rover all’interno del cortile, in modo che non potesse essere avvistata dalla via sottostante, e proseguirono a piedi. sottostante, e proseguirono a piedi. Il Lupo faceva strada con la torcia. Dino, fucile a tracola, trasportava gran parte dei bagagli. Lazzari camminava in coda e ogni tanto, perso nei suoi ragionamenti, si attardava e doveva poi accelerare il passo per riprendere i compagni. Il sentiero, poco battuto, correva dentro un faggeto: dal sottobosco proveniva un sentore di felci e terra umida. Di tanto in tanto si udiva il verso di qualche uccello notturno e rapidi fruscii di animali. A intervalli regolari Dino ripercorreva la piccola colonna e si allontanava per controllare che nessuno li seguisse. Più volte gli capitò di incrociare lo sguardo di Lazzari. Pareva che ciascuno dei due avesse qualcosa da confidare all’altro e cercasse l’occasione giusta per farlo, ma per un motivo o per l’altro quel momento veniva continuamente rimandato. Giunsero infine a una modesta radura circondata da cespugli di dafne: i fiori bianchi e porpora occhieggiavano ogni qual volta erano colpiti dal fascio di luce delle torce elettriche. Quando invece sparivano nell’oscurità, pareva crescere il loro profumo. «Montate le tende tra quei due faggi. Io vado a individuare l’ingresso della tomba. Non è distante da individuare l’ingresso della tomba. Non è distante da qui», disse il Lupo. «Stagli dietro», mormorò Dino all’orecchio di Lazzari, che si affrettò per raggiungerlo. Il Lupo, quando lo vide comparire alle proprie spalle, parve approvare. «Seguimi e stai attento ai sassi e alle radici. A rompersi una gamba non ci vuole niente, a rimettere insieme i cocci invece servono mesi». «Come l’hai scoperta?», gli domandò Lazzari dopo alcuni passi, cercando di non far trasparire la trepidazione. Era la sua grande occasione e se avesse falito non ne avrebbe avuta un’altra. «L’ha scoperta un pastore, per caso, un paio di anni fa. Non esistono in natura animali più curiosi delle pecore», rispose il Lupo senza rallentare l’andatura. Nonostante fosse basso, ogni suo passo valeva due di quelli di Lazzari, che era quasi costretto a rincorrerlo. «La notizia è arrivata a uno dei miei informatori, e due ore dopo ero qui. In meno di tre giorni io e il mio uomo l’abbiamo aperta e ripulita. E nemmeno due mesi dopo avevo già piazzato tutti i pezzi». «Tranne la cassa», gli ricordò Lazzari. «Tranne la cassa», confermò il Lupo sottovoce. «Vedo che la memoria non ti fa difetto». «Vedo che la memoria non ti fa difetto». «Ora proviamo con la tua». «Con la mia?», fece il Lupo sorpreso. «Dove tieni la cassa?». Il Lupo si fermò di colpo e alzò la torcia per studiare il volto di Lazzari che, pur abbagliato, non si sottrasse all’esame. «Voglio dimostrarti che mi fido di te, perché io e te abbiamo la stessa meravigliosa passione che ci scorre nelle vene. La cassa la conserva quel mio informatore a casa sua. Vive a pochi chilometri da qui». Lazzari si passò una mano sulla barba a cui non era abituato. «Lo immaginavo. Tu sei uno che non rinuncia mai a un affare, ma aspetta l’occasione...». «Nemmeno l’immaginazione ti fa difetto. Sono curioso di sapere dove vuoi andare a parare». «Era ancora in buono stato il legno della cassa? E abbastanza spesso?». Il Lupo sgranò gli occhi e abbassò la luce. «Diciamo di sì. Ora puoi spiegarmi cosa ti passa per la testa?» «Ho avuto un’idea». Il Lupo, dopo un’esitazione, fece la faccia di chi ha appena ricevuto una cattiva notizia e ripartì all’improvviso scuotendo la testa e imprecando sottovoce. Lazzari non poté fare altro che seguirlo. poté fare altro che seguirlo. «Vuoi vendere la cassa a quei due allocchi che ci portiamo dietro raccontando loro chissà quale storia? Eh?», fece il Lupo come un fiume in piena. «Lascia che te lo dica: non è una grande idea. Guadagneremo al massimo poche migliaia di euro, e poi non dimenticare il motivo per cui ho accettato la vostra offerta: la possibilità di lavorare ancora per il Committente e ottenere altri incarichi simili. E la prima regola per lavorare ancora con qualcuno è di non gabbarlo alla prima occasione. Quel’uomo non l’ho mai visto eppure già mi piace: cinquantamila euro per vedere una tomba vuota è un meraviglioso biglietto da visita e io non voglio correre il rischio di bruciarlo. Patti chiari, amicizia lunga, amico mio. Hai capito bene?» «Sì e no», disse Lazzari. «Sì e no che?», ringhiò il Lupo. «Sì, ho avuto un’idea. Ma no, non è quella che tu credi». Il Lupo non disse più nulla fino a quando non si arrestò, riconoscendo la pietra triangolare che a suo tempo aveva disposto sopra l’apertura della tomba. «L’ipogeo è tra quei cespugli», rivelò. «Dopo aver portato via tutti i reperti dalla camera mortuaria, ho portato via tutti i reperti dalla camera mortuaria, ho ricoperto l’ingresso. Non mi andava che qualcun altro la trovasse. La sento mia». Lazzari represse un brivido di eccitazione, la sensazione confusa di chi vede il mare per la prima volta, e riprese il filo del discorso: «La mia idea ti garantirà la stima e la riconoscenza del Committente». «Vale a dire una montagna di soldi?» «Vale a dire il migliore mecenate possibile», disse Lazzari cercando di caricare la propria voce di tutto il trasporto di cui era capace. Poi gli si avvicinò. «Non è questo che desideri? Qualcuno che apprezzi il tuo lavoro e possa comprare al giusto prezzo tutti i tesori che porterai alla luce? Che finanzi le tue spedizioni, anche quelle più azzardate? Che sogni i tuoi stessi sogni?». Il Lupo spense la luce. «Sì, è questo», ammise. «Allora ascoltami bene». 22 Lazzari non riuscì ad addormentarsi. Dopo essersi rigirato nel sacco a pelo per un paio d’ore, uscì dalla tenda e scoprì che Dino era rimasto di guardia. Spostò il binocolo e si sedette al suo fianco. Il barbuto gli fece cenno di passarglielo. «Niente sonno?», gli domandò Lazzari. «Ci sono volte in cui l’unico modo sicuro per svegliarsi è quello di non andare a dormire», rispose Dino accarezzando il fucile. Verso le quattro anche Artemisia si unì ai due compagni. Aveva i capelli di una gorgone e il volto leggermente gonfio di una diva francese sulla ribalta qualche anno prima – Lazzari non ricordava il nome. Dino cedette alle richieste della ragazza e acconsentì ad accendere un piccolo fuoco con cui riscaldarsi, schermandolo perché le fiamme facessero meno luce possibile. «Me lo hanno insegnato in Africa», disse quando ebbe finito di camuffarlo. ebbe finito di camuffarlo. «Ci siamo», mormorò Lazzari tra sé e sé. Verso le sei il Lupo uscì dalla sua tenda e fece cenno a Lazzari di raggiungerlo. Gli mise un braccio attorno alle spale guidandolo oltre i cespugli che proteggevano il piccolo accampamento. «Non ci avrai ripensato?», gli disse Lazzari tradendo l’ansia. «Oh, niente affatto. Tutto confermato, anzi», lo tranquillizzò il Lupo. «Però stanotte ho sentito al telefono anche un altro mio amico. È un importante antiquario di fama internazionale, specializzato in codici e volumi antichi». Lazzari gli fece cenno di andare avanti. «Mi sono permesso di chiedere il suo parere su quel libro di cui mi hai accennato, l’Epoptidon. Pensavo, e lo penso tutt’ora, di farti cosa gradita». Lazzari non ricordava di avergliene parlato, ma forse era stato Parodi quando lo aveva contattato dietro loro richiesta. «Arriva al punto». «Questo mio amico dice di essere in possesso di un frammento di pergamena che potrebbe essere appartenuto all’Epoptidon». «Che cosa glielo fa credere?» «Che cosa glielo fa credere?» «È proprio questo il punto. Il suo, per quanto fondato, è soltanto un sospetto, un’intuizione. Mi ha parlato di un viaggio di Valerio Sorano in Sicilia prima della sua morte». «Alcune fonti vi accennano», concesse Lazzari. «Di più non mi ha detto. Forse ipotizza che durante il viaggio Sorano sia riuscito a nascondere una copia dell’Epoptidon e che il libro sia poi sopravvissuto in qualche modo...». «Lascia stare le ipotesi». «Giusto, te ne parlerà lui stesso. Sarebbe felice di mostrarti il frammento in questione. Se fosse davvero autentico, come mi auguro, ci guadagneremmo tutti. Tu ricaveresti informazioni preziose, forse decisive, e lui si ritroverebbe tra le mani un pezzo di valore centuplicato». «E tu?» «E io avrò la mia commissione, come è giusto che sia», ammise il Lupo come se fosse naturale e insindacabile. «Questo mio amico sta a Roma. In mezza giornata andiamo e torniamo. Che ne dici?» «Dico no». «Perché?» «Prima la tomba». «Prima la tomba». «La tomba non scappa». «E il tuo amico nemmeno. Lo hai detto tu stesso. Ha cento buoni motivi per non farlo». Il Lupo pareva deluso e irritato. Rimase incerto su come ribattere, non era affatto preparato a ricevere un rifiuto. «Il tuo non è un ragionamento da uomo del mestiere», disse infine. «Infatti non è il mio mestiere. Ora vieni, prima che Dino si insospettisca». Fecero colazione con pane e formaggio, bagnati da una tazza di caffè freddo, poi radunarono gli attrezzi e si misero in marcia. Il Lupo era il più loquace del drappello e non faceva che raccontare vecchi aneddoti su altri cacciatori di tesori, figure mitiche di un passato più o meno recente che solo lui pareva conoscere e venerare. Sembrava essersi completamente dimenticato della discussione di poco prima con Lazzari. «Di te non ci racconti nulla?», lo interruppe a un certo punto Dino, con fare provocatorio. «Di me parleranno gli altri, un giorno», promise il Lupo. «Come accadde con il grande Schliemann che era Lupo. «Come accadde con il grande Schliemann che era deriso e vilipeso da tutti per le sue intuizioni e alla fine scoprì Troia e passò alla storia». Mancavano poche centinaia di metri alla tomba, quando squillò il cellulare di Dino, un suono disturbante nel silenzio del bosco. «Fermi tutti», ordinò, allontanandosi poi per rispondere. Artemisia si avvicinò a Lazzari. «Che hai? Mi sembri teso come una corda». «Hai presente il primo giorno di scuola?» «Io non ti capisco: prima eri certo che non lo avremmo mai trovato, il lituo, e ora sei convinto che sia conservato in quella tomba». «So tutto quelo che mi serve sapere», rispose Lazzari a disagio. «Ma che cosa ti fa essere così fiducioso?», insistette Artemisia. «All’interno della tomba c’era il medaglione della Confraternita, non dimenticarlo». «Non mi pare un indizio sufficiente». «Ce ne sono molti altri, anche se tu non puoi vederli». Artemisia, già surriscaldata, era pronta a ribattere, ma in quel momento ricomparve Dino, scuro in volto. «Era il Colonnello. Ha appena ricevuto una soffiata «Era il Colonnello. Ha appena ricevuto una soffiata affidabile», li informò senza guardare nessuno in particolare. «La Tauros?», si preoccupò Lazzari. «No, ha a che vedere con le nostre ricerche». «E perché non ha chiamato me?», si arrabbiò Artemisia. «Non so quali fossero i vostri accordi. Io dipendo da lui, lo sai». «Che succede?», insistette Lazzari. «Dobbiamo andare a Ostia», annunciò Dino. «Reperti ripescati dalle paludi...». Lazzari era esterrefatto. C’erano una serie incredibile di assurdità in quello che aveva appena udito e non sapeva quale indicare per prima. «Non ci sono più paludi a Ostia». «Ripescati molti anni fa», precisò Dino. «C’è un tizio disposto a venderli. Roba che scotta e che potrebbe interessarci. Non so altro...». «Non se ne parla», disse Lazzari. «Anche quella di Vento era una pista scovata dal Colonnello e anche allora eri perplesso», si inserì Artemisia. «Ora non sono affatto perplesso. Sono furibondo», «Ora non sono affatto perplesso. Sono furibondo», sbottò Lazzari. «È chiaramente una bufala! Ci voglio rifilare della paccottiglia. È mai possibile che dobbiamo perdere tempo per una cosa simile? Vi avevo messo in guardia a suo tempo. Si stanno di certo diffondendo delle voci sulla nostra ricerca. D’ora in avanti il vostro Colonnello sarà tempestato di telefonate di gente che proverà a vendergli reperti. Che dovremmo fare? Rispondere alla chiamata di chiunque ci...». «Qui non stiamo parlando di cosa dovremmo fare, ma di cosa faremo. E noi andremo a controllare», mise in chiaro Dino, il fucile di traverso sulla spalla. «Sono ordini. A meno che Artemisia non si prenda la responsabilità di scegliere diversamente». Artemisia guardò Lazzari per qualche istante, con un’aria interrogativa, poi si decise all’improvviso. «Andremo là». «Faremo un buco nell’acqua», insistette Lazzari. «È il posto giusto», fece il Lupo. «Paludi, no?» «Se avessi protestato, come prevedeva, il Colonnello mi ha detto di farti questo nome: Costantino Maes», disse Dino rivolgendosi a Lazzari. «Ecco un altro nome da non dimenticare mai», commentò il Lupo. «Un uomo a cui è stato dato troppo commentò il Lupo. «Un uomo a cui è stato dato troppo poco credito». «Troppo poco credito? Era ancora più pazzo di noi!», sbottò Lazzari, resosi conto ancora una volta di averli tutti contro. «Il Colonnello sarà anche il migliore specialista di sicurezza di questo Paese, ma non intendo farmi dire da lui dove posso o non posso trovare tracce del lituo». «Lascia perdere il Colonnello. Te lo chiedo io», disse Artemisia, e addolcì l’espressione. La sua bocca forte si aprì in un sorriso inaspettato che aveva la qualità di un colpo di fortuna, di una bella notizia. Ci fu silenzio. Poi, appena la ragazza si accorse che Lazzari aveva ceduto, aggiunse con fare disinvolto, come se non volesse far notare la resa del compagno: «Chi è questo Costantino Maes? Perché dovrebbe essere importante per noi?» «Il Lupo, magari, proverà a spiegarti perché è importante per noi», disse Lazzari. «Poi io ti dirò perché non lo è affatto». Giunsero sul luogo dell’appuntamento soltanto alle dodici e trenta. Lungo la strada erano stati informati dello spostamento dell’incontro da Ostia a Nettuno, e così spostamento dell’incontro da Ostia a Nettuno, e così erano stati costretti a cambiare itinerario e rifare un pezzo di strada al contrario. Artemisia, Lazzari e il Lupo si sedettero al tavolino di un bar affacciato sul mare: era stato il Colonnello a indicare il nome del locale per telefono. Da Dino si erano separati al parcheggio. Il barbuto voleva controllare la zona e non farsi vedere insieme a loro. Ogni tanto lo scorgevano passare dall’altra parte della strada, con occhiali e cappello, il passo ciondolante del turista. «Era un erudito e un millantatore, ma aveva grandi sogni», se ne uscì a un certo punto Lazzari, posando la birra che aveva appena assaggiato. «Di chi stai parlando?», gli domandò Artemisia. «Di Maes», rispose al suo posto il Lupo. «Era un avventuriero e uno studioso, proprio come me. Grazie a una sua geniale illuminazione, a inizio Novecento furono scoperte nel Lago di Nemi alcune navi romane, di cui tutto il mondo scientifico ignorava l’esistenza. Rimasero con un palmo di naso quando le ripescarono. Ma la sua vera ossessione era il tempio di Giove Capitolino, il più importante tra quelli di Roma. Dedicò tutta la vita a quella ricerca». Artemisia sorrise. «Ritrovarlo? Come si fa a perdere Artemisia sorrise. «Ritrovarlo? Come si fa a perdere un tempio? Non basta scavare sul Campidoglio?» «No, non è più là», rispose il Lupo. «Andò bruciato nel sessantotto dopo Cristo, durante gli scontri cittadini successivi alla morte di Nerone. Tacito racconta che tutti i resti del tempio, così come gli arredi e i tesori custoditi all’interno, furono trasportati via fiume fino alle paludi di Ostia, dove furono sepolti dai sacerdoti». «E perché?» «Forse Lazzari può spiegartelo meglio di me». «Giove era il garante principale della pax deorum, ossia del patto tra gli dèi e i romani. Bruciare il tempio, sia pure per fatalità, comportò la rottura dell’alleanza: era un orrendo sacrilegio e andava espiato a qualsiasi prezzo. La sepoltura rituale dei resti profanati, secondo i libri sacri, avrebbe potuto ricomporre la pace», spiegò Lazzari senza l’abituale trasporto, e poi guardò l’orologio al polso di Artemisia. L’informatore del Colonnello era in ritardo già di mezz’ora. «Stiamo parlando di uno dei più grandi tesori dell’umanità. Però nessuno volle investire nel progetto di Maes», disse il Lupo con partecipazione, quasi fosse stato lui a non aver ricevuto fiducia. «Le paludi sono state comunque prosciugate anni «Le paludi sono state comunque prosciugate anni dopo, come sanno tutti, e nulla del tempio di Giove è saltato fuori». «E chi lo dice? Parliamoci chiaro Lazzari: i musei non sono certo i migliori compratori di questo mondo», si animò il Lupo, facendosi avanti sulla sedia. «Secondo te l’uomo che dobbiamo incontrare ha recuperato parte di quel tesoro?», gli domandò Artemisia. «Non dico che sia così, dico che potrebbe essere così. Io non vendo mai illusioni», puntualizzò il Lupo. «E potrebbe esserci il lituo di Romolo tra quei reperti?», chiese Artemisia. «È del tutto plausibile che i romani lo avessero conservato nel tempio di Giove, e che poi siano stati costretti a seppellirlo nelle paludi insieme a tutto il resto del tesoro contenuto nel tempio», rispose il Lupo. «Ma cosa è plausibile?», sbottò Lazzari. «Qualunque cosa abbia tirato fuori quest’uomo da qualsivoglia palude o pozzo o canale non può interessarci. Anche se fossero reperti del tesoro capitolino, cosa tra l’altro del tutto improbabile. Il lituo, come tutto ciò che riguarda la fondazione di Roma, può essere stato conservato unicamente sul Palatino. I romani non avrebbero mai unicamente sul Palatino. I romani non avrebbero mai trasferito le sacre reliquie della fondazione dal Palatino al Campidoglio. Sarebbe stato un sacrilegio, perché i due colli erano legati a riti e divinità differenti e per certi versi incompatibili». «Dimentichi le fonti che affermano che durante l’invasione dei galli le Vestali e i pontefici portarono via dal Palatino gli oggetti sacri per seppellirli in un posto sicuro». «Le stesse fonti che riferiscono il ritrovamento del lituo, intatto, sul Palatino dopo l’incendio che i galli appiccarono alla città. Se per motivi di sicurezza avessero dovuto spostare il lituo, i romani lo avrebbero portato fuori città piuttosto che sul Campidoglio o in qualsiasi altro luogo di Roma». Il Lupo stava per replicare, ma si trattenne all’improvviso. «Scusate il ritardo, signori», disse un uomo che si era appena avvicinato. Dino attraversò rapidamente la strada e, facendo finta di niente, si sedette al tavolo accanto al loro. «Prenditi una sedia», disse Artemisia allo sconosciuto, che non se lo fece ripetere due volte. Sui sessanta, indossava un completo scuro fuori Sui sessanta, indossava un completo scuro fuori moda, di quelli che si vedono talvolta alle cerimonie. L’odore di naftalina era inequivocabile anche all’aria aperta. «Ho poco tempo e non voglio rubare il vostro», disse l’uomo e tirò fuori un sacchetto di stoffa che lanciò sul tavolino in corrispondenza della sedia di Lazzari. Fu però Artemisia ad agguantarlo. Slegò i lacci e tirò fuori alcune schegge di cinque o sei centimetri di lunghezza. «Che roba è?» «Forse il professore può rispondere», disse l’uomo. Lazzari diede un’occhiata ai frammenti. «Sono presumibilmente scaglie di gusci di tartaruga». Lanciò una breve occhiata al Lupo e poi, dando per scontato le intenzioni del venditore, spiegò senza perdere altro tempo: «I romani, quando dovevano nascondere oggetti sacri per motivi di sicurezza, costruivano sotto terra teche in travertino, in cui depositavano orci sigillati, chiamati doliola. In quasi tutti gli orci ritrovati sono stati rinvenuti frammenti di gusci di tartaruga. Credo fossero indispensabili per il rito con cui i pontefici conferivano la loro protezione magica ai doliola». «Rappresentano il mio biglietto da visita, professore», disse l’uomo visibilmente soddisfatto che professore», disse l’uomo visibilmente soddisfatto che Lazzari avesse colto nel segno. «So del suo scetticismo, ma tengo a farle presente che durante il prosciugamento delle paludi, a cui presero parte centinaia di uomini, furono rinvenuti numerosi reperti romani. Alcuni furono confiscati, altri venduti sottobanco, altri ancora conservati di nascosto. Mio nonno era uno di quegli eroici braccianti, e anche lui ne mise da parte alcuni. Nel corso degli ultimi quarant’anni mi sono dato da fare per recuperare, da coloro che ne erano in possesso, quanti più reperti possibili tra quelli saltati fuori dalle paludi. Ora posso vantare una collezione invidiabile. Vengono da tutte le parti del mondo per visionarli e comprarli. Ho saputo delle vostre ricerche e ho pensato che forse volevate dare un’occhiata». «Possiamo andare ora a vedere la sua collezione?», domandò Artemisia. «Ci sono delle procedure di sicurezza da rispettare, signorina. Precauzioni, capisce? Posso portarvi là, diciamo dopodomani, se per voi va bene. Ah, e un’altra cosa. Stavo quasi per dimenticare», disse l’uomo passandosi un fazzoletto di stoffa sulla fronte. «Si paga il biglietto per entrare. Come al museo. Capite, è per scoraggiare i semplici curiosi. I soldi, poi, vi verranno scalati dagli eventuali acquisti. Sono millecinquecento a testa, in anticipo». «Questa poi», mormorò Lazzari senza nascondere il sarcasmo. «Ti pagheremo dopodomani. Non ti preoccupare, avrai i tuoi soldi», disse con una certa ruvidezza il Lupo, agitandosi sulla sedia. Artemisia lo guardò con aria di rimprovero, per avere parlato a nome loro senza il suo permesso, ma non gli disse nulla. «Come ti contattiamo?», domandò allo sconosciuto. «Il signor Colonnello», rispose l’uomo, che non pareva affatto contento di non aver ricevuto l’anticipo richiesto. Si guardò attorno, come se non sapesse bene cosa fare, poi salutò e se ne andò senza aggiungere altro. Dino si voltò verso il loro tavolo. Per un po’ rimasero tutti in silenzio, come se ciascuno dei quattro stesse ripassando la propria battuta. «Non dire che l’avevi detto», fece all’improvviso Artemisia rivolta a Lazzari. «Dovevi insistere di più, cazzo! Convincerci che era tempo sprecato venire fin qui. Devi piantarla di dire sempre sì. Quel beccamorto ci ha fatto perdere un giorno intero». «Speriamo soltanto quello», disse Lazzari. «Speriamo soltanto quello», disse Lazzari. 23 Ritornarono a Formia e parcheggiarono al solito casolare, ma il pomeriggio era troppo inoltrato per pensare di entrare nella tomba. Trascorsero la sera presso le tende che avevano montato nel bosco. Dino compì numerosi giri di perlustrazione, allontanandosi anche per diverse ore. Il Lupo si ritirò presto, mentre Artemisia e Lazzari restarono a lungo a osservare il fuoco in silenzio. «Sei preoccupato?», gli domandò la ragazza prima di andare a dormire. «Come non lo sono mai stato prima d’ora. E non credevo fosse possibile...». Quando, la mattina dopo, si alzò dopo un logorante dormiveglia, Lazzari mormorò una preghiera tremando per l’emozione. Lasciarono il piccolo accampamento non appena iniziò ad albeggiare. L’inutile puntata a Nettuno della mattina precedente aveva reso Dino ancora più nervoso. Non rimaneva traccia del ragazzone amichevole e sicuro Non rimaneva traccia del ragazzone amichevole e sicuro di sé di qualche giorno prima. Scrutava ogni albero come se dietro vi si celasse un nemico. «Non una parola durante la marcia», li ammonì. «Non sappiamo se quelli della Tauros abbiano approfittato della nostra sortita di ieri per riuscire a rintracciarci nuovamente. Potrebbero essere nei paraggi e io voglio sentirli nel caso si avvicinassero. Non sono certo sopravvissuto a Iraq e Somalia per finire in trappola qui». Ciascuno, sebbene per motivi diversi, avvertiva un senso di urgenza. Lazzari, stranamente, pareva l’unico su di giri – se doveva precipitare, meglio precipitare a capofitto. Non appena raggiunsero il luogo indicato, scaricarono l’attrezzatura e tolsero la pietra triangolare piazzata come segnale di riconoscimento. Poi tagliarono i cespugli cresciuti sulla terra con cui il Lupo, dopo averla depredata, aveva ricoperto l’ingresso della tomba. Infine impugnarono le pale. Lavoravano sotto la direzione del Lupo, che aveva esperienza da vendere e, quanto a forza, non aveva nulla da invidiare allo stesso Dino. «Quanto manca?», domandò dopo un’ora Artemisia. Si massaggiava le braccia e rabbrividiva. Il sole non Si massaggiava le braccia e rabbrividiva. Il sole non riusciva a sciogliere l’umidità e le ombre lunghe coprivano ancora la modesta conca dove stavano scavando. «Poco», assicurò il Lupo. Avevano ammassato un discreto cumulo di terra, ma ancora non erano riusciti a raggiungere l’apertura. «Sei sicuro sia qui?», domandò per la seconda volta Dino al Lupo. Teneva a tracola il fucile e dopo ogni spalata gettava una nervosa occhiata al bosco circostante. I versi con cui gli uccelli avevano accolto il primo sole non si udivano più. «Sicurissimo». «Passami quella pala», disse Artemisia a Lazzari. «Ma...». «Forza, voglio scaldarmi». Lazzari uscì dal fosso e le porse la vanga. «Accomodati». Il vento aveva da poco cambiato direzione e ora portava alle loro orecchie il rumore delle macchine che transitavano lungo la provinciale che correva ai piedi della collina. Il pericolo, per quanto vago e imprecisato, parve avvicinarsi di colpo. Dino si rivolse a Lazzari a muso duro: «Mettiti di Dino si rivolse a Lazzari a muso duro: «Mettiti di guardia, porca puttana! Non siamo al cinema». Lazzari, però, non si voltò. I suoi occhi erano fissi sul terreno, mentre lottava per tenere a bada l’ansia. L’aveva sentita montare durante la notte, inarrestabile come una colata di lava. Provò un’incomprensibile paura di morire da un momento all’altro, e di non vedere cosa ci fosse all’interno della tomba. Nella sua mente si rincorrevano malaugurate premonizioni, ma sotto tutti quei pensieri spiacevoli covava la fiammella della speranza. Ala fine cedette, lasciando che l’ansia lo travolgesse, non gli importava più. Fu Artemisia a colpire per prima la pietra con la pala. «Ehi, c’è qualcosa qui!», gridò. Si avvicinarono tutti. L’eccitazione cresceva a mano a mano che la superficie pietrosa si rivelava. Ben presto emerse un tratto di quelo che pareva un blocco di travertino e d’un colpo si trovarono tutti a gridare. «Silenzio!», ordinò Dino. «Che qualcuno vada a tenere d’occhio il sentiero!», aggiunse, ma nessuno ubbidì. Rimossero l’ultimo sottile strato di terriccio scoprendo un semplice quadrilatero di travertino scoprendo un semplice quadrilatero di travertino incastonato nel terreno, al cui centro c’era una lastra di colore più scuro. Lazzari giudicò a dir poco insolita l’assenza di un ingresso alla luce del sole. I romani non dovevano certo temere razzie alle camere mortuarie e non nascondevano quasi mai l’entrata dei sepolcri. Anche quelli sotterranei, per altro rarissimi, disponevano di una costruzione in superficie, in pietra o in muratura, che funzionava da portale e da atrio. Tutto quello non faceva che rafforzare la sua idea iniziale di una tomba sui generis, in linea con la figura di un personaggio di spicco di una confraternita segreta: quale altro romano avrebbe nascosto a quel modo la propria tomba? Senza contare poi il medaglione con inciso il fico ruminale che il Lupo aveva scoperto all’interno dela bara. Là sotto si celava un mistero, si trattava solo di portarlo alla luce. L’agitazione intanto si era sciolta e ora bruciava d’eccitazione. «Forza!», ripeteva saltellando in preda all’euforia. Dino e il Lupo lasciarono le vanghe e si chinarono sulla lastra che fungeva da coperchio. Il Lupo, a suo tempo, aveva rimosso la malta cementizia con cui la tomba era stata sigillata in origine, e ora la pietra era tomba era stata sigillata in origine, e ora la pietra era semplicemente appoggiata sulla struttura in travertino. La afferrarono e dopo aver contato fino a tre la sollevarono. Lazzari si lanciò sul varco. Cinquanta centimetri più in basso intravide una scalinata. Contò una mezza dozzina di scalini intagliati nella pietra. «Ci siamo». «Andate voi, io rimango di guardia», disse Dino. Lazzari, ancora chino sul varco, lo guardò di sbieco. «Della prudenza si possono rimproverare solo i vivi», spiegò Dino. E poi aggiunse: «Pericolo livello otto». Il Lupo scese per primo, seguito da Artemisia e per ultimo da Lazzari che si fece il segno dela croce prima di entrare. Artemisia fu colpita dall’odore di stantio, impenetrabile come una muraglia, e d’istinto fece un passo indietro. «Respira normalmente», le consigliò il Lupo. «Non pensare all’aria viziata. Anzi, non pensare affatto». La stanza era un semplice rettangolo di dieci passi di lunghezza per cinque di larghezza. Al centro c’era un sarcofago di pietra scoperchiato. Le pareti laterali erano irregolari e nude, mentre quella di fronte a loro era uniforme e recava al centro le tracce di un affresco molto rovinato. rovinato. Lazzari sentiva il cuore crescergli nel petto a ogni respiro. Si avvicinò con passi tremanti. Artemisia, invece, si guardava intorno delusa. Nulla lasciava presagire un’imminente scoperta. D’altronde c’era da attenderselo, visto che il Lupo l’aveva già saccheggiata, ma lei aveva sperato confidando in Lazzari, che le era sembrato così convinto... Il Lupo indovinò l’umore della ragazza. «Vi avevo detto che non dovevate aspettarvi chissà cosa. Faccio questo mestiere da una vita. Nessuno può vantare di aver trovato anche un singolo reperto in una tomba dove sono già passato io». «È un affresco, eseguito con ogni probabilità su un intonaco di calce con colori naturali macinati e diluiti con acqua», stava dicendo Lazzari, che alzò la voce all’improvviso. «Fate anche voi luce qui». Qualcosa nel suo tono fece sobbalzare Artemisia, che si avvicinò al compagno. «Hai visto qualcosa?» «Guarda tu stessa», disse indicando il margine inferiore dell’affresco dove, quasi cancellato, faceva capolino un albero di fico che cresceva tra due colline, o seni, all’interno di un circolo delle dimensioni di un piattino: era lo stesso simbolo che avevano visto sul petto piattino: era lo stesso simbolo che avevano visto sul petto di Vento e sul medaglione. Dal centro del piccolo emblema correva una linea scura che saliva verso l’alto tagliando tutto l’affresco sovrastante. «È l’axis mundi», spiegò Lazzari. «E in questo caso parte dalla terra e arriva al cielo, dividendoli entrambi a metà. L’autore dell’affresco ha voluto rimarcare il rapporto tra il simbolo della Confraternita e l’ axis mundi, mettendo in relazione l’umbilicus Urbis con l’umbilicus orbis, il centro della città e quello del mondo. Mi chiedo il perché...». Le deduzioni si rincorrevano nella testa di Lazzari, che provò a ragionare con calma, ma era impossibile. Quela che aveva davanti agli occhi era la prova che la Confraternita esisteva davvero da secoli, forse fin dalle origini dell’Urbe. «Fate più luce», ordinò. Artemisia e il Lupo, però, erano già al suo fianco da diversi secondi, con le torce elettriche puntate verso il muro. «È solo una sorta di mappa per aiutare il defunto a orientarsi nell’aldilà», disse il Lupo scuotendo la testa. Poi indicò l’affresco in diversi punti per spiegare le sue conclusioni. «Quello in basso è il fiume infernale, il Lete, quello in alto quasi certamente una divinità, forse Ade o quello in alto quasi certamente una divinità, forse Ade o magari Orfeo, il divino cantore che doveva guidare gli iniziati nel viaggio verso la ricompensa promessa nell’altra vita. E quell’albero non può che essere il cipresso bianco che vegliava l’ingresso degli Inferi». Lazzari aveva le lacrime agli occhi. «No, amico mio», disse in un sussurro commosso. «Questo non è l’aldilà. È Roma, Roma nel suo primo giorno...». Il Lupo avanzò con uno scatto, quasi che temesse di essere rimasto indietro. «Che stai dicendo?», gli domandò con un tono duro. «L’ho già visto, l’ho già visto... simile», mormorò Lazzari prima di esplodere. «Sì, un affresco simile è presente nella casa di Marco Fabio Secondo a Pompei, nella Villa dei Misteri». Il Lupo stava per ribattere, ma si zittì di colpo. Artemisia si fece ancora più vicina, attratta più di ogni altra cosa dallo sguardo di Lazzari. «Cosa ritrae?» «Questo è il Cermalus, il colle dela fondazione», disse Lazzari. Con la mano a qualche centimetro dal dipinto, pareva accarezzarlo. «E quello non è un cipresso, ma il fico ruminale, lo stesso del simbolo in basso. Anch’esso è posto sull’axis mundi, l’asse centrale della città e del mondo, proprio davanti alla centrale della città e del mondo, proprio davanti alla grotta del Lupercale. È in quel preciso luogo che il pastore Faustolo trovò i gemelli...». «Che significa l’asse centrale del mondo?», domandò Artemisia, quasi con reverenza. «Secondo i romani due linee attraversavano il mondo, intersecandosi proprio a Roma, che era pertanto il centro del mondo. Il punto esatto dell’intersezione rappresentava l’umbilicus orbis, l’ombelico del mondo. Per tutti i popoli antichi il centro del mondo è la casa della divinità». «Ed era indicato dal fico?» «Il fico ruminale cresceva sull’asse, segnandolo, così come l’albero sacro indicava il centro dell’Eden. L’umbilicus Urbis era sulla stessa linea, ma a un centinaio di metri di distanza, sulla cima del Cermalus, dove Romolo scavò la fossa di fondazione». «E quell’uomo in cima al colle chi è?», lo incalzò Artemisia. «È Remo. Lo riconosci dal pedum, il pastorale che spettava di diritto al re del bosco e dei pascoli. Il fuoco che arde poco lontano è quello di Vesta, mentre la lancia conficcata nel terreno ai suoi piedi è probabilmente l’asta di Marte, la stessa che secondo la leggenda suo fratello di Marte, la stessa che secondo la leggenda suo fratello Romolo aveva scagliato proprio sulla vetta del Cermalus prima di salirvi per il rito di fondazione. Un’asta identica fu conservata per secoli dai pontefici nella Regia: si diceva che si scuotesse spontaneamente e risuonasse all’avvicinarsi dei nemici di Roma». «Farebbe comodo pure a noi», provò a scherzare il Lupo, ma nonostante i suoi sforzi era evidente che l’interpretazione di Lazzari lo aveva turbato. Si torturava il mento con le dita nodose e muoveva la testa a scatti. Lazzari non l’aveva nemmeno udito. «È come ho sempre creduto». «Cosa? Che vorresti dire?». Artemisia ormai gli era addosso. Le sue labbra gli solleticavano l’orecchio. «Quello che le fonti hanno cercato di mascherare senza riuscirci completamente. Remo e Romolo, dopo la presa di Alba, concordarono che si sarebbero affidati al volere degli dèi per stabilire a chi di loro due spettasse il diritto di fondare una nuova città. Secondo un’altra versione, fu loro zio Numitore, quello che avevano rimesso sul trono di Alba, a stabilire che si sarebbero dovuti affidare all’avispicium, ossia all’osservazione del volo degli uccelli, per scegliere il futuro fondatore. La sostanza non muta. L’Urbe sarebbe sorta dove erano sostanza non muta. L’Urbe sarebbe sorta dove erano stati salvati dalle acque e nutriti dalla lupa e avrebbe portato il nome del fondatore: anche su ciò erano d’accordo». «Lo sappiamo questo», lo incalzò il Lupo. Lazzari si portò una mano alla bocca. «Sapere non è sufficiente», disse. «Quasi tutte le fonti antiche sono unanimi nel riferire che Remo avvistò per primo un uccello favorevole. Proprio mentre il volatile girava in cerchio sopra di lui, arrivarono messi inviati da Romolo che gli chiedeva di accorrere perché aveva scorto un uccello. In realtà mentiva, e i testimoni lo sapevano. I compagni di Romolo videro però l’uccello volare sul capo di Remo. Quest’ultimo rispose all’appello e accorse dal fratello. Appena fu al suo fianco – raccontano le fonti – apparvero dodici avvoltoi nel cielo. Sacro il numero e sacro il volatile, legato a Giove ed Ercole. E quindi primeggiò Romolo». Artemisia era sbalordita. «Quindi Romolo prevalse con l’inganno». «Infatti. Remo vide per primo il segno divino, perciò aveva già maturato il diritto di conditor, ossia di fondatore. Dionigi di Alicarnasso racconta addirittura che Numitore aveva specificatamente stabilito che il diritto di Numitore aveva specificatamente stabilito che il diritto di fondatore sarebbe spettato a colui che per primo avesse visto un segno favorevole». Lazzari si morse le labbra e riprese subito. Pareva che le sue parole fossero lacci lanciati verso i pensieri che fuggivano via rapidi. «Le fonti, però, per giustificare l’evidente prevaricazione di Romolo, che per giunta aveva mentito, preferiscono attribuire maggiore importanza al numero di uccelli, scelta quantomeno poco credibile in ambito di investitura divina. Ma non si accorgono di un particolare, che si sono dimenticate di eliminare dal racconto che hanno ereditato. I dodici avvoltoi si manifestano in cielo solo all’apparire di Remo. I compagni dei gemelli non potevano fare altro che testimoniare questa concomitanza, e quindi non poteva esserci margine di errore: sia che contasse la priorità, sia che contasse il numero degli uccelli, era a Remo che spettava la fondazione». «Ma Romolo lo uccise», ricordò Artemisia. Lazzari annuì perso nei propri pensieri. «Altri elementi fanno pensare alla predestinazione di Remo: è il primogenito, sfoggia a differenza del fratello il pedum, il bastone del re pastore...». «Non mi stai dicendo nulla di significativamente «Non mi stai dicendo nulla di significativamente nuovo», lo sfidò il Lupo, ostentando ancora una volta un tono secco e disincantato. «Che il diritto spettasse a uno o all’altro, la sostanza non muta: Romolo fonda la città e traccia il limite sacro del pomerium, che non poteva essere oltrepassato armati, pena la morte. Remo lo attraversa con la spada in pugno e suo fratello lo uccide. Questo è quanto». «Sì, sì». La voce di Lazzari rimbombava nela stanza sotterranea. «Proprio così dicono le fonti, mascherando la verità senza però poterla cancellare. Prova a pensarci». Prese per mano Artemisia scuotendola. Era così eccitato che balbettava. «Remo entra armato nel pomerium e per questo Romolo lo uccide, asseriscono le fonti. È una ricostruzione assurda! Se Remo fosse stato davvero armato, sarebbe stato lui a uccidere il fratello, che non poteva che essere disarmato. Infatti, se Romolo fosse stato armato all’interno del pomerium, sarebbe stato lui il sacrilego». Artemisia si mordeva le labbra. «E quindi cosa è accaduto?» «È accaduto esattamente il contrario. Remo, primogenito e favorito dagli dèi, fonda la città, suona la tromba-lituo e le dà il proprio nome. Romolo, pieno di rabbia, entra armato nel pomerium e uccide il gemello. Ecco perché, come narrano gli autori antichi senza spiegarne il motivo, Romolo aveva scagliato l’asta sulla cima del Palatino: che motivo avrebbe avuto se non quello di dichiarare guerra al fratello Remo? Non a caso, il lancio dell’asta in territorio nemico rimarrà nei secoli il rituale romano indispensabile per dichiarare guerra». «Sei sicuro di quello che dici?», lo incalzò Artemisia. Il Lupo, intanto, sembrava confuso. «Certo che se fosse andata così...», si lasciò sfuggire, ma non terminò la frase. «Altri elementi possono confermarlo», riprese Lazzari. «Remo, quand’erano ragazzini, sconfisse il fratello e primeggiò nella corsa dei Luperci e poi, dopo aver sacrificato le capre come prevedeva il rito della festa dei Lupercalia, si cibò degli exta, ossia delle viscere riservate agli dèi. Le fonti parlano di sacrilegio, ma in realtà Remo era figlio di Marte, e quindi gli spettavano di diritto. In questo episodio, all’apparenza ambiguo, si adombra in verità la sua filiazione divina e il suo futuro di fondatore e di divinità». «Ammettiamo che tu abbia visto giusto, ma perché mai le fonti avrebbero dovuto mascherare la verità?», gli domandò il Lupo con la sicurezza di chi sente di aver domandò il Lupo con la sicurezza di chi sente di aver giocato la carta giusta. «Per celare per sempre il vero nome di Roma», rispose Lazzari senza esitazioni. «Da come hai raccontato l’episodio, pare quasi che Remo si sia fatto ammazzare intenzionalmente», mormorò Artemisia e lo guardò come per fissare quel momento per sempre. C’era qualcosa che assomigliava all’orgoglio nei suoi occhi. «Non sei troppo distante dalla verità», le confermò Lazzari. «Perché l’uccisione di Remo diventa anche il sacrificio rituale di fondazione, che era indispensabile nella mentalità arcaica. Per gli antichi, infatti, soltanto la morte poteva far nascere qualcosa: la morte di Remo in cambio della vita della nuova città. Gli scavi archeologici offrono numerosi esempi in tal senso: abbiamo trovato resti di sacrifici umani in molte fosse di fondazione sia etrusche sia latine». Lazzari si zittì solo il tempo necessario a riordinare le idee: «Così abbiamo un nome di facciata, Roma, in omaggio al gemello vittorioso e superstite, e poi il vero nome, quello del fondatore, che rimane segreto, sia per mascherare la terribile vicenda, sia per il motivo che sappiamo, impedire ai nemici di Roma di dominarla sappiamo, impedire ai nemici di Roma di dominarla grazie al potere contenuto nel suo nome». «Che nome?», domandarono quasi insieme il Lupo e Artemisia. «Il nome di Remo». «Il nome di Remo?» «Remoria». 24 L’aria aveva un sapore diverso quando ritornò in superficie. Lazzari si godette quei momenti di intensa gioia. Tutto pareva improvvisamente avere un senso. Dino dovette ripetergli due volte la domanda. «Man, ma dov’è il lituo?» «Il lituo», ripeté Lazzari, come se cercasse di tradurre un vocabolo straniero di cui aveva dimenticato il significato. «Il bastone di Romolo», ruggì Dino agitando il fucile. La sua era l’agitazione del toro angustiato dalle banderillas, una rabbia pericolosa e magmatica: Lazzari non ne era la causa, ma rischiava di divenirne l’oggetto. Il Lupo si spostò di qualche metro, l’espressione sorniona del ragazzino che sta per gustarsi la scazzottata tra due compagni. Lazzari tornò in sé di colpo. Il lituo, certo. Era quello che volevano, fin dal primo momento. Il mistero sul nome segreto di Roma era soltanto un’esca per convincerlo ad accettare l’incarico. “Il sogno della sua vita”, così lo accettare l’incarico. “Il sogno della sua vita”, così lo aveva definito il Colonnello. Come aveva potuto lasciarsi ingannare? Il Colonnello lo aveva adescato facendo leva sul suo orgoglio. Maledetto orgoglio: ecco il nome proprio del peccato originale. I signori della Fondazione volevano il bastone. Era il bastone a valere per loro. Nient’altro. Fu così che si decise una volta per tutte. E lo fece con il trasporto di chi decide di correre un rischio, sperando in una svolta. «Molto presto lo avremo tra le mani», garantì nascondendo il fastidio e l’amarezza in una smorfia di risolutezza, che così poco gli si addiceva. A ogni passo si allontanava da se stesso, ma che importanza aveva ormai? «Non c’è nessun bastone là sotto», ripeté per l’ennesima volta il Lupo, rivolgendosi a tutti indistintamente, sebbene fosse il solo Lazzari a insistere sulla presenza del lituo nella tomba. «Avete problemi di udito, forse? Ho spostato l’arca, niente. Ho preso a martellate le pareti, niente. Ho sondato il pavimento, niente. Nessuna nicchia, o doppio fondo o corridoio nascosto. Mi credete forse uno sprovveduto?», domandò dopo aver contato sule dita ogni azione. Poi domandò dopo aver contato sule dita ogni azione. Poi aggiunse con più calma: «Io sono uno che pensa positivo per natura, credo che lo abbiate capito, e non mi spaventano né gli ostacoli né i muri, ma so distinguere un vicolo cieco quando ne vedo uno». «L’affresco», gli disse Lazzari. Teneva lo sguardo su di lui, ma pareva fissare qualcosa alle sue spalle, tanto che il Lupo fu tentato di voltarsi a guardare. «Che c’entra l’affresco?» «L’affresco non ti ha permesso di vedere oltre». «Che vorresti dire?» «Non hai sondato la porzione di parete dietro l’affresco». «Si capisce. Non volevo danneggiarlo», si difese il Lupo come se non ci fosse nemmeno bisogno di spiegare. Lazzari, toccando il muro affrescato, si era accorto che era di laterizi a differenza degli altri che formavano la camera mortuaria sotterranea. Inoltre non gli erano sfuggiti nemmeno i segni di piccone sulle pareti laterali in pietra, come se gli operai dell’epoca avessero cominciato a rompere per poi bloccare di colpo il lavoro: il progetto originario della tomba doveva prevedere almeno un paio di camere secondarie, ma per qualche motivo che poteva di camere secondarie, ma per qualche motivo che poteva solo supporre non se ne era fatto nulla. Con ogni probabilità l’idea iniziale era quella di un ciclo completo di affreschi, corredato magari da una serie di fregi, ma poi, evidentemente, i costruttori avevano dovuto rinunciare. Il tempo doveva essere finito all’improvviso e perciò si erano limitati a quell’unico affresco: preparare la pietra grezza per l’intonaco sarebbe stato molto più lungo e difficoltoso che non tirare su un semplice muro di mattoni, su cui stendere molto più agevolmente la calce. E così avevano fatto. «Secondo me il muro nasconde una cavità. Se il lituo c’è, è là dietro», disse Lazzari. «Come fai a esserne certo?», domandò Dino. Lo afferrò per le spalle, squadrandolo dall’alto al basso. Si vedeva che voleva credergli, ne aveva anzi un disperato bisogno. «Non mi avete ingaggiato per questo?», si sfogò Lazzari liberandosi dalla sua presa. Decise che era il momento di dare voce a tutti i ragionamenti che si erano venuti formando nela sua mente, e vedere se le parole avrebbero retto la prova: «Del lituo non si hanno più notizie a partire dalla metà del primo secolo dell’era precristiana: l’ultimo testimone oculare a scriverne è precristiana: l’ultimo testimone oculare a scriverne è Cicerone, fatto decapitare nel quarantatré avanti Cristo da Marco Antonio proprio a pochi chilometri da qui. Mi seguite?». Dopo che ebbero annuito, riprese: «Ora, la tomba che abbiamo sotto i piedi è doppiamente contrassegnata dal famigerato simbolo che conosciamo tutti bene, quello tatuato sul petto di Vento, il fico ruminale tra due colline: uno dei due emblemi è presente sul bordo inferiore dell’affresco e l’altro sul medaglione trovato a suo tempo dal Lupo nella bara, e poi venduto a Parodi. Da questi due indizi possiamo affermare che con ogni probabilità qui è stato sepolto un importante membro della Confraternita che custodiva il segreto delle origini. E non è finita: sappiamo che era un senatore grazie all’anello d’oro che portava al dito e sappiamo inoltre che è morto verso la metà del primo secolo circa, come testimoniano le analisi fatte fare dal Lupo sui reperti ritrovati all’interno». «E quindi?», fece Dino facendogli cenno di stringere. «Il lituo sparisce da Roma in concomitanza con la costruzione di questa tomba. Io non credo si tratti di una semplice coincidenza. Roma stava andando a fuoco in quegli anni. Cadeva un mondo: guerre civili, crisi della Repubblica, dittatori, fazioni e bande armate. Il lituo Repubblica, dittatori, fazioni e bande armate. Il lituo andava preservato a ogni costo». Lazzari si accovacciò e con l’indice disegnò sopra la morbida terra rivoltata il simbolo della Confraternita. «Inoltre, soltanto pochi anni prima Valerio Sorano aveva divulgato l’esistenza del segreto sul nome di Roma nell’Epoptidon: certo, il libro era stato bruciato e l’autore ucciso, ma era chiaro a tutti che il nome vero dell’Urbe era in pericolo. La situazione non era mai stata tanto grave. I membri della Confraternita dovettero decidere, seppure a malincuore, che per salvare la città era necessario mettere in sicurezza e nascondere per sempre i pegni che garantivano il patto tra la città e gli dèi: il suo vero nome e il bastone celeste con cui fu fondata». Si alzò e si pulì le mani sui pantaloni. «In questa tomba non solo è adombrato il nome arcano dell’Urbe, ma è anche nascosto il lituo». «Allora sfondiamo il muro», propose Dino. Lazzari scosse la testa. «Abbiamo bisogno di una macchina per tagliare i laterizi senza rovinare l’affresco». Quindi per dare peso a quelle parole, aggiunse: «Ha un enorme valore». «Posso procurarmi quella macchina», gli venne in aiuto il Lupo. aiuto il Lupo. «Non dicevi che non c’era niente là sotto?», gli ricordò Dino a muso duro. L’ex soldato pareva disorientato tanto dal convincimento granitico di Lazzari, quanto dal cambio di opinione del Lupo. «Sicurissimo, lo dicevo, ma io sono un tipo che sa ascoltare, e il nostro professore mi ha incuriosito e, non so se ve l’ho già detto, la curiosità è la mia forza e insieme il mio limite maggiore. Non sono capace di resistervi. E poi, a questo punto, dare un’occhiata non ci costa nulla. Se volete, in mezza giornata posso recuperare lo strumento che ci occorre per asportare la porzione di muro». «Io verrò con te», disse Lazzari. Senza che il Lupo se ne accorgesse, ammiccò a Dino che, dopo una breve riflessione, gli fece cenno di andare. Artemisia, insolitamente, non aveva detto nulla. Lazzari temeva che si mettesse di traverso, invece la ragazza si limitava a studiarlo con un’espressione indefinita, gli occhi di giada che parevano annidarsi nella penombra come quelli di una statua orientale nascosta nella vegeta zione. «Noi terremo d’occhio la tomba. E spero nell’arrivo al più presto dei rinforzi», disse Dino. al più presto dei rinforzi», disse Dino. «Saremo qui domani all’alba», promise il Lupo. Artemisia accompagnò Lazzari fino al vecchio casolare dove avevano lasciato l’auto. Il Lupo camminava una ventina di passi davanti a loro e non si voltava mai. La luce del sole pomeridiano scontornava gli alberi. I fiori tracciavano scie di profumi nel sottobosco. Pareva impossibile, in un pomeriggio come quello, che qualcuno preparasse un agguato. Eppure Lazzari sapeva che gli uomini della Tauros non dovevano essere lontani. Soltanto quando arrivarono nel cortile, la ragazza trovò l’ispirazione per parlare. «Perché ho l’impressione che mi stai nascondendo qualcosa?». Lazzari era troppo agitato per assaporare la meraviglia che quelle parole gli suscitarono. Parlandole, aveva spesso l’impressione di scoprire cose su se stesso, ma quella frase fu un autentico shock. Fu come apprendere che l’isola, dopotutto, non era affatto deserta e che l’indigena parlava addirittura la sua lingua. Solo che lui era già salito sulla barca e si stava allontanando... Da quale parte stava lei? Forse si era sempre sbagliato. Continuò a guardare davanti a sé, sforzandosi sbagliato. Continuò a guardare davanti a sé, sforzandosi di impiegare un tono neutro, temendo che Artemisia potesse indovinare i suoi pensieri. «Sì, ci sono cose che non ti ho detto», ammise. «Se la mia interpretazione dell’affresco fosse vera...». «Cosa significherebbe?», lo pressò Artemisia. «Lasciami ancora questa notte per rifletterci. Domani saprai», prese tempo Lazzari. Il Lupo salì sul fuoristrada dal lato del passeggero e richiuse la portiera. I loro passi crepitavano sulla ghiaia nel rinnovato silenzio mentre si avvicinavano. Lazzari aveva già la mano sulla maniglia quando Artemisia lo prese per il gomito e lo fece voltare: «Dimmi almeno una cosa, però. Perché il lituo non era insieme al medaglione, dentro il sarcofago? Perché il senatore o quelli che lo hanno seppellito avrebbero dovuto nasconderlo in una nicchia? Ammesso davvero che esista come sostieni tu». «Per ragioni di sicurezza», mentì Lazzari, pregando che la ragazza prendesse per buone le sue argomentazioni. «Nel caso la tomba fosse stata scoperta e depredata, come infatti è avvenuto, anche se molti secoli dopo. E lo stratagemma ha funzionato, se è vero che il Lupo non l’ha trovato». che il Lupo non l’ha trovato». «Allora perché non nascondere anche il medaglione nella nicchia?» «Il medaglione, per quanto importante, era un semplice simbolo, e apparteneva all’uomo, mentre il lituo era un oggetto divino, e apparteneva alla città. Era il lituo che andava salvato a ogni costo». Artemisia non era ancora convinta. «Davvero intendi scavare dietro l’affresco? E se dovesse rovinarsi? Sbriciolarsi? In un colpo solo cancelleresti tutte le possibili prove alla base della tua teoria sul vero nome di Roma. Mi chiedo se sai quello che stai facendo». «Conosco a memoria un paio di versi», rispose evasivamente Lazzari dopo un passaggio a vuoto di quasi trenta secondi. «“Per arrivare a ciò che non sai, devi passare per dove non sai”». «Sono del tuo amico Antonio da Alba Docilia?» «No, ma gli sarebbero piaciuti». Gli occhi di Artemisia non si indurirono. Fin da quando erano usciti dalla tomba sembrava osservare Lazzari in modo nuovo, come se si fosse accorta di un particolare che prima le era sfuggito e che ora faceva pendere in modo diverso la bilancia. «Piacciono anche a me». me». Lazzari non sapeva dove guardare. «Questo significa che...». «...Mi fido di te. Fides, ricordi quello che diceva il Maestro Foglia? Io ho fiducia in te». Lazzari si sentì mancare il fiato. Annuì a occhi bassi, aprì la portiera e salì. Per lui, in quel momento, non poteva esserci notizia peggiore. «Tornerò appena possibile», disse chiudendosi all’interno. Artemisia sollevò l’angolo sinistro della bocca e attraverso il finestrino disse: «Un po’ prima sarebbe meglio». Lazzari ingranò la prima e partì. E mentre vedeva la ragazza che spariva nello specchietto retrovisore, provò dentro di sé una sensazione strana, come se avesse scritto una canzone meravigliosa e l’avesse perduta, conscio di non poterla più ritrovare. 25 «Finché non ti abitui, tutti i nomi sono strani», disse Lazzari il mattino dopo. «Remoria», ripeté per l’ennesima volta il Lupo. Masticava la parola tra i denti, come se fosse un frutto esotico e non sapesse se fosse velenoso o meno. «Non suona affatto bene alle mie orecchie». Avevano appena parcheggiato la Land Rover nel cortile interno del casolare abbandonato e stavano scaricando il materiale che si erano procurati nella notte. Avevano dormito appena due ore in auto e ora Lazzari si sentiva tutto dolorante, ma non gliene importava. L’aquila saltella faticosamente per raggiungere una rocca, ma da lì si lancia verso le stelle. E lui era vicino al grande salto. «Solo perché non l’avevi mai sentito pronunciare. Remoria deriva da Remo, come Roma deriva da Romolo. Era il nome che, secondo alcune fonti antiche, Remo avrebbe voluto dare alla città nel caso fosse stato lui il prescelto per fondarla». «Cosa che secondo te è effettivamente successa», gli «Cosa che secondo te è effettivamente successa», gli ricordò il Lupo. «Infatti», confermò Lazzari. «Come ti ho già spiegato, nella leggenda originaria, sotto le incrostazioni posteriori, i fraintendimenti e le mistificazioni, è contenuta in nuce la verità». Alle loro spalle comparve Dino, il volto scavato e scuro per le occhiaie. Non doveva aver chiuso occhio nemmeno quella notte. Agitava nervosamente il fucile per invitarli a muoversi. «Ce ne avete messo di tempo». «Nemmeno un minuto più del necessario», disse il Lupo. «Tienile per te le tue pillole di saggezza o te la faccio ingoiare», lo minacciò Dino squadrandolo con fare minaccioso. Lazzari si mise in mezzo. «Calmi per favore». E poi, in tono conciliante, come se avesse indovinato le segrete aspirazioni di ciascuno di loro: «Coraggio, poche ore e poi ciascuno per la propria strada». Dino annuì. «Allora, muoviamoci!». Si erano procurati anche una carriola, su cui avevano sistemato gli attrezzi e la macchina con il filo d’acciaio per tagliare i laterizi. «Dov’è Artemisia?», domandò Lazzari. «Dov’è Artemisia?», domandò Lazzari. «È di guardia alla tomba», rispose Dino. «Non avresti dovuto lasciarla sola». «Quello è il punto più sicuro della zona, man. Sono le vie d’accesso come questa che vanno pattugliate: è da qui che può arrivare il pericolo. E comunque potrai spiegarmi il mio mestiere anche camminando. Muoviamoci, forza!». Il Lupo si avviò per primo spingendo la carriola. Quando raggiunsero il limitare del bosco, Dino si affiancò a Lazzari e lo trattenne un paio di passi indietro. «C’è stato movimento stanotte tra gli alberi intorno al nostro accampamento», gli sussurrò, prima di infilargli una pistola nella cintura. «Spero non sia necessaria». «Ma i rinforzi promessi dal Colonnello?» «In ritardo. Però dovrebbero essere qui entro un paio di ore al massimo». Dino aveva ordinato ad Artemisia di appostarsi dietro il muretto che avevano eretto con la terra rimossa dall’imbocco della tomba, ma quando arrivarono lei se ne stava seduta su un masso al centro della radura. Dino mormorò un’imprecazione. Non appena il Lupo vide la pistola nelle mani della ragazza si irrigidì. «Che significa?» ragazza si irrigidì. «Che significa?» «Semplici precauzioni», provò a tranquillizzarlo Dino. Il Lupo scuoteva la testa. «Scusate tanto, ma forse non ci siamo capiti. Mi avevate garantito che non avremmo avuto problemi». «E non li avremo». «Non mi piace», insistette il Lupo. «Con quello che ti abbiamo pagato, abbiamo comprato anche i tuoi gusti. Perciò smetti di lamentarti e aiutami a calare la macchina dentro la tomba», gli ordinò Dino a muso duro. Il Lupo sostenne il suo sguardo in silenzio, infine si sfilò il gilet, lo appese al ramo basso di un albero e si chinò sulla macchina tagliatrice. Dopo averla collegata al generatore, lui e Dino la trasportarono nel sepolcro sotterraneo. Lazzari e Artemisia si guardarono in silenzio. C’era troppo da dire e troppo poco tempo per farlo. Non appena i due uomini ebbero piazzato il macchinario accanto al muro affrescato, il Lupo urlò per farsi sentire in superficie: «Ok, mettilo in moto». Lazzari azionò il generatore e scese a sua volta seguito da Artemisia. Mentre Dino e il Lupo manovravano lo strumento, la Mentre Dino e il Lupo manovravano lo strumento, la ragazza faceva loro luce con due torce e Lazzari li guidava a voce. La lama penetrò nel laterizio emettendo scintille. Un odore di metallo surriscaldato si liberò nell’aria stantia. Lazzari pregava e intanto sudava. Più i sintomi dell’ansia crescevano, e più pregava intensamente. Il laterizio era più friabile di quanto avessero immaginato. La lama viaggiava veloce e i calcinacci piovevano copiosi saturando l’atmosfera di pulviscolo. Ma ben presto avvertirono la resistenza interrompersi di colpo e poi un rintocco secco. «Fermi!», gridò Artemisia. «C’è davvero un interstizio tra il muro e la pietra!», esclamò Dino spostando la lama. Lazzari sentì gli occhi diventare umidi. Ringraziò il cielo e domandò perdono. Non sapeva nemmeno lui che sentimento provare, tanto era sollevato e insieme preoccupato. I secondi successivi sarebbero stati decisivi. Quando la sezione del muro fu tagliata del tutto, il Lupo e Dino fecero leva per estrarla e poi posarla a terra. «Fagli luce», disse Lazzari ad Artemisia. «Che lo sistemino in modo che non cada, è prezioso e sistemino in modo che non cada, è prezioso e importante». Appena la ragazza si voltò verso gli altri due con le torce elettriche, Lazzari si affrettò a chinarsi e a infilare per primo il braccio nell’apertura che si era venuta a creare, una sorta di finestra lunga almeno un metro. Tra la parte ancora in piedi della parete in mattoni e il muro di pietra c’era un’intercapedine di circa un palmo. «Non trovo nulla. Prova tu», disse a un certo punto ad Artemisia, lasciandole il posto. La ragazza si accucciò e attaccò a frugare nella fenditura, schiacciando la guancia contro la pietra. «Riesco a toccare qualcosa!», urlò a un certo punto. «Cosa?», domandò Dino abbassandosi al suo fianco. Il Lupo e Lazzari rimasero in piedi alle loro spalle e si scambiarono un silenzioso cenno di intesa. «Eccolo! Preso!», urlò la ragazza. La aiutarono ad alzarsi e poi a togliersi la polvere di dosso, ma lei li allontanò bruscamente. Stringeva tra le mani un cofanetto lungo una trentina di centimetri e largo non più di cinque. «Forza, aprilo!», la incalzò Dino agitando la torcia. La ragazza guardò Lazzari con aria interrogativa. Infine annuì con solennità: «Aprilo tu. È giusto così». Infine annuì con solennità: «Aprilo tu. È giusto così». Lazzari non se lo fece ripetere due volte, prese il cofanetto, lo ripulì dalla polvere e, dopo un profondo respiro, sollevò lentamente il coperchio. Artemisia gli toccò la mano all’improvviso, facendolo fermare. «Tu dici che...». Lazzari provò a rispondere, ma aveva il cuore in gola. Senza allontanare le dita della ragazza, scoperchiò il piccolo scrigno. Dino e il Lupo mossero per la frenesia le mani con cui reggevano le torce e per un attimo l’oggetto svanì nel’ombra. Quando le luci tornarono a posarsi sul cofanetto aperto, videro una bacchetta di legno simile a un flauto di canna, eccetto per l’estremità ricurva e la punta a forma di corolla. «Dio!», mormorò il Lupo. «Il sacro lituo». «Ce l’hai fatta!», disse Artemisia a Lazzari. Aveva le lacrime agli occhi e tremava. «Ce l’hai fatta», ripeté abbracciandolo. Lazzari aprì la bocca, ma non ne uscì alcun suono. Poi, come se si fosse ricordato di qualcosa di importante, diede il lituo alla ragazza, ma si tenne il cofanetto, infilandolo sotto la felpa. «Ce l’hai fatta! Ce l’hai fatta!», non faceva che ripetere Artemisia, il cui entusiasmo finì per contagiare ripetere Artemisia, il cui entusiasmo finì per contagiare anche gli altri. Dino fu il primo a tornare serio. «Andiamo via da qui, avremo tempo di festeggiare più tardi», li sollecitò avviandosi verso le scale. «Ben trovati signori», li gelò Prati. Lui e Fazio erano appostati in attesa fuori dalla tomba con i fucili spianati. Dino si voltò di scatto: altri due uomini armati presidiavano il lato opposto della radura. Nessuna via di fuga. Il rumore del generatore doveva aver coperto il loro arrivo. Si era fatto sorprendere come l’ultimo dei principianti. Se solo i rinforzi fossero giunti in tempo... Si sforzò di analizzare la situazione. Non era la prima volta che gli capitava una cosa simile. Tentare un’azione di forza era impossibile. Ed era troppo tardi per barricarsi nella tomba e aspettare l’arrivo degli uomini del Colonnello: quelli della Tauros li tenevano sotto mira. Se solo avesse tentato la mossa, almeno due di loro ci avrebbero lasciato la pelle, e lui non poteva permetterselo. Imprecò a bassa voce. «Gettate le armi e non fate sciocchezze. Siamo tutti professionisti», disse Fazio quasi leggendo le sue professionisti», disse Fazio quasi leggendo le sue intenzioni. Dino digrignò i denti e lasciò cadere il fucile. Lazzari lo imitò immediatamente gettando via la pistola. «Anche la ragazza», gridò una voce alle loro spalle. Dovevano aver visto il calcio dell’automatica spuntarle dai pantaloni. Artemisia, però, pareva indecisa. Si mordeva le labbra e la sua espressione ostinata non lasciava presagire nulla di buono. «Fai come dicono», le sussurrò Lazzari. «Bastardi!», sibilò Artemisia prima di lasciar scivolare la pistola ai propri piedi. Prati fece un cenno agli altri due agenti che si affrettarono a raccogliere le armi. Solo dopo che furono tornati ai loro posti, senza smettere mai di tenerli sotto tiro, Fazio si avvicinò all’imbocco della tomba. Teneva il fucile fisso su Dino e non lo perdeva d’occhio. Prese dalle mani di Artemisia il lituo annuendo un paio di volte, quasi a complimentarsi per la scelta di non avere azzardato mosse rischiose, e poi accennò a Lazzari con un movimento del mento. «Ottimo lavoro, professore. È riuscito in un’impresa ritenuta impossibile da tutti gli esperti. Dobbiamo ammettere che il Colonnello sa esperti. Dobbiamo ammettere che il Colonnello sa scegliere con cura i propri uomini». «Figli di puttana», mormorò Artemisia. «Ve l’avevamo detto a Sarzana di accettare la nostra generosa offerta... A quest’ora il lituo sarebbe stato comunque nelle nostre mani, ma nelle vostre tasche ci sarebbero duecentomila euro», disse Fazio offrendole un sorriso algido. Quindi si rivolse a Dino scandendo le parole: «Siamo quattro e armati. Altri due colleghi ci aspettano in macchina all’altezza del bivio per la regionale. Il lituo giungerà a destinazione entro tre ore al massimo, dopodiché sparirà. Noi faremo lo stesso. Sai bene che la partita si chiude qui». Dino sputò per terra e assentì. Prati aspettò che il compagno lo raggiungesse e poi disse: «Addio signori, senza rancore». Appena si furono allontanati, Artemisia afferrò per il braccio Lazzari. «Dài Lazzari, muoviamoci! Dobbiamo inseguirli!». «Impossibile, ora», si intromise Dino e diede un calcio al generatore, che si rovesciò sul fianco spegnendosi in un ultimo rantolo. Una pozza di benzina si allargò sul terreno. «Perché?», lo incalzò Artemisia. «Perché?», lo incalzò Artemisia. «Sono armati e noi no, e poi avranno di certo manomesso la nostra auto. Dobbiamo sentire il Colonnello e concordare il da farsi». «Dobbiamo recuperare il lituo a tutti i costi!», gridò Artemisia. Sotto i capelli scarmigliati, aveva il volto paonazzo e le vene del collo turgide. Dino si tolse il cappello e lo appallottolò. «Se gli ordini saranno questi, li inseguirò anche in capo al mondo. Ma spetta al Colonnello decidere». «Al Colonnello non spetta più niente! Sono io a decidere, lo sai bene. Inseguiamo quei maledetti figli di puttana», urlò Artemisia lanciandosi contro il barbuto. Lo fronteggiava a pochi centimetri di distanza e pareva sfidarlo ad alzare le mani. Era senza dubbio pronta allo scontro fisico, le braccia tese all’indietro e i pugni serrati. Fu allora che il Lupo si lasciò scappare un sogghigno. Artemisia e Dino si voltarono e lo fissarono stralunati. Lazzari non riuscì a contenersi e, seppure lentamente, attaccò a ridere. «Diglielo, prima che si ammazzino», gli suggerì il Lupo. Si era accucciato sui talloni e, con il naso stretto tra pollice e indice, scuoteva la testa senza smettere di tra pollice e indice, scuoteva la testa senza smettere di ghignare. «Dirmi cosa?», domandò Artemisia girandosi verso Lazzari. Lazzari si infilò le mani in tasca, chinò la testa e le lanciò uno sguardo indecifrabile dal basso verso l’alto. «Quello che hanno preso è una copia del lituo», rivelò infine. «Una copia? Che cosa stai dicendo?», fece Dino. «Una copia di ottima fattura, che io e il Lupo abbiamo fatto intagliare da un artigiano stanotte. Per fortuna abbiamo trovato un maestro intagliatore», spiegò Lazzari. «Ma era dietro il muro!», replicò Artemisia. «Perché ce l’ho messa io», rivelò Lazzari. Artemisia e Dino iniziarono a parlare simultaneamente, e le loro parole finirono per coprirsi a vicenda. Lazzari ne approfittò per continuare: «Il legno utilizzato per la copia è quello della bara che era contenuta nel sarcofago presente all’interno della tomba, che come sapete è del primo secolo avanti Cristo. Per risolvere il problema della datazione, abbiamo aggiunto frammenti lignei più antichi di parecchi secoli, che frammenti lignei più antichi di parecchi secoli, che abbiamo ricavato da altri reperti archeologici di scarso valore custoditi dal collaboratore del Lupo. Gli esami a cui i committenti della Tauros sottoporranno il manufatto lo dateranno inizialmente al primo secolo avanti Cristo; poi rifaranno i test in maniera più approfondita e concluderanno che l’oggetto fu in qualche modo restaurato nel primo secolo avanti Cristo, ma che in realtà è almeno di sei o settecento anni più antico: il lituo di Romolo». «Sei sicuro che crederanno alla balla del restauro?», gli domandò Dino. «Il primo secolo avanti Cristo, come sanno tutti gli archeologi, fu un’epoca in cui c’era un vivissimo interesse per gli oggetti delle origini, e un restauro del lituo in quel periodo è perfettamente plausibile: esistevano tecniche specifiche a riguardo, per quanto rudimentali. La forma, d’altronde, è perfettamente ricalcata su quella originale. Il resto lo farà la loro voglia di crederci. Il loro compratore, chiunque sia, si riterrà soddisfatto». «E come...», stava dicendo Artemisia. Lazzari la interruppe subito. «Immaginavo che ci fosse una piccola intercapedine tra il muro e la pietra. È impossibile erigere un muro di mattoni perfettamente impossibile erigere un muro di mattoni perfettamente aderente a una parete di roccia, che è per sua natura ondulata. “Deve per forza esserci un interstizio tra il muro e la parete”, mi sono detto. E per fortuna c’era davvero. Così, quando vi siete voltati per posare la sezione del muro, mi sono accucciato e ho infilato all’interno della fenditura la copia del lituo, che tenevo nascosta sotto la felpa». Sfilò da sotto la maglia il cofanetto e lo gettò ai loro piedi. «Questo è un volgare manufatto contemporaneo: l’ho tenuto perché altrimenti avrebbero capito l’inganno». «Eri d’accordo con lui», disse Dino al Lupo. «Mi ha aiutato», ammise Lazzari. «Non ti fidavi di noi! Pensavi che uno di noi facesse il doppio gioco e lavorasse per la Tauros! Hai dubitato di me. Tu hai dubitato di me!». Artemisia scuoteva rabbiosamente la testa. Lazzari era certo che lo avrebbe colpito, ma si sforzò di mantenere un tono neutro. Aveva bisogno di tempo. «Gli agenti della Tauros ci sono sempre stati dietro. Nessun dossier al mondo avrebbe permesso loro di sapere quello che sapevano, nessun fascicolo per quanto minuzioso gli avrebbe consentito di non perdere mai le nostre tracce o addirittura di precederci. “Qualcuno li informa”, mi sono detto a un certo punto, ormai convinto che uno di voi due fosse sul loro libro paga. Poi, grazie a Dino, ho compreso il mio errore». Senza lasciar loro il tempo di fare domande, indicò il barbuto. «Quando Dino al casolare dell’americano parlò della possibilità di una microspia posizionata nella nostra auto, capii che era grazie a quello stratagemma che gli agenti della Tauros riuscivano a starci sempre attaccati. A quel punto, però, avevo già ideato il mio piano ed ero deciso a non condividerlo: temevo che mi avreste fatto desistere. E poi significava ammettere che avevo dubitato di voi». «Lo hai ammesso ora», puntualizzò Dino. «A missione compiuta. A uno che ha vinto si perdona più facilmente, giusto?» «E cosa hai vinto? Dimmelo!», alzò la voce Artemisia. «Ci siamo sbarazzati della Tauros, e stavolta per sempre», rispose Lazzari, cercando di dimostrarsi padrone della situazione. «Ho scommesso sul fatto che, dopo l’incidente di Sarzana e l’intervento di Dino, i loro agenti avrebbero saggiamente cambiato tattica: starci addosso senza farsi vedere e senza intervenire fino a quando non avessimo trovato il lituo, e quindi tenderci quando non avessimo trovato il lituo, e quindi tenderci una trappola e portarcelo via. E mi è andata bene, perché così è accaduto». Dino era dubbioso e si tormentava la barba. «Non capisco, man. Prima non ti fidi e ci tieni all’oscuro dei tuoi piani, ora invece vuoti il sacco. Se uno di noi due lavorasse davvero per la Tauros li avviserebbe e quelli tornerebbero indietro subito. Perché adesso ti confidi?». Lazzari capì di camminare sulla lama di un rasoio. Una parola sbagliata, e tutto il suo piano sarebbe crollato. «Ho già ammesso di aver sbagliato a dubitare di voi. Ma davvero potete farmene una colpa? Pensateci. Io non so nulla di voi due se non le poche cose che mi avete raccontato, per altro tutte da verificare: inoltre mi avete prelevato con la forza, ricattato, mentito a più riprese, ignorato nelle decisioni, portato in giro come un cane da tartufi...». «Sì, sì, va bene. Lascia stare la litania», disse Artemisia, che si era inaspettatamente calmata. Dino, invece, dopo l’iniziale smarrimento si stava agitando. Qualcosa nel mutamento repentino della ragazza lo aveva colpito: forse lei aveva intuito un particolare che a lui invece continuava a sfuggire. Raccolse il berretto che aveva scagliato a terra e provò a Raccolse il berretto che aveva scagliato a terra e provò a ripulirlo con le mani. «Che succede? Ho l’impressione che qualcosa mi stia sfuggendo...». «Sveglia soldato», lo apostrofò Artemisia. «Il nostro professore, qui, ci nasconde ancora qualcosa. Ha un asso nella manica. Ormai lo conosco abbastanza. E posso anche indovinare». Si girò di colpo verso Lazzari, gli occhi ridotti a due fessure: «Tu sai come mettere le mani sul vero lituo o sbaglio? Lo hai sempre saputo, vero?» «Vero e falso». Lazzari si strinse nelle spalle. Una stretta di spalle lenta, lunga, piena di complicità e di allusioni, che esprimeva falsa disinvoltura, ma anche una riserva di conoscenze superiori. «È vero che so come metterci le mani sopra. Ma è falso che l’abbia sempre saputo». «Man, basta parole», lo minacciò Dino. «Ma non è per questo che siamo qui? Per una parola?». 26 Lazzari aveva sempre temuto il momento in cui il suo saggio sarebbe stato pubblicato. Aveva avuto paura dall’istante stesso in cui aveva deciso di metterci mano. Avrebbe dovuto scrivere centinaia di pagine per sostenere e spiegare un concetto che in realtà si sarebbe potuto riassumere in una frase, forse in una parola soltanto, in un semplice nome. Sarebbe stata la cosa giusta da fare, scrivere un’unica frase, ma nessuno glielo avrebbe perdonato. Lo avrebbero accusato, probabilmente a ragione, di eccentricità e ignoranza. Quando se ne era definitivamente reso conto, gli era bastato un attimo per decidere di abbandonare il progetto a cui aveva dedicato gli ultimi sedici anni della sua vita. Ora, però, aveva l’occasione di sottoporre la sua intuizione alla prova dei fatti. Una parola, una parola soltanto, e si sarebbe salvato. Ne era sempre più convinto, mentre cercava di eludere gli sguardi colmi di rimprovero dei compagni. gli sguardi colmi di rimprovero dei compagni. Erano tornati al piccolo campo tendato a ritirare le loro cose, e poi si erano trascinati in un silenzio sempre più nervoso fino al casolare dove avevano parcheggiato il fuoristrada. Nell’unico tratto superstite del tetto, le tegole brilavano rosse sotto il sole. Gli spazi scuri tra i pilastri del fienile sembravano lavagne in attesa di qualcuno che scrivesse un messaggio. Dino, dopo una breve ispezione al cofano, salì sulla Land Rover che si mise in moto al primo colpo, a differenza di quanto aveva previsto. Questo parve preoccuparlo più che sollevarlo. «Qui c’è qualcosa che non torna», disse ad Artemisia. «Che cosa vorresti dire?» «Quelli della Tauros non hanno manomesso la nostra macchina». «Come è possibile?» «Non lo so. Non so spiegarmi nemmeno perché non ci abbiano requisito i cellulari. Sono errori troppo grossi per professionisti di quel calibro. Oppure...». «Oppure?» «Oppure erano sicuri che non li avremmo inseguiti». «Ma è assurdo!». «Ma è assurdo!». «Sto provando a chiamare il Colonnello da un pezzo, ma non risponde». «Riprova finché non lo trovi», disse Artemisia e poi si rivolse a Lazzari. «Ora è il momento della verità. Voglio sapere tutto quello che non ci hai ancora detto». «Non dovrebbe essere sempre il momento della verità?» «Lazzari, per favore». Artemisia aveva abbandonato ogni traccia di veemenza. Appariva stanca e sfiduciata; negli occhi le rimaneva solo un’ombra della risolutezza e del trasporto che l’avevano infiammata per tutta la mattinata. «D’accordo, inutile rinviare ulteriormente», acconsentì Lazzari cercando di riordinare le idee. «Ma non so proprio da dove partire... Vi posso dire che, in un certo senso, è successo a me quello che è accaduto a Roma». Dino tirò fuori da sotto il sedile un’automatica e la caricò. «Man, prendi la via più breve per arrivare al punto». Anziché lasciarsi turbare, Lazzari si sentì quasi spronato da quella minaccia. Ormai si rendeva conto di essere tra coloro che dovevano essere messi alle strette essere tra coloro che dovevano essere messi alle strette per reagire. Per tutta la vita aveva cercato la tranquillità, ma la tranquillità era stata la sua morte. «Gli studiosi si sono sempre interrogati sul perché i romani, per designare la fondazione di Roma, avessero scelto proprio il termine condere, che ha come significato originario quello di “nascondere”. Il fondatore fu definito conditor, ossia colui che nasconde o forse colui che è nascosto. Il colle della fondazione prese il nome di Cermalus, inteso come luogo del nascondimento, dato che ha la stessa radice di condere. Le fonti antiche parlano di una fossa di fondazione sul Cermalus, nei pressi di un’ara, entrambe opera di Romolo. Nascondere, nascondere e ancora nascondere. Ma cosa fu nascosto là sotto? Soltanto terra benedetta?» «Il lituo?», azzardò Dino. «No, qualcosa di ancora più importante. I più recenti scavi hanno rintracciato sulla sommità del Cermalus un altare e una fossa, databili proprio alla metà dell’ottavo secolo avanti Cristo, e al loro interno tracce di resti umani coevi. Per fondare la città era infatti necessario un sacrificio umano. Capite ora?». Lazzari unì le mani davanti al volto, come se pregasse. «Là sotto fu nascosto il fondatore. E insieme con lui fu celato il nome segreto il fondatore. E insieme con lui fu celato il nome segreto della città. Ogni cosa torna, finalmente... Remo, fondata la città, fu ucciso e sepolto nella fossa di fondazione, la cosiddetta “Roma quadrata”. Questo nasconde il Cermalus! Il segreto di Roma è seppellito nel suo cuore da quasi tremila anni». Aveva parlato tanto in fretta, che ora era quasi senza fiato. Si guardò attorno, cercando di valutare l’effetto della sua rivelazione, e infine, toccandosi il petto, sussurrò rivolto ad Artemisia: «È qui». Dino lo afferrò per le spalle e lo scosse con esasperazione. «Che cosa stai cercando di dire? Dillo chiaramente maledizione!». «Ho sempre avuto il lituo con me». La rivelazione restò sospesa nell’aria per alcuni interminabili secondi. Nessuno sembrava intenzionato a commentare, forse temendo di vederla svanire. Come potersi fidare dopo tutto quello che era accaduto? Fu lo stesso Lazzari a riprendere la parola. «Lupo, raccontagli per favore della voce che circola da sempre nell’ambiente dei cacciatori di tesori». Il Lupo si sedette per terra, la schiena contro la portiera della Land Rover. «A inizio Novecento, durante i lavori urbanistici sul Palatino, furono riportati ala luce per la prima volta i resti di quelle che ormai sono state riconosciute come le capanne dell’età di Romolo: in riconosciute come le capanne dell’età di Romolo: in particolare la Regia, con gli annessi sacrari di Marte e Opi. Alcuni testimoni raccontarono che in una di quelle capanne un avventuriero di nome Casini avesse trovato un cofanetto: sempre secondo le testimonianze, all’interno c’era il lituo di Romolo. La voce è stata tramandata e non ha mai perso consistenza, ed è per questo motivo che nessuno di noi avventurieri si è mai messo alla ricerca del lituo: eravamo sicuri che il lituo fosse stato davvero ritrovato, anche se non sapevamo che cosa ne avesse fatto Casini». «E questo cosa c’entra con noi?», domandò Dino agitando la pistola, che pareva un giocattolo nelle sue mani. «Quel Casini era il nonno del mio mentore, il professore che vi ha indicato il mio nome quando vi siete rivolti a lui per farvi consigliare un esperto di storia romana delle origini», rivelò Lazzari. «È stato proprio lui a consegnarmi il lituo, a Milano». Artemisia era sbalordita. «E tu lo hai avuto per tutto questo tempo con te e non hai detto nulla? Noi abbiamo rischiato la vita e...». «Qualcuno come Parodi l’ha persa. Lo so. Ma io non sapevo affatto di avere il lituo con me, come ti ho non sapevo affatto di avere il lituo con me, come ti ho detto anche prima. Ho ricostruito solo più tardi la verità». Lazzari tirò fuori il lituo dalla tasca interna del giubbotto. «Ho sempre creduto che questa fosse semplicemente una sorta di pipa esile ed allungata. Casini, d’altronde, l’aveva sempre definita così». Sospirò tristemente. «Non l’ho riconosciuto perché non so guardare. E non so guardare perché non conosco i nomi delle cose...». Lazzari si interruppe e mostrò loro il piccolo legno, ricurvo e traforato. «Questi segni neri rappresentano delle bruciature, vedete, ma sono state causate dall’incendio da cui il lituo uscì indenne ai tempi dell’invasione gallica. E questo è sì un bocchino, ma da tromba e non da cannello. I dati al carbonio confermeranno senz’altro la datazione intorno all’ottavo secolo avanti Cristo. La copia che abbiamo fatto per quelli della Tauros è identica a questo». Lazzari porse il lituo ad Artemisia. «È quello che volevi da me, giusto? Prendilo». «È stato regalato a te». «Io cercavo solo una parola, l’unica nella storia dell’Occidente a non essere mai stata messa per iscritto. Un nome capace di far luce sull’intera storia...». «Io non posso prenderlo, appartiene a te», lo «Io non posso prenderlo, appartiene a te», lo interruppe Artemisia allontanandogli la mano. «È tuo», mormorò Lazzari, e poi le afferrò il polso, in modo gentile ma deciso. Le fece aprire le dita, glielo consegnò e infine le richiuse. Il rombo di almeno un paio di motori troncò la conversazione. I rumori erano troppo distinti perché le auto si trovassero sula provinciale e per di più si stavano avvicinando con rapidità. Allarmati, si voltarono tutti verso la pista sterrata. Pochi istanti dopo comparvero tre Mercedes nere con i finestrini oscurati. Due entrarono nel cortile e si fermarono intorno alla Land Rover formando una mezzaluna. L’altra, invece, si mise di traverso a sbarrare l’accesso all’aia nello spazio libero tra due pilastri dove un tempo doveva esserci stato un cancello. Le portiere si aprirono contemporaneamente e otto uomini armati di mitra saltarono giù dalle auto. Per ultimo scese il Colonnello. Indossava un completo grigio e, appuntato sulle spalle, il consueto soprabito. «I rinforzi», esultò Dino andandogli incontro a passo slanciato. Aveva riacquistato di colpo fiducia. «Colonnello, devo aggiornarla che...». Il Colonnello gli sfilò la pistola con un gesto risoluto e Il Colonnello gli sfilò la pistola con un gesto risoluto e lo allontanò da sé. «Signori, arriverò in un attimo al punto. Preliminarmente, però, vi prego di dare a questi gentiluomini russi i cellulari, gli apparecchi elettronici e le eventuali armi rimaste in vostro possesso». «Ma è impazzito?», scattò Artemisia. Uno dei russi le puntò il mitra contro e guardò con aria interrogativa il Colonnello, che fece di no con la testa e spiegò senza rivolgersi a nessuno in particolare: «Non vi preoccupate. Semplici precauzioni». Un altro del gruppo del Colonnello estrasse una pistola sparachiodi e forò gli pneumatici della Land Rover, che si accasciò come un pachiderma ferito a morte. «Nessuna requisizione, tranquilli signori. Lascerò tutti i vostri oggetti nel bagno del bar Centrale di Minturno. Sono circa quattro ore a piedi da qui», disse il Colonnello. «Il maresciallo dei carabinieri della stazione locale, un mio buon amico, ha in mano una denuncia a vostro carico per scavi illegali e traffico di reperti archeologici. Se proverete a cercare soccorsi, un taxi, o anche un semplice passaggio, vi verrà immediatamente a prelevare. In caso contrario, straccerà la denuncia». Artemisia tremava per la rabbia. «Ma tutto questo è Artemisia tremava per la rabbia. «Ma tutto questo è inaudito! Io la rovinerò Colonnello, dovesse costarmi tutto quello che possiedo!». «Temo che non le basterebbe», le rispose indicando la sua scorta. «L’uomo per cui lavorano questi signori non lo permetterebbe. Si fidi di quello che le dico». I russi li perquisirono rapidamente e poi passarono al setaccio l’auto: portarono via loro i cellulari, i portafogli e lo zaino di Dino. «E ora il lituo per favore, signorina Della Rovere. Abbiamo un volo privato per Makhachkala tra poco più di tre ore», disse il Colonnello. Quindi si avvicinò e senza tanti complimenti glielo strappò di mano. Era la seconda volta in un’ora che Artemisia se lo vedeva sfilare dalle dita. Non riusciva a crederci. Ci doveva pur essere qualcosa da fare per riuscire a rovesciare quella situazione assurda. Agguantò l’uomo per la cravatta tirandolo verso di sé. «Ferma!», gridò Lazzari guardando i russi in preda all’ansia. Il Colonnello si liberò della presa con facilità e fece due passi indietro. Guardò in faccia Artemisia, come se cercasse di imprimersi nella mente il suo viso, forse una minaccia velata o forse una dimostrazione di quieto minaccia velata o forse una dimostrazione di quieto disprezzo, infine si sistemò la cravatta con cura e si allontanò. «Codardo», rincarò la dose Artemisia. Il Colonnello fece finta di niente e si rivolse al Lupo che, non notato da nessuno, si era avvicinato alla Mercedes. «Professor De Feudis, la accompagneremo alla prima stazione di taxi. Ho già provveduto a far accreditare sul suo conto il compenso pattuito per la fattiva e preziosa collaborazione. Come da accordi, mi farò vivo io per i prossimi incarichi. Non dubiti che saranno all’altezza della sua competenza e della sua ambizione». Il Lupo si voltò verso Lazzari e si toccò la tempia in un gesto di saluto. «Mi dispiace solo per te, fratello. Però io sono uno che i conti li sa fare. Prima o poi imparerai a farli anche tu. Questi signori finanzieranno le mie spedizioni per il resto della mia vita. È un’occasione che non potevo rifiutare». Lazzari incassò la notizia in silenzio. Era bianco e pareva covare un’indicibile amarezza. Dino, invece, resistette a fatica all’impulso di colpire il Lupo. La testa gli scoppiava. «Colonnello io non posso credere che lei...». credere che lei...». Il Colonnello lo interruppe subito. «Non ha di che lamentarsi, sergente. Il suo onorario le è stato regolarmente versato in anticipo, come da protocollo standard. Che le importa se questo pezzo di legno va a un milionario o a un altro? Sono questioni che non la riguardano. Lei ha portato a termine la sua missione: non c’è altro». «Ma il Committente...». «...se ne farà una ragione. Nessuno si è fatto male: questa era la sua consegna prioritaria, incontestabilmente portata a termine. E poi il Committente potrà trastullarsi con le scoperte del nostro esimio Lazzari», aggiunse il Colonnello prima di rivolgersi a lui. «Ha ottenuto quello che voleva, vero assistente? Anche lei dovrebbe essermi grato». Lazzari gli oppose una smorfia di disgusto. «Ci ha fregati tutti, complimenti Colonnello». Il Colonnello liquidò la questione con un cenno disinvolto, ma una lieve piega agli angoli della bocca tradiva la sua soddisfazione. «Se intende metterla su questo piano...». «Sono solo soldi, Colonnello. Solo soldi», gli fece notare Lazzari sputando letteralmente le parole. notare Lazzari sputando letteralmente le parole. Il Colonnello aspettò che il Lupo salisse in auto e chiudesse la portiera, prima di aggiungere: «Sa qual è il punto debole dell’uomo?» «Da come ne parla ogni volta, pare che il genere umano sia un suo nemico personale», replicò Lazzari. «Non sa cosa vuole», chiarì il Colonnello senza fare caso alla sua risposta. Poi infilò la mano in una tasca interna del soprabito, tirò fuori un pacchetto delle dimensioni di un quaderno e lo gettò con sussiego ai piedi di Lazzari. «Se in questo momento scendesse un fantomatico dio disposto a esaudire le vostre preghiere e chiedesse a ciascuno di voi tre qual è la cosa che desidera più di qualsiasi altra, non sapreste cosa rispondere. Balbettereste. Per questo non avrete mai nulla». 27 Nulla: quella parola sigillò il silenzio calato nel cortile dopo la partenza delle tre Mercedes. La polvere si depositò adagio. Il rumore dei motori si dissolse in lontananza. L’ombra proiettata dal fienile sull’aia si allungò verso l’opposto casolare. Dino si lasciò cadere pesantemente a terra. Aveva lo sguardo perso nel vuoto. Non c’era più alcuna battaglia da combattere, tutto era perduto. Lazzari fissava come un cieco l’orizzonte ignorando i pensieri che gli vorticavano in testa. «Cerchiamo un telefono. Mio padre scatenerà un inferno. Fermerà quel cazzo di volo», provò ad animarsi Artemisia. «Non farà nulla», le fece eco Dino con voce piatta e sfibrata. «Mi è capitato di collaborare con quei paramilitari in passato. Sono al soldo di un magnate russo con talmente tanto denaro e potere da avere un esercito personale alle sue dipendenze: è gente fuori dalla nostra portata. Il lituo è perso per sempre». portata. Il lituo è perso per sempre». «E chi sarebbe tuo padre?», le domandò Lazzari mentre si chinava per raccogliere l’involucro che gli aveva gettato il Colonnello. Lo soppesò senza particolare interesse: era avvolto in una comune carta da pacchi e piuttosto leggero. «Non l’hai ancora capito?», lo aggredì Artemisia. Era furente, e a giudicare dal suo tono di voce sembrava attribuire la responsabilità di tutto a Lazzari. «No», disse Lazzari, senza sollevare gli occhi dal pacchetto. «Il Committente è mio padre». «Tuo padre», ripeté Lazzari incredulo. Artemisia proseguì accalorata: «Il Colonnello aveva già lavorato alcune volte per la nostra famiglia. Su suo incarico, Dino si è occupato della sicurezza di mio padre per un breve periodo di tempo circa due anni fa, all’epoca in cui vendette le proprie partecipazioni in una multinazionale farmaceutica. Ci siamo sempre trovati bene: lavori impeccabili. È per questo che ci siamo rivolti a lui anche per quest’operazione. Mio padre ha una passione smodata per Roma antica e ora che, in un certo senso, si è ritirato dagli affari...». «Ma tutte queste cose non potevi dirmele prima?». «Ma tutte queste cose non potevi dirmele prima?». Il candore con cui le pose la domanda la fece infuriare ancora di più. Con la bocca aperta, gli occhi tristi e quel pacchetto tra le mani, le dava l’impressione di un questuante e lei aveva una gran voglia di strappargli il pacchetto dale mani e poi sbatterglielo in testa. «Non venirmi a parlare di sincerità!». «Non saprei di che altro parlare, a questo punto». Artemisia sbuffò, restò come in bilico per alcuni istanti, le mani sollevate e le gote rosse, e infine parve arrendersi. «Volevo a tutti i costi partecipare alla missione per il ritrovamento del lituo e mio padre non ha potuto fare altro che acconsentire. Avevo bisogno di qualcosa di nuovo, emozioni fuori dal’ordinario. Il Colonnello, però, disse che rivelare la mia identità avrebbe fatto salire il fattore di rischio, e che per giunta tu eri una persona incapace di tenere un segreto». «Sai cosa disse a me?», fece di rimando Lazzari. «Che il bravo venditore piazza il suo prodotto, ma quello bravissimo vende due volte lo stesso articolo a due acquirenti diversi. Lui si è superato: ha piazzato lo stesso pezzo a tre acquirenti distinti». Dino sollevò la testa. «La Tauros...». Lazzari annuì e con gli occhi sembrava dirgli “mi Lazzari annuì e con gli occhi sembrava dirgli “mi dispiace che ti abbia deluso, ma è quanto accade con gli idoli: se li tocchi, la doratura ti rimane appiccicata alle dita”. «Ora sai perché quelli della Tauros erano certi che non li avremmo inseguiti. Avevano la garanzia del Colonnello. Tu riferivi a lui e lui a loro... Deve aver preso contatti subito dopo il pasticcio di Sarzana, cogliendo con piacere l’opportunità insperata di un ulteriore guadagno». «Il Colonnello ha accettato l’offerta che noi abbiamo rifiutato», mormorò Artemisia con il tono di chi scopre all’improvviso una verità evidente. «Già», confermò Lazzari. «Per questo gli agenti della Tauros ci ronzavano attorno senza intervenire. Aspettavano. E il Colonnello a sua volta aspettava con i russi. Erano tutti in attesa che noi mettessimo le mani sul lituo». «Ma come poteva prevedere...». «È la sua specialità, no?», fece Lazzari. «“Il punto debole dell’uomo è la prevedibilità”, mi disse il primo giorno. E io non l’ho deluso. È stato lui d’altronde a suggerirmi l’idea. Vendere due volte la stessa cosa». Dino prese un sasso e lo lanciò oltre il casolare. Lo udirono perdersi tra gli alberi. «Aveva previsto che ti udirono perdersi tra gli alberi. «Aveva previsto che ti saresti sbarazzato della Tauros in quel modo? Con una falsa copia del lituo? Mi pare assurdo». «Non troppo, se ci ragioni bene. Quale altro modo avremmo potuto escogitare per toglierceli dai piedi? Tu stesso ti eri accorto che non era possibile procedere con quella gente alle calcagna, e per questo motivo avevi chiesto rinforzi al Colonnello. Lui te li aveva promessi per tenerti buono e non farti insospettire, ma non te li avrebbe mai concessi, e se io non avessi architettato la messinscena per liquidare la Tauros, ce l’avrebbe suggerita lui stesso». «È grazie al Lupo se lui ha potuto seguire passo a passo le tue mosse», rimarcò Artemisia in tono duro. «Sì, certo», confermò Lazzari, una smorfia amara sul viso. «Il Lupo ha informato il Colonnello sia dela copia sia del lituo che mi aveva dato Casini». «Il Maestro ci aveva messo in guardia», ricordò Dino. «E tu ti sei fidato di quel tombarolo anziché di noi», tornò alla carica Artemisia, ma senza l’abituale impetuosità. Dopo mezzo minuto buono di silenzio, in cui ciascuno contemplò la propria posizione all’interno di quella faccenda, Lazzari riprese: «Avrei dovuto capire che c’era faccenda, Lazzari riprese: «Avrei dovuto capire che c’era un legame tra il Lupo e il Colonnello ieri mattina. All’alba il Lupo mi ha preso in disparte per convincermi a fare un salto a Roma, dove ci aspettava un suo amico in possesso di un brandello dell’Epoptidon. Lì per lì ho creduto che si trattasse semplicemente di qualcuno che volesse vendermi un falso, un modo per il Lupo di intascare qualche soldo in più». «E poi la telefonata del Colonnello, già...», ricordò Dino. «E quell’assurda puntata a Nettuno. L’uomo che si proponeva di venderci i tesori ripescati dalle paludi si è avvicinato senza indugio al nostro tavolo senza averci mai visto prima. E vi siete accorti di come il Lupo cercava di pilotarlo? Era con ogni probabilità uno dei suoi collaboratori. Tutta una messinscena ordita dal Colonnello e dal Lupo». «Sai anche il perché?», fece Artemisia. «L’ho scoperto poco fa. L’hanno fatto per guadagnare un giorno e permettere ai russi di arrivare e attrezzarsi per la trappola di oggi». «Se tu ti fossi fidato di noi anziché del Lupo a quest’ora il lituo sarebbe nelle nostre mani», gli fece notare Artemisia. notare Artemisia. «Sospettavo che il Colonnello fosse in contatto con la Tauros, d’accordo, ma se ve l’avessi detto mi avreste creduto? Non credo. E poi come potevo prevedere l’entrata in scena dei russi? Chi diavolo se lo sarebbe immaginato... Inoltre avevo tante altre cose in testa, dalla tomba al lituo, passando per quello che sai... E volevo vedere a cosa saremmo arrivati». «E a cosa siamo arrivati? Dimmelo un po’». «Alla realizzazione completa del piano del Colonnello», rispose al suo posto Dino. Lazzari assentì. «Il Colonnelo ha intascato soldi dal Committente, dalla Tauros e dai russi. Perché tutti pagano in anticipo il professionista che non ha mai tradito le aspettative di nessuno... Giusto?» «Figlio di puttana», rimarcò Artemisia. Artemisia si avvicinò a Lazzari. «Cosa c’è in quel pacchet to che ti ha lasciato il Colonnello?» «Te lo dirò tra un istante». Lazzari lo scartò e si ritrovò tra le mani un’agendina nera. In basso a destra, sotto un sottile taglio, vide le iniziali C.V.R. e la riconobbe. «È quella del Colonnello», rivelò. «Sì, è proprio la sua», confermò Dino. Ma perché gliela aveva lasciata? Lazzari si ricordò di Ma perché gliela aveva lasciata? Lazzari si ricordò di quando, seduto al tavolino dell’enoteca, il Colonnello aveva letto in quelle righe la storia della sua carriera universitaria. La aprì e la sfogliò incredulo. Tutte le pagine erano bianche. «Grandissimo figlio di puttana», sussurrò. Artemisia prese l’agendina e fece scorrere i fogli a sua volta. «Che significa?» «Che mi ha manipolato a suo piacimento, fin dal primo momento. Che lui ha vinto e io ho perso», rispose Lazzari. «E c’era bisogno di fartelo notare? Non era già abbastanza chiaro? Ci ha fregati su tutta la linea: si è tenuto il lituo e pure i soldi!». «Non basta sconfiggere un avversario; perché il trionfo sia completo occorre che il nemico sia consapevole della sua totale disfatta». «E che motivo poteva avere per inscenare questa sfida? Non ce lo vedo a gingillarsi con le questioni personali. E poi tu lo conoscevi appena». «Forse rappresentavo qualcosa per lui», azzardò Lazzari. «Ormai non ha più importanza», si inserì Dino rialzandosi a fatica. Raccolse il berretto da terra e se lo rialzandosi a fatica. Raccolse il berretto da terra e se lo sbatté contro la coscia un paio di volte per far cadere la polvere, infine ci ripensò e lo gettò via. «Invece ce l’ha», insistette Artemisia. «Non possiamo arrenderci così». «Ci siamo già arresi», le ricordò Dino. «Andiamo al bar di Minturno», fece Lazzari. «Voglio mettere la parola fine a questa storia». I locali del bar Centrale erano quelli di un’ex società di mutuo soccorso che avevano un gran bisogno di una ristrutturazione. Il salone era deserto tranne un tavolo dove quattro uomini giocavano a carte nella luce polverosa che pioveva da una finestra protetta dalle inferriate. Artemisia e Lazzari si fermarono sulla porta. Dino, invece, puntò direttamente in bagno; dentro un vecchio armadio stipato di canovacci trovò il borsone con tutte le loro cose, compresi i cellulari e la sua pistola. Tornò all’ingresso e fece cenno ai compagni di raggiungerlo all’interno del bar. Si sedettero a un tavolino al di là del biliardo che divideva in due la sala e si fecero portare tre bicchieri di whiskey. whiskey. «Puoi controllare in qualche modo se è partito quel vo lo?», domandò Lazzari a Dino. «Conosco una persona che può scoprirlo facilmente», disse Dino afferrando il cellulare. «Un volo privato per Makachakala è decollato dieci minuti fa da Ciampino», riferì al termine della breve telefonata. «Ora mi sento molto più leggero», commentò Lazzari e buttò giù il bicchierino. «Che cosa avrebbe potuto farti ancora?». Lazzari mormorò una preghiera di ringraziamento a occhi chiusi. «Spero di non vedere mai più quell’uomo. È come guardare la parte peggiore di me». «Ti sembra il momento di fare della filosofia?», gli domandò Artemisia. «Forse è finalmente il momento dela verità...», annunciò Lazzari. «E la verità è che siamo tutti colpevoli. Non abbiamo fatto altro che ingannarci». Ordinò una bottiglia di vino alla donna dietro il banco: «Dobbiamo brindare e per farlo ci vuole del vino». Dino temette che Lazzari fosse uscito di testa, ma non disse nulla. Lui stesso era a pezzi, si sentiva come un soldato greco al termine della guerra di Troia: vinto o perso, non aveva più importanza. E ora? Tornare a casa? perso, non aveva più importanza. E ora? Tornare a casa? Quale casa? «Abbiamo bisogno di riposo», disse semplicemente. Lazzari tirò dritto: «Mi dispiace solo per il lituo. Ci ero affezionato». Artemisia afferrò il tavolo con le mani e lo scosse con rabbia. I bicchierini si rovesciarono e nessuno si curò di rialzarli. «Ci eri affezionato? Era un cazzo di oggetto da milioni di euro!». Lazzari si alzò e andò a sedersi sul davanzale della finestra. «Non più di qualche migliaia», rivelò. «Il lituo con cui fu fondata Roma?» «Il lituo con cui fu fondata un’oscura località etrusca alle porte di Tarquinia». «Che vorresti dire?» «La volpe conosce molti trucchi. L’istrice uno soltanto, ma buono. E noi siamo l’istrice». «E la volpe sarebbe il Colonnello?», domandò Dino. La donna del bar giunse ciabattando con tre bicchieri in una mano e nel’altra una bottiglia di rosso senza etichetta. «La versiamo noi», disse Artemisia esasperata dalla sua lentezza. Quando la donna si fu allontanata, Lazzari riprese: Quando la donna si fu allontanata, Lazzari riprese: «Avete mai visto Rashômon? Quel film sull’omicidio di un samurai raccontato in modo diverso da ogni protagonista della vicenda?». Appena si accorse del cambio di espressione di Artemisia, si ravvide: «Come non detto, non fa niente. Però stamattina vi ho mentito. Non ho mai creduto alla storia della microspia. Sono sempre stato convinto che fosse uno dei nostri a informare la Tauros, ma sul principio non sapevo chi fosse, di voi». «D’accordo, ora sappiamo che era il Colonnello. Però mi viene in mente che fu proprio lui a invitarci ripetutamente a rinunciare. L’hai sentito anche tu a Milano quando eravamo a cena da Giacomo», obiettò Artemisia. «Era il suo ruolo e la sua copertura. E ti conosceva. Sapeva che se lui avesse insistito, tu avresti fatto il contrario. Così è stato. Senza dubbio era in contatto con i russi fin dal principio. Poi ha trasformato il pericolo Tauros in un’opportunità, accettando la loro offerta al nostro posto: li informava sui nostri spostamenti in modo che, quando il lituo fosse stato nelle nostre mani, sarebbero potuti intervenire per portarcelo via in tutta comodità». comodità». «E poi lui e i russi l’avrebbero preso a loro?» «Questa doveva essere la sua idea iniziale. Poi io gli ho offerto una soluzione migliore: più facile e molto meno rischiosa. Mi sono accordato con il Lupo per preparare la copia e la trappola per gli agenti della Tauros». «E in quel modo la Tauros è finita fuori dai giochi», disse Dino. «Tu però non potevi avere certezze circa l’accordo tra la Tauros e il Colonnello...», gli fece notare Artemisia. «Ed è per questo che mi sono tenuto un asso nella manica». «Il lituo che ti aveva dato Casini a Milano...». «Esattamente», disse Lazzari, desideroso di svelare le motivazioni che lo avevano portato ad agire in quel modo. Per troppi giorni si era tenuto tutto dentro. «Fin da quella mattina in Garfagnana, quando Dino si è unito a noi, avevo deciso di tirarmi fuori da questa storia in qualsiasi modo. Ero consapevole che nessuno di voi mi avrebbe lasciato andare fino a quando non fosse saltato fuori il lituo. Ero disperato, finché, del tutto per caso, non capii che la pipa di Casini era in realtà un lituo; allora intui il modo di liquidarvi: offrirvi dei falsi. Progettai di mettere di nascosto il lituo nella tomba scavata dal Lupo, mettere di nascosto il lituo nella tomba scavata dal Lupo, ma sapevo di avere in realtà due nemici: non solo la Tauros, ma anche la vostra Fondazione. Così decisi di fabbricare la copia: con quella mi sarei sbarazzato della Tauros e del loro eventuale informatore, mentre con il lituo di Casini mi sarei liberato della Fondazione e di quelli di voi fedeli al Committente». Artemisia non sapeva se essere disgustata o ammirata. «Eri sicuro che il Lupo ti avrebbe tradito e ne hai approfittato. Hai puntato sulla sua infedeltà. Un’impresa degna del Colonnello. Forse davvero gli somigli». «Sì, ho puntato sul fatto che il Lupo mi avrebbe poi fregato. In fondo era il Colonnello a pagare. E così è andata». «Ma come hanno fatto a mettersi in contatto tra di loro? E tu come facevi a saperlo? Poche ora fa hai detto di non esserti accorto del legame tra il Lupo e il Colonnello», disse Dino. «Mentiva», disse Artemisia. «Non ha fatto altro, fin da quando si è sentito tradito. Non è così?» «Mentire? Ho detto a ciascuno quello che voleva sentirsi dire... Ma lasciate che vi racconti i fatti. Il bonifico al Lupo non è stato di quarantacinquemila euro, come avevate concordato, ma di settantacinquemila. Ho origliato la telefonata tra il direttore dela banca e il Lupo, che era sorpreso. Quel bonus era un chiaro messaggio e, a quanto ho potuto appurare subito dopo, non proveniva da voi due». «Fu il Colonnello a occuparsi del bonifico», ricordò Dino. «Infatti», fece Lazzari. «Il Colonnello voleva un alleato in più e se l’è comprato con i vostri soldi». «I soldi di mio padre...», precisò Artemisia. Lazzari chiese a Dino: «Tu ovviamente hai dato al Colonnello il numero di telefono del Lupo?» «È la prassi». «Deve averlo contattato per domandargli se aveva gradito il regalo extra di trentamila euro, e per dirgli che se lo avesse aiutato ce ne sarebbero stati altri, molti altri, e da lì si è instaurato un filo diretto tra i due. Il Colonnello lo avrà persuaso prospettandogli soldi e commissioni da parte dei russi, secondo quanto posso ricostruire ora. Avete sentito che cosa mi ha detto il Lupo prima di andarsene?» «Che i russi finanzieranno tutte le sue prossime spedizioni», rispose Dino. Lazzari annuì. «Così il Lupo ha fatto la sua scelta e al Lazzari annuì. «Così il Lupo ha fatto la sua scelta e al momento opportuno ha telefonato al Colonnello e gli ha confidato il mio piano per toglierci dai piedi la Tauros». «Ma se invece il Colonnello si fosse dimostrato fedele alla Tauros?» «Li avrebbe avvisati dell’inganno e nessuno si sarebbe presentato alla tomba. Ma anche in quel caso avrei avuto la conferma del legame tra la Tauros e il Colonnello. La prova definitiva dell’accordo tra il tombarolo e il Colonnello è stata l’insistenza con cui il Lupo ha provato a convincermi ad andare a Roma e poi le sue parole, apparentemente disinteressate, su Costantino Maes e il venditore di Nettuno. Il Colonnello gli aveva chiesto ancora un giorno di tempo e lui si è prodigato con ben due false piste». «Non hai ancora spiegato come hai fatto a convincere il Lupo che quello che ti portavi appresso era proprio il lituo», disse Artemisia. «Il professor Casini me lo ha regalato durante il nostro ultimo incontro a Milano, facendomi intuire a suo modo che mi stava offrendo una via di fuga. Immagino dovesse sentirsi in colpa per avermi messo in questo guaio, sebbene lo avesse fatto senza volerlo». Lazzari sorrise al ricordo. «Io lì per lì fraintesi il suo gesto... Ho sorrise al ricordo. «Io lì per lì fraintesi il suo gesto... Ho capito la verità solo tempo dopo, quando ho guardato per la prima volta con attenzione quella che, come vi ho già spiegato, credevo una semplice pipa, per quanto antica». «Quel vecchio ha la vista lunga. E anche la lingua. Ricordo quando ho accompagnato a casa sua il Colonnello...», cominciò Dino. Artemisia gli fece cenno che ora non era importante e quindi invitò Lazzari ad andare avanti. Lazzari ubbidì: «Il Lupo, d’altra parte, era fermamente convinto che a inizio Novecento Casini avesse davvero trovato sul Palatino il lituo di Romolo. Così, quando gli ho svelato che l’avventuriero in questione era il nonno del mio mentore e che il suo lituo era da tempo nelle mie mani è andato in visibilio. La grande occasione di tutta una vita». «Gli hai mentito». «Niente affatto. Il lituo era davvero quello. Solo che Casini senior non l’aveva trovato a Roma: sempre all’inizio del Novecento, pochi mesi prima dell’avvio degli scavi palatini, aveva partecipato al dissotterramento di una tomba presso una piccola località etrusca a dieci chilometri da Tarquinia. Nella fossa furono ritrovati tre chilometri da Tarquinia. Nella fossa furono ritrovati tre simboli reali: uno scudo, un’ascia e appunto un lituo. Casini mi raccontò più volte questa illustre storia di famiglia. Ho ricontrollato l’altra notte sul catalogo on line del museo etrusco della cittadina laziale: ci sono lo scudo e l’ascia, ma non il lituo». «Significa che...». «Che Casini senior si tenne il lituo e qualche mese dopo lo aveva con sé a Roma, all’epoca della campagna di scavi sul Palatino. Qualcuno glielo vide o forse fu lui stesso a mostrarlo ai compagni: da lì nacque la leggenda del ritrovamento del lituo romuleo e Casini senior non fece nulla per smentirla». Artemisia ebbe un improvviso dubbio. «Ma tutto quello che hai detto nella tomba...». «Ne sono convinto, fino all’ultima parola», assicurò Lazzari. «Perché allora interrompere la ricerca? Perché non provare a scoprire nuovi indizi per metterci sulle tracce del vero lituo? Non era ciò che volevi anche tu?» «Te l’ho già spiegato, perché insisti a non capire? Mi ero accorto che non cercavamo la stessa cosa. Voi volevate il lituo, che si può vendere o comprare. Io cercavo invece il nome segreto di Roma, una semplice cercavo invece il nome segreto di Roma, una semplice parola da pronunciare e da scrivere. Come potevo continuare ad assecondare il Colonnello? Ero però consapevole del fatto che non avevo altro modo per liberarmi di lui se non quello di procurarvi il lituo, e così ho fatto». «Credi che si accorgeranno dell’inganno?», gli chiese senza quasi averlo ascoltato. «Gli esami dateranno il lituo all’ottavo secolo avanti Cristo e i russi non sospetteranno di nulla», disse Lazzari, poi tornò al tavolo e finalmente versò il vino. Ciascuno prese un bicchiere. Dino sollevò il suo. «Man, allora sei tu a vincere». «Te l’ho detto, non ci sono vincitori». «A che cosa brindiamo? Al Colonnello e ai suoi imbrogli o al nome segreto di Roma?», chiese Artemisia. «Al nome segreto», disse Lazzari lanciando un’intensa occhiata ad Artemisia e svuotò il bicchiere. Gli altri due fecero altrettanto. Artemisia posò il suo con forza e il rintocco parve ridestarle un pensiero spiacevole. «Ma se invece ti fossi sbagliato e il Colonnello fosse stato fedele? Avresti rifilato quel pezzo di legno fasullo a mio padre, vero?» «Sì, lo avrei fatto», rispose a bruciapelo Lazzari. «Mi «Sì, lo avrei fatto», rispose a bruciapelo Lazzari. «Mi avevate ingannato e io volevo uscire da questa vicenda». «Ti sei lasciato ingannare». «Come volete, ma te lo ripeto: cercavamo due cose diverse». «Ne sei sicuro?». Lazzari si voltò e guardò fuori cercando il mare. «Il lituo è perduto per sempre». «Te l’ho sempre detto che non capivi. A mio padre interessava tanto il lituo quanto il nome segreto di Roma. E ora abbiamo l’affresco e abbiamo il nome...». «Solo un’ipotesi di nome. E anche quella, proprio come il lituo, l’avevo con me fin dal principio». 28 Dino fu il primo ad alzarsi. «Ripartiamo dalle procedure: coprire le tracce e preparare il rientro. Io sono uno che le missioni le porta a termine. Vado a recuperare la Land Rover e a organizzare la messa in sicurezza della tomba, chissà che al Committente non interessi... Sarò di ritorno entro tre ore al massimo». Era già sulla porta quando tornò indietro per stringere la mano a Lazzari. «Senza rancore». «Ora che farai? Cercherai un’altra agenzia?» «No. Ho voglia di tornare nei luoghi dove ho fatto il mercenario... guardarli con altri occhi», disse Dino, che teneva ancora la mano di Lazzari nella sua. «Magari un giorno verrò a trovarti e ti racconterò». «Per la verità non so dove andrò ad abitare». «Non ti preoccupare, ti troverò». Artemisia e Lazzari bevvero ancora un bicchiere di vino, senza dirsi nulla, e poi uscirono dal bar. Passeggiarono fino al parapetto che chiudeva la Passeggiarono fino al parapetto che chiudeva la piazzetta, nella parte alta del borgo, lasciando che le loro mani si sfiorassero. In basso si vedevano le rovine romane e l’antico tracciato della via Appia. «Perché non ti sei fidato di me? Per ripicca? Perché ti ho lasciato intendere che non mi interessava una storia... O perché credevi che fossi alle dipendenze del Colonnello?» «Non ricordo il perché, ma ricordo che la mia sfiducia è durata poco, forse una giornata». «Davvero? Quindi ti fidavi di me?», fece Artemisia oscillando tra l’ironia e la meraviglia. «A modo mio, sì», rispose Lazzari. «Ho scommesso sul fatto che, alla fine, saresti stata dalla mia parte. Ma non ho voluto renderti complice. Quanto tempo passerà prima che queli della Tauros si accorgano dell’inganno? Forse mesi, ma accadrà. Lo stesso per i russi. Torneranno a cercarmi». «La smetterai mai di avere paura?». Lazzari infilò le mani in tasca e si girò a guardare l’orizzonte. «Forse con te». «Parli sul serio?». Lazzari ebbe quasi un moto di rabbia, prima di Lazzari ebbe quasi un moto di rabbia, prima di calmarsi. «Vuoi sapere una cosa? In questo momento sarei più felice di pronunciare il tuo nome che quello di Roma, se capisci cosa intendo». Artemisia appoggiò la testa sulla sua spalla. «Ho bisogno di tempo per sistemare alcune cose. E devo vedere mio padre. Vorrà delle spiegazioni». Lazzari assentì. «Anche a me occorre del tempo». «Anche tu hai delle cose da sistemare?» «Cercare una domanda all’ultima risposta che mi resta». Artemisia sembrò non averlo sentito. «È stato tutto così veloce ed esagerato...». «Come un amore estivo: la cosa più importante della tua vita – per una settimana», provò a spiegare Lazzari. «In fondo è come dici tu: io non ricordo il tuo nome di battesimo e tu non conosci il mio. Nessun potere l’uno sull’altra». «Peccato, un vero peccato». «Non pensiamoci più...», fece Artemisia. Poi si spostò all’improvviso e guardandolo con aria di sfida gli domandò: «Ti dispiace se ti saluto qui?». Lazzari si strinse nelle spalle. «Speravo tanto in un passaggio verso nord, ma me la caverò». passaggio verso nord, ma me la caverò». «Tieni, prendi questi», disse Artemisia tirando fuori tutti i contanti che le erano rimasti. «Non ti offenderai mica, vero? Meriteresti ben di più. Mi occuperò personalmente del tuo locale: pendenze, licenze, controlli. Riavrai indietro la tua vita...». «La mia vita?», ripeté Lazzari come se non capisse di cosa stesse parlando. Poi prese le banconote e se le infilò in tasca senza contarle. Artemisia sembrava in difficoltà. Le frasi di circostanza non erano il suo forte: lui se ne accorse e cercò di agevolarle il compito. «Antonio da Alba Docilia scrisse che quando gli addii sono definitivi, devono essere brevi». «Lo vedi?», fece Artemisia scostandosi di colpo. «Non capisci mai niente». Lazzari la guardò allontanarsi, ma tenne duro e non pianse fino a quando non la vide sparire in fondo alla via. Ci sono giornate primaverili in cui Milano si scrolla di dosso la polvere: gli alberi verdeggiano, l’aria brilla e sullo sfondo si scorgono le montagne screziate di bianco, invisibili fino a poco tempo prima. Lazzari, in piedi sulla sommità del monte Stella, il Lazzari, in piedi sulla sommità del monte Stella, il modesto rilievo al centro dell’omonimo parco, guardava la città che era stata sua per tanti anni e si domandava quale sarebbe stata la prossima. A Cesenatico sarebbe tornato solo per vendere l’enoteca e sbrigare gli ultimi affari. La zona a oriente era una distesa di gru e intelaiature, mentre a sud i palazzi declinavano gradualmente verso il centro, dove la madonnina era un barbaglio d’oro. Era però la periferia ovest, in cui aveva vissuto a lungo, ad attirare la sua attenzione. Oltre lo stadio, le toppe verdi dei parchi cucivano i quartieri grigiorossi. La fissò un’ultima volta come per fotografarla. Si congedò con un cenno da quel panorama e scese di corsa per il pendio erboso, con l’urgenza di chiudere i conti una volta per tutte. Tagliò per il boschetto, saltò il guinzaglio che legava una signora e il suo cane, e si lanciò giù per i gradini di legno rosicchiati dall’umidità. Si infilò in un taxi e col fiato grosso disse: «Vilapizzone». L’autista azionò il tassametro e poi gli diede un’occhiata allo specchietto. «A che altezza?» «Pompeo Castelli», rispose Lazzari riprendendo l’abitudine meneghina di indicare gli indirizzi senza specificare se si trattasse di una via o di una piazza. specificare se si trattasse di una via o di una piazza. Mentre ripensava alle vicende dell’ultima settimana, si chiese quante versioni di uno stesso fatto potesse fornire il protagonista. Parevano infinite, e ogni volta la verità sembrava allontanarsi anziché avvicinarsi. Sì, era come aveva sempre sospettato. Non c’era nula da aggiungere, semmai da togliere. Doveva tornare indietro e scrostare le migliaia di parole che si erano sedimentate sopra quella iniziale, per ritrovare la verità. Lazzari pagò quando percorrevano ancora MacMahon, scese dall’auto prima che si fosse arrestata del tutto, e attraversò i binari del tram al centro della piazza. Entrò nel bar all’angolo con Console Marcello e ordinò un caffè. La sera in cui era passato di lì con Artemisia, si era accorto che era l’unico di tutta la zona aperto. Ricordava anche il gruppo di uomini che fumavano e bevevano davanti alla vetrina illuminata. Il barista era un nordafricano robusto che gli scoccò una rapida occhiata e lo classificò come forestiero. «Mi scusi, sono un amico di Achille Vento, l’uomo che è stato ammazzato pochi giorni fa». «Amico?», domandò il barista prima di pigiare con forza il caffè. forza il caffè. «Sì, un amico fraterno, anche se non lo vedevo da molto tempo». «Non ti ho visto al funerale», disse il barista. Si era fermato e lo fissava con aria di rimprovero. «Abito dall’altra parte del mondo. Appena ho avuto notizia della disgrazia sono partito con il primo volo. Arrivo ora dal Cimitero Maggiore», disse Lazzari, che aveva preso informazioni sul luogo dove era stato seppelito Vento. «Avete lavorato insieme?» «Abbiamo frequentato la stessa scuola a Roma. Dai preti». Lazzari era riuscito a scoprire soltanto dove era nato e dove aveva preso la licenza media. Il barista si voltò, azionò il pulsante, aspettò che il liquido scendesse, poi spense la macchina. Mentre posava la tazzina sul bancone studiò ancora una volta il volto di Lazzari e finalmente annuì. «Anche suo zio è un prete, me ne parlava sempre. Lavora in quella grande libreria del Vaticano, come si chiama?» «La Biblioteca Apostolica Vaticana?»«Apostolica Vaticana, sì. Terribili i preti come insegnanti, eh? Non cattivi, come si dice...». «Severi?» «Severi?» «Severi, sì». Lazzari bevve il caffè tutto d’un sorso. «Anche noi, però, eravamo terribili. Gliene facevamo di tutti i colori». «Guarda, mi chiedo spesso cosa ha fatto Achille per meritare una sorte del genere. Era un uomo tranquillo e pacifico, a parte gli ultimi giorni... Era molto nervoso. E poi l’ultimo giorno...». Il barista scosse la testa al ricordo. «L’ultimo giorno?» «Litigò di brutto con Paolino, uno dei ragazzi di qui». «Non lo conosco». «Una parola tira l’altra e... Insomma, arrivarono alle mani e Achille si prese un bel po’ di botte. Ma poi fecero la pace». «Che tipo è questo Paolino?». Il barista ritirò la tazzina, la mise nel cestello e passò la spugna sul bancone. «Pure lui un ragazzo bravo. Guarda, ci è rimasto così male che ha passato tutto il resto del pomeriggio e la sera qui a bere». Lazzari disegnò un disco con il dito sull’alone rimasto sopra l’acciaio. «Perché era nervoso?» «Diceva in continuazione di aver fatto una vigliaccata e che non poteva perdonarselo e che era perduto. Beveva quattro o cinque medie, e poi diceva così». Beveva quattro o cinque medie, e poi diceva così». Lazzari prese anche un pacchetto di caramelle e pagò. «Secondo te che cosa aveva combinato?» «Secondo me niente», rispose il barista. «Guarda, Achille era uno di quegli uomini che si fanno mille scrupoli, sì. Sempre a pensare e ripensare. Sarà stato qualcosa che aveva a che fare con la sua...». Si toccò il petto. «La sua... Come si dice?» «Coscienza?» «Coscienza, sì». Al citofono di via Mantegazza non rispose nessuno, com’era prevedibile. Lazzari si appoggiò al cofano di un’auto parcheggiata e per ingannare il tempo e non dare nell’occhio si mise a controllare il cellulare, anche se non aveva ricevuto alcun messaggio. Era il telefono che gli aveva dato a suo tempo il Colonnello. Forse Artemisia conservava ancora il numero – labile speranza. Il rumore dell’apertura a scatto del portone lo mise in allerta. Sempre fingendo di scrivere, si avvicinò all’uomo che stava uscendo, poi si infilò dentro con il cuore che gli martellava nelle orecchie e prese le scale senza voltarsi neppure una volta. Rallentò solo a metà salita. Nessuno lo aveva seguito. lo aveva seguito. Sulla porta dell’appartamento di Achile Vento c’erano ancora i sigilli della polizia giudiziaria e un foglio con tanto di timbro della questura. Bastò a farlo desistere. Che si era messo in testa? Non era un lavoro per lui. Il rischio era troppo alto e non aveva nulla da guadagnare. Se non la verità. Cominciò a scendere le scale, ma a ogni gradino l’immagine di Artemisia cresceva nella sua mente e dopo due rampe gli pareva di averla a fianco a sé, in carne e ossa. La ragazza, ne era sicuro, l’avrebbe freddato con una di quelle sue frasi velenose e un secondo dopo avrebbe fatto qualcosa per convincerlo, magari un colpo di testa. Sorrise al ricordo e in quel preciso istante seppe di essere perduto. Emise un lungo respiro a occhi chiusi per darsi coraggio, fece dietrofront ripercorrendo i gradini due alla volta, forzò la vecchia finestra priva di imposte come avevano fatto la prima volta ed entrò nell’alloggio. Senza curarsi di appurare se qualcuno lo avesse udito ispezionò il bilocale, ma non trovò nulla che gli offrisse qualche indizio. La croce disegnata dalla polizia sul pavimento al posto del cadavere biancheggiava nella penombra. La scritta S.E. era ormai quasi illeggibile. penombra. La scritta S.E. era ormai quasi illeggibile. Decise di controllare anche il bagno e si stupì di vedere che all’armadietto dei medicinali erano stati apposti i sigilli. Si rammentò che, a detta del Colonnello, Achille Vento era morto per aver ingerito un veleno ricavato dal siero di vipera. Tolse i nastri e aprì l’armadietto, ma il contenuto era stato prelevato. Ne dedusse che doveva esserci stata la prova dell’omicidio lì dentro. Ma, se davvero l’avevano avvelenato, perché poi lasciare il flacone tra i medicinali? Provò a figurarsi la scena: gli uomini della Confraternita entrano nell’alloggio di Vento, lo picchiano e gli fanno confessare il suo proposito di vendere i segreti sull’origine di Roma; allora lo obbligano a ingerire il veleno e poi sistemano la boccetta nell’armadietto. Aspettano che muoia e quindi dispongono il suo cadavere a croce scrivendo con il sangue S.E. Un macabro rituale in previsione dell’appuntamento di Vento con lo stesso Lazzari e Artemisia, una sorta di avvertimento: morte a chi tocca il segreto di Roma. Questo era più o meno quanto aveva supposto Lazzari fin dal’inizio, ma a ripensarci in quel momento, c’erano almeno due particolari che lo lasciavano perplesso: il veleno, che a quanto pareva gli assassini perplesso: il veleno, che a quanto pareva gli assassini avevano messo nell’armadietto del bagno dopo l’uso e il ruolo dei sicari della Confraternita. Li aveva temuti come il più terribile dei pericoli a partire dalla sera in cui aveva visto il cadavere di Vento, ma di loro non aveva più scorto nemmeno l’ombra. Come era possibile che persone pronte a un omicidio così efferato si fossero poi disinteressate dei loro progressi nella ricerca del lituo? Come era possibile che non avessero tentato di bloccarli al momento di scendere nella tomba di Formia o per lo meno di convincerli a desistere? E come era possibile che tutte quelle domande gli venissero in mente solo in quel momento? E poi, lasciare il flacone del veleno nello stipetto significava offrire una prova alla polizia. Perché una leggerezza simile? Sentì il proprio cuore perdere un colpo mentre la risposta prendeva forma nella sua mente. Vento... Se fosse stato lo stesso Vento a ingerirlo? Provò a considerare l’intera vicenda da un’altra prospettiva. I lividi che gli avevano visto in faccia potevano essere quelli della scazzottata con il suo amico Paolino, e non i segni di un’aggressione, come avevano pensato quando lo avevano trovato. A quella considerazione seguì una scarica di adrenalina, e considerazione seguì una scarica di adrenalina, e l’impressione di muoversi finalmente nella direzione giusta. Lazzari tornò in sala in preda all’agitazione, i nastri della polizia ancora stretti in mano. Vento, in preda a una crisi di coscienza, si procura del veleno di vipera e la sera del loro incontro lo ingerisce, poi rimette il flacone nell’armadietto, compone la scritta con il suo stesso sangue e si sdraia in attesa della morte. Suicidio. Non gli pareva affatto inverosimile, tutti gli elementi della vicenda parevano incastrarsi alla perfezione. La scelta del veleno era ricaduta sul siero di vipera per simulare l’antico rituale romano della pena del sacco, riservata a chi si era macchiato del crimine più spregevole, il parricidio, in cui rientrava anche la divulgazione dei riti segreti. Ora era anche più chiaro il significato della scritta Sacer esto, composta con il proprio sangue dallo stesso Vento. Quella formula non prevedeva infatti l’esecuzione diretta: i pontefici la pronunciavano per offrire il reo in riparazione agli dèi, invitando i cittadini a ucciderlo al più presto. Vento doveva aver consacrato se stesso, offrendosi in espiazione per il proprio crimine. La posizione a croce, infine, doveva ricollegarsi La posizione a croce, infine, doveva ricollegarsi molto probabilmente alla condanna capitale inflitta dal Senato di Roma a Valerio Sorano, nel quale Vento si era immedesimato. I mezzi che Vento aveva scelto per togliersi la vita, oltre a far parte di un complesso e arcano rito di espiazione, costituivano un chiaro messaggio per gli appartenenti alla Confraternita: ho tradito e per questo ho pagato il fio; con me, come accadde con Sorano, muore ogni possibilità di ulteriore svelamento del segreto. Le parole confidate al barista di Villapizzone non lasciavano spazio a ulteriori dubbi: Vento lo aveva fatto per riparare alla propria colpa, ossia aver accennato dietro pagamento all’esistenza di un mistero millenario. Sebbene non si fosse spinto oltre, la sua delazione aveva messo in moto una caccia che avrebbe potuto portare alla profanazione del nome nascosto di Roma. Doveva aver pensato che con la sua morte si sarebbe persa ogni possibilità per i non iniziati di risalire la catena fino al contenuto del segreto. Lazzari lasciò cadere i nastri biancorossi che andarono a coprire la testa della sagoma di gesso. Si chinò con l’idea di toglierli, ma poi cambiò idea. C’era una domanda lì sotto, una domanda che avrebbe dovuto farsi fin dal primo momento, e che aveva per soggetto e per oggetto la semplicità: come faceva Achille Vento, un manovale con la licenza media, a conoscere il millenario segreto di Roma? 29 Roma era stata data alle fiamme e rasa al suolo più di una volta. I suoi colli erano stati spianati, il fiume spostato, le valli colmate. I suoi tesori erano stati predati, gli edifici sventrati, le mura abbattute. Eppure era ancora indiscutibilmente Roma. Sebbene quello non fosse mai stato il suo vero no me. Al termine di tutto era giunto lì. Mischiato ai turisti vocianti che fotografavano cielo e pietre con i loro cappellini, i sandali e le magliette colorate, Lazzari passeggiava sul Palatino a occhi bassi. I suoi piedi erano finalmente tornati sul luogo dove forse era stato sepolto Remo, e dove di certo era custodito il segreto primo dell’Urbe. Controllò l’orologio. Gli rimaneva un’ora circa per raggiungere il luogo dell’appuntamento. Nessuna possibilità di arrivare in orario, ma non gli importava. Ancora per alcuni intensi istanti esaminò la città come se fosse una sfera in cui leggere passato e futuro. La osservò come avevano fatto Romolo e forse Remo quel osservò come avevano fatto Romolo e forse Remo quel ventuno aprile e poi si avviò lungo la discesa. In serbo per lui c’era una spada o una corona? Don Giulio Vento lo aspettava nel cortile del Belvedere. Al telefono gli aveva detto che lavorava alla sezione amministrativa della Biblioteca Vaticana. Sui cinquant’anni, con una stempiatura importante, indossava sopra il gilet di lana infeltrita e la camicia blu un completo nero di taglio economico. All’occhiello della giacca portava una croce di metallo e ripiegati nel taschino un paio di occhiali con la montatura di plastica turchese. A Lazzari fece l’impressione di un uomo pacato e dimesso, seppur con qualche piccolo vezzo. «Le piace questo posto?», gli domandò il prete senza presentarsi, come se si fossero lasciati soltanto pochi minuti prima. «Ho visto che lo osservava rapito». Lazzari si strinse nelle spalle e distolse lo sguardo. Era una giornata calda e il quadrilatero del Bramante impediva all’aria di circolare. Il cielo era un rettangolo azzurro e remoto. Come poteva spiegare a quello sconosciuto che fin dalla mattina guardava ogni cosa come se fosse l’ultima volta? Come fare a chiarirgli la sensazione di fine che lo agitava? fare a chiarirgli la sensazione di fine che lo agitava? Infatti, qualsiasi cosa avesse scoperto quel pomeriggio, sapeva che nulla sarebbe più stato come prima. «E a lei piace lavorare nella città più importante di tutti i tempi?», gli domandò Lazzari a sua volta. «A chi non piacerebbe lavorare a Roma?» «Remoria, vorrà dire». Don Giulio sbatté gli occhi miopi. «Nome curioso». «Vuol dirmi che non l’ha mai sentito?» «Non voglio dire questo. Ho sentito questo e molti altri nomi». «È intorno ai nomi che gira il mondo», disse Lazzari con un luccichio negli occhi. «Almeno il nostro». «È lei la persona a cui mio nipote si era rivolto?», gli domandò il prete. «No...». «Però gli ha parlato». «Mi ha parlato lui, in un certo senso». Lazzari socchiuse gli occhi e rivide nel riverbero del cortile schermato dalle palpebre il volto tumefatto del giovane e la scritta S.E. disegnata con il sangue. «A me invece hanno parlato di lei. Ha detto di chiamarsi Lazzari al telefono, non è così?». Il tono del prete era privo di malizia e non lasciava Il tono del prete era privo di malizia e non lasciava intendere doppi sensi o minacce velate, ma Lazzari nell’ultimo periodo era stato talmente immerso nel clima di cospirazioni creato dal Colonnelo che non riuscì a non insospettirsi. «Chi le ha parlato di me?» «Alcuni amici». «Amici di che genere?». Il prete non si indispettì per il tono scortese, ma indicò l’ingresso della biblioteca. «Che genere di amici creda che possa frequentare qui? Studiosi, per lo più». «Che cosa le hanno detto?» «Che conosce molte cose». Lazzari si rilassò e con voce sopita, quasi sconfitta, disse: «Tutto ciò che ho imparato l’ho dimenticato». Il prete parve incuriosirsi. Annuì, come se fosse d’accordo. «Mi sembra esitante. Mi dica pure...». Lazzari chinò la testa. «Sono qui per sapere la verità. Perciò racconterò io per primo quello che so». «Curiosa prassi». «Ha un po’ di tempo?». Don Giulio indicò la porta con un cenno. «Andiamo a sederci». Lo scortò fino a un ufficio al secondo piano. Si sedettero a una piccola scrivania ingombra di volumi, sedettero a una piccola scrivania ingombra di volumi, tazze, penne e quaderni. Il resto della stanza, al contrario, era lindo e ordinato come una sala operatoria, compresi gli altri due scrittoi a cui in quel momento non era seduto nessuno. Il prete accennò a una teiera in porcellana inglese. «Deve esserne rimasto un po’. Forse è ancora tiepido. Me lo porta un sacerdote dall’India ogniqualvolta torna a Roma. Ne vuole? In tutte le aule della biblioteca è proibito introdurre liquidi, ma in questi uffici ci è consentito». Lazzari non l’aveva nemmeno sentito. Appena un’occhiata miope, come per sincerarsi di averlo davanti, e cominciò a raccontare tutta la vicenda fin dal principio, senza escludere nulla e senza capire se, mentre le gettava sul tavolo come tessere, le parole componessero o invece scomponessero il mosaico di quanto aveva scoperto. Il prete lo ascoltò per tutto il tempo in silenzio. Al termine del racconto lo interpellò per la prima volta: «Perché è venuto qui?». La domanda colse di sorpresa Lazzari. «Ho creduto che fosse stato lei a trasmettere il segreto a suo nipote Achille». «È quello che avrei dovuto fare. Ed è ciò che «È quello che avrei dovuto fare. Ed è ciò che avrebbe dovuto fare mio padre con me. Ma purtroppo l’unica cosa che ho potuto trasmettere ad Achille è stata la storia del segreto, e forse sarebbe stato meglio se non gli avessi mai fatto parola nemmeno di quella. Ma come potevo immaginare che l’avrebbe condotto alla morte?», fece il prete. Quindi aggiunse quasi sottovoce: «Forse, invece, avrei dovuto prevederlo, in fondo tante persone sono morte a causa di quel segreto nel corso dei secoli. Avrei dovuto semplicemente dimenticare, ma mi dispiaceva che la storia del segreto andasse irrimediabilmente perduta. Vanità: forse la parola più abusata e meno compresa dei giorni nostri. Vanità, nessuno se ne può considerare immune». Lazzari era sempre più stupito. Si era aspettato un muro di silenzio e invece il prete pareva disposto a confidarsi. «Quindi la Confraternita esiste davvero», disse con un filo di voce. Don Vento sollevò la tazza. «Ne è sorpreso? Se è arrivato fino a me non dovrebbe esserlo affatto». «Sono senza parole». «È il punto a cui arriva ogni uomo, prima di capire». «La Confraternita esiste e lei ne fa parte», insistette Lazzari, come per fissare la realtà. Lazzari, come per fissare la realtà. «Sarebbe meglio dire che è esistita e che io sono ancora vivo per testimoniarlo. La nostra famiglia, come alcune altre per la verità, ha custodito e tramandato il segreto delle origini di Roma per molti secoli». Il segreto. L’interrogativo intorno al quale aveva speso giorni e notti per sedici anni e per cui aveva rischiato la vita insieme ad Artemisia. La domanda gli balzò alle labbra, ma Lazzari non le permise di spiccare il volo. Non si sentiva ancora pronto per sapere e, per timore o per voluttà, preferiva prolungare l’attesa. «Fin dal primo giorno?». Don Vento aprì un cassetto e tirò fuori un medaglione identico a quello che il Lupo aveva ritrovato nella tomba a ipogeo presso Formia. «Mio nipote se l’era fatto tatuare sul petto». «Lo so», ammise Lazzari. E poi, in un mormorio appena udibile: «Lei sa che...». «Si è tolto la vita. Sì, come potrei non saperlo?». Lazzari provò un senso di vergogna al pensiero di quanto fosse stato preoccupato dalla Confraternita e dai suoi metodi apparentemente sanguinari, finché aveva creduto all’assassinio di Achille Vento. Ecco la terribile congrega, un prete di cinquant’anni minacciato dal senso congrega, un prete di cinquant’anni minacciato dal senso di colpa. «È a conoscenza anche della scritta e del veleno...». Il prete annuì. «Il suo era sempre stato un interesse superficiale, ma qualche nozione e alcune formule gli erano rimaste impresse. In un certo senso, si potrebbe affermare che gli ho fornito abbastanza corda da...». Non riuscì a terminare la frase. Indossò gli occhiali per nascondere le lacrime. «Forse è meglio tornare alla storia», propose Lazzari. «I compagni dei gemelli che assistettero alla fondazione giurarono di custodire e tramandare il segreto ai propri discendenti: furono perciò chiamati patres patriae, “padri della patria”». «I primi senatori». «Non solo divennero senatori, ma anche pontefici e membri della Confraternita incaricata di occultare e tramandare il nome segreto della città. Quale confraternita puoi immaginarlo». «I fratelli Luperci», disse d’istinto Lazzari, pensando all’antica Confraternita istituita proprio da Remo e Romolo. «Non ti dispiace se ti do del tu?»«I frateli Luperci, non è così?», ripeté Lazzari. Aveva quasi paura di non è così?», ripeté Lazzari. Aveva quasi paura di toccare il ciondolo della Confraternita e si limitò ad accarezzarlo con la punta vacillante delle dita. Non sarebbe stato capace di tenere una penna in mano, tanto tremava. «Sì, è così», ammise il sacerdote con la voce che a mano a mano riacquistava vigore. Era come se aspettasse da tutta una vita qualcuno con cui poter discorrere di quegli argomenti, qualcuno che non lo prendesse per un folle. Le gote risaltavano di un fresco rosa contro il turchese della montatura degli occhiali. «Parliamo di una confraternita di cui perfino gli stessi romani ignoravano il significato. Addirittura i più dotti tra di loro non riuscivano a decifrarne il mistero, sebbene non cessarono mai di onorarla e di celebrarne la relativa festa». Mille immagini e collegamenti esplosero nella mente di Lazzari. Doveva fare chiarezza. «Ogni anno, il quindici febbraio, i fratelli Luperci sacrificavano una capra presso il Lupercale, la grotta davanti alla quale si era incagliata la cesta con i due infanti, Remo e Romolo. Con il sangue dell’animale i Luperci toccavano la fronte di due giovani iniziati e poi gliela detergevano con un panno bagnato di latte: a questo punto i ragazzi scoppiavano a ridere». latte: a questo punto i ragazzi scoppiavano a ridere». «Un rito di morte e rinascita riservata agli iniziati: prima segnati con il sangue e poi bagnati con il latte», spiegò don Giulio. «I Luperci, quindi, tagliavano a strisce la pelle della capra, e iniziavano a correre nudi lungo un percorso prefissato intorno al Palatino colpendo la folla che assisteva al rito, in modo particolare le donne», riprese Lazzari. «Un rito di purificazione e fertilità. Erano lupi, mentre correvano intorno al Palatino; ed erano capri, l’animale fecondatore per eccellenza, mentre colpivano le donne. Luperci, ossia lupi et hirci, “lupi e capri”, allo stesso modo di Fauno, il demone protettore di Remo», chiarì don Giulio. «Il più oscuro e completo rito latino». «L’ultimo rito latino abolito dai papi», alluse il prete. «Il primo a nascere, l’ultimo a morire». Lazzari si sentiva a un passo dalla soluzione e decise di compierlo con estrema cautela, quasi che temesse di scivolare proprio sul traguardo. E marcando le parole, in modo da escludere qualsiasi fraintendimento, disse: «Erano quindi i Luperci a custodire il segreto delle origini». origini». «Così abbiamo modo di ritenere, anche se rimane aperta la questione del metodo: se lo abbiano trasmesso oralmente o se fosse lo stesso rito a celare l’arcano». «E la sua famiglia discende da uno dei Luperci», disse con estrema lentezza Lazzari come se si esprimesse in una lingua straniera e temesse di essere equivocato. «Sì». «I suoi avi si sono trasmessi il segreto per secoli», riprese Lazzari, insistendo con le domande mascherate da affermazioni. «Sì», disse ancora il prete e quella semplice parola, carica di un’improvvisa tristezza, gli rimase sula bocca come un taglio sanguinante. Lazzari finalmente capì. «La catena a un certo punto si è interrotta», disse con voce strozzata. Nemmeno gli occhiali potevano mascherare le lacrime del prete. «Guerre, migrazioni, carestie, malattie, ma più di ogni altra cosa debolezza di spirito. Il nome è andato perduto. È rimasto soltanto il ricordo. Custodiamo un guscio vuoto». Lazzari si abbandonò contro lo schienale. La stanza sembrava ruotare attorno a lui. Quell’uomo non stava mentendo. «Non lo troveremo mai più». mentendo. «Non lo troveremo mai più». «È quello che credeva mio nipote Achille. Ed è forse per questo che intendeva venderlo». Lazzari fu animato da un’improvvisa e inspiegabile premonizione. «Ma lei la pensa diversamente». «Non avevamo detto di darci del tu?». La rivelazione di essere seduto sopra la verità investì in pieno Lazzari, che balzò in piedi. «Il segreto è qui». «Non qui», disse il prete toccando uno dei libri posati sulla scrivania. Poi, sporgendosi per toccargli il petto, aggiunse: «Ma qui. Il segreto nascosto sotto il Palatino è lo stesso nascosto nell’animo di ogni uomo». «Che cosa sta cercando di dirmi?» «Che il più perfetto dei segreti è quello che ogni uomo può svelare», rispose don Vento. «Nel nome Roma si nasconde una scelta a cui tutti siamo chiamati». Si scambiarono un lungo sguardo. I manoscritti e i volumi e i libri parevano osservarli in attesa, forse di una parola. «Roma o Remoria: non è questa la domanda», provò a indovinare Lazzari. «Ma Roma o Amor? Odio o amore? È questo quello che vuole farmi credere? Che nel nome mistico di Roma il fondatore abbia celato la scelta fondamentale che spetta a ogni uomo?» fondamentale che spetta a ogni uomo?» «È una domanda a cui tutti possono e devono rispondere», disse il prete e senza lasciargli il tempo di una replica aggiunse: «Credo che tu conosca meglio di me le analogie tra la fondazione di Roma e la Pasqua». «Sì, sono numerose e innegabili, ma come giustificarle?» «O sono semplici coincidenze, oppure, come credevano Eliade, Dumézil e tanti altri grandi studiosi, la Rivelazione è una soltanto e ha riguardato tutte le civiltà fino a completarsi in Gesù, l’unica Parola pronunciata dal Padre, che continua eternamente a ripeterla. In quest’ottica Roma, la nuova Gerusalemme, ha un ruolo fondamentale, dal momento che è stata destinata a divenire sede della Chiesa universale». «Sono frastornato... Le sue parole vanno oltre il mio campo...». «E quale sarebbe il tuo campo?» «La storia». «La storia, certo, allora ascoltami. Soltanto due parole, nell’intera storia dell’Occidente, non sono mai state scritte. E tu sai sicuramente di quali parole sto parlando». «Il nome proprio di Dio, per cui è stato usato il «Il nome proprio di Dio, per cui è stato usato il tetragramma, e il nome vero di Roma», rispose Lazzari. «E chi sa che non siano la stessa». Lazzari attese qualche istante prima di replicare. «Mi sta dicendo che nel nome segreto di Roma si nasconde il vero nome di Dio?». Il prete sorrise. «L’hai detto tu». Artemisia sobbalzò quando vide il numero sul cellulare. I ricordi, il dolore intrecciato alla gioia, e anche qualcos’altro di indefinito la sommersero. «Ennio, ciao. Come stai? Non ti ho mai telefonato per ringraziarti dell’ospitalità che mi hai offerto a Milano il mese scorso». «Ma figurati, per te questo e altro. A proposito... ti sto chiamando perché qui è arrivata una cartolina indirizzata a te». «Come è possibile?» «Pensavo di domandarlo a te». «Perché dovrei saperlo?» «Magari hai lasciato questo indirizzo a qualcuno». «Mai». «Sarà, ma qui leggo il tuo cognome». «Ti è arrivata via posta?» «Dall’università di Lima, Perú. Ti dice qualcosa?» «Nulla». «Ti leggo il messaggio?» «Sì, per favore». «È firmato da un buffo nome, Antonio da Alba Docilia. Ti dice qualcosa?» «Tutto», rispose di colpo Artemisia in un sussurro appena percettibile. «Sei ancora lì?» «Leggi, ti prego», lo invitò Artemisia. «Dice così: Antonio da Alba Docilia, mistico medievale, nato ad Alba Docilia nell’anno domini 973, non ha più paura». «Non dice altro?» «Niente. Ho controllato, per curiosità: non è mai esistito un mistico medievale con quel nome». Artemisia piangeva. Il nome non lo aveva mai pronunciato, ma il cognome sì – e aveva di nuovo voglia di pronunciarlo. E non solo. Antonio da Alba Docilia... Come aveva fatto a non capirlo prima? Con frenesia tirò fuori dalla borsa un foglio e una penna e scrisse come se fosse questione di vita o di morte il cognome Lazzari e poi, a fianco, il nome Antonio. «Ora esiste», disse. Una lacrima le inumidì il labbro e «Ora esiste», disse. Una lacrima le inumidì il labbro e lei accennò un sorriso. «...E io andrò a conoscerlo».
Scaricare