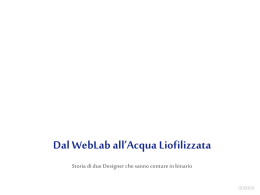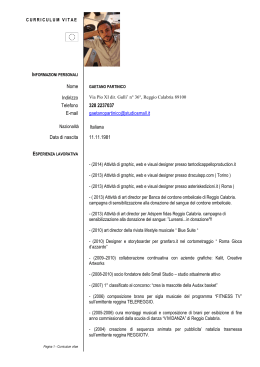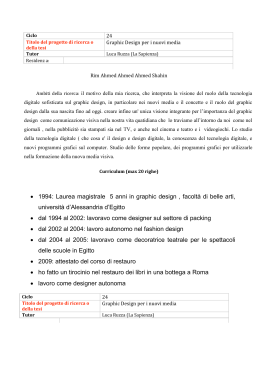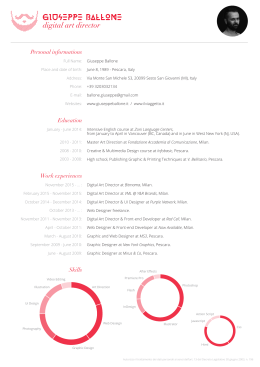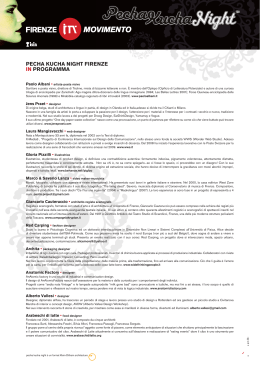Designerism Designerism Graphic design, un’identità frammentaria tra reti, professionalismo e autorappresentazione Emanuele Luppino 767685 relatore Professor Mauro Panzeri Politenico di Milano, Scuola del Design Laurea Magistrale in Design della Comunicazione aa 2013/2014 Designerism. Graphic design, un’identità frammentaria tra reti, professionalismo e autorappresentazione Emanuele Luppino, 2015 Tesi di Laurea Magistrale in Design della Comunicazione Relatore Professor Mauro Panzeri Politecnico di Milano, Scuola del design anno accademico 2013/2014 I testi di questo volume sono composti in Monotype Grotesque (Frank H. Pierpont / Monotype, 1926) e Replica Mono (Norm / Lineto, 2008). Premessa 12 — 20 0.1 Origini 14 0.2 Habitat 18 Prima parte. Una traiettoria nel graphic design 23 — 93 1.1 Istruzione 28 Le diverse facce della digitalizzazione / Dove volgere lo sguardo? / Cosa serve sapere 1.2 Dalla scuola al lavoro 39 Il tirocinio: free labour o necessità? 1.3 Cosa succede nel Regno Unito caso studio 43 Carrotworkers Collective 1.4 Configurazioni del lavoro 52 Il lavoro subordinato / Come cambia il lavoro parasubordinato / Contratti speciali: l’associazione in partecipazione / Senza contratto: il lavoro occasionale 1.5 La scelta del lavoro autonomo Le collaborazioni con partita Previdenza autonoma 59 iva / 1.6 Verso una profilazione delle nuove professioni 65 1.7 Rappresentanza 68 Il ruolo di aiap / Accesso ad aiap / Attestazione del singolo professionista / Intervista a Daniela Piscitelli 1.8 Compensi 78 Dumping / #Rivoluzionecreativa e #coglioneNO, due iniziative online 1.9 Il valore intrinseco della creatività 92 1.10 Conclusioni 93 Seconda parte. La percezione identitaria di una professione creativa 2.1 Mediatori culturali 97 — 151 101 La definizione di Matt Soar 2.2 La classe creativa 103 Tra imprenditoria e ideologia della creatività 2.3 Soggettivazione Il piacere del lavoro / Un processo biopolitico 106 2.4 Vulnerabilità, seduzione e desiderio 109 L’attrazione fatale della creatività 2.5 Pratiche critiche 114 Designing Economic Cultures / Ricercare per trasformare le pratiche e le soggettività / Concetti come utensili: tempo, innovazione, frammentazione caso studio 2.6 Identità e rappresentanza 127 Rappresentazione della moltitudine 2.7 Risorse 131 Scambio e prossimità come strumenti di cura reciproca 2.8 Economie sperimentali 134 Cantiere per pratiche non affermative / Co–working ≠ co–living caso studio 2.9 Sul campo 140 Una nuova cultura progettuale / Rilevanze 2.10 Conclusioni 151 Bibliografia 153 Indice delle figure / Indice delle tavole 159 10 — 11 È una professione in continua crescita, che permette un’evoluzione personale i cui confini si muovono alla velocità delle connessioni raggiungibili nel mondo digitale. La visibilità potenzialmente ottenibile da ogni singolo progettista è illimitata e lo scambio di esperienze e conoscenza tra i designer non è mai stato così intenso. Questa tesi coglie il momento opportuno per proporre una riflessione sul lavoro dei progettisti, per riscoprire la natura della professione e comprenderne la centralità nei processi produttivi. Posizionando le pratiche del graphic design nella mappa estesa del mondo del lavoro, per analizzare i modi di produzione e mettere in discussione ciò che troppo spesso è accettato in modo acritico. Premessa La transizione che sta percorrendo il mondo delle professioni negli ultimi mesi è inscritta in un momento storico nel quale la crisi finanziaria ha inciso non solo sulla frammentazione delle figure e dei rapporti ma anche sulla stessa coscienza del lavoro professionale. L’evoluzione del graphic designer, all’interno di una tale transizione, porta questa figura professionale multisfaccettata ad avvicinare le proprie traiettorie lavorative a quelle di molti altri soggetti del terziario avanzato, a condividerne gli strumenti e le sorti. Stabilire i confini del campo dei lavoratori della classe creativa, l’aggregato al cui interno possiamo includere le pratiche del design, è oggi in primo luogo una questione semantica: si tratta di un perimetro sovrapponibile ad altri definiti via via come «lavoratori della conoscenza», «networker», «lavoratori autonomi di seconda generazione», «capitalisti personali» eccetera.[1] Se è vero che le statistiche sulle professioni, basate sui canoni obsoleti delle professioni liberali, falliscono nel momento in cui provano a profilare le identità lavorative di più recente creazione, quando si tenta di fare luce sul segmento più specifico del design ci si imbatte inevitabilmente nella selva nota ai più come riconoscimento professionale. Trattare di creatività e delle sue implicazioni con il lavoro equivale a dover fare i conti con il mito creato nel decennio scorso sia da autori sia da direttive comunitarie europee[2] rispetto al suo conflitto con le logiche dei compensi. Significa porre l’attenzione su quei modelli «positivi» [1] [3] cfr. Consorzio AAster, Vecchie e nuove professioni a Milano: monadi, corporazioni o terzo stato in cerca di rappresentanza?, Milano 2011, pp. 15–17. [2] mi riferisco al testo del sociologo americano Richard Florida L’ascesa della nuova classe creativa. Stile di vita, valori e professioni, Mondadori, Milano 2003; e all’Incontro tra i capi di stato e di governo europei di Lisbona del 2000, di cui allo studio L’Economia della Cultura in Europa, a cura del Centro Studi di Diritto delle Arti, del Turismo e del Paesaggio, http:// www.dirittodellearti.it/public/SINTESI.pdf (consultato l’ultima volta il 10 marzo 2015). 12 — 13 che combinano «autoimprenditoria, coinvolgimento personale, senso di sfida, disponibilità a mettere a disposizione il capitale umano generico e biografico»[3] e che per mezzo delle culture progettuali stanno riconfigurando le coordinate del consumo, della cittadinanza e della socialità. Ancor di più, vuol dire analizzare il difficoltoso rapporto che intercorre tra l’individualismo del progettista, alimentato dalle dinamiche competitive peculiari del settore, e la propensione cooperativa che anima i network. Proprio in questi ultimi si rintraccia una possibile ma sempre fuori fuoco dimensione di (auto)percezione collettiva. Legittimabile, quest’ultima, da un certo grado di appartenenza e un’antropologia fatta di persone con interessi e comportamenti molto simili, che trovano nelle reti relazionali i nuovi luoghi di associazione e composizione identitaria. 0.1 O rigini «Il modo per accedere alla verità di un sistema (della società, della psiche) passa necessariamente come una distorsione marginale e accidentale “patologica di questo sistema”: lapsus, sogni, sintomi, crisi economiche»[4] —Slavoj Žižek Sebbene il mestiere del grafico trovi le sue origini nella seconda metà del diciannovesimo secolo, con le profonde innovazioni che trasformarono l’universo tecnologico legato alla stampa, la storia del lavoro creativo per come lo conosciamo oggi ha inizio intorno alla metà degli anni Settanta del Novecento, quando la produzione materiale inizia a cedere il passo alla produzione simbolica. Centrali nel cambiamento paradigmatico che è seguito alla fine dell’era fordista-industriale — l’epoca della produzione standardizzata, della catena di montaggio, della materialità dei beni prodotti in serie — sono le nuove dinamiche Pr e m e s s a di downsizing, esternalizzazione e delocalizzazione. La produzione materiale per le grandi imprese, anche grazie alle innovazioni riguardanti la fase di circolazione delle merci (tecnologie dei trasporti), si parcellizza e si delega a reticoli di soggetti minori o si sposta talvolta totalmente in altri continenti, mentre le fasi di ricerca e sviluppo e di diffusione del brand divengono il core business delle aziende. Il valore simbolico della merce assume una posizione egemone. Carlo Vercellone e Antonio Negri definiscono due «stilemi» che hanno alterato le convenzioni fordiste. Innanzitutto il passaggio storico per cui la parte di capitale intangibile (educazione, formazione, sanità, ricerca) diviene fattore principale della crescita, mettendo il capitale tangibile in posizione subordinata. Secondariamente, le capacità di apprendimento, innovazione e adattamento quali condizioni centrali dell’efficacia produttiva rispetto a un passato in cui contavano i tempi di svolgimento delle mansioni. I nuovi cardini della configurazione capitalistica sono dunque la «merce conoscenza»[5] e lo spazio virtuale e geografico di network territoriali della produzione esternalizzata. Contestualmente, la finanza diviene l’ambito privilegiato della valorizzazione dell’impresa capitalistica. Sono queste le condizioni del paradigma definito da molti «capitalismo cognitivo»[6] ed è qui che emerge la figura del lavoratore autonomo: colui che pone su di sé il rischio imprenditoriale in un atto di autodeterminazione e rifiuto del lavoro di routine. Punto d’incontro tra le nuove condizioni di flessibilità imposte [4] Slavoj Žižek, Dalla tragedia alla farsa, Ponte alle Grazie, Milano 2010, p. 23. [5] Antonio Negri e Carlo Vercellone, “Il rapporto capitale/lavoro nel capitalismo cognitivo”, http://halshs.archives-ouvertes.fr/ halshs-00264147, 17 marzo 2014. [6] cfr. Andrea Fumagalli, “Trasfor- mazione del lavoro e trasformazioni del welfare: precarietà e welfare del comune (commonfare) in Europa”, http://www.uninomade.org/ trasformazione-del-lavoro-e-trasformazioni-del-welfare-precarieta-e-welfare-del-comune-commonfare-in-europa/, 15 novembre 2013. 14 — 15 dalla nuova fase capitalistica e il desiderio di un maggiore controllo sul proprio lavoro e sul proprio tempo, egli colleziona esperienze destreggiandosi in un percorso oggi dissestato dalla perenne «flexploitation».[7] La letteratura dei territori comuni tra sociologia del lavoro, filosofia, psicologia sociale degli ultimi anni ha teorizzato di come il reale delle nostre vite cammini su un suolo — o, se preferite, sia sovrastato da un cielo — che via via ha preso il nome di capitalismo cognitivo, economia del simbolico, economia della conoscenza, biocapitalismo.[8] Ciò che accomuna le varie definizioni del paradigma produttivo attuale è ciò che Aldo Bonomi riprendendo un’intuizione di Michel Foucault[9] ha eloquentemente indicato come «la messa al lavoro della nuda vita»: Nuda vita che significa essenzialmente cinque cose: il nostro pensare, il nostro avere memoria, il nostro comunicare, il nostro parlare, il nostro riprodurci. Nuda vita vuol dunque dire che esiste un emisfero dove i processi in cui siamo messi al lavoro sono quelli dove esercitiamo ogni giorno il nostro sentire, il nostro comunicare, da una parte, e dall’altra il nostro bios, la nostra sessualità, la nostra capacità riproduttiva.[10] Il corpo dentro cui è contenuto il cervello sociale è quello del lavoratore cognitivo, la cui storia inizia con [7] cfr. Grieg de Peuter, “Creative Economy and Labor Precarity: A Contested Convergence”, in Journal of Communication Inquiry 35, http://culturalworkersorganize.files.wordpress.com/2012/09/de-peuter_creative-economy-and-lab o u r - p r e c a r i t y - d r a g g e d . p d f, 23 agosto 2014. [8] cfr. Vanni Codeluppi, Il biocapitalismo. Verso lo sfruttamento integrale di corpi, cervelli ed emozioni, Bollati Boringhieri, Torino 2008, p. 22. [9] [10] cfr. Aldo Bonomi e Eugenio Borgna, Elogio della depressione, Einaudi, Torino 2011, pp. 16–19. Pr e m e s s a una crisi produttiva e giunge alla crisi finanziaria degli ultimi anni. La prima, nel corso degli anni Settanta, ha messo in discussione il paradigma produttivo fordista e portato alla sperimentazione di alternative di accumulazione sempre più flessibili; la seconda, che fa da sfondo ai nostri giorni, è forse la combinazione estrema del processo di deregolazione cui la prima ha dato inizio.[11] Col diffondersi in era postfordista di nuove tecnologie di linguaggio e comunicazione, gli strumenti del capitale divengono «le componenti immateriali dell’essere umano, come i processi mentali, le immaginazioni e le visioni del mondo».[12] La produzione di valore si basa adesso sugli elementi che discendono direttamente dall’utilizzo delle facoltà «relazionali, emozionali e cerebrali» degli esseri umani.[13] Uscita dalla fabbrica, la fonte del valore economico e del progresso tecnico giace all’interno della società nel suo complesso: i meccanismi di generazione del valore si estendono «a tutto il tempo e lo spazio sociali».[14] Come risultato diretto di questa trasformazione, il lavoratore manuale del passato, privo dei mezzi di produzione, è stato sostituito da un lavoratore che invece possiede il suo principale strumento di lavoro: la conoscenza, che lo ha reso autonomo e imprenditore di sé stesso. [11] cfr. Andrea Fumagalli, “Le trasformazioni del sistema capitalistico e le nuove contraddizioni sociali”, http://www.aiccon.it/file/ Le_trasformazioni_del_sistema_capitalistico, 18 febbraio 2014. [12] [14] Codeluppi 2008 (op. cit.), p. 23. [13] Andrea Fumagalli, “Trasfor- mazione del lavoro e trasformazioni del welfare: precarietà e welfare del comune (commonfare) in Europa”, http://www.uninomade.org/ trasformazione-del-lavoro-e-trasformazioni-del-welfare-precarieta-e-welfare-del-comune-commonfare-in-europa/, 15 novembre 2013. 16 — 17 0.2 H abita t La graduale individualizzazione dei lavoratori cognitivi, propria delle politiche di soggettivizzazione, ha fondato l’esistenza del cognitariato sul lavoro autonomo. L’avanzamento tecnologico ha fornito la struttura dentro cui operare, una fabbrica di tipo nuovo: la rete. Intelletti–nodi di un tessuto i cui fili corrispondono ai canali nei quali scorrono le informazioni, gli individui entrano in relazione per compatibilità connettiva.[15] Sergio Bologna ha compiuto un articolato percorso sulle strade del lavoro indipendente, raccontato tra le pagine di un libro scritto assieme a Dario Banfi. Vita da freelance apre la narrazione descrivendo proprio lo scenario d’azione prediletto del lavoratore autonomo, questa rete in cui quest’ultimo attua la «migrazione virtuale»: verso una «propria Atlantide»[16] i cui confini sono i limiti delle proprie conoscenze e inclinazioni. La rete che è lo strumento principale per attuare la scelta del lavoro indipendente: una scelta fatta per vivere meglio, per organizzare con maggiore autonomia l’attività che occupa la quantità maggiore del tempo della vita e che permette di sopravvivere. Ma la rete è anche ormai il luogo della dimensione sociale e della conoscenza condivisa, dove acquisire nuovo sapere, scardinare sistemi di accumulazione e portare avanti istanze comunitarie, di coalizione. Le tecnologie sono gli «ammortizzatori professionali»[17] dei rischi che derivano dall’autonomia. Gli ambienti virtuali di scambio aperti e flessibili costituiscono quegli «anticorpi»[18] con cui la società dei lavoratori della conoscenza può far [15] L’idea del tessuto di fili appartiene al noto filosofo Vilém Flusser, esplicitata nel saggio La cultura dei media, edito in Italia da Bruno Mondadori. [16] [17] [18] [19] Sergio Bologna e Dario Banfi, Vita da freelance. I lavoratori della conoscenza e il loro futuro, Feltrinelli, Milano 2011, pp. 38–39. Pr e m e s s a fronte al sistema del «rischio a responsabilità diffusa» che caratterizza il lavoro autonomo.[19] La rete da un lato allarga le distanze tra progettisti e datori di lavoro, riconfigurando e riplasmando i rapporti lavorativi e i segmenti di produzione; dall’altro è anche l’oceano cosparso da quelle piattaforme che le distanze le accorciano, permettendo al designer di far conoscere le proprie capacità e i propri artefatti a un numero smisurato di potenziali committenti. È il nuovo campo di forze in cui poter creare nuove sinergie ed è la platea che può valutare e anche finanziare quelle idee e quei progetti che in assenza di corposi budget rimarrebbero tali. Le pratiche collaborative online possono aiutare le schiere di professionisti a superare il tradizionale ostacolo della differenziazione propria delle professioni intellettuali, delle identità cioè costruite sulle differenze nel nome di un’etica del successo e per questo poco inclini a un’idea di coesione sociale. La collaborazione ampiamente diffusa nei network online ha già dato prova di ricreare le condizioni per quelle pratiche alternative il cui egualitarismo di fondo muove in direzione opposta rispetto alle ideologie del professionalismo, dei saperi taciti ed esclusivi. La creative economy che cresce e si evolve tra i nodi della rete produce indubbiamente flessibilità precarizzante, ma può costruire laboratori di ricomposizione proprio a partire dai suoi protagonisti. Lavoratori autonomi, knowledge workers, creativi, da intendere in questa tesi come sinonimi alla stregua della definizione strategica di cultural producers che Isabell Lorey[20] propone in un prezioso articolo pubblicato dall’European Institute for Progressive Cultural Policies. È una concettualizzazione [20] Isabell Lorey, “Governmentality and Self Precarization. On the normalization of cultural producers”, http://eipcp.net/transversal/1106/ lorey/en, 21 gennaio 2014. 18 — 19 che allarga trasversalmente i confini rispetto alle letterature riguardanti il lavoro nell’industria culturale e la critica del labor of art, includendo aspetti quali condizioni di lavoro sottopagato o gratuito, produzione teorica, self-organization politica e culturale, nuove economie sperimentali. Il design, in questi territori, è la regione che parla i linguaggi più innovativi e fornisce narrazioni tra le più simboliche, poiché, da un lato, proprio il quid immateriale portato dal design ha trasformato le imprese, le ha condotte a differenziarsi, a costruire un nuovo valore per le merci prodotte; dall’altro, i designer sono tra gli attori principali di una nuova trasformazione dei consumi, guidata dalle relazioni di scambio che si alimentano nella rete. È qui che potranno costruire una dimensione intermedia tra le istituzioni e il frammentato universo delle professionalità creative. Pr e m e s s a 20 — 21 Pr ima parte Dedizione e tensione verso uno scopo sono i caratteri principali di una professione che ha sviluppato nel tempo una propria forma mentis, un modo sui generis di concepire e attuare il lavoro. È un mestiere che ha affrontato le sfide poste dal lavoro flessibile ai lavoratori del terziario avanzato: evolvendosi e reinventandosi col cambiamento dei modi di produzione, trasferendo le proprie coordinate nelle nuove cartografie digitali. Ma è anche una professione ancora difficilmente riconosciuta, che pone ai praticanti interrogativi continui e non gode di grandi tutele. Descrivere una carriera nel graphic design significa raccontare le contraddizioni di una figura prestigiosa, singolare e spesso sottopagata. Una traiett oria nel g raphic d e si g n «Siamo le ruote dell’ingranaggio di una società sempre più modularizzata e, nel contempo, siamo noi stessi che moduliamo, che ci moduliamo e moduliamo il mondo che ci circonda. Il modo della modulazione comprende sia un processo di schematizzazione, di standardizzazione, di modularizzazione, un movimento assiduo di ri–forma e de–formazione del sé.»[1] —Gerald Raunig La storia di alcune professioni passa attraverso le innovazioni tecnologiche che ne segnano le ere. Quella del graphic design è fatta di cambi improvvisi, reazioni e adattamenti, nelle sue molteplici ramificazioni lungo un sentiero che si è evoluto attraverso le tecniche di stampa, la tipografia, l’advertising e l’illustrazione, subendo e reagendo all’introduzione del computer, passando per il web e la computer grafica e giungendo alle frontiere dell’interaction design e della realtà aumentata. Un percorso fatto di molti percorsi, in cui gli avanzamenti tecnologici han fatto da sfondo all’emergere di diversi modi di intendere e praticare il progetto grafico. La sua pratica è un esempio estremamente interessante della sfida che la flessibilità del lavoro ha posto e pone tuttora alle singole professioni. Non è una sfida semplice quella dei soggetti creativi impegnati a progettare comunicazione visiva, seppur nel momento storico in cui l’importanza della disciplina è finalmente riconosciuta come portatrice di conoscenza al livello più democratico — si pensi alla crescita d’importanza esponenziale del visual journalism negli ultimi anni. Si tratta di una professione che, perlomeno in Italia, non ha ancora completato il suo sviluppo: se volessimo confrontare lo status del mestiere di graphic designer con i quattro marker principali per lo sviluppo di una professione proposti da Ellen Mazur Thomson[2] [1] Gerald Raunig, Fabbriche del sapere, industrie della creatività, Ombre corte, Verona 2012, p. 35. [2] Ellen Mazur Thomson, The Origins of Graphic Design in America 1870-1920, Yale Univ. Press, Boston 1997, p. 57. 24 — 25 nella sua ricerca sull’aspetto socioeconomico della pratica, dovremmo riconoscere che in relazione alla «governmental regulation» c’è ancora un vuoto, coperto solo parzialmente » vedi 1.6 dalla recente Legge sulle professioni non regolamentate. Proveremo a entrare nel campo relazionale del graphic design costituito da scuole, associazioni, professionisti, dinamiche produttive, sempre assumendo il punto di vista del singolo progettista in corsa verso il riconoscimento di uno status. Noteremo come sia possibile attualizzare nel mondo del progetto grafico le narrazioni di Richard Sennett[3] sulla flessibilità lavorativa: in un territorio dai confini incerti che aprono verso opportunità sempre variabili, le costanti sono la dedizione con cui si affrontano le pratiche progettuali e la tensione verso uno scopo che anima e accomuna i progettisti. Fortificati dall’ambizione di farlo con la propria cifra stilistica, sia essa avvalorata da una profonda componente concettuale o affinata da un alto grado tecnico, essi manifestano quel committment le cui caratteristiche sono riscontrabili nell’accezione di «Beruf» utilizzata da Max Weber: passione, vocazione, dedizione a un’idea di progresso, desiderio di innovazione.[4] È utile e propedeutico allo svolgimento di questa narrazione partire da una chiave di lettura fondamentale. Nel suo libro Cos’è un designer scritto nel 1969 e divenuto un classico, Norman Potter descrive la pratica del design come presenza attiva e centrale di un campo dialogico: Il lavoro del designer può essere descritto come l’utilizzo delle risorse di un particolare linguaggio reso comprensibile attraverso gli equivalenti non verbali di intenzione, stile, senso e struttura […][5] [3] Richard Sennett, L’uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale, Feltrinelli, Milano 1999, p. 28. [4] Max Weber, Schriften 1894-1922, Kröner, Stuttgart 2002, passim. [5] Norman Potter, Cos’è un designer, Codice edizioni, Torino 2010, p. 30. U na t ra ie t t o r i a n e l g r a ph i c d e s i g n Matt Soar definisce i graphic designer quali «mediatori culturali»[6] e questa è una definizione i cui significati sono decisamente stratificati, se presa in esame alla luce dell’analisi di Potter o dopo aver passato in rassegna una giornata di lavoro tipica in uno studio di progettisti. Al di là del grafico in quanto artigiano, nel XX secolo il rapporto che lega la maggior parte dei graphic designer al segmento produttivo dei propri artefatti avviene per via indiretta, passando attraverso l’intermediazione del lavoro di altri fornitori, produttori o esecutori materiali. Ancora oggi, in diversi settori del design, il progettista nel suo lavoro definisce fondamentalmente delle istruzioni da fornire a diversi soggetti in modo da porli nelle condizioni migliori per realizzare e reificare le proprie idee progettuali. Con la digitalizzazione, le caratteristiche del progetto grafico son cambiate ancora una volta: la distanza tra i contenuti formali e la loro presentazione visiva si è assottigliata, l’elemento concettuale è entrato all’interno del codice verbale — si pensi alla complessità di certe interfacce web. Il numero di legami relazionali del processo produttivo si è moltiplicato: la convergenza digitale ha permesso un lavoro in team strutturati, nei quali le diverse competenze concorrono a un obiettivo ben più grande del riconoscimento dei singoli. Essere in grado di orientarsi in questo universo presuppone competenze che prima di essere affinate sul campo vengono sviluppate negli anni della formazione. [6] Matt Soar, Graphic Design / Graphic dissent: towards a cultural economy of an insular profession, tesi di laurea in Filosofia pres- so la University of Massachussetts, Amherst 2002, passim. 26 — 27 1.1 Istruz ione Nelle economie postfordiste la dimensione della conoscenza non si esaurisce nel percorso formativo scolastico, poiché formazione e lavoro si uniscono nelle traiettorie professionali e di vita in un legame che inizia negli anni universitari. Nei settori creativi, soprattutto, le istituzioni universitarie tendono a trasformarsi in luoghi «immediatamente produttivi»: sia perché sono i soggetti incaricati a coltivare quelle soggettività che alimenteranno i meccanismi di accumulazione capitalistica, sia perché sono inseriti direttamente nei circuiti della produzione. Una carriera da graphic designer è lo sviluppo professionale di un percorso approfondito di studi, è il risultato di una educazione al progetto che esplora l’universo dei significati e scopre gli alfabeti visivi, le forze spaziali e le teorie percettive, le convenzioni cromatiche e culturali, i software e i media, le estetiche e le tecniche di stampa. Il design grafico cattura l’attenzione, identifica, persuade, vende, istruisce, educa e gratifica l’occhio. Progettare ha aspetti sociali, estetici, pratici: si comprende allora come il progettista grafico debba necessariamente essere un attore sociale culturalmente avanzato, tecnicamente esperto e aggiornato sul piano tecnologico. Negli ultimi trent’anni, in Italia, l’attenzione posta allo sviluppo di percorsi di studio specifici è cresciuta in maniera esponenziale, dimostrando la necessità di un asset formativo e teorico riconosciuto sempre più anche dal mercato. L’evoluzione della disciplina attraverso le facoltà dedicate al design ha contribuito ad ampliare la diffusione del graphic design, innalzando il livello della pratica progettuale e quello degli insegnanti/formatori. U na t ra ie t t o r i a n e l g r a ph i c d e s i g n Il termine graphic designer fu coniato nel 1922 da W.A. Dwiggins in un articolo in cui introduceva questa figura di «artista commerciale» in risposta alle necessità di nuove forme di advertising per le grandi aziende del suo tempo. Dagli anni Cinquanta il terreno semantico si è steso fino a includere lemmi quali visual communicator, visual designer, communication specialist/consultant, a testimoniare sia la volontà dei progettisti di essere maggiormente riconosciuti in ambito aziendale, che la crescita e la specializzazione della professione.[7] Oggi il carattere crossmediale della cultura progettuale fa sì che le competenze della comunicazione visiva possano includere incursioni in ambiti cinematografici, architettonici, manageriali, di curatela artistica e editoriale. Ellen Lupton, Jim Heimann, Stefan Sagmeister, Lars Müller, Leonardo Sonnoli sono esempi calzanti di carriere che più che grandi definiremmo estese, a testimonianza delle enormi opportunità aperte a chi riesce a cogliere nel lavoro creativo uno strumento per essere protagonista culturale del proprio tempo. Si tratta tuttavia di una cerchia elitaria di (ex)progettisti, figure autorevoli riconosciute e che perciò costituiscono facili idolatrie agli occhi del folto esercito di designer sottoposti. La figura di graphic designer si costruisce negli anni accademici, a fronte di una formazione specializzata e costi talvolta anche molto elevati. La didattica nelle scuole più o meno specializzate in graphic design — in Italia si studia design della comunicazione visiva negli atenei più strutturati; graphic design, grafica editoriale, grafica d’arte, tipografia nelle scuole più piccole e specializzate — ha ereditato l’impostazione bauhausiana di arte come scienza applicata. Nei primi anni è previsto uno studio dedicato all’acquisizione degli strumenti di basic design (disegno, teoria del colore, studio di materiali) e di cultura dell’immagine fotografica [7] cfr. Steven Heller e Teresa Fernandes, Becoming a Graphic Desi- gner. A Guide to Careers in Design, John Wiley & Sons, Hoboken 2010, p. 311–12 28 — 29 e cinematografica oltre che di teoria della comunicazione, sebbene sin da subito gli studenti vengono immersi in campi applicativi in cui simulare la pratica professionale, attraverso laboratori intensivi in cui far crescere parallelamente le capacità progettuali e anche il background concettuale. Lo scambio di conoscenze tra gli stessi studenti, nei ritmi serrati delle attività laboratoriali, aggiunge quel valore condiviso che segna spesso indelebilmente molte biografie professionali. L’inizio di un percorso formativo inerente al design presuppone un’attitudine creativa da incanalare con l’esperienza accademica verso l’acquisizione di un metodo tale da aiutare il futuro designer a viaggiare nei sentieri della progettualità conoscendo già dal principio del proprio cammino gli ostacoli maggiori che s’incontreranno, con un approccio mirato a ridurre al minimo lo spreco di energie disponibili. L’educazione al design prevede lo sviluppo di un approccio da interprete e problem-solver ai segmenti di realtà su cui si opera. Quest’impostazione è entrata nella cultura del design negli anni Sessanta, assieme alle teorie semiotiche, alla filosofia strutturalista, alla critica culturale, alla teoria del cinema e al postmodernismo. Proprio grazie a questi tumulti culturali la grafica è riuscita ad affiancare alla dimensione estetica un’attitudine non-affermativa, divenendo una disciplina che permette di interrogare la realtà e le convenzioni, di conoscere in profondità i meccanismi di produzione economica. Pratiche condivise come il brainstorming e le varie attività analitiche sono entrate a far parte delle abitudini dei designer proprio per via di questi innesti profondi. Il graphic design, storicamente conteso tra arte e scienza applicata, è divenuto l’oggetto di studio di critici e teorici che ne hanno portato alla luce il carattere linguistico. La grafica, per come oggi è concepita, comunica su livelli e profondità diverse: l’espressione personale può arricchire la comprensione di grandi quantità di informazioni oggettive (dati) oggi disponibili, ed entrambe possono stratificare i significati per stimolare pubblici eterogenei. Ci troviamo nel momento esatto in cui il graphic U na t ra ie t t o r i a n e l g r a ph i c d e s i g n designer deve svolgere un ruolo umano in un universo digitalizzato. Katherine McCoy, progettista e insegnante, co–direttrice per ventiquattro anni del programma educativo in design presso la Cranbrook Academy of Art del Michigan e poi ancora insegnante presso il Royal College di Londra, nel suo contributo al volume The Education of a Graphic Designer di Steven Heller — testo che ha aggiornato a metà degli anni Duemila il dibattito sulla formazione nel design di stampo anglosassone — ha scritto: il punto di vista e le forme interpretative del designer potranno essere gli elemento umanizzante essenziale a rendere le grandi quantità di dati astratti significativi, utili, comprensibili e coinvolgenti per i nostri pubblici.[8] Le diverse facce della digitalizzazione L’avvento dei software dedicati alla grafica ha battezzato una nuova era per le arti visive. A detta di molti ciò ha reso decisamente più democratico l’accesso alle arti grafiche, certamente ha dilatato a dismisura le possibilità aperte nel campo della comunicazione visiva, così come le specializzazioni al suo interno. Per quanto concerne l’educazione al graphic design, lo shift tecnologico ha riscritto le coordinate della formazione, inserendosi prepotentemente nelle dinamiche che hanno portato l’insegnamento accademico a una svolta pluralistica e pragmatistica. Le attività legate alle tecniche tradizionali hanno pian piano fatto sempre più spazio all’insegnamento di software per l’illustrazione, l’impaginazione e la composizione tipografica, il montaggio, l’animazione e la grafica in movimento. Gli strumenti sono diventati tool, su scrivanie [8] Katherine McCoy, “Education in an Adolescent Profession”, in Steven Heller, The Education of a Graphic Designer, Allworth Press, New York 2005, pp. 4-5 (mia traduzione). 30 — 31 virtuali in cui il passaggio da un aerografo a un compasso avviene nello spazio tra un dito e l’altro, tra un pollice e l’altro. L’impatto delle tecnologie sull’apprendimento del graphic design ha rischiato di stravolgere del tutto l’approccio alla disciplina, poiché l’introduzione dei software di desktop publishing ha sottinteso uno sforzo nell’adattamento alle nuove condizioni che si è tradotto nel dedicare molta parte dei programmi formativi all’acquisizione delle tecniche digitali. Meno concettualizzazione e più produzione sembrava essere il nuovo dogma implicitamente adottato da molti entusiasti della prima ora, distratti com’erano dal nuovo enorme carico di skill tecnologiche da assimilare. In nome di un’istantaneità — questo il carattere principale del cambiamento — che sovvertiva quei principi dell’educazione modernista che vedevano nella ripetizione la via per il miglioramento personale e che erano un’eredità del modello di «education through imitation» che aveva animato le scuole tradizionali di belle arti.[9] Ma è probabile allo stesso modo che questi stessi entusiasti tra educatori e professionisti proiettassero le proprie visioni in un futuro in cui la convergenza tecnologica avrebbe magnificato la figura del designer: il potenziale che vedevano nella digitalizzazione ne avrebbe elevato le abilità e la conoscenza a un grado mai raggiunto prima. A ciò si aggiungeva la paura che la professione o l’utilità del graphic design tradizionale potesse essere spazzata via. Di certo, l’equilibrio tra chi chiedeva una formazione più generica e culturalmente allargata per i designer del XXI secolo e chi vedeva nella specializzazione delle competenze digitali la chiave per il futuro si è con ogni probabilità sbilanciato a favore di questi ultimi.[10] [9] McCoy in Heller 2005 (op. cit.), p. 5. [10] cfr. Lorrayne Wild, “That was then and this is now: but what is next?”, in Emigre, n. 39, 1996, consultato online all’archivio http:// www.emigre.com/Editorial.php?sect=1&id=18, 13 marzo 2015. U na t ra ie t t o r i a n e l g r a ph i c d e s i g n Dove volgere lo sguardo? L’estrema attenzione posta all’apprendimento delle tecniche digitali sembra un fatto ovvio e indiscutibile ma a ben guardare i più giovani, la crescita dei software e la velocità d’apprendimento possono avere effetti drammatici. Il confronto tra classi d’età immediatamente vicine parla sempre a favore dei neo-immatricolati; le differenze d’approccio, se non addirittura nella tecnica, che prima si stagliavano nello spazio di un decennio, oggi dividono studenti nati a distanza di qualche anno. La domanda sorge spontanea: ma davvero il requisito fondamentale per i graphic designer nell’era dell’istantaneità e dell’ubiquità virtuale è un corposo indottrinamento tecnologico? Scrive Potter: È sbagliato pensare che il design di qualità (o il pensiero creativo di qualsiasi genere) dipenda da un ambiente perfettamente attrezzato: gran parte della professione può essere affrontata con freschezza e intuizione disponendo di un minimo di attrezzature e materiali. Il fatto che si lasci invece intendere l’opposto (considerandolo come la condizione ideale di partenza) riflette unicamente un clima sociale in cui il minimo significato emerge da un grande sperpero di sforzi e mezzi.[11] Siamo giunti al momento in cui la grafica può parlare tutte le lingue del mondo ed essere visualizzata, letta, interpretata in tutti i continenti, affrontare più che in passato temi di importanza globale con le credenziali di una disciplina che si è ormai scrollata di dosso le catene della produzione di beni materiali, divenendo corpo critico di pratica, istruzione e teoria. Educare i graphic designer oggi significa [11] Potter 2010 (op. cit.), p. 21. 32 — 33 anche valorizzarne le sensibilità, potenziarle o farle emergere. Col moltiplicarsi dei campi di applicazione della cultura visuale, le vie sinestetiche rese percorribili dalla convergenza digitale richiedono non un’unica sensibilità, quella essenzialmente visiva, bensì l’intersezione tra attitudini diverse. Per riprendere le parole di McCoy, L’emozione, l’interpretazione soggettiva, e il gesto manuale sono i contributi umani che i sofisticati sistemi computerizzati non possono replicare. Società altamente tecnologizzate probabilmente valorizzeranno le qualità umane soggettive. […] Il design in quanto attività culturale, poiché include in sé l’espressione personale e estetica, potrebbe essere la risorsa principale di valori, emozioni e gioco di cui abbiamo tutti bisogno nel dominio digitale.[12] Se c’è un aspetto delle trasformazioni introdotte dalla rivoluzione tecnologica che metterebbe tutti d’accordo è quello che riguarda un’utilità più alta che il design e il contesto digitale possono condividere. Come suggerisce la designer, insegnante e curatrice Meredith Davis, le tecnologie possono aiutare i designer a portare più facilmente il discorso sulla progettualità al livello dei sistemi, ovvero al più alto dei gradi su cui il design può operare.[13] Potremmo lasciare da parte il design di singoli output, per ragionare ad esempio sulle conseguenze su larga scala della produzione degli stessi. Potremmo riflettere sulle controversie del nostro tempo con l’attendibilità data da una conoscenza nuova, in grado di investigare la realtà attraverso l’uso di particelle di virtualità. Questa diversa prospettiva è già stata condivisa in alcuni atenei, nei quali [12] McCoy in Heller 2005 (op. cit.), p. 12 (mia traduzione). [13] cfr. Meredith Davis, “Raising the bar of higher education”, in Heller 2005 (op. cit), pp. 15-16. U na t ra ie t t o r i a n e l g r a ph i c d e s i g n il design della comunicazione si sta dotando degli strumenti più avanzati in grado di setacciare grandi quantità di dati, per renderli corpi unitari di conoscenza accessibile sotto forma di data visualization. Cosa serve sapere Gui Bonsiepe in un breve paper del 1993 sosteneva la necessità di ridefinire un profilo per il graphic design, alla luce dell’allora recente digitalizzazione che riconfigurava le coordinate e il raggio d’azione della professione. Nello stesso articolo stilava un elenco delle competenze necessarie alla nuova figura dell’«info-designer»:[14] - capacità di selezionare e strutturare le informazioni per costituire un «body of knowledge» coerente; - interpretare le informazioni e trasformarle in oggetti dello spazio visivo; - capacità di utilizzo dei nuovi software; - padroneggiare gli elementi costitutivi dello spazio visivo; - essere in grado di analizzare i linguaggi della «visual rethoric»; - conoscere teorie e tecniche per comunicare in modo efficace; - sviluppare la dimensione cognitiva del processo progettuale, ovvero saper fare ricerca, condurre studi accurati e maturare una certa capacità di presentare i propri progetti; - saper gestire gli aspetti legati al business della professione (gestione, management). [14] Gui Bonsiepe, “A Step Towards the Reinvention of Graphic Design”, estratto da Design Issues, n. 1, 1994, pp. 47–52. Saggio origina- riamente presentato tra le proposte discusse in un Education Project di icograda tenuto in diversi paesi dell’America Latina. 34 — 35 Alle quali aggiungeva le competenze tradizionali: - ampia formazione culturale nei campi di grafica, letteratura, arte, scienza, storia e tecnologia; - conoscenza degli aspetti professionali che potremmo definire di categoria, legati a contratti, compensi, etica professionale e codici di condotta; - conoscenza dei processi di produzione e degli impatti socio-ecologici del proprio lavoro. L’analisi di Bonsiepe, oltre a rendere definitivamente obsolete le vecchie definizioni del graphic design limitate agli aspetti tradizionali legati alla stampa, invitava a ripensare all’educazione dei futuri graphic designer dalla prospettiva dell’organizzazione autoriale delle informazioni. Non si trattava più soltanto della creazione di materiale visivo, ma della capacità richiesta ai progettisti di navigare in un universo saturo di informazioni altamente complesse. Il testo chiudeva con un elenco dei possibili contenuti di un curriculum di studi in design della comunicazione aggiornato alle proposte avanzate, tra cui psicologia della percezione, teoria del linguaggio, semiotica, retorica visiva, cultural history (arte, letteratura, design, scienza e tecnologia), storia delle comunicazioni visive, antropologia del quotidiano, teoria della comunicazione e dell’informazione, teoria e critica del design, fondamenti di programmazione e computer science, matematica applicata. Oggi il graphic design è un campo quanto mai ibrido. Le spinte tech portano i designer verso territori sempre più legati alle interfacce di smarphone e altri device, ponendo l’elemento tecnologico innovativo in primo piano nel processo creativo. Le figure più richieste dal mercato sono quelle che si muovono tra due mondi ormai fusi tra loro: visual design e front-end development. Oltre a ciò, i progettisti devono possedere l’attitudine alla collaborazione come skill incorporata, pena l’esclusione da un mondo che è a un passo da un’accelerazione esponenziale di tecnologia disponibile. Ma c’è anche chi sostiene che sia fondamentale una più accurata formazione in storia dell’arte, che prescinda U na t ra ie t t o r i a n e l g r a ph i c d e s i g n [Grafo 1] CURVA DI ACCELERAZIONE TECNOLOGICA [14] ESPONENZIALE LINEARE 1970 1980 1990 2000 2010 2020 dagli eccessivi tecnicismi e tragga vantaggio dalle differenze, alzando il livello culturale medio delle nuove generazioni di grafici. Scrive Geert Lovink, insegnante di teoria dei media e critico della network culture, sul blog dell’Institute of Newtork Cultures: La distanza e la tensione tra tecnologia e arte nei curriculum delle facoltà applicate sono ancora presenti e il problema sembra non essere stato ancora risolto in modo adeguato. Mentre la conoscenza legata alle tecnologie e al marketing domina, la questione relativa a come integrare ‘arte’ e ‘creatività’ nei curriculum non è stata affrontata. Cosa significa formare migliaia e migliaia di ‘designers’ che non ricevono neppure la più elementare educazione al visual design, all’arte contemporanea e alla storia?[15] [15] grafo tratto da Unità di Crisi, “Identità in crisi”, INNOVeTION VALLEY, 9 settembre 2010, p. 123. [16] [17] Geert Lovink, “Some notes on the future of Communications & Media Design Degrees”, http://networkcultures.org/ geert/2013/01/28/some-notes-on-the-future-of-communication-media-design-degrees, 18 giugno 2014 (mia traduzione). 36 — 37 U na t ra ie t t o r i a n e l g r a ph i c d e s i g n — G E ERT LO V I N K [17] «Non allevate specialisti. Il rispetto per persone con competenze diverse è essenziale, accrescete la vostra conoscenza in ambito legale, diffondete il materiale di vecchi corsi, innalzate il livello generale delle lauree, praticate meno internship e cercate di fornire maggiori conoscenze agli studenti.» 1.2 Da l l a sc uol a al l av oro Il tirocinio: free labour o necessità? Che sia stata un’esperienza richiesta dal curriculum accademico, anche più di una volta, o una scelta propedeutica all’ingresso nel mondo del lavoro vero e proprio, quasi tutti coloro che svolgono un ruolo nel campo del design sono passati attraverso la fase del tirocinio. Un momento dalle caratteristiche contrastanti: impegnativo, stimolante, deludente, eccitante, deprimente. Sono questi gli aggettivi che colorano i resoconti degli stagisti, i quali troppo spesso però inseriscono anche la voce ‘non retribuito’. Una consuetudine che da un lato appare necessaria, data la consapevolezza di molti di non essere ancora all’altezza di una posizione lavorativa; e dall’altro preoccupa per il sentimento quasi di volontariato che accompagna il tirocinante nell’esperienza in studio, alimentato dalla speranza di un contratto imminente. Un’eventualità che si realizza solo in pochi casi e quasi mai con contratti a tempo indeterminato, mentre il senso di sfruttamento percepito nel corso delle ore passate in studio pare esser comune a gran parte dei tirocinanti. Le grandi città a vocazione creativa attirano queste figure in divenire spingendole a sacrifici onerosi secondo l’idea che iniziare a lavorare direttamente in un grosso centro porterà inevitabilmente ad accorciare le distanze da percorrere per giungere ai nodi importanti dei network professionali. Oltre a confermare parzialmente le idee di Richard Florida sul potere attrattivo delle città creative, gli esempi quotidiani di aspiranti designer che si spostano verso i luoghi ad alta densità di innovazione forniscono spunti di riflessione circa l’accessibilità a una professione che sembra necessariamente passare attraverso periodi di indebitamento per chi non può contare sul sostegno della propria famiglia. Lavorare nel mondo del design pone una serie di ostacoli iniziali che portano lo stagista a chiedere aiuto ai familiari, 38 — 39 o lo costringono a svolgere altre attività per sopravvivere. Dunque cos’è che spinge uno studente di design, un aspirante graphic designer, un illustratore a coltivare le proprie ambizioni nonostante le prospettive economiche così precarie? Un entusiasmo di fondo che spinge al progetto, un interesse e una curiosità che vanno oltre la gratificazione e il riconoscimento economico, oltre le condizioni di lavoro non impeccabili e l’iper–competizione, oltre la difficoltà a costruire una famiglia. Un contratto speciale Sotto questa denominazione rientra la prima forma contrattuale esperita dalla maggior parte dei lavoratori creativi: il tirocinio formativo. Concepito come propedeutico all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, necessita di una convenzione stipulata tra ente promotore (scuole, università, agenzie di recruiting, cooperative, istituzioni private no profit) e soggetto ospitante (aziende, studi, enti pubblici), che dev’essere corredata da un progetto formativo a cura del datore di lavoro. I tirocini sono regolati dalle rispettive normative regionali, ma le direttive della Legge 92/12[18] hanno permesso che la Conferenza Stato Regioni e Province autonome formalizzasse degli standard minimi uniformi in tutta Italia per «evitare un uso distorto ed illegittimo dell’istituto»[19] (come ad esempio la sostituzione nei momenti di picco di lavoratori con contratti a termine con tirocinanti) — standard che però non valgono per tirocini curriculari universitari o per praticantati delle professioni ordinistiche. [18] il testo della Legge n. 92 del 28 giugno 2012 è consultabile all’indirizzo http://www.lavoro. gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2012/20120628_L_92.pdf. [19] cfr. Ministero delle Politiche Sociali, “Tirocinio formativo e stage”, http://www.cliclavoro.gov.it/NormeContratti/Contratti/Pagine/Contratto-di-stage.aspx, 21 ottobre 2014. U na t ra ie t t o r i a n e l g r a ph i c d e s i g n Le linee guida redatte dalla Conferenza definiscono il tirocinio quale «periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro», dalla durata non superiore a sei o dodici mesi a seconda che si tratti di stage di formazione/ orientamento oppure tirocini di inserimento/reinserimento; legittimano il diritto alla sospensione dell’esperienza se è in corso una malattia lunga o una gravidanza; definiscono le attività di monitoraggio territoriale da parte dei soggetti promotori e i compiti di tutorship spettanti a una figura designata da parte del promotore e una individuata all’interno della struttura ospitante; vincolano i soggetti promotori al rilascio di un’attestazione finale di partecipazione all’esperienza formativa (con risultati e competenze acquisite) e la registrazione della stessa all’interno del Libretto formativo del cittadino; obbligano le strutture ospitanti a corrispondere un’indennità non inferiore ai trecento euro lordi mensili; impegnano il Ministero nella redazione di un report nazionale di analisi e monitoraggio e le Regioni e le Province autonome in attività di ispezione e vigilanza.[20] La strategia comunitaria “Europa 2020”,[21] infine, propone di qualificare maggiormente il tirocinio, poiché vede in esso anche uno strumento di mobilità geografica dei giovani, al punto da ritenerlo il canale preferenziale di ingresso al lavoro. A questo proposito, con la stesura della Carta Europea dei tirocini di qualità, la Commissione Europea, si sta muovendo verso l’istituzione di un contratto di tirocinio europeo quale format unico di riferimento. [20] cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri, “Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante “Linee–guida in materia di tirocini””, http://www.cliclavoro. gov.it/Normative/accordo_tiroci- » ni_24_gennaio_2013.pdf, 21 ottobre 2014. [21] cfr. Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, “Conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione”, 40 — 41 Le consultazioni della Commissione Europea evidenziano un quadro di abbassamento qualitativo delle mansioni svolte nei tirocini e di progressiva scomparsa delle componenti di apprendimento, in una tendenza generale che vede la frequente sostituzione di lavoratori retribuiti con tirocinanti. La Carta Europea per la qualità dei tirocini e degli apprendistati, voluta dall’European Youth Forum e sottoscritta dalla Presidenza del Parlamento Europeo, mira ad affermare un principio di trasparenza legato all’obbligatorietà del contratto scritto tra datore e stagista.[22] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=IT, 14 marzo 2015; e Commissione Europea, “Un quadro di qualità per i tirocini”, ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7620&langId=it, 14 marzo 2015. [22] cfr. Commissione Europea, “Proposta di raccomandazione relativa a un quadro di qualità per i tirocini”, http://eur-lex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=COM:2013:0857:FIN:IT:PDF, 14 marzo 2015. U na t ra ie t t oria ne l gra p hic d e s i g n 1. 3 C o s a s u ccede nel Regno U nit o I tre casi studio proposti in questa tesi sono esempi concreti di una tipologia di progettualità mirata a supportare quegli studenti in procinto o appena entrati tra le maglie del lavoro; a stimolare pratiche critiche all’interno del mondo professionale; a ripensare all’organizzazione del lavoro in funzione di una maggiore consapevolezza relativa alle condizioni in cui la produzione ha luogo secondo le logiche del mercato. Non si è trattato esclusivamente di casi provenienti dalla pratica del graphic design, perché esperienze come quelle analizzate in questa tesi sono contraddistinte dall’unione di intenti comuni a diversi profili appartenenti all’universo del lavoro immateriale. Il primo dei tre viene dall’Inghilterra e testimonia dello stato di cose delle professionalità creative nei settori artistici e culturali nel Regno Unito. caso studio Carrotworkers Collective Sopravvivere alla non-retribuzione Un notevole esempio di approccio critico alla forma lavorativa degli stage è l’esperimento di controguida all’esperienza da stagista realizzato dal Carrotworkers Collective, gruppo di studenti, stagisti, insegnanti, ricercatori e lavoratori dell’industria culturale d’oltremanica con base a Londra. Surviving Internships. A Counter Guide to Free Labour in the Arts è il manuale anti-sfruttamento che mette in 42 — 43 U na t ra ie t t oria ne l gra p hic d e s i g n [fig. 1] Il documento Contract for an Ethical Intership elaborato dal Collective. « discussione la necessità stessa del meccanismo dei tirocini ai fini di una posizione lavorativa dignitosa nel mondo della creatività e dell’arte. Più in generale, l’obiettivo del think tank è di far riflettere sull’impatto del lavoro scarsamente retribuito sulle condizioni di vita, sulle soggettività, sulle aspettative e sui desideri dei creativi. Lo stagista è una necessità strutturale utile a mascherare il collasso del settore culturale privato delle risorse pubbliche, sostengono al Collective. Una figura chiave della nuova economia, per il ruolo di trendsetter ma soprattutto per l’attitudine alla flessibilità e al lavoro non pagato, cosa quest’ultima che eleva in maniera più che preoccupante il lavoratore appartenente ai settori creativi a modello (negativo) da seguire per chi continua da anni a smantellare il welfare state.[23] L’esperimento si articola lungo quattro semplici quesiti (hai in mente di fare uno stage? Stai attualmente svolgendo uno stage? C’è uno stagista all’interno del tuo studio? In che modo reagire allo stato di cose?) che al loro interno approfondiscono ogni singolo aspetto di ciò che dovrebbe e ciò che non dovrebbe essere un’esperienza da intern. Alcuni racconti di vita da stagista contribuiscono a far luce su una condizione che ha spesso del grottesco, quando si tratta di candidarsi per stage, periodi di prova o da volontari presso le istituzioni culturali — il focus maggiore del Collective è posto al mondo dell’arte, con particolare attenzione » U na t ra ie t t oria ne l gra p hic d e s i g n viving Internship. [grafo 2] “Mapping your working life”, tratto da Sur- alle carriere all’interno delle realtà museali e delle gallerie. Alle richieste di competenze molto più che elevate (overskills) fanno seguito mansioni che poco hanno a che fare con il lavoro creativo o con percorsi di crescita professionale e culturale. Se ciò appare ormai una banalità invalsa è perché — come sostengono i Carrotworkers — il manico del coltello è sempre dalla parte dei datori di lavoro, come conseguenza di politiche del lavoro che allargano le maglie del lavoro gratuito, sollevandosi da responsabilità e normalizzando la flessibilità. I consigli della Counter Guide sono letti come un monito al rispetto di sé stessi e verso le proprie competenze e conoscenze acquisite negli anni di studio, al valore di queste ultime rispetto all’utilizzo sconsiderato che si fa della forza lavoro sottopagata o non retribuita. Il fotoromanzo, medium scelto per raccontare le storie spesso imbarazzanti dei tirocinanti, è in questo senso lo strumento più efficace per fare luce sui tanti tabù delle esperienze individuali e trasformare queste ultime in storie condivise. Se le esperienze preparatorie possono davvero servire a qualcosa, oltre a rifornire i grandi studi di design di fotocopiatori entusiasti e overskilled, è un obbligo del tirocinante quello di individuare a priori cosa si può ricevere in cambio del tempo donato ai capi. Che siano il mantenimento di un canale comunicativo costante con il proprio tutor, il libero utilizzo delle attrezzature, futuri colloqui presso studi amici, è importante avere l’orizzonte nitido rispetto alle possibilità che può offrire un’esperienza formativa resa strutturalmente obbligatoria dalle leggi europee dello scorso decennio. Una controguida che oltre a puntare all’autoconsapevolezza di ciascun aspirante creativo circa la realtà lavorativa odierna, apre varchi di immaginazione che possano mettere in crisi fondamenta ormai consolidate e accettate a priori. Lo stesso Contract for an Ethical Internship proposto all’interno del prezioso fascicolo costituisce un chiaro tentativo di migliorare i contesti del lavoro scarsamente retribuito, 46 — 47 spingendo i tirocinanti a discutere sin dall’inizio i termini del proprio periodo formativo, gli obiettivi di apprendimento e tentare di ottenere compiti che impieghino la totalità delle proprie competenze, esorcizzando così la ripetitività delle attività. Se chiedere condizioni e mansioni più giuste è spesso un ostacolo difficile da sormontare per il singolo stagista, un documento che dettaglia sin dalla prima interview tutto ciò che avverrà durante l’esperienza — la presenza dello stagista ai meeting con i clienti, i rimborsi spese obbligatori, i credit nei progetti nei quali l’apprendista ha contribuito sono alcuni dei termini fondamentali inseriti nel contratto ideato dai Carrotworkers — può senz’altro spezzare il silenzio e aprire a un dialogo più equo tra datori e apprendisti. Oltre al Contract, la guida fornisce preziosi schemi e tabelle utili ad analizzare la qualità delle ore impiegate in ufficio/studio, il valore del tempo non retribuito nei casi in cui si usa svolgere un secondo lavoro per pagarsi l’esperienza in studio, mappare le risorse a disposizione in termini di persone collaborative e strumenti, comprendere meglio le gerarchie interne e soprattutto analizzare la propria posizione in termini di soddisfazione, guadagni, prospettive. La guida punta l’occhio con cognizione anche sul ruolo dei tutor, vedendoli non solo come implacabili sfruttatori ma anche come coloro che non sempre sono felici all’idea di dover coprire le carenze di bilancio con l’arruola- U na t ra ie t t oria ne l gra p hic d e s i g n mento di stagisti. Un questionario dettagliato prova a far luce sulle dinamiche correnti tra tirocinante e tutor, sul reperimento di fondi da parte dell’attività/studio, sul tipo di lavoro affidato agli intern, sulla considerazione che si ha in studio degli stagisti, sul ruolo più o meno essenziale giocato da questi ultimi per smaltire le commissioni dello studio, eccetera. Conseguentemente, una miniguida agli employer prova a far comprendere ai futuri tutor o datori di lavoro poco retribuito, l’impegno necessario a una formazione del proprio tirocinante che sia degna di essere definita tale e che prenda in esame anche la questione relativa al rapporto tra lo studio/istituzione e le rappresentanze dei lavoratori, per educare i propri stagisti alle tutele e al diritto del lavoro. [23] cfr. Carrotworkers Collective, Surviving Internships. A Counter Guide to Free Labour in the Arts, Hato Press, Londra 2011, passim. Nella pagina seguente: [fig. 2] checklist per gli employer in procinto di ingaggiare uno stagista. 48 — 49 1.4 Co nfigu razioni d el l av oro Sebbene i graphic designer siano portati a suddividere il proprio lavoro in unità di misura che coincidono con i singoli progetti cui prendono parte, le prestazioni dei lavoratori creativi rientrano nei rapporti di lavoro definiti dalla Legge italiana e sono informate dalle configurazioni rispondenti alle diverse tipologie contrattuali proprie del mercato del lavoro. Dopo il decreto legislativo 276/03, che dodici anni fa ha ristrutturato il mercato «partendo dalla tesi che la flessibilità fosse il mezzo migliore per aumentare l’occupazione»,[24] passando per la riforma del 2012 (Legge 92/12) e Legge 99/13, le ultime novità sono state introdotte dalla riforma del lavoro varata dal governo Renzi, anche nota come Jobs Act, attuazione della Legge 183 del 10 dicembre 2014.[25] Per effetto della riforma, le numerose tipologie di contratti oggi esistenti possono essere raggruppate secondo quattro denominazioni: contratti di lavoro subordinato; autonomo; contratti di formazione– apprendistato; contratti speciali. Scomparirà gradualmente la quinta denominazione, relativa ai contratti di lavoro parasubordinato, che raccoglie al suo interno due tra le forme contrattuali più diffuse nei settori creativi: le collaborazioni a progetto («co–co–pro») e le forme di collaborazione continuative coordinate («co–co–co»). Queste saranno sostituite dal cosiddetto contratto a tutele crescenti, forma d’ingresso unica che accomunerà tutti i nuovi dipendenti. [24] Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “Rapporti di lavoro”, http://www.lavoro.gov.it/ AreaLavoro/RapportiLavoro/Pages/default.aspx, 21 ottobre 2014. [25] I Decreti Legislativi n. 22 e 23 del 4 marzo 2015, con cui La Legge 183/14 è entrata in vigore, sono consultabili sulla Gazzetta Ufficiale, n. 54, 6 marzo 2015. U na t ra ie t t o r i a n e l g r a ph i c d e s i g n Il lavoro subordinato La subordinazione del lavoratore, che fornisce il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di un altro soggetto in cambio di una retribuzione, è il carattere precipuo della tipologia contrattuale che accomuna oggi quasi due terzi dei lavoratori italiani. Due le categorie principali: la sua forma comune è quella del tempo indeterminato, l’altra quella del tempo determinato; in base alla modalità temporale di svolgimento della prestazione lavorativa si distinguono in full-time o part-time. Altre forme di lavoro dipendente sono i contratti di apprendistato, il lavoro intermittente e a somministrazione. La durata complessiva della prestazione lavorativa — giornaliera, settimanale o mensile — coincide con quanto stabilito nel Contratto Collettivo Nazionale dei Grafici Editoriali o in altro analogo, e in percentuale ridotta se si tratta di contratto part-time (che può essere orizzontale, verticale o misto). I redditi prodotti dal progettista che lavora in regime di subordinazione sono tassati sulla persona fisica (la cosiddetta irpef), con il datore di lavoro che agisce da «sostituto d’imposta»: egli trattiene dalla retribuzione lorda il corrispettivo del prelievo fiscale da versare allo Stato, cosicché al dipendente viene corrisposta la retribuzione netta. Sul versante previdenziale, così come avviene per la tassazione irpef, anche il prelievo dei contributi avviene per detrazione calcolata sul reddito lordo. Tale prelievo è effettuato dal datore di lavoro che poi versa la quota all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. I progettisti dipendenti sono iscritti al «regime generale» dell’istituto. I lavoratori dipendenti hanno diritto alle ferie retribuite per un periodo annuale non inferiore alle quattro settimane.[26] I contratti di apprendistato sono così definiti poiché [26] Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, “Lavoro dipendente”, https://www.inps.it/portale/default. aspx?sID=0%3b5773%3b6118%3b6 196%3b6233%3b6242%3b&lastMenu=6242&iMenu=1, 21 ottobre 2014. 52 — 53 integrano lo scambio tra prestazione e retribuzione con l’obbligo di formazione professionale a carico del datore. È per definizione un contratto a tempo indeterminato e prevede la redazione di un patto di prova e di un piano formativo individuale. È una forma contrattuale che prevede agevolazioni economiche e normative per i datori di lavoro che ne usufruiscono.[27] Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata prevede per il datore di lavoro la possibilità di servirsi delle prestazioni del progettista con una frequenza non predeterminabile. Può essere a tempo indeterminato o determinato, ma nel rapporto con il medesimo lavoratore non può superare le 400 giornate di lavoro nell’arco di tre anni solari — eccezion fatta per i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. È sottoscrivibile per i lavoratori che non abbiano ancora compiuto 25 anni, o ne abbiano più di 55.[28] Il lavoro a somministrazione coinvolge tre soggetti con due tipi di contratto: tra impresa utilizzatrice e agenzie somministratrici si stipula un accordo contrattuale che interesserà poi il lavoratore per mezzo di un secondo contratto tra questo e l’agenzia. Così l’agenzia somministratrice si occupa sia della retribuzione sia del versamento dei contributi, per essere in seguito rimborsata dall’impresa.[29] Come cambia il lavoro parasubordinato Con la riforma del lavoro appena approvata dal governo Renzi il lavoro parasubordinato, denominazione di quelle forme [27] Cliclavoro, “Apprendistato”, http://www.cliclavoro.gov.it/NormeContratti/Contratti/Pagine/Contratto-di-Apprendistato.aspx, 22 ottobre 2014. [28] Cliclavoro, “Lavoro intermittente o a chiamata”, http://www. cliclavoro.gov.it/NormeContratti/ Contratti/Pagine/Contratto-di-la- voro-intermittente-o-a-chiamata. aspx, 22 ottobre 2014. [29] Cliclavoro, “Somministrazione di lavoro”, http://www.cliclavoro.gov.it/NormeContratti/Contratti/Pagine/Contratto-di-somministrazione-di-lavoro. aspx, 22 ottobre 2014. U na t ra ie t t o r i a n e l g r a ph i c d e s i g n di collaborazione continuativa coordinate con la struttura datoriale e prive del vincolo di subordinazione, sarà rimpiazzato dai nuovi contratti a tutele crescenti. Per i contratti a progetto ancora in corso, cioè quelle commesse che prevedono uno specifico risultato finale e tempi di assolvimento indicati alla stipula del contratto, i datori di lavoro dovranno individuare delle forme di gestione transitoria al cui termine i lavoratori dovranno auspicabilmente essere assunti con i nuovi contratti. Il compenso di tali progetti veniva finora calcolato in base a qualità e quantità di lavoro prodotto, comunque non inferiore ai minimi contrattuali previsti per mansioni «equiparabili» a quelle in oggetto. Dal punto di vista contributivo le aliquote sui contratti dipendevano dal regime inps al quale il progettista fa riferimento. I contratti a progetto han costituito negli anni una delle forme contrattuali talvolta utilizzate in modo improprio e strumentale, per mascherare rapporti di lavoro subordinato dietro gli elementi di flessibilità propri di questa tipologia.[30] Contratti speciali: l’associazione in partecipazione È il contratto tra il titolare di un’impresa (associante) e il lavoratore (associato), per il quale è prevista la partecipazione agli utili dell’impresa in cambio di un determinato apporto — che può essere la stessa prestazione lavorativa. Dunque al posto della retribuzione tradizionale l’associato ha diritto di ricevere parte degli utili di un’impresa, assumendosi in parte il rischio che l’impresa non produca effettivamente degli utili. Nel caso in cui l’apporto fornito dall’associato sia esattamente una prestazione d’opera, evidentemente il rapporto potrebbe nascondere una forma di subordinazione. Per questo motivo, [30] Cliclavoro, “Lavoro a progetto”, http://www.cliclavoro.gov.it/ NormeContratti/Contratti/Pagine/ Contratto-di-lavoro-a-progetto.aspx, 22 ottobre 2014. 54 — 55 [Grafo 3] CIFRE DEL LAVORO IN ITALIA [31] 3,62 milioni Atipici PARASUBORDINATO 5,7% 10% A TERMINE 22,96 milioni di lavoratori 21,3% AUTONOMO 64% INDETERMINATO [31] [32] [33] Dati ISFOL, Indagine Plus. Il mondo del lavoro tra forma e sostanza, 2012, pp. 63-77. Sono quasi ventitre milioni le persone occupate in Italia, delle quali il 64% può vantare un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Oltre a questi, un altro 18% conduce un’attività autonoma continuativa, per un totale di 19 milioni di persone aventi un’occupazione permanente. È questa, sostengono gli esperti di ISFOL, la peculiarità strutturale italiana che ha reso più tollerabili che altrove gli effetti della crisi. In questo stesso quadro spiccano anche il dato sul lavoro indipendente (oltre cinque milioni) ben superiore alle medie europee, ma soprattutto i volumi del lavoro atipico. Il 15,8% dei lavoratori italiani (3,62 milioni) rientra infatti U na t ra ie t t o r i a n e l g r a ph i c d e s i g n [Grafo 4] DURATA MASSIMA DEI CONTRATTI ATIPICI [32] 62% COLLABORATORI 16% DIPENDENTI A TERMINE 10% 50% fino a 12 mesi 18% 25% 13–24 mesi oltre [Grafo 5] PERSISTENZA DI CONTRATTI ATIPICI [33] 14,8% 15,2% 13,6% 12,9% 10% anni 7,8% 1 nella definizione di «non standard», ovvero quelle forme contrattuali dipendenti a termine o autonome con palesi indici di subordinazione. Dodici mesi è la durata massima per il 50% dei contratti a terminee per il 62% delle collaborazioni. Solo il 10% dei contratti d i collaborazione dura più di due anni. U n orizzonte breve e a lunga persistenza, dato 2 3 4 5 contratti non standard le situazioni di lavoro atipico si susseguono da più di quattro anni. Lungi dall’essere un fenomeno transitorio, i contratti di collaborazione sono diventati una forma permanente per un gran numero di lavoratori non più giovani, rimasto stabilmente tra le maglie della parasubordinazione. che per il 30% dei lavoratori con 56 — 57 il numero degli associati in ciascuna impresa non può essere superiore a tre, esclusi i casi di parentela tra associante e associati. Sulle somme di partecipazione agli utili ricevute dall’associato si applicano le ritenute fiscali del 20% o del 12,50%, a seconda che egli fornisca un contributo d’opera o un contributo capitale.[34] Senza contratto: il lavoro occasionale Le tipologie di lavoro descritte fin qui prendono forma tutte o quasi in luogo di un contratto tra le due parti, ma vi sono delle altre fattispecie dell’attività lavorativa che si contraddistinguono per l’assenza di un contratto tra committente e progettista. Tra queste, le collaborazioni occasionali sono singole prestazioni di breve durata (minore a trenta giorni) e dal modesto compenso (un massimo di 5000 euro in un anno solare e con lo stesso committente), distinguendosi dalle collaborazioni con partita iva anche per l’assenza di rischio economico sul lato progettista. Sotto il profilo giuridico e previdenziale conservano i requisiti delle collaborazioni coordinate e continuative (co-co-co), perciò i progettisti sono obbligati a iscriversi alla gestione separata inps; mentre per ciò che concerne gli aspetti fiscali, tali collaborazioni sono assimilate al lavoro dipendente, di cui conservano i principi determinanti la base imponibile.[35] [34] Cliclavoro, “Associazione in partecipazione”, http://www. c l i c l a v o r o . g o v. i t / N o r m e C o n tratti/Contratti/Pagine/Contratto-di-Associazione-in-partecipazione-con-apporto-di-lavoro.aspx, 21 ottobre 2014. [35] Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, “Diverse fattispecie di lavoro occasionale”, http://www.inps.it/portale/ default.aspx?itemdir=6395, 30 ottobre 2014. U na t ra ie t t o r i a n e l g r a ph i c d e s i g n 1.5 La sc el ta d el l av oro aut on o m o Le ragioni per lavorare in autonomia sono molteplici: l’indipendenza, la libertà sulla scelta dei clienti con cui dialogare e sui progetti da intraprendere, la volontà di dimostrare il proprio valore rispetto ai colleghi, il fascino di creare ed evolvere una propria identità professionale e il coinvolgimento nel prendere dei rischi ad essa associati. Con anche la convinzione che condurre un’accurata amministrazione può portare a massimizzare le entrate. Oltre a tutto questo, si comprende come l’idea di dare vita a un luogo in cui coltivare in maniera autonoma la propria creatività abbia risvolti utopici e sia perciò ancora più attraente. I clienti possono scegliere di affidarsi a un freelance per ragioni di riconosciuta autorevolezza e segno identitario, per una precisa scelta di lavorare con singoli progettisti anziché studi con catene di competenze, oppure perché è notoriamente più conveniente. C’è bisogno però di quell’xfactor, un aspetto totalmente personale e necessario per ogni freelance che voglia far progredire la propria attività e ottenere nuove commesse. Anche l’apparentemente semplice mantenimento dei clienti iniziali costituisce un impegno costante e per riuscirci al meglio è necessario affinare il proprio carattere e l’attitudine alle relazioni interpersonali. Il lavoro in autonomia oggi implica un committment che in termini di diritto del lavoro significa la garanzia di flessibilità sociale ed economica e in generale vuol dire esporsi ai molteplici venti del rischio e alle continue metamorfosi produttive, senza la certezza del capitale fisso e senza la possibilità di contare su posizioni di rendita. È il prezzo da pagare per il rifiuto della ripetitività e della subordinazione, assieme all’assenza di impieghi certi, all’impegno nella ricerca di clienti e alle insidie della fiscalità. In termini di autorappresentazione culturale del proprio lavoro, le priorità di chi sceglie la strada indipendente sono legate al contenuto intrinseco del lavoro, ovvero quella ricerca di una qualità dell’ambiente di lavoro e 58 — 59 delle relazioni al suo interno unita al piacere della sfida che soggiace al binomio responsabilità/autonomia.[36] Sul piano giuridico, il lavoro autonomo è l’attività in proprio svolta nei confronti di un committente senza vincolo di subordinazione. È la categoria di consulenti, liberi professionisti, cooperatori. Molti dei quali costituiscono il cosiddetto popolo delle partite iva. Le collaborazioni con partita iva Il collaboratore autonomo con partita iva compie prestazioni d’opera o presta servizi dietro corrispettivo e senza alcuna subordinazione, non facendo parte in alcun caso dell’organico del committente. Il collaboratore, in base al contratto definito dall’articolo 2222 del Codice Civile, è libero da vincoli di orario, libero nella scelta delle modalità tecniche di esecuzione dell’opera, vincolato al raggiungimento di un risultato e al rischio economico (che si assume in toto). La prestazione si caratterizza per la sua unicità nel tempo e il compenso è determinato in funzione della specificità dell’opera. Molto spesso, nei casi in cui questa avviene in regime di «monocommittenza», finisce per mascherare rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato, i quali sono più onerosi per il committente. La riforma Fornero varata nel 2011, che aveva l’obiettivo di combattere queste forme «elusive» di collaborazione, ha introdotto un criterio di «presunzione relativa» che si manifesta alla presenza di alcuni fattori, elementi cioè evidentemente riconducibili alla trasformazione del rapporto in forme di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro subordinato. La presunzione opera alla presenza di almeno due dei seguenti tre fattori: - se la collaborazione ha una durata superiore agli otto [36] cfr. Bologna e Banfi 2010 (op. cit.), p. 32; e Aldo Bonomi, La città che sente e pensa. Creatività e piat- taforme produttive nella città infinita, La Triennale Design Museum, Milano 2010, pp. 56-57. U na t ra ie t t o r i a n e l g r a ph i c d e s i g n mesi annui in due anni solari consecutivi; - se, nel corso dei due anni consecutivi, costituisce più dell’80% del reddito annuo complessivo del professionista prestatore d’opera; - se essa prevede una postazione di lavoro presso le sedi del committente. Tali evidenze tuttavia non entrano in gioco se la prestazione: - è qualificata per competenze teoriche di alto grado o esperienze rilevanti; - è svolta da un soggetto che percepisce un reddito annuo minimo di almeno 18.000,00 Euro; - riguarda le professioni ordinistiche o professionisti iscritti ad albi. Dal punto di vista fiscale il compimento della prestazione è vincolato all’emissione della fattura, nella quale oltre al compenso pattuito dev’essere indicata la percentuale di «rivalsa» iva e quella relativa alla ritenuta d’acconto irpef. Classificati come «redditi di lavoro autonomo», i compensi percepiti sotto questo regime sono tassati secondo il meccanismo di acconto e saldo, cui si applicano le aliquote progressive per scaglioni di reddito. Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali, i collaboratori con partita iva sono obbligati a iscriversi alla Gestione Separata inps, che prevede una contribuzione quasi del tutto a carico del progettista stesso (salvo un addebito del 4% al committente).[37] Previdenza autonoma La molteplicità delle forme possibili di esercizio dell’attività, la cui scelta è in mano al professionista, è direttamente in relazione con la gestione previdenziale. Che sia subordinato, [37] cfr. Ranucci Umberto, “Le collaborazioni con partita IVA”, http:// www.dplmodena.it/altri/LE%20COL- LABORAZIONI%20AUTONOME%20 CON%20PARTITA%20IVA%20-%20 Ranucci.pdf, 15 ottobre 2014. 60 — 61 autonomo, parasubordinato, il tipo di lavoro svolto determina le quote di contribuzione da versare alla questione pensionistica. La differenza tra lavoratori dipendenti e autonomi non riguarda soltanto le percentuali di contribuzione, ma definisce una linea di demarcazione tra due differenti regimi previdenziali. Per gli autonomi si tratta di iscriversi alla cosiddetta gestione separata Inps, che significa provvedere da sé agli adempimenti finalizzati alla propria pensione. È una forma pensionistica che affonda le radici negli anni Novanta, quando la riforma Dini introdusse l’obbligatorietà della contribuzione per le figure cosiddette atipiche, tra cui autonomi e collaboratori con contratti continuativi. Oggi i lavoratori che riconoscono come unica copertura previdenziale tale gestione separata versano il 27,72% delle proprie entrate, mentre per coloro in possesso di altra copertura l’aliquota è del 20%. Gli oneri contributivi sono tuttavia sostenuti anche dai committenti, in misura variabile dal 4% al 45% delle aliquote a seconda che i lavoratori in questione siano di titolari di partita iva, collaboratori a contratto o associati. La riforma Fornero, varata nel luglio del 2012, avrebbe portato l’aliquota contributiva al 33,72% (e al 24% per i lavoratori con altra tutela previdenziale). Avrebbe, perché un’iniziativa di acta, l’Associazione dei Consulenti nel Terziario Avanzato, ha ottenuto il blocco dell’aumento dei contributi in questione per il 2014 (sarebbero saliti al 28,72%) — mentre è stato un decreto ministeriale del governo Renzi a congelare l’aumento previsto per il 2015.[38] La battaglia, condotta per mezzo di una raccolta sulla piattaforma change.org, accusava la norma dell’intenzione di «coprire prestazioni di altri [tipi di] lavoratori» e finanziare il welfare dei lavoratori dipendenti.[39] [38] cfr. “Partite IVA free lance: aliquote contributive 2015-2017”, http://www.pmi.it/impresa/normativa/approfondimenti/93449/partite-iva-free-lance-aliquote-contributi- ve-2015-2017.html, 17 marzo 2015. [39] Il manifesto della petizione è tuttora consultabile al sito http:// www.change.org/it/petizioni/. U na t ra ie t t o r i a n e l g r a ph i c d e s i g n Oltre a «cancellare» le figure dei professionisti autonomi (definiti «indipendenti») con partita iva dal mercato, in riferimento al delicato meccanismo previsto dall’articolo 9 del DDL Fornero, che mirava a trovare una soluzione sul tema della distinzione tra vere e false partite iva ponendo alcune condizioni tali per cui rapporti di lavoro indipendente passerebbero sotto l’egida della collaborazione coordinata e continuativa — condizioni evidentemente considerate sfavorevoli per i freelance.[40] [40] Il documento “Memoria per la Commissione Lavoro, Previdenza Sociale del Senato della Repubblica” è pubblicato alla pagina http:// www.actainrete.it/wp-content/ uploads/2012/04/memoria_ACTA_ per_Commissione_lavoro.pdf, 22 maggio 2014. 62 — 63 La Legge n. 4/2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013, è rivolta alle professioni non organizzate in ordini e collegi, dedite alla prestazione di servizi ed esercitate prevalentemente in ambito intellettuale. Ha introdotto il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica. Aprendo la strada all’autoregolamentazione professionale basata sulle certificazioni di qualità e conformità alle normative Uni. U na t ra ie t t o r i a n e l g r a ph i c d e s i g n 1.6 Verso una profil azione del l e nuo v e profes s ioni La Legge sulle Professioni non regolamentate approvata nel dicembre del 2012 aveva l’obiettivo di fornire per la prima volta un ordinamento per un centinaio di professioni consolidatesi negli ultimi decenni, per la maggior parte nel settore dei servizi e riguardanti circa 3,5 milioni di lavoratori autonomi e dipendenti in Italia, riconoscendone diritti e doveri.[41] La legge definisce le professioni non organizzate in ordini e collegi, fonda il diritto all’esercizio di tali attività «sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico»;[42] ne esplicita le forme — individuale, associata, societaria, cooperativa o in quanto lavoro dipendente — e dota il singolo professionista di una dicitura da apporre in ogni documento e rapporto scritto con i clienti. L’articolo 6 della legge introduce il tema della qualificazione, basata sulla conformità a normative Uni, per regolamentare e autoregolamentare l’attività del singolo professionista appartenente o meno alle associazioni di settore. Più nello specifico, sono definite tre categorie di qualità in base alla conformità a normative tecniche e all’appartenenza alle associazioni di riferimento: il primo livello è quello del professionista non iscritto ad associazione di riferimento né provvisto di certificazione Uni; al secondo livello troviamo il professionista coerente con la norma Uni ma non iscritto alle associazioni; il terzo livello è quello del professionista con certificazione e iscrizione. Oltre a queste, una quarta categoria in via di definizione aggiungerà agli adempimenti del professionista un criterio relativo alla certificazione delle sue conoscenze. [41] Gabriele Ventura, “La riforma delle professioni non ordinistiche”, in Le Nuove Professioni, Italia Oggi, 31 gennaio 2013, p. 5. [42] Arvedo Marinelli, “Un volto a tre milioni di professioni”, ibidem, p. 4. 64 — 65 La legge non obbliga un professionista a iscriversi alla propria associazione di riferimento, ma se il professionista decide di compiere questa scelta, allora deve sottoporsi alla qualificazione e al controllo di qualità operati dalle associazioni, seguendo le regole di condotta per la propria attività. Le associazioni divengono così i più importanti organismi di tutela nei confronti dell’utenza. La direzione intrapresa dalla Legge sulle Professioni non regolamentate non va verso la creazione di nuovi ordini, come invocato nell’ultimo decennio da alcuni soggetti del terziario più avanzato, ma apre ai testi di autoregolamentazione per colmare tramite le norme dell’Ente per l’Unificazione i «vuoti del sistema socioeconomico in aree prive di riferimenti ufficiali».[43] Sono dodici le categorie professionali per le quali sono state definite e pubblicate (dati al 2012) norme Uni, ma non c’è traccia finora delle professioni legate al design. Inoltre, tra le professioni catalogate dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro come costituenti la schiera dei senza albo non si fa menzione specifica dei progettisti della comunicazione e del design. Mentre c’è una certa consapevolezza generale rispetto alle professioni legate alla pubblicità.[44] La Legge, oltre a intraprendere un primo sentiero verso la profilazione di molte attività scarsamente riconosciute con l’obiettivo di innalzare la qualità dei vari mercati, apre a diversi interrogativi. Per un mestiere fondato sulla creatività, la libertà d’azione e le influenze multidisciplinari, l’introduzione di normative potrebbe rivelarsi ambivalente. Proteggere l’accesso alla professione per mezzo [43] Cinzia De Stefanis, “La norma tecnica Uni sulle professioni”, in Le Nuove Professioni, Italia Oggi, 31 gennaio 2013, p. 22. [44] “Operatori della pubblicità”, “pubblicitari professionisti”, “art directors”, sono figure normalmente elencate tra le professioni non protette configurate dal CNEL. A dimostrazione della visione poco profonda con cui le schiere di designer sono osservate dall’esterno, nonché della presenza consolidata dei mestieri dell’advertising nel nostro paese. U na t ra ie t t o r i a n e l g r a ph i c d e s i g n delle certificazioni servirebbe certamente a tutelare tutti coloro che investono anni e denaro nella formazione rispetto al problema del dumping e della «sottodisciplinarizzazione». D’altra parte, una tale misura ignorerebbe il fatto che alcune tra le figure più singolari e innovative della storia del graphic design recente siano autodidatti. È come immaginare che una lunga serie di progettisti degli ultimi decenni, alcuni dei quali hanno rivoluzionato la disciplina e amplificato la diffusione del graphic design, siano oggi esautorati dal praticare la disciplina in modo professionale. Si comprende allora come una misura tanto innovativa, mirata a riscrivere i confini della professione, tocchi in profondità l’identità del graphic design. 66 — 67 1.7 Ra ppresent anza Il tema della rappresentanza all’interno del lavoro creativo è argomento particolarmente delicato, date le polarità sociali e professionali contenute dentro la definizione di classe creativa. Se per i progettisti più legati all’imprenditoria e al «capitalismo personale»[45] come i soci o titolari di studi/agenzie permane una domanda rappresentativa di tipo ordinistico, per i lavoratori delle piccole imprese, i creativi più giovani o appartenenti alle fasce della precarietà ci sarebbe la necessità di definire organi di tutela di tipo sindacale, in forme nuove oppure più tradizionali. Le associazioni, realtà a partecipazione volontaria e regolate da processi democratici, faticano a porsi come veri luoghi partecipativi nonostante non manchino le iniziative volte al dibattito e all’allargamento della base di iscritti. Molti dei soci si limitano a presenziare agli eventi più importanti, considerando principalmente la funzione lobbistica svolta dalle associazioni di categoria. Come scrive Bonomi È un fatto […] che albi e associazionismo professionale vecchio stampo nonostante godano di tassi di iscrizione non indifferenti non godano però di grande reputazione; vengono per lo più additate come “pedaggi” da pagare per accedere a cerchie cooptative ristrette gestite dai professionisti più affermati utili per cogliere occasioni di mercato.[46] L’offerta delle associazioni tuttavia prevede una pluralità di funzioni, che vanno dalla community di scambio [45] per una definizione accurata del paradigma noto come “capitalismo personale” si veda Aldo Bonomi, La città che sente e pensa. Creatività e piattaforme produttive nella città infinita, La Triennale Design Museum, Milano 2010, passim. [46] ibidem, p. 68. U na t ra ie t t o r i a n e l g r a ph i c d e s i g n di informazioni su norme, opportunità, prodotti e software a un’offerta formativa erogata per mezzo di corsi, seminari e eventi formativi; funzioni che mirano a ricreare quel vantaggio competitivo che i professionisti cercano nell’adesione alle associazioni, assieme alla certificazione delle competenze. Formazione, network e lobbying sono i sentieri sui quali si muove anche aiap, l’associazione nazionale di riferimento per chi si occupa del progetto della comunicazione visiva. Il ruolo di aiap L’aiap, il cui acronimo stava ad indicare alla sua fondazione autonoma nel 1955 l’Associazione Italiana Artisti Pubblicitari e che ha da poco ridefinito la propria denominazione in Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva, è il soggetto di riferimento per il mondo dei graphic designer. Facendo seguito alla redazione della prima Carta del Progetto Grafico avvenuta nel 1989 e che segna un passo importante verso il riconoscimento professionale dei progettisti della comunicazione visiva, l’associazione nel 1994 si è dotata di un Codice di etica deontologica e condotta professionale per promuovere atteggiamenti di maggiore consapevolezza e responsabilità nelle pratiche progettuali. Membro fondatore nel 1962 di icograda,[47] l’associazione internazionale per la valorizzazione delle pratiche del design, dal 1992 aiap partecipa alla Consulta delle Professioni non riconosciute del cnel. Accesso ad aiap Si diviene soci dopo aver dimostrato di possedere titoli di studio pertinenti e aver intrapreso la professione (per la macrocategoria dei professionisti), aver versato [47] oggi rinominata Ico-D, International Council of Design, è l’associazione dei professionisti della comunicazione a livello mondiale. Fondata a Londra nel 1963, rappresenta più di 140 organizzazioni di professionisti di 67 differenti paesi e regioni. www.ico-d.org. 68 — 69 una quota associativa che si differenzia per tipologie, aver accettato e sottoscritto Statuto, Regolamento nazionale e Codice deontologico. Sono due le macrocategorie associative: trattasi di soci con diritto di voto e rappresentanza oppure semplici aderenti. La distinzione marca dunque il solco tra professionisti e studenti/appassionati. Attestazione del singolo professionista Per gli aspiranti soci professionisti l’ammissione passa necessariamente attraverso un colloquio con una Commissione Professionale, per accertare «il livello professionale del candidato, con la verifica delle competenze e delle mansioni esercitate, delle procedure metodologiche di progetto, di controllo del ciclo di produzione nel suo insieme e di rapporto con la committenza».[48] Il superamento del colloquio dà diritto al progettista all’iscrizione nell’elenco dei professionisti aiap e al registro internazionale del Bureau of European Designers Associations, oltre alla possibilità di apporre il marchio dell’associazione e la relativa dicitura nelle proprie comunicazioni professionali. Il problema della certificazione professionale resta però ancora irrisolto. È sufficiente essere soci aiap per attestare la propria professione di progettista grafico? O meglio, l’associazione e il superamento del relativo colloquio di ammissione validano tecnicamente la conformità alle norme Uni per la professione di progettista della comunicazione visiva? La risposta è negativa per entrambi i quesiti, sebbene l’adesione ad aiap conferisca certamente un plus al designer che intenda sottoscriverla ed è la stessa Legge sulle Professioni non regolamentate a istituire dei gradini qualitativi di distinzione tra soci e non-associati. L’associazione, recentemente riconosciuta dal Ministero per lo Sviluppo Economico tra i soggetti aventi requisiti conformi alle prescrizioni specifiche della legge 4/2013, ma non ancora in grado di rilasciare il cosiddetto «attestato di qualità»,[49] ha da poco affrontato il tema della norma descrittiva. U na t ra ie t t o r i a n e l g r a ph i c d e s i g n intervista a presidentessa Daniela Piscitelli, di aiap L’edizione 2014 di Design Per, la settimana internazionale della grafica di aiap, ha proposto un’importante tavola rotonda con l’obiettivo di aggiornare il dibattito sull’identità professionale del progettista della comunicazione visiva. piscitelli: I contesti culturali, economici e lavorativi di venti anni fa non esistono più. Il modello lavorativo sviluppatosi in quel contesto italiano costituito da piccole e medie aziende, poche grandissime aziende e un tessuto di progettisti fatto prevalentemente da grandi maestri (pochi studi che gestivano grandi commesse) è oggi impraticabile. Le aziende odierne sono polverizzate su tutto il territorio nazionale e non più concentrate nel solo nord Italia; hanno dimensioni molto più ridotte rispetto alle stesse aziende del made in Italy; non sono più aziende padronali, ma aziende che si stanno managerializzando. Questo management però è in genere abbastanza incolto e, provenendo da studi economici o di scienza della comunicazione, evidentemente impreparato sul significato di strategie e pratiche della comunicazione visiva viste in termini strategici daniela [48] cfr. Regolamento per l’ammissione alle categorie di adesione all’AIAP, http://www.aiap.it/documenti/8042/71. [49] l’elenco delle associazioni riconosciute dal mise è consultabile al sito http://www. sviluppoeconomico.gov.it 70 — 71 per l’impresa. A questo corrispondono tantissimi piccoli studi di progettisti di qualità molto eterogenea sparsi in tutto il territorio nazionale, con picchi qualitativi in insospettabili luoghi di provincia che vantano la presenza di progettisti formatisi all’isia di Urbino, allo iuav o al Politecnico e in seguito ristabiliti nelle città d’origine. L’idea alla base della tavola rotonda di Genova è stata quella di far dialogare gli ultimi dei grandi maestri con la generazione dei quarantenni e i giovanissimi. Quindi Pino Grimaldi ed Elio Carmi, progettisti e teorici che hanno vissuto le ultime scorie del made in Italy e soprattutto l’istituzionalizzazione della disciplina della comunicazione visiva all’interno degli istituti di formazione, a confronto con Riccardo Falcinelli, figura ibrida della generazione di mezzo, e con i giovanissimi del Cantiere per pratiche non-affermative. È venuto fuori un putiferio! Le osservazioni dei giovani a proposito della precarizzazione hanno suscitato più di un sorriso tra i maestri, segno questo del carattere cromosomico della precarietà, storicamente presente all’interno della professione. Quale futuro, dunque, per il graphic design? Il lavoro come lo avevamo conosciuto non ha più ragione d’esistere, perché diventa domestico. Dalla comunicazione per eventi al mondo editoriale, le aziende hanno internalizzato il lavoro nei propri uffici di comunicazione, U na t ra ie t t oria ne l gra p hic d e s i g n mentre le istituzioni o i piccoli soggetti autonomi si avvalgono di risorse domestiche, perché la tecnologia lo consente — a scapito della qualità. È qualcosa di cui dobbiamo prendere atto, che ci piaccia o meno. Oggi il nostro lavoro è fondamentalmente quello di fornire linee guida strategiche per output che poi verranno definiti all’interno delle aziende. La competenza allora deve elevarsi a livelli superiori, avere conoscenze matematiche, informatiche, di programmazione. Dobbiamo guardare alle nuove frontiere della comunicazione: dalla consulenza per la pubblica amministrazione all’editoria digitale, dal mondo della comunicazione della scienza — della sua rappresentazione, si pensi alla diagnostica medica — alla possibile rivoluzione dell’editoria scolastica. Continuiamo a pensare al nostro mestiere come al gestore della corporate image, dimenticandoci che ci sono contesti completamente nuovi in cui potremmo fare tantissimo. L’information design è probabilmente il filone che maggiormente può influenzare l’evoluzione del progetto... È un grande strumento di accesso alla conoscenza. Potrebbe ad esempio rivoluzionare il mondo dell’editoria scolastica per le scuole elementari allontanandolo dalla scrittura lineare; l’apprendimento farebbe dei salti da gigante. Il vuoto rappresentativo e la difficoltà dei progettisti a percepirsi come gruppo sociale sono le emergenze più 72 — 73 nette delle ultime ricerche sociologiche condotte all’interno delle professioni creative. Pensa che l’acquisizione del riconoscimento professionale possa in qualche modo colmare questi gap? Il lavoro che stiamo facendo in aiap per ciò che concerne il riconoscimento professionale è sostenuto principalmente da due fazioni. Da una parte coloro i quali vedono nel riconoscimento della professione un passo verso l’istituzione di un ordine professionale; dall’altra lo schieramento che concepisce il riconoscimento come un meccanismo in grado di innescare dinamiche economiche intorno all’associazionismo. Sono sbagliati entrambi i punti di vista: l’affannosa rincorsa al riconoscimento e addirittura alla costituzione di un ordine professionale è totalmente anacronistica rispetto a ciò che avviene in Europa, così com’è illogico pensare a operazioni di stampo corporativistico. Entrambe le fazioni ignorano ciò che sta avvenendo sul piano legislativo… …cioè che in Italia nel frattempo è stata approvata la Legge sulle Professioni non regolamentate. La Legge n. 4/2013 sta riconfigurando il mondo delle associazioni su molteplici piani. Innanzitutto, per la Legge esiste un libero mercato al cui interno non valgono i titoli di studio ma le competenze messe in campo. Così per ognuno degli aspiranti professionisti sarà obbligatorio in futuro avvalersi di una certificazione U na t ra ie t t oria ne l gra p hic d e s i g n Uni e di un’assicurazione professionale, così com’è già stato reso obbligatorio l’aggiornamento professionale. Ciò che un’associazione come la nostra può fare è impegnarsi a contrastare le derive corporativiste che in un modo o nell’altro si presenteranno, data la natura generica della Legge. Per evitare quei meccanismi lucrativi che in altri settori possono assumere dimensioni gigantesche, abbiamo stabilito che l’erogazione da parte di aiap ai propri soci sarà gratuita. Ciò che un’associazione deve fare, oltre a erogare un aggiornamento di qualità, è selezionare tra i propri associati coloro i quali hanno provveduto nel tempo a evolvere il proprio profilo professionale (per mezzo di corsi di aggiornamento, partecipazione a workshop, eccetera). Da questo punto di vista le associazioni diventano un metro importante con cui giudicare i professionisti che si aggiornano e quelli che non lo fanno. Il mercato farà la sua scelta. Le novità della Legge non sono tutte positive: con la sua entrata in vigore le associazioni riconosciute dal Ministero di Grazia e Giustizia hanno un ruolo di responsabilità anche rispetto all’attività professionale dei propri associati. Ciò significa che devono rispondere civilmente e penalmente dell’operato dei propri professionisti. Come si sta adattando il mondo del design alle direttive della Legge 4/2013 in tema di qualificazione dell’attività professionale? Sembra quantomeno complesso parlare 74 — 75 di una norma tecnica riferita al mondo del design… Abbiamo intrapreso una strada, di concerto con le altre associazioni professionali quali adi, Design for All, AIPi e AISDesign, verso la strutturazione di una scheda volta ad avviare un tavolo tecnico che possa scrivere la norma Uni sul design. È un lavoro che va avanti da un anno e al quale hanno partecipato tutti gli attori del design in Italia, da noi convocati: Politecnico di Milano, isia di Urbino, accademie, Art Director Club, Conferenza Nazionale dei Presidi delle Facoltà del Design. Definire una norma Uni sul design vuol dire prendere in considerazione le tre macroaree del design — industrial design, design degli interni e design della comunicazione. Abbiamo dunque costituito tre sottotavoli tecnici che lavoreranno per individuare le criticità inerenti allo sviluppo delle pratiche professionali. Una volta scritta, la norma sarà modificata a seguito di una verifica sul campo entro i primi cinque anni dalla sua definizione. Crede che una normazione professionale così strutturata arriverà a trasformare anche qualche aspetto legato all’insegnamento delle discipline progettuali? La formazione è considerata un presupposto, in questo senso. La norma lavorerà sugli aspetti tecnici, legali e burocratici della professione. Credo piuttosto che l’aspetto formativo e quello normativo si contageranno a vicenda: la U na t ra ie t t oria ne l gra p hic d e s i g n pratica professionale, di conseguenza anche la normativa, dovranno necessariamente contemplare tutti gli aspetti innovativi della professione; gli istituti di formazione allo stesso modo dovranno interrogarsi su questi aspetti, per coprire le voragini che sono presenti nel nostro paese — penso a campi come l’interaction design. In che misura aiap riesce a coinvolgere i giovani progettisti e gli studenti? Per quanto possibile cerco sempre di coinvolgere il mondo dei giovani progettisti. Il fatto stessi di aver ridotto del 45% la quota associativa studenti pur mantenendo intatti i servizi forniti è un dato, in questo senso. Da quel che vedo, c’è sempre una presenza molto nutrita dei giovani agli eventi di aiap che poi non si conferma nel numero delle iscrizioni e soprattutto nella dimensione della partecipazione alla vita associativa. È come se mancasse una visione politica, invece io sono profondamente convinta che il ruolo politico del professionista vada recuperato. Possiamo incidere anche a livello legislativo e l’istituzione del tavolo tecnico per la normativa Uni ne è un esempio importante. I giovani però devono comprendere che bisogna recuperare il valore della responsabilità civile del nostro lavoro, dell’utilità pubblica del progetto di comunicazione. aiap, da parte sua, non deve più essere quel club di autoreferenziati che è stato in passato. Dev’essere un luogo di scambio, condivisione e ricerca. 76 — 77 1.8 Co mpen s i Fare il graphic designer significa trovare alla fine del lavoro la soddisfazione di una sfida portata a termine, arricchita da nuove contaminazioni ed esperienze. La retribuzione è dunque concepita come un premio — e non solo come un bonifico da ricevere — costituito anche da fattori relazionali e motivazioni personali. Parlare di compensi significa allora definire il valore del lavoro intellettuale e della conoscenza in genere e nello specifico della fatica nel trasmettere l’importanza e la dimensione del proprio lavoro; ma vuol dire anche affrontare quella difficoltà a quotarsi che accomuna molti progettisti e che è motivata da diversi fattori. Ed è un compito reso ancora più arduo dal fatto che un lavoro di natura creativa, nel campo della comunicazione visiva, produce effetti la cui durata nel tempo allontana questo tipo di lavoro dal tradizionale concetto di mansione. La misura con cui si valuta una prestazione nell’ambito della creazione di contenuti di comunicazione visiva ricalca il gioco di forze che determina le retribuzioni dei lavori di consulenza professionale. Tempo impiegato e competenze messe in campo, lato progettista; benefici nel corso del tempo, lato committente: il rapporto di forza tra le parti a bilanciare il tutto. Vista la natura delle prestazioni e le differenze di forza contrattuale tra le parti, ciò che è giusto si riduce spesso a ciò che è accettabile. Oltre a questo, l’assenza di salari minimi in Italia non offre le garanzie di un grado di ricompensa minima invalicabile. Nella contrattazione con il cliente oggi si parte spesso da una domanda: qual è il budget previsto? Sembra una consueta banalità ma in realtà è la conferma del peso della committenza nella determinazione del compenso, oltre che dell’inutilità di qualsivoglia tariffario. Inoltre, nel caso in cui la committenza sia un’impresa ben strutturata, sono le regole di quotazione del valore e di pianificazione dei budget interne all’azienda a fissare i tetti di spesa e, in genere, a condurre in maniera incontrastabile a un appiattimento dei prezzi.[50] U na t ra ie t t o r i a n e l g r a ph i c d e s i g n Quando invece il progettista ha del margine per sottoporre una propria richiesta retributiva, succede che molto spesso i designer che si mettono in proprio dopo esperienze passate dentro i team di uno studio o di un’azienda, si trovino a valutare i propri lavori secondo un meccanismo ancora legato al tempo in cui erano subordinati. Calcoli legati al tempo, cioè al costo orario di svolgimento della propria attività, secondo un’equiparazione che in realtà danneggia il lavoratore indipendente e non prende in considerazione il valore della professionalità nel suo insieme. I costi di gestione di un singolo progettista, se autonomo, sono molto più simili a quelli di un’impresa rispetto a quelli di un lavoratore dipendente. Tra questi, oltre al denaro versato in contribuzione previdenziale e tasse e oltre ai capitali investiti in strumenti e processi di produzione, includiamo anche il tempo impiegato nella ricerca di nuovi clienti, quindi nel networking e nelle relazioni pubbliche, come nell’aggiornamento e nell’attività amministrativa contabile. Sono tutti costi operativi che un’azienda scarica sul lavoratore indipendente, che deve sopportare anche carichi fiscali maggiori di quelli previsti per i dipendenti della stessa azienda. Sono quantità di tempo e lavoro nascosti nei processi di produzione e che richiederebbero un sostanziale aumento dei compensi da richiedere alla committenza. Ma è spesso impossibile farlo, all’esterno delle imprese. Dumping Se per il freelance è impossibile coprire i costi operativi nel modo in cui le imprese ricaricano il costo del lavoro per rivenderlo all’esterno, allora lo stesso si trova inesorabilmente portato ad accettare guadagni minori. Il dumping è dietro l’angolo: chiedere meno significa dare il la a una lenta discesa verso il basso dei compensi di una professione [50] cfr. Bologna e Banfi 2010 (op. cit.), pp. 165–67. 78 — 79 U na t ra ie t t o r i a n e l g r a ph i c d e s i g n “è il mercato, bellezza!”, si può facilmente rispondere che in questo meccanismo di impoverimento delle professioni non si è più in competizione con altri lavoratori indipendenti, bensì con il costo del lavoro dipendente che non può certamente essere abbattuto in una lotta ad armi pari. «A chi obietta che è pur sempre una dinamica di tipo concorrenziale, che 80 — 81 — S E RG I O BO L O G N A , D A R I O B AN F I [51] In questo sistema c’è la scure dell’impresa e i costi incomprimibili del lavoro dipendente da una parte, e la necessità di tenere alti i compensi dei freelance dall’altra.» che finisce per intaccare la qualità delle prestazioni svolte. Ciò che spesso si ignora è che l’assenza di contratti nazionali rende implicitamente ogni singolo progettista autonomo il portavoce di un’intera categoria. Il recruiting online è forse la nuova espressione del dumping sociale e della deprofessionalizzazione. Lo studente che vuole mettere in evidenza le sue capacità, ad esempio, accetta di buon grado l’idea di ricevere un misero compenso per un logo proposto da uno degli svariati contest che ogni giorno popolano siti come Iamasource/Starbytes. Alcuni di questi siti, poi, rendono visibili le proposte dei singoli partecipanti a tutti gli utenti che frequentano la piattaforma; visibile è anche la valutazione parziale che il committente/ recruiter fornisce man mano che gli utenti inviano i propri lavori. Certamente si tratta di un modesto esempio, sufficiente tuttavia a comprendere quanto sia svalutato il lavoro di analisi e concettualizzazione che sottende a ogni proposta inviata. Come non pensare poi che i partecipanti in attesa di finalizzare la propria proposta non siano indotti dall’orientamento del recruiter che traspare dai voti dati ai vari competitor che hanno caricato i propri lavori in precedenza? Sembra proprio un caso in cui la cosiddetta democratizzazione portata dalla rete svuota di diritti il lavoro creativo, o comunque un piccolo segno di ciò che Bologna e Banfi (citando Andrew Ross) descrivono come «jackpot economy», ovvero il fenomeno che vede nel crowdsourcing una delle forme con cui le aziende «recuperano le componenti più flessibili della retribuzione di un freelance» e riducono i compensi.[52] Certamente è una prova dell’impatto del digital labour sui tagli del costo del lavoro. Molti oggi aderiscono a quelle forme di collaborazione più o meno gratuite in cambio di visibilità online, contribuendo anche inconsapevolmente alla degradazione del clima lavorativo. [51] [52] cfr. Bologna e Banfi 2010 (op.cit.), p. 179; pp. 191–93 U na t ra ie t t o r i a n e l g r a ph i c d e s i g n #Rivoluzionecreativa due iniziative e #coglioneNO, online «In Italia non esistono cifre che dicano quanti siano i professionisti della creatività. I “creativi” semplicemente non esistono. Eppure siamo quelli che costruiamo, ogni giorno, immagini, sogni e tendenze. Quelli che progettano ogni giorno le piattaforme dove ci si confronta. Che creano stili, storie e visioni da condividere. Disegnano il presente.»[53] Nel’ottobre del 2011 Alfredo Accatino, direttore artistico e creativo di Filmaster Events, scriveva una lettera indirizzata ai colleghi del settore creativo per sensibilizzarli a un sentimento unitario, che abbandonasse certe «visioni corporative»[54] e fosse la spinta verso iniziative volte alla richiesta di maggiori tutele e di riconoscimento del proprio lavoro. «In Italia esistono più di due milioni di persone che vivono di ciò che producono con il proprio pensiero e la propria immaginazione, disegnando le cose e le idee che vedete intorno a voi…» Due milioni di persone che generano il 5,8% del pil del paese e che appartengono ai settori della creatività per il web e la pubblicità, per la moda, lo spettacolo e l’industria dei media; autori, sceneggiatori e attori del cinema; stilisti, scenografi e costumisti; blogger, videomaker, giornalisti; artisti, architetti, 82 — 83 designer, graphic designer e illustratori; e poi traduttori, curatori, ricercatori.[55] La lista non si esaurisce certo qui ma tutte queste professioni, tutte le identità o micro-identità che rappresentano, sono accomunate dagli stessi nuovi linguaggi e tecnologie. Tutte, con il loro contributo in ricerca arte e tecnologia, costituiscono un valore strategico per il rilancio del Paese. Di certo fanno parte di un settore che, per numeri e produttività, ha già superato quello automobilistico. Dunque perché continuare a ragionare per corporazioni, quando vi sono elementi in comune che, guarda caso, concorrono a definire il non-riconoscimento, la mancanza di tutele, di rappresentanza politica e sindacale, l’invisibilità sui media di tutte queste identità lavorative? Accatino sostiene l’inutilità odierna dell’esistenza di associazioni di settore, di nicchie identificative di professioni i cui confini sono sempre più nebulosi. Nell’ottica di una condivisione di opportunità, la via indicata è quella del «divenire massa critica», diventare corpo unitario per esercitare peso e influenza nel futuro dialogo con le istituzioni. Essere «gruppi di pressione», rendersi visibili, bloccare almeno per un attimo i meccanismi di produzione cui tutti i creativi contribuiscono — e in maniera peraltro indispensabile —, per far riflettere e poter così affrontare molti temi d’interesse collettivo. Nell’autunno del 2013 Accatino ha lanciato una petizione sulla piattaforma Change.org, sorret- U na t ra ie t t oria ne l gra p hic d e s i g n ta dall’hashtag #Rivoluzionecreativa, che si rivolgeva a governo, candidati premier, sindacati e forze sociali. Per chiedere a questi ultimi di lavorare sinergicamente, con l’obiettivo di riconoscere la valenza strategica della creatività e della ricerca tecnologica in Italia, a fronte di un impegno comune delle schiere di creativi «ad aumentare la partecipazione alla vita sociale e politica».[56] Corredata dalla creazione del sito Creativi.eu, la petizione invitava ad affrontare molti temi utili a rafforzare l’identità e la tutela di quanti operano nei vari settori del lavoro immateriale orientato alla produzione e diffusione di cultura. Venti punti suddivisi in quattro macrocategorie: tutela del lavoro creativo, formazione e orientamento professionale dei giovani, sostegno alle imprese della creatività, tutela del diritto d’autore. L’iniziativa promossa da Accatino ha avuto il merito indiscusso di aver dato nuova linfa al dibattito sul riconoscimento delle professioni creative ed è giunta subito dopo un intervento dello stesso art director al tedxTrastevere[57] in cui aveva parlato di emozioni e creatività come vie per la diffusione della bellezza. #Rivoluzionecreativa è il classico esempio di molte azioni che riscuotono un successo virale notevole nei primissimi giorni ma la cui spinta propulsiva, come spesso accade per le iniziative diffuse via web, si è esaurita in breve tempo. Dopo le seimila firme dei primi sei giorni, oggi il counter di Change.org è fermo a poco più di 84 — 85 18.000 firme: poche, troppo poche, considerate le premesse.[58] È un indizio di qualcosa che manca a tutto ciò che avviene online: è mancanza di prossimità, di socialità e di vera condivisione. — Il vero boom virale è quello registrato lo scorso inverno dalla campagna di sensibilizazzione #coglioneNO,[59] i cui tre video diffusi via YouTube e rimbalzati di bacheca in bacheca hanno collezionato un totale di quasi due milioni e mezzo di visualizzazioni. Non c’è da meravigliarsi della differenza rispetto ai numeri della petizione di Accatino: contenuti di intrattenimento come i video non possono essere paragonati a una raccolta firme. Ad ogni modo, #coglioneNO è un progetto che per mezzo delle analogie tra creativo e idraulico/antennista/ giardiniere — forzate sì, ma che in realtà ricordano la similitudine di Sagmeister tra designer e elettricista, come anche alcuni interventi di Massimo Guastini sul blog di ADCI[60] — racconta le difficoltà quotidiane che accomunano i giovani creativi italiani, con punte di immedesimazione molto alte tra i freelance. Il focus è unicamente sul compenso, troppo spesso un dettaglio trascurabile per i datori di lavoro. «Devo essere sincero, per questo progetto non c’è budget» chiarisce a lavoro eseguito il burino-con-l’abbonamento-a-Sky-e-servizi-aggiuntivi al malcapitato antennista, così come avviene tra il facoltoso uomo d’affari e il giardiniere U na t ra ie t t oria ne l gra p hic d e s i g n chiamato di domenica mattina a tagliare qualche ramo di troppo; allo stesso modo, il giovane benestante milanese lontanamente fashion victim si prende gioco dell’idraulico promettendo tag sui social in cambio della riparazione del sanitario. Il giusto taglio autoironico e una caratterizzazione ad hoc dei personaggi, uniti alla surreale associazione del termine progetto a lavori così urgentemente manuali e tangibili, sono gli ingredienti di una mini web serie riuscitissima: se l’intento era quello di far fioccare i Like, i tre videomaker di Zero sono stati impeccabili. E certamente è anche uno di quei casi in cui (forse neanche troppo) paradossalmente lavorare gratis serve, come ha fatto notare Niccolò Contessa[61] in un articolo per il blog della casa editrice Minimum Fax. Non c’è dubbio infatti che la campagna, al netto degli sforzi a titolo gratuito dei promotori, abbia già portato o porterà nell’imminente futuro qualche nuova commessa remunerata per la capacità dimostrata nella realizzazione dei tre brevi clip. L’ironia sulla propria condizione come unica arma per uscire dall’anonimato. Ma cosa resta a tutti gli altri creativi dopo la valanga di condivisioni? Le istanze portate avanti da Accatino si muovono nel solco di quanto fatto nel decennio scorso da Enzo Baldoni, o da Massimo Guastini ora presidente di Art Directors Club Italia. Il fenomeno #coglioneNO invece è rappresentativo di chi (come me) negli anni Zero — nella seconda 86 — 87 U na t ra ie t t oria ne l gra p hic d e s i g n 88 — 89 In questa doppia pagina: [figg. 3–6] fotogrammi tratti dalla mini–webserie #coglioneNO metà degli anni zero — non era che una matricola e oltre a intraprendere il percorso accademico iniziava a comprendere quanto difficile sarebbe stato immaginare un futuro agevole. Entrambi ci portano a riflettere in modo più ampio sulla congiuntura attuale di un mercato del lavoro che per i creativi o presunti tali pare essere inevitabilmente saturo, in esso cioè l’offerta supera nettamente la domanda. La soluzione non è semplicemente quella di pretendere d’esser pagati, quantomeno non è soltanto questa la strada. Nel momento in cui a fronte di un progettista che richiede una determinata cifra ve ne sono altri che lo farebbero tranquillamente gratis in nome di una visibilità più o meno millantata, ciò significa che nel breve termine lavorare gratis potrebbe anche funzionare, se si è in grado di dimostrare le proprie capacità. I casi di commissioni e collaborazioni instaurate direttamente via Behance sono in crescita e dimostrano quanto potenziale c’è in un portfolio online in cui i lavori evidenzino originalità e competenze, al di là che essi siano remunerati e al di là del grado di coolness del cliente. Del resto la strada per l’eccellenza è appannaggio di pochi tra i talentuosi, e per la diversificazione, cioè per spiccare in originalità e trovare una via propria al modo di fare il mestiere, c’è bisogno di durissimo lavoro. Ma neanche eccellenza e diversificazione costituiscono le soluzioni condivisibili al problema. Semmai concorrono nell’alimentare una competizione asfissiante, in cui U na t ra ie t t oria ne l gra p hic d e s i g n la mentalità individualistica dei partecipanti non fa che incrementare la distanza abissale da qualsivoglia iniziativa veramente politica. Un sogno di farcela che spesso è la mera ambizione a un modello di vita che afferma senza batter ciglio la propria insostenibilità. [53] [54] la lettera di Accatino è stata riportata da numerosi siti e blog del settore ed è ancora visualizzabile al sito http://www.eventreport.it/stories/news/1037_lettera_aperta_di_alfredo_accatino_ai_colleghi_creativi_diventiamo_lobby_e_chiediamo_le_tutele_che_non_abbiamo/, 11 luglio 2014. [55] cfr. http://creativi.eu/dati-e-cifre/, 11 luglio 2014. [56] http://creativi.eu/rivoluzionecreativa-2/, 11 luglio 2014. [57] http://tedxtrastevere.com/portfolio/alfredo-accatino/, 11 luglio 2014. [58] Il testo della petizione e i risultati sono tuttora consultabili al sito http://www.change.org/it/petizioni/ chiediamo-il-riconoscimento-della-valenza-strategica-della-creativit%C3%A0-per-il-rilancio-del-paese-rivoluzionecreativa?share_id=dwKLRmPZsZ&utm_campaign=friend_inviter_ chat&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition&utm_term=permissions_dialog_true [59] http://zerovideo.net/coglioneno/, 12 luglio 2014. [60] http://blog.adci.it/adci/che-prospettive-offriamo-ai-giovani/, 11 luglio 2014. [61] http://www.minimaetmoralia.it/wp/su-coglioneno/, 12 luglio 2014. 90 — 91 1.9 Il valore intrinseco della creatività Il discorso sui compensi rientra in una riflessione più ampia mirata a far emergere un elemento fondamentale che da molti è descritto come il valore intrinseco del lavoro creativo ed è ciò che ci fa comprendere come il tempo impiegato per realizzare un progetto sia solo uno degli elementi in gioco nella determinazione di una ricompensa. Non senza una buona dose di pretenziosità dovremmo ribadire ad ogni occasione utile che un progetto grafico è il risultato di un lavoro di ricerca che spesso costituisce una grossa fetta della prestazione erogata, e che impegna il progettista a 360° nel suo continuo aggiornarsi e accrescere la propria sfera culturale. Ogni progetto grafico è anche la reiterazione di un processo appreso dal progettista in anni di formazione (con tutti i costi dell’istruzione annessi) e concretizzabile in investimenti tecnologici di cui egli si è autonomamente fatto carico e in rischio. Esempi in questo senso, che danno l’idea del potenziale intangibile dietro ogni idea progettuale, sono: il salto di qualità che un brand compie nel momento in cui la sua identità visiva è disegnata da zero o sottoposta a un restyling; il risparmio sui costi di produzione e smaltimento di cui un’azienda beneficia nel momento in cui introduce un nuovo packaging; la longevità con cui una copertina si fissa nell’immaginario di tanti musicofili. La capacità di cogliere questo potenziale è il punto di partenza per una maggiore equità di trattamento ed è una delle leve con cui incrementare il riconoscimento professionale di chi si occupa di comunicazione visiva. Per riprendere le parole di Vilém Flusser, si tratta di dare valore a quell’Abzeichen (segno distintivo) e a quell’intenzione verso uno scopo che costituiscono le autorevoli fondamenta del lavoro progettuale e dell’attitudine del designer.[62] [62] cfr. Vilém Flusser, Filosofia del design, Bruno Mondadori, Milano 2003, pp. 4-6. U na t ra ie t t o r i a n e l g r a ph i c d e s i g n 1.10 Co nc l us ioni Le dinamiche interne alla professione del graphic designer contribuiscono a testimoniare un’attualità del lavoro in Italia segnata da trasformazioni quali: - la moltiplicazione delle forme contrattuali; - l’individualizzazione dei rapporti di lavoro; - la «sottodisciplinarizzazione» come esito della proliferazione dei percorsi accademici, universitari e post-universitari; - l’incapacità del mercato di assorbire una quota sempre più allargata, dalla moltiplicazione dei percorsi formativi, di potenziali professionisti; - la sovrapposizione di competenze dovuta alla rivoluzione digitale, che fa confluire le diverse professionalità nel grande alveo di lavoro creativo della comunicazione; - la mutazione dei contenuti della professione risultato dell’esplosione tecnologica e il dumping conseguente. In simili circostanze emergono gli svantaggi sistemici del lavoro autonomo, normalizzato dall’uso di forme contrattuali che andrebbero quantomeno messe in discussione. Nella seconda parte condurremo in parallelo una riflessione e un’indagine sul campo. Nella prima, mirata a decostruire le ragioni di una precarizzazione strutturale, e corroborata da una serie di interessanti contributi critici, andremo a cercare l’origine di quella fascinazione — che definiremo fatale — che spinge un numero sempre maggiore di persone a intraprendere percorsi accademici e professionali creativi. La seconda, orientata a indagare la percezione d’identità professionale dei più giovani tra i praticanti, ci porterà a raccogliere testimonianze (virtuali) in giro per l’Italia e a far luce sulle istanze di una nuova cultura professionale, frammentata e autorappresentata sul mercato, che guarda con distacco alle organizzazioni di rappresentanza tradizionali. 92 — 93 94 — 95 Sec ond a p a rte L’identità del graphic designer, intesa come somma dei tratti salienti di ogni singolo progettista che opera nell’universo del lavoro immateriale, è un complesso mosaico le cui tessere appaiono oggi alla ricerca di un collante nuovo. L’attitudine alla flessibilità, dote ormai incorporata nel proprio patrimonio genetico, le ha rese monadi, rispondenti a un mito performativo della creatività che le allontana da istanze condivise. L a p ercez ione id ent it aria di una p rofes s ione c reat iv a «Ciò che è ancor più significativo, e perverso allo stesso modo, è che indirizzare una carriera nella creatività — con tutte le sue incertezze — sembra davvero andare in direzione contraria a qualunque atto formale di resistenza organizzata verso quelle stesse condizioni.»[1] —Matt Soar «Forse il nostro compito dovrebbe essere quello di immaginare la creazione di istituzioni e di territori — mentali e fisici — che siano compiutamente autonomi dall’interminabile dissipazione dell’eredità moderna. Se non finisce l’eclissi occorrerà inventarsi un altro cielo.»[2] —Franco Berardi Bifo Nel capitolo precedente abbiamo visto come il lavoro creativo possieda un certo carattere vocazionale intrinseco alla soggettività di ciascun progettista che rende problematica una costrizione della valutazione del suo operato nei soli termini salariali. Ciò che gratifica il lavoro di un creativo è legato a parametri quali il desiderio, l’ego, la performance individuale, l’autorialità. Questi, uniti alla volontà di una certa autonomia nella composizione del tempo individuale nella suddivisione vita-lavoro, potrebbe far pensare che condizioni in bilico tra flessibilità e precarietà siano appropriate — forse anche richieste — per certa parte del mondo dei creativi. Certamente una formazione accademico–universitaria che incoraggia e istituzionalizza forme di lavoro gratuito partecipa alla produzione e immissione sul mercato di «soggettività vulnerabili allo sfruttamento», come sostengono i membri del collettivo Precarious Workers Brigade. Agli studenti è spesso venduta una versione luccicante del lavoro freelance e […] forniti consigli su come diventare professionisti nel branding, [1] Soar 2002 (op.cit.), p. 121 (mia traduzione). [2] Franco Berardi Bifo e Carlo Formenti, L’eclissi, Manni, Lecce 2011, p. 84. 98 — 99 nell’imprenditoria e nel mercato. Ciò è in contrasto con la teoria critica e le pratiche sperimentali che potrebbero anche imparare nel corso degli studi [in design]. Questo tipo di pratica fornisce un unico modello di professionalità che non ha nulla a che fare con il pensiero critico e allo stesso tempo non trasmette informazioni veritiere sulle condizioni della precarietà, dell’occupazione e della vera vita lavorativa. Allo stesso tempo, gli studi critici sono spesso concepiti e impartiti come teoria astratta scarsamente connessa alla pratica e al sostentamento degli studenti. Tale disconnessione è spesso vissuta come qualcosa di poco chiaro e alienante. Ma ancor peggio, replica un certo schema del mondo accademico nel quale il carattere politico spesso si limita alla produzione di ‘contenuto’ senza una riflessione sulle conseguenze, un contenuto che ignora le strutture e le condizioni entro cui viene prodotto.[3] In questo secondo capitolo guarderemo al graphic design con occhi più attenti al contesto in cui il lavoro creativo dei progettisti viene svolto, per uscire dal perimetro insulare della professione e cogliere l’influenza della struttura socioeconomica postfordista sulle dinamiche produttive della progettualità. Vedremo come alcuni caratteri sviluppatisi negli ultimi decenni nel patrimonio genetico dei progettisti siano comuni in molti settori del lavoro creativo: le debolezze individuali, quell’unpredictability raccontata da numerosi osservatori e ricercatori militanti delle industrie creative. Mali che da individuali tendono a essere sistemici, permeando gli stessi modi di vivere dei progettisti e degli altri soggetti del lavoro creativo, conformandoli secondo modalità che continuano a perpetrare e riprodurre pattern di precarizzazione. È proprio la capacità di comprendere la sistematicità di tali elementi precarizzanti ciò che può liberare il «potenziale di resistenza»[4] insito in ogni progettista. L a p e rce z ione ide nt it a ria di un a pr o fe s s i o n e c r e a ti v a 2.1 Media to ri c ul t ural i La definizione di Matt Soar Un tentativo di delineare i tratti della professione del graphic designer è quello compiuto dal canadese Matt Soar nei suoi studi sociali su una certa parte della produzione grafica anglo–americana che potremmo definire non–affermativa (campagne di sensibilizzazione su temi quali aids e problematiche di genere, critica sociale, attivismo politico) a cavallo tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del nuovo millennio. La dissertazione Graphic Design, Graphic Dissent è il risultato di un approfondimento dal taglio etnografico sui limiti ideologici del graphic designer e sulla vocazione alla responsabilità sociale dei suoi praticanti. Puntando l’attenzione sulle implicazioni soggettive di questo particolare segmento di produzione culturale, Soar ha cercato di comprendere meglio le tensioni delle individualità creative al servizio delle economie capitaliste rispetto agli impulsi critici e resistivi propri dell’espressione individuale di molti progettisti. Lo ha fatto anche alla luce della propria esperienza di ex pubblicitario che a un tratto ha deciso di dedicarsi esclusivamente a progetti non–profit. Tra le caratteristiche salienti dei mediatori culturali — definizione della categoria dei creativi coniata dal filosofo e sociologo francese Pierre Bourdieu nel saggio di ricerca teorica e etnografica Distinction. A Social Critique of the Judgment of Taste, pubblicato nel 1984 dalla Harvard University Press [3] Precarious Workers Brigade, Training for Exploitation. Towards an alternative curriculum, http:// precariousworkersbrigade.tumblr. com, 23 gennaio 2014 (mia traduzione). [4] Bianca Elzenbaumer, Designing Economic Cultures. Cultivating socially and politically engaged design practices against procedures of precarisation, tesi di dottorato di ricerca in Filosofia, Dipartimento di Design del Goldsmith College, University of London, 2013, pp. 23–28 (mia traduzione). 100 — 101 di Cambridge — la collaborazione tra vari membri di uno stesso gruppo è un elemento sociologicamente fondante, alla base di quello «short circuit»[5] — teorizzato da Soar riprendendo le riflessioni di Richard Johnson, studioso ed ex direttore del Centre for Contemporary Cultural Studies della University of Birmingham — nel quale si è allo stesso tempo produttori e consumatori. Nel «circuito corto» il capitale culturale è distribuito velocemente e sottoposto alla fruizione degli stessi mediatori culturali molto tempo prima della ricezione da parte del pubblico più ampio (il «circuito culturale» di Johnson è un modello concettuale mirato a rappresentare la produzione e riproduzione di significati e valori all’interno di una cultura).[6] Dunque sono essi stessi a far da pubblico primario e fonte di ispirazione per il proprio lavoro di creazione di prodotti culturali. Come conseguenza di tale concettualizzazione, i progettisti/mediatori godono di una posizione privilegiata nella produzione e diffusione della cultura. Soprattutto, ciò presupponeva per Soar l’esistenza di una nascente economia culturale (lo studio è stato pubblicato nel 2002) nella quale per le individualità la distinzione tra lavoro e tempo libero si assottiglia, trasformando la quotidianità di tali gruppi sociali in una sorta di «attività culturale»[7] continua che unifica produzione e consumo, scrittura e ricezione. Un habitus che contraddistingue i comportamenti di tali individualità modellando i profili attitudinali delle identità creative, e che in queste ultime è l’effetto osservabile della compresenza di quattro tipi di capitali culturali: capitale istituzionalizzato (formativo, accademico); concreto (beni simbolici, artefatti); sociale (network); incorporato (gusti, attitudini).[8] [5] [7] [8] Soar 2002 (op. cit.), pp. 14–15; 41; 46. [6] l’articolo accademico di Richard Johnson “What Is Cultural Studies Anyway” è stato pubblicato sulla rivista Social Text, n. 16 (Inverno, 1986-1987), Duke University Press, Durham, pp. 38-80; è consultabile online all’indirizzo http://www.jstor. org/discover/10.2307/466285?sid=21105804570591&uid=2&uid=4&uid=3738296. L a p e rce z ione ide nt it a ria di un a pr o fe s s i o n e c r e a ti v a 2.2 La cl asse c reat iv a Tra imprenditoria e ideologia della creatività Per Richard Florida la classe creativa comprende tutti quegli «individui di grande talento motivati soprattutto dalla ricerca di numerose esperienze di lavoro di alta qualità, apertura alla diversità di tutti i tipi, e soprattutto dall’opportunità di confermare la loro identità come persone creative».[9] Persone che scelgono di vivere e lavorare in città–simbolo come Milano, luoghi catalizzatori di talenti e stili di vita legati alla fruizione di esperienze culturali, unici in Italia per la dimensione delle comunità creative; tappe magari intermedie ma fondamentali nello sviluppo delle carriere; città ricche dal punto di vista delle istituzioni della creatività e che vantano un patrimonio largamente riconosciuto. Queste individualità fanno parte di una composizione del lavoro in cui prevale la dimensione personale, tra partite iva, precariato e piccolissime imprese. È una dimensione pulviscolare, eredità di quella new economy degli anni Novanta che aveva disegnato un futuro di autonomia trionfale per le nuove figure professionali protagoniste della rivoluzione della rete. Uno scenario modificatosi poi nei primi anni duemila con una spinta all’autoimprenditorialità dovuta da un lato alla ristrutturazione dei reparti creativi di agenzie e aziende, dall’altro dalla presa di coscienza diffusa circa il deterioramento precarizzante delle condizioni lavorative e professionali che ha percorso l’ultimo decennio.[10] Nel prezioso documento La città che sente e pensa, pubblicato dalla Fondazione Triennale di Milano e seguito al lavoro di ricerca commissionato a Aldo Bonomi e al consorzio AAster, la «nebulosa» del lavoro creativo è definita come quell’insieme di «culture professionali e soggettività per le quali a fronte di una centralità dal punto di vista del ruolo [9] Florida 2003 (op. cit.), p. 36. [10] Bonomi 2010 (op. cit), pp. 51–52. 102 — 103 svolto nel processo di valorizzazione emerge una debolezza di posizionamento politico e sociale nella città».[11] Alla base di questa debolezza vi è anche un’autopercezione disallineata rispetto alla tradizionale nozione di classe sociale, poiché Se di classe creativa si può parlare, è certo che di classe in sé si tratti e non di classe per sé dotata di coscienza del sé collettivo.[12] La definizione di classe creativa è quindi un contenitore al cui interno le due polarità dell’imprenditoria e della precarietà convivono e in parte condividono un’appartenenza maggiormente legata all’ambito della libera professione anziché alle classiche definizioni di ceto. La nebulosa della creatività è un insieme eterogeneo, stratificato, che in città come Milano — dove costituisce un sistema istituzionalizzato — si è trasformata da nicchia elitaria (i maestri della seconda metà del Novecento) a moltitudine, al cui interno opera una «schiera sempre più folta di cognitari». È un aggregato di professionalità per le quali la creatività è una sorta di ideologia, un «mito performativo e disciplinatorio sui destini di migliaia di giovani aspiranti creativi»[13] Sfornati da un sistema della formazione creativa enormemente cresciuto nell’ultimo quindicennio che ha portato a specializzare e a formalizzare i diversi segmenti professionali. Con una democratizzazione di fondo del campo professionale ma nel medesimo tempo di una sua tendenziale proletarizzazione.[14] La proletarizzazione in questione fa riferimento a coloro che — in numero sempre maggiore — nella segmentazione del lavoro creativo rappresentata da Bonomi come una piramide a tre strati si collocano nella fascia più bassa, sono cioè più vicini alla dimensione precaria metropolitana. L a p e rce z ione ide nt it a ria di un a pr o fe s s i o n e c r e a ti v a È lo strato di lavoratori per i quali il lavoro non presenta tanto i tratti della produzione di nuove idee, quanto più spesso ripetitività, eccesso di offerta e quindi rischio di declassamento, sviluppo di capacità generiche e desiderio di miglioramento del reddito. Che tuttavia coesistono con la propensione forte alla ricerca di valori professionali di autonomia, arricchimento culturale, sviluppo professionale.[15] [11] [12] [13] [14] [15] Bonomi 2010 (op. cit), pp. 20–22. 104 — 105 2.3 So ggettiv azione Il piacere del lavoro L’enfasi sul successo individuale e sull’autonomia che accompagna i percorsi formativi e professionali dei progettisti pare essere una voce fondante del vocabolario creativo, tale da aver offuscato, se non omesso del tutto, alcuni aspetti tradizionali del discorso sul lavoro. Temi come i diritti del lavoratore, la solidarietà sul lavoro, la rappresentanza sembrano obsoleti, alieni al mondo–a–parte della creatività. «Come conseguenza di ciò» scrive Angela McRobbie, insegnante di Comunicazione presso il Goldsmith College di Londra e teorica delle culture del lavoro nel’industria creativa, «i settori creativi sono popolati da giovani sovraccarichi, esausti, resi incapaci di considerare l’idea di avere dei figli, e spesso sul punto dell’auto–sfruttamento motivato dal ‘piacere del lavoro’».[16] Come altri prima di lei, McRobbie vede in questo fenomeno le tracce di un movimento ben più ampio, che ha a che fare con le politiche lavorative europee degli ultimi due decenni ree di aver sollevato le responsabilità e il fardello della «protezione del posto di lavoro» dalle spalle dei datori e averle caricate su quelle dei progettisti. L’assottigliamento del tempo di vita libero dal lavoro porta a un calo di attenzione nei confronti della tutela personale da parte del singolo creativo specie se freelance, impegnato com’è nella sua personale lotta per l’autopromozione. Minore attenzione che si traduce in minor consapevolezza o, per usare un termine più netto, depoliticizzazione. Anche questo è il movimento di un congegno più esteso. [16] Angela McRobbie, “Re–Thinking. Creative Economy as a Radical Social Enterprise”, in Variant, n. 41 Primavera 2011; consultabile online al sito http://www.variant. org.uk/41texts/amcrobbie41.html. L a p e rce z ione ide nt it a ria di un a pr o fe s s i o n e c r e a ti v a Un processo biopolitico Il processo di soggettivazione che investe le individualità all’interno delle civiltà occidentali entra gradualmente nel discorso sociopolitico a partire dal 1800, con l’ascesa della borghesia e del liberalismo come struttura portante dello sviluppo degli stati. Con la fine del mercantilismo, l’attenzione del potere statale si sposta sulla società, sul miglioramento delle condizioni di vita generali, quali indici su cui orientare le pratiche di governo. Le economie liberali da quel momento seguono due sentieri paralleli, l’uno orientato a garantire i benefici del libero mercato, l’altro volto a inscrivere gli usi e i costumi sociali dentro i paradigmi economici. Sono gli albori di quella che sarà la biopolitica, come concepita da Foucault.[17] Il grado di salute delle popolazioni diviene allora una variabile importante per definire la forza e la ricchezza dei singoli stati, così le politiche dei governi iniziano a investire gli individui delle civiltà occidentali di quegli elementi che ne avrebbero garantito il controllo: la presa di coscienza dell’individuo moderno circa il proprio corpo e le condizioni esistenziali in cui esso è inserito; la facoltà di sviluppare una relazione con il proprio sé e quindi essere attivo, creativo, produttivo nel plasmare il corpo stesso.[18] È un controllo che avviene per mezzo di formule che rendono le individualità parti attive del dispositivo governativo, configurando il corpo stesso come strumento produttivo. Ciò che Isabell Lorey definisce «governmental self– government» aiuta a comprendere come la soggettivazione si basi su un fondamentale paradosso: la simultaneità di soggiogamento e senso di legittimazione, di potere dell’individuo, investito dall’input vitale a sviluppare [17] Michel Foucault, Nascita della biopolitica, Zanichelli, Milano 2005, p. 57. [18] [19] [20] Isabell Lorey, “Governmentality and Self Precarization. On the normalization of cultural producers”, http://eipcp.net/transversal/1106/lorey/en, 8 aprile 2014. 106 — 107 la propria individualità, la propria essenza, realizzare così il proprio potenziale. Soggettivato in questo modo, tale soggetto partecipa continuamente alla (ri)produzione delle condizioni per la governmentality, poiché è primariamente in questo scenario che l’agire emerge. Secondo Foucault, il potere è praticato solo su “soggetti liberi” e solo fino al punto in cui essi sono “liberi”.[19] Sempre Lorey asserisce come nella modernità occidentale, nelle società di stampo borghese e liberale, la riproduzione stessa costituisce da sempre un meccanismo fondamentalmente interno ai territori politici ed economici allo stesso modo della produzione. Non c’è un tempo di vita che sia altro dal tempo di lavoro, in altre parole. Nelle pratiche di vita e lavoro diffusesi negli anni Sessanta del Novecento, nella loro spinta all’autodeterminazione, vi sono caratteristiche in qualche modo complici della trasformazione verso le nuove forme di controllo neoliberista. Le pratiche lavorative legate al design ne costituiscono un perfetto esempio: la necessità di seguire percorsi maggiormente creativi presta consapevolmente il fianco a condizioni di sfruttamento e incertezza, in cambio di un certo grado di presunta libertà. Sono meccanismi di «normalizzazione»[20] per i quali le relazioni di «potere e dominio sono rese invisibili» dalla compatibilità creatasi tra le aspirazioni dei lavoratori autonomi e la dimensione strutturale della precarietà. L a p e rce z ione ide nt it a ria di un a pr o fe s s i o n e c r e a ti v a 2.4 Vulnerabilità, seduzione, desiderio L’attrazione fatale della creatività Sostiene Suely Rolnik,[21] teorica dell’arte e psicanalista brasiliana, che sotto le spinte dei movimenti controculturali degli anni Sessanta del Novecento, le politiche di soggettivazione sono andate incontro a trasformazioni tali da «stimolare, celebrare e dipingere in modo totalmente affascinante» il potenziale creativo degli individui. Incorporando però quest’ultimo in quelli che Flusser ha definito «apparati» di produzione del «diluvio di immagini»,[22] ovvero conducendo il potenziale creativo verso l’identificazione con le immagini dell’advertising e della cultura di massa. In favore di quel mito del consumo che porta le individualità a spendere le proprie energie vitali nell’inseguimento di un successo misurabile in oggetti e beni di consumo. L’immaginazione ha effettivamente preso il potere — scrive ancora la teorica brasiliana — ma solo per alimentare quell’insaziabile hypermachine per l’accumulazione del capitale. Le riflessioni di Rolnik sembrano echeggiare nelle ricerche di Aldo Bonomi sulle individualità al lavoro, viste come «macchine desideranti iperstimolate» del biocapitalismo odierno. [21] Nel suo contributo alla raccolta di saggi Critique of Creativity. Precarity, Subjectivity and Resistance in the ‘Creative Industries’, curata da Gerald Raunig, Gene Ray e Ulf Wuggenig e pubblicata da MayFlyBooks, Suely Rolnik parla del «corpo risonante», ovvero di una specifica abilità della nostra sfera sensibile. La vulnerabilità, differente dalla capacità percettiva e rintracciabile nell’area sottocorticale del nostro cervello, per la quale comprendiamo il mondo come un campo di forze a noi percepibili come sensazioni. Allo stesso modo, l’«altro» è concepito come presenza pulsante nella nostra superficie sensibile, 108 — 109 È dunque all’interno del processo di trasformazione del lavoro che possiamo leggere quel passaggio centrale nei dispositivi e negli apparati di disciplinamento biopolitico degli individui […] alla fase della psicotizzazione dei rapporti sociali al cui centro è la diretta messa al lavoro della psiche umana, o meglio dell’uomo come macchina desiderante iperstimolata immersa dentro il circuito di espansione allargata dei consumi e delle esperienze.[23] Con l’affermazione di un modello produttivo che «pone all’interno della psiche individuale tutte quelle contraddizioni che nel ‘900 trovavano mediazione sociale»,[24] il circuito di «espansione allargata dei consumi e delle esperienze» cui parla Bonomi è quel luogo in cui il tempo di vita coincide con il tempo di lavoro. Ciò intacca direttamente la socialità degli individui, i quali riconoscono come legami affettivi soltanto i legami utili. Se Bonomi parla di psicotizzazione dei rapporti sociali, per Rolnik è «l’anestesia della nostra vulnerabilità verso l’altro»: viene cioè a mancare quella precondizione per la quale l’altro diviene una presenza vivente, un altro con cui possiamo «costruire i territori della nostra esistenza» e trasformare la nostra soggettività. Sono due dei fenomeni che caratterizzano ciò che Vanni Codeluppi ha definito biocapitalismo: Il biocapitalismo produce valore estraendolo, oltre che dal corpo operante come strumento materiale di lavoro, anche dal corpo inteso nella sua diviene parte del nostro sé. È qui che «soggetto e oggetto si dissolvono, e con essi, ciò che separa il corpo dal mondo»; «È il nostro corpo nel suo insieme che ha questo potere di risuonare con il mondo» (p. 25, mia trad.). La tensione tra la percezione e questa capacità di risuonare è ciò che stimola il potenziale di pensiero/creazione: le nuove sensazioni, le modificazioni che queste apportano alla nostra superficie sensibile, non trovano rappresentazione nei nostri modelli disponibili, mettendo in cri- L a p e rce z ione ide nt it a ria di un a pr o fe s s i o n e c r e a ti v a globalità. Dunque agisce su tutte le componenti biologiche e sulle dimensioni mentali, relazionali e affettive degli individui. Ne consegue che deve presentarsi agli esseri umani in modo nuovo rispetto al passato, evidenziando un volto umano, accattivante.[25] Possiamo ipotizzare che il volto umano di cui parla Codeluppi sia quello dei brand, che nel loro rapporto con gli individui-consumatori offrono loro identità e status in cui riconoscersi. E chi, tra i funzionari dell’hypermachine, si occupa direttamente del make-up di questo volto umano? I creativi, certamente, che tra le schiere di cognitari al lavoro sono: il segmento che in maggior misura sperimenta in primo luogo a livello soggettivo la lacerante contraddizione tra debolezza di rappresentazione in quanto soggetto sociale e la centralità oggettiva del suo ruolo nei processi produttivi e riproduttivi.[26] Eppure la creatività, intesa come la spinta a sviluppare un sé creativo, esercita sempre più una sorta di attrazione fatale. Come scrive ancora McRobbie il distico creatività/talento rappresenta ormai la più desiderata delle qualità umane, che esprime ed è sinonimo di un sé interiore, dunque un segno di unicità, particolarmente risonante per i giovani pronti a fare il loro ingresso nel mercato del lavoro.[27] si i nostri riferimenti. Imponendoci l’urgenza di inventare nuove forme espressive. La nostra mappa dei riferimenti così si aggiorna, con i nuovi segnali che integrano i territori prestabiliti, trasformando i confini soggettivi e oggettivi, e la realtà stessa. [22] Flusser 2004 (op. cit.), pp. 64– 65. [23] [24] [26] Aldo Bonomi, in Bonomi e Borgna 2011 (op. cit.), pp. 2627; 43; 39. [25] Codeluppi 2008, p. 7. [27] McRobbie in Soar 2002 (op. cit.), p. 121. [28] Rolnik in Raunig et al. 2011 (op. cit.), p. 28. (mia trad.). 110 — 111 L a p e rce z ione ide nt it a ria di un a pr o fe s s i o n e c r e a ti v a favorevolmente accolta, ma è persino stimolata, celebrata e frequentemente glamourizzata. Tuttavia, il destino più comune [...] della libertà creativa [...] non è l’invenzione di forme espressive motivate da un’attenzione per le sensazioni che segnalano gli effetti dell’esistenza «La nostra forza creativa nella sua libertà sperimentale è non soltanto 112 — 113 — S UE L Y R O L NI K [28] dell’«altro» all’interno del nostro corpo risonante. Ciò che ci guida [...] è una quasi ipnotica identificazione con le immagini del mondo diffuse dalla pubblicità e dalla cultura di massa.» 2.5 Pra t ic he c rit ic he Come possono i progettisti impegnati a interrogare e interrogarsi sul sistema economico dominante, trovare le risorse per garantirsi un certo grado di sicurezza sociale ed economica senza esser costretti a finire tra le maglie del mercato, succubi delle sue pressioni? È questa la domanda di base del lavoro iniziato quattro anni fa da Bianca Elzenbaumer e Fabio Franz e mirato a indagare il sentiero che unisce precarietà socio-economica e progettazione socialmente e politicamente impegnata. caso studio Designing Economic Cultures «Abbiamo l’obiettivo di informare, mettere in connessione e supportare quei progettisti e quegli studenti che vogliano immaginare un modo di fare pratica che si distacchi dal modello oggi prevalente, fatto di strutture individualistiche e guidate dal mercato.»[29] Posto sotto l’insegna Designing Economic Cultures, il progetto è un tentativo di sviluppare e condividere un’ampia serie di «tattiche e strutture» utili alla promozione e progettazione di una società più «democratica, autonoma e eterogenea».[30] Tutto nasce da una prima fase di ricerca e concettualizzazione focalizzate sull’approfondimento teorico dei significati e dei dogmi delle economie neoliberali, culminata nella selezione La p erc e z ione ide nt it a ria di una p rof e s s i o n e c r e a ti v a di contributi provenienti da teorici e pensatori volti a suggerire una possibile rottura con la logica capitalista. Segue una fase dialogica, fatta di interviste a progettisti e praticanti in genere, volta a portare alla luce le strategie e le strutture d’aiuto con cui i soggetti in questione riescono a condurre le proprie pratiche critiche in maniera sostenibile. La terza fase del progetto è dedicata alla sperimentazione in prima persona, da parte dei promotori, di modelli economici e organizzativi alternativi al regime egemonico: un modo per sintetizzare sul piano della pratica le idee e i discorsi teorici affrontati nelle fasi precedenti. Quarta fase, infine, è una corposa serie di seminari e workshop[31] al Goldsmith College presso la University of London per preparare gli studenti a uno sguardo critico verso le dinamiche con cui di lì a poco questi ultimi avranno a che fare, con l’inizio dei propri percorsi lavorativi e professionali. Momenti, questi, in cui i saperi prodotti e condivisi aiutano i progettisti a identificare e comprendere meglio quei «metodi precarizzanti troppo spesso considerati come la norma che non può essere messa in discussione».[32] Il filo conduttore che lega insieme i quattro momenti del progetto portato avanti da Elzenbaumer e Franz, già soci e fondatori dello studio Brave New Alps,[33] è lo stesso che guida i due nella loro professione: la volontà di coinvolgere il maggior numero di persone possibili nell’atto di riconsiderare aspetti sociali, po- 114 — 115 litici e ambientali del contemporaneo per mezzo di progetti di comunicazione. Interrogandosi e interrogando i partecipanti ai diversi seminari organizzati su temi che mettono in discussione le stesse fondamenta dell’organizzazione del lavoro nei settori creativi, appare evidente l’intenzione dei due di discernere e evidenziare un certo percorso consapevole all’interno del mondo della creatività; un percorso che apra strade che, se battute, possono attualizzare e rinnovare il significato di strumenti di elaborazione condivisa delle identità professionali. Volgendo lo sguardo verso possibili «culture economiche che si sottraggano alla precarizzazione».[34] Ricercare per trasformare le pratiche e le soggettività «Indagando su come siamo educati in quanto soggetti creativi e su come i valori precarizzanti siano radicati nelle nostre vite», dichiara Bianca Elzenmbaumer sin dall’abstract della sua tesi che mutua il titolo dallo stesso progetto di ricerca sopra citato, «possiamo mettere insieme una scatola degli attrezzi fatta di concetti, valori e pratiche». Strumenti articolati per obiettivi molteplici: aprire spazi e momenti di riflessione, stimolare un sentire che sia maggiormente consapevole, innescare interventi concreti sul reale. La necessità che soggiace all’ideazione di tali strumenti è per Elzenbaumer in stretta relazione con il desiderio di poter sostenere concretamente e a lungo termine La p erc e z ione ide nt it a ria di una p rof e s s i o n e c r e a ti v a l’impegno critico e sociale di ogni singolo progettista. Un impegno che deve permeare il modo stesso con cui i designer organizzano le proprie pratiche e in fondo anche le proprie vite. «Voler produrre contenuti critici mentre si continua a lavorare secondo regole convenzionali finisce per sottostimare il considerevole potenziale che i progettisti possono mettere in campo per contribuire al cambiamento sociale non solo attraverso il contenuto del proprio lavoro, ma anche per mezzo dei modi di essere e di produrre.»[35] Così, oltre a ricercare le cause storiche e tracciare gli scenari passati e presenti utili a comprendere appieno la posizione centrale dei designer nei processi di precarizzazione del lavoro, un momento fondamentale per il lavoro di Bianca Elzenbaumer è ciò che lei definisce «to inhabit the question».[36] Ovvero il tentativo di esplorare con interventi in micro-scala le possibilità odierne di creare culture economiche altre nel corso di periodi di residenza in ambienti caratterizzati dalla condivisione comunitaria di spazi e risorse. Un modo per osservare da vicino e farsi ispirare dal modus operandi di altri progettisti per i quali l’esigenza di concretare azioni di contrasto ai modi di produzione egemoni convive con la necessità di “stare a galla” economicamente. Con queste premesse, la residenza di Brave New Alps presso il Centro di Arte Contemporanea del Castello di Ujazdowski a Varsavia è stata l’oc- 116 — 117 La p erc e z ione ide nt it a ria di una p rof e s s i o n e c r e a ti v a 118 — 119 chivio cartaceo delle conversazioni condotte con numerosi progettisti socialmente impegnati. In questa doppia pagina: [figg. 7–8] la home page del sito Designing Economic Cultures e l’ar- La p erc e z ione ide nt it a ria di una p rof e s s i o n e c r e a ti v a 120 — 121 versitario; progetto e costruzione dello spazio per gli ospiti. In questa doppia pagina: [figg. 9–11] allocazione della residenza all’interno dell’edificio uni- casione per una duplice azione: invitare altri progettisti a condividere gli spazi e le risorse produttive dati dalla borsa di studio che i due avevano ottenuto assieme alla residenza d’artista; organizzare un programma di seminari pubblici dal titolo “Constructive dismantling”, mirato a indagare le esperienze di autorganizzazione nella Polonia socialista e il lascito di tali esperienze negli anni successivi alla caduta del regime sovietico nel 1989. L’esperimento condotto dai due, con tutti i limiti temporali del caso — la residenza aveva una durata totale di cinque mesi, mentre i periodi condivisi con ciascuno degli ospiti non hanno superato la durata di un mese — pare aver innanzitutto stimolato una riflessione sui limiti del loro agire, esperire e pensare il ruolo di designer. Un micro-meccanismo in grado di accrescere la consapevolezza riguardante la tendenza a interiorizzare modi di pensare, produrre e relazionarsi che rendono i progettisti «funzionali e vulnerabili alla precarizzazione».[37] Concetti come utensili: tempo, innovazione, frammentazione Centrale nel discorso portato avanti da Brave New Alps è l’acquisizione di un equipaggiamento teorico di cui ogni progettista impegnato a mettere in discussione i propri modi di produzione dovrebbe essere dotato. Concetti strumentali alla comprensione delle dinamiche che normalizzano le logiche del sistema economico in cui operiamo. È un compito non adeguatamente La p erc e z ione ide nt it a ria di una p rof e s s i o n e c r e a ti v a svolto dalle scuole, troppo attente a formare professionisti forgiati alla flessibilità sin dagli anni accademici, a essere designer 24/7. Studiare i fondamenti dell’economia capitalista e delle sue derivazioni neoliberiste odierne, comprendere i meccanismi di produzione del valore in un tempo in cui qualsiasi lavoratore è costretto a essere già di per sé micro-capitalista, e in cui partecipando in quanto designer della comunicazione alla produzione di plusvalore non facciano che ricreare continuamente le condizioni per riprodurre le dinamiche di sfruttamento che precarizzano, sono attività necessarie per conoscere il terreno su cui i progettisti si muovono. Tempo, innovazione e frammentazione sono i tre sentieri teorici esplorati da Elzenbaumer nel suo “Intermezzo”, una pausa d’approfondimento rispetto al report delle attività condotte tra Polonia e Milano, un momento dedicato a rileggere il lascito di Marx e Harvey e comprenderne la portata in riferimento alle sue pratiche di «socially engaged design». Nonostante il design sia oggi percepito come uno dei maggiori driver per l’economia, evidenzia Elzenbaumer, svolgere attività creative è ancora largamente concepito come «qualcosa di cui dover essere grati»,[38] qualcosa per cui valga la pena donare (leggi: lavoro gratuito) il proprio tempo. È anche per questo che i progettisti sono circondati da offerte e proposte di lavoro sottopagato o tirocini non retribuiti: una condizione normalizzata e istituzionalizzata dietro le promes- 122 — 123 se di esperienza e un futuro prestigioso, che continua a instradare sempre nuovi aspiranti designer dentro una spirale negativa di indebitamento privandoli della scelta di rifiutare o meno un lavoro e della possibilità (leggi: tempo) di dedicarsi a progetti che mettano in discussione lo status quo. Il tema dell’innovazione, così centrale nelle dinamiche che movimentano il lavoro nel terziario avanzato, porta con sé un’abbondante dose di disorientamento assieme all’entusiasmo che genera. Controverso sin dalle sue secolari fondamenta, è un processo così incessantemente necessario al funzionamento delle economie capitalistiche che finisce indiscutibilmente per informare le pratiche legate al design. Lasciando ai progettisti il difficile compito di sbrogliare la matassa che unisce, nella sue odierne derivazioni pseudo-responsabili, imprenditoria buona e imprenditorialità che crea nuova precarizzazione. La competizione che regna sovrana e incontrastata tra i progettisti pare esser costituita della stessa materia dell’innovazione. In maniera analoga genera una corsa e informa di sé i percorsi formativi, innestandosi nelle menti degli aspiranti designer come l’elemento che permetterà loro di crearsi un vantaggio rispetto ai colleghi–competitor. Una forza persuasiva che impatta sul piano sociale generando frammentazione sempre maggiore quanto più il mercato del lavoro creativo tende a essere saturo e che, per evidenti motivi, sin dai percorsi La p erc e z ione ide nt it a ria di una p rof e s s i o n e c r e a ti v a formativi s’intreccia con meccanismi di indebitamento personale. [29] Bianca Elzenbaumer, Designing Economic Cultures. Cultivating socially and politically engaged design practices against procedures of precarisation, tesi di dottorato di ricerca in Filosofia, Dipartimento di Design del Goldsmith College, University of London, 2013, p.19 (mia traduzione). [30] www.designingeconomiccultures.net. [31] i seminari sono stati condotti da BNA presso il Goldsmith College di Londra, con il supporto del Design Department della stessa facoltà londinese. I contenuti sono riassunti sul sito www.designingeconomiccultures.net/seminars-forewor/. [32] [34] [35] Elzenbaumer 2013 (op. cit.), pp. 23-28 (mie traduzioni). [33] www.brave-new-alps.com. [36] [37] [38] [39] Elzenbaumer 2013 (op.cit.), p. 52; 58; 100; 73 (mie traduzioni). 124 — 125 L a p e rce z ione ide nt it a ria di un a pr o fe s s i o n e c r e a ti v a — B I A N C A E L Z ENB A UM ER [39] vendere la propria anima, significa modularli come “docili” in termini foucaultiani, cioé “come qualcuno che sia manovrabile, qualcuno che risponda sistematicamente a sistemiche modificazioni introdotte artificialmente nel proprio ambiente”.» «Raffigurare i designer come homines œconomici, seppure essi non vogliano 2.6 Identità e appart enenza Rappresentazione della moltitudine Il lavoro creativo rientra in quel processo di scomposizione del lavoro astratto in quella «poliedrica esplosione dei lavori»[40] che rende difficoltoso qualsiasi tentativo di generare una rappresentazione e dunque una rappresentanza. Il concetto stesso di appartenenza è messo in discussione dal mutato rapporto con i luoghi di lavoro e di produzione. Dagli anni ’80, come sappiamo, il mestiere di designer è andato sempre più incontro alla democratizzazione dell’insegnamento e della pratica. La conoscenza dei software ha rimpiazzato il lungo apprendimento del mestiere del grafico, segnando la nascita di un nuovo tipo di progettista, già esperto ma paradossalmente non specializzato. Che sul piano della ricerca formale nel campo d’azione della grafica ha operato una netta cesura con la tradizione e i modelli della scuola italiana e razionalista europea. Come ha scritto Mario Piazza: La figura del progettista come maestro, oggetto di culto e dotato di forte carica carismatica, viene sostituito da situazioni di lavoro indifferenziate, che si muovono nel campo progettuale all’insegna di una ricerca del linguaggio come momento primario, come scopo del progetto.[41] È il segno dell’ingresso in scena di una nuova moltitudine di giovani professionisti che, con livelli diversificati di conoscenze, grazie allo scambio simultaneo ha coltivato gusti, stili di vita e concezioni del design sempre più legati [40] Aldo Bonomi, “Dalle mosche del capitale alla ragnatela del valore”, in Andrea Branzi (a cura di), The New Italian Design, Gra- fiche Milani, Milano 2007, p. 17. [41] [42] Mario Piazza, “Grafica zaino”, in Branzi 2007 (op. cit.), pp. 10–11. 126 — 127 a contaminazioni culturali che superano i confini nazionali. È l’emergere del grafico «con lo zaino in spalla», l’avvicinamento a uno stile di vita, a una pratica non più disgiunta dalla quotidianità vissuta, non più mestiere che nasce in un luogo protetto e sacrale, ma che si sviluppa dall’iterazione continua e diffusa.[42] Se cambiano i tempi, i luoghi e le pratiche del progetto, si trasforma conseguentemente anche l’identità del designer: le identità, evidentemente, poiché la moltitudine non parla più soltanto la lingua di una categoria professionale ma si esprime nella pluralità della classe creativa. Con la proliferazione dei percorsi formativi degli anni Novanta e la crescita esponenziale nei Duemila, con la nascita e il riconoscimento istituzionale di diverse nuove scuole, si diffonde sempre più l’aspirazione a una dimensione autoriale che motivi un maggiore coinvolgimento personale nel lavoro. La moltitudine creativa, anche per contrastare l’oggettiva difficoltà di un paese il cui mercato fatica ad assorbire la quantità di designer che popolano i corsi universitari, differenzia le proprie competenze e frammenta le professionalità. I percorsi esplorativi si moltiplicano e con essi si sfocano i confini dei perimetri professionali, sovrapponendosi. La pelle del graphic designer è ormai mutata, resa ibrida dalle nuove possibilità offerte dall’internet della conversazione. Cambiano, assieme ai luoghi di produzione, anche i luoghi di incontro. Assumono le forme virtuali delle comunità online, per mezzo delle quali le nuove generazioni di progettisti cercano di crearsi reti di conoscenze che li aiutino a far fronte a un mercato che non facilita il ricambio generazionale. L a p e rce z ione ide nt it a ria di un a pr o fe s s i o n e c r e a ti v a Emerge quindi nettamente uno dei tratti distintivi dei giovani lavoratori dei settori creativi, quella convivenza di identità individualiste e propensione alla cooperazione che spingono a superare i confini formali e i perimetri degli studi per costruire ragnatele relazionali di conoscenze e opportunità. Una tendenza a rappresentarsi direttamente sul mercato, per mezzo di network di saperi e risorse tra pari, che alle associazioni professionali sostituisce sempre più gli spazi di azione virtuali — siano essi vetrine autorappresentative o social network. A questo punto un interrogativo sorge spotaneo: saranno in grado queste nuove comunità epistemiche di assolvere il compito non più richiesto alle associazioni? Potranno davvero organizzare gli interessi comuni in modo autonomo, o i progettisti, silenti nel loro solipsismo produttivo e isolati dalla virtualità delle reti, finiranno per privarsi degli strumenti di rappresentanza? I dati delle ricerche più accurate condotte nel mondo professionale italiano e milanese descrivono un quadro in cui vi è proprio una domanda di rappresentanza per lo più inevasa, che corre in parallelo rispetto a un disinteresse crescente nei confronti degli organi rappresentativi tradizionali.[43] Sempre più l’identificazione con la professione si separa dalla concezione di appartenere a un corpo professionale portatore d’istanze, ancorché di interessi comuni, divenendo conseguentemente un collante sempre più debole. Come scrive Aldo Bonomi, Network professionali, cerchie di riconoscimento, comunità del sentire costituiscono importanti riferimenti per molti lavoratori della conoscenza, ma non si traducono in organizzazione degli [43] [44] cfr. Consorzio AAster, “Vecchie e nuove professioni a Milano: monadi, corporazioni o terzo stato in cerca di rappresentanza?”, Milano 2011, pp. 56–71; 120. 128 — 129 interessi. Il rapporto con il mercato e la fluidità dei legami con le organizzazioni di una parte di essi (e particolarmente dei nuovi professionisti) li espone al rischio permanente dell’isolamento, a una solitudine che sembra tonalità emotiva dominante nella narrazione delle nuove forme di lavoro professionale. Sebbene i nuovi professionisti non appaiano alla spasmodica ricerca di portavoce, la loro esclusione dalle istituzioni rappresentative può tradursi in marginalità rispetto all’allocazione delle risorse pubbliche – economiche, politiche, regolative, ecc. L’accesso ai residui trasferimenti di politica industriale ma anche ad altri beni (credito, formazione, informazioni) continua a essere in buona parte intermediato dai soggetti in grado di organizzare interessi su larga scala.[44] L a p e rce z ione ide nt it a ria di un a pr o fe s s i o n e c r e a ti v a 2.7 Riso rse Scambio e prossimità come strumenti di cura reciproca Abbiamo visto nella prima parte come le iniziative che nascono online perdano velocemente la propria spinta propositiva. È naturale allora pensare che la strada da percorrere, in un cammino volontario di accrescimento qualitativo della rappresentazione intesa come autopercezione identitaria della professione, debba passare per forme che esulino dagli spazi della rete. È necessario, in altre parole, immaginare che i progettisti affianchino all’intensa attività di networking online uno scambio reale, un incontro in prossimità. Se le tradizionali modalità del sindacalismo e dell’associativismo sono percepite come opportunità obsolete, è il caso di affrontare il problema dell’assenza di una dimensione politica nell’identità professionale del graphic design da un punto di vista differente. Le esperienze di Brave New Alps, come vedremo più avanti, ci insegnano a comprendere come l’instaurazione di strutture di supporto reciproco sia una conditio adeguata per giungere a una politicizzazione degli spazi di discussione. Perché allora non pensare che la condivisione delle risorse materiali possa costituire un primo passo verso un sentire comune che aiuti a plasmare collettivamente un’identità di gruppo per i progettisti? In una riflessione sul solco generazionale tra i grafici nati dopo la rivoluzione digitale e i progettisti delle vecchie botteghe, Mauro Panzeri ha individuato alcune cause storiche e antropologiche di quella che ha definito un’incomunicabilità tra generazioni: […] Il personalismo, la capitalizzazione individuale del lavoro e degli utili, l’autocompiacimento per la raggiunta fama ma anche la gelosia nel gestire il rapporto con i clienti hanno prevalso sulla consapevolezza del fatto — perché è un fatto — 130 — 131 che il lavoro del grafico è un lavoro collettivo, non individuale. Per tradizione, se di tradizione in questo caso si può parlare, la grafica italiana è sempre stata legata a individui, e sono rarissimi i casi di studi in cui si pratica il ricambio generazionale. Si esauriscono con le loro figure dominanti, come se il nome, l’idea dell’“autore” — quella che possiamo definire “autorialità” — siano più importanti della storia e del lavoro che uno studio ha saputo compiere e sviluppare. Gli autori esistono, certo; ma sono soggetti collettivi.[45] Se il lavoro del grafico è un lavoro collettivo, e oggi lo è in misura ancor maggiore — due fenomeni su cui altrove si è già abbondantemente scritto: la fine dell’epoca degli “autori” e la diffusione degli stili–virus in rete —, allora perché non considerare il potenziale politico di questo assunto? I dati delle ricerche di AAster, una volta di più, ci aiutano a individuare un fattore sottovalutato nelle pratiche progettuali e lavorative odierne. Nell’indagine “Design e creatività sull’asse Torino – Milano”[46] l’attenzione posta dai ricercatori del consorzio diretto da Aldo Bonomi sulle reti di relazioni professionali del tessuto lombardo– piemontese mette in risalto la dimensione interaziendale come economicamente strategica. Gli scambi informativi, i contatti, le relazioni di mercato e il prestigio dei professionisti si alimentano infatti in uno spazio trasversale agli studi. Scambi di personale, collaborazioni tra studi, condivisione di commesse sono tutti elementi che ricorrono abbastanza spesso nella quotidianità del lavoro progettuale secondo cerchie professionali che eccedono i confini dei singoli studi. [45] Mauro Panzeri, La grafica è un’opinione. Un mestiere che cambia, Ledizioni, Milano 2013, p. 115. [46] [47] cfr. Consorzio AAster, “Design e creatività sull’asse Torino–Milano”, Milano 2008, p. 32. L a p e rce z ione ide nt it a ria di un a pr o fe s s i o n e c r e a ti v a Ma se si parla di condivisione di tecnologie e macchinari, operazioni commerciali condotte in comune, accordi informali per ridurre le spese, le rilevanze crollano fino a divenire rarità. Come evidenzia il report: Le reti orizzontali esistono, ma sembrano perlopiù collegate a progetti singoli e scambi di tipo informale, mentre si rarefanno laddove potrebbero favorire lo sviluppo di economie rilevanti (acquisti, promozione, scambi tecnologici, e via di seguito).[47] Negli ultimi anni, stando a tutte le fonti di ricerca consultate in sede di stesura di questa tesi, molti progettisti sono stati costretti a chiudere gli spazi fisici degli studi per la difficoltà a sostenerne le spese, trasformando di conseguenza anche la configurazione del proprio lavoro. La condivisione delle risorse materiali sarebbe, dal nostro punto di vista, un punto di partenza verso la costituzione di economie di supporto reciproco. Condividere gli strumenti del progetto, oltre agli spazi, sarebbe una risposta anti– individualistica alla crisi di mercato. Risponderebbe a quel desiderio di comunità che è diffuso specie tra i più giovani, e spingerebbe la prossimità strumentale degli spazi di co– working su un livello qualitativamente più alto: quello della condivisione delle stesse pratiche del progetto. Stimolando (perché no?) anche momenti di riflessione in grado di aprire sentieri progettuali non dettati dalle esigenze del mercato. 132 — 133 2.8 E c onom ie s perim ent a li La ricerca portata avanti da Brave New Alps si è evoluta in un secondo progetto di residenza condivisa, ispirato alle riflessioni di Anthony Dunne sul design critico,[48] e pensato come un cuscinetto di protezione temporaneo tra la fine del percorso accademico e l’ingresso nel mondo del lavoro. studio Cantiere per pratiche non–affermative caso Dieci neolaureati provenienti dalle facoltà di design italiane, che avessero già affrontato temi sociali, politici o ambientali, sono stati invitati ad abitare uno spazio in cui la «produzione biopolitica» potesse concretarsi in un movimento di rifiuto e allo stesso tempo di creazione e resistenza. «Volevamo creare uno spazio in cui menti e corpi potessero, per un periodo esteso, incontrarsi e mettere in pausa quella frammentazione che i designer vivono nel quotidiano. Creare una situazione che almeno in potentia avrebbe offerto la possibilità di unire le forze, di dare forma a ciò che Hardt e Negri definiscono “un corpo sociale che sia più potente di qualsiasi singolo corpo individuale”.»[49] Una serie di seminari avrebbe fornito ai partecipanti quegli input teorici con cui innescare La p erc e z ione ide nt it a ria di una p rof e s s i o n e c r e a ti v a la «politicizzazione dello spazio», sin dall’inizio concepito come contenitore di un’intelligenza collettiva al cui interno i ruoli fossero interscambiabili nel corso dell’esperienza. Un’attenzione alle micro-politiche di gruppo, questa, che dichiaratamente si poneva tra gli obiettivi iniziali della residenza: rendere visibili le strutture e le relazioni di potere, affinché fossero contestabili e negoziabili. I due mesi vissuti nella residenza condivisa presso il complesso culturale Careof docva di Milano, nell’autunno del 2011, sono stati contraddistinti da un costante interrogarsi sulle possibilità di indirizzare la creatività individuale e di gruppo verso modi di progettare che non fossero dettati dal mercato e non comportassero la precarizzazione di altri individui. La vita in comune dentro e fuori dallo spazio progettuale condiviso, intervallata dalle giornate di apertura al pubblico dei seminari e dagli intensi momenti di scambio con gli esperti e i progettisti invitati a tenere lecture (Hervé Baron, Serpica Naro e i collettivi Carrotworkers e San Precario), ha certamente aiutato i partecipanti a comprendere meglio verso quali sentieri orientare la ricerca di vie sperimentali da percorrere per costruire quelle «strutture di supporto» utili a liberare il potenziale creativo necessario a ideare nuovi e diversi immaginari. Co-working ≠ co-living Un aspetto cruciale nei resoconti di Elzenbau- 134 — 135 La p erc e z ione ide nt it a ria di una p rof e s s i o n e c r e a ti v a 136 — 137 of DOCVA, in due momenti diversi (seconda e penultima settimana); flyer della Designers’ Inquiry. In questa doppia pagina: [figg. 12–14] lo spazio di lavoro all’interno della residenza presso Care- mer circa l’esperienza del Cantiere riguarda la costruzione di un legame di cura reciproca formatosi nel corso della residenza condivisa. Condividere sin dall’inizio un aspetto fondamentale come il cibo ha evidentemente aperto la strada verso una dedizione reciproca risultante in un continuo supporto vicendevole a partire dagli stessi aspetti del quotidiano che costituiscono gli elementi di pressione politica e sociale sui singoli: ansie, dubbi e paure che la precarizzazione porta con sé. «Trovarsi in un ambiente in cui fosse possibile esprimere liberamente dubbi, paure e desideri, mostrare debolezze, in cui fare strategia insieme, è stato cruciale sia per far emergere gli interrogativi su come affrontare la precarietà, che allo stesso tempo vivere la possibilità di contrastarla collettivamente.»[50] La cura reciproca, dunque, come elemento centrale nella produzione biopolitica, funzionale alla creazione di relazioni sociali forti come quelle emerse all’interno della co-residenza del Cantiere, che hanno fatto emergere un processo collettivo, un «divenire altro» verso un committment di gruppo saldamente costruito su una struttura di supporto reciproco sia affettivo che intellettuale. La p erc e z ione ide nt it a ria di una p rof e s s i o n e c r e a ti v a [48] cfr. Anthony Dunn e Fiona Raby, “Design as critique” in Specultive Everything. Design, Fiction and Social Dreaming, The MIT Press, Londra 2013, pp. 33-45. [49] [50] Elzenbaumer 2013 (op. cit.), p. 128; 138. 138 — 139 2.9 Sul c am po Una nuova cultura progettuale Per concludere questo percorso condotto all’interno del contesto lavorativo del graphic design, una volta comprese le complesse relazioni che si inseriscono nell’ambito del lavoro immateriale postfordista e analizzati nel dettaglio due casi di pratica critica del progetto, val la pena di trasferire l’indagine su una dimensione sperimentale. È il caso, a questo punto, di domandarsi quali sono le espressioni dell’identità professionale del graphic design proprie di quei progettisti in procinto di accedere al mercato del lavoro; qual è lo spazio e l’importanza che i giovani designer riservano alla socialità e alla condivisione di esperienze, bisogni primari di ciascuno di noi eppure in qualche modo soffocati dalle forme d’interazione virtuale e dall’individualismo competitivo; quale il grado di partecipazione alle associazioni di categoria. È altresì opportuno, per aprire un varco al sentiero progettuale che sarà intrapreso nella parte seguente, discutere con il cluster di progettisti intervistati delle possibili linee d’intervento rispetto a quel desiderio di comunità che — come si vedrà — sarà ribadito dagli stessi designer. Sono stati intervistati quattro designer in giro per l’Italia, le cui storie sono in qualche modo rappresentative, ciascuna con i propri elementi di singolarità, di una nuova generazione di progettisti che ha da poco varcato la soglia d’ingresso della professione. Dopo una serie di domande introduttive a proposito dei percorsi biografici e formativi, ai designer è stato chiesto di descrivere la propria percezione rispetto a un’idea di professionalità per il graphic design, con riferimento al proprio ruolo e alle mansioni svolte quotidiamente. Dal ruolo praticato nell’ambito progettuale si è passati a dialogare del possibile ruolo in una comunità di progettisti, che esiste e pulsa nella virtualità delle reti, ma non trova i tempi e gli spazi per un incontro reale. L a p e rce z ione ide nt it a ria di un a pr o fe s s i o n e c r e a ti v a Alessandra — 25 anni, vive a Catania; ba Accademia di Belle Arti. Graphic designer con contratto part–time presso un’azienda di ristorazione, attualmente studia per un master e si impegna in progetti artistico–culturali. Intervistata il 30 ottobre 2014. bio Definisce il suo profilo professionale «schizofrenico», poiché al part–time come «grafico interno» in un’azienda di ristorazione (cura l’identità visiva e la comunicazione online e social) alterna un impegno sia autonomo sia come membro di un’associazione operante all’interno di un’accademia di arti visive e design, nella presentazione di progetti artistico-culturali presso enti istituzionali, oltre che frequentare un master. Non si descrive come precaria: definisce la sua condizione una «tensione irrisolta» tra i poli della sicurezza [stabilità] e il desiderio di crearsi sempre nuovi percorsi. Vive e lavora nella città in cui è cresciuta e ha studiato, Catania, sebbene abbia fatto esperienze di scambio all’estero e collaborazioni di breve durata in città del nord Italia. «Cerco di portare qualcosa qui piuttosto che portare me fuori.» Percepisce un clima lavorativo di apertura, relativo all’ambito strettamente commerciale della professione, principalmente dovuto a una consapevolezza nuova da parte di imprese e imprenditori circa la necessità di inserire figure operanti nell’ambito della comunicazione online (social) — parla espressamente di figure «che non si occupano [esattamente] di grafica». In questa «presa di coscienza» dovuta alla crescita dei social media, intravede la costituzione sul mercato di una figura dinamica meno legata al lato tecnico della professione e più alle competenze culturali e relazionali. Essendo tuttavia radicata in ambiti culturali e di promozione sociale evidenzia la necessità di autoprodursi quale unica via da percorrere, data le poche chances offerte dalla sua città. Conduce la sua ricerca personale di opportunità 140 — 141 (partecipazione a concorsi istituzionali) impiegando tempo che potrebbe altrimenti monetizzare. «È lavoro, non c’è alcun dubbio. Tutto lavoro che se ne va.» Conosce un buon numero di colleghi operanti in città, con i quali non ha mai condiviso luoghi e momenti di socialità dedicati alla condivisione di conoscenze legate a condizioni lavorative, diritti e tutele. Ritiene quindi necessaria l’istituzione di momenti di confronto, occasioni in cui mettere in pratica uno scambio che di solito non entra nelle agende dei progettisti. Gestisce in autonomia gli aspetti burocratici e previdenziali della sua professione, dedicando anche del tempo all’informazione in tema di lavoro e diritti. Pianifica di iscriversi all’associazione di categoria anche perché ha avuto modo di conoscere in profondità l’operato di aiap — per conoscenza diretta di membri dell’associazione operanti nelle scuole/ accademie che ha frequentato/frequenta —, al punto che definisce una «presenza forte» quella di aiap nel suo territorio. È presente nelle piattaforme di valorizzazione online, sia specifiche (Behance) che generiche (LinkedIn), grazie alle quali ha avuto opportunità concrete di lavoro. Distingue la scarsa rilevanza che questi strumenti hanno nel suo ambito territoriale («perché il settore non ha un livello di aggiornamento e utilizzo tale da essere influenzato dai circuiti virtuali») rispetto alla grande utilità in termini di contatti e immagine nella dimensione virtuale sovra–locale. L a p e rce z ione ide nt it a ria di un a pr o fe s s i o n e c r e a ti v a «Mi piacerebbe essere definita graphic designer perché lo paragono quasi a un percorso artistico: è l’aspetto più alto del lavoro che faccio. Rispetto alle varie competenze che ricopro ogni giorno, tuttavia, questo ruolo può essere limitativo. Se la qualità dei compiti che svolgo è più bassa di ciò che dovrei aspettarmi, la quantità delle mansioni è tale da farmi star stretto quest’abito.» 142 — 143 Daria — 29 anni, vive a Trieste; ba in Cinema e diploma biennale presso Scuola di Grafica. Graphic designer freelance con partita iva a regime agevolato. Intervistata l’11 novembre 2014. bio Ex fuori sede a Venezia, dopo alcune esperienze (stage e iniziative legate al mondo dell’arte) è tornata nella sua città, nella quale ha appena iniziato a lavorare da freelance al termine dell’ennesimo contratto di collaborazione — da lei definiti «situazioni ambigue» a causa del protrarsi di promesse di lavoro fisso a tempo pieno. Lavorare in provincia per lei equivale a confrontarsi con una realtà decentrata in cui la comunicazione, legata alle piccole imprese del territorio, opera a un livello «più basico» e non coglie appieno le opportunità offerte dalle professionalità creative. Vista come uno stimolo, la sua condizione di professionista creativa in un contesto a basso riconoscimento è il punto di partenza per crearsi da zero nuove occasioni. «È il mio mestiere, è quello che so fare ed è ciò su cui cerco di costruirmi una professionalità.» Non ha mai pensato di iscriversi all’associazione di riferimento sia per il costo elevato delle tessere associative, sia perché ritiene il tariffario proposto da aiap uno strumento inadatto a contesti come quello in cui si trova ad operare. «La grafica è sempre qualcosa per cui si spende poco, è l’ultima voce.» L a p e rce z ione ide nt it a ria di un a pr o fe s s i o n e c r e a ti v a «Non dedico del tempo alle problematiche della mia professione, ma vorrei farlo. Sento l’esigenza di farlo e credo sia un’esigenza comune… però manca un connettore, qualcuno che faccia da mediatore.» Parla di una mancanza di riferimenti per ciò che riguarda la sfera dei diritti all’interno della sua professione, di una difficoltà a individuare possibili interlocutori (sindacati, associazioni, politica). Nonostante conosca un discreto numero di professionisti del settore operanti nella sua stessa città, non le è mai capitato di condividere con essi momenti di socialità dedicati allo scambio di informazioni su diritti e tutele. Ma la questione è per lei più estesa: «Manca un riferimento a livello generazionale, in ogni caso. Abbiamo tutti gli stessi problemi, al di là della partita iva. È che non sappiamo davvero a chi rivolgerci.» Dedica molto tempo al net surfing sulle piattaforme inspirational, dalle quali però non ha mai ricavato opportunità lavorative concrete. Accoglierebbe molto volentieri, all’interno di queste piattaforme, la presenza di spazi dedicati all’approfondimento di aspetti «più sociali». 144 — 145 Marco — 32 anni, vive a Milano; masc in Design della Comunicazione. Imprenditore (ha appena avviato un’attività di produzione editoriale e stampa tipografica) e collaboratore freelance; partita iva. Intervistato il 6 novembre 2014. bio Nato e cresciuto a Milano, ha studiato al Politecnico e dopo alcuni anni da dipendente a tempo indeterminato presso uno studio creativo ha chiuso con il lavoro subordinato per intraprendere una strada in completa autonomia e far nascere la sua casa editrice che è oggi tra gli esempi più interessanti di un certo ritorno alla produzione analogica. Negli anni successivi alla laurea ha scoperto il mondo materico della stampa non-digitale e così le carenze derivanti da una formazione accademica noncurante del lato esecutivo (e materiale) della produzione grafica sono diventati dei vuoti da riempire, degli stimoli per un percorso di auto– apprendimento che ha condiviso con sempre più persone. È proprio questo lato produttivo del mestiere che quotidianamente lo tiene in contatto con un gran numero di professionisti, molti dei quali curiosi quanto lui delle tecniche non sperimentate negli anni della formazione. I workshop che da anni organizza sono per alcuni partecipanti l’inizio di un percorso creativo, per tutti una (ri)scoperta di aspetti fondanti della cultura grafica. «Io sono molto per la parte pratica del mestiere e poco per quella teorica.» Per questo stesso motivo non ha mai manifestato l’esigenza di iscriversi ad associazioni di categoria. Refrattario agli ambienti in cui «si parla tanto, ma non di grafica», è evidentemente poco interessato a questioni condivise sul tema del lavoro. La sua opinione sul clima lavorativo attuale è netta. L a p e rce z ione ide nt it a ria di un a pr o fe s s i o n e c r e a ti v a «Sicuramente al giorno d’oggi devi guadagnare abbastanza per permetterti una partita iva. Io non mi lamento, ma pagherei volentieri meno tasse. E sulle tutele… beh non credo di avere delle tutele.» È, questa, la testimonianza di chi al momento sta scommettendo molto su un progetto imprenditoriale che unisce le passioni per la manualità della professione e le autoproduzioni editoriali alla necessità di generare introiti, dati i costi di gestione che una tipografia può comportare. Si comprende allora l’urgenza del fare rispetto a qualsiasi istanza condivisa o momento di confronto all’interno della professione. Lara — 28 anni, vive a Milano; masc in Design della Comunicazione. Collaboratrice con partita iva a regime agevolato. Intervistata il 22 novembre 2014. bio Cresciuta a Genova, si è trasferita a Milano per conseguire la laurea magistrale, dopo il triennio in design del prodotto. È grata alla città che l’ha accolta perché le ha dato modo di circondarsi di «persone speciali», con le quali condivide interessi e esperienze. Oggi lavora per un importante studio milanese con orari da dipendente (straordinari a cadenza settimanale compresi), ma non ha un contratto e fattura il suo compenso mensile con una partita iva. È questa la nota dolente di un’esperienza altrimenti preziosissima, che l’ha aiutata a crescere e ha affinato e ampliato notevolmente le sue competenze. «La [loro] strategia è stata quella di aver creato un gruppo così armonioso di persone, che queste arrivano a non curarsi delle ore in più passate in studio.» 146 — 147 «La figura di graphic designer non mi è mai piaciuta del tutto. Preferisco parlare di “direzione creativa”, è più un approccio tout court a ogni aspetto della vita.» «Il fatto che oggi contamini il mio lavoro con ricerche sul campo è un grande stimolo e un arricchimento di questa mia esperienza. Di contro, c’è che gli output visivi alla fine debbano comunque essere impeccabili, per cui si arriva raddoppiare il tempo dedicato ai progetti. Mentre lo stipendio resta sempre uguale.» L a p e rce z ione ide nt it a ria di un a pr o fe s s i o n e c r e a ti v a Se i progetti recenti l’hanno portata a esplorare confini nuovi e inaspettati della professione — la contaminazione con approcci di tipo più antropologico che sempre più caratterizza il suo lavoro è l’elemento che più la gratifica —, non si può dire che la busta paga sia cresciuta allo stesso modo delle competenze e delle responsabilità. La dimensione ridotta dello studio, nonostante le commesse di livello prestigioso e di caratura internazionale, fa sì che la gestione dei soci fondatori si mantenga quasi su un piano «familiare». Di conseguenza, lavorare nel suo studio significa dover accettare le regole inappellabili dei suoi ‘capi’. «Con tutti i lati positivi che questo può avere, è sempre come essere ospiti in casa loro. Tu dai un contributo sempre più importante e responsabilizzato alla loro crescita sul mercato, ma se non accetti le regole puoi solo andartene via.» È questa la caratteristica peculiare di uno studio che, pur crescendo costantemente nel tempo, dal punto di vista dei suoi collaboratori/dipendenti resta una tappa intermedia, un hub in cui stare «mediamente non più di due anni», dal quale è necessario poi «prendere il volo». Lara è convinta che sia il momento di discutere in modo collettivo di una serie di diritti di base per la professione. Trova ottima l’idea di un progetto che aiuti a condurre i progettisti verso un maggior grado di autoconsapevolezza diffusa della propria condizione. D’altra parte non vede nell’associazione di categoria un soggetto in grado di affrontare questo genere di problematiche, poiché, più che un cuscinetto di protezione, al momento «aiap mi dà più l’idea di una costosa poltrona Cassina — collezione “I Maestri”, s’intenda.» Nonostante non curi troppo i suoi profili Cargo/Behance, sottolinea l’importanza di essere presenti su queste piattaforme. 148 — 149 Rilevanze Le quattro interviste sono state raccolte per validare l’idea progettuale che sarà presentata nella parte successiva, secondo un metodo di indagine basato su incontri via Skype e volto a far emergere dati qualitativi piuttosto che quantitativi. I designer intervistati vivono nella perenne tensione tra la ricerca di una stabilità e le numerose strade rese percorribili da un’attitudine alla flessibilità che essi possiedono come dote incorporata. Rivelano un sentimento di esclusione dalla dimensione pubblica dovuto certamente allo scarso sostegno ai redditi e alla vulnerabilità al rischio disoccupazione. Riportano un utilizzo diffuso del cosiddetto «welfare fai da te», ovvero sono acquirenti di servizi al di fuori del welfare pubblico. Le testimonianze raccolte contribuiscono a delineare i tratti di una figura professionale che sta mutando forma, rielaborando i confini delle proprie competenze: sia perché è immersa nei circuiti accelerati di comunicazione– conversazione online, sia per una maggiore contaminazione con metodologie proprie delle scienze sociali. Non mancano, ad ogni modo, i casi di riscoperta di mansioni tradizionali legate a strumenti del lavoro manuale analogico. Grazie alla rete, infine, i designer alimentano la propria spasmodica ricerca individuale di un sentiero professionale e culturale che sia quanto più ramificato possibile, per cogliere appieno le opportunità e le sfide di cui i territori della creatività sono disseminati e confermare così la propria identità di soggetti creativi. L a p e rce z ione ide nt it a ria di un a pr o fe s s i o n e c r e a ti v a 2.10 Co nc l us ioni Il percorso socio–antropologico battuto in questa seconda parte ha offerto molteplici angolazioni dalle quali riflettere sulla condizione odierna del graphic designer in quanto soggetto interno alla «nebulosa» della creatività. I graphic designer rientrano nell’insieme di quelle professioni non regolamentate che oggi soffrono di ciò che alcuni hanno definito «disallineamento» tra governance statuale e reti professionali. Ne soffrono in misura maggiore, evidentemente, rispetto alle professioni ordinistiche, sia per la debolezza nelle dinamiche di rappresentanza sia perché la crisi degli ultimi anni ha accentuato la fragilità dei settori del professionismo sprovvisti delle più importanti strutture di protezione sociale. Così come è diffusa la consapevolezza della scarsa appetibilità verso i soggetti sindacali esistenti, visti come organizzazioni a tutela esclusiva del lavoro normato e salariato. Coltivare la propria identità di soggetto creativo, divenire ‘qualcuno’ tra coloro che «disegnano il presente», appare oggi un’attività dall’approccio fortemente individualistico, da condurre con il massimo sforzo possibile, e con il forte rischio di soffocare i propri impulsi critici rispetto alle dinamiche produttive e alle condizioni lavorative nelle quali si opera. Ricreare le condizioni per l’identificazione dei singoli in un corpo professionale, portatore di istanze a tutela di interessi collettivi, sembra dover passare necessariamente attraverso una maggiore propensione alla cooperazione, a partire dalle condivisione delle stesse risorse materiali. 150 — 151 Bibliografia monografie Aranda, Julieta; Vidokle, Anton; Wood, Brian Kuan (a cura di) e–flux journal. Are You Working Too Much? Post–Fordism, Precarity and the Labor of Art, Sternberg Press, Berlino 2011 Banfi, Dario e Bologna, Sergio Vita da freelance. I lavoratori della conoscenza e il loro futuro, Feltrinelli, Milano 2011 Berardi Bifo, Franco e Formenti, Carlo L’eclissi, Manni, Lecce 2011 Berardi Bifo, Franco e Sarti, Alessandro Run. Forma, vita, ricombinazione, Mimesis edizioni, Milano 2008 Bierut, Michael; Drenttel William; Heller, Steven (a cura di) Looking Closer 5: Critical Writings on Graphic Design, Allworth Press, New York 2006 Bonomi, Aldo La città che sente e pensa. Creatività e piattaforme produttive nella città infinita, La Triennale Design Museum, Milano 2010 Bonomi, Aldo e Borgna, Eugenio Elogio della depressione, Einaudi, Torino 2011 Branzi, Andrea (a cura di) The New Italian Design, Grafiche Milani, Milano 2007 Bukoski, Kate Ann Exploring Network of Relations in the Graphic Design Profession, ProQuest, Ann Arbor 2006 152 — 153 Carrotworkers Collective Surviving Internships. A Counter Guide to Free Labour in the Arts, Hato Press, Londra 2011 Codeluppi, Vanni Il biocapitalismo. Verso lo sfruttamento integrale di corpi, cervelli ed emozioni, Bollati Boringhieri, Torino 2008 De Masi, Domenico La fantasia e la concretezza. Creatività individuale e di gruppo, Rizzoli, Milano 2003 Dunn, Anthony e Raby, Fiona Speculative Everything. Design, Fiction and Social Dreaming, The mit Press, Londra 2013 Elzenbaumer, Bianca Designing Economic Cultures. Cultivating socially and politically engaged design practices against procedures of precarisation, tesi di dottorato di ricerca in Filosofia, Dipartimento di Design del Goldsmith College, University of London, Londra 2013 Florida, Richard L’ascesa della nuova classe creativa. Stile di vita, valori e professioni, Mondadori, Milano 2003 Foucault, Michel Nascita della biopolitica, Zanichelli, Milano 2005 Flusser, Vilém Filosofia del design, Bruno Mondadori, Milano 2003 Flusser, Vilém La cultura dei media, Bruno Mondadori, Milano 2004 Gomez–Palacio, Bryony e Vit, Armin Graphic Design, Referenced. A Visual Guide to the Language, Applications, and History of Graphic Design, Rockport Publishers, Beverly 2009 Heller, Steven The Education of a Graphic Designer, Allworth Press, New York 2005 Heller, Steven e Fernandes, Teresa Becoming a Graphic Designer. A Guide to Careers in Design, John Wiley & Sons, Hoboken 2010 Lovink, Geert e Rossiter, Ned (a cura di) MyCreativity Reader. A Critique of Creative Industries, Institute of Network Cultures, Amsterdam 2007 Panzeri, Mauro La grafica è un’opinione. Un mestiere che cambia, Ledizioni, Milano 2013 Potter, Norman Cos’è un designer, Codice edizioni, Torino 2010 Raunig, Gerald Fabbriche del sapere, industrie della creatività, Ombre corte, Verona 2012 Raunig, Gerald; Ray, Gene; Wuggenig, Ulf, (a cura di) Critique of Creativity. Precarity, Subjectivity and Resistance in the ‘Creative Industries’, MayFlyBooks, Londra 2011 Sennett, Richard L’uomo artigiano, Feltrinelli, Milano 2008 Sennett, Richard L’uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale, Feltrinelli, Milano 1999 Shaughnessy, Adrian How to be a Graphic Designer without losing your soul, Princeton Architectural Press, New York 2005 Soar, Matt Graphic Design / Graphic dissent: towards a cultural economy of an insular profession, tesi di laurea in Filosofia presso la University of Massachussetts, Amherst 2002 154 — 155 Thomson, Ellen Mazur The Origins of Graphic Design in America 1870-1920, Yale University Press, Boston 1997 Weber, Max Schriften 1894-1922, Kröner, Stuttgart 2002 Žižek, Slavoj Dalla tragedia alla farsa. Ideologia della crisi e superamento del capitalismo, Ponte alle Grazie, Milano 2010 Žižek, Slavoj Benvenuti in tempi interessanti, Ponte alle Grazie, Milano 2012 articoli Bonsiepe, Gui “A Step Towards the Reinvention of Graphic Design”, Design Issues, vol. 10, n. 1, Primavera 1994, The mit Press, Cambridge Massachussetts Brovelli, Serena; Farrauto, Luigi; Sfligiotti, Silvia “La grafica è un luogo comune”, Progetto Grafico, anno 10, n. 22, Autunno 2012, aiap, Milano Buchanan, Richard “Education and professional practice in design”, Design Issues, vol. 14, n. 2, Estate 1998, The mit Press, Cambridge Massachussetts Ciccarelli, Roberto “I nuovi poveri sono gli autonomi a partita Iva”, il manifesto, 30 ottobre 2014 de Peuter, Grieg “Creative Economy and Labor Precarity: A Contested Convergence”, Journal of Communication Inquiry, vol. 35, n. 4, Ottobre 2011, sage Publications, New York De Stefanis, Cinzia “La norma tecnica Uni sulle professioni”, Le Nuove Professioni, Italia Oggi, 31 gennaio 2013 McRobbie, Angela “Re–Thinking. Creative Economy as a Radical Social Enterprise”, Variant, n. 41, Primavera 2011, Glasgow Marinelli, Arvedo “Un volto a tre milioni di professioni”, Le Nuove Professioni, Italia Oggi, 31 gennaio 2013 Ventura, Gabriele “La riforma delle professioni non ordinistiche”, Le Nuove Professioni, Italia Oggi, 31 gennaio 2013 Wild, Lorrayne “That was then and this is now: but what is next?”, Emigre, n. 39, 1996, Berkeley in rete Associazione xx Maggio “Analisi dei nuovi dati sulla Gestione Separata inps del 2013”, http://www.tutelareilavori.it/website/osservatorio-sul-lavoro-atipico-del-prof-patrizio-di-nicola/687-analisi-dei-nuovi-dati-sulla-gestione-separata-inps-del-2013, 31 ottobre 2014 Cantiere per pratiche non–affermative “Designers Inquiry. Un’inchiesta sulla condizione socioeconomica dei designer in Italia”, http://www.pratichenonaffermative.net/inquiry/it/, 31 marzo 2015 Commissione Europea “Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro di qualità per i tirocini”, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=COM:2013:0857:FIN:IT:PDF, 14 marzo 2015 156 — 157 Consorzio AAster “Design e creatività sull’asse Torino-Milano”, http://images.torino-internazionale.org/f/Editoria/pa/parte2.pdf, 13 aprile 2014 Consorzio AAster “Vecchie e nuove professioni a Milano: monadi, corporazioni o terzo stato in cerca di rappresentanza?”, http://www.mi.camcom.it/c/document_library/get_file?uuid=e4176c8d-924c-4141-a8fb-547e2514afef&groupId=10157, 31 marzo 2015 Fumagalli, Andrea “Trasformazione del lavoro e trasformazioni del welfare: precarietà e welfare del comune (commonfare) in Europa”, http://www.uninomade.org/trasformazione-del-lavoro-e-trasformazioni-del-welfare-precarieta-e-welfare-del-comune-commonfare-in-europa/, 15 novembre 2013 isfol “Indagine Plus. Il mondo del lavoro tra forma e sostanza – terza annualità”, http://www.isfol.it/temi/Lavoro_professioni/mercato-del-lavoro/plus, 31 marzo 2015 Lorey, Isabell “Governmentality and Self Precarization. On the normalization of cultural producers”, http://eipcp.net/transversal/1106/lorey/en, 8 aprile 2014 Lovink, Geert “Some notes on the future of Communications & Media Design Degrees”, http://networkcultures.org/geert/2013/01/28/some-notes-on-the-future-of-communication-media-design-degrees, 18 giugno 2014 Precarious Workers Brigade “Training for Exploitation? Towards an alternative curriculum”, http://precariousworkersbrigade.tumblr.com, 23 gennaio 2014 Indice delle figure Prima parte fig. 1 fig. 2 fig. 3 fig. 4 fig. 5 fig. 6 45 50 88 88 89 89 Seconda parte fig. 7 fig. 8 fig. 9 fig. 10 fig. 11 fig. 12 fig. 13 fig. 14 118 119 120 120 121 136 136 137 Indice delle tavole Prima parte grafo 1 grafo 2 grafo 3 grafo 4 grafo 5 37 46 56 57 57 158 — 159 Grazie a Giovanni e Teresa per il sostegno, e al professor Mauro Panzeri per la fiducia. La democratizzazione del graphic design ha segnato l’ingresso in scena di una moltitudine di giovani professionisti che si esprime nella pluralità della classe creativa. La tecnologia ne ha trasformato i modi e i luoghi di produzione e di incontro. In uno scenario di deprofessionalizzazione e flessibilità precarizzante, la collaborazione diffusa nei social network è in grado di innescare pratiche critiche egualitarie in direzione opposta al professionalismo dei saperi taciti ed esclusivi? La creative economy che cresce e si evolve tra i nodi del web può costruire laboratori di solidarietà e ricomposizione a partire dai suoi protagonisti?
Scaricare