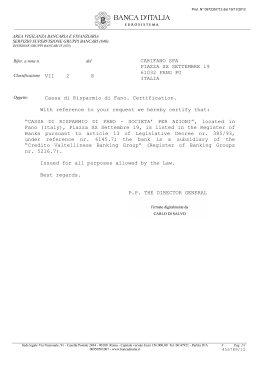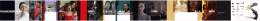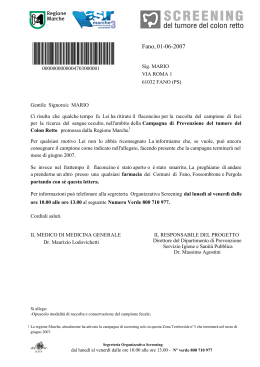II CULTURA FANESE QUANDO I NOSTRI AVI ERANO “FANESTRI” Dai “Commentarii de bello civili” di Giulio Cesare, che occupò Fanum senza combattere e che vi lasciò una coorte, sappiamo che nel 49 a.C. Fano, Fanum, indicata senza la specificazione di Fortunae, esisteva. Era più piccola di quella a noi nota e non ci è attestato come si chiamavano i suoi abitanti. Solo dopo che Fanum divenne con Augusto “Colonia Iulia Fanestris” possiamo dire cose più certe sul nome dei suoi abitanti facendoci guidare da alcune iscrizioni marmoree conservate nel Museo Civico; molte altre sono andate distrutte: speriamo che qualcuna possa essere ritrovata. Apro una parentesi: non si deve scrivere Julia (errore in cui anch’io sono caduto) per il semplice fatto che la “i lunga” (iota) non fa parte dell’alfabeto latino. Tale lettera fu in seguito usata da alcuni vocabolari e da molti editori di classici “per comodità”, come dice il Gandiglio nella sua grammatica. Un’iscrizione che attira subito la nostra attenzione è quella in cui Colonia Iulia appare chiaramente: è la lapide sepolcrale di Lucio Tituleno. Per documentare i “fanestri” ci sono le iscrizioni sulle tombe di Caio Vergisio sèviro “fanestrium” e quella dell’oculista (medicus ocularius) Quinto Gelio Nicomede anche lui sèviro della Colonia Iulia Fanestris. Dalla intera scritta di questa lapide sembra che Fanester venisse addirittura usato come nome di persona. C’è da ricordare che, secondo un codice a noi pervenuto, Vitale, il vescovo di Fano (498-501) di cui si ha per primo notizia certa, si firmò “Vitalis episcopus fanestrensis” in calce alle decisioni prese nel sinodo indetto nel 499 dal Papa Simmaco. Ma quel fanestrense sembra solo un’amplificazione di fanestre e quindi pensiamo che i nostri antenati mai vennero chiamati fanestrensi. A questo punto qualcuno chiederà: ma è possibile che in proposito non ci sia nulla nel Codice Nonantolano che comprende la “Vita Sancti Paterniani”? In quella Vita non solo non vengono mai nominati i fanesi, ma non compare la stessa Fano che l’amanuense, insicuro sulla grafia carolina in cui era scritto il codice dal quale attingeva, scrisse il nome della città in modo tale che agli occhi di successivi copisti l’espressione “episco53 pus Fani” diventò “episcopus Turi, Suri, Juri”, creando gran confusione negli storici. Il fatto è che quella “Vita” non è tutta da accettare (così è stato detto da illustri studiosi), basta ricordare che Paterniano, negli anni di vicende che tradizionalmente a lui si attribuiscono, è fatto passare per eremita quando l’eremo era completamente sconosciuto in occidente. Nei secoli seguenti a volte si usò “fanese”, a volte “fanestre”. Sopra l’effigie dell’Arco di Augusto scolpita nel primo decennio del 1500 (sulla facciata della chiesa di S. Michele) c’è scritto che la rovina della parte superiore dell’arco avvenne nella guerra di Pio II “contra fanenses”. Qualche decennio dopo, invece, nella lapide dettata da Adriano Negusanti e che fu murata sotto l’immagine di Clemente VIII (Papa Aldobrandini, nato a Fano da padre fiorentino) il Consiglio, che volle quella lapide in occasione di una sosta a Fano del Pontefice (1598) , definisce se stesso “fanester”. Nel 1743 la Bolla con cui Papa Benedetto XIV (Lambertini) comunica al Capitolo della cattedrale e ai canonici la concessione di alcuni privilegi parla di Chiesa fanese (fanensis); Tommaso Massarini, che scrive dal 1791 al 1840, intitola i suoi resoconti “Cronaca fanestre”. Dunque fanese e fanestre si alternarono, ma alla fine ebbe la meglio, e giustamente ci sembra, il primo termine. 2007 54 CON VITRUVIO ANDIAMOCI PIANO I resti dell’edificio pubblico d’epoca romana visitabili nell’area sotterranea di S. Agostino (ex convento e chiesa) non coincidono con la basilica, civile o forense che dir si voglia, di cui si parla nel V libro del “De architectura” di Vitruvio. Ma la questione è un’altra. Sono veramente di Vitruvio le misure e la descrizione della basilica (una specie di foro coperto: lo preciso per chi non ha dimestichezza con l’archeologia) costruita a Fano? Ho riletto attentamente quello che il Pellati scrisse per attribuire a Vitruvio la paternità delle righe dedicate alla basilica di Fano: ma le sue argomentazioni mi sono sembrate piuttosto esili. Mi sembra invece possibile che il brano attribuito a Vitruvio sia stato interpolato, cioè sia stato messo in mezzo al testo vitruviano dall’amanuense che vergò l’unica copia del “De architectura” vitruviana ai posteri giunta per merito di Poggio Bracciolini che la trovò nel 1414 a Montecassino e che in seguito purtroppo andò perduta. Il passo che riguarda la basilica di Fano poteva essere una nota a margine del testo vitruviano o un foglio risalenti al vero architetto costruttore della nostra basilica. Ecco perché parecchi filologi e latinisti (Schmidt, Krohn, Silvio Ferri, ma sostanzialmente anche Marchesi e Paratore) hanno considerato di “non sicura paternità vitruviana” il brano che riguarda la basilica fanese e mi sembra troppo facile non prendere in considerazione le loro riserve, le loro critiche. In fondo ci invitano ad essere prudenti e a studiare filologicamente tutta la questione. Del resto se Vitruvio non avesse costruito niente a Fano sarebbe grande lo stesso. Si faccia pure il “Centro di studi vitruviani”, come leggo su “Fano stampa”, ma si vada cauti prima di attribuire a Vitruvio la sistemazione di Fano augustea, delle sue mura etc. etc. Elementi vitruviani, ma solo elementi, possono anche essere indicati, ma di qui a dare per quasi certo che le mura, la porta d’Augusto, la basilica e non so quant’altro siano opera di Vitruvio ce ne corre. Nel brano in questione si parla della “Aedes Augusti” cioè del “Tempio di Augusto”, dove ha sede anche il tribunale, ma è l’unica volta che nel “De architectura” 55 Ottaviano viene chiamato Augusto: Vitruvio dedica la sua opera a Cesare Imperatore e sempre lo nomina con uno di questi due nomi, mai lo chiama Augusto, titolo diventato poi nome, che era stato dato ad Ottaviano nel 27 a.C.; Augusto fu considerato divino solo dopo la sua morte e non risulta che in qualche parte d’occidente fosse a lui vivente dedicato alcun tempio. Aggiungo che Vitruvio pensava che nell’età in cui lui viveva il progresso umano aveva raggiunto il suo culmine soprattutto nella tecnica delle costruzioni e può quindi sembrare assurdo che dopo aver delineato i normali caratteri della basiliche e aver ricordato solo la basilica Iulia di Aquileia, si fermi ad illustrare abbondantemente una basilica, quella di Fano, che invece si distacca dai modelli da Vitruvio stesso presentati come ideali. Lui si aspettava di “farsi valere” presso i posteri con quello che aveva studiato e aveva scritto, dando ordine a ciò che si era giunti a realizzare nel campo dell’architettura. 2004 56 FANO SOTTERRANEA: REALTÀ O IMMAGINAZIONE? La faccenda di Fano sotterranea sta diventando per qualcuno una specie di fissazione. Pian piano si scenderà a livello dei tesori nascosti, come i “fusi d’oro” di Carignano e di Caminate! Parecchie persone mi chiedono se è vero che sotto Fano c’è addirittura un’altra città. Un tale mi assicurava calorosamente che l’antica Fano (gliel’avevano detto i vecchi di casa…) era sprofondata: quindi, volendo, si potrebbe ecc.ecc.! Ultimamente l’iniziativa, in sé lodevolissima, dell’Archeoclub di organizzare una visita al Museo e ad una nota zona archeologica ha fatto accorrere, ahimè, tutte insieme, circa 400 persone. Il numero ideale di persone per gustare la visita di certi nostri ambienti stretti, o affollati di quadri, non dovrebbe essere superiore a quindici-venti. In realtà gli unici scavi che consentono di prendere visione di un grande interessante edificio, forse di carattere termale, sono quelli eseguiti nella prima metà dell’Ottocento (Sovrintendenza Pontificia) e poi proseguiti saltuariamente fino a qualche decennio fa sotto il convento di S. Agostino (oggi Usl). Sono noti come “scavi di Vitruvio” anche se Vitruvio, a quel che pare, non c’entra affatto. Quegli scavi diverranno ancor più interessanti quando sarà realizzata un’idea che vado caldeggiando da molti anni: cioè l’acquisizione e l’apertura al pubblico della cantina dell’ex convento, di notevolissimo valore archeologico. Già nel 1980 il mons. Micci aveva dato la sua disponibilità riconfermata da mons. Cecchini. Un altro scavo interessante e ben presentato, anche se non eccezionale, è quello eseguito nel sotterraneo del palazzetto comunale dell’urbanistica in piazza XX Settembre. Altri ambienti, o perché situati in edifici privati o perché di difficile accesso, non sono fruibili dal grande pubblico. Anche i resti di basi di colonnine fittili (scantinato del “Luigi Rossi”) hanno, turisticamente parlando, ben poco da dire in una città che oltre alla sezione Archeologia del Museo consente di ammirare monumenti di prim’ordine come l’Arco d’Augusto, le mura romane, la porta della Mandria. 57 Dicono i soliti ben informati che in Inghilterra bisogna fare addirittura la fila per vedere pochi metri di muro romano! Appunto, in Inghilterra; non a Fano. 1994 58 VITRUVIO: UN PROGETTO, UNA STORIA L’Archeoclub di Fano, con il contributo della locale Fondazione Cassa di Risparmio e nella Sala di rappresentanza della stessa, ha tenuto l’annunciato Convegno su Vitruvio: un progetto per relazionare sui risultati degli interventi promossi dallo stesso Archeoclub nel chiostro e nell’area archeologica di S. Agostino, interventi, come si è detto altre volte, completamente finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. La sala era affollatissima: buon segno! Dieci gli interventi programmati (troppi per un solo pomeriggio), seguiti da una visita guidata a S. Agostino nella sottostante area archeologica cui è stata dedicata la maggior parte delle relazioni. Invece è stata rinviata la visita del chiostro per vedere le prime sette lunette su ventuno affrescate dal Begni nel 1640 e già recuperate, esaurientemente illustrate dalla relazione del dott. Claudio Giardini. Il commento al convegno, che per la brevità del tempo si è concluso a spronbattuto, è sostanzialmente positivo, soprattutto in riferimento alle acquisizioni di ordine artistico (le lunette) e strutturale-documentario (area archeologica) illustrate dai relatori. Il materiale recuperato negli scavi (monete, oggetti, timbri ecc.) facilita, come ha ben detto la dott. Maria Adele Mariotti, la “lettura nel tempo” del grandioso edificio pubblico romano di cui tuttora non è stata identificata con sicurezza la funzione: santuario della Fortuna? Impianto termale? Basilica o altro? Erano molto attesi, per la novità del loro impianto, le relazioni dell’arch. Taus e dell’ing. Clini su “la Basilica di Vitruvio dalla memoria storica alla realtà virtuale”. I loro interventi non hanno deluso anche se, come essi stessi hanno detto, si tratta di una ricerca “in fieri” per raggiungere una proposta il più possibile esaustiva. Molto discutibile in alcuni particolari, la ricostruzione compiuterizzata (Clini) della Basilica vitruviana: un metodo nuovo che può dare buoni frutti. Dunque, una basilica civile certamente esisteva a Fano con misure e proporzioni esposte nel famoso brano vitruviano che, però, alcuni illustri studiosi non attribuiscono a Vitruvio; ma (a parte questo problema 59 filologico) esiste, come si accennava, quello della identificazione del grandioso edificio romano sotto S. Agostino: a tal proposito mi sembra che la ripetuta espressione “la così detta basilica di Vitruvio”, apparentemente prudenziale, tenda in effetti ad avvalorare ciò che ancora deve essere dimostrato come se lì debba esserci nient’altro che la basilica: si continui lo studio e la ricerca, poi si vedrà. 1996 60 FANO ARCHEOLOGICA: IN QUALE ZONA SCAVARE? Una vecchia, ormai superata, diceria asseriva che Fano antica poteva essere in gran parte “tirata fuori”. Sciocchezze! Dal momento che nel medioevo la nuova città è via via sorta sul tessuto urbanistico antico era inevitabile che andassero distrutti anche elementi interessanti e significativi antichi o coperti o inglobati nelle nuove costruzioni. Dirò che un errore secolare, dovuto certamente a scarsa cultura o a prevenzione, è stato quello di cercare le reliquie romane trascurando o addirittura distruggendo e alterando rovinosamente ciò che il Medioevo aveva costruito (e non solo a Fano), sicché è tuttora aperto (benché compromesso) il problema della conoscenza dell’urbanistica fanese, specie dell’alto medioevo. Ripensavo a queste cose in occasione di un casuale ritrovamento di tombe a ridosso della Flaminia (bivio delle Benedettine). Di altre sei tombe (poi malamente manomesse) rinvenute in un’area fabbricabile davanti alla vecchia chiesa avevo dato notizia io stesso nel n. 2 (1968) del Notiziario di informazione. Rosciano, l’antico fundus roscianus, il podere di Roscio, certamente sede di un’antica villa romana, e la vicina Forcolo hanno già restituito importanti reperti romani. La campagna è ricca di ritrovamenti, gelosamente tenuti nascosti (quasi sempre), riseppelliti o, purtroppo, distrutti. Ma lasciando stare il fundus roscianus, o l’altra interessante zona archeologica di Caminate, direi che si potrebbero tentare assaggi consistenti anche nella zona urbana. Premetto che è quasi impossibile poter scavare in aree private; in città c’è chi recentemente ha volontariamente rinunciato a scavare sotto casa per timore di trovare “qualcosa” che avrebbe fermato i lavori. La sospettosità e la segretezza dei privati sono giustificabili sebbene non comprensibili. Ma in aree comunali la ricerca deve essere facilitata. Quali aree? Ne indico tre. La prima è tutto l’interno, ora erboso, della ex chiesa di S. Francesco, attaccata al municipio, che secondo Nereo Alfieri dovrebbe essere prossima al cardine massimo della città, e mostrare i segni di un’anti61 ca, se non antichissima, urbanizzazione. Ma bisogna andare a vedere, bisogna organizzare con la Sovrintendenza Archeologica un cantiere di scavi: ritengo che sia auspicabile e possibile. Il secondo sito da “assaggiare” è il cortile della Corte Malatestiana dove è stato segnalato un canale fognario (parallelo a via Nolfi) e che potrebbe restituirci o il perimetro delle insulae abitative o addirittura una piazza molto antica, poiché sembra che nel medioevo non vi sorgesse alcuna abitazione. Il terzo sito è quello della Madonna a Mare (colonia ex CIF), a destra dell’Arzilla, messo all’asta dal Comune. In quella zona ritenuta nel Settecento persino sede del primo tempio della Fortuna (!), e di cui ho diffusamente parlato in Nuovi studi fanesi (n. 10, pag. 62-67), furono reperti già in passato “avanzi di marmo, embrici, avanzi di olle cinerarie e una moneta con la testa di Augusto, pezzi di colonne.” È una zona da tenere d’occhio: non può essere manomessa come se niente fosse. 1999 62 NOVITÀ SUL PRESTIGIOSO ARCO D’AUGUSTO Non c’è bisogno di ripetere che l’Arco, o porta, di Augusto è il monumento più prestigioso di Fano. In tutti i testi che ne trattano è riportata la scritta posta sulla sua principale trabeazione IMP. CAESAR, etc. etc., ma osservandola bene ho visto che dopo PONTIFEX MAXIMUS manca una lastra di forma trapezoidale che si estende alla seconda riga sicché anche le ultime parole MURUM DEDIT sono monche sia dell’ultima “M” di MURUM che della prima “D” di DEDIT. Tutti coloro che hanno riportato la scritta intera si sono basati su quella scolpita nell’altorilievo dell’Arco effigiato sulla facciata della ex chiesa di San Michele, o l’hanno riferita fidandosi in buona fede su quanto era stato precedentemente scritto. Non ho trovato cenno della suddetta anomalia nella scheda del Restauro conservativo recentemente redatta (2001) dagli architetti Giampiero Cuppini e Luca Boiardi, però guardando vecchie foto dell’Arco (1937) mi sono accorto che già risultava confusamente visibile la perdita che ora appare in tutta la sua gravità poiché il teleobiettivo messo in essere dalla prof. Valeria Purcaro (che qui ringrazio) non dice menzogne. Per curiosità ho riguardato il prospetto dell’Arco nella ricostruzione geometrica data dall’ing. Cesare Selvelli nel 1922. La scritta è suddivisa in sei lastre rettangolari (le prime e le ultime), in due tra trapezoidali e, al centro, in nove trapezoidali più piccole. Una di esse manca, ma le lettere che vi erano scolpite sono state ripetute incidendo alla meglio il conglomerato posto sotto la lastra che fu tagliata o strappata (questo lo diranno gli esperti) forse per prendere il bronzo delle lettere celatae nei solchi predisposti. Oppure la lastra è caduta per conto suo. Ma quando è avvenuto tutto questo? Non è possibile rispondere. Mi basta aver segnalato il guasto che da me è stato già comunicato al Sovrintendente Onorario prof. F. Battistelli. Aggiungo poche righe al mio precedente articolo sulla Basilica attribuita a Vitruvio. Le mura e la Porta date da Augusto furono terminate verso il 9 d.C. Siccome lo stesso Vitruvio, che in quella data era morto da parecchi anni, dice più volte nel suo trattato che gli edifici pubblici 63 si costruiscono “dopo” innalzate le mura si deduce che né la Basilica né tantomeno la Porta sono opera del grande studioso di architettura. 2004 64 DEVE TORNARE LA STATUA ROMANA DELLA FORTUNA Fra poco tempo, forse pochissimo, la risposta che la Sovrintendenza Archeologica regionale darà al Comune di Fano circa la logica e naturale “restituzione” della bella statua marmorea raffigurante la “Fortuna con cornucopia” sarà questa: “Spiacenti, cari signori, la statua della Fortuna, del II secolo dopo Cristo, trovata a Fano nel 1948 resta in Ancona, al Museo Nazionale, dal momento che vi è stata ricollocata dopo i lavori di restaurazione del Museo stesso: ormai fa parte dei pezzi esposti ed è inclusa nel catalogo dello stesso Museo”. È proprio così: i pezzi già esposti non cambiano sede e allora bisogna concludere il discorso prima che la sezione romana del Museo Archeologico di Ancona sia riaperta. Altrimenti non torneranno né la Fortuna (che non ha nulla a che fare con la brutta statuina della Fortuna posta in Piazza) né le altre statue e statuette, né la bella testa di Ercole, né la preziosa ara con la dedica al Sole Invitto, etc. Ci daranno, per consolazione, alcune iscrizioni marmoree e qualche vasetto trovato nelle tombe di via Fanella con i tegoloni di coccio che le costituivano. Le nostre cose più belle e significative le dovremo andare a vedere in Ancona, città che dal punto di vista della tradizione culturale non ha mai avuto nulla a che vedere con Fano. È bene precisare che la Fortuna, Ercole e l’altro materiale non furono rinvenuti in mezzo ai campi di non si sa quale sperduto borgo (come i “Bronzi dorati” di Cartoceto e di Pergola), ma proprio sotto il campanile del Duomo, nel bel mezzo di Fanum Fortunae: quei marmi (e anche altri) appartengono a Fano, alla sua storia, alla sua cultura. E Fano ha un Museo che proprio quei pezzi che sono in Ancona possono e debbono completare. Essi potranno essere collocati, in attesa di nuovi locali, in qualche sala liberata da cose meno importanti. So che è stato scritto dalla Sovrintendenza che, è naturale, intanto ha preso tempo… Invece non bisogna farne passare molto se si vuol risolvere il problema. E allora il Sindaco, l’Assessore alla Cultura, la Giunta intera, le Associazioni culturali si attivino con energia e continuità: il ferro va 65 tenuto caldo ogni giorno! Potrebbe darsi che per colpa nostra i beni che storicamente ci appartengono rimangano in esilio fuori della città che li ha voluti, pagati e ammirati nei secoli antichi. 1995 66 UN MOSAICO DA CURARE Sotto il portico della Corte Malatestiana, con infelice scelta, fu rimontato e murato poco più di quarant’anni fa (a cura del Comune), il bel mosaico detto della Pantera rinvenuto nel settembre 1952 qualche metro sotto la sala Manzoni (angolo di via Guido del Cassero), che faceva parte del circolo di A. C. San Paterniano, ora trasformato in Casa del Clero. Il mosaicista restauratore dovette sudare le proverbiali sette camicie perché il distacco del grande reperto era stato eseguito rozzamente da chi aveva poca dimestichezza coi mosaici. Comunque il restauro (con integrazioni semiarbitrarie) riuscì abbastanza bene e il mosaico della Pantera è ora indubbiamente un pezzo forte della Fano romana. Prudenza e interesse storico consiglierebbero di vigilare sulla conservazione del grandioso pavimento a tessere bianche e nere. Purtroppo non è così. Le tessere laterali e quelle del tutto marginali hanno molto risentito degli sbalzi climatici sicché da tempo si è incominciato a manifestare un processo di distacco. Processo che certamente favorirà (non è la prima volta che accade) nei turisti, nelle scolaresche, negli spettatori della Corte Malatestiana la tentazione di portarsi a casa, con poca fatica, un pezzetto di Fano romana! Mi è stato riferito che a volte sulle tessere marginali del mosaico ruspano e raspano i piccioni. Insomma il mosaico rischia di sfaldarsi ai lati e di perdere la compattezza del suo complesso. Bisogna intervenire per ben fissare le file di tessere che stanno per staccarsi e inoltre bisogna pensare a qualcosa che protegga l’antico manufatto (II sec. d. C.) dal gelo. Auspichiamo che l’intervento dell’Assessorato alla Cultura sia rapido e risolutivo. 1999 67 SELCI ROMANE IN VIA NOLFI? Ho già scritto altre volte sulle false ricostruzioni che dovrebbero o avrebbero dovuto rendere interessante qualche angolo di Fano (ricordo il falso mastio malatestiano, la falsa torre merlata affiancata alla chiesa di S. Maria del Ponte Metauro, Porta Maggiore, ecc.), né dimentichiamo la “felice” falsità della parte esterna dalla Cassa di Risparmio ad opera dell’arch. Calzabini. A queste ne aggiungo oggi una che ai più è sfuggita: me ne ha dato l’occasione più volte la vista di alcuni turisti perplessi di fronte a un tratto di lastricato romano che, fra le recenti selci di porfido, d’improvviso appare alla vista del “passeggero” in via Nolfi poco lontano dalla torre (ex campanile) della scomparsa chiesa di S. Croce. Selci romane? Dunque reliquie d’un selciato romano. Dunque questo era uno dei cardini più importanti della Colonia Iulia Fanestris? Tutte chiacchiere, tutto falso. Quelle selci “romane” non sono autentiche; ma sono la riproduzione, operata qualche anno fa, di un tratto di selciato che fu trovato quando furono eseguiti i lavori di sterro per sistemare le fognature di via Nolfi. Le selci autentiche coprivano una tratto di fogna romana che stava per essere distrutto… Per essere buoni facciamo conto che si tratta di un “falso a scopi didattici”; però mi chiedo: con tutte le cose autentiche che ci sono pervenute dalla romanità (basta l’Arco d’Augusto) era proprio necessario ricorrere a un falso per ricordare all’ignaro visitatore che Fanum è stata municipio e poi colonia romana? A che serve quel tratto di selciato rifatto? Serve alla retorica della romanità: tanto più che non è accompagnato da alcun cartello o lapide esplicativa che, almeno, eviterebbe di confondere le idee a chi transita per quel tratto di via Nolfi. Sì, lì passava una strada romana, ma almeno un metro più sotto: è infatti noto che il livello delle strade (e della città) dopo le distruzioni barbariche si alzò anche di molto in certi posti. Le macerie non venivano portate via: ci si costruiva sopra! 1998 68 TRE LEGGENDE FANESI Ogni città (quindi anche Fano) ha il proprio leggendario, e purtroppo il tempo (specialmente il nostro preso da preoccupazioni nuove e da vari idoli) cancella dalla memoria e dalla tradizione ciò che un tempo era patrimonio di tutti o di molti. La prima leggenda riguarda il ponte detto di S. Cipriano che era sulla Flaminia vicino alla chiesa da cui prendeva il nome, scavalcava il Rio Maggiore, affluente del Metauro, immediatamente a monte di Tavernelle per chi veniva da Fano; era al confine col Ducato d’Urbino e aveva origini romane. L’umanista Antonio Costanzi stimava che fosse stato costruito da Cesare Augusto. Su quel ponte nacque una leggenda che mi è capitato di leggere nelle “Notitie historiche...” di Vincenzo Nolfi. Dunque ai suoi tempi (si era in pieno Seicento) la qualità e la grandezza delle pietre del ponte - ormai diventato un rudere a cui tutti attingevano pietrame - fece sì che (dice il Nolfi) “il volgo di quei villaroli credeva essere stato fatto, quel ponte, in una notte da spiriti infernali, non sapendo di qual peso fosse a quei tempi la potenza Romana e particolarmente quella di Augusto”. La seconda riguarda l’Arco d’Augusto e precisamente la sua chiave di volta in cui era scolpita una protome, cioè una immagine animalesca che rappresentava un elefante (animale caro a Giulio Cesare) non un toro come affermò, credo, l’astrologo Giulio Firmico e come è scolpito nella riproduzione cinquecentesca dell’arco sulla facciata della chiesa di S. Michele e come molti erroneamente ancora affermano. Scrive nel Seicento Carlo Andrea Negusanti nei suoi “Frammenti istorici...”: “Sopra l’Arco d’Augusto in Fano v’era una testa di toro, di marmo, e (sic!) dove il demonio se ne era impadronito, e turbava non poco gli abitanti di quei contorni, e San Fortunato Vescovo della medesima città e Protettore, l’espurgò, e vi fece il segno della S. Croce come oggi si vede”. Ebbene anche noi osservando attentamente la protome scalpellata possiamo ancora vedere il segno della Santa Croce. Dove prese il Negusanti questa notizia? È un mistero, ma la Croce c’è e forse essa ha dato luogo alla leggenda, non viceversa. 69 Più conosciuta è la terza cinquecentesca leggenda: quella della “carrozzaccia dei Martinozzi”. Si diceva che nelle notti senza luna in via dell’Inferno (ora via Avveduti, ove si fa mercato di frutta e di verdura il sabato, fra via Montevecchio e via Arco d’Augusto) uscisse una carrozza tirata da due cavalli neri governati da un cocchiere in livrea; all’interno sedeva un personaggio vestito di nero dall’aspetto pauroso. Fra sinistri bagliori la carrozza percorreva più volte via dell’Inferno poi si dirigeva verso l’Arco d’Augusto, lo raggiungeva e sprofondava davanti alla chiesa di S. Michele, l’avversario di Lucifero. Simile leggenda circolava ben adattata anche in altre città: era sicuramente il modo più spiccio con cui, vox populi, qualche personaggio malvisto era mandato al diavolo. 2004 70 I MERLI DI FANO Con l’intento di fare o promozione turistica o promozione commerciale sono state pubblicate guide e carte topografiche di Fano. Non sappiamo chi sia l’autore dei testi, ma diciamo subito che è necessario evitare errori e sviste. Non si deve pensare che i lettori siano una massa di sprovveduti per i quali tutto fa brodo né si deve copiare (specie da una vecchia guida regionale, a suo tempo da noi criticata) per non ripetere gli errori altrui e anche perché non tutti sanno copiare. Abbiamo sotto gli occhi cinque di queste pubblicazioni su Fano di cui due, in forma di libretto, hanno carattere di ufficialità; anzi “Fano, città d’arte e di mare” risulta edita, con foto molto belle, dall’assessorato al turismo. Possiamo sorridere di fronte a certe esagerazioni propagandistiche (a fin di bene) che presentano Fano come “una piccola città con un grande cuore” o addirittura come “un luogo incantato” capace di offrire “una vacanza da sogno”; però diventiamo seri di fronte a certe altre cosette anche se qui non intendiamo scolasticamente correggere foglio per foglio, limitandoci a segnalare, preso qua e là, qualcosa che speriamo non rivedere in eventuali ristampe. Prima di tutto non bisogna dare per certo ciò che non ha riscontro nella realtà: per esempio, non si può pubblicare la foto della facciata del Duomo e, in ben due carte topografiche, scriverci sotto “Chiesa di S. Pietro in Valle”. Non si può dire che il Bastione del Nuti (sec. XV) a porta Maggiore è “nelle mura augustee” perché non è vero, come non è vero che l’A14 è “l’autostrada del sole” o che la via Flaminia “fin dall’antichità ha avuto il suo terminale a Fano” quando, invece, lo aveva a Rimini. Né si deve affermare che Garibaldi è stato ospite della Fortezza malatestiana perché non si è mai fermato a Fano; vi transitò in carrozza nel dicembre 1848 andando da Cesena ad Ancona. La Fortezza ospitò, invece, la “legione Garibaldi”. Non esistono né piazza Galeazzo Malatesta (non c’è nessun Galeazzo fra i Malatesta fanesi) né via Guido Nolfi, ma solo via Nolfi. Nessuno ha visto a Fano “porte merlate” medievali: i merli di porta Maggiore, mal restaurata negli anni 71 trenta del secolo scorso, non sono medioevali, sono rifatti. Il Domenichino (non Momenichino) dipinse la Cappella Nolfi nel 1618, come è scritto nel contratto, non nel 1619. Non è barocca la chiesa di S. Silvestro, ma solo la sua facciata: tutto l’interno è stato rifatto dopo l’ultima guerra. Giulio Cesare non presidiò Fano “con una corte”, ma con “una coorte”. È meglio dire “battigia” piuttosto che “bagnasciuga”, termine che si usa per le navi; lo usò maldestramente e clamorosamente Mussolini nel luglio 1943 quando assicurò che se gli alleati fossero sbarcati in Sicilia sarebbero stati stesi “sul bagnasciuga”! Da nessuna parte vengono nominate le Terme di Carignano, ma Urbania, l’antica “Castedurante” (l’errore di stampa è evidente) sì. Risulta anche sconosciuto uno dei nostri più preziosi pezzi archeologici: il Cippo Graccano. In una cartina piazza Marconi appare spropositata così come è immensa piazza Clemente VIII: questo secondo errore si capisce perché mancano il Duomo e il Palazzo vescovile! Non vogliamo insistere sugli errori di stampa che capitano a tutti: ma non si può scrivere cinque volte aereoporto anziché aeroporto, né che il nostro Torelli è (per due volte) “danese”, né si possono spostare i Bronzi dorati dal I secolo d.C. al I a.C. Ci fermiamo per mangiare un pezzo di carne di “assoluta genuità” e speriamo che le prossime guide di Fano siano più corrette e più aggiornate. 2003 72 VIENE DAL MEDIOEVO L’ANTICO STEMMA DI FANO È piuttosto intricata la questione dello stemma di Fano che qui, naturalmente, diamo in sintesi. Se ne occuparono parecchi nostri storici a partire da Vincenzo Nolfi (ma già siamo nel XVII secolo). Ricordiamo anche Amiani, Masetti, Cesare Selvelli, Giuseppe Castellani. Quest’ultimo ne trattò diffusamente da par suo in un articolo apparso sul Gazzettino il 28 agosto 1904. Selvelli in Fanum Fortunae (1943) parla di uno stemma medievale diverso da quello che noi oggi abbiamo in adozione che, però, è ugualmente antico. Selvelli dice che “lo stemma della città non è più quello che adottò il Comune medievale, il quale impresse nei suoi sigilli un glorioso marziale ricordo dei tempi di Roma: l’arco di Augusto su cui sovrastava la civetta e stava a guardia un leone, con il motto… In Fani Portis Custos Est Io (sic) Leo Fortis. Vada per il leone che dai tempi salomonici è simbolo di regalità e forza, ma la civetta che è sull’arco non ha affatto l’aspetto che ci aspettiamo: si tratta di un volatile indecifrabile. Forse l’incisore voleva fare una civetta, simbolo di saggezza, ma è venuta fuori una immagine strana. Il Selvelli seguendo più una leggenda che la storia (dato che non c’è nessun documento in proposito) dice che “lo stemma antico mutò nell’ultimo decennio del XIII secolo quando due potenti famiglie si riconciliarono”. Allude alle nozze di Guido il Giovane, del Cassero, con Oriana da Carignano. Il primo aveva nello stemma una rastrelliera d’argento che “alla banda” attraversava lo scudo rosso, la seconda aveva una rastrelliera rossa che “alla banda” attraversava lo scudo d’argento. Fondendo i due stemmi nacque quello di Fano con la rastrelliera verticale risultante dall’incastro della parte d’argento con quella rossa. Si noti che non c’è il bianco (come vediamo anche nell’attuale gonfalone) ma l’argento. Ora nelle carte con lo stemma del Comune l’argento è graficamente reso col bianco e il rosso con un colore più scuro. L’originale, però, era argento e rosso, non bisogna dimenticarlo. 73 La scritta Ex concordia felicitas pare di origine ecclesiastica, infatti la città si trovava nello Stato della Chiesa. 2008 L’antico stemma medievale Lo stemma dopo il XIII secolo 74 FANO NEL DECAMERONE Oso credere che a molti sia noto che ben tre fanesi di alto lignaggio sono ricordati da Dante nella Divina Commedia: Guido del Cassero con Angiolello da Carignano (Inferno, XXVIII) e Jacopo del Cassero, vero e proprio personaggio (Purgatorio V), tutti e tre morti ammazzati. Ad alcuni invece è sfuggita la novella V della quinta giornata del “Decamerone” di Giovanni Boccaccio nella quale “sotto il reggimento di Fiammetta si ragiona di ciò che ad alcuno amante, dopo alcuni fieri e sventurati accidenti, felicemente avvenisse”. È una novella poco conosciuta e non delle più belle: vi si parla di Agnese una ragazza faentina che trovò salvezza e passeggero rifugio e residenza proprio a Fano a metà del Duecento. Il Boccaccio non si sofferma a descrivere Fano, che di monumentale aveva allora solo l’Arco d’Augusto e la nuova Cattedrale. Non si tratta quindi di una novella descrittiva da cui trarre l’immagine di Fano, ma l’aver scelto la nostra città mostra, perlomeno, che a quei tempi essa era sicura anche se un po’ isolata. È Neifile che parla; ascoltiamola: “dico adunque che già nella città di Fano due lombardi abitarono, dei quali uno fu chiamato Guidotto da Cremona e l’altro Giacomin di Pavia uomini ormai attempati e stati nella loro gioventude quasi sempre in fatti d’arme e soldati...” E proprio in uno di questi fatti d’arme, contrassegnati da distruzioni e ruberie, Guidotto da Cremona aveva salvato una bambina di due anni rimasta sola e che vedendolo lo aveva chiamato istintivamente “padre”. Poi Guidotto la prese con sé e la portò a Fano dov’egli morì. Intanto Agnese ritornata a Faenza crebbe facendosi sempre più bella tanto da fare innamorare di sé sia Giannòle di Severino sia Minghino di Mìngole. Qui Boccaccio ricorre a un diversivo caro ai latini, l’agnizione o riconoscimento, infatti si scopre che Giannòle è fratello di Agnese che sposa con tutti gli onori Minghino. E Fano? Rimane sullo sfondo della novella ed è inutile cercare altro. 2004 75 UNA IPOTESI SUL COGNOME “MALATESTA” I Malatesta, che dalla fine del secolo XIII consideravano Fano come loro preda, divennero Signori della nostra Città nel 1397 quando Galeotto I Malatesta ebbe il Vicariato pontificio di Fano (che di fatto egli già dominava) dal card. Albornoz il quale, per conto del Papa, mirava a ridare consistenza ai territori del vecchio Stato ecclesiastico. La Signoria malatestiana fanese durò fino al 1463 allorché Pio II, avvalendosi della forza militare dell’allora conte Federico da Montefeltro, scacciò il “chiomato Sigismondo” come lo chiama D’Annunzio, (citato da Cesare Selvelli), “la procellosa anima imperiale/ ch’ebbe poche castella e non il mondo”. Sono vicende i cui particolari sono ben conosciuti da chi ha qualche dimestichezza con la storia fanese. Quel cognome “Malatesta” da dove viene? C’è una sola ipotesi sulla sua origine, ma non è da tutti condivisa. Dante, che non aveva simpatia per quella casata, indicando i Malatesta come Signori di Rimini (“Il mastin vecchio e il nuovo da Verrucchio”, Inf. XXVII,45) ce li presenta come avidi e cattivi. Il fatto è che un’antica arme o stemma dei Malatesta aveva sopra le sbarre scaccate, poste nel “campo” dello stemma stesso, una fascia in cui era dominante una testa di mastino, appunto “la mala testa”. Da quello stemma forse è derivato il cognome della famiglia. Il citato verso dantesco in cui viene chiamato in ballo il mastino si trova in una terzina strettamente legata ad altre riguardanti alcune città della Romagna i cui Signori avevano nello stemma qualche figura di animale. Così Ravenna è unita all’aquila dei Da Polenta e Forlì al leone verde presente nello stemma degli Ordelaffi; col “Lioncel dal nido bianco” (nell’arme dei Pagani di Susinana) Dante indica Faenza e Imola. A Fano non c’è traccia di mastini, anzi è da notare che una pietra murata sul porticato dell’ex- chiesa di san Francesco, dove sono le tombe malatestiane, è dominata dall’ippogrifo, animale fantastico completamente diverso dal mastino. 76 Dei Malatesta, oltre ai preziosi codici amministrativi, conosciamo quattro iscrizioni incise su pietra: vi si legge sempre il cognome “Malatesta”. Ma oggi è in gran voga la forma “Malatesti”, una forma antica e legittima, specialmente usata da cronisti e storici che si occuparono di questa famiglia. 2005 77 RITROVATE LE STATUETTE DELLE TOMBE MALATESTIANE Anche da parte de “Il Nuovo Amico” un cordiale riconoscimento all’opera della Polizia di Stato e in particolare al Commissario Dott. Paolo Mataloni e agli uomini del Commissariato di Fano che hanno reso possibile il ritrovamento dell’Arcangelo Gabriele e dell’Annunziata, le preziose statuette di marmo, trafugate nell’ultima decade di giugno a Fano. Questa pagina è stata chiusa felicemente; ma il capitolo dei beni culturali che debbono essere invece protetti a dovere non lo è affatto. Per Fano e per gli altri centri della nostra provincia. Per quanto riguarda la tomba di Paola Bianca Malatesta abbiamo suggerito di togliere tutte le sculture che (lo si è visto) possono essere portate via troppo facilmente. Questa naturalmente è solo la prima misura da prendere. Poi deve seguire il restauro di tutta la tomba; infine, dopo la collocazione delle difese dallo smog e dai trafugatori, tutti i preziosi pezzi potranno tornare a fare bella mostra di sé, come prima e meglio di prima. È meglio privarsi della vista del bellissimo monumento per un anno o due, piuttosto che piangere e pentirsi dopo…! 1991 78 SI RESTAURANO LE MURA MALATESTIANE Se le passate amministrazioni comunali avessero operato per il teatro della Fortuna (tuttora gravato dalle lentezze della Sovrintendenza ai Monumenti) con la determinazione con cui la Giunta ha proceduto al restauro delle vecchie mura, a quest’ora il magnifico monumento polettiano sarebbe già in funzione. Ma torniamo al restauro delle mura il cui “giro” fu progettato dai Malatesta, ma fu portato alla forma definitiva dal Governo di Fano e da quello dello Stato Ecclesiastico. Del resto anche la porta Maggiore che comunemente viene chiamata “Malatestiana” fu modificata dopo il 1463 (anno in cui terminò la Signoria Malatestiana) anche perché gravemente danneggiata dalle bombarde del Conte poi Duca di Urbino. Mentre si sta portando a termine il restauro delle mura che guardano il mare, la Giunta Giuliani procede ad altri due importanti lavori: il restauro del quattrocentesco torrione costruito dall’Architetto fanese Matteo Nuti a destra di Porta Maggiore (pure opera sua), e il consolidamento del poderoso baluardo cinquecentesco dei Sangallo (esattamente Antonio e Luca da San Gallo, Svizzera). Per il primo la spesa prevista è di 300 milioni, finanziata con un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti e col contributo del 5% sugli interessi da parte della Regione Marche. Il consolidamento del baluardo di Sangallo è finanziato per 400 milioni in conto capitale, a fondo perduto, dalla Regione. Dopo che l’amministrazione comunale avrà realizzato le entrate previste con la urbanizzazione dell’area Montevecchio sarà la volta, finalmente, delle mura romane. Accanto al disinteresse dello Stato, che però dovrà essere chiamato in causa per il restauro dell’Arco d’Augusto, ci piace segnalare l’impegno dell’amministrazione comunale e della Regione. 1993 79 SI POSSONO COSTRUIRE MONUMENTI FALSI? In un precedente articolo ho cercato di mettere in luce l’assurdità di quella parte della “relazione di bilancio 1998” dove la Giunta fanese delibera in via definitiva il programma di “recupero”, fra l’altro, della Torre civica disegnata (1739) dal Vanvitelli e mai esistita; e proprio per questo ho l’impressione che il testo votato dalla maggioranza consiliare corra sul filo del falso ideologico. Nello stesso paragrafo si parla del Maschio della Rocca Malatestiana (sec. XV) da ricostruire dove era e come era dopo l’incongruo intervento del 1931-32, quando fu inventata quella scenografica merlatura operistica che, insieme all’ antica copertura, tolse all’intero complesso della fortezza l’aspetto severo di “bello e forte arnese” piantato a guardia del Porto da Sigismondo Malatesta. Insomma il nostro Consiglio comunale ha deliberato a maggioranza di ricostruire “il falso di un falso”; che tipo di dottrina del restauro sia questa proprio non so. Piuttosto mi chiedo: dove andremo a finire? Di questo passo andremo a finire che Fano (con una forte spesa) sarà sempre più una città falsa e volutamente falsificata. Del resto il Calzabini a suo tempo costruì le false case dei Malatesta, e fu poi falsificata la Porta Maggiore nel 1933-34, e negli stessi anni fu falsificato il Campanile della Chiesa di Ponte Metauro. Dobbiamo andare avanti così? Credo di no. Credo che se si vuole intervenire nella zona del Maschio, a 54 anni dalla sua demolizione, sia logico operare con metodi e materiali moderni. Vado dicendo da qualche decennio che sarebbe opportuno restituire solo “lo spazio” occupato dal Maschio senza ricostruirvi i muri, bensì con la costruzione di una articolata e moderna struttura di acciaio modellata in modo da ridisegnare pari pari solo il volume del Maschio stesso come era fino all’ottobre del 1930, allorché il terremoto lo rese pericolante e ne provocò l’abbattimento della parte più alta. Ho avuto la soddisfazione di leggere in una tesi di laurea in architettura, recentemente discussa, che i giovani laureandi (pur non conoscendo la mia idea) sono sostanzialmente giunti alla stessa conclusione 80 aggiungendo col loro approfondimento dei problemi e con sensibilità artistica e urbanistica moderne, interessanti soluzioni tecniche. Questa mi sembra la strada da seguire per disegnare finalmente nella nostra tormentata urbanistica un segno veramente nuovo, un monumento sui generis, unico nelle Marche e forse in Italia: un segno degno di Fano del 2000, un segno capace di tramandare pulitamente la memoria di ciò che è appartenuto alla nostra storia senza ricorrere a falsificazioni di sorta. 1998 Il Mastio della Rocca Malatestiana prima e dopo il 1930 81 UN ROMANZO SU MALATESTA È uscito recentemente Sigismondo, un romanzo dello scrittore spagnolo Alberto Cousté che ha per protagonista Sigismondo Pandolfo Malatesta signore di Rimini e di Fano. Giustamente Rosetta Copioli presentando a Rimini il libro ha affermato che Sigismondo non é né un romanzo storico né una biografia, ma piuttosto un romanzo-affresco, un romanzo-sinfonia d’una preziosa e spesso sensuale evocazione di fantasmi, soprattutto del fantasma di Sigismondo, bastardo di Pandolfo III, nato a Brescia il 19 giugno 1417; nato tra Medioevo e Rinascimento, perciò uomo di due età, giunto tardi all’una e troppo presto all’altra. Con la sua procellosa anima imperiale - cantò di lui il poeta - avrebbe avuto “cuore di conquistare il mondo ed ebbe poche castella”! Scriviamo queste righe non per giudicare il romanzo, ma solo per soddisfare una curiosità: come è stata trasfigurata Fano quattrocentesca dalla fantasia, dalla sensibilità di Cousté? Trattandosi di un romanzo è logico che Fano sia diventata solo un luogo della fantasia, ma quelle pagine sembrano scritte apposta per far stridere tutti i solenni lodatori di Fano: “...la terza città delle Marche”, definizione che di volta in volta può suonare vanto, lamento, delusione, minaccia; Fano la sede “del più antico Carnevale d’Italia”, “la città dei Cesari” e tante altre cosette piuttosto provincialotte. Cousté dice che Fano era la città proprio giusta per i Malatesta. È qui che essi esistono più che in qualunque altra parte, nessun luogo è, come loro, così disgraziatamente uguale, nessun’altra città assomiglia tanto a loro. Più di Rimini, dove la loro fama e il loro potere furono più grandi, più di Cesena, pur seminata dalle loro impronte, più di Pesaro, Cervia o Savignano, più dei borghi dove incrudelirono e dei bastioni che eressero, più delle molteplici cappelle nelle quali imprecarono in silenzio, più dei fienili dove fornicarono, più delle polveri delle strade e dei dirupi che ancora li ricordano. E perché Fano somiglia tanto ai Malatesta? Bisogna ricordare che la dinastia malatestiana generalmente non procedette per “figli legittimi” ma per “figli naturali”. E per Cousté Fano, la città dell’infanzia di 82 Sigismondo, è la piccola Fano moribonda, meticcia della riva dell’Adriatico, bastardissima.... Ahimé cosa dobbiamo leggere: “Addormentata nel suo torpore per otto o nove secoli, qualche volta risvegliata con violenza da genti saracene, cullata da remoti bulgari e commercianti bizantini, uomini di passaggio che lasciarono figli e suoni nelle case latine, soprattutto questa lingua che ha il suono dei Carpazi e di imbarcazioni straniere; questo profondo idioma di concubinaggi ibridi e accoppiamenti singolari, non certo di sposalizi, perché una lingua cosiffatta non sgorga da legalismi e contratti, ma da tradimenti e pagliericci” ... “Lingua di Fano, gente di Fano, pietre di Fano immobili sotto un cielo indolente, secoli di soldati straccioni e di furtivi mercanti hai rimescolato nelle tue mura...”. A parte i diritti della fantasia, sembra proprio che Fano e il suo dialetto abbiano fatto una gran brutta impressione a Cousté. Per fortuna che qui non comanda Komeini e non si emettono sentenze di morte per “lesa maestà”; anzi, civilissimi e tolleranti come siamo ci vien da pensare: “Toh! prendi su e porta a casa...!”. 1992 83 NEL MARE DI FANO Magnifico tripode di bronzo, con delfini, ritrovato nel mare di Fano insieme con un cannone datato 1580. Il tripode è di epoca rinascimentale e ricorda lo stile di Jean Boulogne: è conservato in una collezione privata fuori Provincia. Nel Cinquecento erano assai fitti i traffici tra le Marche, soprattutto Ancona, e Ragusa che disponeva di una imponente flotta commerciale. Il tripode probabilmente naufragò insieme con una nave anconetana o ragusea. Il destino dei pezzi d'arte pescati nel nostro mare sembra ormai segnato: non restano a Fano, ma vanno a finire in collezioni private o in musei forestieri o addirittura stranieri. E' inutile fare appello al civismo dei pescatori; se questi pezzi hanno un valore, e certamente lo hanno, bisogna dare a chi li trova una ricompensa adeguata al loro effettivo valore, sarebbero soldi ottimamente spesi; altrimenti questi pezzi prendono il volo e Fano rimane a protestare, a sognare; ma sempre a bocca asciutta!!! 1993 84 IL BASTIONE DEL SANGALLO Il Bastione del Sangallo è ora considerato un monumento; per i meno distratti si deve aggiungere che è un monumento della Fano pontificia. Alla sua recente riapertura, dopo il restauro, era presente una squadra di figuranti in costume vagamente medioevale o malatestiano che dir si voglia. Comunque il medioevo col bastione del Sangallo non c’entra proprio niente. Dopo la fine del dominio malatestiano (1493) e il ritorno dello Stato della Chiesa ci si rese conto che a Fano non era ben difesa la parte nuova della città gravitante a sud est, dove ora c’è la stazione ferroviaria. Nel 1532 il papa Clemente VII (che nel 1527 aveva subito il tremendo sacco di Roma ad opera dei lanzichenecchi protestanti) inviò a Fano il celebre architetto Antonio da Sangallo (la cui famiglia era originaria di San Gallo, Saint Gallen, in Svizzera) per fabbricare torrioni e soprattutto per risarcire le nostre mura verso il mare, in gran parte diroccate. In seguito si interessò della questione Paolo III, ma non furono trovati i soldi per eseguire i lavori progettati. Finalmente il lavoro riprese e fu portato a termine nel 1552 sotto la cura di Luca da Sangallo, regnando il pontefice Giulio III, di lui fu posta la ciclopica arme nel 1550, cioè lo stemma che ancora vediamo al sommo dello sperone del bastione. Quell’anno non ricorda solo l’elezione di papa Giulio, ma anche l’anno giubilare, si era in pieno Rinascimento. Ma perché fu costruito quell’enorme bastione allora tanto desiderato dai fanesi? È presto detto: soprattutto per difendere la città da possibili incursioni dei turchi. Questi costituivano un continuo pericolo coi loro sbarchi improvvisi: rubavano quello che potevano e portavano via uomini e donne per farli schiavi o per chiedere esosi riscatti. La minaccia andò avanti per un pezzo: ricordiamo che nel 1658 fuste turche provenienti da Dulcigno e Santa Maura si presentarono davanti a Senigallia: catturarono barche e più di cento pescatori. Poi toccò a Pesaro; racconta il Bonamici che il 10 settembre 1672 85 “quattro fuste di Dulcignotti e Turchi Barbareschi” si presentarono davanti al porto a “alla vista delle urlanti donne” presero cinquantanove pescatori “parte dei quali barbaramente portarono in Dulcigno e parte in Algeri”. Nel 1687 sbarcarono vicino al Metauro, ma furono respinti. Il bastione del Sangallo però visse il suo momento “storico” il 5 e 6 settembre del 1791 quando per protestare contro una speculazione sulla farina e su una possibile penuria di pane, vi si asserragliarono “settanta uomini in circa, che armati teneansi nel baluardo” con un numero non precisato di donne e ragazzi. Avevano puntato due cannoni contro la città e chissà cosa sarebbe successo se non li avesse convinti ad uscire il vescovo mons. Gabriele Severoli che assicurò l’impunità a tutti. Leggo queste notizie in vecchie carte dell’Archivio Storico Vescovile. In esse quello che noi chiamiamo “bastione” viene detto “baluardo”. Proprio così, i fanesi lo hanno sempre chiamato “baluardo” o anche la “polveriera”. In una lettera del 1886 all’attore Cesare Rossi, il patriota fanese Marino Froncini, esule in Argentina, gli dice che oltre ad incontrarsi con lui (Rossi era a Buenos Aires per un ciclo di recite) avrà piacere di parlare in dialetto come si usava al baluardo: “cum parlemi malagiù al us del balvèrd”. Durante la prima guerra mondiale nel bastione fu ricavato un rifugio, ma i proiettili sparati nel 1915 dalla flotta austriaca contro la stazione ferroviaria colpirono la chiesa di S.Francesco di Paola (che fu poi ristrutturata e rimpicciolita) la quale si trovava a qualche decina di metri dal bastione; gli austriaci spararono poi contro i ponti dell’Arzilla e - questo molti non lo sanno - uccisero un asino! 2004 86 LA BELLA MOSTRA SU TORELLI Quando si parla del primo Teatro della Fortuna si parla anche di lui. Del cavaliere gerosolomitano Giacomo Torelli (1608-1678), valido combattente e soprattutto “maestro stregone” delle scene teatrali a Venezia e alla corte di Parigi. Torelli, di nobile famiglia fanese, è uno di quei personaggi capaci di mostrare come il Seicento italiano, che conobbe anche aria di crisi non fu, però, secondo la convenzionale e divulgata critica romantica (quante cose devono farsi perdonare il nostro romanticismo e il nostro risorgimento) un’età buia e stravagante (non bastano Galileo e Sarpi a risollevarne le sorti?), ma fu un’età che presentì il futuro, specie melodrammatico e plaudì alla “invenzione” in tutti i campi. Ma tant’è, è un secolo che veniva dopo la Riforma cattolica e gli “intellettuali” si dettero da fare per mostrarne solo i lati negativi. Torelli era di quei fanesi “moderni” che non volevano la loro città via via ridotta a paese; egli era sulla linea dei grandi slanci e delle creazioni tutte nuove. E così, esperto scenografo (il Sabbatini pesarese gli aveva insegnato molte cose), inventò il Teatro della Fortuna, costruito ex-novo nella vecchia Sala della Commedia del centralissimo Palazzo del Podestà. Tra gli ammiratori dell’opera torelliana ci basta ricordare il celebre architetto Milizia. Ora una mostra, nell’ex Luigi Rossi, una mostra molto bella e candida (persino troppo abbagliante negli sfondi) curata dal prof. Francesco Milesi, ci mette a diretto contatto col lavoro grafico progettuale e pittorico del Torelli e riesce perfettamente a darci l’idea del genio e dell’ingegno di questo nostro lontano concittadino. È noto che recentemente il Seicento doveva rinascere teatralmente proprio a Fano, ma nonostante il valore degli organizzatori, non ha trovato terreno adatto a crescere e ad affermarsi. Forse per Fano era troppo. Voglio dire che si era puntato troppo in alto. Insomma c’è stata una scommessa “mondiale” che abbiamo valutato male e, naturalmente, l’abbiamo perduta. Al solito, siamo stati “larghi di bocca e stretti di mano” come dice l’antico proverbio. E così passiamo il tempo a pian87 gere e ripetere lo stantio luogo comune che “noi”, “terza città delle Marche...!!” ecc. ecc.! Torelli già era stato fatto conoscere ai fanesi da Anton Giulio Bragaglia nel secondo dopoguerra. Ora i modelli scenici torelliani sono stati costruiti dalla scuola milanese di Brera e, finalmente, c’è materiale che giunge da Parigi. Notevole è il restauro (merito del Rotary Club) delle quattro statue di legno che ornavano il boccascena del teatro torelliano che, come si sa, fu restaurato nel 1718 da Ferdinando Galli da Bibbiena. Bello e atteso il plastico in legno del Teatro, plastico realizzato dal prof. Gianfranco Grandoni. Il Teatro della Fortuna è una delle poche cose europee che ebbe Fano e che interessa gli studiosi di ogni parte del mondo che in questa mostra possono ben rendersi conto della bellezza di ciò che ormai non esiste più. Per tutti noi, profani di costruzioni teatrali, è una lezione da non perdere! 2000 88 SANT’AGOSTINO E LA “BATTAGLIA” COI SASSI Sant’Agostino (lo scrive padre Cremona su Avvenire) racconta che una volta andò a predicare a Cesaréa di Mauritania e che, prima di iniziare, sentì davanti alla cattedrale un vociare piuttosto scalmanato. “Sarà gente che viene alla predica” pensò. Gli dissero che, invece, si trattava della “caterva”, una “festa” celebrata ogni tanti anni: metà popolo a destra, metà a sinistra e sassate a non finire fra le due parti senza tener conto di niente; volavano sassi e pietre da un fronte all’altro come capitava capitava: ci scappavano sempre i feriti, a volte il morto. Si divertivano così! Sant’Agostino uscì fuori e dal sagrato gridò “Fermi tutti”. Fece poi un predicozzo così salato che tutti si vergognarono. Il santo raccontava poi, con compiacenza, che da quell’anno la caterva “non fu più giocata”. A Cesaréa no, ma a Fano sì. Non si chiamava “la caterva” ma “la battaglia”: strana e violenta usanza vietata definitivamente solo nel 1707 da Papa Clemente XI, Albani. La battaglia a suon di sassate fra due opposte schiere è forse l’antenata del famoso “getto” carnevalesco chiamato curiosamente nell’Ottocento “il combattimento”: era fatto col lancio dei confetti (i mandulòn), fagioli e ceci patinati di gesso colorato; Giulio Grimaldi in una sua poesia dialettale parla anche di patate tirate sulla folla. La battaglia, di cui parlavamo, si svolgeva ogni anno ai primi di settembre, forse nei pressi della porta S.Leonardo. Vi prendevano parte un po’ tutti, tanto è vero che il vescovo Ranuzzi nel 1685 scriveva da Parigi all’abate Federici incaricato di vigilare in spiritualibus: “Si proceda pure contro i Sassaiuoli Chierici”. La “battaglia” dopo l’abolizione fu immortalata in un quadro, ormai disperso, posseduto dalla famiglia Carrara: un segno che quella spericolata “festa” era abbastanza radicata benché gli storici antichi, per es. Nolfi e Amiani, non ne parlino forse per non evidenziare la brutalità di certi fanesi. Ciò che successe a Sant’Agostino ci fa però capire che tale brutalità aveva diffuse radici lontane e antiche. 2003 89 QUALCOSA DI EBRAICO NEL DIALETTO FANESE È noto che il sabato è per gli ebrei giorno festivo dedicato al riposo e alla preghiera: recenti episodi, purtroppo tragici, lo hanno messo per tutti in chiara evidenza. Anticamente anche a Fano c’era la presenza di una comunità ebraica. I Malatesta erano clienti di prestatori ebrei ed erano protettori di quella comunità. All’inizio del Cinquecento il celebre tipografo ebreo Gerolamo Soncino stampò proprio a Fano parecchi suoi libri famosi. La sinagoga e il cimitero ebraico c’erano, però non esistette mai un ghetto. Qualche parola di origine ebraica adattata o, se volete, storpiata passò nel dialetto; pochissime sono giunte sino a noi. Il sabato, da cui abbiamo preso le mosse (shabat o shabbat, da leggere sciabat) è presente col vocabolo sciabà: fare sciabà in fanese - ma forse anche in altri dialetti della provincia pesarese - significa non tanto “fare festa”, ma spendere o, addirittura, “sprecare”: ha fat sciabà de ognicò, ha sprecato tutto. C’è poi, il verbo dialettale asciatare, sciatare che rende l’italiano “soffocare”. Nei Malefici una carta fanese, nientemeno del 1372, parla di una lite fra due ebrei e fra l’altro vi si legge che Massario offeso da Manuele gli dice sel non fusse per lo bando eo te asateria cioè “io ti asciatterei”, ti soffocherei, ti ammazzerei. L’origine ebraica della voce chi la fa derivare da sahat (macellare secondo l’uso ebraico) chi, con maggiore precisione, dal termine shechitàh (da leggere scescità) che si riferisce all’azione del macellaio il quale prende alla gola l’animale e gli recide la trachea. C’è anche un vocabolo rimbalzato a Fano dal dialetto giudaico-romanesco: è il fanese batanài. I batanài sono principalmente costituiti dalla ferraglia che fa uno sgradito rumore quando è sbattuta, ma a volte ci si riferisce a qualsiasi altra cianfrusaglia; ebbene nel dialetto giudaicoromanesco, come scrive in un suo articolo Luigi Magni regista del film In nome del Papa Re, badanài erano chiamati gli ebrei che a Roma da secoli esercitavano il mestiere degli stracciaroli. E lo stracciarolo, come tutti sanno, raccoglieva nella sua carretta anche i ferri vecchi: cioè, per dirla in fanese, ogni sorta de batanài. 2003 90 CIALOCCA, FACOCCHI, PICAROLA Non mi soffermo a lodare quelle compagnie teatrali che cercano di salvare il dialetto fanese, quello autentico (perché ora sta diventando un gergo mescolandosi ad altre pronunce e anche ad altre parole). Ho interrogato a suo tempo i vecchi fanesi perché mi chiarissero il significato di “cialocca” che avevo trovato in una poesia del 1876, ma nessuno seppe darmi una risposta. In una lettera del 1° giugno 1873 alla madre di Ruggero Mariotti (la sora Lucia) un certo Federico de Vergon ci assicura che le poche donne che percorrevano il Corso al mattino (forse era il giorno della festa dello Statuto) erano chiamate “le lumache” e giravano per “fè veda el vestit”. Lumache addio per sempre! Quante parole si sono perdute con la cessazione di vecchi mestieri! Vocaboli che riguardavano gli arnesi, i materiali, il gergo stesso che ogni artiere inventava per conto suo o imparava dal padrone. Non solo sono venuti meno (com’è naturale) “facocchi” (fabbricanti di carrozze), ma anche molto di quello che era legato alla seta e alle setarole. Lo stesso sta per accadere ai “vetturini”. Chi di voi sa cos’è la “picarola”? Era un arnese pieno di punte che usavano i fabbricanti di cotechini i quali “piccavano” il loro prodotto perché risultassero meglio i profumi alla cottura. Sta per scomparire il “fratello di latte” (el fratel de lat) che era un bambino dato a balia, in genere in campagna, perché la balia gli desse il latte che alla madre naturale mancava, o che non aveva voglia di dare per motivi estetici. El fratel de lat era una sorta di parentela che veniva riconosciuta per tutta la vita. Dove sono adesso (con tutti gli omogeneizzati) i “fratelli di latte”? Credo che più nessuno si ricordi di loro. Quando veniva offerto un po’ di mistrà per cacciare giù qualcosa che s’era inghiottito si diceva: Ne prend una sigrimina per ligerì ne prendo una goccia per digerire; e quando nel piatto si lasciava un nonnulla si diceva esortando: “Non lasciare i miracoli”, en lasciè i mirècul, frase che non aveva nulla da fare col sacro (ma che certamente derivava da miror che indicava meraviglia, stupore). Un’altra frase che non si dice più è quella che riguarda l’indulgenza, e 91 anche questo non ha niente a che fare col sacro (deriva da “indulgere”); si diceva per compiacere la padrona di casa: El prend per indulgensa, lo prendo per indulgenza. Non si voleva passare da scortesi, tutto qui, l’indulgenza sacramentale non c’entrava nulla: era però il vecchio latinorum che faceva la sua comparsa anche nel dialetto. Ora non più. 2004 92 LA FIERA “DI SCALDIN” Tre erano le fiere principali che fino a qualche decennio fa si tenevano a Fano: la fiera di S. Paterniano (in luglio); quella di S. Bartolomeo, che in dialetto diventava San Bartulumea e, agli inizi del secolo scorso, era addirittura San Bartlumea, che si tiene in agosto (ed è l’unica sopravissuta); e la fiera di S. Lucia (13 dicembre) detta, appunto, la fiera di scaldin. Ne era venuto fuori il detto che certamente i più anziani ricordano: Chi vol veda le bel de Fan venga el giorn de San Paternian; chi le vol fnì da veda venga a San Bartulumea; chi le vol cum se sia venga el giorn de Santa Lucia (13 dicembre con la variante chi le vol purtà via venga el giorn de Santa Lucia). Cosa era lo scaldino che, ormai come tante altre cose, non si usa più? Era un recipiente a forma di secchiello, era di coccio smaltato all’esterno di marrone scuro (famosi quelli di Fratte Rosa), oppure era di metallo, forse alluminio; riempito di brace, la cenigia (in dialetto la c’niscia), coperta da cenere serviva a scaldare le mani. Era usato soprattutto dalle donne anziane che lo tenevano sotto la scialina, rigorosamente nera. Oppure lo mettevano in inverno dentro lo scaldapiedi, un attrezzo di legno che, come dice il suo stesso nome, serviva a dare un po’ di caldo ai piedi. Ma ora la modernità (il progresso!) incalza; un grande supermercato vale più di tre fiere; pensare al passato serve solo a non perderne la memoria: non serve ad altro; ma la vera memoria è sempre da coltivare; il mondo come è oggi, quello che conosciamo tutti i giorni ci rende davvero felici e contenti? 2006 93 I POVERI DEL SABATO Oggi, giustamente, si parla e si cerca di provvedere alle “nuove povertà”, sicché quelle vecchie, da cronaca che erano, ormai sono storia che è bene non dimenticare. Chi erano a Fano “i poveri del sabato”, i purét del sabet? Erano una pattuglia di poveri, uomini e donne generalmente anziani o vecchi, che ogni sabato, a schiera facevano tutto il percorso da San Leonardo a Porta Giulia battendo negozi e botteghe per chiedere l’elemosina: saltavano quelli dove sapevano che non c’era niente da rimediare; dai “più buoni” ricevevano qualche spicciolo. C’erano, però, anche gl’indipendenti che, non volendosi confondere nella suddetta mesta pattuglia, andavano alla cerca in altre strade bussando solo a quelle porte che abitualmente si aprivano; mai si spalancavano, però! Finirono per passare in proverbio: Me pèri un purét del sabèt; mi sembri uno di quei poveri del sabato, si diceva a chi appariva piuttosto ridotto male. Venivano ad elemosinare anche da fuori Fano; ricordo un povero storpio che accovacciato su una specie di carrettino trainato da due cani sfiancati gridava “Mamma, lo vedi come sono? Dammi una mela, un tozzo di pane, una piccola offerta”. Mi faceva venire in mente quel cieco analfabeta di cui Ildefonso Nieri, alla fiera di Sant’Ansano a Ponte a Moriano (Lucca), registrò l’esemplare, italianissima supplica. Quel cieco, non dimentico di parlare a gente cristiana, fra l’altro diceva “Benedetti cristiani di Dio, vedete i miei occhi bruciati, distrutti… Fratelli, sorelline mie non mi dibandonate, poverino! Ché io non dibandonerò voialtri con le mie orazioni!” Poi con eleganza trecentesca toscana aggiungeva: “Oh, buttamelo un piccolo sollievo di carità, che vi saranno tante rose e fiori in Paradiso”. Non sono certo che a Fano sempre si foderasse religiosamente la propria richiesta di aiuto, ma le donne questuanti solevano tenere in mano la corona del rosario: muto segno religioso anche quello. “Mutiam dolore”, diceva l’Aleardi: la fame; sì, c’era in giro anche quella! Quando non erano in funzione le cosiddette cucine economiche comunali molti poveri andavano a procurarsi un po’ di minestra sotto 94 le finestre della caserma Paolini, in via Bixio. Tra le inferriate delle finestre i soldati travasavano il rancio o i suoi avanzi nelle pentole o nelle gavette che i poveri tendevano. Tutto ciò oggi sembra impossibile e forse ci fa schifo, ma allora, ricordo gli anni ’30 e ’40, quella brodaglia era un ben di Dio per qualcuno. Poi essa fu venduta a chi allevava maiali! E furono messe fitte retine alle finestre della caserma per far cessare “lo scandalo”. I poveri: quante umiliazioni hanno subito e subiscono! 2002 95 LE VILLE DELLA CAMPAGNA FANESE Da pochi giorni Fano può contare su un bel libro che arricchisce la sua storia. Infatti la bella serie di pubblicazioni sulle ville suburbane e residenze signorili sparse nella nostra provincia (et extra) promossa dal prof. Peris Persi, dell'Università di Urbino, si è arricchita di un volume su "Ville e ‘Casini di delizie’ nella campagna di Fano". II libro ha per autori lo stesso prof. Persi e la dott. Erika Roccato; lo hanno presentato nel salone della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, di fronte a un vasto pubblico, i proff. Franco Battistelli e Carlo Pongetti. Sono trentaquattro le ville, i palazzi, le case signorili della campagna fanese che, per il fatto di essere presentate in un quadro organico di studio e di valutazione della loro origine e funzione attraverso una documentazione archivistica di prima mano, e con l'ausilio di materiale fotografico vecchio e recente, fissano e salvano una parte non secondaria di storia civile, economica e paesaggistica di Fano; una storia che riguarda sia il rapporto città-campagna, proprietari (nobili o borghesi e territorio), sia l'evoluzione strutturale ed estetica nonché l'uso pratico (vicinanza all'azienda agricola, casa di villeggiatura o di residenza panoramica) delle costruzioni stesse. Una storia che rimarca quella differenza che un tempo esisteva con rigidi confini tra città e campagna, differenza oggi scomparsa per la dilagante dissipazione e urbanizzazione del territorio che, dicono bene gli autori, ha addirittura inglobato nel perimetro cittadino certe ville signorili un tempo “fuori città”. È giusto che tra le prime venga passata in rassegna Villa Castracane (sui colli della Galassa, di fronte a1 mare) ritratta con bella suggestione in una foto di Paolo Del Bianco: è la più antica (1566) delle dimore signorili extra urbane fanesi quando ben poche tra le decine di famiglie nobili locali (lo lascia capire Vincenzo Nolfi che scrive nel Seicento) potevano permettersi il lusso di costruire comodi "casini di delizie". Gran parte di essi sorse nel Settecento e nell'Ottocento. Distintamente ricordiamo ancora, negli anni Trenta, quelle ville sui 96 colli di S. Biagio, di Monte Giove (la Villa Rinalducci e S. Cristina, tra le più belle e ora tra le più abbandonate), di S. Andrea in Villis dove passeggiavano facendo la ruota i soliti impettiti e striduli pavoni. Ricordiamo (è scomparsa per far "apparire" un condominio) Villa Cinti, a S. Orso, con i suoi due centenari cipressi all'ingresso, la cappellina esterna col campaniletto e i busti neoclassici che l'adornavano. Ricordiamo soprattutto Villa Apolloni (è rimasta in piedi pressoché la sola torretta) che nel 1832-33 ospitò stabilmente la famiglia del principe Enrico Barberini, "latore" pontificio della “rosa d'oro” riservata ai regnanti: con lui era Urbano, suo figlio, che invitava a pranzo, al giuoco, a merenda noi suoi compagni di scuola (al S. Arcangelo); e ci pareva una stranezza quasi uno scherzo venir serviti da un distinto cameriere in guanti bianchi! O ascoltare l'arcigno precettore che parlava esclusivamente in inglese! Un mondo perduto, che è bene non vada interamente sepolto. A questo serve il bel libro di Persi e della Roccato che, oltre a planimetrie e schizzi, fa rivivere tanti personaggi che in quelle ville o lasciarono molto di sé o trovarono qualcosa del loro stesso esistere. 1997 97 IN ATTESA DI NAPOLEONE La prossima settimana cade il duecentesimo anniversario dell’occupazione repubblicana di Fano e naturalmente le dedicheremo la prossima puntata di queste cronache. Nel febbraio 1797 si aprì direttamente e concretamente un periodo di trasformazioni anche in casa nostra: ma non è mia intenzione proporre o discutere interpretazioni storiografiche su quel tumultuoso “lungo periodo”. Mi limito a ricordare che le attese, le realizzazioni dei rivoluzionari, detti anche “patrioti” e “giacobini”, e il loro scontro con chi era contrario alle novità e lavorava poi alla restaurazione generarono fra la popolazione paure, sofferenze, delusioni, né mancarono lutti, ruberie, prepotenze. Fu dunque variegato il corollario. Lasciamo dunque un po’ di spazio a qualche episodio di cronaca degli anni che precedettero l’innalzamento dell’albero della libertà in Piazza Maggiore, la Piassa Granda, dei fanesi. Un albero che certamente non prometteva nulla di buono a chi deteneva il potere dal momento che veniva celebrato con una strofetta che diceva: “Or che piantato è l’albero/ s’abbassino i tiranni/ sui lor superbi scanni/ salga la libertà”. Strofetta che in una sua versione sintetica e canagliesca suonava trucemente: “Con le budella dell’ultimo prete/ noi strozzerem l’ultimo re!”. Anche allora, prima della ghigliottina, furono le parole a giustiziare gli avversari. Nelle vicende fanesi dell’ultimo decennio del Settecento spicca la figura del Vescovo, il faentino Antonio Gabriele Severoli (1752-1824) che guidò la diocesi dal 1787 al 1807, anche se nel 1802 si trasferì a Vienna come Nunzio apostolico: poi divenne Cardinale. Un dato della cronaca da non tralasciare è che dal 1790 al ‘95 egli chiamò a Fano come Vicario generale mons. Francesco Saverio Castiglioni, nativo di Cingoli: siccome nel conclave che seguì la morte di Pio VII nel 1823 il nostro Severoli stava per essere eletto Papa (gli mancarono pochissimi voti) e siccome nel Conclave del 1829, dopo la morte di Leone XII, fu proprio il Castiglioni ad essere eletto Papa col nome di Pio VIII, possiamo dire che per cinque difficili anni la nostra diocesi 98 fu guidata da un tandem di eccezione: un futuro papabile e un futuro Papa! Un segnale di malessere civile si ebbe nel settembre 1791 quando un centinaio di popolani, con donne e ragazzi, esasperati per il prezzo del pane e per un permesso di esportazione di farina improvvidamente rilasciato dal governatore mons. Bisleti, dopo aver assaltato un deposito di grano si impadronirono di armi e occuparono il bastione del Sangallo dove trovarono un paio di cannoni con munizionamento. Li puntarono minacciosamente contro la città, esigendo assicurazioni sul prezzo del pane e sugli approvvigionamenti di derrate alimentari. La rivolta, benché circoscritta nel numero, fu giudicata gravissima e addirittura si pensò ad un complotto per far partire da Fano una insurrezione che “incendiasse” tutto lo Stato Ecclesiastico. A parte queste esagerazioni, il momento fu davvero critico e purtroppo né il governatore (un incapace) né i priori, espressi dalla nobiltà, seppero affrontare la situazione. Solo il Vescovo si recò dai rivoltosi, li supplicò di desistere dalla violenza, promise di far avere a tutti l’indulto sovrano (si commosse e si turbò talmente che a un certo punto svenne): lo ascoltarono e uscirono tutti dal “baluardo” al grido di “viva Maria, viva S. Fortunato” (questo particolare è contenuto nella relazione che il Vescovo inviò al Segretario di Stato). Dopo 48 ore giunse l’indulto: ma tra il ceto dei maggiorenti c’erano degli scontenti perché la restaurazione dell’ordine “con le giaculatorie del Vescovo” proprio non andava giù. A rendere amareggiato l’animo del Severoli, che insistentemente chiedeva a Roma di provvedere la città di un buon governatore perché lui non voleva immischiarsi in cose di politica che non lo riguardavano, si aggiunse l’accusa di tradimento lanciata contro di lui per il fatto che nei mesi successivi alcuni dei rivoltosi già graziati continuando a contravvenire alle leggi furono arrestati, processati e condannati. Non si riusciva a fargli capire che l’indulto valeva per i fatti del settembre 1791 e non anche per il tempo a venire! 1997 99 8 FEBBRAIO 1797: PASSA IL GENERALE BONAPARTE Dopo la burrasca cittadina del 1791 ben altri timori serpeggiano fra la nostra popolazione di fronte alle notizie degli eccessi rivoluzionari di Francia in cui gli avversari del giacobinismo indicavano la mano di una congiura non solo antimonarchica, ma anche anticattolica. Non ci meraviglia che baluginando all’orizzonte un periodo denso di incognite a tanti del popolo sembrasse che in segno di pericolo, e di richiamo alla devozione, numerose Madonnine, nelle cappelle o nei cantoni delle città battessero gli occhi. Accadde anche a Fano con la Madonnina del muro esterno della chiesa di S. Giovanni (era nell’angolo ora con le calzature Fiacconi). Il Vescovo Severoli ordinò una inchiesta e il quadro fu attentamente esaminato da due noti pittori cittadini: Carlo Magini e Giuseppe Luzi. Intanto l’armata comandata dal ventisettenne generale Napoleone Bonaparte, scesa in Italia nel 1796 per tenere impegnati gli austriaci di Lombardia, dopo aver assolto (e come!) il suo compito viene dirottata dal suo condottiero verso altri scopi e dilaga in altri Stati e regioni d’Italia. Napoleone punta sullo Stato Pontificio: il 19 giugno entra a Bologna. Non mettiamo in discussione la spinta che da allora si ebbe verso il rinnovamento delle istituzioni; pur tuttavia si dovrà notare che i metodi non furono indolori e tanto meno furono “fraterni, liberali, giusti”. Ma tant’è: è ben risaputo che i vincitori mettono sempre dalla parte del “diritto” anche le loro prepotenze e iniquità. Lo Stato Pontificio, praticamente disarmato, aveva già chiesto ai sudditi e agli enti ecclesiastici un esborso straordinario (per le spese di difesa) pagabile anche in oggetti d’oro e d’argento che avrebbero permessa di battere monete pregiate: dalle chiese della Diocesi di Fano partirono due quintali e 38 chili di oggetti sacri! Poco dopo, da Bologna, fu Bonaparte ad imporre (luglio 1796) una forte contribuzione al governo pontificio: fu la seconda spogliazione in attesa di altre sempre più pesanti. Fu giocoforza cedere, con la segreta speranza che il Bonaparte si fermasse. Ma da Bologna, invano contrastato, si mosse verso Ancona mentre cominciavano a manifestarsi contro i francesi 100 episodi di ribellione popolare: la cosiddetta “Insorgenza”. Il 6 febbraio 1797 i francesi entrano in Fano senza combattere perché i pontifici s’erano ritirati a Senigallia. Il Vescovo aveva raccomandato di non offendere in alcun modo le truppe repubblicane per evitare sanguinose rappresaglie. Dal canto suo, rifiuta di prestare giuramento “alla loro Repubblica” considerando la Francia “solo potenza occupante”. Naturalmente viene insediata una nuova Municipalità: i francesi di solito affidavano tale incarico ai patrioti moderati, più sicuri di quelli con la testa calda perché più propensi ad eseguire i loro ordini. Finalmente 1’8 febbraio, sul primo pomeriggio, proveniente da Pesaro dove aveva pranzato, il generalissimo Bonaparte fece il suo ingresso a Fano; entrò da una porta (Porta Giulia?) ed uscì senza fermarsi da un’altra (Porta Marina?); percorse via del Corso senza tante cerimonie e senza salutare nessuno, nemmeno la nuova Municipalità che lo aspettava ansiosa ...! Si dice che il filosofo Hegel vedendo, anni dopo in Germania, Napoleone in sella abbia esclamato: “Ecco la Storia che passa a cavallo”. Un po’ più modestamente i fanesi avrebbero potuto dire (ma non ci pensarono): “Ecco la storia che passa in carrozza!”, perché Napoleone attraversò Fano chiuso in una carrozza preceduta da Ussari e circondata da dragoni a cavallo che lanciavano manifestini per assicurare che la libertà era nelle sicure mani di amici del popolo e che l’armata avrebbe tenuto un contegno dignitoso e umana onde smentire tutte le calunnie lanciate contro di essa. 1997 101 IL VESCOVO TENTÒ DI SALVARE UN “GUIDO RENI” Quando i Francesi occuparono Fano il generale Napoleone Bonaparte (come scrive nella sua “Cronaca” Tommaso Massarini) passò in carrozza per il nostro Corso l’8 febbraio 1797. Non sappiamo da quale Porta sia entrato, forse uscì da Porta Marina; era diretto ad Ancona. Fu allora che cominciò per Fano e per tutta la provincia un periodo turbolento il quale per la sua lunghezza e complessità non può essere oggetto del presente articolo. Era Vescovo diocesano Mons. Antonio Gabriele Severoli che ebbe la consacrazione episcopale a soli trenta anni. Fu poi nominato nel 1805 Nunzio apostolico a Vienna; nel conclave da cui uscì Leone XII (Annibale Della Genga) il Severoli non venne eletto Papa per pochi voti. Gli esperti francesi che accompagnavano il Bonaparte decisero di requisire dalla chiesa di S. Pietro in Valle il quadro dell’altar maggiore, La consegna delle chiavi a S. Pietro dipinto da Guido Reni e il S.Giovanni alla fonte del Guercino. Lasciarono stare l’Annunciazione, altra tela del Reni, perché di proprietà privata, essendo (a quel che parve) dei conti Gabrielli. La tela con La consegna delle chiavi era stata restaurata, malamente, durante il Settecento. Quando si seppe della requisizione il Vescovo scrisse una lettera (la cui minuta si trova nell’Archivio Storico Diocesano) che inizia con un enfatico “Invitto conquistatore”. Gli chiese 300 “rubbia di grano per sostenere sino al nuovo raccolto una turba di infelici” di Fossombrone e gli chiese di non portare via il quadro di Guido Reni che egli semplicemente chiama “Guido”. È tradizione che Napoleone abbia inviato al Vescovo la propria risposta, ma tale lettera non si trova da nessuna parte; forse il Severoli la portò con sé a Vienna e poi a Viterbo dove fu trasferito quando venne nominato Cardinale. Aggiungo che il celebre scultore Canova incaricato, dopo la caduta di Napoleone, di recuperare i tesori asportati dai francesi, regalò alla Francia il quadro del Guercino, che ora si trova nel museo di Montpellier. Il dipinto del Reni è al Louvre; è stato esposto a Bologna 102 nel 1988 nella mostra dedicata alla pittura italiana del Seicento. Non posso chiudere senza ricordare una battuta antinapoleonica che allude alle opere d’arte esportate in Francia: un tale chiede: “È vero che a Parigi rubano tutti?”. Risposta: “Tutti no, ma bona parte!”. 2007 103 “TESORI” IN VOLO PER PARIGI Il giorno successivo al passaggio del generalissimo Bonaparte la Municipalità fanese decretò l’apertura dei festeggiamenti di carnevale, dal 9 al 28 febbraio. Il 25 di quello stesso mese, ma non fu certamente una carnevalata, fu innalzato in piazza l’albero della libertà. Poca gente, poco entusiasmo, popolazione piuttosto fredda, se non addirittura ostile: a molti era chiaro che si trattava di una occupazione straniera. Oltre alla abolizione dei titoli nobiliari, dei vestiti con i merletti, degli stemmi patrizi, e persino dell’abito ecclesiastico, fu imposta a tutti la coccarda tricolore e l’ordine di usare solo il titolo di “cittadino”. Non dimentichiamo che i giacobini furono i primi a sperimentare nell’epoca moderna un regime totalitario e che hanno avuto seguaci fin nel nostro secolo. Continuarono le “contribuzioni” e le “requisizioni”: il nostro Comune sborsò più di 25.000 scudi, furono requisite centinaia di rubbie di grano nelle campagne insieme con un centinaio di buoi e una cinquantina di cavalli e persino 300 paia di scarpe. Le chiese furono spogliate delle antiche pianete e di oltre 280 chili di arredi sacri d’argento. Senza contare le ruberie perpetrate dalla truppa nonostante i severi ordini ufficiali in contrario. Il 19 febbraio fu firmato a Tolentino il trattato che ristabiliva la pace tra la Repubblica Francese e lo Stato Pontificio. E Napoleone riapparve a Fano il giorno dopo insieme ad una possente carovana colma di tesori e di opere d’arte razziati nelle Marche. Da Loreto, dov’era giunto il 13 di quel tremendo febbraio, aveva asportato tutti gli oggetti preziosi trovati nel sacello della Santa Casa, dalla Sala del Tesoro aveva prelevato oggetti preziosi per cento chili di oro massiccio e duemila chili di argento: erano doni votivi di sovrani, città, singoli fedeli. Dentro uno dei carri che transitarono per Fano c’era, imballata, la statua lignea originale della Madonna di Loreto: eppure aveva assicurato che non intendeva offendere il sentimento religioso del popolo! Quello stesso giorno furono sottratti a Fano, per sempre, dalla chiesa di S. 104 Pietro in Valle la pala dell’altare maggiore, La consegna delle chiavi di Guido Reni e, sempre del ‘600, il S. Giovanni alla fonte del Guercino. Il Vescovo cercò di farsi almeno restituire la tela del Reni e scrisse una lettera a Napoleone che così inizia: “Invitto Conquistatore, ho qui una chiesa sacra alla memoria del principe degli Apostoli. I vostri commissari hanno posto a requisizione il quadro di essa, che è di Guido. Assicuratevi che questo quadro non è gran cosa. Vel chieggo a monumento della vostra liberalità. Spero tutto da Voi”. In realtà quel capolavoro era in pessime condizioni per un restauro maldestro. Mons. Paolucci ha scritto che Napoleone rispose in termini di molta cortesia (era grato a Severoli che aveva scongiurato possibili sommosse a Fano), ma la tela del Reni è ancora al Louvre. Naturalmente anche la lettera di Napoleone è scomparsa...! A Tolentino il Bonaparte praticamente “ripulì” le finanze pontificie impoverendo lo Stato, ma anche i cittadini e pretese, oltre al resto, 30 milioni di lire francesi pagabili anche in preziosi; ed anzi Fano, con Ancona, fu scelta (art. 15 del trattato) come ostaggio in mano alle truppe francesi finché non venisse pagata una parte della grossa somma pattuita. Non c’è da meravigliarsi se molti sudditi pontifici presero a schioppettate i francesi; ma di questo e del ritorno francese nell’inverno di quel 1797 parleremo a suo tempo; intanto sarà bene non dimenticare (lo diceva un lucido e distaccato intenditore che “la rivoluzione è una faccenda lunga e noiosa”). 1997 105 SAN NAPOLEONE NON PREGA PER NOI L’imperatore Napoleone Bonaparte aveva un cruccio, forse (ci suggerisce la psicoanalisi) fin da bambino, perché nella liturgia e nei calendari, o lunari come un tempo si diceva, non era ricordato nessuno che portasse il suo nome, non c’era nessun San Napoleone. Veramente la curiosità di cui andiamo parlando dovevamo ricordarla prima di ferragosto, giorno in cui è nato Napoleone, ma, come si dice, l’uovo è buono anche dopo Pasqua…! Dunque l’imperatore stimandosi onnipotente, anche quando si trattava solo di vanitosa prepotenza, tanto fece che a un certo punto, con l’intento non troppo segreto di servirsi della religione come instrumentum regni, riuscì a far scovare da alcuni ecclesiastici, piuttosto servili verso di lui, un eremita antico, un “padre del deserto” che non si chiamava propriamente Napoleone, ma Naplone, Napione o qualcosa di simile. Era il 1806 e in quell’anno venne pubblicato uno dei famosi catechismi napoleonici ora noti solo agli studiosi. Una commissione nominata dalla Santa Sede non approvò quel catechismo perché il papa Pio VII considerava libertà irrinunciabile dei vescovi la scelta del catechismo da proporre ai fedeli. In effetti su tale questione la Santa Sede, com’era costume di Napoleone, si trovò di fronte al fatto compiuto e, per di più, si trovò di fronte a un decreto del 3 marzo 1806 con cui il cardinale Caprara, assai propenso ad ignorare le direttive romane, fissava per tutto l’Impero la festa di San Napoleone il 15 agosto mettendo da parte ogni riferimento alla tradizionale festa dell’Assunzione della Madonna. Fu così che San Napoleone, non sappiamo con quanto seguito fra i fedeli, ma certamente con soddisfazione dell’imperatore, entrò fra i santi del calendario. Dopo tutto quello che la Rivoluzione aveva fatto soffrire alla Chiesa ci mancava proprio la trovata di San Napoleone che, però, fece poca strada sebbene nel 1807 la sua festa fosse imposta anche nel Regno d’Italia napoleonico. Caduto l’imperatore la festa di San Napoleone nel 1814 fu abolita in Francia con decreto reale, ma con pervicacia la ristabilì nel 1852 Napoleone III (detto, a scanso di equivoci, Napoleone il piccolo). 106 Sconfitto dalla Prussia nel 1870 con lui finì anche San Napoleone di cui nessuno parlò più e così il 15 agosto fu completamente restituito alla Vergine Assunta. Oggi, però, eccezion fatta per le feste locali che hanno radice nella storia e nella fede, in quel santo giorno si sente molto parlare di turismo e poco di Assunzione. 2002 107 LA CASSA DI RISPARMIO DI FANO HA 155 ANNI “Lo stabilimento della Cassa di Risparmio, da assai tempo invocato da quanti apprezzano la virtù della beneficenza, è presso ad aver vita anche fra noi: ed annunciando ai nostri concittadini una tale avventura noi sentiamo vivamente nell’animo il pregio di essere stati prescelti all’avviamento di un pubblico bene, il quale fondandosi nella moralità, nella istruzione, e nella previdente economia di un intero popolo, ad altro non intende che a sollevarne la miseria e ad accostumarlo al risparmio”, etc. Così inizia l’Avviso col quale il 19 maggio 1843 il duca Giulio di Montevecchio, che ne fu il primo presidente, dava atto della costituzione del “nuovo pio Istituto” le cui tavole statutarie erano già state approvate, il 14 gennaio, da papa Gregorio XVI, sovrano temporale dello Stato Ecclesiastico: per memoria storica il suo stemma dovrebbe essere dipinto nel salone di rappresentanza, accanto all’arme dei Malatesta. La Cassa non nacque come Istituto di Credito nel senso moderno (lo divenne molti decenni dopo) perché all’inizio prevalsero le finalità qui sopra enunciate, soprattutto l’educazione al risparmio perché non si trovasse nella indigenza chi, spesso senza alcuna pensione, si ritirava dal lavoro; e poi pubblica beneficenza e infine, sebbene nell’Avviso non se ne parlasse, per combattere la piaga dell’usura. I depositi fruttavano il 2% annuo, i prestiti erano concessi al 4%. La Cassa iniziò la sua attività 1’11 giugno di quello stesso 1843 con un capitale interamente versato a fondo perduto da 64 sottoscrittori privati che acquistarono 68 azioni di 20 scudi romani l’una per un totale di 1360 scudi: più o meno 15-20 milioni di lire attuali. Sottoscrittori furono una trentina di nobili, sedici tra ecclesiastici ed ordini religiosi, compresi Oratoriani e Gesuiti, e poi professionisti, commercianti, possidenti. Aprono la lista il Vescovo mons. Luigi Carsidoni e il Gonfaloniere conte Filippo Bracci che, si badi, sottoscrissero uti singuli, a titolo personale, senza impegnare la Diocesi e il Comune. Una curiosità: tra i sottoscrittori troviamo l’Intendenza Generale della 108 Casa Imperiale e Reale di Leuctemberg. Che c’entrano costoro con Fano? I duchi di Leuctemberg erano gli eredi di Eugenio Beauharnais, figliastro di Napoleone e Viceré del Regno Italico; in quanto Viceré godeva di un appannaggio costituito dalle rendite di molti terreni sottratti, non solo a Fano, agli ordini religiosi. Eugenio, quando nell’aprile 1814 scomparve il Regno Italico, fu nominato duca di Leuctemberg dal re di Baviera, suo suocero, e ottenne dal Congresso di Vienna e dalla Chiesa di continuare a godere dell’appannaggio per sé e per i propri eredi: ecco perché tra i soci fondatori della nostra Cassa figura anche la Reale e Imperiale Casa di Leuctemberg i cui soldi, in realtà, erano della Chiesa. La Cassa aprì il suo unico sportello l’undici giugno 1843: era aperta al pubblico le domeniche e i mercoledì dalle 10 alle 13 e funzionava con un solo ragioniere volontario e, perciò, senza stipendio. Solo una trentina d’anni dopo il portafoglio crebbe con alti e bassi: disastroso fu il 1903. Nel 1888 il governo italiano sottopose al controllo ministeriale le Casse di Risparmio pur riconoscendone la natura privatistica e decretando, anzi, che “in nessun caso” Comuni e Province, sindaci e assessori ne assumessero l’amministrazione; una regola d’oro. 1998 Papa Gregorio XVI LIBERA FONDAZIONE IN LIBERO COMUNE Ciò che ho scritto due settimane fa nel mio breve intervento sulla origine della Cassa di Risparmio di Fano fa da battistrada a ciò che penso circa il rapporto tra Comune e Fondazione Cassa di Risparmio dato che quest’ultima, nata sul fondamento di una recente legge, ha assunto nei confronti di Fano e di altre realtà comunali del tradizionale comprensorio della Carifano il compito di intervenire ai fini di pubblica utilità nei campi indicati dalla stessa legge costitutiva: Arte e Cultura, Sanità, Istruzione e Ricerca scientifica, Assistenza e Beneficenza. La Fondazione, non svolgendo attività ‘bancaria’ o di lucro, ha così recuperato quella vocazione al pubblico bene che, pur in altre forme e con mezzi modesti, era ben presente nelle intenzioni dei fondatori di quel “pio istituto” che nel 1843 ebbe il nome di Cassa di Risparmio. In un certo senso, ma più grande (per nostra fortuna), si possono recuperare quelle benedette “radici” che in ogni campo tutti lodano, tutti cercano, ma che non sempre vengono percepite nella loro intima sostanza. Nel nostro specifico caso è innegabile che “le radici” affondano nel terreno della società civile, non in quello dell’attività costituita: né comunale né statale. Detto questo mi pare del tutto naturale che oggi fra le Fondazioni e gli Enti pubblici territoriali di più immediato riferimento, in primis i Comuni, vada cercato e stabilito un ottimale rapporto di buon vicinato: una collaborazione senza intromissioni reciproche né ordinanze né supervisioni - né primazie che, del resto, non sono previste o consentite né da leggi ordinarie né dalla Costituzione repubblicana! Non dimentichiamo che nelle Fondazioni bancarie c’è un quid di “privato-sociale” che le differenzia dai Comuni e che in una società libera e democratica (i due aggettivi “insieme stanno e insieme cadono”) nessuno può pensare che il Comune sia tutto o sia “tutti noi”. Ce ne danno vivente prova le numerosissime istituzioni di varia natura che operano nella nostra realtà sociale; e bisogna piuttosto chiedere che, fra esse, quelle operanti “a vantaggio del bene comune” trovino nelle Amministrazioni comunali il referente capace di creare e favorire la 110 loro vita e il loro sviluppo. In tale quadro va collocata l’attività pubblica delle Fondazioni bancarie che con i loro mezzi e le loro strutture decidono i propri interventi che sono di “iniziativa” attraverso i propri progetti, o di “sussidiarietà” per andare incontro ai Comuni, agli Enti sanitari, religiosi, culturali, del volontariato, ecc., secondo quanto è stabilito nella già accennata legge costitutiva. Da ciò consegue che le affermazioni “sopra le righe” fatte dal Sindaco di Fano in un recente convegno ad hoc svolto nella Sala Martinozzi sono apparse alquanto stonate e certamente ben diverse da quelle fatte dal Sindaco di Pesaro. Sono apparse stonate, dunque, e anche troppo marcatamente gramsciane: faccio riferimento a quanto Gramsci sosteneva riguardo al rapporto fra “intellettuali organici” e potere. In quella posizione ideologica vedo adombrata la teorizzazione delle “Fondazioni bancarie organiche al potere”, lo fa pensare una frase come questa: “Le fondazioni devono uniformarsi alle linee di indirizzo impartite dal Consiglio comunale” (cito da una corrispondenza giornalistica; e di mio aggiungo che ormai, purtroppo, il Consiglio comunale conta sempre meno), pare fatta su misura per far perdere alle Fondazioni bancarie la loro natura e consegnarle mani e piedi in mano ai Comuni col rischio della loro stessa sopravvivenza. Invece è necessario non dimenticare che la “democrazia” è concorso e anche “concorrenza” di forze libere e vitali: se mi è permesso un immodesto richiamo personale dirò che dopo non essere più stato rieletto in Consiglio Comunale non ho affatto perso capacità, volontà e interesse in pro della mia città. 1998 111 IL FAMEDIO NEL CIMITERO DI FANO Via della Giustizia. A molti sembra frutto di buon senso popolare questo nome della strada che porta al cimitero urbano dal momento che ognuno di noi deve finire fra le secche braccia di “sorella morte”. C’è almeno (consoliamoci) una giustizia per tutti. Ma non è così! Via della Giustizia, che anticamente seguiva un tracciato leggermente diverso, si chiama così perché vi passavano i carri della “giustizia” con i condannati a morte che venivano giustiziati o col taglio della testa o con la forca nel luogo dove oggi c’è la Cappellina del cimitero che in origine era dedicata, il titolo dice tutto, a San Giovanni Decollato. Lì, la notizia è del Cinquecento, i giustiziati venivano sepolti in povere fosse. Successivamente, nel Settecento, attorno alla chiesuola vennero inumati coloro che morivano nell’ospedale annesso alla chiesa di Santa Croce (che era in via Nolfi; c’è rimasta solo la torre che fungeva da campanile). Quei poveri morti (e si trattava solo di poveracci perché gli altri morivano a casa propria) collocati nei sepolcri della piccola chiesa ammorbavano l’aria della stessa e della intera zona. Fu deciso, allora, di seppellirli attorno a San Giovanni Decollato nel campo della Giustizia; nacque così con ampliamento fatto nel 1812, al tempo del Regno Italico Napoleonico, il nucleo di quello che sarebbe poi divenuto il Cimitero Urbano. La sua ristrutturazione e la cessazione delle sepolture nelle chiese della città risalgono attorno al 1864-65. La prima ad esservi sepolta fu una bambina del rione porto. E il Famedio? Non è un mistero (e anzi la storia “revisionista” ormai lo dice chiaramente) che molti dei più accaniti sostenitori e realizzatori dell’Unità d’Italia avevano in programma la scristianizzazione del popolo italiano e l’abbattimento del papato. A Fano nessuno si fece avanti (per quanto ci risulta) per laicizzare il cimitero abbattendo la chiesetta di San Giovanni Decollato, ma ci fu chi prestò attenzione a ciò che era stato ideato dalle logge massoniche (a Fano c’era quella intitolata a 112 Vitruvio): cioè costruire nei cimiteri una specie di anticappella per celebrare non già Dio, ma la scienza, l’intelligenza, le virtù civili dell’uomo: nacque così l’idea del Famedio (Famae aedis), il tempio della fama. Il Famedio di Fano, costruito molti anni dopo l’Unità, fra il 1907 e il 1909 dall’architetto Balducci, non ebbe un carattere anticristiano. Ha un prospetto con pronao su cui domina la scritta Nostri monumentum amoris (monumento di ciò che amiamo) e arieggia lo stile neoclassico. Sulla facciata ha tre quadri: quello centrale rappresenta Cristo resuscitato! Insomma è innegabile una contaminazione fra una religiosità laica (il primo quadro esalta l’ingegno e le arti; il terzo quadro non è più leggibile) e la tradizione cristiana. All’interno sono i busti dei fanesi illustri, non tutti necessariamente massoni; c’è anche il ricordo di padre Aldo Lampetti, missionario in Brasile, morto nel 1993. Non s’è ancora trovata la nicchia (ma forse non c’è il posto) per Capalozza e Volpini. C’è anche una grossa lapide coi nomi di tutti i caduti nelle varie guerre; in questi giorni abbiamo visto una ciotola di fiori dedicata “ai ragazzi e alle ragazze di Salò”: il revisionismo non ci autorizza, però, a dimenticare i diversi ruoli ricoperti nella nostra recente storia. Un’ultima nota: a custodire il Famedio deve pensarci il Comune e non altri, siano pure parenti o amici, che, invece, onorano con fiori e lumi solo qualcuno dei defunti presenti in detto Famedio. 2001 113 PORTO DI FANO UNA STORIA TRAVAGLIATA La sera del 28 dicembre 1860 pioveva a dirotto, ma in piazza Maggiore (ora XX settembre) un certo numero di persone era in attesa della carrozza sulla quale, diretto a Torino, viaggiava Vittorio Emanuele II. La sosta fu breve: dopo l’omaggio delle autorità, solo un cenno di saluto del re mentre dai presenti si alzava la voce di Gregorio Caprini, umile ma conosciutissimo artigiano (sellaio e costruttore di carrozze), che gridò: “Maestà, Fano ha bisogno del porto”. Il porto, allora, era in precarie condizioni, ma l’invocazione di Caprini restò inascoltata tanto che poco dopo il porto venne tagliato in due dal ponte di ferro su cui doveva passare la ferrovia. Ruggero Mariotti che scrive queste notizie nota che dopo cinquant’anni molti problemi portuali erano ancora da risolvere. Nel settembre 1861 il sindaco Bertozzi, in una sua lettera ufficiale al Console della Marina con sede ad Ancona, esprimeva con parole assai dure il suo scarso apprezzamento per i marinai da lui giudicati “gente bestiale”! Fra tanta cattiveria ci fa però sapere che i marinai in tutto erano 215 persone: 87 uomini, 73 giovani, 53 adolescenti, 2 vecchi. In realtà il porto di Fano ebbe una storia molto travagliata che qui, per ragioni di spazio, non è possibile raccontare per esteso. Diciamo solo che la darsena e il porto iniziati nel 1612 con consenso di Paolo V Borghese, ecco il perché del nome Portus Burghesius, erano belli esteticamente poiché aveva buon gusto l’architetto Gerolamo Rainaldi, ma la funzionalità si rivelò ben presto quasi del tutto nulla a causa del fango e della breccia che ostruivano i fondali vietando l’ingresso alle imbarcazioni di qualche consistenza. Il fiume Metauro e i suoi detriti erano accusati di tutto il danno; fatto sta che l’intenzione di rendere Fano città autenticamente ed economicamente marinara naufragò. Col porto fangoso e puzzolente si andò avanti per tutto il Seicento, poi nel Settecento si eseguirono altri lavori costosissimi tra cui la famosa cascata della Liscia e il ponte sulla strada per Pesaro che migliorarono un po’ la situazione; ma i fondali del porto e soprattutto l’imboccatura, dettero sempre da fare e per 114 tenerli puliti furono usati prima i “varocchi” (specie di argani con una pala) che in epoca moderna lasciarono il posto alle draghe a motore. Dunque dobbiamo dire che la tradizione marinara fanese, contrariamente a quanto si crede e a quanto si va scrivendo sulla propaganda turistica, non è antica ma moderna. Ebbe la sua grande stagione di sviluppo soprattutto nel corso del Novecento. Il caratteristico borgo dei marinari, dei portolotti, cominciò a delinearsi solo alla fine del Settecento, e raggiunse nei due secoli seguenti gli attuali limiti. Nel Seicento dentro le mura cittadine, in cui stavano 4.322 persone, le famiglie dei marinari, mescolate alle altre, erano in tutto 22 per complessive 86 persone: è quindi assurdo parlare di tradizione marinara di Fano. Le barche da pesca venivano tirate sulla spiaggia, quello era il loro porto! Che anticamente Fano non fosse nota come scalo marittimo ce lo mostra la mappa di Ebstorf che fu disegnata nel 1235 dal monaco Gervasio di Tilbury (mappa sconosciuta agli storici fanesi). In quella mappa vediamo Ravenna e Ancona poste proprio sulla linea del mare, a significare che avevano un porto; Fano (Phana) è leggermente staccata dal mare ed è indicata con un simbolo tutto terrestre: una porta turrita. 2004 115 PIAZZA AVVEDUTI DA RIFARE Il Palazzo Martinozzi, di cui è ignoto l’architetto, fu in un certo senso “scoperto” dai fanesi nel 1926 allorché venne demolito il fatiscente “palazzaccio Avveduti” che lo copriva, occupando gran parte della piazza che ora si apre davanti al Politeama. Ebbe finalmente luce una facciata splendida come splendidi furono altri esempi rinascimentali di edilizia fanese: la facciata di San Michele con la loggia della annessa Schola, la chiesa e il chiostro di San Paterniano, il Bastione Sangallo. Adesso i fanesi hanno scoperto per la seconda volta l’antico palazzo patrizio attraverso l’azzeccato volume PALAZZO MARTINOZZI vicende di una famiglia e di un restauro pubblicato dalla Immobiliare Adriatica e presentato e offerto alla Città dal Comm. Pedinotti, amministratore unico dell’Immobiliare. I testi di Aldo Deli, Franco Battistelli, Remigio Bursi (progettista del restauro), l’ampia serie di illustrazioni hanno decretato un immediato successo alla pubblicazione tanto meritoria in quanto dovuta alla sensibilità di un privato cittadino. Adesso, però, tocca all’Amministrazione Comunale dare l’ultimo tocco per valorizzare il monumentale progetto Martinozzi. Come? In modo semplicissimo (il suggerimento ci viene dagli stessi curatori del libro): rimovendo il volgare insignificante manto d’asfalto di Piazza Avveduti per sostituirlo con un selciato il cui disegno potrebbe evocare la traccia del perimetro esterno nonché del cortile interno del demolito palazzo Avveduti. Un selciato non anonimo, insomma. Che ne pensa l’Assessore all’Urbanistica? 1995 116 L’IRONIA DEL MINISTRO BOTTAI Quando l’allora Ministro dell’Educazione Nazionale, Giuseppe Bottai, venne a Fano fu ricevuto, tra gli altri, dal podestà Alberto Tonucci. Ci fu fra i due un colloquio inedito. Tonucci portò Bottai davanti al palazzo Montevecchio e gli disse: “Questo palazzo può essere la sede dell’Università di Fano”. E il Ministro: “Ma quando c’è stata un’università a Fano?”. Tonucci allora: “Non so precisare, c’era lo Stato pontificio”. Bottai ironicamente rispose: “Quando tornerà lo Stato Pontificio riavrete l’Università”. Quello Stato non è tornato, ma qualche facoltà universitaria sì; anzi proprio in questi giorni si è avuta notizia che da noi si terrà il Corso di laurea in Economia Aziendale. Ma già da qualche anno altre facoltà hanno avuto sede in Fano grazie all’impegno dell’università urbinate e al suo Rettore Prof. Bogliolo, grazie anche alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano e al Comune. Nella nostra città un tempo c’era l’università che per l’esattezza si intitolava “Università Nolfi delle Scienze in Fano”. Lo attesta una Notificazione che si trova nell’Archivio storico diocesano. L’università fu riaperta, dopo il periodo del Regno napoleonico, nel novembre del 1815. Vi si invitava “la prode gioventù speranza del secolo” e vi si parlava dei “soccorsi scientifici tanto desiderati”. A riaprirla fu papa Pio VII che dopo la sua elezione venne a Fano per pregare sulla tomba della madre (Giovanna Ghini) che, rimasta vedova, si era ritirata nella clausura del convento carmelitano di S.Teresa dove era morta nel 1777 in concetto di santità. Quell’università ebbe quattordici facoltà: andavano dalle “Belle lettere, poetica e retorica” fino alla “Storia ecclesiastica” né vi mancava la “Medicina”. L’università era “decorata” del Diploma cesareo concesso da Carlo VII imperatore del Sacro Romano Impero (ormai al tramonto) e confermato da Francesco I, imperatore d’Austria. Gli allievi furono sempre pochi; la nostra non era un’università di spicco; fu soppressa nel 1824. Derivava dal Collegio Nolfi di cui qui sarebbe troppo lunga la storia; diciamo solo che fu voluto da Guido Nolfi, morto nel 1627; il suo lascito fu rifinanziato da Rodolfo Nolfi e da Vincenzo 117 Galassi adottato dal Nolfi: però fu aperto solo nel 1680 per merito del vescovo Ranuzzi e dell’abate Federici: in seguito fu dichiarato “ecclesiastico”. L’attuale “Istituto di istruzione superiore Guido Nolfi” fino a pochi anni fa era Liceo Ginnasio, che ha compiuto l’anno scorso cento anni; ha avuto dunque un illustre antenato. 2007 118 È PROPRIO LA “VITTORIA ALATA”? Al primo piano del palazzo comunale nel cippo che sostiene la bella statua di Adolfo Apolloni (1855-1923), cittadino onorario di Fano, l’etichetta reca il titolo “Vittoria Alata”. Fu collocata in cima allo scalone d’ingresso quando sui muri dello stesso vennero sistemate (negli anni ‘20) le lapidi in memoria dei fanesi caduti nella prima guerra mondiale. La statua col titolo che le fu dato era effettivamente rispondente alla sua funzione e collocazione. Ma Apolloni l’aveva creata parecchi anni prima, per altra funzione e con altro titolo. Mentre si trovava negli Stati Uniti, dove aveva collocato parecchie sue sculture, gli morì improvvisamente a Boston la moglie, Marta Holt. Apolloni volle abbellire la tomba di Marta con una statua in bronzo che esprimesse la speranza in un loro futuro ritrovarsi; nacque così L’angelo della Risurrezione: infatti le braccia sembrano invitare ad uscire dal sepolcro e il corpo, che ha chiare forme femminili, forse rappresenta la moglie in sembianze angeliche. La nostra “Vittoria Alata” non è altro che la copia in gesso dell’Angelo collocato nel cimitero di Boston con tutt’altra intenzione. Però tra le lapidi dei caduti ci sta ugualmente bene. Ho tratto queste notizie da un appunto inedito del Conte Pier Carlo Borgogelli. 1993 SULLA PORTA DEL TEATRO UN MARMO SPRECATO La solenne scritta marmorea che ora, ben pulita e restaurata, sovrasta l’ingresso del Teatro della Fortuna è nata piuttosto storpia: non so quando né chi l’ha fatta. Ha una sessantina d’anni o forse più: ricercando in archivio sarà facile scoprirlo. Nelle prime quattro righe ci sono quattro sbagli e una improprietà; vediamo. “Questo palazzo della Ragione/ Sede nel sec. XIII/ del Parlamento dei Cento Cittadini/ nel MDCLV/ divenne ad opera di Giacomo Torelli da Fano/ Teatro della Fortuna/ Ricostruito nel MDCCCLXIII da Luigi Poletti/ A spese pubbliche”. Il palazzo in questione nacque come “Palazzo del Podestà” e sempre fu chiamato così anche dopo che all’interno Torelli lo trasformò in teatro. Fu alla fine del secolo scorso che a qualcuno venne il ghiribizzo di chiamarlo “della Ragione” forse perché anticamente nella sala principale si amministrava la “ragione”, cioè si discutevano le cause. Andiamo avanti: il palazzo fu “sede nel sec. XIII ecc. ecc.” Il palazzo in questione nel sec. XIII non fu sede di niente per il semplice fatto che non esisteva: la sua prima pietra venne posta nel maggio 1299 (proprio agli sgoccioli del secolo decimo terzo) e fu terminato, forse, nel primo decennio del secolo quattordicesimo: l’organismo assembleare che vi si riuniva a partire dal secolo quattordicesimo si chiamava, e sempre si chiamò, “Consiglio” e mai “Parlamento”. Procediamo: la recente riapertura del Teatro ha insegnato a tutti che il Torelli inaugurò il “suo” teatro nel MDCLVII (1677) non nel MDCLV (1655) come afferma la lapide bugiarda. Anche la penultima riga è equivoca, e quindi è inadatta per una lapide. L’architetto Poletti non “ha ricostruito” il teatro progettato dal Torelli (come se l’avesse rifatto tale e quale); ma demolito il teatro torelliano impraticabile per vetustà ne costruì uno del tutto nuovo per stile e per posizione topografica, in gran parte fuori del perimetro del Palazzo del Podestà. Conclusioni: prima di risistemare vecchie lapidi conviene verificare la 120 loro esattezza (non si sa mai!). Se buttar giù la torre di piazza non è possibile è invece possibilissimo buttar giù la lapide strafalciona: prima, però, bisogna assicurarsi che la nuova iscrizione venga dettata da uno che sappia leggere, scrivere, e far di conto! 1998 121 TEATRO DELLA FORTUNA: IGNORATA LA TRADIZIONE E L’ATTESA DEI FANESI Nel corso del prossimo aprile riprenderà a vivere il Teatro della Fortuna, che disastrosi eventi bellici e la susseguente scarsa attenzione degli amministratori locali hanno reso muto per ben cinquantaquattro anni: esattamente il triplo degli anni impiegati per costruirlo ex novo. Anche se tuttora la splendida neoclassica sala progettata dal Poletti nel 1845 (ai tempi del governo pontificio) e inaugurata nel 1863 non ha il soffitto lumeggiato dalle vivaci tempere del Grandi con soggetti mitologici, anche se l’architrave del proscenio non ha certi suoi riquadri dipinti a forti colori (rosso inglese e blu molto carico), anche se gli stucchi non rimandano il bagliore dell’oro zecchino, tuttavia è ora che la grande sala (più scolorita di quella che abbiamo visto fino al 1944) torni alla sua primaria e naturale funzione di contenitore artistico-culturale col teatro lirico, i concerti, la prosa. Nel passato vi trovarono ospitalità anche cerimonie solenni, conferenze, balli, veglioni, e persino il “cinematografo”. Con quale spettacolo inaugurale si apre il Teatro della Fortuna? Non nascondo che in proposito, leggendo su Fano stampa (organo ufficiale dell’amministrazione comunale) la “Programmazione 1998” sono rimasto di sasso: e non per l’approssimativa prosa del comunicato stesso né per la programmazione in cui non viene indicata nessuna data precisa…, ma perché è stata totalmente ignorata la tradizione e l’attesa dei fanesi. Tutte le volte che il teatro ha riaperto i battenti dopo qualche forzata chiusura lo ha fatto proponendo un’opera lirica, un melodramma. Così fu nel 1863, alla vera e propria inaugurazione, con Il Trovatore di Verdi, cui seguirono il Machbet e La Favorita; così fu nel 1893 (dopo la ricostruzione di parte del soffitto) con La forza del destino, cui dettero lustro il celeberrimo Tamagno e Maria Pizzigalli, soprano nostra concittadina; così fu nel 1936 (dopo il terremoto del ‘30) con l’Andrea Chenier di Giordano diretto dal concittadino M° Franco Capuana. In quelle occasioni, i nostri vecchi, da bravi e intelligenti provinciali, seppero sempre corrispondere alle attese dei cittadini. 122 Cancellata la tradizione operistica e scartata anche l’idea di un grande concerto lirico-sinfonico (forse nemmeno presa in considerazione) il teatro si aprirà con spettacoli di prosa che, come è detto nella sgangherata “prosa” della “programmazione”, dovrebbero avere una “valenza europea”. L’inaugurazione del teatro vedrà poi una “Festa barocca” con contenuto e coinvolgimento finora segreti: sembra che anziché festeggiare la risurrezione del teatro del Poletti si debba festeggiare quella del secentesco teatro (morto e sepolto) di Giacomo Torelli. E proprio nel nome di Torelli (scenografo e non musicista) prenderà il via, per ripetersi ogni anno “nell’intorno di Pasqua”, così dice il famigerato manifesto di programmazione, un festival di musica barocca dal titolo A vagheggiare Orfeo. Si tratta di un’operazione raffinata e impegnativa, e quindi costosa; un’operazione che per Fano rappresenta un vero e proprio punto interrogativo. In estate ci sarà poi la “irruzione” del Violino e la selce, e questa volta, nella sua rozzezza, il più volte richiamato manifesto di programmazione dice proprio una cosa giusta, ma sarà un’irruzione semplice o una irruzione con scasso? 1998 123 POLETTI PROGETTISTA DEL TEATRO DELLA FORTUNA: CHI ERA COSTUI? Il nome di Giacomo Torelli, e non quello di Luigi Poletti, è corso e corre più volte sulle ali della festa barocca, per l’inaugurazione del restaurato nostro teatro e sulle ali del prossimo vagheggiamento di “Orfeo”. Il nome di Torelli, in realtà, fa “molto barocco”: un richiamo, un ritorno di cui a Fano nessuno sentiva tanto travolgente necessità; comunque, essendo stato chiamato in campo un esperto come Antonio Zedda, auguriamoci almeno di trovarci di fronte a qualche bella sorpresa. Va precisato, però, che Torelli non ha nulla a che fare col teatro che proprio oggi 18 aprile riapre i battenti: nulla di nulla, se si eccettua il fatto che il famoso teatro da lui costruito nel ‘600, e di cui oggi niente rimane ebbe – per primo – il nome di Teatro della Fortuna. Il quale, si badi, non aveva né la collocazione né l’orientamento dell’attuale teatro. Ad evitare confusione ed errori, platealmente presenti in quasi tutti i dépliants di propaganda turistica, è da ricordare che il teatro torelliano costruito nel trecentesco Palazzo del Podestà, e precisamente sopra le logge, aveva la fiancata destra, molto più alta dell’attuale, fiancata che guardava verso piazza XX Settembre e il suo palcoscenico era stato ricavato in un nuovo ambiente che poggiava su un “voltone” gettato verso il primo piano dell’edificio in cui ora c’è la Cassa di Risparmio. L’architetto modenese Luigi Poletti (1792-1863) progettista dell’attuale teatro (e messo oggi in un cantone!) non era certamente uno sconosciuto. Valente professionista con molto senso artistico, versatile e profondo studioso, si affermò soprattutto nello Stato Pontificio. Era un esponente della cosiddetta “architettura purista”. Costruì con criteri nuovi per il suo tempo tre teatri: a Terni, a Rimini, a Fano. Pio IX lo nominò architetto municipale di Roma dove diresse e in parte progettò i lavori per la ricostruzione della Basilica di S. Paolo fuori le mura (semidistrutta da un incendio) e dove, fra i tanti suoi lavori, collocò in Piazza di Spagna la colonna con l’Immacolata Concezione a cui annualmente i Pontefici rendono omaggio. Nelle Marche costruì la chiesa di S. Venanzio a Camerino, parecchie ville signorili, a Pesaro 124 costruì la cosiddetta fronte polettiana che (rimaneggiata) è la facciata delle Poste nella piazza centrale. Ricostruì la Basilica di S. Maria degli Angeli ad Assisi, parzialmente distrutta da un terremoto nel 1831. Meritava che il “suo” teatro (il più bello) fosse riaperto con quelle musiche che lui immaginava di ascoltarvi; il resto, o moderno o più antico, doveva e poteva venire dopo. 1998 125 È RIAPPARSO IL SIPARIO IN TUTTO IL SUO ORIGINALE SPLENDORE Promosso dal Gruppo Amici della Musica, organizzato dagli Assessorati alla Cultura di Fano e della Provincia, e dalla Associazione “Pro Arte Marche”, con il contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di Fano, martedì 14 settembre al Teatro della Fortuna, tutto esaurito (e anche questo ha un suo significato), abbiamo assistititi ad un Recital, o meglio ad un Concerto lirico-sinfonico, che doveva avere come protagonista Cecilia Gasdia che, ammalata, è stata egregiamente sostituita dal soprano Anna Caterina Antonacci che è stata molto più che una sostituta. Infatti s’è imposta ed ha convinto con le sue eccezionali doti vocali che, lasciando da parte più raffinate definizioni tecniche, le fanno meritare un titolo che tutti e subito capiscono: è stata bravissima e anche nei brani non propriamente di soprano come nell’Habanera della Carmen o nel Che farò senza Euridice di Gluck. Sicura e puntuale è stata la direzione dell’orchestra “Pro Arte Marche” affidata al Maestro Bruno Dal Bon; bravo è stato il coro lirico Mezio Agostini, diretto da Angelo Biancamano che si è esibito nei brani verdiani Va’ pensiero e Patria oppressa. Il teatro oltre che completo di pubblico si è finalmente mostrato anche completo di “sipario”. Infatti, entrando, si parava sul boccascena il famoso sipario dipinto nel 1863 da Francesco Grandi con la ideale visione delle mura dell’Arco di Augusto e delle emergenze monumentali di Fano romana, sfondo ad un immaginario ingresso dell’imperatore, su una biga dorata, nella Colonia Iulia Fanestris. Dopo il restauro il cosiddetto “telone” è apparso in tutto il suo originale splendore coloristico (inevitabilmente accademico) e con le figure di primo piano di Augusto e degli augustali fanestri che ricevono giusto rilievo cromatico dallo sfondo “morbido” delle mura di Fano romana. Il telone durante la guerra e il passaggio del fronte fu messo al sicuro nel seminterrato del Seminario Regionale Pio XI, recuperato dal Comune restò prima nel capannone costruito entro l’ex chiesa di S. Francesco, poi, sempre ben arrotolato, passò parecchie stagioni nel vano dove oggi è sistemata la nuova Sala Verdi, finì la sua odissea 126 come ospite nella chiesa del Suffragio (refugium peccatorum...!) fu poi riportato in teatro per essere affidato a maestri restauratori di Spoleto. Domenica 27 settembre il Teatro si riaprirà per un recital col giovane emergente tenore Salvatore Licita, reduce da due recentissimi grandi successi: al Regio di Parma e poi nel Ballo in maschera messo in scena all’Arena di Verona. 1998 127 TEATRO LIRICO DELLA FORTUNA: LA SALA NON SPLENDE È a tutti noto che a proposito del Teatro La Fenice di Venezia, distrutto da un pauroso incendio, si è subito parlato, e tuttora si parla, di ricostruirlo “com’era” perché Venezia e il mondo della lirica non possono rinunciare alle meraviglie acustiche ed estetiche della grande sala. Però se per Venezia (dove si dovrà ricostruire tutto) dovessero valere i criteri applicati al nostro Teatro della Fortuna che si doveva solo “restaurare”, il La Fenice non risorgerà mai dalle sue ceneri. E’ già stato opportunamente messo in evidenza - mi riferisco ad una recente corrispondenza giornalistica di Carlo Moscelli - che la doratura degli stucchi del nostro teatro è stata dimenticata. Molti anni fa, manifestando il mio vivo disappunto davanti al restauro degli stucchi mi fu risposto da un tecnico del comune che quello che vedevo era solo il “mordente” sul quale, poi, dovevano essere applicati i preziosi fogli della doratura: “Non abbia paura, che tutto sarà fatto a regola d’arte!”. Siamo ancora fermi al “mordente” e la sala ha il colore di un ammalato convalescente, non di un malato guarito. Gli unici colori sono stati dati sulla fronte del proscenio e riguardano lo stemma di Fano. Lo direste? Sono sbagliati. Il campo del nostro stemma è, araldicamente parlando, diviso da “una merlatura verticale innestata d’argento e di rosso e di tre pezzi” (volgarmente una “rastrelliera”): ebbene, l’argento è stato ignorato, fino al 1945 c’era; e lo stemma è banalmente bianco e rosso! C’è di peggio. Riguardo il soffitto e, avendo una certa età, lo confronto con quello che era prima del disastro causato (ironia della sorte) non dagli alleati o dai tedeschi, ma da quella brava nostra gente che ricostruì il teatro nel dopoguerra; ci si accorge che sono stati esattamente rifatti tutti i riquadri a stucco di varia forma, ma che al posto delle figure ornamentali e degli affreschi di soggetto mitologico dipinti dal Grandi (ne conserviamo il disegno esatto) c’è il vuoto assoluto. Gli attuali riquadri nel loro innaturale biancore fanno “volare via” il soffitto che un tempo si stendeva sulla sala col suo prezioso cromatismo. Se questi riquadri volevano lasciarli vuoti, perché li hanno rico128 struiti ex novo? Tuttavia il rimedio ci sarebbe anche senza ridipingere gli affreschi: basterebbe riprodurli su tela e poi montarli entro le cornici a stucco: il soffitto riavrebbe così scene e ornati come quelli dipinti dal Grandi. È possibile? Sì è possibile e non è nemmeno un’operazione scorretta in quanto le tele sarebbero pur sempre elementi mobili. 1996 129 ANCHE LA “SALA VERDI” FINALMENTE! Molte cose sono state dette sulla bella neoclassica sala polettiana del Teatro della Fortuna invece, mentre scrivo queste righe, ancora nulla mi è capitato di leggere (a livello di informazione di “massa”) sulla nuova, anzi nuovissima “Sala Verdi” che sostituisce quella con lo stesso nome diroccata e semidistrutta dall’abbattimento della torre civica. Su quella vecchia sala, anch’essa progettata dal Poletti, l’Assessorato alla Cultura ha opportunamente pubblicato (però è destinata a pochi) una esauriente monografia dovuta a Franco Battistelli e a Luca Ferretti. Era nata come “Sala da Ballo”, ma fu anche sede di concerti, saggi musicali, veglioni, conferenze, feste di vario genere e persino comizi; di essa venne fatto un uso piuttosto parco: in ottantun anni di vita fu usata, in media, sì e no una volta all’anno! All’inizio di questo nostro secolo, subito dopo la morte di Giuseppe Verdi, ci fu chi propose di intitolarla al grande musicista scomparso, ma solo nel 1909 ebbe il definitivo titolo di Sala Verdi. Post fata resurgo (dopo disgraziate vicende sono risorta): ora lo può dire anche la Sala Verdi. E consiglierei di continuare a chiamarla così, senza premettere l’aggettivo “nuova” perché le intitolazioni più sono brevi meglio è. La sua progettazione e la sua messa in opera hanno suscitato molte polemiche e discussioni: fino a proporre di bloccare i lavori e ricominciare tutto da capo. Non è più sala da ballo, d’accordo, ma questa sala è indiscutibilmente la più bella, la più comoda e signorile (non spreco aggettivi), la più attrezzata tra le sale cittadine da adibire a manifestazioni artistiche e culturali, a convegni e congressi: può contenere circa duecento persone. E’ mia opinione, so che non troverò tutti d’accordo, che il progettista, architetto prof. Giovanni Battista Fabbri, e il direttore dei lavori, ingegnere Vittorio Luzi, abbiano fatto un ottimo lavoro così che il costo di mezzo miliardo non pare sprecato, perché comprende un notevole corredo di attrezzature. La sala di metri 11,70 per 28,70 è raggiungibile anche con un capace ascensore, ha l’aria condizionata, possiede moderne e indispensabili 130 apparecchiature (per es. una telecamera a colori a controllo digitale necessaria per convegni di carattere specialistico in quanto consente collegamenti con altre città in tempo reale), vari monitor a colori e videoregistratori, un puntatore a raggi laser, un grande schermo per proiezioni, una lavagna luminosa, tre cabine per traduzione simultanea. E’ il caso di dire: finalmente! A questo punto due considerazioni: prima, l’assessore e la commissione consiliare Cultura facciano ben attenzione a scegliere un degno modo di inaugurare questa sala senza scontentare i fanesi perché, sia ben chiaro, è ora di finirla con le provocazioni; seconda, la disponibilità di questa struttura che si aggiunge a quella dell’Auditorium S. Arcangelo, al Salone della Fondazione Cassa di Risparmio, alle Sale della Concordia, della Fortezza Malatestiana, alla Sala Martinozzi e del Suffragio e alla imminente Aula capitolare di S. Agostino ponga la parola “fine” al pensiero di progettare o restaurare altre sale da adibire a incontri, concerti, ecc: non vorrei che ci trovassimo ad avere più sale che spettatori; per non dire dei costi che sarebbero veramente sprecati. 1998 131 DUE PIAZZE DA NON STRAVOLGERE Tra i propositi del nostro Comune nel settore urbanistico oltre alle fantasie (sia pur generose), come il pensare di ricostruire i campanili abbattuti nel 1944 dalle truppe nazionalsocialiste tedesche, c’è anche quello di disfare piazza Pier Maria Amiani che da circa un secolo (pur cambiando alcuni particolari) è uno degli angoli più caratteristici della città, oggetto di ammirazione (e non invento nulla) da parte di forestieri e turisti per il suo scenario verde immesso lungo la principale via cittadina. Quella “piazza-giardino” fu una soluzione ottima quando si trattò di occupare lo spazio già coperto dal demolito monastero dei S.ti Filippo e Giacomo delle Clarisse. Vi si vorrebbe far sorgere una piazza vera e propria sulla base di considerazioni storico-socialpedagogiche che, ridotte all’osso, nascono prevalentemente dal desiderio (del sindaco o di qualche assessore) di lasciare il “proprio segno” nella città. Ricordo che negli anni venti in questo secolo un sindaco e una giunta volevano “lasciare il segno” (e si misero all’opera con le “mine”) demolendo le mura romane per costruire case popolari “igieniche” sull’area finalmente liberata da quelle brutte anticaglie!! Anche se poi fosse vero che in piazza Amiani aveva sede il foro romano non sarebbe questo un buon motivo per far fuori una soluzione urbanistica ormai storica ed esteticamente valida. Invece sarebbe un gran bene se il Comune pensasse a mantenere e curare il decoro di piazza Amiani sempre, per tutto l’anno. Naturalmente non sarebbero da escludere interventi migliorativi: penso ad esempio alla fontana e all’aiuola in cui è inserita, tutte e due assai malridotte. La seconda piazza che si vuol trasformare è piazza Unità d’Italia sorta negli anni Cinquanta nel quartiere “Poderino” o, come allora si diceva spontaneamente, “nel quartiere Fanfani”. Siamo d’accordo, non è una piazza “bella”; qualche segno che le dia una certa identità potrebbe essere accettato, ma con molta semplicità si può o si deve dire che “essa è comoda e utile così come è”. Pensare a ridurla o a stravolgerla sarebbe come ripetere l’operazione 132 che, al Lido, ha portato alla distruzione di un comodo giardino per far posto ad una inutile (e costosa) càvea che non serve quasi a nessuno. Piazza Unità d’Italia è comoda per il traffico che vi scorre, per il vasto posteggio che offre e che è continuamente usufruito soprattutto a motivo della presenza di una scuola e di una chiesa. Per rendersene conto bisognerebbe venire a vedere la grande distesa di macchine in occasione di cerimonie religiose o di particolari giornate legate alle iniziative scolastiche ecc.: ma la vastità del piazzale lo rende usufruibile per feste di quartiere, raduni sportivi ecc. Sento dire che ci si vuol ricavare un giardino: già, e dopo chi lo viene a curare? Non sanno in Comune che le aiuole che già sorgono a mezzogiorno della piazza in questione si coprono di erbe alte più di un metro che fanno bella mostra di sé per mesi e mesi? Dunque, si pensi pure ad un progetto di miglioramento e di abbellimento, ma non si stravolga la funzionalità della piazza. Anche qui, prima di lasciare a qualcuno il vanto di “lasciare il proprio segno”, si badi a non strafare, a non stravolgere. 1997 133 I CENTO ANNI DEL S. ARCANGELO Oggi parlare di collegio (maschile o femminile) sembra cosa assurda, passata di moda; ma un tempo non era così e non parlo di un tempo lontano. Nel secolo scorso Fano ne ospitava parecchi sia maschili sia femminili. Quest’anno ricorre il centenario della venuta a Fano dei Fratelli delle Scuole Cristiane, i Carissimi, che volgarmente erano conosciuti come “i pret sa la bavarola” per via delle facciole che, secondo la moda ecclesiastica francese, tenevano sotto il mento. Ma non erano preti bensì appartenenti ad una Congregazione religiosa fondata nel Seicento in Francia da S. Giovanni Battista De La Salle (morto nel 1719) per educare i figli del popolo. I “collegi” erano lontani dalla sua mente! Dunque nel gennaio 1905 il Vescovo di Fano Mons. Franceschini chiamò i Fratelli Lasalliani a prendere possesso del vasto ex convento delle benedettine, il S. Arcangelo appunto, che ospitava poco più di una dozzina di “artigianelli”; soprattutto tipografi, ma il Collegio vero e proprio ebbe inizio qualche anno dopo, nel 1908-1909. La sua storia è lunga e varia; bene ha fatto Carlo Moscelli a raccoglierla in un libro che verrà distribuito in occasione del Raduno annuale degli ex alunni, domenica 5 giugno. Qui ricorderò solo qualcosa dei nove anni vissuti come esterno del collegio, dal 1932 al 1941. Indimenticabili, lasciatemelo dire, furono gli anni del dopo-guerra quando gli ex alunni in massa si ritrovarono nel vecchio collegio; c’era molto bisogno di stare insieme: era un modo per assicurarsi d’essere ancora vivi, dopo tutto quello che ognuno aveva passato! In origine i Carissimi gestivano solo qualche classe elementare, per il resto facevano doposcuola a coloro che frequentavano il Ginnasio-Liceo “Nolfi”, l’Istituto Commerciale “Battisti” e, più tardi, l’Istituto Magistrale “Carducci”. Di quel lontano tempo ricordo un inno composto (parole e musica) da fratel Regolo, uno dei Direttori del Collegio. Iniziava con le parole “Fior delle Marche, fior della Romagna”, di esso si perdette poi del tutto la memoria. Molti convittori provenivano (per studiare a Fano) dai centri marchigiani o romagnoli, città e paesi. Il collegio ospitava anche parecchi che abitavano nei dintorni di Fano ma per i quali era 134 scomodo, specie d’inverno, venire a scuola in città. C’erano anche i semiconvittori e infine gli esterni che erano figli di artigiani, commercianti, impiegati e anche marinai. I convittori avevano una bella divisa con mantello: la indossavano solo nelle grandi occasioni o quando andavano a casa. Molti accettavano la vita a suon di campanello o di fischietto, altri la rifiutavano del tutto e consideravano il collegio come una punizione inflitta dalla famiglia. Ma a volte il collegio era una necessità per chi, non di Fano, voleva continuare gli studi. Al S. Arcangelo si svolgevano attività che la scuola statale nemmeno sognava: basti ricordare i tornei di palla a volo, la scherma, il canto, il lavoro manuale I primi viaggi scolastici li ho fatti col collegio. Ricordo Urbino (un’avventura), Loreto, Ferrara ecc. Negli ultimi anni i collegiali andarono all’estero, per es. in Spagna! Non ho mai disprezzato la scuola statale, ma debbo dire che l’educazione cristiana e la disciplina me l’hanno soprattutto insegnata i Carissimi. Poi il collegio si è ingrandito, si è abbellito e dopo la guerra ha avuto la scuola media interna e, classe dopo classe, il Liceo Scientifico. Il massimo che poteva sperare! Ma nello stesso tempo cominciò il suo declino e alla fine fu chiuso e fu venduto (tranne la chiesa) al Comune di Fano. 2005 Cerimonia di chiusura dell’anno scolastico (1960 circa). ESATTEZZE SU FANO Tempo fa scrissi su questo giornale un articolo ironico “I merli di Fano” per mettere in evidenza le sviste su Fano notate in due dépliants che avevano la buona intenzione di illustrare storia, monumenti e vie della nostra città sulla quale capita di dire o scrivere cose non esatte. Nessuna tragedia perché l’esattezza non è cosa di tutti. Comincio dalla leggenda più antica. È stato detto che la chiesetta di S. Pietro Vescovile fu la prima cattedrale di Fano, ma nessun documento l’attesta. Il suo titolo era S. Pietro in Episcopio forse perché sorgeva nel quartiere episcopale mentre le altre chiese dedicate a S. Pietro erano altrove. In dialetto la chiesetta in questione era indicata come San Piruschin (o Pirusquìn); il che può essere interpretato San Pietro (Piero) piccolo, San Pieruscolo, San Pieruscolino. È più sicuro pensare che la prima cattedrale sia sorta (ma non sappiamo come era) dove è la presente. Si doveva contrastare il famoso tempio pagano della Fortuna e San Piruschin con la sua piccolezza non contrastava nulla. San Paterniano non fu eremita (in occidente l’eremitismo non era conosciuto nei primi secoli cristiani) né fu il primo vescovo di Fano come è stato affermato anche nella messa recentemente trasmessa in TV dalla basilica del santo; certamente il redattore lo avrà letto da qualche parte: ecco perché bisogna essere esatti! Vengo ora alla “Vittoria alata”, l’opera dello scultore Adolfo Apolloni che si trova in cima allo scalone del nostro municipio. Chiamiamola pure “Vittoria alata”, ma dobbiamo sapere che quella specie di angelo è la replica, totale e parziale non so, del monumento funebre che l’Apolloni eresse alla moglie Marta Holt, deceduta negli U.S.A. quando correva l’anno 1889. Angeli e croci di Apolloni sono, per dirla con Rodolfo Battistini, “espressione d’astrazioni celesti” perché l’Apolloni, che fu per breve tempo sindaco di Roma, era anticlericale. Lodo (ci vuole anche la lode) il libro di Carlo Moscelli che ricostruisce gran parte della storia del Collegio Sant’Arcangelo di cui fui alunno esterno per ben nove anni. Tra i cappellani del collegio non trovo 136 quello che lo fu a lungo, cioè Mons. Riccardo Paolucci professore in seminario e storico della Chiesa fanese; né trovo Fratel Regolo che scrisse un inno ispirato al collegio. Aggiungo che fra gli alunni più titolati (fu mio compagno di classe) ci fu il principe Urbano Barberini che abitava nella villa Apolloni da dove veniva in collegio tutti i giorni accompagnato dal suo precettore inglese. Era molto generoso. Morì in giovane età. Per finire dirò che è giusto ricordare che l’area già occupata dai capannoni del carnevale era un tempo più bassa e adibita a gioco del pallone al bracciale. Io la ricordo anche come sede del sabato fascista quando, nel pomeriggio, vi si adunavano i balilla e gli avanguardisti spesso arringati da maestri improvvisati che insegnavano il motto fascista: “molti nemici, molto onore!”. Non pensavano che “chi semina vento raccoglie tempesta”. E che tempesta! 2006 137 IL CARNEVALE È ALLE PORTE Il Corso Mascherato un tempo si svolgeva a Fano l’ultimo giorno di carnevale, il martedì grasso. Terminava in “Piazza grande” dove, fra i bengala fiammeggianti, si adunavano i carri che avevano sfilato e tutto finiva col bruciamento del Pupo. Il proverbio diceva: “Finito carneval, finito amore/ finito di mangiare le castagnole”. “Piazza grande” (ora “XX settembre”) fin dai secoli scorsi aveva visto festeggiare il carnevale o con funamboli o con la grossolana “battaglia delle trippe” che vedeva protagonisti i macellai o, come racconta Vincenzo Monti (1754-1828), con una specie di corrida a cui egli assistette, vedendo un toro furioso di colpo ammansito quando venne avvicinato dal proprietario che esso subito riconobbe. Detto proprietariocontadino fu ritenuto dalla folla un mago, uno stregone, rischiando di venire linciato. Il carnevale fanese era modesto, tradizionale, casalingo. Venne mitizzato, tra gli altri, dallo scrittore fanese Fabio Tombari che in un articolo pubblicato nel lontano 1955 su “Microfono” (giornale locale) parlò di “umana fiumana” che partecipava al Corso Mascherato, scrivendo che ognuno che tornava sano e salvo dal carnevale di Fano (alludeva al famoso “getto”) “parlava come un superstite, un reduce”. E più avanti scrive “tre mesi prima per allestirlo e tre mesi dopo per commentarlo il carnevale di Fano dura letteralmente sei mesi” e conclude: “Così nell’apoteosi finale o cremazione del Pupo, fra cascate di torrenti al magnesio e scoppi di mortaretti e bengala, il giorno avanti le Ceneri, Fano manda in cielo col fumo il proprio ridicolo per rinascere, come la fenice, ogni anno dalla proprie ceneri”. Nell’Ottocento il Corso Mascherato fu chiamato el va: ciò forse fu dovuto al fatto che alcuni correndo lungo il percorso carnevalesco con in mano un moccolo acceso gridavano (alludendo al moccolo che continuava ad ardere) “el va, el va”. Quel nome è ormai morto; adesso diciamo per fini turistici che il nostro carnevale è il più antico e il più dolce d’Italia. Che le cose stiano proprio così non sappiamo, ma è bello crederci. 2007 138 LA SOMARATA E “EL GIORN DEL VÀ” Quest’anno il Carnevale di Fano si è aperto con successo facendo rivivere una manifestazione che sembrava archiviata per sempre: la somarata (in dialetto la sumarèta), un corteo in cui i ciuchi, o montati su una rude sella o trainanti carretti infiochettati, ricevevano botte e frustate da denuncia per maltrattamenti. Ricordo le somarate di sessant’anni fa (o giù di lì). Si facevano a maggio,considerato il mese in cui gli asini ragliano assai per cercar compagnia. Allora nel comune di Fano i somari erano molti; adesso non più... bisogna farli venire dall’Appennino. Credo che la prima somarata sia del 1885: in Biblioteca ho ritrovato il Regolamento di quella che ebbe luogo il l° maggio 1885; ha tutta l’aria di essere il primo Regolamento. “La somarata” - c’è scritto – “sarà composta da un numero illimitato di Soci con pelo o tosatí, fatta a cura di alcuni Soci promotori.” La partecipazione costava cinque lire, c’era un “comandante”, la divisa consisteva in pantaloni chiari con stivaloni o gambali, il cappello color cenere all’italiana con piuma. Non mancava la fanfara. La somarata del 1885 partì alle cinque e mezza del mattino dalla piazzetta che si trova di fronte all’attuale Istituto d’Arte: la meta era Saltara, i Soci 96, tra essi Leandro Castellani, il nonno (credo) dell’omonimo regista che ben conosciamo. Le somarate partivano da Fano, toccavano i paesi vicini: portandovi il contagio dell’aria carnevalesca che appassionava quei “matti” fanesi. Invece “El giorn del Và” era tutto fanese e cittadino: era la sfilata per il Corso di carrozze e di maschere; e, poi, di carri allegorici che in principio erano piccoli e semplici. Qual è l’origine dell’espressione “El Và”? In “Nuovi studi fanesi” ho recentemente pubblicato la cronaca di un martedì grasso dell’Ottocento. L’autore, l’abate Francolini, fa capire che “El Và” (con un bell’accento sulla “a” che è sonoramente marcata) si riferisce ai moccoli accesi con cui molti, correndo, partecipavano al corteo carnevalesco dopo il tramonto. Era il moccolo che, -nonostante la corsa, se rimaneva acceso faceva gridare “El và, el và”. Da questo fatto nacque 139 l’espressione “El giorn del Và” riferita al martedì grasso, ultimo giorno di Carnevale: unico pomeriggio in cui sfilava il corteo carnevalesco. Non sto qui a discutere se il Carnevale di Fano sia il più antico d’Italia; forse non è vero, perché ogni città aveva il suo carnevale che si ricollegava alle feste pagane per la fine dell’inverno. Ma per il turismo tutto fa brodo; il dato storico vero e definitivo non è alla portata di nessuno. 2001 140 MUCILLAGINI: UNA VECCHIA CONOSCENZA Ogni tanto sentiamo che in mare compaiono le famigerate mucillaggini. Sono fastidiose per i bagnanti e per i pescatori, ma fortunatamente, come scrive il prof. Corrado Piccinetti, non sono pericolose. Non recano danno né alle persone né ai pesci. Le mucillaggini non sono legate, come qualcuno pensa, né agli scarichi fognari né alle sostanze inquinanti trasportate dai fiumi, infatti comparivano anche quando al mare non giungeva dalla terra ciò che oggi purtroppo vi si scarica. Per documentare ciò che qui si dice basta ricorrere a qualche vecchio documento. Sul giornale “Il Piccolo” del 2 agosto 1891 c’è un articolo con questo titolo: “Strano fenomeno marino”, in cui si nota che da qualche tempo i pescatori dell’Adriatico vanno osservando un fenomeno che rende infruttuosa la pesca e li getta perciò nella costernazione. Ad uno o due metri sotto la superficie del mare si riscontra uno strato di materia semi solida, quasi una crema perlacea che non permette alle reti di affondare”. C’è poi “Sulle masse glutinose” una relazione presentata all’Imperiale Regio Governo marittimo di Trieste dal dott. Syrski che si riferisce alle mucillaggini apparse in gran parte dell’Adriatico da giugno a luglio del 1872. A proposito dell’estate 1872 noi fanesi abbiamo una precisa “Memoria” stesa dall’abate conte Francesco Castracane degli Antelminelli (1817-1899), che la scrisse per l’Accademia Pontificia dei Nuovi Lincei, accademia di cui lui faceva parte. L’abate Castracane era uno scienziato particolarmente esperto negli studi botanici, un vero specialista nel campo delle diatomee e delle bacillarie, tanto che due generi di queste alghe marine furono chiamati Bacillaria antelminellia e Diatomea Castracania. Notiamo, per inciso, che Papa Leone XIII aveva offerto al Castracane la porpora cardinalizia che il nostro scienziato rifiutò per dedicarsi solo ai prediletti studi. Ebbene nella sua “Memoria” il Castracane parla a lungo dello straordinario fenomeno riscontrato nell’estate 1872 nel mare Adriatico, anche di fronte a Fano. Concluse che non poteva trattarsi che di una grande massa di diatomee, un’alga che in certe occasioni si rivelava con “straordinaria apparenza”. 2004 141
Scarica