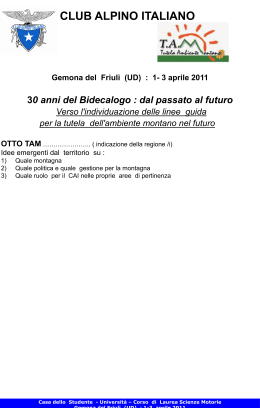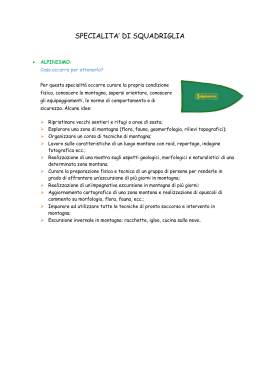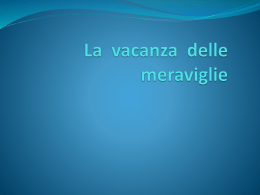comunità montana dell'oltrepò pavese ƌĂůůŽĚŝWƌĞŐŽůĂ Circolo Anspi Fraz. Ponti – Brallo di Pregola SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ PAVESE INVITANO AL sul tema “Racconto breve di montagna” PREMIAZIONE VINCITORI: sabato 07 settembre 2013 ore 15,00 Park Hotel Olimpia Pregola - 27050 Brallo di Pregola (PV) 1° PREMIO categoria A - targa e completo abbigliamento sportivo (da ritirare presso IVO DEL BRALLO Piazza Municipio 27050 Brallo di Pregola (PV) 2° PREMIO categoria A - targa e libri 3° PREMIO categoria A - targa e libri 1° PREMIO categoria B - targa e weekend per due persone presso PARK HOTEL OLIMPIA Pregola (PV) 2° PREMIO categoria B - targa e cesto prodotti tipici locali 3° PREMIO categoria B - targa e cesto prodotti tipici locali REGOLAMENTO Partecipazione al concorso gratuita - Categoria “A” da 14 a 18 anni di età - Categoria “B” oltre i 19 anni di età Inviare: il testo inedito massimo di 10 cartelle (calcola una cartella di 2000 battute compresi gli spazi) carattere Times New Roman, corpo 12 entro e non oltre il 30 giugno 2013 a [email protected] specificando nell’oggetto: CONCORSO LETTERARIO 2013 inoltrare n. 3 copie cartacee all’indirizzo: CONCORSO LETTERARIO PONTI ARTE 2013 presso Associazione Culturale VARZI VIVA Via Di Dentro, 1 – 27057 Varzi (PV) - Gli elaborati dovranno essere presentati nel seguente modo: 1) prima pagina – categoria -titolo e sotto pseudonimo dell’autore 2) a seguire il racconto 3) l’ultima pagina riservata ai dati anagrafici e recapito telefonico. - Gli autori finalisti saranno avvisati telefonicamente o per e-mail. Le opere verranno esaminate da una giuria di esperti le cui decisioni e i giudizi sono insindacabili - Liberatoria per l’organizzazione autorizzando la pubblicazione dei testi rinunciando ai diritti economici. - La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del regolamento. Sito PONTI ARTE www.probrallo.net/pontiarte /ŶĐŽůůĂďŽƌĂnjŝŽŶĞ ĐŽŶ͗ &ƌĂnj͘WƌĞŐŽůĂ ƌĂůůŽĚŝWƌĞŐŽůĂ INDICE 00 - Prefazione 01 - Enzo Alfretti – “I Fungaioli” (Categoria - B) 02 - Francesco Bassanese – “Solo l’indispensabile” (Categoria - B) 03 - Paola Cellario – “Pane, zucchero e fantasia” (Categoria - B) 04 - Elena Coppi – “Giallo di calza” (Categoria - B) 05 - Emilio D’Andrea – “Il lupo bianco dei monti Dauni” (Categoria - B) 06 - Paolo Delucchi – “Dagli Appennini alle Indie – una storia vera” (Categoria - B) 07 - Ennio Di Biase – “Infinite traiettorie” (Categoria - B) 08 - Tamara Furlanello – “Omaggio a Pietro Daglia, combattente per la libertà” (Categoria - B) 09 - Monica Garbelli – “Vita da lupi” (Categoria - B) 10 - Maria Natalia Iiriti – “Una storia tra mare e montagna” (Categoria - B) 11 - Fiorenza Lanfranchi – “Monte sette fratelli” (Categoria - B) 12 - Novella Limite – “Le verità del vento” (Categoria - B) 13 - Giovanni Nicora – “Al pascolo” (Categoria - B) 14 - Maria Grazia Palestra – “Ricordi della Valmalenco” (Categoria - B) 15 - Dario Pastorelli – “Tobia” (Categoria - B) 16 - Andrea Pettinicchio – “Il gigante Amedeo” (Categoria - B) 17 - Maria Grazia Savonelli – “Lontano da dove” (Categoria - B) 18 - Michele Terenzoni – “Agnese ci mancherà” (Categoria - B) 19 - Giampaolo Toccalini – “Ritorno alla montagna” (Categoria - B) 00 – Prefazione Il 2° concorso letterario Ponti Arte 2013 “Racconto breve di montagna”è stato promosso dal circolo culturale “PONTI ARTE” con l’intento di non dimenticare la montagna. Si ringrazia in modo particolare la Commissione Giudicatrice che si è sobbarcata, a titolo gratuito, il gravoso impegno. PONTI ARTE il Presidente Cesare Curatolo 01 - Enzo Alfretti – “I Fungaioli” «Governo ladro, l’acqua bolle!» Con calma accostai la Seicento al ciglio della strada. Scendemmo tutti e tre ed aspettammo qualche minuto finché il bollore nel radiatore non si fu attenuato. Dopo svitammo il tappo con precauzione e lo colmammo con un fiasco d’acqua fresca, quindi ripartimmo. Avevamo una ventina di chilometri d’autonomia prima della prossima ebollizione, che nelle salite a tornanti si riducevano alla metà. Quando il passeggero seduto sul sedile posteriore notava il fumo biancastro uscire dalle feritoie del cofano motore, lanciava l’allarme. Nuova sosta, nuovo rifornimento, nuova tappa. Il che ci obbligava a tenere a bordo una consistente scorta idrica e a programmare i percorsi tenendo conto della presenza di ruscelli e fontanelle. Che le seicento avessero la tendenza a “bollire” era un fatto risaputo. La nostra era appena al di sopra del livello di rottame e il problema ne veniva esaltato. In simili condizioni avevamo avuto l’incoscienza di spingerci sull’Appennino pavese, da cui giungeva notizia che i funghi nascevano a bizzeffe. Due ore di viaggio alla straordinaria media di quaranta chilometri orari scarsi e parcheggiammo nella piazzetta d’un villaggio abbarbicato al fianco della montagna. Una dozzina di case in tutto, una chiesetta lillipuziana, una lastra di pietra piantata orizzontalmente nella scarpata da cui percolava un rivolo d’acqua limpidissima, scrosciante in continuazione nell’albio sottostante. «Ebbene, cosa ne dite?» Silenzio imbarazzante e due facce perplesse. «Insomma, Gianni, che te ne pare del posto?» Gianni non rispose, a meno di voler considerare una risposta il leggero inarcamento d’un sopracciglio. L’occhio destro gli si socchiuse dubbioso. Aveva un’espressione curiosa, oscillante fra l’incredulità e l’insofferenza. «Accidenti a te, non vorrai che ci fermiamo in un buco così?» «È il paradiso dei porcini.» «Dubito che Belzebù in persona abbia mai concepito un posto più abominevole.» «Siete due ingrati. Vi porto in un luogo salubre e ameno, invece che abbandonarvi chiusi in qualche locale sudicio e ammorbante. Orbene, non pretendo che mi ringraziate, ma almeno non fate gli schizzinosi.» «Mah», osservò Paolo, « rischiamo di spendere un giorno di vita per niente.» «Non lasciatevi condizionare dalle apparenze. Al nostro paese ci sono tanti fungaioli, ognuno dei quali è convinto di conoscere i posti migliori, ma non c’è posto al mondo migliore di questo.» «Boh, ormai siamo qui...» «Grazie per l’entusiasmo! Voi due non avete mai idee, però siete pronti a criticare me quando ne tiro fuori una. Se non vi piace tornate pure indietro.» «Ecco là un indigeno. Cerchiamo di carpirgli qualche informazione dettagliata.» Comparve un ometto di mezz’età, tondo come un barilotto. Il naso rubizzo testimoniava che l’astinenza dall’alcool non era la sua virtù prediletta. Aveva passo strascicato e contegno dimesso. Dava l’impressione che neppure un flagello divino avrebbe potuto procurargli il benché minimo scompenso emotivo. Però non fu avaro di indicazioni sui sentieri da seguire e sui boschi da evitare o da esplorare con attenzione. Quando si vuol esser ottimisti a tutti i costi basta anche un interlocutore casuale e non ci si attarda a riflettere se ti ha raccontato la verità o un sacco di frottole. Fungaioli si nasce. Quando si possiede il temperamento adatto, basta trovarsi nel luogo giusto che si avverte una pulsione irresistibile, la quale si trasforma ben presto in passione travolgente. L’odore penetrante ed unico dei funghi, quello del bosco, delle foglie morte in decomposizione, il brivido che accompagna la loro scoperta, il mistero della loro comparsa, lo splendore di certe forme e colori e ancor più la modestia del loro camuffamento mimetico fra erbe e detriti: tutto concorre a creare una cornice suggestiva ed affascinante. Se in passato i funghi erano considerati frutti della stregoneria è perché sembrano materializzarsi nel momento stesso in cui li vedi. Oggigiorno nessuno crede più alle stregonerie, ma il loro fascino arcano è immutato. Cercar funghi è come fare l’archeologo. Per riuscire nell’impresa occorrono pazienza, senso dell’avventura, gusto dell’imprevisto e una buona dose di fortuna. Può capitare di cercare a lungo senza trovare assolutamente niente, ma basta mezz’ora di vena buona per fare bottini leggendari. Il cercatore si alza prestissimo e s’incammina al buio per essere nel bosco alle prime luci dell’alba. È il momento migliore per mettersi in caccia: ci sono le nascite della notte e il bosco è intonso. S’inerpica per luoghi scoscesi, fra rovi e arbusti spinosi. Gusta il piacere dell’esplorazione, l’ansia dell’attesa, l’alternanza fra la delusione e il successo. Scansa le vipere. Cade e si rialza. Tollera il freddo, il caldo, il vento, le precipitazioni e tutte le altre bizzarrie meteorologiche tipiche della montagna. Le accetta stoicamente senza batter ciglio, anzi, provandoci gusto. Certo, anche per il cercatore v’è lo stimolo dei vantaggi materiali. Il frutto della sua ricerca costituisce un condimento eccellente e di grande pregio, un eccitante dell’appetito anche per chi è affetto dalla più terribile ulcera gastrica. Però lui cerca un’altra cosa: l’incantesimo della montagna, che non è commestibile e non ha prezzo, ma ha un valore inestimabile. La mattinata era fresca e luminosa. I fianchi del monte, ricoperti di foreste, mostravano già qualche tratto autunnale, benché si fosse solo a metà d’ottobre. Tuttavia l’inizio non fu incoraggiante perché la maestosità del paesaggio era l’unica gratificazione; funghi, niente. Paolo cominciò ad imprecare contro l’informatore. «Bifolco truffaldino e villano! Ci ha imbrogliati. Non bisogna mai fidarsi di uno col faccione da beota, perché non è detto che sia un beota. C’e chi lo sembra e non lo è e chi lo è e non lo sembra. E c’è chi finge d’esserlo per infinocchiare il prossimo…» Poi il miracolo: una radura pullulante di porcini. Ne riempimmo dei cesti superbi. L’emozione fu tale che un panino masticato di fretta con le mani sporche di terra e una bevuta da una cascatella di ruscello parvero meglio del caviale e champagne di in un ristorante a cinque stelle. Avevamo superato una certa distanza quando Gianni, ch’era il primo della fila, si fermò di botto con un sussulto. «Che c’è?» «C’è che di fronte abbiamo un canalone insuperabile. Avanti non si va e se torniamo indietro perdiamo tempo.» «Macché, attraverseremo il canalone. Bisognerà solo fare attenzione.» Procedemmo con estrema cautela. La pietraia era altamente instabile. Bastava smuovere un ciottolo che si scatenava lo scivolamento di altri cento. Tastavamo il percorso come se si fosse trattato di un campo minato. Con lentezza esasperante giungemmo quasi alla fine della traversata. Pochi metri più avanti ricominciava un sentiero abbastanza agevole. Fu la convinzione d’aver messo il peggio alle spalle a farmi rilassare. O forse fu la stanchezza. Fatto sta che posai il piede senza prima aver saggiato la consistenza dell’appoggio. Il sasso scivolò via di sotto e ruzzolai nel canalone fin sul greto del torrente. Due fratture, ematomi a profusione, pelle a brandelli. All’ospedale di Voghera ebbi in sorte un compagno di stanza che stava peggio di me: paraplegico, senza un nichelino in tasca, abbandonato dalla moglie. Con un termine di paragone così modesto riuscii addirittura a sentirmi fortunato. Per ingannare il tempo giocavamo a carte, ma il gioco andava male perché lui pensava alla moglie, io alle scorribande nei boschi. Allora stavamo in silenzio a guardare dalla finestra. C’era proprio di rimpetto un albero bruttissimo; però verso sera lo frequentava un usignolo che cantava molto bene ed è indicibile quanta consolazione dessero quei pochi grammi di piume gorgheggianti. Con la degenza s’impara la saggezza, si rimpiange il tempo speso male, ci si pente degli errori commessi; si diventa moralmente migliori. La guarigione appare un punto di partenza per un’esistenza più equilibrata. Le degenze inducono in tutti queste buone disposizioni, destinate a durare quanto le degenze stesse. Appena fuori dall’ospedale si dimenticano i buoni propositi e si riprende la vita frenetica e dissennata di prima. Ogni tanto ritorno al villaggio di montagna. Da solo. Al Gianni sono stati fatali i due pacchetti di MS al giorno. Paolo ha tradito: orribile a dirsi, ora predilige il mare. L’acqua nel radiatore non bolle più. La media oraria è più che raddoppiata. A rendere inavvertibile l’afa opprimente della conca di Varzi ci pensa il climatizzatore. Mi piace affrontare i sentieri d’alta quota nella penombra del primo mattino, anche se boccheggio come una trota in secca, con gli occhi fuor dalle orbite e il cuore che batte all’impazzata. Aspetto il sorgere del sole che coi raggi sfiora le rocce sopra la mia testa e accende il sinclinale del Lesima. Nello spazio tra me e la cima, le luci fanno indovinare paesini avvolti nelle brume del mattino. Benché l’abbia vista cento volte, contemplo la vetta illuminata con l’esaltazione con cui gli anacoreti fissano le icone miracolose. È una cosa d’una bellezza straziante. Ogni volta sono rammaricato che non vi sia una gran folla \a godere di simile grandiosità. Chi non si emoziona di fronte al trionfo del sole nascente che investe la maestosità dei monti, o è stupido o è criminale. Del villaggio permane il rivolo d’acqua limpida che percola dalla scarpata. Mi sento a disagio fra quelle case, come se profanassi delle preziose vestigia. Vedo l’indigeno che trascina goffamente il suo corpo sgraziato; Paolo che impreca annaspando fra i rovi; Gianni che scruta il sottobosco con la sigaretta penzolante dalle labbra. Poi i rintocchi lontani d’una campana e di colpo non vedo altro che macerie inanimate e pietre sbrecciate. Allora mi vien da piangere. 02 - Francesco Bassanese – “Solo l’indispensabile” Verso le undici di quella sera, Martino trasse un respiro profondo. Aveva appena deciso che quella giornata lavorativa si concludeva lì e rientrò in casa a prepararsi la cena. Non aveva una routine lui, nè datori di lavoro a cui render conto, era un contadino di un piccolo paese perso tra i monti. Possedeva tre poderi lasciatigli in eredità dal nonno e una stalla annessa alla sua cascina. Le uniche regole a cui doveva sottostare erano quelle, imprevedibili, della natura; ‘’Quand ar sù u s’volta indrè, al dì dop gh’è l’àcqua ai pè (quando il sole spunta, nonostante le nuvole, appena prima del tramonto, il giorno dopo piove)’’ gli diceva sempre il nonno. E così lui assecondava la natura; quando pioveva e non poteva andare a lavorare i campi, tagliava la legna per l’inverno, riparava le sporte per andare a raccogliere i funghi o affilava la falce fienaia con la cote e se invece non pioveva, accendeva il trattore e si recava ad arare, seminare, tagliare l’erba, imballarla, a seconda della stagione. E quando anche quei lavori erano stati fatti, doveva nutrire le vacche, i maiali, pulire le lettiere, fare il formaggio, insaccare i salami, imbottigliare il vino. C’era sempre qualcosa da fare. Martino prese due uova dalla cesta sopra il tavolo, le ruppe in un vecchio tegame che mise sopra alla stufa accesa, insieme a due fette di pane secco, ad abbrustolire. Si abbandonò a riposare sulla poltrona accanto alla stufa e restò a fissare la sua cena che cuoceva lentamente sopra la brace; fissava i tizzoni che, ogni volta che una flebile brezza entrava dalla finestra della cucina, si accendevano di rosso incandescente, dello stesso colore del sole al tramonto in una giornata estiva dal cielo limpido e si mise a ripensare al curioso incontro a cui aveva partecipato quella mattina. Si era svegliato che era ancora buio, non aveva dormito molto bene perchè era preoccupato per la moglie del Vecchio; ‘’l’a siguita a tusì e l’a gà al mal da gula, grama Emma’’ (continua a tossire e ha il mal di gola, povera Emma) così aveva sentito da un discorso tra le donne del paese riunite nel cortile del salumiere un paio di mattine prima; Martino decise allora di raccogliere una dozzina di pesche dall’albero nell’orto e di portarle a casa del Vecchio, prima di andare a lavorare, per aiutare la guarigione dell’anziana donna, come lei era solita fare quando era lui da piccolo ad avere il mal di gola; Martino si ricordava nitidamente quando nei giorni di malattia se ne stava coricato nel letto ad aspettare che il dolore passasse, e che la nonna gli desse il permesso di tornare a giocare all’aperto con gli altri bambini del paese quando, poco dopo pranzo, si sentiva bussare alla porta; Emma entrava salutando la nonna e, recandosi in cucina, rovesciava sul tavolo le pesche che era solita trasportare in grembo, come un bambino, avvolte nel suo grande grembiule blu sempre sporco di terra, e gridava a gran voce: ‘’Martino! Ve chi ca t’ho purtà i pèrsi!’’ (Martino! Vieni qui che ti ho portato le pesche!). Emma le sbucciava, avendo cura di non far rimanere nemmeno una lingua di buccia attaccata alla polpa, le tagliava in pezzi e le metteva a bollire per pochi minuti in una piccola pentola contenente del vino rosso e per ultimo zuccherava abbondantemente la miscela. ‘’Martino, ve chi c’l è proont!’’ (Martino, vieni qui che è pronto!) ; il bambino si alzava rapidamente dal letto per andare ad assumere il miracoloso rimedio preparato dalla medgon (letteralmente medicone, così venivano indicati i ‘’santoni’’ nei paesini che guarivano le malattie al posto dei dottori, spesso non presenti). Al tavolo della cucina c’era già pronta la sua tazza di ceramica che usava ogni mattina per la colazione, piena fino all’orlo. ‘’Fa al brav, beval tut e fa ved a la nona c’a t’è un umett’’ (Fai il bravo e bevilo tutto, così fai vedere alla nonna che sei un ometto). E di Martino si sarebbero potute raccontare di tutto, le malefatte combinate, i capricci per fare il bagno o quelli per non andare a scuola, ma in quanto a deludere la nonna no, quello proprio non si poteva dire. Afferrava con decisione il tazzone usando entrambe le mani e con quattro grossi sorsi ingurgitava tutto il beverone, finiva anche le pesche rimaste sul fondo raccogliendole con il cucchiaio. La sensazione di calore che in un attimo gli pervadeva tutto il petto, poi subito lo stomaco e di nuovo su fino alla testa se la ricordava bene, era pronto a giurare che scottasse addirittura più di quella volta che aveva appoggiato la mano sulla stufa non accorgendosi che era accesa! Non si sa se per il fatto che Emma arrivava quando il mal di gola già stava diminuendo o se il suo intruglio funzionava davvero ma un paio d’ore dopo averlo bevuto, Martino avrebbe detto che mai ,in vita sua ,si era sentito così bene che subito correva fuori casa con un salto e si lanciava alla ricerca dei suoi amici. Così quella mattina, avvolte le pesche in un foglio di giornale, s’incamminò verso l’abitazione del Vecchio; abitava fuori dal paese, bisognava salire in cima ad una strada ripida e piena di tornanti; ci volevano gambe e buon fiato e per fortuna, Martino possedeva entrambe. Arrivato a destinazione, bussò alla porta. Venne il Vecchio ad aprirgli; aveva poco più di ottant’anni e il volto solcato dalle rughe e scottato dal sole rivelava un dura vita dedicata al lavoro nei campi. Appena scorse il foglio di giornale accartocciato, capì e con un sorriso fece entrare il giovane. Martino venne accolto da un casolare povero di luci e di rumori; i figli dovevano dormire ancora a quell’ora, era davvero presto per tutti, meno che per il Vecchio; trovò la porta della camera da letto aperta; entrò senza esitare. Emma, più bianca della farina, lo vide e tentò di nascondere il volto nei capelli color argento; non le piaceva farsi vedere ammalata, nemmeno da Martino; ‘’Emma, t’ho purtà i pèrsi’’ bisbigliò il ragazzo. Un saluto frettoloso e ,rapidamente, Martino prese a scendere verso il paese, a passi cadenzati, lungo la ripida discesa; tornò a casa per prepararsi il pranzo al sacco e prendere gli attrezzi che gli sarebbero serviti durante quella giornata: guanti e forbicioni; Febbraio era alle porte, era ora di potare le viti. Il nonno gli aveva insegnato ad avere pazienza, le viti andavano potate il più tardi possibile; da piccolo, quando il nonno lo portava con sè nel vigneto dopo la vendemmia, Martino era più insistente della pioggia d’Aprile sui tetti; ‘’Nonno, quando potiamo le viti?’’ ‘’Pasiensa Martino, pasiensa’’ ‘’Ma nonno, i miei amici a scuola mi hanno detto che le loro le hanno già potate tutte!’’ ribatteva allarmato il bambino ‘’E indè ch’i stan?’’ (letteralmente dove stanno, dove abitano?) gli domandava gentilmente il nonno ‘’Giù in città’’ ‘’E alura!’’ Il nonno pensava di avergli dato una risposta che più chiara non si poteva; Martino invece non capiva; lo comprese all’inizio della primavera successiva, quando le gelate mattutine causarono gravi danni alla viticoltura della zona, falcidiando i germogli appena nati dai tralci dell’anno precedente. Risparmiando quelli della loro vigna. ‘’T’è capì adès?’’ ( hai capito adesso?) gli disse quella volta il nonno; e lui, che non era stupido e di quello che gli veniva detto faceva sempre tesoro, capì; più tardi io poto la vite, più tardi germoglierà, ed abitando tra le montagne dove il clima è rigido, riuscirò a sfuggire agli ultimi tranelli che l’inverno ha in serbo per me. Prese dalla cantina i guanti e i forbicioni e si incamminò; percorse lo stretto sentiero di terra battuta che si immetteva sulla strada asfalta principale, arrivò a grandi passi in prossimità della mulattiera che scendeva sulla destra e che doveva imboccare per giungere al vigneto, quando, alle sue spalle, udì un clacson insistente; incuriosito, si voltò. A velocità sostenuta, un’automobile rossa stava percorrendo le tre curve che separavano il campo della Gattara, che si trovava all’inizio del paese, dal punto in cui Martino si trovava, e in un attimo lo raggiunse; l’uomo alla guida della vettura si affrettò ad abbassare il finestrino e si rivolse al ragazzo ‘’Ue giovane, pensavo non avessi sentito il clacson, meno male che ti sei fermato!’’ Indossava un paio di occhiali da sole molto grandi che gli coprivano metà del volto, un maglione verde scollato sopra ad una camicia bianca con il colletto sollevato; i capelli pettinati all’indietro e tenuti in posizione con il gel completavano il look dello sconosciuto. Martino, ancora incerto su cosa quell’uomo volesse da lui, pensò tra sè e sè, infastidito <<E come avrei potuto non sentirti?? Nelle mattine invernali a quest’ora, l’unico suono che puoi udire è quello della neve che cade sui tetti sulla neve già caduta!>> ; ma il nonno gli aveva insegnato a non giudicare mai dalle apparenze, quindi decise di ascoltare cosa lo sconosciuto volesse da lui. ‘’E’ stata proprio una fortuna avermi trovato, in questo paesino abitiamo in pochi, poi a quest’ora non c’è davvero nessuno in giro...’’ disse il giovane. ‘’Eh, me ne sono accorto guarda, un’ora che salgo su ‘ste montagne e ancora non ho trovato un’anima che mi aiuti!’’ si lamentò l’altro, picchiettando insistentemente l’indice della mano destra sul grosso orologio che portava al polso; ‘’A Milano almeno abbiamo cartelli e indicazioni per ogni strada, in più qua non prende neanche il navigatore, porca miseria!’’ disse, lanciandolo spazientito sul sedile posteriore. ‘’Tu mi puoi dare indicazioni che ho fretta?’’ ‘’Se conosco il posto dove è diretto, l’aiuto volentieri’’rispose Martino. Mentre si rivolgeva così all’uomo sull’auto, dalla strada sopra di loro si sentì l’inconfondibile brontolio del trattore del Vecchio che scendeva verso il paese. Svoltata l’aspra curva sulla sinistra, lo sgangherato Landini testa calda , guidato dall’anziano contadino, placidamente si diresse verso i due. ‘’Ma no dai, anche il trattore adesso, non me la cavo più!’’ sbottò il milanese spazientito. ‘’Oi Martino, chi è c’l è al to amis?’’ (chi è il tuo amico?) domandò l’anziano contadino ‘’E’ un signore di Milano che si è perso e ha bisogno di indicazioni’’ spiegò il ragazzo; il Vecchio allora spense il motore, scese dal trattore e si accostò alla vettura ‘’Indè cat ghè d’andà?’’ domandò il contandino ‘’Ue, ma che lingua parla? Cos’è che mi ha chiesto?’’ intervenne l’uomo sull’auto ‘’Le ha chiesto dove deve andare, si fidi che quest’uomo, quando si parla delle nostre montagne, è meglio del suo navigatore!’’ disse Martino. ‘’Oh, meno male così ci sbrighiamo’’ esclamò l’altro, continuando a picchiettare sull’orologio ‘’Devo andare al matrimonio di quel matto di mio fratello che ha deciso di sposarsi in una chiesetta su un eremo disperso qua in mezzo ai monti, ecco dove devo andare!’’ continuò il milanese, visibilmente nervoso alzando il tono di voce, come se servisse a farsi comprendere più chiaramente dall’anziano contadino ‘’E poi fa freddo quassù, non vedo l’ora di tornare a casa, in un attimo accendo il riscaldamento, infilo le pantofole, televisione dieci minuti per prendere sonno e poi buonanotte che domattina devo alzarmi presto per andare in quell’inferno di ufficio!’’ concluse, ormai esasperato. Martino rimase travolto dal fiume di parole che uscì dalla bocca dell’uomo sull’auto e si girò intontito verso il Vecchio, poco fiducioso che il contadino avesse capito cosa gli era appena stato detto. Contrariamente alle sue aspettative, il Vecchio comprese e cominciò a spiegare al milanese come raggiungere la chiesa, nel miglior italiano che gli era possibile ‘’Guardi, è molto semplice, continui a salire per un paio di chilometri lungo questa strada, arriverà a un bivio, lì deve girare a destra e imboccare uno sterrato che passa in mezzo al bosco e percorrerlo per circa trecento metri, la chiesa si trova sulla sinistra. Pensi che è stata costruita usando i...’’ ‘’Sì guardi, va benissimo così!’’ lo interruppe il milanese ‘’avevo solo bisogno di un’indicazione, non della storia della chiesa dalla sua costruzione!’’ disse scocciato. ‘’Grazie dell’informazione comunque, buona giornata MITICI!’’ e ,ingranando la marcia, aggirò con una rapida manovra il trattore e sfrecciò via, su per i tornanti. ‘’L’era propri mat!’’ (era proprio matto!) concluse il Vecchio e anch’esso,risalito sul trattore, ripartì. L’odore del pane che iniziava a bruciare destò Martino dai suoi pensieri; si alzò dalla poltrona, tolse la cena ormai cotta dalla stufa e sprofondò di nuovo al suo posto; prima di iniziare a mangiare, fece un’ultima considerazione: lui non aveva una bella macchina, dei vestiti eleganti, un lussuoso orologio, il riscaldamento che si accendeva con un click, la televisione o delle pantofole morbide. Non aveva nessuna di quelle comodità. Aveva però il tempo di stare ad ascoltare le storie degli anziani sul posto dov’era nato, aveva un lavoro che gli piaceva, aveva delle persone a cui voleva bene e soprattutto, aveva avuto un nonno saggio che gli aveva insegnato ad apprezzare tutto ciò. Soddisfatto, consumò la cena, lavò il tegame e lo mise capovolto sul lavello a scolare; si diresse in camera da letto, si infilò sotto le coperte e si addormentò, nell’abbraccio silenzioso e sicuro delle montagne. 03 - Paola Cellario – “Pane, zucchero e fantasia” Paola, una scrittrice per passione, alle primissime armi Varzi, 13 marzo 2012 Gentilissima signora Liana de Mistris, E’gentilmente convocata per un colloquio di lavoro come responsabile delle vendite presso Max Mara il giorno 20 marzo alle ore 15.30. Cordiali saluti Chiamò subito il responsabile Risorse Umane. Iniziò l’incarico presso la filiale. 13 settembre 2012 Ricevette una convocazione per una profumeria di Livigno Nel contempo chiuse il punto vendita di Max Mara dove stava prestando servizio, così andò alla convocazione. Decise così di acquistarsi un monolocale là. Conobbe una signora anziana , Arilda che le insegnò come confezionare i profumi. 13 marzo 2013 Ricevette una lettera per essere convocata a Ponte di Legno come comparsa per il film Lustrini che parlava di una attrice in cerca fortuna . Si ritrovò con due lavori. Una sera svenne , fu scoperta dal vicino Marsilio che chiamò l’ambulanza. Fu licenziata per non aver avvisato alcuno della sua improvvisa assenza. Si scoprì poi la vera destinataria delle due lettere era un’altra persona di Chiesa Valmanenco , Martina che aveva la sua stessa età , nata nello stesso mese ma il 6 anziché il 9 luglio ( il numero fu per errore capovolto) Liana, per mesi era rimasta in coma e quindi non rispondeva alle telefonate; i suoi genitori erano morti. Liana si risvegliò assistita all’ospedale da due infermieri che la conoscevano dai tempi dell’asilo. Vinse un terno al lotto su Venezia. Così non cerco piu’ lavori, Martina ritrovò il suo lavoro per la profumeria di Livigno e lei aprì una libreria dal nome Pane, zucchero e fantasia. Il primo libro che lanciò fu La liberazione delle anime ,era stato realizzato con la collaborazione di Martina che era diventata amica di Liana. Scoprirono poi di essere parenti per una zia della madre di Liana (sorella) che era sparita anni fa in un dirupo ed era incinta ma il marito non volle farlo sapere 04 - Elena Coppi – “Giallo di calza” Camilla aveva accolto con entusiasmo la proposta di una gita in montagna. Le chiacchierate assieme alle amiche avevano sempre creato aneddoti curiosi. Camilla sentiva la necessità incontenibile di vivere la stravaganza casuale in maniera libera e divertente. Era pronta, anzi, non vedeva l’ora. Immergersi soprattutto nell’atmosfera apparentemente semplice dei campi vestiti di giallo della sua Emilia, ai piedi dell’Appennino modenese, questo era il sapore che avrebbe voluto gustare in quella meravigliosa giornata primaverile. Sarebbe stata una esperienza stupenda assieme a Martina e Giulia, amiche da sempre nei giochi estivi e nelle loro esplorazioni spensierate in mountain bike a contatto con la natura e con i sentieri di montagna, che amavano nascondersi tra un cespuglio e l’altro alla ricerca della ‘scatola dei segreti’ inventata in un momento di estrema condivisione emotiva. Non si erano mai potute incontrare in primavera, questa gita era per loro una novità. Le tre amiche si erano accomodate sull’erba, nell’unico punto in cui il verde prendeva ampio respiro rispetto all’estesa barriera di corolle gialle, supine a gambe all’aria godevano dello spettacolo solare e leggevano la loro rivista preferita “Piccole teenager crescono”. Sullo sfondo, vette ancora velatamente coperte di un soffice manto nevoso. “Che fiori sono? Il loro colore è il mio preferito…” aveva sussurrato Camilla, volgendo lo sguardo alla distesa dorata, “E’ colza, me lo ha detto mia mamma”, aveva replicato con tono deciso Martina, che le sedeva accanto con le gambe raccolte a sé. “Sentite questa…” era subentrata nel discorso Giulia, attenta lettrice dei trafiletti riportati sul giornale,“ … il giallo influisce positivamente sull'ottimismo e favorisce la concentrazione. Si tratta del colore del sole e della luce e simboleggia perciò la creatività e la saggezza…per contrastare il pessimismo dilagante degli ultimi tempi, vi regaliamo queste immagini dei campi di colza…maggio è il suo mese, la natura si esprime nei suoi colori più intensi!” Con la lettura Giulia era giunta alla fine della pagina quando Camilla le si avvicinò, improvvisamente risvegliata dal desiderio di cogliere lo scatto del fotoreporter di turno, impaziente di provare quel senso di meraviglia che i bambini vivono in attesa del regalo tanto sognato. Anche Martina aveva ascoltato con interesse, distendendo atleticamente le gambe verso il cielo intensamente azzurro. “Ma com’è possibile??!”, “Non ci posso credere!”, “Guarda questa foto!” avevano esclamato una dopo l’altra. Una delle foto riproduceva esattamente lo stesso paesaggio naturale che si stendeva davanti ai loro occhi, colori e forme identici, stessa volta celeste priva di nuvole, inclusa la casa diroccata dove c’era un vecchio mulino! Disarmante, la natura! In più, da un punto indefinito lontano nel campo, si ergevano ben tre gambe destre, che lasciavano intuire la posizione supina dei corpi nascosti dai molteplici pistilli gialli. Ai piedi, scarpe slacciate che dondolavano in armonia e calzette gialle arrotolate alle caviglie. Con gli occhi puntati alle loro calze e con un risolino perspicace appena accennato a fior di labbra, le tre amiche esclamarono al vento: “Siamo noi!” Disarmante, l’amicizia! “Bimbe, tutto bene?”, aveva chiesto con tono protettivo la mamma di Camilla, Emma, che assieme alle altre due mamme, aveva udito da lontano un’eco di parole provenire dal giallo di colza. “Chi l’ha scattata?” aveva subito domandato Martina, che senza esitazione alcuna era entrata nel ruolo di investigatrice meticolosa. “Non lo so, però sulla foto c’è scritto qualcosa in piccolo…” aveva risposto Giulia, ancora sorpresa per l’effetto che la visione della foto le aveva lasciato. “Ecco qua, possiamo utilizzare la lente d’ingrandimento che ho attaccato al mio super portachiavi gigante!” si fece avanti Camilla che, abituata alla sua fervente immaginazione, aveva comunque espresso un momento raro di reale praticità. “ZOE 12 maggio 1973…ma comunque…sì, sembriamo proprio noi, ma è impossibile… che strano, non si spiega” replicò Giulia, ora quasi impaurita dal mistero che si era appena palesato. “Allora, fatemi pensare, chi può essere Zoe…una che abita qui o che conosce questi posti, questa può essere la data di nascita oppure…oppure la data in cui è stata scattata la foto, chissà” disse Martina nel pieno della sua indagine. “…forse la moglie del vecchio mugnaio…mia mamma mi ha sempre detto che nel mulino abitava una famiglia con tre figlie gemelle, può essere che la loro mamma le abbia fotografate in un momento di giochi, proprio come stiamo facendo noi” continuò Camilla nel suo brillante tentativo di trovare una risposta a quella scritta, ma soprattutto a quello che reputava uno degli aneddoti più insoliti che erano loro mai capitati. L’unica che non riusciva a trovare le parole era Giulia, rimasta impassibile nell’ascoltare i ragionamenti delle amiche. Immagini, persone, ricordi, colori avevano invaso le loro menti e creato un’atmosfera quasi incantata. Si erano immerse nella loro storia: reale o surreale che fosse, era la loro e solo loro l’avrebbero potuta raccontare. Proprio in quel momento di sguardi pensierosi ed occhi chimerici, il gruppo di amiche si alzò in piedi voltandosi verso il vecchio mulino…le loro mamme erano improvvisamente scomparse dalla visuale e …cosa videro? La stessa scena della foto riproposta davanti ai loro occhi increduli! Questa volta le tre gambe sembravano rivelare la maturità dei corpi e delle risate il cui rimbombo faceva oscillare gli steli di colza in una danza liberatoria. Ora sì che era loro tutto chiaro! ZOE come le iniziali dei nomi delle loro mamme! Mamme protagoniste delle letture delle figlie attraverso le foto dei loro ricordi. Giulia, Martina e Camilla da un lato e dall’altro le rispettive mamme Zara, Olimpia ed Emma. Generazioni di mamme che avevano tramandato emozioni di vita alle figlie in un giorno di ricorrenza speciale, lasciandosi trasportare dall’accoglienza di madre natura attraverso la magia del tempo. Era il 12 maggio 2013. 05 - Emilio D’Andrea – “Il lupo bianco dei monti Dauni” Come ogni anno, ad autunno inoltrato, il tredicenne Tonino deve disertare la scuola per aiutare i genitori nella stagionale raccolta delle olive. Ci va malvolentieri, ma si consola nell’ascoltare gli intriganti ragionamenti degli adulti che dall’alba al tramonto catturano la sua inappagabile curiosità. Di buon’ora, sotto il cielo cupo di quella grigia giornata novembrina, il gruppetto di lavoro è già sul podere per riprendere l’opera interrotta la sera precedente. Le tre donne di mezza età, già ripiegatesi a rastrellare i piccoli frutti, iniziano il loro chiacchiericcio con i soliti pettegolezzi di paese e qualche proverbio popolare: < Non tirar troppo la corda che si spezza, uomo di vino non vale uno scellino, attacca l’asino dove vuole il padrone, fai bene e scorda fai male e pensa > . Ad arricchire l’affiatato alternarsi della divertente filastrocca è zio Tuccio, che dalla cima di un ulivo aggiunge: < Mogli e buoi dei paesi tuoi, con un sì t’impicci con un no ti spicci > . Anche compare Peppe, l’attempato papà del ragazzo, scendendo dalla scala dell’albero accanto, dice la sua: < Meglio vino caldo che acqua fresca, chi troppo vuole nulla stringe > . < E’ vero: chi troppo vuole nulla stringe - ribadisce zio Tuccio - queste terre, ad esempio, erano tutte di don Riccardo del Moro, Barone di Roseto ed Alberona, famoso per ingordigia, tasse e vessazioni e a far la fame il popolo e i cafoni, senza parlare delle più belle spose, il suo consenso prima e poi i mariti > . Tonino, che su certi argomenti tende sempre le orecchie come antenne, gli si avvicina portandogli del vino e zio Tuccio, dopo aver bevuto a bocca aperta dal cannello, riprende a raccontare: < Ma questo è niente, all’epoca dei fatti don Riccardo, accolse in casa sua pure i briganti e fingendo bene di voler cambiare, promise al volgo grano, pane e bestie. Nel proclamarsi col popolo e gli insorti egli sognava di diventar più forte e in una cena nel suo grande castello, al loro capo disse compiaciuto: Generale, chi non è con Voi è contro di Voi! Io sono qui, a farvi onori e feste, a darvi ciò che è mio, del mio casato, ma oltre la montagna, c’è mio cugino Olindo, Conte di Faeto e di Bovino, lui è con gli invasori, è col Piemonte: dovete conquistare le sue terre, che con le mie si devono sommare, per dare a Voi ancora più alti onori e al nostro Re Francesco gli occhi del codardo! > . Dopo aver spostato la scala su un altro albero, l’uomo prosegue: < Crocco, però, non era mica scemo e non bastandogli soltanto le parole pretese un pegno che suggellasse il patto, chiedendone di lui la figlia in sposa. Cinicamente quello non si oppose pur di compir il losco suo disegno: Eccola è vostra, la mia dolce Isabella, candida e pura come una Madonna, bionda, leggiadra, dal rango principesco, fatela sposa, io ve la concedo, ma mio cugino lo voglio qui in ginocchio oppure appeso come un traditore ed i suoi beni sotto il mio potere, andate presto, tornate vincitori! Ma dopo l’arrivo di migliaia di Piemontesi, i banditi si diedero alla macchia, con don Riccardo schierato col più forte a denunciare della figlia il ratto, quale sfregio e onta ricevuta da quei briganti selvaggi e senza cuore. Il Generale, pur se braccato e vinto, tornò a palazzo con altri suoi due fidi e all’avido Barone mozzò il capo, come a una fiera indomita e crudele, lanciandolo al popolo festoso. Voleva troppo il ricco blasonato, ma perse figlia, averi e anche la testa: ora le sue terre son di tutti, ora son nostre > . < Bel regalo ci ha fatto quel maiale - replica sua moglie Lisa - terre ingrate per una vita di stenti, a spezzarci la schiena per un minuscolo frutto che ci permette a mala pena di campare > . < Bhè, almeno stiamo in armonia e solida amicizia > , le risponde Carmela, la madre del ragazzo, mentre la terza donna, Graziella, aggiunge: < Povere ma contente > . < Parli bene tu - ribatte Lisa - sola e senza figli, ti basta poco per tirare avanti, ma io quattro ne ho fatti e cresciuti: tre sono al Nord a guadagnarsi il pane e un altro è qui in cerca di lavoro > . Zio Tuccio, la rincuora: < Non lamentarti sempre, moglie mia, tutto sommato abbiamo la casa, la vigna e il castagneto: andiamo a testa alta, non ti basta? Certo con la fatica che facciamo, senza alcun agio e senza neanche un lusso, potremmo reclamar di stare meglio, ma questo è il dato, il pane lo sudiamo! > . < A proposito di pane, è già passato mezzogiorno: bisogna fermarci per mangiare > , dice compare Peppe sospendendo il suo e l’altrui travaglio. Tonino non se lo fa ripetere due volte e corre subito verso il capanno; poi sul grosso e liscio masso lì antistante apre le vettovaglie. Il sole non si vede, ma un chiaro spiraglio dietro le nubi dense e a cupe forme conferma l’apice del suo giorno. Si coprono le donne con gli scialli, anche gli uomini si cautelano le spalle, quel misero riparo è insufficiente ad arginare il vento che si scaglia sopra il terreno e fra le piante inermi. E mentre s’alza la fiamma del bel fuoco, proprio vicino alla tavola di pietra, ognuno siede intorno a prender posto, chi su uno scanno, chi su una legna corta, chi su un sasso rotondo. Solo il ragazzo è in piedi a mandar giù una spessa frittata con due fette di pane fatto in casa, che gli uomini inzuppano nel sugo piccante della “ciambotta” di baccalà, patate e peperoni, per passare a uova fritte, olive salate e formaggio stagionato. Tutti si ristorano col pasto e dopo i maschi anche le femmine gradiscono un bel sorso, così che il cibo sembra aver più gusto; poi una frittella, un pezzo di focaccia, fichi secchi e castagne a completare i frugali bocconi caserecci. Pochi discorsi durante il desinare, le bocche piene e il tempo che s’affretta quasi impediscono a tutti di parlare, quando poi si riprende a lavorare tornano la favella e le parole, con compare Peppe di già su un altro ramo che sogghigna: < Ci resta poco ormai, mio caro Tuccio, un paio di giorni ancora e poi finalmente a riposare>. < Riposare? – gli risponde la moglie – voi uomini forse, ma noi donne avremo sempre un bel da fare: l’olio al trappeto, il pane da impastare, i panni alla fontana da lavare e poi mattina e sera pulire, stirare, cucinare > . Il marito fra gioia e malinconia: < Siam gente di lavoro e patimenti, ma i nostri sacrifici non son vani, viviamo insieme tutti i santi giorni e poi il nostro Tonino può studiare, così che sia più bello e allegro il suo domani > . Sorride grato il ragazzo, ripetendosi nella mente: “Già il domani”. Ci pensa spesso e nonostante legatissimo alla sua terra, a genitori ed amici, sa che da grande dovrà lasciarli per andare a cercare fortuna altrove ed avere più opportunità di lavoro, buoni guadagni e piena libertà di osare, dire, fare. Solo così forse potrà tornare ed aiutare l’amato borgo a progredire! Ma quei pensieri sofferti ed ambiziosi al tempo stesso, sono interrotti dal vispo bastardino che, dopo aver sgranocchiato un tozzo di pane, gli scodinzola fra le gambe mordendogli scarpe e pantaloni: < Basta Sergè, son qui per lavorare, vai giù al burrone se proprio vuoi giocare, ma fai attenzione se non ci vuoi restare, c’è un lupo bianco che ti può azzannare > . Sua madre, Carmela, accennando un’antica leggenda, rassicura l’ignaro cagnolino: < Puoi andare tranquillo Sergè, quel lupo non ti farà niente perché è venuto in queste terre solo per difenderle dall’invasione degli angeli ribelli > . Il figlio, che di vecchie e fantasiose storie popolari pur ne ha sentite tante, ascolta con interesse il prosieguo del discorso: < Si narra che migliaia di anni fa alcuni angeli, per punizione trasformati da Dio in un branco di lupi famelici, dopo un lungo peregrinare sulla terra, si stanziarono proprio sulle nostre montagne > . Lo sguardo sempre più curioso del ragazzo è presto soddisfatto: < I lupi per vendicarsi di quell’insopportabile umiliazione si abbandonarono in sanguinarie razzie, causando numerose vittime fra persone e animali. Uno di loro, pentitosi di essersi ingiustamente opposto al suo Signore, tentò di convincere gli altri a desistere da quella brutale mattanza: fu subito espulso dal gruppo e costretto all’isolamento sulle alte e innevate cime della Daunia. Dopo alcuni gelidi inverni trascorsi in perfetta solitudine, il lupo vide trasformarsi il pelo da nero in bianco, tanto da confondersi con la neve e sfuggire sia alla spietata caccia degli agguerriti popolani che ai suoi stessi vecchi compagni, sempre più braccati e affamati, pronti a sgozzarlo e divorarlo senza pietà > . Anche compare Peppe fornisce al figlio ulteriori dettagli: < Lo sterminio dei lupi neri proseguì per molti secoli, fino alla loro totale estinzione; solo quello albino riuscì a sopravvivere, anche se furono in molti a tentare di catturarlo per sfatare la millenaria leggenda > . Tonino incredulo: < Allora il lupo bianco di cui si parla ancora oggi è lo stesso di quel lontano passato? Ma come è possibile? > . Zio Tuccio glielo spiega così: < L’animale, pur sapendo di essere odiato dagli umani, si avvicinava ugualmente a loro e un bel giorno, proprio nei pressi di questo burrone, per salvare un pastorello intento a recuperare un vitellino sull’orlo del precipizio, non esitò a rischiare la sua vita per evitare all’incauto ragazzino un’irrimediabile caduta nel vuoto. Il redo e il suo padroncino ne uscirono incolumi, ma il coraggioso lupo bianco finì nel baratro e di lui non si seppe più nulla > . L’espressione delusa disegnatasi sul volto del ragazzo viene attenuata dalla nota di suo padre: < Sono in molti, però, a giurare che non sia morto, perché il buon Dio lo raccolse amorevolmente al volo per restituirgli il posto fra gli esseri celesti > . La madre conclude: < Da quella volta tutti lo ritengono l’angelo custode di pastorelli, contadini e boscaioli; qualcuno sostiene anche di avvistarlo spesso sulla vetta del monte Cornacchia > . Tonino, sempre più incantato da quei racconti struggenti e appassionati, viene riportato alla realtà dall’irrequieto cagnetto che continua a rubargli le olive dalle mani. Scacciato con un colpo di gomito, il piccolo ribelle prosegue a scorrazzare fra gli arbusti, i sacchi e le lunghe vesti delle contadine che gli imprecano contro per farlo allontanare. Verso il tramonto si fanno sempre più intensi e prolungati i sospiri per riprendere fiato, mentre pian piano il loro chiacchiericcio si congela per diventar sempre più lieve e fioco sotto quel cielo freddo e grigio topo. Col giungere delle prime ombre della sera le donne già pensano ai mestieri della casa, gli uomini a riposar le membra stanche e il giovane a ritirare la lista dei compiti dal suo compagno di banco. A smorzare i diversi esercizi mentali è il ringhio del cane che d’improvviso immobile rimane; orecchie a punta e sguardo all’infinito per scrutare qualcosa da lontano: son due levrieri dal lucido pelo che giungono veloci ed ansimanti, facendolo svanir nel tronco cavo. < Chi sarà mai? > , si chiedono le donne. A monte del podere appaiono due uomini armati di fucile: < Salute a tutti, gente - dice il primo - siam cacciatori, siamo qui di passaggio, i nostri cani stanno inseguendo un lupo, è tutto bianco e da stamani ci sfugge, ma noi non ci perdiamo di coraggio > . Zio Tuccio continuando a far cadere olive sul ruvido telone risponde: < E che coraggio signori, i vostri schioppi contro un povero lupo, meno male che è svelto e sa sviarvi > . < Che vuoi dire amico? - chiede l’altro - certo siamo più agevolati nella lotta, ma anche lui agisce a tradimento, assalta i greggi, le pecore e i vitelli e sgozza senza pietà capre ed agnelli: ognuno ha il suo ruolo sulla terra, queste sono le regole di vita > . Anche compare Peppe interviene: < Avete detto bene capocaccia: regole di vita, ma il lupo assale solo per mangiare, l’altro tempo lo passa a nascondersi o scappare > . Il primo cacciatore toccato da quelle sagge parole tenta di giustificarsi: < Amici credeteci, non siamo quello che sembriamo, anche noi abbiamo un cuore e una coscienza: tre volpi all’anno, due fagiani, si e no una lepre, due quaglie, sei beccacce, questo è il bottino, non credo sia una strage e poi sapete, i tempi son cambiati, scarsa la selvaggina, torbide e insane le acque di fiumi e torrenti, amara e nauseante è a volte l’aria e anche la pioggia non è più linda e chiara > . Zio Tuccio gli dà ragione: < E’ vero, i segni di questo cosiddetto progresso sono tristi e preoccupanti; una volta qui portavamo letame a concimar la terra, ora dobbiamo ricorrere a fertilizzanti chimici, altrimenti raccolti meno copiosi e il nostro già irrisorio guadagno sempre più inconsistente > . Anche l’altro forestiero, stemperando l’approccio spigoloso, accoglie il fiasco che Tonino gli porge e commenta: < Buono questo vino, è arte locale? > . < Certo – risponde fiero il ragazzotto – lo fa mio padre con l’uva della nostra vigna; qualche grappolo se lo pappa anche il a cui date la caccia, ma noi lo lasciamo sempre tornare alla tana dai suoi affamati cuccioli: ne morirebbero senza! > . Il nuovo clima di dialogo e commozione sembra rasserenare gli animi e i volti di tutti, quelli esausti per la giornata di lavoro e quelli delusi per l’affannosa ricerca della preda mancata. Anche l’impaurito Sergente, lasciato d’un fiato il suo rifugio, torna timidamente a scodinzolare, mentre sul ciglio del burrone come d’incanto appare proprio il lupo bianco e i suoi occhi lucidi e malinconici sembrano ringraziare quegli umani per averlo lasciato vivere un altro giorno. Tutti restano immobili e impietriti, mentre il ragazzo piano gli va incontro: d’un attimo si sfiorano la coda con la mano, poi quel candido pelo fra i rovi e la boscaglia si dilegua e scompare. Finita è la giornata: buona sera, arrivederci e ognuno riprende la sua strada e i suoi pensieri. Tornando a casa sul carro sussultante, il giovane ripensa al suo nuovo e misterioso amico: il mitico lupo bianco delle fiabe. Gli sembra di vederlo in cima alla montagna, mentre lo accompagna con lo sguardo fino all’arrivo in paese. Immagina anche di ritrovarsi con lui in piena estate, in una magica notte di stelle cadenti, a ricercar tartufi e dissetarsi a una fonte sorgiva, fra l’incessante e melodioso tripudio di lucciole e grilli. Tonino ha deciso, da grande non partirà più per posti lontani in cerca della felicità, perché sente già di averla: è nell’aria che respira, nel calore di genitori e familiari, nella semplicità della gente! E’ solo il sogno di un adolescente o anche l’insopprimibile bisogno di sentirsi partecipi di una grande e infinita storia comune? Sicuramente è l’innata aspirazione di essere protagonisti e artefici del proprio destino, alimentata dalle ancestrali reminiscenze dell’anima, dai profondi valori di un popolo e dalla speranza in un futuro migliore. E’ l’intenso respiro del prezioso ed irripetibile presente, fra i sapori, i profumi e le tradizioni di una terra unica e meravigliosa, fatta di uomini, donne, fiumi, valli, alture, aquile e, forse, del leggendario lupo bianco dei monti Dauni … 06 - Paolo Delucchi – “Dagli Appennini alle Indie – una storia vera” Il paesino di Canepa sorge su un monte dell'entroterra ligure. Poche case costruite lungo una strada comunale, che fanno sembrare più grandi la chiesina parrocchiale e il vicino camposanto, tutto circondato da un muro grigio. Più in basso, lungo la stessa stradina, sorge il paesino di Lago. Stesse case in fila lungo la strada, stesse dimensioni compresse, comuni in Liguria. Canepa e Lago sono due minuscole frazioni di un piccolo comune, che si popola solo d'estate. Ma Canepa e Lago non si popolano nemmeno d'estate, salvo il giorno delle rispettive sagre, che sono il palio degli asini e il palio delle oche. A metà strada tra Canepa e Lago abitava la famiglia Pagano. Era una famiglia molto ricca e rispettata. Il papà era imprenditore, costruiva mobili su misura per clienti benestanti e dava lavoro a più famiglie. Il suo laboratorio di falegnameria sorgeva proprio a ridosso della casa. Dalla strada comunale una viuzza portava alla casa-laboratorio, che quindi sorgeva isolata come un piccolo castello, quasi una terza frazione fra Canepa e Lago. Tuttavia allo stesso tempo la famiglia Pagano non era fortunata. La mamma e l'unico figlio, Paolo, erano molto grassi e questo comportava loro gravi problemi di salute. Paolo era talmente pesante che camminava con difficoltà e quasi sempre aveva il fiatone. Questo fatto e la solitudine del luogo dove abitava lo avevano reso di carattere schivo e irascibile. Amava trascorrere il tempo libero in lunghi giri in auto, guidando senza fare soste (li chiamava "giri cardinalizi"), da solo o con qualcuno dei suoi amici, pochi ma affezionati. Questi amici lo chiamavano familiarmente Paolone, non per scherno, ma per distinguerlo da Paolino, un altro amico della loro compagnia. Della stessa compagnia facevano parte, a vario titolo, anche Richi, Pier, Gabri, Magna, Marco, Andrea, che avevano in comune il fatto di essere tutti maschi e quasi tutti ex-allievi della stessa scuola, il Don Bosco di Quarto. Paolone e Paolino, pur volendosi molto bene, raramente erano d'accordo su qualcosa. Paolone in particolare rimproverava a Paolino di essere poco maturo e poco serio, e la cosa suonava a tutti bizzarra e divertente, perché Paolone era di un anno più giovane di Paolino e non pareva più maturo di lui. Comunque, conoscendolo, era impossibile non voler bene a Paolone, perché al di là dei difetti si vedeva un ragazzo buono e triste, che soffriva per il suo fisico infelice. Paolone morì a soli 30 anni per un attacco d'asma, una notte, a casa sua, senza preavviso. Il funerale si tenne nella chiesina di Canepa e il corpo fu tumulato nel vicino camposanto. Gli amici parteciparono costernati alla cerimonia. Poco prima o poco dopo la sua morte, la ditta della famiglia Pagano cessò l'attività. Alcuni dipendenti si erano licenziati per mettersi in proprio e comunque continuare l'attività, ora che non c'era più un erede, aveva poco senso. Qualche anno dopo morì anche la mamma di Paolone e il signor Adriano Pagano si ritrovò solo. Nessuno dei suoi amici sapeva bene che parole trovare per consolare quest'uomo, che nel corso di pochi anni aveva perso tutto, azienda, figlio, moglie. Anche perché il signor Adriano, a incontrarlo, pareva davvero un uomo piegato dalla sventura, curvo, triste, malandato, più vecchio ancora di quanto dicesse la sua carta d'identità, e senza più scopo nella vita, se non portare ogni tanto un fiore al figlio e alla moglie al cimitero di Canepa. Il signor Adriano finì per avvicinarsi a quelli che erano stati gli amici del figlio, ovvero i salesiani del Don Bosco di Quarto e la compagnia di Richi, Pier e soci. In particolare Richi, un ragazzo disabile noto a tutti come genoano sfegatato e per le sue doti insospettabili di poeta, era affezionatissimo al ricordo di Paolone ed era molto legato anche al signor Adriano. Pier invece era un po' il confidente del signor Adriano, dava sue notizie agli altri amici e girava i suoi inviti in trattoria. Era l'antivigilia di Natale quando Paolino ricevette una telefonata. Era Pier. "Pronto, Pier, auguri!", disse Paolino. Silenzio di Pier. Poi Pier mugugnò: "E' morto il papà di Paolone". Silenzio di Paolino. Pier proseguì: "C'è il funerale domani a Canepa. Passa a prendere Richi con la macchina, perché io domani lavoro e rischio di arrivare tardi". L'indomani, vigilia di Natale, Paolino raccolse Richi da casa sua e i due si avviarono insieme in auto. "Sono contento di vederti, Richi. Auguri! Era un po' che non ci vedevamo", disse Paolino. "Sì, sono contento pure io. Auguri anche a te! Peccato però vedersi per un funerale", rispose Richi. Paolino voleva sapere da Richi notizie più precise del signor Adriano, ma Richi non ne sapeva molto. "Adriano era molto riservato", disse Richi, "Sapevo che aveva qualche problema di salute, ma come un uomo della sua età. Ultimamente ci sentivamo meno. Forse aveva da fare, ma non so che cosa". Il discorso passò allora su Paolone e sugli anni passati con lui, e proseguiva ancora mentre la macchina saliva lungo la stradina verso Lago e Canepa. Era bello parlare fra amici e i due quasi si dimenticarono che stavano andando a un funerale. A riportarli alla realtà fu la vista del carro funebre, che saliva lentamente la stradina e creava una piccola coda di auto. Arrivati a Canepa e posteggiata la macchina, Richi e Paolino aspettarono sul sagrato l'arrivo della bara. Fuori dalla chiesina Lago e Canepa erano presenti al completo, insieme a parenti e amici, in tutto un centinaio di persone. Richi e Paolino entrarono in chiesa tra gli ultimi, quando i posti a sedere erano già quasi tutti occupati. Videro con sorpresa che gli unici posti rimasti liberi erano quelli nelle prime due file, quelli dove di solito prendono posto i parenti stretti. Richi e Paolino, un po' a disagio, sedettero in prima fila, insieme a un anziano salesiano laico. Era strano e anche un po' triste che a figurare come "parenti stretti" del signor Adriano fossero due amici di Paolone e un exprofessore di Paolone. Tuttavia ancora più strana era l'atmosfera nella chiesina, per la coincidenza fra il dolore del lutto e lagioia della vigilia di Natale. Nel complesso però prevaleva la tristezza, anche perché tutti i presenti conoscevano la storia della famiglia Pagano. Paolino, seduto in attesa della funzione, fissava in silenzio il presepe lì vicino. Cominciò la Messa. Intorno all'altare c'erano più sacerdoti, i salesiani del Don Bosco di Quarto più il parroco di Canepa. Si fecero le letture, quindi venne il momento più atteso a un funerale, quellodell'omelia. Il celebrante, un salesiano anziano, iniziò dicendo: "Conoscevo poco Adriano...". Paolino guardò il prete, scosse lentamente la testa e pensò: "Cominciamo bene! Hai detto Messa pure al funerale di Paolone e pure con lui avevi iniziato dicendo: 'Lo conoscevo poco'. Ma per piacere! Se mi ci metto, predico meglio io!". Il salesiano, senza interruzioni, continuò: "...ma voglio dirvi tre cose di lui. La prima è che Adriano è morto con tutti i conforti religiosi". Paolino sorrise fra sé e pensò: "Bravo! Almeno una cosa buona l'hai detta. Una cosa adatta a unfunerale e adatta a un prete. Speriamo le altre due...". Il salesiano riprese: "La seconda è che Adriano, negli ultimi tempi, si è avvicinato molto alla Chiesa, in particolare a noi salesiani, e ci ha dimostrato molta gratitudine". Paolino pensò, ridendo sotto i baffi: "Frase ambigua! Si può interpretare in tanti modi. Chissà cosa staranno pensando i parenti... stai a vedere che Adriano ha fatto a tutti lo scherzetto...". Il salesiano riprese, ma cambiando tono, come se sorridesse fra sé: "La terza cosa c'entra con la vigilia di Natale, perché è simile a un racconto di Natale, ma è una storia vera". Molta gente, fino allora mezzo assopita, sentendo il tono diverso drizzò le orecchie, incuriosita. Il sacerdote, checché ne pensasse Paolino, era un predicatore esperto e conosceva il valore delle pause, quindi fece silenzio per qualche attimo, per aumentare l'attesa e stimolare l'attenzione. Il salesiano, sorridendo benignamente, riprese: "Pochi tra voi sanno che, dopo la morte del figlio e della moglie, Adriano si è dedicato ad aiutare gli altri. Adriano non andava a dirlo in giro ma, dopo la morte dei suoi cari, aveva deciso di aiutare la costruzione di una chiesa in India, nella diocesi di ...". Pochi, solo quelli che avevano già sentito questa strana storia, capirono il nome preciso del posto. "Quindi Adriano di sua iniziativa ha pagato il progetto, i materiali, i lavori, e dove prima c'erano sterpi ora c'è una chiesa, dove 10.000 persone possono radunarsi, pregare, ricevere i sacramenti". Fra la gente alcuni avevano gli occhi lucidi, altri gli occhi sbarrati, tutti le bocche aperte. "Adriano, morendo, non ha fatto in tempo a vedere di persona il frutto della sua fatica. Ma ora in quella chiesa in India c'è una lapide che ricorda suo figlio Paolo. E ora certo ce ne sarà un'altra che ricorderà lui e sua moglie. Vi dico questo oggi, vigilia di Natale, perché sappiate che uno di voi, un vostro compaesano, ha fatto cose grandi, è stato un benefattore. Andiamo fieri di lui, facciamo come lui, che ci ha mostrato come dal male e dal dolore possano nascere il bene e la gioia". Paolino pensò: "Questa storia, la vigilia di Natale, sembra un racconto di Dickens!". Si sentiva ilare e leggero e avrebbe avuto voglia di commentare la storia con Richi, ma Richi, col suo animo da poeta, era assorto e pensoso, e non dava modo di parlare. Finita la Messa, una piccola processione, con la bara in testa, uscì dalla chiesina e si avviò al vicino cimitero. Qui l'anziano celebrante benedisse un'ultima volta il corpo del signor Adriano, che fu posto in una cripta, e la cerimonia si concluse così. Nel piccolo camposanto, che pure era affollato, regnava un rispettoso silenzio e chi parlava lo faceva sottovoce. Richi, che fin dall'inizio della Messa era rimasto zitto, si avvicinò a Paolino e disse: "Bella storia, vero?". "Bellissima!", rispose Paolino, "E molto natalizia! Ma tu sapevi qualcosa della chiesa in India?". "Io no", riprese Richi, "Però ho sentito qualche parente che diceva di aver saputo qualcosa. Comunque credo che nessuno sapesse bene tutto". "Quindi nemmeno Pier sapeva qualcosa", osservò Paolino. "Credo proprio di no", rispose Richi. "A proposito", disse Paolino, "Pier non è poi arrivato. So che lavorava. Sarà dispiaciuto. Peccato non averlo visto". "Spiace pure a me", rispose Richi, "Anche perché, se ci fosse, Pier saprebbe dove si trova la mamma di Paolone". "Hai ragione", riprese Paolino, "Anche io so dove è sepolto Paolone, ho visto dove sarà sepolto suo papà, lì accanto, ma non ho visto da nessuna parte la tomba di sua mamma". Paolino si guardò intorno, in cerca di chi potesse aiutarlo, quindi si rivolse a una signora, dicendo: "Mi scusi, non so se lei conosceva la moglie del signor Adriano. Saprebbe dirmi dove è sepolta?". "Sì, la conoscevo. Guardi, la tomba è qui dietro", disse la signora, che girò un angolo e si fermò davanti alla lapide di un loculo in basso. Intorno alla lapide si formò un capannello di persone. La signora, rivolta a Paolino ma in modo che sentissero tutti, commentò: "Prima è morto il figlio, poi la mamma e poi il papà. Una famiglia distrutta!". "Una famiglia riunita!", disse Paolino. La signora lo guardò, poco convinta. La gente intorno commentò sussurrando, non sapendo a chi dare ragione. Paolino stesso aveva risposto d'istinto, ma non avrebbe saputo spiegare bene il groviglio di sentimenti di quella giornata. C'era il lutto, e non un lutto soltanto, ma un lutto triplice, una famiglia distrutta, appunto. Però c'era anche una bella storia di generosità e di speranza. Ed era la vigilia di Natale. Era molto difficile fare una sintesi di tutto questo, ci sarebbe voluto un poeta... Proprio allora prese la parola Richi, il poeta che non ti aspetti, e zittì tutti, riassumendo in una sola frase tutto il senso di quella giornata. Disse con semplicità: "Il Signore ha voluto premiare Adriano, perché sa che non è bene passare Natale da soli". Paolino guardò Richi, pieno di ammirazione per le sue parole. Il capannello si sciolse e i due amici, dopo una breve preghiera per la famiglia Pagano, uscirono lentamente dal cimitero. Fuori arrivava in quel momento Pier in macchina. I tre si salutarono, poi Pier entrò brevemente nel camposanto, per salutare anche lui il signor Adriano e i suoi congiunti. Quindi risalì in auto, diretto verso casa, e salì pure Richi. Paolino li salutò, dicendo: "Và piano, Pier! E tu, Richi, oggi hai parlato bene, sei stato davvero un poeta all'altezza della tua fama, ma ora non montarti la testa. Non sei Leopardi!". "Grazie al cielo!", rispose Richi ridendo, scuotendo la testa e agitando la mano. 07 - Ennio Di Biase – “Infinite traiettorie” “… a quasi settant’anni dal suo sacrificio, per un Paese non suo...” “…un Paese che però aveva imparato ad amare…” Lo slancio dell’oratore cattura i visi arrossati dal freddo con equilibrio dosato di enfasi e retorica. “...la comunità ricorda il coraggio...” Sepolti tra giacconi e berretti di lana gli occhi traducono la commozione in un luccichio tremulo. Ogni anno la valle si raccoglie al monumento dedicato al partigiano russo caduto sui nostri monti. Io l’ho conosciuto, ho combattuto con lui una vita fa. Di fianco, la compostezza mesta dei compagni di allora tradisce la sofferenza del ricordo. Ci hanno riservato le sedie della prima fila. I posti d’onore. Tutti gli anni ci ritroviamo qui, e ogni volta alla fila manca qualche sedia. La solennità della commemorazione sfida imperterrita le sferzate del vento che gioca a rincorrere le ultime foglie. Le nuvole tagliano le cime dei monti con una linea indefinita di grigio. “...onoriamo la scelta importante... l’ideale di libertà...” Il nome del partigiano caduto riecheggia in una ridondanza impronunziabile di consonanti. Per noi è sempre stato il Biondo. Era il nome di battaglia che lo identificava in quella strenua crociata di pseudonimi. Qualche macchina sfila sulla strada vicina, ignara della Storia che anche tra questi monti si è consumata. Qualcun’altra rallenta, incuriosita dal gruppo di gente, poi con un colpo di acceleratore che sembra decretare l’inutilità del ricordo si allontana nell’odore penetrante di un autunno che sta per finire. Il passato ormai è per chi lo alimenta o ne custodisce il valore. Per me, per questa fila di sedie sempre più ridotta. L’occhiata distratta agli altri partigiani racconta di vecchi dallo sguardo stanco e i capelli bianchi esposti alle direzioni confuse del vento. Vecchi come me. “...onore... riconoscenza...” Le parole si lasciano trasportare dalle folate improvvise. Rimbalzano sull’emozione dei ricordi. Le sento lontane, sempre più lontane. Quella notte ero con lui. Faceva freddo. Anche più freddo di oggi... ... i passi cadenzavano lo scricchiolio sordo del gelo sul terreno. Credevo non volesse rispondere, la mia domanda si era persa nella profondità immobile del buio, invece ad un tratto incrinò il silenzio. “Non sono mica l’unico… Sai quanti deportati sono fuggiti dai campi di concentramento? Dovevo prendere una decisione: questa mi è sembrata giusta.” Il freddo della notte convertiva le parole del Biondo in nuvole di fiato caldo. “Ma non ti manca la tua Russia, la tua gente?” Aveva imparato in fretta l’italiano. Rispose che la geografia non mette confini agli ideali. Ora eravamo noi la sua gente, la sua Patria. Non gli chiesi altro. Quella notte eravamo in tre. Dovevamo minare il ponte di accesso all’alta valle. Noi conoscevamo bene questi monti, eravamo abituati a muoverci tra i boschi, ombre nel buio della notte, gambe allenate da chilometri di salite. Per i tedeschi non sarebbe stato facile, per cui interrompere la strada avrebbe decretato un vantaggio schiacciante. Lontano, più a valle, qualche sparo feriva il silenzio della notte. “Sai, ho fatto una scelta, importante, sofferta, ma non è questo che da coraggio. Anche io vivo i miei dubbi, anche io ho paura.” Ricordo che affastellai qualche banalità sull’importanza della paura per difendere la sopravvivenza della specie, o sul coraggio di ammettere le proprie paure e l’incoscienza di non averne. Era troppo assorto per ascoltarmi. Il sentiero declinava nella geometria millenaria di pietre posate da mani esperte e montanare a lastricare i tornanti, come custodi silenziose di infiniti passaggi. I rami sopra le nostre teste sovrapponevano alla fissità della notte un intrico di scheletri nudi trapunti dalla lontananza fredda delle stelle. Qualche soffio di vento violava a tratti la stoffa lisa delle giacche per trafiggerci con aghi di gelo. “Tu sei abituato, non dovresti avere freddo” tentai di scherzare. “Non ci si abitua mai, si impara a sopportarlo… perché, convivere con la paura aiuta a non provarne più?” No, non aiuta, ma non lo dissi. Il sentiero si alternava tra macchie di alberi e declivi di erba prigioniera fragile del gelo. Ci fermammo qualche minuto ad ascoltare il silenzio di quell’aria dall’odore pungente come è il respiro delle notti di brina. Eravamo arrivati. Una decina di metri più in basso la strada era sdraiata in tornanti sinuosi e regolari. Appena più giù il ponte. Avevamo discusso parecchio sull’opportunità di farlo saltare. Alcuni del comando erano contrari, o almeno, pur concordando la necessità di un’interruzione dell’accesso, risultavano frenati dai ricordi di discorsi lontani, di padri o di nonni che con mani sapienti a inizio secolo avevano affogato nel cemento le pietre del fiume per sostituire la vecchia passerella di assi di pino con una strutture più solida e funzionale che permettesse il transito anche ai mezzi, carri trainati dai buoi prima e ora automobili. Per la precisione jeep. E per di più tedesche. Anche mio nonno vi aveva lavorato e anche io ero combattuto, ma priorità andava data alla sicurezza. “Alla fine della guerra lo ricostruiamo noi” ci promettevamo a vicenda, un po’ per fugare le ultime incertezze e un po’ perché parlare di ricostruzione nutriva la speranza. Il canto di un notturno interruppe il silenzio immobile della notte, e il soffio del volo passò appena percettibile sopra di noi. Il Biondo strinse il fucile in un fremito di allerta. Gli posai una mano sul braccio “Tranquillo, è solo una civetta.” I muscoli persero tonicità “Ah… ma non dite che la civetta porta male?” “Portano male i tedeschi, non gli uccelli!” Gli strappai un abbozzo di sorriso. “Aspettiamo ancora un po’ per essere sicuri, poi andiamo” sussurrai sul cenno di assenso del capo dei miei due compagni. La sagoma scura e ininterrotta dei monti di fronte incombeva come una minaccia. Dietro, la luna nella sua lenta risalita iniziava a mostrare il profilo delle cime. Ormai eravamo lì da mezz’ora. Nessun rumore. Nessun movimento. Bisognava andare, prima che i raggi della luna inondassero di luce la strada. Poi, appena percettibile, un fruscio di foglie secche, subito spento in un silenzio più pesante e carico. Non ne ero nemmeno sicuro. Forse era il gioco di un alito di vento. Bastava restare ancora lì. Bastava non ascoltarlo. Il Biondo si girò verso di noi. “No, non andare, aspettiamo.” “Voi non muovetevi. Vedo solo cosa è stato.” Non riuscimmo a trattenerlo. La luna sembrava enorme quando vinse il profilo del monte. Il Biondo si allontanò nel buio violentato dai suoi raggi. Restammo sospesi in un’attesa senza tempo, con i sensi acuiti dalla paura, mentre i passi del Biondo si perdevano tra gli alberi spogli. Provammo ancora a richiamarlo. Un braccio si affacciò tra i fusti centenari di castagno ad intimare silenzio col movimento ripetuto dall’alto al basso. Proseguì in direzione del ponte nascosto tra le piante, parallelo alla strada. Ormai era troppo lontano per indovinarne la figura o gli spostamenti. Lo sparo squarciò il silenzio dell’attesa, quasi contemporaneo al grido strozzato del Biondo. Abbandonai il riparo e corsi tra gli alberi. “Maledetti, maledeeetti!!!” Il fucile vomitava a caso la rabbia nello sfondo indefinito della notte. Il mio compagno mi raggiunse, mi scaraventò a terra. Solo allora ripresi contatto con la realtà, ricominciai a respirare l’odore acre della paura, mi domandai come avevano saputo dell’intenzione di far saltare il ponte. Continuai a chiedermelo per anni, senza riuscire a scoprirlo. I tedeschi ripresero a sparare. Uno di loro uscì dal buio per avanzare al riparo delle piante. Per un attimo il biancore feroce del ghigno rimbalzò sui raggi della luna. Il Biondo era a non più di dieci metri da noi, fermo, indifferente. E noi non potevamo avvicinarci, bersagli invisibili di tre fucili celati tra i contorni del buio. “Sono pochi, credo soltanto tre, e noi siamo più in alto, in posizione migliore.” Ci spostammo tra gli alberi per mirare ai lampi di fuoco che i fucili sputavano ad ogni sparo. Al riparo di una roccia che incombeva sulla strada ora dominavamo la situazione. Ad un tratto qualcuno urlò un ordine. Qualcun altro gli fece eco con voce secca, metallica come un cozzare di spade. Riversammo altro piombo verso quelle grida confuse. L’intrico degli alberi inglobò la loro corsa. Bucammo ancora il buio con qualche colpo, finché il rumore dei rami spezzati si perse del tutto nel bosco. “Se ne vanno, se ne vanno!!!” Infinite traiettorie… Una linea nello spazio può seguire infinite traiettorie. Anche la linea di uno sparo. Deve solo non incontrare ostacoli, forare la notte fino a diventare parabola e perdersi nel buio… però sapevo che stavolta non era così. Il Biondo abbracciava il terreno gelato. Era ancora vivo. Per poco però. Sulla schiena le pieghe della giacca offrivano ai raggi obliqui della luna un chiaroscuro intriso di sangue appiccicoso e tiepido. Tentai di indovinare le parole che interrompevano la sofferenza dei silenzi “…sai, mi manca il mio Paese… la Russia è grande, molto grande, ma anche lei ha dei confini… anche lei finisce…” Soffocò il gemito nello scricchiolio dei denti “io ho lottato per qualcosa di più grande… per togliere i confini alla libertà…” Infinite traiettorie nello spazio… invece ha inciampato nella sua vita… uno stupido, fottuto, preciso segmento di retta tra il lampo di un fucile nel buio e l’orgoglio di una scelta. 08 - Tamara Furlanello – “Omaggio a Pietro Daglia, combattente per la libertà” Non so perché tutti i giovani portino le braghe calate e mettano in mostra le mutande, anche quando qui fa un freddo che ghiaccia la strada e gli alberi portano sui rami la brina. Io che il freddo l’ho patito e ne provo rispetto, non riesco a prendere sul serio uno con la cintura a metà del sedere che gioca con quel trabiccolo del telefonino… neanche se è mio nipote. Del resto, neanche lui prende sul serio me. - E daaai nonno, beviti un punch e racconta dai… Ma io lo so che non mi ascolta, ride con quella faccia inconsapevole della gioventù che non sa che era tutto vero, che non ha mai provato. Parlano di crisi… sì, ma non sanno proprio niente della crisi vera, loro. Ha l’età che avevo io, quando era tutto già finito ed ero già padre e non mi ritenevo più giovane, se mai noi lo siamo stati. Eppure stasera, qui da Rino, in una delle interminabili serate stanche dell’inverno di Bralello, ho voglia di raccontare lo stesso, per il mio scarno pubblico disinteressato che forse vuole solo deridermi un po’. Non mi sottraggo, perché io sono Francesco Montagnola, detto Angelo, classe 1924 e ho quasi 89 anni e una volta ero il più prestante del paese e anche se non bevo punch, ma solo rossi, ho subito due operazioni e mi reggo in piedi camminando lento, io non ho dimenticato come si piantano le patate in questo terreno difficile e quindi ho il diritto di raccontare di tutto quello che è successo quel giorno e del perché esiste una lapide dimenticata dopo il campetto di Bralello, dietro alla curva, con quei fiori finti e tristi che nessuno guarda, una fascia tricolore di plastica che cambiano ogni anno solo il 25 Aprile e che suscita l’interesse solo dei cani, che lì segnano il territorio. Sono passati tanti anni, eppure i ricordi più nitidi sono quelli legati alla mia gioventù. Adesso che sono vecchio e che non so quanti giorni mi restino ancora davanti, non riesco a ricordarmi dove sono stato ieri, ho rimosso la puzza di disinfettante da ospedale dell’anno scorso, ma sento ancora nitido il profumo della pancetta di quella sera del quarantacinque quando io e Giuan non avevamo proprio voglia di partire. Era troppo bello il cielo stellato di Bralello ed era troppo freddo. - quanto dura ancora ‘sta guerra Angelo? Io sono stufo di scappare e di dormire per terra. - Non lo so, Giuan. Ma quando sarà finita, io voglio andare a ballare. - Dobbiamo andare via adesso, lo sai che stare qua in paese è pericoloso. - Lo so, lo so, ma io sono stanco e il bosco lo conosco come le mie tasche. Andiamo più tardi stiamo qua ancora un po’. Intanto arriva Giovanna. Lo sa che sono qui ma le ho detto di non venire, ché se sanno dove sono poi ci fanno la spia. Ma lei no, viene sempre a portarmi qualcosa. Fa finta di andare a portare qualcosa al cane e arriva puntuale, perché non sa mai quando mi rivede ancora. Ha 17 anni ed è la più bella del paese e balla meglio di tutti: balla il tango con una mela in testa e non la fa cadere neanche quando gira. Del resto, io sono il più bravo a condurre perché lo so come si abbracciano le donne: non si chinano mai le spalle su di loro, ma si rimane dritti e si abbraccia con il petto e le braccia. - Giovanna, te l’ho detto che qua non ci devi venire. - Non mi ha visto nessuno e ho un po’ di pancetta e di pane. - Sì ma chi è che dà al cane la pancetta? Anzi, ai cani non dà niente nessuno. Non ce n’è neanche per i cristiani. - Beh ma per due partigiani qualcosa sì… - Senti Giovanna, noi partiamo ma tu che resti qui, non devi farti vedere da nessuno perché se ti fanno la spia, lo sai cosa ti tocca, non ci siamo mica sempre a difendervi. Io faccio lo spavaldo per mettermi in mostra, ma lo so cosa vuol dire avere paura. Perché io ho paura di morire. Non ho paura di soffrire, dormo per terra e ho sempre freddo, mangio quando capita, ma voglio vivere e vedere cosa succede di me. Voglio costruire una casa e la guerra non mi piace, mi fa perdere tempo. E poi io sono di poche parole ma lo so cos’è l’amore e lei è proprio la più bella di tutte. Ma stasera è una serata strana, io non sono tranquillo però non ho voglia di andare via. Lo so che non posso restare qui, ma è come se tutto fosse fatto apposta per me adesso. E questo pane ha un odore di mani laboriose e amorevoli e di stanchezza… di casa, insomma. Nel silenzio della notte, mi estraneo un po’. Penso a chi ha voluto questa guerra e a perché ho dovuto uccidere qualcuno. Il verde scuro di questo monte davanti a casa mia non sembra più lo stesso da quando ho visto gli occhi di quell’uomo morire davanti a me. E l’inverno e la neve bianca e immutata non mi hanno aiutato a dimenticare il dolore di sapere che per ogni morto c’è qualcuno a casa che piange e che almeno una lo avrà fatto per causa mia. E nonostante tutto non riesco a sentire il peso della colpa perché devo vedere il mio futuro e non posso fermarmi. Intanto è tardi, anzi è presto perché è quasi mattina. Siamo distesi su questa paglia che sa di animali e sudore, ma non abbiamo voglia di andare. Mi appisolo… - Angelo cosa sono questi spari, Angelo, vieni via, vieni via, scappiamo presto!!!! Cos’è stato Giuan cos’è stato… cosa facciamo? Scappiamo o ci nascondiamo, Giovanna, vado o resto, cosa faccio? Se scappo ci vedono e mi prendono, se resto mi prendono lo stesso. Vorrei dire ma non mi esce una parola. Non riesco a parlare, non riesco a fare niente. Sono immobile. - Andate per il bosco, vai scappa, vai da Pro del Serro fai il giro lungo e arrivi al Colletta che lassù non ci arrivano mai. - Dai Angelo dai andiamo… scappiamo. Sì scappiamo… Andiamo… Io sono il bosco, nessuno lo conosce meglio di me, nessuno trova i funghi nei posti che conosco io. E le mie gambe sono giovani, non finisce tutto qui perché io scappo più veloce del fulmine. I pini e gli abeti mi guardano immobili e mi proteggono e la rovere vecchia è sempre lì, ché se non muore lei, non muoio neanch’io. In un attimo sono a Eibarele corro come un cinghiale braccato sul Pianon, arrivo sul Taieso e via su verso il Colletta, non sento niente, non sento nessun rumore solo l’aurora e poi l’alba e neanche la stanchezza sento, non sento la corsa. Non ho tempo di ascoltare il mio respiro affannoso, la mia gamba è la mia alleata e questa montagna è la mia unica amica perché mi conosce, mi ha visto nascere e non mi tradirà. Mi nasconderà perché così dev’essere e io ho fiducia in lei, non la lascerò mai. Per favore montagna, per favore mia strada, mio prato, mio posto aiutatemi! E intanto corro e non mi fermo più. Intanto ho perso Giuan. Giuan amico dove sei che non ho tempo di cercarti. Forse sono in salvo ma non posso tornare indietro. Rallento ma non troppo e in un attimo sono al Colletta. I fiori anche adesso che è presto non mancano mai e il freddo pungente mi fa pensare che solo noi che ci siamo nati, sappiamo come vivere qui. - Angelo? - è solo un sussurro. Resto guardingo, ho sognato? Sono confuso. - Angelo?… È la voce di Giuan. È nascosto dietro a un pino. Giuan sei tu, amico mio. Finalmente mi accorgo che sono stanco, che ho graffi e sangue rappreso sulla faccia, sono state le carezze dei rami degli alberi che mi hanno protetto mentre correvo, ho le braghe bagnate, forse mi sono pisciato addosso o forse è stata solo la rugiada del bosco. - Angelo! Era Pietro, Angelo, Pietro Daglia, gli hanno sparato, è morto, Angelo, è morto mentre scappava verso Brallo, Angelo. È morto Pietro. L’ho visto io, Angelo, è caduto sul prato, è inciampato gli hanno sparato sulle gambe, Angelo… e poi alla schiena. Correva, Angelo… era Pietro… Mi guarda Giuan, con gli occhi sbarrati, annaspa ansimando per la corsa e forse per l’emozione, come aspettandosi che io dica qualcosa, ripete di continuo il mio nome, piange e chiede silenzioso pietà o comprensione o solo un po’ di fraterno affetto, ma io non dico niente perché non ho niente da dire. Ho un bruciore in gola che non scende, do la colpa all’affanno della corsa, ma so che non è per quello. È che mi viene da piangere, ma non so se sia per Pietro poveretto. È che adesso l’unico pensiero che riesco a formulare è che un giorno riprenderò a rifare il mio orto, a piantare le mie patate e voglio solo che tutto finisca e che tutto cominci, ma Pietro?… lo conoscevo. Non ballava tanto bene, ma sapeva raccontare le barzellette meglio di tutti. Era mio amico? Non lo so. E allora perché provo tutto questo? Ma in fondo cosa provo? Provo che io sono vivo. Ecco cosa provo, sono vivo e adesso sono sicuro che questa guerra bastarda finirà e che io ci sarò ancora per allora. Ecco sì, voglio esserci e ci sarò. Sono al quarto rosso e la serata è passata qui da Rino. Del mio pubblico strafottente, è rimasto solo un vecchietto paonazzo con l’apparecchio acustico e il figlio di Rino che va e viene dalla sala ristorante dove c’è qualche sparuto cliente. Non so se mi abbia ascoltato, ma in fondo cosa importa? Mio nipote è andato in discoteca giù in città, il paese è deserto. Non si sente che il vento che da sempre accarezza gli aghi dei pini e porta l’odore della cenere delle stufe e il profumo di pino. Non sono mai riuscito a vivere a Milano, neanche nei tempi d’oro in cui tutti costruivano tutto. Non sono mai riuscito a rimanere lontano dai miei posti, dalla mia montagna. Non mi interessa più niente della targa di “Combattente per la Libertà” che rimane immobile appesa al muro del salotto di casa mia. Ho avuto tutto dalla vita: figli, nipoti, bisnipoti, salute, gioia, dolore e posso anche morire, ma nonostante tutto, sono sicuro che Giovanna tra poco verrà ancora a cercarmi, perché anche se ha ottantacinque anni e un’asma che le toglie il respiro, è sempre lei la più bella del paese e io sono sempre il più prestante. 09 - Monica Garbelli – “Vita da lupi” Era inverno inoltrato quando decisi di lasciare il branco. Ho vissuto in quel gruppo da sempre, da quando sono nato. Non che non mi trovassi bene a convivere con quelli, ci mancherebbe, ormai eravamo abituati. C'eravamo organizzati bene, raramente si era dovuti ricorrere a manifestazioni aggressive di predominio al fine di mantenere l'ordine gerarchico prestabilito, e si condivideva tutto; quel che cacciavamo veniva suddiviso in comunanza, ci si proteggeva vicendevolmente e si collaborava per accudire e crescere i più piccoli. Le cose erano sempre andate così, almeno fino a poco tempo fa, perché nelle ultime stagioni in realtà la situazione era cambiata. Per dirla tutta, si andavano intensificando gli attacchi dei due capibranco a danno dei sottoposti, e a volte erano attacchi assolutamente vili, la qual cosa mi infastidiva, oltre che inquietarmi. Così sempre più spesso era necessario sostituire un sottomesso, procurando uno sfoltimento del gruppo davvero impressionante. E benché la serenità non fosse mai venuta meno del tutto, da qualche tempo le tensioni si erano fatte più frequenti, e io stentavo a digerire certi autoritarismi. Che poi non fu neanche una questione di alfa o omega, a spingermi lontano dal branco, quanto il fatto che in quella zona era diventato sempre più difficile vivere. A quelle altitudini, gente non se ne vedeva più. Tanti avevano preferito la città, giacché la pastorizia e l'allevamento del bestiame non rendevano abbastanza, e i pochi anziani rimasti non avevano certo la forza di occuparsi di greggi e armenti. Lo spopolamento del territorio aveva avuto ripercussioni nefaste anche per noi, che fummo costretti a salutare le proficue battute con le quali, nei periodi di ristrettezze, ci garantivamo quantomeno la sopravvivenza. Non che fosse una pratica usuale rastrellare allevamenti, la consideravamo una vigliaccheria evitabile, tuttavia quando la fame ci faceva sragionare capitava anche di attaccare animali in cattività. Certamente catturare capi selvatici ci procurava più emozione, nonostante richiedesse maggior impegno ed esperienza, e poi la nostra bestialità ci conduce inevitabilmente alla ricerca di piaceri selvaggi, ma quando non si poteva fare a meno... Le prede scarseggiavano anche per via del bracconaggio dilagante, che muoveva i cacciatori fino alle zone impervie, alla ricerca di caprioli e cinghiali, che erano poi i nostri pezzi preferiti. C'erano addirittura tizi che servendosi di trappole costituite da due sassi piatti si cimentavano nella cattura di tordi e tordele. Cacciano di tutto, ormai. A dire il vero non ho mai capito questa smania che avete voi umani di cibarvi di animali improbabili, di cercare a ogni costo gusti esotici, mai provati. So di alcuni locali della zona che organizzano veri e propri baccanali quando riuscite a catturare un capriolo. Noi ci dobbiamo campare, con la carne selvatica, ma voi avete la fortuna di saper allevare animali da cortile e bestiame nelle stalle, eppure non smettete di cacciare. Io, ad esempio, antropofago non lo sono mai stato e neppure ho mai desiderato esserlo. Non ci penso proprio a mangiare carne umana, anche se ho sentito di alcuni di noi che lo hanno fatto, immagino più per difesa da un attacco vile, che per il desiderio di gustarvi. Ad ogni modo, era diventato sempre più difficile procacciarsi cibo. E va bene che siamo abituati a saltare i pasti, ché non necessitiamo pranzare quotidianamente, ma ultimamente era un vero e proprio terno al lotto racimolare qualcosa. Insomma, si respirava aria di crisi anche da quelle parti; perciò conclusi che era giunto il momento di migrare. Volevo cambiare, smettere la vita precaria, volevo avere una certa stabilità, e sapevo che solo unendomi all'uomo, anziché combatterlo, me la sarei garantita. In passato altri compagni lo avevano fatto. Approfittando del bisogno dei cacciatori di essere affiancati e in certi casi assistiti da animali forti e furbi, alcuni lupi si lasciano catturare poi addestrare e quindi allevare in cattività per accompagnare i padroni durante le battute. In altri casi diventano ottimi pastori, grazie alle straordinarie doti fisiche assicurano protezione alle greggi, e in cambio vivono: hanno sempre da mangiare e un riparo sicuro. Lasciare il branco per unirsi agli uomini è comunque una decisione che ti cambia la vita. A tal proposito, tempo fa mi raccontarono una storia che circola tra noi. Racconta di un lupo che stremato dalla fame e da un inverno che sembrava non finire mai, decise di fermarsi e di andare a stare con gli uomini, perché la cosa che gli importava era di restare vivo. Così si fece catturare e col passare del tempo dimenticò di essere stato un lupo. Un giorno di molti anni dopo, mentre accompagnava il suo padrone a caccia, si trovò a correre per raccogliere la preda e quando la raggiunse si accorse che la preda era il vecchio capobranco. Divenne muto per la vergogna e l'avvilimento, ma il vecchio lupo parlò e gli disse: “così io muoio felice perché ho vissuto tutta la mia vita da lupo, tu invece non appartieni più al mondo dei lupi ma nemmeno a quello degli uomini. La fame viene e scompare, ma la dignità, una volta persa, non torna mai più.” Sulle alture del Boglelio, gennaio è il mese più freddo dell'anno. Tira un vento forte e l'aria diventa pungente, pizzica sul muso. Di solito nevica anche tanto, le giornate sono corte e il buio comincia a scendere sulla terra molto presto. Un pomeriggio, dopo l'ennesima crudeltà intestina, appena il sole si nascose dietro la cima innevata, imboccai un sentiero che conduceva a valle, sul versante interno, diretto a nord: un'area a me nuova, che non avevo ancora praticato col branco, non essendosi mai reso necessario allontanarsi così tanto dai nostri territori. Scendendo di quota, la vegetazione muta vistosamente. Abeti, pini e faggi lasciano spazio a ontani e pioppi, e più in basso, dove sono frequenti i calanchi, a castagneti intervallati da boschi di roverelle. Qui tutto lasciava presagire si trattasse di un'area favorevole a perlustrazioni umane; lo confermavano strade battute sempre più frequenti, trazzere e sentieri ben tenuti. Il tempo trascorse senza avvistamenti. La luna nel frattempo era salita alta e il suo chiarore riverberato illuminò due seminativi e un pascolo, individuabili malgrado una coltre di neve coprisse il terreno. Intuii di essere prossimo a un centro abitato, ma di animali in giro neanche l'ombra. Appena intravidi alcune abitazioni, cercai un posto sicuro, ben riparato, che mi permettesse di tenere sotto controllo i movimenti della gente. Personaggi curiosi animavano le viuzze del paese. Erano tipi originali, abbastanza giovani ma con gestualità rozze e piuttosto bizzarre, basti pensare che si divertivano ad annusare il borotalco... E non era il buio notturno a trarmi in inganno! Questi non mi convincevano, non sembravano i tipi giusti con cui condividere le giornate, in più non possedevano neanche una pecora. Allora decisi di percorrere le pietraie scoscese che arginano lo Staffora, continuando la discesa a valle. Forse non avevo scelto il periodo migliore per intraprendere un percorso di questo tipo; non che mi spaventasse l'impervia dei territori, ma sulla neve lasciavo tracce evidenti. Tutto sommato non era un grosso problema per me, quello di essere visto, giacché miravo a unirmi all'uomo, però dovevo farmi individuare in modo saggio, evitando cioè che mi abbattessero. Lasciandomi catturare sarei diventato complice di un cacciatore e con lui e per lui avrei ucciso cinghiali, caprioli, lepri e probabilmente qualche lupo. Fu poco sopra il corso del torrente che vidi un borgo ben vivo, illuminato a giorno anche a notte fonda. Piccole lampadine colorate si rincorrevano lungo le stradine facendo sembrare quel paesino un presepe. Alle prime luci dell'alba alcuni uomini mossero verso i campi circostanti, chi per procurarsi la legna per scaldare le case, chi per accudire le bestie. Dopo poche ore si videro in giro anche le donne. Quelle che uscivano per strada erano coperte come mummie, per via del gelo, i bambini sembravano bambolotti impacchettati in mille vestiti, con le sciarpe fin sugli occhi. Un capannello di gente attendeva parlottante un camioncino carico di alimenti. Nei dintorni individuai pure un ovile, qualche pollaio e una piccola stalla seppur molto rudimentale. Fui sedotto dalla tranquillità che ammantava ogni movimento di quella gente e considerai opportuno stanziarmi in zona per trovare il giusto contatto umano. «Mamma, mamma, guarda, un lupo!» gridò la ragazzina. «Ma smettila, non dire sciocchezze» rispose la madre. «Ma sì, ti dico che c'è un lupo, è sul pendio proprio qui di fronte a noi! Me ne sono accorta perché ho sentito un ululato pazzesco: cominciava come il verso di un cane ma finiva che sembrava il grido di un matto.» Del tutto incredula, la mamma di Marta si precipitò fuori casa, corse verso il limitare del cortile, ma ormai il lupo era sparito. Marta però aveva avuto il tempo di scattargli un paio di foto col telefonino. L'immagine dell'animale in posizione plastica mentre puntava lo sguardo fiero verso la fotocamera, fece il giro del paese, suscitando curiosità mista a paura. Sembrava fissare la fanciulla negli occhi. Aveva il pelo fulvo e sul dorso una striscia, più marcata al garrese, beige con punte nere, gli occhi erano il colore dell'ambra. Solo Marta ebbe la fortuna di incontrare il lupo, quell'inverno, perché poi sparì. Alcuni vicini avevano avvistato delle impronte fuori dall'abitato, e qualcun altro si era trovato il gregge saccheggiato, ma dopo quell'apparizione nessuno lo vide più. Nei pressi dell'ovile sentii un odore che mi mandava nei matti. Adocchiai un agnellino già abbastanza cresciuto, gli ronzai intorno, con un breve e minaccioso inseguimento mi avvicinai. Quel poveretto era così spaventato che non riusciva neppure a muoversi. Io mi sono piazzato di fronte a lui e con un colpo di mandibola l'ho addentato mentre lo rovesciavo a terra con una zampata. Nell'afferrarlo mi sono come slogato la mascella, l'ho aperta talmente tanto che non mi sembrava vero. Avrei potuto divorarlo in un solo boccone, tanto ero affamato, invece ho preferito sbranarlo piano piano, cominciando con lo squarciargli la pancia, poi le cosce, e lasciai lì uno straccio di lana e sangue. Nell'istante in cui venni fotografato, avevo deciso di non voler perdere la mia dignità. 10 - Maria Natalia Iiriti – “Una storia tra mare e montagna” Bellina era bellina, ma aveva un gran difetto: quando non otteneva qualcosa si metteva a urlare. Un urlo acuto e prolungato, accompagnato da un forsennato tip tap. La prima volta tutta la spiaggia si fermò. Chi nuotava smise di nuotare, chi mangiava smise di masticare, chi leggeva perse il filo. Bellina era bellina. Lo dicevano tutti: tutti meno suo fratello Giovanni, che non ne poteva più di sua sorella Caterina, soprannominata Urlokitty per la sua passione per il dolce gattino. Tutta la spiaggia la chiamava così, ma sottovoce, per non farla urlare di più. Nello stesso momento in cui Urlokitty divideva le sue vacanze fra bagni e urli, Ernesto era in città davanti al suo computer, senza riuscire a scrivere niente di interessante. A differenza di Urlokitty, Ernesto non si arrabbiava e non urlava mai ma, quello che gli stava capitando, era davvero troppo. Un anno senza scrivere nemmeno un rigo! Gli sembrava di vivere l’incantesimo di una fiabaLa sua casa editrice chiamava un giorno sì e l’altro pure, i giornalisti gli chiedevano per email anticipazioni sul nuovo libro. Senza considerare i lettori di Ernesto, tra i più difficili del pianeta: i bambini. Una mattina, dopo aver sorseggiato il settimo caffè, Ernesto si guardò allo specchio e si disse che non poteva continuare così. Poi diede un’occhiata al suo pappagallo Umberto, che gli disse che non poteva continuare così. Allora si alzò dalla sua scrivania, riempì una valigia con l’essenziale, infilò il computer portatile nella borsa e si chiuse la porta alle spalle. Sul pianerottolo si mise a contare se tutto era a posto. “Posso andare” si disse Ernesto soddisfatto. “E iooooo?”. Ernesto fece un salto che per poco non ruzzolava dalle scale, lui, la sua valigia e il suo computer. Quando si riprese dallo spavento, aprì la porta e, inciampando nei mobili per via del buio, si diresse verso il pappagallo, che borbottava un discorso,che tradotto in linguaggio umano, suonava più o meno così: “Tu, caro mio, hai bisogno di una vacanza”. Ernesto pensava che il suo pappagallo non avesse tutti i torti. Mise in moto la sua auto e si avviò per raggiungere la casa in montagna. In quello stesso istante il papà di Urlokitty propose una bella gita in montagna, con la famiglia e gli amici. Tutti si trovarono d’accordo di partire l’indomani, tutti tranne Urlokitty, che lanciò un urlo verso il mare, spaventando tutti i pesci. Intanto Ernesto, dall’altra parte della storia, si addentrava fra i boschi. Si sentiva un po’ Cappuccetto rosso, un po’ Pollicino, pronto a incontrare il lupo affamato e l’orco cattivo. Ogni tanto si fermava per respirare l’aria soffice della montagna e per ammirare lo spettacolo straordinario che aveva intorno. Il pappagallo che sonnecchiava sul sedile posteriore borbottò: “Ma quando si mangia?”. Ernesto guardò l’orologio: le quattro del pomeriggio! Accelerò per arrivare nella casa di montagna il prima possibile. In quello stesso momento Urlokitty si era convinta che una giornata in montagna non era poi una cattiva idea. E si addormentò senza fare tante storie. Ernesto invece non dormì per niente. Rimase sveglio ad ascoltare la notte. Voleva saziarsi dei profumi, dell’aria e dei misteri della montagna. Voleva immaginarne la vita, dalla zolla di terra ai nidi degli uccellini, dalla punta dei rami ai ricci delle castagne. Per lui la montagna era come una signora che tirava dalla tasca sempre storie deliziose, come i budini al cioccolato che mangiava da bambino. Nello stesso momento in cui, all’alba, Ernesto decise che era ora di riposare un po’, Umberto uscì per fare il suo saluto alla montagna, Urlokitty, la sua famiglia e gli amici partivano per la gita in montagna. La bambina non urlò per parecchie ore. Tutti pensavano la stessa cosa: vuoi vedere che la montagna riusciva a compiere il miracolo e a calmare gli scatti di Urlokitty? Ma qualcosa, nel ragionamento, andò storto. Dopo un urlo lungo sette minuti e quaranta secondi Urlokitty si allontanò dai suoi amici e si sedette su un sasso. ”Ora me ne torno al mare!”Siccome nessuno andava a pregarla di tornare con gli altri, Urlokitty si alzò dal sasso e si esibì in una complicata combinazione di urli e balletti che ipnotizzò piante fossili e animali, tra cui il pappagallo Umberto che, volando volando, era giunto nei pressi. Ernesto, che ancora dormiva, aprì gli occhi. “Ma nemmeno in montagna si può stare in pace?” disse lo scrittore. Giovanni invocò un incantesimo per fare sparire la sorella nei boschi. Come per magia Urlokitty si mise a camminare: era arrivato il momento di ispezionare la montagna. Strada facendo incontrò il pappagallo Umberto e rimase incantata dai colori del suo piumaggio. La bambina lo seguì come ipnotizzata. Urlokitty era una camminatrice instancabile e non si rese conto di quanto si fosse allontanata per seguire il pappagallino. Cammina cammina avvistò una casa. “Vuoi vedere che è la casa della strega cattiva di Hansel e Gretel?” si disse Urlokitty. Ma si lasciò guidare dal pappagallo. La porta di casa era aperta e Ernesto stava prendendo il caffè. “Guarda chi ti ho portato?” disse Umberto. Quando lo scrittore vide la ragazzina pensò che si fosse persa. Nello stesso momento in cui Urlokitty faceva la conoscenza di Ernesto e accettava un panino con la marmellata, i genitori e gli amici si misero in marcia sulle tracce della bambina. Giovanni camminava più veloce degli altri perché si sentiva in colpa: non poteva credere che il suo desiderio di fosse trasformato in incantesimo. Dentro di sé pensava: “Per favore, urla un po’, così potremo orientarci”. Nelle due ore seguenti Urlokitty fece la conoscenza di Ernesto. “Chi sei?” le chiese? “Urlokitty… ma mi chiamo Caterina”. La bambina si guardò intorno. Ammirò il camino, il tavolo e le sedie di legno, il divano con il plaid all’uncinetto. Nella libreria riconobbe i libri del suo autore preferito e sorrise. Poi si mise a chiacchierare con il pappagallo. Ernesto, intanto, cercava di scrivere qualcosa. Urlokitty fu attirata dal ticchettio dei tasti. “Sei uno scrittore?” chiese Urlokitty. E Ernesto, con la faccia da “aiuto, mi hanno appena scoperto”, rispose di sì. “Scrivo storie per bambini. A te piace leggere?”chiese lo scrittore. “Sì certo, che domande” rispose offesa Urlokitty. “Mi piacciono molto le storie di Umberto Manubrio” aggiunse Urlokitty. “Tu che sei uno scrittore lo conosci?”. Ernesto fece appena in tempo a chiudere il becco del pappagallo, che stava per raccontare quello che doveva rimanere segreto. Che lui, Ernesto, era Umberto Manubrio. “Lo conosco di vista” rispose Ernesto. “Allora quando lo vedi, puoi dirgli di scrivere un’altra storia? E’ un anno che non scrive più niente”. “Forse ha perso l’ispirazione” rispose Ernesto.“E cos’è l’ispirazione? chiese Urlokitty. “E’ quel folletto che nasce nella testa dello scrittore e lo tormenta dicendo scrivimiscrivimi”.“E dove si trova l’ispirazione?” chiese ancora la bambina.“Difficile dirlo: sotto la doccia, davanti a un piatto di spaghetti, in riva al mare. O in mezzo ai boschi” rispose Ernesto. “Per questo è venuto qui” aggiunse Umberto.“Scrivimi una storia” disse Urlokitty. “Vediamo se sei più bravo del bravissimo Umberto Manubrio”. Ernesto sembrò meditare sulla proposta, mentre il pappagallo lo incitava: “Accetta… accetta, sciocco!”Urlokitty intanto aveva preso posto accanto allo scrittore. “Allora la scriviamo insieme. Pronto? Il gigante Bubbone e il gatto furbacchione. No… Furbacchione con la lettera maiuscola, perché è il cognome del gatto. Ti piace come titolo?”. Nel tempo che occorse alla compagnia per ritrovare la piccola fuggitiva, Urlokitty e Ernesto scrissero una storia. Dopo il punto finale, la bambina urlò: la sentirono anche gli amici che la stavano cercando e capirono che quello era un urlo diverso, non un urlo di capricci ma un urlo di gioia. La compagnia arrivò in casa di Ernesto appena dopo il tramonto. I genitori e gli amici di Urlokitty fecero la conoscenza dello scrittore, che li ospitò per la notte, dopo una cena improvvisata. L’indomani si salutarono e per tutto il tempo del viaggio di ritorno Urlokitty rimase in silenzio pensando che Ernesto non poteva essere che Umberto Manubrio, il suo scrittore preferito. Le vacanze finirono e Urlokitty tornò in città. Anche se aveva smesso di urlare, continuavano a chiamarla Urlokitty ma lei non si offendeva più. Qualche mese dopo il postino bussò a casa di Urlokitty. Era suo il nome sulla busta e accanto c’era quello del fratello. Dentro due libri, uguali dal titolo <<Urlokitty, il gigante Bubbone e il gatto Furbacchione>>.All’interno una dedica: “Alla mia amica Urlokitty che sa sciogliere gli incantesimi, a Giovanni suo fratello, per averle dato questo simpatico nomignolo. Alla montagna che non delude mai. Dimenticavo… a Umberto, quello vero”. 11 - Fiorenza Lanfranchi – “Monte sette fratelli” Nella Sardegna sud-orientale, il territorio denominato Sàrrabus è caratterizzato dalla presenza delle suggestive guglie di granito del massiccio, che la fantasia popolare ha battezzato i Sette Fratelli. Le cime maestose sovrastano un’immensa zona boscosa di lecci, castagni, olivastri e corbezzoli, dichiarata Parco Nazionale, ricca di sorgenti, cascate, dirupi, sculture naturali nella roccia. L’ambiente naturale, di grande fascino, è abitato da aquile reali, cervi, cinghiali e da un anfibio endemico dell’area, il geotritone sardo, detto volgarmente cani de acqua (cane d’acqua). Il paesaggio già spettacolare di per sé permette, per la sua posizione elevata, di spaziare, nelle giornate limpide, a ovest fino al monte Urpinu e a est fino alla fascia costiera, di ammirare un panorama di pietra, mare e macchia mediterranea. Un patrimonio di così rare bellezze, veri tesori naturali, è fonte ispiratrice di leggende sull’origine dei luoghi, sulla loro conformazione. La tradizione orale tramanda, infatti, due versioni antiche sulla natura del cuore del Sàrrabus, il massiccio di pietra dalle sette imponenti cime. Per alcuni il gruppo montuoso nacque in una notte magica di innumerevoli anni fa, perché sulla Terra ci fosse un punto di riferimento importante di orientamento come le sette stelle dell’Orsa in cielo. Per altri le sette montagne racchiudono sette fratelli, autori di terribili delitti e pietrificati, per punizione, dentro un sarcofago di granito. Per mantenere sempre viva la memoria delle leggende popolari, che possono ancora affascinare e divertire l’infanzia, le trascrivo come sono state narrate dagli anziani del posto. I SETTE FRATELLI DELLE STELLE Moltissimi anni fa, i boschi nel Sàrrabus erano così fitti e intricati che se qualcuno si allontanava troppo dall’abitato, spesso smarriva la strada e non faceva più ritorno. Il saggio della comunità raccomandava di segnare il percorso con un sasso, un ramo spezzato, qualcosa che indicasse la direzione giusta. Capitava però che i segni venissero cancellati dal passaggio di un animale o dal vento e così gli sforzi si rivelavano inutili. «Ci vorrebbero dei riferimenti fissi, inconfondibili come le stelle dell’Orsa» diceva la gente, ma non sapeva come fare per risolvere il problema. Una notte una mano sconosciuta e invisibile creò sette magnifici monti: erano i sette fratelli sulla Terra delle stelle dell’Orsa in cielo. Il mattino dopo, la visione di quel fenomeno, che non era fugace apparizione, provocata da nubi o da nebbie, ma una solida e tangibile composizione granitica, fissa e stabile, confortò tutti e nessuno ebbe più paura di smarrirsi. I SETTE MALVAGI Tanto tempo fa sette malvagi e prepotenti fratelli terrorizzavano gli abitanti dei villaggi del Sàrrabus. Derubavano i pastori, aggredivano i viandanti, sottraevano ai contadini i loro raccolti. Erano pronti ad uccidere se non ottenevano ciò che pretendevano. Per questo tutti avevano paura di loro e nessuno osava più lasciare il proprio paese né per lavoro né per divertirsi. «Ci vorrebbe qualcosa che fermi questi malvagi, che metta fine ai loro misfatti, perché così non si può andare avanti» si lamentava la gente. E pregava che qualcuno intervenisse ad allontanare il pericolo, a riportare giustizia e serenità. Accadde allora un fatto sorprendente: una notte di luna piena, una mano sconosciuta ed invisibile bloccò i sette fratelli malvagi, mentre tornavano al loro covo dopo una rapina. Li paralizzò e li trasformò in mastodontici massi di granito. Il mattino dopo, nel vedere i sette monti giganteschi, i nativi del luogo si stupirono, ma non sapevano se aver fiducia in ciò che appariva ai loro occhi o se temere l’arrivo di qualche altra disgrazia. Rimasero guardinghi per un po’, ma quando s’accorsero che i malvagi erano spariti e che i monti offrivano protezione, si sentirono liberati da tante paure. In seguito si diffuse il detto: «Meglio essere dominati da sette magnifici monti che da sette malvagi». 12 - Novella Limite – “Le verità del vento” Era consapevole dell’importanza di quel momento, ne sentiva l’ebbrezza e la caducità. Osservando in arcano silenzio ciò che le stava di fronte, un delicato susseguirsi di linee e di colori che la natura e la mano dell’uomo avevano creato nel tempo, in simbiosi, modellando e dipingendo quelle cime, quelle valli e quei pendii, era sofferma a riflettere su quanto fosse strano che un insieme di roccia, terra, alberi e cielo potesse regalarle tanto piacere. Da alcuni anni si recava in quel luogo, spinta, all’inizio, dalla banale necessità di salutari passeggiate distanti dai miasmi delle strade trafficate, ma guidata in seguito da un impulso che, a poco a poco, era andato definendosi come un’esigenza del corpo e dello spirito, al punto tale che il valore del Belvedere ormai trascendeva quello di un semplice panorama collinare e il breve viaggio che ve la conduceva aveva finito per tramutarsi in qualcosa di ben più importante di una ordinaria scampagnata, perché la guidava verso un luogo dell’anima e il tragitto che compiva per giungervi assumeva il ruolo di un pellegrinaggio interiore alla ricerca di esso, in cui poter trovare il vero silenzio pacificatore, sedare o urlare le proprie inquietudini, assecondare la malinconia di certi giorni o rinnovare l’entusiasmo per la vita. Aveva viaggiato, visitato celebri mete turistiche italiane ed estere, dalle Dolomiti alla lunare natura di certe isole siciliane, dalle Cliffs of Moher ai tramonti sul Nilo, ma si riteneva pronta ad ammettere, non senza imbarazzo, che, fra i molti paesaggi ammirati, di fronte ai quali si era fermata in estatico rapimento, quello che avrebbe scelto ed eletto fra tutti a personale simbolo di bellezza sarebbe sempre rimasto il caro, semplice, ma armonicamente perfetto Belvedere di quella piccola altura. Non vi si recava assiduamente, in parte perché le contingenze e gli impegni della vita quotidiana spesso ne erano d’impedimento, in parte per il timore che la continuità avrebbe potuto finire col ridurne la magia e l’incanto, cosa che fino ad allora, del resto, non aveva ancora rischiato di accadere, anzi, le bastava mancare due settimane all’appuntamento per poter ritrovare la stessa meraviglia provata il primo giorno e, durante ogni nuovo incontro, essere in grado di carpire altri particolari del paesaggio, che, sommandosi a quelli già noti e apprezzati, andavano ad arricchire e a colorare l’immagine delineatasi nei suoi pensieri. Amava tutto di quel luogo: la ruvida terra arata da sbriciolare coi propri passi, l’erba serica e delicata che rivestiva i pendii di un manto vellutato, da accarezzare con lo sguardo, gli arbusti selvatici piegati dalla brezza che mai dimenticavano di porgerle un saluto ondeggiante, il silenzio imperante che le permetteva di ascoltare il sibilo del vento, ma anche i taciti camini delle case poste lungo la strada, fumosi segni di presenza umana durante la stagione fredda o le torri di castelli emergenti qua e là dalle cime con la stessa naturalezza di alberi millenari, capaci di evocare reminescenze del passato. Eppure, nonostante apprezzasse ogni singolo elemento di quell’ambiente, dalla fragile foglia all’eterno e imperturbabile sasso, dal cielo terso alla più singolare nube cumuliforme, dal misero arboscello alle varietà di faggi, magnolie, querce e olmi dei giardini circostanti, pur dilettandosi nel far vagare ovunque lo sguardo, tornava inevitabilmente a posare gli occhi su un punto ben preciso di quel mirabile quadro, il punto in cui, nella catena di cime che alla sua vista appariva infinita, si apriva con noncuranza un angolo di orizzonte, lasciando intuire, più che realmente vedere, uno squarcio di pianura, un luogo quasi sempre velato di foschia, compreso fra i versanti di due montagne gemelle dietro cui il sole si ostinava a tramontare. Senza che ne avesse mai compreso a fondo la ragione, quel preciso angolo di panorama la attraeva con un ipnotico, singolare potere, imponendole il dolce tormento di tornare a voltarsi più e più volte a contemplarlo. Era forse la nebbia da cui appariva quasi sempre avvolto in lontananza a renderlo così affascinante, conferendogli una natura metafisica? L’impossibilità di scorgere con esattezza ciò che nascondeva? O forse perché, nel continuo susseguirsi di sommità, risultava essere l’unico varco verso la pianura? Si era interrogata più volte sulla natura del fascino e dell’interesse che quella visione esercitava su di lei e riteneva che, probabilmente, comprendendone la ragione, avrebbe capito anche una parte di se stessa. Era l’ultima settimana che trascorreva a casa prima di partire per motivi di lavoro: avrebbe soggiornato in Gran Bretagna per un periodo che si prospettava molto più duraturo del solito, in seguito al conferimento di un sospirato incarico finalmente giunto, ma, contro le sue previsioni, non scopriva dentro di sé l’entusiasmo atteso. Da alcuni giorni, riflessioni spiacevoli la agitavano e quel pomeriggio aveva intenzione di trovare un po’ di pace ai dubbi che non smettevano di assalirla, sapendo che solo in un modo avrebbe calmato la furia dei propri pensieri. Mentre assecondava i tornanti che, uno dopo l’altro si susseguivano in salita, guidando con la sicurezza derivante dalla conoscenza della strada, lasciava che i primi piacevoli scorci del seducente paesaggio di fine settembre trasmettessero al suo spirito una benefica influenza e osservando delle rondini in volo le sovvenne un pomeriggio particolarmente fortunato in cui, camminando verso il punto panoramico prediletto, aveva avvertito un energico e fulmineo frusciare d’ali per poi accorgersi con entusiasmo di trovarsi sulla traiettoria di un vasto stormo dal quale era stata dolcemente travolta. Le rondini avevano risalito il versante su cui si trovava a camminare, dirigendosi proprio verso l’angolo di orizzonte che più la affascinava, dileguandosi infine in una confusa scia nera fra la terra e il cielo, facendo sì che lei, dopo quell’episodio, portasse a lungo dentro di sé il gioioso vigore del loro volo e l’immagine di esso. Raggiunta in pochi istanti la propria meta panoramica, scese dall’automobile, lasciando vagare lo sguardo attorno a sé, ripetendosi quanto fosse piacevole trascorrere il tempo così, consumando le ore alla ricerca di una bellezza che in quel luogo non faticava a scorgere. Poi, diresse lo sguardo verso l’angolo di orizzonte che sembrava chiamarla, invitarla, attendere i suoi quesiti. Il silenzio le permise di cogliere la voce del vento che tirava gagliardo, ma clemente, essendo ancora settembre, e si mise in attesa di capire cosa le stessero comunicando quei sussurri incostantemente sibilati all’orecchio. Una paura improvvisa la pervase, assumendo la forma di un fremito che, a vedersi, sarebbe parso di freddo a chiunque non conoscesse il suo trepidante stato d’animo: era alla vigilia di un importante cambiamento di vita ed ora, più che mai, si accorgeva di esserne spaventata, avvertendo l’incertezza e l’esitazione che derivavano da quel momento. “Cosa devo fare?” domandò silenziosamente, fissando l’angolo di orizzonte, spicchio di pianura annegato in un lago di foschia azzurrina, attendendo che la risposta desiderata sorgesse dentro di sé, che le sillabe del vento le suggerissero un inizio di verità. Ora che si trovava sul punto di partire e che i suoi obiettivi prendevano corpo, non si sentiva più certa dei propri desideri e la invadeva un’intollerabile mestizia dovuta a una premonizione di nostalgia, al presentimento di possibili ostacoli sul suo cammino. D’altro canto, avvertiva che, rinunciando alla partenza, il rimpianto per quella mancata occasione non le avrebbe lasciato tregua e il desiderio di vivere la vita il più intensamente possibile sarebbe presto rinato. Sulla scia di queste riflessioni, i pensieri presero una nuova direzione e l’idea dell’inesorabile trascorrere degli anni si palesò improvvisamente insieme alle recondite paure ad essa legate: paura del futuro e dell’ignoto, della vecchiaia, della malattia, della morte. Camminando lentamente, senza perdere mai di vista quella speciale parte di paesaggio dalla quale si sentiva sedotta, percepiva il conflitto fra l’orrore dell’angoscia e la gioia della bellezza in lotta per prevalere dentro di lei, finché, con sollievo, quella battaglia si fece meno cruenta e l’armonia dell’ambiente circostante si manifestò ancora una volta capace di influenzare positivamente il suo stato d’animo. Il sentimento della bellezza prevalse, così la mente e il corpo poterono distendersi in un piacevole riposo. Gli elementi naturali la conquistarono ancora una volta, facendola sentire parte di un sereno ordine: le nuvole e i boschi, il vento e la terra, la strada e i suoi passi…tutto, intorno, si combinava in un equilibrio perfetto e necessario. Per alcune ore camminò lungo il crinale, accorgendosi infine che il sole si trovava già in procinto di lambire l’ultima cima dietro cui sarebbe andato a scomparire. Era incredibile come ora il tempo fluisse senza far male, permettendo di apprezzare lo stato delle cose ed era straordinaria la forza che quel Belvedere esercitava su di lei, mitigando la sua inquietudine, cancellando le ombre dell’angoscia. Risalì in macchina accompagnata ancora dai propri dubbi, ma senza più fremiti di paura, rinnovando la consapevolezza che, ovunque, in qualsiasi posto, vicino o distante, in qualunque circostanza, felice o dolorosa, quei momenti sarebbero rimasti sempre con lei, custoditi nella protetta dimora del proprio animo, insieme all’immagine di quella montagna, luogo sacro e intangibile a cui poter tornare quando le prove della vita avrebbero richiesto istanti di abbandono e di pace. 13 - Giovanni Nicora – “Al pascolo” A volte d' estate andavo con mio nonno paterno a portare le vacche al pascolo, ma dopo la morte un po' prematura dell'altro mio nonno l' autunno precedente, i miei genitori mi mandarono quell'estate ad aiutare mia nonna e mio zio. Avevo otto anni. Quando le vacche non servivano per trainare il baraccone del fieno o la lesa del letame mi mandavano a farle pascolare sul Colletta. Ne avevano quattro. Prima i prati del Colletta venivano sfalciati, cresceva un erbetta lunga non più di quindici centimetri mista al trifoglino selvatico e vi erano altre erbette che a luglio andavano in infiorescenza ed era uno spettacolo vedere questi prati prati prima dello sfalcio, ma da quando era cominciata l' emigrazione verso le città e i terreni coltivati a disposizione di ciascuno rimasto erano aumentati, i pascoli montani si lasciavano mangiare dalle mucche. Quando uscivamo dalla stalla attraversavamo il paese, poi bisognava fare un pezzo di provinciale che proprio in quegli anni era stata asfaltata, dopo di che si saliva sul sentiero ripidissimo della Bonifica poi un altro pezzo di strada all'ombra dei faggi ed infine raggiunti i pascoli le lasciavo. Queste di solito erano affamate e una volta raggiunta l'erba non perdevano tempo e la trangugiavano con ingordigia lasciando a me la possibilità di andare per funghi o per giocare: se venivano i miei amici magari portavamo dei cartoni, li mettevamo sotto il sedere e a pazza velocità scendevamo per il più ripido pendio che c' era in zona; più di una volta tornammo con i pantaloncini strappati e ogni volta dovevamo sentirci i rimproveri delle nostre madri. Capitò una volta, era da solo, che fatta tutta la salita e giunti in prossimità dei prati, siccome per entrarvici occorreva deviare dalla provinciale in un sentiero ripido e obliquo posto nell'alta scarpata della strada, che la terza vacca quando fu sull'argine dei prati inciampò su uno scalino, l' altro piede scivolo', cadde sul fianco e roteando arrivò sull'asfalto; era una bella vacca, una nostranina color marroncino chiaro di tre o quattro anni, non ricordo il nome ma tutte l' avevano. So che rimasi impietrito a vedere la bestia che una volta ripresasi dalla botta e rialzatasi lentamente, aveva un corno spezzato alla base e dal buco che era rimasto usciva una bella striscia di sangue che pian piano percorrendo il collo gocciolando cadeva a terra. Quando mi ripresi dallo spavento cercai di riunire le idee confuse e senza perdere troppo tempo recuperai le altre che erano già salite non senza aver tribolato un po' nel convincerle con le buone o con le cattive (il bastone) che bisognava tornare a casa senza mangiare e riusci a portarle a casa. Per fortuna nel frattempo il sangue aveva quasi finito di uscire e non occorse neanche chiamare il veterinario. Avevo raccolto anche il corno rotto che poteva essere usato come contenitore per la cote messo alla cintura con un gancio e riempito d' acqua. Purtroppo a quell'epoca una vacca senza corna non valeva molto perché per usarla per trainare queste servivano per metterci le songre che insieme al giogo costituivano il complesso trainante e frenante. A casa non mi rimproverarono più di tanto (non era colpa mia) ma non mi mandarono più da solo e l' anno successivo il problema non sussistette più perché durante l' inverno avevano deciso di venderle tutte: Ma quel ricordo è indelebile nella mia memoria. 14 - Maria Grazia Palestra – “Ricordi della Valmalenco” Sono vecchia e come tutti i vecchi vivo in compagnia dei ricordi. Dì tanti ricordi. Dì tanti ricordi diversi. Dì ricordi lieti che, riscaldando il cuore, lo fanno gioire, e dì ricordi tristi, talvolta addirittura dolorosi, che riaprono antiche e mai sopite ferite. Dì ricordi che inducono al pianto. I primi al pianto della commozione, i secondi al pianto della sofferenza. Oggi, volendo abbandonarmi al dolce pianto dell’afflato, rientro dentro me stessa per farvi riemergere quella parte dì passato che mi ha sempre regalato felicità. Nell’intimo, infatti, è tutto registrato. Tutto quanto si è vissuto – e si vive – è lì custodito in modo permanente. Tutti i sentimenti che ci hanno accompagnato nel corso dell’esistenza e lì depositati, attendono dì essere risvegliati e recuperati. Attendono il momento dì essere ripescati per essere rivissuti. Sì, le esperienze passate non muoiono mai. Tocca noi a cavarle fuori dal mondo interiore per dar loro spazio. Per regalargli voce. Per lasciarle nuovamente esprimere. Ebbene, certa dì quanto vado dicendo, oggi lascio in libertà i miei ricordi riferiti alla montagna, all’amore che da sempre ad essa mi lega. Ad un amore che vive in me dalla nascita perché legato all’amore della mamma che aveva radici montanare. La mamma, infatti, nacque a Chiesa Valmalenco da genitori malenchi. Da due persone umili che ben conoscevano la fatica dì vivere. Da due persone che, come avveniva a quei tempi (il nonno era del 1872 e la nonna del 1876), ebbero vita corta. La nonna morì, infatti, a 46 anni e il nonno a 52. E se la mamma, rimasta presto orfana – insieme ad altri fratelli e sorelle – dovette ben presto lasciare la montagna per procacciarsi i mezzi per vivere, non dimenticò mai le sue origini. Mai si separò definitivamente dalla sua terra. Sempre ne conservò l’amore intenso. Quell’amore che io succhiai col suo latte e dì cui sono rimasta impastata. Quell’amore che ancora, quando è possibile, mi conduce su quei monti per godere e gioire delle loro bellezze. Per imprimerle in quello spazio interno che le conserva per sempre e che, conservandole, consente, come dicevo, dì recuperarle quando lo si desidera. Se chiudo gli occhi, infatti, semi calo nella mia realtà interiore, è come se fossi lì su quei sentieri percorsi tante volte durante gli anni della giovinezza e della maturità. È come se ne rivedessi le erbe, i fiori e i piccoli frutti del bosco. Come se risentissi il rumore dei miei passi che salgono ben determinati a condurmi alla meta. Come se mi vedessi talvolta ferma ad ammirare il salto dell’acqua. Ad ascoltare il cinguettio degli uccelli e il fiasco della marmotta. A levare lo sguardo verso il cielo che, più salgo, più si dilata e si fa azzurro. Come se mi giungesse al mia voce che, sollecitata dalla gioia dì ritrovare gli spazi amati, esplode in un canto dì gratitudine e dì riconoscenza. Come se risentissi il suono del vento che scompiglia delicatamente le chiome dei pini e dei larici che mi dicono, dopo un anno dì assenza:”Bentornata tra noi, Maria Grazia!”. Come se mi vedessi quasi magicamente comparire dinanzi, com’è avvenuto più volte nella realtà, un capriolo o un ermellino. O che gioia che prorompe nel cuore, al riapparire dì queste immagini! Sembra allora dì recuperare il vigore e la forza della giovinezza! Sembra di possedere ancora l’energia necessaria per giungere lì dove si è goduto davvero dì questi meravigliosi doni della natura! E, se in questi istanti ti sembra dì risalire i ripidi sentieri, dì cogliere ad ogni passo uno scorcio che ti invita a proseguire nonostante la fatica, che dire dell’istante in cui, finito il sentiero, sei giunta alla meta? Quando il rifugio che ti proponevi dì raggiungere è là che ti attende? Quando lo scorgi da lontano? Oh, allora, il passo stanco, riprende il ritmo. Si fa spedito e recupera velocità. Sembra abbia messo le ali… Là al rifugio, infatti, ci sono persone che come ogni anno ti accolgono con cordialità. Persone che rendono lieto il tuo soggiorno. Persone amiche che ricordi con gratitudine. Ed è qui, presso questo rifugio che ho trascorso le mie ore più belle. Ore immerse nella pace. Ore impegnate a raggiungere i laghetti della zona. Ore in cui lo sguardo si perde nella contemplazione. Ore trascorse a osservare l’acqua che scorrendo ricorda il Petrarca con le sue dolci, fresche e chiare acque e che rimanda ai versi dì San Francesco: “ Laudato sì, mì Signore, per sora acqua, la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta”… Ore immerse nella più completa e perfetta solitudine. In una solitudine in cui prende la parola il silenzio. In cui odi la voce dì tutti gli affetti che ospiti nel cuore. In cui ti senti in completa sintonia con la natura. In cui avverti dì essere una parte della stessa. In cui ammiri sia la lunga pazienza delle mucche che brucano e ruminano, sia del vecchio alpigiano che le custodisce e che ha nelle stesse le uniche interlocutrici. E già, perché lassù nei pressi del rifugio, c’è ancora il montanaro dalle usanze ormai quasi tramontate che trascorre l’estate pascolando le mucche e vivendo insieme alle stesse in una malga. In una realtà che, primitiva e scomoda, gli regala però la libertà e la possibilità dì vivere secondo i ritmi della stagione. E, se le ore diurne, consentono dì perlustrare la zona conosciuta, dì salutarla e dì rallegrarsi per averla ritrovata, dimenticare non si possono le ore serali allorché, fuori dal rifugio si rivolge lo sguardo verso il cielo dove brillano a centinaia le stelle. Dove tu cerchi la tua. La più bella. La stessa che porta impressa l’effige della mamma. Quella stella con cui ti apparti in un dialogo intimo, segreto e personalissimo. In un dialogo in cui ritrovi te stessa e in cui il cuore palpita in un sommesso grido d’amore. 15 - Dario Pastorelli – “Tobia” Ottobre, per noi gente di alta collina e montagna, è tempo di castagne, tartufi e funghi chiodini. Il bosco accoglie i cercatori con i suoi colori caratteristici. C’è chi cerca e raccoglie per diletto e chi anche per guadagnare qualche soldo. In entrambi i casi è però sempre la passione che ci porta nel bosco. Lo spirito di competizione tra noi cercatori è comunque forte. Siamo gelosi dei nostri segreti: ognuno di noi ha i suoi luoghi di ricerca preferiti e, pia illusione, sconosciuti agli altri … quel ceppo di rovere, il castagno secolare, il roveto quasi impenetrabile… Nel bosco non si è mai soli, si incontra sempre una lepre o un fagiano sfuggiti alle doppiette dei cacciatori e da qualche anno anche un capriolo o un daino, elegantissimi nella loro corsa spaventata, disturbati dal rumore dei nostri passi. Non hanno ancora imparato a distinguere chi li bracca da chi li ammira soltanto. Difficilmente invece si incontra un’altra persona. L’incrocio con un “concorrente” è da evitare assolutamente! Quando si intuisce una presenza umana, segnalata da rumori inconfondibili per noi “conoscitori” del bosco, si cambia strada, ci si nasconde dietro un rovo o comunque si fa di tutto per non farsi vedere, specialmente se il raccolto è abbondante. Nessuno deve sapere cosa e quanto si è raccolto. Il bottino sarà mostrato con orgoglio agli amici e ancora più volentieri, godendo dei loro sguardi invidiosi, ai concorrenti al bar del paese. Quel giorno però l’incontro c’è stato. Distratto dall’abbondanza e dalla bellezza dei funghi non l’ho sentito avvicinarsi fin quando, sorpreso da un assordante”ohilà,” non ho potuto fare a meno di rispondere con un: «Talchì Bertù, che miracul vès in ca vù in tal bosc?» (Ecco qui Berto, come mai anche voi nel bosco?) Ovviamente Berto che non è un frequentatore abituale del bosco non conosce la regola numero uno del cercatore. Dopo aver apprezzato la bellezza dei miei chiodini mi dice che vuole stare un po’ da solo e lasciare lontano il mondo e tutte le sue brutture. Prendo atto! Spero che mi saluti lasciandomi alla mia ricerca ma, smentendosi clamorosamente sul fatto di volere stare da solo, si siede su un ceppo di rovere che sembrava messo lì apposta per fargli da sedile e comincia a parlare, dando per scontato che a me faccia piacere ascoltarlo. Mi rassegno e mi siedo anch’io, cosa che non si fa mai quando si ha la fortuna di trovare una zona ricca, sollevato erò dal pensiero che, tanto, i funghi non scappano. Comincia col dire che proprio in quel boschetto si era nascosto insieme con un’altra ventina di giovani, la vigilia di Natale del “quarantaquattro” per sfuggire alla più grossa retata organizzata dai fascisti. «Li guidava Fiorentini, il loro capo in Oltrepò». Ricorda ancora il terrore che si leggeva sui loro volti. La paura condivisa però aveva fatto sì che tra loro nascesse una salda amicizia che dura ancora adesso e con un timbro di voce commosso precisa «almeno con i quattro o cinque che sono ancora vivi». Nel volgere di pochi minuti passa in rassegna un sacco di argomenti di attualità: guerre, attentati, politici corrotti, uomini che vogliono sposarsi tra di loro e donne che vogliono fare altrettanto e via dicendo. La radio parla quasi solo di cose brutte e la televisione non la guarda più da quando è rimasto solo e poi perché, lui, quella macchinetta non l’ha comprata. (si riferisce ovviamente al decoder). Quando era ragazzo, prima della guerra, la vita era più tranquilla. La povertà e la fame rendevano tutti più solidali. Soldi ne giravano pochi e quei pochi erano già spesi prima di averli in tasca. A San Martino, pagato il libretto della prestinaia e degli altri bottegai, restava ben poco da spendere. Ricorda sorridendo che lui il primo mandarino lo ha visto, «visto nèh, non mangiato», quando aveva già dieci o undici anni, appeso all’albero di Natale nella casa del proprietario dei terreni che la sua famiglia conduceva a mezzadria.. Però è proprio per i soldi che anche lui ha avuto da dire con Tobia. Tutti e due facevano il noleggiatore. Tobia con la sua automobile poteva portare fino ad otto persone e lui, con la sua, solo sei. Per un matrimonio a San Ponzo, Tobia doveva portare quattordici invitati. Essendo il posto lontano non poteva fare due viaggi per cui lo ha coinvolto e lui, ben contento, ha accettato. Tobia, che portava otto persone, delle cento lire concordate come tariffa si sarebbe tenuto però cinque lire in più. La sera, tornati dalla festa tutti e due un po’ alticci per le numerose alzate di gomito, Tobia gli dà quarantacinque lire e lui torna a casa bello contento «più per il mangiare ed il bere che per i soldi guadagnati, se devo essere sincero». Dà i soldi alla sua Ginetta e va a letto. Nel cuore della notte però la moglie lo sveglia con una gomitata e gli dice che Tobia lo ha fregato perché si è tenuto dieci lire in più e non solo cinque come pattuito. Un po’ per il sonno e un po’ perché non è tanto bravo a fare di conto, non riesce a capire. La Ginetta però ha insistito fino a quando gli ha strappato la promessa che il mattino dopo sarebbe andato da Tobia per rifare i conti. Di malavoglia, conoscendone il carattere focoso , ma per il quieto vivere verso mezzogiorno va al bar di Tobia che, provetto pasticciere, stava preparando i cannoncini, i boeri ed il croccante per la festa dei coscritti del giorno dopo. Gli spiega la cosa ma lui non vuole sentire ragioni e sostiene, con toni anche bruschi, che l’accordo per quanto lo riguardava era stato rispettato perché cinque lire meno di cinquanta fanno quarantacinque. Poteva, se voleva, mangiare un paio di boeri e anche portare a casa un pezzo di croccante per la Ginetta, ma di soldi in più neanche a parlarne. Con le pive nel sacco e preoccupato per la reazione che, conoscendola bene, immaginava avrebbe avuto, torna dalla Ginetta. Come previsto anche lei non vuole sentire ragioni e addentando un pezzo di croccante gli dice che deve tornare alla carica altrimenti “quello là” avrebbe dovuto vedersela con lei. Lui però non trova il coraggio e si rifiuta categoricamente anche perché, sinceramente, gli sembra che il conto fatto da Tobia sia giusto e quindi l’accordo rispettato. Insomma, per cinque lire ha rischiato di perdere un amico e passato un periodo d’inferno con la sua Ginetta che ha continuato per un bel po’ di tempo a dirgli che due boeri e un pezzo di croccante, neanche tanto grosso, non dimenticava mai di sottolineare, gli erano costati un’esagerazione. «Certo che al giorno d’oggi, coi tempi che corrono, per una questione del genere ci si può anche sparare o chiedere il divorzio. I boeri però erano proprio buoni», conclude e alzandosi mi saluta augurandomi, ahimè, buona ricerca. Evidentemente non conosce neanche la seconda regola fondamentale dei cercatori di funghi. In un primo momento sono tentato di fermarlo, a questo punto i funghi possono aspettare un altro po’, per spiegargli che Tobia sapeva fare di conto ancora peggio di lui. Se l’avesse fatto giusto, infatti, gli avrebbe dovuto dare ancora meno di quarantacinque lire. Ma poi, ripensandoci, ho ritenuto fosse meglio lasciar perdere, tanto la Ginetta non c’è più, Tobia neanche e a lui a cosa sarebbe servito sapere che oltre ai due boeri e al pezzo di croccante, se pure un po’ piccolo, aveva guadagnato anche due lire in più di quello che gli sarebbe effettivamente spettato? Dietro il ceppo su cui si era seduto Berto raccolgo i più bei chiodini della giornata…quasi ci si sedeva sopra! 16 - Andrea Pettinicchio – “Il gigante Amedeo” In un piccolo villaggio alle pendici di montagne innevate, viveva una volta un gigante, si chiamava Amedeo. Era alto come un pino, con le gambe poteva scavalcare un fiume in un solo passo e aveva due braccia così grosse lunghe e forti che poteva abbracciare quattro o cinque amici alla volta. Ma non aveva più molti amici per farlo. Quando era piccolo invece, si divertiva molto a giocare con tre ragazzi del villaggio e andava con loro per boschi e valli. Erano Giovanni, Luigi e Gigi ed erano tutti molto affezionati ad Amedeo. Col tempo i quattro amici crebbero ma Amedeo molto ma molto di più. Divenne, come dicevo, un gigante. E così mentre passeggiava con loro nei boschi finiva sempre lontano dal gruppo, con le sue possenti gambe in due passi saltava i ponti e i fossi e doveva passare molto tempo ad aspettare gli amici rimasti indietro seduto. E per un gigante sedersi è molto più faticoso che per noi credetemi. Per cui era sempre più scocciato e si stufò al punto che si promise di risolvere il problema o di rinunciare per sempre al suo divertimento. Un giorno mise una corda intorno ai fianchi di ciascun amico e la legò alla sua cintura. Partirono insieme e all'inizio tutto andava bene, Giovanni, Luigi e Gigi correvano aiutati dalla corda dietro ad Amedeo ed erano abbastanza veloci. Ma col tempo iniziarono a stancarsi. Gigi in particolare era l'ultimo non ce la faceva più, così si appoggiò al tronco di un albero per riposare e chiese agli altri di fermarsi. Tutti si fermarono, ma non Amedeo, il quale tuonò con la sua voce possente "Gigi sempre l'ultimo, non ti preoccupare che ci sono io a tirarvi!", e così iniziò a tirare la corda con le sue forti braccia. Non l'avesse mai fatto! Giovanni partì in aria al primo strattone, Luigi si aggrappò con tutta la sua forza ad un filo d'erba, (Luigi non era certo famoso per la sua furbizia) e seguì il primo e Gigi, poveretto, che era appoggiato all'albero, si trovò impigliato tra i suoi rami. Il gigante sentì che la corda era impigliata e così senza pensarci tirò più forte. A quel punto Gigi passò improvvisamente tra i rami, volando catapultato in avanti, veloce come un fulmine seguito poi da Luigi (con il filo d'erba in mano) e Giovanni. Finirono tutti ingarbugliati in testa ad Amedeo, e ci vollero tutti gli abitanti del villaggio per sbrogliare la matassa. Un'altra volta Amedeo pensò di organizzare degli allenamenti per rendere i suoi amici più veloci. Così prese delle grosse bisacce e le riempì di pietre. Le diede ognuna ai suoi amici e gli disse: " Se volete ancora venire con me dovete allenarvi!" E li mandò così appesantiti, al picco più altro della valle. Giovanni, Luigi,e Gigi volevano bene ad Amedeo ed erano disposti a fare un sacrificio per lui. Così si misero in marcia con le bisacce piene di sassi; fu davvero un'impresa perché il picco era proprio a picco. Eppure dopo una grande faticata dicono siano arrivati in cima, perlomeno questo è quello che si dice ancora tra la gente del paese. Ma il problema fu il ritorno! Giovanni partì di gran lena convinto che la discesa sarebbe stata una passeggiata, Luigi lo seguì chiedendosi perché dovevano riportare le pietre al villaggio dopo averle portate in cima (non aveva capito un accidente quel Luigi), e Gigi, poveretto, mentre aveva proprio un piede sulla cima del picco e uno verso la valle svenne dalla stanchezza. Andò giù per terra come un sasso e iniziò a rotolare per il pendio. La sua bisaccia si aprì e uscirono due pietre. Una colpì Luigi e una Giovanni. Tutti finirono per rotolare giù dalla montagna e le pietre che portavano, uscite dalle bisacce, insieme a loro. Le pietre trascinarono altre pietre e il carico di amici e pietre rotolò per la valle verso il villaggio, dove per poco la frana non distrusse delle case gettando nel panico gli abitanti. Amedeo dunque gli disse con la voce possente "Meglio che voi buoni a nulla non mi seguiate più guardate che guaio stavate combinando!". I tre amici pur dispiaciuti si convinsero delle sue parole. E così mentre gli altri si divertivano insieme per monti e valli Amedeo passeggiava sempre da solo triste. Finché un giorno andò dai suoi vecchi amici piangendo dicendo sempre con la sua voce possente "Sono solo e non mi diverto come quando andavamo per monti e per valli assieme!". Allora Gigi chiese ad Amedeo di abbassarsi verso di lui perché doveva dirgli una cosa. Il Gigante si chinò verso Gigi e si piegò quasi in due per arrivare con il grosso orecchio vicino alla bocca di Gigi. Nessuno sa cosa gli abbia detto Gigi! Sta di fatto che prima Amedeo divenne rosso, poi guardò in alto ed infine sorrise. Poi prese gli amici, mise Giovanni sulla spalla destra, Luigi su quella sinistra e Gigi in testa. E tutti e quattro partirono verso i boschi, come un tempo. Certo il gigante doveva sopportare il peso dei compagni ma era felice di farlo perché così poteva divertirsi con loro e ogni tanto quando scendevano per camminare, per non distanziarli faceva dei buffi passetti corti corti che ricordano ancora al paese. E ancora oggi al paese si chiedono cosa abbia detto Gigi al Gigante. Voi lo sapete? 17 - Maria Grazia Savonelli – “Lontano da dove” Quante volte ognuno di noi quando è stanco e stressato desidera essere lontano da dove non sopporta più persone e rumori. Per me questo desiderio, unito al grande amore che nutro per la natura, si rispecchia in distese verdi, circondate da abeti e sottobosco, frusciante e cangiante. Esse non sono un sogno ma una realtà, anche se rara e preziosa: la trovi dopo l’ultimo svincolo del paese di Varzi, dove puoi scegliere tra il passo del Brallo o del Penice, entrambi luoghi degni di essere considerati punti di oasi. Questi posti, anch’essi toccati dalla crisi economica, con bar, negozi ed alberghi chiusi, hanno tra le loro meraviglie posti di ristoro naturali, con panche di legno e fontanelle sorgive. Qui, tra coperte buttate su aghi di pino e cestini di vivande, puoi scoprire tesori quasi nascosti: scoiattoli che fanno capolino su fronde, more che ammiccano a campanelle viola-blu e scarpette di venere, cinguettii armoniosi di gracchi alpini e becchi frusone. Tutto ciò, circondato da aria pura e quiete è un autentico toccasana per il mal di vivere odierno. Per questo occorre diffondere un passaparola vivace senza essere invasivo, per promuovere un turismo basato sulla salvaguardia della flora e della fauna locale; un turismo semplice ma ricco della magia della montagna. Una magia “soft” non eclatante, in grado di dare a chiunque uno spazio verde incontaminato, come un piccolo smeraldo, “lontano da dove” non riesci più a stare. 18 - Michele Terenzoni – “Agnese ci mancherà” Introduzione Durante il mio servizio militare l’Alpino Fischer, un nostro commilitone da tutti odiato per il suo carattere violento, era solito, durante le lunghe marce in montagna, affiancarsi ai ragazzi piu’ in difficoltà e - contro ogni previsione - tenere loro sollevato il pesante zaino. Non c’era nulla di nuovo di quanto non avessi già appreso sin da bambino: eravamo in montagna e lì era possibile alleviare ogni dolore, anche quelli derivanti dallo sporco tradimento. Testo Emma si era alzata presto come sempre quella mattina e stava per dirigersi al lavoro. Ma doveva ripassare da casa. E lo ha trovato lì, a letto con una mai vista prima. Era Settembre quella mattina. La sera sarebbero dovuti partire per la casa in montagna. A suo marito non piaceva andarci da quando avevano chiuso gli impianti di risalita ma a Emma sì, le piaceva, e tanto. Da poco si era anche unita ad una corale locale in cui aveva imparato dalle donne anziane del paese le canzoni popolari tipiche della vallata. La sua passione per le canzoni popolari era iniziata quand’era da bambina. Ne aveva imparate parecchie in una vacanza in una colonia marina a Cesenatico: in quell’occasione qualcuno gliele aveva insegnate. Tornata a casa le piaceva cantarle ai suoi genitori, con suo fratello che la accompagnava con una chitarra. Le sembrava un canto di ringraziamento per aver ritrovato il calore della sua casa, dopo tre lunghe settimane passate al mare ad annoiarsi sulla sabbia. Ma aver visto quella scena a casa sua le aveva tolto ogni piacere possibile. Pensava: “Non è per lui. E’ per me che sono stata così stupida a far finta di non sapere. Quanto tempo perso a raccontarci balle !”. Sistemò le cose al lavoro e partì subito da sola per la montagna. “E’ finita, stavolta è finita per sempre” - diceva parlando da sola a voce alta mentre guidava - “Porco bastardo !”. Arrivata al Passo si fermò un attimo e scese dalla macchina. Quando giungeva all’altezza di quella curva guardava giù verso il torrente e la sua mente faceva sempre lo stesso pensiero bizzarro. Agnese, un’anziana signora della corale, le aveva mostrato un giorno lo spuntone roccioso a cui un tempo si legavano i merluzzi seccati. Messi a mollo nell’acqua si riprendevano la loro forma originaria di pesce, quasi dimenticata. Emma pensava che solo allora si poteva capire che razza di pesce fosse. Ma quando lo avevi acquistato da seccato no, non lo potevi capire. Ti avrebbero potuto mentire su tutto: peso, dimensioni e sapore della carne. Quando Emma arrivò al paese andò subito da Agnese. Pianse a dirotto nel raccontargli quello che era successo. Subito Agnese non reagì ma quando Emma si calmò per un attimo le disse: “Tuo marito è uno stronzo. Ma un pò lo invidio. Io non ebbi il coraggio di tradire ma ne fui fortemente tentata quando conobbi Romano. Ero già promessa ad Aldo ma lui era così bello...Quando Romano era Ufficiale veniva qualche volta la sera al ballo in paese. Tutte volevano ballare con lui. Ma allora non mi gli facevo caso: non mi piaceva. Poi partì per la guerra, prima in Francia, poi credo in Yugoslavia. Tornò dopo più di due anni e ricordo che aveva uno sguardo diverso. Una sera mi confidò che aveva visto uccidere dei civili, che facevano i carbonai, come eravamo noi. Prima della guerra passava in paese per la libera uscita ma ora si era nascosto in montagna assieme ad altri soldati. Di tanto in tanto si fermavano a dormire nel nostro fienile. Io gli portavo qualche sigaretta quando le trovavo. Mi diceva che per lui non esisteva più il dovere di soldato. Che il Re a cui aveva prestato giuramento e di cui era sempre stato fedele servitore era scappato. Tutta l’Italia lo aveva visto per quello che era: un porco bastardo !”. “A me un soldato non sarebbe mai piaciuto” – disse Emma. “Allora era diverso” – ribatté Agnese – “un soldato voleva dire qualcosa di importante, che ti proteggeva. Un Ufficiale poi...non te lo puoi neanche immaginare. Per qualunque donna fidanzarsi con un Ufficiale voleva dire sistemarsi per sempre. Ma ora le cose erano cambiate: le divise le portavano solo i Militi e quelli delle Brigate Nere. Gli Alpini dalle nostre parti la divisa l’avevano tolta pure loro e ora stavano con i partigiani: quelli erano gente di montagna. “Come andò a finire tra voi ?” - chiese Emma - “Anche se ero già promessa ad Aldo non c’era giorno che non pensassi a lui. E quando andavo a trovarlo per portargli le sigarette sentivo un brivido. Poi pensavo ad Aldo, ai miei genitori e correvo via. Non ebbi mai il coraggio di concedermi a lui ma lo avrei voluto fortemente”. “Questo vuol dire che non sei stata stronza come mio marito” – disse Emma – “io preferisco le persone come te”. “Avrei potuto tradire Aldo e con lui l’onore della mia famiglia e questo voleva dire tradire qualche persona: – ribattè Agnese – “se anche mi fossi concessa a Romano sarei stata sempre meglio del Re: il Re aveva tradito l’Italia intera !”. “Feci comunque bene.” – continuò – “Avevo già capito sin da bambina che il tradimento toglie dignità prima di tutto a chi lo commette”. La sera si ritrovarono presso l’associazione della corale per le prove di canto. Iniziò Agnese ad intonare: “La bella al ballo va....tutto il borgo l’ammirerà...larallilerà, larallilerà..e dai monti una stella la bacierà...larallilerà, larallilerà.... e la proteggerà”. La notte Emma pianse forte prima di chiudere gli occhi pieni di lacrime in un sonno di un freddo letto di montagna. “Raccontami ancora un pò di te e di Romano” chiese ad Agnese il giorno dopo. “Parlava sempre dei suoi uomini. Non capiva che responsibilità avesse su di loro. Dovevano agire unicamente secondo le loro coscienze. L’ubbidienza non esiste più. Nell’Italia che vogliamo costruire ogni uomo risponde prima di tutto a se stesso. Allora io che Ufficiale sono ? Sono solo uno di loro”. “Ti ricordi del giorno in cui finì la guerra ?” - chiese Emma. “Eravamo tutti allo stremo delle forze ma facemmo una grande festa giù in valle dove si radunavano i partigiani che venivano dai paesi liberati. Si ballava in tutte le piazze, mentre i camion dei tedeschi si allontanavano e sfilavano i soldati e i fascisti con le mani alzate. Quel giorno avevo anche cercato Romano ma non lo avevo trovato. Mi avevano detto che era stato richiamato a Milano e che era partito la notte prima con i suoi uomini. Non lo rivedetti mai più, ma neanche lo volli cercare. Sposai il mio Aldo e fu un bel matrimonio: era un bravuomo”. Emma rientrò a casa. La sera si sarebbero ancora trovate per le prove della corale. L’indomani ci sarebbe stato il concerto nella chiesetta a fianco al rifugio del Passo. Ma proprio quella sera le altre donne le dettero la brutta notizia. Agnese si era distesa sul letto nel pomeriggio e non si era più rialzata. Stringeva tra le mani il libretto su cui erano scritti i testi delle canzoni di montagna che provavano nella corale. Ce ne erano più di cento. “Diceva sempre che quando sarebbe morta avrebbe voluto che lo tenessi tu” – le disse la figlia Marina – “Era felice quando passavi a trovarla, non faceva che parlare di quando saresti arrivata e quanto era bella la tua voce”. Emma piangeva in silenzio e disse tra sé a voce alta: “E ora a me chi ci pensa ?”. Poi aprì il libretto e incominciò a leggere: “C’è un fiore sull’Alpe, c’è un fiore sull’Alpe, che illumina chi cammina, chi canta con me, chi canta con me risplende di luce divina”. “Penso proprio che dovremmo cantare questa canzone domani sera nella chiesetta. Agnese ci mancherà. Mancherà a tutte quante”. 19 - Giampaolo Toccalini – “Ritorno alla montagna” La carrozza avanzava di buon passo sulla strada polverosa; era trainata da due coppie di robusti cavalli, ansimanti per lo sforzo, ma al tempo stesso dall’aspetto forte e fiero. Le briglie erano tenute da un uomo di mezz’età, che aveva al suo fianco un ragazzo più giovane. All’interno della carrozza vi erano diverse persone, uomini e donne, seduti uno di fronte all’altro; alcuni parlavano tra di loro, altri erano in silenzio, tutti erano impazienti di arrivare al paese, punto in cui la carrozza trainata dai cavalli avrebbe finito il suo percorso. Seduto con gli altri passeggeri un uomo guardava fuori dal finestrino, vedeva la strada salire dolcemente man mano che si avanzava. Le colline intorno diventavano sempre più alte, il letto del torrente che scorreva vicino alla strada era più tortuoso. Il paesaggio era composto da prati a foraggio, da campi coltivati a grano, inframezzati da tratti con piante da frutto, in lontananza invece predominavano boschi molto più estesi. L’uomo era assorto nei suoi pensieri; arrivava da una grande città, in cui si era trasferito al seguito dei genitori quando era ancora un bambino. Ad un certo punto, passata una curva della strada, la carrozza arrivò al paese; i viaggiatori scesero, scaricarono i propri bagagli mentre il cocchiere si dedicò alla cura ed al ristoro dei cavalli. L’uomo di prima prese la sua valigia e si avviò lentamente verso un’osteria la cui insegna faceva bella mostra in mezzo alle altre case. Una volta entrato, chiese da mangiare e si accordò per avere una guida ed un cavallo per proseguire il viaggio. L’oste gli disse che sarebbe potuto ripartire la mattina dopo, non essendo prudente mettersi in cammino allo scendere della sera. Passata la notte, si alzò di buon’ora, dopo una rapida colazione uscì dall’osteria; ad aspettarlo vi era un uomo che reggeva le briglie di due cavalli. Dopo aver sistemato sulle some i bagagli, l’uomo lo fece salire sul cavallo più docile ed iniziarono il cammino. La strada si restringeva man mano che avanzavano, dopo un certo tratto prese a salire con sempre maggiore pendenza. Intorno a loro la vegetazione si faceva sempre più rigogliosa, gli alberi sempre più numerosi; di tanto in tanto vi erano appezzamenti di terreno coltivato, in alcuni erano al lavoro i contadini, intenti a zappare e a dissodare il terreno; altri stavano tagliando la poca erba rimasta prima dell’autunno. Era infatti quel tempo di passaggio tra la stagione estiva e quella invernale, il paesaggio era caratterizzato dalla mescolanza di mille colori, le foglie degli alberi avevano tonalità diverse, bellissime. Avanzando i due viaggiatori scambiavano qualche parola, qualche saluto con i contadini, cosa che li rendeva di buon umore e faceva sentire meno le difficoltà del viaggio. Ora la strada infatti si era ridotta ad una specie di sentiero, in certi punti con ostacoli, con rami in mezzo al cammino; erano nel fitto di un bosco molto esteso, in certi punti le chiome degli alberi, alti e maestosi, ostacolavano la visuale sul paesaggio circostante. Andando avanti videro un pennacchio di fumo che saliva alto nel cielo; arrivati in quel punto si accorsero che il fumo usciva da una carbonaia, una di quelle che i boscaioli della zona costruivano per produrre il carbone, che poi sarebbe stato venduto ai mercanti che l’avrebbero portato ai paesi della pianura. Accanto alla carbonaia vi era il boscaiolo, seduto su un ceppo, che stava consumando il suo frugale pranzo; era un uomo già anziano, conosceva il conduttore dei cavalli, così si fermarono un poco a parlare con lui. Dopo la sosta, ripresero il cammino, in poco tempo il bosco fitto cominciò a lasciare il posto ad alberi in mezzo a prati radi, poveri di erba; erano alla sommità della montagna, il sentiero si stava facendo più pianeggiante, il paesaggio era cambiato, vi era una stupenda visuale su una grande estensione, sugli altri monti della valle, sul cielo sempre più limpido e terso. Camminarono per un buon tratto, in lontananza si vedevano paesi immersi nel verde, in alcuni casi si trattava di case isolate, con vicino le stalle ed il recinto per gli animali. Arrivarono in un punto dove il sentiero si divideva in direzioni diverse, presero per una stradina che scendeva verso il basso. Dopo breve tempo, videro, in una grande piana, le prime case, poi il paese: erano arrivati! Il viaggiatore, anche a distanza di tanti anni, riconobbe quei posti, quelle abitazioni, rivide la grande chiesa, l’osteria con annesse le camere per gli ospiti, più lontano la costruzione caratteristica del cimitero, un po’ staccata dalle case. Pagato e congedato che ebbe la sua guida, prese i suoi bagagli e si diresse verso l’osteria dove si accordò per vitto e pensione. Non sapeva per quanto tempo si sarebbe fermato, anche perché in città molti impegni e il lavoro, lo attendevano. Aveva davanti ancora una parte della giornata, prima della sera, quindi uscì a fare un giro per il paese. Le costruzioni erano molto cambiate nel tempo, se ne erano aggiunte di nuove, altre invece erano in stato di abbandono. Incontrò persone che si ricordavano della sua famiglia, dei suoi genitori, dei suoi nonni. Nei giorni seguenti si dedicò a visitare le diverse frazioni che componevano il paese; arrivò alla casa in cui aveva vissuto i primi anni della sua vita, era una costruzione piccola ma bella, davanti aveva una grande aia; quanto giocare vi aveva fatto nelle lunghe giornate estive, col sole, d’inverno con i giochi nella neve, in compagnia dei bambini della sua età! Ora, seduto su un tronco, risentiva la voce di sua madre che lo chiamava dolcemente, di suo padre che tornava dai campi, stanco ma sereno. In quegli anni della sua infanzia aveva trascorso lì il periodo più bello, pur con tante difficoltà; quando i genitori avevano deciso di seguire gli altri parenti che si erano trasferiti in città, lui ne aveva fatto una malattia, inconsciamente capiva, pur nella sua testa di bambino, che la vita spensierata, gioiosa, stava per cambiare per sempre. Erano passati gli anni, era cresciuto, si era fatto nuovi amici; la vita stava facendo il suo corso. I suoi genitori erano già morti tutti e due, lui non si era mai deciso a sposarsi, nonostante avesse un lavoro che gli dava una certa agiatezza dal punto di vista economico. Pensava a questo quando, in quelle giornate passate al paese natio, faceva lunghe passeggiate lungo i sentieri che, partendo dalle case, arrivavano fino alla sommità della montagna. Stava quasi sempre da solo, meditava su molte cose, assaporava quel clima di libertà, di rilassatezza che in città non poteva avere. A volte incontrava qualcuno, persone gentilissime che si fermavano volentieri a parlare con lui; in un paio di casi si ritrovò in presenza di cacciatori che, essendo aperta la stagione venatoria, perlustravano le zone della montagna, con l’ausilio di alcuni cani, alla ricerca di lepri, fagiani, pernici. Una volta vide anche molti cacciatori che si stavano posizionando per una cacciata al cinghiale. Un giorno, aveva appena smesso di piovere, si incamminò lungo una strada pianeggiante, ad un certo punto vide arrivare, dalla direzione opposta, una donna. Avanzava con passo leggero, quando gli arrivò più vicino gli fece un cenno di saluto e si fermò a parlare. Lui vide che era molto bella, un corpo ben proporzionato, con un viso dolce. Parlando gli disse che da bambini avevano giocato tante volte insieme, che abitavano a poca distanza. Gli disse che abitava ancora in quella casa con i genitori, non era sposata neanche lei, che sarebbe stata felice se lui fosse andato una volta a trovarli, prima di ripartire. Disse queste cose con fare dolce, suadente, che lo colpì. Dopo alcuni giorni si recò a far loro visita, anche i genitori della donna lo accolsero con grande gentilezza e calore; gli raccontarono molte cose degli anni in cui lui era bambino, delle vicende che erano successe dopo che lui ed i suoi cari se ne erano andati, di come si svolgeva adesso la vita sulla montagna. Nei giorni successivi alcuni avventori dell’osteria gli dissero che secondo loro quella donna poteva essere interessata a lui, che lei e la sua famiglia erano brava gente, che lei poteva essere una buona compagna per la sua vita futura. Il viaggiatore rimase turbato da queste affermazioni, quella donna in effetti lo attraeva, sia fisicamente che come carattere, se ne era accorto subito fin dal primo incontro. La ragione che lo turbava era un’altra, che lo aveva reso inquieto dal momento in cui era arrivato al suo vecchio paese di montagna. Era il contrasto tra due mondi, quello della città e quello del paese, due modi di vita differenti, da una parte la frenesia della città, dall’altra la quiete della montagna. Lui, sebbene in diverse stagioni della sua vita, aveva provato le due realtà, per questo ora, anche volendo, non avrebbe saputo decidere quello che più lo attraeva. Però, con una certa malinconia, si rendeva conto che ormai la sua vita era nella città, aveva le sue abitudini, il suo modo di vivere, il suo lavoro. Qui al paese ci stava bene, però capiva che poteva essere solo una cosa di breve periodo, una vacanza, qualche giorno di riposo, non riusciva a vedersi lì in modo stabile. Del paese, in quei pochi giorni, aveva imparato ad amare la pace, lo scorrere lento del tempo, i paesaggi d’incomparabile bellezza che la sua montagna sapeva offrire, la bontà e la cordialità della gente. Queste sensazioni contrastanti lo accompagnarono nei giorni in cui stette ancora in montagna; cercava di godere appieno di tutti i momenti, fece ancora grandi passeggiate, parlò con altre persone, cercando di farsi raccontare più cose possibili su quei posti e sulla gente che li abitavano. Quasi tutti i giorni si trovava in compagnia di quella donna che, ogni momento di più, lo affascinava; stava bene con lei, intuiva che poteva essere la compagna giusta per la sua vita futura: Vi era sempre però l’ostacolo grandissimo dei due mondi differenti, tra l’altro lei gli diceva che non poteva pensare di lasciare soli i suoi genitori, già abbastanza anziani e bisognosi di compagnia. Arrivò così il momento della partenza, l’ultima sera andò a salutare la donna ed i suoi genitori, poi andò a letto presto. La mattina dopo si alzò prestissimo, aveva dormito poco per le sensazioni contrastanti che lo assalivano. Dopo aver caricato i bagagli sui cavalli, saluto i proprietari dell’osteria e si mise in viaggio in compagnia dell’uomo che già lo aveva accompagnato quando era venuto al paese. Fecero un po’ di strada fino ad arrivare in un punto rialzato del percorso, qui si fermarono, il viaggiatore scese da cavallo e stette a guardare in lontananza le case, il suo paese, la montagna maestosa che lo sovrastava. Dopo un po’, ripresero il cammino, avanzavano scambiando ogni tanto qualche parola; il viaggiatore era però immerso nei suoi pensieri, si riprometteva di tornare appena possibile su questi monti, da quella donna però, in cuor suo, si rendeva conto che quella poteva essere l’ultima volta che vedeva quelle case, quelle persone, quella montagna che aveva capito di amare. 2° concorso letterario Ponti Arte 2013 Con il patrocinio di: Provincia di Pavia Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese Comune di Brallo di Pregola Sistema bibliotecario integrato Oltrepò Pavese Pro Loco Brallo di Pregola - Via della Pineta, 7 Brallo di Pregola (PV) – Tel. 0383/500557 email: [email protected] Promosso da: CIRCOLO “PONTI ARTE”, associazione culturale, ricreativa, associata A.N.S.P.I., Fr. Ponti, Brallo di Pregola (PV) – email: [email protected] In collaborazione con: Associazione Culturale VARZI VIVA – Via Di Dentro, 1 Varzi – Tel. 0383-545061 - email: [email protected] Associazione Culturale SPINO FIORITO – Castello di Oramala – Val Di Nizza (PV) - email: [email protected] Circolo Culturale A.N.S.P.I. SASSI NERI – Fr. Pregola - Brallo di Pregola (PV). Tel. 335.7484126
Scarica