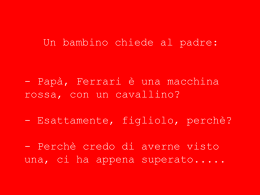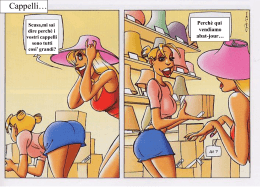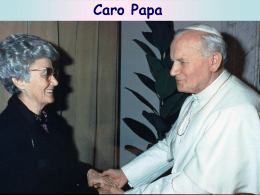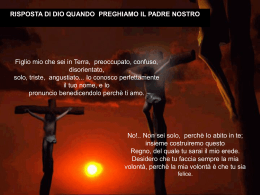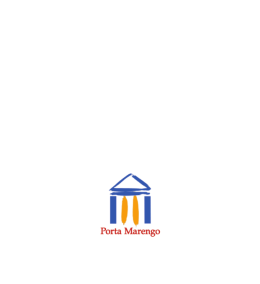1 INTRODUZIONE Giovanni Bianchi, presidente nazionale delle ACLI, non ha bisogno di presentazioni. La conferenza, che qui pubblichiamo, è stata tenuta il 1 7 marzo di quest’anno e, pur destinata ovviamente agli iscritti della Associazione Cristiana Lavoratori Italiani, va ben oltre gli spazi, le finalità e la sensibilità di una Associazione, fino a con figurarsi come riflessione, a voce alta e forte e libera, sulla situazione attuale della società italiana, segnata dalla presenza delle leghe e dall’interesse verso le riforme istituzionali; e come riflessione sugli scenari mondiali, scossi dalla guerra del Golfo e dalla ripresa delle identità nazionali nell’Europa dell’Est e nell’Europa balcanica. In particolare, nei confronti della società italiana, il discorso di Bianchi prende le distanze dalla proposta di una repubblica presidenziale: non per un ostracismo preconcetto, ma in nome di una democrazia che intende salvaguardare i soggetti di una autentica partecipazione alla vita pubblica, senza degenerare a forme plebiscitarie, che della democrazia conservano solo la parvenza. In questa luce Giovanni Bianchi ribadisce il valore dell’associazionismo, che non vuole certo sostituirsi ai partiti, ma che ai partiti chiede promozione e non protezione. Abbiamo voluto lasciare al testo della relazione la forza e l’immediatezza del «discorso parlato», più che scritto, apportando solo lievi modifiche che ne consentissero la pubblicazione. Don Alberto Franzini Direttore del Centro Pastorale Diocesano «Maria, Sedes Sapientiae» Cremona, 2 giugno 1991, festa del Corpus Domini n.b. Il testo è stato digitalizzato e pertanto non mantiene l’impaginazione originale 2 E’ sempre una rimpatriata venire a Cremona in questa vita randagia. «Nella mia vita randagia diceva Enrico Anelli — cammino col vaso di sudore, coi panni laceri, con le spalle curve incontro al Creatore», versi stupendi. Conobbi la poesia di Enrico prima di conoscerlo. prima ancora di essere nelle ACLI, al centro culturale ricerche di Sesto 5. Giovanni. Si fece allora un’esposizione fotografica, presentata da David Turoldo e c’era anche questo libretto di «Preghiere dei campi» di un tale Enrico Anelli; le lessi allora queste liriche autentiche. E quindi continuiamo nella vita randagia quasi come segno di un’esistenza, che anche nella nostra ostinata ricerca si incontri un po’ il Vivente, sul modo di Maria di Magdala. 1. LA FASE STORICA CHE ATTRAVERSIAMO Vorrei partire inevitabilmente da una considerazione che riguarda la fase storica che attraversiamo, proprio perchè desidero che sia superata quella distanza, quello scarto che spesso c’è tra i momenti della meditazione e quelli dell’analisi. Partirei da un interrogativo: con quali occhi abbiamo guardato le vittime dell’assurda guerra del Golfo? Primo dovere è quello di situarci in quest’oggi, nella fase storica in cui siamo inseriti. Direi che ci eravamo abituati a parlare di fase costituente, di nuovo ordine internazionale nel tentativo di capire una fase che è molto magmatica, un processo che credevamo diverso. Le speranze dell’89, l’illusione storicista di pensare che la democrazia si sarebbe diffusa per certi concetti in tutto il mondo, quasi che si stesse per adempiere una splendida profezia di Giorgio la Pira, che ben 35 anni fa scriveva così: «I popoli e le nazioni di tutto il mondo costituiscono ormai ogni giorno più a tutti i livelli una unità indissolubile. I problemi scientifici, tecnici, sociali, politici, culturali, religiosi di ogni popolo sono problemi la cui soluzione interessa organicamente tutti gli altri popoli del globo», e concludeva La Pira con una visione autenticamente profetica «tutti i muri sono spezzati, tutte le barriere sono infrante, tutti gli schemi mentali di divisione sono tolti; i confini dei popoli sono trasformati da muri che dividono e in ponti che uniscono». E poi dicono che la profezia non esiste! La Pira aveva ben visto. Devo dire che un altro uomo del cattolicesimo italiano nel ‘63, Benigno Zaccagnini, era capogruppo alla Camera, in occasione della presentazione di uno dei governi balneari dell’onorevole Leone, in polemica con Togliatti, diceva: «Quel muro cadrà e non cadrà perchè aggredito da fuori, ma perchè svuotato e fatto crollare dall’interno dall’ansia di libertà che quelle popolazioni hanno». C’era dunque una previsione che alcuni occhi profetici avevano anche visto. Da qui allora la giustificazione di un’attesa, di una gioia, coi fatti dell’89, e poi questa doccia fredda, cosiddetta «tempesta nel deserto» della Guerra nel Golfo. Allora io credo c’è un certo disagio in questo senso, dal quale partire, perchè le altre guerre, almeno così come le abbiamo vissute, erano guerre lontane, non meno crudeli, non meno sanguinose, ma lontane; questa è stata una guerra più vicina, ci coinvolge più delle altre nella nostra quotidianità, pensate all’incetta di derrate alimentari al supermercato, il senso quindi di una paura di un tunnel appena imboccato. Forse la percezione profonda che davvero questa guerra ha cambiato qualcosa irrimediabilmente. Non a caso il Papa Giovanni Paolo TI ha parlato di «un’avventura senza ritorno». Io credo ci sia nelle parole del Papa ancora una volta una consapevolezza profetica «senza ritorno», quindi senza illusione che si torni facilmente a quel che c’era prima. Io credo che si sia all’inizio di una fase difficile e complicata. Gli analisti della geopolitica ci possono descrivere i punti di crisi, gli smottamenti, ma credo fatichino a restituirci il senso di un processo. Ebbene, io credo che la prima cosa da cogliere è questa tenace regolarità della guerra nella nostra storia, una storia non ancora redenta allo sguardo umano, questo senso doloroso consegnato alla misericordia di Dio. La guerra segna questa presenza del male, un male sempre più meccanico, le 3 bombe intelligenti, una che si infila dietro l’altra ed insieme sempre più inumano, terribile e mostruoso. Direi che nella nostra storia occidentale c’è questa forza della guerra e contemporaneamente quasi una banalità della pace. La pace è un’essenza, una tregua, pax romana, pax americana, non «shalom» del Signore; tanto forte e profonda la cultura della guerra, tanto fragile la cultura della pace. Esistono intere biblioteche da secoli sulla guerra, la produzione sulla pace invece è molto recente. C’è molta passione di pace tra la gente ma c’è poco pensiero, poca strategia. Questo va inteso, questo scarto va capito. Io credo però, ed è per questo che ho cominciato così, che lo sguardo del cristiano sia chiamato a capovolgere in paradosso questa immagine, questa tradizione della nostra storia politica, a far sì che ci sia una banalità della guerra e una interiorità della pace, una interiorità della pace che non dobbiamo rincorrere per una convenienza ma nella follia della croce. Scindere la pace dalla croce credo sia la tentazione più forte, quella che può venirci dalla sapienza disincantata dello sguardo laico, che misura sui rapporti di forza la pace e che oggi ragiona grosso modo: «beh, è andata così, vado, l’ammazzo e torno, e poi magari faccio un po’ d’ordine». Non a caso la dimensione della croce è quella della riconciliazione, riconciliazione in Cristo, in Lui che ha riunito in Sè Ebrei e Gentili. Io credo che da questa riconciliazione siamo ancora lontani. Ecco, ho voluto situarmi qui, non soltanto perchè come ci insegna la teologia è bene collocarsi in quest’oggi, ma anche perchè rispetto a questa condizione, queste ACLI non sono assenti. In questo senso siamo più carichi di responsabilità perchè se difficile è la fase storica, meno difficile è la fase delle ACLI. Siamo in un periodo buono, abbiamo lasciato alle spalle il tunnel delle più grosse difficoltà, abbiamo una buona immagine e abbiamo anche un grande radicamento, una grande realtà che si è rimobilitata. Le nostre riunioni sono affollate, sto pensando a tre riunioni in una sola giornata acliste nella Milano di ieri, una di addetti sociali del Patronato: non ci stavamo più nel saloncino delle ACLI, tant’è vero che vedendo il nereggiare dei loggioni dicevo: l’anno prossimo alla Scala. Un’altra riunione sulla pace, un’altra sulla formazione professionale. Siamo riaccreditati, per questo abbiamo più responsabilità. Abbiamo smesso, per dirla con il Lazzati e per continuare la metafora lirica, di fare come quelli che stanno sul palco a cantare: «partiam, partiam», e non partono mai. Ci siamo messi in strada e credo ci è riuscita una cosa, per questo siamo più carichi di responsabilità, quella che a mio giudizio era fondamentale: riaccreditarci in quest’area cattolica senza omologarci, ritornare credibili con un alto profilo, mantenendo saldo il luogo dell’autonomia e quindi rendere disponibile il luogo dell’interlocuzione. Il nostro radicamento è riconosciuto e anche i media finalmente dopo anni si sono accorti di noi. Siamo una grande organizzazione popolare perchè siamo nati come grande organizzazione popolare di lavoratori cristiani e tali vogliamo restare. Il nostro sistema aclista tessera complessivamente 560 mila persone, 8000 addetti sociali, 300 centri di formazione professionale, 2000 cooperative, 2500 società sportive, 35 mila aclisti nella sola Europa occidentale e stiamo andando anche in quella che fu l’Europa dell’Est. Insieme agli Scalabriniani stiamo costruendo nel centro di Varsavia una casa della cultura e della formazione professionale. Ce l’aveva chiesto Walesa quando venne a Roma qualche anno fa, prima di diventare Presidente della Repubblica polacca. Queste ACLI ci sono, sono uscite — scusate la metafora guerresca, ma pur essendo uomo di pace io resto anche ufficiale degli alpini tutto sommato — siamo usciti dalle caserme e non ci rientreremo, ma proprio per questo abbiamo più responsabilità. Mi veniva in mente un vecchio proverbio hiddish che diceva «Se Dio abitasse sulla terra, alcuni ne prenderebbero a sassate le finestre». «La guerra è la continuazione della politica ma con altri mezzi» sosteneva Von Klausewiz. La guerra ha interrotto la politica nel caso specifico. Quindi la fase è davvero nuova. Sono così cambiate le cose che si è avuto anche nel nostro Paese quello che sembra un rovesciamento bismarkiano delle alleanze, «una trasversalità medita», per usare un termine molto corrente. Si potrebbero fare molte considerazioni, ne faccio solo una. Mi ha molto stupito che il ragionamento, dirò di più, la letteralità della frase con cui quello che viene considerato il maggior rappresentante del cosiddetto pensiero debole del nostro paese, Gianni 4 Vattimo, la frase con la quale delegittimava la guerra come non più compatibile con il nostro orizzonte moderno, è la medesima frase con cui faceva la stessa operazione il Card. Ratzinger, rappresentante di un pensiero indubbiamente forte, perfino un po’ gerarchico. La frase è questa: «Non è più possibile parlare di guerra giusta — questo diceva Vattimo in polemica con il suo maestro Norberto Bobbio — perchè è eccessivo, è troppo evidente lo scarto tra la distruttività dei mezzi impiegabili e la giustizia dei fini raggiungibili». E’ la stessa frase con la quale in una intervista il Card. Ratzinger ha detto che non è più pensabile l’orizzonte in termini di guerra giusta. Tutto questo può non venire a caso, tutto questo può avere per effetto il congelare per un momento la condizione delle culture politiche di questo paese, finanche le formule governative. Ma poi scongela molto rapidamente. Aveva ragione Leopoldo Elia quando a Chianciano diceva: «Si è aperto anche in Italia un dopo Yalta della politica interna»: è qui che ci dobbiamo collocare con tutte le trasformazioni che questo significa. 2. L’AREA CATTOLICA Per stare al tema io partirei da questa condizione e partirei da una rapida ricognizione della situazione di quest’area cattolica all’interno di questa fase di cambiamento. C’è un primo elemento estremamente importante anche perchè segna per alcuni versi una rottura storica con la tradizione del cattolicesimo sociale in questo Paese e in particolare con il lombardoveneto. Qua1 era la tradizione? La tradizione di pensare che quello che importa è la continuità del sociale, le forme del politico sono comunque effimere se non talvolta un po’ sporche. Se ci pensate è così dal tempo degli intransigenti e dei fratelli Scotton, dei grandi nemici del Vescovo Bonomelli, accusato di essere, questo era il linguaggio, testuggine che non riesce a guardare il cielo; questo era il tipo di polemica che gli intransigenti facevano allora col Vescovo di Cremona. Ebbene, allora c’era questa continuità del sociale, questa distanza del politico. Oggi abbiamo un fatto inedito che è questo: mentre in particolare le culture laiche sembrano aver deciso di dare il nostro futuro se non il destino nelle mani della tecnica e più prosaicamente del mercato, l’area cattolica invece si presenta come un luogo di resistenza politica. Non che non voglia fare i conti con la tecnica, non che non si debbano fare i conti con il mercato. Il mercato è pura istituzione, tutto sommato gli avvenimenti recenti dicono che non si dà democrazia senza mercato; anche se dopo l’errore dell’Est di sostituire la politica al mercato, non bisognerebbe commettere l’errore di sostituire il mercato alla politica. L’area cattolica rappresenta una resistenza politica, vogliamo capire come costruire la città dell’uomo. Costruire la città dell’uomo, attraverso i valori, la nostra quotidianità, l’esigenza di un raccordo tra politica quotidiana e grande politica, e facendo i conti con la tecnica, l’economia, con il mercato, senza che siano essi a forgiare il nostro destino. Questa è la resistenza dell’area cattolica. Sono esemplari a tal proposito il percorso dell’associazionismo, la proliferazione di scuole di formazione alla politica o di scuole di formazione politica, talvolta con dei percorsi ingenui, però come sintomo fondamentale, soprattutto importante se pensiamo che sono ormai macerie le scuole di partito. E d’altra parte non si riesce a capire come si possa in certi casi continuare a celebrare la liturgia di un Dio che è morto. Io ricordo che quando tre anni fa, invitato dai sindacati feci un viaggio in Unione Sovietica, trovai tra gli altri un fatto: alle Università avevano sospeso gli esami di storia, dovevano essere riscritti i libri e non si sapeva più su che cosa interrogare gli studenti. Ebbene io credo allora che sia estremamente importante partire da qui, c’è questa medita resistenza politica della realtà cattolica, un fatto nuovo per la storia del nostro Paese; farebbe piacere a Mons. Bonomelli cui è dedicata l’aula nella quale in questo momento ci troviamo, è la sua rivincita nei confronti degli intransigenti dopo che una grande rivincita nei confronti degli intransigenti aveva già segnato, ci torno tra un attimo, don Luigi Sturzo. 5 Questo è un Paese ricco, ricco per prodotto nazionale, ricco per reddito pro capite, ricco per depositi bancari, siamo sempre tra i primi sèi o cinque del mondo, con una contraddizione però: aumentano in questo paese i picchi di ricchezza, aumentano i picchi di povertà; le due cose insieme. C’è molta più ricchezza e c’è più povertà soprattutto nelle grandi città, è misurabile a naso quanto si sia aumentata la coda alla zuppa popolare dei frati; vicino alla sede nostra a Roma è stata recentemente aperta una mensa per poveri e si è dovuti andare in giro casa per casa a chiedere alla gente di non inquietarsi troppo se durante alcune ore della giornata c’è un po’ di confusione nel traffico perchè c’è questa gente che si reca alla zuppa popolare. Soffermiamoci sul tema irrisolto dei terzomondiali tra di noi e la tragedia e il grottesco della non accoglienza agli albanesi. Anche qui bisogna dirlo molto chiaro; prima la gente la si accoglie, poi la si convince a ritornare o la si dirotta. Ma prima la si accoglie, e uno Stato moderno non può aspettare che siano soltanto i percorsi della solidarietà quotidiana, le ACLI a muoversi. Stiamo attenti che l’Albania può essere soltanto una piccola avanguardia di un flusso ben più impetuoso. Ci sono ben 20 milioni di disoccupati pronti a muoversi da tutta l’Europa dell’Est, esodi biblici. La rottura estiva con Mosca della Comunità economica europea è caduta su questo. Si chiedeva un’apertura per 3 milioni di disoccupati. Queste sono le condizioni di quadro dentro le quali ci muoviamo in questo Paese ricco a partire dalla presenza di un’area cattolica che ho indicato come vivace e da una società civile, quella italiana, che ha visto di molto aumentare la propria politicità. Attenzione, anche qui finiamola di prenderci in giro. Nessuno vuole fare delle caricature enfatiche dicendo che la società civile è buona, è senza peccato originale. Non è vero. C’è chi dentro la società civile cerca protezione piuttosto che promozione, c’è chi insegue le clientele, ci sono settori malavitosi. Però nel momento in cui diciamo che non ha senso una contrapposizione tra il civile tutto buono e il politico che dovrebbe essere tutto corrotto, ha però senso dire che è aumentata di molto la politicità di questa società civile che ha nuovi bisogni, che ha nuove domande da rivolgere alla società politica. 3. L’ASSOCIAZIONISMO E noi ci collochiamo qui. In questa condizione si collocano tutti i percorsi della solidarietà in questo Paese. E’ vero ci sono amplissime sacche corporative, vi è una rincorsa a quella che gli americani chiamano la corsa del topo, in termini di carriera, di stipendio e quant’altro. Però la solidarietà c’è, non è soltanto una parola scritta nelle encicliche di Papa Giovanni Paolo TI o nei documenti dei vescovi o delle AGLI. Noi come AGLI presentiamo ogni due anni al CNEL il rapporto sullo associazionismo nel nostro Paese. Dall’ultimo rapporto emerge un dato: un italiano su dieci dedica almeno sei ore alla settimana a un impegno gratuito per gli altri. E’ gente che non frequenta il Costanzo show, ma che c’è. Dall’associazionismo tradizionale alle forme più nuove: dalle AGLI all’ARGI, dai ragazzi che stanno sulle ambulanze al volontariato, un italiano su dieci, non è poca cosa. Quindi questa realtà esiste ed è questa realtà che ha fatto crescere i percorsi di solidarietà e anche le domande politiche della società civile. Questo è l’associazionismo, questa è la sua diffusione, questo è il suo radicamento, con tutti i problemi che pone rispetto a questo oggi. Anche per questo, diciamolo subito, è stata saggia la nostra riscoperta di Luigi Sturzo, perchè Sturzo ha la scatola d’arnesi che ci aiuta a interpretare questa realtà. Badate il primo Sturzo, quello più medioevalista, quello della croce di Costantino, perchè proprio il pensare la società come tutta composta di soggetti collettivi, di comunità, anche di corporazioni, è una visione della società che ci aiuta a dar conto della complessità. Ecco perchè siam tornati a Sturzo, perchè meglio di Gobetti, perchè meglio di Durso, perchè meglio di Gramsci, aveva il senso di questa complessità, grazie magari ad una visione ideologica di tipo medioevalistica, però questa è la realtà. Ecco perchè ci siamo collocati all’interno dell’orizzonte della cultura cattolico-democratica, perchè grande parte all’attenzione della cultura cattolico-democratica abbiamo dedicato nel nostro 6 Congresso di Milano, perchè abbiamo smentito i Baget Bozzo che dicevano: «la cultura cattolicodemocratica non ha futuro». Se c’è un’area vivace è questa, in termini di cultura sociale e in termini di cultura politica, perchè aveva ragione De Mita concludendo così il Congresso democristiano «la cultura cattolico-democratica è anzitutto ed essenzialmente la cultura della società civile, e non appartiene soltanto alla Democrazia Cristiana». Ecco perchè ci siamo collocati dentro il civile in questo modo, dentro l’associazionismo in questo modo, con questo tipo di visione e con questi strumenti di interpretazione e di azione dentro la realtà. E’ anche per questo che abbiamo fatto la battaglia sulle riforme istituzionali. Non c’è venuta improvvisamente la voglia di giocare con il meccano delle istituzioni, è questa società civile per come è cresciuta che chiede nuovi spazi di interlocuzione e di cambiamento. Il rischio è che a fronte di questa crescita della società civile e dello associazionismo vi sia una non comprensione da parte delle istituzioni e dello Stato. Touraine lo ha notato per la Francia, per esempio, dicendo: «Il rischio è che società e Stato non siano più faccia a faccia ma schiena a schiena». Bruttissimo Kamasutra da abbandonare subito. E Touraine in quel saggio concludeva così per la Francia: «La debolezza di questi partiti è la forza di questa democrazia». Io condivido la diagnosi di Touraine. Ma non ne condivido le conclusioni almeno per l’Italia, sulla Francia non metto lingua: «Non è vero che per noi la debolezza di questi partiti sarebbe la forza di questa democrazia». Da qui allora il nostro rapporto per incalzare i partiti a uscire sulle riforme istituzionali da un dibattito termale, nel senso che non approda a nessuna decisione. Ciò non a caso, ma perchè i partiti sono cambattuti tra due poli: il vedere da una parte l’esigenza di fare queste riforme, il non volere abbandonare dall’altra tutto quello che lucrano persistendo questa situazione di dissesto, attraverso l’occupazione dello Stato e della società medesima. Questa è la contraddizione dalla quale non sanno uscire. E allora il nostro disegno è stato di dare una spinta ad uscire da questa condizione e a produrre la loro autoriforma. Dopo aver citato Touraine cito un autore italiano. Ed è molto importante citano perchè si tratta del migliore allievo di Gianfranco Miglio, Pierangelo Schiera, che fa riferimento ad un filone di pensiero che non è quello attento alla società civile, è quello più attento al potere forte, all’autonomia del politico. Ebbene, Pierangelo Schiera ha scritto: «In Italia, come in tutte le civiltà occidentali, si sono create due dimensioni della politica». Una più orizzontale, attraversata dalle associazioni, dai movimenti, la corrente calda, un’altra più verticale, più vicina alle istituzioni dentro la quale stanno anche i partiti. E dice Schiera: «Il futuro delle democrazie è legato al tipo di incontro di queste due dimensioni della politica». Io condivido questa diagnosi, noi ci muoviamo in questa direzione. Ha ragione Martinazzoli quando dice: «Il partito, in particolare il partito nella visione sturziana ha una forma temperata, ma se dietro non c’è un movimento caldo il partito produce pak polare e non più forme temperate: l’incontro tra queste due dimensioni è fondamentale». Badate bene, due dimensioni politiche, non più il prepolitico di cui parlava qualche anno fa Padre Bartolomeo Sorge, due dimensioni della politica: una del civile, dell’associazionismo, l’altra più istituzionale, detta verticale. E’ il futuro non soltanto della democrazia in Italia: dipende anche negli altri Paesi dell’Europa occidentale, in genere nei Paesi occidentali, dall’incontro di queste due dimensioni del far politica. Ecco qual è la nostra visione, ecco dove ci collochiamo, sapendo il rischio. Quale? Poco fa dicevo: picchi di ricchezze e picchi di povertà; facevo riferimento alle emigrazioni bibliche che aspettano questa Europa e sarà bene studiare più demografia per capire più politica nei prossimi anni. E’ qui che vedo il rischio della nostra democrazia. Quale? 7 3. I LAVORATORI DENTRO LO STATO Tutti abbiamo sentito parlare recentemente dei famosi due terzi di Gloz, le democrazie conservano, garantiscono i due terzi e lasciano fuori un terzo. Il problema non è giocare con le frazioni. Mettiamo la questione in Italia; dov’è che esiste il rischio della sindrome di Gloz? In questo: se pensate tutto il nostro dopo guerra è stato caratterizzato da quella che De Gasperi chiamava la democrazia possibile, e che cos’era? Era questo incontro tra «il riscatto delle plebi rurali», la frase è di Sturzo, «i lavoratori dentro lo Stato», la frase questa volta è di Mario Romani, non dimentichiamolo, primo direttore dell’ufficio studi delle AGLI provinciali milanesi e poi con Giulio Pastore, l’uomo che ha pensato tutta la CISL del dopoguerra. Tutto questo è avvenuto e tutto questo ha fatto sì che ci fosse questo circolo virtuoso tra «riscatto della povera gente», questa volta l’espressione è di Giorgio La Pira, e allargamento degli spazi della democrazia. Ma adesso i lavoratori stanno dentro lo Stato e il rischio è questo: che chi ha ormai non più bisogno di promozione, di riscatto, ma di sicurezza, usi le procedure della democrazia, usi il principio di maggioranza per tener fuori tutte quelle aree di emarginazione che la nostra società va riproducendo. Questo è il rischio. 5. DUE «FENOMENI» DI ATTUALITA’ E qui alcuni fenomeni possono essere letti. Faccio riferimento soltanto a due cose: 1) Inevitabile, siamo in Lombardia; quando giro tutti mi chiedono: «e le leghe?». 2) Un codicillo sulla situazione dei possibili sbocchi istituzionali. 1) Le leghe. Bossi straparla da mattina a sera, eppure guadagna voti, perchè? Perchè le ragioni di Bossi sono i nostri torti, i torti di questo quadro democratico. E’ detto molto in sintesi, però va inteso. Onde i paradossi inquietanti: non sono sorte le leghe nell’Emilia sazia e disperata, ma hanno trovato terreno di cultura in zone fortemente bianche, di radicamento dell’educazione cattolica; parlando del fenomeno prima che avesse il boom elettorale con l’allora direttore dell’Avvenire, egli mi diceva che arrivavano lettere di parroci in favore delle leghe al giornale. Io non ho, checché ne dicano i giornalisti del giornale di Montanelli, nessuna mania di autoflagellazione, il masochismo non lo conosco, però un interrogativo va fatto; è nelle zone più bianche che le leghe sono andate avanti. E badate che questo non è scritto da nessuna parte. Noi abbiamo esperienze di zone bianche dove i percorsi della solidarietà hanno avuto in politica un’ampia rappresentazione. E’ il caso dell’Alto Adige, della Volkspartei, indubbiamente era su base etnica, è però un momento di solidarismo. E’ il caso dei Baschi. Quindi non è detto che necessariamente da una cultura bianca devono esprimersi questi percorsi di non solidarietà. Perfino la stessa CSU di Strauss in Baviera era ed è tutt’altro che priva di elementi solidali. Quindi un primo interrogativo su questa presenza e su come siamo chiamati a rispondere. Io credo che l’associazionismo non possa restare indifferente rispetto a questa condizione delle leghe, perchè è l’altra faccia rispetto ai nostri percorsi di solidarietà. 2) L’altro discorso è quello più vicino, più dentro agli sbocchi possibili della riforma istituzionale. Io ripeto qui una tesi che sostenni quando incominciammo la nostra battaglia per le riforme istituzionali in un circolo milanese con Guido Bodrato. Io credo che sia illusorio, per tutte le trasformazioni che si sono fin qui verificate, pensare di stabilizzare la condizione là dove non è possibile. Quindi o si interviene con alcune riforme o un’altra riforma verrà fuori, e di fronte a una possibile frammentazione elettorale, se non si avrà la forza di andare verso quel filone di riforme che noi abbiamo proposto, si imbucherà a imbuto la strada della Repubblica Presidenziale. Non mi piace, noi ci siamo battuti e ci battiamo contro questa ipotesi, ma di fronte a un’ulteriore frammenta zione fatta da interessi anche in senso egoistico, non ci sarà più possibilità di nessuna razionalità politica di coalizione in grado di governare. Allora l’unica soluzione diventerà quella di suonare la 8 gran cassa sulle forme della Democrazia plebiscitaria ed emotiva, facendo balenare un voto diretto che poi diretto non è. Io credo che questa sia la partita che si è aperta, e bisogna essere molto lucidi. Questo dà conto del perchè queste ACLI, dentro l’associazionismo, dentro i percorsi della solidarietà, hanno fatto innanzitutto una battaglia per il riconoscimento dell’associazionismo, ricevendo grandissimi complimenti da tutti i partiti ma anche grandissimi sgambetti. Questi partiti vogliono soltanto aree protette e di clientela, dà loro fastidio l’associazionismo che chiede promozione anzichè protezione. Questa è la realtà, è bloccata in Parlamento anche la legge sul volontariato e non soltanto quella sull’associazionismo. Complimenti e t’annegano dentro i complimenti; grazie, non beviamo. Questo deve essere molto chiaro: è un rapporto che è di non riconoscimento dell’autonomia di questa società civile che è cresciuta e della quale questa società politica ha pur bisogno per uscire da alcune sue incrostazioni e vizi. Non vogliamo sostituirci, nessuna supplenza, nessuna sussidiarietà. Vogliamo fare la nostra parte, e fare la nostra parte a partire da questa condizione medita: aiutando i partiti. Non abbiamo nessun odio nei confronti dei partiti, li frequentiamo, anzi. Qui si situa anche una parte della questione morale. La questione morale non è qualcuno che ruba — certo che lo è e rubano anche tanto — la questione morale è il senso complessivo della costruzione della città. Se si perde questa direzione non si sa più come lavorare. Questa città deve fare i conti con una società civile dove è cresciuto il tasso di domanda politica. Quindi siamo dentro questo filone, noi ci battiamo per le riforme perchè vogliamo innovare e quindi mantenere questa costituzione. Laddove chi invece vuoi dormire sulle cose come stanno e vuole soltanto arroccarsi in difesa, a mio parere, apre la strada alla cosiddetta democrazia plebiscitaria che è più plebiscito che democrazia. Ci andiamo vicini proprio per questa inerzia, per questa abitudine stramaledetta di considerare tutto, dalla guerra del Golfo ai nuovi ceti sociali che crescono, soltanto in termini di scostamento di voto e che ci riempie di sensali del voto e ci fa mancare assolutamente statisti. 6. CONCLUSIONE Per concludere, non c’è niente di improvvisato nelle cose che facciamo e non ci limitiamo alle diagnosi. Questo è un Paese pieno di gente che ha l’abitudine di battere il «mea culpa» sui petto degli altri. Non è un esercizio di carità. E’ un’operazione estremamente fastidiosa. Noi una volta che abbiamo fatto la diagnosi abbiamo l’abitudine di dirci: e noi cosa facciamo? Ecco perchè, con la modestia delle nostre forze, ma anche con molta determinazione stiamo portando avanti alcune battaglie e siamo riconoscibili per questo: sulla pace, sulla riforma istituzionale, sul lavoro. Il mutamento di questi anni sta esattamente in questo. Anzichè produrre documenti — noi non siamo un saggificio o la fabbrica del ciclo- stile — trovata un’ipotesi, fatta una diagnosi politica, ci mettiamo in strada. Questo è il modo col quale un soggetto ha il dovere di fare la sua parte dentro la storia, e in questo io credo continuiamo la tradizione che è stata dei nostri maggiori: Achille Grandi in particolare, che fonda il primo sindacato di categoria nel 1908, il sindacato dei tessili. E questo, dicevo, è il nostro modo di muoverci. Questa è la nostra concezione dell’associazionismo nell’oggi e per gli anni futuri, perchè crediamo di interpretare non soltanto per noi questa crescita in politicità del civile. 7. PER LE ACLI Un paio di conclusioni da questo punto di vista. Io credo che in una fase come questa abbiamo il dovere, che è poi classico per le ACLI: 1) di sapere da dove veniamo. 2) di recuperare la centralità della formazione. Sapere da dove veniamo. La nostra storia dobbiamo conoscerla di più. Non costruisce futuro chi non sa quali sono le sue radici e quindi anche le nostre storie provinciali, i nostri santi minori. 9 Chissà poi se sono minori. Io ho un paio di carissimi amici con cui ho fatto un lungo tratto di strada dentro le ACLI della Lombardia: Gianmarco, Enrico. Ricordo una frase che era tipica dell’Enrico «non lasciare mai nessuno per strada»: questo cruccio di avere chiarezza, ma anche di non lasciare gente per strada. Quindi conoscere la nostra storia, non perdere occasione per farla conoscere, anche alle generazioni dei giovani. Il momento magico delle ACLI che mons. Canestri, oggi arcivescovo di Genova, mi aveva preconizzato quando era ancora vescovo a Cagliari, fu: «continui». Ringraziamo il Signore «lassù qualcuno ci ama, quaggiù non tutti». Sta bene così. Perchè questa conoscenza della storia? Perchè solo sapendo chi si è, facendo alla maniera del credente, facendo «memoria» della propria storia si può costruire futuro. Altrimenti si è anche qui soltanto consumatori di scenari, di culturologie. E l’ultimo scenario diventa immediatamente il penultimo quando un altro scenario appare sulla scena. Bisogna avere il senso della storia, anche per il Golfo. In questo periodo sono andato a riprendermi quei due grossi splendidi volumi del Brodel sugli Imperi nel Mediterraneo nell’età di Filippo TI. Anche perchè tutti i dibattiti a cui mi è toccato di partecipare in questo periodo, mi hanno fatto incontrare una serie di intellettuali italiani che vanno per la maggiore. Più che intellettuali sono cantinieri, che non studiano niente, che parlano a vanvera e che vengono con una tesi da difendere, che si dedicano al dileggio del pacifismo perchè non sanno che cosa dire nè sulla pace, nè sulla guerra. Quando ti chiamano ti dicono: «Venga, c’è questo dibattito, avrà un tono culturale». Dopo un quarto d’ora devi metterti nella prospettiva «o gambe o pallone», perchè è rissa e non devi venire fuori stritolato. Non sarà cultura questa roba! Altrimenti richiamiamo in campo non Maradona ma Lodetti, quelli che andavano più sulle gambe che sul pallone. Proprio per questo bisogna avere il gusto di sapere dove si viene. Basta con le improvvisazioni, basta con i cattivi maestri, perchè superficiali. Questa è la temperie culturale. Dobbiamo avere la capacità di stare con i piedi per terra, altrimenti c’è il rischio di un nuovo disammoramento della politica. Quella che passa oggi è una sorta di sindrome degli achei, «prima facciamo bottino e poi ce lo spartiamo», e sono diventati così saggi o così miopi da non litigare più sulle forme di Briseide. Per altro sono tutti così longevi e quel tipo di passione dovrebbe essergli piuttosto passata! Ma di fronte a ciò, che gusto può esserci della politica? E che dovere c’è allora di trovare percorsi nuovi, di trovarli lì dove etica e politica stanno insieme. Mi ha fatto molto piacere la settimana scorsa a Udine, la tavola rotonda con quattro vescovi, da Battisti a Bellomi, a Currò, al vescovo Bellomo. Tutti a fare una tavola rotonda con le ACLI e a dire che finalmente la nostra associazione aveva due elementi: una tensione profetica e anche un po’ di razionalità politica. Ecco perchè allora è estremamente importante avere questo senso della storia; lo ha avuto Giovanni Paolo II. Volevano fargli fare Pietro l’Eremita. Ma lui ha detto che non metteva il timbro della crociata e proprio in un momento così drammatico ha aperto il dialogo e con i mussulmani e con gli ebrei, mantenendo fedeltà a quel suo pensiero che trovavamo nelle ultime parti della «Sollecitudo rei socialis» che verso la fine è una innologia alla solidarietà e un’innologia alla pace, dove già allora Papa Giovanni Paolo TI diceva: «Non vi sarà pace se non attraverso il dialogo tra le grandi religioni monoteistiche». Tutto questo chiede di non fare conti meschini con la realtà, di avere il senso della storia più che della congiuntura, proprio per essere un pochino produttivi e un pochino saggi dentro la congiuntura. La formazione. Fin dall’inizio le ACLI sono azione sociale e formazione nell’azione sociale. Nel discorso del’55, il discorso che va sotto il nome delle tre fedeltà: fedeltà alla Chiesa, alla classe lavoratrice, alla democrazia, Pennazato diceva alla marea di aclisti che lo ascoltavano: «Non stancatevi di strappare qualche ora al riposo per maturare negli incontri sociali, nella serena ricerca fatta tra noi, la capacità di capire e di agire nella vita sociale. Semplice, ma bisogna farlo, bisogna recuperare dentro l’azione sociale, non ritirandoci in una villa a scrivere un nuovo Decamerone, non ce n’è bisogno seppur può essere condizione simpatica, dentro l’azione sociale trovare i momenti di questa riflessione. E’ meglio se poi è una riflessione non lontana dalla Parola di Dio». 10 E anche qui ne abbiamo indovinata un’altra: rilanciare queste ACLI voleva per esempio dire recuperare il Patronato. Però rilanciare le ACLI ridandogli continuamente anima. E’ qui che si vince o si perde, il resto sono salmerie. Guardiamoci da certo pragmatismo da finti furbi. Noi una scelta giusta l’abbiamo fatta: il riferimento alla Parola di Dio; avessimo scelto una formula teologica, anche la più avanzata, ci saremmo trovati ben presto in una gabbia d’acciaio. La parola di Dio è più liberante, chiama in campo tutte le competenze. Io credo sia stata davvero una scelta suggerita da Pio Parisi, ma credo a lui suggerita dallo Spirito, che poi è il vero direttore spirituale di tutti noi, se è vero che S. Teresina aveva l’abitudine di dire «Mon Directeur»: non era il direttore spirituale, era lo Spirito Santo. Credo che questa scelta sia stata molto giusta. Ma una seconda riflessione voglio fare e poi concludo sullo stile del nostro fare formazione. Ho detto azione sociale e formazione nell’azione sociale; nel Congresso di Milano abbiano tradotto in moderno questa frase dicendo le ACLI come impresa di formazione sociale: è la stessa cosa detta nell’oggi. E allora non volendo neppure sprecare questa occasione per altro così gettonata del centenario della Rerum Novarum, direi che va1 la pena di recuperare questa riflessione. Nel 1931 per la edizione di Vita e Pensiero esce un libretto: «1 tempi e gli uomini che preparono la Rerum Novarum», lo firmava tal Mario Zanatta. Nel dopoguerra abbiamo tutti imparato che dietro questo pseudonimo si nascondeva Alcide De Gasperi allora bibliotecario in Vaticano. Se andate a rileggervi quelle pagine troverete una grande attenzione alla cultura tedesca, al gruppo austriaco del Vögelsanga, all’arcivescovo di Magonza Mons. Von Ketteler, al Menning e via via. Ma la cosa importante da recuperare è questa: esiste, preesiste, esiste già una esperienza di lavoratori, di artigiani cristiani, di cenacoli di intellettuali: è riflettendo su questa che Leone XIII, un genio, ci dà l’enciclica «Rerum Novarum». Quel che viene prima è l’esperienza, questi gruppi c’erano già; è raccogliendo la loro testimonianza, è raccogliendo la riflessione sulla loro testimonianza che viene l’elaborazione della «Rerum Novarum». E’ a partire da un’enciclica, non a caso in molte chiese non lasciata leggere, osteggiata, che riparte un’esperienza. Su questo le ACLI nascono, perchè poi le ACLI sono dentro questa forma della Dottrina sociale della Chiesa. Non ci sarebbero ACLI se non ci fosse dietro questo fondamento, questo tipo di cultura, questo tipo di indicazione di un orizzonte e di un radicamento. C’è sempre questa circolarità, c’è un’esperienza e una riflessione sull’esperienza. E’ questo popolo di lavoratori, questo popolo di Dio in cammino: questo è il senso della nostra formazione. Un riflettere, come ci diceva Pennazato, sull’esperienza che facciamo, riflettere alla luce della Parola di Dio, con le culture che più ci aiutano in questo senso. Questo è il senso della formazione, questo dice il senso profondo della dottrina sociale della Chiesa, questo dovrebbe insegnarci l’origine e il senso della «Rerum Novarum». Altrimenti si fanno addobbi, roba decadente, barocco, che serve a niente. Questo è il senso, questo è il far memoria, per cui non resta un poster, per cui non resta una teca, non resta una zona pedonale, è il recupero dentro la vita quotidiana di tutto questo. Concludo nel nome di don Mazzolari. Sono andato recentemente a rileggermi una serie di cose di don Primo. Giovanni XXIII accogliendo don Primo lo salutò: «Ecco la tromba dello Spirito Santo in Val Padana». Diceva che bisognava cercare di guardare il mondo dal campanile, nel caso specifico era il campanile di Bozzolo, e noi lo dobbiamo guardare dal campanile aclista, senza cercare di cascar giù evidentemente. Di don Mazzolari ricordo due cose. La prima. Siamo nel ‘29 e Mussolini scrive ai federali italiani grosso modo così «Il clero italiano è a posto, fatta eccezione per alcuni preti e giornaletti del nord» e Mazzolari commentando questa circolare di cui era venuto a conoscenza dice: «Chi mangia non parla» è la saggezza di Bertoldo. Sapete la cosa che mi ha stupito in questo periodo? Mi sono convinto che in questo mondo e in questo momento c’è un solo modello, quello occidentale. Non esistono più quelle figure più o meno approvabili. Anche a Bagdad trovi o trovavi, dopo i bombardamenti, una città totalmente occidentale. Non ho visto un solo chador. Noi alloggiavamo in un villaggio turistico. Un paio di mattine prima di partire sento un gran cicaleccio. Vado a vedere, erano ragazzine di età ginnasiale, liceale, portate in gita lì vicino al Tigri con tacchetti, pantaloncini e radiolina. Tu le spostavi ad Abbiategrasso o a Lecce, c’era la musica araba, qui avrebbero sentito altra musica; la stessa cosa. 11 Quindi il problema vero è questo: c’è un modello occidentale disegualmente distribuito, questo è il problema vero. C’è solo questo modello che si va diffondendo in questo momento in maniera molto diseguale. Infatti quelle pressioni di cui dicevo di disoccupati, più o meno bibliche, che presto saranno alle nostre porte, derivano da qui. E quindi attenzione alla logica e alla saggezza di Bertoldo che «chi mangia non parla»; sarà bene invece parlare, interrogarsi per mettersi in strada. L’altra osservazione che voglio riprendere riguarda la nostra modalità di stare dentro questa condizione, di fare associazioni, associazioni di lavoratori cristiani, con le sue tre fedeltà alla Chiesa, alla classe lavoratrice, al mondo del lavoro nelle sue trasformazioni, alla democrazia. «Noi non siamo diceva Mazzolari — di coloro che si curvano per meglio dominare, noi siamo di quelli che si drizzano per meglio servire». Credo sia davvero un «logos», sia un’indicazione molto forte, molto aclista, questa capacità, questa dignità, questo senso forte di un’autonomia riconosciuta da tutti perchè conquistata sul campo e che però non si crogiuola in se medesima ma chiede con la grazia del Signore di mettersi al servizio degli altri. 12
Scarica