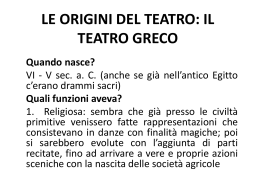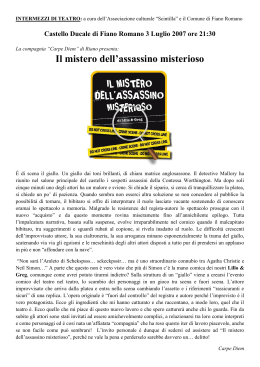Edward Gordon Craig, Il mio teatro. Introduzione e cura di Ferruccio Marotti Feltrinelli, Milano, 1971 Introduzione Il mondo di Craig è un mondo scomparso. E in esso Craig si era ritagliato un mondo a parte, dai confini rigorosamente tracciati e presidiati dall'Inefficacia e dall'Afasia. Inefficacia di un artista radicale, che progetta in solitudine e vuole realizzare ogni cosa in modo perfetto, talmente teso all'assoluto da preferire l’inazione ad ogni sia pur minimo cedimento alle esigenze della “pratica”, da temere in forma quasi maniacale che altri si appropri (e tradisca) ciò che egli ha faticosamente elaborato. “The enemies” erano gli altri, per Craig, coloro che volevano spingerlo al compromesso, coloro che non volevano sapere, che andavano respinti, ai quali si doveva parlare un linguaggio criptico, il linguaggio esoterico di chi si pone come oggetto di persecuzione. Afasia, anche, di colui che non nutre sufficiente fede nella parola e che, impossibilitato a comunicare attraverso segni teatrali assoluti, si serve di emblemi letterari: le forme precostituite del dialogo filosofico, della visione profetica, dell’excursus storico e filologico (dotte esercitazioni su improbabili fenomeni di anni o regioni lontane), della pagina ironica, dell'enfasi satirica. Chi non tenesse presente la fondamentale artificialità del linguaggio craighiano quale si manifesta negli scritti che qui pubblichiamo, difficilmente potrebbe ritrovare in essi la vivacità e la disponibilità di un'idea di teatro per molti versi ancor oggi feconda. Quando parla della sua poetica, Craig allontana il lettore, cerca di porlo nella scomoda posizione di chi legge un testo sacro, la buona novella di un teatro venturo. Posizione tanto più scomoda oggi, quando non solo rischiano di sembrarci inattuali (e inutilizzabili) le immagini di una prosa che risente di un gusto che dal nostro è troppo lontano senza esserlo tanto da assumere il sapore delle cose - un po' ingenue e un po' paludate - di un buon tempo andato; ma quando l’oggetto stesso di quelle immagini e di quella prosa - il concetto di regia, il linguaggio teatrale da Craig elaborati e definiti - sembra non più pertinente al dibattito teatrale contemporaneo, degno, invece, dell'attenzione dello storico per un'avventura estetica in sé conclusa ed esaurita. Partendo dalla consapevolezza del valore riduttivo che acquisterebbe una lettura craighiana volta esclusivamente a un recupero filologico e a una ricostruzione storica - dalla consapevolezza, cioè, che pubblicare oggi, in Italia, gli scritti di Craig (che solo la cultura anglo-americana, e in parte quella mitteleuropea, hanno in certa misura assimilato, mentre, ad esempio, anche in Francia essi sono stati trasmessi in maniera incompleta e non di rado fuorviante) acquista un valore che va al di là dell'interesse che essi possono suscitare presso gli addetti ai lavori solo se nel pubblicarli li si immette nel dibattito contemporaneo sul teatro abbiamo assunto l’idea di teatro di Craig come uno dei poli di tensione cui ancora si riferisce - sia pure, a volte, come alternativa da negare, in base alla quale definirsi opponendosi - la vita dello spettacolo dei nostri giorni. È una scelta motivata anche dal fatto che il valore nodale delle teoriche e dell'opera craighiana per la storia del teatro moderno sono un dato ormai largamente acquisito e su cui non fa conto tornare, così come ci sembra inutile ripercorrere una volta ancora l'arco della problematica artistica fra Ottocento e Novecento inserendo in esso lo svolgersi del pensiero craighiano, la sua utopia di teatro, che costituisce anche il primo tentativo organico di inserire la fenomenologia dell’evento scenico nella problematica estetica. In prima istanza, quindi, leggere Craig oggi può significare porsi il problema della regia. Regia non intesa come prassi empirica, irriflessa, di subordinazione degli interpreti a un direttore, ma come principio estetico di unità degli elementi dello spettacolo e della sua autonomia in quanto fatto artistico. Questa ricerca dell'autonomia linguistica dello spettacolo va certo correlata alle ricerche estetiche che in diversi campi si andavano conducendo sullo scorcio del secolo anche come conseguenza della mutata funzione delle arti nella società. Ma mentre potremmo dire, schematizzando, e ovviamente generalizzando, che la direzione della problematica intorno ad arti come la pittura, la scultura, l'architettura, la musica o la poesia è dettata univocamente dai loro rispettivi sistemi semiologici, l’ambito semiologico che delimitiamo con la parola “teatro" può comportare un duplice orientarsi della riflessione estetica. L'espressione "arte del teatro" (theatre, non drama) indica, infatti, l’organizzarsi dei segni in due diversi sistemi che spesso tendono a sovrapporsi, ma che permettono di separare teoricamente due differenti domini estetici. Da un lato il dominio dell'elaborazione artistica dell'attore, un'arte dell'uomo sull'uomo, il risultato, cioè, del formalizzarsi (se possibile) di un materiale che - sia pure comunicandosi attraverso segni fisici - è in ultima analisi costituito dagli impulsi psichici; dall'altro il dominio estetico dello spettacolo nel suo insieme, assunto come prodotto artistico unitario ed autonomo. Nel primo caso - radicalizzando i due termini dell'alternativa che abbiamo tracciato - la struttura dello spettacolo appare come una struttura sintattica attraversata perpendicolarmente dai sistemi di segni elaborati dagli attori, segni ad essa non omogenei e che essa serve soltanto a rendere leggibili (una struttura che tende per così dire ad atrofizzarsi e della quale, quindi, si potrebbe persino fare a meno); nel secondo caso, evidentemente, il linguaggio dell’attore va reso omogeneo con quello che si esprime dagli altri elementi lessicali che compongono l’unità dello spettacolo, deve risultare dalla pura gestualità, dalla negazione di ogni materiale che rimandi all'orizzonte psicologico: i segni di cui si serve l’attore si pongono accanto, cioè, a quelli costituiti dalle luci, dalle scene, dai costumi, dalle parole del testo, acquistano il loro senso solo in quanto sono ad essi correlati, vengono progettati in base alle intenzioni che fondono in unità gli elementi visivi e sonori dello spettacolo. Più avanti ci riallacceremo a questo ambito problematico, ma va notato fin d'ora che identificare l’arte del teatro nell'arte dell’attore (secondo la migliore tradizione del teatro ottocentesco, rivendicando l’autonomia del fatto teatrale di fronte a quello letterario) sembrò significare un precludersi la via per l’individuazione di un linguaggio artistico in senso stretto, nella misura in cui il linguaggio dell'attore sembrava rimanere un linguaggio "naturale": natura come opposto ad arte. Non si pensi subito alle teorizzazioni craighiane sulla Übermarionette: fin dal sorgere della piena consapevolezza dell'autonomia dell'arte dell'attore, dal suo inquadrarsi fra le "arti maggiori", sorse la parallela coscienza dell'impossibilità del linguaggio attorico ad esprimersi in segni "puri" come quelli che caratterizzavano le altre arti. L’arte dell'attore sembrava così destinata o a vivere in regioni totalmente separate da quelle in cui fiorivano l'arte del poeta, del pittore e del musicista, o a ritrovarsi continuamente bloccata dai limiti, imposti dalla fisicità dell'uomo usato come materiale artistico. Da qui l’alternativa della marionetta già in Kleist o nel dialogo di Hoffmann. Singolari pene di un direttore di teatro (il vecchio capocomico mostra la perfetta compagnia per un teatro ideale nella cassa che racchiude le marionette); da qui l’inquietudine di Stanislavskij di fronte ai quadri di Vrubel; da qui la frase della Duse, almeno nel senso in cui viene epigraficamente riutilizzata da Craig: “Per salvare il teatro bisogna distruggere il teatro: gli attori e le attrici devono tutti morire di peste”. Negare l'arte dell'attore così come si era definita nello spettacolo ottocentesco appariva veramente come una distruzione del teatro, era il confrontarsi con la tradizione non per operare un rinnovamento innestandosi in essa, ma per negarla e quindi inventare un linguaggio nuovo. L'isolamento e l’atteggiamento distruttivo degli “inventori” della regia - che troppo spesso si è ascritto a colpa o a riprova di una carenza di impegno sociale - appaiono così come il risultato necessario della logica del discorso: basta tener presenti i valori della civiltà teatrale del Grande Attore per comprendere come, con la regia, non si trattasse, in realtà, di riformare l’Arte del teatro, ma di fondare una nuova arte. La regia si conferma, anche da questo punto di vista, come un fenomeno affatto diverso da quell'unitarietà e dignità formale predicate dalla messa in scena, che cercava di tradurre nello spettacolo l’unità poetica del testo rappresentato; diverso anche dalla messa in scena verista e naturalista (i Meininger, Antoine...) che, applicando a tutti gli elementi dello spettacolo il carattere mimetico della realtà proprio dell'attore, restavano forzatamente al di qua (malgrado la somiglianza di certi atteggiamenti, e fermo restando l’interesse che riveste una progettazione dello spettacolo condotta sulla base di precise categorie culturali) della ricerca dell'autonomia del linguaggio teatrale. E ancora: la nuova arte dello spettacolo si contrappone allo spettacolo delle arti. Essa, dice in primo luogo Craig, non può essere il risultato di un'accumulazione e fusione di diverse modalità espressive, deve derivare dallo strutturarsi in un autonomo linguaggio teatrale dei singoli elementi linguistici che possono essere estrapolati dai sistemi delle diverse arti. Con l’esigenza di circoscrivere, diremmo oggi, un ambito semiologico esclusivo del teatro, quest'ultimo si precisa fondamentalmente come fatto visivo cinetico, come arte della visione del movimento. Tutti gli elementi che convergono sul palcoscenico subiscono, cioè, un processo che li scioglie da ogni riferimento esterno all'insieme autosufficiente dello spettacolo, che abolisce ogni significazione realistica, e li fonda come puri segni il cui significato deriva esclusivamente dall'intrecciarsi e dallo svolgersi dei loro mutui rapporti. Le modalità di un tale processo mostrano come l’autonomia del linguaggio teatrale che sta alla base delle ricerche craighiane si traduca in progettazioni concrete. Su ciò occorre insistere onde evitare che il discorso intorno a Craig si stemperi (come d'uso) da un lato nell’individuazione delle linee di una vaga e astratta idea di teatro, dall'altro nella descrizione di singole realizzazioni che, private del loro valore di indicazioni programmatiche, apparirebbero come i frutti isolati, come tali fin troppo facilmente assimilabili, dell'estro di un grande artista. È noto come il segno teatrale potesse assumere, nei piani craighiani, un valore simbolico; ma ciò che più importa è che un tale valore viene ottenuto solo come punto culminante di un processo per cui un determinato segno dotato di un significato mimetico, “rappresentazione di una cosa”, perde questo suo originario significato per assumerne uno letterale nel sistema dello spettacolo. L'autonomia del linguaggio teatrale non appare come il presupposto su cui si elabora la rappresentazione (che allora potrebbe risultare immediatamente da pure forme, luci, colori in movimento) ma è, in qualche modo, l’oggetto stesso dello spettacolo. Il movimento interno di questo è dettato dall'alternarsi di momenti di diastole e momenti di sistole attraverso i quali i segni scenici si chiudono, per così dire, su se stessi, negando i riferimenti - dianzi appena accennati alla realtà, per poi aprirsi a una significazione simbolica per via di autonomi procedimenti teatrali. È il ritmo che scandisce la prima vera regia di Craig (Dido and Aeneas di Purcell), salutata, fin dal suo apparire, come un fatto rivoluzionario nella storia del teatro inglese. Si individua, così, veramente una semiologia propria del teatro nella misura in cui non ci si limita a superare l’atteggiamento mimetico trapiantando sul palcoscenico simboli letterari o figurativi. A questo proposito è particolarmente indicativo l’elemento scenico che dominava l’inizio dell'Hamlet nella regia craighiana: il manto di porpora e oro che scendeva dalle spalle del re e della regina e si espandeva - fino a coprire metà della scena - in larghe onde da cui emergevano teste di cortigiani. Si trattava, evidentemente, di dar corpo a un'immagine precisa del potere regale, della corte come propaggine del re, organismo unitario che si opponeva al principe Amleto. A prima vista il procedimento di Craig sembrerebbe consistere semplicemente nell'aver visualizzato l’espressione metaforica secondo cui la corte è tutta raccolta sotto il mantello del re, nell'aver portato in primo piano, cioè, un elemento (il mantello regale) carico di significati simbolici. In realtà accade esattamente l’opposto: lungi dall'avanzare in primo piano, il mantello perdeva il suo valore di oggetto, non appariva come un mantello più grande che quindi deve significare qualcosa di più, si presentava come puro colore e volume, e acquistava un significato simbolico attraverso i rapporti intercorrenti fra quel colore e quel volume e gli altri elementi che organizzavano lo spazio scenico: la piramide di broccato d'oro da cui lame di luce traevano baluginii si opponeva ai toni grigi della parte avanzata della scena dominata da linee orizzontali, dove giaceva Amleto. Il simbolismo, risultante non da un sovrappiù di significato aggiunto al valore mimetico dell'oggetto scenico, ma funzione della crisi dell'oggetto stesso, del suo risolversi nel puro colore e nella pura spazialità, spiega il senso delle affermazioni craighiane secondo cui quella teatrale e l'arte del movimento. Il “movimento” è, innanzitutto, come si diceva, il risultato del procedere dell'oggetto da una "connotazione" realistica ad una connotazione esclusivamente teatrale, ma non si risolve in pura figuratività, nella pura presentazione di “modulazioni visive", frutto di un estetismo fine a se stesso. La visione scenica, cioè, non viene semplicemente “vista”, ma coinvolge ogni livello percettivo. S. A. Luciani, nel descrivere gli esperimenti di Craig con gli screens del Model stage, notava: “Così la scena, manovrata da un artista, diventa come uno strumento nelle mani di un abile improvvisatore. Non più cosa meccanica ed immobile, ma una cosa viva come l’attore, come la faccia umana, capace, pur restando sempre la stessa, di espressioni innumerevoli”. Il richiamo all'espressione umana, all'espressione attorica, è sintomatico: il regista, nell'idea di teatro di Craig, è l'artista che visualizza un ritmo organico, fisiologico ed interiore, traduce nei segni scanditi dell'arte la globalità della percezione psichica. È questo un aspetto fondamentale della poetica craighiana, che - proprio per la sua radicalità - non ha trovato un adeguato sviluppo nella storia della regia moderna (ci si è spesso fermati a una concezione della regia come fatto visivo, o come semplice subordinazione dei diversi elementi dello spettacolo ad un “regista comandante”), e che ha visto forse le sue più interessanti estensioni nelle teorie cinematografiche di Eisenstein. A ben guardare, il superamento della teoria "ortodossa" del montaggio cinematografico fondato sulla dominante in favore di una formulazione del montaggio basata sulla stimolazione totale dei vari organi sensori degli spettatori attraverso la totalità, cioè, degli stimoli - che trovano la loro unità nel fatto di essere dei riflessi fisiologici percepiti psichicamente - può essere vista come un'acuta applicazione al fatto cinematografico di un principio, che Eisenstein individua nel kabuki (o nella qualità “fisiologica” della musica di Debussy e Skrjabin opposta al "classicismo" di Beethoven), ma che è altresì inerente al concetto di regia di Gordon Craig. Anche il rifiuto eisensteiniano di una predeterminata definizione spaziale dell’immagine cinematografica, in favore di uno schermo circolare nel quale possano iscriversi le diverse inquadrature in figure corrispondenti ai loro interni caratteri, trova un'anticipazione teorica nell'uso craighiano degli screens che rifiutano il palcoscenico come “spazio dato” entro cui muovere o fare accadere qualcosa, e che rendono le stesse coordinate spaziali funzioni metrodome dello scandirsi profondo dello spettacolo. Lo spazio scenico non appare, così, spazio nel quale si vede, ma spazio visto, che ingloba lo sguardo da cui è determinato. Su questa linea è agevole precisare il valore della concezione della Übermarionette e della sostituzione del volto dell'attore con la maschera: la figura umana non è più la superficie su cui si esprimono degli stati d'animo, essa deve rappresentarli, è già il risultato di una visione, un tertium quid rispetto all'attore e al personaggio, implica - da parte dello spettatore - uno sguardo che veda “non con gli occhi ma attraverso gli occhi”. E al riguardo va rilevato come la ricerca craighiana sul linguaggio teatrale fosse - proprio in quanto ricerca linguistica - assimilabile anche nell'ambito di poetiche teatrali volte in direzioni affatto diverse da quella di Craig: pensiamo sia al predigra, il pregioco, e alla biomeccanica dell'attore mejercholdiano, sia al Verfremdungseffekt dell'attore epico brechtiano. L'apporto, al livello tecnico linguistico, della visione craighiana dell'attore sulle esperienze operative e sulle ipotesi teoriche sia di Mejerchol'd che di Brecht è storicamente comprovato da un lato dal lavoro che il primo condusse, come traduttore, intorno ai testi di Craig; dall'altro dai colloqui sulla problematica dell'attore che Craig ebbe con Brecht subito dopo la messinscena della Dreigroschenoper e che furono ripresi successivamente a Mosca nel 1935. Sono apporti che meriterebbero una più approfondita indagine attraverso l’esame delle carte private sia di Craig sia dei suoi interlocutori. Ma, prima di concludere queste indicazioni sulle modalità di presenza dell'attore nello spazio e nel tempo scenico teorizzati da Craig, non sarà inutile notare come, ad essere coerenti, solo il mezzo cinematografico possa integralmente tradurre l’espressività della figura umana nella rappresentazione, nella dimostrazione dell’Übermarionette (che non è semplicemente Marionette perché ad essa ineriscono tutti i segni propri dell'espressione corporea). E ciò non soltanto perché il cinema fissa immutabilmente, su di un mezzo di riproduzione meccanico, l’espressione selezionata dell'attore, i tempi e i modi della "maschera mobile", ma anche perché esso permette di formalizzare il processo secondo cui la figura umana si mostra come risultato, come pre- vista (anche, quindi, come il risultato di un giudizio che svela l’interna dialettica della realtà c'è da chiedersi, a questo proposito, se il mezzo privilegiato per realizzare il progetto brechtiano di attore non sia, oggi, il cinema piuttosto che il teatro). Non è un caso se il discorso sulle implicazioni ultime delle ricerche craighiane tende ripetutamente a sboccare in riferimenti alle possibilità del linguaggio cinematografico: ciò che rende necessario un tale percorso della riflessione critica su Craig è anche ciò che spiega la relativa sterilità, per quanto si riferisce alla problematica teatrale contemporanea, dell'idea craighiana di regia. Per fare un solo esempio: quando oggi un uomo di teatro come Grotowski pone all'origine delle sue ricerche la domanda stessa che si poneva Craig (l’individuazione di un autonomo linguaggio teatrale capace quindi di fondare la “funzione” del teatro), e l'esigenza - anche questa craighiana, come si diceva - di superare la concezione dello spettacolo come unione più o meno armonica di differenti mezzi d'espressione, i risultati cui egli giunge costituiscono per molti aspetti l’esatto opposto di quelli cui giungeva Craig. Un esame anche superficiale dell'opera di Grotowski mostra immediatamente come in essa vengano rifiutati precisamente quegli elementi lessicali costituenti il linguaggio teatrale così come si era definito dall'analisi di Craig. Il fatto è tanto più sintomatico in quanto il rifiuto non viene nemmeno esplicitato: non si tratta di una contrapposizione di “poetiche”, ma del sostituirsi di una problematica che esamina il teatro nel contesto del sistema degli spettacoli, a quella che esaminava lo spettacolo teatrale in rapporto al più vasto sistema delle arti. Ciò che qui importa notare, infatti, è l’incomparabilità del discorso craighiano sul teatro con quello - assunto a titolo esemplificativo e in ragione della somiglianza almeno apparente dei punti di partenza - di Grotowski; così come non si può dimenticare che usando il termine "teatro" indichiamo fenomeni non omogenei, che non possono essere racchiusi nel giro di un'unica riflessione generale, a seconda che ci riferiamo al diciannovesimo o al ventesimo secolo, o, per essere più precisi, a quegli anni del nostro secolo che seguono il definitivo affermarsi - come mezzo di comunicazione di massa e come autonoma espressione artistica - del cinema. Sia al livello sociologico sia a quello semiologico, infatti, gran parte dei fenomeni che nel secolo scorso costituivano l’insieme che indichiamo con la parola teatro andrebbero oggi individuati nell'insieme costituito dalla serie spettacolo teatrale, cinematografico e televisivo. Se, quindi, il concetto craighiano di regia nasceva dalla ricerca di un sistema di segni teatrali e soltanto teatrali equivalente, per autonomia, a quello delle altre arti (musica, pittura, architettura ecc.), la ricerca odierna è volta a reperire ciò che distingue il teatro dagli altri mezzi di espressione quando gli siano stati tolti quegli elementi che, nel sistema complessivo dei mass- media e delle arti dello spettacolo (cinema, televisione ecc.), si trovano in una zona di sovrapposizione. Nel primo caso si trattava di reperire la necessità del teatro in un contesto che potremmo indicare come quello dell'estetica idealistica, nel secondo caso il problema della necessità si pone nei termini concreti di un problema sociologico; quello, cioè, di individuare - quando ciò sia possibile - le ragioni di una sopravvivenza che non sia semplicemente il frutto della viscosità delle moeurs. Allo spettacolo della regia, che si realizzava come unitario ed autosufficiente sistema di segni, si contrappone, ora, lo spettacolo che è frutto di un processo di spoliazione (che è povero), e che, necessariamente, finisce con l’identificarsi nell'attore, nella comunicazione per mezzo del sistema psicofisico umano, quel sistema che Craig rifiutava come non dominabile e strutturabile artisticamente. E proprio nella ricerca di un superamento delle ragioni che determinavano un tale rifiuto gli indirizzi del teatro contemporaneo cui prima accennavamo si sono ricollegati alle scienze antropologiche e psicologiche e - nell'ambito della riflessione teatrale - alla tradizione stanislavskijana, attraverso l’eliminazione di tutto ciò che in quella tradizione vi è di mimetico, e quindi innestando su di essa suggestioni da Artaud (o da Witkiewicz). Anche senza voler confrontare la problematica craighiana con l’“opposto estremismo” delle ricerche contemporanee sull'attore, occorre notare che nel momento in cui oggi si esamina lo spettacolo teatrale è proprio il suo carattere di perfezione (di sistema artistico autosufficiente) a venir posto in questione. Il teatro è chiamato a trarre ogni conseguenza dal fatto di porsi come spettacolo che avviene hic et nunc (spettacolo che non dura) in contrapposizione allo spettacolo costruito una volta per tutte (spettacolo che dura, che si riproduce identico), che è quello cinematografico. Anche quando non si giunge, cioè, alla scelta radicale del teatro povero, è il teatro rozzo, immediato, che ancora una volta sembra palesare l’inattualità dell'idea di teatro craighiana. Ma quella di Craig è un'idea di teatro che non può essere chiusa definitivamente nell'ambito storico del problema registico. L’angustia di una tale prospettiva appare evidente non appena si pensi a come la regia sia per lui un momento che media il passaggio dal teatro inautentico al teatro come esperienza totale. Gli scritti di Craig sono, per molti aspetti, scritti esoterici. Pensando ad almeno un lettore attento egli scriveva: “Quell’uno capirà che io scrivo qui di cose che hanno a che fare col presente, col domani e coll'avvenire, e starà attento a non confondere questi tre differenti periodi”. Dagli strati meno superficiali delle pagine craighiane emerge un'immagine del teatro che non si limita a rinnovare la struttura dell'evento artistico, ma che cerca di immetterlo in maniera nuova nel circuito dell'esperienza. L'immagine di un teatro sistolico, per così dire, una sorta di Nô occidentale che - piuttosto di aprirsi verso il pubblico - accentri il pubblico su di sé; non un improbabile “teatro rituale”, ma un teatro, forse, dell'autocoscienza raggiunta per mezzo della precisione tecnica, dell'artificio del velare e dello svelare. È una proposta che si immette nel dibattito contemporaneo, quando gli uomini di teatro sentono l’esigenza di inventariare le possibilità del linguaggio teatrale prima di progettare i modi e gli scopi dell’intervento del teatro nella società, e quando non si vuole più correre il rischio di lastricare di buone intenzioni un edificio inabitato, che sopravvive sempre più inutilmente nel tessuto della metropoli. Craig, spogliato della veste liberty, ci appare come la prima proposta in termini mitici (e non ancora direttamente antropologici) di recupero di una cultura "altra" e di un significato “altro” per l’evento spettacolo. FERRUCCIO MAROTTI L’itinerario di Gordon Craig Edward Gordon Craig nacque a Stevenage, in Inghilterra, nel 1872, da Edward William Godwin, famoso architetto (e appassionato di teatro) e da Ellen Terry, giovane sconosciuta attrice, moglie separata del pittore vittoriano G. F. Watts. Godwin, che rimase accanto ad Ellen Terry solo pochi anni, morì quattordici anni più tardi. Ellen Terry divenne la più grande attrice dell’età vittoriana. Craig debuttò in scena nel 1878, a sei anni, facendo una breve apparizione in Olivia, al Court Theatre. Il 28 dicembre dello stesso anno Ellen Terry iniziò la sua collaborazione artistica con Henry Irving, il maggior attore e capocomico inglese dell’Ottocento, recitando con lui, nell’Hamlet, al teatro Lyceum di Londra. Durante la seconda tournée americana di Ellen Terry ed Henry Irving, nel 1885, Teddy (Edward Wardell, per la legge, essendo questo il cognome del nuovo marito della madre) sostenne una piccola parte, quella del ragazzo del giardiniere, nel primo atto di Eugene Aram, a Chicago. Poi recitò saltuariamente - a volte soltanto come comparsa - nell’Hamlet, in Much Ado About Nothing e in Twelfth Night. Solo quando ebbe compiuto sedici anni Ellen Terry decise di farne un attore. Ma, ha notato in seguito Craig, egli ormai era troppo autocosciente: avrebbe potuto diventare attore solo se avesse cominciato a recitare in modo sistematico da piccolo, per riuscire ad acquistare tutta l’esperienza necessaria prima di giungere all’età della ragione. Nel 1889 venne scritturato con salario, da Irving, al Lyceum, e nel cast del melodramma di Watt Phillips, The Dead Heart, apparve per la prima volta il nuovo nome d’arte di Teddy: Edward Gordon Craig. Lo stesso anno iniziò a studiare recitazione sotto la guida di Walter Lacy, un vecchio attore, e ad istruirsi metodicamente nei vari “mestieri” del teatro. Al Lyceum si rese conto poco per volta di venir sempre additato come figlio di Ellen Terry, e di non poter quindi lavorare senza essere notato, di non poter perdersi fra gli altri, farsi strada da sé ed emergere al momento opportuno con le proprie forze. Quest’idea lo perseguitava e gli impediva anche di apprezzare il privilegio di avere due maestri come sua madre ed Henry Irving. L’esempio e la guida di Irving, mentre in un primo tempo indussero Craig a tentarne un’imitazione che da esteriore divenne sempre più intima, determinarono poi in lui a poco a poco col progressivo formarsi della sua personalità - un senso di insoddisfazione sempre più acuto, poiché, scrisse egli stesso, “osservando Irving nell’ultimo atto di The Lyons Mail e di The Bells, sentii che era impossibile andar oltre quel punto e mi dissi che o dovevo contentarmi per il resto della mia vita di seguire Irving e diventare una sua pallida imitazione, o scoprire chi ero realmente io, ed essere me stesso”. Durante l’estate del '92, mentre il Lyceum rimaneva chiuso, Craig recitò in provincia la parte di Petruchio in The Taming of the Shrew, quella di Charles Surface in The School for Scandal e quella di Modus in The Hunchback. Nel 1893 incontrò William Nicholson e James Pride, due giovani artisti grafici, tramite i quali scoprì il disegno e la xilografia, che divennero presto le sue passioni dominanti. Nello stesso anno, essendosi sposato e non potendo quindi seguire Irving ed Ellen Terry nella nuova tournée americana, Craig mise in scena a Uxbridge, per uno spettacolo di beneficenza, On ne badine pas avec l’amour di de Musset. È il suo primo “tentativo” registico: la preparazione del lavoro gli richiese circa due mesi e mezzo; egli stesso disegnò le scene, aiutò i falegnami a costruirle, le dipinse e diresse le prove degli attori. Lo spettacolo fu replicato due sere, il 13 e il 14 dicembre. Nel cast degli attori, oltre a lui che sosteneva la parte di Perdicano, c’erano Italia Conti (Camilla) e Tom Heslewood. I documenti al riguardo sono molto scarsi: la stampa non si interessò a questo spettacolo di beneficenza. Una nota al programma stampato in quell’occasione dice che “i costumi sono un’esatta riproduzione degli abiti usati nel secolo XIV, e sono fatti su disegni di Viollet le Duc”. L’estate seguente recitò in provincia con la compagnia W. S. Hardy come protagonista in Hamlet, sostenendo anche altri ruoli: Cassio nell’Othello e Gratiano in The Merchant of Venice. Dopo altre tournées in cui recitò la parte di Cavaradossi nella Tosca e fu protagonista in Hamlet e in Macbeth, Craig tornò a lavorare, nel 1896, nella compagnia di Irving, e nel mese di luglio recitò con una propria compagnia al teatro Parkhurst di Londra, come protagonista in Hamlet e in Romeo and Juliet. Con Irving ebbe parti in Cymbeline e in Richard III. L’anno seguente fu di nuovo protagonista di Hamlet per sei repliche serali e due diurne al teatro Olympic, chiamato a sostituire un attore malato. La stampa londinese comincia a notare questo giovane attore pieno di talento. A proposito delle recite al teatro Parkhurst, il giornale “The Era” del 25 luglio 1896 scriveva di Craig nel ruolo di Amleto: “Ha dei tratti fini, espressivi e si muove con grazia e disinvoltura. È chiaro che ha studiato la parte con grande cura e ne dà un’interpretazione al tempo stesso intelligente, penetrante e sapiente. Gordon Craig è un serio rappresentante della nuova scuola di recitazione che si contrappone all’eloquio pomposo e declamatorio e ai procedimenti spesso meccanici della scuola tradizionale”. Su “The People”, più conservatore, il giorno seguente usciva un trafiletto di critica che gli rimproverara il suo stile “decisamente moderno” e lo metteva in guardia sui pericoli dell’uscir fuori dalla tradizione. Clement Scott - uno fra i più influenti critici teatrali dell’epoca - scriveva sulle “Illustrated London News” del 1° agosto 1895 che, pur notandosi ancora in lui il forte influsso della scuola di Irving, Gordon Craig aveva dimostrato di avere “delle idee nuove e interessanti per quel che riguarda i particolari dell’interpretazione e il movimento scenico”. Anni dopo Gilbert Coleridge (“Sunday Times”, 19 agosto 1923) ricordava ancora la sua interpretazione di Amleto come la più intelligente e la più nuova fra le tante da lui viste in Inghilterra. Del tutto inaspettatamente, allorché gli scadde la scrittura con il teatro Lyceum, nel dicembre del 1897 Craig pose fine alla sua carriera di attore a neppur ventisei anni, quando aveva cominciato ad affrontare con successo i ruoli più impegnativi. In questi anni di crisi Craig si diede a disegnare e a incidere su legno sempre più appassionatamente e iniziò anche a pubblicare una rivistina, “The Page”, di cui, a cominciare dal 1898, uscirono quattro annate, con una frequenza prima mensile, poi trimestrale. Ormai si guadagnava da vivere disegnando o incidendo per giornali e riviste. Nel 1900 pubblicò il volume di xilografie The Gordon Craig Book of Oenny Toys. Il numero finale di “The Page” per l’anno 1899 riportava una notizia importante: si era formata The Purcell Operatic Society, una società artistica che intendeva riproporre al pubblico le opere non più eseguite di Purcell, Arne, Händel, Gluck e altri compositori. Il numero dei membri era limitato a duecentocinquanta persone; costo annuale per gli iscritti: una ghinea. Direttore musicale: Martin Fallas Shaw. Direttore di scena: Edward Gordon Craig. La prima opera in programma era Dido and Aeneas di Purcell. Gordon Craig aveva conosciuto Martin Fallas Shaw, un giovane musicista, nel '97, poco prima di ritirarsi dalla sua attività di attore, ed erano divenuti molto amici. Nel suo Index to the Story of My Days, Craig ricorda: “Non avevamo un soldo - e questa era una seccatura minima. Non avevamo un teatro - ma non era niente di insuperabile. Non avevamo una compagnia di attori-cantanti, né potevamo ingaggiarne una perché ci sarebbe voluto un capitale di parecchie migliaia di sterline. Decidemmo subito di provare e riprovare finché tutto non fosse stato pronto - nessun limite di due settimane al massimo per le prove. Niente denaro - niente teatro niente compagnia. Aggiungete a questo: niente personale”. L’orchestra aveva una struttura identica a quella usata da Purcell nel 1680; nel programma per la rappresentazione ad Hampstead si avverte che “nel disegnare la scena e i costumi di Dido and Aeneas il direttore di scena si è preoccupato in particolar modo di essere assolutamente scorretto in tutto ciò che riguarda i particolari”. È evidente l’intenzione polemica con cui il regista desiderava presentare il suo spettacolo, in una Inghilterra dominata in quegli anni dall’influsso dei Meininger e della scuola realistica. Le prove, che durarono circa sette mesi, iniziarono verso la fine del 1899, nei vari locali che si trovarono disponibili ad Hampstead, dove vivevano i componenti della troupe, tutti dilettanti, se si eccettuano i due cantanti che impersonarono Didone ed Enea, i quali d’altronde provarono solo poche volte prima della rappresentazione. La sala, sulla cui piattaforma Craig costruì il proscenio e le scene del dramma, era quella del Conservatorio musicale di Hampstead. La piattaforma “era rialzata di circa un metro e venti dal livello del pavimento e si estendeva per tutta la larghezza della sala; sul fondo di questa lunga scena si elevavano più file di ripiani a gradinata, come nella maggior parte delle sale da concerto dell’epoca” (Craig, Index). Il regista, quindi, si dovette adattare alle proporzioni della scena già esistente; fece costruire, con travi da impalcature, un proscenio, che venne in tal modo a formare una cornice di color grigio alla scena, la quale si presentava particolarmente larga, contrariamente allo sviluppo verticale che hanno in genere i disegni successivi di Craig, e piuttosto bassa. Martin Shaw ricorda nel suo libro come ogni sera, durante le tre repliche dello spettacolo (17, 18 e 19 maggio 1900), le travi orizzontali che formavano la parte superiore del proscenio, su cui erano i due operatori delle luci e tutto l’impianto d’illuminazione (il ponte-luce), si piegavano sempre di più, tanto da far temere che si spezzassero da un momento all’altro. Craig si servì dunque fin da questa prima volta di luci provenienti dall’alto, eliminando ogni luce di ribalta. La cosa, da un punto di vista tecnico, era a quel tempo inusitata; ma c’era anche un’altra significante innovazione tecnica, a quanto risulta da una rivista dell’epoca: “L’illuminazione era eccellente; due potenti riflettori erano adoperati dal fondo della sala, sopra le teste del pubblico; ad essi si aggiungevano delle luci dall’alto del proscenio, ma le luci laterali e quelle di ribalta erano del tutto assenti; i costumi e coloro che li indossavano venivano a guadagnare moltissimo da quest’innovazione”. Per ottenere un effetto di profondità infinita alla scena, Craig aveva inoltre messo a un paio di metri dal fondale blu uno schermo grigio di garza, illuminato lateralmente con luci rosa, che producevano un colorismo cangiante, in cui la terza dimensione si vanificava nella profondità oscura. La prima scena, che secondo il libretto doveva rappresentare dapprima il palazzo di Didone, poi il porto, fu realizzata da Craig con in primo piano “un traliccio molto lungo coperto da rampicanti verdi e da fiori. Il traliccio, era interrotto al centro da un trono - quattro alti, esili pilastri che sorreggevano un baldacchino, e sotto di esso il trono, ampio e ricco di molti cuscini. Subito dietro una grande tela di fondo blu, blu porpora. Questo fondale si elevava oltre il limite di visibilità degli spettatori... così si provava (la gente diceva - per la prima volta) una sensazione di spazialità sulla scena” (Craig, Index). Per rappresentare il porto veniva semplicemente tolto il trono con i suoi cuscini rosso scarlatto e i due tratti di traliccio venivano congiunti. Nella seconda scena, che rappresentava il concilio delle streghe, con in primo piano le sagome scure di navi naufragate, Craig si servì di tutta la profondità del palcoscenico, comprese le gradinate di fondo, coperte di grigio, su cui agivano i personaggi del coro - parte dinanzi e parte dietro lo schermo di garza, su cui si proiettavano luci blu e verdi - veri protagonisti di questo spettacolo, con un’unità e una continuità di movimento che destò meraviglia. Il fine ultimo di Craig - come egli stesso dice - era “non di creare una sensazione di varietà bensì di creare una sensazione di unità”, e questo fu il principio che lo guidò in tutta la realizzazione scenica: a tal fine il proscenio, il sipario, il pavimento del palcoscenico e le gradinate sul fondo erano “di un caldo grigio neutro... L’effetto era quello di elevare e mettere a fuoco al massimo il quadro scenico, sicché ogni minimo pezzo di colore aveva un suo preciso significato... Vi era poi un chiaro intento artistico nell’inseparabilità dei costumi degli attori da quel che li circondava; essi erano essenzialmente parte del disegno d’insieme di ciascuna scena, e tutto questo portava ad una complessità armoniosa che è rara a teatro; i direttori dimenticano con facilità che un certo numero di costumi isolati, anche se belli, non creano un bel quadro” (M. Cox, Dress, in “The Artist”, luglio 1900, XXVII, pp. 130-132). I costumi delle fanciulle al seguito di Didone erano composti di due colori: un fondo verde, coperto da veli di mussola color porpora scuro. Anche il costume della regina si basava sull’accostamento di questi due colori. I colori cupi che caratterizzavano la regina e le ancelle avevano un preciso significato simbolico - quasi presagio di sventura - e si accordavano alla musica e all’azione, che era lenta e misurata. Enea aveva due toni fondamentali: il rosso porpora e il nero; i suoi attendenti portavano vasi rossi e oro, rami d’olivo verdi ed ancore, che dovevano produrre un effetto coloristico molto vivo nelle scene d’insieme. Per il secondo atto, che avrebbe dovuto rappresentare un boschetto sotto il chiaro di luna scena troppo costosa quindi, e difficile a realizzarsi sul palco di una sala da concerti - Craig ricorse al semplice fondale grigio, con luci verdi sullo schermo di garza. Su di esso producevano un fine effetto tonale i costumi delle fanciulle del seguito, avvolte ora in veli grigi. Gli uomini qui indossavano mantelli di un grigio scuro. Tutta la scena, cioè, era impostata sulle gradazioni di tono di un unico colore, e creava come un’oasi di pace, di rinnovato idillio fra i due amanti, dopo un primo atto ricco di colori violenti e cupi che evocavano l’addensarsi del dramma sul capo della regina. Il terzo atto comprendeva tre scene: la prima rappresentava la partenza di Enea e dei suoi uomini; per la seconda - che si doveva svolgere sotto terra fra le streghe - Craig si servì ancora una volta del semplice fondale; - e per la terza riprese lo schema della prima scena del primo atto, modificando - con un’idea geniale - tutti i toni dei colori mediante l’applicazione di filtri gialli alle luci poste sul proscenio. “Sotto il gioco di questa luce”, scrive ancora la Cox, “lo sfondo diviene di un blu cupo, luccicante, quasi traslucido all’apparenza, su cui il verde e la porpora producono un’armonia di grande bellezza, mentre i cuscini scarlatti del trono di Didone sono stati misericordiosamente sostituiti con cuscini neri”. Le scene che più colpirono il pubblico furono le due in cui comparivano le streghe. Qui Craig fece uno studio del chiaroscuro che sconcertò molti per l’arditezza con cui era concepito, ma non da tutti fu apprezzato nel suo giusto valore. Partendo dall’idea che la realtà, lo spazio, non preesistono alla rappresentazione, ma si vengono a configurare in rapporto all’azione e al movimento drammatico, immerse la scena nel buio, privandola di ogni indicazione spaziale e lasciando vedere solo delle forme nere che si muovono in un fermento continuo, ma smisurato. “Qua e là una maschera orribile, o un volto di cadavere colpivano l’occhio con un forte effetto. Queste maschere sono ciò che c’è di più orribile e spaventoso; sono un incubo, la personificazione di orrende emozioni”, scriveva la Cox. Craig, infatti, adoperò in questa sua prima regia delle maschere che egli stesso costruì, e di cui ci rimangono alcuni notevoli studi preparatori in acquerello, oltre alla trasposizione xilografica - che ne rispetta i tratti fondamentali, ma ne annulla gli effetti coloristici da lui stesso curata per 14 pubblicazione del programma. Le maschere erano in parte costruite, in parte direttamente dipinte sul volto dei coreuti. Il lavoro giunse a un così alto grado di unità perché Craig si occupò personalmente di ogni cosa, dalla scena all’illuminazione, ai costumi, ai movimenti dei coreuti e dei protagonisti, fino alla pubblicazione del programma. Nel 1901 Dido and Aeneas fu portato per una settimana, a partire dal 26 marzo, al teatro Coronet di Londra. Un’importante testimonianza di questa ripresa è data da Haldane Mac Fall che sottolinea la qualità innovatrice e antirealistica della messa in scena: “... il primo passo di un nuovo movimento che è destinato a rivoluzionare la messa in scena del dramma poetico... Lo spirito di ogni scena... era reso in uno schema coloristico, che cercava di accentrare il significato emotivo di quella scena”. L’unica differenza tra questa e la precedente edizione dell’opera fu l’abolizione delle gradinate di fondo. Lo spettacolo questa volta era più lungo, poiché oltre Dido and Aeneas comprendeva brani da Nance Oldfield che Ellen Terry, per richiamare pubblico allo spettacolo del figlio, recitò con gli attori della sua compagnia, e The Masque of Love su musica di Purcell, tratto dall’adattamento di Betterton da Prophetess, or Tbe History of Dioclesian di Fletcher. Questo intermezzo drammatico, The Masque of Love, fu la seconda breve messa in scena rivoluzionaria di Craig. “La scena”, dice il programma a stampa, “è una sala in un maniero. Cupido manda fuori i fanciulli a prendere le maschere, dal che comprendiamo, che essi stanno giocando a fare gli Dei e le Dee - Flora, Comus e gli altri. I tre gruppi, che rappresentano la Nobiltà, la Ricchezza e la Povertà, entrano, da parti diverse; hanno i polsi legati e vengono trascinati a forza, a rappresentare il rigido dominio di Amore. Le catene vengono sciolte. Il palo della prigionia diviene l’asta intorno a cui si festeggia la gioia, con un solenne movimento. ‘Odi, possente Amore!’. Alla fine di questo coro, si sente fuori scena un fruscio e un rumore di passi, che suscitano timore e attesa insieme. I sacerdoti di Bacco entrano, le maschere fuggono come cerbiatti in allarme. Segue un inno a Bacco, con vivaci movimenti delle mani e del corpi, e una danza intrecciata. Mentre gli occhi si beano, una gaia danza campagnola incanta l’orecchio, e il trionfo si chiude con la processione d’uso”. La scena fu realizzata in modo lineare: “tre ampi teloni (uno di fondo e due laterali), un grande fondale sul pavimento, e una tela tagliata sul davanti, tutto fu dipinto in un solo grigio, di tono uniforme” (Craig, Index). Craig ritiene che questa sia stata la cosa migliore da lui realizzata sulla scena; dalla ricerca spaziale e coloristica sulla scena era pervenuto qui al puro studio del movimento, del valore figurativo allegorico e ritmico del corpo umano. Anche in questa seconda regia Craig adoperò delle maschere, che riprodusse in disegni acquarellati comparsi in un Souvenir del 1902. È un uso indicativo della teorizzazione della maschera che Craig fece anni dopo nella figura mitica della Übermarionette, la Supermarionetta. Il fatto di utilizzare attori non professionisti ha esso pure un suo valore; lungi dal mettere in risalto alcuna loro dote di estemporaneità veristica, Craig li fece provare tanto a lungo da renderli dei veri e propri burattini dai movimenti ritmati in modo perfetto (cosa che un giovane regista mai avrebbe ottenuto da attori professionisti). Dopo circa un anno di studio e di prove, Craig inscenò insieme con Martin Shaw al Great Queen Street Theatre il terzo spettacolo della Purcell Operatic Society, Acis and Galatea di Händel su testo di John Gay, e una ripresa di The Masque of Love. Dopo sei sere soltanto, a partire dal 10 marzo 1902, si dovettero però interrompere le recite per mancanza di pubblico, nonostante i commenti favorevoli della stampa più qualificata. Anche in Acis and Galatea Craig semplificò al massimo la scena. Nel primo atto sostituì al “paesaggio campestre con rocce, fontane e grotte” del libretto, una semplice “tenda bianca” composta di sottili strisce verticali, su cui spiccavano i costumi di gusto geometrico degli attori-cantanti, mentre fra gli spiragli che si aprivano nella tenda a strisce si intravedeva un fondale bianco alla base, che attraverso una serie di graduazioni tonali diveniva rosa poi blu e infine, in alto, color indaco. Ma l’interesse coloristico nel primo atto era incentrato soprattutto sui costumi corali: quelli di Galatea e delle fanciulle constavano di una semplice tunica dalle cui maniche e dalla cui scollatura scendevano dei lunghi fitti nastri chiari, che producevano un forte accentuarsi del valore ritmico di ogni singolo movimento e portavano con sé un elemento di pura linearità che era in relazione con quella della scena; dal ginocchio in giù i loro vestiti erano disegnati a scacchi bianchi e scuri. I costumi dei fanciulli erano in tutto simili ai precedenti, tranne che per la minor lunghezza della tunica; vi erano poi i personaggi con “costumi di giunchi”, cioè di strisce verdi verticali aderenti al corpo e fermate alle giunture. La prima scena del secondo atto, una delle più belle pagine musicali dell’opera, in cui il coro cantava fuori scena l’aria Wretched lovers, mentre l’ombra di Polifemo con le braccia spalancate si proiettava sempre più gigantesca, fino ad avviluppare i due amanti abbracciati al centro della scena nuda, era preludio all’altra scena, che indusse W. B. Yeats a scrivere: “La scena in cui Polifemo uccide Acis appartiene ad un’arte che è stata sepolta sotto le basi delle piramidi per diecimila anni tanto è solenne”; qui Craig suggerì il senso del terrore mediante le luci rosse - che illuminavano il covo del gigante, seduto su di un alto trono che le vesti coprivano in parte, in modo da ingrandire la sua figura - e con ombre profonde. La scena seguente, la “tenda grigia”, trovava la sua nota fondamentale nell’impronta di tristezza per la morte di Acis, che la pervadeva. L’opera si concludeva con l’assunzione del pastore a dio dell’acqua e la sua trasformazione in fonte: lentamente la tenda a strisce si apriva sulla tela di fondo blu, in cui si illuminavano brevi linee perforate salenti verso l’alto con movimento curvilineo sempre più ampio. Qui l’illuminazione era duplice, davanti e dietro il telone, e davanti ai proiettori posteriori venivano fatti ruotare dei dischi perforati, che proiettando una luce stroboscopica attraverso i fori del telone, creavano l’effetto di uno zampillo d’acqua in movimento. Con questa terza messa in scena ebbe fine l’attività della Purcell Operatic Society, per motivi di carattere economico: all’ultimo spettacolo assistettero gli agenti venuti a requisire da parte dei numerosi creditori quanto era in scena. Un epigono della Purcell Operatic Society si può considerare anche la messa in scena di Bethlehem di Laurence Housman, all’Imperial Institute dell’Università di Londra. Craig dedicò circa sei mesi di preparazione a questo dramma sacro, che venne recitato alcune sere, a partire dal 17 dicembre 1902. Gli attori erano in parte gli stessi dell’opera di Purcell e di quella di Händel. Lo sfondo della prima scena era di un blu scuro, cosparso di stelle (cristalli di lampadario, sospesi in aria a diverse altezze): il palcoscenico era recintato da una staccionata; in esso stavano, disposti a gruppi, i pastori, vestiti di ampi mantelli tutti uguali di stoffa ruvida, con lunghi bastoni in mano, che durante lo svolgersi dell’azione valorizzavano i movimenti dando loro un’euritmia strumentale; in alcuni punti della piattaforma tele di sacco raggruppate per terra servivano a indicare il gregge. Ancora una volta al centro dello spettacolo era uno studio del rapporto di luci e movimento, in un complesso gioco chiaroscurale; ed anche questa volta Craig si servì di pochi elementi ripetuti (i costumi dei pastori, il cielo scuro e le stelle, lo steccato) per dare un’impronta di armonica uniformità allo spettacolo. Con questa messa in scena si conclude l’attività registica di Craig al di fuori del teatro più propriamente professionale. I consensi che aveva riscosso erano stati più che lusinghieri: specialmente gli artisti vedevano in lui chi avrebbe portato il teatro al livello delle arti superiori, traendolo fuori dagli schemi della fastosità tradizionale e del realismo positivistico. Si trattava di inserire questa reazione idealistica, questo che Craig definiva ritorno alle tradizioni più antiche della semplificazione e dell’unità, nell’ambito della routine teatrale londinese. Un primo esperimento in tal senso egli lo fece disegnando tre scene per il dramma musicale For Sword or Song di Legge e Rose, che suo zio Fred Terry presentò il 21 gennaio 1903 allo Shaftesbury Theatre. Nella prima scena Craig fece uso degli alti letti che aveva visto al palazzo di Hampton Court tante volte. Un’altra scena, con un vasto fondo blu, rappresentava una foresta che sorgeva da una collinetta ampia quanto l’intero palcoscenico. Il critico drammatico di “The Stage”, il 22 gennaio 1903, scrisse che in tutto lo spettacolo si notava “l’ispirato giudizio di Gordon Craig”. Lo stesso anno Ellen Terry decise di formare una propria compagnia indipendente, con Gordon Craig metteur en scène ed Edith, l’altra sua figlia, costumista. Il 15 aprile la formazione debuttò all’lmperial Theatre, un teatro periferico affittato da Ellen Terry, con I guerrieri a Helgeland, un dramma giovanile di Ibsen, il cui titolo inglese era The Vikings. Con questo spettacolo, oltre che proporre un criterio direttivo nuovo (che oggi si definisce registico) ad una formazione completamente professionale, Craig si cimentava in una tragedia di Ibsen (il dramma è del 1858). Nei Guerrieri a Helgeland c’è un romanticismo di impronta schiettamente nordica: è una saga norvegese, pervasa da una foga barbarica, da un maestoso crescendo tragico che, pur nelle incertezze di un autore ancora inesperto, è sconvolgente e richiama il Wagner dell’Anello dei Nibelunghi. C’è una tensione nei dialoghi dei protagonisti, che Craig tradusse visivamente in campi di forze musicali, trascendendo del tutto ogni aggancio realistico. Egli - nonostante Ibsen avesse scritto delle indicazioni sceniche precise per ogni atto trascurò le didascalie e, nel lavoro di mesi per disegnare le scene e i costumi, si fece guidare soltanto dalle reazioni della sua fantasia di fronte al semplice dialogo dei personaggi. Era questo un fondamentale principio che avrebbe teorizzato più tardi in un saggio di On the Art of the Theatre. Un rapido confronto fra le didascalie del dramma di Ibsen e i caratteri della scenografia di Craig è sufficiente a fare un quadro degli intenti d’arte perseguiti dal giovane regista inglese. La scena del primo atto dei Guerrieri a Helgeland è così descritta da Ibsen: “Un’alta costa, che in fondo scende ripida al mare. A sinistra un capanno di legno, a destra rocce e boschi di conifere. Giù nella baia si vedono gli alberi di due navi da guerra; a destra in lontananza isolotti scogliosi; il mare è molto agitato. È inverno; nevischio e bufera”. Craig ci vide in primo piano una roccia praticabile grigia, più indietro una costa, anch’essa grigia, che si levava altissima a sinistra e degradava fin oltre il mezzo del palcoscenico. Qui si svolgeva un duello barbarico, simile a quelli dei Samurai: movimenti lenti, misurati, carichi di tensione; poi bagliori improvvisi di spade. L’esatto opposto dei duelli teatrali di quegli anni. Ad indicare il cielo, il nevischio e la bufera Craig fece un fondale che avvolgeva tutta la scena, blu scuro, opaco. Naturalmente i critici notarono che l’azione si dovrebbe svolgere di giorno e all’aperto, non in una tenda gigantesca. Qui si intrecciavano le fila della tragedia. Con lo sfondo monotono, evanescente, Craig tendeva a creare uno spazio indefinito, che assumesse di volta in volta le dimensioni drammatiche dei personaggi. Dapprima vasto, quando la scena si popolava di guerrieri; poi opprimente, cupo, quando Sigurd presentiva l’imminente catastrofe. Il secondo atto si svolge nella sala delle feste in casa di Gunnar, dove sono convenuti tutti, tranne Örnulf, che ha promesso di giungere presto. La didascalia dice: “La sala delle feste in casa di Gunnar. La porta principale è nel fondo, porte più piccole alle pareti laterali. In primo piano, a sinistra, il grande seggio d’onore, di fronte a questo, a destra, un secondo seggio meno elevato. In mezzo alla sala, su un focolare in muratura, arde un fuoco di sterpi. In fondo ai due lati della porta, due tribune per le donne. Lungo i muri laterali, due lunghe tavole, con panche dalle due parti, che vanno dai seggi d’onore alla parete di fondo. Fuori è buio; il fuoco di sarmenti illumina la sala”. Nel creare l’atmosfera di questa che dovrebbe essere la festa di riconciliazione, Craig costruì una scena circolare le cui pareti erano costituite da tante strisce verticali di stoffa di differenti tonalità del grigio, eliminando qualunque porta; gli attori potevano entrare e uscire da ogni dove. I loro vestiti erano sgargianti, di seta, simili al colore delle pareti - non più i costumi barbarici di pelliccia e di ferro del primo atto. Al centro della scena un’ampia pedana rotonda, lungo i cui bordi si estendeva una tavola circolare, mentre al centro erano i seggi d’onore per i personaggi principali, dietro a un tavolo più piccolo. Una gradinata frontale congiungeva l’alto centro della scena al proscenio. I ventiquattro guerrieri che partecipavano al banchetto entravano dal fondo disponendosi intorno alla tavola circolare volgendo le spalle all’esterno, con i loro mantelli da festa tutti uguali. Un anello amplissimo incorniciava dall’alto, come un baldacchino, la piattaforma rotonda; fanciulle dai costumi bruni e dorati con cesti di frutta e portatori di torce vestiti di nero davano con i loro movimenti un senso di festosità al convito. L’atto terzo, secondo la didascalia di Ibsen, si svolge nella stessa sala del banchetto. Ma Craig ritenne che quest’atto, in cui Hiördis prepara, secondo magici riti, con i suoi capelli, la corda dell’arco con cui si vendicherà di Sigurd, non potesse svolgersi nello stesso ambiente in cui alla festa era succeduta la morte, alla gioia il dolore. Fece perciò una scena nella quale al valore simbolico del cerchio - la vita ora infranta - succedeva quella di una duplicità di piani paralleli, allegoria della vendetta e del perdono. Questi valori extrateatrali non procedono da un proposito intellettuale aprioristico, ma sono, direi, quasi delle verifiche a posteriori di un impulso spettacolare e artistico. Il luogo immaginato da Craig constava di un grande vano scuro che occupava tutta la parete di fondo, era velato da una tenda purpurea e delimitato in basso da un muretto, dal quale si accedeva con degli scalini - che scendevano da destra a sinistra - nello spazio del proscenio. Per rendere l’ambiente più raccolto, Craig ridusse in questo quadro l’ampiezza e l’altezza del proscenio, e fece svolgere la recitazione degli attori sui gradini e sul due piani, quello arretrato più alto e quello avanzato più basso. L’ultimo atto del dramma è così descritto da Ibsen: “Sulla costa. È sera; ogni tanto la luna appare fra le nubi temporalesche. In fondo un tumulo scuro, scavato di fresco”. Craig diede un semplice fondale di veli neri alla scena, costruendo in primo piano una collinetta grigia che degradava verso i lati ed il fondo, in modo da porte i personaggi su di un’infinità di piani differenti. La nota dominante era l’oscurità, in cui - grazie a una duplice illuminazione dall’alto, anteriore e posteriore - si stagliavano di tanto in tanto le figure, ora evidenti, ora evanescenti quasi alla vista. “... Solo per un istante, quando Hiördis sta in piedi per prendere di mira e colpire Sigurd, si scorge un lampo del cuoio verde e dell’acciaio lucente del costume che essa portava nel primo atto”. Nell’oscurità la sensazione di uno spazio preesistente si annullava, nell’ultimo atto come nel primo, e ogni momento del dramma, con una notazione di luci, assumeva la dimensione spaziale che più gli era propria. Il sistema perseguito da Craig nel primo e nell’ultimo atto dei Guerrieri a Helgeland, dell’oscurità tragica, vide la critica in posizioni contrastanti. Entusiasmò però al solito gli artisti, che ritrovarono in tutto ciò un carattere tipico dell’arte nordica, da Dürer a Rembrandt; la realtà, cioè, e lo spazio come determinati dal movimento drammatico, sorti insieme ad esso e non preesistenti come fattori oggettivi esterni alla rappresentazione. L’unico appunto mosso a Craig, da G. B. Shaw - in relazione al sistema dell’oscurità tragica - fu che non si vedevano in viso gli attori, e a questo si ribellavano per primi gli attori stessi. The Wikings, nonostante la grande validità artistica della messa in scena, finanziariamente si risolse in un fallimento. In pochi giorni, per rimettere in sesto le precarie finanze della compagnia, si dovette preparare una ripresa di Much Ado Ahout Nothing di Shakespeare, in cui Ellen Terry, nella parte di Beatrice, si era rivelata già anni prima la migliore interprete teatrale inglese. Craig disegnò per questo lavoro le scene in tutta fretta, e si valse di tutto il suo “mestiere” per far risaltare l’interpretazione di Ellen Terry. Il suo lavoro non era sorretto però dall’ispirazione e dallo studio profondo che avevano caratterizzato I guerrieri a Helgeland e le regie precedenti. Nel complesso, anche se da un punto di vista formale può apparire che le tende e le strutture cubiche adoperate qui da Craig preludano agli screens, questa messa in scena fu più una “digressione” nello svolgimento artistico del regista inglese che non un contributo determinante alle linee strutturali della sua arte; naturalmente non si vuol dire che sia mancato un valore e uno stile teatrale. Ancora una volta il pubblico, però, non mostrò di seguire lo spettacolo, tanto che pochi giorni dopo la compagnia si dovette sciogliere. Fu l’ultima regia fatta da Craig in Inghilterra. L’interesse suscitato fuori d’Inghilterra dal suo nuovo modo di concepire il teatro, insieme con le difficoltà incontrate nel proporlo all’ambiente conservatore britannico, indussero Craig ad accogliere nel 1904 l’invito, fattogli dal famoso mecenate il conte Harry Kessler, di trasferirsi in Germania. A Berlino Craig disegnò progetti scenici per Otto Brahm (Venezia salvata), per Eleonora Duse (Elettra) e per Max Reinhardt (The Tempest, Macbeth, Caesar and Cleopatra di Shaw), ma nessuno dei tre progetti fu realizzato in palcoscenico, perché troppo lontani dalla concezione realistica allora dominante (Brahm), o per ragioni di carattere pratico, stante la difficoltà economica di proporre certe soluzioni d’avanguardia nelle strutture commerciali del teatro (Duse), o perché Craig voleva avocare a sé non solo il diritto di progettare le scene, ma anche quello di dirigere gli attori (Reinhardt). Sempre a Berlino, nel dicembre 1904, Craig tenne la prima mostra dei bozzetti per scene teatrali e costumi; e nel 1905 pubblicò un dialogo intitolato The Art of the Theatre, in cui affermava la sua idea di teatro. Il libro venne subito tradotto in tedesco, in olandese e in russo, divenendo il punto di riferimento per l’avanguardia teatrale di tutta l’Europa, da Mejerchol’d a Reinhardt, da Rouché a Copeau, da Vachtangov a Tairov. È di questi anni l’incontro con Isadora Duncan e il suo sodalizio con la famosa danzatrice, che lo portò a girare l’intera Europa. Tramite la Duncan, Craig conobbe a Berlino Eleonora Duse; per lei, abbiamo detto, disegnò le scene e i costumi per Elettra di Hofmannsthal, che però la Duse non ebbe modo di rappresentare. Lo invitò invece a disegnare le scene di Rosmerholm di Ibsen, da mettere in scena a Firenze. Questo spettacolo rimane ancor oggi uno dei “miti” del teatro italiano, cui ci si riferisce spesso per sentito dire, ricordando di più alcune circostanze di sapore scandalistico che non il livello della rappresentazione in sé. Sarà bene pertanto chiarirne la storia. Un singolare documento al riguardo è costituito dal diario di un attore della compagnia di Eleonora Duse, Guido Noccioli. Scriveva il Noccioli: “Firenze, 4 Dicembre 1906. Giornata terribile. La prova della nuova scena per il Rosmersholm, il dramma di Ibsen. La signora adora questo lavoro. La scena nuova di cui parlo è ideata da un giovane pittore inglese: Gordon Craig, figlio naturale del grande attore Irving. È una scena strana tutta verde e illuminata da 10 riflettori. I mobili sono verdi, di tela uguale la scena: in fondo una gran porta a vetri dà su un paesaggio che ricorda stranamente quello dell’Isola dei Morti. L’altra porta grande è coperta da un velo bleu. Altri veli sono ai fianchi. Un sogno! Piacerà al pubblico? La signora è entusiasta”. In soli dieci giorni di intenso lavoro Craig aveva creato per Rosmersholm un’ampia scena unica, di tinta uniforme, color dell’indaco, molto alta, con due sole quinte laterali, con alla base le sagome dipinte rispettivamente di un secrétaire e di un altro mobile. Al centro della scena un tappeto, un ampio tavolo con sedie, un divano ed una lampada, sotto il cerchio della cui luce si svolgeva la vita della casa. Nella parete di fondo due enormi aperture, chiuse alternativamente da una tenda, anch’essa color dell’indaco, attraverso l’una delle quali - quella di sinistra - si vedeva, dipinta su di una tela di fondo, una strada in un parco, e attraverso l’altra una lunga scalea. Le luci cadevano dall’alto, discrete, lasciando la scena in leggera penombra. Solo quando si apriva l’ampio vano a sinistra della parete di fondo, la stanza si inondava di luce, di sole. Lo spettacolo andò in scena al Teatro della Pergola, il 5 dicembre 1906. Enrico Corradini scrisse: “...il palcoscenico appariva trasformato, veramente trasfigurato, altissimo, con una architettura nuova, senza più quinte, di un solo colore fra il verde e il cilestrino, semplice, misterioso e affascinante, degno insomma di accogliere la vita profonda di Rosmer e di Rebecca West... La scena è la rappresentazione di uno stato d’animo”. Anche in questo caso, come già era accaduto per gli spettacoli di Craig a Londra, il pubblico nell’insieme rimase del tutto insensibile di fronte alla scena, tanto che l’amministratore della compagnia decise di non replicare più lo spettacolo a Firenze. Non è a dire d’altra parte che la Duse provasse per l’arte di Craig un entusiasmo semplicistico, non critico; c’è infatti un biglietto, in cui ella gli scrisse: “Prière! N’oubliez pas que le 2nd et 3me acte doit être jour. 1er soir - et 4 me nuit. N’oubliez pas - et pardonnez le travail fait sans tout le nécessaire! E. D. Merci, merci”. Dove si vede come anche Eleonora Duse stentasse ad accettare la luce psicologica, atemporale, posta solo in funzione degli stati d’animo dei protagonisti, che Craig aveva già dalle sue prime regie sostituito alla luce-tempo: ma su di un testo come questo di Ibsen la cosa era ben più rivoluzionaria. Eleonora Duse, che Craig volle vestita di bianco in iscena, istintivamente comprese, o meglio rimase suggestionata dalla potenza emotiva, “di natura musicale”, come acutamente la definì Corradini, che emanava la scena, e l’indomani, prima che Craig lasciasse Firenze, gli scrisse: “Merci. C’est ma première parole ce matin. J’ai travaillé hier soir dans le rêve - et lointaine. “Vous avez travaillé dans des conditions très penibles - et d’autant plus je vous dis: Merci. “J’ai compris hier soir votre aide - et votre force. “ Encore: Merci. “J’espère que nous travaillerons encore, et avec Liberté et joie. E.”. La Duse chiese a Craig di disegnarle ancora altre scene per i drammi di Ibsen, divenuto ora la sua “buona forza”. Secondo gli accordi presi, si incontrarono il febbraio dell’anno seguente a Nizza, dove la Duse avrebbe dovuto replicare Rosmersholm. Craig portò con sé i bozzetti per La donna del mare; alla Duse piacquero molto, ma non fu presa alcuna decisione al riguardo per motivi di carattere economico; pregò soltanto l’artista di vedere come erano state montate le sue scene nel teatro cittadino. Qui Craig si trovò di fronte ad uno spettacolo che lo fece andare su tutte le furie: la scena era parsa troppo alta per il palcoscenico di quel teatro, così ne erano stati tagliati circa settanta centimetri lungo tutta la base, in modo che il secrétaire disegnato sulla quinta di sinistra ed il mobile su quella di destra risultavano l’uno completamente senza gambe, e l’altro tagliato a metà nel senso dell’altezza; inoltre le proporzioni delle due aperture di fondo erano state alterate, e i due sfondi, del viale nel parco, e della scalea, anch’essi malamente decurtati, avevano perduto ogni valore prospettico. Craig, ferito nel suo orgoglio d’artista, scrisse furente a Eleonora Duse: “Se un uomo rinunciasse all’intera sua vita (quasi fosse un niente) per il lavoro - volentieri -, solo questo potrebbe far rinascere l’Amore per il teatro. Null’altro potrà farlo. “Noi siamo tutti tutti troppo egoisti, vani ed egoisti. Ed è questo che uccide il lavoro. Voi forse siete la più egoista. Penso bene a quel che dico. Vi dico ciò con sempre tutto l’affetto, l’ammirazione ed il rispetto, però sono furioso oltre ogni dire”. La Duse stessa, pur offesa, non gli seppe dar torto, e rispose dolorosamente con parole sibilline: “Ce qu’on a fait avec votre décor, on le fait depuis des années pour mon art”. Ma egli non volle più collaborare con lei, ritenendo che la sua opera non fosse stata affatto compresa. Pure, l’esperienza di Rosmersholm aprì un periodo di importanza capitale nella vita artistica di Craig. Qui egli aveva portato all’apice le intense possibilità emotive insite nelle forme figurative più semplici, nel dualismo esistenziale (vita-morte) riportato su scala cromatica (cupo o chiaro, sole o luna). La sua posizione antidemocratica derivava dal fatto che egli era riuscito a cogliere l’essenza spaziale attraverso uno studio rigoroso delle proporzione e della prospettiva scenica. Questo era ormai per Craig un punto di arrivo nella sua ricerca dell’equilibrio, di una nuova intelligenza spaziale, di una sostituzione dello spazio vuoto, libero, a quello affollato da masse di oggetti; ed era al tempo stesso punto di partenza per quella ricerca dell’intera realtà poetica e spaziale dell’oggetto al di là delle leggi temporali, che sarebbe stata - di lì a poco - una sua scoperta fondamentale nel campo del teatro. Nel 1907 Craig, trasferitosi a Firenze, iniziò a disegnare una serie di acqueforti, che illustravano una nuova idea di scenografia totalmente rivoluzionaria: gli screens, le “mille scene in una”, una scena tridimensionale dalle infinite possibilità di movimento: visioni di rigorose strutture monolitiche mutevoli, un continuo misurato movimento di forme verticali e di luci, immagini astratte di stati d’animo, ricordi, miti; in questo scenario irreale si muoveva l’utopia dell’attore perfetto, disincantano, la Supermarionetta. Da Firenze nel 1908 Craig cominciò a pubblicare una rivista dedicata totalmente all’arte del teatro, “The Mask”, attraverso cui diffuse il suo credo per oltre 20 anni. Nello stesso anno fu invitato da Stanislavskij per realizzare la messa in scena di Hamlet al Teatro d’Arte di Mosca: fra alterne vicende, in tre anni di lavoro, fu costruito uno spettacolo pieno di intuizioni geniali, che rifletteva nel dramma di Amleto il dramma di Craig, l’afasia, l’impossibilità di comunicare al mondo il proprio messaggio. Craig giunse a Mosca l’1 novembre 1908 per prendere i primi contatti con l’ambiente del Teatro d’Arte e per definire gli accordi circa la regia. Qui strinse subito amicizia con Suler*ickij, assistente e grande amico di Stanislavskij, e spiegò come vedeva l’arte del teatro e in particolare la tragedia di Amleto. “In Hamlet quel che noi vogliamo rivelare al pubblico non è il carattere o la psicologia dei personaggi; noi siamo qui per interpretare un Poema più che un Dramma. Hamlet è un Poema drammatico più che un Dramma poetico. “Se mi è permesso adoperare una parola che ha diversi significati, Hamlet non è un dramma ‘naturale’, è essenzialmente un dramma ‘non naturale’, se lo paragoniamo agli ultimi drammi di Ibsen e a quelli del vostro maestro Cechov. “I fatti e i personaggi della storia si muovono secondo linee non naturali. All’inizio del dramma - o meglio, del poema - siamo condotti proprio in presenza del ‘non naturale’, del ‘soprannaturale’. La storia è narrata in modo ‘non naturale’; i versi prendono il posto della prosa, cioè il modo di parlare non naturale prende il posto di quello di ogni giorno. Io lo definirei un parlare sopra naturale... è la Poesia. “E per questo sarebbe assurdo pensare di tradurla in prosa. Sarebbe un errore recitare i versi con l’intenzione di rivelare í pensieri della vostra mente, o i pensieri della mente di Amleto o di Orazio. lo penso invece che voi dobbiate recitarli con l’unico intento di rivelare la bellezza dell’anima di Shakespeare”. Le linee generali dell’interpretazione craighiana dell’Hamlet sono riassunte dallo stesso Stanislavskij nel suo libro di memorie La mia vita nell’arte. “Craig ampliava moltissimo il contenuto spirituale di Amleto. Per Craig, Amleto era il migliore degli uomini che passava come un capro espiatorio attraverso il mondo. “Amleto non era un nevrastenico e ancor meno un pazzo, ma era divenuto diverso dagli altri uomini per aver spinto lo sguardo un solo momento al di là del muro della vita entro il mondo futuro, dove suo padre soffriva. “Nella mente di Amleto la realtà della vita subiva una trasformazione. Egli scrutava a fondo nella vita terrena per risolvere il mistero ed il significato dell’esistenza; amore e odio, i convenzionalismi della vita di corte, cominciavano ad assumere per lui significati del tutto diversi e i problemi che gli venivano prospettati dal padre assassinato - troppo ardui per un semplice mortale - lo portavano alla confusione della mente ed alla disperazione. Se si fosse potuto risolvere tutto con l’assassinio del nuovo Re, Amleto non avrebbe esitato un momento, ma la questione non si fermava solo all’assassinio del Re. Per alleviare le sofferenze di suo padre, era necessario purificare dal male tutta la corte, era necessario passare a ferro e fuoco tutto il regno, distruggere il peccato, respingere i vecchi amici dall’anima corrotta, come Rosencrantz e Guildenstern, salvare i puri di cuore come Ofelia dalla rovina terrena. “Queste torture inumane facevano di Amleto una specie di superuomo, agli occhi dei semplici mortali che vivevano la loto monotona vita di corte in mezzo alle piccole preoccupazioni quotidiane; un uomo diverso da tutti gli altri, e perciò pazzo. Allo sguardo miope dei piccoli uomini che non solo sono incapaci di riconoscere il mondo dell’al di là, ma che non sono neppure in grado di vedere oltre gli stretti confini delle mura del palazzo, Amleto appare naturalmente anormale. Parlando della corte, Craig alludeva a tutto il mondo”. Amleto, diceva Craig, “è riuscito semplicemente a portare a termine in due mesi un’impresa che si è tentato di realizzare per secoli in tutte le corti d’Europa: ha deciso di purificare la vita sociale e pubblica dall’oscurità morale e dalla degenerazione. Si è messo al lavoro con un fine preciso e con l’entusiasmo di un uomo giovane, virile, crudelmente ferito. Le sue idee sono logiche, egli ha ragionato e meditato ogni movimento e ogni atto, in quel breve momento di tempesta e di tensione che finisce nella tragedia. Questa è la mia idea di Amleto”. Craig sin dal primo momento aveva deciso di adoperare per la messa in scena a Mosca i suoi screens, con pezzi aggiunti, scale, cubi, parallelepipedi, in rigorosa proporzione. All’inizio dello spettacolo gli screens dovevano formare come una parete, una continuazione architettonica alla platea. Poi, nella semioscurità, dovevano muoversi, assumendo posizioni determinate. Delle luci, provenienti dall’alto, avrebbero illuminato la scena, secondo un sistema di illuminazione a “raggi e macchie”. Tale sistema era stato studiato da Craig proprio per il Teatro d’Arte, e tendeva ad ottenere risultati simili, ma non ugualmente perfetti, a quelli che egli raggiunse in seguito con il suo Model Stage. I “raggi” erano prodotti da proiettori mobili, che nella quasi totale oscurità facevano scorrere una luce diretta, radente, sugli angoli degli screens o sui personaggi, creando ombre e guizzi improvvisi. Le “macchie” erano invece un’illuminazione diffusa, con più filtri di colore di varia tonalità, che permettevano di produrre zone di colore o zone scure. L’artista inglese voleva creare nella rappresentazione uno stridente contrasto fra i due mondi, quello di Amleto e quello della corte. Egli vedeva quest’ultimo, nella seconda scena del primo atto, attraverso gli occhi del Principe Danese: era tutto dorato, dagli screens ai costumi, fino ai volti dei cortigiani e del Re. Amleto sedeva in primo piano, vestito di nero, ma più che seduto era disteso, con le braccia aperte, la testa reclinata sulla spalla, simile al Cristo deposto dalla croce. E qui aveva la visione torturante della corte: alle sue spalle, in una marca di broccato color oro, si svolgeva, con la sua chiara impronta di corrotta ingenuità, la vita lussuosa del re. Il lavoro in comune di Craig e Stanislavskij sulla tragedia di Shakespeare ebbe inizio con una serie di colloqui a tavolino in cui Craig, col testo del dramma alla mano, spiegava a Stanislavskij e Sulel*ickij, che gli facevano da assistenti, qual era la sua interpretazione di Hamlet. Erano lunghi monologhi di Craig, che spesso si trasformavano in dialoghi o addirittura in battibecchi. L’interpretazione dell’Hamlet che Craig delineava a Stanislavskij era senza dubbio alquanto personale. E vorremmo notare come molte delle sue idee realmente precorrevano i tempi. La calma nella recitazione - per dirlo in termini tecnici: la recitazione sdiaframmata, priva di tensione - è, ad esempio, uno del cardini del teatro epico di Brecht. E al teatro epico ci richiamano anche le inserzioni di elementi dimostrativi di straniamento nel dramma, quale l’operaio nella scena di Polonio, Laerte e Ofelia; l’idea craighiana di rendere il pubblico cosciente di trovarsi a teatro è poi tipica delle forme più avanzate di teatro oggi esistenti: il pubblico dev’essere libero di giudicare e di gustare ciò che vede, e non deve abbandonarsi passivamente allo spettacolo. Il simbolismo dell’interpretazione craighiana della tragedia si tramuta poi spesso in presentimenti espressionistici, tanto esasperata è la carica espressiva che ha in sé. In modo particolarmente originale è svolta da Craig l’idea base del dualismo di spirito e materia, di vita e morte della dialettica non risolta nella tragedia. “Fin qui abbiamo visto due mondi, uno di fronte all’altro: quello di Amleto e quello della corte. In primo piano Amleto disteso su due cuscini grigi, neri; sembrano quasi una tomba aperta. Un velo enorme, trasparente, ampio quanto tutto il palcoscenico, lo separa dal mondo della corte. Il mondo della tirannia e dello splendore è tutto d’oro, con degli sprazzi di colori violenti, diabolici. È una scalea, una piramide che ha al vertice il re e la regina. Un enorme mantello d’oro e di porpora scende dalle spalle del re, dell’usurpatore, e copre tutta la scena, formando tante onde dorate. Dalle creste delle onde emergeranno le teste dei cortigiani rivolte in su, verso il trono. La corte noi la vediamo attraverso gli occhi di Amleto, e la ascoltiamo attraverso la maschera delle parole. Ma quel che sentiamo è falso, quel che vediamo è vero. “Fra le luci offuscate di nero guizzeranno i raggi del proiettori, e l’oro luccicherà con riflessi paurosi; il presagio della sventura; si sentiranno musiche stridenti, piene di dissonanze. “Questa scelleratezza, questa tirannia, questo splendore si deve sentire, è fondamentale! “Poi, quando si passa al monologo di Amleto, tutto quel che è dietro le sue spalle diventa a poco a poco più scuro; la corte a poco a poco scompare e si perde in una calda oscurità; le musiche stridenti e i rumori si attenuano e svaniscono. “Poi di nuovo si sentirà il suono delle campane, bello, triste, rotto come un singhiozzo lontano. Il monologo di Amleto non è fatto di riflessioni; Amleto è sull’orlo della disperazione, tutto gli danza davanti agli occhi, i pensieri gli sfuggono dalle labbra per la pena che sente...”. Il violento, stridente contrasto fra il mondo della corte e il mondo di Amleto veniva evidenziato da Craig anche nei singoli personaggi. Ogni cosa era vista attraverso gli occhi del principe danese: per questo il re Claudio è trasformato in un bull-dog, oppure in un essere gonfio, a metà fra il serpente e la testuggine. Lo stesso accade agli altri cortigiani: Rosencrantz e Guildenstern, nella visione paradossale dell’artista inglese, sono due serpenti; quindi vanno vestiti di lunghissimi abiti verde screziato, con uno strascico e un piccolo turbante che fascia loro la testa, privandoli di ogni caratteristica umana. La loro posa abituale è con le braccia conserte, le mani nelle maniche, come i cinesi; così appaiono simili a due serpenti rizzati all’impiedi. Di questo passo, il cortigiano Osric è un camaleonte o un pavone, le guardie di Claudio degli orsi, Polonio un rospo... Solo Orazio è un uomo, vicino ad Amleto. Poesia, fantasia, divagazione da un lato, e dall’altro realtà, psicologia, razionalità, si scontravano in modo sempre più insofferente e clamoroso. Da un lato Stanislavskij era proteso nella ricerca dei sentimenti, delle azioni da leggere fra le righe del dramma; dall’altro Craig insisteva nella sua idea di non fare altro che visualizzare la poesia. Ormai Stanislavskij vedeva svanire la sua speranza di convincere Craig a studiare Amleto dal suo punto di vista. Una volta scartato il criterio di interpretare il dramma secondo i criteri di un naturalismo psicologico, pressoché tutte le obiezioni del direttore del Teatro d’Arte venivano a cadere, e Craig poteva finalmente sognare in piena libertà il suo Amleto ideale. Finché Craig è a Mosca Stanislavskij si limiterà ad accogliere tutte le sue idee registiche. Non appena sarà partito però sull’impostazione idealistica craighiana cercherà di sovrapporre l’analisi psicologica dei personaggi, nel suo lavoro con gli interpreti dell’Hamlet, ottenendo naturalmente dei risultati assai poco unitari. Uno dei tratti più singolari dell’impostazione registica di Craig era l’idea di visualizzare, di drammatizzare scenicamente i monologhi di Amleto. Craig aspirava a creare un luogo ideale, avulso da ogni realtà contingente, in cui le riflessioni solitarie del principe danese trovassero una dimensione spaziale dinamica loro propria. Musica, poesia, luce, architetture essenziali, rigorose, ispirate al primo rinascimento fiorentino, tutto doveva contribuire a creare un’atmosfera di sogno. A volte, la sua fervida fantasia portava Craig a concepire soluzioni scenografiche fin troppo ardite che, in gara con le parole stesse di Shakespeare, avrebbero dovuto suggerire quei pensieri, quelle intuizioni che non sono traducibili in parole. Tale, ad esempio, era il caso del monologo “Essere o non essere”, per il quale il regista inglese proponeva un’interpretazione degna d’interesse, anche se - ai nostri occhi - viziata dal gusto per un simbolismo assai acceso, che la faceva apparire addirittura bizzarra. “Al centro il lungo, enorme corridoio della reggia, che si perde in lontananza, sul fondo. Non è più luccicante d’oro, ma è opaco, grigio: agli occhi di Amleto ha perduto tutto il suo inutile splendore. Sul davanti, ai lati, gli screens formano come due nicchie. Una, che si vede in trasparenza, dietro un velo di garza, è illuminata: è qui che il Re parla con Polonio, Ofelia e la Regina. Egli ha in viso una maschera e le sue mani sembrano artigli. Nell’altra nicchia, dal lato opposto, si rifugia Ofelia, mentre dal fondo del corridoio, nell’oscurità, viene Amleto. “Tutti, tranne Ofelia che è al buio, escono. “Vediamo attraverso un grande velo di garza Amleto che viene dal fondo. Nell’aria si sente una musica, una musica come quella di Bach, una musica grave, che d’ora innanzi deve fare sempre da sottofondo, piano e forte in alternanza. “Amleto sente la musica e sorride, ride con lei come in un duetto. Nella parete a sinistra, in un fascio di luce d’oro, appare a tratti e scompare una figura femminile, simile al sole. Ma, sulla parete opposta ora si intravvedono appena delle ombre oscure: le ombre della vita terrena; strisciano, odiose, dal basso, dall’inferno. Amleto le guarda con terrore: vivere ancora significa soffrire, torturarsi... “La figura dorata, splendente, lo chiama dall’altra parte, lo chiama a sé lontano da tutto... È la Morte. Amleto è sorpreso e felice. Sorride, sente nell’aria la musica e vede l’immagine luminosa della Morte. La musica è la voce della Morte, che sgorga come una fontana tra le parole di Amleto...”. Amleto e i commedianti: queste, per Craig, erano le due “forze”, i due elementi positivi che agiscono nel dramma. E l’azione congiunta di queste due forze attive aveva luogo nella famosa “mouse trap scene”, in cui il re Claudio assiste alla rappresentazione dei comici. Dinanzi ai suoi occhi gli attori raffigurano l’assassinio del duca Gonzago, avvelenato dal nipote, che poi sposa la sua vedova. Il turbamento di re Claudio di fronte a questa che Amleto chiama “la trappola per topi” conferma definitivamente al principe danese l’assassinio del padre. È Stanislavskij stesso che, nelle sue memorie, ricorda la realizzazione di questa scena: “Craig qui aveva creato un grande quadro, trasformando il proscenio del teatro in palcoscenico per lo spettacolo di corte. La parte posteriore della scena, in fondo, rappresentava la platea dei cortigiani. I commedianti e il pubblico della corte erano divisi dalla enorme botola che avevamo nel nostro palcoscenico del Teatro d’Arte. “Due alti pilastri delimitavano ai lati il boccascena. “Dalla scena preparata dai commedianti c’era una discesa, che dava nella botola, mentre sul lato opposto la scala risaliva più ampia fino all’alto trono, dove sedevano il re e la regina. Accanto a loro, in più file, sedevano i cortigiani, vestiti anch’essi con costumi dorati e mantelli, che li rendevano simili a statue di bronzo. “I commedianti, in costumi di gala, dovevano rappresentare il loro dramma volgendo la schiena agli spettatori del Teatro d’Arte, con il viso rivolto verso re Claudio, che è immerso, insieme con la corte, nell’oscurità, rotta di tanto in tanto da sprazzi di luce sinistra sugli abiti d’oro. “I costumi dei commedianti sono affatto realistici. Dodici musicisti si esercitano, a sinistra. “In sottofondo, accordi di strumenti musicali”. Per chiarire a Stanislavskij le idee che aveva dei personaggi, Craig disegnò numerosi bozzetti, dapprima studiando la singola figura, poi collocandola nella scena. A un solo personaggio, che nella sua concezione aveva un ruolo determinante nella vita più intima di Amleto - cioè lo spettro del padre ucciso - egli non riusciva a dare una fisionomia scenica definita. Per Craig lo spettro del padre di Amleto deve apparire soprannaturale, ma deve avere delle sembianze reali. Mi spiego: al pubblico il re morto deve apparire vero, il pubblico deve credere realmente nella sua esistenza, però lo spettro al tempo stesso deve essere un’astrazione. In realtà non era facile comprendere Craig. Questo accostamento di due concezioni in antitesi esasperata era il motivo fondamentale della concezione craighiana dell’Amleto; tutta l’impostazione della tragedia per lui era basata sul concetto di dissonanza, di plurivalenza, di tensione poetica. E questa impostazione per dissonanza può essere definita soltanto con la figura chiave dell’Oxymoron, cioè con una figura del discorso poetico classico che indica l’accostamento di ciò che è normalmente inconciliabile. Qui l’accostamento era quello di semplicità e complessità, di intellettualismo e misticismo, di reale e simbolico, di naturale e soprannaturale... Non ci è possibile narrare come Craig voleva realizzare ciascuna scena del dramma, sia perché la cosa richiederebbe molto tempo, sia perché spesso il regista inglese affidava le sue intuizioni, le sue fervide immaginazioni, più ai disegni, agli schizzi, che non alle parole. È il caso di alcune fra le scene risolte in modo più originale da Craig - ad esempio quelle sugli spalti del castello di Elsinore, fra Amleto e lo spettro del padre. In un’atmosfera fredda, livida, l’ombra del padre di Amleto appariva e scompariva nell’oscurità dinanzi agli occhi atterriti dei soldati, sdoppiandosi, dissolvendosi e ricomparendo altrove, quando questi la inseguivano. Poi, nel colloquio con il figlio, il fantasma si tramutava in un’immagine di danza macabra delle pitture medioevali. Infine l’alba e il suono lontano di campane che si rispondono a distanza faceva svanire quest’immagine di morte, mentre Amleto prendeva su di sé le pene del padre. Le scene di morte, le scene in cui domina la presenza della Morte, erano agli occhi di Craig le più suggestive, le più pregne di una dolente poesia. E i disegni per la scena del camposanto e i funerali di Ofelia sono certo fra i più belli che egli fece per l’Hamlet. Assai suggestiva, ad esempio, è l’immagine che egli dà dei due becchini: sono due clown, coi capelli rossi, il naso a patata, la bocca enorme; poi, quando i clown escono, mentre si avvicina la processione funebre per Ofelia, l’atmosfera diviene triste, elegiaca, carica di misticismo. La scena dei funerali di Ofelia rappresenta una cripta nel cimitero, con altari bianchi alla morte. È bassa, poco profonda, lunga. Sugli altari c’è incenso che brucia, vicino agli altari, in alto, sono appese delle lanterne. In primo piano dei parallelepipedi alternati - le tombe - interrotti al centro da una fossa aperta - la tomba di Ofelia. Dietro di essi, lungo le lesene, i pilastri e gli altari del fondo, si svolge lenta la processione funebre. Tutti hanno in mano una campanella e di tanto in tanto la fanno tintinnare, come per caso. Ci sono tre preti giovani, uno grasso, quattro ragazzi con gli incensieri, e una folla di cortigiani, che riempie tutta la scena. C’è un coro di ragazzi, è un coro semplice, di poche voci. Ma quando è giunto sul posto della sepoltura, smette di cantare. Tutti, uomini e donne, sono a lutto. Rammentiamo ancora una scena, che in genere, nel rappresentare Hamlet, pochi interpreti sottolineano: la scena fra Amleto e Orazio, poco prima del duello finale del principe con Laerte. Anche qui è l’idea della morte, del fato, che colpì la fantasia creatrice di Craig: e fin dall’inizio egli volle giocare tutta la scena, anche l’incontro col cortigiano Osric, sulle variazioni di un unico tema, il destino di morte. Questa, per Craig, è la scena più struggente, più profondamente umana del dramma: è la scena della fatalità che incombe, la scena dell’affetto fra Orazio e Amleto. Il leitmotiv sta nelle parole di Amleto a Orazio: “Tu non puoi credere come mi senta male qui intorno al cuore, ma non importa”. Quando si leva il sipario Amleto è seduto. È sereno. È la calma prima della tempesta. Orazio gli è accanto, in piedi, con un ginocchio appoggiato alla sua sedia. Il colloquio fra Amleto e Orazio non è una semplice conversazione: è la confessione di un uomo che sta per essere assassinato. Il tono di Amleto è distaccato, quasi monotono. “Ora entra Osric, il cortigiano: è profumato molto abbondantemente. Il suo profumo si dovrebbe sentire per tutto il teatro. Fa un giro intorno a un pilastro... senza un perché... Si accorge che Amleto e Orazio stanno conversando; rimane un po’ in disparte, guarda attraverso l’occhialino ne ha diversi, che gli penzolano addosso - si aggiusta il vestito, si carezza i capelli. Rimette il fazzoletto profumato nella manica. Tutt’intorno gli penzolano forbici da unghie, scatole portacipria, calze piene di dolci. Spesso si bacia la punta delle dita...”. “Amleto non ha sospetti precisi, tuttavia sente dentro di sé che la fine è vicina. Egli intuisce che qualcosa deve accadere durante il duello ed è per questo che evita di parlare dei dettagli con quel camaleonte. Poco dopo l’uscita del camaleonte, entra un altro cortigiano: al contrario di Osric, questo è una persona simpatica, dal portamento nobile e sereno. Amleto e Orazio si alzano al suo arrivo. “Shakespeare fa spesso così: per bilanciare le impressioni sgradevoli che ha prodotto, a volte usa contrapporre un personaggio positivo a uno negativo. Lo strano è che nella prima redazione dell’Hamlet questo personaggio non esiste; è stato introdotto solo nell’edizione in folio. “Ma come si spiega, da un punto di vista logico, l’ingresso di questo secondo cortigiano? In fin dei conti non fa altro che ripetere quel che ha già detto Osric. “Le alternative sono due: o Osric, tornato dal re Claudio, lo ha riempito a tal punto di chiacchiere da costringerlo a mandare a parlare con Amleto un cortigiano più bravo, oppure lo ha mandato la Regina. “Dal punto di vista drammatico quest’idea è molto suggestiva: la Regina sospetta qualche inganno nel duello con Laerte, perciò manda ad Amleto un suo cortigiano fidato per invitarlo a prender tempo, a far pace con Laerte. Infatti il cortigiano dice: ‘Sua maestà manda a chiedere se vi è sempre in piacere di battervi con Laerte, o se volete prendere più tempo’. “E quando Amleto gli risponde: ‘Io sono fedele ai miei propositi’, il cortigiano, prima di uscire, gli sussurra: ‘La Regina desidera che voi usiate qualche cortesia a Laerte, prima di cominciare a battervi’. “La Regina vuole che suo figlio e Laerte facciano pace, perché ha paura. “Ma Amleto è troppo assorto nei suoi pensieri per avvertire quel che sta succedendo intorno a lui. È Orazio invece che comincia a sospettare qualcosa: forse nel duello c’è un inganno. Ma quest’idea è così tremenda, così difficile a dirsi, che Orazio parla come se scherzasse, seduto sul bracciolo di una poltrona. “Orazio è pronto a fare qualsiasi cosa per Amleto; è incapace di disobbedirgli. Perciò accetta la sua rinuncia, il suo abbandono alla fatalità che si sente nell’aria. “Amleto lo guarda a lungo negli occhi - ora sono seduti sui due braccioli della stessa poltrona: con uno sguardo si dicono tutti quei terribili pensieri che non hanno espresso a parole - poi escono insieme, ognuno con un braccio intorno alla spalla dell’altro”. Per la scena finale Craig aveva disposto una combinazione degli screens che gli valse poi il titolo di plagiario da parte di Simonson, poiché - più nel modello da lui fatto a Firenze che non nel disegno corrispondente e nella scena adoperata a Mosca - è simile ad un disegno pubblicato nel volume di Sabbatini: Pratica di fabricar scene e machine ne’ teatri, che invece - a quanto afferma Craig - egli vide per la prima volta nel 1914. Craig, dopo aver terminato di spiegare a Stanislavskij le sue idee di messa in scena, ripartì per Firenze, nel luglio del 1909. Giunto a Firenze Craig, che aveva assunto l’impegno di lavorare alle scene dell’Hamlet fino alla fine dell’anno, le disegnò e ne fece i modelli al completo all’Arena Goldoni; ma intanto l’idea di fondare una scuola, dove poter studiare egli stesso senza dover più lavorare su drammi altrui, si radicava sempre più nella sua mente e gli faceva sentire una sorda insofferenza per la preparazione dello spettacolo per Mosca. Il 20 febbraio 1910 Craig era nuovamente a Mosca, dove era stata costruita su sua richiesta una scena modello avente le medesime caratteristiche tecniche del Teatro d’Arte, con lo stesso sistema d’illuminazione. Qui furono disposti gli screens e le figure di legno e cartone, rappresentanti i vari personaggi del dramma. Cominciarono così le prove con gli attori e Stanislavskij. Craig, con l’aiuto di un lungo bastone, mostrava agli attori scena per scena quali movimenti essi avrebbero dovuto fare, spostando sul Model Stage le figure in legno e cartone. La cosa si rivelava difficile, perché tutti questi colloqui si svolgevano sempre a mezzo dell’interprete. Dopo aver spiegato i movimenti di ogni screen ai tecnici del Teatro d’Arte, il 4 maggio Gordon Craig ripartì per Firenze. Ormai il suo lavoro sull’Hamlet era terminato: aveva consegnato a Stanislavskij e Suler*ickij i modelli e i disegni di ogni scena, aveva definito l’illuminazione degli screens, aveva spiegato a Il’já Sac come dovevano essere le musiche di fondo, aveva disegnato tutti i costumi ed aveva impostato la recitazione degli attori. Per la parte di Ofelia però Stanislavskij non aveva aderito alla sua proposta di affidarla a Lilina, la moglie del regista russo, o ad Alice Koorien, ed aveva scelto una giovane attrice. Poco dopo la partenza di Craig, Stanislavskij si ammalò seriamente di tifo, e i preparativi per lo spettacolo furono interrotti. Da questo momento la storia di questa messa in scena fu storia interna del Teatro d’Arte. Ma è bene seguirla per spiegare il perché dell’insoddisfazione che generò la rappresentazione nei suoi autori. Stanislavskij dedicò gran parte del 1911 alle prove dell’Hamlet, poiché intendeva creare una recitazione psicologicamente valida, pur rimanendo fedele alle precise indicazioni dei movimenti fornite da Craig. In tal modo l’idea di Craig di creare uno spettacolo essenziale, di un simbolismo puro, veniva contaminata dalle ricerche psicologiche di Stanislavskij. Da un lato il regista inglese aveva impostato una recitazione dura, fredda, puramente esteriore - simile alla recitazione che poi teorizzò Bertolt Brecht, la recitazione epica - che contribuisse a dare allo spettacolo un ritmo antinaturalistico, musicale e poetico insieme. Dall’altro il regista russo, pur mantenendo intatte le posizioni degli interpreti, le intonazioni di voce, i movimenti fondamentali voluti da Craig, cercava di ottenere dai suoi attori che studiassero le loro parti basandosi sull’introspezione psicologica dei personaggi e sul pere*ivanie, cioè su di un sistema per vivere i sentimenti che ciascun personaggio avrebbe provato durante lo svolgersi dell’azione drammatica. È chiaro che il sistema di Stanislavskij, se applicato ed un dramma di Cechov o comunque di un autore realistico, poteva dare dei risultati interessanti; ma in un dramma come quello di Shakespeare in cui i sentimenti dei personaggi - secondo l’interpretazione craighiana - erano mantenuti su di un piano affatto estraneo al sentire quotidiano, naturale, degli interpreti, andava incontro a difficoltà enormi. Quando si dovettero costruire gli screens in grandezza naturale per lo spettacolo si presentarono le prime difficoltà: Craig li avrebbe voluti in ferro o in legno o in rame o in sughero, ma sarebbero risultati eccessivamente pesanti; così di comune accordo si decise di fabbricarli in tela non dipinta con chassis di legno. Una scena dopo l’altra, inevitabilmente, più volte Stanislavskij e Suler*ickij si vedevano costretti a modificare le soluzioni indicate da Craig. Al primo atto vennero modificate la scena della famiglia di Polonio e due scene dell’incontro di Amleto con lo spettro del padre. Negli altri atti vennero soppresse - sempre per motivi di ordine tecnico - altre sei soluzioni scenografiche craighiane, e ancora quattro scene furono modificate, fra cui quella dei funerali d’Ofelia. In tutto, dunque, tredici scene erano state adulterate rispetto ai progetti di Craig. Il 21 dicembre 1911 Craig tornò a Mosca per sovraintendere alle ultime prove di Hamlet. Qui si trovò di fronte alle numerose modifiche apportate al suoi piani di regia. Scena per scena ripercorse tutto lo spettacolo, fremendo di fronte ai cambiamenti operati nella realizzazione delle sue idee. E alla scena dei funerali d’Ofelia non poté più trattenersi... Di fronte alla violenta reazione di Craig, Suler*ickij - che era il maggior responsabile delle modifiche - si sentì offeso. Nella sua esaltazione inoltre Craig - ritenendolo responsabile di aver rovinato lo spettacolo - chiese di non firmare più la regia, se accanto al suo nome doveva apparire quello del suo amico di un tempo, divenuto ora - come egli diceva - “l’assassino del mio Amleto”. Così - ultima peripezia di questo travagliato spettacolo - Suler*ickij abbandonò il teatro il giorno prima della prova generale. Era una conclusione amara, spiacevole. Ma, nonostante tutto ciò, 1’8 gennaio 1912 il pubblicò applaudì a lungo la prima di Hamlet. Nemiròvi# Dàn#enko disse poi a Craig in un discorso, riportato dai giornali: “Siete venuto con nuovi metodi per la nostra arte e avete posto in essi tutto il vostro genio poetico... aspettiamo ancora dell’altro lavoro da voi per la perfezione della nostra arte”. Lo spettacolo si presentò agli occhi del pubblico con una grandiosità non priva di sfarzo, non corrispondente alla semplicità voluta da Craig. Di essa Stanislavskij scrisse: “Avevamo voluto dare alla messa in scena una forma quanto più possibile semplice e modesta, eppure essa si era rivelata straordinariamente sontuosa, elevata e piena d’effetto - addirittura in modo che la sua bellezza saltava agli occhi, si spingeva in primo piano e copriva col suo splendore gli attori. In questa maniera si dimostrò che quanto più ci si sforza a mantenere semplici le decorazioni, tanto più chiassose esse diventano, tanto più appaiono pretenziose e sembrano pavoneggiarsi di una premeditata primitività. “La rappresentazione ebbe grande successo: alcuni erano entusiasti, altri criticavano, ma tutti erano eccitati ed emozionati, contrastavano, tenevano dibattiti, scrivevano articoli, e alcuni teatri si appropriarono segretamente delle idee di Craig, spacciandole per proprie”. La stampa inglese recensì ampiamente l’avvenimento. Nel 1911 e nel 1913 Craig aveva proposto al pubblico il suo ideale di teatro in due libri fondamentali: On the Art of the Theatre e Towards a New Theatre. Nel 1913 aveva dato vita a un laboratorio di ricerche di arte teatrale, la Scuola di Arte del Teatro, a Firenze. Ma ben presto la guerra lo costrinse a rinunciare alla realizzazione del suo sogno. Fu una cesura fondamentale nella sua vita artistica. Rinchiuso in un volontario isolamento, sulla riviera ligure, si dedicò soprattutto a scrivere, sotto 64 pseudonimi diversi, drammi per marionette, articoli per “The Mask”, e vari libri: The Theatre Advancing (1919), Scene (1923), in cui proietta in una dimensione storica l’esperienza mitica della Supermarionetta e delle mille scene in una, rivelandone egli stesso il valore di utopia assoluta; Woodcuts and Some Words (1924), Nothing or the Bookplate (1924) e Books and Theatres (1925), tutti in parte autobiografici. Nel 1926 disegnò le scene de I pretendenti alla corona di Ibsen per Johannes Poulsen al Teatro Reale di Copenaghen. Nel 1929, dopo anni di lavoro, apparve per la Cranach Press di Weimar l’edizione inglese e quella tedesca di Hamlet, illustrata con xilografie di Craig. Nel 1930 pubblicò il libro sul suo maestro Henry Irving. L’anno successivo dedicò un libro a sua madre: Ellen Terry and Her Secret Self. Trasferitosi poi dall’Italia in Francia, vicino a Parigi, cessò di pubblicare “The Mask” e si dedicò sempre più alla storia del teatro e alla Gordon Craig Collection, una vastissima collezione teatrale, che voleva lasciare ai futuri studenti dell’arte del teatro. Dopo la seconda guerra mondiale - che lo vide anche internato in campo di concentramento, durante l’occupazione tedesca - passò sulla Costa Azzurra, a Vence, dove iniziò la sua autobiografia incompiuta, Index to the Story of My Days, pubblicata nel 1957. Mori nel 1966 a novantaquattro anni: fino all’ultimo la sua fantasia era fertile, originale, ricca d’inventiva, e molti artisti, da Laurence Olivier a Peter Brook a Jean-Louis Barrault, andavano a trovarlo per sentirlo parlare di teatro. F. M.
Scarica