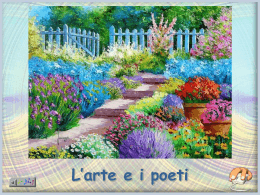Anno VII - Numero 1 Gennaio - Marzo 2013 l’EstroVerso No Muos Periodico d’Informazione, Attualità e Cultura - Direttore Responsabile Grazia Calanna Memorie Grazia Calanna “Non siamo contro gli americani. Ma vogliamo tutte le garanzie per la tutela della salute dei cittadini”. Il Presidente Rosario Crocetta, dopo una nottata di scontri a Niscemi, in Sicilia, ha bloccato i lavori per l'installazione delle antenne militari statunitensi nonostante il richiamo formale del Ministro dell'Interno. Quella sera, anziché restare incollati alla lobotomizzante tv o (meglio?) intrappolati tra le fitte maglie della rete, un gruppo di cittadini sono insorti per difendere la nostra terra dal Muos, sistema di telecomunicazioni satellitare che, secondo studi condotti da esperti del Politecnico di Torino, comporterebbe inquinamento elettromagnetico e rischi per la salute. Esiste il comitato “No Muos”, chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri Salute, Difesa e Ambiente, “l’adozione di ogni utile provvedimento finalizzato alla revoca delle rispettive autorizzazioni rilasciate per l’inizio dei lavori di realizzazione del sistema Muos”, abbiamo il dovere morale di sostenerlo con la forza di un’indignazione unanime, immune da singoli tornaconti. (Memento mori). Nessuno di noi è abbastanza distante da potersene disinteressare. Ritratto di Cristina Campo di Gianfranco Draghi Laura, la mia prima moglie, figlia di un generale dei bersaglieri, di un cognome pisano, Salvadori, perché nato vicino a Pisa, e di una mamma invece di Carpi, di Carpi era anche lo scrittore Arturo idea grafica di Nino Federico Loria con cui mi ha legato una profonda amicizia, era stata a scuola con Marcella Amadio, figlia di due musicisti, un organista e una violinista, tutti e due insegnanti al Conservatorio e il papà di Cristina Campo era appunto il direttore dei conservatorio. La Marcella era un'esile ragazza molto bellina di un viso aristocratico che aveva avuto la polio da bambina e quindi camminava un po' zoppetta, aveva una voce anch'essa espressiva, ma esile, ed era incerta su quello che avrebbe voluto fare, aveva anche una forsennata passione letteraria per la letteratura inglese, soprattutto per ragazzi. Marcella conosceva Vittoria Guerrini per via di questa concomitanza dei genitori musicisti, e Marcella che era così amica di Laura, conobbe anche me, anzi io la invitai sia da mia nonna vicino a Bologna con Laura e Lamberto Maccioni, sia una volta, ma qui posso sbagliare, sul lago di Como, no anzi qui mi sbaglio, invitai sul lago la Francesca Sanvitale. Comunque Marcella parlò molto di noi di me e di Laura, con CristinaVittoria che espresse il desiderio di conoscermi. Così io che allora ero appena sposato e stavo in Costa San Giorgio 30 inforcai la mia bicicletta e andai a trovarla in via dei Lauger 12, sul viale dei Mille, portandole in dono propiziatorio il libretto elegantissimo e tipograficamente raro, in cui il grande tipografo Giulio Preda aveva stampato le Lettere ad una giovinetta, il mio primo libro in assoluto, di cui avevo stampato con giovanile e un po' sciocca ritrosia soltanto 50 copie. Un giorno Giulio Preda venne lì nello studio di mio padre a Milano, in corso di Porta Nuova 15, in quelli che erano i resti di casa nostra dopo i bombardamenti, e mi disse "le faccio spendere la stessa cifra, facciamo 200 copie", ma io fui irremovibile nella mia ritrosa modestia. Così entrai nel piccolo appartamento dei Guerrini, nel piano sopraelevato di questa piccola villetta o casa che aveva attorno a sé un piccolo giardino. Da allora fin quando Vittoria/Cristina rimase a Firenze, cioè per circa tre anni, la andavo a trovare due o tre volte per settimana, una vera grande amicizia. L'intensità, l'assoluta non formalità, nel rapporto con me, era ciò che mi attraeva, che ci portava subito nel mezzo di un rapporto intimo, come fosse stato un rapporto d'amore che non era, era un rapporto di chiara e squillante amicizia, e di fraterno e devoto sodalizio. Cristina sorrideva ai bordi della labbra, quando entravo nella stanza… (segue a pag. 2) Allo Specchio di un quesito “La parola umana è come una caldaia incrinata su cui battiamo musica da far ballare gli orsi quando vorremmo commuovere le stelle”. Con Flaubert per chiedere: qual è la tua più intima definizione di scrittura? Davide Orecchio Vivo la scrittura come un atto d’insubordinazione. A chi disobbedisco (o provo)? Alla realtà. Ai fatti cucinati male, accostati senza garbo, già scaduti prima di avverarsi, rozzi, inavvertiti e maleducati che noi definiamo come “l’accadere”, oppure come “la concatenazione degli eventi”, “le cause e gli effetti” o anche, proverbialmente, come “ciò che è stato, è stato” e tu datti pace. La realtà con la sua pretesa di comandare lo stile e la vita, è detestabile. Ma non è una rivolta semplicemente estetica, la scrittura per me. È un gesto etico. È il racconto per bocca dell’essere umano, per mano dell’uomo e della donna, per l’occhio della donna e dell’uomo che rompe il silenzio delle cose che avvengono, muoiono e una volta morte spariscono. Il silenzio dell’universo, della natura, di una storia che senza storie elaborate da noi non si vedrebbe nell’impassibile inerzia del mondo: quello è l’avversario. La scrittura è ricreare la vita, assegnare giustizia, sottolineare ingiustizia, protestare, comandare la realtà rifacendola, interrogare il passato, recuperare i morti, esistere, soprattutto essere felici nel gesto imperfetto di ciò che si scrive. Quanto si possa essere felici nella scrittura è il mistero più acuto, che però si attutisce nel controcanto di un altro mistero: quanto si possa fallire e soffrire nella materia della vita non scritta, subita. Mirò, alla scoperta di una realtà ‹‹profondamente poetica›› di Laura Cavallaro Forme e segni semplici, appena accennati o marcati, che laPalma di Maiorca che ha prestato le opere. Una piacevole pausa sciano intuire nulla o qualcosa, ora una donna, ora un occhio, verso un immaginifico regno della fantasia, capace di stupire i una stella, il sole, un corpo, uno strano uccello; e poi i colori, bambini, privi di preconcetti ed anguste gabbie di pensiero, e di pieni di luce, ampiamente distesi sulla tela o incorniciati da far sorridere quegli adulti che hanno conservato uno spirito puro spesse pennellate nere senza oggetto né titolo, ed ancora e che sanno godere della magia dell’arte. Sono cinquanta oli di chiazze, gocciolature, impronte… tutto ciò che è fantasia, sogrande formato ma anche acquerelli, bronzi e terrecotte, a costigno, impulsività, essenza, creazione pura, immediatezza, evatuire il nucleo della mostra cronologica e tematica che si consione dal reale, movimento, sperimentalismo, concorre a creacentra essenzialmente sugli ultimi trent’anni di attività re l’arte del pittore catalano Joan Miró (1893-1983) che, dopo dell’artista, trascorsi a Palma di Maiorca, luogo definito da Mila tappa romana, è possibile osservare ancora, fino al 7 aprile ró simbolo di poesia e luce, come preannuncia il titolo della 2013, al Palazzo Ducale di Genova dove è stata allestita la mostra, e al quale egli si sentiva indissolubilmente legato non mostra “Miró! Poesia e luce”, prodotta da Arthemisia e 24 Ore Cultura e solo per le sue caratteristiche ma in quanto paese d’origine della madre. curata da María Luisa Lax Cacho, in collaborazione con la Fundació Miró di (segue a pag. 5) 2 l’EstroVerso Gennaio - Marzo 2013 Società&Sapere (segue da pag. 1) Ritratto di Cristina Campo Munch di Gianfranco Draghi La passeggiata in città di Fabrizio Bernini Con fiera ed esasperata lentezza amo camminare lungamente per la città. Mi stupisco sempre, per esempio, quando passo davanti un bel palazzo del Settecento e allora alzo immediatamente lo sguardo alle sue eleganti finestre, alla sua rigorosa facciata esterna, così sobria e imponente, e qualche volta, da un vetro spalancato, dietro una tenda ricamata finemente e solleticata da un vento leggero, mi arriva la soave musica di un pianoforte a coda. Oh, com’è ancora piacevole poter puntare gli occhi in alto, e meravigliarsi delle antiche statue che sporgono dai discreti balconi o dalle semicolonne che si allungano snelle e leggere. Una meraviglia! Una delizia dei sensi! Finché, appunto, occhi e orecchie si perdono beatamente in ciò che ancora di bello ti può regalare lo sguardo verticale di una strada di città. Ma quando inesorabilmente i sensi tornano a percepire quello che sta in basso, allora quella lieta sospensione di gradevolezza si schianta al suolo! Orrendi agglomerati di automobili di tutte le dimensioni possibili che occupano la strada, i marciapiedi, perfino i passaggi pedonali, e che sputano gas maleodoranti e venefici, che strombazzano senza ritegno al conducente che li precede, reo di non scattare al semaforo anche se per farlo deve scavalcare il cadavere di una vecchietta appena falciata da un Suv. Gente che bofonchia orribilmente, che snocciola il suo tetro linguaggio sessuale, che di sessuale e virile non ha proprio nulla, se non l’impotenza! Ridicoli signori pluridivorziati e pluriprotestati che si accaniscono sul proprio corpo falcidiandosi senza pietà le sopracciglia, tostando impunemente la propria pelle con le lampade solari, infilandosi sulla panzetta, a mò di profilattico, la felpa che hanno visto indosso al figlio la sera prima! Allora gli occhi, avviliti da tanta miseria, vanno verso il basso, per non incontrare più cotanta immondizia per le pupille. Ma non possono far altro che annichilirsi nuovamente perché spiaccicate al suolo spuntano miliardi e miliardi di chewing gum che maculano l’intero marciapiede, e a fargli compagnia milioni di mozziconi di sigarette che tappezzano perfino la scala della metropolitana. Mi immagino le lugubri signore del passeggio masticare la loro gomma mentre fumano la sigaretta, tanto da annullare vicendevolmente le reciproche funzioni! Per poi lasciarci questi splendidi ricordini! Dei veri geni! E mentre mi rammarico per lo scarso senso civico del “buon cittadino” mi accorgo di aver spiaccicato l’ennesima cacca di cane, che questi educati e autocelebranti animalisti ci donano senza riserve. E allora, sconsolato, cerco nuovamente un angolo di città dove poter riposare lo sguardo, scantono velocemente, cerco di lasciarmi alle spalle l’obbrobrio a cui sono quotidianamente condannato, e in testa mi ripeto i versi del grande Giuseppe Parini: “Col dubitante piè torno al mio tetto”. l’EstroVerso Numero 1 - Anno VII Registrazione Tribunale di Catania n. 5 del 9 febbraio 2007 Direttore Responsabile Grazia Calanna Segretario di Redazione Luigi Carotenuto Editore EstroLab www.lestroverso.it …di solito entravo e mi sedevo nel piccolo salotto ad aspettarla e lei arrivava poco dopo. Quegli occhi scuri battevano come piccole ali di uccelli e frangevano con la loro luminosità lo spazio fra lei e l'interlocutore. Le risposte erano sempre nella direzione non esteriore, piuttosto di una scoperta quasi nuda interiorità. Il mio libretto iniziale creò tra di noi un legame di corrispondenza, come se Vittoria/Cristina trovasse lì un fratello, un po' più giovane di lei, ma psicologicamente, umoralmente, solido e affettivo a cui poteva consegnare i costosi drammi amorosi che allora la affliggevano, fin dal nostro primo incontro. Raccontandomi senza indiscrezioni, senza troppe parole, ma con fremente emotività, il suo rapporto con Leone Traverso di cui era stata, già verso i 15, 16 anni, una devota allieva culturale e una appassionata amante. Leone Traverso era un signore più grande di noi, un veneto che girava con un grande cappello a lobbia, dei begli occhi azzurri, ammiccanti e insieme quasi teneri, un veneto tipico di dolcezza e di ironia, anche se poi tutta la sua etica, il modo di concepire il rapporto con le donne, alla mia seriosissima, e diciamo così per essere onesti, piuttosto severa etica giovanile, non andavano troppo. Però avevo una grande simpatia per lui, perché era anche suadente e limaccioso e io ero un giovane ardente, bisognoso di affetto, carico di progetti di amicizie. Lo conobbi proprio attraverso Cristina, così come conobbi tutto il gruppo dove c'erano Luzi, Leone, Bigongiari, Parronchi, etc. Mentre Arturo Loria mi arrivò indipendentemente da tutti loro, ma non so più in che modo. Cristina si vestiva come le giovani donne di allora, come mia moglie Laura, con delle camicie di seta bianche, o di seta cruda, brevi tailleur scuri, cappottini attillati neri, qualche volta portava un cappellino, come anche Laura. Cristina era non alta, non posso dire piccola, come non era piccola Laura, erano donne non alte, ben proporzionate, collegate bene col terreno. Laura è stata anche una donna sportiva, Cristina per via del guizzo al cuore, no. Le piaceva nuotare, fare i bagni al mare e ai laghi e abbastanza camminare. Ma niente di più. Quel giorno quando andai quella prima volta da lei scoprimmo di avere tanti interessi comuni, io conoscevo bene le letterature francese, tedesca e inglese, certi miei libri da comodino, erano gli stessi libri che amava Cristina, a parte come ovvio i grandi classici. Aveva una grande ammirazione per Mario Luzi, e attraverso Traverso e le sue traduzioni conosceva bene alcuni classici. Ma i discorsi letterari fra di noi non erano mai avulsi dal contesto della vita e le sue situazioni. Io mi divertivo molto ad andare da Cristina, perché era così vivace, sdrammatizzava bene la sua vita, e quando tornavo a casa raccontavo a Laura tutte le nostre conversazioni con molto entusiasmo e la Laura un poco diventava gelosa, ma neanche poi tanto, perché si rendeva perfettamente conto del tipo di amicizia che mi legava a Cristina. Cristina aveva un piccolo sorriso che le stava ai lati degli occhi che erano piuttosto grandi e scuri che poi scendendo lungo le guance, ai lati delle labbra, poteva avere anche un aspetto leggermente ironico o allegro a seconda dei casi. Aveva delle mani abbastanza piccole, ma non deboli o fragili, anzi, sembravano mani abbastanza forti, le unghie rettangolari, ben curate e userei un aggettivo un po' bizzarro: nobili. Con me in tutti quei primi anni di amicizia in fondo ero come nei drammi di Calderón de la Barca o Lope de Vega, una figura di confidente, quasi di confessore a cui lei poteva esporre tutta la sua fragilità, le pareva di essere confortata e mai assolutamente moralizzata. Sia perché non era nel mio stile moralizzare le persone fin da allora, sia perché le sue storie erano semplicemente delle confessioni, a volte drammatiche, commosse, d'amore senza nessuna implicazione troppo concreta. La concretezza stava dietro alle cose, alle parole, non veniva utilizzata altro che nel suo aspetto sentimentale. Poi Cristina nel bel mezzo del dramma era capace di buttare lì una frase faceta o scherzosa con cui forse cercava di depotenziare la sua stessa personalità, molto forte. Cristina era nata a Bologna e anche la mamma e il papà erano bolognesi, userò questo termine psicologico che non uso mai, ma è molto significativo, Cristina era esigentissima sia con se stessa che con gli altri, e questo essere esigente molto spesso toccava un strato proprio moralistico, diciamo così, super egoico, anche se poi sapeva essere generosa e poteva perdonare, non avere scarti verbali antipatici. Bastava prenderla per il verso giusto, cioè il verso dell'affettività. Infatti sennò non si capirebbe la sua grande tenerezza, amicizia, oltre alla stima come poeta, la grande intimità affettiva che ebbe con mio fratello Piero che era un tipo, per l'epoca, piuttosto stravagante. Talvolta Cristina poteva essere, non voglio dire violenta, però improvvisa, molto impulsiva. Avevamo passioni in comune come per quel grande libro incompiuto per la sua morte improvvisa, la Citadelle, di Saint-Exupéry. Credo che ci scambiassimo molte notizie, informazioni, passioni reciproche anche senza squadernarle di fronte all'altro, semplicemente introducendole nel discorso che stavamo facendo, poi Cristina era molto generosa e si dava da fare per i suoi amici, si è data molto da fare per me, per i miei libri inediti, e si impegnò veramente per anni per Piero. Mi ricorderò sempre un giorno che la vidi sul Lungarno dovevo essere in bicicletta, oltre il Ponte Vecchio, che aveva sotto il braccio il mio manoscritto Infanzia che stava in mezzo tra Luzi e Traverso, e che portava il manoscritto da qualche parte. Non aveva però peli sulla lingua, quando parlava anche di qualcosa di un amico, e non bisognava assolutamente prendersela, anche se di solito non cambiava spesso i suoi punti di vista. Infatti io ero cauto nelle cose che le davo da leggere, non le presentavo mai degli scritti che immaginavo potessero suscitare la sua irritazione. Poteva avere anche un bel sorriso largo, grande, soprattutto con i bambini. Te l'ho già raccontato, mi telefonava presto la mattina, era anche un'epoca in cui ci alzavamo tutti piuttosto presto, magari mi telefonava verso le 7 e 30. Il nostro rapporto quei primi anni a Firenze ebbe un aspetto giovanilmente festoso, era come se facessimo tutti insieme, e coinvolgo in questo la Laura, la Margherita e poi mio fratello e gli altri amici, Ferruccio Masini, Lamberto Maccioni, e anche altri che pure frequentavamo meno, come l'ispanista Maurizio Costanzo, l'Anna Chiavacci, Renzo Gherardini e forse anche in qualche modo laterale il pittore amico di Renzo [...], un viaggio nel mondo della letteratura, tentassimo un cammino tutto nostro e personale. 3 l’EstroVerso Gennaio - Marzo 2013 Società&Sapere di Luigi Taibbi di Raffaella Belfiore Missioni di pace o corse al massacro? È questo l’interrogativo che accompagna le riflessioni sull’impegno militare italiano all’estero. Al di là di qualsiasi ideologia politica, appare quanto meno futile la bipartizione tra interventisti e neutrali, e questo perché quando si gioca con la vita dei propri ragazzi la politica conta poco, se non nulla. È di queste ultime settimane la denuncia di un caporal maggiore dell’esercito ammalatosi di tumore dopo la sua Rik partecipazione alla missione di pace in Iraq. In realtà dal 2007 a oggi i casi si sono moltiplicati spaventosamente palesando, tra l’altro, un’allarmante discordanza tra i dati numerici a seconda delle fonti. Secondo il Ministero della Difesa, infatti, dalla fine del 2007 a oggi le morti riconducibili all’uranio impoverito sarebbero 77 su 312 militari ammalati, ma l’Osservatorio Militare attesta invece dati più drammatici con 2500 malati e 170 morti dagli anni ’90 al 2012. A tal proposito rinviamo ad una lettura particolarmente interessante, l’inchiesta “L’Italia chiamò”, realizzata da Leonardo Brogioni, Angelo Miotto e Matteo Scanni (libro e dvd, Edizioni Ambiente 2009), opera multimediale che riassume le testimonianze di quattro militari italiani che hanno prestato servizio in Bosnia, Kosovo e Iraq. Allegato all’inchiesta è anche un video, girato dai soldati, che mostra le procedure standard utilizzate in Kosovo durante la cosiddetta “Operazione Vulcano”, una bonifica effettuata nel 1996. I soldati seppelliscono dentro una buca scavata nel suolo le armi e le munizioni lasciate dall’esercito americano e dagli alleati e poi le fanno brillare. La nuvola radioattiva che si alza in cielo li ricopre come un manto di morte e va da sé che i ragazzi non erano protetti né da tute né da maschere anti gas. Dei 14 elementi che componevano la squadra, otto si ammalano, due muoiono e altri due mettono al mondo figli con gravi malformazioni genetiche. Se è vero che i soldati, come veri Fratelli d’Italia si dichiarano pronti alla morte, crediamo che l’Italia, dal canto suo, tacendo o assottigliando e falsificando dati tanto tragici, si dimostri una volta ancora indegna dei suoi figli. Franz Kafka “Amore… tu sei per me il coltello con cui frugo dentro me stesso” di Carina Spurio Aprile 1920. Dalla pensione “Ottoburg” di Merano, dove si era recato per un soggiorno di cura, Franz Kafka scrisse le prime lettere a Milena Jesenská – Polak, una giovane traduttrice ceca che aveva conosciuto a Praga. Gli amici la ricordano avida di vita, di denaro e di sentimenti. “Lei è un fuoco vivo come non ne ho visti” scrive, evidenziando delicatamente alcune caratteristiche della sua personalità. La corrispondenza tra Kafka e Milena divenne molto stretta e intima. Si racconta che nella vita di Kafka ci furono altre donne, ma che nessuna riuscì a penetrare il suo animo così in profondità. Le Lettere a Milena restano eterne e sono la testimonianza di un amore profondo, dentro il quale, prendono vita scintille d’infinito che illuminano i nostri giorni. Due mesi dopo scrive: "Tu mi appartieni, anche se non dovessi vederti mai più". Sembra una frase d’amore qualunque, come se ne leggono tante. Sembra il solito amore che si manifesta nel mondo ma non appartiene al mondo e di cui gli esseri umani hanno paura. Sette mesi dopo il turbato Franz scrive: “Questo incrociarsi di lettere deve cessare, Milena, ci fanno impazzire, non si ricorda che cosa si è scritto, a che cosa si riceve risposta e, comunque sia, si trema sempre”. S’incontrarono soltanto poche volte: a Vienna e poi a Gmünd. Kafka pose fine alla loro relazione anche a causa del fatto che Milena non voleva lasciare il marito. La loro corrispondenza quasi quotidiana, si interruppe nel novembre 1920 ma si scrissero ancora nel 1922 e nel 1923. Quando la conobbe, aveva trentotto anni e «i capelli bianchi delle vecchie notti»; lei era sposata, scriveva sui giornali, «Era bella come un angelo», era molto giovane, ventitré o venticinque anni; lui si stava consumando, lei era fresca e coraggiosa. “Milena se n' è andata, alla metà di maggio del 1944, fra i reticolati del campo di Ravensbrück, sfinita dai patimenti, con il peso della memoria e l'affanno d'un congedo senza dolcezza” (da I turbamenti del giovane Kafka di E. Biagi). Milena rimase un'ombra nei suoi sogni impossibili e disperati. «Cara signora Milena», comincia l'ultima lettera, «per favore non mi scriva più». Non c'è neppure un'ora per il dialogo, bisogna che l'uomo Kafka si prepari all' addio. È la fine. Anche se una volta aveva detto: «Non prendo commiato. Come potrei farlo se tu sei viva?».” Meno di un secolo dopo Franz e Milena la corrispondenza non è più epistolare. Una lettera diventata “email”, poi “sms”, prima di “Whatsapp”, un'applicazione di messaggistica istantanea per smartphone. Nell’era post-carta nessuno ha storie da ricordare, semmai ha storie da dimenticare. I rapporti sono appesi come le t-shirt nei grandi magazzini, in bilico, tra la presa in giro e l’amicizia. L’amore costa di meno. La vecchia cena “a lume di candela” è stata sostituita dai “fast food”. “Ci frequentiamo” ha sostituito il “ti amo”. Ci si conquista di meno e ci si concede di più. I messaggi istantanei consumano le storie velocemente: si può lasciare qualcuno senza nemmeno avvisarlo, senza camminare a piedi fino a casa sua per comunicarglielo, senza imprecare per la difficoltà di parcheggio e senza bagnarsi con una goccia di pioggia, in caso di pioggia. La nuova civiltà è social. L’individuo è posseduto dalla smania di allargare le proprie conoscenze. L’inizio e la fine di una storia sembrano contenute nello stesso attimo. In un nanosecondo: velocemente si ama, velocemente si consuma, velocemente si passa ad una nuova conquista. Nelle vene dei messaggi social regna l’impulso del momento, posseduto da una proiezione di sé molto fugace e uno stato mentale altrettanto effimero. Non esistono emozioni che arrivano al giorno successivo, ma solo conversazioni luminose e fragili. Eppure, dentro un attimo fuggente, ci si può far male di dolore vero! La legge non ammette ignoranza. Eppure si contraddice da sola. In Italia, infatti, si è creato, negli ultimi quattordici anni, un polverone giudiziario legato alle cure tumorali. Ciò che ha interessato questi processi sulla salute dei cittadini non riguarda solo il diritto a ricevere una cura, ma, anche, il diritto a essere sostenuti economicamente per essa. Utilizzare una parola come “business” vicino a una parola come “tumori”, può apparire inopportuno solo a chi non si è mai informato sui rimborsi che lo stato paga alle grandi case farmaceutiche per i medicinali antitumorali. A parlare di cure alternative a quelle legalmente riconosciute e ritenute standard, ci si sente sprofondare in una diatriba sterminata senza confini dialettici e morali, dove l’inganno è sempre dietro l’angolo. Quando poi si tocca l’argomento soldi, ecco che anche alcuni magistrati, politici, capitalisti e medici perdono ogni contegno. Partendo dal presupposto che ciò che importa non è la cura adottata, piuttosto che funzioni, oggigiorno le cure tumorali discusse nel mondo sono molte, ma quelle riconosciute in Italia e dal blocco dei colossi farmaceutici sono esclusivamente: chirurgia, radioterapia e chemioterapia. Secondo uno studio australiano (Morgan G.) terminato nel 2004 e iniziato nel 1990, prendendo in esame quasi 230.000 casi di pazienti affetti da tumori negli stati degli USA e nell’Australia, solo il 2% di coloro che si sono sottoposti a cure chemioterapiche sono sopravvissuti fino a 5 anni dall’inizio del trattamento. Cosa significa nello specifico? Significa che 2 pazienti su 100 riescono a sopravvivere più di 5 anni alla chemioterapia. I farmaci chemioterapici hanno, infatti, tra le varie controindicazioni, quella di distruggere il sistema immunitario e causare (senza alcun condizionale) lo sviluppo di nuovi tumori. Ma la raccolta di statistiche ufficiali è un’impresa che sfiora l’impossibile, perché, come denunciato da molti medici fuori dal coro, i dati vengono volontariamente integrati male, di modo da mostrare risultati al pubblico migliori di quelli reali. Ma siamo sicuri che non ci sia un’alternativa? Alcuni medici italiani, tutt’oggi, si ostinano a prescrivere la cura Di Bella. Bisogna sottolineare proprio il fatto che si ostinino, perché se consideriamo che le multinazionali del farmaco, i media e i ministeri della salute, hanno demonizzato le cure “alternative” tra cui la Di Bella, questi medici (in regola come tutti gli altri) devono esserne proprio convinti per metterci la faccia. Nel 1998, il Ministero della Salute fece partire una sperimentazione in grande stile, coinvolgendo 51 ospedali ma escludendo il dott. Di Bella. La cura fu dichiarata fallimentare. Poco dopo, però, il procuratore aggiunto di Torino, Raffaele Guariniello, aprì un’indagine in seguito a denunce su irregolarità nella sperimentazione presso gli 8 centri piemontesi, con la prospettiva che l’indagine si allargasse a macchia d’olio. L’ipotesi di reato fu “somministrazione di medicinali guasti o imperfetti”. Il Metodo Di Bella è stato quindi messo alla berlina. Alcune centinaia di medici però, sembra che abbiano continuato a prescriverlo caso per caso, nonostante esso sia stato bandito. Nel frattempo, i casi di malati affetti da cancro guariti, o le cui condizioni di salute sono decisamente migliorate, grazie alla terapia Di Bella, si sono moltiplicati, benché questa non sembri proprio immune ai fallimenti. È recente il caso, per dirne uno, di Barbara Bartorelli, 40enne imprenditrice bolognese, guarita totalmente dal “linfoma di Hodgkin” grazie al metodo Di Bella. Ironia della sorte, l’Ausl ha vinto il ricorso contro la donna, sostenendo che dev’essere l’imprenditrice a pagarsi le cure ricevute dato che nonostante esse abbiano funzionato perfettamente, solo chirurgia, radioterapia e chemioterapia sono riconosciute dalla legge italiana come terapie ufficiali per la lotta al cancro e quindi sovvenzionate. In breve, Barbara Bartorelli si sarebbe dovuta curare con i metodi ufficiali, sarebbe morta (come previsto nel suo caso, dato che la chemioterapia a cui fu sottoposta non ebbe effetti positivi), ma avrebbe avuto il rimborso. Se mai dovesse accadervi di ammalarvi di questa tremenda malattia, forse sarebbe il caso, prima di darsi ciecamente a un ospedale, o a un presunto guaritore, o a un rinomato chirurgo, o a chiunque altro, di informarsi per bene, perché si sa che la legge, la morte e le case farmaceutiche hanno una cosa in comune: non ammettono ignoranza. Buonanotte. Edvard Munch Notturni Nuvole radioattive, manti di morte taciuti da “madre” indegna 4 l’EstroVerso Gennaio - Marzo 2013 Arte&Creatività Alea iacta est… nell’arte di Daniele Cencelli Giulio Cesare, dopo aver sconfitto Vercingetorige nel 52 a.C., è sicuro di ottenere un’accoglienza trionfale nella lontana Roma, ma i suoi nemici, guidati da Pompeo, sono pronti per privarlo del suo comando, l’imperium. Cesare cerca quindi di negoziare col Senato una tregua, proponendo così di lasciare il potere a patto che anche Pompeo faccia lo stesso. Il Senato continua la sua ostilità così Giulio Cesare decide di commettere uno dei più gravi affronti per la Res publica Populi Romani: superare il confine meridionale della Gallia Cisalpina, il fiume Rubicone. Con questo evento, verificatosi tra il 10 e l’11 gennaio, inizierà la guerra civile tra Cesare e Pompeo. Proprio questo fatto, data la sua importanza storica, è stato spesso soggetto d’arte. Un dipinto in tempera cattura questo evento, si tratta del pannello di Francesco Granacci (1469-1543) attivo nel fiorentino. La scena rappresentata è ispirata a un fatto prodigioso raccontatoci da Svetonio: mentre Cesare meditava sul da farsi gli apparve accanto un bellissimo giovane, suonante un EscogitArte flauto. D’improvviso il giovane prese una tromba dalle mani di un soldato di Cesare e, suonando il segnale di tromba, attraversò il fiume. Il dipinto di Granacci (nella foto) racconta l’evento in ogni particolare: la scena è unica e continua, con i protagonisti che si ripetono per “recitare” la loro parte, un espediente di magnifico effetto che permette di vedere l’ambientazione senza tagli. Alla fine di questa “pellicola dipinta” Cesare si dirige a Roma col suo esercito, trovandosi dinanzi una città circondata da possenti mura. Ad altra opera letteraria, precisamente Farsaglia di Lucano, è ispirato il lavoro di Richard Westall, pittore inglese del XVIII secolo: in procinto di attraversare il Rubicone apparve a Cesare la grande dea Roma in ansia, luminosa ma immersa nell’oscurità, con i capelli bianchi che le cadevano dal capo turrito. La scena di Westall è avvolta dalla luce divina, una luce che non è però, aperta, piena ma nebulosa così da rilevare la paura e lo stupore dell’esercito, come traspare tra l’altro dai loro volti. Giulio Cesare è invece rappresentato sicuro, come se si fosse aspettato le apparizioni preoccupate delle divinità. Jean-Léon Gérôme, pittore e scultore francese di fine Ottocento, dedica all’impresa di Cesare una statua bronzea che immortala il generale romano nell’attimo in cui, in sella al suo cavallo, è uscito dalle acque. La statua, di modeste dimensioni e conservata nella National Gallery of Canada, mostra tutta la fisicità dell’evento, dalla fatica del destriero al vento che innalza le vesti di Cesare. Le raffiche sono così forti che quasi sembrano aiutare nella risalita i due soggetti, così come accentuate sono le increspature dell’acqua. La plasticità classicheggiante, accademica, dell’opera di Gérôme, conferma le convinzioni dell’artista nel rifiutare l’impressionismo francese, protraendo quindi lo stile neoclassico. Daniel Richter Raimondo Ferlito “Rimeditare la lontananza” di Elisa Toscano Tracce del passato ci parlano di un’esistenza immortale che riaffiora tra i colori e le fibre delle tele del pittore Raimondo Ferlito. È lo stesso artista che afferma: “L’idea dello spazio e del tempo è connessa a quella del viaggio dell’andata, del ritorno, del ripensamento nostalgico, della rimeditazione nella lontananza, per una ripartenza magari verso un medesimo tragitto ma con altro sguardo e più ricco bagaglio”. È proprio il viaggio ad ispirare l’artista, un viaggio dal significato simbolico e catartico, che vede l’uomo, moderno Ulisse, errare lungo i percorsi della propria vita verso un luogo, una meta che si scopre essere il punto d’origine. La circolarità di questo iter, lontana dall’accezione cristiana e lineare del tempo, è permeata dall’esperienza, dal ricordo nostalgico e da nuovi punti di vista di uno stesso tragitto. Luogo di incontro tra modernità e passato, sono i lini settecenteschi ed ottocenteschi, usati un tempo per avvolgere opere sacre, che compongono e accolgono l’espressione artistica di Ferlito assumendo una nuova funzione e riscaldandosi di nuova vita. Sono tele che comunicano e si donano come ricordi e segni di un tempo passato, intriso di significati colti e raccontati dall’artista che esalta le tracce di oli, colori e umori rendendoli parte della propria opera. La materia, intesa non solo come presenza o assenza di colore o di altri materiali, ma anche come elemento, tecnicamente necessario, per valorizzare e lasciare spazio ad ombre e luminosi riflessi creati dalla superficie irregolare delle opere. Elementi diversi perfettamente armonizzati vivono e comunicano con grande forza espressiva un rasserenante senso di equilibrio. Il linguaggio pittorico dell’artista esprime, tramite la combinazione di scrittura, pittura e materia, una continua ricerca esistenziale che solo un’anima lirica e sensibile può percepire. È un racconto mai negativo, seppure fortemente impregnato da elementi nostalgici, che riportano l’uomo a confrontarsi con la propria memoria. Esperienze e ricordi del passato tradotti in una prospettiva attuale e moderna che impreziosisce e rende eterna l’opera di questo artista. L’astrazione come “ideale purezza” di Rosario Leotta Piazza George Pompidou, Parigi. Agosto 2007. Un pittore di strada come tanti ritrae i turisti vendendo loro disegni per cinque euro. Pochissimo, ad ogni modo, in confronto al collega “più bravo” che chiede ben cinquanta euro a ritratto. Immediatamente molti lo snobbano per lo stile strambo, un cinese addirittura lo paga con tre euro anziché con i cinque dovuti, accusandolo di consegnare in pochi minuti i suoi ritratti senza impegnarsi. Solo giorni dopo si scoprirà che in realtà si trattava di Daniel Richter, uno dei più grandi pittori contemporanei, quotato per milioni di euro a dipinto. Una delle tante provocazioni sotto forma di performance dell’artista tedesco, che ci fa riflettere ancora una volta sui meccanismi del gusto e dell’estetica. Il linguaggio di Richter si evolve quasi all’inverso rispetto al consueto: a differenza di molti pittori esso parte dall’astrazione, intesa da lui come “ideale di purezza”, per poi recuperare la figurazione tramite una sorta di unione tra lo stile simbolista del secolo scorso e la cultura pop e dei mass media attuale. "In definitiva, non c'è differenza tra pittura astratta e figurativa, a parte alcune forme di decifrabilità, i problemi di organizzazione dei colori sulla superficie rimangono sempre gli stessi. In entrambi i casi lo stesso metodo si insinua in forme diverse", afferma Richter. Queste nuove figure da lui inserite sono rappresentazioni contemporanee della realtà ed esprimono un chiaro disagio politico e sociale. Tematiche che emergono fortemente nella sua ultima personale a Parigi “Voyage Voyage”. A Debrecen in Ungheria è in corso una collettiva alla quale è stato invitato, sulle nuove tendenze della pittura figurativa, il cui tema è ispirato all’inquietante racconto “Nightfall” di Isaac Asimov. 5 l’EstroVerso Gennaio - Marzo 2013 Arte&Creatività (segue da pag. 1) Mirò, alla scoperta di una realtà ‹‹profondamente poetica›› di Laura Cavallaro Qui si trasferì nel 1956 e realizzò il suo sogno di un grande studio, ricostruito in mostra con gli arredi originali, in cui poter lavorare liberamente, mettendo da parte pennelli e cavalletto e sperimentando, in un prolifico fervore creativo, nuovi mezzi e tecniche espressive che lo portarono a camminare sulla tela, a bucarla, a spruzzarvi sopra il colore o a lasciarlo gocciolare, spesso stendendolo con le mani. Il processo di creazione artistica di Miró, apparentemente semplice ma carico di un senso profondo e di significati nascosti, si poteva riassumere, per sommi capi, in tre fasi: seguire un impulso, organizzare le forme ed arricchire infine la composizione. Dietro a tutto ciò un artista che non aveva confini e non amava incappare in “etichette” artistiche che lo definissero surrealista o astrattista: ‹‹Voglio scoprire la realtà profonda ed oggettiva delle cose, - disse - una realtà che non è superficiale e neppure surrealista, ma è profondamente poetica››. Talani Pyromanie di Erica Donzella “‹‹Dammi un bacio forte prima di andare via. Prima di richiuderti nella tua crisalide vetro opaco, verde edera. Ramificata dentro la schiena. È per troppa materia a cui abbiamo dato nomi e cifre che non sappiamo più sfiorare l'attimo. Schiavi seviziati dalla paura.Come se l'aria potesse dividersi in atomi tutti uguali, schegge affilate dentro la gola, le parole che rimangono in silenzio. ›› Era il pensiero abortito, raschiato e vomitato lucidamente dopo molte bocche passate sulla sua. Se avesse potuto strozzare quella rabbia, mai gridata, sempre decorata di sguardo collerico, di quel gioco della filosofia, scudo d'oro alle urla bulimiche. Panta rei. Non passa un cazzo senza lasciare taglio. Sempre cullata col senno di poi, pur sempre spina dorsale di ogni giorno, notte, alba rubata al sonno, mano vibrante di mancanza. Tremava. Per quella vita che sentiva troppo, che le drogava la bocca e anestetizzava il dolore, pur sempre canto, caduta libera dentro uno specchio riflesso di sé. Se avesse potuto spegnersi, per morire almeno in pochi millimetri di pelle, da ricucire senza sentire il graffio dell'abbandono, se avesse dimenticato di respirare per il dovere di rimanere viva, avrebbe ingaggiato un patto con la sua malsana patologia, si sarebbe resa vulnerabile e avrebbe gettato la maschera della fragilità. Era il simulacro del suo stesso essere. Essere troppo, essere sempre, per sempre. Es, per trovarsi sempre dov'era stata lasciata. <Mi muovo in base alla mia violenza>. Allo stato brado delle sue emozioni, sfiniva la mente di innumerevoli intrecci e visioni, fotogrammi, rebus sfilacciato di nervi rossi e neri. Sinapsi incazzate." 6 l’EstroVerso Gennaio - Marzo 2013 Cultura L’aforisma di Claudio Bagnasco Impossibile amare una sola persona: o tutti o nessuno. L’antro della Pizia di Savina Dolores Massa Il male oscuro La Pizia oggi non ha voglia di parlare di Arti, di disperati poeti, di amabili scrittori, di registi geniali, e di pittori tanto meno. La Pizia ha freddo in quest’antro di gennaio ragnateloso, grigio come un topo denutrito. Sta sul trespolo, immobile, lo sguardo spalmato sulla parete di fronte. Non ha pensieri saettanti nel cuore delle pupille. Può accadere, questo, quando leggendo e frugando con accanimento nel mondo delle Arti il cervello si riduce a schegge appuntite rivolte verso la propria carne. E ci si dissangua in un momento sopra le ceneri di un Majakovskij, di una Woolf, di una Plath, di un Bacon. Anime bruciate, impazzite, straziate. Meglio sarebbe stato scegliere di non incontrare nessuno di loro? Rinunciare alla ricchezza di opere commoventi, se golosamente afferrando non si è stati in grado di ignorare il doloroso percorso che ha condotto tali artisti alla svenata espressione di sé? Dubbi d’inverno, quando il male oscuro avvolge, ed è un lugubre velo. Brutti discorsi, oggi, in quest’antro. Sono desolata, ma dalla Pizia avrete sempre e solo ciò che lei è, e adesso la Pizia non indossa piume di pappagallo caraibico, né le scorre la risata in gola, e come mai come mai? Perché finora dentro la sua testa aveva eretto scale di pietra, gradini sui quali collocare libri, quadri, fotografie, città intere con i propri abitanti. La Conoscenza non sempre è un dono quando per ottenerla si disprezza il tempo da dedicare a un passo leggero in un viale che merita, anch’esso, di essere conosciuto. Si disprezzano, - con un’alzata di spalle perché “non si ha il tempo” - il mutare delle stagioni, il sapore di un cibo, la domanda di un figlio, l’occhio dolce di un cane che timidamente, per non disturbare, ti domanda, Guardami. Distratti da troppi stimoli, pur bellissimi, si precipita nel disoriente, ci si scorda di ascoltare l’ignoranza, che dietro alle spalle, sempre, sa nascondere esistenze di uguale valore a quelle scritte nei libri della Storia. La Conoscenza ha l’obbligo della misura se non si vuole incorrere nel danno dell’onanismo fine a se stesso o di vedersi trasformati in tanti miserabili cloni, pappagalletti con nulla di autentico di se stessi da dire. La Conoscenza ha un senso se si è capaci di trovare l’equilibrio tra ciò che si scopre e ciò che contemporaneamente si è capaci di vivere in prima persona. Il topo da biblioteca, per quanto si impegni, resterà sempre e soltanto un ratto nel momento in cui non saprebbe neanche descrivere il colore del cielo che si è lasciato alle spalle, prima di entrare nell’edificio. Alla Pizia che sono: disordinata, pasticciona, sognatrice con sette gatti e due cani è stato prescritto, Riposa, dormi, passeggia, contempla. Il mio oracolo per voi è, Fate altrettanto: la fretta, la vanità e l’avidità fanno inciampare anche il più astuto tra i corridori. Ecco, questo è tutto, confusamente espresso come il mio cervello adesso esige. Se non mi avrete compreso, sarete giustificati. Buon anno. SDM 7 l’EstroVerso Gennaio - Marzo 2013 Cultura Scrivere di Selenia Bellavia La scrittura è effectio corporis. Indistinti rimuginìi cerebrali esigono una edificazione, un alcunché di tangibile, una cristallizzazione in forma. Una reflexio anatomizzata e assettata, che non sfumi in un reflexus cerebri, reclama un corpo. Tuttavia, la sua genesi, come ogni concepimento, mostra la sua insidia: in aggiunta all’evidente effetto prodotto da una spoglia sostanziale che confina l’intelletto entro i suoi margini, quantunque necessari per dare ordine e gravità ai pensieri, tende a fondere, subdolamente, l’io scrivente con l’oggetto narrato. L'io incombe sulla cosa e questa, di rimando, s’imprime nel soggetto. La contrazione indotta da tale contaminante infiltrazione innesca un’identificazione che trascina verso un esiziale deragliamento: la comunicazione. Antitetica all’espressione, epiphania del rapporto con se stesso e con il proprio spirito, riguarda quel correlarsi con l’altro che origina dalla necessità di vivere in branco. È spontaneità d’esistenza, come un digrignìo di fiera, un ammiccamento d’intesa o un’emanazione feromonale. Chi comunica non può non identificarsi con la cosa che, in quel momento, lo sta abitando. È quel passaggio dall’oralità al gergo scritto che annienta la forma in favore della fretta e riduce la parola a traccia d’inchiostro analoga a cartello stradale o insegna promozionale. Quantunque la scrittura sia condizionata dalla pulsante materia antropica, l’io determinato a esprimersi può, nondimeno, fiaccare tale assorbimento con una coercizione, vale a dire con l’attuazione di una frattura tra se stesso e il proprio actus. Stendere uno iato che s’interponga tra scrittura e ordinaria esistenza di funzioni fisiologiche e bisogni equivale a staccarsi da se stesso, tuttavia deve tentare con ogni mezzo. Tale scarto è risonanza della sua attenzione e può preservarlo dallo sdrucciolare verso un io comunicante. l’editore racconta… Le Edizioni Clichy nascono a Firenze dalla ex redazione di Barbès, marchio editoriale nato nel 2007 e messo in liquidazione alla fine del 2012 a seguito dei problemi finanziari del gruppo che la possedeva, Edison. La nuova casa editrice, del tutto indipendente, prende il nome dal quartiere parigino di Clichy, teatro del capolavoro di Truffaut I 400 colpi, ed è composta dallo stesso staff (la caporedattrice Franziska PeltenburgBrechneff, le redattrici Giada Perini e Maria Pia Secciani, l’addetto stampa Silvio Bernardi, con l’aggiunta di Tania Spagnoli, già traduttrice e consulente per Giunti, Garzanti e Fanucci) e diretta da Tommaso Gurrieri, artefice della nascita di Barbès. Le Edizioni Clichy, le cui prime pubblicazioni partiranno a fine gennaio 2013, guarderanno con un occhio di riguardo alla Francia odierna, sempre più luogo di incontro tra la storica cultura europea e quelle “altre”, da sempre nuova linfa per la creatività di artisti e scrittori: la topografia di Parigi sarà richiamata, infatti, non solo dal nome della casa editrice, ma anche dalle collane. Il “mondo nel mondo”, parafrasando Stephen Spender, della città delle Luci, fungerà così da ponte per una produzione che abbraccerà la narrativa contemporanea - sia essa di stampo letterario o legata alla cultura popolare, sempre col denominatore comune della qualità della scrittura - e quella classica. Altro aspetto importantissimo della proposta di Clichy saranno i libri per ragazzi, scelti accuratamente tra le più ricercate proposte straniere e italiane. Infine, centrale sarà il dialogo con la Toscana e in special modo Firenze, città che ospita la redazione e con cui quest’ultima si augura di sviluppare un rapporto privilegiato e tutt’altro che univoco, offrendo e raccogliendo stimoli sia attraverso un marchio integralmente dedicato alle proposte toscane, Firenze Leonardo Edizioni, sia con la programmazione di corsi, reading ed eventi all’interno della sede di via Pietrapiana. Ecco nello specifico la presentazione delle collane e delle prime uscite. La stazione parigina Gare du Nord, frenetica e multiculturale, dà il nome alla prima collana, dedicata alla narrativa contemporanea di stampo letterario, francofona ma non solo: tematiche forti, autori dalla scrittura inconfondibile, senza timore di assumere posizioni di rottura di fronte all’establishment culturale e sociale. Simbolica in tal senso è la scelta del primo titolo, in libreria dal 23 gennaio, I miei luoghi: si tratta di un librointervista di Marguerite Duras, scritto con Michelle Porte e finora inedito in Italia, in cui l’autrice de L’amante si racconta dal di dentro, attraverso i luoghi della sua vita che fanno da contrappunto a tutti i suoi straordinari romanzi. Sempre il 23 gennaio uscirà Scrittori di Antoine Volodine, autore franco-russo di grande complessità e originalità, celebratissimo dalla critica di tutto il mondo. A fine febbraio sarà poi la volta di La conversazione, romanzo breve in cui l’Accademico di Francia Jean d’Ormesson immortala Napoleone Bonaparte nel momento prima della scelta più importante della sua vita: proclamarsi imperatore. E ancora, nei prossimi mesi: le storie di banlieue di Pierric Bailly, l’America secondo Philippe Besson e il lunatico e imprevedibile Mago di Oz secondo Claro. Il Centre Pompidou, luogo d’incontro di giovani artisti e performer, musicisti e skater, presta il nome a Beaubourg, la collana di Clichy che più di tutte darà voce allo spirito della cultura pop, in tutte le sue espressioni: dalla musica al cinema, alla narrativa postmoderna che sappia venire incontro ai lettori più diversi. Il primo titolo (anche questo in libreria il 23 gennaio), Woody, Cisco & Me, romanzo autobiografico dell’americano Jim Longhi che racconta, in tono spigliato e rocambolesco, delle sue esperienze in Marina durante la Seconda Guerra Mondiale al fianco della leggenda del folk Woody Guthrie, incarna in unico libro le diverse anime della collana. Il percorso a tutto tondo sulla cultura pop non si fermerà alla parola scritta: tra i titoli di Beaubourg figureranno anche graphic novels, selezionate tra le migliori proposte del settore, senza paura di affrontare argomenti difficili o scomodi, secondo le molteplici possibilità di espressione di un mezzo che sempre meno viene considerato alla stregua delle arti minori. I primi due albi di questo filone saranno il doloroso Estate ‘79 di Hugues Barthe e Fern Grove della finlandese Katie Närhi. Sembrerà un azzardo intitolare una collana a un cimitero, ma il Père Lachaise è da sempre molto di più di questo: è un luogo di memoria storica e culturale, monumentale, di culto anche pagano, di scoperta delle proprie radici. In questo senso la collana che ne prende il nome proporrà autori considerati fondamentali per la storia della letteratura, riscoprendone opere minori, inedite o assenti da lungo tempo dalle librerie italiane, con traduzioni e curatele nuove. Faranno parte di questo filone una breve raccolta di scritti di Herman Melville mai tradotti in Italia, in programma per metà 2013, e un’opera teatrale di Ottiero Ottieri, I venditori di Milano, pubblicata per la prima volta nel 1951 e mai più riproposta. La piazza in cui sorge la piramide di vetro del Museo Louvre, e che originariamente ospitava una grande giostra a cavalli, dà il nome Carrousel, collana per ragazzi che avrà grande spazio nella produzione di Clichy: comprenderà albi scritti e disegnati dai migliori illustratori del mondo, scelti in base al carattere inconsueto o alla storia avvincente, al tratto originale o al testo sognante. Tra i primi titoli, lo spiritoso e variopinto Il ladro di calzini di Marie Paruit e il dolcissimo Grande lupo piccolo lupo di Olivier Tallec. Il rapporto con Firenze, città pulsante e dalla vita intensa al di là dei circuiti turistici, è infine centrale nelle intenzioni della nuova casa editrice. In tal senso ecco un marchio dedicato alla produzione toscana e fiorentina, Firenze Leonardo Edizioni, che pubblicherà libri incentrati sulla storia e i costumi della città dei Medici, senza dimenticare il vernacolo e l’umorismo fiorentino, ma anche con particolare attenzione ai personaggi che hanno fatto la storia della Firenze di oggi. In questo senso si inserisce La Pira: la città e l’urbanistica, raccolta di scritti sulla città dello storico sindaco Giorgio La Pira, curate da Francesco Gurrieri e già in libreria da pochi giorni. Tommaso Gurrieri (Direttore Edizioni Clichy) 8 l’EstroVerso Gennaio - Marzo 2013 Inediti d’autore Diego Caiazzo Paolo Aldrovandi Diego Caiazzo è nato a Napoli il 25 ottobre 1955. Vive a Pomigliano d’Arco. I suoi interessi principali sono la letteratura, e in particolare la poesia; la musica, suona il pianoforte con predilezione per Bach; gli scacchi, è Candidato Maestro della Federazione Scacchistica Italiana e inserito nel ranking internazionale della Fédération Internationale des Échecs. Considera la poesia una finestra sull’anima. Scriverla o parlarne significa guardarsi dentro, senza mentire. La sua opera è ancora interamente inedita. Questa è la prima pubblicazione su rivista. Le seguenti poesie sono tratte dalla raccolta “La via lattea”. Mi chiamo Paolo Aldrovandi. Sono nato a Mantova nell’agosto afosissimo e pieno di mosche del 1974. Da allora, credo, non ho mai più sopportato il caldo. Da buon essere invernale, ho scritto la mia prima poesia a tredici anni per un amore non corrisposto (ovviamente). Ma ricordo che già allora trovai il modo per essere assai poco carino nel far notare il mio disappunto. Infatti, quando la lei del momento si ritrovò la mia poesia tra le mani e la lesse, non mi abbracciò affatto. Il mio modo di scrivere è così: crudo, reale e poeticamente quotidiano… Nel mondo e nella vita, anche nella peggiore, esiste uno strato di poesia ben compatto, anche se il più delle volte impercettibile… Viaggiando molto, e spesso da solo, ho avuto la possibilità di farmi più idee e di prendere spunto da queste. Di osservare i vari mondi e le diverse abitudini, di parlare con persone che quasi certamente non incontrerò mai più… È stata essenzialmente questa la linfa vitale della mia poesia. Non ho nessuna pubblicazione rilevante: ho scritto per decine di riviste di poesia, sia cartacee che online, ma non ne ricordo nemmeno i nomi. Scrivere poesia è una liberazione obbligatoria, e io faccio così. Dagobert D. Runes dizionario di filosofia Oscar Studio Mondadori “stampato nell’aprile 1975” l’ultima pagina rivela l’età i fogli sono gialli come una pelle malata picchiettati di puntini neri come minuscoli nei segno d’una corruzione chimica della carta non avevo ancora vent’anni quando comprai questo libro considerandolo eterno come me stesso ora dopo altri trenta l’ittero della cellulosa ne denuncia la fragilità ricorda che non resisterà ancora a lungo al passare del tempo una tragica avvertenza al lettore sul suo disfacimento. *** Si sa, scrivere è un tentativo di sopravvivere a sé stessi, di sprigionare l’anima per metterla in salvo sulla carta; forse ci si illude di valicare il muro della morte usando una scala di sillabe; e così, sillabando, la vita si attenua, scritta sembra quella di altri, di cui si è pronti a consolare il dolore. *** Forse è questo la poesia una via di salvezza come la religione un’invocazione alla divinità sacrificio e preghiera ogni componimento è una tappa di riposo e di conoscenza stazione di posta del pensiero e dell’anima in una via altrimenti smarrita. Dormiveglia La schiuma resta in testa e vorrei non dormire mai nella mia risacca omicida che ricopre tende la notte sbalzando anime passate e rimuovendo fantasmi pagliacci che portano allo sgomento del mattino con incapacità recidiva che abbraccia come una scimmia e gratta con unghie sporche e dita nere come la povertà entrata nella mia casa nuda col sorriso dal volto mancato pensando al momento eterno come al sangue tenuto stretto nelle vene piene d'aria in embolia costante sparata come uno zero da siringhe sante capaci di far dormire l'idea e di salvarsi dall'estasi momentanea nell'infimo viaggio riciclabile Non ti allontanare Non ti allontanare resta e sbriciola quel pezzo di pane lascia lo smalto fluire lento in arteria rosso scomposta nel tocco del senso che è padrone del vedere di questi occhi buttati che rubano colore al sole nella speranza d'incendiare i fronti del tuo bollente pudore che scivola in languide serietà come il braccio armato della sua stessa vita domandandosi se l'amore è spedito in posta celere da postini pazzi che fischiano mille volte al giorno sotto casa la stessa nenia in ripetizione permettendo di frugare rapido tra scatoloni di non amore schiacciati in soffitte che preferiamo tenere sempre chiuse agli altri 9 l’EstroVerso Gennaio - Marzo 2013 Inediti d’autore Il senso negato di Letizia Dimartino Racconti uniti da un comune denominatore. Protagoniste le donne. Flaminia Flaminia è il suo nome. Ha capelli verdi, occhi gialli. Ha pure due- tre sogni. Le si attorcigliano lungo le gambe, su per il corpo allungato quando la sera cerca, inutilmente, di pensarsi stesa sul letto al di là della sponda e cerca di vedersi immobile e sdoppiata in un vano tentativo di training. Succede invece che al posto della visione, difficile da immaginare, le si inerpicano i sogni per le gambe immobili e tese, che invano cerca di rendere molli. Arrivano, i sogni, immediatamente alla testa e vi dimorano nei rimanenti cinque minuti necessari al raccoglimento. “Cara mia Flaminia, hai dimenticato più cose in bagno. Ti elenco: salvelox cotton fioc forbici dalle punte arrotondate (a che servono?) spazzola con capelli vecchio dentifricio. Ho raccolto il tutto in un sacchetto da farmacia e l’ho posato sulla mensola di vetro, quella sempre schizzata d’acqua. Non penso verrai mai a prendere quanto ti ho detto, conserverò il sacchetto per un’altra settimana - poi si vedrà. In bagno ho fatto finta di parlarti, ti ho detto: oggi racconterò una storia, una storia breve e concisa; tu l’ascolterai poi verrai a dormire, finalmente per sempre, in quella stanza bianca che cosi’ poco ti piace, ma piace a me perché fatta di luce, priva di tende, assolata e vicina alle nuvole. La storia è una poesia, la poesia che cerco sempre nella mia mente, quella che arriverà prima o poi nella tua vita e sarà la poesia del sempre e del tutto. L’unica che io sappia e sappia dirti. Quella che tu ascolterai e seguirai; io, quando tu la ripeterai, camminerò ai margini della tua vita confusa, rassettando e raccogliendo i tre sogni che ogni sera si attorcigliano lungo le tue gambe. Le sentirai finalmente sciolte, immobili ma lente, molli di carne ossa e sangue. I tre sogni saranno dentro la mia poesia, non la declamerò ma tu l’ascolterai lo stesso perché ti giungerà oltre la spalliera del letto e ti vedrai stesa - figura dormiente - sdoppiata e leggera. E sarai tu, in questi versi rilassati, pronta a sciogliere il nodo ai capelli che stringe i pochi pensieri di troppo, quelli che attanagliano la tua piccola mente inquieta. Ascolterai la poesia dei tuoi giorni qualunque, ogni parola ti giungerà sommersa, sfoglierà giorni di calendario, trapasserà ore immaginifiche, si poserà sul tuo sguardo irriflesso e strapperà, straccerà, i tre sogni che ti hanno fatto fuggire e urlare lungo le scale del mio palazzo antico che, mai, ha ascoltato simili urla. Il tuo grido mi è giunto ed io ne ho raccolto l’ultima frangia del lamento contenuto, per trasformarlo in poesia. Nessun computer potrà conservare il canto compresso dei miei versi slabbrati ma io so, per primo, quante parole contiene il silenzio di questa poesia che tu mi strappi e chiedi da giorni e mesi. So che vuoi parole silenziose quelle che non giungeranno mai - così dicevi commossa con il brillio dei tuoi occhi gialli che riempiva la stanza bianca, ed era luce sulle tue parole. Ora che te ne sei andata attendi pure versi imbrigliati perché nessuna magia verrà più fatta". Moltevoltecaro Diego, l'urlo di cui tu parli io non l'ho sentito né emesso. Chi dunque ha gridato al mio posto il giorno in cui ho sceso le lunghe scale di casa tua, stentando non poco per il peso di una valigia troppo scomoda e pesante? C'era silenzio in fondo alla mia gola secca, bruciava di dolore compresso ma tu non hai potuto sentire molto delle piccole frasi che ti dicevo, scalino dopo scalino. Del fuoco della testa, di quello avresti dovuto sentire l'odore acre …ma tu pensavi alla poesia che mi avresti detto un giorno. Quale giorno? le attendo, le parole sparse; ma che colore avranno e che sapore? gusterò le vocali che si attardano sul foglio bianco - perché ci sarà un foglio bianco - e finalmente divorerò le tue parole nel silenzio che tu conosci bene. Il silenzio dei miei occhi della mia voce, il silenzio che inseguo. Tu invece insegui i miei tre sogni. Vuoi conoscerli, li inventi, li immagini, li vedi strisciare per le mie gambe tese. Ma io, io li conosco i miei tre sogni? Mi accompagnano da anni, credevo di averli trovati fra le pieghe delle lenzuola stropicciate del tuo disordinato letto, nella camera bianca vicino alle nuvole minacciose oltre la finestra, nel miagolio del tuo grigio gatto che sfugge al mio minimo gesto, tra le trame del tuo unico maglione color arancio, intrecciato ai riccioli corti della tua piccola e tonda testa. E ancora potrei dire. Ma ricorda, non li conosco i miei tre sogni e non sono andata via perché li cerco da sempre. La tua poesia dovrebbe dirmi che le mie gambe sono finalmente morbide, niente si attorciglia intorno ad esse ed io mi vedo oltre la sponda del letto, supina e dormiente in altro letto, ormai, in altra casa in un misero pianoterra vicinissimo ai rumori di una strada di periferia, fra le nuvole di traffico senza colore. Chi, allora, ha gridato quella mattina durante la mia lenta e impacciata discesa? Non aspettarti più niente, perché poco verrà da me e io sono incapace di fare magie. Nessuno cambierà i miei tre sogni in semplice realtà. Né permetterò mai che tu lo faccia, anche se con una splendida e unica poesia". Diego si alza e va alla finestra. La sera della città è dietro i vetri della sua alta casa. Poco giunge del traffico, la camera è invasa d'altri rumori: un computer che attende, acceso, d'essere accarezzato; un gatto grigio che sogna sussultando sulla poltrona, il ronzio del frigorifero quasi vuoto, la spia rossa e ticchettante del vecchio scaldabagno. Diego non attende più. Lì, fra le pieghe delle lenzuola stropicciate del suo disordinato letto si attarda un capello verde. Apre la finestra, il primo infisso, il secondo infisso e poi nel vuoto, leggero, il capello si attorciglia, si slarga. Galleggia nell'aria della notte sopraggiunta. Nessuna magia è stata fatta. Nata a Messina nel 1953, Letizia Dimartino vive a Ragusa. Ha pubblicato nel 2001 la sua prima raccolta di poesie, Verso un mare oscuro (Ibiskos), seguita nel 2003 da Differenze (Manni) e, nel 2007, da Oltre (Archilibri). Nel 2010 è uscito La voce chiama per Archilibri. La silloge Cose, tratta da La voce chiama, è stata pubblicata sull'Almanacco dello Specchio 2009 (Mondadori). Nel novembre 2010 Metallo, primo premio per l’inedito (premio Gilda Trisolini) del circolo culturale Rhegium Julii, è divenuto un libro a opera della stessa associazione. A maggio 2012 è uscito per Ladolfi Editore Ultima stagione con un testo critico di Renato Minore. 10 l’EstroVerso Gennaio - Marzo 2013 Notizie Letterarie Fotoracconto di Massimiliano Raciti Belli da leggere di Grazia Calanna Chiacchiericcio Dario Spoto di Marco Saya (Marco Saya Edizioni) Mio padre suonava la chitarra; era bello ascoltarlo alle feste insieme a tutti i vicini. Quando cantava aveva uno spirito e una verve tale da ammaliare tutti. Una volta se qualcuno voleva ascoltare della musica doveva bussare alla porta di un musicista e chiedergli se poteva suonare per lui. Se il musicista accettava bene, se no niente, dovevi aspettare il momento giusto. A parte gli strumenti, mica esistevano supporti per riprodurre musica. Poi fu la radio; la sera c'era quasi sempre un concertino dopo il bollettino di guerra, piccole orchestre trasmettevano Bach in onde medie. Poi un tizio inventò il disco in vinile, arrivò il grammofono per sentire qualche disco. Era come avere Beethoven ospite a cena quando volevi. Ogni disco era un tesoro speciale, ricordava una data ben precisa, una ricorrenza, un regalo e le note intrappolate nel vinile erano vive dentro la mente di chi ascoltava, meditava, imparava. Poi arrivarono le case discografiche e gli LP. I Long Plain, meravigliose suite musicali tutte da gustare, nacque il rock, figlio di jazz e blues... quelli sì che furono anni memorabili... arrivava anche l'elettronica. Costavano i dischi, mica era per tutti, mettevi da parte qualche cosa e poi correvi in un negozio o aspettavi di ricevere per posta i primi successi dei grandi stranieri. Quando finalmente arrivarono anche le musicassette si diffuse quella che ancora oggi chiamano pirateria. Poi l'alta fedeltà, il compact disc, plastica, fibra ottica, dati elettronici letti da un laser rosso. Adesso basta un mini lettore mp3 per conservare oltre 300 canzoni in 2 centimetri per 1. Mi sono diplomata al conservatorio, suono l'arpa, il violino, la chitarra, il piano e sto pian piano imparando anche la tromba. Amo la musica, è la mia vita, mi fa sentire mio padre ancora vicino, come quando mi vide per la prima volta alla filarmonica, il mio debutto. Ormai però non trovo più lavoro, pazzesco. Le lezioni private mica bastano a pagare tutto, ormai i ragazzini giocano a guitar hero, uno stupido giochino con una chitarrina a tasti colorati in cui devi schiacciare in sequenza quello che ti dice il video. Ricordo con malinconia gli sguardi che cercavano mio padre e aspettavano in silenzio che lui accordasse la chitarra e ci regalasse un sogno fatto di note, accordi, voce. Magari alla fine ci regalava anche qualcosa da ballare tutti insieme. Assurdo, sono quasi cinque anni che lavo scale dei condomini ormai. E quest'oca giuliva mi ha appena macchiato con il suo gelato zeppo di conservanti, come la musica confezionata dalle case discografiche che ha nelle cuffie. “cinque muniti per dirvi di non ascoltare / codeste cassandre puttane / travestite da lauree con master a seguito, / figlie di un capitalismo abortito / e di una democrazia stuprata. […] cinque minuti per riprendervi quella dignità / persa nella sabbia fine di qualche deserto”. Marco Saya, edita se stesso, e, tra virgolette, si scusa per il tempo rubato al nostro tempo chiamandoci alla malmenante lettura del suo spregiudicato Chiacchiericcio. Dopo averlo scusato, lo ringraziamo. Converrebbe Cioran, esistono solo le cose che abbiamo scoperto da soli, le altre sono tutte chiacchiere. Saya, cosciente della “precarietà della parola”, addita la menzogna, “verità tramandata da previi accordi”, figlia dell’umanità intrappolata nel cerchio perpetuo della reiterazione, “ricordo quei convogli / che, allora, avevano / un’unica destinazione”. Plasma versi agili, “il caleidoscopio della mente / ricicla immagini variopinte / come ruote di pavoni”, fotogrammi verbali di un paese popolato da lacchè, opinionisti senza opinioni, morti sul lavoro, precari in cerca di dignità, in cui “la povertà precipita / fracassandosi sull’asfalto / cosparso da compresse di xanax”. Versi acuti, “mi domando se, oggi, l’idea abbisogni / di un nuovo re-styling / ma gli orchestrali della mente / dirigono solo metà emisfero / perché a corto di dipendenti”, di sociale interpellanza, “ri-apprendere come sfregare le pietre focaie / potrebbe essere il miglior inizio / per dar fuoco a questo presente?”. SoloMinuscolaScrittura di Silvia Rosa (La vita felice) “Il linguaggio è uno specchio della mente in un senso profondo e significativo; è un prodotto dell’intelligenza umana, ricreato ex novo in ogni individuo mediante operazioni che si situano ben oltre il limite della volontà e della consapevolezza”. Leggendo “SoloMinuscolaScrittura” di Silvia Rosa, sovviene la riflessione di Noam Chomsky. Siamo in presenza di una prosa poetica che non sfugge il silenzio, bensì lo accoglie in policroma (faconda) pienezza. Taciturne, “le parole sono carne tenera dell’anima, l’alfabeto di occhi mani labbra che siamo, eterni a svanire”. Con verità cristallina, “a denti stretti”, l’autrice partecipa il lettore del proprio “precipitare nell’ansa nuda di parole”. Indaga le geografie del tempo, pur (talvolta) assente da se stessa, instancabile, pur (talvolta) stanca dell’immobilità che la “preme contro i minuti sbeccati taglienti dei giorni che scorrono in fretta, e si sbriciolano”. Sveste i propri dubbi esistenziali, “bolo indigesto che ulcera la coscienza”. Sul “candore delle pagine” adagia desideri cosmici, riconoscibili, anche quando taciuti, “vorrei che ci scambiassimo le fiabe, e le dolcezze che teniamo nascoste al mondo intero, […], il tempo di un sospiro di piacere che tremi il cuore e frani cielo e terra fino all’origine di (un) noi - possibile”. Ebbene, cardine è l’amore, che, insegna Ludwig Feuerbach, è passione, contrassegno della vita, senza il quale, ricorda (semplicemente) Silvia Rosa, “i giorni (e le notti) precipitano nel vuoto”. la ferrovia di Lina Maria Ugolini (L’Arca Felice) “Il segno ferrato dei caratteri tipografici traccia un percorso emotivo aperto dentro il quale il lettore può ritrovarsi e aggiungere tratte, destinazioni, fermate. Il senso dell’itinerario è racchiuso in questo verso: - Corre sui binari la scrittura ma il conoscere è meta provvisoria -. Esprime a mio avviso una necessità fondamentale per l’uomo: l’anelito laico dell’intelletto al mai-finito auspicabile nella dimensione di un oltre”. Parole di Lina Maria Ugolini, autrice, per le Edizioni L’Arca Felice (collana arte-poesia a cura di Mario Fresa, progetto grafico di Ida Borrasi), della plaquette lineare la ferrovia ornata da una litografia di Roberto Matarazzo. La Ugolini celebra il viaggio, porta attraverso la quale si esce dalla realtà come per penetrare in una realtà inesplorata che sembra un sogno (Guy de Maupassant). La meta è “l’ignota stazione Ω”, ricorda. Dovremmo imparare a mitigare la corsa, lontani dalla “retta oraria alla ragione”; imparare a sostare, “Ti volevo salutare: / una mano sulla spalla, un abbraccio fraterno”; imparare (meditando) che non basta “spostarsi per essere altrove // scendere dal treno e ricominciare / il lavoro sporco in un’altra piazza”. Un canto lirico con esteso registro acuto (accorto), “Il fischio del capostazione / arriva come una lama di coltello // fende la nebbia / cola sangue grigio / sulla cicatrice del ricordo”, e grave (intenso), “tra le dita della morte / prossima a recidere / minuti pezzetti / estreme briciole di un tempo vuoto / coriandoli / al carnevale della vita”. 11 l’EstroVerso Gennaio - Marzo 2013 Anteprima "Mi hanno detto di Ofelia" di Cristina Bove “Ho cominciato da piccolissima a nutrire la passione per le arti, la lettura e la scrittura. A tredici anni scrivevo poesie, alcune furono pubblicate sul quotidiano Il Mattino. A diciotto anni mi suicidai (non “tentai”il suicidio, come comunemente si dice, perché non avevo sperato né previsto di sopravvivere). “Viva per miracolo dopo un volo dal quarto piano” titolarono i giornali. Ho vissuto da giovanissima tre anni a Tunisi dove fu allestita con successo la mia prima personale di pittura. È mia la scultura in bronzo nell’atrio dell’hotel Sabbiadoro a S. Benedetto del Tronto. Negli ultimi tempi mi dedico soprattutto alla poesia. Mi sento testimone del mio tempo e della mia esistenza. Credo nella libertà e nella giustizia. Considero la poesia un linguaggio universale, l’esperanto dell’anima”. Parole di Cristina Bove autrice dopo, Fiori e fulmini (2007), Il respiro della luna (2008) e Attraversamenti verticali (2009), di Mi hanno detto di Ofelia (Edizioni Smasher 2013). “Divagazioni, divertissement, diletto? Le definizioni colgono solo una parte dell’essenza, restringono il campo e, delimitandolo, lo tradiscono, restituendone, appunto, una versione tranquillizzante perché divulgabile. È bene, allora, diffidare di etichette sbrigative, sottrarsi alla tentazione di catalogare. Consiglio, questo, particolarmente calzante per Mi hanno detto di Ofelia di Cristina Bove. Silloge proteiforme, nel senso più ampio e nobile del termine, poiché dalla ricchezza e dalla mutabilità di forme e di declinazioni della poesia essa trae una linfa originalissima. La parola, quanto mai duttile qui, attraversa tutti gli stati della materia e altri ne crea, mescolando sapientemente e in guisa mai scontata gli elementi ‘naturali’. Chi legge è invitato qui ad avventurarsi su Holzwege, sentieri interrotti nel bosco, a seguire vene sotterranee erroneamente date per esaurite, a percorrere traiettorie divergenti dal canone consolidato, anche da quello che l’epidermica impressione può far percepire come inusuale e innovativo e che troppo spesso, nella poesia contemporanea, non osa oltrepassare la striminzita e logora tessera del canovaccio pseudoermetico-essenziale”. Estratto dalla nota critica di Anna Maria Curci. La strada per il molo Hai sogni dipinti in verticale come gli occhi dei gatti tristi di vissuto a gabbie per infinitesimi chiacchierii riposti scaffali imbarcati al centro a sostenere il peso dei miracoli una cicca d'avanzo tra le labbra il respiro invetriato nella tosse mi prendo tempo e giro oltre la strada a filo di gessetti - il marciapiede dilaga di madonne dipinte con l'assenzio ed il vetriolo non è tempo da tetti né comignoli vieni sul mare a guardare velieri controluce doppiare l'orizzonte e il calendario. L’ANGOLO DEL COMMERCIALISTA I risvolti positivi dell’IMU di Danilo Lizzio - [email protected] L’Imposta Municipale Propria (IMU) ha portato conseguenze negative nell’anno 2012, per l’innalzamento delle tariffe e degli esborsi che si sono abbattuti sui possessori di immobili, terreni e aree fabbricabili. Però l’IMU ha anche un risvolto positivo; riduce, infatti, il peso fiscale dell’IRPEF sugli immobili non locati. Tale vantaggio è visibile già adesso con la consultazione delle bozze dei modelli di dichiarazione per l’anno 2012 (Unico PF 2013 e 730/2013), ma lo sarà ancor di più al momento del versamento dell’IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi. Per il periodo d’imposta 2012, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le sue addizionali (regionale e comunale) per ciò che riguarda i redditi fondiari sui beni non locati. In pratica questo vuol dire che per gli immobili non locati nell’anno 2012 non si pagherà né IRPEF né addizionale regionale e/ o comunale in quanto già sostituite dall’IMU; tale meccanismo sarà possibile escludendo gli imponibili di tali immobili (ovvero le rendite catastali rivalutate) dal reddito complessivo sul quale calcolare l’imposta sul reddito delle persone fisiche e, di conseguenza, delle sue addizionali. Quanto detto vale anche per i redditi dominicali dei terreni (mentre il reddito agrario continuerà ad essere gravato da IRPEF e addizionali), per gli immobili in comodato d’uso gratuito e quelli adibiti promiscuamente ad uffici da parte di liberi professionisti. Fanno eccezione gli immobili esenti dall’IMU, che sconteranno le imposte. Per gli immobili locati, come recita la circolare 3/DF/2012, anche se in comodato gratuito o ad uso promiscuo, si pagherà sia l’IRPEF e le sue addizionali sia l’IMU. Per le abitazioni adibite a prima casa locate parzialmente, si pagherà soltanto l’IMU se la rendita catastale rivalutata del 5% è maggiore del canone annuo di locazione, al netto della riduzione spettante, altrimenti sono dovute anche IRPEF e addizionali. Sponsorizzazioni gratuite a cura di EstroLab Réclame 12 l’EstroVerso Gennaio - Marzo 2013 Notizie Letterarie Saggistica di Luigi Carotenuto Poesia senza gergo “Il saggio, come la poesia, è un genere capace di riflettere la superficie della realtà soltanto a partire da quel frammento deformante che è l'individuo, con il suo irripetibile retroterra e le sue idiosincrasie”. Così, cercando di contenere, e insieme espandere le sue riflessioni partendo dal continente singolare dell'individuo, Matteo Marchesini offre, in questo saggio edito da Gaffi, alcune chiavi di interpretazione del panorama vastissimo, dissestato, a tratti prezioso, della poesia contemporanea. Il critico possiede la verve del polemista e la sua penna sa essere sottile e acuminata nell'elencare i mali del verso odierno: “La Repubblica della poesia rifondata in questi anni, come i gerghi hegeliani dopo Hegel e quelli fenomenologici dopo Husserl, è la città della farsa, che si ripresenta sulle fondamenta della tragica cittadella un tempo chiamata lirica moderna” (pagina 7); questa investitura sempre più kitsch del ruolo e del modo di fare poesia viene messa alla berlina: “contro i risultati del miglior Auden, i cascami del peggior Valéry” (pag.31), gli autori finiscono per essere fagocitati dall'entropia e non riescono a trovare giustificazioni interne ai loro testi, che li rendano attendibili e resistenti, a prova di complessità per così dire. La strada indicata dal critico privilegia quindi i poeti -critici, i poeti-saggisti, coloro che lavorano continuamente con il linguaggio e la dialettica ragionante, poeti loici che hanno scavato sui testi, raggiunto una economia (ecologia) che contempli la controversa disarmonia del mondo, lasci spiragli per accennare alla complessità del sistema-mondo. Tra i poeti esemplari contemplati da Marchesini troviamo Umberto Fiori, che “si porta dietro un bagaglio leggero, sostenuto da una sintassi robusta e sorvegliata”, la cui poesia ha la “capacità di lustrare fino alla vertigine un linguaggio anonimo, mediocre, e così di straniarlo, lasciando balenare nella superficie cristallina l'abisso della sua grottesca o minacciosa insensatezza, il brivido che può offrire l'intuizione improvvisa del suo confortevole inferno, della sua mancanza di fondamenta. Fiori sa trovare esempi calzanti per descrivere i modi in cui gli individui soggetti a questa lingua sperimentano la vergogna del per-sè, instabile e carente d'essere, davanti al muto, ottuso, impenetrabile in-sè delle cose” (pag.32-33). Altro poeta è Andrea Temporelli, che “vuole ospitare nei suoi versi la maggior fetta di realtà possibile, in un equilibrato compromesso tra la via intensiva e quella estensiva. Con molti equivoci, ma anche con molta onestà, crede davvero nelle temperature alte della poesia” (pag.35). A lui si aggiungono Zuccato, che “sfrutta voracemente l'immaginario suggerito da un'epoca in cui la storia fisica e quella sociale si vanno mescolando dentro un unico fiume gonfio di scorie” (pag.38), Maccari, Paolo Febbraro (poeti definiti “pudici”), infine Elio Pecora, Giorgio Manacorda, Alessandro Fo, Anna Maria Carpi, Patrizia Cavalli. Il linguaggio „Centrifuga“ Dialogo-intervista con Michael Schels fondatore e presidente del consiglio direttivo di „Zentrifuge“ (Centrifuga) di Norimberga di Alessandra Brisotto A.B. Come definisce il termine „cultura“? M.S. La cultura consiste nel dar forma al compimento e alla nostalgia. A.B. Quale oggetto potrebbe a Suo avviso indentificarsi con essa e simbolizzarla? M.S. Un pozzo: offre sinteticamente ciò che ci anima. Anche se si tratta di un'opera umana si confà alla natura come se fosse cresciuto in lei. È creato per la vita. A.B. Il rapporto che intercorre tra cultura, creatività ed economia potrebbe essere comparato al rapporto uomo-donna? Si tratta di integrazione, collaborazione o concorrenza? M.S. Laddove il tecnico e razionale venga recepito come maschile e il sensibile e creativo come femminile, sì. Poiché tuttavia i contrasti e le differenze oltre i loro confini danno vita anche alla condivisione, essi compiono la propria funzione nella tensione che subiscono nella loro differenza. Da questa tensione e consapevolezza ha origine la percezione. Non dovremmo competere per combattere ma per giocare. Se la concorrenza viene vista come una parte del gioco collaborativo allora ha un senso ed è un diletto. A.B. La lotta per l'esistenza si svolge nel regno animale, vegetale ed umano. Quali differenze e quali similitudini esistono tra loro? Potremmo forse trarre un insegnamento dal sistema naturale dal quale ci stiamo sempre più allontanando? M.S. Ogni forma di vita tende allo sviluppo e al compimento di sé. Tanto più essa è compenetrata dallo spirito tanto più si fa presente in lei la libertà. Dalla natura impariamo l'umiltà e prendiamo coscienza della creatività del nostro essere. A.B. Perché esiste Zentrifuge (Centrifuga in italiano) e in quale ambito, in quale regno si pone? M.S. Zentrifuge esiste per creare spazi di pensiero, di sentire, di commercio. Il suo luogo effettivo è l'utopia. È un sensore per le possibilità. In quanto a ciò discende dal futuro. Riceve la propria forza dalla nostalgia del compimento. A.B. Che cosa o chi è Zentrifuge? M.S. Zentrifuge è una struttura di sviluppo che unische persone per un determinato tempo in un progetto comune donando loro il senso di una reale coesione. A.B. Potrebbe svilupparsi una Zentrifuge o una sua filiale in Italia, Francia...in altri paesi? M.S. Di Zentrifuge ce ne sono già a migliaia in tutto il mondo, in diverse forme e stadi di sviluppo. Hanno diversi nomi e compiti. Sono asserzioni di un esteso movimento sociale e creativo rivolto ad un nuovo mondo organizzato in modo totalmente diverso. A.B. Che ruolo hanno individuo, arte, economia, letteratura, musica, cultura... nella Zentrifuge? M.S. Tutto ciò che è creativo trova nella Zentrifuge ed attraverso di lei il massimo riconoscimento e partecipa allo scambio con l'inaspettato. L'alchimia del rinnovamento ottiene inimmaginabili impulsi e processi che ci preparano a ciò che verrà. Zentrifuge ci richiama nuovamente allo stupore. A.B. Che ruolo hanno nei vari „regni“? Nel Suo? M.S. Suonano e danzano, vibrano e scintillano, respirano e toccano, danno un significato alla vita. Ci fanno sentire chi e che cosa siamo. Ci aprono i sensi e ci rendono felici. A.B. Un'ultima domanda. Ci ponga una domanda. M.S. Può sentire il Suo pensiero? La piattaforma creativa Zentrifuge di Norimberga collega e presenta creativi ed artisti, crea basi per sinergie, dà vita a progetti, stimola l'impegno e la motivazione. Attraverso l'Accademia Zentrifuge sviluppa proposte di professionalizzazione di creativi e scambio culturale, economico e amministrativo. Zentrifuge è sorta dall'arte e dalla scena creativa come cultura innovativa dinamica e finalizzata. La collocazione Auf AEG, luogo di trasformazione postindustriale, offre molto spazio allo sviluppo artistico e creativo. Dal 2008 Zentrifuge agisce in questi ambiti come piattaforma culturale-creativa di collegamento e sviluppo Auf AEG a Norimberga (www.zentrifuge-nuernberg.de). 13 l’EstroVerso Gennaio - Marzo 2013 Notizie Letterarie Biblioteca Birichina di Anna Baccelliere Ecco, bene, con le statuine del presepe ho proprio finito di sistemare. Ora è tutto a posto. Ho messo il Natale “in scatola” e posso sedermi al calduccio accanto al camino. Pantofole, tutona felpata, cioccolata calda con panna e cialde croccanti. E un buon libro, naturalmente. Facile a dirsi, ma quale? Ho solo l’imbarazzo della scelta. Ne ho ricevuti così tanti per Natale…Oh! Ciao, ragazzi. Scusatemi. Non m’ero accorta che, tra una fetta di panettone e una di pandoro, nel frattempo s’era già fatta l’ ora del nostro consueto appuntamento. Non preoccupatevi: per voi, in fatto di libri, ho le idee chiare perché voglio consigliarvi un romanzo che ho letto il mese scorso. Il mio consiglio questa volta però è rivolto agli adolescenti che, in verità, ho un po’ trascurato negli ultimi tempi. Il libro che vi suggerisco di leggere è L’importante è adesso, Oscar Mondadori, di Francesco Gungui, autore di Mi piaci così. È Mondadori Illustrazione di Giordana Galli una storia moderna, delicata, a volte tenerissima, a volte dura, nella quale tre persone per caso s’ incontrano a Londra. Giacomo arriva nella capitale perché non ha voglia di iscriversi all’università come fanno tutti e perché teme che quella possa non essere la strada giusta; decide così di partire per inventarsi un’altra vita. Viola, alla quale dell’università non importa proprio niente, a Londra ci va per inseguire un sogno e costruire una vita con il suo ragazzo, Dj X, incontrato un mese prima ad Ibiza. E poi c’è Lucas che ha nove anni ed un padre incapace di occuparsi di lui; vive in un istituto a Londra, che non gli piace moltissimo, ma è l’unico posto che abbia mai visto in vita sua. I loro destini si incrociano proprio nella bella città e l’amore, inaspettato, improvviso, entra nelle loro vite. Quello che cercano è molto più vicino di quanto sembri. E “l’adesso” diventa per loro tre la cosa più importante. Vedrete: il libro vi piacerà perché è adattissimo ai vostri “gusti letterari”. Bene, ora vi lascio alle vostre letture, io invece mi dedico alla mia scelta. A presto, ragazzi. Buone letture. Favole racconti e dintorni “Un genere da leggere per tenere sempre viva la fantasia” di Annamaria Platania “Favole racconti e dintorni”, AA. VV. Edizioni Eracle, è nato e si sviluppato all’interno di un gruppo su Facebook, scritto da dieci autori provenienti da ogni parte d’Italia e anche dal Regno Unito, ognuno dei quali con il loro bagaglio di esperienze nel campo editoriale. Il libro presenta una vasta gamma di tematiche adatte all’uso che ciascun genitore o insegnante vorrà farne. Perché la scelta di raccontare favole? Perché le favole sono e saranno un metodo sempre valido per istruire e innestare principi di vita efficaci in tutti gli esseri umani. Gli autori si sono attenuti ad argomenti d’importanza didattica quali: l’educazione, l’autonomia, la democrazia, l’ambiente, l’alimentazione, la mondialità, raccogliendo vari consensi e riconoscimenti tra cui “Libro del Mese di Novembre 2011” sul sito letterario il Romanziere. Alba Cataleta, Gaetano Barreca, Daniela Frascati, Anna Maria Mustica, Annarita Amadio, Lucia Benedetto, Cristiana Edizioni Eracle Pivari, Carolina Pelosi, Irina Turcanu, questi i nomi dei nove autori da Favola con i quali ho condiviso questa interessante esperienza. Leggere le favole fa tornare bambini e insegna ai nostri piccoli quanto è importante tenere sempre viva la fantasia. Tra le pagine di Favole racconti e dintorni incontrerete la dolce gattina Camilla con il suo grande coraggio. Una colorata Danza dei libri ci porterà a scoprire l’importanza della lettura. Una simpatica tartarughina lotterà per salvare la sua isola dalla distruzione per mano dell’uomo. Mentre il Natale con la notte più magica dell’anno si avvicina, conosceremo Giada, la renna di Babbo Natale che ci ricorderà di non perdere mai la speranza. In un tripudio di colori sboccerà La Rosa Arcobaleno, per capire che le diversità ci rendono speciali e non diversi. Tra le placide acque di un fiume incontreremo Hart, l’Ippopotamo dal cuore d’oro, per non farci dimenticare quanto è importante rispettare la natura. Martin e White sono i protagonisti della Storia di una grande amicizia, perché quando trovi una persona speciale con cui condividerla non ci sono ostacoli che la possano impedire. Per festeggiare tutti insieme ci sarà un grande Girotondo nella foresta, con in testa il Re Leone e tutte le varie specie di animali, per non dimenticare che possiamo essere diversi come aspetto ma il cuore è uguale per tutti. Le ore scorreranno via piacevolmente in compagnia di queste e di tante altre bellissime Favole che coloreranno le giornate di grandi e piccini. 14 l’EstroVerso Gennaio - Marzo 2013 Notizie Letterarie La Recensione L’amata. Lettere di e a Elsa Morante di Sandro De Fazi Che rapporto c’è tra l’epistolario di uno scrittore e la sua opera? Lo stesso che esiste tra quest’ultima e la sua vita, vale a dire nessuno. Colui che firma le lettere non è la stessa persona che scrive i libri, in entrambi i casi non è in gioco l’io anagrafico ma la soggettività inconscia immanente, un mascheramento sostanziale dell’io che lo rende finzione, raggiro, nel senso lacaniano che “il vero io non sono io”, e che va analizzato. Era costruita per contraddire quanto veniva proclamato nelle occasioni ufficiali la corrispondenza di Cicerone, con grave disappunto del Mommsen nel suo feroce anticiceronianesimo («dove lo scrittore è ridotto a se stesso, come nell’esilio, nella Cilicia e dopo la battaglia di Farsalo, essa è fiacca e vuota come l’anima di uno scrittore d’appendice»); quella di Petrarca e di Leopardi non è fatta solo per comunicare coi destinatari immediati ma nella teatralizzazione della loro personalità. La maschera attraversa le lettere e l’opera di Nietzsche come un enigma da decifrare, quasi sempre indecifrabile o frainteso; il carteggio tra Thomas Mann e Hermann Hesse è la documentazione di un’amicizia intellettuale durata quasi mezzo secolo; quello di Pavese è scritto per essere tramandato a noi, comprese le lettere a Fernanda Pivano ricopiate ogni volta con la carta carbone; quello di Pasolini – scritto verso la parte finale, negli anni del suo segretariato, da Dario Bellezza – testimonia la diplomatica rete di rapporti coi molti destinatari illustri all’inizio della sua carriera. Nel caso de L’amata. Lettere di e a Elsa Morante, a cura di Daniele Morante e con la collaborazione di Giuliana Zagra (Einaudi 2012) non esiste nessun carteggio vero e proprio, inteso cioè nel senso binario. Si tratta piuttosto di un anti-epistolario intorno alla “Non-amata” analogamente all’«inseparabile prossimità con se stesso ed assoluta differenza dagli altri» che Foucault ha visto nei dialoghi di Rousseau («credere ciò che dice la parola scritta, ma non crederla perché la si è letta»). Elsa è giudice della Morante ma tra i mittenti e la destinataria, tra la mittente e i destinatari insiste un dialogo interrotto dal monologo. Con delle eccezioni, la scrittrice o non risponde o lo fa per troncare i rapporti. È risaputo il suo anticonformismo assoluto, l’imperativo categorico di dire la verità - di pretenderla da sé e dagli altri - anche a rischio della sua famosa inimicizia. Amicus Plato sed magis amica veritas è la sua sincerità antiadattiva specialmente dopo il 1968, in questo la già sublime autrice di Menzogna e sortilegio e de L’isola di Arturo trova un precursore solo nell’ultimo Rousseau, per attenerci al moderno, in particolare in quello delle Passeggiate. Come se parlasse Amleto, non siamo qui davanti alla drammatizzazione cartesiana, l’autenticità di Montaigne portata a compimento da Rousseau prevale in modo irriducibile nel segno di una unicità irripetibile dalla forte valenza politica. Quanto Rousseau è implicato nella teorizzazione dell’individuo astratto isolato, tanto alla Morante non interessa che la solitudine, ricerca dell’altrove per arrivare al linguaggio dell’altro («por el analfabeto a quien escribo»). Ce n’è la riprova soprattutto nelle espressioni di solidarietà complice di lettori vari, relativamente all’uscita di La Storia e di Aracoeli che ne è il capovolgimento e l’abiura. «Ha qualcosa in contrario se, nel caso la traduzione riuscisse artisticamente soddisfacente, il poema sia pubblicato in una rivista di qui?» le chiede in tedesco da Budapest György Lukács a proposito de Il mondo salvato dai ragazzini. Dice a Bellezza nella minuta manoscritta, forse del 1969: «il fatto che tu, a differenza di quelli che mi sono amici, abbia scelto di me proprio questa immagine, dimostra che, se è vero che tu non mi sei simpatico, anch’io non ti sono simpatica. Anzi, credo (posso anche sbagliarmi) che in fondo la tua non simpatia per me abbia preceduto la mia, e magari l’abbia prodotta» (p. 538). E Dario ha ricevuto questo testo e lo ha trascritto pressoché letteralmente in Angelo (Garzanti 1979), il suo capolavoro in prosa, tutto ruotante intorno a lei, omettendo genialmente l’inciso «posso anche sbagliarmi». Ha l’«allergia per la corrispondenza», confessa a Eduardo De Filippo. Eppure è allegra e premurosa con Wilcock, innamorata di Luchino Visconti, talora chiamato Luca, affettuosa con Leonor Fini, Carmelo Bene e Ninetto Davoli. Rifulgono le due lettere di Anna Maria Ortese, datate a Rapallo rispettivamente il 16-5-75 e il 17-4-83. Esilarante il carteggio con Tonino Ricchezza. Densa di forza profetica è la postfazione del nipote Daniele. Certo, come rilevò a suo tempo Cesare Garboli, sia Rousseau sia Elsa Morante hanno pagato un prezzo altissimo, ponendosi come grandi maestri. Molte lettere de L’amata non hanno avuto dunque risposta pur essendo assunte come carteggio sia pure unilaterale o in primo luogo, pregiudizialmente, espunte da questa raccolta composta da stratificazioni significative molteplici. Si è parlato di criterio sentimentale di selezione e davvero non si capisce il motivo per non avvalorare «senza eccezioni tutta quella corrispondenza che non avesse significanza in sé, ma solo in quanto testimonianza di presenza, in quanto attestante che “io c’ero” o “c’ero anch’io”» (p. XIX). Una scelta cursoria da una parte si imponeva, ma esorbita alquanto anche quando i curatori ricorrono direttamente ai mittenti/destinatari che avessero conservato documentazione utile al repertorio delle fonti epistolografiche, che filologicamente è il problema fondamentale di questo libro. Non ne sapremo forse mai di più, perché il criterio è anche quantitativo e contraddittorio al punto che sono riportate nel quarto capitolo lettere di lettori ignoti, e per l’esclusione di tutta la corrispondenza degli amici come di chiunque altro avesse avuto «una comunicazione altra che epistolare (o, quand’anche epistolare, non “storicamente” significativa» (ibidem). Impossibile fermarsi a una sola prima lettura, nel suo carattere d’eccezione questo libro in cui la scrittrice è percepita in absentia, dà resoconto della molteplicità di voci e situazioni in termini di ricerca veritativa ribaltabile in amica veritas sed magis amica Elsa. leggodico Ombra di vita di Bruno Brunini (La Vita Felice) “In un’apparente linearità di percorso, riservano improvvisi cortocircuiti da cui affiorano illuminazioni e straniamenti che riflettono l’inafferrabilità dell’esistenza”. Così Giorgio Celli definisce i versi di Bruno Brunini attraversati dal dolore per la perdita di una persona amata, dal desiderio acceso di riconciliazione con se stesso e col mondo. “Inutilmente cerco / ciò che non può più essere raggiunto”, “La cenere è ancora tiepida / il calice, vuotato in mare, / morbida discesa verso il riposo. / Nella luce irreale del distacco / scorri via / sei onda, fuoco, / sei sabbia e tempo, / ti vedo partire / nel fondo del mare / dove non finirai mai di sparire”. Disillusione, smarrimento, angoscia, senso d’impotenza, lacerazione interiore, memorie di un vissuto incolmabile, impregnano ogni singolo componimento. La poesia è radiazione luminosa, “la poesia che rinfresca la fronte / che non ti lascia svanire nel niente. // A te devo il futuro. Respiro / per diventare la tua nicchia”. Le Ballate (Ballata seriale) di Domenico Donaddio (Marco Saya Edizioni) “Questo libro è consigliato nel trattamento delle seguenti patologie: inconsapevolezza sociale semplice e aggravata, dipendenza dal porno via internet, produzione di poesia impressionista/paesaggistica, schizofrenia, insonnia, cimurro, deficit dell’ormone della crescita, pertosse e sindrome di Asperger”. Già dalle avvertenze di lettura nella spassosa “Comunicazione iniziale” risalta il carattere avventuroso, provocatorio e ludico della scrittura di Domenico Donaddio. Il vicequestore Palizzi è il protagonista di questo bizzarro “romanzo” in versi, quasi una parodia grottesca de “La ragazza Carla” di Elio Pagliarani. Palizzi è “convinto che viviamo in un’epoca di spiccata manipolazione fisica e mentale”, ricerca “sponde sicure per i propri ragionamenti”, è “raro che partecipi a concorsi di poesia”. Forse perché “…la poesia / è un’azione criminale conforme / a nessuna regola nemmeno alla propria”. Inversi panici di Maurizio Alberto Molinari (La Vita Felice) “Aria in proiezione / deposita / ombre. // Mattoni e calce / dispongono / sfumature. // Il sale / si offre al vento. // Segni / di calendario // transiti / di senso”. Testi di Maurizio Alberto Molinari ispirati in libertà dalle immagini, in bianco e nero, realizzate dallo stesso autore (elaborate - si legge nell’accurata prefazione di Cristina Balzaretti -, in poesia visiva con parole e frasi sovrapposte, scritte in inglese o francese e a seguire, il testo poetico a fronte, in italiano e inglese traduzione, quest’ultima, di Lucia Gazzino). Parole come evidenziato dal sottotitolo (foglie del terzo millennio), in stretto legame con la natura (“olivi secolari, cielo intervallato da nuvole, il mare, il fuoco, montagne capovolte …soggetti che raccontano la realtà e la verità del tempo, della storia, del mondo”) . “Secchi / di cielo / traducono sentenze. // Ansa cromatica / riverbero perfetto. // Luce / su foglie stanche / - ultima nota - // imminente / Primavera. // Silenzio // nel riposo / del vento”. Comici randagi di Orazio Caruso (Sampognaro&Pupi) Comici randagi, dopo Sezione aurea (Manni), è il nuovo libro di Orazio Caruso che parla di teatro: “Eugenio si lasciò sfuggire un’ultima occhiata in platea prima di ritirarsi. E gli parve di vedere che ci fossero solo donne”. Il testo - si legge nella quarta di copertina -, è diviso in quattro parti, che rispecchiano quattro momenti dell’anno e le quattro stagioni. La narrazione non segue le azioni dei personaggi in modo continuo durante l’anno, ma si limita a descrivere solo alcuni momenti salienti, saltando in modo ellittico da un momento all’altro, lasciando intuire al lettore quello che è successo nel frattempo. Ed è qui che s’intrecciano le storie dei nostri protagonisti. La narrazione passa e ripassa sopra alcuni grumi, aggiungendo ogni volta dei fili nuovi che modificano l’insieme. È così, come in un puzzle, i pezzi a poco a poco vengono messi nel loro giusto posto ed emerge la visione d’insieme. Alcune scene, non vengo narrate, ma scritte alla maniera teatrale. Notizie Letterarie 15 l’EstroVerso Gennaio - Marzo 2013 Scrivere per fare opera di “resistenza” Parola d’Autore di Francesco Palmieri Ho letto spesso in diversi autori, in libri diversi (ed io stesso l'ho pensato di frequente) che la 'scrittura' salva la vita, almeno quella di coloro per i quali la 'scrittura' si fa genio domestico, folletto amico, o demone inquieto e inquietante, invasione, possessione non esorcizzabile. Ed è così; non so se anche per chi lo scrive ancora nel presente, non so se con la stessa intensità di vissuto -e persino ossessività- di chi lo ha scritto in passato, ma per me è così da molto tempo e per tutti i giorni che io posso ancora ricordare. 'Scrittura' non solo come via di fuga, strategia di sopravvivenza, vocazione coattiva, esperienza individuale ora lirica ora filosofica ora narrativa, ma anche come forma di “resistenza”, pratica clandestina di un Io che nella opposività privata cerca di rimanere fuori dal coro di uno scrivere che, quando non è evasione, superfluità, si fa cicaleccio sterile, chiacchiera o gossip, mondanità da rotocalchi in bella mostra nelle edicole e persino nelle librerie. Scrivere oggi, nel modo in cui lo sto intendendo, è anche fare opera di “resistenza” (in senso intenzionalmente politico), essere un po' come gli amanuensi medioevali che hanno preservato valori e cultura dall'irruzione iconoclasta della barbarie; scrittura, quindi, anche come impegno civile e sopravvivenza estrema e stremata dell' umano. Mi è stato suggerito il motto “Nulla dies sine linea” (Plinio il Vecchio) e mi ci riconosco interamente: neanche un giorno senza una linea, non un giorno senza almeno una parola, un segno, un nero a tracciare lettere, sillabe, sintagmi a cui affidare almeno due intenzioni forti: incidere il divenire che cancella cinicamente l'esperienza soggettiva e irripetibile dell'esserci, tentare di lasciare traccia di un Sé vivo -ora e qui- nella Storia nullificante, e farsi sincronicamente 'segno' Scrivere senza aspettare l’ispirazione di Giuseppe Scaraffia Ho cominciato a leggere da piccolo perché ero ansioso di impadronirmi del segreto racchiuso nei libri. Per questo li ho letti febbrilmente per anni, per questo a sedici anni avevo divorato tutto Proust trascurando gli studi al punto da avere ben quattro esami di riparazione. Intanto avevo cominciato a vivere e a esaminare la vita secondo Byron, Baudelaire o Proust. Inutile dire quanto quelle splendide chiavi continuassero ad aprire porte sbagliate. Poi a lungo la mia guida è stata, proprio per la sua sofferta astrazione dalla realtà, ottima per entrarvi o almeno tentarlo. Non mi ricordo quando ho imparato a scrivere ma ho l’impressione di avere sempre sentito che quella sarebbe stata la mia strada. Mi piaceva fare qualcosa che, credevo allora, avrei potuto coltivare anche da solo, in silenzio, lasciando ai posteri il compito di scoprirmi. Quanto al mio ultimo libris, I piaceri dei grandi, Sellerio, è nato da uno dei temi portanti della mia ricerca, l’idea di felicità. Chi lo leggerà infatti scoprirà la saggezza di quei pazzi geniali. Quasi tutti sapevano che la felicità è percepibile solo quando è sfumata e quindi, a rigore, non esiste se non, più modestamente nel paziente collage di tante piccole felicità. Dal calice di champagne di Virginia Woolf alla motocicletta di Lawrence d'Arabia, dalla collezione di farfalle di Nabokov alle passeggiate di Thomas Mann. Come Stendhal penso che non bisogna aspettare l’ispirazione, ma scrivere ogni giorno, non importa quanto e come. Personalmente mi distraggo di perché vivo nella letteratura con delle regolari, indispensAbili uscite nella realtà. tangibile, specchio grafico, grammaticale, di un Io che è coscienza, consapevolezza, ricerca della svolta di pensiero e sentimento che possa restituire un 'senso' al vivere, un rispecchiamento identitario, una giustificazione esistenziale nel linguaggio degli uomini e non solo negli algoritmi neutri e necessari della chimica, della fisica, della biologia. Perché, sì, noi accadiamo come biologia ma restiamo, e presumibilmente rimarremo per sempre, biologia che pensa e sente. Soprattutto sente. Ed è dalla dimensione del sentire, del provare -intensamente, profondamente- che provengono gli Studi Lirici (solo parole d'amore), ossia da quella tonalità del percepire endopsichicamente che noi chiamiamo ancora amore, eros, sentimento, passione. Un'esperienza, il libro, di scrittura e vita in tempo sincrono, una sorta di istant movie dove l'io lirico è quella voce fuori campo che racconta quanto la macchina da presa (il fenomeno nudo) non può rendere, mostrare, far vedere: le immagini interiori, il pensiero, il guizzo emozionale, il sentimento di estasi erotica o l' annichilimento, la disintegrazione, la perdita di sé. Studi Lirici è una silloge privata, intimistica certo (e la poesia resta ancora il rito privato per eccellenza e non ancora sostituibile), ma vuole anche essere l'eco di un dire collettivo, una voce che avendo la sua genesi in un sentimento universale - possa farsi voce pubblica, sentire condiviso, parola comune e non solo mia, perché amore fa spesso rima con dolore, e il dolore ha un bisogno vitale di elegia, preghiera, di parole che sappiano in qualche modo lenire. E se proprio non potranno essere parole 'di tutti', spero che lo siano almeno per qualcuno. Mi basta. Mi basterà. Scrivere per ricongiungerci al cuore delle cose di Valeria Spallino Come potrebbe spiegarsi una cosa tanto grande. L’amore per la scrittura nasce inconsapevolmente, per inclinazione ma non casualità, e, come accade in ogni innamoramento, l’innamorato si riconosce conquistato solo quando è ormai legato indissolubilmente all’oggetto dell’amore, non può più farne a meno pena una mancanza, una amputazione, un restringimento del proprio sé. Scrivere è una forma d’amore che ci ricongiunge al creato donandoci pienezza, allargando confini, superando barriere. Cosa ci si aspetta dalla scrittura, per qual motivo la si pratica? E, nello specifico, perché la scrittura poetica? Mi si chiede ma è una sintesi impossibile. Ed inoltre, con un sorriso, metterei le mani avanti: Non io poeta (Prova d’Autore, 2011) direi, e dovrei parlare piuttosto di silenzi. In realtà non ci si aspetta nulla, si è persino restii a darle nome; tuttavia esercitandola si apprezzano i suoi doni, si scoprono mondi, si traducono messaggi, si afferrano chiarimenti. Ma perché la vita non basta! confessiamocelo, ben lo sapeva Pessoa. E di sempre nuovi doni abbiamo bisogno. Doni che ignoriamo si rivelano indagandoli, sempre cangianti in continuo svelamento quali sono, sempre necessitando differente consapevolezza e non ultimo più importante l’altro fuori noi, l’interpretazione del lettore nell’interazione e reciproco riconoscimento. Doni che aggiungono vita alla vita, doni che si delineano per lampi fuggenti fortunosamente carpiti o si conquistano lentamente e a fatica per una indispensabile paziente, disperata sollecitudine (Ungaretti); in ultimo si traducono prodigiosamente nello spazio del linguaggio quali alchimie, esercizi di magia, incanti. Tra le forme della scrittura io credo la poesia sia la più libera, offra ed eserciti la più grande libertà; se pur costretta in endecasillabi o altra metrica, l’essenzialità d’un haiku o la forzatura di una rima baciata, la poesia è la forma del linguaggio che più d’ogni altra, di passo con la musica, permette interpretazioni e continui intendimenti, comprende e armonizza in unità contraddizioni ed apparenze, allarga immaginazione istruendoci sull’infinita polifonia del vero, sulla nostra variegata moltitudine in margini di silenzio già immagine e parola. Parola che non basta, i vocabolari sono sempre insufficienti a definire amore-libertà. È compito dei poeti re-inventare la parola, scardinare i limiti e le catene che imprigionano il linguaggio, giocare con sillabe e fonemi, giocare, come bambini, con la significanza delle cose, l’ambiguità della voce, ambiguità che mai disorienta la visione poetica, al contrario la esalta ed alimenta – dall’uno all’universale in una rifrazione infinita di specchi. Rendere alleata la parola, tramite al sentire, strada e ponte verso l’assoluto, l’altro e il centro esatto di noi stessi. Denunciare e costruire speranza. Scrivere è il tentativo, seppur talvolta maldestro, di ricongiungerci al cuore delle cose, di non sfuggire alla nostra stessa solitudine, che in ultima analisi è la nostra miglior fonte di libertà, nasconde il nostro migliore essere capace di sentimento: noi stessi nel mondo, col mondo. Nell’incontro con la parola la più legata all’assenza e al silenzio, il vuoto diviene l’enormemente pieno, l’angoscia diviene speranza, la solitudine incontro, amore condiviso. Una irrinunciabile magia. Rimirando 16 l’EstroVerso Gennaio - Marzo 2013 Qual è il ruolo odierno della poesia? di Gabriella Bertizzolo Spesso mi sono chiesta qual è il ruolo della poesia oggi. E ogni volta non ho saputo darmi una risposta. Bisognerebbe prima intenderci su che cosa si intende (casuale il bisticcio di parole?) per poesia e qui si aprirebbe un'immensa voragine. Penso comunque che anche al tempo di internet, il valore della poesia è quello che essa ha sempre avuto. Il poeta dirà le cose che ha sempre detto in un modo diverso. Parlerà della bellezza, del dolore (Alda Merini, la "poetessa dei Navigli", soprattutto in virtù della terribile esperienza vissuta in manicomio, è la poetessa più letta anche dai giovani) e della morte. Grazie alla forza evocativa che possiede, entra nella sfera dei sentimenti e delle emozioni del lettore, mantenendo tuttavia un necessario distacco. Tutt'altro che avulso dalla realtà e dalla società, il poeta testimone del suo tempo, è investito di una grossa responsabilità nel trasmettere conoscenza. Al contrario spesso oggi si scrive poesia con leggerezza, come si scrive un sms, mentre la vera poesia esige un profondo esame di coscienza, un rinnegamento di sé, e - non ultimo - un doloroso scontro con la struttura linguistica (si leggano Raboni, Bandini, Ruffato). Come ben dice Gianmario Lucini, bisogna ridare alla poesia, "svuotata del suo ruolo, scissa ed esiliata in un mondo alieno", il suo ruolo sociale, ruolo che ha detenuto fin dall'antichità, quando costituiva il tramite col sacro. Eppure la poesia sa stare anche in silenzio, soprattutto in momenti in cui il rumore dei media furoreggia. A questo proposito è esemplare la lezione di Loi, poeta che ho avuto il privilegio di incontrare anni fa nel vicentino, il quale asserì, tra l'altro, di non ricordare i suoi testi perché "una volta pubblicati, non appartengono più al poeta". In questo, - si licet parva componere magnis - mi sento in sintonia: delle tante poesie che ho scritto ne ho memorizzata solo una formata da un unico distico. Un autore che mi ha profondamente ispirato è David Maria Turoldo, "la coscienza inquieta della Chiesa” (personalità poliedrica che con la collaborazione di Pasolini realizzò anche un film, Gli Ultimi, tratto dal suo stesso racconto Io non ero fanciullo): ne ho letto l'opera omnia che mi ha letteralmente incantata. Molti altri sono i poeti che amo, dall'«ermetico» Eraclito al prolifico Erri De Luca. Per concludere questa riflessione, ricordo che Maria Luisa Spaziani definisce Montale il "capo cordata" dei poeti di tutto il Novecento e oltre: come darle torto? Francesco Foti, Jettu uci senza vuci di Grazia Calanna Se Cartesio asseriva “Cogito ergo sum”, similmente Francesco Foti (nella foto di Vladimir Di Prima), autore della suggestiva raccolta di versi in vernacolo siciliano, “Jettu uci senza vuci”, edizioni Prova d’Autore, impreziosita da undici raffinatissimi acquarelli di Alfredo Musumeci, confessa che è vivo, esiste, se: vede, sente, canta, suona e scrive (“vidu / sentu / cantu / sonu / scrivu / sugnu / vivu”). Coerentemente con la prima, Afotismi, contraddistinta, dal prospero connubio tra osservazione ilare e osservazione malinconica della realtà, è un’opera gustosa, affabilmente ironica, che richiama la riflessione di Leonardo Ortolani, “se vuoi salvarti leggi. E se tu volessi, addirittura, salvare qualcuno, scrivi”. Un’opera dettata oltreché dalla passione perenne per la scrittura (’u vulemu capiri o no / ca n’e pozzu ammazzari ‘sti paroli? - lo vogliamo capire o no / che non posso uccidere queste parole?), per la lettura (pruvulazzu / supra ’i mo’ libbra / nun n’appigghia - polvere / sopra i miei libri / non se ne forma), dal disincanto (m’attrovu / sulu / ’na pinna / ’n foggh’i carta jancu / e ’na chitarra - mi ritrovo / solo / una penna / un foglio di carta bianco / e una chitarra), dalla meraviglia dei ricordi che risorgono nostalgici dal passato (vidu fotu antichi / d’a mô cità / ca ’na vota fu paisi / […] / ma nenti / nun pari mai / ’a stiss’e ’na vota - guardo foto antiche / della mia città / ai tempi paese / […] / ma nulla da fare / non sembra mai / la stessa come un tempo). Risalta- no l’attaccamento palpabile alla propria terra, lo stupore cheto dell’amore (’i to’ occhi e ’a to’ vuci // è ccu ‘sti sbrizzi ’i puisia / ca inchi d’amuri / ’stu cori - i tuoi occhi e la tua voce // è con queste gocce di poesia / che inondi d’amore / questo cuore), l’impetuosità, quasi a voler dare uno scossone al torpore esistenziale, ai mali del nostro tempo quali, per citarne alcuni, gioco d’azzardo (cchi m’a spacchìu a ffari / si pp’ammunsiddari / cincucentu euru / ô poker online / ddoppu tri anni ’i jocu / ottu uri ô jornu / mi scuppulau ’n computer sanu / ca custava cchiù assai? - che senso ha vantarmi / se per racimolare / cinquecento euro / al poker online / dopo averci giocato per tre anni / otto ore al giorno / s’è bruciato un computer / che costava di più?), malasanità, omologazione (facemu tutti ’a stissa fila / ppi ffari tutti ’a stissa fini - facciamo tutti la stessa fila / per fare tutti la stessa fine). E, ancora, sintomatico del tentativo di appiattimento intellettuale operato dall’alto, Foti, beffardamente, “denuncia” l’infame proliferare di libri che del libro conservano (a stento) la forma. Non ultimo, tra le braccia del tempo, ora propizio ora avverso, in un’epoca di altisonante vuoto emerge il valore inqualificabile del silenzio, equiparabile, talora, alla (perduta) comprensione (si ni vaddamu / senza parrari / ni sapemu sentiri / macari / megghiu - se ci guardiamo / senza parlare / ci capiamo / anche / meglio). Slam Poetry Venerdì 1 marzo al teatro Coppola di Catania Organizzato da Sebastiano Adernò e Salvino Maltese, venerdì 1 marzo 2013, al Teatro Coppola di Catania, si terrà uno “Slam Poetry”, ovvero, spiegano gli organizzatori, “una competizione che “forza” la Poesia ad essere qualcosa che solitamente, nella tradizione letteraria, viene dimenticato: cioè “messaggio” capace di scuotere ed essere Folon recepito nell'istante in cui viene declamato. Occorre quindi fare leva su parametri differenti. La validità del testo letterario non è l'unica discriminante. Non è un concorso di poesia a voce. È una competizione che valuta la capacità di comunicare il proprio operato poetico, la capacità di farlo “passare” ad un pubblico eterogeneo, che non conosce né il poeta, né i suoi testi”. Poeti invitati a partecipare: Daita Martinez, Grazia Calanna, Giovanni Parentignoti, Luigi Taibbi, Luigi Carotenuto, Salvatore Randazzo, Paolo Gulfi, Dario Matteo Gargano, Raffaele Gueli, Domenico Stagno, Simona Cannata Di Gabriele, Santina Lazzara. Di seguito una sintesi delle regole basilari del Poetry Slam, stabilita a Chicago durante il meeeting Slammasters del 1998. Le poesie possono essere su qualsiasi soggetto e in qualsiasi stile. Ogni poeta deve presentare propri testi originali. Ogni testo dovrà avere una durata non superiore ai 3 minuti. Il tempo sarà calcolato dal momento in cui inizierà la vera e propria lettura. Non è permesso utilizzare alcuno strumento musicale o traccia musicale preregistrata. Nessun costume o oggetti di scena. La regola è: nessun costume. Una poesia può essere usata una volta sola durante la fase preliminare o finale. Le performance saranno cronometrate. Se la performance supererà i 3 minuti saranno conteggiate delle penalità calcolate secondo quanto indicato dal regolamento. I cinque giudici saranno estratti a sorte tra il pubblico presente all’evento. L'estrazione verrà ripetuta per almeno tre volte: alla battuta dei Sedicesimi, Quarti e alla Finale. Il maestro di cerimonia condurrà lo show velocemente e imparzialmente. Una nota finale: “I poeti devono lasciare il loro ego alla porta”. Rimirando 17 l’EstroVerso Cristina Annino “La poesia non ti obbliga a metterla al mondo ” Intervista a cura Luigi Carotenuto Cristina Annino, poeta, pittrice, autrice di racconti e saggi letterari, nasce ad Arezzo e attualmente risiede a Roma. Il suo primo libro, Non me lo dire, non posso crederci, è edito nel 1968 dalla casa editrice Tèchne di Firenze, città nella quale si laurea in Lettere Moderne, con una tesi sul poeta peruviano César Vallejo. Nel 1977 esce Ritratto di un amico paziente, Roma, Gabrieli. Nel 1979 Boiter, con Forum, Forlì (romanzo). Nel 1980 Il Cane dei miracoli, Foggia, Bastogi. Nel 1984 L'udito cronico, in Nuovi Poeti Italiani n°3, a cura di Walter Siti, Torino, Einaudi. Del 1987 è Madrid, Corpo 10, Milano, libro al quale Giovanni Giudici assegnò il premio Russo Pozzale nel 1989. Quest'ultimo è un testo particolarmente significativo per l'autrice, che, sul suo sito, scrive: “questo libro ha il suo motore emotivo in quel sentimento iberico che già da prima costituiva una sorta di coscienza, memoria, attrazione geografico-spaziale. Negli anni anteriori all’87 ho avuto infatti rapporti culturali con varie città spagnole, soprattutto con Salamanca (Cattedra Poetica) e con Siviglia e Madrid. A quell’epoca Leopoldo María Panero mi tradusse una raccolta di poesie intitolata La Casa del loco su richiesta dell’editore madrileno Antonio Huerga, Edicione Libertarias. Alla fine degli anni ottanta abbandonai l’ambiente letterario per dedicarmi al secondo matrimonio. Dopo la vedovanza - 2000 - ripresi la mia attività, pubblicando Gemello Carnivoro, Faenza, 2002, con i Quaderni del circolo degli artisti. A seguito, Macrolotto, Canopo, Prato, in collaborazione con il pittore Ronaldo Fiesoli. All’inizio del 2008 Casa d’ Aquila, edito da Levante Editore, Bari. Proprio in quegli anni iniziai a dipingere ed ho all’attivo svariate mostre collettive e alcune personali”. Inoltre, ha pubblicato Magnificat (poesie 1969-2009), Puntoacapo editore, 2009; Chanson turca, Lietocolle, 2012. A breve uscirà il nuovo libro che include poesie e dipinti (www.anninocristina.it). “La «chanson turca» è una canzone fuori dal coro, una parola barbara”, così scrive Walter Siti (Nuovi Argomenti n.60, Ottobre-Dicembre 2012) sul tuo nuovo libro edito per Lietocolle. Cosa ti ha indotto alla scelta di questo titolo e quanto conta per te la musica, citata in molti testi poetici, anche passati? Una volta terminato il libro, per prima cosa ho pensato all’aggettivo dell’eventuale titolo. Hai presente la definizione “cose da turchi”? Ecco, questo attributo mi è sembrato giusto; quanto al sostantivo Chanson l’ho visto come un modo di presentare le varie situazioni poetiche, alleggerito però dall’ironia di un uso diciamo improprio del sostantivo. Per quanto riguarda la musica ritengo che questa sia inscindibile dal pensiero stesso, dalle parole. Ogni tipo di poesia ha la sua orchestrazione musicale, e credo che anche qui il timbro sia quello mio di sempre. Magari, là dove gli argomenti sono diversi rispetto a quelli dei libri precedenti (mi riferisco ai due poemetti), questi hanno semplicemente “ubbidito” ai suoni dei fatti e dei soggetti narranti. Giacché sono gli avvenimenti, ad avere una loro musica. Anche fuori dal terreno creativo, ciascuno di noi fa musica sempre, magari senza accorgersene, ed è tale linguaggio che lega la logica delle vicende, dentro una casa, in una città e nel mondo. Scrivere è rispettare il ritmo già esistente in tutto ciò di cui si parla. Musica e parola stanno tra loro come il significato sta al significante di un vocabolo. Io la vedo così. Nietzsche apre, in esergo, le due sezioni di Chanson turca. Credo tu possa condividere con il filosofo la critica di tutti i valori, il ruolo di demistificazione mi pare ben attivo nella tua opera, che ne pensi? Nietzsche demistifica tutto, io no. Da lui si può ricevere qualsiasi tipo di stimolo emotivo, proprio perché il suo pensiero filosofico è un grande fiume dove possiamo immergerci secondo l’umore o la stagione: a mio parere questo è uno dei più grandi fascini che lo avvicinano a ogni generazione di lettori. Per quanto mi riguarda, più che valori, io ho delle certezze personali che non sono mai cambiate nel corso della mia vita adulta. Per dirla seriamente: penso che i così detti valori cambino la loro valuta nel tempo e che inoltre Nietzsche sia un esempio magnifico di come essi possano essere contraddetti o manipolati proprio per il fatto di costituire delle categorie: morali, religiose, filosofiche o quant’altro. Credo insomma che i valori non aderiscano mai o poco alla condizione realmente umana. Cioè quando una qualsiasi misura reale diventa assoluta, perde ovviamente coscienza individuale, si codifica entrando nella sfera appunto filosofica, la quale può metterla in crisi. Ciò che dico mi avvicina in parte, ma mi allontana anche dal pensiero nicciano il quale dà importanza a ciò che demistifica capovolgendo o sostituendo un valore con un altro - che può essere anche il suo esatto contrario -, ma di pari assolutezza drammatica, cioè ne rigenera altri (per lo meno così mi sembra), mentre io tento di togliere credibilità a qualsiasi valore per sostituirlo con la forza individuale di certe mie convinzioni. In Nietzsche, inoltre, non riesco mai a trovare ironia. Se “la vita è un affare che non copre le spese” (Schopenhauer), si può Gennaio - Marzo 2013 dire lo stesso della poesia? Beh, la vita, se escludi il suicidio, devi viverla, in qualche modo; la poesia non ti obbliga a metterla al mondo. A meno che non si creda nell’idea bizzarra della vocazione. È una scelta personale, quindi ha il senso che tu le dai. Io credo che avrei potuto benissimo vivere senza scrivere perché ho un’incrollabile fiducia nella creatività umana. È questa che muove l’universo. Ognuno può esprimere il proprio potenziale creativo in mille modi. Se un individuo invece vede nella scrittura la sua unica realizzazione possibile, ed è coerente con se stesso, rendendosi cioè conto del tipo particolare di scommessa rappresentata dalla poesia, le spese dovranno risultargli obbligatoriamente coperte. “La morte è la condizione inaccettabile dell’esistenza. Sono sempre stato ossessionato dalla morte. Dall’età di quattro anni, da quando ho saputo che dovevo morire, l’angoscia non mi ha più lasciato. E’ come se avessi capito d’un tratto che non c’era niente da fare per sfuggirle e che non c’era più nulla da fare nella vita. Scrivo anche per gridare la mia paura di morire, la mia umiliazione di morire”. Così Eugéne Ionesco affrontava il tema della morte, presente in maniera considerevole nella tua scrittura. Come vivi, da poeta e da essere umano la partita a scacchi con il signor Mortis? Il pensiero della morte (solo quella mia, ovviamente) non mi ha mai disturbato. Direi, ecco, che la morte è un “valore”, proprio perché ha, generalmente, un peso differente, mutevole, durante gli anni della vita. Io l’ho sempre ritenuta una grossa fiche: nell’infanzia la vedevo come un eventuale fatto eroico o avventuroso, nell’adolescenza come una possibile soluzione ad avvenimenti sgradevoli. Ma sempre, considerandola come un oggetto da usare subito oppure mantenersi per gli anni a venire, quasi che lei dipendesse da me, che fosse insomma un cospicuo patrimonio da giocarmi o no. Anche oggi non penso alla morte per vecchiaia, non riesco a darle questo senso funebre. La sento talmente mia, così dentro al mio spirito, che è diventata un modo di esprimermi, di essere. Potrebbe cogliermi di sorpresa, potrebbe farlo subito, certo, ma conservo comunque l’idea che lei è rimasta una parte di me stessa infinitamente inferiore. Allo stesso modo che ritengo sia meno concluso di me un bambino. Infatti cosa rappresenta la morte confrontata con la vitalità di un individuo? In sé e per sé non è espressiva, non ha un pensiero suo, non ha evoluzione. Tutto sommato, il signor Mortis come ricordi tu, è, per me, solo un essere competitivo, non selettivo. Non stimandola, non riesco quindi neppure a temerla. Quale il tuo rapporto con “la valle / mitologica dell'infanzia”? L’infanzia, per ogni individuo, è il più temibile banco di prova. Uno se ne accorge solo dopo. Tutto si stabilisce in quegli anni. Io la ricordo appunto mitologica, come ho scritto. Voglio dire: essa è come una sfocata gigantografia del nostro futuro, per questo può accadere che il bambino si creda infelice nonostante la condizione di grazia in cui vive. Non è facile spiegarlo in alcun modo, ma parlando della mia infanzia, ammetto che all’epoca avvertivo fastidiosamente tutto il peso dell’ombra di ciò che sarei stata da grande, in più senza capire chiaramente niente né potermi staccare da questa doppiezza. Tale stato mi impediva insomma di “vivermi” liberamente come piccola. I “valori”, di cui parlavamo prima, cominciano a profilarsi in quella valle, quando ancora non riusciamo ad avere nessuna convinzione da opporre, perché non abbiamo una capacità di misura. Posso dire che per me l’infanzia è geologia allo stato puro, rappresenta la deriva del nostro continente-persona. Con gli anni poi si trasforma in una sorta di mitologia, ripeto, che il tempo fa sfumare progressivamente. Per questo la definisco come la più impura tra le varie tappe dell’evoluzione di un individuo. Sto forse esagerando, ma per me è stata esagerata e non posso esprimermi in altro modo. “m'annoio come / il secolo, lentamente”, scrivi in un testo di Magnificat. Forse che, paradossalmente, la nostra epoca freneticamente produttiva, materialista, vive di una velocità statica, fagocitante, andando incontro a un'inesorabile quanto lenta fine? Ho in più parti definito la noia come l’“otium dei poveri”, riferendomi al concetto alto che le attribuivano i latini. Non è che io abbia un carattere troppo clemente, però, così come non temo la morte, posso dire che amo la noia. È per me il punto massimo di concentrazione del pensiero; devo arrivare a sentirla profondamente, devo calarci dentro, per ottenere “una forza di spinta verso la superficie dell’acqua e respirare”. Allora vuol dire che sto per produrre qualcosa. Ammetto che le sono sempre vissuta accanto e da sempre con un senso refrigerante di libertà e di riposo (sinonimo di libertà o liberazione). Ciò non mi impedisce di accorgermi del mondo e di avere le mie certezze, appunto, anche su questo, ma la noia resta il grande catino di elaborazione dei miei dati percettivi. Tale stato psichico comporta inevitabilmente una notevole dose di solitudine, però spontanea; genera delle selezioni spinte, questo sì, ma senza compiacenze da “torre d’avorio”. Intendo dire che non mi estraneo da ciò che la realtà offre di buono, né mi sottraggo, ripeto, a ciò che mi fa sentire in opposizione con certi aspetti del mondo. Ossia, dal mio punto di vista, la noia è l’esatto contrario della distrazione, potrei definirla come la rielaborazione di quei dati cui alludevo, e che proprio grazie a lei si formulano. Inoltre - e termino -, oltre a permettermi una concentrazione assoluta, mi pone continuamente di fronte a me stessa, dandomi la misura di quel che sono e la distanza da ciò che mi circonda. Io la chiamerei, ecco, la mia genesi e la mia difesa. 18 l’EstroVerso Gennaio - Marzo 2013 Rimirando Aveni Lucio Piccolo, folgorante preludio di Diego Conticello Dell’esordio di Lucio Piccolo (Palermo, 1901 – Capo d’Orlando, 1969) sulla scena letteraria nazionale restano indimenticabili le bizzarre vicissitudini di come questo libriccino giunse a Eugenio Montale, suo futuro presentatore al meeting di San Pellegrino Terme, il quale ne parlerà poi nella celeberrima prefazione ai più famosi Canti barocchi: Il giorno 8 aprile del 1954 ricevetti un libriccino che portava un nome a me sconosciuto: Lucio Piccolo. Era contenuto in una busta gialla, purtroppo chiusa, affrancata da un bollo da 35 lire. Per ritirarla dovetti pagare 180 lire di tassa. […] Forse volevo appurare se valesse 180 lire. […] Lessi le prime cinque liriche, non facili, non immediate, senza sforzarmi di capire. Difficile è far andare d’accordo il senso letterale e il senso musicale d’una lirica. […] D’altra parte, una lirica non può esser fatta soltanto di musica; essa chiede di rivelare un senso che una semplice armonia di parole inintelligibile non può darle. […] Sarei tentato di attribuire a lui il motivo husserliano di cui egli ci parlava a San Pellegrino: la contraddizione fra un universo mutevole ma concreto, reale, ed un io assoluto eppure irreale perché privo di concretezza; ma non definirei con questo tutta una corrente di poesia metafisica che in varî aspetti dura da sempre? Al di là delle egregie chiavi di lettura disseminate dall’illustre padrino, ci sembra oggi fuorviante, alla luce di rinnovati studi sul poeta palermitano, tacciarlo di estenuato onirismo basandoci solo sulle difficoltà esegetiche imposte da un linguaggio arduo e, a prima vista, astratto. Esempio lampante di questo equivoco, ingenerato dai primi lettori, poi protrattosi, con varie eccezioni, per moltissimo tempo, è certamente Mobile universo di folate. Mobile universo di folate di raggi, d’ore senza colore, di perenni transiti, di sfarzo di nubi: un attimo ed ecco mutate splendon le forme, ondeggian millenni. E l’arco della porta bassa e il gradino liso di troppi inverni, favola sono nell’improvviso raggiare del sole di marzo. Forse Montale pensava proprio a questa lirica nell’attribuire a Piccolo l’aporia husserliana sopra citata. In effetti, lo stacco tra i primi cinque e gli ultimi tre versi mette in luce una contraddizione ‘cosmica’ fra l’imponderabile vastità di un universo in continua trasformazione (pensiamo alle violentissime correnti interplanetarie, alle collisioni meteoritiche, agli influssi delle macchie solari, all’ampia gamma di “raggi e onde”, alle nebulose galattiche dei più sgargianti colori, ma anche alle terribili implosioni delle supernove, ai precari equilibri gravitazionali, fino ad arrivare all’antimateria e, non ultime, alle teorie einsteiniane sulla relatività spazio-temporale) e l’infimo dettaglio, l’irrisoria porzione oggettuale che tuttavia, attraversata da un minimo bagliore di quel flusso eternante, lievita fino ad assurgere a simbolo dell’estrema caducità della condizione umana. L’ansiosa apnea ritmica, che prende forma grazie alle ripetute inarcature, alla complessa sistemazione fonica (soprattutto nei richiami delle assonanze e delle rime interne), contribuisce ad un forsennato senso di vertigine tipico dell’accumulazione barocca (pensiamo al procedimento spagnolo-seicentesco della enumeración caotica). Lo stesso Lucio Piccolo ha voluto chiarirci, in una storica intervista rilasciata a Vanni Ronsisvalle nel 1967, questa propensione ad un particolare simbolismo trasfigurato a partire dalla quotidiana materialità: […] La mia è un’oggettività che può trarre in inganno, perché è un’oggettività dell’oggetto il quale è lungamente maturato nell’interiorità e quindi è caricato… ha una carica – la ‘parola precisa’ è questa – ha una carica di sensi, l’oggetto rimane la sua realtà concreta; ma l’oggetto per forza d’intensità – si può dire anche per forza ritmica – è elevato a simbolo. Un evento, all’apparenza incentrato solo su analogie naturalistiche, diviene fulcro di meditazioni sul pauroso trascorrere del tempo e sul dissolversi dello spazio, che è sensoriale, ma precaria – come in Montale – incarnazione ontologica. Dove spore di sole frangono spume in volo… […] vibran spazi marini; […] Ma dove già si ferma l’ombra… […] sapienza di sorgive sospesa l’aria incanta. […] nei sonni scenderanno reclini su l’ignoto. Qui risuona la perpetua ossessione di trovare un varco che rallenti questo flusso inesorabile, e Piccolo sembra individuarlo nella particolare condizione sospensiva propria dei sogni; essa ha indotto Natale Tedesco a parlare di «dormiveglia mediterraneo». Ma non si tratta, come alcuni hanno erroneamente ipotizzato, di una negazione della storia o della realtà quotidiana, anzi è l’esatto opposto: l’insignificanza di eterne ripetizioni fattuali viene elevata ad emblema della miseria umana, così ogni minimo evento trova posto in un immagine, più ampia, di fatale erosione, che sconvolge tutto sino ad annullarlo. Di soste viviamo; non turbi profondo cercare, ma scorran le vene, da quattro punti di mondo la vita in figure mi viene. Non fare che ancora mi colga l’ebbrezza, ma lascia che l’ora si sciolga in gocce di calma dolcezza… In questa Di soste viviamo, Lucio Piccolo ragiona sulla rimozione della fatica fisica che ostacola il suo desiderio di conoscenza, unica azione umana che possa rallentare l’ineluttabile divenire del tempo. La poesia diventa dunque il solo spazio possibile per il necessario recupero del simbolico («[…] la vita in figure mi viene»): così l’angoscia esistenziale si stempera nel fervore gnomico, e questa sarà una delle poche costanti nella poetica di Piccolo. La tensione simbolica può giungere anche a innervare interi componimenti. Accade così in Veneris Venefica Agrestis dove, sotto un quadro di vita contadina, si allude ripetutamente ad un erotismo elementare, ‘terragno’ che, riproponendo certe pose del D’Annunzio alcionio, funge da contrasto al movimento verticale (purificante) dell’elevazione interiore. Sorge dalla macchia terragna, il volto - ilare, arcigno - stretto nel nero fazzoletto sembra di castagna risecchita, il capello che ne sfugge non è vello gentile ma riccio caprigno; quando va (non sai se ritta o china) il bruno piede contratto è ràdica che d’un tratto sbuca dalla terra e cammina. Bada che non t’offra la tazza di scorza dove l’acqua è saporosa di radici, di foglia vischiosa, o la mora, o la sorba, il frutto silvestre che lusinga le labbra ma lega la lingua. Governa, sembra, la forza delle lune crescenti che gonfia le cortecce e alterna gl’invincibili fermenti i flussi, le linfe… In questa prima parte si intuiscono le malìe in cui viene trascinato il poeta: esse non sono quelle di una Venere, bensì di una strega. La potenza sprigionata dal lessico dona ai versi un crescendo drammatico che sfocia nell’avvertimento: non bisogna cedere ad una sensualità elementare che conduce alla perdizione. Insomma la figura rustica altro non è che un’anti-Beatrice, un’omerica Circe, un amplesso regressivo verso la primitività insita nell’animo umano. L’offerta della megera ricorda l’immagine fiabesca della Biancaneve dei Grimm, ma cela inoltre, seguendo l’analogia tazza-pube, un’offerta sessuale. Come ebbe a notare Montale nella succitata prefazione, il magistero dannunziano viene oltrepassato da Piccolo senza estenuazioni formali, anzi con uno stile compatto e inflessibile: […] Ma come siamo lontani da ogni parnassianesimo e dannunzianesimo; e com’è scarnito, macerato e assottigliato il linguaggio! Mi pare che proprio qui si raggiunga, grazie al rigoglio dei cataloghi e alla pregnanza lessicale e ritmica, un limite già altissimo di “barocchismo naturalistico”. Lucio Piccolo riesce a tenere salde le redini delle metafore senza risultare troppo manierista, preludendo così ad una tecnica che raggiungerà lo zenit armonico solo nei Canti barocchi. 19 l’EstroVerso Rimirando La riva l’Autore Racconta La poesia? Un metodo a-sistematico di conoscenza sinistra di Massimo Morasso Più di duecento anni fa, in una lettera a Friedrich Schlegel Novalis ha enunciato la grande legge imperativa che dovrebbe far tremare i polsi a ciascun essere umano dedito alla buona pratica della scrittura: “nel mondo si dev’essere quel che si è sulla carta: creatori d’idee” - ciò che significava allora, e significa oggi, fare poesia con e per gli uomini a- o anti-ideali che abitano un mondo sempre più (sempre ancora) disertato di senso. Leggo Novalis da circa trent’anni e sono convinto, come lui, che i poeti non esagerino abbastanza nell’uso della loro immaginazione. Ritengo, anzi, che siano soltanto oscuramente presaghi di molte cose essenziali e che si limitino nella stragrande maggioranza dei casi a baloccarsi con la fantasia invece di avventurarsi nella dinamica autorivelativa dell’immaginazione creatrice. Ciò che vuol dire, insomma, che solo i più audaci o i più porosi fra di noi sono in grado di allontanarsi per davvero dalla via larga dell’io, per arrischiarsi nelle regioni meno conosciute del nostro spirito. Lì dove siamo soli con noi stessi eppure stranamente separati da noi stessi, e dov’è più facile, perciò, perderci nel mare magnum dell’indifferenza verso il nostro compito più autentico. C’è poesia e poesia, beninteso, e tutti i modi di fare poesia hanno diritto d’asilo, poiché nel gesto poetico onesto trova espressione sempre un elementare, e salutare, anelito all’umanizzazione, prima e in un certo senso anche al di là di qualsiasi orizzonte d’officina, e di poetica. Anche se su questo occorre intendersi. E occorre vigilare. Per evitare equivoci, lo dico con chiarezza, rifacendomi a una antica, feconda dialettica anceschiana, ogni atto letterario non può che essere “scelta” all’interno di una “situazione”, tecnica al servizio della dimensione iconica del linguaggio... E tuttavia ho motivo di credere che l’altezza di una poesia - e, mutatis mutandis, di ogni creazione artistica - sia determinata per larga parte dall’estensione e dalla qualità dell’esperienza estatica cui essa dà voce. Per me, la poesia degna di questo nome non è soltanto un fenomeno magicomusicale, né un rendiconto in versi di carattere metafisico-morale, più o meno diaristicamente (sentimentalmente) atteggiato. La penso piuttosto, la poesia, come un metodo a-sistematico di conoscenza che insegna ogni volta daccapo come avvicinarsi alla realtà e alla materia che la costituisce dalla parte dell’anima, per così dire. E ogni singola poesia, in questa prospettiva, la leggo in primo luogo come un segno, come il resto riflesso di un banchetto sacrificale che facilita l’incamminamento dello straniero, dell’irriducibile al sé («mi contrappongo a me stesso, mi separo da me stesso» scrive Hölderlin). Credo che all’apice di se stesso, il poeta debba indirizzare tutte le sue migliori facoltà come un intero teso a comprendere il cuore più intimo del mistero. Pochi, ovviamente, sono all’altezza di tale mandato. È ben vero che non tutti quelli che scrivono poesia sono poeti. Massimo Morasso, poeta, saggista, critico e “comunicatore culturale”, come egli stesso si definisce, è nato nel 1964. Laureatosi in Lettere Moderne all’Università di Genova, con una tesi su Rilke traduttore di Michelangelo, ha lavorato come giornalista, consulente editoriale, culturale, organizzatore di eventi e convegni per conto e/o in collaborazione con alcuni dei principali centri culturali della sua città (Centre Galliera, Goethe Institut, Fondazione Mario Novaro, Centro Ricerche Scienze Umane, Festival Internazionale di Poesia), è presente nelle maggiori antologie nazionali di poesia, ha pubblicato, tra gli altri, con Marietti, Raffaelli, Jaca Book. Ha lavorato recentemente alla costituzione della sezione italiana di Plant-for-thePlanet, l’organizzazione internazionale di bambini che si occupa, per conto dell’ONU, di sensibilizzare le generazioni più giovani su una questione di importanza epocale, i mutamenti climatici (www.massimomorasso.it). Gennaio - Marzo 2013 di Andrea Giampietro Eso Peluzzi Di nuovo un uccello a rappresentare la figura del poeta, ma tra tutti il più nobile: il cigno. E infatti l'autore che va ad identificarsi con questa raffinata figura selvatica è uno dei poeti più aristocratici (per qualità e spessore della propria estetica) della storia, Stéphane Mallarmé (1842 - 1898). Al contrario del suo illustre maestro, Charles Baudelaire, che nella poesia "Le Cygne" (inserita nella sezione "Tableaux parisiens" dei suoi "Fleurs du mal") sfrutta l'immagine del volatile come allegoria di una violenta ribellione nei confronti della condizione naturale sofferta dall'uomo o eventualmente dell'ingrato destino imposto da una divinità beffarda, Mallarmé rappresenta con glaciale ermetismo una tragedia ormai in frantumi che sta in piedi solo grazie a una perfetta struttura compositiva. Il cigno si ritrova a riconoscere il proprio splendore, che però lo ha reso perfettamente estraneo alla realtà, così da non poter far niente per concretizzare il proprio slancio ideale verso un irraggiungibile assoluto. Conseguenza fatale del proprio ascetico idealismo è un'annichilente immobilità, una dolorosa impotenza, un’implacabile inadeguatezza della mente mai decisa all'azione. Allo stesso modo l’agave montaliana, che sta impietrita sullo scoglio, e i cui chiusi boccioli non sanno fiorire (come il cigno che non è più capace di volare), soffre la propria staticità come un tormento. Ecco infine la mia traduzione del celebre sonetto mallarmeano: Il vergine, il bello e il vivace presente con un colpo d’ala ebbra a noi frantuma il duro lago obliato che sotto il gelo assilla il ghiaccio trasparente dei voli mai fuggiti! Un cigno d’altri tempi ricorda di esser lui magnifico ma sa di elevarsi invano ormai per non aver cantato il luogo dove vivere quando dell’inverno sterile splendeva la noia. Il suo collo scrollerà quella bianca agonia dallo spazio inflitta all’uccello che lo nega, ma non l’orrore del suolo che afferra le piume. Fantasma qui destinato dal suo puro bagliore, s’immobilizza al freddo sogno di disprezzo che ammanta nel suo inutile esilio il Cigno. ... Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui Va-t-il nous déchirer avec un coup d'aile ivre Ce lac dur oublié que hante sous le givre Le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui! Un cygne d'autrefois se souvient que c'est lui Magnifique mais qui sans espoir se délivre Pour n'avoir pas chanté la région où vivre Quand du stérile hiver a resplendi l'ennui. Tout son col secouera cette blanche agonie Par l'espace infligée à l'oiseau qui le nie, Mais non l'horreur du sol où le plumage est pris. Fantôme qu'à ce lieu son pur éclat assigne, Il s'immobilise au songe froid de mépris Que vêt parmi l'exil inutile le Cygne. Rimirando 20 l’EstroVerso PoeSia di Luigi Carotenuto La casa rotta di Annelisa Alleva (Jaca Book) Grande controllo stilistico e dovizia di immagini, apparentemente inesauribile, regnano nella poesia di Annelisa Alleva. Come folletti impertinenti, i giochi verbali che troviamo soprattutto nel finire della seconda sezione del libro, omonima, sembrano anche divertissement di una poetica che vola sempre elegante e leggera, anche nel rasoterra della quotidianità, riuscendo a trovare il guizzo lirico, surrealista e fumettistica a tratti, dal riso palazzeschiano, riabilitando il domestico a dignità letteraria. L'acuto principio di realtà dell'autrice rende la chiarezza figurativa e la felicità di scrittura al servizio di un dettato più segreto, che prende le mosse dalla perdita di un familiare, la madre, più esplicito nela prima sezione, Sogno chimico, tracciato poi in altri punti, dove si accenna al rischio di caduta, alla paura di cadere, ossessivamente (vedi pag.40, 41, 95, 109, l'esclamazione “Fortunato se trovi un predellino”, a pag.52). Altro topos, per così dire, è quello legato al dualismo sogno-veglia, che sembrano fondersi e confondersi, ciò nonostante, i due elementi reggono benissimo da soli, e la poesia della Alleva, riesce con arte e metodo, quest'ultimo chissà quanto cosciente, a mostrarci in quale misura convivano l'uno nell'altra, come una medaglia a due facce, maschile-femminile, in una sorta di indistinguibile conciliazione dei contrari. I libri, come i gatti, elementi concreti e simbolici, sembrano i numi protettori dell'io lirico, vegliato nel dipanarsi delle vicende testuali. Storia e Natura appaiono agli sgoccioli, della prima si invoca (e applaude) la “fine liberatoria”, la seconda (stravolgendo la visione leopardiana) “non vuole pesare. / Vuole sfilarsi i costumi di scena”. Resta solida la buona volontà del poeta: “Vorrei pulire le strade come il mio appartamento”. Ossa per sete di Sebastiano Adernò (Nuova Editrice Magenta) L'affondo poetico di Sebastiano Adernò, in Ossa per Sete (Nuova Editrice Magenta), s'impasta di una lingua a tratti oracolare, asciutta, in un linguaggio scarno, scavato, scheletrico, che nell'avorio cerca la purezza originaria imbrattata di sangue. Cantico torbido, esegesi in versi, dove ricorrono denti, mascelle, ossa, appunto, come un asfodelo a indicare la presenza del non visibile. “Una sorta di beffardo dizionario della redenzione, dove ogni lemma diventa il sarcasmo di un dio tragico, incapace di univoco silenzio, e perciò di salvezza”, scrive con grande perspicacia Vincenzo Di Maro nella prefazione, e aggiunge: Nell'ostensione di un equivoco linguaggio rituale avvengono smascheramento e restauro di una più giusta “norma mitica”. Adernò ha delle intuizioni folgoranti: “morto io / Dio si dovrà sostenere sulle sue gambe”, “Per esempio / quella che chiami madre / non è che un tentativo”; la sua “Sete (di meraviglie)” si raccoglie nel grembo della memoria, della custodia sacrale: “Colleziono ciò che altrove fu raccolto in brandelli, / suoni subacquei, / sfiati del ventre // Colleziono ciò che alcuni chiamarono Sete”. Un poemetto che indica come unica pedagogia possibile quella ontologica: “Essere sarebbe sufficiente ad insegnare”. In una sintassi ben oliata da un orecchio musicale, Adernò con la sua scrittura-fionda e “un fucile caricato / a tuberi e sonagli” in spalla, difende il “Nome” con la maiuscola, dalla ridda di coloro che “lanciano pietre / convinti / di poter lapidare / nome e miracolo”. La via battuta dagli uomini, oscura “come la notte incede / sugli occhi del cieco”, orfana di senso, ma, ancora, a ben udire, può riconoscere “l'eco di un Dio lontano”, e, scavando a fondo, rinvenire la Misericordia. L’inverno apre l’ombrello in casa di Saragei Antonini (Prova d’Autore) Una poesia che crea scompiglio, rimescola, scombina, devia i sensi unici dei luoghi comuni riordinando a proprio gusto con la fantasia colorata di uno Chagall la propria anima-stanza-casa. Testi che metamorfizzano e metaforizzano i propri umori alterni, altalenanti, in un andirivieni giocoso e serissimo. Giustamente, con sapienza critica, nella presentazione al libro di Saragei Antonini, Stefano Lanuzza ha parlato di “poesia per certi aspetti complessa eppure sorgiva e naturale, dal tessuto compatto”, “poesie misteriose e introverse, piene d'intelligenza e alonate d'una malinconia esistenziale o da languori innominati che non arrestano le irruzioni – assidue, impetuose, a stento contenute – d'una gioia senza infingimenti”. Una “quotidianità magica” vagamente alla Savinio, “sorretta da un linguaggio frizzante quanto ipnotico, incisivo e studiatamente antilirico, dominato dallo spirito allogeno di chiaroveggenti pensieri metafisici da intuire, altresì, come metapsichici” (Lanuzza). Immagini floreali, nuziali, interni e finestre proiettano fuori e difendono dentro, come armature sensibilissime, lo spirito poetico “bambino” dell'autrice, che si declina dolcemente, con amore materno, verso una fiabesca stimmung, di versi-filastrocche dedicati alla figlia lungo le parti finali del libro: “vuoi meno luce / ti darò meno luce / vuoi metterti le dita in bocca / ti farò mettere le dita in bocca / vuoi una finestra davanti e una dietro / ti darò una finestra davanti e una dietro”. Saragei Antonini grazie alla sua immaginazione fa scacco al tempo nichilista: “quel tempo imperfetto era solo singolare – / e me lo dettavo / perché ero stata troppo brava a fare presente / che per me il tempo all'infinito / non era a capo di niente –”. Gennaio - Marzo 2013 l’étranger di Davide Zizza Il tempo in un bicchiere di vino. Le quartine di Omar Khayyâm L’interesse europeo per le quartine del «fabbricatore di tende» – questo il significato letterale del cognome di uno dei più affascinanti poeti di lingua persiana dell’XI sec. quale fu Omar Khayyâm – risale, ci ricorda Mario Praz, alla sua diffusione nell’Inghilterra pre-raffaelita. Edward Fitzgerald, poeta e traduttore, basandosi su un manoscritto del 1460-61 conservato nella Bodleian Library, pubblicò una sua vulgata nel 1859, edizione questa scoperta da Dante Gabriel Rossetti l’anno dopo su una bancarella. Khayyâm apparve subito consono al clima letterario di allora, l’edonismo e lo scetticismo dei suoi componimenti accompagnati alla raffinatezza del verso sembravano collimare con la concezione di vita dell’epoca. Lungi dall’inquadrare in modo esaustivo l’autore e l’opera – i dati biografici rientrano nel rango dell’aneddotica e le interpretazioni sulla sua figura risultano controverse, inoltre rimangono ancora aperte ipotesi sull’autenticità di alcuni componimenti – per conoscere la visione di Khayyâm possiamo serenamente soffermarci su due delle edizioni più note che incontrano ancora adesso ristampa in Italia, l’edizione di Hafez Hajdar (Rizzoli, 1997) e quella di Alessandro Bausani. In particolare Bausani (Einaudi 1956, ristampa 1979 e successive) – allora uno dei più forti studiosi del mondo culturale e letterario islamico – traccia dei criteri essenziali per dare una fisionomia, se non esatta tuttavia meno incerta, riguardo il poeta e la sua raccolta. Ma a prescindere dalla filologia, rimangono le liriche e le sensazioni fugaci che queste comunicano al lettore. Alternando misticismo, filosofia pessimista e ateismo venato di umorismo, Khayyâm, un po’ alla maniera di Orazio, suggerisce di cogliere l’attimo perché la ruota del tempo gira e ci riduce in polvere («Cogli quest’attimo, tu, del Tempo» quartina 65; «ché passa e non resta questa tua vita d’un giorno» quartina 83); in questo giardino-mondo la nostra vita è racchiusa in «scrigno di terra» (quartina 57); siamo anfore di argilla, creati da un Dio-Vasaio (quartina 117), che contengono l’inafferrabile mistero dell’esistenza. L’amarezza nel non poter fermare la fuggevolezza dell’istante, essendo la morte il destino comune degli uomini, si traduce in tristezza e cerca consolazione nel piacere di vivere. Il tema del vino ricorre spesso in Khayyâm. Nonostante la controversia ermeneutica nel considerarlo un vino vero o simbolico – allora vi erano delle restrizioni sul bere e al tempo stesso il vino acquisiva valore evocativo nella creazione di quartine – Khayyâm non manca nel consiglio di trascorrere i giorni «con una coppa e una bella fanciulla». Ma se da una parte i suoi versi, esortandoci a non sprecare il tempo in affanni, ritornano seducenti alle nostre orecchie, dall’altra il poeta invita a riflettere filosoficamente sul senso di quanto accade intorno a noi («Dal mare della Meditazione la Sapienza m’ha tratto una Perla» quartina 128). Il mistero di esistere non può essere svelato. Può essere solo vissuto.
Scarica