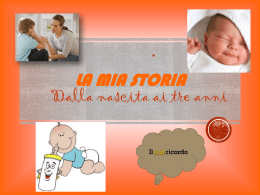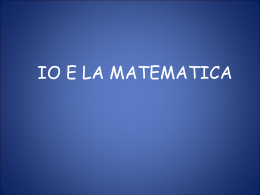Cronaca breve di quei dieci anni, di Monica Maimone Ritratto, di Sandro Colbertaldo L’Armata Brancaleone, di Anna Foà Il tram della rivoluzione, di Alberto Montanari Il rischio di essere Saracino, di Antonello Nociti Cronaca breve di quei dieci anni di Monica Maimone 1962 La mia prima manifestazione in piazza: crisi di Cuba, avevo 17 anni. Io e mia sorella manganellate da un carabiniere. Mi fecero impressione i guanti neri sulle mani quasi femminee. Un SS gentile. Rividi anni dopo gli stessi guanti sulle mani di Restelli (noto personaggio del Movimento Studentesco e poi dell’Armata Brancaleone, se doveva usare le mani lo faceva con eleganza) a una manifestazione, ed ebbi la stessa impressione. Ricordo un operaio che roteava la sua bicicletta per farsi largo tra quelli della celere. Ero iscritta al PCI, non alla FGCI come era d’obbligo per i giovani, direttamente al Partito. Un onore. Film: di Ingmar Bergman. Libri: Le memorie di una casa morta, Fëdor Dostoevskij. Musica: Ne me quitte pas, Jacques Brel. 1963 Frequentavo una Comune, in via Scaldasole. Vivevano lì dei compagni; mi ricordo di Saverio, con una barba lunga, che ancora non si usava. L’essenza di vita che si cercava era sulla rotta di Parigi. Ancora Bohème. Altro ricordo: una coppia fantastica, lei capelli rossi e baschetto, lui un artista figurativo molto piccolo; si diceva che lei lo facesse dormire in un cassetto. Per starci ci stava. Come contraltare Mondo Beat: un gruppo di irregolari, proletari, che avevano sede in una cantina, ribelli e pacifisti, fondarono “Barbonia city”: una piccola città di tende, forse le prime canne. Per qualche motivo strano io, giovane comunista, ero accettata dal loro capo. Mi fecero scrivere sul loro giornale libertario – un articolo che inneggiava alla violenza rivoluzionaria. Intanto, in America, “I have a dream”, Martin Luther King, il mondo stava cambiando. Film: Salvatore Giuliano, Francesco Rosi. Libri: 1919, John Dos Passos. Musica: Ballata per l’Ardizzone, Ivan Della Mea. 1964 Era un’epoca in cui si arrivava ancora vergini al matrimonio. Lessi per caso Wilhelm Reich, rivoluzione sessuale, amore libero ma comunista. Non molti mi seguirono. Nel frattempo conoscemmo Aldo Brandirali, segretario dell’organizzazione giovanile comunista. Nacque Falcemartello, gruppo “entrista”, affiliato in modo sghembo alla IV Internazionale trotzkista, che teorizzava: stare nel Partito (il PCI) ovviamente, per spingerlo a sinistra. Temutissimi, i quattro gatti trotzkisti rappresentavano l’orrore puro per l’apparato del Partito: lo spettro del frazionismo. Film: Il Vangelo secondo Matteo, Pierpaolo Pasolini. Libri: Memorie d’una ragazza perbene, Simone de Beauvoir. Musica: Blowin’ in the wind, Bob Dylan. 1965 E così, dopo riunioni segrete, nomi di battaglia, letture attente sull’esempio del Mali (Stato africano che non ricordo perché stava molto a cuore ai trotzkisti), venimmo espulsi dal Partito Comunista. Avevo 20 anni, mi sposo. Viene ucciso Malcom X. A Berkeley iniziarono le manifestazioni contro la guerra nel Vietnam, si costituì il Free Speech Movement. Quanto a noi, fu lì, in Falcemartello, che incontrai “gli studenti”: Saracino, Nozzoli, Radino. Ci si chiamava per cognome, come a scuola. Credo che arrivassero tutti dal Liceo Leonardo. Due mondi diversi. Il nucleo originale di Falcemartello era proletario. Brandirali, io, mia sorella, gli altri del mio “gruppo” eravamo lavoratori/studenti, quelli delle serali, lavoravamo da quando avevamo 14-15 anni. Eravamo per un cambiamento radicale contro i privilegi che non avevamo. Non capivo gli altri, che i privilegi li avevano; ne diffidavo. L’unico “studente” accettato dall’inizio, il nostro Majakovskij, era Alberto Montanari, il giovane alto e biondo che sfidava i fascisti tutti i giorni al Berchet ed era quotidianamente malmenato. Film: Le mani sulla città, Francesco Rosi. Libri: La recherche, Marcel Proust. Musica: Hasta siempre, Comandante (Che Guevara). 1966 Giungevano intanto notizie, grazie soprattutto agli articoli di Nozzoli (il padre del nostro Nozzoli) sul Giorno: gli invincibili Vietcong. Non affascinanti come i belli, solari, sorridenti “Barbudos” cubani, ma comunque eroi della rivoluzione. “L’imperialismo americano” divenne sempre più il nemico da battere. Ascoltavamo Bob Dylan, ma – noi proletari – ci rifiutavamo di parlare inglese. La nostra lingua era quella di Sartre. Anche se il nostro eroe di quell’anno era Rudi Dutschke, con gli studenti tedeschi in prima fila nella lotta contro la guerra del Vietnam. Film: La battaglia di Algeri, Gillo Pontecorvo. Libri: Autobiografia di Malcom X, Alex Haley. Musica: Auschwitz, Equipe 84. 1967 In Bolivia uccidono il “Che”, gli tagliano le mani. Mio comizio in Piazza Duomo, nel quale sostenni in buona fede che il cadavere non era di Guevara ma un montaggio della CIA (!). Grandi manifestazioni. “Il Che è vivo e lotta insieme a noi”. Era così bello e sorridente, era giovane, ci sembrava immortale. Film: Blow up, Michelangelo Antonioni. Riviste: Quaderni rossi. Musica: Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers, Fabrizio De Andrè. 1968 Sparano a Rudi Dutschke; di quella ferita morì non molti anni dopo. Fu la prima uscita pubblica di Falcemartello. Ci trovammo in Piazza Duomo, una manifestazione spontanea. Ricordo io e mia sorella in prima fila. Fu un inizio: sfaccendati, giovani, studenti, si aggregarono al minuscolo corteo di partenza e diventammo tanti. E fu lì, io credo, che si rovesciarono le parti. Fino a quel momento le manifestazioni, i cortei, erano “di difesa”: gli operai, i comunisti che scendevano in piazza sapevano di doversi scontrare con la polizia, ma ad armi impari. C’era coraggio, ma anche paura. In quel corteo, soprattutto di giovani e di studenti, c’era voglia di attacco, non di difesa: il ribaltamento di un mondo. E fu lì che i nostri, Saracino per primo, divennero protagonisti. Parigi, la Francia in rivolta. L’immaginazione al potere. Parole d’ordine affascinanti e pompose, come solo i francesi sanno fare. “Vietato vietare”, “Corri compagno il vecchio mondo ti sta dietro”, “La vita è altrove”. Seduzioni alle quali era impossibile resistere, per dei giovani affamati di cambiamento, in un’Italia ancora codina e repressiva. Nasce il Movimento Studentesco, con un leader improbabilmente vestito con una mantella. Viene dalla Cattolica, ha una parlata umbra, mi ricorda Davide Lazzaretti, il profeta del Monte Amiata. Mi piace. Lui, non gli altri. Saracino e i nostri studenti si sanno inserire; sono i comunisti, quelli seri, e nello stesso tempo quelli che stanno al gioco. Vero, di boccette, e vero di strategie di scontri con la polizia. Abbiamo con noi un po’ di universitari. Film: Teorema, Pierpaolo Pasolini. Libri: Cent’anni di solitudine, Gabriel García Márquez. Musica: Aquarius, Hair (film). 1969 Il mio giovane marito va militare. Non ho i soldi per pagare l’affitto della casetta. Mia sorella va a vivere con Saracino. A me Saracino concede una stanza, a un costo di affitto decoroso. Torno ad abitare in “Comune”. Così era l’appartamento, quello del “fatto” di anni dopo: un ingresso, una cucina abitabile, un bagno, la mia stanza, quella di Savona (il figlio del Quartetto Cetra), quella di Saracino in fondo. Una stufa a cherosene, un tubo che passa nelle altre stanze per scaldare. Il tubo della stufa porta parole e suoni da una stanza all’altra. Lavoro e tengo il telefono vicino al letto, perché ogni notte si occupa una fabbrica (sono un dirigente politico) e devo dare istruzioni ai miei pards. Intanto sento la vita degli altri, anche se Saracino (diventato Popi per me) parla sempre a voce bassa, perché sa del tubo. Gli ospiti in prevalenza di sesso femminile no. Naturalmente non c’è televisione. In agosto si tiene il Festival di Woodstock. Da parte nostra azione di attacco al consolato americano, organizzazione logistica perfetta, con medici, posti di ritrovo, piani di attacco. Organizzazione militare anche, sempre con Saracino. Film: Queimada, Gillo Pontecorvo. Easy Rider, Dennis Hopper. Libri: Il Capitale, Karl Marx. Musica: With a little help from my friends, Joe Cocker. 1970 Siamo a casa da soli, noi tre, io, Popi e Savona. Vita da scapoli. Popi entra nella mia camera e mi trova mentre dormo con una mia compagna di lavoro (avevo rotto politicamente con Dario Fo: dopo sei anni di lavoro comune, stavo con i suoi ex compagni a fare teatro politico). Si entusiasma all’idea di aver scoperto un amore saffico. Delusione, era solo ospitalità per mancanza di denaro. Ma intanto mi vuole un po’ di bene. Pulisco la casa. Adesso sto sempre a Milano, prima viaggiavo. Passo anche la lucidatrice, tutto splende. Popi mi elogia, sono silenziosa, sessualmente inappetibile, politicamente interessante. Mi chiede, dopo l’estate: «Hai letto Lavoro Politico?» (pubblicazione marxista-leninista-maoista, ci scrivevano Curcio e Berio). «Sì, hanno ragione» (non l’avevo letto). «Adesso siamo sei» (non ricordo gli altri quattro). E così, a studiare rapidamente, s’impara a parlare e scrivere come i cinesi, ci si innamora degli slogan “Fuoco sul quartier generale”, bellissimo per noi, detto da Mao che era il Quartier Generale. Un leader che chiede di non essere considerato infallibile! Così pensavamo, ignari della lotta politica che si stava svolgendo in un Paese di cui non sapevamo nulla. “Ribellarsi è giusto”, le Guardie Rosse, la Rivoluzione Culturale… Ci sembrava uno splendido ribaltamento dei rapporti di potere! Dopo tanto tempo si può dire che il rapporto città-campagna del mondo fu uno sguardo sul futuro. Ma allora non sapevamo altro che il Libretto rosso e Stella rossa sulla Cina di Edgar Snow. Ci bastava. Così andammo allo sbaraglio, contro Brandirali e altri. Non fu un massacro, ci dividemmo in due gruppi paritari. Entrammo nel Partito Comunista d’Italia marxista-leninista, riconosciuto da Mao. La cosa più buffa è che subito il PC m-l si divise in due gruppi, noi eravamo “La linea rossa” e gli altri si chiamavano “La linea nera”. Ma, incredibile, si chiamavano così anche tra loro! Ed era evidentemente un aggettivo spregiativo. Dovemmo fare autocritica e includere Stalin tra i nostri riferimenti. Stalin, per noi che eravamo stati trotzkisti (!). Film: Woodstock, Michael Wadleigh. Musica: Acqua azzurra, acqua chiara, Lucio Battisti. 1971 Prima manifestazione del PC m-l linea rossa: grande coreografia. Servire il Popolo ci seguiva e aveva tutto da imparare. Scontro con il servizio d’ordine del PCI-CGIL, Radino si prese un sigaro acceso sul collo. Gli iscritti al PCI il nostro nuovo obiettivo, non più gli studenti, che tanto avevano entusiasmato una certa borghesia milanese. Portavamo il distintivo di Mao, sognavamo le loro divise. La severità era un must. Anche nella vita privata si doveva mettere ordine. C’erano i nuclei territoriali, io ero la dirigente del Partito a Milano: una delle mie limitate virtù politiche era che sapevo imitare molto bene il modo di scrivere dei cinesi. A quel tempo bastava. Ero fiera del mio esercito, delle mie Guardie Armate. In un sopralluogo contro un raduno fascista restammo isolati, io, Daniele Nozzoli e Popi, nell’albergo occupato in Piazza Fontana. Con loro mi sentivo tranquilla, non ebbi paura. Ci fu una rivolta del Nucleo Universitario, non ricordo il motivo: nuova minaccia di scissione. Popi era caduto in moto e si era fatto molto male. Andai da sola a fronteggiare questi ragazzi, quasi tutti biondi, belli, inadatti alla divisa blu. Ero spaventata e mi sentivo impreparata. Popi arrivò e fece quello che aveva sempre fatto: fu onesto. Disse le cose come stavano. Fu l’unico a non mediare, e ne avrebbe avuto modo; tutti volevano lui, ma decise di stare dalla parte meno attraente. Beh, non lo dimentico. Entro breve, sarebbe diventato il tutti contro tutti. Estremismo, malattia infantile del comunismo. Erano ragazzi, ma erano quelli del futuro e avevano nelle loro mani il golem della vittoria, potevano imporre le regole del gioco. Chi poteva resistere al loro charme, alla loro sicurezza, alla loro caparbietà? E alla loro ingenua avidità di tutto? Avrebbero attraversato con fatica tutto quello che venne dopo: il femminismo, la messa in discussione del machismo, il rapporto con il denaro, la via aspra della rimozione o quella dolce del rimpianto. Ma riuscirono comunque a cambiare le cose. Film: Fragole e sangue, Stuart Hagmann. Libri: L’anello di Re Salomone, Konrad Lorenz. Musica: Echoes, Pink Floyd. 1972 Nacque mio figlio, mi spostai da casa di Popi in una casa mia, mi separai da mio marito che andò con la sua compagna ad abitare a casa di Popi, nella mia ex stanza. Andai a insegnare in una scuola media a Quarto Oggiaro. Continuavo a fare politica nella scuola. Poco dopo tornai in teatro e lì rimasi, fino a quando una nuova spinta politica mi portò in giro per il mondo a dare consistenza a utopie della memoria. Non incontrai più nessuno di loro. Persi di vista i miei magnifici studenti, il mio esercito, i miei nuclei proletari. Dopo tanti anni chiesi a Popi in affitto la sua casa per i miei stagisti romani. Ci sentimmo per telefono. Avevo sue notizie dai pochi che ancora incontravo. E poi ci fu “il fatto”, la notizia dello stupro. Non mi stupì. Non perché pensavo che fosse realmente accaduto. Ma ero consapevole che l’orda del protofemminismo alla ricerca di sangue sacrificale di allora non poteva trovare obiettivo più ghiotto, e più stupidamente inerme. Come potevano fargliela passare liscia? Ai nostri tempi fu imprigionato per una qualche manifestazione. Uscì da San Vittore e andammo in tanti a prenderlo. Mi abbracciò e, come sempre, non si commiserò. Non l’ho più visto. Ma lo ricordo. Bene. Ritratto di Sandro Colbertaldo Un tipo differente. Passava di lì perché viveva in Montenapoleone ma, quando mi fece salire a casa sua, non aveva niente a che vedere con gli splendenti appartamenti dei miei amichetti. Viveva da solo con suo padre, un avvocato già anziano, separato dalla moglie, in un appartamento abitato da due uomini, labirintico, disperso e disordinato, pieno di librerie polverose cariche di volumi consunti, divani e poltrone coperti da pile di giornali e riviste, portaceneri pieni di cicche, piatti da lavare in cucina e letti sfatti. Mi trovai a mio agio, contento, libero di muovermi e di fare ciò che mi pareva. Si vestiva in qualunque modo, casuale, tutto stropicciato, e con qualche patacca qua e là, ma non gli stava affatto male. Lo si vedeva sciolto, agile, disinvolto. I capelli, un po’ lunghi, spettinati e castani, avrebbero avuto bisogno di un buon parrucchiere e di uno shampoo, ma gli cadevano bene, col ciuffo sugli occhi chiari, liquidi come l’acqua. Parlava in fretta, come una mitraglietta, e sorrideva, ironico, come se ciò che stava dicendo fosse uno scherzo o una barzelletta. L’Armata Brancaleone Saracino leader anomalo del ’68 milanese di Anna Foà Ho conosciuto il Popi Saracino a Milano nel 1970, quando era leader dell’Armata Brancaleone, un gruppo poco compatto e tantomeno allineato di compagni universitari che si erano scissi dal Movimento Studentesco, un’accozzaglia di dissidenti dal gruppo dirigente di Capanna, capo indiscusso che dava la linea. Quelli erano tempi in cui i gruppi marxisti-leninisti e l’MS avevano una struttura a piramide molto rigida, con gerarchie, organi dirigenti e riunioni traslati dal partito cinese o dai vecchi comitati centrali del PCI. Verbali accurati, cellule militanti, decisioni prese solo dallo stretto gruppo dirigente, tutti gli altri “del collettivo” addetti a mansioni minori: ciclostilare, scrivere in bella calligrafia i tazebao, diffondere volantini, persino “portare la borsa” dei capi. Le decisioni venivano dall’alto e i sottoposti difficilmente si azzardavano, un’idea diversa significava espulsione. La teoria veniva calata attraverso documenti (lunghissimi e astrusi) d’ispirazione maoista stilati dal “soviet supremo” di turno. Pur essendo ginnasiali, dopo un po’ tutta questa storia cominciò a starci un po’ stretta. Sì le manifestazioni erano toste e con i plebisciti assembleari ti sembrava di “fare la storia”, però non era certo il fiorire di tutte le idee libertarie di cui si vagheggiava a Parigi o a Berkeley, piuttosto quelle ci arrivavano da Bob Dylan, insieme alla lotta planetaria contro la guerra del Vietnam, questa sì che cementava i movimenti. Invece nei gruppi che dominavano il ’68 ci si perdeva in minuziose discussioni su dettagli della lotta di classe con o senza operai, su come definire l’imperialismo, sulla rappresentanza, sul Capitale, con feroci scontri su Stalin, Trotzkij e i diversi modelli di comunismo o socialismo o anarchia o regno dei cieli in terra ecc. ecc. In quei primordi – poco dopo si arrivò allo scontro fisico tra le diverse fazioni che sfinì e incupì il movimento – comparve questo “Gruppo Saracino”, chiamato da tutti Armata Brancaleone, che si contrapponeva all’MS, nella fase in cui questo si organizzava sempre più come servizio d’ordine. Non so in che modo arrivò la notizia a noi piccoli, i “medi” come eravamo chiamati, ma l’aspetto che più ci attraeva era che qui c’era un sacco di gente grande che discuteva, era il caos, non c’era un ordine o una gerarchia prestabilita, sembravano “cani sciolti”, non si capiva bene chi fossero i capi, se c’erano non si comportavano come capi m-l o Capanna e i suoi “ufficiali”, era una specie di dibattito continuo, senza un vero filo logico. Un’accozzaglia di persone diverse e pensanti, universitari e fuori corso, intellettuali che non sarebbero sopravvissuti un giorno alle Guardie Rosse di Mao (detto col senno di poi). Andavi lì e in quelle stanze fumose potevi sentir parlare le persone più disparate che insinuavano dei dubbi, era come affrontare per la prima volta la complessità, dopo i reggimenti m-l e i servire-il-popolo (tutto stava già nel nome, ma servivi il capo). A parlare erano Piccardi, Nociti, Levi Della Torre, Pepe, Scherillo e naturalmente Saracino. Lui per noi, nonostante tutto, era il capo, sì, ma era anomalo e sfuggente, mai troppo afferrabile, dava “la linea” ma era tortuosa. Insomma i soliti meccanismi qui non funzionavano, almeno per noi, forse per loro quello delle donne che sognavano solo di conquistare il capo sì, però il Popi aveva quella bella fidanzata, sobria, Luisa, che tutti gli invidiavano… Nell’insieme era un’enclave di individui anticonformisti, lontani dalle ovazioni assembleari e soprattutto dalle “spedizioni punitive”. Molte riunioni avvenivano al bar, dove si giocava a boccette e si beveva, cui erano ammessi anche i liceali, che bigiavano la scuola per andarci. Non ricordo quando e perché si sciolse il gruppo, come succede a ogni armata brancaleone, o se fummo noi piccoli (e groupies) a stancarci prima, non ricordo quanto sia durato, ma era un laboratorio vivo di idee, mentre fuori tutto si faceva più cupo. Insomma per noi che, per età, il ’68 ce l’eravamo trovato lì bell’e fatto, quella fu l’unica zona di libero scambio delle idee che conoscemmo. Chi era il Popi: un Nowhere Man? carisma senza potere? Pensava in fretta e parlava a raffica, talvolta in modo quasi incomprensibile, mischiando temi e piani, non sembrava un capo-popolo avido di consenso assembleare – chi capisce bene, chi non capisce amen –, piuttosto cercava l’attenzione di pochi, era un mentore “per sbaglio”, mai un guru, niente fedeli, non mi pareva approfittasse del suo potere, non c’illudeva di portarci chissaddove. Senza illusi né disillusi fu meno traumatico il “liberi tutti!”. Il tram della rivoluzione di Alberto Montanari «POPI» urlavamo a squarciagola Lolla e io nel cortile della sua casa di Via Spartaco, quando ancora non si rischiava una denuncia per disturbo della quiete pubblica. “Popi” o ci faceva salire, o ci cacciava via con un gesto inequivocabile o taceva del tutto, il che significava, nove volte su dieci, che era impegnato in tornei amorosi. Ma quella volta che ci fece salire quasi non accorgendosi di noi, e camminando a larghi passi fra l’ingresso e la cucina, e finalmente sbottando: «Mi hanno denunciato per stupro.» «Ma chi?» «Una mia allieva.» «Ma sei scemo?» dissi io. «Quanti anni ha» chiese Lolla, più pratica. «Ha 18 anni e convive con uno.» Fu allora che decidemmo, io subito, Lolla dopo qualche minuto di riflessione, che andava difeso. Chi espresse il giudizio più lapidario sull’episodio fu la nonna di Saracino: «Così impari a metterti con le mezze calzette». L’avevo conosciuto alcuni anni prima, alla FGCI, che altro non era che l’organizzazione dei giovani comunisti, a cui mi ero iscritto a 15 anni, nel 1960, dopo i fatti di Genova. Avevo vissuto con straordinaria passione l’ultima fase del togliattismo culturale, fra un pallido richiamo al realismo lukacsiano – «Leggete I Buddenbrook, compagni» – e la riscoperta dei Manoscritti economico-filosofici del 1844 di Marx. Un mondo da favola, già umbratile, fra la sezione “15 martiri”, gli anni del Berchet, gli amici – carissimi – del circolo della FGCI con cui si andava in vacanza nell’ostello di Lerici. «Il compagno Montanari, dirigente senza pari, che ci porta ai monti e ai mari», si canticchiava. Morì Togliatti e io mi iscrissi alla IV Internazionale trotzkista, parendomi la faccia di Breznev insopportabile. Fondammo un giornalino, Falcemartello, e una corrente nascosta all’interno del PCI che ci causò la chiamata alla CCC – che sta per Commissione Centrale di Controllo – con l’accusa di frazionismo. Ero dunque un Giano bifronte quando, verso il ’65, incontrai Saracino e i ragazzi del circolo “Fillak”: ero dentro il partito ma fortemente critico e la cosa suscitò entusiasmo. Facemmo amicizia: loro si avvicinarono a Falcemartello e l’intesa politica divenne personale. Apparvero subito di un altro mondo: di qualche ascendenza meridionale, tutti del liceo scientifico, tutti tombeurs de femmes con tanto di scommesse e liste snocciolate, tutti dalla mente rapida nel cogliere fatti e sfumature, tutti – e non è affatto questione secondaria – militarmente impeccabili. Perché io militavo in una sezione che si chiamava “15 martiri” e avevo passato la mia adolescenza fra manifestazioni e randellate, sempre prese e mai date, per commemorare dei morti: il compagno Grimau, garrotato da Franco; il compagno Lumumba, assassinato dal vile imperialismo belga; i compagni indonesiani, massacrati da Suharto e via così, con la guerra di Spagna che incombeva, tetra. Io stesso pensavo che l’importante non fosse vincere, ma sportivamente partecipare, che significava buttarsi come un fesso in mezzo ai fascisti o alla polizia e uscirne regolarmente con le ossa rotte. Saracino e i suoi, allorché si pose la questione, chiarirono subito che non erano lì per partecipare ma per vincere, come peraltro facevano laggiù i Vietcong, e dunque durante le manifestazioni si appostavano dietro qualche angolo, aspettavano i poliziotti e li menavano come tamburi, ma – va detto – senza cattiveria. Ora l’effetto sulle ragazze era devastante: mentre io potevo contare al massimo su sguardi di simpatia, a loro si offriva – anche se i tempi non lo consentivano – ogni sorta di beneficio che si riserva al riposo del guerriero. Nulla andava sprecato: si trombava per menare e si menava per trombare. Era la nuova frontiera, il nuovo mondo che emergeva a Milano con l’intento dichiarato di farsi strada sulle prossime macerie della società industriale, imponendo un nuovo ritmo alla città. Il ’68 rappresentò per costoro la via maestra per emergere: simili agli eroi di Stendhal, si fecero strada fra le assemblee della Statale, i lacrimogeni della polizia e le provocazioni fasciste, utilizzando pragmaticamente la rivoluzione come un tram. La fine del ’68, come si sa, era stata traumatica per molti e anche Saracino finì per ritrovarsi marginalizzato, a fare il professore di geografia, e allora troppa erba, troppa inquietudine. Troppe donne. E immancabilmente incappò in quella sbagliata. Prese sottogamba l’accusa, rifiutò, pure con coraggio, una via di fuga che gli era stata offerta con l’insufficienza di prova, e lo condannarono. Montò contro di lui la canea del politicamente corretto, con alla testa il PCI che mostrava la sua vera natura antiliberale, a cui non pareva vero prendersi delle meschine rivincite, naturalmente giudiziarie. Riuscì a essere saldo in carceri pesanti, aiutato da una gentile giovane donna che gli voleva bene, e forse anche dall’affetto degli amici, fra cui un gentiluomo, Dado Ulrich. Si andò all’Appello, dove mi capitò di rivivere le temperie di ragazzo con l’arringa ciceroniana, caustica, lucida, risorgimentale, di uno straordinario avvocato monarchico, Lodovico Isolabella. Fu assolto da una magistratura non ancora militarizzata. Quel che non poterono i gradi di generale avuti nel corso del ’68 poté una vittoria processuale dai contenuti ambiguamente emblematici: da quella vittoria, non dalla via Paal, prese il via il suo vero ingresso a Milano. Il rischio di essere Saracino di Antonello Nociti Del mio amico (perduto) Giuseppe, volete sapere? Sì, davvero? Bene, allora cominciamo. Avrete notato che ci sono vite che se ne stanno docilmente racchiuse in una tazzina di caffè. Il tempo passa, e uno non s’accorge nemmeno più se si sono svuotate o sono state lasciate sul bancone d’un bar, sempre più fredde, trascurate e magari neppure pagate. Lo stesso, più o meno, succede anche se sono state invece versate in un boccale o in un calice. Non v’inganni l’euforia d’un poco di schiuma, o lo sfarfallio precoce di qualche migliaio d’isteriche bollicine: dopo un avvio, mettiamo pure, disinvolto e brioso, il subbuglio si placa, s’assopisce del tutto, e così, in qualsiasi ampiezza di bicchiere, si spegne e affoga anche la più minuscola voglia d’evadere. E Giuseppe? Giuseppe Saracino? Un momento, Saracino, notate bene: ogni nomen ha il suo omen. Almeno per noi, civilizzati, svogliati ed evangelizzati latini, abituati dai tempi di Petronio ad acquattarci in qualche loculo, nella tana di qualche nostra lascivia o di un nostro inestinguibile risentimento, insomma nel primo bicchierino disponibile ad accoglierci e là rimanere, al riparo e in riposo, fino al giorno del nostro inavvertito trapasso. Ah, lui no, no, non scherziamo. Non dico infatti in una tazza, ma metti pure in una capace caraffa, in un catino, o persino in una vasca da bagno, non c’era proprio nessun modo di rinserrarlo. Qualsiasi margine, per lui, lungi dall’essere una protezione, come per la più parte di noi, era una gabbia che l’offendeva, provocava, eccitava: ovunque lo si mettesse, non c’era verso, lui, prima o poi, straripava. Osservo, con l’apatia e la sicumera dello storico: non tutte le sue esondazioni ebbero l’effetto benefico d’un Nilo, ché, anzi, spesso ne usciva malconcio e lutulento lui stesso, al punto che gli amici lo tenevano in quarantena. Eppure Giuseppe era così, un Proteo che, al chiuso, ritrovava miracolosamente chissà quale energia della savana, e dalla gabbia, piuttosto che sgusciar fuori, se ne andava, ogni volta, diroccandola a forza di grugniti e di pugni sul muro. Un filosofo di mestiere sarebbe rimasto esterrefatto di fronte al groviglio e al ruggito dei suoi pensieri. Meno male che, in quel periodo, andava di moda, presso una minoranza d’eretici all’ultimo stadio, la frase di Pascal secondo la quale “beffarsi della filosofia, è filosofare davvero”. Così prendeva la lode, e riscuoteva un certo successo tra i suoi coetanei. La normalità accademica, comunque, rimaneva all’incirca quella che è sempre stata. Non preoccupatevi. C’erano giovani aspiranti filosofi, dei quali ancora non s’intuiva la casacca che avrebbero indossato, per accasarsi come assistenti o ordinari. Sartriani, nietzschiani, heideggeriani, popperiani, linpiaoisti: dove mai si sarebbero arruolati? Mi seguite? Sicuro? Alludo a quel tipo d’intelletti che si credono orgogliosi di tenere al caldo, nel cervello, opinioni coerenti, profonde e personali, senz’essersi però neanche accorti che un pensiero estraneo, di passaggio, come un qualunque cinico sostitutore di uova nei nidi, da chissà quanto tempo s’era infilato anche nel loro, l’aveva ripulito d’ogni residuo delle idee originali e stanziali, e al loro posto aveva intromesso una o un’altra verità da cuculo fedifrago, che essi avrebbero conservato per sempre, come se fosse la più legittima e prediletta delle loro covate. Ehi, ehi, non sia mai: Giuseppe, il mio rodomontico amico (perduto e non ancora ritrovato), qualche giacca d’ordinanza l’aveva in effetti infilata, dato ch’era stato maoista, guevarista, mickjaggerista, persino simpatizzante della reaganomics (anche i migliori cadono in periodi di catalessi intellettuale, non c’è scampo). Tutto vero e documentato. Tuttavia si sarebbe detto che ogni volta fosse l’ideologia stessa del momento, ancor prima di lui, a sentirsi offesa e a disagio, sbilenca e raffazzonata come si vedeva ridotta in sua compagnia, affranta e avvilita di dover aderire a un corpo, ma soprattutto a uno spirito, che era senza rimedio troppo sconnesso, sregolato e irriverente per farle fare una decorosa figura. Si vestiva arraffando un pullover qui e un jeans lì, a casaccio, e faceva all’incirca lo stesso coi giudizi e i pensieri anche meglio stirati. Talvolta, è vero, finiva per accoppiare un calzino verde con uno rosa, ma direi che l’effetto, se non altro, era che Giuseppe, comunque avesse a sproposito accoppiato i colori e le fogge, non riusciva mai a mascherare il Giuseppe (Saracino) che era e sarebbe rimasto, vitale e incoerente, sotto qualunque uniforme. Se avesse riletto di quando in quando i vangeli, invece d’imparare a memoria La pratica e Sulla contraddizione del presidente Mao, per poter far sfoggio di citazioni tra le guardie rosse del liceo Berchet o del Leonardo, che pendevano allora dalle sue labbra, avrebbe intuito che così come il sabato è per l’uomo, e non viceversa, così pure qualunque ideologia, fosse pure la più nobile e rispettata, era per il Saracino, e non lui per essa, e che non bisognava rimanervi appiccicato sopra, come una patella al suo unico scoglio, per tutta una vita. S’innamorava di frequente, forse persino troppo (così mormoravano i rivoluzionari dell’ala più puritana, nell’ambito della morale amorosa: chissà come mai ce n’è sempre, anche nel marasma più travolgente). Tuttavia, devo riconoscerlo, s’innamorava sempre e ostinatamente con gli occhi suoi, e mai e poi mai con quelli degli altri. Bambolette e belle statuine, per le quali contendevano con furore, lasciando una scia di reciproci odi inestinguibili, i suoi coetanei, non gli facevano né caldo né freddo. Non so dove andasse a scovarle ma, come un pescatore subacqueo dall’audacissima apnea, se ne tornava a riva quasi sempre con perle scintillanti e misteriose, della cui non appariscente bellezza, noialtri suggestionabili profani, intontiti dalla ricerca ossessiva di qualche sosia di Brigitte Bardot, avremmo capito qualcosa un anno o una vita dopo. Si sarebbe detto che l’Eterno Femminino in persona avesse intuito che lui era un suo devoto, schietto ed entusiasta. E che quando proprio non trovava a chi affidare una delle sue predilette, dalla grazia timidamente ancora in bocciolo, si rivolgesse a lui, come a un genuino intenditore, perché l’aiutasse a fiorire. Non era un collezionista, comunque, oh no. Anche se un catalogo avrebbe potuto compilarlo, un suo Leporello, e anche lunghetto. Piuttosto lui era, diciamo così, un talent scout del fascino discreto e ancora velato, e trovava le sue Fiammette, Zerline e Angeliche quando neanche loro sospettavano di essere destinate a diventarlo. Fu lui, del resto, a bofonchiare una volta, tra un risucchio di caffè e uno sproloquio sulla politica internazionale, correndo trafelato dalla Palestina al Cile di Pinochet, che negli ambienti della Gioventù comunista, c’era una giovane giornalista radiofonica che meritava un’occhiata. Pensa un po’: sarebbe diventata mia moglie. Talvolta ho il sospetto che se non me l’avesse indicata lui, il mio amico perduto (e forse da recuperare), magari adesso sarei ancora alla ricerca di qualche avvizzita copia di Sharon Stone. Meglio soprassedere sul fatto che la sua prima descrizione non assomigliasse affatto a quella del Foscolo sulla Teresa dello Jacopo Ortis, con l’arpa e una posa da angelo raffaellesco, ma si riducesse a uno schizzo piuttosto lascivo e a una frase spiccia, anche se, a suo modo, eloquente e augurale, «È davvero un bel pezzo di…». Correva voce che non fosse per niente egoista e parsimonioso, nel sesso come nella passione. Direi che con gli altri maschietti si fosse abituato a condurre la parte feriale e ordinaria dell’esistenza, tra contese, alleanze e giochi di sopraffazione, mentre con le donne trascorreva la parte festiva, tra allacciamenti interminabili da sagace bonobo, chiacchiere, allegria e incantevoli sbirciamenti sull’abisso inesplorato del caosmos femminile. Già. Dato che la voce e i verdetti delle sue più care fidanzate spesso non erano affatto una fotocopia sbiadita dei suoi e di quelli maschili. C’erano momenti nei quali Giuseppe diventava grossolano e ripetitivo, come un orango che si dondola, penzolando per ore alle sbarre della gabbia, avvilito di non riuscire nemmeno a difendere il suo orgoglio ferito, essendo stato offeso da qualche sasso o da qualche ingiuria scagliatigli addosso da un vile inserviente o dal solito incivile gorilla, fascista e reazionario, della parte opposta dello zoo. Negli occhietti semichiusi delle sue ragazze compariva allora, inaspettatamente, da un secondo all’altro, uno sfavillio sornione e un po’ canzonatorio, insieme a un’increspatura ironica delle labbra, e, senza immiserire il tutto ricorrendo alle parole, lui di colpo s’accorgeva della meschina figura che stava facendo, sbuffando e inveendo contro i nemici disegnati dalla propria immaginazione, oltre che, più in generale, dello sconfortante spettacolo della rissosità e delle nevrosi del mondo al maschile. E allora si spalancava in un sorriso che un dio della pace, della serietà e della riconciliazione avrebbe apprezzato moltissimo, chinava e ciondolava l’enorme testa crinita e si metteva a ridere, a ridere, finché abbracciandole bisbigliava qualcosa del tipo: «Oh, caspita, che massa d’idioti, noi siamo, mamma mia. Crediamo ogni volta di bastonarci e atterrarci per meritare il vostro applauso e voi, invece, avete smesso da un pezzo di guardare in fondo all’arena noi che ci malmeniamo, e magari fissate da un’ora le nuvole che s’accartocciano e si distendono in alto, danzando divertite al ritmo dei venti. Voi donne (sai Luisa?, sai Isabella?) abitate sì in questa nostra stessa aiuola, che rende noi maschietti tanto feroci, dementi e scontenti, ma, secondo me, non appartenete a essa, nient’affatto, né a tutto questo dozzinale, burlesco spettacolo del mondo». A questo punto dovreste intuire perché, quando giunse la notizia ch’era inciampato in una turpe storia di sequestro e di violenza sessuale nei confronti di una sua studentessa, parecchi di noi restarono increduli e attoniti, come se fossero venuti a conoscenza che un raffinato scopritore e ammiratore di ritratti di Madonne e Maddalene fosse stato colto in flagrante mentre distruggeva a martellate una splendida icona appena scoperta. Eppure ci vollero pochi giorni perché s’instaurasse un clima di vendetta e di tempesta. L’ho capito in seguito, parecchio tempo dopo gli eventi, e vi consiglio di stare in guardia, quando dovesse capitare anche a voi d’imbattervi in una di quelle epoche fosche nelle quali una qualche armata, concepita per arrivare alla sua Mosca, si trova invece impegolata nella melma della delusione e della ritirata. Erano gli anni in cui era stato dato il comando del “rompete le righe” agli euforici, spensierati, ribelli sessantottini, e ovunque sembrava dilagare il contagio del risentimento e della collera. Sono stagioni in cui, con la rapidità e la facilità delle trombe d’aria settembrine, s’avviluppano i venti del furore e dell’insensatezza e, quando meno te l’aspetti, ti trovi sommerso nella burrasca d’un linciaggio, talvolta dalla parte di chi sbraita e rincorre con la bava alla bocca, talaltra di chi invece s’esamina stranito e perplesso, nel dubbio d’essere diventato proprio lui la preda da scannare. In breve, Giuseppe (amico e compagno davvero ingombrante e pericoloso in certe circostanze d’alta e incontrollabile turbolenza: meglio tenersene alla larga) divenne più reprobo e ripugnante dello stesso Edipo. Non dico che avesse sedotto la madre, di questo non c’era prova, ma una fanciulla, per giunta della sua classe e con ottimi voti, dal visino d’un angelo del Mantegna, e dalla coda dorata di cavallo che avrebbe ammansito un Attila. Lui l’aveva sequestrata o no, per un intero pomeriggio, a casa sua, per sgualcirla e strapazzarla come si fa con un cencio? E non era magari la sua stessa anima inconcludente, ottenebrata dall’offesa della resa e della fuga precipitosa dei suoi fedeli, la sorgente di quella pestilenza di disimpegno, di droghe e di vizi che si stava impadronendo della città? Aborrivano il mio amico (abbandonato in quell’occasione alla furia degli elementi dalla maggior parte di noi) i benpensanti d’ogni sorta, com’è naturale; i colleghi del professore isterico – di cui lui aveva sbaragliato in quattro e quattr’otto la guardia del corpo, fatta di signorini dal buon cognome e di picchiatori fascisti allevati inutilmente in palestra – al quale aveva sfasciato a pugni e a testate il taxi sul quale fuggiva a rotta di collo dopo aver offeso l’ennesimo studente lavoratore; i giornalisti del Corriere, accusati di scrivere che Valpreda e Pinelli erano stati scoperti con la bomba di Piazza Fontana in mano, e che il napalm versato dai bombardieri sui vietnamiti bruciava e scuoiava, in fondo, non degli esseri del tutto umani ma soltanto piante della giungla o selvatici comunisti alla Giap; per non parlare della moltitudine di coloro che si trovano a proprio agio indifferentemente in qualsiasi tempo e in qualsiasi esistenza, e si irritano e si sentono offesi se qualcuno li accusa d’assomigliare un pochino ai pesci rossi d’un comune acquario conformista. Ma poi c’erano anche i maggiorenti del grande partito di sinistra d’allora, che lui aveva derubato in poche settimane dei tre quarti della loro preziosa federazione giovanile, e che finalmente potevano mostrare ai loro fedeli quali pericoli avevano evitato rimanendo immobili e leali nel recinto dell’unico comunismo certificato da Kruscev e da Breznev. E poi… E poi s’intrufolarono nel linciaggio alcune giornaliste del femminismo dell’ultima ora, fiere d’aver scoperto una lurida storia che mostrava un rivoluzionario all’università o in piazza e che in camera sua si denudava e si trasformava in un tiranno di donne e bellezze. Già. Dimenticavo: la città, inoltre, era piena di don Ottavi le cui mogli, figlie e fidanzate lui aveva adescato e, loro pensavano, maltrattato come forzate Lucrezie. Era venuto il momento di smascherare il profanatore. Così, al primo processo fu davvero per bene staffilato e insudiciato d’accuse. Venne, tra gli applausi d’una parte, condannato a quattro o cinque anni, non ricordo più. Lo rivedo condotto in manette da un plotone di carabinieri, così, non tanto, credo, per evitargli la fuga o per rassicurare le mamme e i papà delle ragazze liceali, quanto, presumibilmente, per ammonire altri giovani scapestrati sul modo in cui quasi sempre finiscono certi destini insolenti e intemperanti. A San Vittore se la cavò, il tipo, se la cavò, con la coriacea sfrontatezza d’un Jean Valjean. Del resto fu assolto fin dal primo giorno dal tribunale dei carcerati. I quali, a pensarci un momento, la vita, e la giustizia che li ha atterrati e calpestati, devono conoscerla a menadito, quant’è brutale e calunniatrice, probabilmente molto più a fondo e onestamente, di tanti giuristi e sociologi che non hanno mai vissuto nel sottosuolo. Come un autentico pastore tedesco (un esempio per tutti? il mio Duk), istruito e addomesticato, una volta fuggito dalla villa, magari per colpa d’una noia momentanea riguardo alla sua esistenza medio-borghese, se venisse adottato da un branco di lupi, si dimenticherebbe in un nonnulla delle ciotole e dei bocconi a orari fissi, dei “sitz” e dei “platz”, e riscoprirebbe la sua indole superba e battagliera sotto la maschera compita e morigerata del faccendiere peloso di casa che era, così lui s’adeguò a quel mondo di reclusi, senza un cedimento né un rammarico, e vi trascorse un bel po’ di mesi, imparando a farsi degli amici, a cui insegnava a giocare a scopone o agli scacchi, e prendendosi persino a morsi, a pugni e a calci, per far capire che genere di mascalzone anche lui, nel bisogno, sapeva diventare, con dei compagni di cella che volevano vietargli l’ascolto del Rigoletto. A una visita lo trovai col volto tumefatto come un pugile dopo il match, ma quando gli chiesi con quale bufalo si fosse scontrato, sollevò le spalle ed evitò di rispondermi: si limitò a indicarmi un tizio che s’intratteneva sussurrando affettuosamente qualcosa a una bambinetta, anche lui con noi nella sala dei colloqui, e notai che anche quello sembrava uscito piuttosto malconcio dal ring. Venni molto tempo dopo a scoprire che gli erano state concesse alcune ore da dedicare all’ascolto della musica lirica, e che la riconciliazione nella stanza era stata firmata davanti a un’enorme cofana di spaghetti alla carbonara. Noi, intanto, almeno quella manciata di ex compagni che non s’era dispersa, travolti e intimoriti dalla sventura e dalla vergogna, lo incalzavamo con petulanza perché moderasse almeno un poco la sua alterigia da Tarquinio il Superbo e riconoscesse, se non d’aver commesso un autentico stupro, se non altro una sconveniente ineleganza, oltraggiando una Lucia Mondella ammaliata dalle sue lezioni. Macché. Risoluto come Don Giovanni nell’ultimo atto, alle nostre insistenze – “Pentiti, Giuseppe, pentiti, scriteriato! Non osare sfidare l’intero tribunale, che è più duro e stentoreo della statua del Commendatore” – lui continuò imperterrito a ripetere che i casi erano due, o aveva ragione la bella ragazza, o aveva inventato, per qualche suo strano motivo, una storia falsa se non al cento, almeno al novantanove per cento, e che nessuno mai l’avrebbe assolto con una pacca sulle spalle per un reato minore. Tagliava corto, insomma. Ci diceva di non andarlo nemmeno a visitare se dovevamo portargli quelle piccole dosi di opportunismo per acquietare i nostri timori di vedercelo scomparire nella Geenna di qualche penitenziario per pedofili e violentatori di studentesse liceali: ci limitassimo semmai a fargli avere i volumi delle Memorie del sottosuolo, o del Viaggio al termine della notte, o magari, perché no?, Le nozze di Figaro, dato che aveva un suo progetto di far diventare melomani quelli della sua cella che stavano già cominciando ad apprezzare l’aria di “Cortigiani, vil razza dannata”, e la intonavano talvolta a squarciagola addirittura nel mezzo della notte. Resistette, resistente, leggendo Musil, parlando di politica, ascoltando le storie dei dannati della vita, insegnando ad alcuni di loro la consolazione della chiacchiera tra amici e dell’opera. Ci fu poi un Appello, un giudizio in Cassazione, un riappello, non ricordo che altro. Fatto sta che, a conclusione d’un ciclo più o meno decennale, un giudice donna, dall’aria molto severa ma anche molto serena, signorile ed esperta della vita, fece notare che non è facile immaginare una violenza sessuale durante la quale le chiavi di casa del luogo del martirio siano rimaste sempre a disposizione più della vittima che del suo carnefice, oltre ad altre incongruenze, come il tipo particolare di accoppiamento, su cui sarà meglio versare un poco di reticenza, anche a distanza di tanto tempo. So che l’avvocato avrebbe voluto che lui continuasse il duello, e denunciasse a quel punto la sua accusatrice di calunnia, aggravata per giunta da futili, molto futili motivi. Ma Giuseppe compì allora, forse, il gesto più mite e longanime di tutta quella sconcia faccenda: non sporse nessuna denuncia. Conoscendo il tipo, credo che avrebbe semmai avuto voglia d’inviare un biglietto alla sua vittima-non-vittima, scrivendole qualcosa come una sorprendente, concisa ma schietta dichiarazione: “Peccato sia finita così”. Ma la ragazza, nel frattempo, si era probabilmente costruita non una sola, ma due o tre nuove vite e famiglie, e soprattutto non aveva lasciato alcun recapito. Il mio amico tornò a vivere all’aria libera e aperta, e si trovò in un mondo nel quale parlare del ’68, e delle lotte operaie e studentesche, era alla moda come ricordare le carrozzelle coi cavalli o le poesie di Giosuè Carducci. Non avendo più alcuna possibilità di architettare Nuovi Mondi, tantomeno di tentare il restauro delle anime infiacchite dei giovani in arrivo, si dedicò a ripristinare prima appartamenti di ringhiera, poi palazzi di ringhiera, quindi palazzi meno popolareschi, e infine interi ex stabilimenti e quartieri fatiscenti. Collaborò insomma, in mancanza di meglio, al trapasso dalla Milano bisunta e operosa del dopoguerra a quella mezza metropoli dalla vita fervida, e spenta, dal consumismo facile, e coartato, che ancora non sa bene cosa fare dell’anima e del benessere suoi, ancor meno del proprio nichilismo sempre meno gaio e sempre più smorto. Mi piace però ricordare che, anche da costruttore di gran successo, rimase più o meno vestito da leader trasandato di manifestazioni studentesche, non si comprò un appartamento a San Babila né una macchina come si deve. Neanche una donna, composta punto a punto, come un ricamo, in qualche nobile scuola delle Orsoline. Ricoperto di calce e scamiciato, s’affaticò a strapazzare una città che non ne voleva sapere di uscire dall’adolescenza del boom e del primo grande sviluppo industriale. Aggiungerei soltanto una cosa al breve schizzo biografico d’un rappresentante d’una scontrosa specie umana, pressoché in via d’estinzione. Vorrei invitarvi a non guardare, per un momento, soltanto al palcoscenico, dove i personaggi e le comparse compongono quella che noi chiamiamo la comune realtà. Provate a seguirmi per qualche minuto dietro le quinte, cauti, senza far troppo rumore, per non infastidire e far ritirare il regista o, nominiamolo pure, lo spirito ficcanaso dei tempi, che è l’unico vero tessitore dello spettacolo e delle singole parti dei diversi attori. Ci sono epoche a tal punto irrimediabilmente ibernate nell’accidia e nel disincanto più greve e gramo, che lo spiritello stesso, agile e incontenibile (creato, io credo, per suscitare di quando in quando la voglia euforica dell’infinito in qualche essere vivente, che se ne sta incapsulato nella sua dimensione ristretta e limitata), si sente apatico e malaticcio, intossicato dalla mancanza di qualsiasi autentico, vispo desiderio, e viene lambito spesso dal cupo pensiero che l’umanità farebbe bene ormai a riconoscere d’essere rimasta allo stadio insuperabile d’una specie ambigua e malnata, inadatta sia a sopravvivere tra i bruti inconsapevoli ma soddisfatti, sia a sollevarsi tra entità più pure e più nobili. Ed eccola lì, in bilico, come di questi tempi, tra l’impulso di regredire alla condizione spensierata e vorace degli squali o dei varani, e la spinta, proveniente chissà mai da dove, ad aggrovigliarsi in se stessa, e a ripetersi, come un mantra stanco e desolato, qualche frase céliniana del tipo: “Periamo d’essere senza grandezza, senza mistero, senza leggenda. I cieli ci vomitano. Crepiamo di retrobottega”. Si direbbe che tutto, proprio tutto, stia tornando al caos tenebroso e al silenzio primitivo, e che le scintille di coscienza e ambizione residue si stiano spegnendo una ad una, consegnando l’umanità a un’esistenza magari operosa e irrequieta, ma anche insignificante e d’una vacuità insopportabile. E invece? Invece, nel mortorio generale, ecco spuntare qua e là qualcuno che non segue il copione d’una esistenza regolamentare e sgomenta. Questo, non una parola di più, volevo dire del mio amico perduto, non dimenticato, e certo anche da ritrovare, Giuseppe Saracino. Se non ci fossero stati quelli come lui a insegnarci la pazza ebbrezza delle ascensioni spericolate e indimenticabili (anche molto rovinose, per alcuni, com’è ovvio), noi saremmo rimasti quegli esseri ammalati di realismo, di sfiducia e di rinuncia, pensando ai quali ancora oggi ci viene da piangere e da vergognarci. Mentre al contrario siamo fieri e persino gioiosi, anche se non sappiamo bene di che.
Scaricare