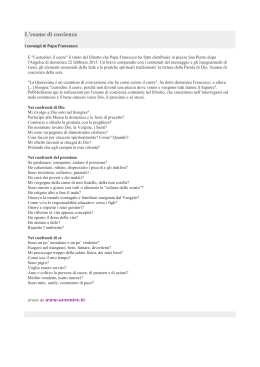Domenica La di DOMENICA 30 LUGLIO 2006 Repubblica l’inchiesta Salma, la principessa scalza del Marocco TAHAR BEN JELLOUN e FRANCESCA CAFERRI la memoria Marcinelle cinquant’anni dopo GIORGIO BOCCA e LEONARDO COEN il cuore segreto Comincia il viaggio estivo di “Repubblica” Un’avventura fuori schema e fuori rotta lungo milletrecento chilometri di montagne PAOLO RUMIZ È SAVONA un attimo. Come infilo la chiavetta a forma di chiodo nella toppa dell’accensione, la Calabria diventa lontana come la Patagonia. E l’Aspromonte, capolinea del viaggio, si trasforma in un infuocato purgatorio, perso nei miasmi della distanza. Ce la farò? Non accendo nemmeno il motore. Guardo le spiagge roventi della Riviera di Ponente, i primi lumini dei ristoranti, le donne tirreniche, le palme, le agavi, e mi chiedo come ho fatto a cacciarmi in un guaio simile. Fare gli Appennini per le strade minori è già una follia. Gli Appennini non finiscono mai. Ma farli con una Topolino del 1953 è un delirio assoluto. È la sera della vigilia — domani si sale al Grande Inizio, Cadibona — e la capretta meccanica è appena arrivata nel parcheggio di un hotel assieme al proprietario, un bolognese simpatico con barbetta da ufficiale di cavalleria; uno che all’auto un po’ ci somiglia. Si chiama Roberto Righi da Bologna e mi guarda con invidia. Vorrebbe partire anche lui, ma il lavoro non glielo permette. Ignora completamente la “Reisefieber”, la febbre da viaggio che mi divora. Non lo sfiora che possa avere dei dubbi. O forse ignora quali pazzeschi sali- scendi ho in mente di fare. Sessantamila metri in su e in giù, più o meno. Ho un bel dire a me stesso che tutto questo ha un senso, che nel 2006 la Topolino compie settant’anni (il primo modello è del ‘36), e che è cosa buona e giusta fare un viaggio italiano con un’auto italiana. Italianissima, anzi, come la littorina, la divisa dei carabinieri e il profumo del ragù. Il meglio del meglio. Un’auto simpatica, priva di arroganza, capace di svegliare ricordi, propiziare incontri. Una capretta ideale per provocare gli italiani divorati dalla fretta, adattissima a un viaggio di montagna. Nonostante tutto questo, la sproporzione fra il trabiccolo e l’immensità del Paese mi schianta già prima di partire. La guardo, la annuso. Sa di ferriere e praterie. Ha mille anni, non 53. Apro il cofano. Non c’è dentro niente. Pistoni, benzina e basta. Elettronica zero. La porta si apre controvento. Le marce non sono sincronizzate, la freccia manuale non si spegne a curva finita, il cambio è una sbarra diagonale lunga ottanta centimetri, il contrario del freno a mano, che è una leva cortissima e scomodissima all’altezza dei piedi. Devo imparare da zero cose come taccopunta, doppia debraiata, partenza da fermo in salita. Se fossi in bici, partirei con meno preoccupazioni. (segue nella pagina successiva) i luoghi La Siberia del fotoreporter Tornatore GIUSEPPE TORNATORE cultura Andrea Pazienza, i disegni mai visti MICHELE SMARGIASSI la lettura Così l’uomo ha catturato il fulmine DARIA GALATERIA e RUGGERO PIERANTONI spettacoli Truffaut, il cinema istruzioni per l’uso STEFANO MALATESTA FOTO MARCELLO BERENGO GARDIN/CONTRASTO Repubblica Nazionale 27 30/07/2006 Appennino 28 LA DOMENICA DI REPUBBLICA la copertina Cuore segreto DOMENICA 30 LUGLIO 2006 Domani si parte, a bordo di una utilitaria costruita nel ’53 e con regole di ferro: niente città, niente pianure, niente guide e soprattutto niente rettilinei. Il nostro è un mondo fuori rotta, una storia di paracarri e tornanti, un viaggio fatto di curve nella pancia del Paese, una pista cheyenne incollata alla spina dorsale della nostra lunghissima penisola Con la vecchia Topolino dentro PAOLO RUMIZ (segue dalla copertina) ome se non bastasse, si chiama «Nerina», ed è blu. Valla a capire. Dev’essere una vecchia zia stizzosa e intrattabile. «Ma no — ride il Righi — l’ha battezzata così un tedesco che l’ha avuta negli anni Sessanta e l’ha dipinta di nero. Io l’ho riportata al colore originale, ma non potevo più cambiarle il nome, porta male». Sorride con malizia: «Non è affatto una vecchia zia. È una vivandiera partigiana, una donna di bocca buona. Arrampicatrice implacabile. Nervosetta, dispettosa, perfino aggressiva. E poi, se apri la capote e la sai tenere ben bene su di giri, ah, d’estate è una meraviglia». Proviamo a fare un giretto insieme, nel traffico asfissiante della Riviera. Il cambio gratta, bisogna farsi l’orecchio. Devo capire che Nerina non è un’auto, è un’altra cosa. Devo spingere, premere, afferrare, tirare, girare con forza. Faticare più di un camionista. Lei non è un corridore di gran fondo. È un lagunare che striscia sui gomiti col coltello fra i denti. Il treno ha un’andatura sincopata, la bici un “sound” binario e frusciante. La Topolino ha un moto muscolare, a strattoni. Morde le salite con una voce rauca, persino autoritaria, da contralto. Domani si parte, con regole di ferro. Niente città. Niente pianure. Niente guide rosse, verdi o blu ai monumenti. Soprattutto, niente rettilinei. Non c’è nessun mistero in fondo a un rettilineo. Il rettilineo non accorcia un bel niente: ti mangia la vita, è un interminabile nulla, una condanna come la galera. La nostra, invece, è una storia di paracarri e tornanti. Un viaggio fatto di curve, nella pancia del Paese. Migliaia di curve. A falcata lunga o di culo basso, spigolose o rotonde, non importa. Un viaggio di uomini e incontri. Una pista cheyenne incollata alla spina dorsale del Paese. E allora sì che non esiste auto migliore di questa. La più simile al mulo che trovi sul mercato. In assenza di guide basta una buona carta. Basta fidarsi dei nomi, e l’Appennino ne ha di favolosi. Doppi, come Buonalbergo, Rupecanina, Castelsaraceno, Girifalco o Papasìdero. Allarmanti, come Latronico, Timpa del Demonio, Passo della Femmina Morta. Evocativi: Alpe della Luna, Sasso Tignoso, Gole dell’Infernaccio. Enigmatici: Cozzo Gummario. Sperduti: Badia di Repubblica Nazionale 28 30/07/2006 C Moscheta. Vuoi mettere con Brescia Ovest, Cavenago, Sasso Marconi… Muti, afoni, spenti; con l’anima rubata da svincoli e tangenziali? Questo è un viaggio topografico a caccia di toponimi. Lavoro perfetto per una Topolino. Chi ha detto che in Italia non c’è più terra incognita? Provate a infilarvi in Val Quaderna, a pochi chilometri da Bologna. Vi perderete. Sentirete un vuoto ansiogeno da altopiano iranico. Avete mai sentito nominare la Val Sèllaro e la Valle Sallustra, che stanno lì accanto? Non provate a dire di sì, perché non vi crederò. Gli Appennini sono deserti e sconosciuti. Li scopri solo se un orrendo ingorgo ti espelle dall’autostrada. Soltanto allora ti capita di scoprirne l’infinito labirinto. E se spegni per un attimo il motore, senti un immenso silenzio di cicale, torrenti e lucciole. Altro che Alpi. Quando fate la E 45 da Ravenna a Perugia, nulla vi dice che a Sàrsina, a pochi metri da voi, nel santuario con il collare di San Vicinio, si spalanca l’abisso di un mondo popolato di dei — e oscure deemadri — molto più antichi di Roma. I ladri rubano meglio vicino alle questure: per motivo analogo i posti più misteriosi stanno spesso accanto alle grandi strade, ignorati dal flusso che le percorre. Un giorno m’è bastato uscire di pochissimo dalla A 25 Roma-Pescara per scoprire l’incanto di Santa Maria in Valle Porclaneta. O per trovare frate Osvaldo, custode dei polverosi manoscritti dell’abbazia di Valleverde a Celano. Stelle, una terrazza a mare, un chinotto freddo, sul tavolo la carta uno a un milione col piano del viaggio. È da due mesi che ci appiccico Per questo tipo di viaggio non c’è auto migliore della vecchia Nerina: la più simile al mulo che trovi sul mercato meticolosamente, sugli spazi laterali, rettangoli su misura con le indicazioni dei luoghi e delle persone da incontrare. Un viaggio comincia sempre così: con un affascinante inventario, un grande disordine dove poi sceglierai la strada in leggerezza. Ma già la mappa, da sola, svela l’arcano di questo mondo fuori rotta. Cose come: il caravanserraglio di San Martino di Paravango, sulla via del sale tra Tirreno e Piemonte. O il santuario della dea Vacuna, nel Reatino, dove un toro ogni anno deve segnare il solco con l’aratro dall’orizzonte. Righi esplora la mappa, è come se scoprisse un altro pianeta. Ci perdiamo nelle galassie, navighiamo dalle inspiegabili mummie cinesi seicentesche nel museo di Ferentillo in Umbria alle terribili storie partigiane raccolte da Roberta Biagiarelli in Val d’Arda sopra Piacenza. Ecco il Monte Fumaiolo con le sorgenti del Tevere, rubato alla Toscana e annesso dal Duce alla “sua” provincia di Forlì come legame imperituro con Roma. Ecco, in fondo a destra, il tunnel di Balvano, dove nel ‘44 un treno a vapore pieno di borsaneristi non riuscì a superare la galleria e VOLTAGGIO Grande ponte medievale a schiena d'asino. Inizia la terra selvaggia degli antichi Liguri segnata da migliaia di chilometri di muretti a secco BACUGNO PORRETTA TERME Trattoria di Pellegrino Castelli, vulcanico oste di destra amato da famosi "sinistri", come Sergio Cofferati, Dario Fo e Francesco Guccini Qui, lungo l'antica via Salaria, torna ogni inizio d’agosto il rito della dea Vacuna. Un toro ara i campi dall'orizzonte fino alla Madonna della Neve DOMENICA 30 LUGLIO 2006 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 29 UN TOUR IN VENTIQUATTRO TAPPE In queste pagine lo schema e le anticipazioni del viaggioreportage compiuto dal nostro inviato Paolo Rumiz a bordo di una vecchia Topolino lungo l’intera catena degli Appenini Il viaggio, alla scoperta di un’Italia quasi sconosciuta ma non minore, proseguirà da domani e fino al 24 agosto, ogni giorno sulle pagine di “Repubblica”. Ventiquattro puntate, dalla Liguria alle porte della Sicilia, ventiquattro racconti in presa diretta sulla storia e le storie, su territorio, borghi, tradizioni e personaggi della spina dorsale del nostro Paese Un percorso lungo le strade meno battute della nostra Italia, guardata dall’angolatura meno consueta. Qui a sinistra, il logo del viaggio-reportage disegnato da Altan il labirinto dei tesori d’Italia asfissiò tutti i passeggeri. Ecco la casa di Vasco Rossi e quella di Enzo Biagi. Un po’ dappertutto, favolose osterie e uliveti. È scandaloso quanto poco si nomini l’Appennino. Nei titoli dei giornali compare cinque volte di meno rispetto alle Alpi. Della catena dominante si parla continuamente. Convegni sulla transumanza degli orsi, sulle regioni a statuto speciale, i dialetti occitani, il post-fordismo del Nordovest pedemontano, la biodiversità nelle Orobiche e i fiumi del Bellunese. Non parliamo dell’Alto Adige con i suoi maledetti gerani. Un’inflazione. Eppure, diavolo, le Alpi sono solo la cornice esterna del Paese. Gli Appennini ne sono l’anima. E sono lunghi quasi il doppio. Senza di loro la penisola si affloscerebbe come un dirigibile senza gas nella pancia. Giorni fa passavo in aereo sulle Alpi. Dal finestrino riconoscevo tutto. Sulle Alpi è impossibile perdersi, hai quei grandi pilastri che ti orientano sempre. Quando volo da Roma a Milano, invece, non riconosco quasi nulla, a parte i laghi. Navigo nell’indistinto, come in un mare in tempesta. Perché? Perché non so collocare Te- ramo, Macerata o Ascoli su una carta muta d’Italia? Dove sono i Simbruini, le Mainarde o i Monti della Daunia? Dove sono i vertiginosi Alburni? Qual è il passo della Raticosa e dove sta il Furlo? E Annibale, dove ha scollinato nella sua marcia su Roma? Domande a cascata. Come mai gli Alpini non si chiamano Appennini? Per quale maledetta ragione non ci hanno insegnato nessuna filastrocca — tipo «Ma-congran-pe-na-le-re-ca-giù» — per orientarci nella principale catena montuosa del Paese? Perché questo straordinario terreno grondante di storia ha un ruolo subalterno nell’immaginario nazionale? E come mai nessuno convoca gli stati generali dell’identità appenninica? Si teme che si risveglino i Sanniti, gli Apuani o i favolosi Etruschi? La nostra anima cattolica ha paura de- gli dei in esilio? O c’è qualcosa di non risolto nell’identità d’Italia? Attento, mi hanno detto, gli Appennini sono come la ribollita. C’è dentro di tutto e rischi di perderti, di spezzare l’andatura nella ricerca dei singoli ingredienti dell’italico minestrone che, invece, va mangiato tutto assieme. Per non smarrirti devi seguire i gangli della spina dorsale, non perdere di vista quei becchi inconfondibili chiamati «Pen» che hanno dato il nome al tutto. Monte Pènice, Penna, Pennino, Penne, Pennabilli, Pescopennataro. Li trovi dalla Liguria al Molise. Sono le boe di una regata, i paletti di un supergigante. Luoghi sacri di cui è rimasto solo il nome, celtico. E quel brivido che ti prende sulla cima, dove — mentre guardi l’universo — una voce ti tenta dicendoti: «Ecco, un giorno tutto Perché si parla sempre delle Alpi e di questi monti mai? Eppure sono l’anima, non la cornice, della nostra terra ISERNIA Chiesa dei Santi Cosma e Damiano. Qui, sino a ieri, le donne portavano in chiesa falli di cera e gli uomini si facevano benedire il sesso CALITRI Da qui alla Sella di Conza (Avellino) funzionano innumerevoli pale eoliche sullo spartiacque ventoso tra Adriatico e Tirreno SANTUARIO DI POLSI Nella Locride più inaccessibile Sul lato "greco" della montagna trovi i segni di ritorno del cristianesimo ortodosso degli antenati questo sarà tuo». Il Righi mi apre il libretto. Logoro, in una busta di pelle dal profumo carovaniero. Nei passaggi di proprietà c’è la storia d’Italia dal dopoguerra. Un inizio in sordina, un onorato servizio negli anni del miracolo economico, l’acquisto del tedesco che la usa in Italia come auto da scorribanda. Poi la vecchietta acciaccata cambia vita, viene restaurata, entra nel giro dei Topolino Club, partecipa ai raduni, raggiunge il Gargano, percorre le Consolari, s’arrampica sul Sella, il Gottardo e l’Abetone. Per questo viaggio di Repubblica la Fiat la spedisce nientemeno che alla Ferrari di Maranello. In caso di guasto, sul pianale posteriore c’è di tutto: albero motore, differenziale, frizione, cacciaviti e chiavi inglesi che tintinnano appena si mette in moto il trabiccolo. Aggiungiamo sulla mappa i nomi di specialisti capaci di metterci le mani. Gente come Gigino Tramparulo da Castellammare di Stabia, detto «o professore», uno che un giorno — in assenza di ricambi — aggiustò il monoblocco col tappo-corona di una bottiglia di lambrusco. Ci salutiamo a malincuore. Sciabordio, il Tirreno è stanco, l’aria ferma. Le montagne dei tostissimi Liguri, osso duro di Roma imperiale, incombono nella foschia. Cerco Cadibona, ma forse lassù non c’è nessun inizio. Gli Appennini sono solo la continuazione delle Alpi. Ma, a pensarci, anche le Alpi sono la prosecuzione della catena Dinarica. La quale a sua volta viene dai Monti Rodopi, dall’Anatolia e dal Caucaso, e oltre ancora fin nel cuore dell’Asia. Se nel Buthan accendessero un fuoco, di cima in cima la segnalazione arriverebbe fin qui, e poi oltre, lungo le cime chiamate «Pen», per quel promontorio interminabile che si chiama Italia. Fino al monolito dell’Aspromonte, fermo in mezzo al Mediterraneo. Il grande capolinea, dirimpettaio di un altro fuoco da leggenda. L’Etna. Riguardo il percorso di domani verso il confine tra Piemonte, Liguria, Emilia e Lombardia. Anche lì fantastici nomi. Montenotte, Combascura, Barbagelata, Fontanigorda. Quei nomi ti fanno il nido dentro, non ti lasciano in pace, chiedono di essere ascoltati e decifrati. Parole, lo so, che si svelano di notte: allora senti che mormorano come se chiedessero il silenzio per essere comprese davvero. Ce la faremo. Se a cavallo del secolo il capo del governo Zanardelli ha fatto la Basilicata a dorso di mulo, noi saremo pur capaci di fare l’Italia in Topolino. 30 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 30 LUGLIO 2006 l’inchiesta Islam che cambia Si chiama Salma Bennani, è una borghese di Fes, ha ventotto anni e una laurea in ingegneria. Per le ragazze marocchine la sposa di re Mohammed VI è un simbolo di emancipazione Anche se troppo spesso le riforme illuminate del sovrano restano lettera morta in una società maschilista presidiata da giudici e funzionari. Come il nuovo codice di famiglia... Salma, la principessa scalza e le libere donne del Marocco L FRANCESCA CAFERRI Repubblica Nazionale 30 30/07/2006 RABAT alla Salma non stira più i capelli e raramente li raccoglie: da qualche tempo anche nelle occasioni ufficiali li lascia sciolti sulle spalle, una cascata di riccioli rossi a incorniciare un ovale chiaro e grandi occhi verdi. La ragazza ventiquattrenne avvolta nella jellaba che nel 2002 sorrideva tesa dalla prima foto scattata a Palazzo oggi cammina sicura sotto i flash: largo sorriso, tailleur bianco d’alta moda, scarpe con il tacco, lunghi pendenti alle orecchie. A quattro anni dal suo matrimonio con sua maestà Mohammed VI, erede della millenaria dinastia alawita, il Marocco ha imparato ad amare i riccioli di Salma Bennani, e l’aria nuova che la giovane ingegnera, nata in una famiglia borghese di Fes, ha portato a corte e in tutto il Paese. Che non sarebbe stata una principessa come le altre a Rabat lo hanno capito subito, quando nell’ottobre 2001 un comunicato ufficiale annunciò il fidanzamento con il re, succeduto al padre tre anni prima. Per la prima volta il nome della sposa veniva svelato prima delle nozze, per la prima volta la donna prescelta dal sovrano aveva un volto: per il Paese che non aveva mai visto neanche in foto Latefa, la berbera che per più di tre decenni aveva vissuto accanto ad Hassan, fu una rivoluzione. Confermata dallo stesso sovrano: «Salma sarà Sua altezza reale, ma non regina, perché questo ruolo non esiste nell’Islam… per lo meno, non in Marocco», disse. Seguirono le foto del matrimonio e poi quelle, sempre più numerose, della principessa al fianco del marito in patria e all’estero. Il rapido arrivo dell’erede Sidi Moulay Hassan, che oggi ha tre anni, consacrò definitivamente il suo posto nel cuore dei marocchini. Oggi Lalla — titolo acquisito con il fidanzamento, significa nobildonna — Salma sorride dalle foto in ogni angolo del Paese, seconda in popolarità solo al marito. Ad amarla sono soprattutto le ragazze che passeggiano nelle città più grandi in jeans e a capo scoperto: la principessa che segue la moda è un simbolo per la nuova generazione di donne marocchine, che nei vincoli imposti dalla tradizione stanno sempre più strette. Ma per gli osservatori stranieri Lalla Salma è molto di più di questo: l’ex ingegnera dai riccioli rossi è la migliore immagine di un regno che di modernizzazione e cambiamento ha fatto le sue parole d’ordine, pur non rispettandole sempre. In sé Sua altezza reale raccoglie tutte le contraddizioni del Marocco. Non è regina, ma non è neanche, come le donne che la hanno preceduta, solo «la madre dei principi»: non ha un incarico ufficiale ma nessuna prima di lei era stata tanto attiva sulla scena pubblica. Guida da sola l’auto ma raccontare troppe cose di lei può costare caro, come hanno imparato i giornali marocchini. È un punto di riferimento per le donne ma di concreto per loro fa poco. Così è Lalla Salma, a metà strada fra ciò che fu e ciò che sarà, come il Marocco di Mohammed VI. A cinquant’anni dall’indipendenza si può dire senza timore di sbagliare che il figlio di Hassan II è il monarca che più ha fatto per la modernizzazione del suo paese. La Commissione per la Verità e la Riconciliazione è stato il primo tentativo mai fatto da un Paese musulmano per far luce su un periodo di sangue: è stato il re a creare l’organo che ha indagato sugli assassini, le scomparse, le detenzioni arbitrarie e gli abusi che hanno macchiato il regno del padre. Ma quando la relazione finale ha messo alla gogna la gestione paterna del potere, Mohammed VI non si è scusato, né ha perseguito i responsabili: una scelta che ha lasciato molti con l’amaro in bocca. «L’ennesimo passo sospeso a metà», hanno commentato quelli che alla Commissione si sono opposti. Nulla come la riforma della Mudawana — il codice della famiglia — sintetizza meglio le contraddizioni che ancora circondano il regno del giovane sovrano. Mohammed VI ha imposto ai conservatori la riforma del codice che condannava la moglie a una posizione di assoluta inferiorità rispetto al marito e ne ha festeggiato, due anni fa, l’entrata in vigore. Ma basta mettere il naso dentro un’aula di tribunale a Rabat per toccare con mano i limiti della sua azione. Nadia Oulehri è stata una delle prime a usufruire della nuova legge. Da giuri- Sua altezza reale concentra in sé tutte le contraddizioni del Paese: non è regina ma nemmeno soltanto la “madre dei principi”, non ha incarichi ufficiali ma è attivissima sulla scena pubblica sta ha gioito di fronte alla norma rivoluzionaria che le garantiva uguali diritti rispetto al marito sulla gestione dei figli, lo obbligava al suo e al loro mantenimento e gli toglieva dalle mani l’arma del ripudio. Non appena è stato possibile è stata lei a chiedere il divorzio dall’uomo che per 28 anni l’ha picchiata e tradita, utilizzando la più innovativa delle norme della nuova Mudawana. Oggi a due anni da quel giorno, e a uno da quando la fine del matrimonio è stata sancita, è di nuovo di fronte al giudice, a pretendere che l’ex marito paghi per il mantenimento dei figli. Al suo fianco Zina, 23 anni, studentessa di economia, che appoggia le richieste della madre, e Fassi Fihri Sanaa, la battaglie- La battaglia lenta e sottotraccia di un paese di figlie e spose TAHAR BEN JELLOUN itemi come trattate le vostre donne e vi dirò in che situazione sta il vostro Paese! Questo slogan non è una caricatura. L’esame della condizione della donna in una società è il parametro migliore per valutare i progressi o i ritardi di quella società. L’Europa ci ha messo un bel po’ prima di concedere il voto alle donne (in Francia si è dovuto aspettare il 1945!), e poi ha dovuto affrontare e metabolizzare le lotte femministe degli anni Sessanta, e tutto ciò continua ancora oggi. Con l’eccezione della Tunisia, gli altri paesi del Maghreb hanno un codice della famiglia tra i più retrogradi del mondo arabo e musulmano. Il Marocco, grazie a re Mohammed VI, ha modificato il codice dello statuto personale, migliorando alcuni aspetti riguardanti i diritti della donna. Questa riforma della Mudawana è il risultato di due anni di lavoro di una commissione composta da giuristi ed esponenti della società civile. L’età del matrimonio è fissata a 18 anni per la donna, contro i 15 della legge precedente. La donna marocchina non ha più necessità di un tutore per agire e viaggiare; gli sposi sono corresponsabili della famiglia, sono uguali sotto il profilo dei diritti e dei doveri. Il ripudio — il marito aveva il diritto di mandare via la moglie senza doverle praticamente nulla — non è più possibile o, per essere più precisi, è stato sostituito dal divorzio giudiziario (la donna può chiedere il divorzio). La poligamia — che è rara — è sottomessa a condizioni tali che si può dire sia stata resa impraticabile. In definitiva, è meglio di prima, ma non è ancora la liberazione della donna. Rimane la vita quotidiana e il comportamento dell’uomo in generale. Qui bisogna distinguere fra città e campagna. Nelle campagne, la donna da sempre lavora più dell’uomo. Non porta il velo, si occupa sia dei lavori di casa che di quelli dei campi. L’uomo ha il ruolo da protagonista, prende le decisioni, scende nei suq per vendere il raccolto, dà gli ordini, eccetera. Ma la donna contadina non si lascia mettere i piedi in testa, soprattutto se ha un carattere forte. In città le cose sono leggermente diverse. Il rapporto di forze è variabile. L’uomo lavora e la donna anche. L’uomo fa riferimento alla religione quando vuole giustificare la sua supremazia, spingendosi fino a citare versetti del Corano che interpreta come più gli fa comodo. La nuova Mudawana è stata criticata soprattutto dagli uomini, di tutte le tendenze politiche. Hanno visto minacciato il loro potere, rimesso in discussione il loro ruolo. Le mentalità resistono, perché sono abituate ad avere il diritto dalla loro parte. L’applicazione di nuove leggi, soprattutto per quello che riguarda il divorzio (la custodia dei figli, il calcolo della pensione, il seguito delle decisioni giudiziarie) non è sempre giusta e rigorosa. Il giudice è libero di valutare D Quando un giornale ha però osato rivelare particolari, del tutto innocenti, della sua vita familiare, è subito incappato nei rigori della censura RICCIOLI ROSSI Dall’alto: Sua altezza reale Salma Bennani; una mano decorata con henné; due ragazzine sbirciano da una porta quello che bisogna decidere, la donna non può far altro che sottomettervisi. In realtà tutto dipende dal giudice con cui si capita, ma questo succede ovunque, è una questione di sensibilità o addirittura di ideologia. Il Marocco progredisce lentamente. È obbligato a tenere conto del fatto che più del quaranta per cento dei suoi cittadini sono analfabeti (una gran parte dei quali donne delle campagne), che la gente è sempre più legata alla religione, religione che taluni sfruttano a loro piacimento. Questa riforma non è una rivoluzione, ma un’evoluzione che tiene conto di tutti questi parametri. La Mudawana non è stata dettata dalla shari’a, cioè dal diritto islamico, ma si ispira alla cultura dell’islam. Per questo nella nuova Mudawana gli articoli relativi all’eredità non sono stati modificati. Non si possono toccare, perché provengono direttamente dal Corano (la Sura delle donne): la sposa ha diritto a un ottavo del patrimonio del marito, e la figlia eredita la metà della parte che spetta al figlio. In Marocco, queste regole continuano ad essere applicate, e chissà se qualcuno avrà mai il coraggio di cambiarle, considerando quanto fanno comodo agli uomini, che tengono al loro privilegio. Lo stesso vale per l’adozione. È possibile adottare, ma senza dare al bambino il proprio cognome, in modo da evitare problemi di eredità e di incesto. Il versetto 4 della Sura al-Ahzab (Sura delle fazioni alleate) recita: «Dio non ha fatto […] dei vostri figli adottivi dei veri figli». Lo stesso profeta Maometto aveva adottato un ragazzo chiamato Zayd, uno schiavo affrancato, e lo fece sposare con Zaynab. Quando Zayd ripudiò Zaynab, fu il profeta a sposarla, un modo per dimostrare che il figlio adottato non ha lo stesso status del figlio biologico. Altro problema spinoso: quale status dare ai figli delle ragazze madri? Per la religione e per la tradizione sono dei bastardi, quindi destinati a non essere riconosciuti. Fortunatamente, delle associazioni femminili lottano quotidianamente per trovare delle soluzioni caso per caso a dei bambini che la società non vuole. La società civile è nelle mani delle marocchine. Sono in prima linea e difendono in tutti i modi le sinistrate della vita e dell’amore. Lottano contro la descolarizzazione delle ragazze nelle campagne, contro il lavoro delle ragazzine che fanno le domestiche in città. Tutto quello che si fa di positivo è ispirato da donne che restano nell’ombra. Il re lo sa e ne tiene conto. Ci sono donne (non moltissime) in Parlamento, ce ne sono altre che fanno le ambasciatrici, le ministre o le consigliere. Il Marocco nuovo avanza lentamente. Altrettanto lentamente progredisce la mentalità della gente. Malgrado il suo ostentato dinamismo, il Marocco è diventato un Paese di una certa lentezza. (Traduzione di Fabio Galimberti) DOMENICA 30 LUGLIO 2006 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 31 LA MUDAWANA RIFORMATA Uno degli atti più rivoluzionari del regno di Mohammed VI è stata la riforma del codice della famiglia o Mudawana, che il re ha imposto ai conservatori islamici dall’alto della sua carica di suprema autorità religiosa. Varata a ottobre del 2003, entrata in vigore qualche mese dopo, la nuova Mudawana rende più difficile per il marito ripudiare la moglie o prenderne più di una. Lo sposo inoltre è obbligato a provvedere al mantenimento della consorte e dei figli La legge rende più facile per le donne chiedere il divorzio e innalza da quindici a diciotto anni l’età necessaria perché una ragazza possa prendere marito È anche previsto che uomini e donne abbiano la stessa autorità in famiglia e che anche le madri possano ottenere la custodia dei figli TRADIZIONE Due donne musulmane sono a passeggio e indossano il tradizionale chador nikab nei colori blu e azzurro L’abito lascia scoperti solo gli occhi ra avvocatessa che la rappresenta. A turno le tre donne si rivolgono al giudice mentre il pubblico le ascolta in silenzio: donne e bambini da una parte, uomini dall’altra. L’aula è affollata, soprattutto la metà femminile: donne in attesa dell’udienza di divorzio, che seguono con attenzione lo strano terzetto: Nadia indossa un velo bianco e nero, in tono con le scarpe e la borsa; Fassi agita la manica della lunga tunica nera da avvocato quando parla; Zina, a capo scoperto, è la più tranquilla. La loro storia attira l’attenzione delle donne, che improvvisamente comprendono che anche quando il giudice sancirà la fine del matrimonio i problemi non scompariranno. Alla fine il dibattimento viene rimandato: «È ingiusto — sbotta Nadia quando esce dall’aula — la legge c’è, ma i giudici rifiutano di applicarla. E nessuno dice loro nulla». E il re? «Il re lascia che le riforme marciscano sulla carta». «È una storia come tante altre», dice Rabea Naciri. Capelli ricci, aria dura, è la presidentessa dell’Associazione donne democratiche del Marocco (Adfm): «La legge c’è ma il suo impatto reale è ancora tutto da valutare: non c’è assistenza sociale per le donne abbandonate dal marito, i giudici non applicano le norme. In Marocco negli ultimi anni c’è stata un’evoluzione democratica, ma non siamo ancora uno Stato di diritto. Troppe cose sono ancora in sospeso». In cima alla lista di Rabea c’è la nuova legge sulla cittadinanza, che consentirebbe alle madri di trasmettere la nazionalità marocchina ai figli, diritto che finora spetta solo al padre. Il re si è impegnato per promuovere la riforma, eppure finora nulla si è mosso: l’Adfm ha inviato un memorandum al governo, ma nessuno ha risposto. Perché non chiedere l’appoggio di Lalla Salma? Rabea lancia uno sguardo di sufficienza, e torna a concentrarsi sulle sue carte. Il fatto è che Sua altezza reale per la vita pratica dei suoi sudditi fa poco o nulla: presiede un’associazione contro il cancro e poche settimane fa è stata nominata ambasciatrice dell’Organizzazione mondiale della sanità sul tema. Accompagna il marito alle cerimonie ufficiali e nei viaggi. In qualche occasione ha rappresentato il suo Paese all’estero. Tutti sanno che è una delle menti dietro all’Iniziativa nazionale per lo sviluppo umano, il piano con cui Mohammed VI punta a costruire scuole e ospedali per i tre milioni di persone che vivono nelle baraccopoli e nelle zone rurali. Ma a Rabat o Marrakech di questioni come questa, dei cinque milioni di marocchini che vivono in povertà o dei tredici milioni di analfabeti (su una popolazione di 30 milioni), non la si è mai vista parlare in pubblico. Lalla Salma è una speranza, un simbolo: non un riferimento reale. Talvolta ai sudditi appare come un’icona lontana: i servizi fotografici che la ritraggono sono appannaggio delle riviste spagnole o francesi, mai di quelle marocchine. Il settimanale di Rabat che ha osato parlare di lei come fanno le riviste dell’altra sponda del Mediterraneo ha pagato caro l’azzardo: il direttore di Al Jarida al-Oukhra si è visto recapitare una lettera di censura da parte del ministro del Protocollo, custode della privacy e della sacralità della famiglia reale. «Vi siete spinti troppo oltre», recitava. Fra gli eccessi segnalati, l’aver rivelato che il piatto preferito di Sua altezza reale è la tajine alle carote, che la principessa ama la moda straniera, che spesso è lei stessa a dare da mangiare al figlio, che le capita di pranzare seduta al tavolo dei suoi collaboratori. E — scandalo supremo — che Lalla Salma ama camminare scalza nei corridoi dei palazzi reali dove vive. La censura ha creato un caso in Marocco, ma Sua altezza reale non ha dato segno di curarsene. Il tam tam di palazzo la dà concentrata nell’educazione del piccolo Sidi Moulay Hassan. Spetterà a lui, forse, portare a termine il processo di modernizzazione iniziato da Mohammed VI. Un futuro ancora lontano, in cui una cosa però appare certa: nessuna principessa marocchina potrà più scomparire dietro le mura di un Palazzo. Nei suoi quattro anni a corte la sua rivoluzione personale Salma Bennani l’ha già consegnata alla storia. 32 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 30 LUGLIO 2006 la memoria Tragedie operaie Accadde l’8 agosto 1956: un banale incidente dà fuoco al Bois du Cazier, miniera del bacino carbonifero di Charleroi in Belgio, ed è l’inferno. Muoiono 262 minatori, 136 sono italiani e la metà vengono dal paesino abruzzese di Manoppello Cinquant’anni dopo siamo tornati a Manoppello per ricordare Marcinelle, gli orfani del “lavoro sotterraneo” LEONARDO COEN Repubblica Nazionale 32 30/07/2006 S MANOPPELLO tavolta Geremia Iezzi non ha voglia di raccontare. Di dire come è scampato alla tragedia, e come invece i fratelli Rocco e Camillo sono morti asfissiati, inseguiti dalle fiamme, nel pozzo della miniera di Marcinelle, al Bois du Cazier, quel maledetto mattino dell’8 agosto 1956. Non ha nemmeno voglia di rievocare la disperazione, la sofferenza e il dolore della sua famiglia, che poi era il dolore di un’Italia disperata, avvilita. La tv belga voleva intervistarlo: «Lo faccia per i giovani di oggi, che devono il loro benessere ai vostri sacrifici, è quasi un dovere il suo. Il dovere della memoria». Che paroloni. Ha scosso la testa, Geremia. Metà delle 136 vittime italiane di Marcinelle erano abruzzesi. Un Abruzzo ben diverso da quello ricco di oggi. C’era una fame da non finire. Ventidue minatori venivano da Manoppello. Dieci da Lettomanoppello che sta a cinque chilometri e otto da Turrivalignano, che è ancor più vicino. Da queste parti — Pescara è a trenta chilometri, Chieti la metà e l’autostrada a un tiro di schioppo — c’era campagna povera, e povera era anche la pastorizia, la gente per sopravvivere s’arrangiava. Lettomanoppello era chiamato il paese degli scalpellini, abilissimi artigiani che plasmavano la pietra nera e bianca della Maiella. C’erano le miniere d’asfalto della Valle Romana e le cave. Ma il dopoguerra aveva seppellito questo mestiere e riempito la vita di stenti. Gli uomini emigravano in America, in Australia, in Francia. E in Belgio. «No, non me la sento più di ripetere sempre le stesse cose — ha risposto ai belgi il signor Iezzi — mi fa troppo male, ormai, ricordare. E poi sono offeso. Hanno invitato le vedove alla cerimonia di Marcinelle. Con le vedove ci andranno i parenti. Io no. Mi hanno messo da parte. Eppure ho perso due fratelli. Potevo esserci anch’io, con loro. Rocco, il più giovane, mi aveva chiesto di cambiar turno, per stare insieme almeno una volta. Ma la mia futura moglie, una ragazza belga, aveva un piccolo negozio di frutta e verdura, mi aveva pregato di andare ai mercati generali quel mattino. Mi salvai così. Per puro caso. Rocco stava per compiere ventun anni. Camillo andava per i ventisei. Io ero il fratello di mezzo. Se volevamo metter su famiglia dovevamo trovar lavoro. Qui non c’era. Siamo saliti sul treno diretto a Milano». Milano, già. A piazza Sant’Ambrogio c’era il Centro di emigrazione. La Federazione carbonifera belga reclutava «operai italiani» per il «lavoro sotterraneo» nelle miniere di carbone. Da Milano al Belgio, il viaggio «dura solo 18 ore», si leggeva sul manifesto rosa affisso in ogni comune d’Italia. Elencava i salari giornalieri «di ogni categoria di lavoratori di fondo miniera». Chi apparteneva al gruppo X (10) avrebbe guadagnato 315,95 franchi belgi, ossia 3.949 lire. Quelli classificati manovali semplici si sarebbero dovuti accontentare di 2.451 lire. A lato, altre promesse: «Assenze giustificate per motivi di famiglia». «Carbone gratuito». «Biglietti ferroviari gratuiti». «Premio di natalità». «Ferie»: ordinarie, complementari. E ancora: vitto e alloggio «presso la cantina della miniera, al massimo 55 franchi belgi al giorno». Contratto annuale. Per convincere gli uomini già sposati, in fondo al manifesto c’era scritto in neretto: «Compiute le semplici formalità d’uso, la vostra famiglia potrà raggiungervi in Belgio». «Mio padre scoprì subito che la realtà era tutt’altra», racconta Giuseppe Pompilio Di Donato, assessore alla Cultura di Manop- pello. Suo padre Santino era emigrato nel 1953, con la moglie Lucia: «Per cercare un futuro». Aveva 25 anni. Era contadino ma la campagna non bastava a tirare avanti. Giuseppe nasce nel febbraio del ‘54, a Marcinelle. Diventerà orfano a due anni. Di suo padre non ricorda nulla. Si è imposto di onorarlo e di onorare tutti gli altri sventurati compagni di miniera. Certe volte, basta un nome. Una strada. A Marcinelle esiste una via che si chiama Manoppello. O una piazza. A Manoppello, la piazzetta dei Portici è diventata piazza Marcinelle. In mezzo, un monumento importante, firmato Cascella (costato 300 milioni). Più due lapidi. Una, dei sindacati. L’altra ha 262 stelline: ognuna simbolizza la vita perduta dei 262 minatori periti nell’incidente. «Oggi si sta bene. C’è lavoro. Non manca nulla». Tanto per dire, a Lettomanoppello, tremila abitanti, ci sono dodici bar e sette ristoranti. A Manoppello gli abitanti sono il doppio e continuano ad aumentare perché giù a fondo valle si sta allargando la zona industriale. Se lo sognavano, i centocinquanta dei tre paesi che finirono a Marcinelle. Che si erano fatti illudere dalle promesse di un manifesto rosa, pensando che sarebbe stata rosa la vita da quel momento in poi. Macché: «Le condizioni di lavoro erano durissime. L’alloggio, spesso, in baracche di ex internati», sottolinea l’assessore Di Donato. Quelle di Marcinelle avevano accolto — si fa per dire — i prigionieri di guerra tedeschi e prima ancora quelli russi. Il lavoro era pericoloso, le condizioni di sicurezza minime: dal 1946 al 1963 sarebbero morti 867 italiani nelle miniere belghe. Chi voleva guadagnare di più poteva farlo optando per l’estrazione e l’avanzamento della galleria, lì la paga era a cottimo, tanti metri si facevano tanto si guadagnava. Per frantumare la roccia si usava l’esplosivo. I detriti dovevano essere sgomberati velocemente in modo da armare subito la galleria. La maschera in dotazione per filtrare la polvere di carbone serviva a ben poco: si intasava quasi subito, e faceva sudare moltissimo. Per diminuire gli effetti devastanti della polvere, tutti ciccavano continuamente tabacco. «Di questo, della silicosi che uccideva, che rendeva impotenti, che consumava la vita non c’era traccia, nel manifesto rosa», ricorda Nino Domenico Di Pietrantonio, presidente dell’associazione Minatori-Vittime Bois du Cazier (sede a Lettomanop- “Io avevo nove anni, mio padre trentanove Ricordo tutto di quel giorno: il fumo che si levava dal pozzo, le sirene, i gendarmi, le grida, l’odore della morte Poi tornai al paese, le stesse donne vestite di nero, le stesse case diroccate” IL DOLORE Immagini della tragedia al Bois du Cazier: il fumo dalla miniera, i soccorsi, e la foto di una famiglia italiana. Nella pagina anche due messaggi di solidarietà: una lettera di lavoratori italiani in Germania e un telegramma dell’Udi pello) e figlio di Emidio che morì nel pozzo Saint Charles: «Io avevo quasi nove anni, lui 39. Ricordo tutto di quel giorno. Il fumo che si levava dalla miniera, le sirene, i gendarmi, le grida, la confusione, l’angoscia, l’odore della morte». Da anni Di Pietrantonio persegue uno scopo: ristabilire la verità sulla dinamica dell’incidente. Sei anni fa incontrò a Toronto Antonio Iannetta, l’ex minatore ritenuto, sia pure accidentalmente, il responsabile della tragedia: «Ammise l’errore. Mi disse di aver ottenuto una bella casa, e una sorta di vitalizio». Iannetta nel frattempo è sparito. La casa dove viveva, demolita. Spariti anche i figli e i nipoti, così asserisce Di Pietrantonio. Mistero fitto. Non è invece sparita dalla mente l’immagine del ritorno a casa: «Le stesse case diroccate. La stessa frana di quando ero partito. Le stesse donne vestite di nero, sdentate, precocemente invecchiate, sfiancate dalla fatica dei lavori da uomo. Io mi sentivo diverso, ormai. Il Belgio mi aveva dato uno schiaffo, mi aveva tolto papà, però mi aveva dato anche una carezza: una cultura, una mentalità più aperta e moderna, un modo di vedere le cose diversamente». Successe lo stesso a gran parte di quelli che tornarono. Sapevano che ora la miniera era lì, a cielo aperto. Erano i loro paesi. I documenti nella pagina sono tratti dall’archivio storico Cgil, serie Atti e corrispondenze 1956, Emigrazione DOMENICA 30 LUGLIO 2006 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 33 LA STORIA LA MINIERA IL DISASTRO LE VITTIME IL PROCESSO Dallo sfruttamento del giacimento di Marcinelle, Le Bois du Cazier, ogni anno venivano prodotte 170mila tonnellate di carbone I minatori che lavoravano nel bacino carbonifero di Charleroi erano 25mila Alle 8,10 dell’8 agosto 1956 il fumo si alza dalla miniera. Il pozzo Saint Charles a 975 metri di profondità brucia Il disastro è provocato da un ascensore chiamato per errore e da un carrello che resta incastrato I soccorsi sono disperati Il 23 agosto uno dei soccorritori esclama: “Tutti morti”. Intrappolati tra i 975 e i 1.035 metri rimangono 262 uomini di 12 nazionalità diverse, fra questi 136 italiani Solo sei i superstiti L’inchiesta sulla sciagura dura trenta mesi Il processo si apre nel 1959 a Charleroi Nel 1961 la Corte d’appello di Bruxelles condanna a sei mesi un ingegnere delle miniere, chiudendo così la vicenda Così gli emigranti pagavano il conto all’Italia del boom GIORGIO BOCCA ra l’8 agosto del ‘56 e in una miniera di carbone di Charleroi, al Bois du Cazier di Marcinelle, in un incendio morivano 262 minatori, 136 dei quali italiani, abruzzesi e calabresi della Sila, gente di San Giovanni in Fiore, Castelsilano, Rocca Bernarda e dell’intero marchesato di Crotone. Una parte dei centoquarantamila emigrati in Belgio di quegli anni, una parte del prezzo che gli italiani poveri pagavano alla ricostruzione, al “miracolo”, una parte del buon affare che il governo italiano aveva fatto con quello belga. Ogni anno migliaia di disoccupati nostri mandati a lavorare nelle miniere di Charleroi, lavoro italiano in cambio di carbone a basso costo per le industrie del triangolo Torino-Genova-Milano, la nostra locomotiva. Lavoro pesante, avvertiva un minatore, lavoro ingrato. «Perché è cusì, alla miniera nunn’è cosa facile, è cosa difficilissima. Tocca aprì gli occhi alla miniera, se no nun ci vai». Ma tocca andarci, la povertà è grande nell’Italia del miracolo, bisogna lasciare le montagne luminose e profumate della Sila del Bruzio e venire a vivere in questo paese straniero e ostile, la Vallonia: in superficie i villaggi operai con le casette eguali dove tutti si riscaldano con il carbone della miniera, dove tutti campano faticando nelle viscere della terra, dove le donne sono vestite di nero quasi in attesa di un lutto, dove la terra è perforata da chilometri di cunicoli a volte non più alti di mezzo metro, dove si respira gas e si vive nel terrore che il gas si incendi. Il patto che il governo italiano ha fatto con quello belga è del tipo schiavistico: nessuna garanzia per la sicurezza del lavoro, nessuna assicurazione seria sulla salute, sugli incidenti, sulla vecchiaia. Un gregge da sfruttare, ma avercene in quel dopoguerra di patti così. Sembrava anzi di aver trovato una fortuna, al principio dell’estate il popolo rimesso in carne della emigrazione tornava in Italia sulle Fiat scassate di seconda e terza mano, macchine cariche di gente felice di conoscere una vacanza. Fra questa gente che restava legata alle sue origini si è celebrato per decenni il rito della Vallonia amica e memore che si schierava lungo le strade per vedere i Magni, i Bartali, i nostri ciclisti famosi, quel vento di paese che passava fra un frusciar di ruote, la LiegiBastogne-Liegi, la Freccia Vallone e le altre classiche sul terribile pavé lucido fra i bistrot con le baguette morbide e il casse-croûte. La cronaca della catastrofe è breve e disperata, si apre e si chiude con l’annuncio del primo dei soccorritori che riemerge da un pozzo: «Tutti cadaveri». Anche quelli che hanno scritto su una tavola di legno: «Fuggiamo davanti al fumo. Siamo una cinquantina, ci dirigiamo verso lo snodo 26». Anche loro, il fumo dell’incendio e il gas li hanno fermati a pochi passi dal pozzo di soccorso. Ci sarà naturalmente una inchiesta governativa sulla catastrofe da cui non risulteranno colpe della proprietà della miniera. Neppure quella di non aver fornito ai minatori le maschere antigas, ma non è lo stesso risparmio che noi abbiamo fatto nelle miniere del Sulcis o della Valle d’Aosta? L’unico colpevole del disastro, secondo la commissione di inchiesta, è l’operaio che stava di manovra all’ascensore del pozzo uno: quello dove è scoppiato l’incendio. Il fatale incidente avviene a livello meno 975. Due vagoncini pieni di carbone vengono caricati sulla gabbia-ascensore. Il primo è bloccato da un carrello incastrato. La gabbia si mette in moto e li trascina, così che una putrella che sporge da un vagoncino trancia dei fili telefonici e due cavi elettrici ad alta tensione. Vengono tranciate anche la condotta dell’olio e dell’aria compressa, gli archi elettrici appiccano il fuoco all’olio e alle parti in legno del pozzo. Alimentato dall’aria compressa e dalla ventilazione, l’incendio di inaudita violenza si estende a tutta la miniera: un incidente di carico si è trasformato in un disastro. A meno di un’ora dallo scoppio dell’incendio ogni contatto fra il fondo della miniera e la superficie è divenuto impossibile. Sotto l’azione del calore i cavi di estrazione si spezzano, le gabbie degli ascensori restano bloccate, la trappola infernale si è chiusa. Quando si sarà riaperto un ascensore e si tenterà di scendere in miniera, ci si fermerà a quota centosettanta dove un tappo di fumi stagnanti blocca l’operazione. Sei minatori vivi vengono trovati dalle squadre di soccorso: tre si sono riparati sotto un vagoncino; altri tre vengono trovati in una galleria per il riflusso dell’aria. Una folla di parenti si è riunita davanti alla miniera, una folla di donne vestite di nero. Una ragazza in stato di gravidanza viene schiacciata dalla ressa contro il recinto degli ingressi. Marcinelle segna la fine della tragica vicenda mineraria in Europa. L’estrazione del carbone diminuirà fino a finire completamente nel 1993. Nei giardini di Marcinelle è stato inaugurato il monumento ai caduti di Manoppello, il comune abruzzese che ha avuto il maggior numero di morti. La miniera di Cazier è chiusa dal 1967. Ormai è un monumento «permanente a ricordo dei minatori». La sera dell’8 agosto prossimo vi sarà scoperta una targa commemorativa e si pregherà, di nuovo, per le vittime. Chi ha avuto ha avuto, chi è morto è morto. FOTO PUBLIFOTO - OLYCOM Repubblica Nazionale 33 30/07/2006 E DOMENICA 30 LUGLIO 2006 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 35 le storie Mestieri aristocratici Alduino Ventimiglia di Monteforte Lascaris, nobile siciliano imparentato con Federico II, si dedica in un castello toscano all’antica e sofisticata arte dell’addestramento dei falchi alla caccia “Loro non ti riconosceranno mai come padrone”, dice “Bisogna fargli credere che sono loro a usare noi” Il principe falconiere che nel volo dei rapaci fa rivivere il passato quell’imperatore che sui falchi scrisse De arte venandi cum avibus, un trattato che ancora ai giorni nostri rappresenta LURIANO un’opera ornitologica di valore e un testo sacro per l’addestramento dei rapan picchiata Hikmett, il predatore che porci e che si può trovare in libreria (Laterta il nome di un emiro, è un puntino nero za, 1.444 pagine, 83 euro). nel cielo. Precipita, si avvita su se stesso e La falconeria non è mai stata solo una scompare nell’aria rarefatta. È veloce, caccia da carniere ma una caccia per risempre più veloce. Sfiora i quattrocento chilovelare la capacità del cervello umano di metri l’ora quando, con l’ultimo sussulto, si avcomandare, un’esibizione di forza che venta sulla sua anatra. Va a caccia sopra le cime era anche di grande efficacia mediatica. dei cerri e dei lecci che coprono le colline toscaSi faceva davanti a tutti, si dimostrava a ne intorno a Siena. Tra i boschi scorre un torrentutti quanto si era potenti. Le sue origini si te, c’è una grande casa sul picco più alto. Hikmett perdono nella preistoria. Veniva praticae tutti gli altri abitano qui. «E qui siamo in cima al ta in Cina e in Mongolia già nel mondo», dice Alduino Ventimiglia 2000 avanti Cristo; addestradi Monteforte Lascaris, un siciliano vano rapaci le tribù nomadi successore della dinastia normanna dell’Arabia prima di che ci presenta i suoi amici. Uno è Maometto; in Europroprio Hikmett, poi c’è Arbalat, un pa si è diffusa in altro è Firusè, c’è Odalisca, in fondo Grecia e poi semfa capolino anche Sham. Sono in fila pre più su, fino su una pertica bassa, tutti con un in Germania. cappuccio di cuoio in testa che copre Il principe sii loro occhi, tutti che aspettano per ciliano fa un po’ alzarsi un’altra volta in volo. di conti. FederiSono i cento falchi del principe. co II, incoronato Una sua antenata, Emma, sposò un re nel 1208 a quatfiglio dell’imperatore Federico II. IMPERATORE tordici anni, di falchi Poi uno dei rami dei Ventimiglia si Federico II, l’imperatore ne aveva duecento. Lui, divise la Sicilia fino all’Unità d’Italia. che possedeva che di anni ne ha cinquanta, li ha co«La falconeria ce l’abbiamo in famiduecento falchi minciati ad allevare un quarto di seglia da più di mille anni», racconta il colo fa sulle Madonie, le grandi monnobile Alduino nel castello di Luriatagne della Sicilia. Dopo una laurea in agraria a no, un tempo antica dogana senese e oggi proCatania, dopo l’avventura dei fiori nelle serre del prietà del casato dei Chigi. Per arrivare quassù Ragusano, dopo il servizio militare al Centro alleabbiamo attraversato la campagna selvatica tra vamento e rifornimento quadrupedi di Grosseto le province di Grosseto e Siena, ci siamo arram— i cavalli, altra attrazione fatale per Alduino — picati lungo uno sterrato che finisce dove c’è un prato e dove ci sono loro. Immobili sui trespoli, i becchi adunchi, le zampe grigioblu dei più giovani e quelle gialle degli adulti, gli artigli aguzzi, la livrea color ardesia. Sono lì, pronti a sollevarsi ancora e avvistare la prossima preda. Arrivano dagli allevamenti della Germania o della Norvegia e nelle voliere di Luriano vengono nutriti, curati, coccolati. Mangiano la loro razione quotidiana di piccioni e il principe li addestra per mesi, a volte per anni. «È un lavoro infinito farli crescere in cattività e soprattutto prepararli, è sufficiente un movimento brusco o una decisione sbagliata e si deve ricominciare tutto daccapo», spiega il falconiere mentre si infila il tradizionale guanto per far accomodare sul suo braccio uno dei rapaci. È un rapporto ad incastro, quello tra il falco e l’uomo. Lo descrive così Alduino: «Lui non ti riconoscerà mai come padrone, non si sentirà mai sottomesso ma al massimo amico. Bisogna far credere al falco che noi siamo usati da lui e non il contrario, è una relazione dove nessuno dei due può perdere la propria identità, comunque c’è un momento preciso dove entrambi capiamo che finalmente si è raggiunto un legame di fiducia e di amicizia». E dopo la fatica e il piacere di scoprirsi uno con l’altro, in mezzo alle valli si trasformano in un’arma da guerra. Pesano poco meno o poco più di un chilo, l’apertura delle loro ali va da ottantacinque a centodieci centimetri, attaccano anche le gru che sono quattro o cinque volte più grosse e con un calcio possono spezzarli in due. Ce ne sono di tre specie nella tenuta di Luriano. I falchi lanario che sono i più piccoli, i girifalchi quelli più grossi, i falchi pellegrini che sono i più veloci e cacciano solo in volo. «Nel medioevo avere in mano un animale selvatico e così temibile era una prova di potere: chi governava un falco poteva governare il mondo», ricorda il discendente di ATTILIO BOLZONI FOTO CORBIS Repubblica Nazionale 35 30/07/2006 I Gli esemplari più pregiati fatti crescere in Europa vengono venduti a Dubai e ad Abu Dhabi. Possono arrivare a valere anche centomila euro il falconiere venuto dal sud si è accampato in questo angolo di Toscana fondando l’“Accademia italiana cavalieri di alto volo”. Prima i cavalli. Ricerche di anni e anni per individuare quelli dell’antica razza di Persano, selezionata proprio da Federico II, l’unica italiana riconosciuta a livello internazionale. E poi i falchi. Ricostruisce il suo arrivo nella tenuta di Luriano: «L’antica razza di Persano fu scelta per la guerra e per la falconeria, il rapace incute paura al cavallo e quindi il quadrupede deve avere caratteristiche particolari, ecco perché qui alleviamo anche quei cavalli». Ma anche il falco ha le sue paure. È terrorizzato dall’uomo. «Specialmente dalla sua faccia, credo che la veda orribile», spiega Alduino Ventimiglia di Monteforte Lascaris. Per quella paura una volta lo tranquillizzavano chiudendogli gli occhi, “cigliandolo”, cucendo le due palpebre inferiori. Piano piano si aprivano e il falco ricominciava a vedere. Il cappuccio lo inventarono gli arabi, in Europa lo importò uno straordinario naturalista-scienziato-falconiere, il solito Federico II. Vicino alle stalle di Luriano c’è una grande voliera. E dietro i caseggiati quelle più piccole dove fanno crescere i falchi. Ci vogliono almeno quarantacinque giorni perché prendano il volo. Dai paesi del nord arrivano quasi tutti dai “laboratori”, incroci con l’inseminazione artificiale, ibridi per farli resistere in un altro mondo. Dai freddi e dai ghiacci scandinavi fino ai bollori delle terre mediorientali. È laggiù, a Dubai e ad Abu Dhabi, che vanno a finire gli esemplari più pregiati addestrati in Europa. Li usano soprattutto per la caccia all’ubara, una gallina delle zone desertiche. È un mercato da milioni e milioni di dollari. «Gli esemplari migliori possono arrivare a valere anche 100mila euro», assicura il principe. Il costo medio dei girifalchi va dai 10 ai 20mila euro, per allevarli ce ne vogliono circa millecinquecento, l’addestramento è sudore e tecnica e passione che non ha prezzo. Alduino guarda i suoi rapaci e sospira: «Loro ti aiutano a non pensare da terra ma ti fanno pensare dall’alto, l’arte della falconeria è quella di mettere il piccolo falco contro un animale più forte e combatterlo con intelligenza e coraggio». In combattimento le femmine sono più affidabili dei maschi. Sono meno imprevedibili in cielo. Sono loro che cacciano sopra il fiume Merse, che si lanciano dal picco più alto tra Chiusdino e Luriano per inseguire cornacchie e fagiani. «In quel momento si crea un senso tale di stupore e di riconciliazione con la natura che ti fa sentire vivo, che ti fa sentire incredibilmente vicino a Dio», sussurra il principe dei falchi. È ora di farli alzare. Cerca la direzione del vento, calcola la sua posizione e quella degli altri animali che stanno intorno, misura le distanza dal ruscello e dagli alberi. E comincia a pensare. Il principe comincia a pensare cosa farà il suo falco in quel momento. E un attimo dopo. 36 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 30 LUGLIO 2006 i luoghi Scatti d’autore Nel buio di una sala-moviola arriva una telefonata: “Venga a fotografare Novij Urengoi, una città nella tundra siberiana che non sta neanche sulle mappe...”. E per il regista premiato con l’Oscar comincia un’avventura che è anche un viaggio a ritroso nel tempo e che adesso sta per diventare una mostra al Tuscan Sun Festival di Cortona Tornatore fotoreporter nel Repubblica Nazionale 36 30/07/2006 GIUSEPPE TORNATORE opo mesi e mesi vissuti in una moviola, al buio, con gli occhi eternamente puntati a vedere, rivedere, rivedere, rivedere e ancora rivedere sempre le stesse immagini, a un regista accade fatalmente di smarrirsi nelle viscere della storia che sta raccontando, di non percepirne i contorni, addirittura di non riuscire più a “vederla”. Un sognatore perso in un sogno insognabile. E senza apparente promessa di risveglio. Ero in questo limbo dell’immaginazione, quando un bel giorno, inaspettatamente, una voce nordica e gentile giunge a insinuarsi come una nota stonata nel quotidiano coro telefonico: «So che da ragazzo lei è stato un fotografo. Se la sentirebbe di tornare a fare fotografie?». Freno la corsa della moviola, spengo la proiezione, già pronto a urlare: «Magari!». Molto più discretamente chiedo di che cosa si tratta. «Dovrebbe venire in Siberia — replica la voce — a fotografare una città di centomila abitanti che appena diciotto anni fa non esisteva neppure, e ancora adesso non è disegnata neanche sulla carta geografica. Si chiama Novij Urengoi». Ora, non è che la parola “Siberia” in genere faccia pensare a qualcosa di concreto, di preciso e di palpabile, e men che meno l’impronunciabile nome di quella sconosciutissima città, ma in quel momento a me evocarono la solidità di una lima di ferro nascosta dentro la pagnotta impavidamente inviata al carcerato. Pochi mesi dopo, durante il complicato viaggio per Novij Urengoi, l’eccitazione non era svanita per nulla. Anzi. Mi sembrava un viaggio a ritroso nel tem- D “Io dai 9 ai 25 anni ho usato la fotocamera tutti i giorni: la mettevo in spalla come ai piedi mettevo le scarpe. Una stagione della vita spesa a rubare immagini” po, verso quella stagione della mia vita spesa ad andare in giro a rubare immagini con la mia indimenticata Rolleicord. Anni di pedinamenti e appostamenti, anni che mi hanno insegnato a osservare la gente, a studiarne le espressioni e i movimenti, sino a prevenirne quasi le azioni, sino all’illusione di condizionarne il comportamento. Anni in cui ho scoperto che se fotografi uno sconosciuto, nell’istante stesso in cui fai scattare l’otturatore, quella persona smette di esserti estranea, perché la porterai sempre con te. Ecco, andare per le strade di Novij Urengoi, intrufolarsi nelle case, nei mercati, negli ospedali, negli uffici, nei negozi, nelle fabbriche, nelle scuole, inseguendo sorrisi e stupori, frugando proporzioni e geometrie, non è stata per me una fuga verso un mondo che non conoscevo, al contrario, un ritornare a un paese perduto di cui, in qualche maniera, sapevo già tutto e di cui, per mezzo della macchina fotografica, mi sarei finalmente riappropriato. Oggi mi capita spesso di pensare a quella città quasi metafisica, circondata dal grande nulla della tundra, ed è il non poter continuare a fotografarla, l’esserne lontano, la distanza, che me la restituisce in tutta la sua estraneità. Ma rivedo i volti misteriosi e gentili dei suoi abitanti, e mi sorprendo a fantasticare su cosa stiano facendo nel momento stesso in cui mi ritornano in mente. L’anziana donna a una fermata d’autobus con le spalle disinvoltamente rivolte all’infinito deserto di neve. Lo scultore poverissimo che si ostinava a non vendere le sue opere. La signora che dormiva sulla corriera diretta alla stazione da cui avrebbe raggiunto Mosca in tre giorni di treno. Il giovane chiuso nella cabina telefonica del centralino pubblico che parlava animatamente e voltava le spalle per non farsi leggere in volto. La bellissima ragazza che vendeva aglio all’ingresso di un supermercato. I bambini che suonavano all’impazzata le campane della chiesa. I nomadi oltre il circolo polare artico, che vivono oggi come i loro antenati qualche secolo fa. È stata una meravigliosa distrazione che mi ha restituito quel risveglio ne- DOMENICA 30 LUGLIO 2006 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 37 VITA QUOTIDIANA Nelle pagine: scene di vita quotidiana a Novij Urengoi, città di 100mila abitanti in Siberia Il centro, nato negli ultimi vent’anni, non è segnato sulle carte geografiche In una delle immagini a fondo pagina, Giuseppe Tornatore con la sua fotocamera Repubblica Nazionale 37 30/07/2006 grande nulla della Siberia cessario a riconquistare i confini delle storie che amo raccontare. Se oggi mi capitasse di nuovo accetterei di corsa, partirei subito per la Siberia, magari anche con la cinepresa. È un luogo che esercita un’attrazione fortissima su un fotografo, un luogo in cui le proporzioni tra figura umana e paesaggio sono così estreme da rendere molto accattivante la ricerca visiva, la composizione delle immagini: questa vastità infinita in cui la figura umana si perde. Oggi, che in qualche modo a Cortona, al Festival del Sole, si stringe il rapporto tra le immagini e la musica, mi scopro sempre più convinto che il linguaggio più affine all’inesprimibile è proprio la musica, l’unico che suggerisce quelle sensazioni assolute, indefinibili, estremamente profonde, di spazi così aperti, incommensurabili. Spazi in cui l’attesa, la noia anche, il silenzio, sembrano essere la dimensione più familiare, consueta. Questo tempo dell’attesa, prima che il gesto si compia, è il tempo della fotografia, il suo spirito. Con la fotografia ho imparato ad attendere che la figura umana compisse un gesto, ho imparato ad osservare l’uomo, a studiarne le mosse, talvolta a prevederne le azioni, a inseguirle, in un certo senso a provocarle. Il “pedinamento zavattiniano”, per esempio, l’ho sperimentato in maniera del tutto naturale e naïf con la fotografia prima d’avere studiato Zavattini. C’è un attimo in cui speri che la figura che hai “inseguito”, il tuo personaggio, faccia qualcosa. E talvolta accade. Anche perché la fotografia, a differenza del cinema, è semplice, agile: è libertà espressiva. In Siberia per esempio ero da solo, non ho voluto neanche un assistente, talmente ero attratto dall’idea di “fare un film” con la macchina fotografica, riuscendo a cogliere immagini con estrema immediatezza. Cosa impossibile con la cinepresa, con la quale devi sapere prima quello che vuoi riprendere. La fotografia, invece, ti lascia il piacere della sorpresa nel cogliere la microdrammaturgia del quotidiano. La fotografia è una grande palestra: io, dai nove ai venticinque anni, ho usato la macchina fotografica tutti i giorni: la mettevo in spalla ogni mattina come ESPOSIZIONE E CONCERTI A CORTONA La mostra fotografica “Giuseppe Tornatore, fotografo in Siberia” (300 scatti in bianco e nero) è in programma dal 5 al 20 agosto al Palazzo Casali di Cortona, Arezzo L’esposizione del regista siciliano viene presentata nell’ambito del Tuscan Sun Festival, rassegna internazionale di musica classica e cultura, che vede in cartellone, tra l’altro, il concerto della soprano russa Anna Netrebko e del baritono siberiano Dmitri Hvorostovsky (sul palco l’11 e il 16 agosto) Ad accompagnarli il direttore artistico del Festival Nina Kotova, musiche di Chajkovskij. L’appuntamento con la Siberia prosegue il 12 agosto alle 11 a Palazzo Casali con “Un’ora in Siberia”. Una conversazione tra Tornatore e Hvorostovsky ai piedi mettevo le scarpe. La portavo a scuola, oppure quando uscivo con gli amici. Era sempre con me. La mia prima macchina fu il regalo che chiesi finita la quinta elementare: mi ero messo da parte un po’ di soldi, mancavano quarantamila lire, una somma impossibile per me, ci pensò mio padre. Ultimamente più che altro è uno strumento di ricerca durante i sopralluoghi, mi aiuta a fissare le atmosfere ambientali, le foto sono dei suggerimenti per il mio scenografo. Poi ogni tanto ritrovo tutto il gusto di quando ero bambino: in viaggio è il mio taccuino di appunti. In famiglia torna ad essere la mia quotidianità: amo fotografare soprattutto mia figlia. Come per la foto anche l’incontro con la musica classica è avvenuto quando avevo sei, sette anni. Amo tantissimo la musica, non scrivo se non ascoltando musica, la concentrazione necessaria viene dalla magia che la musica mi trasmette. Ma a Cortona, per il Tuscan Sun Festival, sarò semplicemente uno spettatore. Non vedo l’ora di farmi catturare da questa notte di grande musica russa, con il concerto di Anna Netrebko e l’Orchestra Russa. Negli ultimi anni ho riascoltato e studiato moltissimo Shostakovich che mi regala emozioni molto forti. Su Rachmaninov mi era stato addirittura proposto di fare un film. La notte dell’11 agosto, quando ci saranno solo musicisti e cantanti russi, credo che mi intrigherà molto cogliere nelle voci le tracce dei luoghi d’origine. Per esempio nella voce del baritono Dmitri Hvorostovsky, nato proprio in Siberia. Credo che nelle pieghe di una voce si nascondano gli elementi più veri, più rivelatori di un’essenza, di un vissuto. D’altra parte, come nelle pieghe di un movimento o di un gesto rubato con la macchina fotografica, appunto. “Ripenso a quella città metafisica, allo scultore che non voleva cedere le sue opere, alla ragazza bellissima che vendeva aglio, ai bambini che suonavano le campane in chiesa” 38 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 30 LUGLIO 2006 Diciotto anni fa, appena trentaduenne, moriva Andrea Pazienza: il più esplosivo, il più enigmatico, il più solare ma anche sulfureo genio del fumetto italiano. Ora Sandro Visca, il “prof” che lo scoprì in un liceo di Pescara e che ne fu l’amico-mentore degli anni di formazione, ha aperto i cassetti e recuperato quei primi, già straordinari disegni. Ne sono usciti un libro per Fandango, e i disegni mai visti pubblicati in queste pagine Paz Inedito perché somigliava a me da ragazzo: ribelle, un po’ esibizionista, gran voglia di ridere e di far ridere. Che fosse un gePESCARA nio lo capii subito dopo». Quel giorno, nella classe di Disegno di figura, il futuimabue, il pittore, tutti ro Apaz s’annoia vistosamente, come sanno chi è. Il nome di sempre. «Prof, copiare dal vero è una Sandro Visca, invece, dirà rottura». Visca non è un professore alpoco a chi non frequenta l’antica, ma rispetta ruoli e doveri. «Pale gallerie d’arte e non ha confidenza zienza vieni un po’ qui, prendi questo», col Bolaffi. Qui però si dimostrerà che un Fabriano ruvido A3, «e disegnami l’artista e professore abruzzese fu più una mano». La mano, croce dei pittori, grande, almeno come uomo, dell’antila prova più difficile. «Uffa co maestro toscano. Al giovane prof». «Poche storie, e disegnaGiotto, pastorello di Vespignala bella grande, anche». Silenno scoperto con «grandissima zio di sfida. «Prende il carbonmaraviglia» mentre su un sasso cino e comincia a disegnava le sue disegnare. Frenepecore, Cimabue tico, velocissimo, offrì la sua bottega senza pause, come e la sua sapienza. un plotter meccaAl suo Giotto, un LICEALE DI TALENTO nico. Una mano, sedicenne dolce e Vignette e disegni inediti, storie piccola; poi un’alimpertinente ina fumetti mai viste prima tra, un’altra ancocontrato nell’aula Quello che esce a tutto tondo ra... In due minuti d’un liceo, il prodal libro Andrea Pazienza sul foglio ci sono fessor Visca mise a di Sandro Visca (Fandango Libri, sette mani dispodisposizione la sua 164 pagine, 22 euro) è il profilo ste ad arco, in bottega, la sua saadolescente di un genio realtà una mano pienza e anche il del fumetto italiano, morto sola, semiaperta, suo corpo. Come ad appena 32 anni nel 1988 congelata in sette cavia, modello, Sono le prove d’autore realizzate pose mentre ruota soggetto, vittima, nei primi anni Settanta, gli anni su se stessa. E io materia plastica di studio al liceo artistico penso: questo non per l’apprendista“Misticoni” di Pescara è possibile». to di colui che (Vi«Senza essergli sca l’aveva capito insegnato modo subito) sarebbe dinessuno altro che ventato il più dallo estinto della natura», così pensò, esplosivo, il più enigmatico, il più solastrabiliato, Cimabue di Giotto. Così pure ma anche sulfureo, il più indiscutibire pensò, affascinato, Visca di Pazienle genio del fumetto italiano: Andrea za. «Aveva un mondo di forme in testa. Pazienza. Un database immenso. Sapeva l’aspetChi oggi non si stanca di rileggere le to e le flessioni di qualsiasi muscolo storie di Zanardi, di Penthotal, di Pomumano o animale. Il professor Sciarretpeo, e rimpiange che non abbiano avuta, il collega di anatomia, me lo rubava to eredi, e maledice quell’ultimo per fargli disegnare alla lavagna mentre “schizzo” (l’unico schizzo sbagliato di spiegava. Gli bastava pensare una figuun disegnatore che non conosceva la ra per riprodurla, perfetta». Un Mozart gomma da cancellare, uno schizzo fatto con la siringa, non con la matita) che diciotto anni fa ci portò via Andrea appena trentaduenne, chi continua a leggere i suoi romanzi a pennarello deve sapere che Zanardi, Penthotal e Pompeo ebbero un fratello maggiore, un personaggio magro allampanato baffuto, quasi sempre nudo, costantemente sbeffeggiato, triturato, massacrato in ogni posa, movimento, atteggiamento, in decine e decine di pagine strappate da quaderni a quadretti. Un personaggio che non era solo di carta e inchiostro, infatti eccomelo qui davanti, in carne ed ossa, sessantaduenne, senza più baffi e coi capelli diventati di cenere, nel suo studio d’artista al primo piano di un condominio di Pescara, tra i suoi grandi quadri di stoffa cucita, i suoi teatrini di cartone e oggetti incollati, le sue sculture di legno. Visca: un cognome che già sa di fumetto, se il professore non s’offende. Ma se non s’è offeso allora... «Sono stato il primo personaggio di Andrea», ammette, orgoglioso ed esitante, «e non è stato facile, sa. Pescara è una piccola città, e nel ‘72 era ancora più provinciale». Nel liceo che oggi esibisce Pazienza come il più illustre tra i suoi alumni,veder circolare vignette con un professore nudo faceva scandalo. «Fermare Andrea però sarebbe stato un delitto. E io, al diavolo i pudori, non l’ho fermato». Sarà perché in fondo erano entrambi ragazzi. Quando s’incontrarono, Visca aveva appena 27 anni, solo undici più di Pazienza, pur avendo già lavorato a Roma e a Milano con grandi artisti come Burri. Andrea poi si dava arie da più grande della sua età: del resto a Pescara viveva da solo, i suoi lo avevano mandato al liceo artistico Misticoni, che aveva buona fama in tutto il centrosud, ma erano rimasti a San Severo. Un ragazzino anni Settanta, «stessa età di Miguel Bosé», scrisse nel curriculum; alto, scheletrico, caschetto di ricci neri narcisisticamente lavati ogni mattina, un’ombra di peluria sul labbro superiore sempre tirato da un sorriso un po’ beffardo un po’ complice. «Mi piacque MICHELE SMARGIASSI C La matita ribelle e maudit del vignettista-ragazzino “Frenetico, velocissimo, senza pause: in due minuti sul foglio c’erano sette mani, perfette. E io mi dissi: non è possibile...” con la matita, un discolo irriverente ma baciato dalle muse. Andrea ne era consapevole: «So disegnare qualsiasi cosa in qualunque modo», ha lasciato scritto, «ma disegno poco e controvoglia». Falso. «Falsissimo. Andrea disegnava continuamente, compulsivamente, ovunque si trovasse, qualunque foglio o penna avesse sottomano». Poco gli interessavano le attempate modelle in posa sul palchetto dell’aula di disegno. Amava Rembrandt e Duchamp, ma di immagini ne aveva già troppe di sue, nella mente, da far uscire già perfette come Minerva dalla testa di Giove. Il primo fu un orsetto, a diciotto mesi. Per la meraviglia di papà Enrico, acquerellista di talento. Voleva farne un pittore, papà. Ma Andrea svignettava e basta. Disegnini sottobanco, caricature dei professori e dei compagni di classe, scherzi, sberleffi, disegnati in classe tra lo strabilio dei compagni e subito regalati, a decine, a centinaia. Visca, il profragazzo che gli aveva aperto la porta del suo studio e della sua amicizia, diventò il suo bersaglio preferito. Forse perché era più artista che prof, e non si ribellava. «Per tutti, anche per i miei colleghi, erano disegnini stupidi. Invece guardi qui», fruga tra vecchie carte, «sono io, vede? Nudo, in tutte le pose, decapitato, sbranato, evirato, ecco guardi questa dove ho le gambe in alto, guardi questa coscia di scorcio, la curva delle natiche: solo un grande riesce a disegnare a memoria un corpo in questa prospettiva. Aveva bisogno di usare me per esprimersi così? Bene, lo facesse pure. Non era giusto fermarlo». Chi avrebbe potuto? Andrea sedicenne era «un vulcano», era anche «sicuro di sé, vanitoso, felice di essere al centro dell’attenzione». Irrispettoso, sardonico, sospeso già il primo giorno di scuola, «ma solare», consapevole di essere molto bravo e capace di approfittarne come di un lasciapassare: così per Visca. Anche se Pazienza, degli anni pescaresi, ricordava un’esistenza sdoppiata: di giorno «bravo, fertile e sgarbato», di notte in «condizione tudemònchei» (to the monkey, scimmiesca?), irriverente, oltraggioso, trasgressivo. Sfogandosi su Visca, forse, poteva ricongiungere le sue metà. A tutto rischio di Visca. «Un giorno arrivo a scuola e tutti, professori e ragazzi, appena mi vedono ridono e svicolano. Mi dico: qui è successo qualcosa. In classe Andrea ha la sua faccia furba. Gli altri ridacchiano. Capisco che sono l’unico a non sapere. Allora Andrea trova il modo di informarmi. Finge un litigio col compagno di banco, “No, lascia, nascondilo!”, io ovviamente intervengo, “Pazienza portami quel foglietto”. È l’ennesima caricatura mia, ma terribile: io che mi masturbo leggendo Topolino e immaginandomi Minnie nuda. Mi vien da ridere. Ma devo rispettare il ruolo: “Pazienza, fuori”. Lui fa la scena, m’abbraccia le ginocchia, “Perdono!”, anch’io recito, “Fuori di qui!”, lui esce fingendo disperazione. Tre ore dopo vado a cercarlo, il bidello mi dice che è al gabinetto, infatti eccolo, sdraiato sulle piastrelle a pancia in giù a disegnarmi ancora, nudo, mentre mi faccio uno spinello». E lei? «Non aveva biso- DOMENICA 30 LUGLIO 2006 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 39 GIOVANISSIMO gno di un professore. Aveva bisogno di attenzione, forse di affetto. Il pomeriggio, come sempre, era nel mio studio». Gli invidiò mai quel talento maudit? «Ero troppo felice di insegnargli quel poco che potevo». «Gli tolga di testa quelle sciocchezze, quelle caricature», papà Enrico andò apposta da Visca a lamentarsi, «ne faccia un artista». «Ma lui era già un artista, di un’arte che nessuno ancora apprezzava». In quei primi anni Settanta poche e poco stimate le riviste “nobili” di fumetti in Italia: quasi solo Linuse il suo Alter. Non era previsto che si potesse uscire dal liceo artistico altro che pittori. E tutti se lo immaginavano pittore, Andrea. A un certo punto provò anche a esserlo». C’era una coraggiosa galleria d’arte, a Pescara: si chiamava Laboratorio comune d’arte Convergenze, l’aveva creata, con Visca e altri artisti, Giuseppe D’Emilio, uno di quegli intellettuali estroversi che hanno permesso alla provincia italiana di non essere provinciale. «Gli proponemmo di esporre: quadri, però. E lui ci si mise di buon grado. Grandi bristol 70x100 che riempì di colori, tutto a pennarelli. Sono splendidi. Ma a lui non piacevano. “I vostri quadri finiscono nei salotti e lì muoiono”. Forse aveva ragione. Allora segui la tua strada, gli dissi, però non ti perdere con le vignette. Col disegno puoi raccontare storie. Provaci». Il giorno dopo tornò in classe con un mazzetto di fogli. Don Viskotte della Mancia, «dove io percorrevo l’Abruzzo in avventure inverosimili. Ero diventato il suo primo personaggio». Quell’incunabolo è andato perso. Ma seguirono Visc8 Il poliziotto, Visco Little, storie oniriche come L’ulcera, tutte inedite fino a quando, più di trent’anni dopo, Visca ha pensato fosse arrivato il tempo di farle vedere a tutti. «Andrea non solo disegnava benissimo: scriveva benissimo. Follie in una lingua nuova, come i suoi disegni. Ma geniali follie, perché leggeva molto, leggeva di tutto, e sapeva raccontare tutto». Durò tre anni l’educazione sentimentale del giovane Pazienza a Pescara. «Lui voleva restare qui. Ma qui tu muori, Andrea. E lui: tu allora perché vivi qui? Ma io avevo scelto Pescara dopo aver fatto la mia strada, e dopo aver rinunciato a un mondo che non mi piaceva. Andrea invece aveva il futuro davanti». Scelse Bologna, il Dams. Tornò a Pescara solo nel ‘75 per una mostra personale, sempre a Convergenze, stavolta solo di disegni: quelli inediti che vedete in queste pagine, già straordinari, già all’altezza di quelli dell’artista maturo. Col vecchio prof, solo telefonate. «Non mi invitò mai a Bologna, e io so perché». Perché a Bologna Pazienza incontrò il suo giorno e la sua notte. Divenne famoso, pubblicò le sue sturiellètt, conobbe l’albero del bene e del male, lo sperimentò e lo raccontò. «Zanardi è un personaggio disgustoso e affascinante, ma il vero Io di Andrea non era Zanardi, era Pompeo, come il suo luogo era l’eden senza tempo di San Menaio, non il caos del ‘77 di Bologna. Cercava il sole. Ma non riusciva a non raccontare il buio che vedeva crescere intorno a sé». Quando Pazienza si ritirò in un cascinale a Montepulciano con la sua compagna Marina, Visca sospirò di sollievo. «Non immaginavo che i pusher lo avrebbero trovato anche lì». Pochi giorni prima dell’epilogo, una telefonata: «Sandro vieni a trovarmi, ci sono novità, ho in mente una cosa straordinaria, poi ti dico». Visca non ebbe il tempo di sapere quale. La fulminea, torrenziale esistenza del Mozart col pennarello era al capolinea. «Dieci minuti dopo mi ritelefonò solo per dirmi “Sandro Sandro ti voglio bene”». I personaggi dei fumetti raramente piangono, e Visca è un personaggio come si deve. «Ma darei i suoi disegni per riavere lui». FOTO DI RICCARDO ZANELLO DALLA COPERTINA DEL LIBRO "I DOLORI DEL GIOVANE PAZ!" DI RICCARDO FARINA, CONIGLIO EDITORE Nella foto accanto, un giovanissimo Andrea Pazienza al lavoro con carta, matita e cavalletto A sinistra, alcuni disegni di “Paz” del tutto inediti 40 LA DOMENICA DI REPUBBLICA la lettura Natura e cultura DOMENICA 30 LUGLIO 2006 I temporali d’estate, le saette che uccidono: molto meno che i bagni di mare o l’autostrada, ma evocando una misura magica della morte, una fine mitologica voluta dagli dei Per questo, da sempre, scienziati, poeti e pittori lavorano per capire e addomesticare quel lampo di luce accecante, fino a illudersi di averlo replicato nei fuochi d’artificio Così l’uomo ha catturato il fulmine U n tetto di tavole coperte di muschi antichi nel New England. Il mare si vede bene, in fondo alla valle che diviene golfo allungato e sfumato. Ma quello che commuove il pennello di Andrew Wyeth, e siamo nel 1957, è un antico parafulmine. Una sottile guglia di metallo attraversa, per il diametro, una sfera di color miele semitrasparente. Ne esce in alto, dal polo nord, e punta e chiede ancora verso un cielo lirico di gabbiani. Nel cuore di vetro vinoso e ambrato della sfera si devono essere addormentati tanti fulmini, da allora. E nessuna traccia ne è restata. Ma per Emily Dickinson avvenne una catastrofe e i frammenti non si composero più. «Era bella, bella, silenziosa vestita di bianco» e ci canta ancora: Sentii una frattura nella mente — come se il cervello mi si fosse spaccato — cercai di ricongiungerlo — giunta a giunta — ma non riuscii a farle combaciare. Repubblica Nazionale 40 30/07/2006 Il pensiero di dietro cercai di attaccarlo al pensiero davanti — ma la sequenza si srotolò dal suono come un gomitolo — sul pavimento. Così Massimo Bacigalupo, splendidamente, traduce Emily Dickinson ed è questa la sua poesia The Lost Thought (Il pensiero smarrito) del 1864. L’urto e la lacerazione che separa «il pensiero di dietro» dal «pengliaia di occhi, commossi o inflessibili o sosiero davanti» ha prodotto due nuove menlo distratti osservarono il fulmine composto ti che non combaciano più. Nel 1927 Paul da due o tre segmenti rettilinei tra loro conKlee dipinge un Physiognomischer Blitz (fulnessi attraverso angoli acuti e, di certo, nesmine fisiognomico). Un viso ovale è frattusuno ebbe a ridire. L’evidente, elementare, rato da un fulmine convenzionale, letteranon conformità assoluta tra il fulmine “sulrio, la cui forma “a zig-zag” mostra, dietro, la carta” e quello “nel cielo” non scandalizzò un nulla oscuro e che tiene separate, come i lembi di una IL GRAFICO ferita recalcitrante, le due Nel disegno: la turbolenza metà, ormai irriconciliabili, nella nuvola fa spezzare della stessa, ma doppia e vacua, faccia umana. Nel 1919, le molecole di acqua sempre Klee in un curioso POTENZIALE autoritratto si mostra ancora e ghiaccio. Alcuni frammenti NEGATIVO unito, simmetrico ma già hanno carica positiva, altri con tutti i segni di un clivagnegativa. Come regola gio doloroso e gli occhi sigilgenerale, i primi salgono lati in un dolore profetico della frattura. È la litografia verso l’alto della nuvola che egli intitola, almeno nelSCARICA e i secondi scendono la mia edizione della UniverELETTRICA Tra la nuvola e il terreno, o sity of Berkeley, Press, 1964 dei Diari: 1898-1918: Lost in tra due nuvole vicine, si crea Thoughts (Smarrito nei penuna differenza di potenziale sieri). L’esperienza interiore di Emily, quel sentirsi attraelettrico che provoca versata da una improvvisa la scarica, grande fino corrente di nulla ma che laPOTENZIALE POSITIVO a diversi milioni di volt scia, dietro, un tempo per sempre fratturato, si traduce, pochi anni dopo, nelle mani esperte di Klee, in un fulmine che strappa una faccia umana impedendole, ormai per sempre, di risigillarsi e di cicatrizzare un tempo ormai per sempre interrotto. Con meno sottile filosofia, assoluto disinteresse per la scienza fisiognomica, pur così in voga a quei tempi, ma con sbrigativa e sulfurea violenza aveva un fulmine posto fine alla vita del Herr Professor Wilhelm Richmann esattamente il 6 agosto 1753 a San Pietroburgo. La cosa non deve esser durata più di pochi millesimi di secondo e l’imprudente scienziato che aveva attirato attraverso fili e ganci e lunghi trespoli metallici il fulmine nel suo bell’appartamento russo rimase fulminato. Ai superstiti restò il compito della cristallizzazione, della eternizzazione dell’evento fulmineo. In almeno due occasioni il povero professore venne rappresentato nell’atto supremo della sua vita: quasi nello stesso tempo e, poi, nel 1880, ad almeno 130 anni di distanza. Naturalmente, la morte nel 1880 è divenuta assai più bella. Il corpo snello e giovane s’inarca sotto la potente scarica, una gamba è flessa all’indietro, l’altra protesa in avanti. I polsini di pizzo, elettrizzati, si sventagliano attorno alle mani spalancate, il tricorno sta ancora sospeso in aria. Gli strumenti scientifici, muti e innocenti, testimoniano della sua sventurata imprudenza. Il disegnatore della stampa ebbe il compito leggero e impossibile di rappresentare il fulmine: bianco su nero. Figlio del suo tempo, lo rappresentò rigorosamente “a zigzag” e lo consegnò, senza particolari sussulti di incertezza, agli inchiostri di stampa. Mi- La forma a zigzag nacque per illustrare la folgorazione di uno studioso del ’700 ti, schizzi, francobolli e affreschi. Non possiede alcuna originalità, venne clonato in decine di migliaia di esemplari. La sua esoterica forma angolare, quel suo articolarsi in segmenti successivi che indicano una sostanziale incertezza nel procedere ma, al tempo stesso, una scientifica determinazione ad aspirare ad un superiore “status” geometrico, non venne adattata alla parallela “forma naturale”. La ricoprì, invece, la oltrepassò e si installò, in sua vece, nei nostri pensieri fornendo una traduzione stabile, semi-permanente e scrivibile di una forma originale irregolare, riottosa, assurdamente e abbondantemente ramificata, a-geometrica, istantaneamente arborea. A parte alcuni cammini iconografici che si possono tentare per cercare di ricostruire la nascita e il procedere imperiale dello “zigzag” e che sono e resteranno sempre insoddisfacenti e inconclusi, resta il problema più bello: la necessità morale, logica, estetica di “rappresentare” un tempo infinitesimo. Molto probabilmente, un fulmine è “la cosa” visibile la cui durata è la più breve tra tutte. Da una delle tante immagini fotografiche ad alta velocità fornite dal New Mexico Institute of Mining and Technology si deduce facilmente che un fulmine in cui siano presenti tutte le componenti (correnti “leader”, scarica di ritorno, corrente in discesa, eccetera) duri circa 90 millesimi di secondo. Si tratta, in questo caso particolare, di un fulmine che si sviluppa sulla distanza di tre chilometri tra la nube e il terreno. La nostra attrezzatura sensoriale e percettiva ce ne connessuno. La fisionomia del fulmine era staserva una “immagine interiore” per un temta assai ben afferrata e conchiusa in quella po assai più lungo, naturalmente. Ma i detforma rettiliana e geometrica assieme e tuttagli strutturali si obliterano assai in fretta e to procedette tranquillamente. Naturalsi nascondono efficacemente alla memoria mente, il fulmine che sta uccidendo dal 1753 e alla coscienza. In definitiva, l’unico modo il Professor Richmann è uno delle migliaia che è utile seguire per avere una idea del feche hanno popolato immagini, tele, appunnomeno è di studiarne le serie fotografiche. I cosiddetti IL LIBRO “superfulmini”, adesso asIl nuovo libro di Ruggero POTENZIALE sai di moda, si palesano, inPOSITIVO Pierantoni, scrittore vece, assai bene mediante ragionevoli ma coloratissie studioso della percezione me simulazioni digitali. acustica e visiva, si intitolerà Il 16 luglio 1864 viene scattata la prima fotografia di un Uno scherzo fulmineo. fulmine dal dottor Kaiser in Cinquecento anni di fulmini Berlino e, certamente, non dal 1929 al 1447 (240 pagine, mostra un fulmine “a zigzag”. Ma l’effetto sull’icono22 euro) e sarà in libreria grafia del fulmine è praticaa ottobre per i tipi mente nullo. La forma geodi Rosellina Archinto editore metrica e regolarizzata possiede troppi elementi rassiTra gli scritti precedenti: curanti, seduttivi e “razionaVortici, atomi e sirene. li” per essere spazzata via da una banale immagine fotoImmagini e forme del grafica. Ma, come stavamo pensiero esatto intravedendo, non è tanto la (Electa Mondadori) forma che viene consegnata al fulmine ad essere interessante, quanto l’intenzione e la convinzione di poter rappresentare una percezione istantanea e darle forma stabile e perenne. Insomma, l’antica illusione irriducibile della potenza venatoria della scrittura: della sua insuperabile capacità d’impossessarsi di forme naturali, per quanto veloci, potenti, pericolose esse possano essere. L’infantile e necessaria illusione del fermare il tempo che si manifesta nella mano del pittore che sta tracciando il suo lampo accecante di biacca contro una nuvola gravida, verdastra e minacciosa non è diversa da quel gioco doloroso e triste che giochiamo contro di noi nel vedere i fuochi artificiali. Il dotare i fulmini di una vita misurabile, l’averli estesi miseramente nel tempo, li dota, molto semplicemente, di una morte. E, per compensarla, per assicurarci che, tutto sommato, tutto continua per il meglio, che siamo noi a definirlo il tempo, a dargli forma ed assicurargli una decente illusione di continuità ripetiamo e ripetiamo il lampo. Si alzano contro il cielo nero parabole dorate e subito si polverizzano, si espandono perfette sfere color fragola e sono subito fiammelle disperse da Purgatorio. Si propelle più in alto di tutto, altissima sul promontorio notturno, l’ultima lama accecante di luce candida e subito dopo tutto è già nulla. Segue, incoerente e solitario, uno strano boato. Buio, ancora una volta. MIRCO TANGHERLINI RUGGERO PIERANTONI Sommarsi come il tuono sul finire poi grandiosamente crollare mentre ogni cosa creata si nasconde questa — sarebbe poesia. Sempre Emily... La metafora di Paul Klee ed Emily Dickinson: una frattura nella mente che disperde il pensiero DOMENICA 30 LUGLIO 2006 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 41 La folgore tra miti classici e letteratura Da Athena a Justine era il castigo degli dei DARIA GALATERIA «I l colpo di fulmine ha questo di buono, che fa risparmiare un sacco di tempo», medita l’umorista francese Pierre Doris. Il tempo è lento e inarrestabile. Il fulmine, subitaneo e imprevedibile. Così insensato, e più veloce del tempo, si è messo presto dalla parte del sacro; e così mirato nell’incenerire, è sembrato un fuoco punitivo: l’arma (saetta, sagitta, freccia) di Giove. Lucrezio, essendo pazzo, si sforzò di spiegarne la natura in termini ragionevoli; per trecento versi (De rerum natura, L. VI), si scaglia contro le interpretazioni teologiche del fulmine. Se Giove punisce con corrucciate saette i mortali, perché tutti i colpevoli, «folgorati, non esalano fumo?». Perché il dio trafiggerebbe alberi e luoghi isolati, e senza peccatori? Ma più forte di Lucrezio (e di Empedocle, Democrito e Aristotele, e dei miti nordici, con la scintilla celeste creata da Thor battendo sull’incudine) la poesia epica e la tragedia avvolgono i lampi di corruschi aloni divini. «Zeus mi promette il fuoco del suo fulmine, per colpire gli Achei e incendiarne le navi», si vanta, nelle Troiane di Euripide, Athena, cui i Greci hanno oltraggiato il tempio. Sade, nel 1791, polemizzerà con l’idea della folgore punitiva. Ha scritto alla Bastiglia la storia della virtuosa Justine, sottoposta contro la sua volontà a ogni sorta di violenza (quasi sempre retrograda) e alle più alambiccate angherie erotiche escogitate da libertini infiammati — perlopiù giudici e frati: tutti soprusi e corali assalti subiti con i begli occhi inondati di lacrime, e invocando il soccorso divino. Ora, mentre la sorella Juliette prospera nel vizio, la virtuosa Justine muore colpita da un fulmine «che la scaglia in mezzo al salone»: prova provata che la provvidenza sembra accanirsi sulle creature immacolate, e soccorrere propizia il crimine. L’Essere Supremo squaderna un universo crudele: «Stolto, perché non mi imiti?». «Ah cielo che sento? Un fuoco invisibile mi brucia!» si lamentava invece a giusto titolo Don Giovanni di Molière, della schiera di atei e libertini colpiti dalla folgore divina. Il Seicento devoto restaura il Cielo tuonante sui reprobi; ma con che leggerezza Shakespeare invia lo spiritello Ariel, su incarico dello spodestato duca di Milano Prospero, a fiammeggiare tra le sartie dell’usurpatore: «I flam’d amazement, ho fiammeggiato terrore», racconta Ariel, più veloce della vista, come lampo di Giove. Tutti salvi, alla fine; rinsavimento e amore concludono La tempesta (1611). Il pentimento è pure il fine dei fulmini di Defoe, un anno dopo Robinson Crusoe; Il capitano Singleton (1720) è convinto dal quacchero Guglielmo, complice un fulmine estremamente persuasivo, a abbandonare vita dissoluta e filibusta. Nell’Oberon di Wieland — è il 1780 — il paladino Huon, incaricato dall’imperatore Carlo di riportargli quattro molari del califfo di Bagdad, riesce nell’impresa, ma non a mantenersi virtuoso sulla nave del ritorno, in una notte di luna, in compagnia dell’amata: tuoni, fulmini, tempesta, erranza, e guai di ogni tipo — fino alle nozze benedette dal papa. Ormai i fulmini sono ridicoli, o mal consigliati. A inizio Ottocento, la Batracomiomachia, e gli annessi, leopardiani Paralipomeni, deridono il Padre Giove che, mosso a compassione delle rane, disperde l’“armata intiera” dei topi (IV,6). A metà secolo, il Rigoletto verdiano, abituato a esecuzioni verbali, sogna di vendicarsi più concretamente sul suo padrone: «Qual fulmin scagliato dal cielo, la mia mano colpirti saprà» — ma il fulmine si sa è cieco, e il pugnale per errore colpisce la figlia adorata del giullare. La giustizia divina era ondivaga peraltro anche nella tradizione classica; perché colpire con la folgore il benemerito Esculapio, dio della medicina? Plutone era bensì irritato dalla rarefazione dei morti; e Zeus dà ascolto alle sue recriminazioni. Ride Giove del resto alla richiesta di Numa Pompilio, che cerca il segreto dei fulmini (Ovidio, Fasti, III). Il Novecento ha un senso nebuloso della colpa, e vividissimo il terrore del tempo. Così, sorge Eugenio Montale a ritenere che «la bufera che sgronda sulle foglie» abbia a che fare con l’eternità: i colori improvvisi creati dai fulmini («il lampo che candisce / alberi e muri e li sorprende in quella / eternità d’istante») sono l’immagine dei fotogrammi della memoria, che a sorpresa illuminano certi attimi, per sempre. 42 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 30 LUGLIO 2006 Esce “Il piacere degli occhi”, un libro di minimum fax che raccoglie i saggi del grande regista francese. Una galleria di vividi ritratti degli attori e degli autori che hanno contato nella sua formazione e nella creazione dei suoi film Ma anche una lezione sulla settima arte impartita da uno scrittore di straordinaria qualità STEFANO MALATESTA rançois Truffaut, come tutti sanno, ha scritto molto sul cinema: probabilmente il regista europeo che ha scritto di più, da critico e da cinefilo; da sostenitore del cinema americano e da ammiratore del suo contrario, Roberto Rossellini; da capofila della Nouvelle Vague a tollerante e un po’ ecumenico ex “giovane turco” diventato regista famoso. Una produzione letteraria che è apparsa ancora più ampia e fitta di interventi di quanto non sia stata perché molte cose che diceva non erano tratte da suoi scritti personali, ma dalle interviste, un genere spurio e interessante, applicato non so bene perché soprattutto al cinema. È rimasta famosa l’intervista data da Buñuel allo scrittore e sceneggiatore francese Carrier, rallegrata o funestata non saprei dire dal traduttore perché a un certo punto Buñuel richiesto di indicare cosa rimpiangesse di più della Spagna, da dove mancava dal tempo della guerra civile, diceva: «Gli aperitivi», e tutti noi avevamo commentato: ma questo Buñuel si è rimbambito. Rimbambito invece era stato il traduttore: gli aperitivi stavano per «ta- F Truffaut François Un film dove è protagonista potrebbe quasi fare a meno di raccontare una storia [...] Lei ha la naturalezza delle ragazze nate dopo la guerra ROBERTO ROSSELLINI Mi ha insegnato che il soggetto di un film è più importante dei titoli e una buona sceneggiatura deve stare in dodici pagine ‘‘ CATHERINE DENEUVE ‘‘ Repubblica Nazionale 42 30/07/2006 “Vi racconto il cinema e i suoi fuoriclasse” pas», parola che però indica anche quei locali coloriti e pieni di atmosfera dove si mangiano acciughe, tonno o fritti, tutto un mondo di bevute e di amicizie, introvabili fuori dalla Spagna. In una raccolta di interviste a Truffaut uscita nell’88, ad un certo punto la prefatrice sentenziava: «François adopera le parole con grande virtuosismo». Poi aggiungeva: «Un dono raro per un cineasta». Mica vero. Chi abbia ascoltato anche una sola volta Federico Fellini involarsi in uno dei suoi racconti su cose e persone, non si sapeva mai se vere o inventate, ma descritte con una cura straordinaria nei dettagli elaborati con la mimica e che la sua voce sottile rendeva ancora più nitidi e precisi come fossero lavorati al tornio, si rendeva conto che a trascriverli sarebbero stati dei pezzi straordinari. E così, anche se non in questa misura, molti altri registi avrebbero saputo tenere la penna in mano (qualcuno l’ha fatto, da Bergman a Orson Welles; Roberto Rossellini, che lavorava quasi senza sceneggiatura, era veramente un caso all’opposto) se avessero avuto tempo, voglia e un minimo di fiducia nella possibilità della scrittura di genere alto o elegante che non avevano. Gli uomini del cinema sono uomini di cinema, uomini di cinema, uomini di cinema, incantati da questa arte così istintiva e gelosa che ha altri modi di rappresentazione della letteratura, e si nutre più di intuizioni che di ragionamenti, più di visioni che di razionalizzazioni, che non ha quasi mai permesso che ci si allontanasse troppo da lei. Il mondo del cinema, degli attori, dei registi, è fatto di immensi vuoti, mascherati da un attivismo forsennato per evitare la pazzia, in attesa della messa in opera del film, che si può prolungare per tempi infiniti. E più questi tempi si prolungano più i registi sono o fingono di essere indaffaratissimi e non c’è testa per altro. Provate a immaginare un regista che si sveglia di buonora la mattina, prende con calma il suo caffè, esce, raggiunge la casa di produzione e al chiuso di una confortevole stanza, sotto l’occhio benevolo del produttore che sta cercando ansiosamente di chiudere il pacchetto, si mette a vergare decine di saggetti come Il cinema DOMENICA 30 LUGLIO 2006 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 43 IN LIBRERIA Il piacere degli occhi, selezione di scritti sul cinema di François Truffaut, è in libreria da domani Il volume fa parte del cofanetto L’uomo più felice del mondo, con due film in dvd, I quattrocento colpi e La signora della porta accanto (coedizione minimum faxBim, 302 pagg., 99 + 106 minuti, 28 euro) ‘‘ ISABELLE ADJANI ‘‘ STEVEN SPIELBERG ‘‘ FANNY ARDANT ‘‘ ALFRED HITCHCOCK È la sola attrice che mi abbia fatto piangere davanti alla televisione. Pensavo che filmandola avrei potuto rubarle cose preziose FOTO MAGNUM Ha la speciale capacità di rendere plausibile ciò che è straordinario [...] Ha reso più quotidiane possibili le scene fantastiche è una maschera o uno specchio? Truffaut ha fatto esattamente il cammino inverso cominciando giovanissimo a scrivere interventi diventati famosi, e molto prima che iniziasse a girare una scena di un vero film. Non vorrei qui ripetere per la milionesima volta i passaggi dell’infanzia truffautiana, conosciuta dai cultori del suo mito quasi come quella di Pinocchio: la liberazione, l’arrivo dei film americani tra i quali spiccava Citizen Kane visto venti volte (François non era solo: un altro pazzo per i film di guerra aprì un american bar in Rue Delambre, a Montparnasse, la prima a destra venendo dalla Coupole, chiamato “Rosebud Bar”. Rosebud era la misteriosa parola che fa da leitmotiv al film); e poi i lavori manuali, la breve galera, il recupero da parte di André Bazin, inquieto ma perbene ultimo erede della schiatta dei moralisti francesi, dove moralismo sta per un sistema qualche volta religioso, ma sempre scettico di eleganti proporzioni, che manteneva alto il tono della cultura in Francia. Ma se il giovane François la mattina indossava la tuta da operaio, la sera andava a letto presto con uno dei volumi della collezioni Classiques Fayard, da A-Aristofane a V-Voltaire. Dietro di lui si innalzava ancora potente e riverita la società letteraria di un paese in cui anni più tardi un presidente della Repubblica in carica dirà: «Avrei preferito fare lo scrittore». Viviamo in tempi così miserabili per tutto quello che riguarda il dibattito culturale che ci siamo scordati che una volta, non molti anni fa, esistevano luoghi differenti e un po’ più eleganti di Porta a Porta per parlare di tutto e anche di cinema. Per esempio i caffè di una Rive gauche, sia pure di maniera e risaputa, dove scendevano Sartre e la Beauvoir, Althusser e Merlau-Ponty e magari più tardi Deleuze e Guattari e i “noveau philosophes”, e gli studenti facevano la fila dall’alba per ascoltarli. È verissimo che molti di questi che venivano definiti, con un termine or- ribile, “maitres à penser”, soprattutto gli ultimi, facevano passare dei luoghi comuni per folgoranti rivelazioni e loro stessi erano di una vanità ributtante. Ma almeno i ragazzi tornavano a casa con qualche ideuccia in più e qualche conformismo in meno e nelle polemiche tra loro erano ancora abbastanza lontani dallo stile “ultrà curva sud” di quelli che avrebbero urlato: «Sartre, devi MO-RI-RE». In quegli stessi anni Cinquanta durante i quali Truffaut pubblicava sui Cahiers, Roland Barthes scriveva i sarcastici commenti intitolati Mitologie. E il modo classico di costruire la frase e poi di spezzarla per mostrarsi modernissimi era molto simile. Anche se Truffaut aveva abbandonato la scuola a quattordici anni e l’altro rappresenterà la crème de la crème dell’alta accademia. Non a caso il libro che uscirà nei prossimi giorni, in cui sono raccolti i testi più significativi del regista francese, ha come titolo Il piacere degli occhi, che ricorda immediatamente Il piacere del testo di Barthes. Poi è venuta la stagione dei film. Il primo, I quattrocento colpi, rivelò subito un talento. Servendosi della sua corazza di maniaco cinefilo, Truffaut è riuscito in un’impresa quasi impossibile: respingere le lusinghe della letteratura evitando di trasformare i libri in pièces de théâtre. Solo in Jules e Jim la letteratura sembra che si avanzi fino a un punto di non ritorno, ma il talento di Truffaut trasformò lo spunto per un film letterario in grande cinema. Conosco solo Pasolini che sia riuscito a superare indenne la metamorfosi da scrittore a regista girando il meraviglioso Accattone. I quattrocento colpi deve molto all’influenza di Rossellini per la chiarezza e per la volontà di non complicare la narrazione con troppi personaggi e fatti. Ma il richiamo che hanno sempre esercitato i suoi film su un pubblico vastissimo, in particolare quello femminile, ha altre ragioni. Le sue storie sono molto differenti tra loro e François stesso diceva di girare un film per smentire quello che aveva detto nel precedente. Tutti comunque hanno in comune di essere dei racconti privati creati da un romantico che aveva una sola passione: quella di perdersi in una serie infinita di vicende amorose non molto lontane per il contenuto dalle telenovelas ma che, elaborate e montate e graziate dal tocco di Truffaut, sembravano così moderne, così spiritose, così nuove da incantare anche i critici più sofisticati. E naturalmente dietro c’era Parigi. Ricordate Baci rubati? Cosa sarebbe senza Parigi di sfondo la scena iniziale, quando il giovanotto comincia a seguire tutte le ragazze che vede entrare o uscire dal metrò mentre Charles Trenet canta Que reste-t-il de nos amours. Sono tutti film da cui traspare, molto più che dai saggi, l’amore di Truffaut verso le donne, da lui adorate in quella sua maniera che nascondeva e mascherava: una maniera che aveva come effetto di esporle ancora di più: Fanny, Marie France, Catherine, Françoise, Janet e tutte le altre che con le loro gambe a compasso, come lui diceva, prendevano le misure del globo. ALLA MACCHINA DA PRESA François Truffaut, che ha contribuito alla nascita della Nouvelle Vague, dietro alla macchina da presa sul set del film Le due inglesi del 1971 Dalla sua opera traspare l’amore per le donne In lei ho subito apprezzato vitalità, coraggio, umorismo ma anche il suo gusto del segreto e, soprattutto, qualcosa di vibrante Con le loro gambe a compasso amava dire prendono le misure al mondo La sua carriera dimostra che un regista cinematografico può arrivare al successo e restare fedele a se stesso 44 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 30 LUGLIO 2006 i sapori Profumi di cucina Amatissimo o odiato, dal gusto inconfondibile, il bulbo accompagna da secoli carni, pesce e verdure. E ora è diventato protagonista di ricette creative, nonché di una fiera che lo celebra il prossimo fine settimana nel ferrarese Aglio È lo spicchio più forte d’obbligo schierarsi LICIA GRANELLO tiamo diventando intolleranti al buono. Gli odori intensi ci urtano, i sapori vigorosi ci preoccupano. Ci stanno insegnando a diffidare dei nostri stessi sensi: l’omologazione del gusto passa per il cibo inodore e insapore. L’aglio, il “tartufo dei poveri”, è il primo a farne le spese: pesto, sughi, arrosti, bruschette sempre più spesso sono orfani di un elemento che da sempre al solo profumo scatena l’appetito. Non digeriamo più l’aglio. Possibile? Intanto, c’è aglio e aglio. Nei mercati, sugli scaffali, l’aglio italiano è quasi scomparso. Siamo inondati da quelli cinesi, indiani, spagnoli. Grossi, lucidi, perfetti, inattaccabili da muffe e secchezza. Ma anche invadenti, mono-odori, senza grazia. Perché l’aglio può essere seducente come un profumo d’autore, invitante e lascivo, promessa di godimenti golosi senza spiacevolezze residue. A patto di saperlo scegliere al momento della spesa, e trattarlo con cura quando arriva in cucina. Dall’aglio ursino, pianta boschiva spontanea di cui si usano anche le foglie, a quello rosa di Lautrec, nei Pirenei francesi, fino all’aglio di Vessalico, coltivato nell’entroterra d’Imperia, la gamma di gusti e profumi si fa via via più soave. Esistono anche dei piccoli trucchi, come l’uso degli spicchi “in camicia”, l’asportazione del germoglio verde interno, la marinatura nel latte, giù giù fino allo sbianchimento, con gli spicchi sbollentati più volte, cambiando sempre l’acqua di cottura. E per “resettare” il palato a fine pasto, basta masticare un chicco di caffè o di anice stellato… Le preparazioni possono essere mirabili. Basta pensare al tradizionalissimo pesto genovese, la cui ricetta venne codificata a metà Ottocento con accanto il nome alternativo di savore d’aglio. Tante anche le ricette creative, dalla mousse di Ferran Adrià alla caramellatura di George Blanc. A Gardone Riviera, la corona d’aglio candita inventata da Riccardo Camanini (le teste sbianchite sette volte, passate in forno coperte a 60 gradi per 3 ore con zucchero di canna, sale, grasso d’anatra, e infine girate sulla brace) resiste a tutti i cambi di menù. Buono e terapeutico, l’aglio era già conosciuto dai Faraoni che lo distribuivano agli schiavi per aumentarne l’energia e curare le malattie. Del resto, l’elenco delle sue virtù è lunghissimo: antibiotico naturale contro tosse, influenza, infezioni intestinali, abbassa pressione, glicemia, colesterolo e trigliceridi, attenua i disturbi epatici ed è un potente avversario di funghi e parassiti. Ma l’aglio è indispensabile anche ai seguaci di Bram Stoker (inventore di Dracula) e agli scaramantici. Sugli schermi Rai, quarant’anni fa, Aitano Pappagone (alias Peppino De Filippo) scacciava il malocchio con una filastrocca rituale, Aglio, fravaglie, fattura ca nun quaglia; corna, bicorna, cape 'e alice e cape d'aglio, che metteva insieme pesci (fravaglie e alici), in quanto simboli di Cristo, corna (efficaci perché appuntite) e l’immancabile aglio. Se temete nuvole sulle vostre escursioni alpine o una medusa tra le onde, sulla strada delle vacanze fate tappa a Voghiera, Ferrara. Nel prossimo fine settimana, infatti, verrà celebrata la nona edizione della Fiera dell’aglio di Voghiera: bianco lucente, aromatico, a un passo dal riconoscimento Dop. Tra le tombe della necropoli etrusca e le corti della reggia estense di Belriguardo, potrete fare scorta di trecce, creme, essenze. Un pizzico di peperoncino non guasterà. S Bianco I TIPI Detto anche comune o rustico per la sua adattabilità, è caratterizzato da dimensioni e aromi più o meno accentuati a seconda dei diversi climi e terreni di coltivazione Zona più produttiva: il Polesine Repubblica Nazionale 44 30/07/2006 Rosa Esibisce tuniche di un color rosa o giallo pallido, è precoce, soffre l’umidità, non si conserva facilmente, i bulbi sono grandi e irregolari, il gusto è delicato e aromatico. Le coltivazioni migliori sono nel Sud Conosciute fin dall’antichità le sue virtù disinfettanti e terapeutiche Glossario Vestito (in camicia) Spellato(nudo) Schiacciato A fette Testa Resta Rosso Galles Le coltivazioni più importanti sono a Nubia e Sulmona Il bulbo siciliano, tuniche esterne bianche e interne rosse, è alla base del pesto trapanese L’altro, color porpora, è ricco di oli essenziali e si usa vestito Fa parte della stessa famiglia botanica delle liliacee, ma rispetto all’allium sativum, il fistulosum, noto come aglio del Galles, ha fioriture più importanti e foglie aromatiche Diffuso in Cina e Giappone Bulbilli Tuniche Si utilizza lo spicchio intero Viene eliminata la guaina protettiva Si schiaccia con il palmo della mano Spellato e tagliato sottile dopo aver tolto il germoglio Il bulbo intero La treccia di bulbi lavorati a coppie e lasciati essiccare Gli spicchi da semina ricavati dai bulbi migliori dell’anno precedente Le sezioni esterne del bulbo in cui sono incorporati gli spicchi DOMENICA 30 LUGLIO 2006 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 45 itinerari Riccardo Camanini, chef di Villa Fiordaliso, relais affacciato sul lago di Garda, declina l’aglio in maniera originale e leggera, sia in forma di crema per condire gli spaghetti, sia candito, contorno strepitoso dell’anguilla alla brace Adria (Ro) Il centro più importante del Basso Polesine, adagiato nell’ultimo fazzoletto della pianura padana, ha una storia antica La coltivazione di aglio bianco è ampia e di qualità La nuova raccolta in questi giorni Sulmona (Aq) Paceco (Tp) Patria di Ovidio e sede della giostra cavalleresca d’Europa (5 e 6 agosto). Dedita da 2000 anni alla produzione di confetti, la città vanta un’altra produzione pregiata, quella dell’aglio rosso, coltivato nella conca Peligna Centro agricolo adagiato nella riserva regionale Saline di Trapani, è famoso per i suoi meloni dolcissimi, gli ottimi oli, i formaggi ovini La produzione di aglio rosso, protetto dal presidio Slow Food, è localizzata nella contrada di Nubia DOVE DORMIRE DOVE DORMIRE SANTA LUCIA B&B Corso Ovidio 13 - Tel. 0864-210616 Doppia da 90 euro, colazione inclusa BAGLIO COSTA DI MANDORLA (con cucina) Via Verderame - Tel. 0923-409100 Doppia da 86 euro, colazione inclusa DOVE DORMIRE HOTEL MOLTENI (con cucina) Via Ruzzina 2 - Tel. 0426-42520 Doppia da 85 euro, colazione inclusa DOVE MANGIARE TAVERNA DEL CAVALIERE Via Brenta Ariano, Rivà di Ariano Polesine Tel. 0426-79300 Chiuso mercoledì e giovedì a pranzo, menù da 35 euro DOVE MANGIARE CLEMENTE Vico Quercia 5 - Tel. 0864-52284 Chiuso giovedì, menù da 25 euro DOVE MANGIARE DOVE COMPRARE DOVE COMPRARE DOVE COMPRARE AGRICOLA BIOLOGICA IL SALICE Via Eridania 1667, Papozze Tel. 0426-44416 FATTORIE PINGUE Via Lamaccio 2 Tel. 0864-33580 ORTOFRUTTA MARTINICO Via Francesco Crispi 3 Tel. 0923-526673 MONTE SAN GIULIANO Vicolo San Rocco 7 - Tel. 0923-869595 Erice A lungo relegato nelle cucine contadine, viene poi ingentilito per le tavole nobili Cibo povero, ma trasformista MASSIMO MONTANARI n prodotto povero, anzi di più: un “segno” di povertà, da cui i signori ostentano distacco. Questo è l’aglio, nella nostra tradizione alimentare. Cominciamo con un testo del Decimo secolo. Un vecchio pellegrino con un sacco carico di aglio, cipolle e porri sta tornando da Roma e incrocia la sua strada con quella di un monaco schizzinoso, di nome Giovanni. «Allontaniamoci da questo puzzo», dice il monaco al suo compagno di viaggio, l’abate di Cluny, Oddone. Il quale gli impartisce una bella lezione: «Vergognati: lui può mangiare queste cose e tu neppure riesci a sentirne l’odore?». Il finale edificante dell’episodio lo rende comunque rivelatore della percezione che allora si aveva dell’aglio, del suo odore, del suo sapore, come di cose estranee alla cultura delle classi alte: esse appartenevano all’universo alimentare contadino, rustico, volgare. Tale era l’immagine dell’aglio già in epoca antica, tale rimarrà per secoli. Una novella di Sabadino degli Arienti, scrittore bolognese del Quindicesimo secolo, mette al centro dell’azione proprio l’aglio, in una vicenda feroce che ha come protagonisti il duca di Ferrara e un contadino della bassa padana di nome Bondeno. Questo Bondeno era riuscito a entrare negli ambienti di corte come camariero del duca, e si era un po’ montato la testa: a un certo punto addirittura pretende di essere nominato cavaliere. Il duca decide di giocargli uno scherzo: finge di accogliere la sua richiesta e un bel giorno invita i cortigiani alla cerimonia di investitura e allo svelamento del blasone nobiliare appositamente studiato per Bondeno e la sua famiglia. Si leva il drappo ed ecco apparire «uno capo d’aglio in campo azzurro», e di fianco una damigella che si ritrae turandosi il naso per il fetore. Il senso appare chiaro a tutti con immediatezza: contadino sei, contadino resterai. E il tuo essere contadino sempre si sentirà, come ora si sente, LE RICETTE U dal puzzo d’aglio emanato dal tuo corpo. Eppure... eppure anche l’aglio può entrare nella cucina di élite. Basta qualche piccolo accorgimento per “ingentilirlo”. Lo stesso Sabadino, commentando la storia di Bondeno, dopo aver ribadito il suo significato e cioè il valore dell’aglio come rivelatore della natura rustica di chi lo consuma, osserva che però anche l’aglio talvolta può farsi “artificiosamente civile”, ossia entrare in un diverso universo gastronomico e culturale. Ciò accade, dice Sabadino a titolo di esempio, quando l’aglio «si conficca in uno papero arrosto», cioè si usa come ingrediente per aromatizzare una carne pregiata, una vivanda di lusso. È uno dei “segreti” con cui il patrimonio culinario popolare spezza le barriere ideologiche del privilegio sociale e viene assunto anche dalle élite, secondo modalità che ritroviamo nei libri di cucina medievali e rinascimentali, destinati alle classi alte della società, nobili e alta borghesia, ma con ampie aperture alla cultura popolare. I meccanismi sono semplici: prendere una ricetta povera, o un ingrediente povero, e nobilitarli facendoli parte di un diverso sistema di cucina, arricchendo la ricetta con ingredienti preziosi (per esempio, aggiungere spezie abbondanti su una semplice zuppa di cereali o di legumi) oppure inserendo quegli ingredienti in preparazioni più complesse (il caso dell’aglio «conficcato nel papero» da questo punto di vista è esemplare). Il gusto si disegna secondo confini sociali precisi, sul piano ideologico. Ma facilmente supera quei confini, nel momento in cui il signore si appropria di un piatto o di un sapore contadino. I segni dell’identità sociale in questo modo diventano patrimonio comune. Forse avviene anche il contrario, forse anche i contadini accolgono valori e sapori delle classi alte, ma di questo parleremo un’altra volta. Bagna cauda Pesto Allioli Bagnetto verde Cento ricette per la più celebre delle salse agliate: obbiettivo, ridurne l’impatto gustativo Ammollati in acqua o latte, gli spicchi tritati si cuociono a fuoco basso nel coccio con olio, acciughe e poco burro, fino a diventare crema Nel mortaio di marmo, si pestano in successione aglio (l’ideale è quello ligure, uno spicchio ogni 30 foglie) sale grosso, basilico, pinoli, parmigiano, pecorino L’olio ligure, non aggressivo, va aggiunto a goccia Di matrice spagnola, prevede l’uso degli spicchi crudi, pestati nel mortaio e lavorati con poco sale. Una volta ammorbiditi, si incorpora il tuorlo d’uovo e si monta con l’olio come una maionese, aggiungendo alcune gocce di aceto o limone Si mescolano con l’olio, tritati finemente, prezzemolo, aglio, acciughe, mollica imbevuta nell’aceto e strizzata. Si può caratterizzare con peperoncino, capperi, cetriolini, cipollotti, tuorlo sodo. Meglio lasciarlo riposare in frigo qualche ora 46 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 30 LUGLIO 2006 le tendenze Tessuti ultraleggeri, alluminio, titanio, gomma, poliuretano: il baule Tempo di vacanze e la valigia di antica memoria si trasformano in accessori fashion pensati per offrire la massima capienza e l’immagine più trendy Capita così che anche l’oggetto più piccolo abbia il suo contenitore griffato, perché portare con sé iPod , computer o lettore cd non sia mai più un problema per i nuovi viaggiatori BASTA PER UN WEEKEND Linee essenziali per la valigetta da weekend Le Sac V 50 di Hermès. In pelle color visone PROFESSIONE DOTTORE DEGNO DI NOTA Assomiglia alle vecchie borse da dottore il modello proposto da Bridge. In pelle invecchiata con profili in ottone Non solo una trovata per farsi notare. È il comodo borsone in cervo giallo firmato David & Scotti TOUR A COLORI Sono disponibili in molti colori e tre dimensioni diverse le valigie rigide di Carpisa. Dotate di manico estensibile e rotelle GITA LAMPO ELEGANZA D’ANNATA L’idea per una gita lampo? La sacca in tessuto arancio di Salvatore Ferragamo. Con manici in cuoio e tasca frontale con chiusura zip Fu lanciata nel 1924 ed era usata solo all'interno di valigie rigide. Oggi la Keepall di Louis Vuitton in cuoio monogrammato è un cult in Viaggio Elogio della leggerezza il bagaglio perde peso Repubblica Nazionale 46 30/07/2006 JACARANDA CARACCIOLO FALCK ll’inizio del secolo scorso quando Rita De Acosta Lydig, meglio nota come la duchessa D’Alba, arrivava all’hotel Ritz di Parigi per il suo tradizionale soggiorno annuale, non passava inosservata. La celebre dama si portava dietro un seguito degno di nota: un maggiordomo, un autista, un parrucchiere, una massaggiatrice, una segretaria e soprattutto quaranta bauli firmati Louis Vuitton. Vere e proprie opere d’artigianato traboccanti di abiti da gran sera, cappelli per ogni ora del giorno e scarpette fatte su misura. Eppure nessuno si stupiva, perché l’elegante nobildonna, più volte ritratta da Giovanni Boldini incantato dalla sua bellezza, non era che una delle tante eclettiche viaggiatrici del suo tempo. Signore note tanto per la loro eleganza quanto per la cura maniacale che dedicavano alla preparazione dei propri spostamenti. Sono passati cento anni durante i quali il nostro modo di viaggiare, ma anche e soprattutto di prepararci al viaggio, si è evoluto ogni giorno di più. I pesanti bauli di allora, indispensabili per i lunghi tragitti in treno e/o in transatlantico, sono stati via via sostituiti da valigie, da borse destrutturate e, infine, dal mitico trolley su rotelle. Modelli ultramoderni realizzati con materiali tecnologici, come l’alluminio o il titanio, il poliuretano o la gomma, dalle elevate prestazioni tecniche. Riempiti non più di veli e chiffon, ma di accessori e vestiti studiati ad hoc: abiti che non necessitano di stiratura, giacche pieghevoli e pantaloni che A con un colpo di zip diventano shorts. Insomma piano piano l’arte del viaggiare con stile è stata sostituita da quella di sapersi muovere, da una parte all’altra del mondo, con sempre maggiore velocità ed efficienza. Le storiche aziende di valigeria, ma anche i grandi stilisti e i più affermati designer hanno cominciato a fare a gara per sfornare il bagaglio — valigia o beauty case, porta-computer o ventiquattrore, zaino o sacca estensibile — più adatto alle esigenze del traveller moderno. Un contenitore resistente ma al tempo stesso leggero, pratico ma anche trendy. Studiato fin nei minimi dettagli per contenere al meglio i sempre più numerosi gadget che ognuno di noi ha voglia di portarsi in vacanza, dall’iPod al personal computer, dal cellulare al blackberry. Il risultato? Chi decide di partire ha solo l’imbarazzo della scelta. Si può optare per i modelli vintage proposti, ad esempio, da Louis Vuitton o da Gucci, o scegliere una soluzione fashion come il trolley in coccodrillo rosa shocking firmato Prada. Si può guardare al futuro con le idee realizzate per Samsonite da geni del design come Philippe Starck e Marc Newson, o indirizzarsi verso l’eleganza minimal della gamma in alluminio ultraleggero firmata dalla casa tedesca Rimowa. Si può scegliere l’eleganza di Valextra o la praticità di Desley, la creatività di Gap o l’ingegnosità di Mandarina Duck. Ma qualsiasi sia la scelta una cosa è certa: oggi come ieri, chi decide di mettersi in viaggio si prepara con grande cura. Anche se i quaranta bauli della duchessa sono stati sostituiti da valigie grandi poco più dei beauty case usati una volta. E nei trolley più tecnologici trovano il giusto ordine abiti SCELTO PER CALCOLO Il cronografo Cs Pilot di Seiko è dotato di lunetta e ghiera speciali: può compiere operazioni aritmetiche e calcoli della velocità SENZA ARIDITÀ Combatte l'aridità della pelle la linea di creme e fluidi Aquasource Biotherm Il kit in formato mini è ideale per i viaggi che non si stirano pantaloni e gonne trasformiste e mini beauty case completissimi QUASI HIPPY Ispirazione hippy per il beauty case di Samsonite Con fodere rosa shocking e stampe a fiori DOMENICA 30 LUGLIO 2006 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 47 LA PUBBLICITÀ SIGNORE A BORDO A centro pagina, un manifesto pubblicitario di Marcello Dudovich (1878-1962) per i grandi magazzini “La Rinascente” Milano, 1925 Prada rilancia un oggetto da viaggio per signore che sembrava caduto in disuso: la cappelliera in tela ecrù con profili rosa shocking ATTENTI AL BEBÈ Portare un bebè in viaggio non è mai facile. Per questo Aprica propone Sling, un innovativo modello di marsupio porta-enfant ANIMA SPORTIVA Si chiama Kubra lo zaino in tessuto tecnico firmato Nannini Dotato di scomparto porta documenti Così si riscopre il vero spaesamento Dimenticare la meta per capire il mondo UMBERTO GALIMBERTI uando, in procinto di iniziare un viaggio, vedo caricare le macchine fino all’inverosimile, in tutti quegli oggetti che riempiono il bagagliaio, i sedili posteriori e perfino il tetto delle vetture, scorgo solo la paura di abbandonare la casa, le proprie collaudate abitudini e l’incapacità di offrirsi all’insolito che è la vera promessa segreta di ogni viaggio. Certo se il viaggio è un pacchetto d’agenzia, allora, anche se la sua meta sono i confini del mondo, non c’è spaesamento che percorra l’anima come un brivido che la rende instabile. Ma quando viaggiare è offrirsi al rischio di non essere compresi e, al limite, neppure letti come uomini o come simili, allora è la terra a offrirsi senza nessun orizzonte, è il cielo a coprire una vastità senza riferimento, è la storia a inabissarsi nei secoli per evocare tutta quell’immaginazione che mai avremmo sospettato avesse riscontri di realtà. Il sole sorge insolito e la notte copre tutte le insidie che l’uomo primitivo temeva nascoste nel buio. Le facce delle persone appaiono nei loro lineamenti indecifrabili, dove l’intenzione non si traduce in linguaggio e la comprensione è affidata all’empatia dell’animale. Qui il viaggiatore incontra quella parte dell’anima che è la meno spirituale perché è la più istintiva. L’anima-animale appunto. E istinto qui vuol dire fondersi con gli odori, le variazioni di temperatura, i suoni, il vento, con il sole che cuoce sulla testa e porta i pensieri su vie associative inconsuete, dove ciò che alla fine si trova è la giusta dimensione di sé. Questa dimensione significa consapevolezza della propria spaesata e casuale esistenza su una terra, che quando non è tecnicamente organizzata come la nostra, dove ogni oggetto esprime nella sua funzionalità il suo senso, mostra, devastante nella sua vastità, la sua totale indifferenza alla sorte umana e soprattutto alla nostra sorte. Da questo disincanto e dall’instabilità che ne scaturisce nasce un paesaggio insolito, simile allo spaesamento, in cui si annuncia una libertà diversa, non più quella del padrone di casa che domina la sua abitazione, ma quella del viandante che al limite non domina neppure la sua via. Consegnato al nomadismo, l’uomo spinge avanti i suoi passi, ma non più con l’intenzione di trovare qualcosa: la casa, la patria, l’amore, la verità, la salvezza. Anche queste parole nel viaggio si fanno nomadi, non più mete dell’intenzione o dell’azione umana, ma doni del paesaggio che ha reso l’uomo viandante senza una meta, perché è il paesaggio stesso la meta, basta percepirlo, sentirlo, accoglierlo nell’assenza spaesante del suo senza-confine. Facendoci uscire dall’abituale e quindi dalle nostre abitudini, il viaggio ci espone all’insolito dove è possibile scoprire, ma solo per una notte o per un giorno, come il cielo si stende su quella terra, come la notte dispiega nel cielo costellazioni ignote, come la religione aduna le speranze, come la tradizione fa popolo, la solitudine fa deserto, l’iscrizione fa storia, il fiume fa ansa, la terra fa solco, in quella rapida sequenza con cui si succedono le esperienze del mondo che sfuggono a qualsiasi tentativo che cerchi di fissarle e di disporle in successione ordinata, perché, al di là di ogni progetto orientato, il viaggiatore sa che la totalità è sfuggente, che il non-senso contamina il senso, che il possibile eccede sul reale e che ogni progetto che tenta la comprensione e l’abbraccio totale è follia. Ma chi sono i veri viaggiatori? Sono coloro che non trascurano l’intervallo tra l’inizio e la fine, che non viaggiano solo per arrivare perché per coloro che vogliono arrivare, per chi mira alle cose ultime, ma anche per chi mira alle mete prossime, del viaggio ne è nulla. Le terre che egli attraversa non esistono. Conta solo la meta. Egli viaggia per “arrivare”, non per “viaggiare”. Così il viaggio muore durante il viaggio, muore in ogni tappa che lo avvicina alla meta. E con il viaggio muore il viaggiatore stesso fissato sulla meta e cieco all’esperienza che la via dispiega al viandante che sa abitare il paesaggio e, insieme, al paesaggio sa dire addio. L’andare che salva se stesso cancellando la meta inaugura allora una visione del mondo che è radicalmente diversa da quella dischiusa dalla prospettiva della meta che cancella l’andare. Nel primo caso si aderisce al mondo come a un’offerta di accadimenti dove si può prendere provvisoria dimora finché l’accadimento lo concede, nel secondo caso si aderisce al senso anticipato che cancella tutti gli accadimenti che, non percepiti, passano accanto agli uomini senza lasciar traccia, puro spreco della ricchezza del mondo. Se siamo disposti a rinunciare alle nostre radicate abitudini, allora il viaggio ci offre un modello di cultura che educa perché non immobilizza, perché desitua, perché non offre mai un terreno stabile e sicuro su cui edificare le nostre costruzioni, perché l’apertura che chiede sfiora l’abisso dove non c’è nulla di rassicurante, ma dove è anche scongiurata la monotonia della ripetizione dell’andare e riandare sulla stessa strada, con i soliti compagni di viaggio, con tutto il conforto delle nostre cose che, sotto la specie della sicurezza, sigillano solo la nostra chiusura al mondo. Q EFFETTO DIGITALE Repubblica Nazionale 47 30/07/2006 Christian Dior lancia una linea di borse e beauty case chiamata Digital È destinata a contenere i nostri gadget tecnologici, dall'iPod alla macchina digitale NON FA UNA PIEGA Il classico giaccone Barbour in tela rosso-arancio con colletto di velluto un must per i traveller Leggero e pieghevole si infila in ogni valigia 48 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 30 LUGLIO 2006 l’incontro Il 20 agosto compirà 70 anni, ma non ha timore della vecchiaia e soprattutto non ha alcuna voglia di smettere di danzare perché “a ogni età si può migliorare” E pensare che da piccola sognava di fare la parrucchiera, amava la rumba e alla scuola della Scala fu ammessa “per il rotto della cuffia”. Ma da allora, lei, tenace, dolce eppure forte come l’acciaio, non si è più fermata perché mai ha creduto di essere finalmente“arrivata” Vita da étoile Carla Fracci l 20 agosto Nostra Signora della Danza compie settant’anni, «ma non ho timore della vecchiaia, il fisico tiene. Ogni giorno lavoro alla sbarra con le ballerine del Teatro dell’Opera, e studiando osservo le ragazze, le correggo, mostro un gesto o un passo. Mi dicono che sono unica, speciale. Non è vero! Semplicemente voglio andare avanti. La lezione non è un riscaldamento dei muscoli: a ogni età serve per migliorare. Anche al culmine della carriera non ho mai pensato: eccomi arrivata. Mi sento sempre sotto esame, mi metto di continuo in discussione. Credo che sia questa la mia forza». Carla Fracci è d’acciaio. Potente, solida, tenace. Altro che evanescente. Chi la conosce sa il suo senso pratico lombardo, la sua salute del fare, la sua assoluta estraneità a svenevolezze. Dirige da sei anni il ballo all’Opera di Roma: sceglie, coordina, organizza, fa stagioni. Le altre, alla sua età, sono in pensione. Figuriamoci le ballerine, la cui carriera corre in un soffio. Invece lei ancora è in scena in ruoli mimici giusti: Regina Madre nel Lago dei cigni, “grande mère” nello Schiaccianoci. Le basta un gesto del braccio, o una camminata in palcoscenico, per dimostrarsi unica, “diversa”. E quando viaggia in Italia o nel mondo la gente la riconosce, i giovani le fanno festa, le bambine la inseguono per gli autografi. Fracci è così: un’immagine di tutti e per tutti. Cenerentola e Grand’Ufficiale della Repubblica, emblema dell’Italia come la Loren e gli spaghetti, protagonista di un’ascesa che sembra una fiaba: dal nulla alle vette della gloria, dalla mingherlina figlia di un tranviere alla diva del balletto. Riverberata dagli abiti immancabilmente bianchi, sovrana di uno stile angelicato e senza tempo. Altro che femminismo, altro per il rotto della cuffia. Alla fine della prima selezione fui inserita nel gruppo delle bambine “da rivedere”. Poi mi prese, ma «solo per il faccino»: così mi disse, poco confortante. Negli anni delle classi entravo alla Scala da via Verdi, l’ingresso delle maestranze, delle sarte, degli operai e di noi allieve. Si saliva a piedi fino al sesto piano, con la schiscetta, il contenitore per il pasto di mezzogiorno. All’inizio non capivo il senso della sbarra, mi pareva una prigione. Sognavo la mia rumba e i miei conigli». I genitori, dice, erano «discreti, mai invadenti. Gente solida e serena anche nel sacrificio. Mia madre, operaia alla Innocenti, per arrotondare faceva un secondo lavoro: metteva i datteri nelle scatole. Papà era un uomo allegro. Quando passava col tram sotto la Scala scampanellava per farmi festa. Purtroppo è andato in pensione troppo presto ed è finito in depressione. Lui era fatto per lavorare, come me. Nell’ultimo periodo non riusciva più a vedere i miei spettacoli. Stava fino a un certo punto e doveva uscire dal teatro, si emozionava troppo. Fisicamente gli somiglio, devo a lui questo mio corpo Mio padre era un uomo allegro, quando passava col tram sotto la Scala mi scampanellava Era fatto per lavorare, come me. Devo a lui anche questo mio corpo asciutto... FOTO A3 Repubblica Nazionale 48 30/07/2006 I ROMA che mode. Fracci ha reso il tutù e le punte un sogno popolare, restituito i paradisi del balletto all’uomo della strada: «Ho danzato nei tendoni, nelle chiese, nelle piazze. Sono stata una pioniera del decentramento. Volevo che questo mio lavoro non fosse d’élite, relegato alle scatole d’oro dei teatri d’opera. E anche quand’ero impegnata sulle scene più importanti del mondo sono sempre tornata in Italia per esibirmi nei posti più dimenticati e impensabili. Nureyev mi sgridava: chi te lo fa fare, ti stanchi troppo, arrivi da New York e devi andare, che so, a Budrio... Ma a me piaceva così, e il pubblico mi ha sempre ripagato». Siamo nella sua casa di Roma, chiara e fresca, divani bianchi e tanta luce. Il Foro Romano è lì sotto, ti sporgi dalla finestra e quasi tocchi una colonna. «Ho anche casa a Milano, Firenze, Venezia, Verona. È il mio lusso. Mi piace lavorare in città diverse stando a casa mia». È sempre uguale a se stessa, trasparente d’incarnato, molto bella. Il vestito è candido e pieno di pizzi e merletti, le mani sottili sono poggiate in grembo. È così giusta che pare finta. Lo disse un suo collega illustre e cattivo: «Vien voglia di gridare: basta con la controfigura, datemi la Fracci vera!» Ma la Fracci vera è identica alla sua controfigura. Ballerina perfetta. Specchio concreto della propria vocazione. Eppure, dice, non scelse mai di fare danza, «proprio non ci pensavo. Da bambina ignoravo cosa fosse il balletto. Durante la guerra mio padre era stato dato per disperso in Russia, e la mamma portò me e mia sorella Marisa dagli zii a Gazzolo degli Ippoliti, in provincia di Mantova. Amavo la campagna, i fiori, le corse nei prati. Rubavo l’uva, parlavo con i conigli. Passavo dei periodi con la nonna nella campagna di Cremona, con le galline a beccare lungo i fossi. Non c’era la televisione, ci si divertiva con nulla. Quando mio padre tornò ci trasferimmo a Milano. Prima abitavamo a via Tallone, in periferia, col bar-biliardo a due passi e il grammofono a manovella che suonava le canzoni di Alberto Rabagliati e Natalino Otto, poi, anni più tardi, a via Tommei, nella zona di viale Molise, in una casa di ringhiera, col gabinetto fuori dalla porta. A me in città è mancata sempre la campagna, mi pesava la costrizione della scuola. La marinavo per scappare a raccogliere margherite nei campi dietro alle case popolari». Sognava di fare la parrucchiera: «A casa pettinavo tutti. Ma mi muovevo bene, seguivo la musica con naturalezza. Ero un’attrazione tra gli adulti che ballavano la rumba sulla pista del liscio al laghetto di Redecesio, dopolavoro dell’Azienda Tranviaria, dove si andava la domenica. Così un’amica dei miei, col padre orchestrale alla Scala, li convinse a portarmi all’esame d’ammissione alla scuola di ballo. La mia insegnante, la Mazzucchelli, mi ammise asciutto. Una fortuna, perché sono golosa. Mi piace la pasta, amo un bicchiere di vino rosso la sera». Negli anni Cinquanta, per Carla, giungono i primi, clamorosi successi. Il Pas de Quatre a Nervi la svela, sfolgorante, accanto a tre dive come Alicia Markova, Yvette Chauvirée e Margaret Schanne. La figlia del tranviere prende il volo: Giselle alla Scala, Giulietta a Venezia. La paragonano a Margot Fonteyn, stesso stile parco ed esatto, stesso struggente romanticismo. «Io veneravo la Fonteyn, fin da quando la vidi per la prima volta. Avevo undici anni, lei danzava col Royal Ballet alla Scala. Era la principessa Aurora, tutta magia e bellezza. Nelle prove il coreografo, Frederick Ashton, le corresse la posizione di un mignolo. Capii quanto nella grandezza contino i dettagli». Osservare i massimi artisti, racconta, è stato sempre fondamentale: «Quando Alicia Markova venne a ballare alla Scala avrà avuto 45 anni. Le altre ragazze la chiamavano la vecchietta. Per me era fantastica. Che nobiltà, che incanto di piedini». Dagli anni Sessanta le si apre la scena internazionale: Londra, Stoccarda, Monaco, Montecarlo, il lungo contratto con l’American Ballet Theatre. Lavora con coreografi come Cranko, Tudor, Balanchine, Agnes De Mille, Mac Millan e Tetley, e accanto a partner come Erik Bruhn, Bortoluzzi, Vassiliev e Baryshnikov. E c’è l’intensa sintonia con Nureyev, «di cui s’è detto che aveva un caratteraccio e forse era vero, ma sapeva anche essere tenero e di gran cuore, molto generoso. Insegnava il coraggio, lanciava sfide continue. In scena poteva fare piccoli trucchi, metterti alla prova, darti l’assillo non facendosi trovare dove avrebbe dovuto essere, o ritardando un’entrata, cose del genere. Ma in questo modo mi ha fortificato. Eravamo amici davvero. Quand’era molto malato, alla fine, ci parlavamo spesso al telefono. Era sfrenato, faceva un mucchio di follie. Mentre si lavorava alla Scala poteva decidere di volare a New York nell’unico giorno di riposo. Gli dicevo: ma perché non ti fermi un attimo? E lui: se mi fermo che faccio? Tu hai una famiglia, io non ho nessuno». La famiglia di Carla cominciò dall’incontro con Beppe Menegatti, suo compagno da oltre mezzo secolo: «Siamo insieme dal ‘54, ci sposammo nel ‘64. La prima volta ci incrociammo alla Scala, lui lavorava come assistente di Visconti. Spiavo le prove, lo guardavo dalla balaustra, mi sembrava irraggiungibile e bellissimo. Erano i tempi della Callas, di Giulini e Bernstein. Stagioni d’oro, spettacoli meravigliosi». Beppe sarebbe divenuto suo regista d’elezione, il pianificatore della sua immagine, il provocatore dei suoi tanti volti, non solo silfide e cigno ma anche Medea e Isadora, Fedra e Dama delle Camelie, Duse e Alma Mahler, Cleopatra e Signora Stone di Tennessee Williams. «Beppe mi ha permesso di spaziare, mi ha dato ruoli drammatici e lirici, mi ha fatto uscire dagli stereotipi. Ricordo che Paola Borboni era furiosa che ci sposassimo. Diceva che la danzatrice deve rimanere casta e libera. Sgridava Beppe: lasciala stare! Lei profuma l’Italia! Poi però, quando nel ‘69 nacque nostro figlio Francesco, loro due fecero pace. Desideravo tanto diventare madre, anche se all’epoca era una cosa insolita per una ballerina. Oggi Francesco è architetto e io sono nonna. Per me è come rivivere la maternità. Il mio nipotino ha due anni ed è talmente intelligente, sono così orgogliosa». Visto che anche una nonna può danzare, «continuano a propormi personaggi. Alicia Alonso ha fatto una coreografia per me, Desnuda luz del amor, che interpreterò a Cuba in novembre. E Yoshito Ohno, figlio di Kazuo Ohno, leggendario creatore della danza moderna giapponese, mi ha offerto uno spettacolo a Tokyo nel gennaio 2007». Insiste che la sua fortuna sta nell’avere conosciuto le personalità più grandi: «Ho avuto incontri straordinari, come Visconti, burbero e dolcissimo. Come Herbert Ross, per cui ho fatto la Karsavina nel film Nijinsky. O come Peter Ustinov, con cui ho girato Le Ballerine. E la Cederna, e Manzù. E il magnifico Eduardo. In un galà in suo onore, a Viareggio, interpretai Filumena Marturano, proprio il ruolo di Titina, e lui mi mandò un biglietto con su scritto: “ora posso chiamarti sorella”. Ricordo il fascino e l’ironia di De Sica. Voleva affidarmi ne La Vacanza il ruolo che poi fece la Bolkan. E rammento le estati con Montale, a Forte dei Marmi. Ci si ritrovava ogni giorno tra persone come Henry Moore, Marino Marini, Guttuso. Montale disegnava sempre: il mare, le Apuane... Usava tutto, dal vino al rossetto. Mi dedicò una bellissima poesia: La danzatrice stanca. No, io a settant’anni non mi sento affatto stanca. E sono quello che sono anche grazie a loro». ‘‘ LEONETTA BENTIVOGLIO
Scarica