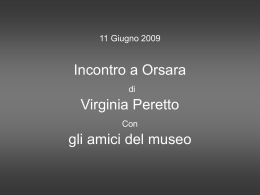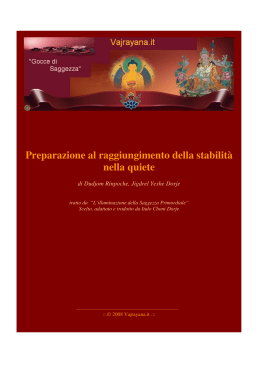Titolo originale dell’opera: “Abbiamo perso lo smalto. L’insicurezza di 15 oggetti” MACCHINA DEI SOGNI associazione culturale cinema&scrittura È un motore alimentato dal propellente della creatività e messo in moto dalla comunità solidale di tutti gli ingegni impazienti. Genera conoscenza connessioni incontri, alimenta passioni, traduce sogni in scintille e non danneggia l’ozono. www.macchinadeisogni.org [email protected] collana LIBRI della MACCHINA DEI SOGNI volume 14 © 2011 by MACCHINA DEI SOGNI Corso NARRATORI DI STORIE 2011 Settembre 2011 EDIZIONI AUTOPRODOTTE traduzioni previste in tutte le lingue richieste Progetto MACCHINA DEI SOGNI Art director: Jasmina von Büren – www.xsdsign.ch Coordinamento del progetto: chicca profumo Redazione: Loretta Patrini am bi ab er op so lo o alt sm a z z e r u c : i i t t s e g n g i ’ o >L 5 1 i d Indice 01 - Valentina Sutti > Smalto per unghie - Vestito vintage:- pag. 5 02 - Danila Iaquinto > Vestito vintage - Palla di vetro con neve:- pag. 17 03 - Morgen Miragoli > Palla di vetro con neve - Vibratore:- pag. 24 04 - Alice Tedeschi > Vibratore - Bastone da passeggio:- pag. 30 05 - Anna Ornaghi > Bastone da passeggio - Fumetto manga:- pag. 38 06 - Irina Marazzi > Fumetto manga - Ricettario:- pag. 43 07 - Alessandro Mariotti > Ricettario - Clessidra:- pag. 49 08 - Chiara Blau > Clessidra - Libro con dedica:- pag. 54 09 - Claudia Redaelli > Libro con dedica - Carillon:- pag. 61 10 - Marco Mastromattei > Carillon - Cartolina spedita:- pag. 65 11 - Chiara D’Amico > Cartolina spedita - Portasigarette:- pag. 74 12 - Giovanni Pirelli > Portasigarette - Manette:- pag. 88 13 - Beatrice Fossati > Manette - Biberon:- pag. 97 14 - Matteo Pianosi > Biberon - Binocolo:- pag. 103 15 - Donatella Milani > Binocolo - Smalto per unghie:- pag. 110 16 - Costanza Di Robilant > tutti gli oggetti. pag.114 Fuck-simile 01 di Valentina Sutti > Smalto per ungh ie - Vestito vintage :- LIQUIDAZIONE TOTALE UN VASTISSIMO ASSORTIMENTO DI CAPI IN PELLE, TESSUTO, SHEARLING E PELLICCERIA DI PRODUZIONE PROPRIA E DELLE MIGLIORI MARCHE RIGOROSAMENTE "MADE IN ITALY" SUPER PROMOZIONE - GRANDI SCONTI PER IMMINENTE CHIUSURA DELL'ATTIVITA', AVANT GARDE PELLICCERIA ATTUA UNA SVENDITA, TUTTO A CINQUANTA EURO. Uno strato croccante di piccole foglie, senza nome, sfrigola sul pavimento di marmo rosa, freddo e rigato. Il nero si è incastrato, profondo, nelle fessure, nei dislivelli, nelle gole irregolari. Un gioco di luce e ombra, solo che quella non è ombra, è sporco. Si scivola su questo pavimento, come tutti gli anni, gli inverni, in questa città, Milano. Una pellicola di sudore insano e denso. Le panchine di questo spiazzo nascono, rosa, funghi di pietra, poco probabili. Appoggiati a questo pavimento di noiosi rombi, due scarpe abusate. Pare che abbiano calpestato la terra del mondo intero, ma al contrario, con il dorso. Una spatolata di cuoio, grattato e lurido. Di contro, lo spesso strato di gomma secca e solida pare non essere soggetto alle regole del tempo e dell’usura, un controsenso, fin dal principio. Ora, ci sono quelli che sostengono che le persone si possano intravedere dagli occhi, chi dalle mani, chi dalla bocca. Per me il modo più efficace per capire chi si ha davanti è quello di osservare che tipo di scarpe hanno scelto i piedi della persona in questione. I piedi, le scarpe; le spalle, le giacche; le gambe, i pantaloni; i polsi, i gemelli o gli orologi. Ogni pezzo di corpo sceglie come coprirsi. In queste scelte si nasconde, floscio come un’ostrica e impaurito, il carattere. L’uomo dalle scarpe sottosopra è vuoto. Vuoto come un appartamento >5 :- appena lasciato, come una macchina d’epoca sotto un lenzuolo, come la bottiglia di vino che non osa allontanarsi dal suo piede, per l’appunto, in cerca di coccole, a zampe all’aria, girandosi e rigirandosi, spostata da chissà quale dispettosa divinità pagana. Vuoto, come quelle confezioni vuote di cheeseburger che riempiono l’inadeguato cestino alle sue spalle. Accartocciato. Un solo breve tratto del suo corpo, più per necessità che per scelta, sembra essere su quella panchina, in quello spiazzo di quella città. Vigile. Il braccio destro, obliquo e teso, nervoso, preso com’è a sorreggere il peso del resto del corpo, tutto. «Devo lavarmi la faccia. Mi sento impiastricciato e ho la nausea.» Il braccio si piega lento, un angolo vecchio. Il peso bascula come un galleggiante di cent’anni, i piedi si riaccendono. Quella cartaccia abbandonata e biodegradabile si è risvegliata. Si alza facendo leva sulle braccia e barcolla per un attimo. Per un attimo il suo naso sembra essere irresistibilmente affascinato dal puzzo del pavimento. Penso il peggio, ma non dovrei. L’uomo si raddrizza di scatto, come ripreso da un caporale severo e perverso e si avvia, a passo incerto, verso la fontanella dall’altra parte dello spiazzo. Lo seguo con lo sguardo. È mio. «Che bellezza l’acqua, oddio che meraviglia!» Il barbone che ha catturato il mio sguardo si rinfresca lavandosi la faccia con l’acqua ghiacciata della fontanella, se la passa in bocca più volte, in parte la sputa, il resto lo inghiotte. Rivoli scendono dietro il collo, insaponandosi con lo sporco della camicia di flanella sgualcita. Il suo puzzo arriva fino a me che lo guardo da almeno una decina di metri di distanza. I capelli unti e crespi, dove la vecchiaia fatica a prender posto, tanto è la sozzura di quella testa. È una meraviglia. Sono sulla jeep di qualche guardiacaccia, sto vivendo l’avventura di un improbabile safari all’italiana e osservo eccitata, attraverso le lenti di un cannocchiale, un esemplare raro. Un animale, che se esiste, avrà pure una qualche sorta di senso. Voglio lasciargli qualcosa di me. Prendo manciate di secondi e poi ecco, mi strappo le unghie finte, rosse, del mio migliore smalto. Ne prendo una, mi gratto il naso. Sono simpatiche, grottesche, queste unghie finte. Siamo finti. Riflessi di cera, manichini. Eppure qualcosa gira. Le raccolgo, le metto nel palmo della mano sinistra e chiudo il tutto, senza fretta. Osservo le unghie collose, quelle vere, devo smetterla di mangiarle, sono rovinate e inquietanti. Mi avvicino. Lui non si accorge di nulla. Sono la sua ombra sbagliata >6 :- per un po’. Finalmente si volta. Mi guarda, che buffo. Ha delle sopracciglia enormi e irregolari, con peli qua e là, lunghissimi; occhi piccoli, incastrati a forza fra quel nasone poroso e rossastro e quelle sopracciglia da gufo. Resto in silenzio, lo fisso. Anche lui non parla, mi guarda inespressivo mentre la fontanella scroscia acqua coprendo le nostre voci, forse per questo non parliamo, quel suono fragoroso basta. Apro la mano, piano piano, come avessi catturato una farfalla unica al mondo. Guardo in giù, guarda in giù. Richiudo il palmo e faccio strusciare la mano sul lato del suo cappotto, ruvido e appiccicoso. La nascondo nella tasca e lascio cadere il grottesco bottino. Lui non fa una piega. Faccio un passo indietro. «Patty.» Resto immobile e in silenzio. Forse si aspetta qualcosa. Forse è per questo che dopo pochi secondi si gira e se ne va, senza voltarsi. Strana donna. Cammina come un’anatra, eppure c’è qualcosa di molto sensuale in lei. Stivali di pelle e fibbie, troppo grandi per la sua stazza minuta. Un cappello verde scuro le copre tutto. Di che colore avrà i capelli? Saranno lunghi o corti? Non vedo nemmeno che vestito abbia indosso, con quel cappotto troppo lungo, con le spalle squadrate, sembra un capitano d’altri tempi. Peccato. Patty. Cos’è che m’ha lasciato in tasca? Frugo e sento piccoli pezzetti secchi. Ne prendo un paio. Li guardo, ci metto un po’ a capire. Sono unghie, per dio. Unghie rosse. Le prendo tutte. Al tatto provo uno strano senso di fastidio, come piccoli frammenti estranei. Mi irrigidisco. A passi veloci mi dirigo verso il cestino della spazzatura e lancio quei cinque alieni di plastica secca. Mi rigiro, afferro il carrello, faccio per andarmene, abbasso lo sguardo, vedo la bottiglia di vino, la prendo per il collo, sono un omicida suicida. La butto insieme alle unghie disgustose. Tre passi, poi la mano affonda nella merda. Nelle foglie di lattuga dimenticate, nelle umidità del genere umano. Ne riafferro una per la punta, una solamente. Non so nemmeno perché. Rivedo la mia mano riaffiorare dalla sporcizia pudica di questa città. Non ci posso credere. Non può essere vero. Una banconota da cinquanta euro attaccata all’alieno rosso. La guardo veloce e rapace. Mi infilo tutto in tasca, unghia e soldi, quasi in preda alla vergogna, guardandomi di soppiatto in giro. La sento liscia al tatto. Molto liscia. Non me lo ricordavo così, il denaro. Me lo ricordavo diverso. >7 :- Non importa. Mi siedo, ho paura di guardarlo questo pezzo di carta, mi sento a disagio. Insomma, penso che se tutta questa faccenda è successa – le unghie, la donna strana, la grana – tutto questo avrà un senso. Queste cose non capitano così. Ci penso, con calma. Ordino al cuore di battere più lentamente, alle mani di smettere di tremare. Cosa faccio con questo cinquantone? Saranno dieci anni che non mi girano per le mani più di un paio di monete per volta. Cosa me ne faccio dei soldi? Vado a fare la spesa. Cammino per una mezz’ora buona, mi pregusto il momento. Finalmente arrivo. Visto da fuori, quest’enorme supermercato, sembra uno ziggurat prefabbricato. Piccole, grandi macchine, schizzano in tutte le direzioni, suonandosi contro, fermandosi, ripartendo velocemente. Carrelli avanti e indietro, rumorosi e traballanti. Io uso il mio, libero, senza catenelle e cazzate simili. Entro. Un vortice d’aria calda e profumata di mille odori mi arriva in faccia. Sono spaesato, non so dove andare. Osservo la fiumana di gente e la seguo. A sinistra: piante, piantine, vasetti, macchie verdi di varie tonalità. Davanti un bar. Un bar? Nel supermercato? A quanto pare sì, bar Atlantic. Sorrido, solo un accenno. Penso che vorrei tanto farmi un caffè e poi fumarci sopra una Marlboro rossa, morbida. Faccio il giro, vedo un po’ di cose e poi mi tengo da parte i soldi sia per il caffè che per le sigarette. Quanto costeranno ora? Due? Tre euro? Un’esagerazione comunque. Davanti a me l’ingresso vero e proprio. Sembra di varcare il confine di una qualche nazione, assomiglia più a una dogana che a un supermercato. Che stranezza. Ma cosa voglio davvero? Non posso non essere preparato per una cosa del genere. Devo comprare esattamente quello che mi serve, che voglio. Intanto mi accorgo che la saliva si fa avanti. Avidità. Gola. Brutta faccenda. Prendo un foglietto da una busta del mio carrello, la matita scheggiata da un’altra busta. Lista: arance/mele/pere/uva? tonno formaggi duri fazzoletti salame, speck vino biscotti >8 :- cioccolato vino schiuma da barba rasoi sapone shampoo Mi serve altro? Non mi sembra, no. Cammino facendomi strada con il carrello, passo le sbarre. Che lingua parleranno da questa parte? È cambiato tutto o forse niente. L’ultima volta che ho messo piede in un supermercato non avrò avuto più di trentacinque anni, ed ero con Rosanna. No. Solo. Adoravo fare la spesa con lei, per lei, per noi. Scegliere i formaggi, pecorino, che le piaceva tanto, e poi osservare minuziosamente le varie conserve da abbinarci, cipolle o mele cotogne, si ricadeva sempre su quelle. La maniacalità delle piccole cose, delle piccole scelte, che ci legava, stretti, prendendoci tempo prezioso, quel tempo che lascia i demoni fuori, che ti fa sentire calmo e quasi appagato. Correre al reparto dei dolci e prenderle i biscotti al cioccolato e, ancora con la confezione in mano, pregustare il momento in cui, dopo aver fatto l’amore, con troppa saliva, saremmo rimasti lì, io palle all’aria e lei a gambe incrociate, a gustarceli quei buonissimi biscotti pieni di conservanti e dolcissimi. Con bicchieroni di latte freddo che scivolano dentro, trascinando detriti di cioccolato, infilati fra i denti e sul palato. Amore, poter essere puliti e mostrare a qualcuno che in fondo sei rimasto quel bambino, curioso, arrogante e impaurito. Farglieli trovare in cima al carrello. Vederla tornare con la schiuma da barba, la mia, che non arrossava la pelle. No, non è cambiato niente, non cambia mai niente, per davvero. Le brave donne di casa pescano pere e mele una a una, osservandole bene, tastandole come esperti medici, alcune le rimettono al loro posto, altre le catturano in sacchetti di plastica trasparenti. Non vedo la differenza fra le une e le altre, sarà perché non me ne intendo, per me sono tutte uguali. Le sciure si girano e mi guardano disturbate, ci sono abituato. Devo puzzare parecchio perché hanno tutti un’aria disgustata quando passo. Lavatevi voi, con zero gradi là fuori, con l’acqua gelida delle fontanelle, poi ne riparliamo. In estate è tutta un’altra faccenda. Vero che il caldo e l’afa sporca mi fanno sudare come un pazzo, quindi come mi giro mi giro puzzo. Me ne fotto. Mele: Golden: 2,25; Granny Smith: 1,68 al chilo. Vada per le seconde. >9 :- Pere: Williams: 1,79; Kaiser: 1,98. Le Williams le preferisco. Un paio di mele le prendo. Mi piacciono le mele, quelle verdi più di tutte. Sgranocchiarle fino all’osso e sentire la lingua girarsi e rigirarsi nel loro succo aspro. Sì, un po’ di mele verdi me le prendo. Una ragazza tutta in ghingheri prende il sacchetto e il guanto, una specie di profilattico a cinque punte. Poi prende patate e zucchine, arance. Poi? Poi le appoggia su una bilancia con mille tastini colorati. Ne schiaccia uno, di questi tastini, poi un altro e un altro ancora. Dal fianco della pesa piccoli foglietti bianchi e appiccicosi. Non capisco, non leggo. Se ne va, mi avvicino. Ogni tasto è una piccola fotografia di frutta e verdura. Appoggio la mano sul piatto facendo forza, schiaccio lo scalogno, a caso, beep. È uno scontrino, immaginavo. Allora mi rimetto davanti alle montagne di frutta. Prendo delle mele, delle pere. Arance: Tarocco: 1,75; Sanguinello: 3,25. Tarocco. Uva? Guardo un grappolo d’uva bianca e opaca. Qui dice che è senza semi: 2,25. I chicchi sembrano esplodere, tesi al limite. Non mi dice granché, quest’uva. Quando ero bambino, mio padre mi portava spesso dal nonno a Cormano, fuori città. Mi ricordo, sul finire d’agosto, il profumo dolce delle viti giù in fondo all’orto. Questa è americana, mi diceva il nonno. Me li ricordo i chicchi. Erano perfettamente rotondi, piccoli piccoli. Ammassati gli uni agli altri, stipati. Sembravano uova di pesce. Riguardo il grappolo. Non so se lo voglio davvero. Lo rimetto al suo posto. Beep, beep, beep. Passo oltre. Scaffali lunghissimi pieni di pane, baguette, ciabatte, ciambelle, panini al latte, all’olio, ai cereali, integrali, pugliese, toscano, scuro, bianco etc etc. Crackers, barrette di riso saltato, croccantissime o meno. Questa visione un po’ mi turba. Ora mi ricordo a cosa servono i soldi. Servono esclusivamente a non dover scegliere. Prendo una ciabatta fresca per oggi e una confezione di pane a fette che dura giorni. 4,49. Un omino basso e tarchiato infila cartoni rotti in un carrello, mi osserva almeno da un paio di minuti. Lavora qui, ovviamente. Sì, ce l’ha proprio con me. Mi giro verso di lui che non abbassa lo sguardo. E mo’ questo chi cazzo è? Maronna che puzza infernale. ’Na monnezza proprio. Ma perché ’sta gente non se ne sta fuori, invece che rompere i coglioni a noi altri? Entra con ’sto carrello pieno di merda, con buste, bustini, cartoncini. E che si crede, di venire qui a fottere le > 10 :- cose e che io glielo faccio fare, senza muovere un dito. S’infratta le cose nelle buste sue e via. Ma perché non mettono una sorveglianza all’ingresso, mi domando io. Che ci dobbiamo pensare noi dei reparti a queste cose? Tra una scatola e l’altra fare pure la sicurezza. E datemi il doppio stipendio e te la faccio anche la guardia. «Eh, mi scusi. È qui a fare che?» Ma perché la gente deve sempre e comunque rompere le palle. «Prego?» Nano bastardo, penso io. «Che sta facendo?» Che puzza! «Mi scusi, ma dove mi trovo?» Il nano mi guarda confuso. «Si trova all’Esselunga di Ripamonti.» Maronna! «Ah. L’Esselunga è un supermercato?» Scemo. «Sì, è un supermercato, come può vedere da solo.» Io chiamo Franco. «Allora faccio la spesa! Se questo è un supermercato, faccio la spesa!» Coglione! «Ce li ha i soldi?» Merdoso di un barbone. «Sì, ce li ho i soldi, non si preoccupi.» Irritante, ignorante, insulso, testa di cazzo. «Me li fa vedere?» Ma tu guarda questo. «Non credo sa, credo che li farò vedere in cassa, quando avrò finito di fare il mio giro.» Ma guarda questo. «Ti tengo d’occhio!» Capa di cazzo! «Faccia come vuole. Con permesso, devo scegliere che tonno comprare.» Coglione, enorme coglione. Lo dribblo, Riva non sarebbe riuscito a fare di meglio, con una mossa da manuale mi levo, carrello appresso, allontanandomi da lui. Il bastardo mi segue, corsia per corsia. Ma che si fotta, penso, scegliti il tonno che è meglio. Maruzzella: 3,25; Rio Mare: 4,15; Esselunga: 2,86. Dov’è il mio preferito? Eccolo! Nostromo: 3,29, preso. Io chiamo Franco, non esiste che questa monnezza vada avanti e indietro per le corsie a fottere le cose, e poi senti che puzza di merda, puzza veramente come la merda. Ma dov’è? Lì c’è Cecco, da solo, non è qui. Speriamo che non è al reparto carne, dietro, perché là mi fa schifo per davvero andarci. Mi viene in mente a quanto male stavo a lavorare nel macello, giù a Cetara. Quella puzza orrenda di morte, di dolore, maronna, mi viene ancora da vomitare > 11 :- come allora, i tonfi delle carcasse e quelle povere bestie, nelle mani fredde di noi altri. Il lavoro più brutto della mia vita. Speriamo che non è là. E che cazzo, è là. Gli faccio cenno col braccio, e vieni fuori tu. No esci, che ti devo dire una cosa. Ecco. Bravo. «Uè Ciccio, sa ghè?» «Uè, c’è uno che fotte la roba, un barbone, che va in giro con il suo carrello e sta facendo la spesa come se niente fosse, si mette le cose nel suo carrello fra buste e bustini e poi puzza che è una cosa che non ci si crede. Insomma, fai qualcosa. Vieni a vedere, non è bello che la gente lo vede.» «Ma i soldi ce li ha?» «Che cazzo ne so. Gliel’ho chiesto e lui sai che mi ha risposto? Li faccio vedere in cassa! Capito? In cassa li fa vedere. Vuoi venire per favore? Ci parli tu.» Siamo qui a cercare il barbone, corsia 7: dolci. Franco mi sta davanti, lo osservo che cammina con questo grembiule da coglioni che ci tocca di mettere. Per un attimo mi sento triste e penso che da giovane ero proprio bello, basso ma bello, e che volevo fare il meccanico come mio padre. Penso che è stato un errore venire qui e guarda come sono finito a inseguire questo spilungone con il grembiulino, e poi mi guardo, ho lo stesso grembiule che mi arriva alle ginocchia. Se mia madre mi vedesse, che figura di merda. Il pecorino: 4,36. 4,36 + 3,29 + 4,49 +... quanto avrò fatto alla frutta? Sei euro, sono… una ventina di euro, ci sto alla grande, mi compro anche la conserva alle cipolle, questa è per te, amore. 5,35. Perfetto. Ora schiuma da barba. Cammino che sembro una marionetta, ogni passo di ’sto stronzo sono dieci dei miei. Ma ’sta monnezza dove si è infilato? Possibile che non lo trovo. Inutile andare fin là, c’è la corsia cura e bellezza, non ce lo vedo a comprarsi il bagnoschiuma. «Franco, proviamo ancora agli scatolami, che qui non c’è di sicuro.» «Effettivamente dubito che si stia scegliendo il dopobarba.» «E infatti!» Ti facevo più coglione. Non ci posso credere, la producono ancora. Stesso colore, stessa con> 12 :- fezione. Mi viene da piangere. La mia schiuma da barba. Quella che non arrossa la pelle. Mi pesa il petto. Che uomo sono, puzzolente e con le lacrime agli occhi per una schiuma da barba. Non saresti per niente fiera di me, o forse sì, lo sei. Mi manchi, mi manchi ancora, sempre. Mi odio per aver dimenticato il tuo odore e adesso piango con il sorriso, davanti a questi deodoranti e creme e cremine, e continuo a odiarmi perché non sono stato abbastanza forte per tenere il tuo odore. Andiamo a prenderci i biscotti, ti va? Quelli al cioccolato, chissà se li fanno ancora, quelli che ti piacevano tanto. Questo posto, comunque, è inquietante. Ti ricordi il nostro piccolo supermarket? Con la signora alla cassa che aveva quel sorriso immenso e bianco. Per me era un posto intimo, quello. Questo posto qui invece, d’intimo non ha proprio nulla. La vedi quella signora, là, quella con i capelli biondi, tinti malamente? Guardala bene, non ti sembra che siano gli yogurt a scegliere lei? Non riuscirà mai a scegliere quello che vuole, cioè, le sembrerà di scegliere, ma sarà lo yogurt ai cereali e caffè, con praline di cioccolato a parte, che sceglierà lei. A me ’sta faccenda, non piace, neanche un po’. «Uè Ciccio, non è che posso stare a zonzo tutto il giorno per questo qui, nè!» «Ehh Franco, che cazzo vuoi che ti devo dire. Se poi ruba e succede il guaio io ti ho avvisato, sei tu il responsabile del personale.» «Cià, facciamo così, cercalo, se lo becchi lo porti in cassa e mi fai chiamare?» Prende e se ne va a passo svelto. Ma tu guarda questo. Che capa di cazzo. Direi che manca solo il vino. Quanto mi è rimasto? Circa quindici euro. Mi perdonerai, vero, ma questa cosa qui non la possiamo condividere. Questa è mia e mia soltanto, post mortem, un buco privato, dove far cascare la mia persona. Allora potrei prendere cinque bottiglie da 375 ml, oppure due bottiglie buone e due da 375 ml. Ma sì, trattiamoci bene. Stasera me ne vado in Sant’Eustorgio e ceno con pecorino e amarone. Oggi mi butta bene, festeggio. Ma dove si è infilato? Dove? Ai vini, cazzo, non ho guardato ai vini, un ubriacone dove volevo che andava se non ai vini? > 13 :- Venticinque casse, però. Che posto da pazzi. La prossima volta che trovo dei soldi in giro vado in un super più piccolo. Quest’Esselunga proprio non mi piace. Beep, beep, beep, sì signora, inutile che mi guarda così, sono io che puzzo, ma non si preoccupi, ho comprato shampoo, sapone e schiuma da barba e rasoi. Beep, beep, beep. «Sono 45 euro e 15 centesimi. Ha la fidaty?» Sposto lo sguardo dalle caramelle alla menta appese alla grata metallica accanto alla cassa, intento a fare conti, ho ancora una cosa come tre euro, ho dimenticato caffè e sigarette. Per le sigarette vada ma un buon caffè, quello non me lo toglie nessuno. Guardo la donna alla cassa. «Vuole un sacchetto?» Capelli corti, scuri, tinti. Hanno un curioso taglio che la fanno sembrare una bambina poco seguita, con ciuffi soffici e lucidi che sparano di qua e di là come richiamati da calamite nascoste. È incellofanata in un ceruleo grembiule bianco a righine verdi che lascia intravedere il vestito sotto. Un bel vestito, particolare, molto anni Settanta. Ocra e blu, con piccole e insistenti figure geometriche, incollate, abbracciate, su questo tessuto di poca grazia, ruvido e poroso, finta seta, acrilico con più probabilità. Sul grembiule, appuntata all’altezza del seno, una targhetta di plastica trasparente. Patty. Non ci posso pensare che il barbone se n’è uscito di qui tranquillo. Torno indietro e riguardo tutte le corsie. Non può essere uscito. Cassa 23, 22, 21, 20. È là ’sto figlio di una mignotta. Eccolo. Adesso vediamo. ’Sto coglione fa pure finta, si è messo in cassa, ma tu guarda che faccia che tiene. La guardo, mi guarda. Ha delle unghie orrende, erano meglio quelle finte. Chissà poi perché avrà voluto lasciarle nella mia tasca. Beep, beep, beep. Non me lo chiede se ho la fidaty? No. Be’, il sacchetto almeno. No, nemmeno quello. Beep, la schiuma da barba. Beep, i biscotti. Beep, beep, beep. Mele, pere e arance. > 14 :- «46 euro e 45 centesimi.» Rimango un po’ perplesso dalla sua freddezza, poi penso: una che si stacca le unghie e le lancia in tasca a un barbone tutta a casa non dev’essere. E penso anche che, tutto sommato, se mi trovo qui ora, e a mangiare e bere cose buone, stasera, in fondo è proprio grazie alle sue unghie. Quindi caccio la mano in tasca, prendo la banconota e a sfregio pure la sua unghia secca. Le passo prima l’una e poi l’altra. Lei non fa una piega mentre io me la sghignazzo allegramente, dentro però. Prende l’unghia e la fa scivolare sul pavimento, sotto i suoi piedi. «Patty, c’è qualche problema con il… signore qui?» «La banconota, signore.» «E lo sapevo! Il furbo fa questo!» «Cos’ha la mia banconota che non va? È sporca?» «No signore, è falsa. È un fac-simile, vede? È un biglietto promozionale, per un negozio che liquida tutto. È scritto in piccolo, qui dietro, vede?» Mi passa la carta, la guardo bene adesso, senza l’imbarazzo provato stamattina. È vero. LIQUIDAZIONE TOTALE UN VASTISSIMO ASSORTIMENTO DI CAPI IN PELLE, TESSUTO, SHEARLING E PELLICCERIA DI PRODUZIONE PROPRIA E DELLE MIGLIORI MARCHE RIGOROSAMENTE "MADE IN ITALY" SUPER PROMOZIONE - GRANDI SCONTI PER IMMINENTE CHIUSURA DELL'ATTIVITA', AVANT GARDE PELLICCERIA ATTUA UNA SVENDITA, TUTTO A CINQUANTA EURO. È un fac-simile. Cazzo, ma è scritto così in piccolo! Adesso? Mi tocca lasciare giù tutto. Poveraccio, va che faccia che tiene, sta a vedere che pensava davvero di avere una banconota da cinquanta euro. Guarda ’sto cristo. «Mi spiace signore, se non ha altri soldi sono costretta a riprendere le > 15 :- cose.» «Ma io…» Non so che dire. Abbasso la testa come se mia madre mi avesse appena sgridato e impedito di andare a giocare con gli altri a calcetto, nel campo in fondo alla via. «Vabbuò senti, è ovvio che c’è stato un quì quà quò. Quanto ha preso il… signore qui? Quanto è la spesa?» «46 euro e 45 centesimi.» «Eh, gliela pago io e siamo contenti tutti, mia moglie un po’ meno, ma è così.» Guardo il nano bastardo, non ci posso credere. «Grazie. Davvero.» «E che, tu non lo faresti al posto mio?» «Sì, forse, non lo so. Credo di sì.» «E vabbuò, speriamo di non scoprirlo mai.» Prendo lentamente la mia spesa. Ho quasi paura che si tratti di uno scherzo e che da un momento all’altro salti fuori l’ennesimo grembiule a righe verdi a dirmi di andare a farmi fottere, ma senza la spesa. Guardo Patty, la pazza. Guardo il nano, la sua targhetta dice che si chiama Ciccio. Gli sorrido, mi volto e faccio per andarmene. Mi volto ancora. «Grazie Ciccio.» Lui mi fa un cenno con il capo, su e giù, sembra volermi dire qualcosa, tipo che il signore sia con te o le strade del signore sono infinite. Sono buffe le persone, ho sempre avuto l’impressione che quando fanno del bene, lo fanno soprattutto per se stesse. Mi fa piacere che il nano bastardo si stia sentendo un messia grazie a me. Gli sorrido ancora, vorrei abbracciarlo ma so di puzzare e so che lui non gradirebbe, quindi alzo i tacchi con il mio carrello dietro. Mi allontano di una decina di passi. «Uè» mi fa lui, «come ti chiami?» «Jacopo» gli rispondo io. > 16 :- Rane 02 di Danila Iaquinto tro con neve :e v di lla Pa ge ta in v > Vestito Era già sulla nave, fumava una sigaretta mentre il vento le graffiava il volto arrivando dritto al cuore. Halima: ricordi vividi e carne e sangue. Corse lungo sentieri deserti e case diroccate, sempre inseguita da qualcuno. La costa di Lampedusa è una speranza, un raggio di sole nel buio, vale la pena affrontare qualche notte di paura, una paura che le ricorda che non è vero che non ha nulla da perdere, come dice Saim, il barcaiolo. Halima ha dentro tutta la speranza di reinventarsi, combattere, vincere, crescere, sognare, amare ancora. A Tunisi il ricordo degli affetti, qui in Italia la speranza di un lavoro. Gli affetti hanno il nome di Mohamed e Fatma, padre e madre, settant'anni ciascuno, reduci da un'irruzione della polizia che li ha lasciati pieni di lividi e amarezza. La polizia gli ha rubato tutti i soldi, così come ha fatto con Faysal, il promesso sposo, pelle scura e luce negli occhi senza futuro. L'hanno ucciso. Non servono altre parole, e il ricordo è solo l'ennesima ferita in cancrena. Mentre le lacrime cadono, si accende una seconda sigaretta. Che sapore intenso e fumoso, in quella vita a pezzi il cuore brucia. «Saim, arriveremo alla riva? È vero che non ci rispediranno indietro?» Saim non risponde, pensa ai soldi che raccoglierà all’arrivo e alle donne che si farà al ritorno. Delle paure di Halima non gliene frega nulla. Lei ci pensa e poi si sente quasi grata per quel silenzio, perché lui non le ha banalmente proposto una scopata in cambio di protezione. Ha il cuore tanto straziato che potrebbe accettare qualsiasi cosa, si sente fragile e vulnerabile ed è lì, nel contatto profondo e diretto con la debolezza dell’umana natura, che capisce quant’è perdutamente sola. Quando incontra Mario, nel giardino del Castello Sforzesco dove ama andare a rilassarsi, c’è uno spettacolo di clown per bambini. È una di > 17 :- quelle rare giornate di sole che se si è fortunati si scorgono anche in inverno. Era andata a fare una passeggiata, era domenica, il suo giorno libero, come quello di Mario. Ultimamente aveva voglia di svago, di evadere dal lavoro che la impegnava da ormai due anni e che la stava alienando. Glielo aveva trovato Ines, la sua unica amica: «C’è una signora anziana, pare sia invalida, i figli cercano una badante, tempo pieno giorno e notte, domenica libera. Vogliono una persona giovane ed energica che non abbia impegni o legami, e tu sei perfetta.» «Oh, grazie Ines, ma non ho il permesso di soggiorno e non so se accetteranno.» «Halima, questa è una vera occasione, seicento euro al mese e ti fanno anche il permesso di soggiorno.» Sapeva che era un’occasione relativa: avrebbe avuto il permesso, ma lo stipendio era proprio basso per costruirsi una vita che ne valesse la definizione. «Hai ragione Ines, andrò a presentarmi. Dammi l’indirizzo.» Da lì era iniziato tutto. Il giorno dopo era già badante di una piccola ottantenne invalida, la signora Pin, doveva sistemarle casa, fare la spesa, prepararle da mangiare, aiutarla a lavarsi, portarla in giro al parco, metterla a letto, aiutarla di notte all’occorrenza. Mario è bello, robusto e forte, con labbra carnose e occhi che quando sorridono evidenziano due rughe agli angoli. Da quando era venuta in Italia non aveva ancora osato guardare nessun uomo, non ne aveva avuto tempo ma neanche la voglia. Mario le aveva offerto una sigaretta fuori dal piccolo chiosco di fronte al Castello, proprio quando avevano consumato gomito a gomito un caffè, senza conoscersi. L’aveva fatta arrossire ma istintivamente aveva accettato: le sembrava dolce, attento. Ah, da quanto tempo qualcuno non si preoccupava per lei! La cosa che capì subito di lui fu che aveva un gran bisogno d’affetto. Un bambino in un corpo grande e grosso. La prima volta che uscirono la portò a passeggiare all’orto botanico. Era la domenica successiva a quella della mostra e le raccontò subito la sua vita: il sole di Napoli nel cuore, la paura, la rabbia e l'orgoglio nel sangue. Cresciuto in una famiglia povera di Fuorigrotta, tanti ricordi da bambino di quando si intrufolava al San Paolo per vedere la partita del Napoli. Un lavoro come ambulante al mercato rionale, pochi soldi e tanti sogni. Ben presto era > 18 :- scappato: il sole e il mare non sono mai bastati a nessuno. Mario ormai lavora da cinque anni come portiere in un palazzo in centro a Milano, ed è single. Halima pensa che sia strano, un single così dolce, affettuoso e possente, chissà se riuscirà mai a svelargli i suoi sogni più segreti, le sue paure più grandi. Per aprirsi bisogna fidarsi e lei non si fida di nessuno, neanche più di se stessa. Era arrivata in Italia con sogni e ambizioni, si era scontrata con povertà e solitudine. Ultimamente l’amarezza aveva preso il posto nel letto accanto al suo. Per questo motivo nelle settimane successive Halima non aveva risposto alle chiamate, numerose ma non pressanti, di Mario. Aveva deciso che erano entrambi due reietti, che non c’era previsione di gioia per due come loro. Qualche mese dopo Halima passeggia ai Navigli, è quasi Natale, nevica e Milano sembra una torta di panna montata. Mario è in giro per comprare un regalino per Anna, la più attenta e simpatica bambina che abbia mai conosciuto, figlia dei signori Bolchi, una delle tante famiglie del condominio presso il quale fa il portiere. Lavora tutti i giorni tranne la domenica, quasi come un doorman americano. Inizia tutte le mattine a un'ora imprecisata ma molto presto, perché anche scendendo alle sette lo si può già trovare intento a lucidare i vetri delle due entrate. La sera puntuale alle sei chiude gli ingressi. Il palazzo del quale si occupa è abitato da molte famiglie, qualche coppia, solo un single, anziano e vedovo. È un palazzo massiccio anni Settanta della cui gestione va molto fiero. Dal lunedì al venerdì ogni mattina c'è sempre una calca di bambini accompagnati dalle tate o dalle madri che corrono per andare a scuola, in perenne ritardo. I papà scendono solitamente mezz'ora prima, con qualche distinzione a seconda del lavoro, le coppie senza figli, solo tre nel palazzo di sette piani e due scale, invece escono di casa insieme. Tutti i giorni però Mario aspetta l’arrivo di Anna, perché puntualmente con il suo entusiasmo gli regala un sorriso e dei dolcetti: «Mariooooo sono io! Chi sono? Indovina! Ho per te una nuova caramella: melone e panna!» Le caramelle erano ogni giorno le stesse ma Anna con il suo entusiasmo le arricchiva di gusti inventati e fantastici, come se a soli cinque anni potesse offrirgli ogni giorno la speranza di un entusiasmo nuovo da assaporare. Mario le vuole un gran bene, l’ha vista nascere e crescere, finire in ospedale quando era caduta dal seggiolone e aveva > 19 :- battuto la testa facendo preoccupare tutti per un trauma cranico. Anna sorride sempre. Mario quindi è in giro a cercare un regalino per lei, perché si avvicina il Natale e anche perché in quei giorni Anna compie cinque anni. In una vetrina di una cartolibreria si lascia incantare da una pallina di vetro bianco contenente due ranocchiette su una spiaggia, circondate da stelline color argento e blu che galleggiano in un liquido trasparente e cambiano posizione a ogni movimento della sfera. Che immagine magica! Che sogno di serenità fuori dallo spazio e dal tempo! Entra, compra la sfera e se la fa incartare, quando esce è entusiasta dell’acquisto. Proprio all’uscita intravede dall’altro lato della strada Halima che passeggia con indosso un cappotto grigio scuro e un cappello azzurro puffo sormontato da una pallina di lana batuffolosa. Mario sorride e pensa di seguirla per un po’ per vedere cosa fa. Da un’attenta osservazione il nostro portiere capisce che: Halima fuma troppo. Halima è molto affascinante e dolce. Halima ama entrare in ogni negozietto vintage a provare cappelli, borse e vestiti appartenuti ad altri, senza però mai comprare nulla. Quando poi gli sembra di averla osservata abbastanza si fa coraggio e le si piazza davanti all’uscita: «Posso offrirti una cioccolata calda?» Halima si spaventa, pensando di essere stata seguita per chissà quanto tempo. Più tardi, Mario le racconta tutta la giornata e le confessa di averla solo osservata guardare quei negozi. Halima gli racconta che ama i vestiti vintage perché le ricordano tempi e spazi lontani, quando colori e geometrie erano diversi e di moda, mentre oggi le sembra tutto così grigio e banale. Al riparo dalla neve, al caldo di un tavolino di un minuscolo bar, Mario le racconta perché l’aveva cercata. Voleva vederla ancora, ma c’era anche un motivo più pratico: la badante peruviana del signor Primati, unico anziano solo del palazzo dove Mario lavora, era andata via e la famiglia cercava una sostituta. Ci sarebbe stata almeno una settimana di prova retribuita, ma il vecchietto era abbastanza indipendente, quindi non c’era nulla di complicato o umiliante da fare, solo preparargli da mangiare, pulire casa, accompagnarlo a passeggiare; vitto e alloggio erano garantiti e lo stipendio sarebbe stato di mille euro al mese. Halima si sente una stupida a non aver risposto prima alle sue telefo> 20 :- nate. Trova una sostituta per la signora Pin, va in prova dal signor Primati, viene subito accolta come una figlia e all’improvviso è felice come non lo era da tanto tempo. La routine lavorativa era diventata, ora che entrambi vivevano nello stesso palazzo, una gioia e un piacere. Si salutavano ogni mattina con un semplice squillo al citofono, Halima fingeva spesso di dimenticare la posta o la spesa per scendere più di una volta, sapeva che il signor Primati era troppo buono per insospettirsi. Teneri sguardi, dolci sorrisi ma nulla di più, il rapporto si era consolidato sul versante spirituale e Mario non osava fare passi falsi. Dopo averle proposto quel lavoro, aveva paura che Halima potesse pensare che lui l’aveva fatto per un secondo fine. In realtà non ne aveva, se si esclude il piacere di seguirla anche solo con lo sguardo e col pensiero. Dal canto suo Halima era troppo interessata a lui per fare un qualsiasi passo che la mettesse in discussione. Seguiva scrupolosamente l’anziano, ma questa volta il lavoro da badante lo affrontava con una speranza nel cuore che le dava la sensazione di una perenne primavera. Un giorno però accadde una cosa abbastanza inconsueta. Il signor Primati aveva voglia di biscotti nel latte per colazione e i biscotti erano terminati, Halima era scesa sorridente ma aveva visto Mario parlare a bassa voce con fare intimo con la signora Lai, del quarto piano. Il viso le si era di colpo oscurato, aveva messo il broncio ed era passata diritta davanti alla portineria senza salutare i due che confabulavano. Al ritorno dal supermercato era entrata nel palazzo senza salutare, Mario l’aveva chiamata ma lei aveva finto di non sentirlo. Ci pensava e ci rimuginava, si chiedeva cosa diavolo volesse da Mario la signora Lai, ossigenata e scollacciata come una divetta da teatro di quart’ordine. In un accesso d’ira l’aveva chiamato al citofono: «Per favore Mario, potresti salire giusto due minuti? Ho bisogno di sollevare il signor Primati dal letto, ma ho mal di schiena e da sola non riesco.» Lui era corso, mollando tutto come ogni volta che lei aveva bisogno d’aiuto. Fu sorpreso a vedere che l’anziano dormiva e che lei non lo aveva chiamato per lui. Halima partì con una filippica: «Ascoltami bene, io lavoro tutto il giorno, tutti i giorni quasi, non mi concedo mai uno svago, non esco con le mie amiche, non guardo mai un uomo. Poi scendo un attimo la mattina presto e ti vedo con la prima smorfiosa che passa? Cosa voleva da te? E > 21 :- chissà poi con quante altre lo fai!» Mario aveva provato a ribattere ma lei prontamente lo aveva zittito: «No, non mi interrompere! E non provare a dirmi che è il tuo lavoro, non mi interessa, non sei in un bar, sei in una portineria e devi mantenere quel vetro di separazione se vuoi stare con me!» Aveva quasi parlato d’un fiato, si era accesa d’ira e non si era neanche accorta di aver svelato senza troppi giri di parole ciò che aveva nel cuore, davvero in fondo. Si sentì indifesa. Mario scoppiò a ridere, innocente com’era: «Ora ascoltami tu: io in questo quadro che dipingi proprio non mi ci ritrovo. A sentire te sarei un dongiovanni che corre dietro a qualunque donna passi in portineria. Se avessi voluto, essendo single, stai sicura che ne avrei cambiate di donne! Non starei qui ad aspettare anche solo un tuo cenno come un ragazzino. Tu mi hai fatto rimbecillire!» «Adesso è colpa mia?» sbottò Halima ma Mario la sorprese con la sua risposta. «Tu dimmi cosa vuoi da me, e se me lo dici smetto anche solo di parlare con ogni essere femminile.» Ma non aspettò che lei rispondesse, perché la tirò forte a sé, le afferrò la testa tra le mani e la baciò così appassionatamente che sembrò che l’intero palazzo tremasse dalle fondamenta insieme a loro. Lei rispose al bacio con parecchio trasporto, tanto che lui senza troppo pensare le sollevò il vestito, la appoggiò al muro e mentre la palpava dappertutto le strappò le mutandine e sollevandola entrò dentro di lei. Il tutto si consumò in cucina, in un momento che poteva essere stato di ore o giorni, perché entrambi persero il senso del tempo. In realtà era trascorsa poco più di mezz’ora. Mario scese in portineria e ritornò al suo lavoro, camminando sul suo personale pezzo di cielo. Arrivò il Natale e con esso luci rosse e verdi, vischio, abeti, neve, fumo di camini e profumi di castagne, frittura di pesce e panettone caldo. Arrivò anche il compleanno di Anna, che aveva espresso come desiderio, per il 27 dicembre, data in cui avrebbe compiuto cinque anni, di fare una festa in maschera. Essendo Natale la cosa suonò quantomeno bizzarra ai suoi genitori ma visto che la piccola era tanto fantasiosa e sopra le righe quanto buona e spontanea, i genitori la accontentarono. Non fu banale spiegare ai compagni di classe e ai cuginetti che avrebbero avuto bisogno di un vestito carnevalesco, ma Anna obiettò che > 22 :- lei era certa di aver visto un negozio vicino casa di abiti di carnevale sempre aperto. In realtà era un negozio in via Sarpi di costumi colorati e appariscenti, ma che con le maschere carnevalesche aveva poco a che fare. Poco male, pensò la madre, erano a Milano, non in mezzo al nulla. Alla festa furono invitati tutti i compagni di classe e la madre di Anna chiese a Mario un aiuto per la spesa e un suggerimento su una persona fidata che potesse fare da tata, visto che quella sera la loro baby sitter era impegnata. Lui pensò subito ad Halima e glielo propose. Il problema era con chi lasciare l’anziano signor Primati. Mario si offrì di vegliare su di lui, mentre lei si occupava dei bimbi, anche per guadagnare un po’ di soldi extra per un vestito vintage che sognava da tanto. Saltò fuori però che la piccola Anna voleva assolutamente che anche Mario partecipasse alla festa, in particolare vestito da cacciatore. Quando lui sentì la notizia, scoppiò in una grassa risata, si sarebbe vestito volentieri in quel modo per lei, ma quel giorno doveva badare al signor Primati. La madre della piccola trovò subito la soluzione: «Bene, perché allora non portiamo anche il signor Primati alla festa? Gli mettiamo un cappellino e sarà anche per lui un’occasione di svago!» Quando la proposta fu fatta al signor Primati, lui non poté fare a meno di pensare, come sospettava da anni, che la famiglia di Anna fosse piuttosto stramba, e imputò il tutto al fatto che era una famiglia napoletana, non essendo tuttavia convinto che tanto bastasse a renderla così bizzarra. Alla fine però si convinse e partecipò all’allegra festicciola. Anna era vestita da Biancaneve, tutte le sue amichette da varie principesse: dalla bionda Rapunzel alla scura Tiara, all’eterea Aurora. Halima indossò un vestito rosso, regalo di Mario, usato e un po’ stile anni Settanta, ma col trucco adatto si fece passare per Cappuccetto Rosso. Mario si vestì da cacciatore e portò alla dolce Anna la palla con le rane in dono. Anna fu felicissima, osservò bene il movimento interno delle stelline inclinando la testa insieme alle ranocchie che giravano su se stesse. Fu un regalo speciale e lo conservò nel cassetto custodito per qualche giorno. Poi un pomeriggio Biancaneve-Anna pretese di parlare con Cappuccetto Rosso-Halima perché aveva un messaggio urgente dal paese delle fiabe. Anna disse ad Halima che aveva sognato la fata di Cenerentola, che le aveva detto di consegnarle la palla con le ranocchie. La fata non le aveva spiegato il perché, ma era assolutamente importante che l’avesse lei, Halima-Cappuccetto, per ricongiungersi con il suo cacciatore-salvatore. Questa è una storia vera. > 23 :- Marciapiede 03 di Morgen Miragoli >Palla di vetro co n neve - vibrato re:- La pioggia cola rumorosamente sul vetro appannato della Renault blu. La notte scura delle sei di pomeriggio che solo l'inverno può offrire li ha guardati consumare un orgasmo frettoloso. Il monossido di carbonio della loro fredda passione ha scaldato debolmente l'abitacolo. Fuori Milano umida e abbandonata si estende dall'arancione di un deposito dei tir e il retro di un grosso cartellone pubblicitario, discarica abusiva. I fanali allo xeno illuminano per un attimo la macchina per poi ronzare silenziosamente altrove. Nella cassa di lamiera respirano piano. Quasi non riesco a guardarla, mi fa schifo. Buttata lì senza grazia, accartocciata su se stessa, non mi guarda, cerca dei fazzoletti per asciugarsi. Il mascara livido, strisciato, le nasconde gli occhi gonfi, ogni tanto sbuffa ed emette risolini soffocati solo per stemperare l'atmosfera che è diventata marcia. Distolgo lo sguardo, non la posso guardare, sono marcio anch’io adesso, non sono capace di mascherare le mie espressioni, nascondere l'imbarazzo della situazione, stringo i pugni per occupare spazio. Accendo la radio senza chiedere permesso, noto che non ha il lettore cd ma il mangiacassette, questo mi fa sentire meglio. Giro la rotella lentamente, mi fermo quasi subito “You, you just know, you just do”. Gli XX riempono le parole che non siamo stati capaci di dirci. Senza preavviso allunga un dito corto sul vetro appannato e disegna un cerchio, all'interno due occhi e un sorriso molto piccoli, non centrati ma tutti spostati su un lato, quello che ne esce è un buffo alieno, sorrido anche io. «Ehi amico, quel fiore è per me, vero?» L'uomo si volta e mi guarda perplesso. Insisto: «Dai, se me lo regali ti faccio uno sconto sul prezzo. Sono una romantica io.» Sembra impreparato, vulnerabile, mi avvicino. Indossa stracci, un muratore, muratore scuro, sarà straniero, una preda facile senza pretese, mezz'ora compresa la trattativa poi basta, è l'ultimo di oggi. Guardo in > 24 :- alto, comincia a piovere. «Che fiore è? Sembra una calla, a me piacciono le calle.» «Sì, è una calla, ma non posso dartela, è un regalo.» «Ho capito, quindi non vuoi la mia compagnia stanotte?» mi sbilancio. «Dipende da che tipo di compagnia». Le sue mani escono dalle tasche e si abbandonano lungo i fianchi. Ci incamminiamo lungo il bordo della strada, le gocce cominciano a cadere più forte, lui mi segue a poca distanza, la testa china, più che rassegnato sembra vergognarsi di questa attesa. Seguo un sentierino lercio di carte e preservativi e arriviamo allo spiazzo dove ho parcheggiato. Mi si avvicina, mi chiede se quella lì è la mia macchina, annuisco e mi metto a ridere: «Sei il primo cliente che viene senza, che facciamo, vuoi entrare nella suite?» La portiera scatta e lui esce scomposto, non una parola. La portiera che si richiude e il battere della pioggia, adesso di nuovo attutito. Mi chino per raccogliere i fazzoletti sporchi gettati frettolosamente ai piedi del sedile, alzo la testa e guardo fuori, la sua figura sfocata si confonde nel buio, ma non capisco se si stia allontanando o se sia immobile. Sul suo sedile è abbandonato il vibratore azzurro, non ha voluto che lo usassi, non si è lasciato convincere dai miei racconti. «Tutte le donne lo vorrebbero usare, è solo che non hanno le palle, usarlo bene poi è tutto un altro discorso, è un'arte.» Rimane fermo sotto la pioggia ancora un po', poi bussa con le nocche sul mio finestrino, dov’è rimasto il segno della faccina, abbasso il finestrino quel tanto che basta per sentire: «È tardi, forse è ora che vada.» Lo fisso per qualche secondo senza dire niente, aspettando che succeda qualcosa, invece niente, dico solo buonanotte, e mi fa strano. E mentre chiudo il finestrino mi chiedo perché ho detto buonanotte. Mi guardo i piedi mentre cammino, le scarpe sono inzuppate d'acqua, ho freddo e mi sto bagnando completamente, ma non me ne frega un cazzo. Per la prima volta da quando lei è partita sento qualcosa, e quel che sento mi nausea. Mi sento violato, sto tremando, non solo per il freddo. Mi fermo un secondo, il mio respiro affannoso, la mia giacca di tela è schiacciata addosso. Qualche macchina ogni tanto mi sfreccia davanti per poi planare in frenata al semaforo, l'acqua schizza ovunque. Sono solo su questa strada di merda, senza sapere dove andare. In tasca non ho niente, nessun biglietto del tram, niente di niente, > 25 :- vuoto. Mi incammino verso quella che penso sia la direzione di casa. Penso a lei, a tutte le volte che non ci sono stato e mi sento così lontano da quello che sono, frustrato e impotente. La calla che avevo in tasca è fradicia, ormai non ha senso darla a lei, la butto con forza ma ricade sul marciapiede. Accendo la macchina, quando mi giro per fare la retromarcia l'occhio mi finisce sul sedile posteriore, un portafoglio. Che ci fa un portafoglio. Mi allungo per prenderlo senza togliere il piede dalla frizione, che mi scivola e la macchina scattando si spegne. Guardo subito se ci sono soldi da prendere, qualcosa, ma è vuoto o quasi, nella tasca delle monete un euro e sessanta, nel posto delle banconote un pezzo di carta piegato in quattro. Lo apro curiosa, non è una lista della spesa, è una lettera, scritta male e un po' bagnata, non si riesce a leggere benissimo. Vengo presa da una strana eccitazione che non è solo invadenza ma anche qualcosa che non riesco a capire. Cara Anju, ti scrivo come un padre, perché sono tuo padre, anche se non so bene che senso abbia se tu nemmeno sai chi io sia. Un padre che ha compiuto piccoli passi di un lungo abbandono, e l'unica cosa che ci lega sono i pochi soldi che riesco a spedirti ma che non sai di ricevere. Tutte queste cose non le sai perché il giorno che sono partito ho deciso di allontanarmi e di perderti, troppo grande era il dolore che i tuoi occhi di miele, gli occhi di tua madre, mi davano, non potevo sopportare di aver perso lei e per punirmi ho deciso di perdere anche te, mia unica luce. Non ti ricordi niente di quella notte, quando tua madre per salvarti dal gelo ti ha avvolta con il suo corpo, un corpo caldo che a poco a poco ha perso tutto il suo calore. Io ero in prigione, quando sono arrivato non faceva più freddo ma era troppo tardi. Quando ti ho portato all'ospedale ti ho lasciato nelle mani di tua nonna, le mani vecchie e nodose che ancora adesso ti preparano da mangiare. Non so ancora cosa mi diede la forza di partire, di cercare lavoro lontano. Non so se l'ho fatto per egoismo o per amore, non sai quante volte ho desiderato vederti e parlarti e baciarti e raccontarti le storie che non ti ho raccontato in tutti questi anni, ma dentro di me, dentro dentro, non volevo vederti mai più. Non reggerei, non sarei mai capace, non sai quanto queste lacrime non sappiano di niente lontano da te, non potrai mai capire quanto l'amore che provo sia paura e rab> 26 :- bia che terrò nel mio cuore, che affronterò io da solo perché il tuo cuore non deve soffrire come ho sofferto io. Non sai che io dalla nostra casa di lamiera non ho portato niente, nemmeno delle scarpe, solo un oggetto, che non puoi ricordarti. Una palla di vetro, di quelle con la neve dentro, che avete fatto tu e la mamma per me. Dentro ci sono una rana e un fantasma che esce dalla lavatrice, tu mi hai detto che sono innamorati, anche io l'ho pensato. Non saprai mai se è giusto così, come non lo saprò io, perché non saprai mai queste cose. Getto i vestiti fradici sul pavimento di marmo senza badare all'ammasso che si crea, anzi evitandolo, mi butto in mutande, anche loro fradice, sul divano sfondato, post-it ovunque: “non aggiusteremo più forcelle mangiando pasta e fagioli”, “hai allagato tutte le mie soffitte mentre scrostavi dai muri i miei adesivi”, “potrei regalarti una collana che non metteresti mai con tutte le palline di quelle che hai rotto”. Sorrido triste perché lei mi ha sempre fatto ridere e mi ha sempre fatto stare male, non starò mai con lei, non sarò mai come lei. La lettera mi ha distrutta, mi ha toccato in un punto impolverato in fondo che non sapevo nemmeno di avere. Io ho toccato quell'uomo, ho intrecciato le mie braccia intorno al suo collo, i nostri corpi sono stati uno dentro l'altro, e lui dentro aveva tutte quelle cose, tutti quei sentimenti così puliti, così umani. Accendo la macchina, riparto cercando di non pensarci, distraendomi mentre i colori bagnati di viale Novara scivolano sotto le ruote. Più tardi a casa continuo a farmi milioni di domande, quanta sofferenza deve aver provato, quante cose deve aver visto, che bello sarebbe poterlo conoscere, quante cose potrebbe capire. Mentre abbasso le tapparelle prima di andare a dormire bevo un sorso a canna dalla bottiglia, mi tolgo le forcine dai capelli, devo farmi una doccia. Domani mattina gli porterò il portafoglio perché è giusto, uno senza portafoglio non può stare. Il mio materasso buttato sul pavimento stile bohémien la mattina mi sembra sconfinato, mi rotolo nel piumone per ore prima decidermi ad alzarmi, che poi non è una decisione ma una costrizione. Mi trascino in cucina dove c'è Louis. Il mio coinquilino portoghese è in mutande che guarda nel frigorifero con in mano un succo. Mi guarda chiudendo con troppo vigore la porta. Sembra perplesso, non ho un bell’aspetto. > 27 :- Ci salutiamo e gli dico che devo uscire, come al solito lui borbotta qualcosa sulla spesa, ma so che finirà per stare a casa tutto il giorno. È una bellissima giornata dopo tutta quella pioggia di ieri, il cielo è spazzato da un forte vento pungente che regala colori innaturali e freddi a tutti gli edifici. Mentre guido per andare da lui mi immagino la sua vita e nella sua vita, o meglio quello che io penso sia la sua vita. Ci sono rinunce e lavoro duro, sofferenza e paure, e poi ci sono gli incubi, i miei incubi, e così anche io ci entro, nella sua testa e nei suoi pensieri, che si frammentano e sono tante istantanee di noi due. Per la prima volta penso a un uomo al di fuori dal lavoro. Un uomo come persona, come compagno o amico, o forse solo come persona. È per questo forse che inconsciamente prima di uscire di casa lo sguardo si è posato sul vibratore. Ho deciso di portarlo con me, di regalarglielo, per dargli qualcosa di mio, che appartenga alla nostra comune esperienza. E adesso quel regalo mi sembra così inopportuno, impulsivo e di pessimo gusto, senza senso. Decido di metterlo in un sacchetto e di portarlo lo stesso, mentre scendo dalla macchina. Citofono dopo aver controllato per l'ennesima volta il nome che mi sono scritta su un post-it. La voce che mi risponde sembra sorpresa ma mi dice di salire. L'androne mi pare familiare, decadente, e mentre salgo le scale vengo assalita da una gioia luminosa, mi piace pensare che non sarà l'unica volta che salgo queste scale. Mi apre la porta un tipo trasandato, rimango in punta di piedi. Impacciata chiedo cortesemente se posso entrare, lui sembra colpito da tutta questa formalità e senza degnarmi di uno sguardo si fa da parte come se ci conoscessimo da tempo. Porta una maglietta bianca unta e si muove svogliatamente. Si butta su una poltrona e mi fa cenno di sedermi sul divano. Mi siedo composta senza sapere bene cosa dire e incomincio a stringere il vibratore dentro il sacchetto di plastica, come se mi potesse dare coraggio. Chiedo timidamente dove posso trovare Latif, quasi sussurrandolo. «Chi?» mi chiede sorpreso, con un accenno di sorriso di cui non lo credevo capace. Allora riprovo con più energia: «Latif, ho trovato il suo portafoglio e sono venuta qui per restituirglielo, ha cambiato indirizzo?» «No, vive qui, almeno penso che viva qui con me, se stiamo parlando della stessa persona. Marco, nessuno lo chiama Latif.» «Come nessuno lo chiama Latif, è scritto sul suo documento.» «Sì, ma non lo usa mai quel nome, lo odia, lui è Marco.» > 28 :- Le mie mani allora cercano nella borsa il suo documento, lo prendo e lo apro mostrandoglielo. Lui sembra sempre più divertito, sghignazza: «Certo che è lui, anche se in questa foto sembra un profugo. Che fortuna che hai trovato il suo portafoglio, sveglio com'è non se ne sarà nemmeno accorto.» Solo adesso mi rendo conto del forte accento straniero del ragazzo. «Di dove sei?» gli chiedo senza pensarci. «Lisbona, ma mi sono trasferito qui con Marco sei anni fa.» «E Marco adesso dov'è?» chiedo con la speranza di rivederlo presto. «Marco? Sarà al parco, gli piace andare in giro a scrivere, non stare chiuso in camera.» Appena sento “scrivere” il mio cuore accelera e senza controllarmi stringo ancora più forte il sacchetto e lo interrompo: «Scrivere cosa?» ma la mia testa comincia a capire, è un risveglio: il nome, la stanza, tutto mi sembra diverso, tutto mi sembra com’è sempre stato, non come mi immaginavo. «Scrivere un romanzo, è il suo lavoro, o almeno questo è quello che cerca di fare, mi sembra un po’ in crisi il ragazzo.» Il mio respiro si fa affannoso, so benissimo dove vuole arrivare, una voce chiede per me: «Su cosa sta lavorando adesso?» «Mi chiedi troppo, non mi ricordo, forse la storia di una bambina e un padre lontano, qualcosa sull'abbandono, ma potrei sbagliarmi.» «Non ti sbagli» dico con un filo di voce, e mi faccio piccola rimanendo tra i cocci delle mie speranze rotte. La porta sbatte dietro di me e ritorno scendendo le scale alla realtà. > 29 :- Virginia avrà un figlio marrone 04 di Alice Tedeschi > Vibratore - B astone da passeg gio:- prima di tutto, scegli il font; un carattere che rispecchi quello che stai per scrivere, non troppo invadente se vuoi che escano di più i significati delle parole. scelto il carattere, il suo colore e la dimensione, se non hai niente da dire, se ti sei ritrovato, quasi senza motivo, di fronte alla scelta quasi compiuta, inizierai semplicemente a battere le dita sulla tastiera, per assuefarti a quel tic tic tic, che se hai le unghie un po' lunghe è anche più soddisfacente. per i primi momenti, non avendo la minima idea di cosa starà per succedere, desidererai avere una macchina da scrivere, per sentirti più al sicuro, perché quando schiacci una lettera poi lì rimane impressa e non puoi tornare indietro, non corri il rischio di rimanere con un pugno di mosche in mano che, anche se farà schifo, qualcosa sulla carta sarà rimasto. quelle che usciranno all'inizio saranno solo parole vuote, legate all'atto dello scrivere, proprio come adesso. font scelto, dimensione impostata, colore simpatico e un po' illeggibile; desiderata macchina da scrivere; scrivere del non saper cosa scrivere. distratto, inizierai a pensare che hai le lenti degli occhiali sporche, con alcuni aloni: le pulirai, perdendo così un altro minuto. vorresti andare a lavarti le mani, di nuovo, come se averle più pulite facilitasse il tutto, ma tu non cadrai nel tranello, tornerai a concentrarti. devi scrivere, scrivere un racconto, un pezzo che parla di una ragazza che, non si sa bene ancora come, dovrebbe essere rimasta incinta, incinta di chi? sempre più sorpresa dalla surrealtà che, già sai, dovrà caratterizzare il tuo pezzo. di nuovo ti distrai, è partito un nuovo brano su itunes, devi controllare com’è scritto perché ti piace e vuoi inserirlo nella tua playlist primaverile, se il brano è salvato con le lettere maiuscole, anche solo l'iniziale, va sistemato, Virginia 24.5.11 17:17 Formattato: Tipo di carattere: Calibri, Evidenziato > 30 :- è prioritario. lo stampatello minuscolo è più pulito, più lineare, ergonomico. brano corretto, ora puoi andare avanti. pensi alla vale e a quello che ti ha detto: vorrebbe riuscire a vedere lei la tua protagonista tra le lenzuola, sul letto disfatto, sdraiata a pancia in giù, con la bocca semiaperta, quasi svenuta, sfatta, con un vibratore, azzurro rugoso di gomma. lei, che aprendo gli occhi all'improvviso, colpita dal dolore che la luce ti provoca dopo una notte di alcol e di chissà cosa altro, si sveglia, nauseata e maleodorante, l'alito pesante. Virginia 24.5.11 16:46 Eliminato: dellʼincipit, E urla, piano: «Aaaaaaaa.» le fa male la testa. la camera che puzzo ha? la camera fa schifo, di quello schifo che più la nostra protagonista apre gli occhi, prima sbirciando, poi richiudendoli e poi riprovando di nuovo «Aaaaaaaaa» le fa male la testa e più c'è puzzo, e più puzza, perché lei respira, e anche il suo respiro puzza; più respira e più puzza, e più puzza e più le viene da vomitare. non basta aprire la finestra, è un olezzo che servono giorni per renderlo così denso. voglia di avere una federa pulita per respirare a pieni polmoni, ma no, la tua federa fa schifo. «Aaaaaaaaaaa.» Le fa male la testa. Richiude gli occhi e prova a muovere le mani. le mani come sono? sono mani che da lontano, se le vedi, sono belle, le puoi sognare sottili, ma non quelle da pianista che tutti pensano siano belle, e invece sono solo asessuate: lei ha mani da femmina, con le unghie smaltate, che più ti avvicini e più si ingrandiscono, non solo perché sei più vicino, è che sono proprio grandi, ma comunque, mani da femmina. Virginia 20.6.11 23:59 Eliminato: eccola, prova a muoversi: cementata in quelle lenzuola luride, peli, ancora puzzi, puzzi di gente che cʼé passata lì, su quelle lenzuola, che ci ha lasciato proprio la traccia. Virginia 21.6.11 00:00 Eliminato: mani un poʼ robuste, mani che hanno stretto di tutto, mani le manone iniziano a muoversi, sì, si muovono da sole, lei vorrebbe alzarsi ma la vedi, non ci riesce, tutte le sue energie le fanno solo allungare un braccio, tra le sue gambe. ancora imbrigliata nel letto, ecco che lo sente: gommoso. non capisce se è lei a essere appiccicosa o quell'oggetto > 31 :- lì; lo tasta un po', lo sfila e lo prende in mano: questa volta urla, più forte – o almeno così crede. c'è un vibratore nel suo letto, e non è suo, cioè sì, è il suo, ma è come se non lo fosse, non lo usa da almeno un mese, non doveva essere lì, dentro al letto con lei, infilato su. lo sfila, a fatica. okay, ti sei addormentata con un vibratore tra le gambe, di solito non capita, questa volta sì, è successo. Un'ora di rimandi, di voglia di vomitare, di sperare che sia domenica, sessanta minuti passati incastonata nel letto, perché non puoi fare altrimenti. La osservi e ti piace, curioso di sapere cosa si vede, spiato, se ti ubriachi. E scoprire come questo scricciolo di donna, sporca e nauseata, non più che trentenne, ci provi, tenti di issarsi, punti i piedi, prima uno e poi l'altro, e come vorresti proprio aiutarla, ha bisogno di essere presa sotto le ascelle e letteralmente tirata su, ha bisogno di aiuto. Si sforza e meglio di uno spinnaker, con il vento in poppa, si gioca tutto sul colpo di reni, una bella spinta, barcolla in avanti, attenzione, rischia di cadere, vacilla all'indietro, sbilanciata, ripiomba sul letto, questa volta almeno è seduta, si è liberata, brava. È stata tenace, sai, non è affatto facile. Virginia 24.5.11 16:51 Eliminato: lì dentro di lei Virginia 24.5.11 16:53 Eliminato: solo «Aaaaaa» com’è freddo il pavimento. «Aaaaaa» come le fa male la testa. Seduta finalmente sul talamo riflette, anzi ci prova, non può semplicemente decidere e imperare, così, su se stessa; inizia a procedere per tentativi, pochi, faticosi, misurati. Convinta di riflettere per ore, trascorrono minuti che le sembrano interminabili, vuoti, o forse sono solo secondi. Che ti importa, lei, Virginia, non lo sa, vorrebbe solo svenire, su quel letto lercio, svegliarsi domani, fresca come un fiore, pensare più in là, a riparare la giornata persa. Ubriachezza = meditazione. Si entra nel tunnel dell'alcol o in quello della lucidità: in entrambi i casi, prima o poi, ti ritrovi con la mente vuota, e sei tanto forte quanto vulnerabile. La sconfitta di Virginia è dietro l'angolo, la testa, caduta tra le braccia mentre è ancora in camera nella penombra, > 32 :- la testa le pesa. Più la guardi e più speri, ti chiedi se ne sia valsa la pena di passare una serata tale, da ridursi così. Non è proprio il momento di chiederle come diavolo abbia fatto ad addormentarsi con quel coso dentro. Devo alzarmi, lavarmi, mangiare. Mi viene da vomitare. Nausea, odori, fastidio, naso, ancora nausea. Gola e conati, mi gira la testa. Non riesco a trattenermi, devo ri-met-te-re. Cazzo, è giovedì. Devo avvisare, sono in ritardo. Mi viene da vomitare e non mi ricordo nulla. Aaaaaaaaaaaaaa. Almeno mi sono svegliata sola, nel letto, dopo tutto, è già qualcosa. Virginia 21.6.11 00:03 Eliminato: Rimane seduta, non si capacita di cosa sia successo, di come quel vibratore sia finito lì, su quel letto. Virginia 21.6.11 00:03 Eliminato: , e poi, dal suo comodino, é inspiegabile come sia arrivato tra le sue cosce, e, come poi, lei, sia riuscita a dormirci, sopra. Virginia 24.5.11 16:57 Eliminato: Speriamo almeno sia venuta, addormentandosi di piacere. Virginia 21.6.11 00:30 Eliminato: Cazzo, cazzo, cazzo. Doccia. La vedi, sgambetta Virginia, fino alla doccia, si appoggia alla plastica del box, da dentro. Quanto sono odiosi quei pezzi di plastica, claustrofobici, che se hai mai fatto una doccia in quelle scatolette anguste – di quelle con il silicone che si è annerito, la plastica opacizzata, che hanno perennemente quella patina di sporco anche se le pulisci, che sono vecchie – be’, se lo hai fatto, allora puoi capire a che punto di degrado sia arrivata. È passata una settimana da quando l’hai vista, quella mattina, perduta. Oggi dovevano arrivarle le mestruazioni – l’ho capito perché è uscita dalla doccia, ha vomitato, si è lavata il viso, e ha tirato fuori gli assorbenti. Ecco, si è dimenticata le mutande pulite in camera. Corre di là, entra ed esce velocemente per il puzzo che dopo una settimana non è ancora svanito. Certo se avesse pulito... Ancora lì, che quando entra nella camera da letto vuole vomitare, ma non le va, quando rimette le brucia la gola. Prende le mutandine da un cassetto, scappa in bagno, si siede sul water e finalmente si libera. Si pulisce con della carta igienica e scopre il misfatto: certa di trovare sulla carta un po’ di quei segni che ti avvisano, stanno arrivando, sei > 33 :- ancora fertile e no, non sei incinta: nulla, nessuna traccia. Virginia 24.5.11 17:01 Eliminato: , ma Si accende la turbina dei pensieri, assurdi. «Non ci crederai, ma quando hai paura di essere rimasta incinta le pensi tutte, dalla prima all'ultima.» Unknown Eliminato: «Ritardo.» Quanto ritardo? Chi è stato? Con chi ero quella notte, non lo so. Cazzo. Sono incinta? Okay, calma – prometto che non lo faccio più. Vibratore. Ho usato il vibratore. No, oggi rimango a casa. Cazzo. E se sono incinta? 30 anni, lo tengo. Ma poi lo cresco da sola? Magari è femmina. Non sono stata con nessuno. Okay faccio il test. No, non lo faccio, tanto è negativo, ora arrivano, ora se mi concentro le sento, forse devo stare più in piedi, farle scendere. Se mi convinco che non sono incinta e non mi stresso, ritardano meno. Cazzo. Okay faccio il test. Virginia 24.5.11 17:02 Eliminato: porca puttana. Sta facendo pipì sul test di gravidanza, aspetta un attimo, le serve un minuto. Mi sa che è positivo. Perché? È svenuta. Letteralmente, con il culo per aria. Sì, sì, mi sa che è positivo. Mh. E di chi è? Sono stata a letto solo con il mio vibratore. Mese di magra. Meglio così. Incinta di un vibratore? Naaaaaaaa. Non posso avere un figlio blu. Chiamo. Chi chiamo? Chiamo Giulia. Virginia 24.5.11 17:03 Eliminato: Chiamo Giulia Virginia 24.5.11 17:05 Eliminato: . «Giulia?» «Ciao.» «Okay, non prendermi per pazza.» «Non posso essere incinta di un vibratore?» «Sì, un fallo di gomma, hai capito benissimo.» «Sì, quello celeste.» «Daiiii. Non ridere.» «Dici di no, eh?» «Okay, quindi falso allarme. Ma sei proprio sicura?» > 34 :- «Lascia stare, ti spiego poi, smettila di ridere. Stronza.» «Sì, ti chiamo dopo.» «Cià. » Virginia 24.5.11 17:04 Eliminato: Grazie. Virginia 24.5.11 17:04 Eliminato: Ciao Arriva, raggiunge Virginia, un po' di tristezza, perché la musica nelle orecchie ti ricorda di tempi passati. Pensa d’amore: noioso, inflazionato, argomento sviscerato in ogni suo aspetto, raccontato da tutti, ma tu ci entri comunque, in quest'atmosfera triste, e lei è triste, perché è sola, e non ricorda dov’è stata quel giovedì notte, durante la quale il vibratore, audace, l'ha fecondata. Virginia 24.5.11 17:05 Eliminato: Ecco, arriva Triste di sensazioni amare, in una camera in penombra,sul divano. Sofà di velluto giallo, brutto, vecchio, così vecchio che non lo puoi nemmeno spacciare per vintage, ed è l'imbrunire, è tornata da poco a casa, e non le fa più male la testa ma «Aaaaaa.» Le viene da vomitare. Virginia 21.6.11 00:06 Eliminato: - no, non la camera da letto - ora é Virginia 21.6.11 00:05 Eliminato: Perché é John Lennon, e perché parla dʼamore. Virginia 21.6.11 00:06 Eliminato: notte Sono già iniziate le nausee, e quella testa piccola, ora, è volutamente tra le sue mani, sembrano essere le sole, questa sera, a sostenerla, mentre pensa a questo figlio che blu, lei, forse, non vuole. Suona un uomo il suo campanello. Virginia 21.6.11 00:10 Eliminato: il vicino Virginia ha un vicino, è brutto, claudicante, è un essere insignificante, di cui non ti voglio neanche parlare. La sua massima espressione è il rumore, quando cammina appoggiato a quel bastone ogni passo si trascina, perché in questa storia è tutto consumato, anche la gomma sotto al pezzo di legno, e anche lui, che sembra di certo più anziano; di lui Virginia ha sempre avuto un po’ pena, forse per questo lo ha sempre evitato. Lui lo vedi sulla porta, incerto, non sa se entrare o meno in casa, e lei, che lo guarda assente, non lo invita a entrare, e lui quindi non si muove e, fermo lì, con un foglio macchiato e piegato in mano, le tende il braccio. Virginia 24.5.11 17:07 Eliminato: che fa rumore, Virginia 24.5.11 17:08 Eliminato: , anche se a Virginia, ha sempre ispirato un poʼ di tenerezza, come tutti, del resto. Virginia 24.5.11 17:10 Eliminato: consunto «L'hai scritto l'altra notte, è tuo.» Virginia prende il foglio teso, lascia il vicino sulla porta e in > 35 :- rigoroso silenzio lo spiega, lo legge, arrossisce, strabuzza gli occhi, sbatte la porta, si appoggia sulla porta chiusa come se il suo corpo fosse necessario a tenerla chiusa, e di nuovo, Virginia, viene a mancare: è svenuta, scivolando sulla porta, e ora, accovacciata sul pavimento, intravedi quel testo, quel foglio, la memoria di quella notte, la confessione di una persona che ormai non esiste più. Una settimana, due svenimenti, un vibratore e un bastone da passeggio, questa è la sua storia. Il vicino, la settimana prima, aveva bussato alla sua porta, ed era tardi, era sera, la musica troppo alta, a sentir lui, forse era solo tutta una scusa. Virginia già alticcia lo aveva invitato, quella volta, a entrare, gli aveva servito da bere, avevano esagerato, aveva servito di nuovo da bere, avevano iniziato a parlare di solitudine e per sentirsi meno soli si erano avvicinati, così vicini, così ubriachi, così tanti. Virginia aveva trovato, tra alcune foto che gli aveva mostrato, un foglio, pensieri di una Virginia più forte, non compromessa. I ricordi affiorati di quella notte. Virginia è incinta, no, non del vibratore. Virginia avrà un figlio. Virginia è incinta, incinta sul serio. Il padre chi è? Come, non lo hai ancora capito? È il bastone da passeggio. Sul foglio cosa c’è scritto? Leggi qui sotto. “Non sono così. Mi passano davanti cercando di annientare la loro femminilità nel vano tentativo di disperderla tra i lunghi corridoi. Quel non portare il profumo per non lasciare la scia. Quell'essere donne solo per cura, non per passione. Sorrido di fronte alla loro disperazione. Le osservo e mi sento femmina. Le sorprendo sbottonarsi un poco in discorsi da bagno, ignare e ironiche. Le ascolto sparlottare quando, così unicamente, sono sfacciate e sincere: mentre fanno la pipì, sedute. Piene di occhiali. I capelli corti. Il trucco inesistente che mi spacciano per elegante. Le scorgo indossare maglioni con colli così alti che ho pena. Virginia 24.5.11 17:10 Eliminato: in silenzio, Virginia 24.5.11 17:11 Eliminato: arrossisce, Virginia 24.5.11 17:12 Eliminato: di nuovo, Virginia 24.5.11 17:16 Eliminato: Una settimana, due svenimenti, un vibratore ed un bastone da passeggio, questa é la sua storia. > 36 :- Provo un sincero dispiacere per tutti quegli uomini che, maschi, dovranno scorgere i loro seni. Ascolto racconti da uomini, in toilettes per donne. Fuori da quelle mura disinfettate ogni ora riprendono la mesta giornata le ragazze di gesso. Tra i lavandini sono femmine d'oro, delle umane con sesso. Lo negheranno, arrossendo scapperanno, orecchie felpate e occhi velati. Torneranno a casa, dopo l'ennesima giornata vissuta così. Rifletteranno, non potranno fare a meno di darmi ragione. Come me, proveranno. Sentiranno vibrare i sensi, tese come corde di violino. Ripenseranno a quello che ho scritto, ascolteranno me, paladina di ovvietà. Posso farlo come voglio, dire cosa sento, tacere oppure no. Ho una vita tra le cosce. Gioco con i sensi e l'immaginazione. Fuori i timori, benvenute le scoperte. Fuori tutti gli altri, benvenuti vibratori. Immagino mani di maschio. Le sue dita sulla schiena. Il tenermi salda e calda. Mi frugo, mi percorro, mi lusingo, mi moltiplico di gioia. Amplifico i sensi. Sono una donna che si prende. Mi sintonizzo, armonica, sincera, dedita, bella. Mi racconto con brividi di lento piacere. Potrei non dover più cercare maschi e sesso. Potrei lanciarmi esclusivamente in rapporti così cerebrali da farli durare per sempre. Potrei tenere per me il succo. Cambio le batterie e ricomincio. Mi scivolo di nuovo tra le mani. So che siamo due sessi. Imparo a fare la mia parte, non aspetto per sempre, mi aiuto. Non cerco l'amore nel sesso. Non sento il nitrire del cavallo bianco tra le lenzuola. Il principe azzurro, fuori dal letto, mi aspetta impettito nel suo ampio mantello. Lascia il destriero, candido e mansueto, legato qui fuori, di fronte al portone. Suona la porta ed esco di casa, apro la porta, la pelle distesa, lo sguardo leggero. Sorrido del sesso sedato.” Virginia, avrà un figlio marrone. Virginia 24.5.11 17:13 Eliminato: Il vicino, la settimana prima, le aveva suonato ancora alla porta, ed era tardi, era sera, la musica troppo alta, a sentir lui. Virginia per stemperare la tensione, lo aveva invitato, quella volta, ad entrare, gli aveva servito da bere, avevano iniziato a parlare di solitudine e, per sentirsi meno soli, si erano avvicinati, così vicini, così ubrachi, così tanti. Virginia adesso ricorda tutto di quella notte, sì, hai ragione, é incinta, no, non del vibratore. Virginia avrà un figlio, Virginia é incinta, il padre? Come non lo hai ancora capito? È stato il bastone da passeggio. Adesso lei sa, avrà un figlio marrone. > 37 :- Altrove 05 di Anna Ornaghi to manga:et m fu o gi eg ss pa a d > Bastone “L’anima è la prigione del corpo.” Michel Foucault Vorrei che mi allacciassi le scarpe, che mi togliessi il grasso del prosciutto, vorrei che mi soffiassi il naso. Prenditi cura di me, amore mio. Ti prego, comprami il gelato, mi sporcherò, tu mi pulirai con un fazzoletto dopo averlo bagnato con la tua saliva, poi correndo cadrò, piangerò, tu ti preoccuperai ma sarà solo un graffietto e ci metteremo il cerotto con gli animaletti. Gioia mia, ho voglia di sporcare tutta la cucina, di usare un sacco di piatti e di posate, di tagliare, mischiare, di imburrare una teglia, cuciniamo una torta insieme, al cioccolato, e poi mangiamola subito, ancora calda, mangiamola tutta noi due. Saltiamo sul letto, tiriamoci le cuscinate, poi facciamo la lotta, ci faremo il solletico, ci daremo i pizzicotti, e i morsi, e anche i baci. Ci aggroviglieremo, ci annoderemo tutti e ti si scoprirà un capezzolo per sbaglio. Allora io vorrò vederle tutte le tue belle tette, tu farai finta di non volerlo, io farò finta di crederti, e tenterò di convincerti, ti terrò ferme le mani, ti alzerò la maglietta, ti vergognerai, con quel trepidante pudore che, dio mio, e io starò in silenzio apposta, in religioso silenzio per sentire che ansimi, e aspetterò qualche secondo prima di toccarti, e quando lo farò non potrai fare a meno di gemere. Spogliamoci, anima mia, ti voglio tutta nuda, in fretta, e voglio sentirti gemere ancora, voglio farti gemere, voglio farti godere, vieni qui, voglio mettertelo subito, anche le dita in bocca, ti entro da tutte le parti, mia, sei mia. Mia. Ma cosa cazzo dico? Mia, ma chi? No, non ce la faccio, non ce la faccio più. Non posso nemmeno farmi una sega. Non riesco più ad aver voglia di niente, eccetto di te, che nemmeno esisti. Piango, per me, per te, sarebbe bello se qualcuno mi accarezzasse i capelli, me li accarezzo da solo e finalmente mi addormento. Daniele non la conosceva affatto. Si erano parlati una volta soltanto. «Ma secondo te qui lo trovo un bastone da passeggio?» Una domanda di un'assurdità disarmante a cui aveva saputo rispon> 38 :- dere solo con un ottuso forse. Lei aveva cinguettato grazie ed era volata via senza nemmeno chiedere dove. È sconfortante pensare come nel corteggiamento gli animali si facciano belli e gli esseri umani invece si facciano scemi. E loro due in quel momento si erano fatti proprio scemi. Lei era tornata indietro, e tra le poche parole che si erano scambiati c'erano state anche "caffè" e "venerdì". Era lunedì, e quella fu una settimana bellissima. Quel dialogo surreale era stato una manna per la sua immaginazione. Era già da un po' che Daniele la guardava. La vedeva spesso passare al supermercato tra gli scaffali ben ordinati, a orari sempre diversi, senza mai un carrello o un cestino, con pochi prodotti ingarbugliati fra le mani e in procinto di cadere; proprio come i suoi vestiti, spalline disobbedienti la spogliavano volentieri lasciando nude le sue femminee clavicole e il loro lato opposto, quell'irresistibile momento in cui il collo diventa schiena. Non sapeva neanche il suo nome ma la pensava tantissimo, passava ore in attesa di poter raccogliere qualche secondo della sua identità, qualche filo del suo mondo con cui poi cucirle addosso storie che non erano la sua ma che, così gli sembrava, le calzavano alla perfezione. Glossava il suo modo di vestire, la sua voce, il cibo che sceglieva, parafrasava i suoi passi un po' dispari e ci leggeva dentro un'identità insolita, proprio quel tipo di personalità di cui si sarebbe potuto innamorare. Ti compri il burro e la marmellata perché ti piace la colazione più di tutti gli altri pasti. Quando c’è il sole la fai sul balcone, anche se fa freddo, ti avvolgi nella coperta, ti metti il cappello e la sciarpa. L’hai fatta tu quella sciarpa, con l’uncinetto, l’hai fatta che era giugno però e faceva caldo, lavoravi al parco, in costume, con le cuffie nelle orecchie, hai un vecchio lettore cd portatile, che tieni chiuso con un elastico azzurro. Hai anche un giradischi a casa, comprato per quattro soldi a un mercatino dell’usato, un giorno, a settembre. Ami i mercatini dell’usato, l’odore della polvere, le storie che raccontano gli oggetti. Ci ascolti la musica classica, a volume basso, seduta per terra, ti piace Bartók, Schönberg, le loro note un po’ storte, la disarmonia, come del resto ti piacciono tutte le cose in bilico. Cammini sul ciglio del marciapiede infatti, sui muretti, e ogni tanto cadi anche, perché sei maldestra, e ridi forte quando succede. Non che fosse del tutto inconsapevole dell'assurdità della sua infatua> 39 :- zione, ma non poteva fare a meno di continuare a fantasticare e a invaghirsi. Disegnava lui stesso questa amorosa spirale di Fraser e quindi conosceva bene l'illusorietà dei suoi cerchi concentrici, ma non solo continuava a vedere al loro posto un inesistente vortice, si faceva addirittura trascinare nel mezzo delle sue sleali volute. Alienante, forse, ma magnetico. Daniele era incantato dai suoi stessi giochi di prestigio e trovava più vero il loro inganno che la realtà della sua esistenza. Come quando continui a masticare una cicca anche se è diventata stopposa e insapore, ecco, così andava la sua vita. Faceva il macellaio, nonostante tentasse di essere vegetariano, in un grande ipermercato, nonostante si dichiarasse marxista, dal lunedì al venerdì, nonostante la convinta ostilità contro la settimana e in generale contro qualsiasi altra cosa che fosse standardizzata. Sono solo quattro ore al giorno, solo per pochi mesi. Il mondo poi mi porterà da qualche altra parte, no? Non posso pensarci io a dove portarmi, e non posso pensarci adesso. Non posso, lo sai anche tu. Ora vorrei soltanto non dico una stanza, ma almeno un posto letto più vicino al centro, dovrei trovare un coinquilino, ti piacerebbe essere la mia coinquilina? Coloriamo le pareti di giallo, piantiamo il basilico fuori dalla finestra della cucina, compriamo due pesciolini rossi, Capodoglio e Cleo, cosa ne dici? Preferisci un gatto? Però a un gatto gli dobbiamo dare nome e cognome: Giannino Stoppani, ti piace? Mi regalerai delle ciabatte brutte, le comprerai dai cinesi qui sotto, e comprerai anche delle candele, viola, rosse, bordeaux, e un nauseante incenso alla cannella che non ti permetterò mai di bruciare. C'è anche un discount lì vicino, metteremo i cestini alle bici per portare la spesa, però il pane lo prendiamo dal panettiere, compriamo pure la focaccia, e ne portiamo un pezzo anche a Giannino. Sogni low-cost che lo facevano sorvolare sulla scortesia dei clienti, sul ritardo del treno, sulla coda alle macchinette. Pensava di tutelarsi, di proteggere quello che era o che credeva di essere, tenendolo lontano da quello che si trovava a fare, e così prendeva le distanze dalla sua vita e la sbirciava da là, come se non riguardasse veramente lui ma qualcun altro. Erano stati i mesi dopo la laurea ad aver cominciato a parlare di quella persona con cui non si identificava per niente: lui non era un macellaio, non viveva nella triste provincia di una città che detestava, non faceva gli stessi orari tutti i giorni, la stessa strada. No, lui era tutt'altro e se ne stava, esiliato dalle sue giornate, a fare tutt'altro. Dovunque fosse > 40 :- era altrove, in un disperato, inconsapevole tentativo di crearsi una vita lontano dalla propria. Signore, vuole una mano? Gliela porto io la valigia, dove abita? Ah ma non è lontano, la accompagno volentieri. No, non ho ancora mangiato. Ma si figuri, non voglio disturbarla, davvero, vado a casa, abito qui a due passi. No no, non faccio complimenti. E va bene, se ci tiene così tanto, mi fermo. Piacere signora, scusi il disturbo ma suo marito ha insistito tanto. Ah, già in tavola? Dove scusi? Di qua? Ma che bello, io amo il glicine. Deve avere un sacco di anni questa pianta. Sì, con il sole fa proprio un effetto meraviglioso. E invece il sole non c’era. Pioveva, e quel signore anziano, che da solo trascinava faticosamente la sua valigia, aveva ormai girato l’angolo. Daniele camminava verso casa, e intanto consumava quell’etereo pasto, una grossa bottiglia di vino, l’etichetta scritta con la penna, il suono del primo bicchiere, ascoltando storie di partigiani da una voce malferma, sotto un vecchio pergolato coperto di fiori lilla. Purtroppo a fine pasto si beve il caffè. Era tutto il giorno che tentava di stare alla larga da questo pensiero ma ovunque andasse si ritrovava proprio lì, in quell’amaro caffè dov’erano annegate le sue speranze. Venerdì era arrivato pestando i piedi sulle scale, un rumore forte e imminente. Tremando gli aveva aperto la porta, e invece il fatidico giorno gli era passato in mezzo alle gambe, strisciando come una serpe, rapido era sgusciato via, lasciando di sé solo il suo veleno pulsante. Finalmente erano riusciti a parlarsi per più di qualche secondo, lontano da controfiletti e trita scelta, seduti al tavolino di un bar. Credeva che sarebbe stato magico il momento in cui avrebbero cominciato a conoscersi, se lo immaginava assoluto, senza i contorni delle circostanze, loro due e nient'altro, mentre il mondo sarebbe di certo scomparso, e invece c'erano stati i semafori, lo sgocciolio degli ombrelli, le monete, la segatura per terra. Un contesto prosaico, un palco illuminato al neon e dei pessimi attori a recitarci sopra un copione penoso. Era scontento di sé, delle sue mani imbarazzate, dei suoi silenzi che tamburellavano il tavolo e di tutto il resto, tutto il suo solito, timido, maledetto resto. Ma incredibilmente era ancora più scontento di lei, che aveva tradito tutti i colori che si portava addosso. In pochi minuti aveva brutalmente scacciato tutte le fantasticherie che Daniele aveva messo ad abitare nel suo corpo. Parlava di sé in terza persona, usava espressioni come > 41 :- un minutino, le scarpette, fa calduccio; nella borsa aveva un dannato smartphone con la cover fucsia e un inutile winny the pooh impiccato a un angolo, e le salviettine profumate. Ma soprattutto gli aveva scritto il numero di telefono su un fumetto manga, consigliandogli pure di leggerlo. In un'ipotetica classifica di fastidio Daniele avrebbe messo i manga al pari degli uffici postali, dei babbi natale appesi ai balconi e di Mr. Lui. Ma perché leggi queste stronzate? Tu dovevi leggere poesie, dovevi scrivermelo su un pentagramma il tuo numero, su uno scontrino del fioraio, l’avrei appeso al frigo, con una calamita a forma di carota. Come faccio ad appenderlo questo robo? Se lo rigirava tra le mani, faceva scorrere le pagine veloci per sentirne il rumore e l’aria, odorava di plasticaccia; poi guardò a lungo negli enormi occhi della ragazza in minigonna sulla copertina, lei non gli rispose nulla, continuò ad ammiccare e basta. Lo aprì: una calligrafia rotonda, larga, un numero e un nome. La rivide mentre lo scriveva, il tintinnio dei suoi tanti braccialetti colorati. La rivide mentre lo leggeva, stavi seduta per terra, ci scommetto, su un tram affollato, una mano nei capelli arruffati, il tuo viso morbido, il tuo bel sorriso asimmetrico con cui avrai di certo risposto agli sguardi di disapprovazione degli altri passeggeri. Sorrise. > 42 :- Blue ink. Un inchiostro blu sbiadito 06 di Irina Marazzi cettario:> fumetto manga- ri «Scusa, ho dormito tutto il viaggio. È ancora l’effetto del jet lag.» Il volto di Kazuko venne travolto da uno sbadiglio che lei cercò di trattenere con il suo pudore e con la mano di porcellana che spuntava dalla giacca di panno blu. Una sensazione di inaspettata familiarità l’aveva accompagnata durante tutto il tragitto accanto ad Anita, inconsapevole pedina del suo destino e spensierato connubio di ilarità e leggerezza distribuiti in un metro e ottanta centimetri di una magrezza spontanea. Il suo invito era arrivato la sera prima, preceduto solo da un tecnologico bip bip: “Sabato parto per la campagna, vado a trovare mio padre, sei dei nostri? Ti prometto buon vino, lunghe dormite e un po’ di lezioni di italiano. A.” Kazuko aveva guardato fuori dalla finestra alzando gli occhi al cielo sereno, portando il pensiero a quei film neorealisti con le ragazze in Vespa sulle colline e la famiglia riunita intorno a una tavola con la tovaglia a scacchi. Poi era tornata alla realtà, che sapeva molto di più di interessi condivisi e di una strana attrazione per quel mondo lontano dal suo, ma che sapeva accoglierla con un calore e una naturalezza da crearle dipendenza fisica. Dieci e mezza. Calle de la Misericordia, 11. Kazuko era lì, in piedi davanti al portoncino di legno un po’ délabré avvolta nella sua eleganza minimal, che le dava l’aria di un’illustrazione ad acquarello appoggiata lì per caso da un artista di strada. Le due esili figure bagnate dalla pioggia, impacciate nei loro scambi verbali da secondo incontro, si erano lasciate trasportare dalla lenta andatura del vaporetto che le avrebbe condotte alla loro terza compagna di viaggio: la vecchia Cinquecento di cui la bionda andava fiera come di un pesce rosso un bambino dell’asilo. Anita guardava avanti dominando la strada con la stessa decisione con cui era solita affrontare tutte le sue partenze, con o senza un motore sotto gli ischi. «Non ti preoccupare, sono abituata a viaggiare da sola» disse incli> 43 :- nando l’angolo della bocca in un sorriso, «e poi i Beady Eye mi hanno tenuto compagnia». Infilò la mano sotto il volante e senza mai distogliere il suo sguardo dalla linea tratteggiata che delimitava la striscia di asfalto di sua pertinenza, estrasse la custodia scalcagnata di un cd, dove troneggiavano i bronci del gruppo inglese. Il contachilometri ondeggiava tra i settantacinque e gli ottanta chilometri orari e l’automobile sembrava sospesa sull’asfalto umido. Anita adorava girare la chiave del motore e arrivare rapidamente alla quarta, le dava un senso di libertà che la inebriava come una piccola sbornia. Il motore acceso e l’autoradio a tutto volume erano una delle cose che le mancavano di più da quando, dal paese sulle colline dov’era cresciuta, si era trasferita nella città dei canali, delle gondole e dei turisti d’assalto. Aprì il finestrino motorizzato e inspirò a tutte narici l’aria frizzantina che entrava scompigliandole l’ingestibile nido di ricci biondi. L’occhio di Kazuko nascosto dall’obiettivo della sua Canon immortalava quegli istanti con scatti veloci sull’inchiostro digitale. Dopo meno di un giro di lancette la Cinquecento rossa sterzò infilandosi in una stradina sterrata, varcò le lance verdi arrugginite del cancello e frenò sulla ghiaia gracchiante alla fine del viale. Il professor M. era lì, fermo e vigile come un gabbiano che scruta l’orizzonte appollaiato sull’albero di una barca in attesa di scorgere un movimento di onde che gli dia il via per partire in planata sullo schermo lucido dell’acqua. «Un’ora e dieci minuti scarsi. Ti piace proprio tirare quel povero motore». La sua voce pacata e ferma attraversò il portico ombreggiato e diede il benvenuto alle due ospiti. Anita allungò le sue gambe da fenicottero avvolte nei jeans azzurrini, le lasciò cadere leggere dall’auto sbattendo con decisione la portiera e si diresse verso la porta d’ingresso fingendo di non preoccuparsi dei bagagli e della sua ospite. Il professore si diede un piccolo slancio per alzarsi dalla sedia di vimini, sulla quale aveva deciso di abbandonarsi nel pomeriggio alla lettura di uno dei libri che avevano segnato la scoperta della sua passione per le culture del mondo. La ragazza dalla pelle di mandorla era in piedi davanti all’auto, abbandonata dall’amica al suo destino. Rimasero per un breve e interminabile momento in silenzio, uno di fronte all’altra, illuminati da ombre lunghe che si protraevano dai loro corpi cercando di avvicinarli. > 44 :- Quel silenzio non cercato si interruppe troppo presto: «Tu devi essere K., Anita mi ha parlato molto di te». La figura elegante avvolta in un lino beige si avvicinò e prese sottobraccio la nuova arrivata. Le due ombre ormai intrecciate voltarono le spalle al cancello come a un pubblico immaginario ed entrarono finalmente sul palcoscenico della loro futura messa in scena, Villa Ghiandaia. Era un edificio dei primi del Novecento che nella facciata esterna conservava il fascino di una signora ultracentenaria i cui tratti rivelano l’antica bellezza: un intonaco rosa pallido da cui spuntavano grandi finestre come occhi dipinti di verde e un portico accogliente e intimo come un abbraccio materno. La casa era tenuta in perfetto ordine, nonostante da qualche anno rimanesse vuota per molti mesi consecutivi. L’ambiente non aveva niente di tetro, anzi, nonostante l’assoluta assenza di elementi d’arredo moderni e di una cura femminile, trasmetteva una freschezza e una disinvolta classe che le perdonavano le tarme sui tappeti e il miscuglio di stili e colori delle stoffe e dei mobili. Dopo qualche minuto dal loro arrivo, Anita aveva già occupato la sua postazione preferita, la grande cucina al piano terreno, dove ogni cosa conservava il ricordo delle donne di quella casa. Canticchiava e rumoreggiava spostando piatti e pentolame e, come un’attrice sulla scena, ripeteva ad alta voce il nome di tutto quello che toccava, quasi a volerne definire la presenza, per paura di dimenticarsi qualche strumento fondamentale per la sua rappresentazione finale. Kazuko, attratta da quell’orchestrare di melodia, rumori e profumi, decise di rimandare l’esplorazione dei piani alti e si lasciò condurre lentamente alla fine del corridoio per raggiungere la cucina. «Eccoti. Ti stavo aspettando. Perché ci hai messo tanto? Papà ti ha dato fastidio?» Anita scoppiò in una risata fragorosa e palesemente forzata. «Be’… benvenuta nel mio regno!» disse con tono stentoreo, «qui gli uomini non ci mettono piede. Non ci hanno mai messo piede. Papà lo sa, infatti se ne sta alla larga.» Come un direttore di giochi prese in mano il suo libretto d’istruzioni e lo lanciò sul tavolone in marmo di fronte a lei, senza mai distogliere lo sguardo dal viso immobile dell’amica. Era un quaderno comune dalla copertina verde consumata sugli angoli. Le pagine ingiallite erano riempite da una calligrafia blu sbiadita che aveva trascritto minuziosamente ricette, indicato misure, ingredienti, impreziosendo il tutto con qualche schizzo dal tratto infantile. Kazuko iniziò ad analizzare il contenuto del libretto cercando di na> 45 :- scondere ogni suo tentennamento sulla lingua all’amica che la osservava severa come un’istitutrice in grembiule e scarpe da tennis. Le sembrava di essere stata catapultata in un’altra dimensione. Non sapeva bene che cosa la portasse a provare quella sensazione, ma le era chiaro che lì dove si trovava si pesava al microgrammo chi aveva più carattere dell’altro. «È un ricordo di famiglia?» chiese per rompere quel silenzio quasi interrogativo. «Diciamo che è una delle poche cose autentiche che mi rimangono di lei» disse Anita aprendo la copertina del quaderno dove campeggiava il nome di una donna: Valerie M. «Tutto il resto sono foto in posa e vestiti da ballo. Ma questa non era mia madre.» Il suo volto si illuminò per qualche istante di una strana dolcezza, che lei stessa non conosceva, nascosta com’era sempre dietro la sua scorza da dura. «Dai, aiutami. Leggi qui» le disse indicando una pagina segnata all’angolo. «È il mio piatto preferito ma non riesco ancora a conoscerne a memoria la ricetta.» Kazuko si schiarì la voce e iniziò a tradurre quei segni apparentemente senza significato e che sillaba dopo sillaba svelavano l’incredibile mistero della scrittura. Parola dopo parola, riga dopo riga, quei frammenti di biro sulla carta tessevano una rete invisibile che legava anche solo per pochi istanti quelle due anime forse poi non così distanti tra loro. Le due donne si muovevano sul terreno fragile e incerto dei ricordi, delle paure, delle facciate e delle convenzioni, celandosi dietro quell’impegno condiviso. Dal giardino il professor M., tra una pagina e l’altra del libro che ormai distrattamente sfogliava, osservava la scena incorniciata dagli infissi color canna di fucile delle grandi finestre. Il suo sguardo era catalizzato dai gesti delle due ragazze, movimenti sincronizzati come in una danza di cui lui era unico e privilegiato spettatore. Presto la cena fu pronta. La tavola era stata coperta con una tovaglia blu cobalto, sulla quale piatti di porcellana bianca stavano come oblò affacciati sull’oceano. Una bottiglia di Valpolicella del 2006 e un pacchetto di carta, anch’essa bianca ma legata da un nastro rosso, erano stati posizionati vicino al capotavola. I tre commensali presero i loro posti come burattini manovrati da regole non scritte. L’uomo a capotavola, l’ospite alla sua destra e la padrona di casa di fronte. Un momento di silenzio li colse. I loro sguardi oltrepassarono come > 46 :- laser i piatti che riempivano la tavola senza curarsene troppo e senza farsi scorgere dagli altri, si alternarono nell’osservare il pacchetto. La forma rettangolare e lo spessore di qualche centimetro sembravano svelarne il contenuto. «Un pensiero per questo vecchietto...» disse il professor M. prendendo tra le mani l’oggetto che era stato appoggiato sul piatto di fronte a lui. «Chi devo ringraziare? Anita, non mi dire che ti sei ricordata del mio onomastico, sarebbe la prima volta in trent’anni!» Anita scoppiò in una delle sue risate fragorose quanto fuori luogo e, appoggiandosi allo schienale della sedia, lanciò uno sguardo di sfida alla neo rivale dandole la parola. «Credo che sia un regalo che ha portato la nostra ospite. Sei un vecchietto coccolato. Non è vero, Kazuko?» «Era un pensiero…» non riuscì a terminare la frase che fu interrotta dallo squillo del telefono, puntuale come un orologio svizzero che scandisce il tempo della rappresentazione. «Papà, non ti alzare» disse Anita con aria scocciata, «diamo inizio alle danze di Bacco!» e allungò la mano alla bottiglia di vino versandone il contenuto ai suoi vicini. E la danza iniziò. Verdure variopinte, affettati, risotto con i funghi e poi carni, contorni, vino: un’orgia di sapori per il palato e lo spirito. Il professore teneva la scena con i racconti dei suoi studi, i suoi viaggi, la sua passione per il paese del Sol Levante, intervallando nozioni storiche ad aneddoti di vita di cui neanche Anita era a conoscenza. Kazuko rideva inebriata dal vino e dai discorsi del professor M., che dietro l’apparente riservatezza sembrava compiaciuto di quel suo momento da protagonista. Il suo viso, rilassato e sorridente, svelava tutta la femminilità di una giovane donna. Un fascino nascosto come il cortile di una città che cela fiori e rampicanti, che una volta scoperti non lasciano dubbio alla loro bellezza. Anita si godeva lo spettacolo cercando di capire fino a che punto essere divertita da quel riscoperto Cirano che affabulava con le parole la sua uditrice o quanto esserne profondamente infastidita. Questa dicotomia di pensiero e di sentire la portava a guardare attonita i suoi commensali, senza aver esigenza di proferire parola, quasi a non voler intaccare quel tableau vivant che le si presentava davanti agli occhi. «Forse ho parlato troppo questa sera» disse il professor M., «Kazuko, raccontaci un po’ di te. Sono stanco di conoscere l’Oriente solo dai > 47 :- miei libri» sorrise inclinando il busto verso la sua designata complice. E così iniziò il valzer a due che escludeva con uno scacco Anita, spettatrice ormai insofferente e fuori dai giochi, forse per sua stessa volontà. Si alzò sgranchendosi le lunghe braccia nude per sistemare la tavola, scusa indiscutibile per potersi ritirare dalla scena, e tornò in cucina, lì si sentiva sempre a casa. Si accese una sigaretta per sentire il conforto della nicotina e del respiro a pieni polmoni. Si lasciò cadere sulla sedia di vimini appoggiata al muro e sorrise sotto i baffi. Sentiva le loro voci che dalla sala da pranzo si spostavano lentamente verso il portico d’ingresso, dove una sera lucida d’umidità avrebbe accolto i due spiriti allegri. Guardò il disordine che la circondava, non curandosene affatto. Sapeva di avere tutta la notte solitaria davanti a sé per occuparsi di faccende pratiche come quelle. Si alzò e tornò verso la stanza abbandonata. Sulla tovaglia blu erano rimaste solo briciole, due bicchieri e una bottiglia vuota. E il pacchetto ancora incartato. Anita lo prese in mano premendo la carta bianca che lo avvolgeva per cercare di intravedere qualcosa. Ma non resistette a lungo, sciolse il nastro rosso e scartò il pacchetto silenziosamente, quasi per paura di essere scoperta. Rimase di stucco non appena vide di cosa si trattava. Trattenne una delle sue fantomatiche risate, che però le riempirono gli occhi di lacrime. Un fumetto manga. Il primo volume di una collana dal titolo incomprensibilmente scritto in giapponese. Aprì la prima pagina. Una scrittura azzurro pallida, che dichiarava la sua appartenenza femminile, aveva lasciato queste parole: “Ad Anita. Per iniziare ad amare questo piccolo ma immenso mondo. K.” Scivolò lenta sulle sue gambe molli fino a sedersi a terra. Il suo viso era bagnato dalle lacrime che facevano spazio alla sua fantastica, contagiosa e rumorosa risata. Una rete di parole scritte, sussurrate, dette e non dette, tesseva quelle tre anime con intrecci e nodi di un color inchiostro blu sbiadito. > 48 :- Demone del XX secolo 07 di Alessandro Mariotti > ricettario - clessidrA:- Era un lieto fine malgrado tutto, ne era certa. Era un piccolo quaderno verde pieno di ricette quello che le avrebbe procurato fama, crescere l’autostima e data la soddisfazione di rivelare al mondo un mistero notevole. Pazienza, quindi, se ormai stava per morire lontana da casa, in una moschea di Baghdad con un pugnale conficcato nella schiena. Pazienza perché finalmente si sentiva davvero felice, come se non le restasse altro da fare al mondo. Estasi superiore era impossibile. Aveva combattuto e aveva vinto. Per questo negli ultimi due anni aveva girato l’America alla ricerca di quell’uomo. A Miriam i soldi interessavano poco: ciò che le stava più a cuore era che qualcuno apprezzasse il suo lavoro e riconoscesse i suoi meriti. Potesse essere finalmente riconosciuta, la migliore, migliore degli altri. Una sensazione nuova, attesa da tutta la vita. Fin da bambina aveva sofferto di quello che chiamano “complesso di inferiorità”: studentessa mediocre e persona introversa. Dagli adulti riceveva più che altro critiche e rimproveri, e si sentiva indietro rispetto alla maggior parte dei suoi coetanei. Nulla era cambiato da adolescente e neppure quando il giornale l’aveva assunta. Eppure molta gente si sarebbe accontentata di un impiego fisso, di questa sicurezza: nessuna variazione, nessun rischio, una situazione che ti permetta di organizzare la tua vita “al dettaglio”. Ma non era questo che cercava. No, lei aveva bisogno di stima. Per lei il tempo non serviva per essere riempito ma per essere usato al massimo. I libri che leggeva glielo suggerivano: solamente il rischio, l’avventura e il cambiamento costante ti fanno uscire dall’anonimato. Ricercare la sicurezza in un ufficio e in un marito voleva dire accontentarsi: nel suo caso appassire, invecchiare prima del tempo, restare nell’ombra. Miriam aveva sempre preferito il dolore alla noia, al nulla, alla resa totale. Aveva accettato una sfida: indagare per conto del suo giornale, una > 49 :- rivista femminile italiana, sulla morte della diva più famosa d’America. Marilyn Monroe. Tutti in redazione avevano rifiutato l’incarico, troppa concorrenza, troppa mafia intorno alla questione, troppi i rischi. I genitori e gli amici erano contrari a questa sua scelta, non ne capivano la ragione. Non le bastava quello che aveva? Per la prima volta in vita sua avrebbe voluto essere un uomo. Era arrivata addirittura a invidiare quelli che partivano per la guerra: morte, distruzione e sangue, ma avventura. Così era partita per Washington per incontrare due giornalisti americani di cronaca nera e si era trattenuta lì tutta l’estate intervistando gente dello spettacolo, imbucandosi in party frequentati dai politici, passando ininterrottamente da un incontro a un altro e tendendo l’orecchio a ogni dettaglio, anche il più insignificante. Il direttore del giornale continuava a ripeterle di basarsi solo sui fatti, di essere imparziale e oggettiva. Lei però era stufa delle “regole della buona stampa”, iniziava a detestare l’oggettività e si lasciava andare al suo sesto senso. Qui ci voleva immaginazione, se no non sarebbe andata oltre quello che gli altri giornalisti avevano già portato in luce. E lo faceva soprattutto per se stessa, non solo per dovere verso il suo lavoro. Non aveva nostalgia per il suo anonimo passato. Anonimi genitori anonimo paese natale anonimo focolare domestico. La sua avventua americana decollava e quello che più la stimolava era il remare controcorrente dentro a quell’indagine, che era giunta alla conclusione più semplice e meno compromettente. Marilyn si era suicidata, il risultato di una vita burrascosa e tormentata, di cui il flirt col presidente Kennedy era stato solo l’epilogo. La storia dell’omicidio era pura invenzione, al cento per cento. Ma per Miriam c’era di più. Due punti oscuri nell’indagine: la presenza di un uomo misterioso, presumibilmente straniero, che Marilyn aveva incontrato tre giorni prima di morire a Dallas, e la conversazione telefonica che aveva avuto, alcuni mesi prima della morte, con il famoso scienziato tedesco Wernher von Braun, l’uomo che negli anni Quaranta aveva venduto a Hitler i raggi V2 e che ora era diventato il direttore della Nasa impegnato nel progetto dello sbarco sulla Luna. Numerosi colleghi avevano già indagato sulla presunta telefonata ma non erano arrivati a capo di nulla. Von Braun, uomo schivo e cinico, era praticamente inavvicinabile. Impossibile estorcergli un’intervista. Miriam non si era lasciata intimidire ed era partita per il Texas, verso la sede Nasa, e con caparbietà in pochi giorni era riuscita a fissare un > 50 :- colloquio col celeberrimo e misterioso scienziato. Il press agent di von Braun le aveva concesso un incontro di trenta minuti. Erano pochi ma li avrebbe fatti bastare. Grazie a una ritrovata sicurezza e un talento non ancora riconosciuto, la capacità e la sensibilità di cogliere in ogni piccolo dettaglio degli atteggiamenti delle persone la loro psicologia, mise von Braun con le spalle al muro e lo indusse a rivelare ciò che non aveva detto agli altri giornalisti. Una storia che aveva dell’incredibile iniziava a emergere: l’uomo misterioso che Marilyn aveva incontrato poco prima di morire esisteva davvero. Un personaggio di origine araba che von Braun aveva conosciuto vent’anni prima. Lo aveva visto solo una volta nel lontano 1943: un uomo dall’aspetto agghiacciante, né giovane né vecchio, simile a un diavolo biblico, e questi lo aveva ricattato e minacciato, obbligandolo a vendere a Hitler le sue scoperte tecnologiche. Proprio quei raggi che avrebbero seminato tanta morte e tanta distruzione. Era stato quindi quello strano dottor Faust il vero responsabile di tanti orrori, e da allora von Braun aveva cercato di cancellare il passato dedicandosi a un progetto che lo potesse riscattare da tanto orrore e fosse di vantaggio al progresso del genere umano: l’esplorazione lunare. Miriam promise di non pubblicare né divulgare la notizia ma non poteva far a meno di ripensare a quell’uomo freddo, distaccato, quasi glaciale. A quello sguardo privo di emozioni e sentimenti, a quella voce che raccontava fatti terribili come se non lo riguardassero, senza alcuna partecipazione. Pensava che forse tutti gli scienziati sono così: cercano solo la logica nelle cose, vedono il mondo con distaccato cinismo, probabilmente non hanno mai letto un romanzo. Uomini che dimostrano più anni di quelli che hanno, a cui manca l’ironia e soprattutto la scintilla della gioventù. Due giorni dopo era a Dallas a seguire le tracce del diabolico arabo, con una domanda che le girava per la testa: ma si trattava di una persona o erano due? Due settimane di incessanti ricerche, setacciando pub e locali notturni, pellegrinando dall’ufficio di uno sceriffo all’altro per le varie contee della città, interrogando i direttori di quasi tutti i motel. Quando stava per arrendersi, stanca, al bancone di un dinner deserto con davanti un triste hot dog, aveva alzato gli occhi verso la cucina a vista del locale e il suo sguardo aveva incrociato quello di un cuoco che poteva ricordare la descrizione dell’uomo. > 51 :- Miriam decise di affidarsi al suo istinto, lo fissò senza distogliere neppure un secondo i suoi occhi da quella figura, ma bastò un battito di ciglia che restò solo una porta cigolante a sventolare e dell’uomo più nulla. Era lui. Due chiacchiere col cameriere e subito la lingua si sciolse: era stato assunto dal proprietario perché diplomato in una buona scuola di cucina, la migliore in città. Anche se proprio lui non capiva a cosa servisse, visto che lì più che hot dog e hamburger non si servivano. Quanto bastava, Miriam ora aveva una traccia. E la certezza che il suo istinto la potesse portare lontano. Non erano ancora le dieci della mattina successiva quando il direttore della scuola di cucina identificò il sospettato: «Sembrava venire da un’altra epoca, parlava malissimo l’inglese e si esprimeva più che altro a cenni, cosa ci faceva qui? Era un mistero. Di certo però la cucina non gli interessava, era molto più probabile che volesse nascondersi da qualcuno, che stesse tramando qualcosa e che frequentasse la scuola per imparare meglio la lingua e integrarsi. Infatti da un giorno all’altro è sparito.» Ma qualcosa di lui era rimasto lì, e visto che nessuno l’aveva reclamato glielo poteva consegnare: il quaderno degli appunti. Miriam era sull’aereo che sorvolava il Kansas e aveva tra le mani un ricettario di cucina accuratamente scritto in buona calligrafia. Lo osservava attentamente: era la prova che cercava? La ricompensa per tutti i suoi sforzi? Qualcosa non funzionava. Sembrava scritto da una donna, anzi la scrittura arrotondata era del tutto femminile, così come l’ordine e la cura delle ricette. Nulla di sospetto e l’assoluta mancanza di un qualsiasi tocco personale. Era diretta a Philadelphia e aveva come destinazione la casa di Arthur Miller, il celebre commediografo che era stato l’ultimo marito di Marilyn. Miller era l’opposto di von Braun: anche lui uomo di grande cultura e con una forte personalità ma brillante e spigliato, schietto e ben poco misterioso. Di lui si percepivano immediatamente i sentimenti, le paure, e traspariva una timidezza che metteva chiunque a proprio agio. A differenza di von Braun e di Miriam era critico nei confronti dell’America, non capiva l’odio per i russi, non appoggiava minimamente la caccia alle streghe del maccartismo e criticava duramente l’industria dello spettacolo: Hollywood e Broadway. Chiaccherarono a lungo, Miriam sosteneva le sue idee e la sua fede nel sogno americano, argomentava, ironizzava, si muoveva con disin> 52 :- voltura. Era un’altra Miriam, quella che aveva sempre voluto essere. Arrivato il momento di tornare all’indagine, gli raccontò tutto il percorso della sua ricerca. Miller la seguiva con interesse e iniziò a collegare con lei alcuni fatti accaduti anni prima. Un giorno Marilyn gli aveva mostrato una clessidra regalatale da un suo ammiratore, uno straniero dall’aspetto mediorientale, che sembrava essere avvolta da una strana leggenda. Arrivava da Baghdad e si diceva che nelle notti in cui il deserto è attraversato dalla tempesta, la sabbia in essa contenuta salisse invece di scendere, come detta la legge di gravità. Miriam era molto colpita ma lui non ricordava altro e non sapeva che fine avesse fatto quella famigerata clessidra, rammentava solo che era molto grande e che la sabbia era di un viola intenso. Mentre camminava sul vialetto della casa di Arthur Miller, lasciandosela definitivamente alle spalle, Miriam iniziava a rendersi conto di quello che era accaduto. Si rivedeva in quel salotto, a suo agio nei modi e nelle parole. Si vedeva per la prima volta se stessa. Ora bisognava completare il viaggio: Iraq, nella città cuore del Medio Oriente, seguendo il talismano della storia, la magica clessidra. Baghdad era un mondo a sé stante dal sapore antico e contraddittorio. I racconti de “Le mille e una notte” che aveva letto da bambina erano lontani in quella città assalita dal cemento armato, ma le antiche moschee trattenevano ancora un po’ di quell’aria magica. Difficile catturare in poco tempo una città così diversa per cultura e religione, difficile congiungere le atmosfere dell’Oriente con quel paesaggio urbano e sofferto. Il quarto giorno, verso sera, aveva raggiunto la moschea di Kazimayn, il luogo di culto più famoso della città, con una cupola dorata. Aveva indossato abiti musulmani scuri, si era velata con la hijab e si era fatta spiegare come comportarsi nella moschea. Pochi minuti dopo il suo ingresso un leggero fruscio alle sue spalle l’aveva fatta voltare. Aveva sentito un dolore intenso alla schiena e si era piegata, cadendo a terra. Non aveva fatto rumore sul tappeto, dove si intrecciavano blu cobalto e rossi accesi. Era stata pugnalata. Nei suoi occhi si impresse un’immagine che aveva del solenne, un viso scolpito e affascinante. Se quello era il diavolo aveva un viso perfetto. Miram aveva varcato il confine di quello che un giornalista deve sapere, ma qualcuno doveva provarci. Aveva lasciato che la passione per il suo lavoro la trasportasse e la trasformasse in quello che lei avrebbe voluto essere. Da bruco a farfalla, anche solo per un giorno. > 53 :- Appartamento pomeridiano 08 di Chiara Blau ca:> clessidrA -Libro con dedi Erano visioni e strade ancora inconsuete, erano foglie diverse e passi diversi, erano respiri e sospiri di una nuova vita. Si sentiva un nuovo rumore, uno sconosciuto ticchettio di scarpe su un marciapiede mai percorso prima. Ines respirava gli odori di un vento insolito, catturava con lo sguardo e con il cuore quel mondo per il quale si sentiva vibrare di diffidenza e gioia. E mentre si perdeva in quegli intrecci che erano parte all’infuori di lei e parte dentro di lei, Alvise la stava seguendo. Ines non sapeva che il suo atteggiamento etereo e sfuggente non era passato inosservato tra i nuovi colleghi di scuola, e che uno di loro ne era rimasto talmente colpito da aver deciso di porsi furtivamente al suo seguito. Non c’era voluto molto perché Alvise prendesse quella decisione. Dalla prima volta che l’aveva vista, aveva sentito ardere in lui il desiderio di varcare quella barriera che lei pareva ergere tra sé e il mondo. La prima volta l’aveva vista di spalle, in un luminoso corridoio dell’ultimo piano, con i lunghi capelli vermigli e lisci scorrerle fin sopra i fianchi e con quel suo corpo esile e delicato. Si era voltata lentamente e con grande determinazione, e quando Alvise aveva visto il suo volto, era rimasto impressionato dal candore della sua pelle che tradiva i suoi quarant’anni solo attorno agli occhi e ai margini della bocca, alla quale si contrapponeva quel colore rosso che predominava tanto nel suo viso quanto nella sua figura. Erano le sue guance, le sue labbra, i suoi capelli, le sue unghie, i bottoni del cappotto, le sue scarpe. Quelle scarpe così vezzose e stravaganti, rilucenti e infantili da far strabuzzare gli occhi al più imperturbabile degli uomini. Quell’immagine lo aveva attratto come una sorprendente opera d’arte, ma quel fascino era rimasto un bel sogno nel suo sguardo perché lei, benché cortese e gentile con tutti, non concedeva a nessuno la sua parte più cospicua. Non appariva inibita o timorosa, piuttosto ponderava con grande naturalezza una spontanea socievolezza. Nessuno era riuscito a sapere che cosa l’avesse spinta nella nuova città, se avesse seguito un > 54 :- amore, una passione, un ragionamento, o se fosse stato il caso o una forza più grande di lei a condurla lì. Finita la scuola, nel primo pomeriggio, Alvise non era il solo a guardarla allontanarsi con suo passo sicuro. Ines si dirigeva verso quei luoghi per lei ancora sconosciuti, lasciando interdetti tutti coloro i quali avevano creduto di poterne essere il cicerone. Ines svoltò l’angolo. Il suo passo era deciso ma Alvise vide che qualcosa l’aveva placato e la sua andatura tradiva ora una certa mestizia, un certo languore. Spostando all’indietro il cappello, dal quale si illudeva che la sua imponente figura potesse essere nascosta, la vide osservare la vetrina di un negozio e poi, dopo un tempo non indifferente, entrarvi. Allora si avvicinò alle vetrine e la osservò dall’esterno muoversi tra gli scaffali. Sembrava una bambina in un negozio di dolciumi alla quale i genitori hanno vietato di assaggiare alcunché. La sua mano scorreva sugli oggetti esposti, talvolta si soffermava su qualcosa. Il suo fare suggeriva che volesse afferrare tutto ciò che la circondava, eppure sfiorare quegli oggetti o impugnarli con impeto non era né una conquista né un piacere, ma un gesto inutile e deludente. Guardandosi intorno avidamente, Ines si addentrò nel negozio e Alvise non riuscì più a distinguerla. Entrò quindi nel negozio, si diresse con decisa circospezione verso la zona dove l’aveva vista scomparire. E all’improvviso eccola, seduta su una panca di dimensioni minute, le gambe aperte lasciate andare e i piedi, calzati da un paio di slanciate scarpe rosse, appoggiati sul lato interno. Nella mano destra impugnava un oggetto dalla forma cilindrica e lo girava da una parte all’altra a ritmo regolare. Alvise guardò più intensamente per capire cosa fosse quell’oggetto e quale senso potesse avere che un’adulta e affascinante donna, nel tenerlo tra le mani e nell’osservarlo, sembrasse preda di una stregoneria. Strizzò gli occhi per capire meglio e credette di identificarlo con una strana clessidra. Poi guardò il suo volto e gli parve d’improvviso disgustoso. Era come se si stesse gonfiando, come se i suoi occhi si stessero ingigantendo e la sua bocca si fosse raggrinzita. D’un colpo, sentì il sudore gelargli sulle mani. Le passò sui pantaloni per asciugarle, ma un brivido lo sorprese alla schiena e il suo viso si infiammò di vergogna. Era come se eclissato dietro una tenda stesse osservando un amplesso o assistendo di nascosto a un’agonia mortale. Distaccò la sua attenzione da lei e si guardò intorno per capire dove fosse. Alla sua destra una miriade di microscopici pupazzi di gomma rappresentavano animali di vario genere, alla sua sinistra una serie di libri illu> 55 :- stravano l’arte della puericultura e dell’essere genitori e dal soffitto un enorme pterodattilo pareva si stesse gettando con aria minacciosa su di lui. Il suo sguardo tornò su di lei, la quale stava ora passando in rassegna la folta chioma di una bambola. All’improvviso Ines voltò lo sguardo dalla sua parte, tanto che lui credette di essere stato scoperto e già meditava le scuse da somministrarle, ma il suo corpo fu più veloce dei suoi pensieri e riuscì a nascondersi nel reparto libri. Lì un commesso lo esaminò con aria scontrosa, mandò un’occhiata dalla parte di Ines e ritornò con sguardo ancor più severo su di lui. Questi, con un sorriso teso, raccolse casualmente un libro dal bancone, fece segno al commesso come se avesse trovato proprio quello che cercava, ed estrasse il portafogli dalla tasca dei pantaloni dirigendosi verso la cassa. Distratto dal mascherare il suo reale atteggiamento, si era sentito in dovere di intrattenersi più del necessario con gli inservienti del negozio, almeno fino al momento in cui, al di là delle vetrine, vide Ines lungo il marciapiede. Afferrò in fretta il libro e mentre lo infilava nella cartella di cuoio che teneva a tracolla uscì di corsa per strada. Si guardò smarrito a destra e a sinistra e per un istante temette di averla persa. Poi la vide, dall’altra parte della strada. Camminava ondeggiando, come se i suoi piedi non appoggiassero a terra, come se esitasse sospesa nell’aria. D’un colpo, Ines fu a terra. Alvise si lanciò sul suo corpo inerme. Le sollevò la testa e quando vide che non era ferita le sollevò le gambe. Le scosse le braccia e la colpì sul viso con le sue mani imponenti. Quando lei aprì gli occhi credette per un istante di trovarsi nel suo letto, nella sua stanza, ma guardandosi intorno vide la città. Poi distinse il volto conosciuto di Alvise. «Ines, è tutto a posto. Sei solamente caduta, uno svenimento probabilmente. Nulla di grave. Come ti senti?» le disse cercando di nascondere una certa apprensione. «Alvise… non capisco come possa essere accaduto…» I suoi occhi erano spalancati di fronte a lui. Sembrava che tutti gli oceani si celassero dietro quella sfumatura umida che le velava lo sguardo. Repentinamente, Alvise sorrise con dolcezza. «Io un dubbio ce l’avrei…» le disse, indicando i suoi piedi, «le hai rubate a Dorothy?» Lei lo guardò dritto in viso. Poi il suo sguardo severo si sciolse in un sorriso che sembrava non dovesse mai completarsi. «Sono davvero assurde… sembrano proprio uscite dal Mago di Oz!» > 56 :- Quando il riso si smorzò, Ines bevve un sorso d’acqua dalla bottiglia che Alvise aveva recuperato nella sua borsa. Poi, lentamente, l’aiutò ad alzarsi. La prese per le braccia e sentì il suo esile corpo, le sue ossa sporgenti sui gomiti e il suo polso sottile. «Ines, ti accompagno a casa. Dimmi dove abiti» disse senza lasciarla, quando fu in piedi. «Non è necessario, davvero. Prendo qualcosa da mangiare se mi accompagni» rispose cercando di non guardarlo negli occhi. «Certo, ti accompagno. Ma poi ti porto a casa» rispose lui con risolutezza. Ines non aveva la forza di replicare ancora, e sebbene la prospettiva di essere accompagnata fino al suo appartamento la terrorizzasse, si rassegnò per mancanza di forze. Entrarono da un fornaio poco distante e mentre Alvise trafficava alla cassa, Ines sedeva all’ingresso del negozio e addentava con pigra soddisfazione un pezzetto di croissant. Sempre osservandola, chiamò un taxi. Quando arrivarono davanti al portone della casa di Ines, Alvise vide qualcosa che non si aspettava. Sul citofono il cognome di Ines era affiancato a un altro. Il suo petto ebbe un sussulto, la sua mente cominciò a correre. Ines era sposata e con ogni probabilità c’era di mezzo un bambino, un figlio, ecco perché era rimasta così colpita da quel negozio. Mentre questi pensieri galoppavano nella sua mente, Alvise si sforzava di mantenere un atteggiamento sicuro e cordiale. Inserì la chiave nel portone, lo aprì e sempre sorreggendola la guidò sulle scale. Arrivati sul suo pianerottolo, sentì un fremito sulla pelle, un turbamento in tutto il corpo. Si stava avvicinando al nucleo più intimo della vita di Ines. Tuttavia, allo stesso tempo, quel brivido era pacato dalle nuove scoperte che credeva di aver fatto. Sapere che era sposata, convivente di un uomo, diminuiva quello slancio che aveva provato per lei fin dal primo incontro. Con questi sentimenti di attrazione e sconforto entrò nell’appartamento per primo, sostenendo Ines che stava alle sue spalle. Una strana oscurità adombrava l’ingresso. Gli scatoloni ancora colmi che ricoprivano il pavimento creavano nell’aria l’effetto di una luce soffusa tagliata da infiniti pulviscoli. Si guardò intorno con avidità, combattuto tra la sua brama di osservare e la coscienza di non essere solo. Ma la sua curiosità era troppo grande e il suo sguardo non poteva fare a meno di correre da un dettaglio all’altro dell’appar> 57 :- tamento, in modo da poter cogliere il più possibile di quella vita, di quel matrimonio. Ines chiese di essere portata sul divano del salotto e lì si sdraiò, ancora visivamente sprovvista delle forze necessarie, chiudendo gli occhi. Alvise approfittò della situazione per aggirarsi lungo l’appartamento con la scusa di dover sistemare in cucina le vivande. Attraversò il corridoio e vide, ordinate una a fianco all’altra con grandissima meticolosità, una serie di calzature scarlatte il cui effetto d’insieme era quello di un tappeto dall’aria difforme. Le scarpe erano così tante che non avrebbe potuto dire quante fossero. E lui, che credeva di averle visto indosso le più bizzarre, dovette ricredersi nel constatare che si era limitata a indossare le più sobrie. Borchie, lustrini, plateau, tessuti pregiati e tacchi si sprecavano in quello stretto corridoio che pareva non avere altro ruolo che quello di contenere i sogni di un’adolescente. Tornò in salotto con un piatto di focacce e dolci. Ines si mise seduta, addentò un pasticcino e continuò a mangiare fissando il parquet. «Vuoi che avverta qualcuno, Ines?» le chiese dopo qualche istante che la osservava gustare le creme e i biscotti. «Non ce n’è bisogno. Sto bene, grazie» rispose lei ingoiando una fragola intera. «Forse tuo marito, il tuo compagno vorrebbe saperlo…» disse lui con esitazione. «Non fa nulla…» Si guardò intorno, non sapendo più cosa dire né come agire. «Non ho potuto non notare le scarpe nel corridoio. Una vera perversione?» «Sì, da quando ero piccola. Mia madre detestava il rosso e mi vietava di indossarlo. Quelle scarpe mi fanno sentire diversa da lei e adulta, a differenza di quello che può sembrare» rispose lei con astio, come se lo spirito di ribellione predominasse ancora in lei sulle sicurezze adulte. Alvise smise di guardarla e fece ruotare il suo sguardo per la stanza. Avrebbe voluto sapere dell’uomo che abitava con lei, ma non avrebbe osato chiederle. «Vuoi parlare di quello che è successo?» «No. Ma forse sei tu che vuoi parlarne. O vuoi parlare del motivo per cui mi stavi seguendo?» Alvise si impietrì. «È meglio che io vada ora» disse mentre lei lo fissava negli occhi. «Avresti fatto di tutto per arrivare qui fino a pochi minuti fa. E adesso > 58 :- che ci sei arrivato te ne vuoi andare?» Ines era seduta sul divano. Parlava con freddezza, eppure sembrava che il suo corpo si fosse d’improvviso rinvigorito. I suoi occhi erano accesi e profondi, il suo tono di voce vivido e risoluto. Era una donna adulta che lottava per difendere se stessa ed era pronta a distruggere l’altro pur di salvarsi. «Sei sposata. Questo non me l’aspettavo. Credevo fossimo alla pari» rispose lui mentre si preparava a uscire. Ines corse verso di lui, lo prese per un braccio e gli disse: «Se è per questo, non andartene.» Lo guardò per un brevissimo instante, poi lo baciò. Gli sfilò la tracolla, poi la giacca e dopo ancora la camicia, e in un momento i due furono avvolti l’uno all’altra sul pavimento del corridoio, nel mezzo di una caotica mescolanza di scarpe rosse. «Sto cercando di avere un figlio» disse Ines, rompendo un lungo ma sereno silenzio. Lui si girò verso di lei e la guardò sgomento. «Sono venuta qui per vivere con un uomo. Ma lui non è realmente il mio compagno, sarà solamente il donatore, quando accerteranno che siamo una coppia abbastanza stabile da poter costituire una famiglia.» Alvise si mise seduto e guardò lontano, sul fondo della stanza. «È l’uomo del citofono? Quindi è tutta una farsa?» «Sì, è così. Non posso più aspettare il caso per realizzare il mio desiderio.» «Certo» rispose Alvise, che tuttavia avrebbe voluto fuggire immediatamente da quella discussione, mentre lei sembrava determinata a volerla indagare in ogni sua implicazione. Si alzò e cominciò a raccogliere i suoi vestiti. Ines vide che lui stava sfuggendo e capì che era arrivato il momento di lasciarlo solo, sebbene lo avrebbe volentieri trattenuto a sé. «Vado a fare una doccia.» Alvise rimase solo. Indossò distrattamente i suoi vestiti e andò in salotto. Aprì la finestra e si mise al davanzale a fumare. Guardò la strada stretta, vide il traffico, la gente che camminava, il sole che stava impallidendo, gli alberi mossi dal vento, il cielo fumoso. Guardò la sua città, quel luogo dove aveva passato gran parte dei suoi cinquant’anni di vita, quel panorama così conosciuto e familiare al quale aveva creduto di essere ormai abituato. Ma tutto gli parve nuovo. Erano visioni e strade inconsuete, alberi diversi e respiri di una nuova vita. Si sentiva > 59 :- un nuovo fragore, uno sconosciuto rumore di passi su una strada mai attraversata prima. L’aria odorava di un vento insolito, lo sguardo catturava un mondo per il quale il suo cuore vibrava di diffidenza e gioia. Nel cerchio di sensazioni quotidiane che era la sua vita si era inserito quel piccolo appartamento incasinato e tutto era ricominciato. Terminò la sigaretta aspirando profondamente, finì di vestirsi, andò alla porta, indossò la giacca, prese la tracolla di cuoio, estrasse il libro acquistato nel negozio e se ne andò. Ines uscì nel corridoio avvolta da un asciugamano. Parlò per qualche istante ma si accorse che tutto taceva intorno a lei e nessuno la stava ascoltando. Si affacciò nel salotto per cercare Alvise ma non lo trovò. Allora vide che la sua tracolla era scomparsa dall’ingresso. Si sedette a terra, vicino alla porta d’entrata. Il suo cuore batteva forte, di sofferenza e di rabbia. Prese una scarpa rossa e la indossò. Cercò l’altra attorno a sé, senza alzarsi. All’improvviso sentì freddo e si accorse che la finestra del salotto era aperta. Si alzò per andare a chiuderla e mentre si stava avvicinando zoppicando per via dell’unico tacco che indossava, notò sul divano un libro mai visto prima. Lo prese in mano, lo guardò meglio, stabilì con certezza che non le apparteneva e che non c’era quando si era sdraiata sul divano al ritorno a casa. Poi si accorse che una penna fungeva da segnalibro. Aprì alla pagina segnata e lesse. “Forse abbiamo lo stesso desiderio. Lo realizziamo insieme? Alvise” Si tolse la scarpa e la gettò lontana da sé. Si strinse il libro al ventre e sorrise. > 60 :- Aspettando 09 di Claudia Redaelli > Libro con ded ica -carillon:- Stavo seduta su una sedia nell’enorme sala d’attesa dell’aeroporto già da un po’, era tarda mattinata, sole splendente fuori e climatizzazione che manteneva una temperatura stabile dentro. A volte, quando la vita si comporta in modo bizzarro, io non so come reagire, ho bisogno di stare seduta immobile da qualche parte e lasciare che il mondo corra davanti a me. È un po’ come se dovessi abituarmi a una nuova condizione, il respiro rallenta e io macino la bizzarria trasformandola in una nuova normalità. Parola sopravvalutata: “NORMALE”, che poi ciò che è normale cambia rapidamente come le foglie sugli alberi, dipende dal luogo e dalle persone. Questa mattina è uno di quei momenti di bizzarria immobile. Un ragazzo con un buffo berretto aveva in parte oscurato la luminosità che entrava dalla parete a vetri attraverso cui guardavo gli aerei muoversi silenziosi per attaccarsi o staccarsi dai ponti mobili che li collegano alle sale d’attesa. Si chiamava Piero, doveva attendere un paio d’ore il suo aereo e si stava annoiando. «Sei sola? Ti ho osservata e sei qui ferma nella stessa posizione da un po’. Di cosa ti sei fatta questa mattina? Sembri catatonica!» questo mi disse dopo avermi salutata. «Leila, mi chiamo così. Non sono sola, mio padre è da qualche parte in aeroporto. Perché parli con me?» «Sono qui da un po’, ho contato venti aerei che sono decollati da quella pista laggiù e non ho aggiornato il mio iPod, non ho più nulla di nuovo da ascoltare. Mi annoio! E pensavo fosse lo stesso per te…» Mi raccontò che stava andando a Stoccolma, sperava di trasferirsi lì a studiare per un po’, voleva andarsene da casa, non ne poteva più della sua famiglia e voleva un po’ di spazio, visto che a casa quel poco che aveva veniva assorbito dal fratello minore, con cui era costretto a condividere la camera. Lo raccontava con tale veemenza che al mio sguardo un po’ fisso reagì concludendo con un: «Mi capisci, vero?» > 61 :- Non lo capivo. La mia è una microfamiglia composta da uomini e da me. Ricordo il giorno in cui il mio Abba è arrivato. Era domenica, papà era uscito presto e mi aveva lasciata dormire. Quando mi sono svegliata ho trovato la nostra vicina in casa intenta a sfogliare nervosamente una rivista. Le ho chiesto dove fosse mio padre e lei mi ha detto che era andato all’aeroporto a prendere mio nonno. Un nonno? Ho provato ad avere altre informazioni ma per tutta risposta, scocciata, mi ha rifilato un libro che era appoggiato sul tavolino accanto al divano. Ricordo il rosso della copertina e dentro una dedica grossa a inchiostro. Il libro era scritto in una lingua che non capivo, ma era in linea con quella mattinata, non capivo neppure da dove potesse arrivare un nonno. Un paio d’ore dopo, ancora in pigiama, avrei conosciuto il mio Abba. Si aprì la porta, corsi incontro a mio padre e quando si scansò vidi un uomo sui sessantacinque anni, aveva la pancia tonda come una botte che terminava in alto con il nodo sottile di una cravattina scura, il viso roseo, non sorrideva (avrei imparato che Abba non sorride) ma mi guardava con uno sguardo avvolgente, quasi volesse sorbirmi come si fa con un succo di frutta gelato in una giornata afosa. Non raccontai questo episodio al perfetto estraneo qui di fronte, semplicemente risposi: «Sono figlia unica e mio padre è spesso fuori casa» sperando avrebbe capito che non sentivo il suo stesso bisogno di fuga da una famiglia asfissiante. Venni invece tacciata di estrema fortuna. Io non ero proprio d’accordo, avrei anche gradito qualcuno con cui vivere i miei giorni, ma Abba divenne presto il mio surrogato di persona amabile. Era il padre di mia madre. Di lei non ricordo nulla, semplicemente è uscita di scena quando ero piccola e conosco pochi particolari; non so perché se ne sia andata, sembra che non sopportasse la monotona vita sedentaria della casalinga madre di famiglia, e mio padre non ne ha mai parlato davvero, solo ogni tanto pronuncia brevi frasi contenenti il suo nome. Di solito mi paragona a lei quando sono impulsiva e imputa questo mio tratto, secondo lui deplorevole, al patrimonio genetico da parte materna. Nonno arrivava dalla Turchia, da quella città che è una specie di crogiolo di persone e di storie. Faceva il commerciante, come quasi tutti i turchi. Credo che i turchi siano commercianti da sempre, fa parte della loro cultura, e lui aveva un negozio nel mercato principale della città, il Gran Bazar. Ripercorsi la mia vita degli scorsi anni spinta dalle domande incalzanti > 62 :- di Piero. La mattina Abba si alzava con me, mentre io mi lavavo lui mi preparava la colazione, poi ci sedevamo al tavolo della cucina, io intingendo biscotti nel latte, lui aspettando che il caffè si depositasse sul fondo della tazza. Non si è mai abituato a quello italiano, diceva che masticare due gocce di liquido nero non era bere un caffè. All’inizio non lo diceva, lo indicava. Abba non parlava italiano e le mani prendevano il posto delle parole. Così la colazione divenne presto il momento in cui io gli insegnavo nuovi vocaboli e lui parlava con me. Cominciammo ad alzarci in anticipo entrambi, senza pianificarlo, semplicemente per trascorrere più tempo insieme. La prima parola che ho sentito uscire dalla sua bocca fu il mio nome, il giorno che entrò in casa: voce profonda un po’ roca per gli anni di sigarette, il mio nome con una musica diversa. Con lo stesso accento esotico che avrei amato, mi augurava buongiorno e aspettava che io cominciassi a parlargli. Non so bene come iniziò il nostro “corso di italiano e biscotti”, ma ogni giorno Abba imparava da me una parola nuova, alcune erano molto pratiche e gli servivano per fare la spesa, altre erano più astratte. Per tutti gli anni delle elementari lui partecipava a ogni parola nuova che io scoprivo, tornavo a casa chiamandolo. Spesso sonnecchiava nella sua camera con l’immancabile tazza di tè che riempiva la casa di un profumo dolce di mela, ed eccitata condividevo lettere che accostate creavano nuove parole. «Cos’è quel mappamondo tempestato di brillantini che hai accanto?» chiese Piero. «Un regalo di compleanno a cui sono molto legata. Il primo regalo che mio nonno mi ha fatto, è un carillon» e lo aprii, mentre il sole che entrava dalla vetrata faceva brillare di riflessi la superficie. «Non suona una musica famosa, ma è la colonna sonora di ogni momento importante della mia vita.» Uno degli articoli più venduti a Istanbul sono le palle pendenti. Ce ne sono in ogni parte della città: Abba vendeva palle bellissime nel suo bazar, dipinte a mano con catene lunghissime. Mi ha raccontato che una palla pende da sempre al centro della cupola del palazzo reale di Istanbul, dove il sultano riceveva gli ospiti e le sue concubine, e la palla indica la centralità del potere del sultano rispetto all’universo, ma gli ricorda che è un uomo sospeso al centro dell’universo e delle sue forze. «E come mai te lo porti in giro? A proposito, dove stai andando?» Stavo andando a Istanbul, in Turchia, per la prima volta. Avrei visto la > 63 :- città che mio nonno decantava per la sua architettura, ma soprattutto il luogo di cui avevo sempre ascoltato storie. Le ricordavo raccontate in una lingua indefinita ma che io capivo, che diventavano un gomitolo di lana calda, si confondevano in una coperta che scaldava pomeriggi invernali trasportandomi in un mondo che a un certo punto decisi fosse finto. Insomma, per me a Istanbul viveva Abba, la sua famiglia, mia madre ma anche Cappuccetto Rosso e il Gatto con gli stivali. Credo abbia smesso di essere un luogo magico quando a scuola ho studiato l’Impero Romano d’Oriente e tutte le guerre che la città ha visto e causato, per poi trasformarsi nella città del sultano, delle donne velate ed eleganti, dei baci appassionati tra marajà e principesse e infine una specie di ombelico del mondo come canta Jovanotti. Un luogo tra Occidente e Oriente in cui le persone hanno voglia di incontrarsi, di raccontarsi, a prescindere dal luogo di provenienza. «Sto aspettando l’aereo per Istanbul» dissi a Piero indicando con il mento l’uscita di fronte a noi. Il tabellone indicava un ritardo di quasi due ore. «Quindi stai andando in Turchia a trovare i tuoi parenti?» «Accompagno Abba a casa» risposi. «Mi piacerebbe conoscere tuo nonno, dov’è?» Piero si stava guardando intorno. E mi accorsi di cercare anch’io una persona anziana con la pancia che ci guardasse sonnacchioso. «Abba è morto, stiamo riportando a casa il suo corpo.» È la prima volta che vado in Turchia, non so se incontrerò qualcuno che sappia raccontarmi ancora storie avvincenti. Se così non fosse ascolterò quelle che stanno nella mia testa e le racconterò ad Abba per farmi compagnia. > 64 :- L’enigma del carillon 10 di Marco Mastromattei spedita:>Carillon - Cartolina Le lancette del grande orologio di plastica appeso a una colonna della biblioteca segnavano le diciotto. Pit le fissò distrattamente mentre seduto su una confortevole poltroncina di tessuto verde leggeva un romanzo d’avventura. Il ragazzo frequentava quel luogo sin da quando era adolescente e adesso, passati da un pezzo i trent’anni, continuava a tornarci tutte le volte che poteva. Per lui era diventato quasi un rito: attraversava con calma l’ingresso e scambiava un saluto con le persone che conosceva. Entrava nell’immenso salone centrale dove troneggiava, esattamente nel mezzo, una maestosa scalinata di legno intarsiato. Era tanto magnifica a vedersi quanto difficile da descrivere a chi non l’avesse mai vista. Assomigliava a un gigantesco tronco di quercia, di quelli descritti nelle fiabe. Saliva al piano superiore biforcandosi a metà altezza in due rampe simmetriche che si torcevano a semicerchio e si incrociavano tra loro. Dalla scalinata, se si guardava verso l’alto, si poteva ammirare il luminoso lucernario colorato che occupava la parte centrale dell’alto soffitto. Da questo pendeva un mastodontico lampadario a forma di piramide rovesciata, sorretto da quattro grosse catene di ferro. Il soffitto e i controsoffitti che separavano i due piani erano un trionfo di legni intarsiati a motivi floreali, come la scalinata. Una volta attraversato il salone centrale, se aveva già recuperato il libro che desiderava leggere, Pit si dirigeva verso una delle numerose salette laterali, di solito quella più in fondo. Pensava che leggere nel silenzio di una biblioteca, circondato da altri libri e da persone che condividevano con lui il suo stesso amore per la letteratura, fosse il modo migliore per apprezzare e comprendere ciò che si stava leggendo. Inoltre era un modo per raggiungere – sebbene solo per poche ore – una sorta di stato di grazia, un luogo dove dimenticarsi delle ansie e delle delusioni quotidiane. Aveva aperto da circa un anno un minuscolo studio legale che gli procurava pochi clienti e parecchie seccature. A volte, nel silenzio del suo > 65 :- ufficio, si ritrovava a riflettere su ciò che aveva realizzato fino a quel momento. Una vita di studi intensi fino alla laurea, che non gli aveva lasciato molto spazio per altre attività. E poi il lavoro, duro e opprimente, che aveva finito per prosciugargli quel poco di vita sociale che ancora gli rimaneva. Ricordava quasi con disgusto gli anni di lavoro spesi nei grandi uffici legali della città, dove si entrava la mattina alle nove e si usciva la sera alle dieci. Nessuno ti regala mai niente, si sentiva dire. E questo ci poteva anche stare. Ma il fatto che ti imponessero di lavorare così tanto da scorticarti via la pelle di dosso per un tozzo di pane, con la giustificazione che ti stavano insegnando un mestiere, era una cosa ipocrita. E Pit odiava l’ipocrisia più di ogni altra cosa. Per questo motivo, dopo dieci anni di lavoro a quelle condizioni, decise di chiudere con quella vita. Avrebbe preferito fare qualsiasi altra cosa, ma quello dell’avvocato era l’unico mestiere che conosceva. E così aprì un piccolo studio tutto suo, partendo da zero. Era più che disposto a lavorare duramente, ma d’ora in poi l’avrebbe fatto per se stesso. Il risultato di tutto questo? Una vita passata prima a studiare e poi a lavorare; pochi soldi e una solitudine che, se ci pensava, spesso gli faceva mancare il respiro per la disperazione. Per questo motivo cercava di pensarci il meno possibile e tutte le volte che poteva si rifugiava in quella biblioteca. Guardò di nuovo il grande orologio che segnava mezz’ora dopo le diciotto. Si ricordò di aver udito qualcosa dall’altoparlante della sala che riguardava una tempesta di neve e la chiusura della biblioteca, ma al momento non ci fece caso e non ricordava di cosa esattamente si trattasse, e forse non gli interessava nemmeno. Continuò a leggere. Giunte le diciannove, con riluttanza chiuse il suo libro. Aveva fatto tardi anche questa volta. Si alzò dalla poltroncina e stiracchiandosi diede un’occhiata fuori dalla finestra della piccola saletta. Nevicava copiosamente. Anche quando era arrivato stava nevicando, ma adesso i fiocchi erano grandi quanto piume d’oca e vorticavano impazziti come in un frullatore. Si avvicinò ai vetri e guardò meglio. Le strade erano ricoperte da un abbondante strato di neve e si sentiva soffiare impazzito il vento. “Una bella tempesta di neve… e devo ancora andare a fare la spesa” pensò con disappunto. Mentre si accingeva a recuperare zaino e cappotto per uscire dalla saletta, gli sembrò di udire un suono sommesso. All’inizio non riuscì a definirlo, sembrava più un’eco che proveniva dalla sua mente. Lenta> 66 :- mente il suo udito riuscì a dare una direzione a quel suono e Pit volse interrogativamente lo sguardo verso una scala che conduceva ai sotterranei della biblioteca. Diede di nuovo un’occhiata all’orologio, mancavano pochi minuti alla chiusura. Esitò per un istante, poi si mosse verso la fonte di quel suono e scese le scale. Il piano inferiore era vasto quanto quello superiore ed era occupato da decine e decine di scaffali carichi di vecchi libri che formavano un dedalo di corridoi lunghi e intricati. Pit era sceso raramente lì sotto. Sentì che il rumore proveniva dalla parte più lontana del locale e così, pian piano si incamminò percorrendo una dopo l’altra quelle corsie fatte di libri. Mano a mano che si avvicinava il suo udito riusciva a definire meglio quel suono. Era una musica, una specie di valzer, semplice, composto con poche note da un qualche strumento metallico. Appena svoltato l’ultimo corridoio si ritrovò davanti alla fonte di quella melodia. E non era solo. Davanti a lui, raccolte attorno a un piccolo tavolino posto accanto a una parete, due persone osservavano un oggetto appoggiato sopra. Pit si avvicinò per guardare meglio. Vide una specie di carillon, a forma di sfera, color porpora, grande quanto un melograno. La parte superiore rappresentava una volta celeste, punteggiata da un nugolo di minuscoli vetrini colorati a forma di stella. All’apice della sfera svettava una luna a spicchio. Il tutto ruotava lentamente sopra una base cilindrica da cui si diffondeva la musica che aveva udito. Per quanto strano potesse sembrare, rimase in silenzio insieme alle altre due persone ad ascoltare quella melodia. Il meccanismo stava rallentando così come la rotazione della sfera e il ritmo della musica. Poco dopo le stelle del carillon terminarono di girare e il valzer si spense. Solo allora Pit scambiò un’occhiata con le altre due persone. Erano due ragazze, più o meno della sua età, scese lì sotto probabilmente per il suo stesso motivo: attirate da quel suono. Quella alla sua destra aveva i capelli rossi come il fuoco e indossava dei vestiti decisamente eleganti, più adatti a un party nell’alta società che a una biblioteca. L’altra aveva degli splendenti occhi azzurri e un viso da bambina. Pit accennò un sorriso e disse: «Mi piacerebbe sapere che cosa ci fa un carillon qui sotto…» «…e in che modo si è messo a funzionare» aggiunse la ragazza dai capelli rossi, ricambiando il sorriso. «Lo avrà dimenticato qualcuno» replicò la ragazza dagli occhi chiari. > 67 :- «Qui sotto ci sono molti libri che riguardano i movimenti meccanici e le macchine automatiche dell’Ottocento. Probabilmente qualcuno stava compiendo una ricerca.» «Be’, riportiamolo su e lasciamolo al banco informazioni» tagliò corto la prima ragazza. Presero il carillon e dopo aver ripercorso i vari corridoi del sotterraneo giunsero alle scale da cui erano scesi. Saliti al piano terra, i tre giovani si accorsero, con un po’ di apprensione, che tutte le luci erano spente. Pit diede un’occhiata al suo orologio da polso: segnava le diciannove e un quarto. «Dovrebbe chiudere adesso la biblioteca…» disse con aria interrogativa. Poi come in un flash gli vennero in mente le parole scandite dall’altoparlante della sala circa un’ora prima. Quelle a cui non aveva prestato attenzione. Si avvisava il pubblico che quella sera la biblioteca, a causa della tempesta di neve, avrebbe chiuso un quarto d’ora prima. Il sospetto più che fondato di non aver fatto in tempo a uscire mise Pit a disagio. Nella semioscurità i tre ragazzi aumentarono il passo e tornarono al grande salone centrale, buio e vuoto. Non c’era anima viva. Lo percorsero speditamente sino a raggiungere l’ingresso. Nessuno, nemmeno lì. Arrivarono alla grande porta a vetri dell’entrata. Chiusa. «Fantastico… siamo rimasti chiusi dentro» esclamò la ragazza dai capelli rossi in un misto di apprensione e disappunto. Pit appoggiò le mani alla vetrata e guardò fuori. La tempesta imperversava più forte e violenta di prima. Si poteva udire il sibilo minaccioso del vento. La neve aveva completamente ricoperto la scalinata dell’edificio e si stava ammassando davanti al portone. La strada di fronte formava un’unica striscia bianca con il marciapiede e le macchine parcheggiate portavano sui tetti un notevole strato di neve. I tre si guardarono in faccia quasi dire: e adesso? «Come modo per passare la notte di Halloween lo trovo molto originale!» esclamò la ragazza dai capelli rossi sorridendo. Nessuno di loro aveva intenzione di rimanere lì per la notte. Bisognava comunicare con l’esterno. La prima cosa che fecero fu quella di usare i propri cellulari, ma nulla. Non c’era segnale. Si diressero nell’ufficio della biblioteca per usare il telefono fisso, ma anche questo era muto. La tempesta aveva interrotto le linee, e non solo quelle di comunicazione. Anche l’elettricità era saltata e per quanto la ragazza dai capelli rossi si accanisse sull’interruttore, le luci rimasero spente. > 68 :- «Di bene in meglio» disse stizzita. «Siamo chiusi qui al buio e non possiamo nemmeno chiamare qualcuno.» Anche la temperatura stava cominciando a scendere e i ragazzi cominciavano a sentire freddo. Pit rovistò nei vari armadi dell’ufficio e trovò delle candele innestate in un vecchio candelabro. Le accese, passò il candelabro alla ragazza dagli occhi chiari e disse: «Cominciamo a cercare un posto dove scaldarci.» Ricordava di una saletta provvista di un piccolo camino, così si misero a cercarla. Una volta trovata, recuperarono da uno sgabuzzino anche della legna e l’occorrente per accendere il fuoco. Quando dopo diversi tentativi finalmente riuscirono a incendiare i ciocchi di legna, si sedettero di fronte al camino con aria sconsolata. Cominciavano a scaldarsi e perlomeno non sarebbero morti di freddo. Passarono diversi minuti di silenzio. «Il mio nome è Peter» disse a un certo punto il ragazzo, ricordandosi di non essersi ancora presentato. E altrettanto fecero le ragazze. Trascorsero l’ora successiva a fare le rispettive conoscenze. Alice Leir, la ragazza dai capelli rossi, aveva viaggiato e vissuto molto. Era di famiglia agiata e aveva frequentato le migliori scuole del paese. Ma era anche uno spirito irrequieto e sin da subito aveva preferito allontanarsi da casa piuttosto che lavorare alle dipendenze del ricco padre. «Sono in una fase della vita tra un uomo e un altro, tra un viaggio e un altro» disse scherzosamente. Mary Cloud, la ragazza dagli occhi chiari, era un tipo affabile e semplice. Al contrario di Alice non era affatto agiata, e per tutta la vita non aveva fatto altro che studiare e svolgere lavori umili e poco remunerativi. Tra un discorso e l’altro, i tre ragazzi trascinarono nella saletta alcuni divanetti, per stare più comodi in vista della notte. Li sistemarono a semicerchio intorno alla fiamma allegra e scoppiettante del caminetto e vi si misero sopra a gambe incrociate. Adesso un rassicurante tepore invadeva la stanza. Pit si ritrovò tra le mani il carillon. Tutto questo disagio per colpa di quello stupido oggetto, pensò con un mezzo sorriso. Lo fece ruotare per farlo suonare ancora ma nello stesso istante si accorse che la parte superiore a forma di sfera si poteva sollevare. L’aprì e con sorpresa vi trovò dentro qualcosa. Mary e Alice lo guardarono incuriosite. Era un biglietto. Il ragazzo lo portò alla luce del candelabro e vide che c’era > 69 :- scritto qualcosa a mano, in bella calligrafia. Lo lesse ad alta voce: “Tutto è un enigma e la chiave di un enigma è un altro enigma.” Per me, nulla di trascendentale e non sono un’aquila! Ma se pensi che trovare la risposta in questo oceano di conoscenza sia soltanto un’illusione, non ti abbattere e abbi fiducia in te stesso. Le illusioni sono importanti quanto la realtà. Lothar von Ratsel Dopo averlo letto i tre ragazzi si fissarono per qualche istante. Pit passò il cartoncino prima ad Alice e poi a Mary. «“Tutto è un enigma e la chiave di un enigma è un altro enigma”… dev’essere una specie di aforisma scritto da qualcuno» osservò Mary. «Sì. È una frase virgolettata che questo von Ratsel riporta… ma chi l’ha scritta?» disse Pit. «Un romanziere forse…» disse Alice, piuttosto annoiata. «Sembra che questo von Ratsel ci inviti a cercare l’autore della frase tra i libri della biblioteca» azzardò Mary con perspicacia. «Infatti…» convenne Pit. La questione iniziava a incuriosirli. Tutti e tre cominciarono ad azzardare delle ipotesi su chi potesse aver scritto quella frase: Shakespeare, forse. O forse Dickens… oppure Wilde? Con un pizzico di eccitazione vollero verificare le loro ipotesi. Uscirono dalla stanza con il candelabro in mano e i cappotti addosso e si avviarono verso gli scaffali della biblioteca alla ricerca del libro che poteva contenere quella frase. A ciascuna supposizione seguiva la ricerca del libro e uno sfoglio rapido delle pagine, ma in realtà nessuno dei tre aveva la minima idea di cosa cercare. Verso mezzanotte, vinti dal freddo e dalla difficoltà di quella ricerca, decisero di ritirarsi nella saletta che avevano adibito a dormitorio. Pit rinforzò il fuoco nel piccolo camino. Si ritrovarono sdraiati sui rispettivi divani, l’uno posto accanto all’altro. Nessuno aveva voglia di dormire. Fuori la tempesta di neve non era cessata e si riusciva a sentire l’ululato violento del vento che batteva sugli infissi e le finestre. La temperatura era scesa di molto sotto lo zero e i tre ragazzi spostarono i divani per quanto possibile vicino al caminetto. «Nessuno ha qualcosa da mangiare?» chiese con tono lamentoso Mary, rannicchiata nel suo cappotto. Pit si ricordò del suo zaino e si alzò per prenderlo. > 70 :- «Vediamo un po’…» disse incominciando a frugare con la mano al suo interno. Rovesciò il contenuto sul divano. «Io ho due pacchetti di patatine, una barretta di cioccolato fondente, uno snack alla nocciola e della caramelle.» Di solito, quando si dimenticava di fare la spesa, quella era la sua cena. Anche Mary e Alice presero le rispettive borse. «Io ho due bottigliette d’acqua e una di aranciata» disse Mary mettendo a disposizione quello che aveva. Alice esitò per un istante, ma poi lasciandosi andare disse: «Io ho del rum» e tirò fuori una fiaschetta che rivelava una sua certa propensione a bere. «Bene» aggiunse Alice, «festeggeremo Halloween con rum e cioccolato!» Trascorsero buona parte della notte parlando delle rispettive vite e scaldandosi con il rum e il cioccolato. Di sicuro avevano una cosa in comune: tutti e tre soffrivano di insonnia. Tra una chiacchiera e l’altra, Pit prese in mano il cartoncino con l’enigma e lo rilesse per l’ennesima volta. «Mi dispiace ragazzi» fece Mary. «Conosco a memoria gli scritti di Shakespeare e le poesie di Emily Dickinson ma questa frase proprio non so chi l’abbia scritta.» «Secondo me» osservò Pit, «dobbiamo concentrarci anche su quello che ha scritto von Ratsel: “Per me, nulla di trascendentale e non sono un’aquila! Ma se pensi che trovare la risposta in questo oceano di conoscenza sia soltanto un’illusione, non ti abbattere e abbi fiducia in te stesso. Le illusioni sono importanti quanto la realtà”. Sono scuro che ha usato queste parole per darci degli indizi.» «Ma quali?» domandò Alice, che iniziava ad avvertire la fatica della giornata. «Be’…» rifletté Pit, «ha usato la parola “oceano” e non “mare” per descrivere una moltitudine di libri. Magari l’autore della frase viveva in un paese bagnato dall’oceano.» Le due ragazze cominciarono a seguire interessate il suo ragionamento. «Ci sono molti paesi bagnati dagli oceani» puntualizzò Alice. Poi il ragazzo fu illuminato da un’intuizione: «L’aquila!» esclamò. Mary e Alice dissero quasi contemporaneamente: «È il simbolo degli Stati Uniti d’America!» «Giusto!» esclamò Pit. «Quindi sappiamo che il nostro autore è ame> 71 :- ricano. Cos’altro ci dice quella frase?» «“Nulla di trascendentale”…» lesse Alice prendendo in mano il biglietto. «Il trascendentalismo era una corrente filosofica e letteraria che si affermò in America nell’Ottocento.» «Giusto anche questo!» convenne Pit. «Chi erano gli esponenti?» Ormai un senso di eccitazione aveva colto tutti e tre i giovani, che persero quel poco sonno che avevano. «Be’, vediamo…» cominciò Mary cercando di ricordarsi. «C’erano filosofi, scrittori… C’era Thoreau, che era un poeta e saggista; c’era Emerson, che era un filosofo, oltre che saggista e poeta; e poi c’erano Fuller e Channing, entrambi scrittori. E poi ancora Whitman, che era un poeta, e Hawthorne, e la stessa Emily Dickinson…» «“Abbi fiducia in te stesso”… a quale di questi autori si può maggiormente associare questa frase?» si chiese Pit. «Ralph Waldo Emerson!» esclamarono tutti e tre all’unisono, sollevandosi in piedi sui divani. A questo punto l’eccitazione fu tale che afferrarono il candelabro e corsero per i bui corridoi della biblioteca alla ricerca della sala dei filosofi e scrittori americani dell’Ottocento. «Ralph Waldo Emerson… eccoli» disse Alice indicando una consistente quantità di libri contenente i suoi scritti. «Rimane comunque una moltitudine di pagine da sfogliare: “Natura”, “Società e solitudine”, i “Saggi”, “Condotta di vita”, “Discorso alla facoltà di teologia”, “Lo studioso americano”, “Uomini rappresentativi”, sono tutti libri di Emerson che vedo qui…» disse sconsolata Mary. Pit lesse di nuovo il cartoncino che si era portato dietro: «“Le illusioni sono importanti quanto la realtà”…» «“Condotta di vita” è una raccolta di nove saggi e uno è intitolato “Illusioni”!» esclamò Mary. Alice si precipitò verso il libro indicato, lo prese dallo scaffale e cominciò a sfogliarlo. L’ultimo dei nove saggi che componeva la raccolta si intitolava effettivamente “Illusioni”. Incominciava con una sorta di sonetto, poi l’autore descriveva il suo pensiero. Giunti alla quarta pagina del saggio, tutti e tre all’unisono lessero a voce alta: “La vita è una successione di lezioni che devono essere vissute per essere capite. Tutto è un enigma e la chiave di un enigma è un altro enigma. Ci sono così tanti cuscini fatti di illusioni quanti sono i fiocchi in una tempesta di neve. Ci svegliamo da un sogno per ritrovarci in un altro sogno.” Rimasero in silenzio per qualche istante. Erano riusciti a trovare la > 72 :- chiave di quell’enigma. Sorrisero, mentre i loro spiriti venivano pervasi da un senso di appagamento e contentezza. Pit prese il libro e notò che nell’ultima pagina c’era attaccata una cartolina. Con delicatezza la staccò e la girò. C’era scritto a mano, in bella calligrafia: “A chi mi leggerà. Se hai trovato questa cartolina non per caso vuol dire che hai fatto un buon lavoro. Se per te è stata un’avventura, spero che tu non l’abbia affrontata da solo, perché le avventure, come la vita, si affrontano insieme agli amici, vecchi e nuovi. A volte un’avventura può cominciare e terminare in una biblioteca, altre volte andare avanti. Se ti stai domandando il perché, la risposta è la seguente: sono alla ricerca di giovani di talento che collaborino con la mia casa editrice e l’enigma del carillon è stato un ottimo test di ingresso. Se vuoi che la tua avventura continui, consegnami il mio carillon all’indirizzo segnato sulla cartolina.” Lothar von Ratsel I tre ragazzi lessero l’indirizzo e si guardarono a vicenda, immaginando cosa avrebbero fatto l’indomani. > 73 :- Sincronicità 11 di Chiara D’Amico > Cartolina spedi ta -Portasigarett e :- La giornata era incominciata in modo strano. Una di quelle in cui ci si sveglia con la vaga sensazione che stia per accadere qualcosa. Un rapido sguardo fuori dalla vetrina, giusto in tempo per notare il planare di un foglio, o qualcosa di simile, sul marciapiede. No, era una cartolina. Sergio la raccoglie e la tiene tra le mani ponendosi mille domande. Una cartolina leggermente sbiadita, in bianco e nero. Raffigura un imponente edificio monumentale avvolto da un freddo cielo di nubi dense. Rientra e rimane a osservarla affascinato per un po’. Dopo un lungo gioco a quiz, gira il verso in cerca di una risposta. Ha vinto o perso? Perso. Si tratta del Palais de Chaillot a Parigi. Boh? Più interessante è il timbro, che riporta l’anno 1951. Molti anni di storia fa. Non è roba sua. Si sente in colpa. Prosegue nella sua ricerca con zelo. Il testo in francese frustra la sua curiosità facendola rimbalzare sul destinatario: Guido Barda, casa albergo di via Corridoni 22, Milano – Italia. Le 7:00, suona la radiosveglia. Ogni domenica il signor Sergio Bianchi, salumiere di professione da più di trent’anni, si concede un’ora in più di sonno. Nel suo letto a baldacchino comprato a un’asta di quartiere si gode alcuni minuti di pigro dormiveglia ascoltando le note di Mahler, rigirandosi nel letto prima di decidere di alzarsi. Le ciabatte in pelle, perfettamente allineate, aspettano fedeli i suoi piedi nudi e caldi. La prima tappa è sempre la cucina: rigorosamente anni Settanta, rivestita di piastrelle da motivi grafici a rilievo, con composizioni sinuosamente geometriche nelle tonalità marrone e verde salvia, accuratamente abbinate al mobilio in formica opaca beige. La moka, preparata la sera prima, aspetta sul fornello di una vecchia Gasfire. Dietro la tenda dai grandi fiori vivaci ma sbiaditi debutta una giornata uggiosa. La piccola radio transistor annuncia le notizie e gli eventi del giorno, la grande manifestazione a favore dei diritti delle donne in piazza Duomo. “Oggi ho ben altro da fare. E poi il ’68 è passato da un po’. Dai su, me > 74 :- lo conferma anche la fantastica pubblicità di quel bel dunìn… come si chiama… quella gnocca che si spoglia eroticamente in ascensore… che sta con quel pirla di un fotografo… ah sì, la Belén.” Mentre pensa tra sé e sé in beata solitudine, prepara la tazzina in porcellana cinese con il solito mini cucchiaino, souvenir rubato all’Alitalia quando ancora le posate erano in metallo. “Non ti dimenticare di prendere la pastiglia per il colesterolo come ieri”. E a questo pensiero l’indice e il pollice si appoggiano sui baffi folti e brizzolati accompagnandone il verso. “È ora di accorciarli un po’. Me l’ha fatto notare anche la signora Brambilla ieri in negozio. Certo che col fatto che non ha più il marito sfoga tutte le sue attenzioni su di me. Mi fa piacere, ma ogni tanto è veramente opprimente. Mi ricorda tanto la povera mamma. Dai sopporta, visto che tra culatello di Zibello e gamberetti in salsa rosa ti lascia giù un pezzetto del suo capitale ogni giorno. Tiremm innanz!” Sergio possiede il talento di rendere interessante una coscia di maiale e tutte le altre forme d’insaccati di suino e carni varie, un vero artista nel posizionare le forme tondeggianti dal taglio fresco sui ripiani metallici dietro al bancone. Considerando ogni rotondità come un enorme punto, crea dei veri e propri quadri astratti, usando prevalentemente tutte le tonalità del rosa carne, intercalate da qualche tocco di bianco qua e là. Dicono sia un vero maestro, intraprendente ma discreto, e come ogni vero artista nasconde le sue migliori opere gelosamente nel retrobottega dove solo poche elette, forse le più facoltose, hanno diritto di accesso esclusivamente dietro invito scritto. Quella mattina, su un tavolo lindo dalle gambe esili in acciaio cromato, poggiano degli inviti in cartoncino ruvido bianco. Il primo è indirizzato alla signora Brambilla, appunto. Raggruppandoli tra le mani li fa passare uno a uno per verificare la presenza di tutti i nomi delle sue predilette. Poi si accorge che in un invito, giù in basso a destra, manca la dicitura R.S.V.P. accompagnata dal suo numero di cellulare. Con la sua penna stilografica Pelikan dall’inchiostro blu lo completa. Deve assolutamente ricordarsi di portarli in negozio il giorno dopo. La sua nuova mostra di quadri è pronta e questa volta si sente profondamente soddisfatto dei risultati pittorici. Le sue nature morte non sono mai state così belle e verosimili, soprattutto quella dell’alzatina di frutta con in mezzo un pezzo di mortadella. Per non parlare della rappresentazione più che perfetta della forma rettangolare del fois gras con tutte le sue sfumature dove, sullo sfondo scuro, giace un’abnorme anatra defunta > 75 :- con il collo a penzoloni. Il signor Sergio è un vero autodidatta, ma per crearsi un po’ di celebrità dice a tutti di aver seguito un corso di pittura a olio alla Pinacoteca di Brera. Alle clienti descrive la sua arte come un’autentica passione, facendo sempre riferimento all’impareggiabile Michelangelo, non il Buonarroti, ma il Merisi da Caravaggio. Arriva ad affermare che le sue opere possano essere facilmente scambiate per gli originali da quanto sono perfette. I vernissage hanno luogo, puntualmente, ogni mese nel retro bottega. Pare che riesca anche a venderli i suoi quadri, a detta di alcuni, dozzinali e a volte disgustosamente truculenti, ma lui questo lo ignora. Ricordandosi del particolare del fois gras, la mente lo riporta in un lampo al viaggio fatto con suo padre, salumiere anche lui, nel sudest della Francia, e precisamente in Linguadoca, alla ricerca di un nuovo fornitore. Era il 1950, aveva otto anni all’epoca. Quel viaggio gli aveva lasciato tanti bei ricordi indelebili. Si alza per versarsi ancora un po’ di caffè. Gran viaggio, non tanto per l’aver trovato l’anelato nuovo fornitore di fois gras, ma perché suo padre decise di portarlo a un circo di paese nelle vicinanze, Alès. L’idea gli venne dopo aver adocchiato un manifesto, che oltre annunciare la venuta del circo, sottolineava l’esibizione di un trombettista solista che lo accompagnava, un tale di Maurice André. Suo padre nutriva una viscerale passione per la tromba che da anni cercava di suonare, e non c’era modo di fargli capire che forse era meglio per lui e per tutti quelli che gli stavano intorno continuare a fare solo il salumiere, perché gli riusciva decisamente meglio; all’epoca aveva adibito il retro bottega a sala da musica. Quella serata rimase una pura magia nei ricordi del bimbo. Non tanto per il magnifico tendone colorato gremito di gente e pagliacci, ma per chi gli si sedette al fianco: Micheline, Micheline Barda, primo amore della vita. Bellissima: bionda, formosa, occhi azzurri splendidi e conturbanti. Nulla rimase dello spettacolo, sicuramente ci saranno stati ruggenti leoni, tigri ed elefanti, ma per lui solo il viso di lei e le sue mani aggraziate, che a un certo punto gli offrirono un nuvolone di zucchero filato rosa. Mai, niente e nessuno gli aveva fatto esplodere il cuore come quel giorno. Lo chiamano colpo di fulmine. Il primo e unico. Eppure lei avrà avuto almeno quindici anni più di lui. > 76 :- Durante l’intervallo suo padre si era messo a parlare con i genitori di Micheline e col fratello Guido, che gli sedeva accanto, in un francese dalle cadenze dialettali milanesi. Comprese approssimativamente che erano originari di Alès, che Guido aveva studiato a Parigi e che presto si sarebbe trasferito a Milano per approfondire i suoi studi di fotografia, alloggiando in una casa albergo appena inaugurata in via Corridoni. Quell’incontro rassicurò i genitori di Guido, che videro subito nel salumiere un punto di riferimento per il figlio. Sergio era felice, avrebbe potuto rivedere Micheline, prima o poi. Arrivato a Milano, Guido passava tutte le settimane dalla salumeria per comprarsi il fantastico fois gras galeotto di quel fortuito incontro. Si instaurò un rapporto di amicizia, tanto che la famiglia Bianchi fu invitata varie volte a passare le vacanze ad Alès dalla famiglia Barda, con immensa gioia di Sergio. Che intanto cresceva e maturava, sia nel corpo che nella mente. E gli anni passavano e anche il peso della differenza di età con l’amata. I mesi trascorrevano a blocchi solidi, impilandosi, creando la piramide che conduce alla cima: le vacanze estive. L’apice dell’anno, la carica di energia, e Sergio non ne sprecava neppure un watt, sia di giorno che di notte. Tutta la luce era puntata su di lei e solo a lei. Perfetta sintonia d’intenti. Fino a quando, durante l’ultima estate che si rivelò essere tale solo qualche mese dopo, l’inatteso ebbe il sopravvento. Non ne parlò mai con nessuno, ma il legame con Micheline non era annodato più solo di passeggiate e confidenti chiacchierate. Le loro misteriose e lunghe scomparse, malamente giustificate, iniziarono a destare qualche sospetto. Ma cosa veramente stesse accadendo tra loro non lo seppe mai nessuno. Dopo la repentina morte della madre di Sergio gli incontri si diradarono e si tagliarono i contatti, fino a cessare del tutto. Ad Alès non tornò più. Cambiarono i numeri di telefono così come gli indirizzi. Segnali spietati del fluire del tempo che distratti da mille stimoli si dissolvono, lasciando posto a un’insopportabile e impotente nostalgia. Micheline non l’avrebbe mai dimenticata. E lei, aveva dimenticato? È vero che il ricordo rende tutto più bello, ma forse lo era anche stato. O forse lo sarebbe stato, se solo… e se… e ancora se… Sentiva di volerla rivedere anche dopo tanto tempo. Sentiva più che mai la necessità di avere delle risposte e non più solo domande. I sentimenti non invecchiano, rimangono uguali, ormai l’aveva capito. Arriva un momento nella vita in cui il tempo perde la propria immortalità. E a quel > 77 :- punto ci si chiede se è veramente tutta una questione di momenti giusti o se è soltanto una questione di scelte. Avrebbe potuto scegliere diversamente, essere stato l’unico responsabile di quel distacco gli faceva paura. Forse era il momento di scoprirlo, a costo di sconvolgere il senso di ogni cosa. Quel cerchio doveva essere chiuso. Intanto il caffè è finito, si veste per andare in salumeria a organizzare l’esposizione dei suoi quadri per il giorno dopo. Corinne Prati, tacco dodici zeppa inclusa per raggiungere il suo metro e settanta di francesità, corre per le strade di Milano come se non avesse mai un minuto da perdere. Polpacci ben torniti e agili contenuti in un collant nero coprente che, nell’accurato accavallarsi delle gambe su un tram come a un party, invitano lo sguardo ad andare oltre, più su, dove la gonna stretta fa intravedere forme sinuose ben proporzionate. Anche con freddo e neve lei si ostina a tenere il giaccone aperto, rigorosamente senza sciarpa, così da mettere in risalto il seno sostenuto e florido sotto un pullover scollato a V in puro cashmere. Sul décolleté qualche segno dei suoi quasi cinquant’anni portati con molta disinvoltura. Il viso armonioso agevolato da un naso rifatto alla francese ospita fiero uno sguardo curioso e acceso, disturbato ogni tanto dall’insinuarsi lento di un ciuffo morbido e ramato che si frappone all’occorrenza fra lei e il mondo. Quasi una visiera a comando che le regala sensualmente qualche zona d’ombra per concedersi un po’ di respiro tra una scena e l’altra. Non è opportuno mostrarsi completamente. Opportuno è piuttosto sorridere sempre, come le aveva ben insegnato la madre a suo tempo. Sempre e in qualsiasi occasione. Un imperativo categorico. Tanto che, quando il suo secondo marito le aveva comunicato che stava per avere un figlio con un’altra, lei era riuscita a sorridere camuffando egregiamente l’avvenuta recisione di tutte le sue arterie in un colpo solo. Ma aveva aggiunto anche che non l’avrebbe lasciata e che poteva stare tranquilla. Tranquilla, certo. Come quando durante il suo primo matrimonio, tornando a casa in anticipo dal weekend con sua figlia, aveva scoperto il suo primo marito nel suo letto con un’altra. Anche allora aveva saputo sorridere insabbiando egregiamente le prove di un alto tradimento in corso ma, ancora inesperta, non fu del tutto impeccabile e se n’era andata sbattendo la porta. Certo, aveva commesso qualche errore, ma assolutamente nei ranghi. Inizialmente sembrava che la sua seduzione avesse scelto bene le sue prede: due uomini ricchi, piacenti, impren> 78 :- ditori in vista, di rappresentanza insomma. Due cognomi discussi e chiacchierati della “Milano bene”. Meglio definire “bene”. Il primo era un dichiarato cocainomane che tra un affare e l’altro frequentava gli alcolisti anonimi e donne di varie arti e mestieri, mentre il secondo, pubblicitario di professione ma Marlon Brando nel tempo libero, collezionava Harley-Davidson per favorire il suo ruolo di benefattore nel mondo glamour delle top model. Diceva che le sue campagne pubblicitarie erano vincenti proprio per questo suo spiccato senso del dovere. Lo stesso senso del dovere che aveva messo incinta Corinne – o era lei a essersi fatta mettere incinta – quattordici anni prima, provocando il sospirato matrimonio fra loro. Questa sì che era una conquista, visto che l’unione con il precedente marito non era di fatto stata legittimata. Due figlie uniche, due mariti diversi, un matrimonio. Evidentemente si era cercata fin dalla sua adolescenza una posizione accessoria rispettabile. Esattamente come sua madre prima di lei, quando aveva scelto suo padre. Di lui, d’altronde, aveva potuto apprendere ben poco, assente fisicamente e geograficamente, con l’unico risarcimento possibile, al momento della sua definitiva dipartita, di un ingente lascito monetario. Corre Corinne, come sempre. E come sempre è in ritardo per il suo ennesimo appuntamento con l’immobiliarista di turno. Costantemente in cerca di mono e bilocali da comprare. Questo è diventato il suo vero hobby. Un costoso modo per riempire i vuoti quotidiani, che contribuisce a definirla nei confronti degli altri. Un enorme cerotto per fronteggiare la cinica e alquanto dolorosa indifferenza subita dal marito in anni infiniti. Il traffico è impazzito sotto le luminarie che annunciano l’arrivo del Natale. Ogni anno la stessa storia, come se quelle lucine scintillanti sprigionassero misteriosamente messaggi subliminali per incentivare la corsa agli acquisti. Nella sua borsetta straripante e mai perfettamente chiusa custodisce la lista gastronomica da ordinare in salumeria per la cena e il pranzo natalizi. Meglio organizzarsi prima così da evitare le lunghe code delle clienti fan del signor Sergio. Si sarebbe recata da lui subito dopo il suo appuntamento, visto che si trovava a due passi da lì. E pensare che un anno prima, sempre nello stesso periodo, era a Parigi. Meglio continuare a far finta di non ricordare. Meglio non soffermarsi sui soliti pericolosi “se”. Ecco la sua fermata. Esce con difficoltà dal tram schivando contrariata > 79 :- la solita fiumana di gente che sale dalle porte dell’uscita rendendo la discesa un’impresa teutonica. Minaccia pioggia e deve imporsi controcorrente verso un gruppo di bulli adolescenti che sosta irrequieto proprio nei pressi della fermata. L’ombrello di fabbricazione cinese, con chiusura automatica volubile, si apre involontariamente facendola inciampare maldestramente verso il cartellone pubblicitario riparato dal tetto sporgente della pensilina. Gli occhi le scivolano magneticamente sull’immagine dell’affissione provocandole un’inaspettata contrazione facciale molto simile a “L’urlo” di Munch. Incredula e attonita cerca di far finta di nulla. Il solito sorriso le si stampa sulla bocca, si ricompone e scappa via, senza più voltarsi indietro. Durante la visita all’appartamento Corinne trattiene a stento il turbamento della visione alla fermata. È distratta, svogliata e insofferente di fronte al dimesso agente immobiliare dai capelli induriti dall’eccesso di gel. Lo stesso che pazientemente l’ha dovuta aspettare una bella mezz’ora al freddo. Le sue parole le rimbombano nel canale uditivo causandole un improvviso attacco di labirintite. Si siede su una sedia sudicia e impolverata, unico oggetto superstite di un recente trasloco. «Mi deve scusare, ma non mi sento affatto bene. Penso sia la pressione. Ho bisogno di aria. Se non le dispiace fisserei per un altro giorno. Non riesco a concentrarmi.» Pesca l’agenda tra i mille oggetti ammassati nella sua borsetta per annotare sotto una nuova data l’orario convenuto. Lentamente, sorreggendosi alle pareti, esce dall’edificio, sosta per qualche attimo usando l’ombrello come sostegno. “Forza e coraggio, riprenditi e prosegui verso il salumiere. In fondo cosa vuoi che sia quella foto. Nessun ripensamento. Si tratta solo di un gioco del destino. Mera coincidenza. Non farci caso. Passerà” la mente le consiglia. Riprende lenta il tragitto verso la salumeria. Appena fuori dalla vetrina nota, con immenso piacere, che il negozio è vuoto. «Buongiorno signor Sergio, che brutta giornata, vero?» «Ma buongiorno signora Corinne. Aspettavo proprio lei.» «Come aspettava me?» «Mi è venuta in mente proprio un’oretta fa quando ho trovato una cartolina sul marciapiede all’entrata del negozio. Avrei bisogno che mi traducesse il testo, è scritto in francese. Conoscendo le sue origini l’ho chiamata col pensiero. Sembrerebbe proprio così.» Risata imbarazzata. > 80 :- Apre un cassetto e le porge la cartolina: «Vede, mi sembra un vero e proprio segno del destino e ora le spiego perché. Mi è venuto un colpo nel leggere a chi era indirizzata. Non potevo crederci. Le devo confessare di essermi emozionato. È indirizzata a un amico legato al passato ma ancora molto vicino: Guido Barda.» Appoggiandosi al suo solito ombrello cinese Corinne spalanca gli occhi come per riflesso condizionato. Il salumiere interpreta il suo sbigottimento come chiaro segno di interesse e procede rassicurato: «Se ha cinque minuti da dedicarmi le racconto brevemente la mia storia. So che magari non le interessa, ma ho bisogno di sfogarmi con qualcuno.» Gli occhi di Sergio sono fissi sul volto di Corinne, cercano un qualsiasi segno di approvazione. Inciampando col pensiero su ogni consonante e vocale di quel nome, Corinne risponde: «Faccia pure, l’ascolto.» Nel dimostrare solidarietà al salumiere, Corinne si interroga con ansia sul nome appena menzionato. L’attacco di labirintite appena schivato preannuncia una possibile ricomparsa. Il rapido e incontrollato susseguirsi di parole inondano con impeto ogni centimetro quadrato dello spazio circostante, come se la chiusa della diga per troppo tempo oppressa dalla pressione selvaggia dell’acqua in piena non possa più contenere l’esondazione. Un nanosecondo a sconvolgere l’ordine universale costruito in milioni di anni. Corinne assorta, sguardo fisso sul salumiere che le confida i dettagli della sua ancora vivida love story con Micheline. Ma l’immagine del suo interlocutore incomincia lentamente a sfumare fino a scomparire del tutto. Inizia l’immersione nel flashback. Onda di sensazioni ed emozioni che non trova barriere di scogli. Fotogrammi. Set fotografico sotto la Tour Eiffel: fotografi, assistenti, luci. Sigaretta magicamente fuoriuscita da un portasigarette metallico e vissuto. Merci. Stretta di mano. Gilbert: sguardo magnetico senza via di scampo. Attrazione fulminea, devastante, che si trasforma in un sorriso a un party affollato di gente chiassosa. Quanto i ricordi possono scoppiarci dentro. Persa ma viva. Torna lì a quel party: forse è solo la lontananza da Milano. Prende il suo bicchiere di champagne e si dilegua. Perché la guardava così quel ragazzo, Gilbert. Leggero imbarazzo mentre pensa che sicuramente si stava prendendo gioco di lei. Avrà ventisette anni o giù di lì. La solita > 81 :- storia del fantastico modello che seduce la moglie del capo. Anche se la situazione le sembrava intrigante, la ragione le dimostrava che non era opportuno. Anche se suo marito era un porco e le avrebbe fatto molto piacere vendicarsi di lui, non le sembrava il caso di considerare quella possibilità anche solo per un secondo. Certe situazioni bisogna essere pronti ad afferrarle, lei non lo era. Flirtare le era sempre piaciuto, ma in quel caso sarebbero state più le complicazioni che altro. Il rischio di cadere nel ridicolo. Anche di fronte a un matrimonio di pura convenienza non se la sentiva di affrontare le squallide scenate e le sminuenti battute del marito. Incominciava a non avere più voglia di sfoderare il suo solito sorriso imperturbabile. Era stanca. Ma fantasticare sul fatto che mentre suo marito si faceva le modelle lei si faceva il modello immagine della sua campagna pubblicitaria non le sembrava affatto male. Anzi, la stuzzicava. Tutto nella norma in quel mondo, su quell’enorme giostra di sesso e vanità. Dove ogni corpo finiva per diventare una semplice unità di svago. Forse non si sentiva più così all’altezza e quel ragazzo era troppo bello e giovane per lei. Il suo volto sorride nella salumeria mentre l’anima, ancora al party, non può evitare di rimanere aggrappata al ricordo della travolgente serata. Altri fotogrammi. Uscita dalla toilette delle donne, Gilbert l’aspetta. Piacere e disagio che si sommano. Leggero movimento delle labbra per accennare l’intenzione di scappare nella direzione opposta. Tentativo vano. Neutralizzata da una presa forte e sicura. Paralizzata. La mano di lui anestetizza qualsiasi tipo di facoltà di intendere e di volere. Forse, in fondo, era quello che desiderava. Attirare l’attenzione di qualcuno. In quel momento le bastava. Sentiva di volersi mettere in gioco, anche se sapeva benissimo che nulla sarebbe cambiato. Sapeva perfettamente che per lei era troppo tardi. Si girò simulando un’espressione sorpresa. Standing ovation. Incrociò lo sguardo fisso di Gilbert e fu la fine di ogni residua certezza. Nessuna parola. Niente. Il vuoto. Solo un pulsare caldo di vene e arterie. Si ritrovò di spalle contro il lavabo della toilette a un palmo dai suoi occhi, con le sue lunghe mani sotto la gonna stretta. Corinne non riusciva più a mascherare il respiro ansimante e lasciò che il suo corpo vibrasse libero in quel gioco avvolgente fatto di fluidi disegni tattili. Ecco, era successo, ora non poteva più tirarsi indietro. Baciava bene Gilbert. Baciava spontaneamente bene. Aveva le labbra morbide e una bocca che disarmava ogni sua titubanza. Dirigeva la > 82 :- danza, delicatamente rude. Sembrava la conoscesse da sempre. Sembrava la baciasse da sempre. E lei con lui. Pura alchimia il suo sguardo socchiuso come drogato dentro di lei, sopra di lei, intorno a lei, una sostanza dimenticata nel profondo che incontrollata la rendeva sempre più complice. Un rimbombo metallico provocò uno strappo netto tra i loro corpi riattivando con violenza i loro riflessi assopiti. Sembrava il gong di un tempo scaduto. Corinne si girò verso lo specchio così da essere sicura di riposizionare ogni pezzo perduto qua e là, senza badare a Gilbert, che sicuramente si sarebbe riassettato in modo sbrigativo, com’è concesso agli uomini, per dileguarsi come da copione, senza aggiungere parola e in punta di piedi dietro di lei. Appena soddisfatta della sua immagine restituita dallo specchio, si girò sicura di trovarsi di nuovo sola. Ma lui era ancora li, in silenzio a osservarla. Un colpo nel petto quasi all’inizio dello stomaco. Lo guardò come per dire: “Cosa fai ancora qui?” Lui rispose con un dolce sorriso e le disse senza mezzi termini che avrebbero dovuto rivedersi ancora. Mancava ancora una settimana alla fine della campagna pubblicitaria a Parigi e il tempo non sarebbe mancato. Lei si dimostrò dubbiosa e trovò ogni scusa. Gilbert aveva intuito i termini del matrimonio di Corinne, sapeva del comportamento discutibile di suo marito. Sapeva per certo che dietro quella corazza da donna sorridente e inattaccabile si nascondeva un mondo fragile. Saltò ogni ostacolo per poi ritrovarla sul podio. Si sarebbero rivisti il giorno dopo in un bistrot nelle vicinanze dell’abitazione di Gilbert. «Mi sta ascoltando, signora Corinne? Crede che in qualche modo io la possa rivedere? Signora Corinne…?» Niente. «Rivedermi…? Ah, sì… certo. Ma certamente, Gilbert» risponde di soprassalto. «Scusi? Chi?» chiede confuso il salumiere. «Nulla, volevo dire signor Sergio. Sono un po’ distratta… mi perdoni.» «Ho proprio avuto l’impressione che non fosse molto presente. Non ha battuto ciglio! Mi guardava con uno sguardo vuoto.» «Interessante la sua storia. Mi sembra di conoscerla già. Come si chiama? Micheline, certo. La vuole rivedere, quindi. Bene. Penso di poterla aiutare. Deve sapere che Guido Barda, la persona della sua cartolina, è diventato un fotografo molto famoso e richiesto in Italia, e mio marito, che come lei sa è proprietario di un’agenzia di pubblicità, > 83 :- lavora molto spesso con lui per le sue campagne. Domani mi metterò in contatto con la segretaria e le farò avere il suo numero di telefono, così potrete ricordare i vecchi tempi e gli potrà chiedere direttamente notizie di sua sorella Micheline. Ma cos’ha in mente di fare? È una donna quindici anni più vecchia di lei e inoltre è passato così tanto tempo dal vostro ultimo incontro. Direi quasi una vita. Crede che abbia senso?» «Senso, mi chiede? Crede allora che abbia avuto senso tutto questo tempo di rinuncia? In nome di cosa e per chi? Per ritrovarmi dove sono ora, alla mia età, solo? All’improvviso mi sono reso conto di quello che sapevo già ma che non volevo vedere. Da tempo mi porto dietro questo peso, ma ben allenato a reggerlo sono rimasto fedele a quelle condizioni che mi permettevano di vivere come sempre; giorni cadenzati da ritmi così artificiali quanto assassini. Mi chiedo spesso come potrebbe essere la mia vita se solo avessi scelto diversamente allora. Mi tormenta il ricordo di lei che non ho cercato più, un amore che sarebbe potuto essere ma che non so, emozioni forti, sensazioni dolci. Sono sicuro di esserci stato interamente in quei giorni con Micheline. E oggi? Oggi dove sono? Quando si impone la verità la resa diventa necessaria e bisogna finalmente prendersi cura del proprio dolore, limpido quanto crudele. Non si può più barare e non serve più aggrapparsi a qualcosa, qualsiasi cosa, per continuare a fingere che tutto intorno vada bene così. Che tutto abbia un senso perché in fondo… in fondo è meglio dare un senso alla propria vita anche se dopo, anche se tardi, piuttosto che non darlo affatto.» «Ah… Mi sento confusa!» esclama sorpresa e imbarazzata. Sembra quasi che abbia parlato di lei, che si stia riferendo a lei. Disarmata, rimane in quella sensazione. «E chi è Gilbert? Lo sa che ho un cliente che viene proprio da Parigi che si chiama così? Veramente un bel ragazzo, un modello sa? Ha presente quei cartelloni che si vedono alle pensiline delle fermate dei tram e degli autobus, con quel bel ragazzo a torso nudo, tutto muscoli e mascella… Quello che pubblicizza un profumo francese, credo. Ecco, è lui! Ne è piena la città. Gilbert viene qui per il mio fantastico fois gras, il migliore di Milano, senza modestia.» Terremoto forza dieci della scala Mercalli sotto i tacchi di Corinne la costringono ad appoggiarsi con entrambi le mani al bancone lustro in cristallo illuminato da un’orribile luce al neon. Attimo di cecità e incoscienza: Gilbert è qui. Sorride. Ovviamente per paura di farsi scoprire dal signor Sergio, e riacquista il pieno controllo della sua postura. > 84 :- «Si sente bene, signora Corinne? Eppure non fa caldo qui dentro. Ha capito di chi sto parlando?» «Non si preoccupi, sono solo un po’ sotto pressione. Sa, il periodo prenatalizio è sempre uno stress. Direi che è il caso di ritornare alla mia lista di cose da ordinare ora che ha finito. Allora inizierei con…» ma la curiosità pedante del salumiere non dà tregua. «Ha capito allora di chi sto parlando?» «Sì, penso di aver capito. Conosco appena quel ragazzo, ma lo conosco. Anzi, le dirò di più, è proprio il suo amico Guido Barda ad aver scattato quelle foto per la campagna pubblicitaria, che è stata ideata ed eseguita dall’agenzia di mio marito.» Corinne risponde con orgoglio misto a indifferenza, nell’intento di zittire la lingua sciolta del signor Sergio. Invano. Nell’udire quell’informazione l’effetto provocato è esattamente l’opposto. «Ma non mi dica. Incredibile. Non so proprio cosa dire! Questa è veramente una giornata dai mille risvolti. Quindi conosce il caro Gilbert?» Corinne non riesce più a trattenere lo tsunami della sua euforia controllata troppo a lungo. Il velo è sollevato: usciti dal controllo. Pressione che sale. Si siede sulla sedia in radica beige con gambe cromate che serve proprio ad alleviare i momenti di lunga ed estenuante attesa nel negozio. Sergio corre a prendere un bicchiere d’acqua nel retrobottega lasciandola sola per qualche minuto. Minuti come ore, giorni, un anno. Esattamente un anno prima aveva conosciuto Gilbert. Esattamente un anno prima l’aveva perso. E ora, per la seconda volta, lui poteva essere di nuovo vicino a lei. Poteva tornare a sorridere come una bambina, raccogliersi i capelli in un’esuberante coda di cavallo che lasci la sua fronte nuda di fronte al mondo, tornare a sentirsi sanamente svogliata e serena. Sul set fotografico arrivava sempre per ultima per poter osservare Gilbert da lontano, senza correre il rischio di essere notata. La sua anima ballava incontrastata tra luci, flash e isterie dello staff, mentre la consapevolezza del loro segreto la rendeva unica, forte, sazia. Tutti i perché e i per come cadevano. Lui era riuscito a oltrepassare la barriera delle convenzioni, delle sue paure. E lei si sentiva onestamente libera e presente nella sua vita. Sinceramente voluta. Capiva cosa volesse dire vivere se stessa con qualcun altro e non più solo attraverso. Senza strategie o fatiche di ruolo. Tutto sostituito da baci al croissant au chocolat, abbracci alle crêpes au fromage, amore allo champagne e molto sesso alla crème chantilly. Finalmente si stava divertendo. Scoprì di > 85 :- esserne capace e non poté fare a meno di interrogarsi su come avesse vissuto fino ad allora. Poi arrivò la sera dell’arrivederci in quel meraviglioso bistrot tipicamente parigino, vicino a casa di Gilbert. Erano felici. Lui era convinto: la storia non finiva lì. Ne aveva raccontato la continuazione. Fu allora che Corinne pronunciò quella frase maledetta, quella che uscì automaticamente dalle sue labbra. Come se il fantasma dell’imminente ritorno alla sua vita milanese si fosse, a sua insaputa, impossessato di lei. «Gilbert, non saprei, lasciami tempo per pensare. È tutto fantastico, anche troppo, e non sono abituata a tutto questo. Io con te sono felice ma… lo sai, insomma, sei così giovane, ti stancherai presto. Io ho la mia prigione a Milano ed è difficile uscirne. È stata una magnifica settimana, una boccata d’ossigeno ma…» Ecco riaffiorare l’ombra di tutti i suoi ma e perché. Gilbert non esitò a prenderle le mani e le strinse forte nelle sue, lo stesso fece con il suo sguardo. Non disse più nulla. L’osservò dolcemente come fuori dal tempo. Un rimbombo metallico che proveniva dal pavimento ricordò il gong del tempo scaduto, riportandoli istantaneamente alla densità di quell’attimo. Era l’inseparabile portasigarette di Gilbert ad averli fatti ritornare sulla terra. Lo raccolse e subito dopo, come posseduto da un’incontrollabile ispirazione, chiese un pennarello alla cameriera. Lo fece scivolare morbidamente sulla superficie metallica del portasigarette lasciando impresso il suo numero di telefono come un geroglifico, nella speranza che fungesse da guida a Corinne lungo il suo percorso verso un nuovo destino. Evidentemente era indelebile quel pennarello blu, visto che Corinne, sapendo quanto Gilbert tenesse a quell’oggetto, cercò inutilmente di pulirglielo con un fazzolettino imbevuto di acqua Perrier. «È possibile che tu non abbia ancora capito, chérie? È impossibile cancellarlo. Ormai è scritto, mon amour, e lo lascio nelle tue mani. Fanne quello che vuoi. Aspetterò la tua chiamata. Non ti chiamerò per primo perché voglio lasciarti il tempo per pensare. Io voglio te Corinne, ma ti lascio anche la libertà di scegliere. Se non ti sentirò nei prossimi giorni capirò, e non ti cercherò più. Come tu vorrai. Ora abbracciami!» Punto e a capo. Nel passare i controlli all’aeroporto Charles de Gaulle con destinazione Milano, l’iPhone di Corinne rimase dimenticato in una delle vaschette azzurre portaoggetti dopo il metaldetector e non fu mai più ritrovato. Qualche ora prima, la stessa fine era toccata al portasigarette distrattamente dimenticato sul tavolino del bistrot, dopo che Corinne si rico> 86 :- nobbe, per l’ennesima volta, in ritardo per la sua partenza. Arrivando a Milano maledì la sua distrazione, la sua nascita e anche sua madre. Proseguì dando la colpa al destino, al fato, agli dei e a tutto l’universo che cospirava contro di lei. Non era opportuno chiedere il numero in agenzia, avrebbe destato sospetti. A Guido Barda men che meno, il fotografo era troppo prossimo a suo marito e non le sembrava proprio il caso. Si arrese alla sua invalicabile costrizione e rinunciò con inerzia, com’era solita fare, passandoci sopra. Sorridendo, si fece scivolare tutto addosso e dimenticò. In fondo era meglio così. Forse non era poi tanto un caso disgraziatamente accaduto e si risistemò opportunamente nella sua consueta quotidianità. Gilbert, fedele alle parole pronunciate al bistrot, non la cercò più. Al suo ritorno con il bicchiere d’acqua, il signor Sergio trova Corinne in lacrime desolata e ricurva sulla sedia. Sembra una bambina disperata. Prova un senso di colpa per averle raccontato la sua toccante ma in qualche modo evidentemente stravolgente storia con Micheline. Porgendole il bicchiere cerca, per quanto possibile, di distrarla, facendo scivolare il discorso su un banale evento accaduto proprio qualche giorno prima in negozio. Corinne vergognandosi delle sue lacrime le asciuga rapidamente con il palmo delle mani. Pesca uno specchietto nel solito mare di oggetti della sua borsetta e si ritocca rapidamente il trucco con l’aiuto di un fazzolettino al profumo di eucalipto che contribuisce anche a liberarle il naso. «Ma ritornando a Gilbert, lo sa che l’altro giorno al momento di pagare si è dimenticato questo aggeggio di fianco alla cassa? Appena lo vedo devo ricordarmi di restituirglielo.» Estrae qualcosa di quadrato, ammaccato e rigido dalla tasca del camice inamidato e bianco, per mostrarglielo. Un portasigarette metallico, vissuto e contrassegnato da un numero di telefono scritto con un pennarello blu. Corinne cade precipitosamente in un pianto isterico. Il salumiere è totalmente sbigottito e in preda al panico non sa più cosa pensare. Disorientato, s’interroga in silenzio su cos’abbia potuto dire o fare al punto di renderla così inconsolabile. In fondo le ha mostrato un semplice portasigarette. Sicuramente gli è sfuggito qualcosa. Ma l’intreccio di vite apparentemente non affini è compiuto. Pura sincronicità. Curiosi incidenti di percorso li spingono, a loro insaputa, verso quella che sarà la loro grande ora. Scegliere di non avere un domani, esattamente come prima. > 87 :- Life Crawlers 12 di Giovanni Pirelli anette:> Portasigarette - m Sono sicuro che la chiave sia una di queste. Non c'è dubbio che sia una di quelle più grosse, rotonde, ma cazzo continuano a cadermi di mano e si mischiano sul pavimento del ballatoio che gira come un maledetto figlio di puttana, e ogni volta che mi chino a raccoglierle non sono così certo di riuscire a tirarmi su. Il buco della serratura scappa avanti e indietro, a destra e a sinistra, non riuscirò mai a entrare in casa, merda. Bisogna riprendere il controllo. Trascino i piedi fino alle scale di servizio, mi infilo tre dita in gola, spingendole fino in fondo, fino a sentire con le unghie l'ugola, o qualsiasi cosa ci sia là, in quel punto dove non puoi più andare oltre e ti sale tutto su. Lo schizzo arriva fino al terzo gradino, sorrido, è quasi un record. Mi pulisco le labbra acide con il collo della camicia, regalo di Claudia; il mondo è ancora un posto di merda, ma almeno gira un po' più piano, quanto basta per riportarmi davanti alla porta. Mi metto a gambe larghe davanti alla maniglia, come un pugile sconfitto che ha intenzione di vendere cara la pelle. Galvanizzato da questa immagine, accenno qualche saltello con i pugni alzati, ridendo. Scommetto che resto in piedi anche questo round. Devo riuscire a vincere usando l'intelligenza. Aggrappandomi alla parete mi calo sul pavimento, gambe divaricate e chiavi davanti. Le sciolgo dal gancetto una a una, le metto in fila davanti a me, ordinate. Tempo di esecuzione: venti minuti. I jeans, luridi di vomito e alcol, puzzano in modo ributtante. O molto più probabilmente sono io, razza umana caucasica, ventisei anni, a far schifo. Prendo in mano la prima chiave rotonda della fila. Eroicamente mi butto sulle ginocchia, lo slancio rischia di farmi cadere faccia avanti con i denti conficcati nel finto marmo di pessima qualità del ballatoio. La prima chiave, ovviamente, non è quella giusta. La lancio lontano, per non correre il rischio di usarla di nuovo. Spero non sia volata giù dalle scale. La seconda entra ma non gira. Faccio per provare la terza, mi scivola la mano d'appoggio, finisco dritto sopra le chiavi allineate > 88 :- sul pavimento. Le lacrime mi scorrono giù in un rivolo unto sulle guance. Devo cercare di ricacciare giù in fondo all'anima questa orribile autocommiserazione, un po' di dignità, che cazzo. Devo solo riposarmi un po', far entrare un po' di pace nel mio cervello e riprendere il controllo. La chiave dev’essere una di queste e non esiste che io non la trovi. Voglio una doccia e un letto. Prima magari una canna, ma sul divano. Mi sdraio per terra e riposo un po' gli occhi, solo per un attimo, solo cinque minuti. Quando li riapro è buio pesto e c'è odore di fragole. Il pavimento non è più freddo, è morbido e qualcosa sopra di me è caldo. Faticosamente metto insieme i dati forniti dai sensi. Sono su un letto. Questo è bene, tranne il fatto che non sia mio. Quindi non sono riuscito a entrare in casa, male. Seduto cerco di capire dove sono, senza un reale interesse, pura curiosità. Dalle persiane chiuse filtra un po' della luce arancione della strada. Scoprire che il letto non è proprio quello che sembra, ma un divano, non fa che aumentare la mia ammirazione per il creato: trova sempre un modo per stupirmi, è incredibile. La stanza non è grandissima, ci stanno a malapena il magnifico divano, una tv di ultima generazione e una piccola scrivania con annessa poltrona. Niente libri, zero. Devo rendermi conto del mio stato psicofisico, mi alzo. Il mondo gira ancora ma alla consueta impercettibile velocità, quella per cui noi possiamo solo fidarci degli scienziati che ci dicono che non è il Sole a girare intorno alla Terra ma il contrario, e io mi fido, d'accordo, ma è un po' come la storia che nel vuoto una piuma e un'elefantessa incinta, lasciati cadere dalla medesima altezza, toccano il suolo nello stesso momento. Rimane un bel margine di dubbio. La scrivania è completamente coperta di fogli e quaderni e mozziconi di sigaretta. Ne scelgo uno fumato a metà. Fogli e quaderni sono coperti da una calligrafia al limite del leggibile, assolutamente asessuata. dieci cose per cui vale la pena vivere (ordine casuale): 1. la figa, le tette 2. viceversa 3. tenere in scacco il Kamchatka a Risiko 4. sperare di ereditare una piantagione di tabacco 5. essere fieri dello stronzo appena cacato > 89 :- 6. 7. 8. 9. 10. attendere la morte di Silvio Berlusconi Natalie Portman le canne di Ludovico vedere quanto ci metto ad accorgermi di non saper scrivere ribadisco: Kamchatka. Sopra tutti i quaderni, buttati alla rinfusa sulla scrivania, campeggia un portasigarette orrendo, marca Camel, di quelli prodotti in serie per alimentare il consumo del prodotto, incrementare gli utili, aumentare il bonus dell'amministratore delegato e permettere a lui e alla sua amante trentenne di sfogare la libido sulle spiagge bianche delle Maldive. IL FUMO DANNEGGIA GRAVEMENTE TE E CHI TI STA INTORNO, favorisce gli squilibri sociali, finanzia le guerre in Iraq e Afghanistan e stimola l'ego dei non fumatori. Spengo il mozzicone rubato sulla scatolina di metallo dozzinale, a sfregio. Guardo il mio riflesso sui vetri della finestra dietro la scrivania. «Dovresti fare più sport. Hai il culo flaccido.» I capelli lunghi e biondi le cadono sulla vestaglia bianca, come le donne che si svegliano nei film e sono pettinatissime. La mia ospite non ha più di vent'anni. Oppure li porta molto bene. «Ci sono dei vestiti puliti sulla sedia davanti a te. Facciamo così: ti vesti e vieni in cucina, io ti preparo un caffè e facciamo che te ne vai senza che io debba chiamare la polizia, come la vedi?» Il fatto di essere nudo non mi mette nella posizione di fare lo spiritoso. «Grazie.» «Bevi, starai meglio. E non iniziare a raccontarmi di come tu sia imbarazzato, che cose così non ti succedono mai, che eri ubriaco fradicio perché la moglie ti ha lasciato o che ne so, non raccontarmi cazzate. Stai zitto, bevi il caffè e levati dai coglioni.» «Grazie.» «Non ringraziare. Credevo fossi qualcun altro.» «Ti capita spesso di salvare giovani alcolisti che non riescono a tenersi in piedi e bussano alla tua porta? Chi sei, santa Maria Goretti? Il don Bosco degli ubriaconi?» «Bevi il caffè e togliti dai piedi.» «Visto che sono già qui tanto vale che mi racconti qualcosa, giusto per tenermi sveglio, che se no ti giuro che stramazzo al suolo e ti tocca tenermi qui tutta la notte.» «Fai il bravo, lasciami stare e vattene, prima che torni mio padre.» > 90 :- «Quindi non vivi qui tutta sola.» «No. Per questo ti ho portato dentro. Sono andata ad aprire pensando di trovare mio padre e invece vedo te, in stato pietoso, sdraiato su un mucchio di chiavi davanti alla mia porta. Cosa dovevo fare? Lasciarti lì?» «Certo. Io avrei fatto esattamente così.» «Sei un uomo orrendo.» «Lo so, mamma mi ha fatto così.» «Lascia stare tua madre, che di sicuro non ti ha cresciuto a forza di gin tonic e droghe sintetiche.» «No, infatti, credo che adesso sia sotto la luce di un qualche lampione a succhiare cazzi a tranvieri fuori turno. Quando io sono nato era troppo impegnata a bucarsi per rendersi conto di aver partorito.» «...» «Scherzo. Vedermi in questo stato le farebbe ringraziare il padreterno che io me ne sia andato.» «Bevi il caffè.» «E tuo padre, invece? Lo sa che sono qui? Che hai fatto entrare in casa un completo sconosciuto, ubriaco, potenzialmente violento e sicuramente dalla dubbia moralità?» «Mio padre deve ancora tornare.» «Che mestiere fa, che se ne torna a casa nel cuore della notte, lasciando la figlia in balìa del destino? Il metronotte?» «Senti, ti ho dato dei vestiti puliti, stai bevendo il mio caffè, non mi dare fastidio e vattene fuori dal culo. Non ho mai visto uno che non riesce nemmeno a riconoscere la porta di casa sua. Ma lo sai almeno dove siamo?» «Veramente no. Stavo cercando di entrare a casa mia, mi sono appisolato un attimo e mi sono risvegliato qui. Sono un amante dei misteri, ma questo è inspiegabile. Io abito al settimo piano e questo è senza dubbio il settimo, c'era scritto di fianco all'ascensore; la porta di casa mia è la prima sulla destra, e fin qui tutto torna; il palazzo è per forza questo, visto che le chiavi hanno aperto il portone; e allora come cazzo è possibile che questa non sia casa mia?» «Perché hai sbagliato scala, alcolizzato. Questa è la B e io abito qui da quando sono nata. Non ti ho mai visto prima, ti ho aiutato solo perché mi facevi pena. Prendi i tuoi stracci e vattene a casa tua.» «Per essere la mia salvatrice sei parecchio stronza. Tuo padre non ti ha insegnato l'educazione?» > 91 :- «Ti ho detto di lasciar stare mio padre! Non sai un cazzo di me e della mia vita! Sei solo un fallito.» Mi rimetto i vestiti luridi, ho pensato di tenere gli altri, lavarli e riportarglieli puliti, ma credo che lei non abbia nessuna voglia di rivedermi. Se ne sta in cucina, tiene lo sguardo fisso su un punto lontano, ben oltre questa casa e questa vita, un punto assolutamente irraggiungibile per chiunque altro. Vorrei salutarla, dirle che non ero così, che non è colpa mia e che secondo me lei è bellissima e deve solo sorridere un po' di più, lei che è ancora salva, che può ancora sorridere senza sentirsi spezzare la pelle dallo sforzo, con il cuore che cazzo, batte all'unisono con il mondo e non al rallentatore come il mio che spera solo che arrivi una botta più forte, qualsiasi cosa che gli dia una buona ragione per spaccarsi in due e lasciarmi boccheggiante a terra. Mi avvicino lento alla maniglia della porta, temporeggio, guardo con insistenza verso la cucina, niente, non uscirà. «Merda, mio padre!» «Come, scusa? Cosa sei, sensitiva?» «Non la senti la porta dell'ascensore? Cazzo, cazzo, cazzo.» «Stai calma. Magari è un vicino che stanotte ha deciso di fare festa e torna tardi.» «Non ci sono vicini, è lui. Le chiavi! Ma non le senti! Vieni via dalla porta, ti faccio uscire da quella di servizio. Non stare lì impalato, vieni cazzo, che se ti vede siamo fottuti tutti e due.» «Vengo vengo, ma fai piano che mi fanno male le gambe!» «E parla piano, coglione! Cazzo! Il lucchetto. Dove merda saranno le chiavi? Fanculo!» «E mo'? Non sarà poi così grave, gli spieghi che sono un fallito, che mi hai aiutato e che me ne sto andando.» «Tu non capisci, non sai niente di lui, lui è... è... diverso. È...» Nemmeno me ne sono accorto. Mi ha preso e spinto sotto il tavolo della cucina. Ho fatto in tempo a sentire la porta di casa sbattere, lei che si sedeva su una sedia davanti a me sperando di nascondermi. Il padre non parla, sta fermo davanti alla porta, ogni tanto sposta il peso da una gamba all'altra. Lei invece continua a parlare, lo distrae, gli racconta le proprietà calmanti della camomilla, di come la aiuti a dormire. Lo vedo girare i piedi e andare in salotto. Sembra essersi completamente dimenticata di me, non mi dice niente e lo segue fuori dalla stanza. Non sta zitta un secondo, non riesco a sentire cosa dice > 92 :- ma sembra che non voglia lasciare spazio al padre, che cerchi di annegarlo in un fiume di parole, ma la sua voce è strana, stridula, nervosa. I suoni mi arrivano confusi dal salotto, non riesco a capire cosa si stiano dicendo, sempre che lui abbia detto qualcosa. Che cazzo, ora esco, non posso restare qui in eterno, sono scomodissimo e sento che se non mi alzo tra poco sarò costretto a vomitarmi addosso di nuovo. Mi presento educatamente, gli spiego la situazione e me ne vado da dove sono venuto, recupero le chiavi dal pavimento e cerco di tornare a casa. Faccio per spostare la sedia ma c'è qualcosa che non funziona. C'è troppo silenzio, lei non parla più e non arriva un suono dal salotto. Se mi muovo adesso faccio un casino che mi si sente in tutta la casa, meglio aspettare, fanculo. Per la prima volta, credo, lui parla. Non capisco cosa dice ma non mi piace il suono della sua voce: nasale e strascicata, vuota. Ora ha smesso e c'è di nuovo silenzio. Niente, non un rumore, quasi non si sente il suono della vita giù in strada, è come se fosse tutto lontanissimo e questa una dimensione parallela. Ecco, lo sapevo: sto sognando. In realtà sono addormentato, ubriaco, davanti alla porta del mio appartamento, e sto sognando. Bene, meglio svegliarsi e continuare a letto. Svegliati! Svegliati, cazzo! Apri gli occhi, fottuto ubriacone di merda! Alzati ed entra in casa tua! Questo è un rumore nuovo. Non riesco a capire cosa sia stato. Ancora. Porca puttana maledetta. Non ci credo. Lo sapevo che sarebbe successo, coglione del cazzo, dovevo capire, cristo, cristo. Ribalto tutte le sedie che mi impediscono di uscire. Mi tiro in piedi e mi lancio verso il salotto. Lei è sdraiata per terra, sembra che dorma, ma su un letto di pezzi di legno. Lui è in piedi davanti al divano, i pugni chiusi, nemmeno mi vede. È alto, quasi come me, vestito elegante. Finalmente si accorge di me, mi guarda, fa un passo avanti. Il calcio le arriva tra le scapole. Lui lo fa guardandomi, sorride con quei suoi occhi fradici. Non la sentivo da tanto, almeno quattro anni. Mi sale dall'inguine fino alla testa, è bellissimo. È qualcosa che non mi veniva da parecchio e ora me la sto godendo. Mi sale su da lì, da sopra il cazzo, in un brivido scorre su per la pancia, tende i pettorali, allarga le spalle, la mia bocca si tende in un ghigno orrendo, ah che sensazione! Che meravigliosa sensazione! Sento le narici dilatarsi e la testa svuotarsi, finalmente! Tutto passa in un secondo. Ogni ragione di debolezza non c'è più e io > 93 :- sono un dio. Non sei più nella mia testa, Claudia! Guardami! Sono immortale, Claudia! Ci metto una frazione di secondo, un attimo, a buttarmi su di lui. Lo sento benissimo il suo anello sul mio sopracciglio. E mi piace, è caldo e reale e vivo, è sangue. Il mio primo sinistro va a vuoto, ma la mia era una finta. Scarico il sinistro nell'aria, sfrutto lo slancio e il destro gli arriva feroce sotto lo sterno. Vomita, pezzo di merda, ti voglio vedere boccheggiare. Dall'occhio destro non vedo più un cazzo, il sangue scorre pulsante e non si vede niente. Non mi serve, lui è grosso ma io ho ancora l'occhio sinistro. Aspetto che si rialzi prima di colpirlo di nuovo, stavolta in faccia, sulla tempia, che fa male, ma non lo manda in terra. Gli rido in faccia, quasi urlando, rido come un pazzo e lo guardo, tiro pugni al muro, forti, solo per sentire male alle mani, solo per fargli vedere che sono pronto a tutto, anche a ucciderlo. Rimangono macchie rosse di sangue sulla parete dipinta di arancione dalla luce che filtra tra le imposte. Cerca di reagire, si lancia con un urlo patetico addosso a me ma è lento e ubriaco e vecchio e io sono dio, non puoi prendere un dio, coglione. Mi sposto di lato, lo lascio passare e lo afferro per la camicia, da dietro. Lo tiro a me, di spalle, gli prendo i capelli e lo sbatto in terra. Gli piego la testa all'indietro, vicino alle mie labbra, così magari mi sente, se non è già svenuto. Gli parlo piano, quasi sussurro, scandisco ogni sillaba, voglio sentire il potere delle mie parole che gli entrano nel cervello e liberano terrore puro. Ascolta, ora ti spacco i denti sul pavimento, poi continuo a sbatterti la faccia per terra, mentre ti pisci addosso, sapendo che i respiri si faranno sempre più faticosi, col sangue che ti scende in gola e coagula in grumi abbastanza grossi da toglierti il fiato. E tutta la mia vita mi sembra meravigliosa, sono forte, ho vinto, non sono più un fallito. Claudia, mi vedi? Non sono più un fallito! Guardami, Claudia! Ho in mano la vita di un uomo, amore, e la dedico a te, solo a te amore mio, a te e al nostro bambino, Claudia, a te e al nostro bambino. Guardo la ragazza buttata per terra in mezzo al salotto, sopra la sedia sfondata. «Bevi, starai meglio.» «Grazie.» «È acqua e zucchero, ti farà bene.» «Cosa gli hai fatto?» «Niente, sono venuto di qua e tu eri per terra, lui mi ha attaccato, mi > 94 :- sono solo difeso.» «E adesso?» «Niente, è legato. Ho trovato le manette che avevi nella tasca della vestaglia...» «Pensavo di doverle usare su di te, quando ti ho visto fuori dalla mia porta. Ma poi quando ti ho tirato dentro avevi la faccia così buona.» «Sì. Buona…» «Buona, sì. Non dovevi legarlo, non è cattivo, solo quando beve, poi dorme e tutto va a posto.» «Tutto va a posto.» «Tutto va a posto, sì.» «Come no.» «Ti fanno male?» «Come?» «Dico le mani. Ti fanno male le mani?» «No.» «Vieni. Ti metto del disinfettante.» «Ma perché non te ne vai? Perché rimani qui a prenderti cura di questo stronzo?» «...» «Ma non studi? Non lavori? Cosa fai tutto il giorno? Aspetti che lui torni e ti prendi un'altra manica di mazzate?» «Non mi picchia sempre, te l'ho detto, solo quando beve.» «Ah sì? Solo quando beve? Allora basta, a posto, possiamo stare tranquilli.» «Mia mamma è morta due anni fa. Lui prima non era così. Era buono, è buono. Solo sta male, soffre, e allora beve e quando beve dice di vederla, lì, che lo sgrida, che gli dice di non bere e allora lui s'incazza.» «Metti giù quelle bende, non mi servono, me ne vado. Ma come si apre ’sta porta?» «Gira prima il pomello di sotto.» «Senti, grazie per avermi aiutato, sei una brava ragazza, non so cosa dirti. Queste sono le chiavi delle manette. Non sei costretta a usarle. Prendi le tue cose e vattene. Ci saranno dei soldi in casa, avrai degli amici da cui andare, prendi tutto e vattene. Vattene via.» «Pronto?» «Claudia, sono io.» «Cosa c'è? Ma lo sai che ore sono?» > 95 :- «Sì.» «Sei ubriaco.» «No, non più.» «Cosa vuoi? È tardi, domani devo lavorare.» «Come sta il bambino?» «Non ti importa.» «Claudia, ti amo.» «Vaffanculo.» «Ti amo.» > 96 :- Tra due A il terzo è un Analista 13 di Beatrice Fossati >Manette -Biberon :- “È cosa che chiunque sa bene. Ma nessuno sa bene sottrarsi al cielo che conduce gli uomini in tale inferno.” William Shakespeare (Sonetto 129) Manette È ora di cena, il fumo dalle pentole, la condensa sulle finestre. Fuori è ancora buio e fa freddo, entri in casa e le dita esplodono per lo sbalzo di temperatura. Chiavi, cappotto, scarpe, bagno. L’acqua nel lavandino, l’acqua della pasta. «Ciao.» «Ciao.» «Come stai?» «Come stai?» «Com’è andata la giornata?» «Com’è andata la giornata?» Sedia, sedere, tovagliolo e posate, ci si specchia. Simmetria senza alcuna fedeltà nella riproduzione, solo gesti meccanici e ripetuti, nessuna percezione di quel che accade davanti. Piatti che stridono ed è lontano il pensiero di stoviglie gaudenti, a parte il pane non esiste condivisione, figuriamoci la fantasia. L’animale di fronte sbatte le fauci, è uno strazio per le orecchie, non c’è gusto in quel che mangia, solo cibo per non morire di fame e vino per addormentarsi presto. La notte poi arriva e quando è tempo di dormire si trasforma in quello di cui avevi paura da bambino: il buio e le sue ombre, il silenzio e i suoi rumori, gli incubi e le luci accese per tornare alla realtà. Ma non esiste un giorno tutto giorno? Deve arrivare per forza la tenebra? E poi dicono che la notte sia fatta per i grandi, gli stessi che scoprono quando sono adulti di non essere poi così invulnerabili. > 97 :- Scaccia i mostri oh bel bambino, nella tua testa ripeti le note di “Viva Topolin”, pensa all’orso di pezza e a niente che potrà farti male. Mentre accanto a te sonnecchia il desiderio di farti fuori. Intro Alcune volte avrei voglia di picchiarla. Di dargliele di santa ragione e scaricare su di lei la rabbia di decenni. Poi passa e mi bevo la bile. La guardo muoversi in cucina e mi chiedo cosa mi trattenga ancora qui. Mi danno sui nervi i gesti che conosco ormai a memoria: il rumore delle pentole, le stoviglie, le sue mani che non sanno maneggiare le cose. L'orologio è l'ulteriore strazio che mi ricorda costantemente quanto il tempo rimanga immutabile nonostante il passare dei giorni. Quel che cambia è il mio stato d'animo, sento di non farcela più, sono sul punto di esplodere, potrei non controllare le mie azioni, non conosco fino in fondo quello che c'è dentro di me. Ho paura di compiere gesti che mi potrebbero condannare agli occhi degli altri e rovinarmi la vita, anche se un atto definitivo, al momento, sembra l'unica via d’uscita da questo strazio quotidiano. Potrei diventare protagonista di uno di quegli episodi che si sentono ormai così di frequente nella cronaca domestica: “Trovata uccisa in casa, ecco in esclusiva le immagini di lui che si copre il viso mentre lo arrestano”. I telegiornali raccontano la notizia, l'orrore della gente comune che si crede superiore. Per un attimo nelle menti delle casalinghe, come in uno psicodramma, si palesa l’immagine dell'attimo successivo al delitto. “Forse sarà rimasto in piedi in mezzo alla stanza, oscillante come un birillo prima di cadere.” Un salotto pieno di ronzante silenzio dopo chissà, le urla, il sangue sulle mani, le lacrime, il pentimento, dopo aver realizzato di aver ucciso uno specchio. E poi tanto ci si dimentica subito delle vite degli altri, anche se si sa, ma non si dice, quante volte si è pensato di essere sul punto di compiere la stessa cosa. Che ipocrisia. Intro Me ne sono accorta solo nel momento in cui è nato che sarebbe stato per tutta la vita. Lo volevano tutti: > 98 :- «Allora quando un bel bambino?» «Ma non sei ancora incinta?» «Quanto tempo ancora pensi di far passare prima di farmi diventare nonna?» «Avete provato a fare degli esami, ho trovato un medico che mi ha cambiato la vita con una cura speciale, dovreste provare anche voi.» Trenta, trentuno, trentacinque, gli anni passano. «Al giorno d'oggi si è spostata l'età per fare figli, non è più come una volta, prima anche senza soldi si mettevano al mondo, ora ci sono gli asili, le scuole private e poi vogliono il cellulare, il motorino, crescere un figlio è diventato un investimento.» La verità è che non mi sono mai sentita davvero pronta, alla fine sono ancora una bambina io, devo ancora risolvermi, come posso mettermi nelle condizioni di crescere un'altra creatura. Una nuova persona che da me prenderà oltre che il taglio degli occhi anche un'educazione, i difetti caratteriali. Non posso pensare di essere la madre di un cavernicolo. E a scuola sentirmi dire: «È lei la madre snaturata del bambino disagiato?» Non posso stufarmi di mio figlio, di dire come ho fatto con il tennis, non mi va più, non vado più. Mi faccio un po' schifo ma non riesco a capire se sia più un senso di inadeguatezza sociale oppure se sto dicendo la verità che molti non hanno il coraggio di dire. «Lei cosa pensa?» Mostro Come pensa di essere in grado di fronteggiare questo mostro che è dentro di me? Se mi gira potrei distruggerle lo studio in questo momento. Come ci rimarrebbe se le sbattessi a terra tutti quei soprammobili, se le spaccassi la sedia in mille pezzi e poi chissà, magari dopo potrei prendermela anche con Lei? Una volta sono stato sul punto di picchiare un suo collega, lo sa? Vi ci vorrebbe una scorta, altroché. Come fa a essere così tranquilla con me accanto? Lei lo sa, vero? Lei sa che dentro qui non c'è nulla che può far male, me lo dica. Silenzio. Ogni volta che prendo un coltello dalla cucina per metterlo in tavola o per affettare il pane ho paura di sbagliare direzione e di colpire qualcuno... Ma Lei lo sa, vero, che io non lo farei mai, giusto? Lei ha fiducia in me, Lei conosce tutte le ragioni del mio malessere e mi sta portando > 99 :- lentamente verso una strada morbida, in discesa, le colline della pace. Vorrei essere stato in grado di arrivarci da solo, invece mi sono trovato costretto a chiedere aiuto. Eppure tutti dicono che sono una persona intelligente, Lei mi eviterà di finire pazzo come i migliori pensatori. Mi sento a un bivio ma ho la sensazione che la strada da compiere sia ancora molto lunga. È buio e sento che ho ancora paura a entrare nella cantina del mio animo. C'è gente che urla e piange laggiù, non so se ho voglia di incontrarli. Forse ho paura, non lo so, ma in ogni caso voglio che lo sappia solo Lei. Ho quarant'anni e in questa società non si può, a quest'età… Mi sento paralizzato, per ogni mia mossa aspetto i suoi consigli, come i cani al guinzaglio quando si fermano e guardano il padrone, rivolgo lo sguardo a Lei e attendo una risposta sul da farsi. Non è vero quello che sento? «Sì.» Mostro Mi accade quando lo porto in giro con il passeggino, non appena faccio scendere le ruote davanti dal marciapiede. Passano le auto, una, due, alcune anche veloci. Se mi scivolasse la presa dalle maniglie qualcosa o qualcuno potrebbe trascinarlo via, in un attimo il passeggino finirebbe accidentalmente sotto la macchina, o più semplicemente se mi cadesse mentre lo tengo in braccio? Si farebbe male, specie se la caduta avvenisse di testa. Mio Dio, che orrore. Però potrebbe capitare, e subito dopo il mio sguardo sarebbe lo stesso di quelle madri che dopo aver inflitto una pena al proprio figlio, nell’attimo in cui riflettono su ciò che è accaduto, affondano nel vortice di se stesse. Le ha mai osservate bene? Piano piano i bulbi oculari, la faccia, il naso, vengono risucchiati dall’oblio. L'assenza di una qualsiasi struttura interiore le fa crollare dentro e fuori, rimane solo quello sguardo che è già deserto, già morto. Chissà se mio figlio lo sente che ci sono volte in cui con me non è affatto al sicuro. Ci sono donne che abortiscono, perché portare avanti questa gravidanza pur sapendo che le cose non andranno bene. A volte penso alla vita che avrei avuto se davvero avessi fatto scelte diverse o dato retta a quella morsa nella pancia che mi diceva che stavo prendendo la strada sbagliata. Come si fa a essere sulla via giusta per sacrificarsi e non rendersene conto? Se solo penso a quanto ho criticato mia sorella, le mie amiche, per poi ritrovarmi nelle stesse condi> 100 :- zioni. Non l'ho desiderato, mi è capitato, non è frutto dell'amore ma figlio dell'abitudine, dell'anestesia della mente, dell'illusione di un’esistenza tranquilla affidata all'inerzia. Mio Dio, cos’ho fatto alla mia vita, non trovo la via d’uscita. «Vediamola da un altro punto di vista.» Antonio «Facciamo come l'altra volta, mi descriva la situazione.» «La conosco, so già dove vuole andare a parare.» «Faccia uno sforzo, so bene che non è stupido, ma è per il suo bene che lo stiamo facendo.» «Dottoressa, sono anni che vengo da lei, ogni tanto mi chiedo quando la finiremo.» «Il segreto dell'analisi non è certo la fretta di voler arrivare a destinazione.» «Lo so, ma so già qual è il mio problema, non la sopporto quella donna, non l'avrei dovuta sposare e la soluzione non è di certo un'analista, ma un avvocato. Mi irrita anche venirgliele a raccontare certe cose, mi sembra di dovermele ripetere in testa e sono stufo persino di ripensarle.» «Da dove sente che arriva questa rabbia?» «E me lo chiede? Non l'ha ancora capito da sé? Mi infastidisce ogni cosa ormai, mi dà noia persino parlare di lei qui, mi sembra uno spreco di tempo. Parliamo di me.» «Antonio, smettiamola di prenderci in giro, è evidente che questa faccenda preferisce subirla piuttosto che prendere una decisione, sto solo cercando di aiutarla, di accompagnarla a vedere cosa c’è stato prima e oltre la collina immaginaria che è il suo matrimonio. È un mestiere difficile anche il mio, essere d’aiuto a tutti non è facile ma è quello che mi sono scelta e faccio con passione da quasi trent’anni. Quindi pensi a qualcosa, un episodio qualsiasi che possa essere identificativo di quel che si scatena dentro di lei in presenza di sua moglie. E facciamo presto che il tempo sta per scadere.» Anna «Il problema vero è che sento che questo figlio mi legherà per sempre a lui.» > 101 :- «Ma il figlio è anche tuo. Ci hai mai pensato? L'hai portato tu in grembo.» «Lo so che lui non mi vuole più. Lo vedo da come mi guarda, crede che io non lo veda, mentre con gli occhi di traverso osserva ogni mio movimento. Non capisco perché lo faccia ma ho la netta sensazione che sia così. Guarda le altre, sa? Non posso più portare un'amica a casa, deve vedere come le spoglia con gli occhi. Brutta merda. Gli uomini mi fanno schifo. Lui in particolare. Dov'è finito l'amore? Con tutto quello che gli ho dato in tutti questi anni. E ho anche un figlio maschio.» «Le persone si legano pensando di non avere nulla in comune a parte le passioni, invece come calamite si attraggono e cascano nella rete della relazione, che molto spesso è il cestino dove raccogliamo le nostre insicurezze, i bisogni più antichi. Si pensa che basti l'amore perché le cose funzionino, non si riflette mai sul fatto che siamo noi stessi in prima persona a essere in gioco. La coppia non è il luogo dove l'Io si abbandona come un uomo stanco in poltrona. Nella coppia l'individualità deve continuare a esistere.» «Tante belle parole, ma mi spiega come faccio a uscire da questo casino?» «Non esiste nessun casino, Anna. Devi solo riappropriarti con calma di quello che sei come persona.» «Vorrei solo che la vita che sto facendo non esistesse: il lavoro che non mi valorizza, la spesa, la macchina, il traffico, i biberon, i pannolini che costano e non posso neanche comprarmi un paio di scarpe col tacco come si deve. E accanto a me ogni notte lui, lo so che vorrebbe una vita e una donna diversa. Non ha idea di come vorrei schiacciargli la faccia dentro il cuscino fino a non sentirlo più respirare, sarebbe la fine dei miei problemi. Non mi interessa cosa accadrà poi, tanto non ho voglia di costruire nulla. Solo distruggere.» «Solo la morte?» «Mah, forse solo quella, ma sarò felice dopo?» > 102 :- Un sabato di sera 14 di Matteo Pianosi > Biberon- Binocolo: - Il suo odore. Questo è il primo viaggio che intraprende chi incontra Zuleima. Un viaggio nel sole, nel mare. Un profumo di dolce calore, di una leggerezza blu. E allora ti basterebbe questo. Spegneresti ogni pensiero per cullarti e non svegliarti mai. I suoi occhi. Pensavi di essere già in carrozza e invece era solo l’inizio. Ti sei perso. In una foresta che respira per tutti, circondato da spiagge dove è impossibile non incontrare nessuno. Ti sei perso in Brasile. Zuleima no. È scappata. Da un segreto. E quel biberon che ora tiene in mano le sembra pesante come se fosse rigonfio di sangue e dovesse berlo tutto d’un fiato, come succede ormai ogni singolo giorno da quarant’anni. Lo sguardo domato, i sogni falcidiati, l’amore cancellato. Quel biberon rappresenta tutto quello che non vuole ricordare e che la insegue in un’estenuante, disperata fuga senza partenza. Le capita spesso di non riuscire a non pensare ad altro e sentire il petto comprimersi fino a farle mancare il fiato. Vorrebbe fermare il primo che passa e sputare la verità. Sentirsi sollevare, portata solo dal materno vento. Ma la forza della vergogna la blocca ogni volta e la schiaffeggia platealmente. Vorrebbe solo dire al mondo che ha visto una cosa terribile e che allora era troppo piccola per capirne l’atrocità. Raccontare l’orrore e togliersi dalla mente ogni fotogramma di quel giorno, quando ha visto suo padre uccidere un uomo. Ci sono momenti, oggi, dove la voce le manca all’improvviso. Forse il ricordo delle urla di quel giorno, la disperazione che c’è dietro un segreto o forse l’incantevole incoerenza di un padre assassino che seppellisce quell’uomo nel giardino di casa. L’acre odore di ogni primavera, la viva immagine di un cadavere sfrangiato dalle stagioni. Ormai non ci fa nemmeno più caso. Perché dovrebbe. Sono passati quarant’anni. O forse tutto è successo gradualmente, accompagnando > 103 :- fedelmente lo scorrere del tempo. Oggi è diverso. È un altro giorno. Zuleima si guarda allo specchio e si accorge che il suo occhio destro è leggermente socchiuso. Si avvicina lentamente sporgendo la parte interessata e scruta con distaccato stupore quello che vede. Pensa che sia una cosa passeggera, di stamani. Non è così. Quel suo occhio ha smesso di vivere da quel giorno ormai lontano ma mai come ora così presente. Si veste di corsa, niente trucco. Anche se i diciotto anni li ha passati da un bel pezzo conserva tutta la bellezza della sua terra. Le forme non sono più quelle canoniche viste nei servizi dei telegiornali sul carnevale carioca ma nessun uomo potrebbe dire che non sia una bella donna. Nonostante lei adotti inconsapevolmente ogni strategia per passare inosservata, ogni suo movimento trasuda femminilità. La guardi e ti senti a casa, come se ti stringesse tra le sue dolci appesantite braccia. E le sue mani. Curve, rugose, quasi accartocciate, ma capaci di accarezzarti e farti sentire allo stesso tempo il più indifeso e il più forte degli uomini di questa giostra. Per fortuna oggi non lavora e può tranquillamente andare da Luca, un vigoroso e buffo ragazzo a cui tempo fa faceva da tata e che ora si è laureato, zoppicando, in medicina, e che lavora come oculista in uno studio privato. Un autobus, due passi nel centro e bussa alla porta. Il suo figlioccio, scoordinato come una giraffa ubriaca, l’abbraccia goffamente e le chiede il motivo della visita. Zuleima con beata leggerezza gli parla del problema notato al risveglio e gli chiede se può darle una controllata. Dopo qualche esame arriva il responso. «Zuleima, mi dispiace ma il tuo occhio destro non vede.» «Non fare come al solito, che ti prendi gioco di me. Io ci vedo benissimo, come sempre.» «Credimi, stavolta nessuno scherzo. Ma è possibile che non te ne sia mai accorta? Da quello che vedo sono anni che la tua retina ha smesso di elaborare le immagini.» Il silenzio fotografa una situazione irrespirabile. Il povero Luca tenta di consolarla abbracciandola, ma inutilmente. Le sembra incredibile. Non può ancora sapere, e forse non lo saprà mai, che tutto questo esiste quasi da sempre. Più precisamente da quel giorno. Come è presto per capire, per vedere perché. O forse è meglio non comprendere. Questa mattina ha visto di non vedere. Spesso pensa che nessuno di noi sia in grado di sopportare la bellezza che ci circonda e si nasconde dietro > 104 :- l’impalpabile evidenza. Ognuno a modo suo si aggiusta le cose quanto basta a complicarle. Zuleima ha deciso di non vedere, o meglio di vedere solo a metà. E come ciliegina sulla torta non se n’è mai resa conto. Succede poi che questa comparsata sotto questo cielo di lacrime e speranze non sia così dura, e vivere diventa all’improvviso la cosa più facile del mondo. Perché un sabato pomeriggio di un fantastico metà settembre incontri Vladimir. Un ragazzotto ucraino con l’espressione di un bambino uscito da scuola che non vede i genitori. Ha due mani leggere, come fatte di zucchero. Vladimir è un musicista. È il suonatore ufficiale di fisarmonica della città. Se ne sta quasi tutti i giorni tra via Cavour e il Duomo ad allietare con soave incanto il passaggio di frenetiche anime. Glielo ha presentato quell’azzeccagarbugli di Sara, che sembra scema ma è furba come una faina che ha fatto le scuole superiori a Napoli. Entrambi frequentano il corso di italiano per stranieri che tiene quell’adoratrice di scarpe, il martedì mattina e il sabato pomeriggio. E ieri sera quel ragazzotto sparuto, dopo un eroico e dolce corteggiamento, le ha chiesto di andare a cena da lui. Torna a casa, stavolta a piedi. Le persone le passano di fianco indifferenti, come sono passati tutti questi anni all’oscuro di una morte. La morte di una delle porte con il mondo esterno. Una finestra. Verso la vita, verso il futuro. Vaga per le strade facendo la spola tra gli unici due parchi della città degni di questo nome. Ogni tanto si ferma e siede su una panchina per riposare le gonfie gambotte che tanta strada hanno fatto. Ormai è sera e la sua testa non riesce a pensare ad altro che all’occhio. Stasera doveva andare a mangiare una pizza con Sara, che oltre a insegnarle l’italiano è diventata sua amica, ma non se la sente. Stasera no, e le manda un sms. “Ciao Matta, sono molto stanca, vado a letto presto. Mi dispiace, domani mattina passo in negozio così ci salutiamo. Tvb” Spegne il telefono e via verso casa. Un minestrone di quelli surgelati, un po’ di televisione e poi dritta verso il divano. Indossa una tutona stile Rocky, delle buffe calze antiscivolo e la solita fascia a cingerle la testa. Pochi minuti e crolla in un sonno profondo. Giornata devastante, di scoperte, di passato ma soprattutto di futuro. Buon giorno miss Brasile. È un meraviglioso sabato mattina di metà febbraio e splende il sole. La televisione ancora accesa e la faccia tutta > 105 :- stropicciata. Il tutto la rende ancora più bella. Una solitaria guerriera moderna in tuta. Una bella tazza di latte con i cereali, le prime cose che trova nell’armadio, ed esce quasi senza pensare. Stranamente è come se non ricordasse nulla di ieri. Pochi passi ed è nel cuore dell’oltre torrente. Dove un tempo vivevano gli esclusi dalla nobile città filofrancese. Via D’Azeglio ti è sempre piaciuta, con quelle vecchie fette di case vicine vicine. Studenti, immigrati, anziani che vanno a fare la spesa. E sempre quella romantica frenesia del borgo. Tra uno scherzo di un gruppo di amici e quell’inconfondibile profumo di kebab. Sì, questa via proprio la ami. E poi ci lavora Sara, in quel forno ci sono delle cose buonissime. Ti vengono in mente le mini torte al limone fatte ogni anno per san Valentino, dove con la glassa scrivono frasi dolci dolci come “Je t’aime”. Lei è dietro al bancone. Bella e frenetica come ieri, anzi un po’ di più. Appena ti vede fa il giro e ti salta addosso come una scimmia urlatrice e ti stringe fino a quasi toglierti il fiato. È come se un raggio di sole ti avesse scaldata per mille anni, ma nello stesso istante ricordi cos’è successo il giorno prima. Rimani attonita, l’unico appiglio con la realtà è la farina che ti ha lasciato addosso nella bollente morsa. Un po’ di pettegolezzi, compri due micche e la saluti, anche perché questo sabato il forno è particolarmente affollato e la tua amica, se possibile, è più spiritata del solito. Se non fosse per quel suo cuore immenso, diresti che è figlia del caos. Ti viene in mente quella volta in cui ti ha spiegato perché insegna gratuitamente italiano agli stranieri. Con la luce negli occhi ti disse: «Aiutare gli altri a imparare cose che per me sono scontate mi riempie di energia, di speranza.» Già la speranza. Sei di nuovo su quella via. Barcolli come se avessi fatto quindici round contro Iron Mike. Ti fermi e guardi la gente passare, stringendo tra le tue braccia il sacchetto del pane. Non vedi l’ora che sia sera per sprofondare nel divano guardando la Corrida. Vedere quei pazzi ti fa sentire un po’ più normale. Peccato che stasera tu debba andare a cena da Vladimir. Cinque, quattro, tre, due, uno… ansia. Mille pensieri come un puzzle impazzito. Cosa ti metterai, cosa dirai, cosa farai. D’istinto agguanti il cellulare e mandi un messaggio alla scimmia urlatrice: “S.O.S. stasera sono a cena da vladimir ed è colpa tua! che faccio?” Risposta: “Be’, partirei con una bella ceretta, un paio di scarpe nuove, > 106 :- una maglietta un po’ scollata e tutta la tua strabordante bellezza… buona serata!… dimenticavo, ti chiamo domattina così mi racconti tutto.” Cinque, quattro, tre, due, uno… paura. Magari fosse così facile, l’ultima volta che sei uscita con un uomo c’era ancora il muro di Berlino. Dal canto suo Vladimir, nonostante manchi più di qualche ora, è già nel pieno dei preparativi. Abita in una piccola mansarda vicino al Duomo. Un interior designer, magari uno di quelli visti su Real Time, direbbe che la casa è arredata in perfetto stile minimalista. Macché! Sembra piuttosto che il budget per l’arredamento fosse piuttosto scarso. Stasera però ha deciso di esagerare. Un bel mazzo di girasoli, candele ad ammorbidire l’atmosfera, una tavola apparecchiata con deliziosa cura e un regalo. Effettivamente questo straordinario ragazzo non può definirsi un golden boy, vive solo della sua musica e dei sorrisi dei passanti. Conserva però dentro di sé un’assoluta e unica attenzione per le piccole cose e per la storia degli oggetti. Non è difficile trovare nella sua sobria dimora oggetti vecchi, insegne di metallo, lanterne o scatole di latta. Quando era piccolo un’alluvione ha spazzato via il suo villaggio uccidendo la sua mamma. Quel giorno l’acqua ha rubato tutto quello che aveva. È cresciuto con il nonno e con la sua musica. Nelle lunghe giornate d’inverno gli sembra ancora di sentirla. Quell’inconfondibile caos trasformato in melodia dalla sua sfavillante fisarmonica. Le domeniche passate in cortile tra una giornata che tramontava in un’ora e un’intera epoca che mai albeggiava. I balli, i canti. Le corse a perdifiato tra il frumento. Se solo chiude gli occhi riesce ancora a sentire sui vestiti quell’acre e rassicurante odore di legna bruciata. Quando si accendeva un falò in mezzo all’aia per scaldare le anime. Come suonava bene nonno Vladimir. E pensare che le sue mani sembravano due vecchie vanghe. Le dita danzavano tra i tasti e le braccia accompagnavano con impetuosa eleganza il gesto. Quei baffoni che sapevano di vodka e l’increspato viso solcato da un sorriso. Seduto sulle sue ginocchia, fiero e spavaldo. E il tutto che sembrava non potesse finire mai. È tanto che ci si arrovella. Sino a quel pomeriggio di metà dicembre quando ha visto due innamorati che si guardavano in mezzo alla folla da lontano. Sembrava fossero gli unici abitanti del pianeta. Un fermo > 107 :- immagine nell’indifferente divenire degli istanti. Ora sa cosa regalarle. Ci siamo. Sono quasi le otto e Zuleima corre come una gallina impazzita tra lo specchio del bagno e quello della camera da letto. Guardandola di sfuggita sembrerebbe stia perdendo tempo. Ma se la si osserva con attenzione si scopre che con poche mosse sta facendo quattro cose contemporaneamente. Le donne sono veramente straordinarie. Ogni loro frammento di giornata è un regalo per chi ha la fortuna di riuscire a vederle. Come quando al semaforo, sedute alla guida della propria agghindata auto, le vedi truccarsi guardandosi allo specchietto retrovisore. Si vede proprio che l’ultima volta che è uscita con un uomo erano gli anni Ottanta. Una camicia di jeans, una gonna nera di raso che prova a domare il rassicurante sederotto, delle scarpe da ginnastica e una splendida fascia colorata a cingerle la testa. Molto metropolitana, poco armonica ma bella come non mai. L’ultima passata di lucidalabbra, afferra la borsa ed è di nuovo nel cuore pulsante della città. Da casa sua sono solo pochi minuti a piedi. Se possibile questa rissa di vecchie case al sabato sera è ancora più bella. L’aria fredda rende le immagini nitide e le sue scarpe sembrano mangiare l’asfalto. Una leggera salita che porta al Ponte di Mezzo e sotto di lei uno dei rumori che più le piace. L’acqua che scorre. Si ferma un istante, lo fa spesso. Ma stasera questo fiume sembra vivo, ne sente l’odore, l’energia. E via verso la piazza principale con i mille tavolini occupati per l’aperitivo. Un’ultima occhiata sulla vetrina di un negozio e resta ferma per un bel dieci minuti dinnanzi al campanello fissando un punto non precisato. Quando sta per tornarsene indietro inghiottita dalla paura, si apre all’improvviso il portone. «Ciao Zuleima, ti ho vista dalla finestra. Tutto bene?» «Ciao! Be’ sì, tutto bene. Non ero sicura fosse questa la porta.» «Sei bellissima! Hai fame?» «Grazie! Sì, abbastanza.» Vladimir si avvicina con manifesta timidezza e la stringe in un abbraccio senza fine. Zuleima si abbandona con tutto l’imbarazzo del caso. I due entrano in casa in un’atmosfera senza tempo. Una bolla di sapone sospesa nella luce. Ogni cosa è al suo posto. Le candele accese ovattano i movimenti, accarezzano le idee. Zuleima appoggia la borsetta sul divano e Vladimir le sfila il giaccone. Una musica soffusa ac> 108 :- compagna l’imbarazzo di questo meraviglioso e bizzarro incontro. Lui versa due bicchieri di prosecco e le si avvicina porgendole il mazzo di girasoli. «Questi sono per te, per la tua bellezza.» Esterrefatta si avvicina e allunga il braccio: «Grazie, sei molto carino, ma non dovevi disturbarti!» «Veramente non è finita.» Dicendo queste parole, gonfio di paura e spavalderia mischiate quanto basta, dirige i verdi occhi verso un pacchetto appoggiato sul tavolo. Un brivido corre dietro la spaziosa schiena di Zuleima. Muove dolcemente il collo verso il tavolo e lo vede. Una carta verde lucida e un nastro giallo a voler ricordare la bandiera della sua terra. «Sono senza parole. Che faccio, posso aprirlo?» «Non aspetto altro.» Era da tanto che questa guerriera adottata dalla pianura padana non scartava un regalo. È bellissimo vedere come ci siano alcune cose che riescono a portarti all’origine. Quando ti bastava salire su un tavolo per sentirti un re, o quando infilarsi una collana della mamma ti faceva sentire la più bella delle principesse. Le mani tremanti scartano lentamente quel piccolo romantico scrigno. Vladimir con le braccia conserte si gode tutta la scena e pensa al fantastico mondo che può nascondersi dietro a uno stupido regalo. Rivede stampata nel suo cuore la ricerca di quell’oggetto. Zuleima non può credere a quello che vede a metà. Una chiave di una vecchia porta, una maniglia per una nuova finestra, uno strofinaccio per lucidare un impavido cuore, una coperta per scaldare le solitarie notti. Vladimir le ha regalato un binocolo. Il suo odore. Questo è il primo viaggio che intraprende chi incontra Zuleima. Un viaggio nel sole, nel mare. Un profumo di dolce calore, di una leggerezza blu. E allora ti basterebbe questo. Spegneresti ogni pensiero per cullarti e non svegliarti mai. I suoi occhi. > 109 :- Un bicchiere di inferno 15 di Donatella Milani > Binocolo - sm alto per unghi e:- «Vuole dell’altro vino, signora?» Rachele non se lo fa ripetere due volte e allunga il bicchiere verso Luca, poi riprende a parlare. «A volte mi chiedo se sono stata una buona madre» e scoppia in una fragorosa risata con uno strano retrogusto amaro. Non è raro che durante qualche pranzo o cena in cui si sente più rilassata, o forse semplicemente più malinconica, si lasci andare al cibo e anche al buon vino, perdendo quel suo fare da gran signora aristocratica, creando dapprima ilarità e poi un po’ di imbarazzo nei figli e nel marito, soprattutto se, come quella domenica, ci sono ospiti. Per quel pranzo, infatti, il figlio minore di Rachele si è presentato, oltre che con la giovane moglie in attesa del primo figlio, anche con un amico, Luca. In realtà era stata proprio lei a insistere affinché lo portasse, visto che non perde occasione per cercare di accasare la figlia. «Ma certo che lo sei!» e cercando di non dare troppo nell’occhio suo marito cerca di spostare sia la bottiglia che il discorso su un altro argomento. Ma Rachele con i sensi sempre più offuscati non glielo permette: «Tu dici? Guarda Emma, ti sembra felice?» e si interrompe solo per bere l’ultimo sorso di vino rimasto nel bicchiere. Emma, che fino a quel momento è stata zitta, chiamata in causa non riesce a fare a meno di reagire: «Cara mamma» inizia senza nascondere un tono sarcastico, «certo che sono felice, prima o poi forse riuscirai anche tu a gioire delle mie scelte.» Emma aveva ricevuto l’invito a questo pranzo qualche giorno prima, a seguito di una telefonata della madre. Aveva smontato dal turno di notte e quando era entrata in casa il buio stava già facendo posto alle prime luci dell’alba. In quel momento un getto d’acqua bollente le aveva fatto dimenticare il suo squallido appartamento, la periferia, le schifezze che il suo lavoro la costringeva a vedere. La sua vita. Appena posata la testa sul cuscino era crollata in un sonno profondo. La sve> 110 :- glia nel primo pomeriggio del giorno seguente era stata una voce amplificata dalla segreteria telefonica che aveva invaso la casa: “Ciao Emma, sono la mamma, è mai possibile che tu non ti faccia mai sentire? Comunque domenica vengono a pranzo tuo fratello e tua cognata.” Pausa. “Vieni anche tu? Guarda che tuo fratello porta quel collega tanto gentile.” Pausa. “Insomma vedi di venire, lui viene per te. E poi hai un’età, vuoi darmi la soddisfazione di vederti sistemata prima che io muoia? Vabe’, ti richiamo io, tanto so che tu non lo farai. Ciao.” Per tutta la durata del messaggio Emma non aveva fiatato, il respiro le era tornato solo quando un bip lungo le aveva fatto capire che sua madre aveva finito di pressarla con i soliti discorsi. Nel momento stesso in cui aveva deciso di accettare l’invito, si era fatta strada in lei la consapevolezza che avrebbe avuto il piacere di percorrere quella piccola strada sterrata, unico accesso al cascinale dove vivevano i suoi genitori, fatta di sassi e terra dura che quando si inumidisce emana quell’odore che per Emma sapeva di infanzia, e che avrebbe dovuto affrontare, come sempre, un estenuante braccio di ferro con la madre. Rachele ride. Ha perso la lucidità per distinguere una situazione divertente da una imbarazzante. I capelli sempre perfettamente raccolti le cadono in piccoli ciuffi impalpabili sulla fronte e sul collo. La voglia di puntualizzare prevale e come un rigurgito che sente salire dallo stomaco le parole le escono dalla bocca e si scagliano come sassi sui commensali, anzi, su una in particolare. «Ma Emma, non ti devi risentire se ti faccio un’osservazione, sono tua madre ed è ovvio che io voglia il meglio per te. Hai deciso di fare l’infermiera, hai deciso di andare a vivere lontano da qui, insomma, dammi almeno la soddisfazione di vederti sistemata.» Con un’aria fintamente dubbiosa Emma alza lo sguardo come se pensasse, come se in fondo la madre avesse ragione: «Ma sì, forse ho sbagliato tutto. Però una cosa la potrei fare a modo tuo. Posso farmi mettere incinta, posso farmi lasciare e poi sposare un altro uomo solo perché mi dà un po’ di sicurezza economica, e vaffanculo l’amore! Ah, non devo dimenticarmi che se poi dovessi avere delle frustrazioni da sfogare posso sempre rivalermi su mia figlia o in un bicchiere di vino! > 111 :- Un altro goccio, mamma?» e le versa un altro bel bicchiere di rosso. Rachele ride. Ma di un riso forzato. Con una mano tremante sistema un ciuffo di capelli dietro l’orecchio, ringrazia per il vino e pensa a un caldo pomeriggio di luglio di una vita prima. Aveva subito capito che mettere il panciotto era stato un azzardo, il caldo era soffocante e per fortuna nel negozio, a parte la canzone degli Stones “Angie”, un piccolo ventilatore vicino alla cassa riusciva a dare un po’ di respiro a quella stanza. Erano entrati perché lui voleva portare a suo figlio un regalo. Era stato proprio questo a farla innamorare, la premura che aveva nei riguardi dei suoi figli. Non c’era viaggio in cui non comprasse un regalo, un ricordo da portare a casa, il tutto preannunciato da una telefonata solo per creare un po’ di fermento, di attesa. Già, era proprio un bravo padre, ma la domanda che tormentava Rachele ogni giorno da ormai nove mesi a quella parte era: “Sarà così premuroso anche con questo figlio?”, non voluto eppure capitato, frutto di un amore proibito consumato nei ritagli di tempo tra un viaggio e l’altro, in una casa in affitto di una cittadina lontana dalla sua famiglia e da occhi indiscreti. Lei lo portava in grembo con il dolore incessante per non aver saputo resistere alle lusinghe di un uomo sposato e ancora innamorato di sua moglie dalla quale, però, lo avevano allontanato anni di silenzi e troppe incomprensioni. Trascinandosi pesantemente tra gli scaffali cercava, suo malgrado, di aiutarlo nella scelta del regalo. Tutti gli occhi erano addosso a questa strana coppia, lui era un uomo di una certa età, sicuramente molto più anziano di lei, vestito fuori dal tempo con panciotto e giacca, nonostante il caldo soffocante. Lei aveva dei lunghi capelli che le scivolavano sulle spalle e una sigaretta che le fumava tra le dita. Lui la guardò dolcemente e le prese la mano. Per un momento, un solo breve istante, si sentì sua e lo sentì suo. Fu solo un attimo però, il suo sguardo pieno di gioia nel pensare al suo ritorno a casa con quel binocolo che alla fine decise di comprare, la fece tornare bruscamente sulla terra. Rachele pensò che la canzone che riempiva il silenzio di quel negozio fu semplicemente il preludio di quello che successe da lì a poco. Il pranzo finalmente finisce. Il fratello di Emma con la moglie e l’amico si congedano. Rachele si lascia sprofondare sul divano ed Emma aiuta suo padre a risistemare. «Tesoro, non badare a ciò che dice la mamma, sai come fa quando > 112 :- beve un po’ più del dovuto.» «Non ti preoccupare, ci sono abituata. È che a volte proprio non resisto e devo risponderle… anzi volevo chiederti scusa, non volevo tirare fuori ancora quella vecchia storia.» Quell’uomo dall’espressione infinitamente gentile le posa l’indice sulle labbra: «Non dirlo neppure. Tu sei la mia bambina. Da quando ti ho vista la prima volta reggerti a stento in piedi e muovere i primi passi ho capito che saresti stata mia, qualunque cosa sarebbe successa.» Tornando in salotto, dopo aver sistemato la cucina e lavato i piatti, trovano Rachele che nel frattempo ha avuto modo di sonnecchiare sul divano. Il suo atteggiamento precedente lascia il posto alla sua solita espressione da gran dama. I capelli sono di nuovo perfettamente raccolti sulla nuca e ora è intenta a mettersi lo smalto: «Tesoro, perché non ti dai anche tu una sistemata a quelle unghie?» > 113 :- Camminava per la strada, ha visto il sole e l’ha inseguito 16 di Costanza Di Robilant > tutti gli o g getti “This is the woman you have to share me with”. Come tradurre l'incredulità? Presa dall'eccitazione di aver trovato casa, quel sabato mattina si era svegliata presto. Il quartiere cristiano di Achrafieh era una zona poco accogliente ma riservata e non conservativa. Thomàs era partito per Haiti, una settimana dopo il terremoto, le Nazioni Unite lo avevano trasferito. La sera prima, alla sua festa di saluti, le aveva lasciato casa. Chiavi, un bacio e una regola: “Non più di due uomini per volta”. Era triste di partire. Le aveva detto che sarebbe tornato il quattro di aprile, lo aveva abbracciato e Nikolas lo aveva accompagnato all'aeroporto. Verso le sei ha salutato l’ultimo gruppo di amici e invitato Karim a rimanere. Lui l’ha aiutata a portare i bicchieri in cucina, ma poi ha dovuto accompagnare la sua ragazza e lei si è infilata a letto. La mattina dopo si sveglia presto. Un grande letto di vimini, è ancora vestita, si era tolta solo il reggiseno che comunque porta raramente perché le stringe il costato. Guarda fuori dalla finestra della stanza. “Sono vicinissima a casa sua” pensa, e non aspetta a lungo. Sei sveglio?, gli scrive. Tra due ore. No, adesso. Sono con qualcuno. Lo so. Mi vengo a prendere i libri. Venti minuti di silenzio, alle 9:40 scrive: Ok. Un balzo al cuore, alza gli occhi e si prepara. Ha ancora il trucco sugli occhi, una leggera linea nera di kajal. Fuori c’è il sole che splende. È dimagrita cinque chili in questi due mesi lontana da Beirut. Prima New York, la rottura del suo fidanzamento, poi l’India con sua nonna e ora di nuovo a casa, con un amico che le lascia l’appartamento e molti > 114 :- altri che l’abbracciano. Medita. Trenta minuti di vuoto mentale. La nuova pratica la riporta presente allo spazio e al tempo. Fa un giro per la casa tra gli avanzi della festa, tra un tappeto e l'altro schiva il pavimento freddo e appiccicoso, guarda fuori dalle finestre, è finalmente tornata. Dal sesto piano vede tutta Achrafieh fino al mare, il museo nazionale, l'università e il silenzioso trambusto del sabato mattina. Le sue valigie sono a sud, vicino a Cola, a casa di Giorgia. La casa è bellissima: due stanze doppie e due bagni, una cucina con piastrelle marroncine a fiori e una marmellata di fichi. Ha le sue stranezze e non le sembra vero. Sul tavolino accanto al divano vede un manga giapponese. Una donna seminuda con lo sguardo da guerriera sferza una sciabolata sulla copertina viola e blu. Sorride: Sicuramente lo ha portato Maurice, pensa, non sapeva si fosse fidanzato. Si sdraia sul divano blu per dargli un’occhiata e sfoglia un paio di pagine. Non aveva mai avuto un doppio salone con due divani e quattro poltrone di design a forma di mano. Guarda il camino, c’è molta luce lì sopra la città. Sulla mensola vede un binocolo e libri sulle relazioni civil-militari. Non ci ha mai creduto, ma sono un'evidenza nella striscia blu. Sono trentatré anni che i caschi dell'Onu pattugliano il territorio a sud del Litani, insieme ai palestinesi e agli hezbollah, accanto alla popolazione civile. Entrano in villaggi drusi soldati francesi, spagnoli, indiani e cinesi, a seconda di quali sono i battaglioni in carica. Ci sono donne coperte da veli in puro cotone bianco, vecchissime. Hanno la faccia coperta da morbide rughe, pochi denti e lo sguardo fisso negli occhi degli stranieri. Non vogliono foto. Entrano in villaggi cristiani dove le tette a balconcino e i nasi rifatti illudono di libertà ed emancipazione, poi di nuovo tra gli shiiti, dove le donne sono tutte coperte di nero e perfettamente depilate. Tutto è maschile e non ci si può fermare a prendere un caffè, non ci sono bar, si può solo essere invitati in case private. Vogliono sapere cosa ci fa in piazza una ragazza come Giulia, che si muove tra l’amico macellaio, rientrato dopo venticinque anni in Brasile, e Riad, il presidente dell’influente cooperativa hezbollah. È così che ha scoperto gli angoli delle case sempre piene di bambini, con biberon di vecchia data e finjen1 che sgocciolano accanto al lavandino. Il caffè è nero, ha un fondo polveroso e sa di cumino. Spesso le leggono i fondi e lei ascolta il racconto del suo futuro delineato con attenzione, senza capirne il senso. 1 Tazzina senza manico usata per bere il caffè. Gli uomini lungo le strade di Beirut le sbattono una contro lʼaltra per attrarre clienti, assetati di caffè, stanchi, o che hanno voglia di accompagnare una sigaretta. > 115 :- Non parla arabo ma adora ascoltarlo. I soldati non li invitano. Dovrebbero, almeno per vendergli qualche cianfrusaglia di cui sono pieni, ma non si sa chi ha più paura. Le relazioni civil-militari sono sempre una lama a doppio taglio e niente è mai cambiato. Accanto al camino vicino alla finestra c'è una sfera di vetro grossa poco più di una palla da biliardo, silenziosa. La scuote, ne compaiono rane innevate. Thomàs. Chissà da quale diplomatico ha ricevuto questo oggetto. Con un gesto affettuoso, forse, gli hanno portato in casa una palla pesante che racconta la neve e il freddo a chi sta lungo il Mediterraneo, dove il ghiaccio c’è, tra l’afa, il calore e la tensione. Cammina sulle punte dei piedi, è in casa d'altri, che è diventata casa sua. Mette le scarpe e apre la porta. Sul pianerottolo, mentre aspetta l’ascensore, nota un bastone al posto degli ombrelli, pensa alla pioggia, alla vecchiaia. Quando piove l’acqua scende a catinelle, si sta chiusi in casa aspettando la tregua, per questo niente ombrelli, ma un bastone. Entra in ascensore, mette le chiavi per attivare i pulsanti e mentre si guarda allo specchio scende. Esce, incontra Hicham, il portinaio siriano. «Buongiorno, vengo a stare nella casa di Thomàs per un mesetto.» È contento, farfuglia qualcosa di incomprensibile, le sorride con gentilezza e si allontana. Gira sulla sinistra e chiede al fruttivendolo all'angolo: «Afuan, tarif ween Sassine Square?» «Doghre, fo» le indica con un cenno della testa, «Bes tawiile!» aggiunge. «Ma fi mishkele, ana beheb meshware2» risponde con le poche parole che conosce e segue le sue indicazioni. Nella borsa l'iPod appena ricevuto suona Ludovico Einaudi, Dolce Droga. Inizia la salita, non c’è canzone più bella. Ascolta i rumori della città dalla quale manca da troppo tempo e le note l’accompagnano a voce alta. Arriva a Place Sassine affaticata, con un po’ di fiatone ma ancora in buon equilibrio sulle scarpe alte. Le mancano 137 passi per arrivare alla sua porta. Vive in una bellissima casa coloniale al piano terra, un cancelletto sgarrupato e rumoroso chiude il patio d’entrata. Un semicerchio colonnato con piastrelle dipinte e una doppia porta di legno rossa, i vetri grigliati 2 «Scusi, sa dovʼè Piazza Sassine?» «Dritto, su di là. Ma è lunga.» «Non cʼè problema, mi piace camminare.» > 116 :- che al buio erano soliti anticiparle se lui era sveglio in sua attesa o già nudo nel letto, sono silenziosi. In autunno, una notte tornando a casa, aveva parcheggiato il grande pick-up all’angolo della strada, aveva scritto su vecchi biglietti del parcheggio parole e pensieri di saluto, lui stava per partire. Li aveva infilati tra le griglie a rombi insieme a un paio di calze e a un euro perché potesse prendere il carrello al suo arrivo all’aeroporto di Roma. Suona il campanello girando quel chiavistello di ottone che assomiglia a quelli dietro ai vecchi carillon per ricaricare la melodia. L'ha sempre girata dando due colpi secchi verso sinistra. Drin-Drin! E adesso? Fa un respiro profondo, pensa alla meditazione, si fa coraggio, vuole capire. Si ostina a capire, non vuole accettare che tra un po’ sarà lei il suo bastone, a reggere vent’anni di differenza. Apre la porta. È in maglietta e mutande, non si aspettava di trovarlo in pigiama. «Morning» farfuglia e prova a baciarla. Lei allontana il viso, lo guarda di traverso, ma si toccano. «Taa – Vieni dentro.» «Morning. Sono venuta a prendermi i libri» gli risponde. «Entra a prendere un caffè.» Lo guarda stranito, vuole solo dare un’occhiata veloce e ritornarsene a godere la città senza pensare, ma non capendo dove voglia arrivare entra. Nasconde la paura. Prima di togliersi le scarpe come ha sempre fatto, dà una veloce occhiata in giro. C'è un vestito vintage, gentilmente appoggiato sul puff vicino alla porta finestra che dà sul cortile interno. Manie franco-libanesi, “dev'essere molto più giovane anche lei”, pensa. Sbircia in camera, manette e vibratore sul bordo del letto. Inizia a darsi delle spiegazioni. Fa finta di nulla, richiede i libri che le spettano, vorrebbe prenderli e andarsene. È venuta per un vecchio libro di ricette e una traduzione dei loro libri sacri. Lui era andato a prenderli in montagna apposta per lei, tre giorni prima. Walid non le dà ascolto, è seduto di spalle sul divano, le appoggia la borsa accanto e va a farsi un nescafè in cucina. Conosce benissimo quello spazio. Prende una bottiglia di acqua dalla dispensa, ne rovescia tre quarti nel bollitore, accende; tazza, nescafè, e aspetta che l’acqua sia calda. Torna di là ed eccola, la vede comparire. Con un tanga e una grande felpa beige che si è infilata per coprirsi, per andare incontro a questo fatto appena scoperto: c’è un’altra donna. > 117 :- Maya ha smagliature chiare sulle cosce, ha da poco perso peso. Si porta le gambe al petto sedendosi sul divano marrone, senza dire una parola. Si presentano. «Giulia.» «Maya.» Giulia si siede comoda tra i due, Maya non ha alzato lo sguardo, tanto non la vuole vedere. Sono in un territorio inesplorato, sta a lui dire la seconda parola ma non sa come muoversi. «Questa è la donna con cui mi devi condividere.» Giulia non perdona, lui si dimostra incapace e tutto crolla. Lo guarda, non può credere che questa sia l'unica frase che riesce a dire. “Ma brutta scimmia, ma chi ti credi di essere?” si dice, e nota che ha un atteggiamento da re che gode di diritti divini. “Ma per chi ci hai prese?” si ripete. «Non m’importa, hayet3» le dice Maya in arabo. «Capisce l'arabo» la informa indicando Giulia. «Non mi interessa» risponde. Non la guarda neanche e lo implora con lo sguardo tremante. Giulia vede cosa esce dai suoi occhi: una linea densa di emozioni mentre lui la lascia scivolare nell’abisso di se stesso, incapace. In bilico tra l’orgoglio, l’azzardo, il vuoto e l’incapacità di sostenere le sue stesse stronzate. Giulia non sente altro che una rapida e triste pietà per un povero vecchio uomo, che ama. È ferita: «Ma cosa dici? Ma perché voi libanesi pretendete che nulla vi interessi, che nulla vi tocchi? Voi e la vostra indifferenza, puttanate che non ti interessa!» Si rivolge a Maya: «Ma non ti vedi, cazzo? Non capisco perché siate tanto ostinati.» Maya, distrutta, si tiene strette le ginocchia, senza dire una parola riesce a tenere una voce ferma, lo guarda con aria supplicante. Sconcerto. “Ma come ci puoi fare questo?” pensano. “Ma come ti permettiamo di farci questo?” pensa Giulia. Maya si accende una sigaretta e riappoggia il portasigarette d'argento sul tavolino di vetro. Un rumore gelido, tiene lo sguardo alto, la sigaretta stretta tra le dita tremanti, aspira. Lui zitto, un lunghissimo breve istante. Giulia lo guarda. Sente le gocce di una clessidra scendere, pochi minuti, pesanti e rumorosi dentro un’anima bloccata. 3 Vita mia > 118 :- «Non sono venuta per vedere questo, Walid, ma a prendere i miei libri» gli dice con tono fermo. Lui si alza e va in cucina. Lei si alza e va in bagno. Giulia rimane seduta ancora qualche istante. Scuote la testa per riprendersi, si alza come trainata per l’ombelico da quattro cavalli, appoggia la tazza ancora piena e fumante sul tavolino, tac, e la segue in bagno. Maya è seduta sulla tazza, sta per fare pipì, forse per distendere la tensione. “Ha dormito nel nostro letto” Giulia scaccia il pensiero, teme per un attimo di disturbarla ma non può più andarsene, i cavalli tirano. «Maya, io me ne vado» le dice, «Buona fortuna.» Esce dal bagno, la musica nella borsa sta ancora suonando, si sente accolta. Mette il lungo cappotto scuro, la borsa in spalla, risale sui suoi tacchi e si muove. Non dice una parola, lui la accompagna alla porta e le dà i suoi libri. «Ma da quando vai in giro coi tacchi?» le chiede. Giulia lo guarda, fa un cenno di saluto ed esce dal cancelletto. Ritorna verso Sassine, ha sempre trovato le sue zeppe bianche con la punta nera molto eleganti, si sente più vicina al sole su quelle scarpe alte, e da sotto il cappellino militare alza gli occhi, incontra i raggi e li insegue, dirigendosi verso casa di Giorgia a prendere le sue valigie. > 119 :-
Scarica