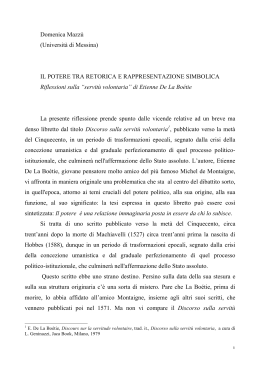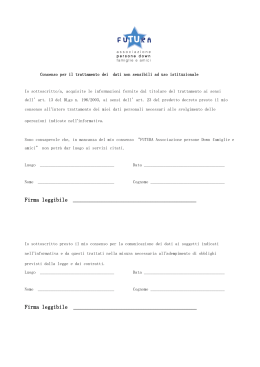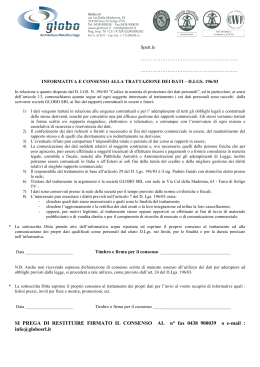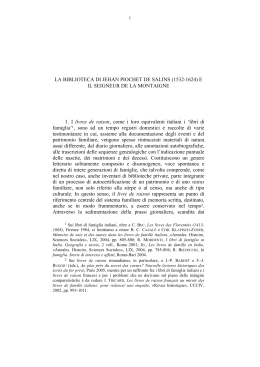Editoriale Stato, collettività, individui, consenso Questo fascicolo è, in larga misura, la riedizione del I numero della “II serie” di Porta di Massa – Laboratorio Autogestito di Filosofia, uscito nel 1995, il quale proponeva una serie di elementi che mostrassero lo sviluppo storico della riflessione filosofica sul rapporto di accettazione, da parte dei sudditi, del potere politico. Ad esso affiancammo – e qui riproponiamo – la traduzione commentata di un testo filosofico classico sul tema: il Discorso sulla Servitù Volontaria di Étienne de La Boétie – il grande amico di Michel de Montaigne, autore di un testo scritto “in onore della libertà contro i tiranni.” La questione dell’acquiescenza al potere politico – anche quando esso compie gli atti più efferati e gravidi di disastrose conseguenze – è di una tale importanza oggi che ci è sembrato di notevole utilità riproporre ed ampliare quelle riflessioni. Sono passati dieci anni da allora, durante i quali la questione del consenso a politiche sempre più pericolose per la stessa sopravvivenza della vita in quanto tale è divenuto sempre più un nodo centrale. Porta di Massa – Laboratorio Autogestito di Filosofia... costituisce un momento comunitario di lavoro collettivo e di confronto tematico – un “laboratorio” – in vista di un rinnovamento extraistituzionale del dibattito e della ricerca filosofica. Il progetto parte da alcune constatazioni. Innanzitutto, uno stato sociale di marginalità culturale delle discipline filosofiche trova oggi riflesso nella cultura che di esse si occupa in modo specialistico, in una forma di autocomprensione della Filosofia, che tende a racchiudere le attività filosofiche nel circolo delle attività solitarie della riflessione, della lettura e della scrittura, e a circoscrivere il loro momento pubblico nei luoghi, istituzionalmente predisposti, dell’insegnamento scolastico/universitario e del convegno tra esperti. Ora, ciò che rischia di andare perduto e/o occultato in queste immagini della Filosofia è proprio una caratteristica che è stata matrice essenziale per la nascita stessa di questa disciplina. Tale caratteristica va individuata nella pretesa della Filosofia di essere una modalità di partecipazione diretta alle forme di comprensione dell’essere e della vita sociale, nonché di revoca di quel consenso che viene concesso, per autorità di rivelazione o di tradizione, per timore della forza o per invidia, ai poteri culturali e politici vigenti. Il progetto di Porta di Massa – Laboratorio Autogestito di Filosofia... è volto perciò alla costruzione di un lavoro di ricerca non elitario ed esoterico, ma che riscopra invece quel ruolo sociale che la Filosofia aveva all’atto della sua nascita e che ne ha caratterizzato i suoi momenti più fecondi. L’obiettivo è quello di mostrare come la Filosofia possegga la capacità di parlare in modo razionale e sensato, di offrire, in altre parole, validi momenti di riflessione ed elaborazione di categorie e comportamenti culturali, sui nodi cruciali dei vari e diversi campi dell’esperienza umana. Al di là di ciò, non esiste una “linea” culturale prefissata della pubblicazione, il che la rende simile ad una sorta di matematico insieme di Cantor: come questo, essa è definita in modo esclusivo dai suoi elementi, in altre parole dai testi che di volta in volta, numero per numero, costituiranno l’ossatura del dibattito e del lavoro collettivo. D’altronde la redazione stessa è costituita da persone provenienti da esperienze culturali e politiche eterogenee, che ritrovano nell’autogestione culturale – in una forma e non in un contenuto – il loro punto di incontro. Scrivere su Porta di Massa – Laboratorio Autogestito di Filosofia... significa, pertanto, riaffermare la volontà di mantenere uno spazio aperto e totalmente autogestito di discussione e di dibattito. Ciò, ovviamen- 1 “(...) à l’honneur de la liberté contre les tyrans.” MONTAIGNE, Michel de, Essais, Paris, Garnier, 1962, pp. 198. 2 te, non implica affatto la corresponsabilità reciproca degli indirizzi d’indagine. Il ruolo e la responsabilità del dibattito redazionale e, in ultima istanza, quello del direttore sono limitati perciò, nella piena libertà di indirizzi culturali dei singoli, alla garanzia nei confronti del lettore della correttezza scientifica dei materiali presentati alla sua attenzione. D’altro canto, la vita umana associata, nell’esperienza di ciascuno di noi, è colma d’inutili sofferenze ed irrazionalità, che rimandano ad una riflessione sui meccanismi del loro superamento. La rivista che avete tra le mani, nei suoi limiti, è pertanto anche un esperimento utopico: è il tentativo di mostrare la possibilità di fare Filosofia e, in generale, Scienza in un luogo che non è quello degli spazi istituzionali, attraverso un’esperienza redazionale comunitaria e libertaria che si pone come alternativa alle gerarchie culturali e politiche della Filosofia ridotta a sapere morto ed istituzionalizzato, a mero “genere letterario”. La particolarità della rivista – ciò che la rende un “laboratorio” – consiste in un particolare metodo di lavoro redazionale. La redazione è composta, numero per numero, da chi propone un articolo su una determinata parola-chiave: si può trattare di chi partecipa in maniera fissa alla redazione, così come di chi dà il suo contributo solo per quello specifico numero. In entrambi i casi, chi presenta un articolo s’impegna contestualmente a partecipare al lavoro redazionale, che si svolge secondo un’ottica comunitaria. In altri termini, non è possibile consegnare il proprio contributo e basta: chi presenta un articolo s’impegna a leggere quelli di tutti gli altri partecipanti al numero ed a fornire loro spunti critici, nei limiti ovviamente delle conoscenze e/o possibilità di ognuno. Il lavoro redazionale, inoltre, è sottoposto ad una norma generale: in linea di principio, non va criticata l’idea di base, l’opzione culturale di fondo del singolo, ma esclusivamente la sua espressione scientifica. Questo significa che chi si ritrova a leggere un contributo di cui non condivide l’impostazione di base, deve fare lo sforzo concettuale di entrare all’interno di quelle idee – che possono essere estremamente distanti dalle sue – e pensare come queste stesse idee potrebbero essere espresse con maggiore incisività e coerenza logica. Tale meccanismo fa sì che il collettivo redazionale si sostenga vicendevolmente in un’ottica libertaria, senza cioè censurare in alcun modo le peculiarità concettuali dei singoli, ma, al contrario, arricchire le sue potenzialità espressive. Questo, ovviamente, cum grano salis: il ruolo del Comitato di Redazione e, in ultima istanza, del Direttore Responsabile, consiste anche nell’individuare quelle opzioni culturali che appaiono loro irrimediabilmente contraddittorie e garantire, quindi, il lettore della correttezza scientifica dei materiali che, alla fine, vengono presentati alla sua attenzione. Si tratta, evidentemente, di un meccanismo redazionale coerente con il tentativo di porsi al di fuori dei luoghi e delle gerarchie del sapere istituzionalizzato. La parola-chiave serve da spunto per aprire un ricco dibattito collettivo, che si sviluppa in numerose riunioni redazionali, le quali non hanno lo scopo di giungere a definire una “linea” alla quale i redattori devono sottostare, bensì alla presentazione di un ventaglio di proposte di ricerca diversificate, volte ad offrire al lettore i problemi, i risultati, le ambiguità connesse al tentativo di dare conto, secondo ragione, almeno parzialmente, degli svariati mondi che una determinata parola ha il dono di offrire alla riflessione degli esseri umani. Parallelamente a questo tipo di lavoro redazionale, il collettivo lavora anche intorno all’edizione di un “classico” della storia del pensiero filosofico, congruente con la parola chiave prescelta, che viene allegato alla rivista. Il collettivo redazionale lavora poi anche sul territorio, nel tentativo di riportare il pensiero concettuale nell’agorà, offrendo soprattutto al di fuori dei luoghi deputati istituzionalmente alla ricerca filosofica, numerosi spazi di conoscenza, di confronto e di dibattito. Quest’ultimo genere d’attività è riuscito a coinvolgere centinaia di persone, mentre la stessa, più impegnativa, attività redazionale di “laboratorio” è riuscita comunque ad attrarre in questi anni l’attenzione di decine di persone. Negli ultimi tempi, inoltre, si sta cercando di esportare il progetto culturale sotteso alla rivista anche al di fuori della città di Napoli, in cui questa esperienza è nata e si è radicata. 3 Étienne de La Boétie Discorso sulla Servitù Volontaria Titolo originale dell’opera Discours de la Servitude Volontarie (1546?) Traduzione di Vincenzo Papa Saggio introduttivo “Un’Ambigua Utopia Repubblicana” e note al testo di Enrico Voccia 4 5 Enrico Voccia Un’ambigua Utopia Repubblicana In primo luogo, credo che sia fuori dubbio che, se vivessimo secondo i diritti che la natura ci ha dato e secondo gli insegnamenti che ci rivolge, saremmo naturalmente obbedienti ai genitori, seguaci della ragione e servi di nessuno. (Étienne de La Boétie, Discorso sulla Servitù Volontaria) N egli Essais di Montaigne noi troviamo un lungo capitolo intitolato “Dell’amicizia”, quasi totalmente dedicato alla celebrazione ed al ricordo di un amico scomparso in giovane età. D’altronde, ciò che noi chiamiamo ordinariamente amici e amicizie, non sono che accostamenti e familiarità annodate per qualche occasione o convenienza, attraverso la quale le nostre anime si trattengono reciprocamente. Nell’amicizia di cui parlo, esse si mescolano e si confondono l’una nell’altra, in un insieme così universale, che esse smarriscono e non ritrovano più la connessione che le ha unite. Se mi si costringesse a dire perché l’amavo, sento che non potrei esprimere la cosa altrimenti che rispondendo: “Perché era lui, perché ero io.” (...) Ci cercavamo prima di esserci visti (...) ci abbracciavamo per mezzo dei nostri nomi. E al nostro primo incontro, che avvenne casualmente in una grande festa e riunione cittadina, ci trovammo così presi, così conosciuti, così obbligati fra noi, che da allora niente fu tanto vicino quanto l’uno all’altro. (...) Le nostre anime hanno viaggiato insieme talmente unite, si sono considerate con così ardente affetto, e di questo stesso affetto si sono scoperte fino al fondo delle viscere l’una e l’altra, tanto che, non solo io conoscevo la sua come la mia, ma certamente mi sarei affidato più volentieri a lui che a me stesso. Queste pagine sono state per lungo tempo il migliore passaporto per la posterità di Étienne de La Boétie, l’au- tore di un testo “maledetto” che – spesso e volentieri in edizioni clandestine – ha percorso con la sua carica liberatoria i movimenti di opposizione all’ancien régime prima, allo stato borghese/liberale poi, e che in Italia conobbe la sua prima traduzione durante la Rivoluzione Napoletana del 1799. Vita di un ateniese antico nella Francia del XVI secolo Ètienne de La Boétie era nato il I novembre del 1530 a Sarlat, piccola città del Périgord non lontana dal capoluogo della regione, Périguex: restato orfano in giovane età era stato allevato dallo zio, che era il curato di Bouilhonas, e da questi avviato agli studi. In questo periodo era Vescovo di Sarlat un cugino dei Medici di Firenze, Nicolò Gaddi, personaggio dotato di un’enorme cultura – legato strettamente alle esperienze dell’umanismo italiano – che intendeva fare della propria diocesi una sorta di “Atene del Périgord”. In questo sogno classicista il giovane La Boétie venne ben presto introdotto: fu in un tale ambiente che egli entrò in contatto con il culto e le idee repubblicane dell’antichità classica che forniranno gli strumenti concettuali al suo pensiero maturo. Dopo gli studi collegiali gli si fece balenare davanti l’occasione di accedere alla magistratura ed Étienne, allora, si iscrisse alla Facoltà di Diritto dell’Università di Orléans. Il giovane pensatore francese incontrò nei suoi studi universitari una serie di insegnanti molto brillanti e, spesso, anche assai poco ortodossi: in effetti la Facoltà di Diritto cui si era iscritto La Boétie era all’avanguardia degli studi giurispru- 1 MONTAIGNE, Michel de, Essais, Paris, Garnier, 1962, pp. 203/220: “Au demeurant, ce que nous appellons ordinairement amis et amitiez, ce ne sont qu’accoinctances et familiaritez nouées par quelque occasion ou commodité, par le moyen de laquelle nos ames s’entretiennent. En l’amitié dequoy je parle, elles se meslent et confondent l’une en l’autre, d’un melange si universel, qu’elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Si on me presse de dire pourquoy je l’aymois, je sens que cela ne se peut exprimer, qu’en respondant: "Par ce que c’estoit luy; par ce que c’estoit moy." (...) Nous nous cherchions avant que de nous estre veus (...) nous nous embrassions par noz noms. Et à notre premiere rencontre, qui fut par hazard en une grande feste et compagnie de ville, nous nous trouvasmes si prins, si cognus, si obligez entre nous, que rien dès lors ne nous fut si proche que l’un à l’autre. (...) Nos ames ont charrié si uniement ensemble, elles se sont considerées d’une si ardant affection, et de pareille affection descouvertes jusques au fin fond des entrailles l’une à l’autre, que non seulement je connoissoy la sienne comme la mienne, mais je me fusse certainement plus volontiers fié à luy de moy qu’à moy.” 2 Discorso di Stefano della Boétie della schiavitù volontaria o il Contra uno, Napoli, 1799. Traduttore e curatore dell’opera fu Cesare Paribelli, un prigioniero politico del regime borbonico. 6 1 Anne du Bourg, Professore di Diritto all’Università di Orléans nonché Consigliere al Parlamento della città di Parigi, era assai noto sia per la sua vasta ed indiscussa cultura giuridica sia per la sua dichiarata fede protestante, che lo portò, di fronte alla persona stessa del re Enrico II, a contestare vivamente la repressione antiugonotta. La sua coraggiosa presa di posizione gli costò la vita: nel 1559 venne condannato all’impiccagione ed il suo corpo fu successivamente bruciato. Étienne de La Boétie, benché cattolico, avvertì fortissimamente l’influenza del suo maestro all’Università; è pressocché unanimemente riconosciuto che il Discorso sulla Servitù Volontaria risente dell’influsso di alcune delle idee di Anne du Bourg. 2 Nel 1557 il Parlamento di Bordeaux fece giustiziare il leader ugonotto Bernard de Borda; l’anno dopo inviò al rogo Jean de Caze e Arnaud Monnier, due giovanissimi accusati di eresia; l’anno dopo ancora fu la volta di un mercante della città accusato di aver istigato altre persone a mutilare le statue della Madonna e del Cristo. I protestanti vennero co3 stretti a restituire ai monaci del monastero di S. Giacomo i loro possessi di natura religiosa (convento e chiese), mentre ai cattolici venne ordinato di lasciar svolgere agli ugonotti le loro funzioni religiose nella chiesa di Sainte-Foy. Nelle località minori, dove era presente un unico edificio di culto, si stabilì il principio dell’uso a rotazione dello stesso. VOCCIA, Enrico denziali dell’epoca. In questa sede infatti le opere di Lorenzo Valla, di Angelo Poliziano, di André Alciat circolavano abbondantemente e, con esse, l’abitudine di applicare la filologia e le conoscenze erudite di storia antica allo studio del diritto. Ad Orléans insegnava in particolare Anne du Bourg: l’interpretazione grammaticale delle espressioni giuridiche, l’analisi semantica dei termini, le riflessioni di filosofia del diritto, l’esame critico dei testi erano il tratto distintivo del suo insegnamento. La tipica forma mentis razionalistica e non puramente storicistica delle argomentazioni che La Boétie inserirà nel suo Discorso sulla Servitù Volontaria si svilupperà proprio nel clima culturale vissuto in questi anni da docenti e discenti della Facoltà di Diritto dell’Università di Orléans. Dopo una brillante carriera di studi, La Boétie si laureò in Giurisprudenza il 23 settembre del 1553; pochi giorni dopo, il 13 ottobre, ottenne la licenza reale che gli consentiva di accettare la carica di Consigliere al Parlamento di Bordeaux e, dopo un periodo di prova ed un esame, il 17 marzo 1554 venne definitivamente integrato in tale carica. Tre anni dopo, nel 1557, diverrà Consigliere al Parlamento di Bordeaux anche Michel de Montaigne e nascerà tra i due la celebre amicizia che quest’ultimo descriverà coi toni che già conosciamo. I due amici svilupperanno la loro amicizia in un contesto politico estremamente travagliato: il Parlamento di Bordeaux venne infatti trascinato, volente o nolente, nel pieno dei disordini legati allo scontro religioso e al diffondersi della Riforma nel Midi acquitano. Chiamato al lealismo realista, attraverso di esso passarono dapprima numerose condanne a morte e poi, nel 1560, l’applicazione di un editto reale che, oltre a negare ogni diritto di associazione agli ugonotti, imponeva una repressione feroce contro ogni istanza alternativa al cattolicesimo. É in questo contesto che nel 1560 venne affidata a La Boétie una missione segreta di riconciliazione religiosa presso Caterina dei Medici, la reggente al trono per il decenne Carlo IX – missione nascosta sotto l’apparenza di una discussione presso il potere centrale della paga dei magistrati della città. Il motivo per cui una missione così delicata fu affidata ad un consigliere così giovane e, fino ad allora, con una carriera non particolarmente brillante, va ricercata nel fatto che La Boétie era, sotto molti punti di vista, l’uomo più adatto per una tale incombenza. Innanzitutto il giovane consigliere si era formato alla scuola intellettuale di Nicolò Gaddi, parente della reggente, ed era perciò un elemento ben accetto alla corte reale francese. Inoltre proprio il fatto che La Boétie era rimasto notevolmente in ombra durante tutta la sua attività di Consigliere al Parlamento di Bordeaux era segno evidente, al di là dei comportamenti obbligati e della sua fede cattolica, di una posizione in qualche misura dissidente rispetto alla politica ottusamente repressiva attuata dal Parlamento nei confronti dei non cattolici. Étienne de La Boétie per svolgere questa missione entrò in contatto con il cancelliere Michel de L’Hospital, fautore della politica di pace e di tolleranza religiosa inaugurata dalla reggente, con cui si legò in un’amicizia al tempo stesso personale e politica. Il cancelliere affidò al giovane amico il compito di farsi interprete presso il Parlamento di Bordeaux, fino ad allora seguace della politica repressiva e filocattolica legata al partito dei Guise, della nuova linea di tolleranza i cui punti salienti erano contenuti nell’ordinanza degli Stati Generali emanata ad Orléans il 31 gennaio 1561. Dopo aver svolto brillatemente tale compito, de L’Hospital gli affidò il tentativo di mediazione pacifica di alcuni scontri religiosi avvenuti nella zona di Agenais. In tale compito La Boétie affiancò il luogotenente reale de Burie; il suo ruolo fu essenziale nel raggiungere una soluzione di compromesso sostanzialmente soddisfacente per entrambe le parti in lotta. Il rapporto strettissimo che legava oramai il giovane cancelliere alla politi- 7 Un’ambigua Utopia Repubblicana ca di conciliazione religiosa della reggente e del suo cancelliere si concretizzò nella pubblicazione della Mémoire sur l’Edit de Janvier, dove La Boétie prendeva posizione a favore della politica di relativa tolleranza religiosa della reggente Caterina dei Medici e del suo entourage. In questo testo egli denunciava, da un lato, i pericoli connessi agli scontri religiosi che dilaniano una nazione, dall’altro, l’inutilità – anzi la dannosità rispetto allo scopo della conciliazione sociale – della repressione violenta. Il cattolicesimo sarebbe dovuto restare la religione principale dello stato francese, ma la strada per la pacificazione nazionale consisteva, a suo avviso, nella creazione di un “cattolicesimo riformato” in cui cattolici tradizionali e protestanti avrebbero potuto riconciliarsi. In questo periodo Étienne de La Boétie collabora con il suo grande amico Michel de Montaigne per convincere le ali cattoliche oltranziste del Parlamento di Bordeaux a non ostacolare la politica di pacificazione nazionale portata avanti dalla reggente e dal cancelliere de L’Hospital. Nel dicembre 1562 egli è ancora una volta protagonista di un riuscito tentativo di pacificazione, entrando a far parte di una missione incaricata di arrestare un piccolo esercito ugonotto che si dirigeva verso Bordeaux. Dopo vari anni di anonimato, La Boétie cominciava ad assumere un ruolo politico di una qualche rilevanza; pochi mesi dopo però, all’età di nemmeno 33 anni, egli si ammalò bruscamente. Sentendosi prossimo alla morte, il 14 agosto 1563 egli redasse il suo testamento; Montaigne era accorso al suo capezzale e, il 18 agosto, Étienne de La Boétie morì tra le sue braccia, invocando il nome del grande amico che ne raccoglieva l’ultimo respiro. Un ambiguo esecutore testamentario Durante la sua breve vita Étienne de La Boétie non ebbe materialmente il KRITIOS e MNESIOTES, I Tirannicidi tempo di pubblicare la maggior parte dei suoi lavori; nel testamento redatto poco prima di morire egli lasciò la sua biblioteca e soprattutto i suoi manoscritti a Montaigne. Questi deciderà di onorare la memoria del grande amico scomparso pubblicandone a più riprese le opere, ma in quest’attività di esecutore testamentario si comporterà in maniera a dir poco assai cauta. Innanzitutto tra la morte dell’amico e la pubblicazione di alcuni suoi testi lascia passare ben sette anni – un periodo di tempo assai lungo, difficilmente giustificabile con le necessità tecniche dell’ordinamento dei manoscritti. Inoltre, e soprattutto, Michel de Montaigne esclude con estrema cura dalla pubblicazione non solo il Discorso sulla Servitù Volontaria ma anche qualunque testo di La Boétie che abbia sia pur lontanamente a che fare con esso. Montaigne infatti dell’amico scomparso fa stampare una serie di poesie e le traduzioni in francese di alcune opere di Senofonte e Plutarco; inserisce inoltre nelle cinque edizioni dei suoi Essais pubbli- 1 Il testo, considerato per lungo tempo come perduto, fu ritrovato nel 1917 e venne edito a cura di Paul Bonnefon (Paris, Brossard, 1922); l’editto di cui si parla è quello che la reggente e il suo cancelliere emanarono il 17 gennaio 1562 in favore della conciliazione nazionale. 2 La morte dell’amico è efficacemente descritta da Montaigne in una lettera al padre. Cfr. MONTAIGNE, Michel de, Oeuvres complètes, Parigi, Gallimard, 1962, pp. 1347/1365. É incerta la malattia che ne ha causato della morte: a giudicare dalla testimonianza di Montaigne (“un flux de ventre avec des tranchées”) potrebbe trattarsi di una grave forma di dissenteria o, forse, di colera; ma non si può escludere che egli sia stato invece vittima dell’epidemia di peste che imperversava in quel periodo nell’Agenais. VOCCIA, Enrico 8 1 MONTAIGNE, Michel de, Essais, Paris, Garnier, 1962, pp. 198/199: “C’est un discours auquel il donna nom La Servitude Volontaire; mais ceux qui l’ont ignoré, l’ont bien proprement depuis rebaptisé Le Contre Un. Il l’escrivit par maniere d’essay, en sa premiere jeunesse, à l’honneur de la liberté contre les tyrans. Il court pieça és mains des gens d’entendement, non sans bien grande e méritée recommandation: car il est gentil, et plein ce qu’il est possible. Si y a il bien à dire que ce ne soit le mieux qu’il peut faire; et si, en l’aage que je l’ay conneu, plus avancé, il eut pris un tel desseing que le mien de mettre par escrit ses fantasies, nous verrions plusieurs choses rares et qui nous approcheroient bien prês de l’honneur de l’antiquité; car, notamment en cette partie des dons de nature, je n’en connois point qui luy soit comparable. Mais il n’est demeuré de luy que ce discours, encore par rencontre, et croy qu’il ne le veit onques depuis qu’il luy eschapa, et quelques memoires sur set edict de Janvier, fameus par nos guerres civiles, qui trouveront encores ailleurs peut estre leur place. C’est tout que j’ay peu recouvrer de ses reliques, moy qu’il laissa, d’une si amoureuse recommandation, la mort entre les dents, par son testament, hériter de sa bibliothèque et de ses papiers, outre le livret de ses oeuvres que j’ay fait mettre en lumiere. Et si, suis obligé particulierement à cette piece, d’autant qu’elle a servy de moyen à notre premiere accoinctance. Car elle me fut montrée longue piece avant que je l’eusse veu, et me donna la premiere connaissance de son nom, acheminant ainsi cette amitié que nous avons nourrie, tant que Dieu a voulu, entre nous, si entiere et si parfaite que certainement il ne s’en lit guiere de pareilles, et, entre nos hommes, il ne s’en voit aucune trace en usage.” BRUEGEL, Pieter (il vecchio), La Torre di Babele cate durante la vita, in appendice al capitolo dedicato all’amicizia, 29 sonetti di La Boétie di contenuto per lo più amoroso. Ma il Discorso sulla Servitù Volontaria cita esplicitamente il passaggio di una poesia dal contenuto chiaramente politico; di tali versi non c’è più traccia nella biblioteca di Montaigne, così come dello stesso manoscritto della principale opera politica di La Boétie. La difficoltà che Montaigne prova nei confronti dell’aspetto politico dell’attività di pensiero dell’amico scomparso è patente in due passaggi del capitolo XXVIII dei suoi Essais: É un discorso al quale diede nome La Servitù Volontaria; ma quelli che hanno ignorato ciò, l’hanno assai propriamente ribattezzato in seguito Il Contr’Uno. Lo scrisse come per un saggio, nella sua prima giovinezza, in onore della libertà contro i tiranni. Da molto tempo è nelle mani delle persone d’ingegno, non senza enorme e meritata fama: poiché è nobile, e denso quant’è possibile. Si deve ciononostante dire che non sia il meglio che avrebbe potuto fare; e se, all’età in cui io l’ho conosciuto, più maturo, avesse preso lo stesso disegno mio di mettere per iscritto i suoi pensieri, vedremmo molte cose pregiate e che ci richiamerebbero assai da vicino la grandezza dell’antichità; infatti, specialmente nella parte dei doni di natura, non conosco nessuno che gli sia comparabile. Ma non è avanzato di lui che quel discorso, forse per caso, e credo che egli non l’abbia più visto dopo che gli sfuggì dalle mani, ed alcune memorie su quell’editto di gennaio, famoso a causa delle nostre guerre civili, che troveranno forse anch’esse altrove il loro posto. É tutto ciò che ho potuto recuperare delle sue reliquie, io che egli lasciò, con una raccomandazione così amorosa, la morte tra i denti, con il suo testamento, erede della sua biblioteca e dei suoi manoscritti, oltre al libretto delle sue opere che ho fatto pubblicare. E sono particolarmente riconoscente a quest’opera, in quanto essa è servita come mezzo per la nostra prima conoscenza. Infatti essa mi fu mostrata molto tempo prima ch’io l’avessi veduto, e mi fornì la prima conoscenza del suo nome, avviando così quell’amicizia che abbiamo coltivato tra di noi, per tutto il tempo che Dio ha voluto, così integra e così perfetta che di sicuro non se ne legge niente di simile, e, fra noi contemporanei, non se ne vede alcuna traccia dell’uso. Ma andiamo un po’ a parlare di questo ragazzo di sedici anni. Poiché ho riscontrato che quell’opera è stata successivamente pubblicata, e per un cattivo fine, da coloro che cercano di turbare e cambiare la forma del nostro governo, senza darsi cura di sapere se lo miglioreranno, che lo hanno unito ad altri scritti farina del loro Un’ambigua Utopia Repubblicana sacco, recedo dalla mia idea iniziale di metterla qui. E affinché la memoria dell’autore non abbia a soffrirne nei confronti di coloro che non hanno potuto conoscere da vicino le sue opinioni e le sue azioni, li avviso che questo soggetto fu trattato da lui nella sua primissima giovinezza, soltanto come per un esercizio, come soggetto volgare e affrontato mille volte nei libri. Non metto assolutamente in dubbio che egli non credesse in ciò che scriveva, perché era abbastanza coscienzioso da non mentire neanche per gioco. E so anche che, se avesse dovuto scegliere, avrebbe di gran lunga preferito essere nato a Venezia che a Sarlac; ed a ragione. Ma egli aveva un’altra massima sovranamente scolpita nella sua anima, obbedire e sottomettersi scrupolosamente alle leggi sotto le quali era nato. Non ci fu mai un miglior cittadino, né più affezionato alla pace del suo paese, né più nemico dei rivolgimenti e delle innovazioni del suo tempo. Egli piuttosto avrebbe impiegato le sue capacità per spegnerli, che a fornire materiale per fomentarli ancora di più. Aveva il suo spirito forgiato sul modello di altri secoli piuttosto che di questo. Il problema è evidente: il testo dell’amico scomparso possiede una valenza politica innegabile e, se ciò non bastasse, circola in edizioni clandestine edite dalle correnti repubblicaneggianti dell’ opposizione protestante alla monarchia francese. Farsene editore ufficiale creerebbe dunque grossi problemi a Montaigne – che d’altronde sente l’obbligo morale di parlarne comunque, dal momento che si tratta in assoluto dell’opera più nota di La Boétie e che lui stesso aveva avuto occasione di leggere manoscritta prima del 1557. Altrettanto evidente del suo imbarazzo è poi la strategia messa in atto nei passaggi citati: separare le riflessioni del giovane La Boétie da quelle del suo pensiero maturo. Montaigne, innanzitutto, fa notare che i promotori delle edizioni clandestine del Discorso sulla Servitù Volontaria l’hanno pubblicato come Il Contr’Uno – mentre tutti coloro che conoscevano personalmente il suo autore erano perfettamente a conoscenza del vero titolo dell’opera. La Boétie, sembra sugge- 9 rire Montaigne, non era quindi evidentemente interno all’area politica, sociale e religiosa che curava la diffusione del testo “unito ad altri scritti farina del loro sacco”. Il testo sarebbe poi stato scritto “nella primissima giovinezza” del suo autore, e non avrebbe avuto altro scopo che quello di produrre una esercitazione scolastica su un tema retorico in qualche modo classico e molto praticato nelle scuole dell’epoca. La Boétie non lo rivide mai in età matura (dunque non fu “il meglio che avrebbe potuto fare”) e, soprattutto, l’opera “gli sfuggì dalle mani”: Montaigne lascia cioè intendere che l’amico scomparso avrebbe inizialmente controllato la circolazione dell’opera manoscritta, passandola solo agli amici fidati, ma che in seguito (“forse per caso”) gli sarebbe sfuggita dalle mani, circolando in cerchie sempre più ampie fino a conoscere le stampe clandestine post mortem. Montaigne corona queste argomentazioni, volte in qualche modo a difendere l’onorabilità di La Boétie maturo dalle sue intemperanze giovanili, teorizzando in lui l’accettazione di una sorta di “morale provvisoria”: La Boétie continuava insomma a credere fermamente nelle idee repubblicane giovanili, ma, ciononostante, “aveva un’altra massima sovranamente scolpita nella sua anima, obbedire e sottomettersi scrupolosamente alle leggi sotto le quali era nato.” La posizione di Montaigne presenta numerose contraddizioni. Egli cerca di presentare il testo dell’amico scomparso come poco più di una esercitazione retorica giovanile; eppure è evidente che a tale “esercitazione” La Boétie doveva attribuire grande importanza, dal momento che egli si preoccupava di far circolare ampiamente il manoscritto – e non solo fra gli intimi, dal momento che lo stesso Montaigne aveva conosciuto l’opera prima di incontrarne personalmente l’autore. Nemmeno convince l’idea sottintesa nelle pagine citate che La Boétie avrebbe riscritto diversamente il testo in età più matura. É divenuto infatti 1 MONTAIGNE, Michel de, Essais, Paris, Garnier, 1962, pp. 211/212: “Mais oyons un peu parler ce garson de seize ans. Parce que j’ay trouvé que cet ouvrage a esté depuis mis en lumiere, et à mauvais fin, par ceux qui cherchent à troubler et changer l’estat de notre police, sans se soucier s’ils l’amenderont, qu’ils ont meslé à d’autres escris de leur farine, je me suis dédit de le loger icy. Et affin que la memoire de l’auteur n’en soit interessée en l’endroit de ceux qui n’ont peu connoistre de près ses opinions et ses actions, je les advise que ce subject fut traicté par luy en son enfance, par maniere d’exercitation seulement, comme subject vulgaire et tracassé en mille endroits des livres. Je ne fay nul doubte qu’il ne creust ce qu’il escrivoit, car il estoit assez coscientieux pour ne mentir pas mesmes en se jouant. Et sçay d’avantage que, s’il eut à choisir, il eut mieux aimé estre nay à Venise qu’à Sarlac; et avec raison. Mais il avoit un’autre maxime souverainement empreinte en son ame, d’obeyr et de soubmettre très-religieusement aux lois sous lesquelles il estoit nay. Il ne fut jamais un meilleur citoyen, ny plus affectionné au repos de son païs, ny plus ennemy des remuements et nouvelletez de son temps. Il eut bien plustost employé sa suffisance à les esteindre, que à leur fournir dequoy les émouvoir d’avantage. Il avoit son esprit moulé au patron d’autre siècles que ceux-cy.” 2 É interessante notare che Montaigne abbassa progressivamente l’età a cui l’amico scomparso avrebbe scritto il Discorso sulla Servitù Volontaria: i “sedici anni” citati nel testo erano, nelle edizioni precedenti, diciotto. 10 1 L’espressione “enigma” compare nel titolo di vari saggi dedicati all’opera di La Boétie: si veda, p. e., Dr Armingaud, Montaigne pamphletaire. L’énigme du Contr’Un, Hachette, 1910 e Lablénie, Edmond, “L’Énigme de la Servitude Volontaire”, in Revue de XVI siècle, 1930, tomo XVII, pp. 203/227. 2 D’altronde anche questa a ben vedere non è propriamente una lamentela, dal momento che lo stesso Montaigne ritiene che – data l’ignoranza del titolo preciso del testo – i suoi editori clandestini “l’hanno assai propriamente ribattezzato in seguito il Contr’Uno”. In altri termini, il richiamo presente nel nuovo titolo alla istituzione monarchica non sarebbe affatto fuori luogo e non tradirebbe affatto il significato profondo dell’opera; ed anche questo atteggiamento di Montaigne appare assai strano, vista la sua dichiarata intenzione di presentare l’amico scomparso come un campione di fedeltà alle istituzioni politiche “sotto le quali era nato”. Le Réveille-Matin des Français et 3 de leurs voisins. Composé par Eusèbe Philadelphe Cosmopolite en forme de Dialogues, Bâle ed Ebimbourg, 1574, Middelburg, 1557 e 1578; Mémoires de l’Estat de France sous Charles Neufiesme, contenans les choses plus notables, faites et publiées tant par les Catholiques que pars ceux de la Religion, depuis le troisiesme Édit de pacification fait au mois d’Aoust 1570, jusques au régne de Henry troisiesme, edito dal pastore protestante Simon Goulart nel 1576, nel 1578 e per ben due volte nel 1579. Entrambi i testi sono delle raccolte; nel primo vi è citato all’incirca un terzo del Discorso sulla Servitù Volontaria, nel secondo l’edizione è quasi integrale. All’inizio del Novecento si è 4 addirittura ipotizzato, oltre che Montaigne fosse l’autore delle interpolazioni al testo il cui manoscritto conservava, che le interpolazioni fossero state tali e tante da doverlo considerare il vero autore del Discorso sulla Servitù Volontaria: si veda Dr Armingaud, Montaigne pamphletaire. L’é- VOCCIA, Enrico persino un topos letterario l’imbarazzo che prova un autore di fronte all’idea di far leggere un testo scritto in anni precedenti e nel quale non ci si riconosce più: ma Montaigne stesso ci informa che l’amico scomparso non aveva alcun problema a diffondere il manoscritto del suo testo. Quanto poi alla incondizionata adesione di La Boétie “alle leggi sotto le quali era nato”, è la stessa scrittura e diffusione di un’opera “sovversiva” come il Discorso sulla Servitù Volontaria che rende poco credibile una simile informazione. Ma le stranezze dell’atteggiamento di Montaigne non terminano qui: è ora il caso di addentrarci brevemente in uno dei maggiori misteri che circondano l’opera e che ha fatto parlare di un vero e proprio “enigma” che circonderebbe la sua genesi. Montaigne, l’abbiamo appena visto, afferma che l’“esercitazione” sarebbe stata scritta in età giovanile (nel 1546/1548) e mai più rivista in età matura, e che egli avrebbe avuto occasione di leggerla prima dell’incontro con il suo autore (avvenuto nel 1557). Egli inoltre, e questo è il punto essenziale, non afferma affatto che il testo edito clandestinamente dalle correnti repubblicano/ protestanti di opposizione sia stato in qualche modo interpolato dai suoi editori – limitandosi a lamentare il cambio del titolo ed il fatto che fosse stato pubblicato insieme ad altri testi farina di diverso sacco. Eppure sarebbe stato per lui facilissimo, se la sua intenzione fosse stata davvero quella di separare l’opera “giovanile” dell’amico dall’area politico/sociale che ne aveva curato le edizioni clandestine, denunciare una serie di evidenti interpolazioni del testo, di cui la più clamorosa è la citazione di un’opera (la Franciade di Ronsard) pubblicata ben nove anni dopo la morte di La Boétie. Montaigne invece, su tutto ciò, tace; e si tratta di un atteggiamento effettivamente strano. Come spiegare questo comportamento da parte di Montaigne? Le ipotesi possibili sono solamente due. La prima ipotesi, che sembrerebbe la più naturale ed immediata, è che egli fosse venuto a conoscenza del solo fatto delle varie pubblicazioni clandestine del testo col titolo mutato, senza che avesse avuto occasione di mettere materialmente le mani su una delle copie. La cosa sembra però plausibile solo ad una prima occhiata: le copie manoscritte del Discorso sulla Servitù Volontaria come sappiamo erano state molteplici, e la loro diffusione incontrollata già durante la vita dell’autore. Occorrerebbe pertanto presumere che non solo Montaigne, ma nessuno dei tanti che avevano letto il testo manoscritto avesse avuto l’opportunità di avere tra le mani una copia de Le Reveille-Matin des Français et de leurs voisins... o delle Mémoires de l’Estat de France sous Charles Neufiesme... contenenti il testo di La Boétie. Queste avevano, in effetti, conosciuto una diffusione notevolissima: dal 1574 al 1579 il Discorso sulla Servitù Volontaria vedrà la media di più un’edizione all’anno. Sembra perciò strano che all’orecchio di Montaigne non fossero giunte le voci di tali interpolazioni e che lui non avesse provveduto a sfruttarle in difesa della memoria dell’amico scomparso. La seconda ipotesi spiega la cosa supponendo che l’autore per lo meno di alcune delle interpolazioni del Discorso sulla Servitù Volontaria fosse stato proprio Montaigne. Il grande amico di La Boétie non poteva infatti non notare la citazione della Franciade, specie nel momento in cui andava affermando che l’opera non era mai stata rivista dai tempi della composizione giovanile e si lamentava di una sua edizione clandestina da parte dei gruppi di opposizione alla monarchia francese! Avrebbe allora taciuto, accettando l’ipotesi che fosse perfettamente a conoscenza di tali interpolazioni al testo, per il semplice fatto che era stato lui ad operarne una larga parte o, quantomeno, ipotizzando in lui una qualcerta “complicità” in tali correzioni... É possibile allora che le varie pubblicazioni clandestine del Discorso sulla Servitù Volontaria siano state il vero modo con cui Montaigne ha tardiva- 11 Un’ambigua Utopia Repubblicana mente adempiuto al suo compito di esecutore testamentario? É possibile, in altri termini, che egli -- o per lo meno il suo entourage – abbia fatto giungere il testo di La Boétie nelle mani della pubblicistica di opposizione alla monarchia francese? E fino a che punto potrebbe essersi spinta una tale “complicità” nelle sue varie edizioni clandestine? Ci stiamo muovendo in un campo in cui le evidenze oggettive sono per la maggior parte disperse e risultano del tutto irrintracciabili, come il suono dell’albero caduto che il vescovo Berkeley non udì. Eppure ciò che ci resta – l’ambiguo comportamento di Montaigne e le sue altrettanto ambigue affermazioni presenti negli Essais – ci spinge in quella direzione. Ed allora ci ritornano in mente le parole, filorepubblicane anche queste in maniera ambigua, con cui Montaigne descrive le posizioni politiche dell’amico scomparso: “E so anche che, se avesse dovuto scegliere, avrebbe di gran lunga preferito essere nato a Venezia che a Sarlac; ed a ragione.” BOSCH, Hieronymus, Trittico del Giudizio (Giudizio Finale) nigme du Contr’Un, Hachette, 1910 e i suoi due articoli comparsi nel 1906 nella Revue politique e parlamentaire. La tesi di Armingaud provocò una polemica nella quale P. Bonnefon, P. Villey, F. Strowski, R. Dezeimeris, H. Barckhausen e M. Lablénie intervennero riaffermando la sostanziale paternità dell’opera a Étienne de La Boétie. In tempi recentissimi però Simone Goyard-Fabre, curatore dell’ultima edizione critica del testo di La Boétie (sulla quale è condotta la presente traduzione), pur non riconoscendosi nella tesi di Armingaud ha affermato: “Néanmoins, il n’est pas impossible que Montaigne ait inséré dans le manuscrit de son ami des interpolations non négligeables; et, ainsi que le remarque P. Villey, il n’est pas impensable que Montaigne, lisant e relisant l’essai de La Boétie, ait apporté – ou ait laissé apporter avec une certaine ‘complicité’ – quelques corrections au manuscrit original du Discours.” Questa posizione ci pare corretta, anche perché le obiezioni che mettono in evidenza come il progetto del testo di Ronsard fosse già noto durante la vita di La Boétie hanno poca forza. Occorre infatti notare che: 1. Montaigne afferma che il testo non sarebbe stato mai ritoccato dopo il 1546/1548; 2. anche ammettendo che Montaigne possa aver mentito su questo punto, l’intero Discorso sulla Servitù Volontaria è costruito su citazioni di autori classici e di momenti storici alla base dell’insegnamento scolastico dell’epoca – e di fronte a quest’aspetto essoterico avrebbe poco senso la citazione di un’opera ancora tutta da scrivere ed il cui semplice progetto era conosciuto in cerchie molto ristrette; 3. infine, occorre notare che il tono dell’intera opera è decisamente serioso e in certi tratti sarcastico – per cui la lieve ironia dell’accenno ai poeti della Pleiäde risulterebbe essere un episodio completamente isolato nell’economia dell’opera. Insomma un’analisi anche solo superficiale dell’opera tenderebbe a confermare l’eterogeneità stilistica del passaggio (che, sia detto per inciso, ricorda molto di più certi passaggi degli Essais montaignani). VOCCIA, Enrico 12 1 Il testo che presentiamo in questa traduzione è in buona parte tratto dal cosidetto “Manoscritto di Mesmes”, ovvero dalle trascrizioni – pressocché identiche – che Henry de Mesmes e Claude Depuy, amici di Montaigne, faranno del manoscritto originale presso la biblioteca dell’autore degli Essais. La pressocché identità dei due manoscritti, ritrovati nel XIX secolo, è un ulteriore indizio a favore della tesi che vede in Montaigne l’autore di almeno alcune delle interpolazioni al testo. 2 Da notare, oltre alla già citata traduzione italiana durante la Repubblica Napoletana del 1799, anche l’opera del noto rivoluzionario francese Marat The chains of slavery... (London, 1774) e Les chaînes de l’esclavage... (Paris, 1792), nel quale il testo di La Boétie è abbondantemente parafrasato in vari punti. Dopo le edizioni settecente3 sche, la riscoperta in chiave filorepubblicana e democratica del testo di La Boétie avverrà a partire dall’edizione che verrà curata da Félicité de Lamennais, con una sua prefazione e le note di Pierre Coste, e pubblicata a Parigi, Daubrée et Cailleux, 1835. Il successo del testo sarà tale che nel giro di sei mesi conoscerà una seconda ed anche una terza edizione e darà adito ad un notevole dibattito intellettuale e politico (si veda la bibliografia finale). “In nome della libertà, contro i tiranni” Abbiamo quindi (probabilmente) a che fare con un testo dalla composizione assai complessa, nel quale, a partire dall’originaria stesura più o meno giovanile da parte di Étienne de La Boétie, si sono sovrapposte tutta una serie di interpolazioni e/o rifacimenti da parte di Montaigne, del suo entourage e dei primi editori clandestini. Nelle sue varie redazioni il testo godrà di una notevole fortuna durante tutto il XVI secolo e, dopo una breve eclissi nel secolo successivo, ricomparirà come testo di opposizione all’ancien régime durante il secolo dei lumi, conoscendo poi le sue prime edizioni non clandestine durante gli eventi legati alla Rivoluzione Francese. I primi due terzi del XIX secolo vedranno ulteriori e numerose edizioni dell’opera, utilizzata come pamphlet filorepubblicano contro la politica restauratrice negli avvenimenti politico/sociali susseguenti il Congresso di Vienna, ma il vero e proprio “successo editoriale” del testo di La Boétie si avrà con la nascita della Prima Associazione Internazionale dei Lavoratori. Reinterpretato in chiave socia- lista e libertaria, il testo, a partire dal secondo terzo del XIX secolo e fino ai giorni nostri, conoscerà numerosissime edizioni e verrà tradotto in quasi tutte le lingue d’Europa e persino in esperanto. Il motivo di una tale vitalità dell’opera di la Boétie può spiegarsi solo con quella che che è forse la sua caratteristica peculiare. Scritto in un periodo storico ben determinato, il Discorso sulla Servitù Volontaria è però strutturato in maniera tale da mantenere la sua validità in ogni tempo ed in ogni luogo: in questo senso, nel suo tentativo di evidenziare il fondamento del potere tirannico in quanto tale, è opera filosofica nel senso più profondo e specifico del termine. L’opera viene scritta – dal solo Étienne de La Boétie o come opera collettiva poco importa – agli inizi del XVI secolo, mentre le strutture politiche tardomedievali si vanno dissolvendo sotto l’avvento sempre più evidente delle monarchie nazionali centralizzate. La Boétie innanzitutto, ma anche ognuno dei suoi possibili coautori – Montaigne e gli stessi scrittori protestanti d’opposizione – sono immersi pienamente in questo nuovo clima e, come in tutti i momenti storici di pas- L’ultima notevole edizione 4 in questa chiave del Discorso sulla Servitù Volontaria è quella comparsa nel 1976 in Critique de la Politique, nell’edizione critica stabilita da P. Léonard, con una “Presentazione” a cura di M. Abensour e M. Gachet. Accompagnano il testo, infatti, le prefazioni di Lamennais all’edizione del 1835, un articolo di Pierre Leroux del 1847, la prefazione di Pierre Vermorel all’edizione del 1863, alcune pagine di Gustav Landauer del 1907, un breve passaggio di Simone Weil e, soprattutto, due testi critici di accompagnamento al testo a cura di Pierre Clastres e Claude Lefort. TRUMBULL, John, La Dichiarazione d’Indipendenza Un’ambigua Utopia Repubblicana saggio da un sistema politico all’altro, l’effetto di straniamento è assai forte. In momenti come questi le strutture politico/sociali perdono il loro carattere di “naturalità” ed è più facile che vengano alla luce nella riflessione le strutture profonde della socialità: le categorie del politico. L’analisi di La Boétie è dedicata, in apparenza, ad un tema specifico: la critica al potere tirannico, attraverso l’evidenziazione dei meccanismi strutturali e consensuali che sorreggono tale forma di potere politico. (...) vorrei solo comprendere come è possibile che tanti uomini, tanti paesi, tante città e nazioni tollerino talvolta un solo tiranno, che non ha altro potere che quello che gli danno; che ha il potere di nuocere loro solo finché essi possono sopportarlo; che non potrebbe far loro alcun male, se non quando essi preferiscono sopportarlo piuttosto che contraddirlo. È davvero sorprendente, e tuttavia così comune che c’è più da dispiacersi che da stupirsi nel vedere milioni e milioni di uomini servire miserevolmente, col collo sotto il giogo, non costretti da una forza più grande, ma perché sembra siano ammaliati e affascinati dal nome solo di uno, di cui non dovrebbero temere la potenza, visto che è solo, né amare le qualità, visto che nei loro confronti è inumano e selvaggio. Come è possibile insomma – si chiede La Boétie – che gli uomini acconsentano ad un potere sfacciatamente contrario ad ogni loro possibile interesse e spesso addirittura ampiamente nocivo ad essi? Come possono gli uomini innamorarsi delle loro catene? Questa domanda permette lo sviluppo di un interrogazione più generale sulle strutture del dominio, che porta l’autore ad allargare in maniera estrema il concetto di “tirannia”. “Tiranno” è, nella concezione di La Boétie, qualcosa di più che il monarca centralizzatore del XVI secolo e/o i suoi equivalenti funzionali del passato dell’umanità. L’ “Uno” di cui si parla nel Discorso sulla Servitù Volontaria non è infatti necessariamente una singola persona, anche se ai tempi di La Boétie tale figura politica coincideva spesso con quella del 13 monarca; essa è piuttosto la funzione politica svolta da chi – singolo o persona giuridica collettiva – riesce ad imporre agli altri la legge della propria volontà individuale. E, da questo punto di vista, conta ben poco il meccanismo politico con il quale il tiranno giunge a governare. Vi sono tre tipi di tiranni: gli uni ottengono il regno attraverso l’elezione del popolo, gli altri con la forza delle armi, e gli altri ancora per successione ereditaria. Chi lo ha acquisito per diritto di guerra si comporta in modo tale da far capire che si trova, diciamo così, in terra di conquista. Coloro che nascono sovrani non sono di solito molto migliori (...) Chi ha ricevuto il potere dello Stato dal popolo dovrebbe essere, forse, più sopportabile e lo sarebbe, penso, sennonché appena si vede innalzato al di sopra degli altri (...) è strano di quanto superi gli altri tiranni in ogni genere di vizio e perfino di crudeltà (...) A dire il vero, quindi, esiste tra loro qualche differenza, ma non ne vedo affatto una possibilità di scelta; e per quanto i metodi per arrivare al potere siano diversi, il modo di regnare è quasi sempre simile (...). Esiste quindi per La Boétie una struttura profonda, indipendente dal tempo, dallo spazio e dalle contingenze storiche, in base alla quale si innescano le dinamiche che portano al paradossale fenomeno della “servitù volontaria”: difatti il grande amico di Montaigne può esemplificare la propria analisi con esempi tratti dalla storia antica così come dalla medievale e da quella a lui contemporanea, dalla storia della civiltà europea come da quella africana ed asiatica. Il tentativo di comprendere il fenomeno della tirannia porta così ad allargare l’analisi ai meccanismi universali di formazione del consenso al potere e dell’aggregazione delle oligarchie politiche. Qualunque governo, dice La Boétie, ha bisogno del consenso dei sudditi; e questo tanto più il potere politico è “tirannico” nel senso comune del Si vedano le riflessioni di termine. Per potersi reggere un quaBertold Brecht su tale conlunque governo deve dunque mettere cetto. Cfr. BRECHT, Bertold, in atto una serie di strategie volte alla Scritti teatrali, Torino, Einaudi, creazione di tale consenso; e qui l’ana- 1971. 1 VOCCIA, Enrico 14 lisi di La Boétie si biforca, andando ad analizzare dapprima i meccanismi di formazione/estorsione della “volontà di servire”, poi la ramificazione dell’organizzazione oligarchica che sfrutta tale struttura consensuale. L’estrema plasmabilità del carattere umano mercè quella forma dell’educazione che è la vita sociale risulta essere il fondamento dell’acquiescenza popolare alla tirannia: 1 Questa parte dell’analisi di La Boétie ricorda assai da vicino le idee alla base degli esperimenti novecenteschi di psicologia comportamentale sulle tecniche di rinforzo discontinuo: vedi p. e. ZIMBARDO, Phylip G., Elementi di psicologia e vita, Napoli, Idelson, vol. I, pp. 69/89. 2 Questa tesi – come molte altre presenti nell’opera antitirannica di La Boétie – verrà ripresa e generalizzata a qualunque forma di governo dal pensiero anarchico otto/novecentesco. In effetti la gran parte degli strumenti concettuali dell’anarchismo contemporaneo si vanno formando nella cultura europea proprio a partire dalla riflessione filosofica dettata dalla nascita dello stato moderno: le tesi di testi come il Discorso sulla Servitù Volontaria o il Leviatano di Hobbes verranno generalizzate e/o mutate valutativamente di segno per ricomparire, organicamente collegate in una teoria politica libertaria e autogestionaria, dalla metà del XIX secolo in poi. Cfr. p. e. STIRNER, Max, L’Unico e la sua proprietà, Milano, Adelphi, 1978 o MALATESTA, Errico e MERLINO, Francesco Saverio, Anarchismo o Democrazia, Ragusa, La Fiaccola, 1974. Si tratta di meccanismi di trasmissione culturale molto evidenti, ma che ciononostante sono stati assai poco o quasi per nulla approfonditi. (...) la prima ragione della servitù volontaria è l’abitudine: come i più bravi destrieri che prima mordono il freno e poi ne gioiscono, e mentre prima recalcitravano contro la sella, ora si addobbano coi finimenti e tutti fieri si pavoneggiano sotto la bardatura. Dicono che sono sempre stati sottomessi, che i loro padri hanno vissuto così. Pensano di essere tenuti a sopportare il male e lasciano che gli si dia ad intendere con l’esempio, basando sull’estensione del tempo il potere di coloro che li tiranneggiano. Ma a dire il vero, gli anni non danno mai il diritto di fare il male, anzi ingigantiscono l’offesa. Questa tesi però non resta isolata. Ovviamente l’abitudine, alla lunga, non riuscirebbe a tenere in piedi un potere politico che sfruttasse continuamente e senza alcuna tregua i suoi sudditi; non riuscirebbe cioé ad impedire continue rivolte. Ma il potere è attento ad elargire di tanto in tanto panem et circenses ai suoi sudditi e, così facendo, non solo li placa, ma fa sì che questi siano stoltamente riconoscenti per questi pretesi regali. Ringraziando il ladro che restituisce loro una piccola parte del maltolto, i sudditi si abituano così a vedere nel tiranno addirittura una sorta di benefattore! Parlando degli imperatori romani, La Boétie ci dice che I tiranni elargivano un quarto di grano, un mezzo litro di vino ed un sesterzio; e allora faceva pietà sentir gridare: “Viva il re!” Gli zoticoni non si accorgevano che non facevano altro che recuperare un parte del loro, e che quello che recuperavano, il tiranno non avrebbe potuto dargliela, se prima non l’avesse presa a loro stessi. Chi avesse raccattato oggi un sesterzio, e si fosse rimpinzato al pubblico festino, benedicendo Tiberio e Nerone e la loro bella generosità, l’indomani, costretto ad abbandonare i suoi beni alla loro avarizia, i propri figli alla lussuria, il suo stesso sangue alla crudeltà di quei magnifici imperatori, non avrebbe detto una parola più di una pietra (...). Ma c’è di più. Il potere tirannico tende ad atomizzare la società, fa di tutto per impedire qualunque forma di aggregazione e comunicazione sociale e politica che non abbia a proprio fondamento l’obbedienza servile allo Stato. In questo senso il potere tirannico si presenta a sua volta come un privato, come per l’appunto l’“Uno”; ma quest’Uno è il privato più forte, talmente forte da controllare i flussi della comunicazione sociale e da riuscire a imporre ideologicamente i propri interessi privati come “bene comune”, “utilità pubblica”. Il tiranno, infatti, nel momento in cui porta avanti i propri interessi, non trascura di creare consenso intorno alla propria politica presentando i suoi interessi particolari come “interesse generale della società”. Gli imperatori romani non dimenticarono neanche di assumere di solito il titolo di tribuno del popolo, sia perché quella carica era ritenuta sacra, sia perché era stata istituita per la difesa e la protezione del popolo, e sotto la tutela dello Stato. Così si garantivano che il popolo si fidasse di più di loro (...) Oggi non fanno molto meglio quelli che compiono ogni genere di malefatta, anche importante, facendola precedere da qualche grazioso discorso sul bene pubblico e sull’utilità comune (...). L’altro strumento di creazione del consenso – dell’abitudine alla servitù volontaria nel linguaggio di La Boétie – è la creazione di quella che nella storia politica del XX secolo verrà detto il “culto della personalità” del tiranno. Intorno alla figura del tiranno, viene detto, si sono in tutti i tempi impostati una serie di meccanismi della comunicazione politica volti ad offrire di esso, coerentemente con la sua rappresentazione politica come del privato più forte (l’“Uno”), un’immagine superoministica. Il tiranno, in altri termini, cerca di presentare al popolo la sua Un’ambigua Utopia Repubblicana superiorità politica come il frutto di una originaria e particolarmente accentuata superiorità gerarchica a base naturalistica: egli “non è un uomo come tutti gli altri”. L’utilizzo della religione come instrumentum regni è in effetti, nell’analisi che fa La Boétie di tale meccanismo politico, strettamente collegato all’immagine superoministica che il tiranno vuole dare di sé; proprio perché non è un uomo comune, ma è qualcosa di “più di un uomo”, che egli ha un rapporto particolare con il divino – è un “Unto dal Signore”. La tesi della legittimità divina del potere monarchico, che recupera ed attualizza a favore del potere monarchico degli Stati accentrati l’ideologia imperiale tardoantica e medievale, viene da La Boétie impietosamente smontata e ricondotta nella sua essenza ad un tipico meccanismo ideologico volto alla creazione dell’abitudine alla servitù volontaria. Ma come fa il potere politico ad instillare così profondamente nella società l’accettazione di tali meccanismi ideologici? Come è possibile che l’ideologia dell’interesse dell’“Uno” come interesse pubblico, il culto della sua personalità spinto talvolta fino alla 15 semidivinizzazione, ecc. vengano così favorevolmente accolti dalla maggior parte dei sudditi? Ancora una volta il grande amico di Montaigne precorre una serie di indagini contemporanee di Psicologia Sociale volte ad evidenziare come il consenso, spesso, si configuri come una risposta selettiva alle pressioni alla conformità di gruppo. Innanzitutto abbiamo già detto che il potere tirannico fa di tutto per impedire la comunicazione sociale delle idee non conformiste, critiche nei confronti della propria ideologia, e veicola invece nel modo più ampio e capillare le voci consenzienti. Quel che non abbiamo ancora detto è che La Boétie individua, al di là del puro dato osservativo, il senso profondo di una tale meccanismo di censura: di fronte alla nudità del re, ogni suddito atomizzato, pur vedendola, applaude vedendo applaudire gli altri; di fronte all’apparente consenso generale, essendo pericoloso esprimere le proprie percezioni del reale agli altri (l’unico metodo possibile per comprendere quelle altrui), preferisce alla fine modificare le proprie idee. Il dissenso dei singoli individui si trasforma così paradossalmente nel consenso della massa. 1 RUBENS, Pieter Paul, L’Entrata Trionfale di Costantino a Roma Un’interessante rivisitazione di questi esperimenti, svoltisi nelle università statunitensi alla metà del XX secolo, è l’articolo di GALIANI, Riccardo, “Il consenso ingannatore”, in questo stesso numero di PORTA DI MASSA – Laboratorio Autogestito di Filosofia Epistemologia e Scienze Politico-Sociali. VOCCIA, Enrico 16 Ora, comunemente, lo zelo e l’affetto di quelli che hanno conservato, nonostante il tempo, la devozione alla libertà, per quanto siano numerosi, resta senza effetto per il fatto che non si conoscono reciprocamente: sotto il tiranno, gli viene tolta del tutto la libertà di fare, di parlare e quasi anche di pensare, e rimangono tutti isolati con le loro idee. La maggior parte degli uomini trova così vantaggioso non opporsi al tiranno, e qualcuno individua addirittura il suo vantaggio personale nella collaborazione con esso. 1 Per quanto concerne la “Teoria dei Giochi” rimandiamo a NIGEL, Howard, Paradoxes of Rationality: Theory of metagames and political behavior, Cambridge, Massachussets and London, M.I.T. Press, 1971 e al più facilmente rintracciabile D’AMORE, Bruno, “Cenni storici sulla teoria dei giochi”, in Cultura e Scuola, 66, pp. 198/208. La concezione protosistemica di La Boétie degli attori del gioco sociale e politico la si ritroverà in maniera ancora più evidente nel Leviatano di Thomas Hobbes. 2 APEL, Karl-Otto, “Il problema di una macroetica universalistica della co-responsabilità”, in Informazione Filosofica, n. 11, febbario 1993, pp. 16/23, p. 21. Non sono le truppe di cavalleria, non sono i battaglioni di fanteria, non sono le armi che difendono il tiranno. Non lo si crederà immediatamente, ma certamente è vero: sono sempre quattro o cinque che sostengono il tiranno, quattro o cinque che mantengono l’intero paese in schiavitù. È sempre successo che cinque o sei hanno avuto la fiducia del tiranno (...) Questi sei orientano così bene il loro capo, che a causa dell’associazione, egli deve essere disonesto, non solamente per le sue malefatte, ma anche per le loro. Questi sei ne hanno seicento che profittano sotto di loro, e fanno con questi seicento quello che fanno col tiranno. Questi seicento ne tengono seimila sotto di loro (...) Da ciò derivano grandi conseguenze, e chi vorrà divertirsi a sbrogliare la matassa, vedrà che, non seimila, ma centomila, milioni, si tengono legati al tiranno con quella corda (...) si trovano alla fine quasi tante persone per cui la tirannia sembra redditizia, quante quelle cui la libertà sarebbe gradita. La Boétie usa spesso espressioni spregiative nei confronti di chi si sottomette al tiranno, come pure nei confronti di chi cerca di risalire la scala gerarchica e divenire suo collaboratore più o meno diretto. Tali espressioni non ci devono però trarre in inganno: nella sua analisi la catena del vantaggio gerarchico si costituisce e funziona al di là della volontà e della moralità del singolo. La Boétie afferma ripetutamente durante tutto il suo Discorso sulla Servitù Volontaria una concezione radicalmente egualitaria degli uomini, e come abbiamo già visto nelle sue analisi rivolte all’evidenziazione di quei fenomeni che oggi conosciamo come risposte alla pressione alla conformità del gruppo, l’immagine che egli ha degli uomini inseriti nella dinamica sociale della tirannia è assai simile a quello che sarà il postulato della moderna “Teoria dei Giochi”. I sudditi appaiono cioè degli attori razionali volti a massimizzare il proprio vantaggio personale, coinvolti sotto la tirannia in un perverso gioco a somma zero, nel quale la maggior parte dei giocatori – per mancanza di informazioni essenziali – invece di perseguire il proprio vantaggio oggettivo, si accontenta timorosamente di ciò che appare loro il male minore nella situazione data: l’acquiescenza al potere. E ora risulta anche evidente perché La Boétie non consideri la democrazia di per sé alternativa alla tirannia. (...) quelli che sono posseduti da una ardente ambizione e da una notevole avidità, si ammassano attorno a lui [il tiranno] e lo sostengono per prendere parte al bottino, ed essere, sotto il gran tiranno, tirannelli anch’essi. (...) Così il tiranno rende servi i sudditi gli uni per mezzo degli altri (...) Ecco i suoi difensori, le sue guardie, i suoi alabardieri. Non che a loro stessi non capiti di subire qualche volta da lui, ma questi esseri perduti e abbandonati da Dio e dagli uomini sono contenti di sopportare il male per farne (...) É nota la famosa teoria della “Società dei due terzi” che evidenzia uno dei rischi totalitari ed oligarchici insiti nella democrazia: “la tentazione di una politica sociale che sfrutti il meccanismo maggioritario della democrazia parlamentare per soddisfare i due terzi della popolazione a scapito del terzo restante”. Ma La Boétie evidenzia un rischio ancora maggiore, insito nella catena del vantaggio gerarchico: il meccanismo della “Società dei due Terzi” è un meccanismo ricorsivo che, alla fine del processo, non soddisfa pienamente nemmeno i “due terzi” della società ma solo una ristretta oligarchia. La catena del vantaggio gerarchico infatti funziona, come abbiamo visto in precedenza, “a cascata”: di Un’ambigua Utopia Repubblicana fronte al rischio insito nella ribellione, la maggior parte degli uomini che hanno accettato di collaborare con il governo tirannico e che si trovano ai livelli minori della gerarchia vengono a loro volta ferocemente tiranneggiati dai livelli superiori. L’ unico loro vantaggio residuo consiste nel poter ferocemente tiranneggiare a loro volta i “senza potere”; ma così facendo non fanno altro che attirare su di loro l’attenzione dei dominati – che spesso e volentieri individuano in loro i veri artefici dell’oppressione – facendone salvo il tiranno e dando vita alla favola del Re Buono e dei Ministri Cattivi. É questo meccanismo che rende inessenziale il fatto che il tiranno sia tale per elezione popolare, eredità o per conquista manu militari dello stato. L’umanità intera appare nella rifles- 17 sione di La Boétie prigioniera di un gioco perverso, che appare come una malattia snaturante la sua vera e libera essenza. Come può sfuggire da questa trappola “e, per così dire, da bestia ritornare uomo”? Il vero onore tributato alla libertà dal Discorso sulla Servitù Volontaria è un invito alla disobbedienza civile. Se il fondamento della tirannia è il consenso, organizzare il suo rifiuto è l’unica strada che può spezzare l’incanto. “Siate decisi a non servire più, ed eccovi liberi”. Certo La Boétie lascia aperti molti interrogativi senza risposta sul come, nello specifico, si possa percorrere la strada della liberazione, il rifiuto del consenso. Ma la pars destruens della sua opera resta notevolissima ed è stata viatico sufficiente nei secoli per un testo scritto “in onore della libertà, contro i tiranni”. REMBRANDT, Harmenszoon van Rijn, Mosè Distrugge le Tavole della Legge VOCCIA, Enrico 18 Bibliografia Principali edizioni del Discorso sulla Servitù Volontaria • Edizione parziale senza indicazione dell’autore, senza titolo e alquanto rimaneggiata in COSMOPOLITE, Eusèbe Philadelphe, Le Réveille-Matin des Français et de leurs voisins, Bâle, edizione clandestina, 1574 (successive edizioni appariranno già lo stesso anno ad Edimburgo). • Edizione quasi completa senza indicazione dell’autore e col titolo Contr’Un in GOULART, Simon, Mémoires de l’Estat de France sous Charles Neufiesme, contenans les choses les plus notables, faites et publiées tant par les Catholiques que par ceux de la Religion, depuis le troisiesme Édit de pacification fait au mois d’Aoust 1570, jusques au règne de Henry troisiesme, Luogo di edizione sconosciuto, edizione clandestina, 1576 (Successive edizioni appariranno a Meidelbourg nel 1578 e nel 1579). • DE LA BOÉTIE, Étienne, Discours de la Servitude Volontaire ou Contr’Un, in MONTAIGNE, Michel de, Essais, Parigi e Ginevra, 1727, Londra, 1739, Parigi, 1740, Londra, 1745. • DE LA BOÉTIE, Étienne, La Servitude Volontaire, in LAFITE, Discours de Marius, plébéien et consul, traduit en prose et en vers français du latin de Salluste; suivi du Discours d’Étienne de La Boétie, ami de Montaigne et conseilleur au Parlament de Bordeaux, sur La Servitude Volontaire, traduit de français de son temps an français d’aujourd’hui, Parigi, 1789. • DE LA BOÉTIE, Étienne, Discours de la Servitude Volontaire ou Contr’Un, edizione parziale in MARÉCHAL, Sylvain, L’Ami de la Révolution ou Philippiques dédiées aux représentants de la nation, aux gardes nationales et à tous le français, Parigi, 1791, pp. 137/183 (“Supplemento” all’ottava filippica). • DE LA BOÉTIE, Étienne, Discorso di Stefano della Boétie della schiavitù volontaria o il Contra Uno, traduzione italiana di Paribelli, Cesare, Napoli, 1799. • DE LA BOÉTIE, Étienne, De la Servitude Volontaire ou Le Contr’Un, a cura di de La Mennais, Félicité, Parigi, 1835. • DE LA BOÉTIE, Étienne, De la Servitude Volontaire ou Le Contr’Un, a cura di Teste, Charle, Parigi, Delhasse,1836. • DE LA BOÉTIE, Étienne, Discours de la Servitude Volontaire, in Oeuvres complètes, a cura di Feugère, Leon, Paris, Delalain, 1846. • DE LA BOÉTIE, Étienne, La Servitude Volontaire, Parigi, Firmin/Didot, 1853. • DE LA BOÉTIE, Étienne, La Servitude Volontaire, in AA. VV., a cura di Poupart, Auguste, Tyrannie, usurpa- • • • • • • • • • • • • • • • • tion et servitude volontaire (raccolta di scritti di Vittorio Alfieri, Benjamin Constant ed Étienne de La Boétie), Bruxelles, 1853, pp. 143/170. DE LA BOÉTIE, Étienne, Discours de la Servitude Volontaire, Parigi, Dubuisson, 1863. DE LA BOÉTIE, Étienne, Il Contr’Uno o Della servitù volontaria, discorso di Stefano de La Boétie, con la lettera del signor de Montaigne circa alla ultima malattia e alla morte dell’autore, traduzione italiana di Fanfani, Pietro, Milano, Daelli, 1864. DE LA BOÉTIE, Étienne, Discours de la Servitude Volontaire, a cura di Jouast, D., Parigi, Librarie des Bibliophiles, 1872. DE LA BOÉTIE, Étienne, Discours de la Servitude Volontaire, in Oeuvres complètes, a cura di Bonnefon, Paul, Bordeaux e Paris, 1892. DE LA BOÉTIE, Étienne, Discours de la Servitude Volontaire, Bruxelles, 1899. DE LA BOÉTIE, Étienne, Discours de la Servitude Volontaire, a cura di Charrier, C., Parigi, Hatier, 1926. DE LA BOÉTIE, Étienne, Discours de la Servitude Volontaire, a cura di Laisant, C. A., Parigi, La Brochure mensuelle, 1931. DE LA BOÉTIE, Étienne, Verhandeling over de vrijwillige slavernij, traduzione olandese di de Ligt, Barthelemy, La Haye, 1933. DE LA BOÉTIE, Étienne, Estienne de la Boétie’s Discours de la Servitude Volontaire (Le Contr’Un) und seine Beziehungen zu den staatspolitischen Schrifttendes 16 Jahrunderts in Frank Reich, traduzione tedesca di Schmidt, Hans, Marburg, 1934. DE LA BOÉTIE, Étienne, Discours de la Servitude Volontaire, a cura di Gilliard, Edmond, Parigi, Porte de France, 1943. DE LA BOÉTIE, Étienne, Discours de la Servitude Volontaire ou le Contr’Un, a cura di du Raisin, 1944. DE LA BOÉTIE, Étienne, Il Contr’Uno, traduzione di Fanfani, Pietro, Firenze, Le Monnier, 1944. DE LA BOÉTIE, Étienne, Discours de la Servitude Volontaire ou le Contr’Un, Bruxelles, 1947. DE LA BOÉTIE, Étienne, Discours de la Servitude Volontaire, a cura di Hincker, François, Paris, Édition Sociales, 1971. DE LA BOÉTIE, Étienne, Speech about the Voluntary Slavery, traduzione inglese di Rothbard, Murray N., New York, 1975. DE LA BOÉTIE, Étienne, Discours de la Servitude Volontaire, a cura di Léonard, P., Parigi, Payot, 1976. Un’ambigua Utopia Repubblicana • DE LA BOÉTIE, Étienne, La Servitù Volontaria, traduzione italiana di Fanfani, Pietro, Catania, Anarchismo, 1978. • DE LA BOÉTIE, Étienne, Discorso sulla servitù volontaria, traduzione italiana di Geninazzi, Luigi, Milano, Jaca Book, 1979. • DE LA BOÉTIE, Étienne, Discorso sulla servitù volontaria, traduzione italiana di Capriglione, Franco, Napoli, Procaccini, 1993. Riflessioni sull’opera di Étienne de La Boétie • MONTAIGNE, Michel de, “Fragment d’une lettre que Monsieur le Conseiller de Montaigne escrit à Monseigneur de montaigne son père, concernant quelques particularitez qu’il remarqua en la maladie & mort de feu Monsieur de La Boétie”, 1563 (?), in Oeuvres complètes, Parigi, Gallimard, 1962, pp. 1347/ 1365 (traduzione italiana come “Lettera al padre sulla morte di Étienne de La Boétie” in DE LA BOÉTIE, Étienne, La Servitù Volontaria, op. cit., pp. 41/46). • MONTAIGNE, Michel de, Essais, Bordeaux, Millanges, 1580. • GONDI, Jean François Paul de, La Conjuration du comte de Jean-Louis de Fiesque, Parigi, 1633. • MORERI, voce “La Boétie” in Le Grand Dictionnarie Historique, Lyon, III edizione del 1683, I volume, p. 616. • BAILLET, A., Jugements des savants sur les principaux ouvrages des auteurs. Amsterdam, 1685 (II edizione 1725), II volume, p. 425; IV volume, p. 85; V volume, p. 44; VI volume, pp. 211/212. • D’AUBIGNÉ, Histoire universelle, Amsterdam, 1726, libro I, p. 670. • MARAT, The chains of the slavery, wherein the Clandestine and Villainous Attempts of Princes to ruin Liberty are pointed out and the Dreadful Scenes of Despotism Disclosed, to Which is prefixed on Adress to the Electors of Great Britain, in order to Draw their Timely Attention to the Choice of Proper Representatives in the Next Parliament, Londra, 1774. • MARAT, Les chaînes de l’esclavage (traduzione del testo inglese The chains of slavery, whwrein... Londra, 1774), Parigi, 1792. • DE LA MENNAIS, Félicitè, “Prefazione” a DE LA BOÉTIE, Étienne, De la Servitude Volontaire ou Le Contr’Un, a cura di de La Mennais, Félicité, Parigi, 1835 (traduzione italiana in DE LA BOÉTIE, Étienne, La Servitù Volontaria, op. cit., pp. 47/54). • FEUGÉRE, Leon, Étienne de La Boétie, ami de Montaigne; étude sur sa vie et ses ouvrages, précédée d’un coup d’oeil sur les origines de la littérature français, Parigi, Labitte, 1845. • PAYEN, J. F., “Note bibliographique sur Étienne de La Boétie”, in Bulletin de Bibliophile, n. 20, agosto 1846, Parigi, pp. 904/908. 19 • LEROUX, Pierre, “Il Contr’Un di Étienne de La Boétie”, in Revue Sociale, agosto/settembre 1847, pp. 169/172 (traduzione italiana in DE LA BOÉTIE, Étienne, La Servitù Volontaria, op. cit., pp. 54/59). • POUPART, Auguste, Tyrannie, usurpation et Servitude Volontaire, Bruxelles, 1853. • PAYEN, J. F., Notice bio-bibliographique sur La Boétie, l’ami de Montaigne, suivie de La Servitude Volontaire, donnée pour la première fois selon le vrai texte de l’auteur, d’après un manuscrit contemporain et authentique, Parigi, Firmin/Didot, 1853. • SAINTE-BEUVE, C. A., “Étienne de La Boétie”, in Le Moniteur, 14 novembre 1853. • PRÉVOST-PARADOL, A., “Études sur les moralistes français: Étienne de La Boétie”, in Journal des Débats, 19 dicembre 1859. • VERMOREL, Auguste, “Prefazione” a DE LA BOÉTIE, Étienne, De la Servitude Volontaire ou Le Contr’Un, Parigi, Dubuisson, 1863 (traduzione italiana in DE LA BOÉTIE, Étienne, La Servitù Volontaria, op. cit., pp. 59/65). • DEBERLY, A., Étude sur Estienne de La Boétie – Traité de la Servitude Volontaire ou Contr’Un, Amiens, 1864. • FILLON, B., La devise de La Boétie et le juriste fontenaisien Pierre Fouschier, 1872. • HABASQUE, F., Un magistrat au XVI siècle, Estienne de La Boétie, Agen, 1876. • MAGNE, E., Étude sur Estienne de La Boétie, Périgueux, 1877. • COMBES, F., Essai sur les idées politiques de Montaigne et La Boétie, Bordeaux, 1882. • BONNEFON, Paul, Estienne de La Boétie. Sa vie, ses ouvrages et ses relations avec Montaigne, Bordeaux, 1888. • BONNEFON, Paul, Montaigne et ses amis, Parigi, Colin, 1898. • BONCOUR, P.-J., Estienne de La Boétie et les origines des libertés modernes, Parigi, Alcan, 1900. • JOUVENEL, H. de, Recensione di BONCOUR, P.-J., op. cit., in Revue de Sociologie, n. 5, maggio 1900, pp. 376/379. • LANDAUER, Gustav, Die Revolution, Frankfurt, 1907, pp. 70/71 e 85/92 (traduzione italiana parziale in DE LA BOÉTIE, Étienne, La Servitù Volontaria, op. cit., pp. 66/68). • ARMAINGAUD, Dr., Montaigne pamphlétaire. L’énigme du Contr’Un, Parigi, Hachette, 1910 (volume che raccoglie vari articoli comparsi in diverse riviste tra il 1906 ed il 1909, nel quale si esponeva la tesi della paternità sostanzialmente montaigniana del Discorso sulla Servitù Volontaria). • VILLEY, Pierre, “Le véritable auteur du Discours de la Servitude Volontaire: Montaigne ou La Boétie?”, in Revue Litteraire de la France, ottobre/dicembre 1906, pp. 727/741. • DEZEIMERIS, R., Sur l’obiectif réel du Discours d’Estienne de La Boétie de La Servitude Volontaire. Remarque nouvelles, Bordeaux, 1907. 20 • BARRÉRE, Joseph, Estienne de La Boétie contre Nicolas Machiavel. Étude des mobiles qui ont déterminé Estienne de La Boétie à écrire le Discours de la Servitude Volontaire, Bordeaux, 1908. • BARRÉRE, Joseph, “La Boétie e Machiavel, d’après une publication récente. Réponse à M. le Dr. Armaingaud”, in Revue philomatique de Bordeaux et du Sud-Ouest, Bordeaux, 1909. • DELARUELLE, L., “L’inspiration antique dans le Discours de la Servitude Volontaire”, in Revue d’Histoire littéraire de la France, 1910, pp. 34/72. • BARRÉRE, Joseph, L’Humanisme et la politique dans le Discours de la Servitude Volontaire. Étude sur les origines du texte et l’objet du Discours d’Estienne de La Boétie, Parigi, Champion, 1923. • LABLÉNIE, Edmond, “L’énigme de la Servitude Volontaire”, in Revue du XVI siècle, XVII, 1930, pp. 203/227. • HAUSER, H., La modernité du XVI siècle, Parigi, Alcan, 1930. • LYONS, J. C., “Concept of the Republic in French life of th 16th Century”, in Roman Review, 1930. • DEMEURE, F., “Montaigne et La Boétie”, in Mercure de France, 1 luglio 1933. • PLATTARD, Jean, Montaigne et son temps, Parigi, Boivin, 1933, pp. 57/79. • SCHMIDT, Hans, Estienne de La Boétie Discours de La Servitude Volontaire (Le Contr’Un) und seine Beziehungen zu den staatpolitischen Schrifetn des 16 Jahrhunderts in Frankreich, Marbourg, 1934. • MICHEL, Pierre, “La Boétie, Montaigne et Machiavel”, in Dante, febbraio 1935, pp. 57/63. • MESNARD, Pierre, L’essor de la philosophie politique au XVI siècle, Parigi, 1935, IV volume, pp. 389/406. • STROWSKI, F., Montaigne, sa vie publique et privée, Parigi, 1938, pp. 72/83. • DAY, Hem, “Étienne de La Boétie”, in Cahiers mensuel de littérature et d’art, Parigi, 1939. • RIVELINE, Maurice, Montaigne et l’amitié, Parigi, Alcan, 1939. • RAT, Maurice, “Montaigne et La Boétie”, in MONTAIGNE, Michel de, Essais, Parigi, Garnier, 1942, vol. II, pp. 579/611. • PAULUS, Claude, Essai sur La Boétie, Bruxelles, 1949. • LASKI, J., A defence of Liberty Against Tyrants, Gloucester, 1963. • FRAME, D., Montaigne: A Biography, New York, 1965. • SCHMIDT, A. M., Études sur le XVI siècle, Parigi, 1967. • RICHET, D., “Autour des origines idéologiques lontaines de la Révolution française: élites et despotisme”, in Annales, 24, 1963, pp. 1/23. • PONCEAU, Amédée, Timoléon. Réflexions sur la tyrannie, Parigi, Rivère, 1970, p. 58. • ROTHBARD, Murray N., “Introduzione” a DE LA BOÉTIE, Étienne, Speech about the Voluntary Slavery, New York, 1975, pp. 9/35 (traduzione italiana in DE LA BOÉTIE, Étienne, La Servitù Volontaria, op. cit., pp. 69/82). • ABENSOUR, M., e GAUCHET, M., “Présenctation” a DE LA BOÉTIE, Étienne, Discours de la Servitude Volontaire, Parigi, Payot, 1976, pp. VII/XXXII. • CLASTRES, Pierre, “Liberté, Malencontre, Innomable”, in DE LA BOÉTIE, Étienne, Discours de la Servitude Volontaire, Parigi, Payot, 1976, pp. 229/245. • LEFORT, Claude, “Le non d’Un”, in DE LA BOÉTIE, Étienne, Discours de la Servitude Volontaire, Parigi, Payot, 1976, pp. 247/307. • LEFORT, Claude, “La naissance de l’idéologie et l’humanisme”, in Texture, 6/7, 1978. • BONANNO, Alfredo Maria, “Introduzione” a DE LA BOÉTIE, Étienne, La Servitù Volontaria, op. cit., 1978. • MONTANO, Aniello, “Atteggiamenti scettici ed esiti fideistici in M. de Montaigne”, in Atti dell’Accademia di Scienze morali e politiche, XC, 1979, pp. 541/588. • GENINAZZI, Luigi, “Introduzione” a DE LA BOÉTIE, Étienne, Discorso sulla servitù volontaria, traduzione italiana di Geninazzi, Luigi, Milano, Jaca Book, 1979. • GOYARD-FABRE, Simone, “Au tournant de l’idée de Démocratie: l’influence des Monarchomaques”, in Cahier de Philosophie politique et juridiqu, Caen, n. 1, 1982, pp. 27/48. • GOYARD-FABRE, Simone, “Le peuple et le droit d’opposition”, in Cahiers de Philosophie politique et juridique, n. 2, 1982, pp. 69/89. • GOYARD-FABRE, Simone, “Introduction” a DE LA BOÉTIE, Étienne, Discours de la Servitude Volontaire, Pargi, Flammarion, 1983, pp. 17/122. • DE CAPUA, Raimondo, “Introduzione” a DE LA BOÉTIE, Étienne, Discorso sulla servitù volontaria, traduzione italiana di Capriglione, Franco, Napoli, Procaccini, 1993. • GIANNINI, Giorgio, “Ghirigori sulla libertà. In margine al Discorso sulla Servitù Volontaria di É. de La Boétie”, in L’Osservatore Romano, quotidiano, Sabato 11 febbraio 1995. 21 Étienne de La Boétie Discorso sulla Servitù Volontaria traduzione italiana di Vincenzo Papa Nell’aver molti signori non ci vedo bene alcuno Che uno solo comandi, e che il re sia solo uno così diceva Ulisse in Omero, parlando in assemblea. Se avesse detto soltanto: Nell’aver molti signori non ci vedo bene alcuno non avrebbe potuto dire niente di meglio. Ma mentre, seguendo il filo del ragionamento, si doveva dire che il dominio di molti non può essere conveniente perché il potere di uno solo, dal momento in cui prende il titolo di signore, è duro e irragionevole, egli invece ha aggiunto: Che uno solo comandi, e che il re sia solo uno Bisognerebbe, in questo caso, scusare Ulisse, che forse doveva usare quel linguaggio per sedare la rivolta dell’esercito, adattando, credo, il suo discorso più alla circostanza che alla verità. Ma, per parlare consapevolmente, è una tremenda disgrazia essere soggetti a un padrone, della cui bontà non si può mai esser certi, visto che, quando vuole, può sempre essere malvagio; e avere più padroni significa essere altrettante volte sventurati. Non voglio per il momento discutere quella questione così dibattuta, se cioè le altre forme di pubblico potere siano migliori della monarchia, tuttavia vorrei sapere, prima di mettere in discussione quale posto la monarchia debba avere tra le forme di governo, se essa debba averne uno, poiché è difficile credere che vi sia qualcosa di pubblico in un governo in cui tutto è di uno solo. Ma questa questione va messa da parte per un’altra volta, e richiederebbe una trattazione a sé, o piuttosto si tirerebbe dietro ogni sorta di disputa politica. Per ora, vorrei soltanto comprendere come è possibile che tanti uomini, tanti paesi, tante città e nazioni tollerino talvolta un solo tiranno, che non ha altro potere che quello che gli danno; che ha il potere di nuocere loro solo finché essi possono sopportarlo; che non potrebbe far loro alcun male, se non quando essi preferiscono sopportarlo piuttosto che contraddirlo. È davvero sorprendente, e tuttavia è così comune che c’è più da dispiacersi che da stupirsi nel vedere milioni e milioni di uomini servire miserevolmente, col collo sotto il giogo, non costretti da una forza più grande, ma perché sembra siano ammaliati ed affascinati dal nome solo di uno, di cui non dovrebbero temere la potenza, visto che è solo, né amare le qualità, visto che nei loro confronti è inumano e selvaggio. La debolezza umana è tale, che dobbiamo spesso ubbidire alla forza; dobbiamo prendere tempo, non possiamo essere sempre i più forti. Dunque, se una nazione è costretta dalla forza delle armi a sottomettersi ad uno, come la città di Atene ai trenta tiranni, non bisogna stupirsi che serva, ma compiangere quella sventura; o meglio ancora, né stupirsi né lamentarsi, ma sopportare il male pazientemente e riservarsi per l’avvenire una sorte migliore. La nostra natura è tale che i comuni doveri dell’amicizia prevalgono per una buona parte della nostra vita. È ragionevole amare la virtù, apprezzare le buone azioni, essere riconoscenti verso chi ci ha fatto del bene e limitare spesso il nostro benessere per accrescere l’onore e l’utile di chi amiamo meritatamente. Così, se gli abitanti di un paese avessero trovato qualche grande personaggio che gli avesse dato 1 OMERO, Iliade, II, vv. 204205. La traduzione non è stata condotta sull’originale greco ma, come in tutti i casi che seguiranno, ha cercato di rendere la traduzione francese di La Boétie. Il contesto in cui Omero fa pronunciare ad Ulisse tali parole è il seguente: sono passati nove anni dall’inizio dell’assedio alla città di Troia e l’esercito greco, stanco e sfiduciato, è a un passo dalla rivolta; gli stessi capi achei sono in forte dissidio tra di loro per problemi di leadership. 2 Il testo originale è, a nostro avviso, contorto nell’espressione e va interpretato alla luce di quanto La Boétie dirà nel seguito. Il concetto è il seguente: è giustissimo dire che avere molti signori non arreca alcun bene, ma questo non perché siano molti bensì perché essi sono dei tiranni. Pertanto invocare un singolo tiranno contro la tirannia dei molti è insensato poiché è la la signoria politica in quanto tale che è un male, non il numero delle persone che la esercitano. Qui è evidente come l’appel3 lativo di “Uno” utilizzato da La Boétie per definire la tirannia non coincida con il potere assoluto di un singolo individuo, che è solo un caso limite di tale forma politica. Infatti tale concetto viene esemplificato storicamente attraverso il ricordo della sconfitta di Atene ad opera di Sparta, che impose nel 404 a. C. al governo della rivale sconfitta la feroce dittatura di trenta cittadini ateniesi appartenenti al partito aristocratico e filospartano. 22 1 Si tratta delle battaglie di Maratona (490 a. C.), delle Termopili (480 a. C.) e di Salamina (480 a. C.). Milziade e Temistocle erano gli strateghi ateniesi vittoriosi sugli eserciti e sulle flotte persiane rispettivamente a Maratona e a Salamina; Leonida era il generale spartano divenuto celebre per la sua morte eroica avvenuta al passo delle Termopili, dove egli, con altri trecento soldati di Sparta, si sacrificò per ritardare l’avanzata dell’esercito persiano e dare tempo agli eserciti greci di riorganizzarsi. DE LA BOÉTIE, Étienne prova di una grande previdenza nel salvaguardarli, di un grande coraggio nel difenderli, di una grande cura nel governarli; se, da quel momento, essi si abituassero ad obbedirgli ed a fidarsene fino al punto di riconoscergli alcuni privilegi, non so se sarebbe una cosa saggia, visto che lo si toglierebbe da dove faceva bene, per innalzarlo dove potrebbe far male. Ma certo, non si potrebbe fare a meno di amare e di non temere alcun male da chi si è ricevuto solo bene. Ma, buon Dio! che storia è questa? Come diremo che si chiama? Che disgrazia è questa? Quale vizio, o piuttosto, quale disgraziato vizio? Vedere un numero infinito di persone non obbedire, ma servire; non essere governati, ma tiranneggiati; senza che gli appartengano né beni né parenti, né mogli né figli, né la loro stessa vita! Sopportare i saccheggi, le licenziosità, le crudeltà, non di un esercito, non di un’orda barbara, contro cui bisognerebbe difendere innanzitutto il proprio sangue e la propria vita, ma di uno solo. E non di un Ercole né di un Sansone, ma di un solo omuncolo, molto spesso il più vile ed effeminato della nazione; non avvezzo alla polvere delle battaglie, ma a malapena alla sabbia dei tornei; non solo incapace di comandare gli uomini con la forza, ma in imbarazzo già a servire vilmente l’ultima donnicciola! Chiameremo questa vigliaccheria? diremo che coloro che servono sono codardi e deboli? Se due, tre o quattro persone non si difendono da un’altra, questo è strano, ma tuttavia possibile; si potrà ben dire giustamente che è mancanza di coraggio. Ma se cento, mille sopportano uno solo, non si dovrà dire che non vogliono, che non osano attaccarlo, e che non è vigliaccheria, ma piuttosto spregevolezza ed abiezione? Se si vedono, non cento, non mille uomini, ma cento paesi, mille città, un milione di uomini non assalire uno solo, che li tratta nel migliore dei casi come servi e schiavi, come potremmo chiamare questa? Vigliaccheria? Ora, naturalmente in tutti i vizi ci sono dei limiti, oltre i qua- li non possono andare: due uomini, e forse anche dieci, possono temere uno solo; ma se mille, un milione, mille città non si difendono da uno solo questa non è vigliaccheria, perché non arriva fino a questo punto; proprio come il coraggio non arriva fino al punto che uno solo dia la scalata ad una fortezza, assalga un esercito, conquisti un regno. Dunque quale vizio mostruoso è mai questo che non merita nemmeno il nome di vigliaccheria, e per il quale non si trova un termine sufficientemente offensivo, che la natura rinnega di aver generato e la lingua rifiuta di nominare? Si mettano cinquantamila uomini armati da una parte e altrettanti dall’altra; li si schieri in battaglia e li si faccia scontrare, gli uni liberi, combattenti per la loro libertà, gli altri per toglierla loro. A chi si pronosticherebbe la vittoria? Chi andrà al combattimento con più coraggio, quelli che sperano come ricompensa di salvaguardare la loro libertà, o quelli che come contropartita dei colpi inferti o ricevuti possono aspettarsi solo la schiavitù altrui? Gli uni hanno sempre davanti agli occhi la felicità della vita passata e l’aspettativa di una gioia simile per l’avvenire; non pensano a quel poco che patiscono il tempo che dura una battaglia, ma a quello che dovranno sopportare per sempre loro stessi, i loro figli e tutta la discendenza. Gli altri non hanno niente che li imbaldanzisca, se non un pizzico di bramosia che si smussa subito contro il pericolo e che non può essere tanto ardente da non spegnersi, forse, alla minima goccia di sangue che esca dalle loro ferite. Nelle battaglie così famose di Milziade, Leonida e Temistocle, avvenute duemila anni fa e che ancora oggi sono così presenti nella memoria dei libri e degli uomini come fosse accaduto l’altro ieri, che furono combattute in Grecia per il bene dei Greci e come esempio per il mondo intero; ebbene, cosa diede ad un così piccolo numero di uomini, quali erano i Greci, non il potere, ma il coraggio di resistere alla forza di navi che riempivano il mare intero, di scon- Discorso sulla Servitù Volontaria figgere tanti popoli, talmente numerosi che le truppe dei Greci non avrebbero, eventualmente, neanche potuto fornire dei comandanti agli eserciti nemici? In quei giorni gloriosi non si svolgeva tanto la battaglia dei Greci contro i Persiani, quanto la vittoria della libertà sul dominio, della lealtà sulla bramosia. É straordinario sentir parlare del coraggio che la libertà mette nel cuore di chi la difende; ma ciò che avviene in tutti i paesi, fra tutti gli uomini, tutti i giorni, cioè che un uomo ne opprima centomila e li privi della loro libertà, chi potrebbe crederlo se lo si sentisse solo raccontare e non vederlo? E se avvenisse solo in paesi stranieri ed in terre lontane, e lo si raccontasse, chi non penserebbe che sia piuttosto una favola e una invenzione e non una cosa vera? Per di più questo tiranno solo, non c’è bisogno di combatterlo, non occorre sconfiggerlo, è di per sé già sconfitto, basta che il paese non acconsenta alla propria schiavitù. Non bisogna togliergli niente, ma non concedergli nulla. Non occorre che il paese si preoccupi di fare niente per sé, a patto di non fare niente contro di sé. Sono dunque i popoli stessi che si lasciano o piuttosto si fanno tiranneggiare, poiché smettendo di servire ne sarebbero liberi. È il popolo che si assoggetta, che si taglia la gola e potendo scegliere fra l’essere servo e l’essere libero, lascia la libertà e prende il giogo; che acconsente al suo male, o piuttosto lo persegue. Se gli costasse qualcosa recuperare la libertà, non lo inciterei, sebbene l’uomo non dovrebbe avere niente di più caro che affermare il suo diritto naturale e, per così dire, da bestia ritornare uomo. Ma non pretendo lui un tale coraggio; gli concedo pure che preferisca una certa sicurezza di vivere miserabilmente ad una incerta speranza di vivere nell’agiatezza. Ma se per avere la libertà basta desiderarla, se c’è solo bisogno di un semplice atto di volontà, quale popolo al mondo potrebbe valutarla ancora troppo cara, potendola ottenere solo con un desiderio, e che lesini la volontà di recuperare il bene che do- 23 vrebbe riacquistare a prezzo del proprio sangue, e la cui perdita dovrebbe rendere insopportabile la vita e desiderabile la morte a tutte le persone dignitose? Certo, come il fuoco di una piccola scintilla diviene grande e si rafforza sempre, e più trova legno, più è pronto a bruciarne, e se non vi si mette dell’acqua per spegnerlo, basta non metterci più legno, non avendo più da consumare, si consuma da sé, diviene senza forza e non è più fuoco; allo stesso modo i tiranni, più saccheggiano, più esigono, più rovinano e distruggono, più gli si dà, più li si serve, tanto più si rafforzano e divengono sempre più forti e più rinvigoriti per annientare e distruggere tutto; ma se non gli si dà niente, se non gli si obbedisce, senza combattere, senza colpire, restano nudi e sconfitti e non sono più niente, o sono come il ramo che diviene secco e morto quando la radice non ha più linfa e nutrimento. I coraggiosi non temono il pericolo per ottenere ciò che desiderano. Gli avveduti non rifiutano la fatica. I vili e gli ottusi non sanno sopportare il male né riconquistare il bene: si limitano a desiderarlo, e la virtù di aspirarvi gli è negata dalla loro vigliaccheria, restandogli per natura il desiderio di averlo. Questo desiderio, questa volontà di aspirare a tutte le cose che, una volta ottenute, li renderebbero felici e contenti, è comune ai saggi ed agli stolti, ai coraggiosi ed ai codardi. C’è una sola cosa di cui, non so perché, manca agli uomini il desiderio naturale: è la libertà, che pure è un bene così grande e piacevole, che una volta perduto, tutti i mali vengono uno dietro l’altro, e perfino i beni che restano dopo di lei perdono completamente gusto e sapore, corrotti dalla servitù. Solo la libertà, gli uomini non la desiderano perché, così pare, se la desiderassero essi l’otterrebbero; come se rifiutassero di fare questa conquista solo perché troppo facile. Poveri e miseri popoli insensati, nazioni ostinate nel vostro male e cieche nel vostro bene, vi lasciate strappare sotto gli occhi la parte migliore DE LA BOÉTIE, Étienne 24 1 Il termine è utilizzato da La Boètie nel senso stretto, specifico e originario di “pensatori dell’accademia”, ovvero Platone ed i suoi seguaci. Per comprendere la specifica attenzione alle posizioni platoniche va ovviamente tenuto conto del grande fiorire (e della relativa fama) che ebbe la rinascita neoplatonica fiorentina del XVI secolo. del vostro reddito, saccheggiare i vostri campi, derubare le vostre case e spogliarle dei mobili antichi e di famiglia! Vivete in modo da non poter vantare niente che sia vostro; e ciònonostante sembrerebbe per voi un grande favore tenere in affitto i vostri beni, le vostre famiglie e le vostre vite. E tutto questo danno, questa disgrazia, questa rovina, non vi viene da molti nemici, ma bensì da un solo nemico, da colui che voi fate così potente com’è, per il quale andate coraggiosamente in guerra, per la cui grandezza non rifiutate certo di affrontare la morte. Colui che tanto vi domina non ha che due occhi, due mani, un corpo, non ha niente di più dell’uomo meno importante dell’immenso ed infinito numero delle nostre città, se non la superiorità che gli attribuite per distruggervi. Da dove ha preso tanti occhi, con i quali vi spia, se non glieli offrite voi? Come può avere tante mani per colpirvi, se non le prende da voi? I piedi con cui calpesta le vostre città, da dove li ha presi, se non da voi? Come fa ad avere tanto potere su di voi, se non tramite voi stessi? Come oserebbe aggredirvi, se non avesse la vostra complicità? Cosa potrebbe farvi se non foste i ricettatori del ladrone che vi saccheggia, complici dell’assassino che vi uccide e traditori di voi stessi? Seminate i vostri frutti, affinché ne faccia scempio. Riempite ed ammobiliate le vostre case, per rifornire le sue ruberie. Allevate le vostre figlie perché abbia di che inebriare la sua lussuria. Allevate i vostri figli, perché, nel migliore dei casi, li porti alla guerra e li conduca al macello, li faccia ministri delle sue bramosie, ed esecutori delle sue vendette. Vi ammazzate di fatica perché possa trattarsi delicatamente nei suoi lussi e voltolarsi nei suoi piaceri sporchi e volgari. Vi indebolite per renderlo più forte e rigido nel tenervi la briglia più corta. E di tutte queste indegnità, che neanche le bestie potrebbero accettare o sopportare, voi potreste liberarvi se provaste, non dico a liberarvene, ma solo a volerlo fare. Siate decisi a non servire più, ed eccovi liberi. Non voglio che lo scacciate o lo scuotiate, ma solo che non lo sosteniate più, e lo vedrete, come un grande colosso al quale è stata tolta la base, piombare giù per il suo stesso peso e rompersi. Certo i medici consigliano giustamente di non toccare le ferite incurabili, ed io non mi comporto saggiamente volendo dare consigli al popolo, che ha perso da lungo tempo ogni consapevolezza, e che, visto che non sente più il suo male, dimostra che la sua malattia è mortale. Cerchiamo dunque per ipotesi, di capire come si sia così profondamente radicata questa ostinata volontà di servire, da far sembrare che lo stesso amore della libertà non sia così naturale. In primo luogo, credo che sia fuori dubbio che, se vivessimo secondo i diritti che la natura ci ha dato e secondo gli insegnamenti che ci rivolge, saremmo naturalmente obbedienti ai genitori, seguaci della ragione e servi di nessuno. Tutti gli uomini sono testimoni, ciascuno per sé, dell’obbedienza che ognuno, senz’altro impulso che quello naturale, porta a suo padre e a sua madre. Quanto alla questione se la ragione sia innata o meno, questione dibattuta a fondo dagli accademici ed affrontata da ogni scuola di filosofi, per il momento non penso di sbagliare dicendo che nell’animo nostro c’è un seme naturale di ragione, che, coltivato dal buonsenso e dal costume, fiorisce in virtù e, al contrario, non riuscendo spesso a resistere contro i vizi acquisiti, si isterilisce soffocato. Ma di sicuro, se mai c’è qualcosa di chiaro ed evidente nella natura, che è impossibile non vedere, è che la natura, ministro di Dio, la governatrice degli uomini, ci ha fatti tutti della stessa forma, e come sembra, allo stesso stampo, perché possiamo riconoscerci reciprocamente come compagni o meglio come fratelli. E se, dividendo i doni che ci faceva, ha avvantaggiato nel corpo o nella mente gli uni più degli altri, non ha inteso per questo metterci al mondo come in recinto da combattimento, e non ha mandato quaggiù né i più forti né i più furbi come briganti armati in Discorso sulla Servitù Volontaria una foresta, per tiranneggiare i più deboli. Ma, piuttosto, bisogna credere che la natura dando di più agli uni e di meno agli altri, abbia voluto lasciar spazio all’affetto, perché avesse dove esprimersi, avendo gli uni potere di dare aiuto, gli altri bisogno di riceverne. Da quando questa buona madre ci ha dato a tutti la terra intera per dimora, ci ha alloggiati tutti in una certa misura nella stessa casa, ci ha formati sullo stesso modello, perché ognuno potesse specchiarsi e quasi riconoscersi l’uno nell’altro; se ci ha dato a tutti questo gran dono della voce e della parola per familiarizzare e fraternizzare di più, e per reciproca e comune dichiarazione dei nostri pensieri, arrivare ad una comunione delle nostre volontà; se ha cercato con ogni mezzo di stringere così saldamente il vincolo della nostra alleanza e associazione; se ha mostrato in ogni cosa, che voleva farci non solo tutti uniti ma addirittura una cosa sola, non bisogna dubitare che siamo naturalmente liberi, perché siamo tutti compagni, e a nessuno può venire in mente che la natura abbia messo qualcuno in servitù, dopo averci messo tutti insieme. Ma, in fondo, è del tutto inutile discutere se la libertà sia un dato di natura, visto che non si può tenere nessuno in schiavitù senza fargli torto, e che non c’è niente al mondo di così contrario alla natura, che è tutta razionale, dell’ingiustizia. Se ne deve concludere che la libertà è un dato naturale, e per ciò stesso, a mio avviso, che non solo siamo nati in possesso della nostra libertà, ma anche con la volontà di difenderla. Ora, se per caso avessimo qualche dubbio in proposito e fossimo tanto imbastarditi da non poter riconoscere i nostri beni né le nostre inclinazioni innate, vi dovrò trattare come meritate, e far salire, per così dire, le bestie in cattedra, per insegnarvi la vostra natura e condizione. Gli animali, per Dio! se gli uomini non fanno troppo i sordi, gli gridano: VIVA LA LIBERTÀ! Molti muoiono appena sono catturati: come il pesce muore appena fuori dall’acqua, così 25 quelli chiudono gli occhi e non vogliono sopravvivere alla loro libertà naturale. Se gli animali avessero tra loro qualche gerarchia, farebbero dell’esser liberi la loro nobiltà. Gli altri, dai più grandi ai più piccoli, quando sono catturati, fanno un resistenza così accanita con unghia, corna, becco e zampe, da dimostrare a sufficienza quanto gli sia caro ciò che stanno per perdere. Poi, una volta catturati, ci danno tanti segni visibili della consapevolezza che hanno della loro disgrazia, che è facile osservare che per loro è più un languire che un vivere, e che continuano la loro vita più per rimpiangere il felice stato perduto che perché soddisfatti della prigionia. Cos’altro vuol dire l’elefante che, essendosi difeso fino allo stremo, non vedendo altra possibilità e sul punto di essere catturato, sfonda le sue mascelle e rompe i suoi denti contro un albero, se non che il grande desiderio che ha di restare libero com’è, gli dà dell’intelligenza e decide di mercanteggiare con i cacciatori barattando l’avorio dei suoi denti come riscatto per la sua libertà? Noi adeschiamo il cavallo fin dalla sua nascita per addomesticarlo a servire; eppure non lo sappiamo blandire in modo tale che, al momento di domarlo, non morda il freno e non scalci contro lo sperone, come (parrebbe) per mostrare alla natura e testimoniare almeno in quel modo, che se serve, non è per sua volontà, ma per nostra costrizione. Cos’altro dire? Anche i buoi gemono sotto il peso del giogo E gli uccelli in gabbia si lamentano, come ho detto in altre occasioni, per passatempo nelle mie rime francesi. Perché scrivendoti, o Longa, non esito a mescolare i miei versi, che non ti ho mai letto, perché se tu avessi mostrato di apprezzarli, sarei stato considerato un vanaglorioso. Così dunque, se ogni essere dotato di sensibilità, dal momento che ce l’ha, avverte il male della sottomissione ed insegue la libertà, se le bestie, che pure sono fatte per servire l’uomo, possono adattarsi a 1 Queste rime non sono state ritrovate nella biblioteca di Montaigne: che si tratti di una perdita accidentale o della censura da parte dell’amico (che, lo ricordiamo, non pubblicò il Discorso sulla Servitù Volontaria) di rime di contenuto politico per ragioni di quieto vivere e/o perché in tal modo riteneva di rispettare meglio la memoria dell’amico scomparso non abbiamo alcun modo di saperlo. 2 Il manoscritto di Mesmes da cui è stata sostanzialmente ricavata la presente edizione del Discorso dulla Servitù Volontaria era dedicata per l’appunto a Longa, predecessore di La Boètie al Parlamento di Bordeaux. 26 1 L’episodio biblico cui allude La Boétie è quello che viene descritto nel I libro di Samuele, 8. Fra l’altro le parole con cui il vecchio Samuele cerca inutilmente di scoraggiare il popolo di Israele dall’insana idea di sottomettersi volontariamente ad un re ricordano vari passaggi del Discorso sulla Servitù Volontaria: “Prenderà i vostri figli e li destinerà in parte ai suoi carri e ai suoi cavalli; in parte perché corrano davanti al suo cocchio. Altri li farà capi di migliaia, di centinaia e di cinquantine; altri infine li destinerà a coltivare i suoi campi, a mietere le sue messi, a preparargli armi da guerra ed il necessario per i suoi carri. Anzi prenderà pure le vostre figlie, perché facciano da profumiere, da cuoche e da panettiere. Prenderà i migliori dei vostri campi, dei vostri vigneti e dei vostri oliveti, per darli ai suoi ministri. Preleverà le decime sulle vostre messi e sulle vostre vigne, per darle ai suoi cortigiani ed ai suoi ufficiali. Prenderà invece i vostri servi e le vostre serve, i vostri bovi migliori o i vostri asini, e se ne servirà per i suoi lavori. Esigerà infine la decima sui vostri greggi e voi stessi diventerete suoi schiavi. Allora vi lamenterete del re, che vi siete scelto, tuttavia il Signore non vi esaudirà.” 2 Pisistrato impose la sua tirannia ad Atene nel VI secolo a. C.; l’Alessandro di cui si è parlato è ovviamente Alessandro Magno, che nel IV secolo a. C. conquisterà la Grecia e la incorporerà nell’Impero Macedone. DE LA BOÉTIE, Étienne servire solo manifestando il desiderio contrario, quale evento sventurato ha potuto snaturare talmente l’uomo, l’unico nato davvero per vivere liberamente, e fargli perdere il ricordo del suo stato primitivo ed il desiderio di riacquistarlo? Vi sono tre tipi di tiranni: gli uni ottengono il regno attraverso l’elezione del popolo, gli altri con la forza delle armi, e gli altri ancora per successione ereditaria. Chi lo ha acquisito per diritto di guerra si comporta in modo tale da far capire che si trova, diciamo così, in terra di conquista. Coloro che nascono sovrani non sono di solito molto migliori, anzi essendo nati e nutriti in seno alla tirannia, succhiano con il latte la natura del tiranno, e considerano i popoli che sono loro sottomessi, come servi ereditari; e, secondo la loro indole di avari o prodighi, come sono, considerano il regno come loro proprietà. Chi ha ricevuto il potere dello Stato dal popolo dovrebbe essere, forse, più sopportabile e lo sarebbe, penso, sennonché appena si vede innalzato al di sopra degli altri, lusingato da quel non so che chiamato grandezza, decide di non spostarsi più da lì. Di solito, costui decide di consegnare ai suoi figli il potere che il popolo gli ha lasciato; e dal momento che questi hanno concepito quest’ idea, è strano di quanto superino gli altri tiranni in ogni genere di vizio e perfino di crudeltà, non trovando altri mezzi per garantire la nuova tirannia che estendere la servitù ed allontanare talmente i loro sudditi dalla libertà, che, per quanto vivo, gliene si possa far perdere il ricordo. A dire il vero, quindi, esiste tra loro qualche differenza, ma non ne vedo affatto una possibilità di scelta; e per quanto i metodi per arrivare al potere siano diversi, il modo di regnare è quasi sempre simile: gli eletti trattano i sudditi come se avessero catturato dei tori da domare; i conquistatori li considerano una loro preda; i successori pensano di farne dei loro schiavi naturali. Ma a proposito, se per caso nascessero oggi delle persone del tutto nuo- ve, non abituate alla sottomissione, né attratte dalla libertà, e che non conoscessero cos’è l’una e cos’è l’altra, se non a stento i nomi; se gli si prospettasse di essere servi o di vivere liberi, quali regole sceglierebbero? Senz’altro preferirebbero obbedire alla sola ragione anziché servire un uomo; a meno che non si tratti di quelli d’Israele, i quali, senza costrizione né bisogno, istituirono un tiranno: così non leggo mai la storia di quel popolo senza provarne risentimento, quasi fino a diventare così disumano da rallegrarmi dei tanti mali che gliene derivarono. Certamente tutti gli uomini, finché conservano qualcosa di umano, se si lasciano assoggettare, o vi sono costretti o sono ingannati: costretti dalle armi straniere, come Sparta o Atene dalle forze di Alessandro, o dalle fazioni, come il governo di Atene prima di cadere nelle mani di Pisistrato. Spesso gli uomini perdono la libertà con l’inganno, ed in questo, sono più frequentemente ingannati da se stessi di quanto non siano sedotti dagli altri: così il popolo di Siracusa, principale città della Sicilia (mi dicono che oggi si chiama Saragozza), oppresso dalle guerre, badando sconsideratamente solo al pericolo immediato, innalzò Dioniso, primo tiranno, e gli diede l’incarico di guidare l’esercito, non accorgendosi di averlo reso così potente che quel furfante, ritornato vittorioso, come se avesse vinto non i suoi nemici ma i suoi concittadini, si fece da capitano re e da re tiranno. È incredibile come il popolo, appena è assoggettato, cade rapidamente in un oblio così profondo della libertà, che non gli è possibile risvegliarsi per riottenerla, ma serve così sinceramente e così volentieri che, a vederlo, si direbbe che non abbia perduto la libertà, ma guadagnato la sua servitù. È vero che, all’inizio, si serve costretti e vinti dalla forza, ma quelli che vengono dopo servono senza rimpianti e fanno volentieri quello che i loro predecessori avevano fatto per forza. È così che gli uomini che nascono sotto il giogo, e poi allevati ed educati nella servitù, Discorso sulla Servitù Volontaria senza guardare più avanti, si accontentano di vivere come sono nati, e non pensano affatto ad avere altro bene né altro diritto, se non quello che hanno ricevuto, e prendono per naturale lo stato della loro nascita. E tuttavia non c’è erede così prodigo e trascurato da non dare un’occhiata qualche volta ai registri di famiglia, per vedere se gode di tutti i diritti di successione, o se si è tramato qualcosa contro di lui o contro il suo predecessore. Ma è certo che la consuetudine, che ha una grande influenza su di noi, ne ha soprattutto nell’insegnarci a servire e, come si dice di Mitridate che si abituò a bere il veleno, nell’insegnarci ad ingoiare ed a non trovare amaro il veleno della servitù. Non si può dire che la natura non abbia un ruolo importante nel condizionare la nostra indole in un senso o nell’altro; ma bisogna altresì confessare che ha su di noi meno potere della consuetudine: infatti l’indole naturale, per quanto sia buona, si perde se non è curata; e l’educazione ci plasma sempre alla sua maniera, comunque sia, malgrado l’indole. I semi del bene che la natura mette in noi sono così piccoli e fragili da non poter sopportare il minimo impatto di un’educazione contraria; si conservano con più difficoltà di quanto si rovinino, si disfino e si riducano a niente: né più né meno che gli alberi da frutta, che hanno tutti qualche qualità specifica, che conservano bene se li si lascia crescere, ma che perdono subito per portare altri frutti estranei e non i loro, secondo gli innesti. Le erbe hanno ciascuna la loro proprietà, la loro qualità naturale e la loro specificità; ma tuttavia il gelo, il tempo, il terreno o la mano del giardiniere vi aggiungono o diminuiscono gran parte della loro virtù, per cui la pianta vista in un posto, è impossibile riconoscerla in un altro luogo. Chi vedesse i Veneziani, un pugno di uomini che vivono così liberamente che il più misero di loro non vorrebbe essere il re, nati e cresciuti in maniera tale che non riconoscono altra ambizione se non quella di gareggiare a chi meglio conserverà gelosamente la li- 27 bertà, educati sin dalla culla in maniera tale che non scambierebbero una briciola della loro libertà con tutte le felicità della terra; chi avrà visto queste persone e partendo di là se ne andrà nelle terre di colui che chiamiamo il Gran Signore, vedendo lì delle persone nate solo per servirlo e morire per mantenere la sua potenza, penserebbe che questi e gli altri abbiano la stessa natura, o piuttosto non penserebbe che, uscendo da una città di uomini, sia entrato in un parco di animali? Si racconta che Licurgo, il legislatore di Sparta, aveva allevato due cani, tutti e due fratelli ed allattati dello stesso latte, l’uno ingrassato in cucina, l’altro abituato ai campi e al suono della tromba e del corno, e volendo mostrare al popolo spartano che gli uomini sono come li fa l’educazione, mise i due cani in piazza, e tra loro una scodella di zuppa ed una lepre: l’uno corse alla zuppa e l’altro alla lepre. “Eppure – disse – sono fratelli.”. Egli dunque, con le sue leggi e la sua politica, educò così bene gli Spartani, che ognuno di loro preferì morire mille volte piuttosto che riconoscere altro signore che il re e la ragione. Vorrei ricordare un discorso che tenne una volta uno dei favoriti di Serse, il gran re dei Persiani, con due Spartani. Mentre Serse preparava il suo grande esercito per conquistare la Grecia, inviò i suoi ambasciatori per le città greche a chiedere dell’acqua e della terra: era la maniera che i Persiani avevano di intimare alle città di arrendersi. Non ne inviò né ad Atene né a Sparta perché quelli che erano stati spediti da Dario, suo padre, gli Ateniesi e gli Spartani avevano gettato gli uni nelle fosse e gli altri nei pozzi, dicendo loro che prendessero quanta acqua e terra volessero per portarla al loro principe. Quegli uomini non potevano sopportare che si attentasse alla loro libertà neanche con la minima parola. Per averli trattati così gli Spartani si avvidero di essere incorsi nell’ira degli dei, specie di Taltibio, dio degli ambasciatori: perciò per placarlo, presero la decisione di inviare a Serse due loro 1 La libertà regnante presso la Repubblica Veneta era in alta reputazione tra gli umanisti rinascimentali. Si trattava di un mito, dato il carattere aristocratico ed autoritario dello Stato Veneto, ma La Boètie lo accetta senza riserve. Lo stesso Montaigne testimonia che il suo amico avrebbe preferito di gran lunga nascere a Venezia piuttosto che a Sarlat: cfr. MONTAIGNE, Michel de, Essias, Paris, Garnier, 1962, p. 212. 2 “Gran Signore” era l’appellativo che l’Occidente attribuiva al Sultano di Turchia, considerato come il simbolo vivente per antonomasia della tirannia politica. 28 1 La Boétie trae l’episodio raccontato da ERODOTO, Le Storie. Cfr. p. e. la traduzione italiana di IZZO D’ACCINNI, Augusta, Firenze, Sansoni, 1951, pp. 690/691. 2 Pensatore e statista romano del I secolo a. C. di ispirazione stoica. Oppostosi al protoimperialismo di Cesare in nome degli ideali dell’antica Repubblica Romana, dopo la sconfitta di Tapso dell’anno 46 a. C., si diede la morte trafiggendosi il petto con la sua spada. Silla (136/78 a. C.) fu il capo 3 indiscusso del partito aristocratico romano che istituì la sua feroce dittatura in opposizione al partito filopopolare. Nella storiografia filorepubblicana d’epoca imperiale la sua figura appare come quella del tiranno per antonomasia. I Cimmeri omerici erano un 4 popolo leggendario che abitava un paese dove il sole non sorgeva mai; Ulisse si recò nel loro paese per evocare i morti ed interrogare l’indovino Tiresia. I Cimmeri storici, invece, erano una popolazione originaria del Chersoneo Taursico e delle regioni adiacenti fino al Tyras che invase alla fine del VII secolo a. C. la Lidia. Cfr. ERODOTO, op. cit., pp. 8 e nota, 14 e nota, 15 e 74. La Boétie cita però il fatto che tale popolo vivesse giorni e notti di sei mesi l’uno; egli li confonde perciò molto probabilmente con i popoli antartici. Simone Goyard-Fabre ha voluto vedere in questo accenno ad un paese dove il sole si mostra altrimenti che a noi una reminescenza del mito platonico della caverna. Cfr. GOYARD-FABRE, Simone, “Introduction” al Discours de la Servitude Volontaire, Paris, Flammarion, 1983, p. 150, nota 53. DE LA BOÉTIE, Étienne concittadini per presentarsi a lui, che disponesse di loro secondo la sua volontà, per vendicare gli ambasciatori che essi avevano ucciso a suo padre. Due Spartani, chiamati l’uno Sperto e l’altro Buli, si offrirono di loro spontanea volontà per questo risarcimento. Infatti vi si recarono, e sulla strada arrivarono al palazzo di un Persiano chiamato Indarne, che era luogotenente del re in tutte le città asiatiche della costa. Questi li accolse con tutti gli onori, fece loro una magnifica accoglienza e, dopo varie discussioni che andavano da una cosa all’altra, chiese loro perché rifiutassero così ostinatamente l’amicizia del re. “Vedete, Spartani, – disse – giudicate dalla mia persona quanto il re sappia onorare coloro che lo meritano, e pensate che se gli apparteneste, egli farebbe lo stesso: se vi avesse conosciuto, non c’è nessuno fra voi che non sarebbe signore di una città della Grecia.” “Riguardo a questo, Indarne, tu non sapresti darci un buon consiglio – dissero gli Spartani – perché hai provato il bene che ci prometti, ma non quello di cui noi godiamo: hai provato il favore del re; ma non sai niente di quale gusto abbia la libertà e quanto sia dolce. Se ne avessi provato il gusto, tu stesso ci consiglieresti di difenderla, non con la lancia e lo scudo, ma con le unghie e con i denti.” Solo lo Spartano diceva quello che occorreva dire, ma certamente l’uno e l’altro parlavano come erano stati educati: poiché era impossibile che il Persiano avesse rimpianto della libertà, non avendola mai avuta, né che lo Spartano sopportasse la soggezione, avendo gustato la libertà. Catone l’Uticense, ancora ragazzo e sottoposto alla verga, andava e veniva spesso dalla casa di Silla il dittatore, sia perché per la casata cui apparteneva non gli si sbarrava mai la porta, e sia perché erano parenti stretti. Era sempre in compagnia del suo maestro, quando ci andava, secondo l’abitudine dei ragazzi di nobile famiglia. Egli si accorse che, nella casa di Silla, in sua presenza o con il suo consenso, alcuni venivano imprigionati, altri condannati; chi era esiliato, chi strangolato; uno chiedeva la confisca dei beni di un cittadino, l’altro la testa. Insomma, tutto si svolgeva non come a casa di un pubblico ufficiale, ma come a casa di un tiranno del popolo, e non come in un tribunale di giustizia, ma in un laboratorio di tirannia. Allora il ragazzo disse al suo maestro: “Perché non mi date un pugnale? Lo nasconderò sotto il vestito: entro spesso nella camera di Silla prima che si sia alzato, ho il braccio sufficientemente forte per sbarazzarne la città.” Ecco un discorso che appartiene davvero a Catone: un inizio degno della sua morte. Ed anche se non si dicessero né il suo nome né il suo paese, e si raccontasse soltanto il fatto così com’è, la cosa stessa parlerebbe da sé e si penserebbe subito che era Romano e nato a Roma, quando la città era libera. Perché dico tutto questo? Non certo perché io ritengo che il paese o il territorio contino qualche cosa, poiché in tutti i paesi la soggezione è amara e piace l’esser libero; ma perché sono dell’avviso che si debba avere pietà per coloro che dalla nascita si sono trovati il giogo al collo, oppure che li si scusi, o meglio che gli si perdoni, se, non avendo visto neanche l’ombra della libertà e non avendone alcun sentore, non si accorgono di quale danno derivi dall’essere schiavi. Se ci fossero dei paesi, come racconta Omero riguardo ai Cimmeri, dove il sole si mostra diversamente che da noi, e dopo averli illuminati per sei mesi continui, li lascia sonnecchianti nell’oscurità per l’altra metà dell’anno, coloro che nascessero durante quella lunga notte, se non avessero mai sentito parlare della luce, si stupirebbero oppure forse, non avendo visto il giorno, si abituerebbero alle tenebre in cui sono nati, senza desiderare la luce? Non si rimpiange mai quello che non si ha mai avuto, ed il rimpianto viene solo dopo il piacere, ed il ricordo della gioia passata accompagna sempre la conoscenza del male. La natura dell’uomo è proprio quella di essere libero e di volerlo essere, ma la sua indole è tale che naturalmente Discorso sulla Servitù Volontaria conserva l’inclinazione che gli dà l’educazione. Diciamo dunque che all’uomo risultano naturali tutte le cose alle quali si educa e si abitua; ma gli è davvero innato solo quello a cui spinge la natura semplice e non alterata: così la prima ragione della servitù volontaria è l’abitudine: come i più bravi destrieri che prima mordono il freno e poi ne gioiscono, e mentre prima recalcitravano contro la sella, ora si addobbano coi finimenti e tutti fieri si pavoneggiano sotto la bardatura. Dicono che sono sempre stati sottomessi, che i loro padri hanno vissuto così. Pensano di essere tenuti a sopportare il male e lasciano che gli si dia ad intendere con l’esempio, basando sull’estensione del tempo il potere di coloro che li tiranneggiano. Ma a dire il vero, gli anni non danno mai il diritto di fare il male, anzi ingigantiscono l’offesa. Si trovano sempre alcuni di carattere più fiero, che sentono il peso del giogo e non possono trattenersi dallo scuoterlo; che non si abituano mai alla soggezione e, come Ulisse che per mare e per terra cercava sempre di vedere il fumo di casa sua, non possono fare a meno di avvedersi dei loro diritti naturali e di ricordarsi dei loro avi e del loro stato primitivo. Sono spesso questi che, con mente lucida e lo spirito acuto, non si accontentano come il popolino, di guardare ciò che è davanti ai loro piedi, ma guardano indietro ed avanti e ricordano anche il passato per giudicare il futuro e valutare il presente. Sono quelli che, avendo la mente di per sé ben fatta, l’hanno ancora migliorata con lo studio ed il sapere. Questi, quand’anche la libertà fosse del tutto persa e scomparsa dalla faccia della terra, l’immaginerebbero e la sentirebbero nel loro spirito, e perfino l’assaporerebbero, e la servitù non sarebbe di loro gusto, per quanto la si possa imbellettare. Il Gran Turco si è reso conto del fatto che i libri e l’istruzione danno più di qualunque altra cosa agli uomini il senso e la consapevolezza di sé e l’odio per la tirannia; per questo sento 29 dire che nelle sue terre non ci sono quasi più persone di cultura, né sono richieste. Ora, comunemente, lo zelo e l’affetto di quelli che hanno conservato, nonostante il tempo, la devozione alla libertà, per quanto siano numerosi, resta senza effetto per il fatto che essi non si conoscono reciprocamente: sotto il tiranno, gli viene tolta del tutto la libertà di fare, di parlare e quasi anche di pensare, e rimangono tutti isolati con le loro idee. Perciò, Momo, il dio burlone, non scherzava poi tanto quando trovò da ridire sull’uomo che Vulcano aveva forgiato, perché non gli aveva messo una piccola finestra al cuore, affinché attraverso di essa si potessero vedere i suoi pensieri. Si è detto che quando Bruto e Cassio intrapresero la liberazione di Roma, o meglio di tutto il mondo, non vollero che ne facesse parte Cicerone, quel grande pieno di zelo per il bene pubblico, e giudicarono il suo cuore troppo debole per un evento così grande: si fidavano della sua volontà, ma non erano affatto certi del suo coraggio. E tuttavia, chi voglia ripercorrere gli avvenimenti del passato e gli annali antichi, ne troverà pochi che, vedendo il loro paese male guidato ed in cattive mani, avendo cercato con intenzione e con onestà di liberarlo, non ci siano riusciti, e che la libertà non si sia fatta strada con le sue forze. Armodio, Aristogitone, Trasibulo, Bruto il vecchio, Valerio e Dione realizzarono felicemente quanto avevano progettato; in questi casi, quasi mai la fortuna fa difetto alla buona volontà. Bruto il giovane e Cassio eliminarono felicemente la servitù, ma restaurando la libertà morirono: non indegnamente (perché sarebbe blasfemo dire che ci sia stata qualche cosa di indegno nella vita o nella morte di quelle persone). Ma certo con gran danno, perpetua sventura e completa rovina della repubblica, che fu seppellita con loro. Le altre imprese che sono state compiute in seguito contro gli imperatori romani non erano che congiure di persone ambiziose che non sono da compiangere per gli inconve- 1 In senso stretto il Sultano di Turchia, ma è probabile che si tratti di una figura di copertura usata da La Boétie per stigmatizzare la politica dei tiranni in generale ed in particolare quella delle monarchie francesi. 2 Nella mitologia greca antica Momo era la personificazione del Sarcasmo, figlia della Notte e sorella delle Esperidi. Il dio zoppo della mitologia 3 greca antica, fabbro del pàntheon olimpico. Gli esecutori filorepubblica4 ni dell’assassinio di Gaio Giulio Cesare durante le idi di marzo del 44 a. C. 5 Armodio e Aristogitone uccisero nel 514 a. C. il tiranno ateniese Ipparco nel tentativo di portare istituzioni libere nella loro città. Trasibulo fu tra i protagonisti principali della cacciata dei Trenta Tiranni ateniesi nel 403 a. C. Bruto il vecchio e Valerio furono tra i fondatori della Repubblica Romana antica. Dione rovesciò la tirannide di Dioniso a Siracusa, divenendo però a sua volta un tiranno. 30 DE LA BOÉTIE, Étienne 1 L’argomentazione si trova in realtà nel testo ippocratico intitolato Le arie, le acque e i luoghi. Cfr. IPPOCRATE, Opere, traduzione di VEGETTI, Mario, Torino, U.T.E.T., 1965, p. 192. 2 3 Artaserse (464/424 a. C.), re dei Persiani. SENOFONTE, La tirannide, traduzione italiana di TEDESCHI, Luciano, Palermo, Sellerio, 1986. Simonide di Ceo (554/468 a. 4 C.) fu uno dei più grandi lirici greci; Senofonte lo mette a confronto con Gerone, tiranno di Siracusa dal 478 al 466 a. C., alla cui corte il poeta era vissuto per qualche tempo. 5 Publio Cornelio Scipione (detto l’Africano) fu un generale romano distintosi durante le guerre puniche, famoso anche per la sua magnanimità e lealtà nei confronti sia degli amici che degli stessi avversari. L’Eunuco, atto 6 TERENZIO, III, sc. I., v. 25. Ciro il Grande, fondatore del7 l’Impero Persiano e suo primo imperatore dal 558 al 538 a. C. Creso di Lidia salì al trono 8 nel 561 a. C. Il suo regno, in cui sviluppò una vivace attività mercantile ed attrasse nella sua orbita le città della Grecia ionica, è ricordato come un periodo di enorme ricchezza e fasto per la Lidia e le città greche collegate; al suo servizio operò come ingegnere il primo filosofo e scienziato della storia del pensiero occidentale, Talete di Mileto. Entrato in conflitto con Ciro, Creso perse il trono con la conquista di Sardi nel 546 a. C. “Creso aveva sostenuto nelle città ioniche il partito democratico; Ciro, al contrario, si appoggiò sull’aristocrazia e vi stabilì dei tiranni, i quali, non potendo mantenersi che col suo appoggio, erano destinati ad essere docili strumenti nelle sue mani.” (PIRENNE, Jacques, Storia Universale, Firenze, Sansoni, 1972, I vol., pp. 125/126). nienti che gli sono capitati, essendo evidente che non desideravano eliminare ma spostare di capo la corona, con la pretesa di scacciare il tiranno e mantenere la tirannia. A costoro non vorrei che avesse arriso il successo, e sono contento che abbiano mostrato, con il loro esempio, che non bisogna abusare del santo nome della libertà per compiere imprese malvagie. Ma per tornare al nostro discorso, che avevo perso di vista, la principale ragione per cui gli uomini servono volontariamente, è che nascono servi e sono educati come tali. Da questo deriva che facilmente essi divengono, sotto i tiranni, vili ed effeminati. È ad Ippocrate, il progenitore della medicina, che dobbiamo questa intuizione, che l’ha esposta in uno dei suoi libri dal titolo Le Malattie. Questo personaggio aveva in tutti i sensi un cuore nobile, e lo dimostrò chiaramente quando il Gran Re volle attirarlo presso di lui con offerte e grandi doni, ed egli rispose francamente che avrebbe avuto degli scrupoli ad impegnarsi a guarire i Barbari che volevano uccidere i Greci, ed a servire con la sua arte chi progettava di assoggettare la Grecia. La lettera che gli inviò trova ancora posto tra le altre sue opere, e testimonierà per sempre del suo cuore leale e della sua natura nobile. Dunque è certo che con la libertà si perde di colpo anche il valore. Le persone asservite non hanno né vigore né asprezza nella lotta: vanno negligentemente verso il pericolo quasi come costretti ed appesantiti, e non sentono affatto nel loro cuore ribollire l’ardore della libertà che fa disprezzare il pericolo e dà voglia di acquistare l’onore e la gloria con una bella morte tra i propri compagni. Le persone libere fanno a gara, ognuno per il bene comune, ognuno per sé, aspettando di aver tutti la loro parte di male nella sconfitta o di bene nella vittoria. Ma le persone asservite, oltre a questo coraggio guerriero, perdono anche la vivacità in tutte le altre cose, e hanno il cuore abietto e debole e incapace di aspirare a grandi cose. I tiranni lo sanno bene, e, vedendoli prendere questa piega, ve li spingono per farli infiacchire di più. Senofonte, storico autorevole e di primo rango tra i Greci, ha fatto un libro in cui fa parlare delle miserie del potente Simonide con Gerone, tiranno di Siracusa. Questo libro è pieno di onesti e profondi rimproveri, che, secondo me, sono anche esposti ottimamente. Fosse piaciuto a Dio che i tiranni di tutti i tempi l’avessero messo davanti agli occhi e se ne fossero serviti da specchio! Non posso credere che non avrebbero riconosciuto i loro difetti ed avrebbero avuto qualche vergogna delle loro tare. In quel trattato egli racconta la pena in cui vivono i tiranni, che facendo male a tutti, sono costretti a temere tutti. Tra le altre cose, vi è scritto che i cattivi monarchi si servono di mercenari stranieri per la guerra, non osando mettere le armi in mano alla loro gente, alla quale hanno fatto torto. (Ci sono stati dei buoni sovrani che hanno assoldato delle popolazioni straniere, come i Francesi stessi, più in passato che oggi, ma con l’intenzione di salvaguardare i loro concittadini senza curarsi di perdere del denaro pur di risparmiare uomini. È quanto sosteneva, mi pare, Scipione l’Africano, che avrebbe preferito salvare un cittadino piuttosto che aver sconfitto cento nemici). Ma quello che è assolutamente certo è che il tiranno non pensa mai che il potere gli sia garantito, finché ha sotto di lui un solo uomo di valore. Dunque a buon diritto gli si potrà dire quello che Trasone in Terenzio si vanta di aver rimproverato al domatore di elefanti: Per questo così bravo siete perché avete in governo delle bestie. Ma quest’astuzia dei tiranni nell’abbrutire i loro sudditi non la si può comprendere più chiaramente che nell’atteggiamento di Ciro nei confronti dei Lidi, dopo che si fu impadronito di Sardi, la principale città della Lidia, e che ebbe preso in ostaggio e fatto prigioniero Creso, quel re tanto ricco. Appena gli fu portata la notizia che i Discorso sulla Servitù Volontaria Sardesi erano in rivolta, li avrebbe potuti schiacciare subito; ma, non volendo né mettere a sacco una città così bella, né essere sempre obbligato a mantenervi una guarnigione per sorvegliarla, concepì un grande espediente per garantirsene il controllo: vi impiantò dei bordelli, delle taverne e dei giochi pubblici, e fece pubblicare un’ordinanza perché gli abitanti ne facessero uso. Si trovò così bene con questo presidio che in seguito non fu mai necessario un solo colpo di spada contro i Lidi. Quelle persone povere e miserabili si divertirono ad inventare ogni sorta di giochi tanto che i Latini ne hanno tratto una loro parola e ciò che noi chiamiamo passatempo, essi lo chiamano LUDI, cioè LYDI. Non tutti i tiranni hanno dichiarato così espressamente di voler effeminare la loro gente; ma, a dire il vero, quello che lui ordinò formalmente e completamente, gli altri lo hanno ottenuto surrettiziamente. In realtà, questa è il tipico atteggiamento del popolino, sempre più numeroso nelle città, che è sospettoso verso chi lo ama ed ingenuo verso chi lo inganna. Non pensiate che vi sia alcun uccello che si catturi meglio alla pania, né pesce che per golosità del verme, si attacchi più rapidamente all’amo di quanto tutti i popoli vengano attratti rapidamente alla servitù, per la minima piuma che passi loro, come si dice, davanti alla bocca. Ed è straordinario che si lascino andare così presto, basta solo che li si solletichi. I teatri, i giochi, le farse, gli spettacoli, i gladiatori, le bestie esotiche, le medaglie, i quadri ed altre simili distrazioni poco serie, erano per i popoli antichi l’esca della servitù, il prezzo della loro libertà, gli strumenti della tirannia. Questi erano i metodi, le pratiche, gli adescamenti che utilizzavano gli antichi tiranni per addormentare i loro sudditi sotto il giogo. Così i popoli, istupiditi, trovando belli quei passatempi, divertiti da un piacere vano, che passava loro davanti agli occhi si abituavano a servire più scioccamente dei bambini che vedendo le luccicanti immagini dei libri illustrati, imparano a leggere. 31 I tiranni Romani trovarono anche un altro stratagemma: festeggiare spesso le decine pubbliche, ingannando quella gentaglia che si lascia andare più di ogni altra cosa ai piaceri della gola. Il più intelligente e colto tra loro non avrebbe lasciato la sua scodella di zuppa per ritrovare la libertà della repubblica di Platone. I tiranni elargivano un quarto di grano, un mezzo litro di vino ed un sesterzio; e allora faceva pietà sentir gridare: “Viva il re!” Gli zoticoni non si accorgevano che non facevano altro che recuperare una parte del loro, e che quello che recuperavano, il tiranno non avrebbe potuto dargliela, se prima non l’avesse presa a loro stessi. Chi avesse raccattato oggi un sesterzio, e si fosse rimpinzato al pubblico festino, benedicendo Tiberio e Nerone e la loro bella generosità, l’indomani, costretto ad abbandonare i suoi beni alla loro avarizia, i propri figli alla lussuria, il suo stesso sangue alla crudeltà di quei magnifici imperatori, non avrebbe detto una parola più di una pietra, non si sarebbe commosso più di un tronco. Il popolino ha fatto sempre questo: subito pronto e dissoluto verso il piacere che non può ottenere onestamente, e del tutto insensibile verso il torto ed il dolore che non può sopportare onestamente. Non vedo oggi nessuno che, udendo parlare di Nerone, non tremi al solo nome di questo spregevole mostro, di questa ripugnante peste del mondo; e tuttavia, di costui, di quest’incendiario, di questo boia, di questa bestia selvaggia, si può ben dire che dopo la sua morte, spregevole quanto la sua vita, il nobile popolo romano ne ebbe un tale dispiacere, ricordandosi dei suoi giochi e dei suoi festini, che fu sul punto di portarne il lutto; così scrive Cornelio Tacito, autore coraggioso e serio ed affidabile. Tutto questo non sembrerà strano, visto che quello stesso popolo aveva fatto lo stesso in precedenza alla morte di Cesare, che abolì le leggi e la libertà; personaggio che non ebbe, mi pare, niente che valesse, poiché la sua stessa umanità, tanto decantata, fu più dannosa della crudeltà del più disuma- 1 Etimologia fantasiosa, ma assai diffusa presso gli autori romani antichi. 2 Tiberio, imperatore romano dal 14 a l 37 d. C., salì al trono sostenuto dall’esercito (da lui precedentemente condotto in maniera brillante nelle campagne di Germania); proseguì l’opera di centralizzazione imperiale e di esautorazione dei poteri del Senato iniziata da Cesare e proseguita da Augusto – non esitando a condannare a morte vari senatori romani che si opponevano alla sua politica. Nerone, imperatore romano dal 54 al 68 d. C., dopo un iniziale tentativo di mediazione istituzionale proposto dal filosofo Seneca, proseguì l’opera di Tiberio mettendo anch’egli a morte numerosi membri della classe senatoria e confiscandone le proprietà; morì suicida in seguito ad un sollevamento dei governatori militari in nome della difesa delle antiche prerogative del Senato del Popolo Romano. Publio Cornelio Tacito, sto3 rico romano filorepubblicano di illustre famiglia equestre, nacque all’incirca nel 54 d. C. e morì durante il principato di Adriano (117/120 d. C.). 32 1 Gaio Giulio Cesare (100/44 a. C.), di nobile famiglia si schierò con il partito popolare di Mario e fu condannato a morte da Silla. Tornò a Roma alla morte di questi e collaborò con i consoli Pompeo e Crasso, fu tribuno militare, poi questore di Spagna e nel 59 a. C. console. Dopo aver annesso la Gallia alla repubblica, la sua popolarità crebbe enormemente. Ciò causò la rottura con Pompeo e Crasso e l’apertura di una guerra civile, conclusasi con la sua vittoria e la nomina a dittatore. Il suo progetto di abbattere il potere senatorio attraverso la forza popolare era riuscito, ma, mentre si apprestava a fondare una monarchia di stampo orientale, venne ucciso da una congiura filorepubblicana. Gli venne elevata nel Foro una colonna alta circa venti piedi, costruita con pietre provenienti dalla Numidia. La colonna portava la scritta Al Padre del popolo romano (cfr. SVETONIO, Vite dei Cesari, traduzione di MARCHESI, Concetto, Firenze, Le Monnier, 1969, p. 53). 2 Pirro, re dell’Epiro dal 297 al 272 a. C., famoso per le sue eccezionali qualità di capo militare che gli permisero, sovrano di un piccolo regno, di sconfiggere a più riprese sia le forze di Roma sia quelle di Cartagine. Generale romano che appro3 fittò della guerra civile apertasi nel 69 d. C. dopo il suicidio di Nerone per farsi eleggere imperatore: proseguì la politica di accentramento del potere politico ed esautorazione delle prerogative senatoriali del suo predecessore. SVETONIO, Vite dei 4 Cfr. Cesari, op. cit., p. 330. dei figli del dio Eolo 5 Uno nella mitologia greca antica. Publio Virgilio Marone (70/ 6 19 a. C.). Legatosi agli ambienti epicurei e a quello dei poetae novi scrisse varie opere che lo consacrarono, ancora vivente, come uno dei maggiori poeti della latinità. L’inferno di cui parla La Boétie è l’Ade in cui Virgilio fa scendere Enea su indicazione della Sibilla Cumana. DE LA BOÉTIE, Étienne no tiranno, perché fu proprio quella sua velenosa dolcezza che indorò la pillola della servitù per il popolo romano Ma, dopo la sua morte, quel popolo che aveva ancora in bocca il gusto dei suoi banchetti e nella mente il ricordo delle sue prodigalità, per rendergli gli onori e cremarlo, fece a gara ad ammucchiare i banchi del foro, e poi gli innalzò una colonna, come al Padre del popolo (così riportava il capitello), e gli rese più onore da morto, di quanto se ne sarebbe dovuto rendere ad un vivo, a parte forse a quelli che l’avevano ucciso. Gli imperatori romani non dimenticarono neanche di assumere di solito il titolo di tribuno del popolo, sia perché quella era ritenuta sacra, sia perché era stata istituita per la difesa e la protezione del popolo, e sotto la tutela dello Stato. Così si garantivano che il popolo si fidasse di più di loro, come se dovesse sentirne il nome e non invece gli effetti. Oggi non fanno molto meglio quelli che compiono ogni genere di malefatta, anche importante, facendola precedere da qualche grazioso discorso sul bene pubblico e sull’utilità comune. Tu infatti conosci bene, o Longa, il formulario che potrebbero usare assai finemente in alcune situazioni. Ma, nella maggior parte dei casi, non ci può essere tanta finezza dove c’è tanta impudenza. I re d’Assiria, e dopo di loro quelli della Media, si presentavano al pubblico il più tardi possibile, per insinuare nei popoli il dubbio che fossero in qualche cosa più che uomini, e lasciare in questa fantasticheria i popoli che lavorano volentieri di fantasia nelle cose che non possono giudicare a vista. Così tante popolazioni, che furono per moltissimo tempo sotto il dominio assiro, con quel mistero si abituavano a servire e servivano più volentieri, non sapendo quale padrone avessero, né quasi se ne avessero, e temevano tutti, per fede, uno che nessuno aveva mai visto. I primi re d’Egitto non si mostravano quasi mai, senza portare sulla testa un gatto, un ramo o del fuoco; e, così facendo, con la stranezza della cosa, da- vano ai loro sudditi un senso di riverenza ed ammirazione; laddove, alle persone che non fossero state troppo stupide o troppo asservite, non avrebbero suscitato che lazzi e risate. È penoso ricordare quanti espedienti abbiano utilizzato i tiranni nel passato per consolidare la loro tirannia; di quanti mezzucci si servivano, trovando sempre il popolino fatto apposta per loro, che si lasciava prendere nella rete per quanto male la tendessero; e che si lasciava ingannare così facilmente da essere più sottomesso quanto più lo prendevano in giro. Che dire poi di un’altra bella favola che i popoli antichi presero per oro colato? Essi credettero fermamente che il pollice di Pirro, re degli Epiroti, facesse miracoli e guarisse i malati alla milza; e ingigantirono la favola, sostenendo che quel dito, dopo la cremazione del cadavere, si fosse ritrovato tra le ceneri, intatto nonostante il fuoco. Eppure è così che il popolo sciocco fabbrica da sé le menzogne, e poi ci crede. Molti lo hanno scritto, ma in modo che è facile vedere che l’hanno raccolto dalle voci di città e dalle chiacchiere del popolino. Vespasiano, di ritorno dalla Assiria e passando per Alessandria per recarsi a Roma ad impadronirsi dell’impero, fece meraviglie: raddrizzava gli zoppi, rendeva vedenti i ciechi, e tante altre belle cose nelle quali chi non riusciva a vedere il trucco, era a mio avviso più cieco di quelli che guariva. I tiranni stessi trovavano molto strano che gli uomini potessero sopportare uno che faceva loro del male; essi volevano farsi scudo della religione, e se possibile, prendere a prestito qualche prova della divinità a sostegno della loro vita malvagia. Dunque Salmoneo, se si crede alla sibilla di Virgilio nel suo inferno, per essersi preso gioco del popolo così ed aver voluto spacciarsi per Giove, sconta ora le sue pene nell’inferno più profondo, Soffrendo crudeli tormenti per voler imitare I tuoni del cielo, e i fuochi di Giove, Sopra quattro corsieri, quegli andava traballando, Discorso sulla Servitù Volontaria Montato in groppa, con in pugno una grande fiaccola brillante. Tra i popoli greci ed in pieno mercato, Nella città di Elide in alto aveva camminato E facendo il suo affronto così usurpava L’onore che, senza dubbio, apparteneva agli dei. Il folle, che la tempesta e l’inimitabile fulmine Contraffaceva, col bronzo e con una spaventosa corsa Di cavalli dal piede di corno, il Padre onnipotente; Il quale, subito dopo, punendo la grande offesa, Lanciò, non una fiaccola, non una luce di una torcia di cera, con il suo fumo, E col duro colpo di una orribile tempesta, Lo portò giù, i piedi sopra la testa. Se costui che faceva solo lo sciocco, e viene a quest’ora trattato laggiù come si conviene, credo che quelli che hanno abusato della religione, per essere cattivi, vi si trovano ancora meglio. I nostri seminarono in Francia non so che genere di rospi, di fiordalisi, l’ampolla e l’orifiamma. Cose che, comunque sia, non voglio mettere in dubbio, poiché né noi né i nostri antenati abbiamo avuto sin qui l’occasione di dubitarne. Infatti, abbiamo sempre avuto dei re tanto buoni in tempo di pace quanto valorosi in guerra, che sebbene nascano re, sembra che non siano stati fatti come gli altri dalla natura, ma scelti da Dio onnipotente, prima della nascita, per il governo e la salvezza di questo regno. E quand’ anche così non fosse, non vorrei per questo scendere in campo per contestare la verità delle nostre storie, né esaminarle tanto minuziosamente, per non distruggere quei bei temi, in cui potrà cimentarsi la nostra poesia francese, rinnovata del tutto, sembra, dal nostro Ronsard, dal nostro Baïf, dal nostro Du Bellay, che in questo hanno talmente fatto progredire la nostra lingua, che oso sperare che presto né i Greci né i Latini ci saranno superiori, se non per essere stati i primi. E certamente farei gran torto alle nostre rime, (poiché uso volentieri questo termine, e non mi dispiace perché, sebbene molti l’abbiano reso meccanico, tuttavia vedo molte persone che lavorano per nobilitarlo ancora e restituirgli l’onore antico), ma dicevo, le farei gran torto togliendole quei bei racconti di 33 re Clodoveo, ai quali mi pare già di vedere, con quanto piacere e con quanta facilità si eserciterà la vena del nostro Ronsard, nella sua Franciade. Ne comprendo la qualità, ne riconosco lo spirito acuto, so la grazia dell’uomo: trarrà profitto dall’orifiamma quanto i Romani dalle loro ancelle e gli scudi caduti dal cielo, come dice Virgilio. Trarrà profitto dalla nostra ampolla quanto gli Ateniesi dal paniere di Erittone. Farà parlare delle nostre armi altrettanto bene che essi del loro olivo che conservano ancora nella torre di Minerva. Sarei certamente irriguardoso a voler smentire i nostri libri e saccheggiare così le terre dei nostri poeti. Ma per tornare all’ argomento da cui non so come mi ero allontanato, non è mai successo che i tiranni, per garantirsi, non si siano sforzati di abituare il popolo, non solo alla obbedienza ed alla servitù verso di loro, ma anche alla devozione. Dunque ciò che ho detto finora per abituare le persone alla servitù volontaria, serve ai tiranni solo per il popolino e la plebaglia. Ma ora vengo a un punto, che è a mio avviso la risorsa ed il segreto del dominio, il sostegno ed il fondamento della tirannia. Chi pensa che le alabarde, le guardie ed i posti di sentinella salvaguardino i tiranni, a mio avviso si sbaglia di grosso; e se ne servono, credo, più per l’aspetto formale e di spauracchio che perché ci facciano affidamento. Gli alabardieri impediscono di entrare nel palazzo ai poveracci senza mezzi, non agli uomini ben armati e pronti all’azione. È facile verificare che ci sono stati meno imperatori romani che siano sfuggiti a qualche pericolo grazie al soccorso delle loro guardie, di quanti siano stati uccisi dai loro stessi pretoriani. Non sono le truppe di cavalleria, non sono i battaglioni di fanteria, non sono le armi che difendono il tiranno. Non lo si crederà immediatamente, ma certamente è vero: sono sempre quattro o cinque che sostengono il tiranno, quattro o cinque che 1 2 VIRGILIO, Eineide, vv. 585/594. Si tratta dei segni araldici della casa reale di Francia e delle altre nobiltà maggiori, la cui genealogia è suggerita da La Boétie in antichi tentativi di spacciarsi per maghi e taumaturghi. Si veda BLOCH, Marc, I re taumaturghi., Torino, Einaudi, 1973. Qui e nel seguito l’elogio di 3 La Boétie nei confronti delle dinastie reali francesi è ironico. La Boétie allude qui alle 4 leggende sulle capacità taumaturgiche e il rapporto privile- giato delle dinastie reali con il creatore, leggende a fondamento ideologico del concetto della monarchia di diritto divino. 5 La Franciade di Ronsard, è stata pubblicata nel 1572, ossia nove anni dopo la morte di La Boétie. L’argomento è abbondantemente dibattuto nella nostra introduzione al testo. Virgilio racconta la leggenda 6 dello scudo di bronzo che, sotto il regno di Numa, cadde dal cielo nel territorio della prima Roma. La sibilla Egeria affermò che alla conservazione di tale scudo era legata la salvezza della città; Numa, allora, per evitare il furto dello scudo da parte dei nemici di Roma, ne fece fare altre undici copie per confondere gli eventuali ladri. 7 La Boétie parla dell’ampolla che contiene l’olio che serviva per una serie di atti sacramentali. legati al potere politico (le “unzioni” reali in primo luogo). Cfr. BLOCH, Marc, op. cit. Leggendario re d’Atene, me8 tà uomo, metà serpente che guidava un carro che nascondeva la parte serpentina, del suo corpo. Pausania (cfr. PAUSANIA, Guida della Grecia, Milano, Mondadori/Valla, 1982, p. 75) racconta come Minerva avrebbe rinchiuso Erittone in un paniere. La leggenda del “paniere di Erittone” era conosciuta nel XVI secolo soprattutto attraverso Ovidio (cfr. OVIDIO, Opere, Torino, U.T.E.T., II vol., p. 185). 34 1 2 DE LA BOÉTIE, Étienne Ovviamente Gaio Giulio Cesare. Probabile errore del copista o meno probabile lapsus dello stesso La Boétie: siciliens per ciciliens. La Cicilia era una provincia dell’Asia Minore che fa oggi parte della Turchia asiatica. Gneo Pompeo Magno (106/ 3 48 a. C.), uomo politico e generale romano. Nel 67 venne inviato contro i pirati della Cicilia, riuscendo a sconfiggerli in breve tempo. mantengono l’intero paese in schiavitù. È sempre successo che cinque o sei hanno avuto la fiducia del tiranno, che si siano avvicinati da sé, oppure chiamati da lui, per essere i complici delle sue crudeltà, i compagni dei suoi piaceri, i ruffiani delle sue voluttà, e partecipi ai bottini delle sue scorrerie. Questi sei orientano così bene il loro capo, che a causa dell’associazione, egli deve essere disonesto, non solamente per le sue malefatte, ma anche per le loro. Questi sei ne hanno seicento che profittano sotto di loro, e fanno con questi seicento quello che fanno col tiranno. Questi seicento ne tengono seimila sotto di loro, che hanno elevato nella gerarchia, ai quali fanno dare o il governo delle provincie, o la gestione del denaro pubblico, affinché appoggino la loro avarizia e crudeltà e che le mettano in atto al momento opportuno; e d’altro canto facendo tanto male non possono resistere, né sfuggire alle leggi ed alla pena, senza la loro protezione. Da ciò derivano grandi conseguenze, e chi vorrà divertirsi a sbrogliare la matassa, vedrà che, non seimila, ma centomila, milioni, si tengono legati al tiranno con quella corda, servendosi di essa come Giove in Omero, che si vanta, tirando la catena, di ricondurre verso sé tutti gli dei. Da ciò deriva la crudeltà del Senato sotto Giulio, la fondazione di nuovi Stati, la creazione di uffici; non certo, a conti fatti, riforma della giustizia, ma sostegno della tirannia. Insomma che ci si arrivi attraverso favori o sotto favori, guadagni e ritorni che si hanno sotto i tiranni, si trovano alla fina quasi tante persone per cui la tirannia sembra redditizia, quante quelle cui la libertà sarebbe gradita. Proprio come i medici dicono che quando nel nostro corpo c’è qualcosa di guasto, se in un’altra parte non c’è nulla che non va, questa finisce per cedere alla parte infetta: allo stesso modo, dal momento che un re si è dichiarato tiranno, tutti i malvagi, tutta la feccia del regno, non parlo di quel gran numero di ladri e furfanti bollati, che in una repubblica possono fare ben poco, nel bene e nel male, ma quelli che sono posseduti da una ardente ambizione e da una notevole avidità, si ammassano attorno a lui e lo sostengono per prendere parte al bottino, ed essere, sotto il gran tiranno, tirannelli anch’ essi. Così fanno i grandi ladri ed i famosi corsari: gli uni scoprono il territorio, gli altri pedinano a cavallo i viaggiatori per derubarli; gli uni tendono imboscate, gli altri sono in agguato; alcuni massacrano, altri spogliano, e sebbene vi siano tra loro delle egemonie, e gli uni siano solo servi e gli altri capi della banda, alla fin fine non ce ne è uno che non partecipi se non al bottino, almeno alla sua ricerca. Si dice bene che dei pirati della Sicilia non solo si adunarono in numero tale che si dovette spedire contro di loro Pompeo il grande, ma attirarono persino dalla loro parte diverse belle e popolose città, nei cui porti si mettevano al sicuro, al ritorno dalle scorrerie, e in cambio davano loro qualche ricompensa per l’occultamento del bottino. Così il tiranno rende servi i sudditi gli uni per mezzo degli altri, ed è salvaguardato da coloro dai quali dovrebbe guardarsi, se valessero qualcosa; secondo il detto che per spaccare del legno, occorrono dei cunei dello stesso legno. Ecco i suoi difensori, le sue guardie, i suoi alabardieri. Non che a loro stessi non capiti di subire qualche volta da lui, ma questi esseri perduti e abbandonati da Dio e dagli uomini sono contenti di sopportare il male per farne, non a colui che gliene fa, ma a chi lo sopporta come loro, e non ne può più. Tuttavia, vedendo queste persone che servono il tiranno per trarre profitto dalla sua tirannia e dalla servitù del popolo, mi assale spesso lo stupore per la loro disonestà, e talvolta la pietà per la loro stupidità: poiché, a dire il vero, che altro vuol dire l’avvicinarsi al tiranno se non allontanarsi dalla propria libertà, e per così dire, stringere a due mani ed abbracciare la servitù? Che mettano un po’ da parte la loro ambizione e che si liberino un po’ del- Discorso sulla Servitù Volontaria la loro avarizia, e poi si osservino e che si esaminino, e vedranno chiaramente che i campagnoli, i contadini, che ogni volta che possono calpestano sotto i loro piedi, e trattano peggio che forzati e schiavi, vedranno, dico, che costoro, pur così maltrattati, sono tuttavia in confronto a loro fortunati e in una certa misura liberi. Il contadino e l’artigiano, per quanto siano asserviti, facendo quello che gli hanno detto di fare se ne liberano. Ma il tiranno vede gli altri che gli sono accanto, che implorano e mendicano il suo favore: non devono solamente fare ciò che dice, ma pensare ciò che vuole, e spesso per soddisfarlo, che precorrano persino i suoi pensieri. Non basta che gli obbediscano, devono addirittura compiacerlo; occorre che si facciano in quattro, che si tormentino, che si ammazzino di fatica per i suoi affari e poi che si compiacciano del suo piacere, che rinuncino al loro gusto per il suo, che forzino il loro temperamento, che si spoglino del loro carattere. Devono prestare attenzione alle sue parole, alla sua voce, ai suoi segni ed ai suoi occhi. Non devono avere né occhio né piede né mano che non sia in guardia per spiare le sue volontà e per scoprire i suoi pensieri. Questo sarebbe vivere felici? Questo si chiama vivere? Ci può essere al mondo niente di meno sopportabile di questo, non dico per un uomo coraggioso, non dico per uno di buoni natali, ma semplicemente per uno che possegga il senso comune, o anche solo le fattezze di un uomo? Quale condizione può essere più miserabile di quella di vivere così, in cui non si ha niente per sé, dipendendo da altri per la propria gioia, la propria libertà, il proprio corpo e la propria vita? Ma essi vogliono servire per possedere beni: come se potessero guadagnare qualcosa per sé, dato che non possono dire neanche di appartenere a sé stessi. E come se qualcuno potesse avere niente di proprio sotto un tiranno, vogliono fare in modo che i beni siano loro e non si ricordano che sono loro che gli danno la forza per togliere 35 tutto a tutti, e di non lasciar nulla che si possa dire appartenga a qualcuno. Vedono che niente rende gli uomini soggetti alla sua crudeltà quanto le sostanze; che non esiste nessun crimine verso di lui degno di morte come la proprietà; che ama solo le ricchezze e si sbarazza dei ricchi; ed essi si vanno a presentare, come davanti al macellaio, per offrirsi così grassi e messi a nuovo da fargliene venire voglia. I suoi favoriti non dovrebbero tanto ricordare coloro che, accanto ai tiranni, hanno guadagnato molte ricchezze quanto di quelli che, avendone accumulato per qualche tempo, hanno poi perduto i beni e la vita; non deve venir loro in mente quanti hanno guadagnato ricchezze, ma quanto pochi di loro le hanno conservate. Si ripercorrano tutte le storie antiche, si considerino quelle di cui abbiamo memoria, e si vedrà con chiarezza quanto è grande il numero di coloro che, avendo guadagnato con mezzi disonesti la confidenza dei principi, avendo utilizzato la loro malvagità o abusato della loro ingenuità, alla fine sono stati annientati da quegli stessi che avevano trovato tanta facilità nell’innalzarli, e che hanno mostrato altrettanta incostanza per abbatterli. Certamente nel novero così esteso di persone che si sono mai trovate vicine a tanti cattivi sovrani, poche, o nessuna, non hanno saggiato qualche volta su se stessi la crudeltà del tiranno che avevano precedentemente aizzato contro gli altri, e che hanno alla fine arricchito loro stessi con le loro spoglie. Anche le persone dabbene, se qualche volta se ne trova qualcuna amata dal tiranno, o perché nelle sue grazie, o perché risplende in lei la virtù e l’integrità, che persino ai più cattivi ispira un certo rispetto di sé quando la si vede da vicino, ma le persone dabbene, io dico, non ci potrebbero resistere; occorre che sentano il male comune e che a loro spese provino cos’è la tirannia. Un Seneca, un Burro, un Trasea, questa terna di brave persone, due dei quali furono avvicinati dalla cattiva sorte al tiranno che mise loro 1 Lucio Anneo Seneca (5/65 d. C.), filosofo e uomo politico romano, tra i massimi esponenti dello stoicismo. La sua carriera politica fu estremamente burrascosa: conseguì la questura, ma subì anche una condanna a morte revocatagli all’ultimo momento e trasformata in un esilio in Corsica. Tornato a Roma, ottenne grazie ai favori dell’imperatrice Agrippina la pretura e si dedicò all’educazione del figlio di questa, Nerone. Con la salita al trono di quest’ultimo, Seneca ne divenne il consigliere più fidato ed uno degli uomini più potenti dello Stato. Durante i primi anni del suo impero, in effetti, il giovanissimo Nerone sembrò incarnare l’ideale stoico del rex iustus – da cui però si allontanò ben presto incarnando sempre di più il modello monarchico di matrice orientale. L’atteggiamento di Seneca nei confronti del nuovo corso del potere imperiale fu di sostanziale accondiscendenza; trovatosi ciònonostante del tutto isolato politicamente, si ritirò a vita privata nel 62 d. C. Coinvolto, a torto o a ragione, nella congiura di Pisone ricevette l’ordine di suicidarsi dallo stesso Nerone. 2 Sesto Afrenio Burro (?/62 d. C.), collaboratore di Seneca, rifiutò di cooperare con Nerone nell’ assassinio della madre Agrippina e morì – quasi sicuramente avvelenato – nel 62 d. C. Publio Clodo Peto Trasea 3 (?/66 d. C.), senatore romano che condusse una integerrima politica filorepubblicana di opposizione a Nerone. Coinvolto nella congiura dei Pisoni fu costretto da questi al suicidio; a differenza di Nerone e Burro (la cui opposizione a Nerone è da La Boétie alquanto idealizzata) incarnò politicamente il rigorismo dell’ideologia e della morale stoica. 36 1 Messalina (15/48 d. C.) visse alla corte di Claudio e fu la madre di Britannico e di Ottavio. É restata alla storia come esempio di donna dai costumi sessuali dissoluti. 2 Il personaggio di cui La Boétie racconta l’episodio più o meno leggendario è l’Imperatore romano Caligola (12/41 d. C.). Cfr. SVETONIO, Vite dei Cesari, op. cit., pp. 193/194. Domiziano, imperatore dall’ 3 80 al 96 a. C., rimane famoso per l’avidità di denaro che lo spinse a condannare a morte i cittadini più facoltosi per incamerarne le ricchezze (è perciò probabile che egli sia il modello cui si è ispirato La Boétie nella descrizione della bramosia del tiranno). Commodo, imperatore dal 180 al 192 d. C., è restato famoso per le sue stranezze ed atrocità. Antonino il Pio, imperatore dal 138 al 161 d. C., ha però lasciato alla storia l’immagine del rex iustus e, d’altronde, a differenza dei primi due, è morto di morte naturale; in effetti anche sulla morte di Commodo La Boétie è impreciso (il suo assassinio è avvenuto per mano di un atleta di nome Narcisso). DE LA BOÉTIE, Étienne in mano la gestione dei suoi affari, entrambe stimati da lui, entrambe amati. Per di più uno l’aveva allevato e considerava come pegno della sua amicizia l’educazione della sua infanzia. Ma questi tre testimoniano a sufficienza con la loro morte crudele, quanta poca garanzia vi sia nel favore di un cattivo padrone. E, a dire il vero, quale amicizia si può sperare da colui che ha il cuore così duro da odiare i suoi sudditi, che non fanno che obbedirgli? E da colui il quale, per non sapere neanche amare, impoverisce se stesso e distrugge il suo dominio? Ora, se si vuol dire che questi sono caduti in quegli inconvenienti per aver vissuto rettamente, si osservi attentamente attorno allo stesso, e si vedrà che quelli che arrivarono nella sua grazia e vi si mantennero con mezzi disonesti non durarono più a lungo. Chi ha sentito parlare di un amore così disponibile, di un affetto così ostinato? Chi ha mai visto un uomo così ostinatamente accanito verso una donna quanto lui verso Poppea? Ora, lei fu in seguito avvelenata da lui stesso. Agrippina, sua madre, aveva ucciso suo marito Claudio, per fargli posto al trono. Per favorirlo, non aveva mai avuto difficoltà a fare e sopportare qualsiasi cosa: dunque il suo stesso figlio, il suo allievo, l’imperatore fatto con le sue mani, dopo vari tentativi falliti, alla fine le tolse la vita. E tutti allora dissero che aveva fin troppo meritato quella punizione, se fosse stato da altre mani che quelle di colui al quale lei aveva dato la vita. Chi fu mai più accondiscendente, più semplice, o per meglio dire, più tonto dell’imperatore Claudio? Chi fu mai più invaghito di una donna che lui di Messalina? Ciononostante, la mise infine tra le mani del boia. L’ingenuità caratterizza sempre i tiranni, se ne hanno, nel non sapere fare il bene, ma non so come alla fine, quando si tratta di praticare la crudeltà, anche verso coloro che gli sono vicini, la loro intelligenza, per quanto poca ne abbiano, si risveglia. Molto famoso è il motto di spirito di quell’altro che, ve- dendo la gola scoperta della moglie, che amava tantissimo, e senza la quale sembrava non avrebbe saputo vivere, gliela carezzò con queste parole: “Questo bel collo sarà presto tagliato, se lo ordino.” Ecco perché la maggior parte degli antichi tiranni erano di solito uccisi dai loro favoriti, che, avendo conosciuto la natura della tirannia, non potevano essere tanto sicuri della volontà del tiranno quanto diffidavano della sua potenza. Così fu ucciso Domiziano da Stefano, Commodo da uno dei suoi stessi amici, Antonino da Macrino, e così pressoché tutti gli altri. È per questo che il tiranno non è mai amato né ama. L’amicizia è una cosa sacra, e si stabilisce solo fra brave persone, e con una stima reciproca. Essa si coltiva non tanto con i favori quanto con la vita retta. Quello che rende un amico certo dell’altro, è la conoscenza che ha della sua integrità: le garanzie che ne ha, sono la sua bontà naturale, la fede e la costanza. Non può esservi amicizia laddove c’è la crudeltà, laddove c’è la slealtà, laddove c’è l’ingiustizia. E fra i disonesti, quando si associano, c’è un complotto, non una compagnia; non si amano vicendevolmente, ma si temono l’un l’altro; non sono amici, ma sono complici. Ma anche se non ci fossero questi ostacoli sarebbe comunque difficile trovare in un tiranno un amore sicuro, perché essendo al di sopra di tutti, e non avendo compagni, è già al di là dei confini dell’amicizia, che ha il suo vero terreno di coltura nell’eguaglianza, che non vuole mai contravvenire alla regola, anzi è sempre uguale. Ecco perché tra i ladri c’è davvero (così si dice) una certa fiducia nella spartizione del bottino: perché sono pari e compagni, e se non si amano, almeno si temono l’un l’altro e non vogliono diminuire la loro forza disunendosi. Ma i favoriti del tiranno non possono avere alcuna garanzia, dal momento che ha imparato da loro che egli può tutto, e che non c’è né diritto né dovere che lo obblighi, dato che la sua condizione gli fa considerare il suo arbitrio come la ragione, Discorso sulla Servitù Volontaria non gli fa avere nessun compagno, ma essere il padrone di tutti. Dunque è davvero penoso che, pur vedendo tanti esempi lampanti, vedendo il pericolo così presente, nessuno voglia imparare dalle altrui disgrazie e che, di tante persone che si avvicinano così volentieri ai tiranni, non ce n’è uno che abbia l’accortezza ed il coraggio di dir loro quello che disse nella favola, la volpe al leone, che faceva il malato: “Verrei volentieri a farti visita nella tua tana, ma vedo troppe tracce di animali che vanno avanti verso di te, e non ne vedo una che ritorni indietro.” Questi miserabili vedono luccicare i tesori del tiranno e osservano sbalorditi i raggi della sua ostentazione; e, attratti da questa luce, si avvicinano e non si accorgono di mettersi nella fiamma che inevitabilmente li consumerà: così il satiro indiscreto (come dicono le favole antiche), vedendo luccicare il fuoco scoperto da Prometeo, lo trovò così bello che andò a baciarlo e si bruciò. Così pure la farfalla, nella speranza di godere di un certo piacere, si mette nel fuoco, perché riluce, e prova l’altra qualità, quella di bruciare, come dice il poeta toscano. Ma concediamo pure a questi graziosi favoriti che sfuggano alle mani di colui che servono, non si salverebbero mai dal re che viene dopo. Se questi è buono, bisogna rendere conto e riconoscere almeno allora la ragione; se è disonesto e simile al loro padrone, non sarà possibile che non abbia i suoi favoriti, i quali di solito non si accontentano di prendere il posto degli altri, ma ne vogliono il più delle volte i beni e le vite. Come può accadere dunque che si trovi qualcuno che, con un pericolo così grande e con così poca sicurezza, voglia prendere questo posto disgraziato per servire con una tale difficoltà un signore così pericoloso? Che tormento, che martirio è questo, mio Dio? Esistere giorno e notte solo per pensare a piacere ad un uomo solo, e tuttavia aver timore di lui più di ogni altro al mondo; avere sempre l’occhio vigile, l’orecchio in ascolto, per intuire da dove verrà il colpo, per scoprire le imbo- 37 scate, per avvertire la rovina dei suoi compagni, per scoprire chi lo tradisce, ridere con tutti e tuttavia temere tutti; non avere nessun nemico aperto né amico certo; sempre con il viso sorridente e il cuore paralizzato; non poter essere lieto e non osare essere triste! Ma è un piacere considerare quello che ricevono in cambio di questo gran tormento, ed il bene che possono aspettarsi dal sacrificio della loro miserabile vita. Di norma il popolo, non accusa il tiranno per il male che subisce, ma quelli che lo governano. Di costoro, i popoli, le nazioni, tutto il mondo a gara, perfino i contadini e i paesani, sanno i nomi, scoprono i loro vizi, addossano su di loro mille oltraggi, mille bassezze, mille maledizioni; tutti i loro discorsi, tutti i loro voti sono contro questi. Ad essi addebitano tutte le disgrazie, tutte le pesti, tutte le loro carestie. E se talvolta gli fanno in apparenza certi onori, nello stesso istante li maledicono nel loro cuore, e provano orrore per loro più che per le bestie feroci. Ecco la gloria, ecco l’onore che ricevono dal loro servizio verso la gente, che se potesse fare in mille pezzi il loro corpo, non sarebbe ancora soddisfatta né sollevata almeno in parte dalla sua pena. Ma anche dopo che sono morti, i posteri si danno da fare perché il nome di quei mangiapopoli sia annerito dall’inchiostro di mille penne, e la loro reputazione fatta a pezzi in mille libri, e perfino le ossa, per così dire, trascinate dalla posterità, che le punisce anche dopo la loro morte della loro vita malvagia. Impariamo dunque una buona volta a fare il bene. Leviamo gli occhi al cielo, sia per nostro onore, sia per l’amore stesso della virtù, sia, per parlare secondo verità, per l’amore e l’onore di Dio onnipotente, che è sicuro testimone delle nostre opere e giudice giusto delle nostre colpe. Da parte mia penso proprio, e non mi sbaglio, che non ci sia nulla di così contrario a Dio, tanto buono e liberale, come la tirannia, che egli riservi laggiù delle pene particolari per i tiranni ed i loro complici. 1 La favola esopea citata è quella celeberrima della volpe e del leone. Cfr. ESOPO, Favole, traduzione di MARCHESI, Concetto, Milano, Feltrinelli, 1976, pp. 38/39. 2 Il poeta toscano in questione è Petrarca; la lirica è il XVII sonetto. Cfr. PETRARCA, Canzoniere, Torino, Einaudi, 1964, p. 19. 38 ANONIMO, Teseo ed il Minotauro 39 Marco Celentano La Scissione della Relazione tra Filosofia e Politica nel Pensiero Antico ed il Ripiegamento del Filosofo su Se Stesso 1 Nella riflessione dell’ultimo Seneca il saggio, il filosofo, appare come colui che, ritirandosi da ogni impegno diretto nella vita pubblica, “deve vivere in pace e in tranquilla solitudine, per potersi dedicare alla contemplazione”. Il modello ideale di esistenza filosofica, incarnato dalla figura del sapiente, viene a coincidere con l’utopia di una perfetta autarchia individuale, mentre il mondo della società e della politica torna a confondersi in una più ampia dimensione cosmica, il cui ordine acquista, per l’ineluttabilità che lo contraddistingue, i caratteri del “naturale” e del “divino”. Nella Roma imperiale, in cui si svolge la riflessione dello stoico Seneca, il margine di scelta che resta al filosofo, in ambito “pubblico”, sembra effettivamente essere rigidamente definito dall’alternativa tra una totale rinuncia alla politica attiva e la servitù consapevole nei confronti del tiranno. Una simile caratterizzazione della sofia e della filosofia come discipline che implicano l’astensione ed il distacco dall’attività pubblica non rappresentava tuttavia un momento di continuità con la tradizione culturale della filosofia greca, quanto piuttosto il compiersi di un processo di rovesciamento di questa tradizione ed il sanzionamento teorico di una scissione storicamente già avvenuta: la scissione di quella relazione che aveva visto, fin dalle loro origini, le figure del “sapiente” e del filosofo intimamente legate a quelle del “legislatore” e del riformatore politico. Plutarco, un pensatore che nasce quasi cinquant’anni dopo Seneca, e che all’interno dell’impero romano ri- coprirà importanti cariche sia religiose che politiche, si riallaccia direttamente a questa tradizione presentando, ne Il simposio dei sette sapienti, queste figure “capostipite” della filosofia greca come portatrici del grande rinnovamento in senso “democratico” ed antitirannico della cultura greca. Anche in un’altra opera, il Maxime cum principibus viris philosophes disserendum, il “platonico” Plutarco insiste sul valore “pubblico” dell’attività filosofica, criticando il disimpegno teorizzato e praticato da altre scuole filosofiche, principalmente dalla scuola stoica che, per lo stesso motivo, sarà suo bersaglio polemico anche nel De Stoicorum repugnantis. La coesistenza di queste due immagini così diverse e contrastanti del “sapiente” nella tarda tradizione filosofica greca era in effetti il risultato di un processo che, segnando alcune delle fasi più drammatiche della storia sociale greca, aveva condotto alla scissione tra attività filosofica e attività politica. Il passaggio culturale dall’ideale di una “perfetta compenetrazione tra attività intellettuale e attività sociale e politica”, originariamente caratteristico della figura del “sapiente”, a quel “modello di ‘saggio contemplativo’ che compare, sembra, nel V secolo a. C. e trionfa in epoca ellenistica per perpetuarsi nei secoli successivi”, trova le proprie premesse nelle lotte politiche del VI e del V secolo a. C. e il proprio primo punto nodale di svolta in quegli eventi del IV secolo che furono legati alla condanna a morte di Socrate ed alla riforma platonica della filosofia, per essere poi sancito dal mutato quadro politico, dopo la perdita dell’indipendenza greca. 1 SINCLAIR, T. A., Il pensiero politico classico, Bari, Laterza, 1973, pp. 413/414. 2 Di quest’opera, che in passato è stata considerata spuria da alcuni studiosi, sembra oggi accertata la paternità. Cfr. PUPPINI, P., “A tavola con la saggezza”, in PLUTARCO, Il simposio dei sette sapienti, Palermo, Sellerio, 1991. PUPPINI, P., “A tavola con 3 la saggezza” in PLUTARCO, Il simposio dei sette sapienti, op. cit., p. 100. 40 CELENTANO, Marco Risulterebbe probabilmente impossibile comprendere la nascita stessa della filosofia, quale si venne delineando tra VI e IV secolo a. C., e le sue successive trasformazioni, senza tener conto sia della vocazione politica che alle origini caratterizzò le azioni, le riflessioni ed i discorsi dei filosofi, sia del fallimento e dell’esito tragico cui questa vocazione andò incontro, già durante i primi secoli di vita della filosofia. Questa sconfitta o fallimento, che trovarono nell’accusa di “empietà” e nella condanna a morte di Socrate il loro evento forse più emblematico e tragico, ebbero come esito trasformazioni così profonde della filosofia, che solo attraverso di esse possiamo comprendere gli sviluppi successivi di questa disciplina. Se queste trasformazioni trovano nelle svolte che Platone impresse alla pratica e alla teoria filosofica la loro matrice, uno dei motivi sta proprio nel fatto che Platone cercò di ripensare il nesso tra politica e filosofia a partire dall’evento della condanna a morte e dell’esecuzione di Socrate. Soffermandoci adesso a considerare specificamente la valenza “politica”, in altre parole d’intervento diretto nelle forme di autocomprensione ed autoorganizzazione della Polis, che la figura del “sapiente” ed il concetto di “sapienza” rivestirono, soprattutto tra VI e IV secolo a. C., nell’epoca delle origini della filosofia greca, ed utiliz- MASOLINO DA PANICALE, Il Festino di Erode zando le trasformazioni del concetto di “sapienza” e della figura del “sapiente” come un indice del trasformarsi della relazione tra filosofia e politica, cercheremo in queste pagine di ripercorrere brevemente gli eventi della storia sociale della filosofia, da Solone a Platone. Insomma ripercorreremo quegli eventi che, dal “sapiente” del VI secolo la cui attività fu più fortemente caratterizzata in senso politico, all’ultimo dei grandi filosofi dell’epoca classica greca che tentò l’attuazione di un progetto politico globale, segnarono l’evolversi della relazione tra attività filosofica e attività politica, e la sua prima drammatica rottura all’interno della cultura greca. Ricostruendo questo percorso cercheremo di porci essenzialmente tre domande: in che modo, ovvero con quali pretese, la filosofia ed il movimento sapienziale che la precedette, si accostarono alla politica e quale fu il senso dell’innovazione da essi introdotta in quell’ambito? Quali trasformazioni fondamentali la filosofia stessa subì dal fallimento di questo suo primo grande tentativo di partecipazione diretta alla regolamentazione ed all’autoorganizzazione della vita sociale, nonché dalla presa d’atto platonica di questo fallimento? Quali trasformazioni subì entro questo percorso che va da Solone a Platone, la stessa nozione filosofica dell’agire politico? La Scissione tra Filosofia e Politica... 2 La parola sofos, scrive Hegel, significava in greco “uomo saggio” nel senso di capace di un sapere “pratico”, che rivela un’utilità “non soltanto per sé” ma anche per la collettività, “uomo di buon naso”, “astuto”, “ingegnoso”, “versato in tutte le mansioni del vivere pubblico e privato”. Essa dovè caricarsi forse proprio durante il VI secolo anche di una più specifica valenza politica, se alcuni interpreti posteriori come Dicearco qualificarono i “saggi” di quell’epoca come “né sapienti né filosofi, ma uomini esperti e legislatori”. Vicini all’ambiente culturale che gravitava intorno al tempio di Apollo, a Delfi, i “sapienti” del VI secolo (sui cui nomi le fonti antiche non concordano, tranne che per quattro: Talete, Solone, Biante e Pittaco) ebbero a particolare modello e punto di riferimento la tradizione oracolare e lo stile espressivo degli indovini del tempio, e svolsero la propria riflessione “inquadrandola in un atteggiamento mentale gradito al dio che veneravano”: “le massime concise che le epoche seguenti hanno tramandate come profferite dalle labbra dei `Sette saggi’ presentano i segni dell’influenza salutare di Apollo”, “detti come ‘É difficile essere buoni’ o ‘Non chiamare felice nessun uomo finché la sua vita non è finita’ testimoniano della saggezza gentile e piacevolmente ironica che aveva parlato dal santuario di Delfi”. Alla figura del “sapiente”, che rappresentò per la loro cultura un modello ideale di vita e di conoscenza, i greci attribuirono sempre le qualità della “moderazione” e della “prudenza”, dell’“equilibrio” e della “giustizia”. Gli uomini che incarnarono questa figura furono tuttavia, almeno nei due casi a noi più noti, non semplici continuatori bensì profondi innovatori di una cultura. É caratteristico di figure come Solone o Talete il fatto che pur essendo innovatori radicali di aspetti costitutivi della cultura e della società del loro tempo, essi non furono percepiti, o meglio la cultura posteriore greca non li raffigurò come “nemici” della tradizione. Sulla loro opera e sul loro comportamento non si abbatté quell’ accusa di “tradimento”, di “divulgazione di un segreto religioso, estensione ad un gruppo aperto d’un privilegio riservato, diffusione di un sapere prima proibito” che in seguito fu alla base di tante condanne nei confronti dei filosofi e della filosofia. Essi però rivoluzionarono o cominciarono a rivoluzionare, con una svolta carica di conseguenze, le tradizioni religiose, politiche e culturali, i sistemi di produzione e trasmissione del sapere, i privilegi e i poteri su cui si era precedentemente basata la vita associata, già per il fatto che, nella sfera della conoscenza come in quella della politica, “non ricorsero a un dio per attribuirgli la paternità della propria opera”: “Solone, come gli altri legislatori, ammetteva che la giustizia veniva dagli dei, ma non si appellava a una missione divina e neppure, in alcun senso rilevante, a una guida divina”. Se la “sapienza” significò in questo senso assunzione umana dell’azione politica, del comportamento etico, delle pratiche conoscitive, il movimento sapienziale, pur muovendosi nel solco di una non rottura con la tradizione, dette inizio di fatto ad un atteggiamento di revoca di quel consenso aprioristico e incondizionato che la tradizione precedente e l’opinione comune avevano concesso all’ordine sociale e politico esistente, considerandolo come “naturale”, apparentandolo alla sfera del sacro, accreditando il mito di una sua origine divina. É difficile valutare l’impatto che questa modificazione dovette avere sulle forme della vita associata. L’assunzione umana e personale dei discorsi e delle pratiche politiche, iniziata col movimento sapienziale, ebbe, alla lunga, l’effetto di delegittimare, almeno in una certa fase e in certi luoghi della civiltà greca, quei discorsi e quelle pratiche che basavano la propria autorità solo sulla continuità con la tradizione o sulla pretesa di un rapporto privilegiato col divino. L’introduzione della filosofia finì per spostare di fatto il luogo deputato alla decisione politica, indicando il terreno 41 1 HEGEL, George Wilhelm Friedrich, Lezioni sulla storia della filosofia, Firenze, La Nuova Italia, 1967, vol. I. pp. 221/222. 2 DIOGENE LAERZIO, citato in I presocratici. Testimonianze e frammenti, Bari, Laterza, 1983 , vol. I. p. 71. ZIMMERN, A., “Il com3 monwealt greco” in L’origine dello stato greco, antologia a cura di Codino, F., Roma, Editori Riuniti, 1975, p. 143. VERNANT, Jean-Pierre, 4 Mito e pensiero presso i greci, Torino, Einaudi, 1970, p. 402. 5 FINLEY, M. L., “Gli antichi greci”, in L’origine dello stato greco, op. cit. 42 CELENTANO, Marco del confronto tra i discorsi e tra le pratiche, della valutazione dei discorsi e delle pratiche sulla base della loro maggiore o minore capacità di produrre “vantaggi” per la comunità, come il solo luogo deputato alla maturazione delle scelte politiche. Tuttavia se il concetto di “sapienza” (sofia) rappresentò per i greci un vertice ideale della conoscenza, se il “sapiente” divenne per la cultura greca figura ideale di un connubio e di un equilibrio tra sapere pratico (saper fare, sapere di utile collettivo) e comprensione razionale, tra sapere delle “cause” e sapere dei “fini”, tra rispetto delle tradizioni religiose e rinnovamento dei costumi, il trasformarsi della sofia in filosofia significò di fatto la rottura di quegli equilibri e l’esplosione dei conflitti sociali e culturali in essi latenti. Nell’operetta di Plutarco sopra 3 citata, in cui si descrive una discussione tra i “sette sapienti” ed altri convitati riuniti dal tiranno Periandro alla sua tavola, Solone esprime il proprio parere affermando “che il non comandare è preferibile al comandare”: una tale opinione si addice alla figura di Solone quale la cultura greca posteriore l’ha tramandata. Verso gli inizi del VI secolo, ad Atene “un pugno di famiglie controllava tutte le risorse e tutte le sanzioni” e la città “era di fronte ad una situazione rivoluzionaria, del tipo che altrove aveva portato all’affermarsi della tiran- nide”. In questo contesto maturò l’esigenza di codificare e fissare per iscritto “le leggi costituzionali, civili, sacrali e criminali”, e “Solone fu scelto per accordo e incaricato di riformare lo stato”. “Questo è il punto – scrive Finley – egli fu scelto dagli stessi ateniesi, di loro iniziativa, e per loro autorità”, “egli non era ‘chiamato’ e non aveva vocazione, né prese il potere da tiranno”, mentre “la classe dirigente, sembra, cercò la sua mediazione solo per paura di una rivoluzione che avrebbe potuto spazzarla via”. Solone afferma poi nei suoi poemi di aver voluto cercare l’equità e l’equilibrio ma di essersi schierato innanzitutto contro l’“arroganza” e la “superbia” di quei “reggitori del popolo” diventati “ricchi grazie alle loro opere inique”, contro “questa piaga insanabile” che vedeva i cittadini poveri “venduti schiavi, costretti indegnamente in catene”. Egli adottò la misura rivoluzionaria di abolire la schiavitù per debiti, onde far liberare tutti coloro che, per tale motivazione, erano costretti a lavorare per conto di altri senza compenso, e restituire ai proprietari originari “le terre che questi avevano perdute per darle in garanzia di prestiti”. Riformò inoltre le regole dell’accesso alle cariche governative, modificando una situazione di fatto, che vedeva il monopolio del potere politico tramandarsi per discendenze familiari, e “senza badare ai diritti della nascita, istituì quattro classi distinte sulla base del reddito agricolo. L’appartenenza a queste classi costituiva il 1 Inserito nel novero dei “sette sapienti” da alcune fonti antiche, Periandro, essendo stato tiranno di Corinto, venne spesso, dalle fonti posteriori, come in questo caso da Plutarco, estromesso dal gruppo, avendo acquisito il concetto di “tiranno” una connotazione negativa. 2 3 FINLEY, M. I., op. cit., p.149. ibid. BRUEGEL, Pieter, Pieter (il vecchio), Predica del Battista La Scissione tra Filosofia e Politica... titolo per rivestire cariche pubbliche”. Infine, come conferma egli stesso nei suoi scritti posteriori, ricevuta l’offerta di diventare tiranno della città, rifiutò, e, completata la sua opera, “lasciò Atene per dieci anni in modo che la comunità potesse sperimentare senza pregiudizi il suo programma”. Anche se i conflitti che egli cercò di risanare tornarono ad esplodere con virulenza in seguito, e la tirannide, che il poeta/legislatore aveva rifiutato, fu poi portata ugualmente ad Atene da Pisistrato, Solone “restò nella memoria degli ateniesi, indipendentemente dai partiti, come l’uomo che infine li aveva avviati sulla strada della grandezza”. “Le sue istituzioni fornirono uno schema sul quale furono possibili ulteriori sviluppi”, che portarono ai regimi democratici del V secolo, e questo schema “non venne mai del tutto abbandonato finché Atene rimase libera”. Non lo stesso si può dire di quei filosofi che, successivamente, tra sesto e quarto secolo, tentarono di rinnovare, e trasformare in senso “democratico”, “tirannico” od “oligarchico”, le istituzioni delle loro città. Seppure raggiunsero, già in vita, una fama talvolta leggendaria, essi non poterono più essere infatti uomini apprezzati “indipendentemente dai partiti”: furono invece uomini chiaramente di parte, che spesso pagarono in prima persona, e ad un prezzo molto alto, le proprie scelte culturali e politiche. Nel clima di profonde trasformazioni sociali e politiche e nell’acceso scontro tra fazioni “democratiche” e “aristocratiche“, che dominarono buona parte del V secolo, i filosofi furono quasi sempre al centro delle vicende sociali e degli scontri politici che si svolsero nelle loro città. Alcuni di essi presero le difese di una parte, alcuni dell’altra, determinate scuole filosofiche si mossero nel segno di una continuità con la tradizione religiosa e scelsero di mantenere l’obbligo del segreto sulle loro dottrine, altre si orientarono ad un ragionamento laico e alla pubblica discussione. Ma sia quando si richiamarono al rispetto delle tradizioni religiose e politiche, sia quando se ne fecero critici, i filosofi espressero la loro riflessione, introducendo un’idea e una pretesa del tutto nuova: quella per cui non un’autorità tramandata, incontestabile e incomprensibile, né semplicemente l’autorità della forza, bensì “la scienza deve governare” negli atti dei singoli e della comunità. La forza di questo punto di vista va intesa a prescindere da come poi ognuno dei singoli pensatori riempì di propri contenuti, o di motivi ideologici che gli provenivano dalla sua cerchia sociale e culturale, il proprio modello di “scienza” (Episteme): comune ai diversi filosofi fu l’idea che il proprio discorso potesse avere la meglio su quello degli altri in quanto riconoscibile, nell’ambito di un corretto argomentare, come più “saggio”, più razionale, più capace di comprendere le cause dei fenomeni e di descrivere correttamente le esperienze, più capace di stabilire le regole di un discorso in cui il parlante non inganni sé stesso, e perciò come discorso portatore e indicatore di un maggior vantaggio pratico per la comunità. Questa pretesa portò perciò di fatto con sé la designazione del confronto tra i discorsi, dell’esame da parte di ognuno dei vantaggi e degli svantaggi di una determinata pratica, come modalità e luoghi deputati alla decisione delle forme di autoregolamentazione e autoorganizzazione della vita politica della comunità. Questo passaggio si rende tanto più significativo e visibile proprio in quei pensatori che più ostili o distaccati si mostrarono di fronte al nuovo corso, orientato in senso antiaristocratico, degli eventi politici. Ad ascoltare “non me ma il logos” invitava ad esempio già il solitario Eraclito: Eraclito, si noti bene, non è per niente un democratico, al contrario è un uomo di origine e di pensiero aristocratici, nemico del nuovo corso della società greca. Questa frase che esprime l’essenza del nuovo discorso filosofico è tanto più notevole in bocca ad un personaggio del genere, a dimostrazione di come il nuovo modo di pensare sia ormai diffuso al punto tale che 43 1 2 3 4 FINLEY, M. I., op. cit., p. 146. FINLEY, M. I., op. cit., p. 150. ibid. ibid. 44 CELENTANO, Marco nessuno, nemmeno gli oppositori più radicali delle forme che ne hanno accompagnato l’avvento, vive ormai al di fuori di esso. L’aristocratico Eraclito non invoca il mito a difesa del suo discorso, né fa appello alla nobiltà degna di fede della sua origine. 399 a. C. la restaurata demo4 Nel crazia ateniese pronuncia e mette 1 2 VOCCIA, Enrico, “Gli inizi della Filosofia”, testo inedito. NIETZSCHE, Friedrich, La filosofia nell’epoca tragica dei greci, in NIETZSCHE, F., Opere, vol. III, tomo II, Milano, Adelphi, 1973, p. 276. in atto la condanna a morte di Socrate. Una stagione di guerre civili e di delitti politici, una trafila di condanne religiose e politiche nei confronti dei filosofi, precedono la vicenda di Socrate, eppure è essa a fissare, quantomeno per Platone, un punto di irreversibilità nella pratica politica della filosofia. Platone raccoglie gli esiti estremi di due atteggiamenti diversi di fronte alla politica: quello del potere costituito che in nome della legge pronuncia la condanna di Socrate, difendendo la propria conservazione, e quello di Socrate che, in nome del rispetto della legge, a quella condanna si sottomette. A partire dalla valutazione di questo duplice esito Platone si decide per una riforma radicale del progetto politico della filosofia, riforma che appare connotata in modo ambivalente, rispetto alle pratiche e alle teorie politiche di altri pensatori precedenti o contemporanei, da una acutizzata consapevolezza “rivoluzionaria” delle condizioni necessarie ad una modificazione radicale dell’ordine sociale, e da una spiccata tendenza ad un’involuzione “reazionaria” delle pratiche politiche della filosofia. “Da Platone in poi, il filosofo è in esilio e cospira contro la sua patria”. Con la condanna di Socrate diviene chiaro, almeno per Platone, che la filosofia non può giungere pacificamente ad una radicale modificazione delle istituzioni sociali e politiche, poiché i poteri costituiti non solo non tollerano modificazioni rivoluzionarie al proprio interno, ma sono disposti, contro di esse, a giungere alle estreme conseguenze. A partire da questa consapevolezza matura anche il distacco platonico dall’etica sacrificale di Socrate, ed il tentativo di un suo superamento. Con Platone il filosofo perde le speranze di giungere a “far governare la scienza” con le sole armi del discorso e della dialettica: quest’ultima è indispensabile per governare, ma deve essere una forza militare a sostenerla, e una concentrazione monarchica del potere a garantire l’unità dello Stato. Nel passaggio dall’idea di un “governo della scienza” all’idea di un “governo dei filosofi” si consuma però il sacrificio di quella innovazione profonda di cui la pratica filosofica era stata portatrice in politica, ovvero dell’utopia filosofica della polis come luogo del confronto tra i discorsi e dell’autodeterminazione collettiva delle forme di organizzazione. Dell’antica nozione sapienziale e filosofica per cui “il non comandare è preferibile al comandare” resta una traccia nella riflessione platonica, ma il suo effetto è paradossale: i filosofi devono governare perché sono gli unici che non vorrebbero farlo, che vorrebbero far altro; questa loro elettiva lontananza dalla sete di potere dovrebbe far da garante sul loro senso di giustizia. Il filosofo platonico si fa qui erede di quel senso di “nobiltà intrinseca” del proprio agire che era stata nelle pretese e nelle forme di autorappresentazione dell’aristocrazia. Il “governo dei filosofi” si distingue, in ultima analisi, dalle antiche costituzioni monarchiche solo per l’istituto della rotazione. Speculari rispetto alle riforme del5 l’agire politico della filosofia, introdotte da Platone, sono le innovazioni che egli introduce nelle pratiche di formazione e di espressione del filosofo. Tra queste le più evidenti e sostanziali sono due: la sostituzione del dialogo parlato, socratico, con il dialogo pensato e scritto da un unico autore, e la sostituzione del luogo pubblico con un luogo privato in cui fare filosofia e formare i filosofi. L’Accademia platonica, riprendendo in parte il modello delle scuole pitagoriche, è istitu- La Scissione tra Filosofia e Politica... zione filosofica, scolastica e politica insieme, e mantiene una certa tendenza al segreto, un aspetto “misterico”. Dopo il fallimento dei tentativi politici di Platone l’ipotesi di un “governo dei filosofi”, e ancor più l’utopia filosofica di un autogoverno della comunità, perderanno senso e attualità, poiché sarà l’intera Grecia a perdere la propria autonomia politica, cadendo sotto la superiore potenza militare della monarchia macedone. A partire dalle svolte che Platone imprime alla pratica e alla teoria filosofica (la cui discussione dettagliata esula dagli intenti di questo articolo), dal fallimento pratico del progetto governativo di Platone, inteso come tentativo di dare risposta ad una sconfitta dell’originario atteggiamento politico della filosofia, e dalla perdita di autonomia della Grecia, la filosofia comincerà a sua volta a perdere le proprie caratteristiche originarie di forma di partecipazione diretta alla scena sociale e politica. Dall’epoca di Platone, l’epoca di una prima radicale sconfitta dell’azione politica dei filosofi e dell’affermarsi di una prima forma di ritiro del filosofo dalla scena sociale, si dipartono i fili intrecciati che in mutati contesti sociali e politici porteranno all’emergere di un’altra immagine non solo della filosofia ma anche del filosofo stesso. Quest’immagine, oggi profondamente radicata nel linguaggio, ha anch’essa 45 una sua radice antica (si pensi al racconto, riportato anche da Platone nel Teeteto, su Talete che “mentre osservava le stelle e guardava in alto cadde in un pozzo”) ma diventerà preminente solo a partire dall’epoca postplatonica. Essa caratterizza il filosofo come uomo solitario, dedito alla contemplazione e alla meditazione, orientato a perseguire un distacco e un’autonomia nei confronti del mondo e del corpo, come colui che si rifiuta di inseguire ciò che i “molti” reputano importante (piacere, amore, felicità, potere), come persona infine che trova il proprio spazio espressivo nel privato pensare, leggere e scrivere, piuttosto che nel pubblico agire, nella “teoria” piuttosto che nella pratica. Il trionfare di questa immagine, in epoca post-ellenistica, può essere considerato il risultato del lento precipitare di uno stato sociale, che investì la filosofia ma ovviamente non soltanto essa, in dato culturale e professionale: il trasformarsi della sconfitta di quella pretesa di radicale rinnovamento politico di cui era stata portatrice la filosofia, in uno statuto disciplinare e in una forma di autocomprensione in cui il filosofo si autoesclude dalla scena del politico; il trasformarsi di un ripiegamento del filosofo su sé stesso in quella forma di consenso alla tirannia che offrì, da allora in poi, a molti filosofi, il mestiere di consiglieri di principi, imperatori e governanti. 1 RUBENS, Pieter Paul, L’Entrata Trionfale di Costantino a Roma AA.VV., I presocratici. Testimonianze e frammenti, Bari, Laterza, 1983, I vol., p. 88. 46 DE ROSA, Giulio Giulio De Rosa Note Critiche sull’Atenaion Politeia omposto molto probabilmente C tra il 431 ed il 424 a. C., durante la prima fase della guerra del Pelopon- 1 Per una discussione più approfondita del complesso dibattito sulla paternità del breve trattato si veda CANFORA, Luciano, “Studi sull’Atenaion Politeia”, in Memorie dell’Accademia delle Scienze di Torino, V, 4, 1980, e CANFORA, Luciano, “Crizia prima dei Trenta”, in AA. VV., I Filosofi e il potere nella società e nella cultura antiche, Napoli, 1988, pp. 29/41. neso, l’Atenaion Politeia è un dialogo dalla paternità anonima (e destinata a rimanere tale). Non siamo di fronte ad un’opera di teoria politica ma ad una riflessione “empirica” sul carattere della democrazia e sulla difficoltà da parte dei suoi avversari di abbatterla – ovvero sulla coesione interna e sulla coerenza complessiva di un tale sistema politico. Esso si presenta sotto forma di dialogo tra due interlocutori, “A” e “B”. Il primo è un conservatore moderato e intelligente che espone le tesi dell’autore stesso, rispondendo man mano alle sollecitazioni che gli provengono del secondo dialogante. Quest’ultimo è su posizioni oligarchiche come il primo ma molto più oltranzista, pregiudizialmente ostile nei confronti di qualunque manifestazione del regime democratico e politicamente poco flessibile. Dal punto di vista dei contenuti trattati possiamo dividere lo scritto in quattro parti. Nella prima “A” esprime una serie di giudizi tesi ad illustrare “oggettivamente” la potenza politica del demos ateniese: questo, formato dai nuovi ceti emergenti dei commercianti, artigiani e marinai, dimostra capacità e coerenza nel conservare il regime instaurato. Il demos infatti evidenzia un’ estrema cura nel lasciare ai nobili quelle cariche colme di responsabilità che comportano per chi le ricopre gravissimi rischi e pochi meriti, e nel dare, nelle assemblee pubbliche, largo spazio alla “canaglia” ed ai poveri a scapito dei ricchi e delle “persone per bene”: entrambe queste tattiche rafforzano la democrazia. “B” replica che l’unico scopo del popolo quando giunge al governo sembra essere quello di “governare liberamente”, in altre parole “governare male purché si governi”, ma “A” gli risponde che del “malgoverno” al demos non importa nulla – anzi la sua strategia politica è rivolta coscientemente al conseguimento di esso nei modi sopra accennati. Il governo dei “peggiori”, infatti, non può essere che malgoverno. Lo sperpero del denaro pubblico in continue feste e la considerazione sociale relativamente elevata di cui godono gli schiavi nella città di Atene (spiegata attraverso la loro fondamentale importanza per il mantenimento della potenza economica e commerciale dell’Impero), sono gli argomenti che “A” utilizza per passare alla seconda parte del dialogo. In essa infatti l’anonimo autore si sofferma sulle caratteristiche dell’impero commerciale e marittimo di Atene, e sulla sapienza politica mostrata dal demos nel conservarlo anche attraverso il sagace rapporto con gli alleati. Questi essendo stati costretti a dirimere le proprie controversie giuridiche presso i tribunali ateniesi, in tal modo sono necessitati a mantenere buoni rapporti con il demos ateniese che tanta parte ha nella formazione di tali istituzioni. L’unico punto di debolezza della potenza – essenzialmente marinara – dell’Impero consiste nel fatto che Atene non è un’isola e, di conseguenza, è esposta agli attacchi terrestri che di tanto in tanto devastano il suo territorio. Nella terza parte “A” illustra la diversità dei modi e dei tempi della strategia politica fra regimi politici oligarchici e democratici. I primi sono infatti costretti ad una politica fatta sostanzialmente di moderazione, alleanze e compromessi (poiché la responsabilità Note Critiche sull’Atenaion Politeia delle decisioni politiche è chiaramente definita), mentre i secondi si lanciano molto più facilmente in decisioni avventate (la responsabilità delle decisioni politiche essendo qui in qualche modo collettiva e “impersonale”). Il punto che nella “impersonalità” della decisione politica consista il fondamento del potere del demos è testimoniato dal fatto che questi, tollerantissimo quando nelle commedie si mette in scena e si scherniscono i difetti di un singolo individuo, anche se d’origine popolare, dimentica ogni liberalità quando ad essere messo in scena e schernito è il popolo in quanto tale. Altro aspetto tipico della democrazia, a giudizio di “A”, è la lentezza di qualsivoglia pratica burocratica che riguardi il singolo, poiché ad essi s’antepone il disbrigo degli affari “collettivi” (allestimento di feste, spettacoli, delibere sulle guerre, sulla politica economica, ecc.); il singolo è così spesso costretto a sborsare denaro per corrompere i funzionari pubblici ed accelerare in tal modo le sue pratiche. La quarta parte del trattato s’apre con l’acuta considerazione di “A” che tutto quanto elencato non sono i “difetti”, bensì la forza della democrazia; essa può reggersi proprio perché si comporta in questa maniera. Risulta pertanto utopistico immaginare di “cambiarla dall’interno”: si tratta di un regime politico con leggi ferree, perfettamente integrato ed omogeneo, che può sopportare mutamenti interni molto delimitati. D’altronde, argomenta “A”, ognuno fa i propri interessi; il regime democratico è per definizione la condizione politica consona alle aspirazioni del demos. Nulla di che stupirsi dunque, dal momento che “il simile favorisce il proprio simile”, nemmeno se nei rapporti con le altre città greche il regime democratico favorisce le componenti “canagliesche” a scapito dei “migliori”: questi infatti sono i nemici giurati del demos. La democrazia non potrà perciò mai permettere che qualcuno la convinca a schierarsi con i “migliori” – pena la sua dissoluzione. 47 Da un punto di vista formale il testo riflette l’acquisizione della tecnica argomentativa della sofistica, poiché il dialogante “A” illustra le sue tesi sul regime democratico assumendo su di sé il punto di vista opposto, la tesi contraria, mostrandone l’intima coerenza e validità. Come dicevamo all’inizio, infatti, questo testo non consiste in una critica negativa né in una svalutazione preconcetta della democrazia, ma in un’intelligente discussione sulle strategie, sui metodi e sui valori di cui si serve il demos per difendere il regime da esso costruito. Possiamo infatti constatare che tutta l’esposizione di “A” – nella quale s’identifica la posizione dell’autore – è straordinariamente obiettiva, e sembra scaturire da una sorta di rassegnazione ammirata nei confronti di una strategia politica spietata, priva di smagliature, difficilissima da scardinare e che appare, di conseguenza, come il risultato di una notevole sapienza politica. “A” (contrariamente al dialogante “B” che mostra un’ostilità atavica e risentita nei riguardi del demos giustificata dalla sua presunta rozzezza o malvagità) vede nel popolo ateniese un soggetto politico maturo che, avendo oramai una chiara percezione del proprio compito e del proprio ruolo, ha creato una forma politica caratterizzata dal meccanismo dell’esclusione che è lo specchio dei propri interessi e dei propri valori. “A” afferma chiaramente: “Io al popolo la democrazia gliela perdono. É comprensibile che ciascuno voglia giovare a se stesso”. L’astio e il livore nei riguardi del demos – responsabile della condizione di atimòs (fuoriuscito politico) dell’anonimo – ha lasciato il posto al tentativo di comprensione delle sue ragioni politiche che ne hanno dettato il comportamento, risultato alla distanza vincente. Ma che caratteristiche ha il demos ANONIMO ATENIESE, oggetto di discussione in quest’opera? Atenaion Politeia, traduzione Come poi vedremo in Aristotele, esso di CANFORA, Luciano, Palerè un ceto composto da artigiani, mari- mo, Sellerio, 1991, p. 34. nai, commercianti che, una volta costruite sulle proprie virtù tecnico/ ANONIMO ATENIESE, professionali la propria fortuna e la Atenaion Politeia, op. cit., p. 30 1 2 48 1 2 DE ROSA, Giulio PLATONE, Repubblica, VII, 577a. Cfr. ARISTOTELE, Politica, traduzione di LAURENTI, Renato, Bari, Laterza, 1993, pp. 121/126. ATENIESE, 3 ANONIMO Atenaion Politeia, op. cit., p. 29. Cfr. CANFORA, Luciano, 4 “Studi sull’Atenaion Politeia”, op. cit., pp. 17/33. 5 ANONIMO ATENIESE, Atenaion Politeia, op. cit., pp. 33/34. Cfr. ROUSSEAU, Jean6 Jacques, Il contratto sociale, traduzione di GERRATANA, Valentino, Torino, Einaudi, 1980, capitolo IV (“Della Democrazia”), pp. 92/94. prosperità dell’Impero Ateniese, si è anche impossessato di quel sapere pratico per eccellenza che è la virtù politica, grazie alla quale ha tradotto pubblicamente la propria potenza e dettato la propria egemonia. Il popolo ateniese ha così mostrato un notevole dinamismo, che ha travalicato l’ambito delle occupazioni private per sfociare in ambito pubblico sia all’interno della città (nella forma dell’egemonia sugli altri ceti) sia all’esterno d’essa (nella forma dell’egemonia sugli alleati della Lega Attica). Questo dinamismo ha posto le condizioni dapprima per la nascita di una coscienza politica e, successivamente, di un vero e proprio regime politico consono ai valori del demos e basato sui meccanismi dell’esclusione degli antichi ceti dominanti dalle leve del potere. Ma quali sono i valori che il demos ha incarnato nella democrazia antica? É opinione dell’anonimo ateniese che questo regime politico – come tutte le forme politiche storicamente realizzatesi – consista in una società politica esclusiva dal punto di vista della rappresentanza e per niente egualitaria. Così come Platone considererà la democrazia “il regime in cui hanno il sopravvento i poveri” e dove, “in quanto gli ottimi uccidono i poveri (…) la distribuzione degli uffici viene fatta per sorteggio” e allo stesso modo Aristotele la concepirà quale “degenerazione” del regime costituzionale, in cui la volontà arbitraria del demos si sostituisce alle leggi, per l’anonimo essa è il governo di coloro che osteggiano la “gente per bene”: “Io dico che il popolo di Atene sa ben distinguere i cittadini dabbene dalla canaglia. Ma pur sapendolo predilige quelli che gli sono benevoli ed utili, anche se sono canaglie, e la gente per bene la odia proprio in quanto per bene; pensano infatti che la virtù, nella gente per bene, sia nata per nuocere al popolo, non per giovargli”. Certamente, così come qualcuno ha messo in evidenza, queste affermazioni nascono in un periodo dell’esperienza della democrazia ateniese antica – quello immediatamente successivo alla grande stagione periclea – in cui essa è in preda ad una profonda involuzione rispetto al modello originario. É anche vero però, d’altra parte, che l’argomentazione dell’anonimo vuole mettere in luce soprattutto che il carattere “degenerativo” ed intollerante del regime politico democratico in cui si trova a vivere non è un dato accidentale o contingente ma strutturale. La democrazia si trova perciò nell’impossibilità materiale di tradursi in isonomia, nel regime di ciò che è uguale e giusto. Ciò accade proprio perché essa è il prodotto di una coscienza politica che s’ispira ai valori del “simile in funzione del proprio simile”. Infatti la scelta di campo da lei operata è prospetticamente orientata in funzione di determinati interessi che non le permetteranno mai d’elevarsi al punto di vista dell’equidistanza di tutti gli interessi e di tutti i valori di una comunità politica, cosa che costituisce il fondamento e la condizione dell’isonomia. Ciò considerato si comprende anche il significato dell’altra affermazione impietosa contenuta nel breve dialogo, vale a dire che “molto non è possibile modificare senza intaccare l’essenza stessa della democrazia”. L’anonimo considera in altre parole assolutamente illusorio seguire la strada dei correttivi per migliorare la democrazia ed adattarla alle nuove situazioni, poiché essi non potranno mai mutare la sua natura ferocemente esclusivista – a meno di capovolgerla radicalmente in un regime altro che non rispetti più i suoi valori originari e che con essa non abbia più niente a che fare. L’autore del dialogo sembra anticipare qui alcune conclusioni rousseauiane de Il Contratto Sociale sull’impossibilità della democrazia – intesa come regime della totalità che governa in favore della totalità – proprio perché essa è pur sempre espressione di una coscienza politica che può operare solo in nome del “giovare a se stesso” e dell’“interesse” – e ciò anche nel rarissimo caso che tale interesse coincida con quello della comunità intera. Note Critiche sull’Atenaion Politeia 49 7 Cuma (NA), Camera Pentagonale di Accesso al cosiddetto Antro della Sibilla Come osserverà in seguito Aristotele, anche per l’anonimo ateniese l’origine e il fondamento delle diverse costituzioni politiche si trova nella dialettica del conflitto di classe tra i ricchi e i poveri. In tal senso qualsiasi forma politica sarà pur sempre destinata ad essere una forma politica “interessata”, che non governerà mai “la comunità in funzione della comunità”. In tal senso – e qui mettiamo a fuoco il limite dell’analisi dell’Anonimo – non si comprende su cosa sia fondata la sua predilezione nei riguardi del re- gime oligarchico, ancora da lui dipinto come il governo dei “perbene”, che governa la comunità in nome della virtù e del sapere, in poche parole la comunità in nome di se stessa. Infatti appare chiaro da tutta la sua analisi precedente che ogni forma politica sarà irrimediabilmente di parte e destinata a governare in funzione di sé e in nome del tutto, proprio perché nessuna di essa potrà mai corrispondere ad un punto archimedico esterno al mondo degli interessi privati e capace di sublimarli. I termini precisi del ragionamento aristotelico sono i seguenti: “la pluralità delle costituzioni è dovuta al fatto che ogni stato ha un considerevole numero di parti” (ARISTOTELE, Politica, op. cit., p. 119). Dall’osservazione storico/empirica il filosofo giunge ad affermare che le costituzioni fondamentali sono due, l’oligarchia e la democrazia; egli specifica poi che “si ha democrazia quando stanno al potere uomini liberi e poveri, che sono in maggioranza, oligarchia quando vi stanno uomini ricchi e nobili, che sono in minoranza” (ARISTOTELE, Politica, op. cit., p. 121). Si tenga infine presente che per “poveri” Aristotele – così come l’Anonimo Ateniese – non intende affatto i lavoratori manuali in genere, bensì tutti coloro che, pur non essendo schiavi o ridotti in miseria, non godono pienamente, ma solo in parte, dell’otium. Per “poveri” perciò qui Aristotele intende tutti gli uomini liberi che non possono fare a meno di lavorare per vivere. 50 Enrico Voccia Questioni di Fondazione della Società. Lettura de L’Unico e la sua Proprietà di Max Stirner Premessa. L’eterodossia del pensiero stirneriano 1 Si faccia riferimento in particolare alle idee espresse da Coleridge, Ruskin, Southey, Ticknor e Stendhal. Sull’enorme influenza dell’economia politica classica nei confronti della riflessione romantica cfr. RANCHETTI, Fabio, La formazione della scienza economica, Torino, Loescher, 1977, pp. 13/14. Tra i testi “classici” della tradizione del pensiero filosofico contemporaneo, L’Unico e la sua proprietà di Max Stirner viene a trovarsi in una condizione paradossale. La sua valenza di testo politico gli dona da sempre lettura e diffusione notevole negli ambiti più disparati, mentre l’insegnamento e la ricerca accademica – attenti talvolta a vere e proprie cineserie e/o ad autori che l’argomentazione filosofica non sanno nemmeno dove sia di casa – si può dire che lo ignori pressoché completamente. Eppure i manuali di Storia della Filosofia citano, unanimemente, questo testo come un momento fondamentale della riflessione sui fondamenti dell’agire sociale portata avanti dalla cosiddetta “sinistra hegeliana”. Il motivo di quest’esclusione/ rimozione è in realtà facilmente comprensibile, purché si tenga conto della preminenza pressoché assoluta, nella cultura contemporanea, della critica romantica del moderno. La società moderna, secondo questa diffusissima visione, sarebbe caratterizzata da valori puramente materiali quali la produzione, la tecnica, il profitto, la merce, ecc.: tale situazione precipiterebbe l’uomo in una condizione di alienazione, di perdita della sua essenza umana, di incapacità a riconoscere il vero senso della vita. Questa visione della modernità nasce per l’appunto nel movimento romantico, ma si è rapidamente diffusa ed ha trovato una assai vasta rispondenza nella cultura contemporanea, ed oggi è un leit-motiv che accomuna “trasversalmente” le principali visioni del mondo. Tenendo presente una tale condizione, è comprensibile come qualunque voce che si ponga fuori del coro sia guardata con sospetto e sottoposta a meccanismi di esclusione/rimozione. Max Stirner, in effetti, sostiene la tesi esattamente contraria a quella appena esposta: a suo giudizio, lungi dall’essere dominata da valori puramente materiali, la società contemporanea è totalmente ideologizzata e sacralizzata. Secondo l’autore de L’Unico e la sua proprietà, infatti, noi non ci troviamo immersi nel regno dei valori materiali bensì in quello degli “spiriti”, dei “fantasmi”, delle “idee fisse”; e, se ciò non bastasse, la tesi stirneriana ha come corollario diretto l’idea che i critici romantici del moderno non sono nemmeno dei critici ma, al contrario, gli ideologi (nel senso marxiano del termine) maggiormente autentici della società contemporanea. Su cosa si fonda questa tesi sicuramente eterodossa rispetto alla corrente dominante del pensiero contemporaneo? Stirner sostiene esplicitamente che ciò che è accaduto con il passaggio dall’età medievale/moderna a quella contemporanea non è stato un processo di desacralizzazione, di pura e semplice messa fuori gioco della potenza politica della mentalità religiosa, ma un semplice mutamento dell’oggetto sacralizzato. Utilizzando a piene mani l’armamentario concettuale della critica hegeliana al “dover essere”, Stirner conclude che l’“Uomo” ha scalzato Dio dall’altare dei meccanismi ideologici. Che cos’è l’ideale se non l’io di cui si va in cerca e che resta sempre lontano? Si cerca 51 se stessi, perciò non si ha ancora se stessi, si aspira a ciò che si deve essere, perciò non si è. Si vive nello struggimento: per secoli si è vissuti in esso, si è vissuti nella speranza. (...) Forse che questo riguarda solo la cosiddetta gente pia? No, riguarda tutti quelli che appartengono a quest’epoca storica che sta tramontando, anche quelli di cui si dice che sono “uomini di vita”. Anche per loro c’è sempre una Domenica, attesa dopo i giorni di lavoro, e oltre all’agitazione mondana c’è il sogno di un mondo migliore, di una felicità universale per l’uomo, insomma un ideale. (...) Ovunque struggimento, speranza, e nient’altro. Chiamatelo pure, per quel che mi riguarda, romanticismo. (...) Nel caso di queste persone religiose che sperano nella vita eterna e considerano la vita terrena come una semplice preparazione per l’altra, salta subito agli occhi la subordinazione della loro esistenza terrena, da loro posta completamente al servizio della speranza in quella celeste, ma ci si sbaglierebbe di grosso se si attribuisse ai più illuminati meno spirito di sacrificio. (...) Forse che, per presentarne subito il concetto liberale, la vita “umana” e “veramente umana” non è la vera vita? Forse che ognuno ha già in partenza questa vita veramente umana o non deve piuttosto innalzarsi a tanto con grandi fatiche? Ce l’ha già come sua vita presente o non deve piuttosto raggiungerla come sua vita futura, di cui parteciperà solo quando “non sarà più macchiato da nessuna forma di egoismo”? Secondo questa concezione la vita è fatta solo per acquistarsi la vita, e si vive solo per rendere viva in noi l’essenza dell’uomo, si vive per amore di questa essenza. Si ha la propria vita solo per acquistarsi, per mezzo di essa, la vita “vera”, depurata da ogni forma di egoismo. Per questo si ha paura di fare della propria vita l’uso che più ci piacerebbe: di essa si deve fare il “giusto uso” e nessun altro. Insomma, si ha una missione nella vita, un compito per la vita, si ha da realizzare e attuare qualcosa con la propria vita, un qualcosa per il quale la nostra vita è solo un mezzo e uno strumento, un qualcosa che vale più di questa vita, un qualcosa a cui si deve tutta la vita. Si ha un Dio che pretende vittime vive. Soltanto la brutalità del sacrificio umano è andata perduta col tempo; il sacrificio umano stesso è rimasto inalterato (...) noi “poveri peccatori” ci portiamo al macello in sacrificio per l’“essenza dell’uomo”, per l’“idea dell’umanità”, per l’“umanitarismo” e come altrimenti si chiamano idoli e dèi. Il linguaggio e l’egoismo come fondamenti dell’ agire normativo “Linguaggio” ed “egoismo” sono i concetti chiave utilizzati da Stirner nella sua analisi del fondamento dell’agire sociale umano regolato da norme. L’Unico e la sua proprietà svolge incessantemente l’idea che dietro qualunque comportamento sociale, ivi compresi quelli apparentemente “altruistici” e/o “ascetici”, vi siano interessi assolutamente egoistici. La posizione stirneriana coniuga e porta alle estreme conseguenze le tradizioni filosofiche dell’intellettualismo etico e dell’utilitarismo: ogni essere umano regola la sua azione in conformità a ciò che, in un momento dato, gli appare essere il comportamento migliore in vista della soddisfazione dei suoi interessi egoistici. Quando Stirner parla d’interessi egoistici, non vuole intendere che il singolo potrebbe operare una scelta tra interessi “privati” ed interessi “pubblici”; la sua tesi anzi è proprio che gli “interessi pubblici”, il “bene comune”, ecc. siano oggettivamente inesistenti, pure funzioni linguistico/ideologiche con le quali si portano avanti i propri interessi privati depotenziando le altrui volontà. Ma se l’egoismo è il fondamento ultimo d’ogni azione umana, come spiegare il fatto che la grande maggioranza degli uomini acconsente a formazioni politiche, modi di produzione, idee religiose e morali sfacciatamente contrari ai loro interessi? La risposta di Stirner è che l’attuale sistema di dominio deve necessariamente fondarsi sul STIRNER, Max, L’Unico e la sua proprietà, traduzione di linguaggio. Infatti, gli esseri umani, per portare avanti i loro interessi, devono AMOROSO, Leonardo, Milano, cooperare con i loro simili; e lo stru- Adelphi, 1979, pp. 335/336. mento indispensabile per tale cooperaSTIRNER, Max, L’Unico e la zione è per l’appunto il linguaggio. I sua proprietà, op. cit., pp. meccanismi del dominio dell’uomo 336/337. 1 2 52 VOCCIA, Enrico sull’uomo passeranno perciò anch’essi per lo strumento principe della comunicazione intersoggettiva: la “parola”. Se si tratta d’intendersi e comunicare con gli altri, posso ovviamente far uso solo dei mezzi umani, di cui dispongo perché sono anche uomo, oltre ad essere me stesso. (...) Il linguaggio o “la parola” ci tiranneggiano nel modo più brutale perché ci sollevano contro un intero esercito di idee fisse. Il meccanismo ideologico delle idee fisse 1 STIRNER, Max, L’Unico e la sua proprietà, op. cit., pp. 360/361. 2 L’influenza di tale concezione stirneriana sul concetto marxiano di “ideologia” è evidente. L’Unico e la sua proprietà era stato letto con estrema attenzione da Karl Marx: L’ideologia tedesca di Marx ed Engels è dedicato in larga parte alla discussione critica delle tesi di Max Stirner. 3 /53. STIRNER, Max, L’Unico e la sua proprietà, op. cit., pp. 52- Max, L’Unico e la 4 STIRNER, sua proprietà, op. cit., p. 11. Prima di andare avanti occorre sgombrare preliminarmente il campo da un possibile equivoco. La riflessione stirneriana non è rivolta a rendere evidente il fatto banale che alcuni uomini possono ingannare coscientemente altri uomini attraverso l’utilizzo di una particolare dialettica; il meccanismo linguistico/ideologico che viene analizzato è invece del tutto inconscio, al punto tale che i personaggi che ricevono evidenti vantaggi dal suo funzionamento e coloro che altrettanto evidentemente ne vengono svantaggiati possono essere accomunati dalla “fede” in esso. Torquemada e la sua vittima possono entrambi credere in perfetta buona fede nella validità del cristianesimo; anzi il potere del torturatore si basa proprio sul fatto che esiste tale condivisione. In quest’ottica il potere ottenuto, di fatto, da una piccola parte della società contro la stragrande maggioranza degli uomini è un risultato del processo, non un suo scopo coscientemente perseguito. Questo meccanismo, vero e proprio fondamento della “società gerarchica”, ha molto a che fare per Stirner con la logica della follia – tant’è vero che il termine che egli utilizza per definirlo è fissazione. Che cos’è che chiamiamo “idea fissa”? Un’idea che ha soggiogato l’uomo. Se voi riconoscete che una tale idea fissa è sintomo di pazzia, rinchiudete chi ne è schiavo in un manicomio. E forse che la verità di fede di cui non si può dubitare, la maestà, per esempio, del popolo alla quale non si può attentare (chi lo fa è reo di lesa maestà), la virtù contro la quale il censore non può permettere una sola parola, affinché la moralità si mantenga pura, ecc., non sono tutte “idee fisse”? (...) Un povero matto del manicomio è convinto, nel suo delirio, di essere Dio Padre o l’Imperatore del Giappone o lo Spirito Santo, ecc.; un bravo borghese è convinto di essere chiamato ad essere un buon cristiano, un protestante credente, un cittadino fedele, un uomo virtuoso, ecc. – bene nell’un caso come nell’altro si tratta esattamente della stessa cosa: di un “idea fissa”. Chi non ha mai tentato e osato non essere un buon cristiano, un protestante credente, un uomo virtuoso, ecc. è schiavo e succubo della fede, della virtuosità, ecc. Gli scolastici filosofavano solo all’interno dei dogmi della Chiesa; papa Benedetto XIV scrisse opere ponderose restando sempre all’interno delle superstizioni papistiche, senza mai metterle in dubbio; allo stesso modo ci sono scrittori che riempiono grossi in-folio sullo Stato, senza mai mettere in questione la stessa idea fissa dello Stato e i nostri giornali rigurgitano di politica, perché sono fissati sull’idea che l’uomo sia fatto per diventare uno zóon politikón; e così i sudditi vegetano nella sudditanza, i virtuosi nella virtù, i liberali nell’“umanità”, ecc., senza provar mai sulle loro idee fisse il coltello tagliente della critica. E così quei pensieri sono ostinati e irremovibili come le manie di un pazzo: chi li mette in dubbio, compie atto sacrilego. Ecco cos’è veramente sacro: l’idea fissa. Il meccanismo che Stirner descrive è fondato sostanzialmente su di un meccanismo di depotenziamento della volontà politica delle classi subalterne. Il testo stirneriano inizia difatti proprio con la constatazione che le classi superiori – “coloro per la cui causa noi dobbiamo lavorare, sacrificarci ed entusiasmarci” – possiedono la capacità politica di far passare i propri interessi privati per interessi pubblici. Le religioni di tutti i tempi, ivi compresa l’attuale “religione dell’Uomo”, sono interpretate da Stirner come puri meccanismi ideologici. Le classi superiori non affermano affatto di voler portare avanti i propri interessi privati e di subordinare a questi ogni interesse altrui, e in Questioni di Fondazione della Società… Max Stirner primo luogo gli interessi dei senza potere: esse affermano al contrario di voler portare avanti obiettivi per quest’ultimi psicologicamente e/o socialmente desiderabili, almeno all’apparenza. Questi obiettivi sono ampiamente sbandierati ed utilizzati come collante sociale, meccanismo ideologico unificante dei desideri di tutti gli strati della società: il servo e il padrone hanno tutti uguale interesse a salvarsi l’anima, a captare la benevolenza della divinità sulla società nel suo complesso, a mostrarsi potenti verso i nemici esterni, a combattere la disoccupazione... Le classi dominanti si fanno allora benignamente carico del compito di portare a compimento tali obiettivi, “sacrificandosi” per essi. Per un puro caso, però, le strategie volte a conseguire tali obiettivi “collettivi” coincidono stranamente con gli interessi privati dei potenti. Com’è possibile che le classi subalterne caschino da millenni in un simile inganno, apparentemente facile da smascherare? Questo accade perché gli interessi privati di queste classi sono accusati d’egoismo, in altre parole di voler sabotare in maniera bieca il “bene 53 pubblico”. Le classi subalterne vengono educate ad aver vergogna di sé, dei propri desideri, della loro stessa vita; qualunque loro azione non subordinata agli interessi dei ceti dominanti è bollata come “asociale”, “dominata da volgari interessi privati” e additata al pubblico ludibrio. La richiesta di un piccolo aumento salariale da parte dei lavoratori è negata come contraria agli interessi della società, dello sviluppo dell’economia, della creazione di nuova occupazione, ecc., mentre l’arricchimento dei grandi proprietari e dei burocrati statali viene fatta apparire come uno strumento per conseguire il “bene pubblico”. Accade così che le stesse classi subalterne educate partecipino alla repressione di quelle sue componenti che vogliono, coscientemente o perché giunte alla disperazione, dar libero sfogo al loro egoismo; esse per prime credono infatti che il perseguimento degli “interessi pubblici” comporti la loro subalternità. “Le cose vanno male perché finora abbiamo vissuto sopra le nostre possibilità”: un tale modo di pensare – implicitamente autodenigratorio – ha necessariamente come co- 1 LORENZETTI, Ambrogio, Effetti del Cattivo Governo (La Tirannide) L’interesse di Max Stirner verso il problema dell’educazione è evidente in molti altri suoi scritti: vedi, p. e., STIRNER, Max, Über Schlegesetze (Sulle leggi scolastiche) e, soprattutto, Das unwahre Princip unserer Erziehung oder: Humanismus und Realismus (L’ingannevole principio della nostra educazione, ovvero l’umanesimo ed il realismo). 54 VOCCIA, Enrico rollario che gli interessi della nazione possono essere realizzati solo attraverso l’arricchimento di chi è già ricco ed il contemporaneo nuovo impoverimento di chi povero già è. I poveri, i senza potere, sono così intrappolati nel meccanismo inutile ed anzi controproducente della denuncia morale: invece di perseguire coerentemente e senza remore i propri interessi privati, si limitano di solito ad accusare i potenti di “cattiveria”, di “immoralità”, insomma d’egoismo. Ma condannando la prassi dell’egoismo essi introiettano sempre di più quel meccanismo che li ha depotenziati politicamente, portandoli a rinnegare i propri interessi, a farli vergognare di se stessi e a credere che – se non l’azione del singolo potente – gli interessi privati delle classi dominanti coincidano proprio con l’“interesse generale della società”. Secondo la borghesia ognuno è possessore o “proprietario”. Come mai, allora, i più non hanno praticamente niente? Dipende dal fatto che i più sono contenti già solo del fatto di essere possessori, anche se quel che posseggono non sono che i loro stracci (...) 1 2 3 4 5 STIRNER, Max, L’Unico e la sua proprietà, op. cit., pp. 275. STIRNER, Max, L’Unico e la sua proprietà, op. cit., p. 126. STIRNER, Max, L’Unico e la sua proprietà, op. cit., pp. 52/53. STIRNER, Max, L’Unico e la sua proprietà, op. cit., p. 224. “Privato” ovviamente non nel senso d’individuo, ma in quello di “persona giuridica”; nel senso cioè per cui si parla, p. e., di interessi privati della FIAT (che pure non era composta dal solo Giovanni Agnelli). 6 Poiché nella società si manifestano i peggiori disagi, soprattutto gli oppressi, cioè gli appartenenti alle classi sociali inferiori, pensano di trovare la colpa nella società stessa e si pongono il compito di scoprire la società giusta. É solo il vecchio fenomeno per cui si cerca la colpa in tutti gli altri prima che in se stessi; la si cerca quindi nello Stato, nell’egoismo dei ricchi, ecc. i quali invece debbono la loro esistenza proprio alla nostra colpa. (...) voi ripetete sempre meccanicamente a voi stessi la domanda che avete sentito porre: “A che cosa sono chiamato? Che cosa devo fare?”. Basta che vi poniate queste domande e vi fare dire e ordinare ciò che dovete fare, vi farete prescrivere la vostra vocazione (...). Questo, secondo Stirner, è il meccanismo ideologico con il quale le classi subalterne vengono depotenziate poliSTIRNER, Max, L’Unico e la ticamente e instradate in un vicolo ciesua proprietà, op. cit., p. 208. co. Credendo di perseguire il loro inte- resse, esse in realtà inseguono solo dei fantasmi senza esistenza oggettiva – la volontà di Dio, l’essenza dell’Uomo, il bene pubblico, la giustizia, l’altruismo, ecc. – e così facendo consentono paradossalmente all’interesse delle classi dominanti: “Il bene comune può esultare mentre io devo ‘chinare la testa’, lo Stato può prosperare nel modo più splendido mentre io faccio la fame”. Il consenso come fondamento dello Stato Il potere politico, lo Stato, è quindi nell’analisi di Stirner l’esatto contrario di una funzione pubblica. Vale la pena di specificare che la gestione privatistica delle funzioni di governo appare essere un momento strutturale del potere politico e non un dato storico contingente – una sorta d’usurpazione in vista dei loro scopi privati che alcuni uomini fanno di quelle che dovrebbero essere delle istituzioni dedite alla cura degli interessi collettivi. Quest’ultimo ragionamento Stirner lo bolla come un cedimento alla retorica del “dover essere”: gli uomini di Stato dovrebbero accantonare i loro interessi particolari, e dovrebbero dedicarsi agli interessi pubblici. Sta di fatto che ogni singolo ha interessi diversi da quelli di ciascun altro, che gli “interessi generali della società” e cose simili si sono dimostrati essere nient’altro che meccanismi ideologici per portare avanti al meglio determinati interessi privati. Dal momento quindi che esistono solo ed esclusivamente interessi privati, lo Stato nell’analisi stirneriana non è altro che il privato più forte – così forte proprio perché riesce a convincere il resto della società che il perseguimento dei suoi scopi privati coincide proprio con il “bene pubblico”. Tutti i tipi di governo partono dal principio che tutto il diritto e tutto il potere appartengono al popolo preso nella sua collettività. Nessuno di essi, infatti, tralascia di richiamarsi alla collettività e il despota agisce e comanda “in nome del popolo” esattamente come il pre- Questioni di Fondazione della Società… Max Stirner ENSOR, James, L’Ingresso di Cristo a Bruxelles sidente o qualsiasi aristocrazia. Il fondamento della potenza dello Stato è dunque il paradossale consenso alla sua politica – in primo luogo alla “necessità” della sua esistenza – che questi riesce ad estorcere all’intera società, soprattutto alle classi inferiori che ne subiscono gli effetti negativi. L’operaio starebbe davvero molto meglio se il padrone, con le sue leggi, le sue istituzioni, ecc. – tutte cose poi che è l’operaio a pagare – non esistesse affatto. Ma con tutto ciò il povero diavolo ama lo stesso il suo padrone. Come nella cinquecentesca analisi di La Boétie, anche per Stirner quindi il vero fondamento della tirannia – che per lui coincide tout court con lo Stato – non sono i – pur importanti – apparati militari e burocratici, bensì il paradossale consenso che questi riesce ad estorcere ai dominati. Senza l’educazione dei sudditi a quella paradossale forma di consenso che egli chiama fissazione, “credenza nei fantasmi”, “idee fisse”, il potere politico resterebbe in piedi ben poco. L’egoismo come fondamento dell’uguaglianza reale e del rifiuto del consenso Se le classi dominanti fanno leva sull’- egoismo altrui – cercano, infatti, di convincere le classi dominate che i loro interessi coincidono con quelli del potere – è segno evidente per Stirner che questa è l’unica molla dell’agire umano. L’unica possibile strategia di rifiuto del consenso dovrà perciò passare a sua volta proprio per l’“egoismo”, per i “biechi interessi materiali del singolo”. In effetti, la tesi di Stirner è che l’egoismo è distruttivo se e solo se una parte della società è depotenziata in questo suo egoismo, a tutto vantaggio della parte restante. L’egoismo generalizzato, invece, eguaglierebbe, di fatto, le condizioni umane, impedendo la formazione della gerarchia sociale. “Ciò che Stirner vuol dire è evidente: la scelta che si pone non è tra arbitrio personale da un lato e ordine legale/morale dall’altro. La scelta effettiva è fra un arbitrio personale nudo e quindi non pericoloso, ed un arbitrio personale che, grazie alle armi della morale e della legge, può assumere una legittimazione, una potenza e una impunità, e può quindi esaltare a dismisura la sua componente distruttiva, che sarebbe rimasta, altrimenti, di dimensioni innocue.” L’universalizzazione dell’egoismo porterebbe quindi, di fatto, ad una società egualitaria, anche se Stirner non ama questo termine. Il riconoscimento dell’unicità dei singoli, delle loro aspirazioni, interessi e desideri, impedirebbe, 55 1 2 STIRNER, Max, L’Unico e la sua proprietà, op. cit., p. 324. Cfr. LA BOÉTIE, Étienne, Discorso sulla Servitù Volontaria, traduzione di PAPA, Vincenzo, allegato al presente fascicolo di PORTA DI MASSA – Laboratorio Autogestito di Filosofia, Epistemologia e Scienze Politico-Sociali. AA. VV., La tirannia delle 3 parole: una lettura di Max Stirner, Napoli, Comidad, 1989, p. 19. Stirner sta qui utilizzando uno strumento classico della riflessione etico/morale: quello di domandarsi gli effetti della generalizzazione di un comportamento del singolo (“cosa accadrebbe se tutti facessero così”). Solitamente, questo strumento serve a mostrare come ciò che – dal punto di vista del singolo – appare un comportamento apparentemente valido o quantomeno neutro dal punto di vista morale (p. e. “io posso nascondere la verità delle cose agli altri, se io so cosa è giusto per loro sapere o meno”), è in realtà un comportamento del tutto negativo se visto dal punto di vista della sua generalizzazione (“anche gli altri decideranno per me ciò che io devo o non devo sapere”). In questo caso, però, Stirner utilizza questo strumento classico dell’argomentazione filosofica per mostrare come un comportamento che, oggettivamente negativo se isolato al singolo, è portatore di notevoli potenzialità positive se universalizzato. 56 VOCCIA, Enrico CHAGALL, Marc, Rivoluzione (studio preparatorio) infatti, la formazione delle gerarchie sociali. Se non hanno fantasmi da adorare e/o da temere, idoli cui sacrificarsi, gli individui venderanno a caro prezzo la loro merce, e nessuno sarà perciò più in grado di sfruttare il lavoro altrui. Il “proletario” Stirner suggerisce perciò alla classe sociale di cui sociologicamente fa parte di valorizzare al massimo le proprie capacità lavorative, di non svenderle a nessun costo nei confronti delle classi dominanti, impedendo così il perpetuarsi del meccanismo gerarchico. 1 In più luoghi della sua opera Stirner si definisce tale (o anche “povero”): in effetti, egli proveniva da una famiglia di modeste condizioni economiche e viveva dello stipendio di maestro elementare. L’Unico e la sua proprietà ha, in ogni caso, come interlocutore privilegiato le classi lavoratrici, il che ha portato a parlare – a nostro avviso con buone ragioni – di un “operaismo” stirneriano. noi non vogliamo regali da voi, ma non vogliamo nemmeno regalarvi niente. Per secoli vi abbiamo fatto l’elemosina per generosa stupidità, abbiamo dato l’obolo di noi poveri a voi ricchi, vi abbiamo dato ciò che non vi appartiene, è giunto il momento che apriate la vostra borsa, perché d’ora in poi la nostra merce comincerà a salire vertiginosamente di prezzo. Una tale azione presuppone il rifiuto del consenso non alla singola politica statale e/o padronale ma all’idea di potere politico in quanto tale, in altre parole la fuga dai meccanismi ideologici su STIRNER, Max, L’Unico e la cui si fondano i legami “religiosi” della sua proprietà, op. cit., p. 284. società gerarchica. Va tenuto presente Cfr. su questo tema STIR- che per Stirner la borghesia non è la NER, Max, L’Unico e la sua classe detentrice del potere statale, bensì una classe vassalla nei confronti del proprietà, op. cit., pp. 193/194. 2 3 potere dello Stato. Lo Stato è per Stirner l’unico vero proprietario che concede in feudo ad alcuni dei suoi servi più fidati alcune parti della sua proprietà, sapendo di poterle avere indietro in ogni momento attraverso il diritto d’esproprio (ed è per questo che egli vede nei progetti di Weitling e Marx di statalizzazione dei mezzi di produzione una semplice variante del capitalismo). La classe “proprietaria”, in cambio del suo feudo, svolge funzioni di controllo sulla classe lavoratrice e attira su di sé gli odi di questa, che spesso vedono nello Stato un possibile difensore contro le angherie dei suoi feudatari. La concessione in feudo della proprietà dei mezzi di produzione permette così allo Stato di diffondere nella società una sorta di versione moderna della favola del Re Buono e Dei Ministri Cattivi. Rifiutare il consenso alla società gerarchica significa dunque, per Stirner, rompere il meccanismo ideologico d’autodenigrazione che porta il singolo a rinnegarsi, a credersi un essere abietto, le cui inclinazioni e i cui desideri devono necessariamente passare in secondo piano davanti a Dio, alla Patria, alla Nazione, al Bene Pubblico, all’Interesse Generale, alla Società, alla Comunità, alla Chiesa, all’ Uomo, alla Verità, alla Santità e via all’infinito. Questioni di Fondazione della Società… Max Stirner Per questo Stirner afferma che noi viviamo ancora pienamente immersi in una cultura mitico/religiosa: dal suo punto di vista è assolutamente indifferente inginocchiarsi davanti alla volontà di Dio o all’essenza dell’Uomo, alla Fede o alla “Libertà”. Avremo sempre a che fare con meccanismi ideologici che depotenzieranno alcuni individui a tutto favore di altri, creando servi e padroni – la società gerarchica. Negare il consenso a tali meccanismi ideologici appare a Stirner come l’unica strada dotata di senso per la costruzione di una società in cui la follia non sia la norma dominante, al punto tale da far apparire degni di alta considerazione ed offerti a modelli di comportamento i comportamenti più assurdi ed autolesionisti. Come non esaltare la coscienza di Socrate, che gli fa rifiutare il consiglio di evadere dal carcere? Ma non capite che Socrate è pazzo a concedere agli ateniesi il diritto di condannarlo? (...) Il fatto di non fuggire fu appunto la sua debolezza, il suo delirio, per cui credeva di avere ancora qualcosa in comune con gli ateniesi, ossia l’idea di essere un membro (e solo un membro) di quel popolo. (...) Avrebbe dovuto restare sulle sue posizioni e, dato che non aveva pronunciato contro se stesso una sentenza di morte, avrebbe fatto bene a disprezzare la sentenza degli ateniesi e a fuggire. Ma egli, invece, si sottomise, riconoscendo nel popolo il suo giudice, immaginando di essere piccola cosa di fronte alla maestà del popolo. Il fatto di sottomettersi, come a un “diritto”, al potere violento al quale in realtà soggiaceva, fu tradimento di se stesso: fu virtù. Stirner vede dunque nella Società senza Stato – in quella che lui chiama l’“Associazione degli Egoisti” – il compimento definitivo del processo storico di demitizzazione avviato al tempo dell’antica Grecia. Gli esseri umani hanno imparato col tempo che gli esseri supremi delle religioni non erano altro che fantasmi; ora è auspicabile che ogni singolo giunga finalmente a comprendere di non avere un fine nella vita cui tendere, diverso dai suoi desideri ed aspirazioni. L’uomo 57 singolo non deve diventare un “vero Uomo” più di quanto un cane deve diventare un “vero Cane”. É questo l’insegnamento più interessante che la lettura di un testo come L’Unico e la sua proprietà può dare: il gioco dell’autodenigrazione, del sentirsi impotenti ed umili di fronte ad entità esterne, qualunque esse siano, di rinnegare la propria individualità, il proprio specifico senso della vita a favore di sensi a noi estranei è un gioco senza senso; che, infine, dietro l’apparente razionalità del consenso all’ideologia “umanistica”, alla società capitalistico/liberale moderna, può nascondersi una lucida – ma non per questo meno distruttiva – follia. Appendice I. Stirner e la Tradizione Filosofica Stirner ha subito, nel corso degli anni, una lettura sostanzialmente legata al cosiddetto “irrazionalismo” o, per utilizzare una terminologia maggiormente in voga, al “pensiero debole”: in particolare, il nome cui è stato più frequentemente legato è stato quello di Nietzsche. Mi sembra invece evidente che una tale lettura sia inconsistente e, in larga misura, dovuta ad un sostanziale fraintendimento del suo pensiero. Alcuni chiarimenti preliminari: il termine “Filosofia”, come molti altri, è usato in svariate accezioni, sia “colte” sia “popolaresche”. Si usa talvolta per indicare la complessiva “visione del mondo” di una persona, in altre parole l’insieme delle sue idee sul mondo, sulla conoscenza, sulla politica, sulla vita sociale, sulla religione… Altre volte, invece, si usa per indicare una qual certa abilità nel sapersi muovere tra le cose del mondo, nelle difficoltà della vita quotidiana, nell’adattarsi alle circostanze senza però lasciarsene sopraffare. Altre volte, invece, si usa il termine per indicare una visione del mondo argomentata razionalmente e con estremo rigore concettuale. Si usa il termine in questo senso – sostanzialmen- 1 2 STIRNER, Max, L’Unico e la sua proprietà, op. cit., p. 225. Vedi, per una ricostruzione della lettura di Stirner, l’ottimo (in generale) FERRI, Enrico, La Città degli Unici. Individualismo, Nichilismo, Anomia, Torino, Giappichelli - Multiversum, 2002. 58 1 Vedi VOCCIA, Enrico, “Cos’è la Filosofia. Tecnica, Linguaggio, Verità, Fondamento”, in PORTA DI MASSA – Laboratorio Autogestito di Filosofia, VIII fascicolo (“Filosofia”), Napoli, La Città del Sole, 2002, pp. 19-23. 2 Vedi p. e. HEGEL, Gorge Wilhelm Friedrich, Enciclopedia delle Scienze Filosofiche in Compendio, Bari, Laterza, 1984, pp. 4-5 (§ 1). In generale, poi, la stessa struttura de L‘Unico e la sua Proprietà ricorda assai da vicino la Fenomenologia dello Spirito hegeliana, per non ricordare la testimonianza di Engels che lo classifica, all’interno del gruppo dei giovani hegeliani, come il più interessato alle questioni legate alla Filosofia nel senso “forte” (lettera di Friedrich Engels a Max Hildenbrandt, in FERRI, Enrico, La Città degli Unici. Individualismo, Nichilismo, Anomia, op. cit., p. 167-169). VOCCIA, Enrico te come sinonimo di “scienza” – soprattutto in area linguistica anglosassone. Il termine è usato talvolta anche per indicare un atteggiamento di pensiero “aperto“, rivolto continuamente all’indagine, “critico”. Altre volte, infine, si usa il termine “Filosofia” per indicare una particolare scienza, nata in Grecia più di duemilacinquecento anni fa in contrapposizione alle forme del pensiero mitico, che cerca di trovare e analizzare il fondamento logico di verità di qualsiasi conoscenza (scientifica, morale, religiosa, politica, ecc.). Si usa allora il termine con questo significato, quando si fa riferimento – come abbiamo già accennato – ad un sapere scientifico che indaga soprattutto – anche se non esclusivamente – le verità “assolute”, in quanto esse, essendo valide sempre e comunque, indipendentemente dal particolare linguaggio usato o dal contesto cui si applicano, possono essere usate come fondamento logico, criterio ultimo di giudizio di validità, per tutte le altre verità. Ovviamente qui non si tratta di stabilire un uso “giusto” o “sbagliato” del termine; gli usi sono usi, e basta. Una comunità di parlanti può utilizzare quel suono o segno grafico attribuendogli il significato che gli pare, purché sia cosciente di ciò e non cada negli equivoci. Quello che, però, può essere evidenziato in maniera oggettiva, è che l’ultimo significato del termine – Scienza del Fondamento – è qualcosa di assolutamente peculiare nella cultura umana: mentre tutti gli altri significati lo portano verso la confluenza con altri aspetti culturali (“visione del mondo”, “scienza”, “saggezza”, “atteggiamento critico”), l’aspetto di riflessione fondazionale è invece unico ed inconfondibile. Stirner, mi pare evidente, rientra a pieno in questa concezione “forte”, fondazionalistica, della Filosofia: il suo argomentare si basa proprio sul non dare per scontato nulla, nel richiedere ad ogni concetto di andare ben oltre l’accettazione del senso comune, e da questo punto di vista i suoi debiti con Hegel sono enormi. Lungi dal rico- noscersi in un generico e banale appello ad un nichilismo gnoseologico e/o ontologico, la sua causa è fondata “sul Nulla” dell’inconsistenza delle argomentazioni ideologiche, delle “idee fisse” che sostanziano la società gerarchica, che egli sottopone ad un’analisi stringente e “nullificante”. Appendice II. Il Linguaggio come Fondamento della Società Di là da tutto ciò, è poi lo stesso contenuto della sua opera maggiore, come abbiamo visto, ad essere tipicamente “fondazionalistico”. Stirner, come abbiamo visto, svaluta sia il livello politico, sia il livello economico, sia il livello culturale, come strutture portanti dell’essere sociale: tutte queste compagini, infatti, non potrebbero essere quelle che sono indipendentemente dal linguaggio. Il linguaggio, dunque, non è per nulla un semplice strumento, più o meno accidentale, bensì è il vero fondamento dell’agire sociale umano, ciò che ne caratterizza l’essenza, e per comprendere i paradossi della società – il consenso sostanziale dei sudditi alla loro penosa condizione, in primo luogo – egli indaga nelle sue caratteristiche e nelle sue potenzialità. Il linguaggio gli appare dotato di caratteristiche distruttive – le “idee fisse” – ma anche foriero di potenzialità positive enormi. In effetti, egli ritiene che la società gerarchica sia una unione assurda, delirante, non in quanto fondata sul linguaggio tout court, bensì in quanto fondata su di un uso folle ed improprio del linguaggio stesso. La sua idea di un’Associazione degli Egoisti è legata, a doppio filo, al concetto che un uso diretto e proprio del linguaggio – della comunicazione intersoggettiva – sia lo strumento per la creazione di una società radicalmente egualitaria. Per abbattere le “fissazioni”, per guarire l’umanità dalla follia, Stirner invita ad un uso ampio e senza remore della razionalità, del principio logico di causalità e di quello di non Questioni di Fondazione della Società… Max Stirner contraddizione. L’uso “folle” del linguaggio – e la conseguente follia sociale che ne consegue – sono per lui proprio il risultato della rinuncia, implicita od esplicita, dei principi logici alla base del linguaggio corretto. Il “sacro” è per lui proprio questo, e vale la pena di richiamare, stavolta a questo riguardo, una precedente citazione di un passo della sua opera maggiore: Che cos’è che chiamiamo “idea fissa”? Un’idea che ha soggiogato l’uomo. Se voi riconoscete che una tale idea fissa è sintomo di pazzia, rinchiudete chi ne è schiavo in un manicomio. E forse che la verità di fede di cui non si può dubitare, la maestà, per esempio, del popolo alla quale non si può attentare (chi lo fa è reo di lesa maestà), la virtù contro la quale il censore non può permettere una sola parola, affinché la moralità si mantenga pura, ecc., non sono tutte “idee fisse”? (...) Un povero matto del manicomio è convinto, nel suo delirio, di essere Dio Padre o l’Imperatore del Giappone o lo Spirito Santo, ecc.; un bravo borghese è convinto di essere chiamato ad essere un buon cristiano, un protestante credente, un cittadino fedele, un uomo virtuoso, ecc. – bene nell’un caso come nell’altro si tratta esattamente della stessa cosa: di un “idea fissa”. Chi non ha mai tentato e osato non essere un buon cristiano, un protestante credente, un uomo virtuoso, ecc. è schiavo e succubo della fede, della virtuosità, ecc. Gli scolastici filosofavano solo all’interno dei dogmi della Chiesa; papa Benedetto XIV scrisse opere ponderose restando sempre all’interno delle 59 superstizioni papistiche, senza mai metterle in dubbio; allo stesso modo ci sono scrittori che riempiono grossi in-folio sullo Stato, senza mai mettere in questione la stessa idea fissa dello Stato e i nostri giornali rigurgitano di politica, perché sono fissati sull’idea che l’uomo sia fatto per diventare uno zóon politikón; e così i sudditi vegetano nella sudditanza, i virtuosi nella virtù, i liberali nell’“umanità”, ecc., senza provar mai sulle loro idee fisse il coltello tagliente della critica. E così quei pensieri sono ostinati e irremovibili come le manie di un pazzo: chi li mette in dubbio, compie atto sacrilego. Ecco cos’è veramente sacro: l’idea fissa. Lo stato di follia causato dall’uso improprio del linguaggio è per lui fondamentale: se i meccanismi ideologici del dominio possono agire con dilaniante potenza, creando i sommi deliri e dolori della società gerarchica, è proprio perché essi agiscono in una collettività che è stata educata a svalutare gli strumenti di controllo del linguaggio, i principi logici basilari. La potenza dell’analisi stirneriana è evidente se solo si pone attenzione al fatto che, oggi, l’Occidente industrializzato, nonostante gli indubbi progressi in tutti i campi del sapere oggettivo, ha adottato, come “principio dell’opinione pubblica”, non solo un generico umanesimo retorico, ma addirittura posizioni irrazionalistiche, emarginando, di fatto, nell’ambito della disciplina filosofica, qualunque riflessione coerentemente razionale. La spiegazione da dare a 1 2 MASACCIO, Tommaso, Il Pagamento del Tributo STIRNER, Max, L’Unico e la sua proprietà, op. cit., pp. 52/53. Vedi, di là dall’aspetto religioso d’alcune sue tesi, HÖSLE, Vittorio, Hegel e la fondazione dell’idealismo oggettivo, Milano, Guerini e associati, 1991. Vedi anche, in un’ottica più laica, NAGEL, Thomas, L’Ultima Parola. Contro il Relativismo, Milano, Feltrinelli, 1999. 60 1Per un’analisi del concetto di “doppio legame” come meccanismo eziologico-causale delle sofferenze mentali vedi BATESON, Gregory, JACKSON, Don D., HALEY, Jay e WEAKLAND, John H., “Verso una teoria della schizofrenia”, in BATESON, Gregory, Verso un’ecologia della mente, Milano, Adelphi, 1976, pp. 244-274, e WATZLAWICK, Paul, BEAVIN, Allen e JACKSON, Don D., Pragmatica della comunicazione umana, Roma, Astrolabio, 1971. In generale, si ha un “doppio legame” quando: 1. avviene, in un determinato contesto, la comunicazione di un contenuto e, a livello di metacomunicazione, la sua negazione; 2. è impossibile, di fatto, negare e/o sfuggire a questa comunicazione paradossale. Per esempio, un padre, che condiziona fortemente la sopravvivenza economica ed affettiva di una figlia, può tenerla letteralmente reclusa, impedendole di partecipare a qualunque attività sociale, giustificando, a livello di metacomunicazione, il suo atteggiamento con una frase del tipo “lo faccio perché tu sia felice”. Per un’analisi del concetto di “doppio legame” come meccanismo eziologico-causale della schizofrenia e di altre sofferenze mentali vedi BATESON, Gregory, JACKSON, Don D., HALEY, Jay e WEAKLAND, John H., “Verso una teoria della schizofrenia”, in BATESON, Gregory, Verso un’ecologia della mente, Milano, Adelphi, 1976, pp. 244-274, e WATZLAWICK, Paul, BEAVIN, Allen e JACKSON, Don D., Pragmatica della comunicazione umana, Roma, Astrolabio, 1971. sociale, giustificando, a livello di metacomunicazione, il suo atteggiamento con un “lo VOCCIA, Enrico questo dato di fatto non può essere altro che la necessità del controllo ideologico delle classi subalterne. I meccanismi ideologici del dominio hanno bisogno, in altri termini, di persone educate ad accettare per vere conclusioni contraddittorie con le premesse, a non notare la contraddizione tra mezzi e fini, ecc. Nel passato, questo ruolo “educativo” era svolto esclusivamente dalla religione. La pratica religiosa era comunemente, per la stragrande maggioranza delle persone tenute fuori di qualunque processo di scolarizzazione, la fonte principale d’acculturazione. Una fonte, questa, che combatteva strenuamente, persino nelle classi dominanti, la diffusione di una cultura scientifica e filosofica seria, portatrice in altri termini di una prassi coerente volta alla ricerca della verità oggettiva. La Rivoluzione Industriale, però, ha imposto una sempre maggiore scolarizzazione delle classi subalterne, accrescendo le potenzialità di un loro accesso ad una forma mentis razionale e, di conseguenza, di un loro sganciamento dal controllo ideologico del dominio. L’apologia contemporanea CARRÀ, Carlo, I Funerali dell’Anarchico Galli delle varie forme d’irrazionalismo, allora, può essere letta come una sorta di “meccanismo di assicurazione” da parte delle classi dominanti nei confronti del rischio di essere costrette ad “esporre” le classi dominate ai meccanismi logici della razionalità. Le masse sono “istruite”, in altre parole introdotte ad una serie di contenuti e di strutture argomentative valide dal punto di vista di un sapere oggettivo forte. Al tempo stesso, però, questi stessi contenuti e strutture argomentative vengono, ad un livello metalinguistico e con un’enorme pressione sociale, fortemente negati e svalutati in quanto tali. L’obiettivo cardine di un tale processo è stato l’infiltrarsi nella stessa cultura del movimento operaio e socialista di tensioni irrazionalistiche, allo scopo di depotenziarne le potenzialità sovversive dello stato di cose presente. La cultura contemporanea è perciò rinchiusa in un tipico “doppio legame”, resa schizofrenica, immersa in un contesto dove, alla fine dei conti, l’unica “verità” che conta – e che resta sostanzialmente indiscussa, nonostante le sue palesi contraddizioni – è Questioni di Fondazione della Società… Max Stirner quella del potere. Appendice III. L’Uguaglianza Ho già ricordato che Stirner usa raramente il termine “uguaglianza”, eppure non v’è filosofo che prima di lui abbia così radicalmente sostenuto la tesi della perfetta equipollenza di tutti gli esseri umani – detto per inciso, questo è uno dei punti che più rendono difficile il suo accostamento a Nietzsche, che sostiene con altrettanta radicalità la posizione opposta. Il paradosso è facile da spiegare: sinora si è cercato, a giudizio di Stirner, di comparare l’uomo all’Uomo, alla sua idea o, meglio, ad un suo ideale. L’uguaglianza, allora, diveniva un compito: occorreva adeguarsi ad un modello, divenire un “vero uomo” e, anche se si presupponeva l’uguaglianza radicale di tutti gli uomini, in realtà si finiva sempre in un nuovo modello cui, di là dalle belle intenzioni dei suoi autori, alcuni uomini corrispondevano, altri meno… Per Stirner, invece, noi siamo già uguali ora perché siamo sin da ora tutti diversi. Nulla dell’umano – dell’homo sapiens sapiens – ci è alieno, ma ognuno di noi ha declinato la propria umanità in modo unico, irripetibile ed imparagonabile. Di conseguenza, nessuno di noi è “più” o “meno” uomo di altri, proprio perché un modello della declinazione dell’umano, cui paragonare i singoli individui effettivamente esistenti, non esiste. Di conseguenza, la società gerarchica non ha fondamento se non sul Nulla. L’unica società che possa vantare credito nei confronti della ragione o, meglio, di un uso proprio del pensiero, è solo quella egualitaria. Non a caso perciò, più che alla cosiddetta corrente “individualista” – ben più influenzata dal superominismo nietzscheano e, dunque, da un dover essere modellizzante dell’Uomo – Engels vede l’eredità stirneriana nella corrente comunista dell’anarchismo, l’unica, in effetti, teoria politica che ha provato a sostanziare concretamente l’idea di un’“Associazione degli Egoisti”: un’Unione senza Valore, radicalmente egualitaria, non basata su di un modello 61 dell’umano da raggiungere, ma solo sulla reciproca e pianificata cooperazione per il raggiungimento del maggior benessere possibile del singolo, che è sempre libero di scindersi da essa e di riorganizzarsi al meglio con chi gli pare, dove le decisioni valgono solo per chi le accetta. Stirner, d’altronde, per quanto la cosa possa sembrare paradossale, è ben poco “individualista” e notevolmente “realista” nel delineare il rapporto tra gli “unici” e le loro associazioni egualitarie: lo è certamente – ed ecco un nuovo apparente paradosso – ben più del suo antagonista Karl Marx. È nota, infatti, la riflessione del pensatore socialista tedesco volta al rifiuto dell’elaborazione utopistica. Nel suo rifiuto di “prefigurare il futuro” egli però si costringe, ogni qualvolta è portato a descrivere in qualche modo l’obiettivo del movimento socialista, ad una notevole genericità o, talvolta, ad una sorta di pseudoutopismo del tutto irrazionale, privo in pratica di quell’aspetto di progettazione sociale razionale che caratterizVedi, solo per fare un esemza il pensiero utopico. Quest’aspetto pio, NIETZSCHE, Frieè stato fatto notare soprattutto da drich, Al di là del Bene e del Male. Preludio di una Filosofia dell’AvveniDomenico Losurdo: 1 “Nella società comunista, in cui nessuno ha una sfera di attività esclusiva ma ciascuno può perfezionarsi in qualsiasi ramo a piacere, la società regola la produzione generale e appunto in tal modo rende possibile fare oggi questa cosa, domani quell’altra, la mattina andare a caccia, il pomeriggio pescare, la sera allevare il bestiame, dopo pranzo criticare, così come mi viene voglia; senza diventare né cacciatore, né pescatore, né pastore, né critico” [MEW, vol. III, p. 33]. Se accogliamo tale definizione, allora il comunismo presuppone uno sviluppo così prodigioso delle forze produttive da cancellare i problemi e i conflitti relativi alla distribuzione della ricchezza sociale e quindi relativi al lavoro, e alla misurazione e al controllo del lavoro, necessario alla sua produzione; anzi, così configurato, il comunismo sembra presupporre la scomparsa, oltre che dello Stato, della divisione del lavoro, e in realtà dello stesso lavoro, il dileguare, in ultima analisi, di ogni forma di potere e di re, Milano, Rizzoli, 1992 (ma, per i nostri scopi, è sufficiente anche solo la lettura della parte IX – “Che cos’è Aristocratico?”, pp. 233-268). 2 Vedi sempre la lettera di Friedrich Engels a Max Hildenbrandt, in FERRI, Enrico, La Città degli Unici. Individualismo, Nichilismo, Anomia, op. cit., p. 167-169. Vedi, p. e., il classico KRO3 POTKIN, Piotr, La Conquista del Pane, Catania, Anarchismo, 2002, ma anche il meno conosciuto ed inaspettato PISACANE, Carlo, La Rivoluzione, Torino, Einaudi, 1970 (particolarmente i capitoli: IX. Diritto di proprietà; X. Governo; XI. Dichiarazione di principî; XVIII. Risorgimento d’Italia). LOSURDO, Domenico, 4 Utopia e stato di eccezione, Napoli, Laboratorio Politico, 1996, p. 76. 62 obbligazione. La tesi generale di Losurdo è che Marx sarebbe condizionato da posizioni “anarchiche”: egli dimentica però che queste posizioni marxiane nascono proprio come critica all’anarchismo. Le pagine citate, che s’inseriscono nella tematica della “abolizione del lavoro”, sono nate, infatti, proprio all’interno della polemica antistirneriana. Stirner, infatti, riteneva impossibile tale abolizione, e poneva invece ad obiettivo della “unione degli egoisti”, dell’azione dei proletari, la “liberazione del lavoro” dal capitalismo e dallo Stato: “Lo Stato si fonda sulla schiavitù del lavoro; se il lavoro diventerà libero, lo Stato sarà perduto”. Anche la prefigurazione della scomparsa d’ogni forma di potere e d’obbligazione fa parte della polemica antianarchica di Marx: 1 2 Stirner, infatti, affermava che È ben vero che una società a cui aderisco mi toglie alcune libertà, ma in compenso me ne concede altre; non c’è niente da dire nemmeno sul fatto che io stesso mi privo di questa o di quella libertà (...). Per quel che riguarda la libertà, non vi è differenza essenziale tra lo Stato e l’unione. Neppure la seconda può nascere o conservarsi senza che la libertà venga limitata (...). La religione e in particolare il cristianesimo, hanno tormentato l’uomo con la pretesa di realizzare ciò che è contro la natura e contro il buon senso; l’autentica conseguenza di questa esaltazione religiosa, di questa tensione esagerata è nel fatto che la libertà stessa, la libertà assoluta, venne alla fine innalzata ad ideale (...). Stirner, insomma, analizzato con attenzione, fa piazza pulita di mille preconcetti – nati sia tra i suoi avversari, sia tra coloro che pretendono di ripe- STIRNER, Max, L’Unico e la sua proprietà, op. cit., pp. 124. STIRNER, Max, L’Unico e la sua proprietà, op. cit., pp. 321/322. GOYA, Francisco, Il Sonno della Ragione Genera i Mostri 63 Lucia Aiello “Consenso” ed “Obbedienza” attraver so la Leggenda del Grande Inquisitore di Dostoevskij N ella concezione comune, il consenso, perché sia tale, presuppone una convergenza di giudizio, conformità di voleri intorno alla validità di una proposizione. Ciò significa che esso è il risultato di una scelta tra più opzioni, una scelta che impegna la volontà e la ragione e implica un giudizio di valore. L’Obbedienza, così come è definita nell’Enciclopedia Cattolica, è infatti “virtù morale annessa alla giustizia, che regola i rapporti dei sudditi con l’autorità e rende la volontà pronta ad eseguire il comando del superiore”. Anzi, “se poi si attende all’oggetto che l’obbedienza disprezza per unirsi a Dio”, la volontà, e cioè il più importante tra i beni spirituali, “l’obbedienza fra le virtù è la più lodevole”. Messa in questi termini, l’obbedienza non solo non implica un giudizio di valore, ma esclude qualsiasi impegno della volontà e della ragione, sottomesse in maniera incondizionata alla volontà di un’autorità superiore, e quindi apparirebbe in qualche modo antitetica al consenso. Ma la morale cattolica va oltre. Tre gradi di obbedienza vengono indicati: 1. obbedienza materiale: esecuzione dell’opera comandata; non è virtù specifica, ma solo osservanza della legge; 2. obbedienza formale: esecuzione dell’opera in quanto comandata; obbedire cioè per il motivo del diritto del superiore sul suddito, confermando per questo la propria volontà a quella del superiore; 3. obbedienza di giudizio o cieca che sottopone pure il proprio modo di vedere a quello del superiore, rite- nendo quanto è disposto dall’obbedienza come migliore di quanto suggerisce la propria ragione. Qui sta l’obbedienza perfetta, la quale non discute l’intenzione, né pesa le ragioni. Lodevole quanto ai precetti umani, è assolutamente necessaria nei riguardi di Dio e del magistero infallibile della Chiesa, non potendo qui bastare un silenzio ossequioso, ma esigendosi piena sottomissione di giudizio. Non è sufficiente dunque attenersi alle leggi o sottomettersi ad una autorità. Perché ci sia obbedienza è necessario negare la propria volontà, o meglio, negare la propria liberta con un atto di volontà, un atto di negazione originario, premessa indispensabile di tutte le successive non-scelte. É il popolo che si assoggetta, che si taglia la gola e, potendo scegliere fra l’essere servo o l’essere libero, lascia la libertà e prende il giogo, che acconsente al suo male, o piuttosto lo persegue. (...) se vivessimo secondo i diritti che la natura ci ha dato e secondo gli insegnamenti che ci rivolge, saremmo naturalmente obbedienti ai genitori, seguaci alla ragione e servi di nessuno. Due passaggi questi, tratti dal Discours de la Servitude Volontiarie di Étienne de La Boetie, che richiamano l’attenzione su almeno due questioni importanti ai fini di un dibattito che riguardi il consenso. Innanzitutto, il rifiuto della libertà, che per l’amico di Montaigne è un “dato naturale”, una scelta, un atto di volontà. In secondo luogo, si fa una distinzione tra “obbedienza” ed “ser- 1TOMMASO, Summa Theologica, II/II, q. 80, ultimo, in AA.VV., Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano, Ente per l’ Enciclopedia Cattolica e per il libro cattolico, 1948/1954, voll. 22, voce “Obbedienza”. 2 Ibidem. L’origine controriformistica 3 e, in particolare, gesuitica di tale concezione è evidente: “So- pra ogni altra cosa giova et è molto necessario al profitto spirituale che tutti si diano alla perfetta obbedienza, riconoscendo il superiore, qualunque egli sia, in loco di Christo Nostro Signore, e portandoli intera riverenza et amore, et obediscano non solo intieramente conprontezza, perfettione et humiltà debita nella essecutione esterna a quanto sarà loro imposto, senza scuse e mormorationi, ancor che comandi cose difficili et alla sensualità repugnanti; ma oltre di ciò si sforzino haver interiormente una vera rassegnatione et annegatione del proprio volere et giuditio, conformandolo con quello ch’il superiore vuole e sente, in tutte le cose ove non si conosce peccato, pigliando la volontà e giuditio del Superiore per regola del proprio parere e sentire, acciò si conformino più perfettamente con la prima e somma regola d’ogni buona volontà e giuditio, la qual’è la eterna bontà e sapientia.” (LOYOLA, Ignazio di, Regole della Compagnia di Gesù, Roma, 1582, p. 9). 64 1 DOSTOEVSKIJ, Fëdor, I fratelli Karamazov (Bratj’a Karamazovy), traduzione italiana di POLLEDRO, Alfredo, Milano, Garzanti, 1974. 2 PAREYSON, Luigi, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, Torino, Einaudi, 1993. AIELLO, Lucia vitù”; si ammette cioè una forma di obbedienza soggetta alla ragione, ben distinta dalla servitù volontaria, un’obbedienza che trova la sua ragion d’essere ad esempio nell’ambito del sistema familiare gerarchicamente organizzato, e che è legittimata, si potrebbe aggiungere proprio come nel caso della servitù volontaria, dalla decisione di rimettersi ad una autorità superiore, a prescindere da quali siano le motivazioni e le strategie che portano a questa adesione consensuale. Se, dunque, la libertà è un “dato naturale”, se “non si può tenere nessuno in schiavitù, senza fargli torto, e che non c’è niente al mondo di così contrario alla natura, che è tutta razionale, dell’ingiustizia”, perché, si chiede La Boetie, sembra che nell’uomo sia più radicata la “ostinata voglia di servire”? É il quesito a cui il Grande Inquisitore dostoevskiano nel suo drammatico “dialogo” con Cristo dà una risposta decisa nelle sue argomentazioni, ma carica di ambiguità, soprattutto se considerata nel complesso in cui si inserisce e con cui interagisce in un rapporto dialettico non superato in una sintesi finale. É necessario considerare l’episodio nel suo insieme, dall’incontro di Ivan e Alëša nell’osteria al racconto della Leggenda da parte di Ivan. Oggetto di discussione tra i due fratelli sono le questioni ultime, in primo luogo il problema dell’esistenza di Dio. Si fronteggiano due punti di vista, quello terrestre, euclideo, di Ivan e quello celeste di Alëša. Alla base del punto di vista euclideo non c’è la negazione di Dio. Ivan afferma che se Dio non esistesse bisognerebbe crearlo. Alla base c’è il rifiuto del mondo creato da Dio, un mondo in cui si paga un prezzo troppo alto per una non meglio identificata armonia futura. É questa armonia che Ivan rifiuta. Il suo rifiuto del mondo è giustificato dall’inaccettabilità della sofferenza dei bambini, che innocenti vengono sottoposti a torture inaudite. Non c’è riscatto per quelle sofferenze; un mondo basato sulla “sofferenza inutile”, come la de- finisce Pareyson nei suoi vari studi sulla tema della libertà, del bene e del male in Dostoevskij, è un mondo assurdo. Mettere in discussione il senso della creazione, metterne in risalto il fallimento nel momento in cui se ne afferma l’inaccettabilità, significa per Ivan, secondo Pareyson, mettere in discussione Dio, negarlo come senso del mondo e quindi negarlo in toto. A sostegno della sua tesi, per dimostrare come anche la Redenzione sia un fallimento, Ivan racconta la Leggenda. Cristo ha rifiutato le tre tentazioni nel deserto e si è sacrificato sulla croce per non privare gli uomini della libertà, per essere scelto liberamente. La responsabilità di scelta tra bene e male è consegnata interamente all’uomo: l’uomo cioè fa un’esperienza più originaria e profonda, di là del bene e del male, che è quella della libertà. Il bene e il male sono frutto della libertà; senza libertà non ci sarebbe male, ma neanche bene, perché il bene non è veramente tale se c’è imposizione o necessità. Questo sacrificio, lungi dal liberare l’uomo dal dolore, non ha fatto che accrescerne l’infelicità caricandolo dell’enorme peso della libertà. Il livello del discorso si è spostato su un piano differente rispetto a quello di La Boetie. Al centro del ragionamento di Ivan/Grande Inquisitore non è il rapporto tra un tiranno o un sistema di potere tirannico e i suoi “servi volontari”; vi è l’individuo che, essendo libero non per “dato naturale”, ma grazie al sacrificio di Cristo che ha voluto l’uomo libero anche di scegliere il male, e quindi ha legittimato la presenza del male come una delle possibilità di scelta date all’uomo, sperimenta nella sua concretezza i limiti di questa esperienza originaria che è la libertà. Essa cioè coinvolge l’uomo nella sua interezza ed essenza e non solo in quanto parte di una società organizzata per sistemi di potere gerarchizzati, la cui esistenza è strettamente legata al consenso. Il problema è non solo come il potere organizza il consenso, ed è questo l’aspetto su cui si concentra maggiormente l’attenzione “Consenso ed “Obbedienza”… Dostoevskij di La Boetie, ma anche, per rifarsi a Dostoevskij, quali elementi presenti nell’uomo rendono efficace questa azione. Acconsentendo al miracolo dei pani, Tu avresti dato una risposta all’universale ed eterna ansia umana, dell’uomo singolo come dell’intera umanità: “Davanti a chi inchinarsi?”. Non c’è per l’uomo rimasto libero più assidua e più tormentosa cura che quella di cercare un essere dinanzi a cui inchinarsi (...). Perché la preoccupazione di queste misere creature non è soltanto di trovare un essere a cui questo o quell’uomo si inchini, ma di trovarne uno tale che tutti credano in lui e lo adorino, e precisamente tutti insieme. Il rimprovero che Ivan/Grande Inquisitore rivolge a Cristo è il non aver compreso che l’uomo non ha solo bisogno di essere libero, ma anche di essere felice, e per esserlo ha bisogno di soddisfare i cosiddetti bisogni primari, il “pane terrestre”, che la libertà, per quanto preziosa, non garantisce. La libertà è un dono che l’uomo non riesce a gestire, perché in lui prevale lo spirito di obbedienza, il bisogno di inchinarsi, non tanto a un tiranno o a un’autorità, che comunque può essere rovesciata in nome di un’“ideale” più alto, ma a qualcosa di incontestabile, coralmente, per consenso comune. Cristo non ha compreso che questo qualcosa non può essere scelto, raggiunto autonomamente dopo aver percorso le tortuose vie del male, ma si deve imporre, manifestare e deve rendere tangibile la possibilità di una felicita terrena e ultraterrena. Solo pochi eletti riescono a sopportare “un terribile fardello come la libertà di scelta”, e il Grande Inquisitore è stato tra questi. COURBET, Gustave, Funerale ad Ornans 65 Egli stesso si è svelato l’inganno e il suo amore per l’umanità lo ha portato a non dimenticarsi della stragrande maggioranza dei deboli e a dar loro ciò che la libertà non permette di raggiungere: la felicità terrena. La Chiesa, per quindici secoli, afferma l’Inquisitore, ha lavorato per questo. Ormai gli uomini sono convinti di essere perfettamente liberi. In realtà hanno deposto la loro libertà ai piedi di chi ha accettato di passare con lui (il diavolo) non rifiutando le sue tentazioni, ripudiando la parola di Cristo, ma facendo credere di fare tutto questo in nome di Cristo stesso. (...) Dispone della libertà degli uomini solo chi ne acquieta la coscienza (...). Ci sono sulla terra tre forze, tre sole forze capaci di vincere e conquistare per sempre la coscienza di questi deboli ribelli, per la felicità loro; queste tre forze sono: il miracolo, il mistero e l’autorità. L’uomo, pur nella sua debolezza, non può sopprimere la coscienza e vuole avere un concetto sicuro per cui vivere. Non solo il pane terrestre avrà da questi “nuovi dei”: (...). Certo li obbligheremo a lavorare, ma nelle ore libere dal lavoro organizzeremo la loro vita come un giuoco infantile con canti e cori e danze innocenti. Oh, noi consentiremo loro anche il peccato, perché sono deboli e inetti, ed essi ci ameranno come bambini perché consentiremo loro di peccare (…). Tutti, tutti i più tormentosi segreti della loro coscienza, li porteranno a noi, e noi risolveremo ogni caso, ed essi avranno nella nostra decisione una fede gioiosa, perché li libererà dal grave fastidio e dal terribile tormento odierno di dovere personalmente e liberamente decidere. 1 2 3 4 DOSTOEVSKIJ, op. cit., pag. 271. Fëdor, DOSTOEVSKIJ, op. cit., pag. 272. Fëdor, Ibidem. DOSTOEVSKIJ, Fëdor, op. cit., pag. 276. 66 AIELLO, Lucia L’atto del Grande Inquisitore ha in sé tutta la necessità morale della redenzione cristiana: egli si sacrifica per amore dell’umanità. Ivan/Grande Inquisitore è pieno di amore per l’umanità, si vota alla menzogna e si fa Uomo/Dio per difendere la felicità degli altri, ben consapevole della sofferenza che questa scelta costa a lui. Lo stesso sentimento anima Kirillov, uno dei Demoni, che compie un atto di negazione: si uccide e non per paura della finitezza, per paura della morte, ma per affermare il suo libero arbitrio e per dimostrare a Dio che la sua migliore arma, il terrore della morte, ha perduto il suo potere. Kirillov compie una rivoluzione grandiosa: 1 DOSTOEVSKIJ, Fëdor, I Demoni, traduzione italiana di KUFFERLE, Rinaldo, Milano, Garzanti, 1973, pag. 241. 2 3 4 3DOSTOEVSKIJ, op. cit., p. 240. Fëdor, 4DOSTOEVSKIJ, op. cit., p. 241. Fëdor, Lo stesso concetto lo ritroviamo espresso ancora ne I Demoni, laddove Šigalev teorizza un modello di società in cui i nove decimi dell’umanità sono sottoposti al restante decimo. Questa minoranza, appropriatasi della libertà della maggioranza, non dovrebbe far altro che pensare e agire per il benessere e la felicità della maggioranza stessa. Solo così secondo Sigalev è possibile raggiungere una società perfetta, ma bisogna pagare un prezzo: “Mi sono imbrogliato tra i miei propri dati, e la mia conclusione è in diretta contraddizione con l’idea iniziale da cui parto. Partendo da un’assoluta libertà, concludo con un assoluto dispotismo. Aggiungerò però che tranne la mia soluzione della formula sociale non ce ne può essere nessun’altra”. (DOSTOEVSKIJ, Fëdor, op. cit., pag. 407) (Kirillov) — Verrà e il suo nome sarà uomo/Dio. (Stavrogin) — Dio/uomo? (Kirillov) — No, uomo/Dio, c’è una differenza. Il suo suicidio è un atto assolutamente gratuito, la negazione volontaria della vita, per amore della vita. Egli compie un salto dalla necessità all’arbitrio incondizionato. Il primo gesto da Uomo/Dio è compiuto non solo per sé, ma per l’umanità intera, per passare a una società di Uomini/Dei, una società in cui, quando tutti si renderanno conto che tutto è bene e che gli uomini sono buoni, allora non ci sarà più male: (…) L’uomo è infelice perché non sa di essere felice; solo per questo. É tutto, tutto! Chi lo saprà, colui diventerà subito felice, sull’istante; svuota anche il senso della colpa e dell’espiazione; per una mente euclidea tutto avviene naturalmente, tutto si equilibra. Il rifiuto della Redenzione porta alla concezione che tutto sia bene e a considerare il “bene” e il “male” come aspetti della ciclicità della vita. Il senso della vita non sta in un’armonia futura, in Dio. Cade il senso dell’atto supremo del Dio/uomo, per cedere il posto all’uomo/Dio, il cui primo atto non è una azione, ma una negazione, una disobbedienza. Ma i due gesti portano a esiti differenziati. Mentre il Grande Inquisitore non vuole che l’inganno si sveli ed è convinto che solo pochi eletti possano sostenere il peso della responsabilità di gestire la felicità terrena degli uomini, Kirillov è invece convinto che tutti gli uomini saranno Uomini/Dei: il gesto del Grande Inquisitore porta all’Obbedienza, il gesto di Kirillov porta all’affermazione incondizionata del libero arbitrio. Dal primo atto di ribellione da Uomo/Dio si apre la possibilità di mondi nuovi, in cui tutti saranno buoni nel momento in cui ne avranno coscienza, e cioè nel momento in cui annulleranno il Divino che è in loro e si ergeranno a Uomini/Dei, comprensivi l’uno verso l’altro perché coscienti della loro finitezza. Ciò che accomuna Ivan/Grande Inquisitore a Kirillov è la compassione, nel senso etimologico del termine (dal latino cum e passio: sentire, patire in comune): i loro atti non sono motivati dalla sete di potere o da manie di grandezza da superuomo, ma dalla consapevolezza della problematicità della condizione umana. e poi ancora, gli uomini (...) sono molto cattivi (...) perché non sanno d’essere buoni. Quando lo sapranno, non violenteranno la bambina. Hanno bisogno di saperlo che son buoni, tutti fino a uno. Kirillov, come Ivan/Grande Inquisitore, rifiuta la libertà, non riconosce quindi il sacrificio di Cristo e il valore della Redenzione. In quest’ottica si I n Dostoevskij non troviamo una sintesi a cui ricondurre in maniera definitiva gli elementi di tensione. Obbedienza, libertà, libero arbitro, obbedienza come sottomissione, obbedienza-a-Dio, libertà-in-Dio, obbedienza all’Inquisitore che è rifiuto della libertà di Dio, libero arbitrio e volontà che contrastano con la libertà in Dio: sono i termini entro cui la tensione si svi- “Consenso ed “Obbedienza”… Dostoevskij luppa. Le tematiche sono intrecciate tra di loro in un rapporto dialettico che Dostoevskij evidenzia in tutta la sua problematicità e ambiguità, grazie alla struttura polifonica dei suoi romanzi. Le argomentazioni contrapposte non solo sono affermate con uguale vigore, ma ognuna di esse è inserita in un gioco di specchi che le moltiplica e a volte le deforma. Se è vero che la rivolta contro Dio, l’affermazione del libero arbitrio, porta alla costrizione e all’Obbedienza, è anche vero che la causa originaria di tutto ciò risiede proprio in quel sacrificio di Cristo per una libertà di cui la maggior parte degli uomini non possono fruire perché incapaci di gestirla. Anche i personaggi votati totalmente al bene, quelli che dovrebbero essere i portavoce dell’etica cristiana, non sono inquadrabili nell’ambito dell’ortodossia ufficialmente riconosciuta, escono dai quadri canonici, presentano i tratti di quella che Pareyson chiama “l’ambiguità del bene” che è anche l’ambiguità dell’idea di libertà-in-Dio. I confini tra Consenso e Obbedienza risultano, di conseguenza, sempre più sbiaditi, nel momento in cui un atto di obbedienza si qualifica come atto di volontaria rinuncia alla libertà di scegliere, e quindi, ancora una volta esercitazione delle possibilità date da quel dono o dato originario. É la questione della libertà, e il concetto che di essa si è veicolato nel corso dei secoli, che è problematica e si ripropone in tutta la sua scottante attualità. É o no legittimo, per estremizzare, evidenziare il grado di consenso e di esaltazione, che comunque va registrato, delle folle, perché di folle si tratta, e non anonime, ma fatte di uomini concreti, per il più dispotico dei regimi, cioè la dittatura? DELLA FRANCESCA, Piero, San Girolamo ed un Devoto 67 68 Aldo Oliveri Consenso e Validità Scientifica L 1 Cfr. p. e. GALILEO, Galilei, Il Saggiatore, traduzione dal latino di SOSIO, Libero, Milano, Feltrinelli, 1992. 2 POPPER, Karl Raimund, The logic of Scientific Discovery, (1934), trad. it. di TRINCHERO, M., La logica della scoperta scientifica, Torino, Einaudi, 1970. Per un primo approccio a 3 Feyerabend si può consultare FEYERABEND, Paul K., Against method. Outline of an anarchistic theory of knowledge, (1975) traduzione italiana a cura di SOSIO, Libero, Contro il metodo. Abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza, Milano, Feltrinelli, 1979 e FEYERABEND, Paul K., Der wissenschaftstheoretische Relismus und die Autoritt der Wissenschaften, (1978) traduzione italiana di ARTOSI, A., Il realismo scientifico e l’autorità della scienza, Milano, Il Saggiatore, 1983. KUHN, Thomas S., The Struct4 ure of Scientific Revolution, (1962) traduzione italiana di CARUGO, A., La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Torino, Einaudi 1969. 5 MORIN, Edgard, Science avec conscience, (1982) traduzione italiana di QUATTROCCHI, P., Scienza con coscienza, Milano, Angeli, 1992. ’immagine -- di origine positivistica -- che la maggior parte delle persone hanno della scienza è quella di uno sviluppo progressivo ed indefinito verso la piena comprensione della realtà fenomenica che ci circonda. I dati sperimentali disponibili in un dato momento, o almeno il maggior numero possibile di essi, vengono ordinati in una teoria capace di predire nuovi fenomeni, di determinare le loro caratteristiche quantitative con un apposito esperimento approntabile, effettivamente o anche solo di principio, allo scopo. Quando le teorie, che nascono sempre da ipotesi connettive e formalizzate matematicamente (motivo per cui il metodo scientifico è definito anche ipotetico/ deduttivo) sono più di una, e spesso tra loro alternative, si cerca di ideare quell’esperimento, definito cruciale, che permette di stabilire quale teoria è quella “vera”. Il metodo della verifica sperimentale sembrerebbe, dunque, costituire un arbitro imparziale della validità oggettiva di una teoria rispetto alle altre teorie alternative, della sua effettiva “corrispondenza” con la realtà. Certo nuovi dati possono, ogni tanto, mettere in discussione questa corrispondenza e ricordarci che le teorie scientifiche sono un prodotto dell’attività spirituale dell’uomo, di quel “soggetto”, cioè, che la scienza, basata sul postulato di oggettività, tende ad estromettere o a ridurre ad occasionale produttore di teorie intrinsecamente valide. In questi casi allora si tende a dire che la scienza è progressiva, tende cioè ad un accumulo della conoscenza attraverso un movimento lineare, forse infinito, l’unico in grado di cogliere la complessità del reale e ricondurlo a quell’unità strutturale fondamentale da cui ha origine. Molti scienziati sono così fiduciosi del loro metodo, del fatto che la realtà ultima sia esprimibile in termini matematici, e quindi ideali, come aveva sostenuto per primo Galileo, da ritenere l’effettiva realtà fenomenica nient’altro che un’approssimazione, distorta soggettivamente dai nostri sensi limitati, di quella “vera”, oggettiva, da loro descritta. L’epistemologia critica moderna, in ogni caso, ci ha fatto capire come tale sviluppo non sia affatto lineare e come in realtà risente degli interessi e dei valori sociali e culturali entro cui l’attività scientifica opera. Popper, ad esempio, sottolineando il carattere induttivo, e quindi intrinsecamente probabilistico, delle sue leggi ha evidenziato come la conoscenza scientifica non progredisca per accumulo di verità, e dunque come le basi della scienza siano meno solide di quanto sembri: essa non poggia sulla roccia ma è “costruita su palafitte”. Feyerabend ha poi parlato di scienza anarchica per sottolineare come non esistano regole precise nella costruzione delle teorie scientifiche. Ogni teoria costituisce una visione del mondo costruita sulla base di una parte delle esperienze disponibili e può venir criticata solo da un’altra teoria che si poggia anch’essa su una base di esperienze parziali. Le due teorie, così costruite, sono, come le definì per primo Kuhn, incommensurabili e la scelta tra loro non avviene più sulla base di criteri oggettivi ma sui giudizi soggettivi espressi dalla comunità degli scienziati. Come sostiene Morin: “L’ultima scoperta dell’epistemologia anglosassone è che è scientifico ciò che è riconosciuto come tale dalla maggioranza degli scienziati. Vale a dire che non esiste alcun metodo oggettivo per considerare la scienza come oggetto di scienza e lo scienziato come soggetto.” 69 La validità scientifica si basa così sulla retorica, sulla capacità persuasiva dei suoi autori. Storicamente si è assistito diverse volte alla contrapposizione di teorie “rivali”, formulate sulla base di una diversa valutazione dei dati sperimentali, risolta con l’adozione da parte della comunità scientifica di una delle due. In ogni teoria, che non sia una invenzione arbitraria, c’è sempre un certo contenuto di verità, e spesso una teoria “perdente” in un determinato momento storico ha rivelato successivamente tutta la sua fecondità concettuale; ma sul momento è proprio la valutazione degli “addetti ai lavori”, il loro consenso, il loro giudizio sull’importanza delle “prove” sperimentali a decidere un tipo di sviluppo scientifico/tecnologico, più o meno proficuo, rispetto a possibili percorsi alternativi. Venuta meno la certezza dogmatica del sapere scientifico/sperimentale, sottolineata la sua relatività culturale e storica, bisogna ancora considerare la sua dipendenza dalla sfera soggettiva dello scienziato. Infatti Popper stesso ha sottolineato come la sua messa in evidenza della validità induttiva delle leggi scientifiche era riferita a quello che Reichenbach ha definito come il contesto di giustificazione della scoperta già avvenuta, mentre la scoperta vera e propria rientrava nella sfera soggettiva dello scienziato sia pure inserito nella tradizione culturale e scientifica della propria epoca. Per quanto riguarda l’aspetto relativo al contesto della scoperta scientifica ci si rende sempre più conto di come l’invenzione scientifica (come forse è più giusto chiamarla) per quanto mai arbitraria e sempre comunicabile simbolicamente, non sia riducibile ad un mero algoritmo deduttivo. In caso contrario, i computer avrebbero già dovuto produrre infinite scoperte scientifiche ed invece si limitano ad eseguire velocemente calcoli di cui non capiscono nulla. Alla base della scoperta scientifica c’è infatti una comprensione delle connessioni tra i fenomeni di tipo analogico che è frutto dell’intuizione soggettiva dello scienziato, di tutto il suo bagaglio di esperienze, del suo “vissuto”, tradotta in formalizzazione simbolica e riscontrata dal dialogo sperimentale. Certo, la familiarità con la materia trattata, la conoscenza approfondita dei fenomeni e della metodologia d’indagine favorisce l’elaborazione di ipotesi 1 BRUEGEL, Pieter (il vecchio), Il Paese di Cuccagna REICHENBACH, Hans, The Rise of Scientific Philosophy, (1951) traduzione italiana di PARISI, D. E e PASQUINELLI, A., La nascita della filosofia scientifica, Bologna, Il Mulino, 1961. 70 pertinenti: la competenza non si improvvisa ma è conseguenza di studi laboriosi. Tuttavia, la competenza tecnica, pur indispensabile, non è di per sé sufficiente alla produzione di idee innovative. Queste, generalmente, si presentano in scienziati relativamente giovani, con un bagaglio tecnico già notevole ma in cui il sapere acquisito non ha ancora ucciso il piacere dell’immaginazione, della fantasia. Un esempio di idea innovativa (riferita ad un nuovo modo di vedere fenomeni di organizzazione della materia in condizioni termodinamiche lontane dall’equilibrio, conosciute come “celle di Bernard” e denominate nella della Teoria della Complessità da Prigogine “strutture dissipative”) è quella dell’irreversibilità temporale. La scienza classica, in particolare la meccanica, formula le sue leggi servendosi di equazioni differenziali di secondo grado che sono invarianti alla trasformazione +t -t; concepisce cioè il tempo come un parametro reversibile e quindi postula l’equivalenza di passato e di presente. La proposta di Prigogine tende invece a rendere coerente il concetto scientifico del tempo con quello 1 PRIGOGINE, Ilya e STENGERS, Isabelle, La nouvelle alliance. Metamorphose de la science, (1979), traduzione italiana di NAPOLITANI, P., La nuova alleanza, Torino, Einaudi, 1981. MERZ, Mario, 610 Funzione di 15 della nostra esperienza vissuta, ribaltando quindi completamente la filosofia scientifica dominante che identifica la percezione del mutamento come un limite delle nostre capacità conoscitive nei confronti di una realtà idealisticamente oggettiva e invariante. Idee innovative come questa, per affermarsi, devono prima penetrare nella mentalità, fondamentalmente conservatrice, degli scienziati, ottenere il loro consenso e con esso la realizzazione di un programma di ricerche finalizzate. Infatti gli esperimenti costano, richiedono finanziamenti che vengono elargiti sulla base della loro presunta validità (conoscitiva ma anche relativa a vantaggi economico/militari) e che sono necessari per allestire quella “sceneggiatura” sperimentale che, sola, permette di interrogare la natura sulla base di un’idea preconcetta. Il consenso della comunità scientifica (sulla base di concezioni ideologiche e metafisiche come sulla base di interessi economici e politici) è quindi il fondamentale criterio di validità scientifica su cui poggia lo sviluppo della scienza, della tecnica, e, in definitiva, del modello sociale in cui vivremo. 71 Riccardo Galiani Il Consenso Ingannatore Cominciamo con alcune definizioni: Consenso: incontro di volontà; conformità, concordia di volontà, giudizi, opinioni, sentimenti, o accordo su un punto specifico, fra due o più persone (ZINGARELLI, Nicola, Vocabolario della lingua Italiana, 1970); Consent: to agree together; voluntary agreement to or acqiuscence in what another proposes or desires; agreement in feeling, sympathy (The Oxford Universal Dictionary, 1973); Consenso: atteggiamento di adesione ad un costrutto potenzialmente o attualmente normativo (cfr. STRADA, Vittorio, voce “Consenso/Dissenso”, in Enciclopedia Einaudi, 1978; vol. III, pp. 806-817, p. 806). Consideriamo prima le definizioni contenute nei due dizionari; ciò che in esse viene sottolineato è l’aspetto dinamico del fenomeno “consenso”: qualcosa che diviene in un contesto relazionale. Il consenso come possibile risultato di un incontro tra individui (condizione necessaria), tra le loro volontà ed il loro sentire (agreement in feeling; condizioni necessarie e sufficienti). Un film statunitense, La parola ai giurati , che ha per oggetto la seduta di una giuria popolare, chiamata ad esprimersi su di un caso di presunto parricidio, rappresenta forse un buon esempio dei rapporti esistenti tra tali condizioni ed il manifestarsi di un consenso. All’inizio undici giurati su dodici sono concordi (esprimono apparentemente un consenso) nel ritenere colpevole l’imputato; il dodicesimo dissente non tanto perché convinto del contrario, ma piuttosto perché ha ragione di dubitare della veridicità della convinzione degli altri e del consenso manifestato riguardo ad essa. Nello spazio di alcune ore, i dodici giurati si ritroveranno concordi sulle posizioni del sostenitore del “ragionevole dubbio”. Il consenso ha cambiato segno. Individui certi di aver già trovato l’accordo tra le loro volontà ed il loro sentire, hanno negoziato il valore attribuito alle proprie convinzioni ed hanno prodotto un mutamento. Un nuovo consenso. Il consenso appare quindi come il risultato della dinamica generata dall’incontro di più individui. Tuttavia, l’incontro contenuto nell’esempio scelto ha luogo in condizioni particolari. Esso si trova come “tra parentesi”; le persone non si conoscono, hanno momentaneamente reciso – sospeso – i legami con il contesto sociale cui appartengono; la decisione che dovranno prendere non avrà influenza sulla struttura delle loro relazioni sociali intese in senso “esteso” (è possibile cioè immaginare una moglie più o meno fiera del resoconto fattole dal marito; con più difficoltà immaginiamo lo stesso marito mettere al corrente di quanto accaduto un capoufficio o un cliente). Siamo quindi di fronte ad una situazione anomala. Ciononostante essa contiene un elemento fondamentale per determinare la natura “reale” del consenso, e cioè il riferimento alla Legge, come norma comune ad un numero di individui superiore a quello rinchiuso nella camera di consiglio. La situazione considerata permette cioè di osservare la struttura stratificata del consenso: il primo strato visibile è quello dell’incontro tra il volere ed il sentire di due o più individui, mentre lo strato successivo, che comprende il primo, è costituito dall’incontro tra il volere ed il sentire di uno o più individui ed il volere ed il sentire di una maggioranza. Di questi due ultimi fe- 1 LUMET, Sidney (regia di), Twelve angry men, 1957. GALIANI, Riccardo 72 1 GERGEN, K. J., e GERGEN, M. M., Social Psychology, New York, Springer/Verlag, 1986 (traduzione italiana Psicologia Sociale, Bologna, Il Mulino, 1990, p. 190) 2 Il riferimento al termine tedesco Kultur, che ritorna in diversi passaggi dell’articolo, è dettato dall’esigenza di sottolineare, più di quanto consenta l’uso distinto dei termini italiani “cultura” e “civiltà”, il legame strutturale esistente tra gli elementi, propri ad ogni contesto sociale, atti a produrre un arricchimento intellettuale dei membri di una civiltà, e la civiltà stessa. Il termine Kultur si presta cioè a significare contemporaneamente “grado di civiltà” e “livello culturale”, una contemporaneità che nella lingua italiana permane esclusivamente nell’uso dotto dei termini “cultura” e “civiltà”. Per una discussione più approfondita della questione si rinvia alle voci “Civiltà” e “Cultura/Culture”, rispettivamente di SACHS, I. e di LEACH, E., dell’Enciclopedia Einaudi, Torino, 1978. 3 Ibid. nomeni ciò che appare è la loro, già compiuta, trasformazione in norma, ovvero la codificazione di un antico consenso. Il prevalere di questo codice sedimentato sui codici alternativi che possono risultare dagli incontri “minimi” tra sentire e volontà è ciò che costituisce la continuità, necessariamente conservatrice, di una cultura (Kultur). Le forme della conservazione, per essere efficaci, devono però agire non solo sulle altre possibili forme di consenso, ma sulle premesse stesse del consenso, ovvero sul volere ed il sentire individuale. A questo punto, la definizione di consenso ricavata dall’articolo “Consenso/Dissenso” di Vittorio Strada, pare più soddisfacente: “atteggiamento di adesione ad un costrutto potenzialmente o attualmente normativo”. Trattando del consenso occorre quindi considerare la relazione con questo tipo di costrutto. Può essere utile, per comprendere la natura di questa relazione, muovere da una sua manifestazione estrema di carattere adesivo: la condivisione di un pregiudizio. Sono cresciuto nel Minnesota, dove ci sono molti pregiudizi contro gli indiani (...). E, devo dire, che per un sacco di tempo anch’io l’ho pensata così. Dopo essere venuto all’università, ed aver cominciato a riflettere sulla condizione di vita degli indiani, ho cominciato a pensare che gli atteggiamenti così comuni al mio paese sono precostituiti. Ma la cosa terribile è che ogni volta cha vado a casa per un po’ mi accorgo di scivolare di nuovo dentro l’antico modo di pensare (...). é veramente difficile dire ai miei amici che loro sono un branco di razzisti fanatici. Il brano citato consente di osservare, secondo un diffuso manuale di psicologia sociale, l’azione di “uno dei più potenti meccanismi di sostegno al pregiudizio: il consenso sociale”. Ma da cosa, e come, nasce questo consenso? Adoperando ancora le categorie della psicologia sociale potremmo rispondere che il consenso (per sua natura, sociale) è il risultato della pressione all’uniformità/conformità, o, meglio: il consenso rappresenta l’obiettivo implicito (ed ultimo) della pressione all’uniformità/conformità, espressione che si riferisce al processo concludentesi con l’adesione ad una norma (più spesso implicita che esplicita). E l’adesione ad una norma, o meglio ad un corpus normativo, costituisce la struttura e la ragion d’essere di ogni Kultur. L’esistenza e l’efficacia della pressione all’uniformità/conformità è stata l’oggetto di alcuni esperimenti di psicologia sociale, divenuti ormai classici. Consideriamo brevemente quanto posto in luce da tre di questi studi. 1. Con l’intenzione di valutare gli effetti prodotti dal confronto sociale, Muzafer Sherif nel 1935 allestì ad Harvard un esperimento sulla valutazione del movimento apparente. Dei soggetti vennero condotti uno alla volta all’interno di una camera completamente buia e ad ognuno di essi venne data l’istruzione di valutare, discrezionalmente, il “movimento” compiuto da un punto di riferimento luminoso in posizione fissa (l’illusione ottica, nota come effetto autocinetico, è dovuta alle condizioni di oscurità). Successivamente ai soggetti venne chiesto di ripetere l’operazione riuniti in piccoli gruppi. L’assunto da cui muoveva Sherif era che, non esistendo alcun criterio obiettivo per valutare il movimento del punto luminoso, le eventuali variazioni di giudizio si sarebbero potute ascrivere totalmente al mutare delle condizioni sperimentali, ovvero al dover formulare le valutazioni in gruppo. I risultati parvero confermare l’ipotesi formulata in merito all’influenza del confronto sociale: nella condizione di gruppo le valutazioni individuali tendono ad uniformarsi, mentre quelle espresse in precedenza singolarmente risultano, se illustrate graficamente, molto più disperse. Questa tendenza all’uniformità può essere interpretata come un adeguamento inconsapevole (non prodotto cioè da una riflessione, ma manifestantesi come nuova e diversa percezione) alla presunta opinione comune; tale adeguamento sarebbe sollecitato 73 Il Consenso Ingannatore dallo stesso confronto sociale. Come dimostrarono successive interviste ai partecipanti all’esperimento, l’effetto di questa tendenza uniformante può permanere per circa un anno, posto che non intervengano diversi fattori di influenza. 2. Salomon Ash nel 1946 chiese ad alcuni soggetti, volontari in una presunta ricerca sulla percezione, di valutare comparativamente la lunghezza di alcune rette disegnate su di un pannello; il compito dei partecipanti è cioè quello di valutare se le rette in questione sono più grandi o più piccole di una retta assunta come parametro. I gruppi sperimentali sono composti da “complici” dello sperimentatore e da un unico soggetto “ingenuo”. Le valutazioni vengono eseguite a voce alta; dopo la prima tornata di valutazioni che, in quanto reali, risultano concordi, il soggetto ingenuo, a cui spetta, in ogni tornata, di formulare la sua valutazione per ultimo, è messo di fronte ad una serie di palesi errori di valutazione: i soggetti complici dello sperimentatore dichiarano cioè di ritenere di lunghezza uguale alla retta parametro rette più corte di alcune decine di centimetri. I risultati di questi esperimenti dicono che nel 33% dei casi il soggetto ingenuo fornisce, in queste circostanze, un giudizio concorde con quello espresso dalla maggioranza dei presenti, anche nel caso in cui l’errore resta di proporzioni notevoli. Si parla in questo caso di pressione alla conformità, in quanto il soggetto, per non differenziarsi dalla maggioranza, muta consapevolmente il proprio giudizio; uno sviluppo per nulla infrequente di questa conformità è la convinzione postuma dell’erroneità della propria percezione: il soggetto preferisce distorcere il proprio dato percettivo anziché accettare di aver ceduto ad una pressione sociale. 3. Nel 1965 Stanley Milgram organizzò il seguente esperimento: ad alcuni 1 Una tale conformità di errore non è evidenziata dai gruppi di controllo, composti unicamente da soggetti ingenui. 2 GENTILE DA FABRIANO, Adorazione dei Magi Per quanto sia teoricamente possibile, l’eventualità che tutti i soggetti esaminati da Ash (o la maggior parte di essi) si siano conformati inconsapevolmente alle valutazioni del gruppo per ragioni non previste dalla procedura sperimentale appare estremamente remota. GALIANI, Riccardo 74 soggetti viene offerta una somma di danaro (circa 4 dollari e mezzo, somma modesta) per partecipare ad un progetto di ricerca presso una prestigiosa università. Le finalità dell’esperimento comunicate sono quelle di uno studio degli effetti prodotti dalle punizioni sull’apprendimento. I soggetti pagati, che sono la componente ingenua dell’esperimento, dovranno esercitare l’eventuale azione punitiva su di un complice degli sperimentatori (l’ “allievo”), collocato nella stanza attigua a quella in cui si trova il soggetto (sicché egli può sentire, ma non vedere, le reazioni dell’allievo alle punizioni inflittegli), servendosi di un apparecchio che somministra scosse elettriche, da un minimo di 15 ad un massimo di 450 volt. All’allievo vengono poste dallo sperimentatore, che si trova nella stessa stanza del soggetto retribuito per fungere da esecutore, delle domande; ad ogni risposta errata il soggetto deve somministrare una scossa di intensità crescente. Tali scosse si somministrano premendo alcuni pulsanti indicanti il grado di pericolosità della scossa stessa. Sotto la pressione dello sperimentatore, il 62% dei soggetti, pur opponendo in alcuni casi una notevole resistenza, arrivò a premere il pulsante contrassegnato come “scossa estremamente pericolosa” (450 volt), anche dopo che l’“allievo” aveva apertamente dichiarato di sentirsi male e di essere sofferente di cuore. L’ipotesi di Milgram era per l’appunto che una pressione autoritaria potesse produrre, partendo da un consenso rappresentato dall’adesione all’esperimento, un’obbedienza (una forma di consenso) “distruttiva”. Come si vede, nel setting sperimentale allestito da Milgram la pressione non è esercitata da una “maggioranza”, ma da un’autorità la quale, agli occhi del soggetto, esercita in questo caso il proprio potere nello stesso modo in cui lo esercita la maggioranza: rendendo inadeguata (quando non pericolosa) l’espressione di una diversità di opinioni e di azioni, quindi di un dissenso. Un tale esercizio di potere si manifesta, nella fatti- specie, attraverso il prestigio di un’istituzione, di un sistema, quello universitario, rappresentato dall’autorità dello sperimentatore. Non era nelle intenzioni degli autori analizzare, attraverso questi esperimenti, la natura del consenso; mi pare tuttavia legittimo l’aver posto in relazione le categorie di “uniformità”, “conformità” ed “obbedienza”, proprie della psicologia sociale, con la natura del consenso, per quanto si potranno avanzare altre obiezioni sulla liceità della generalizzazione di un simile modello interpretativo. Ad esempio, si obietterà che lo stesso Ash escluse l’automatica estensione delle considerazioni ricavabili dai risultati ottenuti a contesti diversi, più ampi e meno caratterizzati dall’interazione diretta tra le persone, mentre l’ influenza degli altri fattori riconosciuti da Ash come agenti sul grado di conformità espresso – l’ambiguità dello stimolo, l’attrazione verso il gruppo, le prospettive di interazioni future – è facilmente riscontrabile anche in situazioni non così fortemente caratterizzate come quelle del setting sperimentale creato da Ash. Tuttavia, credo che ostacoli di questo tipo possano essere superati affermando che la conformità rappresenta, per così dire, l’aspetto paradossale, immaturo del consenso, vista la distorsione consapevole della percezione e del giudizio; paradosso che può darsi solo in condizioni che assicurano l’interazione faccia a faccia di un certo numero di individui. Non ha bisogno di rapporti ispirati al paradosso la relazione uniformità/ consenso, così come si può ricavare dall’esperimento di Sherif; qui l’omologazione si produce senza l’apporto della consapevolezza e la convinzione cui dà luogo ha, come visto, effetti ben più duraturi, creando un arco di tempo durante il quale negli individui uniformatisi in tale maniera riguardo ad un giudizio può facilmente svilupparsi ciò che definiamo consenso. 75 Il Consenso Ingannatore ROSENQUIST, F-111 (particolare) Un aspetto particolare del consenso, che pare essere ciò a cui in molti casi esso si riduce, è messo in luce dall’esperimento di Milgram. In tali circostanze il consenso consiste nell’accettare, nel condividere, finché l’esperimento è in corso e vi si continua a partecipare, la necessita della procedura proposta dallo sperimentatore, per quanto la manifestazione concreta di questa condivisione, cioè la somministrazione della scossa, possa essere preceduta da un’opposizione veemente e da un travaglio interiore. Nonostante possa essere considerato un comportamento che, sin dal principio, assume una forma diversa dal consenso, l’obbedienza all’autorità, l’atto dell’obbedire non può compiersi senza un consenso preliminare. La necessita “interiore” di comportarsi in maniera coerente con un tale consenso è proprio ciò che l’esperimento di Milgram mostra essere un elemento esclusivamente situazionale, e quindi, dal punto di vista individuale, un costrutto artificiale, difensivo. Il soggetto cioè è vincolato dalla propria adesione all’esperimento solo se continua a riconoscere il valore dell’esperimento stesso, e quindi dell’autorità (dell’istituzione) che lo ha organizzato; allo stesso modo, solo se continua a riconoscere “interiormente” la norma nel comportamento dei più il soggetto sarà disposto ad acconsentire ad una valutazione palesemente errata ma sostenuta dalla maggioranza. Dall’aver acquisito questi esempi nella loro funzione di elementi che testimoniano della circolarità della catena Kultur - pressione all’uniformità/conformità - consenso - mantenimento del pregiudizio (caso limite della conservazione della norma) - Kultur, ricaviamo una domanda: può darsi un consenso non indotto? In altri termini: esiste la libera scelta del consenso? I territori di una tale liberta dovrebbero essere, considerato quanto detto, quelli che cominciano oltre i confini del contesto sociale, i territori dell’individuo chiuso in se stesso. Si tratterebbe cioè di un consenso non comunicato, ovvero di un “puro sentire” orientato alla decisione: io sento che ciò che si dice sugli – e agli – indiani del Minnesota è vero, assumo questo sentimento come una mia decisione riguardo ciò che è reale e la tengo per me, non partecipo con essa ad una “comunità del sentire”, né avverto la presenza di questa comunità nel processo di formazione della mia decisione. Possiamo ritenere sufficiente questa “difesa” del consenso? A mio parere no; e questo perché dopo Freud quali che siano i nostri convincimenti, le decisioni individuali, insomma quelle manifestazioni del 76 pensiero che per molti costituiscono uno scudo con cui parare gli attacchi della pressione conformante/uniformante, produttrice di consenso, non possono non apparire come il risultato di un altro tipo di pressione (termine quanto mai “dinamico”): quella originata dal confronto tra le diverse componenti della personalità di colui che “decide”. Il comportamento, l’azione consapevole, è sempre il risultato di un cedimento sotto una pressione: sia quella del mondo esterno, sia quella del mondo interno e di ciò che lo costituisce (l’insieme mente/corpo).Va da sé che il soffrire o meno per tale cedimento, il suo apparire o non apparire esplicitamente in quanto tale, dipende dal “peso” (ossia dal valore) assegnato all’oggetto della decisione e dalla violenza della pressione esercitata. A ben vedere entrambi gli elementi citati (il valore dell’oggetto e la forza della pressione) fanno anch’essi parte di quella catena o circolo all’interno del quale ha luogo il consenso, poiché ad esso appartengono i criteri valutativi che contribuiscono alla “taratura” dell’oggetto della decisione ed alla misurazione della pressione esercitata. In altre parole, il comodo e chiaro riferimento al soggetto come unità compiuta e conclusa viene meno anche e soprattutto nell’analisi del processo decisionale; tenere conto di questo equivale a ampliare per poi ridiscutere i termini che definiscono il consenso, e cioè: se il comportamento può essere in ogni caso interpretato come il risultato di una “pressione”, anche ciò che usualmente è definito decisione deve essere inteso come consenso, ovvero come il risultato di una negoziazione, svoltasi all’interno di ciò che convenzionalmente definiamo soggetto, tra forze non aventi un eguale potere negoziale. “Non è solo il nevrotico che non è padrone di se stesso, lo è, innanRICOEUR, Paul, De l’inter- zitutto, l’uomo che ha una morale, pretation. Essai sur Freud l’uomo etico”, dove per ethos si in(traduzione italiana Genova, Il tende “mores, Sittlichkeit, cioè costumi, Melangolo, 1991, p. 175). morale effettiva”; e l’esercizio del consenso sta proprio nell’adesione ad Ibid., p. 178. un uso (anche e soprattutto “quotidia- 1 2 GALIANI, Riccardo no”) o alla proposta di mutamento di un uso in vigore. Si potrà a questo punto obiettare che una tale conclusione poggia su di una premessa falsa, quella per la quale ogni consenso (sociale) è il risultato di una pressione, come se il modello sperimentale approntato dagli psicologi sociali fosse universalmente valido. Non sempre, si dirà, si danno condizioni come quelle create negli studi di Ash, Sherif e Mowrer, mentre ciò che abitualmente si definisce consenso si manifesta nelle più svariate circostanze. Proviamo allora a distinguere tra due possibili tipi di consenso: quello palesemente conforme rispetto a qualcosa che possiamo far rientrare nella categoria della “maggioranza” (come nel caso degli esperimenti di Sherif ed Ash riguardo al piccolo gruppo), e quello che, riprendendo le definizioni da cui siamo partiti, possiamo ascrivere all’incontro di due o più volontà individuali. Tuttavia parlare ancora, in questo contesto, di volontà “chiare e distinte” crea un certo imbarazzo, equivalendo ad un rifiuto del confronto con l’ormai non più nuovo, ma sempre disorientante statuto del soggetto (beninteso l’imbarazzo nasce non dalla contraddizione in sé, ma dal fatto che essa poggerebbe sul disconoscimento di quello che è il risultato della recente storia del pensiero occidentale). Rispetto a ciò che è in uso, resta quindi il primo tipo di consenso; rispetto a ciò che è sfuggito all’uso resta una possibilità, che è quella di restituire al significante “consenso” il suo significato di “simpatia” svincolata dall’intenzione di cui dobbiamo necessariamente (ed illusoriamente) ritenerci titolari. Tale significato sembrerebbe conservarsi nelle forme degli atti “ingenui” (“voto per lui così… perché mi ispira simpatia”); ma la fiducia in questa conservazione è minata da un dubbio: che l’elemento ingenuo sia tale solo in virtù del fatto che è questo il suo ruolo all’interno della catena circolare cui in precedenza ho fatto riferimento, non perché il suo posto sia al di fuori di essa. Non si tratta di inge- 77 Il Consenso Ingannatore nuità “naturale”, ma di ingenuità “culturale”. L’azione (o meglio la non azione) dell’elemento ingenuo che manifesta consenso, non è ispirata alla “simpatia”; si tratta piuttosto del risultato meno visibile ma al tempo stesso più duraturo della pressione all’uniformità. “Mi piace perché è proprio come uno di noi, come me. Ma io come sono? non lo so; so però che mi piacerebbe essere come lui”. Nel caso di simili atti ingenui non è possibile conservare nemmeno la forma “consenso”, termine che comunque è depositario, come abbiamo visto, di una tensione derivante dalle dinamiche inter ed intrapsichiche; in questo caso si da solo assenso. Su questo assenso grava il sospetto di essere l’espressione di una mortificazione, in quanto esso mostra la fragilità del suo produttore in un modo in cui non siamo ancora disposti ad accettarla; un tale sospetto cadrebbe se da una frase come quella citata ad esempio, potesse scomparire la risposta “non lo so” alla domanda “ma io come sono?”. L’unico efficace strumento di difesa a disposizione dell’individuo (che suo malgrado deve vivere traendone piacere e vantaggio all’interno della catena culturale) per tutelare la propria unicità sarebbe quindi la conoscenza delle forme dell’agire della pressione conformante/ uniformante, il che equivale a conoscere la propria natura psicologica. Tuttavia appare difficile immaginare una modalità di trasmissione di un tale sapere a sua volta libera dai vincoli della “cultura”; riesce cioè difficile im- maginare in che modo questo sapere, prodotto dall’uomo, possa divenire patrimonio di quello stesso uomo che vive all’interno di un sistema necessariamente consensuale conservando la propria valenza destabilizzante. Il destino cui esso va incontro consiste in un’alternativa illusoria quanto il movimento del punto luminoso nell’esperimento di Ash: o riprodursi mutando per assumere una forma acquiescente e stabilizzante (così come è accaduto finora per la massima parte della conoscenza psicologica; prima “alternativa”); conservare la propria diversità al di fuori o di là del circolo culturale stesso, divenendo così “incomunicabile”, non visibile e non udibile (seconda “alternativa”). Per tornare, in conclusione, alla distinzione che, ricercando un’autentica soggettività del consenso, abbiamo provato a cogliere nell’uso fatto del termine in oggetto, bisogna dunque riconoscere il carattere artificioso di una tale separazione tra senso consueto e senso desueto del termine stesso: resta quindi il primo tipo di consenso, la cui natura e la cui funzione sono evidenziate da esperimenti come quelli di Ash, Sherif e Mowrer, il consenso “necessario” al mantenimento della catena circolare che rappresenta la dinamica culturale. Il fare parte di questa catena è l’elemento che giustifica la necessita del consenso così come ci appare ora; difficilmente il nostro agire parla di un dissenso alla Kultur. RODCENKO, Aleksandr, Manifesto di Propaganda del Libro 78 GAGNO, Rosaria Rosaria Gagno John Rawls e la Stabilità della Società Ben Ordinata Il contrattualismo e la promessa della società migliore 1 Vilfredo Pareto (1848/1923) è uno dei maggiori esponenti della scuola economica neoclassica. Walras, prima di lui, aveva dimostrato come solo una situazione di concorrenza “perfetta” possa generare un equilibrio efficiente tra la dinamica dei prezzi e i programmi di azione individuale. Tale equilibrio costituisce, secondo Pareto, un “ottimo sociale”, cioè una situazione dalla quale non è possibile allontanarsi senza danneggiare almeno un individuo, e al di là della quale l’unanimità non trova più posto. Va osservato come una tale situazione di “concorrenza perfetta” risulta essere, ovviamente, del tutto ipotetica. La natura generale del contratto è quella di fornire uno schema tipico di ingresso volontario in società. In Una teoria della giustizia Rawls affida a questo strumento teorico il compito di realizzare una promessa: far germinare la società migliore dalla correzione morale del mercato. Si tratta, per il filosofo americano, di salvare le certezze Pareto/efficienti secrete dagli equilibri di mercato, correggendone gli esiti sociali controintuitivi mediante il ricorso a principi di giustizia sostanziale che siano il luogo del bene comune, dell’utilità pubblica, del consenso dialogico. Da un lato Rawls assume la logica di mercato come ossatura obiettiva e razionale di una teoria della giustizia sociale, dunque come parte formale dell’etica, dall’altro è alla ricerca di vincoli morali alla massimizzazione del benessere perché interpreta la caduta del consenso, cui le moderne democrazie a capitalismo avanzato sono esposte, come una richiesta di moralità che la cittadinanza rivolge alla struttura fondamentale della società. In questa prospettiva il contrattualismo, dettando le condizioni essenziali per un’adesione e una fedeltà libere e non naturali, offrirebbe ai contraenti sociali la possibilità di valutare di volta in volta il loro operato alla luce dei principi di giustizia sociale eletti: il senso dell’artificialità della statuizione e la volontarietà dell’obbligazione politica sono le condizioni di possibilità della società migliore. Ma se conveniamo che è delle moderne società a capitalismo avanzato che stiamo parlando, allora va rilevato che, come è indubbia l’artificialità delle loro strutture giuridico/istituzionali, così è altrettanto certa la forma naturale che in esse assume il consenso. Questa affermazione non è interessata ad avallare l’ ovvietà per cui ciascuno propriamente sceglie il suo ruolo di consociato, quanto a negare che l’operato delle istituzioni sia di volta in volta apprezzabile con la consapevolezza della sua artificialità e modificabilità. Il consenso o la mancanza di un dissenso che abbia peso politico, quale è quello che si estrinseca nella richiesta generica di moralità, non sono in grado di generare dal loro seno la società migliore. La ragione sta nel fatto che tale consenso meccanico o tale forma di protesta/dissenso spoliticizzati hanno dalla loro un atteggiamento molto diffuso (percepito come diritto) di insofferenza verso tutto ciò che sembra minacciare la sicurezza dei possessi individuali e la tranquillità della vita privata. Questo consentire è un chiaro segno della distanza degli uomini dall’azione politica, il segno cioè di una povertà culturale, di una deresponsabilizzazione rispetto al fare, di una impossibilita di immaginare scopi comuni e nominarli. Se nelle società a capitalismo avanzato la stabilita e il consenso non derivano dalla “legittimità razionale” dell’autorità, ma dal fatto che la statuizione si è trasformata per la collettività in un dato naturale, allora la possibilità di esprimere un punto di vista diverso dal corso del mondo risiede esclusivamente in una ragione colta e sapiente che lo comprenda e lo giudichi: solo ad una siffatta ragione le regole del gioco potranno apparire confutabili. Rawls però non pensa ad una ragione John Rawls e la Stabilità della Società Ben Ordinata colta quando detta le condizioni per approdare alla stipulazione equa dei principi di giustizia sociale, né vi è traccia in Una teoria della giustizia della tensione drammatica che insorge tra coscienza morale e istituzioni quando esse vengono messe in discussione. L’interscambio di razionalità strumentale ed intuizioni morali di senso comune annulla la tragicità della rivolta morale dell’individuo. É delle istituzioni quello che ne è dei rapporti degli uomini tra loro e con le cose. Il mondo è opaco e muto; tanto più lo si concepisce come costruzione umana tanto più si fa silenzioso, diventa sfuggente il sapere implicito nelle cose che quotidianamente si producono e si usano. Il mondo di oggetti, costruiti in gran parte attraverso il soggiogamento della natura, ridiventa esso stesso natura. É per questo che chiunque voglia porre un problema di cambiamento sociale è tenuto a farne una questione di cultura. Il contesto rawlsiano di scelta dimostra che – nonostante un apparente rifiuto della metafisica – c’è nell’autore americano una forte pretesa fondazionale. Essa rimanda alle nozioni di razionalità, natura umana, imparzialità, autonomia individuale, soggettività morale e le sottrae al contesto storico che solo può determinarne i contenuti. Quelle nozioni, così deprivate, fondano la loro validità universale facendo leva unicamente sulla forza emotiva delle parole, una forza che, pur derivando dalla loro genesi temporale, finisce per diventare (a causa di smemoratezza) appello ad un’astorica obiettività e ragionevolezza. Ma ciò significa che il presunto fondamento, ossatura formale e ordine dell’azione umana, è di fatto in balia della contingenza che si vorrebbe addomesticata con il suo aiuto. La violenza e l’arbitrarietà possono assumere le sembianze del diritto perché i valori morali che esso incorpora non sono in grado di garantirsi da soli una loro applicazione fedele. L’ordine è un ordine della violenza, dunque non è violenza. La forza dei diritti sta nella ragione storica di chi li persegue, cioè sta nei bisogni concreti che, a rigore, non sono diritto. Se ciò che rappresenta la vita reale, la forza delle passioni, la ricchezza delle culture, la carnalità dei bisogni, la forza emancipatoria del sapere, la critica all’omologazione, la protesta sociale, se tutto ciò viene chiamato diritto e chiede come tale di essere riconosciuto dalle istituzioni, allora non potrà che spogliarsi della sua valenza passionale e anticonformista. Qualunque bisogno chieda riconoscimento giuridico finisce, se soddisfatto, per essere inglobato in un sistema di diritti, cioè entro una struttura di riconoscimenti di cui non potrà mutare la logica. Alla società migliore non si perviene portando a compimento le buone ragioni di una morale di senso comune. La rivolta morale si colloca dopo la certezza e contro il diritto statuito, non al suo interno. Molto grossolanamente possiamo dire che quando nella riflessione politica diventa centrale il problema del consenso, unito a quello della tutela dei diritti e del cambiamento sociale, si possono dare due alternative: o si vuol far valere un punto di vista esterno, di rifiuto della logica degli ordinamenti giuridici vigenti, oppure si fa un discorso di riformismo interno e garantismo giuridico. Rispetto a queste opzioni, la riproposizione contemporanea del contrattualismo, che ripropone il pathos catartico della protesta morale alle ragioni della ratio strumentale, sembra avere una forte connotazione ideologica. Una domanda interlocutoria Perché una teoria della giustizia di ispirazione liberale e contrattualistica si vede necessitata a fissare la sua attenzione sulla razionalità umana intesa come volontà pratica? Il fatto è che, paradossalmente, la fiducia nei confronti di una società ben ordinata trova il suo più fecondo alimento nell’il- 79 GAGNO, Rosaria 80 1 Con riferimento alla suddivisione arendtiana dell’attività umana in “lavorare”, “operare” e “agire”, per superamento artificiale del processo naturale si intende la costruzione di un mondo di oggetti non naturali propria dell’operare; per superamento culturale intendiamo invece quella forma di azione che afferisce all’agire, alla interazione umana, alla pluralità e alla differenza. Cfr. ARENDT, Hannah, Vita activa, traduzione di Finzi, S., Milano, Bompiani, 1984. 2 Il principio organizzatore della società è la lotta con la natura esterna. Scrive Eric Weil: “Ogni società costituisce una comunità di lavoro. La società moderna si comprende e si organizza in vista di uuna lotta progressiva con la natura esterna”. (WEIL, Eric, Filosofia politica, traduzione di Cofrancesco, L. B., Napoli, Guida, 1973, p. 75). lusione collettiva di una sfera di vita privata come luogo dell’inviolabilità. Senza il sogno della progettualità, senza il miraggio della pianificazione del senso, non sarebbe possibile lo scioglimento del conflitto all’interno delle istanze amministrative dello Stato e l’interpretazione della protesta civile come richiesta di beni e servizi. Rawls deriva il momento coattivo dell’autorità statale dalla libera scelta di individui razionali, lo presenta come l’esito di considerazioni di stretto interesse personale dei contraenti sociali in posizione originaria. L’unico modo per impedire al processo decisionale di sfociare in un credo individualistico e licenzioso è, per Rawls, quello di forzare l’incontro tra interesse personale e stabilità sociale su un terreno dove l’etica di Stato sembrerà essersi completamente neutralizzata: qui gli individui, adempiendo alla loro caratterizzazione morale, chiederanno allo stato di erogare quantità eque di beni principali, ed esso soddisferà la richiesta senza entrare nel merito delle loro destinazioni individuali. Rawls ha concepito la razionalità/moralità degli uomini come capacita deliberativa, possibilità di elaborare piani di vita adeguati alle dotazioni di beni principali. Ma questo esercitarsi, spacciato per naturale, in calcoli sull’ottima utilizzazione dei beni disponibili è il frutto di un’attitudine indotta dal controllo delle passioni, dall’etica della lungimiranza e del risparmio. Il controllo che ogni persona è in grado di esercitare sulla propria vita diventa garanzia di stabilità per lo Stato erogatore inefficiente di prestazioni e servizi. Lo statuto ambiguo delle categorie in Una teoria della giustizia Ogni formazione storica produce e ha prodotto sia beni materiali legati alla sopravvivenza della specie, sia una concezione del bene capace di mettere in discussione il dato immediato della sopravvivenza organica, cioè di chiedere ragione di un processo naturale e di superarlo sia artificialmente che culturalmente. Non interessano qui i modi in cui storicamente si è determinato questo processo di culturalizzazione che ha riguardato le forme dell’agire degli uomini tra loro e rispetto al mondo, ma il suo senso più riposto che consiste in una separazione di piani, in una contrapposizione di principi: da una parte la natura con i ritmi ciclici dei suoi meccanismi riproduttivi; dall’altra la cultura, la sfera dell’azione libera, dell’autonomia creatrice di senso nella storia. Sino all’avvento della modernità la nozione di bene conservava la sua specificità nell’afferire ad un livello altro rispetto a quello della vita naturale o del bisogno che costruisce il mondo, nella possibilità di mettere tra parentesi, come necessità, quel processo interminabile di produzione e soddisfacimento di bisogni, nella possibilità ancora di includere l’“evento” nella condizione umana. Ora, se Rawls può trattare il “bene” e i “beni” come parole attinenti ad una stessa area semantica, ciò è sintomo che qualcosa di non trascurabile è intervenuto a modificare la comprensione che l’uomo per secoli ha avuto dei suoi rapporti con il mondo. Se il bene è linguisticamente appiattito sui beni vuol dire che la separazione tra livello naturale di riproduzione della vita e conservazione della specie, e livello culturale, politico e di riflessione sulle forme possibili dello scambio metabolico con la natura esterna è quanto meno molto assottigliato. Che Rawls abbia dunque ragione, che sia una pratica effettiva di vita ad autorizzare la sovrapposizione dei piani? Le cose non stanno così. Se è vero che una confusione è resa possibile dalla pervasività del principio del lavoro sociale, l’esistenza di due parole distinte non è però un fenomeno di mera arcaicità linguistica: esse rimandano a categorie eterogenee. Rawls nella sua opera offre un chiaro esempio di riduzione dell’agire poli- John Rawls e la Stabilità della Società Ben Ordinata tico all’agire sociale e trasferisce alla dimensione sociale categorie come il bene, la bontà, la giustizia che hanno rinviato storicamente ad altro. La situazione è per certi versi paradossale: da un lato uno spiccato realismo teorico e fors’anche politico ci vuol far intendere come di fatto sono andate le cose, e cioè come il principio universale dell’organizzazione del lavoro abbia prevalso sulle altre forme dell’agire umano; dall’altro lato, dismettendo se stesso come principio di legittimazione, si serve a questo scopo delle categorie sorte dalla sfera dell’azione libera, quando non dall’aperta ostilità nei confronti del principio sociale. L’uso generico delle categorie e il loro spessore semantico consentono a Rawls di tradurre efficienze con giustizia, beni con bene, capacità produttiva con facoltà morale prendendo sul serio queste traduzioni. Il principio sociale si trova investito della forza di valori nati altrove perché è offuscato il senso di quell’altrove. L’uso non problematizzato delle categorie è autorizzato dall’ipotesi di una loro comprensione comune che, in quanto comune, ha dignità etica e pubblica. L’equivoco di fondo è credere che per correggere il principio sociale, percepito come insufficiente ad esaurire il senso di nozioni come giustizia e bene, basti mostrare che nella società c’è spazio per opinioni condivise e per un senso comune opportunamente epurato da pregiudizi, in grado di aggiungere all’autocoscienza sociale una patente di eticità. L’organizzazione capitalistica del lavoro fa assurgere alla dignità della sfe- 81 ra pubblica le forme di agire legate al soddisfacimento dei bisogni, conferendo al principio sociale la capacità di dar luogo morbidamente ad una sfera di vita privata come sede del senso. L’elemento che opera la mediazione tra il mercato e la realizzazione del senso è l’ideale della pianificazione, del progetto di vita ottimale. Forse che questa assunzione significhi altro che una fiducia cieca nelle potenzialità del sapere tecnico? Il successo dei piani di vita individuali, razionalmente formulati, cui si affida il compito dello sviluppo integrale della persona, si fonda sulla presunta docilità ed illimitata disponibilità del sapere tecnico. Ma il sapere tecnico in se stesso sfugge al controllo dei singoli poiché riproduce nel suo seno le dinamiche dell’incessante meccanismo riproduttivo naturale, perché è separato dalla vita presa come un tutt’uno ed è invece legato alla discontinuità temporale, al tempo scandito dalle operazioni parziali e parcellizzate del lavoro quotidiano. Non sembra azzardato sostenere che ci troviamo di fronte ad uno dei luoghi fondamentali del liberalismo contemporaneo: l’ideologia delle risorse umane. L’illusione del progetto di vita razionale e sensato, che fa dell’insuccesso una questione di demerito personale, è la traduzione a livello individuale dell’impresa che valorizza il lavoro e diventa “ambiente di vita”. Non è un caso che la richiesta di moralità nelle democrazie a capitalismo avanzato proceda parallelamente ad una spietata concorrenza per i beni posizionali scarsi, ad una forte crisi 1 DA VINCI, Leonardo, Ultima Cena La prospettiva rawlsiana richiama da vicino quell’"elogio dell’etica" di cui, sempre in ambito di lingua inglese, ha parlato Hirsch riflettendo sulla necessità di un ritorno alla morale come unico antidoto proponibile contro i limiti oggettivi, sociali e materiali, dello sviluppo. Cfr. HIRSCH, Fred, I limiti sociali allo sviluppo, traduzione di Aleotti, L., Milano, Bompiani, 1981. 82 GAGNO, Rosaria economica e ad una sempre più spinta tecnologizzazione del lavoro. Ideologia della pianificazione ed interpretazione sovrastrutturale della crisi avvicinano così Rawls ai teorici del funzionalismo sistemico. Linguaggio dei diritti e soggettivizzazione del conflitto 1 Cfr. a questo proposito OFFE, Claus, “Iniziative popolari e riproduzione della forza lavoro nel tardo capitalismo”, in OFFE, Claus, Lo stato nel capitalismo maturo, traduzione di Zolo, D., Milano, Etas, 1977, pp. 205-218. Alcuni interpreti hanno legato la fortuna dell’opera di Rawls al diffondersi, tra i cultori di etica, della convinzione dell’autonomia della giustizia rispetto alla crescita del benessere, e perciò alla convinzione che la prima possa farsi carico degli interessi di soggetti che chiedono di essere giuridicamente riconosciuti. In realtà però la stretta convergenza tra filone orientativo dell’etica e linguaggio dei diritti – lungi dall’essere una manifestazione dell’autonomia della giustizia dalla crescita economica – diventa il simbolo dell’impossibilità per la prima di definire un luogo di nascita dei diritti diverso da quello della distribuzione dei beni. É la natura delle richieste avanzate che determina la qualità di un soggetto come soggetto giuridico e, nella rawlsiana società ben ordinata, tutti i soggetti sociali sono soggetto di diritto in quanto tutti rivolgono alle istituzioni richieste formulabili in termini di beni principali. Dietro alla definizione dei beni principali non c’è un ideale umano ma un modello di sviluppo che collega la giustizia alla loro equa ripartizione. Certo ciò equivale al riconoscimento che l’equità della distribuzione non è il prodotto automatico della crescita, ma non ha niente a che vedere con l’autonomia della giustizia come luogo della ridefinizione di ciò che è bene, di ciò che è bene produrre e come produrlo. L’autonomia qui significa semplicemente che i limiti dello sviluppo sono emersi come esclusione da esso di soggetti che rivendicano il diritto a goderne e nello stesso tempo la loro fede che detti limiti siano correggibili mediante interventi istituzionali al suo interno. Su questo equivoco si gioca la partita dell’adesione e del consenso. Il sistema si difende dal collasso tentando di perfezionare la sua elasticità, cioè la capacità di rispondere di volta in volta ai problemi sociali man mano che i nodi si presentano al pettine. Il linguaggio dei diritti soggettivizza il conflitto sociale e trasforma la debolezza potenziale del sistema, cioè la sua carenza di autocomprensione, in sua capacità di risposta. Abbiamo visto prima come l’ideale della pianificazione esponesse il singolo ad un insuccesso concettualizzabile come destino individuale. Allo stesso esito si approda traducendo il malessere sociale nella richiesta di diritti. L’abitudine ad una fruizione individuale dei beni fa sbiadire il senso di essa come parte della riproduzione materiale della vita. Il consumo o l’uso dei beni prodotti socialmente, inteso come fatto privato, significativo per la qualità di vita di un individuo e per i suoi progetti, determina forme di protesta sociale che sfociano nella richiesta di beni e di servizi. Questa non è semplicemente una forma di protesta che si serve di vie legali: essa ha semplicemente interiorizzato l’individualismo come unica forma di produzione e riproduzione della vita, come unica possibile forma di consumo nonché di titolarità delle rivendicazioni. Il malessere sociale è diventato patologia individuale presupponendo la moralità/ elasticità del sistema. Senso comune come principio di legittimizzazione istituzionale e come strategia di giustificazione dei principi Si può pensare che teorie come quella di Rawls traggano la loro forza persuasiva da un uso impudico del senso e del linguaggio comuni; tuttavia tale constatazione non sarebbe niente di più che una critica aristocratica – anche piuttosto scontata – se non fosse in grado di dimostrare che quel linguaggio e quel richiamo costanti al John Rawls e la Stabilità della Società Ben Ordinata senso comune, lungi dall’essere un vezzo poco attraente, costituiscono il canale privilegiato attraverso cui il liberalismo contemporaneo fa propria l’utopia sociale dei nostri tempi: la vita privata come luogo del senso. Rawls in realtà compie un’operazione molto raffinata nella misura in cui riesce a fare del linguaggio comune il linguaggio di una teoria scientifica. Per Rawls giustificare vuol dire fornire buone ragioni, e la migliore giustificazione cui un lavoro intellettuale possa aspirare è la plausibilità del suo insieme. Il significato principale della posizione originaria in Una teoria della giustizia è quelle di rendere possibile la deduzione dei principi di un’etica pubblica a partire da scelte individuali. Sta proprio qui l’aderenza della teoria all’abito argomentativo del ragionar comune. Non c’è dubbio che si è inclini ad immaginare esattamente così l’imparzialità, come minimo comun denominatore di scelte individuali dal lato della domanda, come neutralità delle politiche istituzionali dal lato dell’offerta. Questo concetto di imparzialità, che è il frutto delle condizioni oggettive della produzione e riproduzione della vita nella società reale, viene trasferito tal quale da Rawls nella ipotetica situazione contrattuale mediante il velo d’ignoranza. Strategie di legittimazione e rapporti di potere causano, nella società reale, la trasformazione del conflitto MAESTRO DI MOULINS, Natività in malessere individuale e fanno del potere una questione di meriti soggettivi; velo d’ignoranza e scelta individuale riproducono la medesima frammentazione in posizione originaria. Occorre aver presente il nesso tra senso comune, ignoranza delle radici della conflittualità sociale e senso della vita come destino individuale. L’individuo in posizione originaria è ridotto ad entità fondamentale del consumo, ma c’è di più. Su questa riduzione poggiano la presunta neutralità del momento istituzionale, la possibilità per esso di promuovere politiche di settore con relativo successo e i limitati margini di autocorrezione concessi al sistema. Non si possono avere dubbi riguardo al fatto che il senso comune costituisce la struttura profonda della strategia rawlsiana di giustificazione dei principi, dove il compito di verificare la teoria spetta, in ultima istanza, alle intuizioni di fondo che costituiscono il senso di giustizia di un uomo maturo e bene educato da istituzioni democratiche. Ed il senso comune non si annida tanto nei contenuti dei giudizi ponderati, nell’ovvietà di un vocabolario che giudica riprovevoli discriminazione razziale e sessuale, intolleranza rispetto alle altrui convinzioni religiose, politiche, filosofiche o che in un modo altrettanto certo ritiene giustamente fondata la pari dignità degli individui, il 83 84 valore della libertà e dell’autonomia della persona, ma nell’astoricità di quelle assunzioni, nella carenza di analisi che le sottende. Non sembra inverosimile sostenere allora che, sebbene operi attraverso una categoria forte di cittadinanza, identità personale e soggettività morale, Rawls si avvicini non poco alle tesi relative alla contingenza assoluta dell’esperienza umana che pongono al centro della loro attenzione lo studio del particolare e delle tradizioni, facendone il perno di una rivalutazione etnocentrica dei valori di appartenenza ad una determinata comunità storica. Rawls e la giustizia internazionale. Una riflessione ulteriore 1 “Oggi gli stati/nazione, sia intermini organizzativi che di processo sociale, sono società di gran lunga più partecipate di qualsivoglia stato territoriale del passato sul piano dell’istruzione, dei mezzi di comunicazione, delle comunicazioni materiali e della espressione pubblica, tanto che si può scorgere abbastanza facilmente la complicità fra poteri statali e popolazioni soggette nel determinare il luogo degli interessi che questi poteri devono rappresentare" (DUHN, John, La teoria politica di fronte al futuro, traduzione di Berti, L., Milano, Feltrinelli, 1983, p. 134). Razionalità individuale e conseguibilità di un’equa ripartizione dei beni principali all’interno della società bene ordinata sono le vie della legittimazione suggerite da Rawls alle moderne democrazie a capitalismo avanzato. Chi nutrisse dubbi in proposito potrebbe domandarsi come mai Rawls, che pure ha impostato l’intero impianto della sua opera avendo particolare riguardo per la nozione di giustizia distributiva, abbia trattato solo marginalmente il tema dei rapporti tra giustizia locale e giustizia globale. Il motivo a nostro parere sta nel fatto che le ragioni avanzate in favore dell’equità interna delle politiche distributive sono anche le ragioni di giustificazione e di costruzione del consenso dello stato/nazione interventista. Proprio per questo non potrebbero essere altrettanto efficaci sul piano internazionale. La via della conciliazione sociale domestica è percorribile sulla scorta di convinzioni radicate nel senso comune: l’illusione della libera espansione delle volontà individuali e l’appartenenza ad una comunità nazionale integrata. Ora, una politica redistributiva applicata a livello globale le metterebbe in crisi entrambe: la prima interferendo con le dotazioni di beni principali spettanti a ciascun individuo; la seconda anteponendo l’interesse sovranazionale a quello comunitario. La cultura occidentale è una cultura cosmopolita, nelle sue vene scorre il sangue di un’etica universalistica e i suoi umori si animano intorno alla pari dignità di ogni uomo e di ogni cultura, e tuttavia essa non ha contribuito al successo di alcun insieme sovranazionale politicamente rilevante. Il nazionalismo resta un sentimento di massa molto forte che ha legami stretti con le politiche distributive e con i cosiddetti problemi di giustizia sostanziale. certo Rawls in nessun luogo della sua opera esterna simpatie comunitarie, ma è pur vero che, mentre si premura di eliminare ogni sentimento morale dalla posizione originaria, lascia che la nozione di cittadinanza come appartenenza ad uno stato autosufficiente faccia il suo gioco. D’altra parte s’inganna chi ritiene che il contrattualismo, come fondamento di una teoria della giustizia sociale, contenga le omeomerie della radicalizzazione che, spinte a manifestarsi liberamente, potrebbero addirittura costituire gli elementi fondativi di una nuova teoria dell’ordine mondiale giusto. In realtà il contrattualismo o è la veste ideologica di una prassi politica già sperimentata oppure non può che tacere. Il contrattualismo, poiché azzera la funzione sociale del sapere, può produrre esclusivamente utopie sociali praticabili – cioè già praticate. CHAGALL, Marc, Soldato che Beve 85 Giuseppe Perfetto L’Espressione Ideologica del Consenso alla Schiavitù nel Pensiero Cristiano e Liberale. Una Lettura del Lavoro di Domenico Losurdo In vari luoghi della sua opera di ricercatore, il Professor Domenico Losurdo ha condotto una serrata analisi sulla giustificazione ideologica dell’istituto della schiavitù nella tradizione cristiano/liberale – un momento della cultura occidentale assai spesso rimosso ed anche occultato dalla cultura ufficiale. In questa sua linea di ricerca Losurdo è andato evidenziando come Nietzsche, pensatore che passa per critico radicale del moderno pensiero cristiano/liberale, può invece essere tranquillamente letto come la massima espressione proprio di quel pensiero, smussato dai falsi moralismi e da determinate mistificazioni ideologiche. In altri termini, Nietzsche rappresenterebbe un “liberale estremista” che considera l’istituto della schiavitù in modo più spregiudicato e duro, privandolo delle tradizionali trasfigurazioni ideologiche. Nelle sue analisi, infatti, Losurdo sovverte le convinzioni della storiografia ufficiale, secondo cui la storia del liberalismo coinciderebbe con la storia della libertà ed il cristianesimo avrebbe comportato inevitabilmente, con il suo avvento, la soppressione dell’istituto della schiavitù. Tutta la tradizione cristiano/liberale, in piena continuità con la corrente principale di pensiero dell’antichità classica, ha quasi unanimemente teorizzato una giustificazione della schiavitù come momento necessario per il progresso storico e per lo sviluppo della civiltà, neutralizzando e in certi casi obliando la potenziale carica eversiva del cristianesimo in nome di una libertà in interiore homine, ricor- rendo inoltre al peccato originale come colpa che avrebbe distrutto la originaria libertà degli uomini e legittimato la schiavitù. Ripercorrendo le tappe del pensiero liberale, partendo da Grozio, padre spirituale di tale corrente, Losurdo mostra come quest’ultimo giustifichi la schiavitù facendo uso sia del vecchio testamento che della tradizione greco/ classica: nel De Jure Legis ac Pacis, infatti, la schiavitù viene sussunta sotto la forma di un “contratto” stipulato tra il lavoratore che si impegna ad erogare forza/lavoro per un “determinato” periodo di tempo (coincidente con la sua intera vita), ed il padrone, che in cambio gli procura gli elementi per la sopravvivenza materiale. “Contratto” questo che può anche essere il risultato del diritto di guerra, dove il vincitore piuttosto che togliere la vita al vinto scambia quest’ultima con l’assoggettamento vita natural durante. Quest’ultimo tipo di contratto, secondo Grozio, si realizzerebbe in particolare nelle guerre coloniali perché in quei paesi l’istituto della schiavitù sarebbe ancora in uso. Locke, dal canto suo, dichiara sostenibile la schiavitù nelle colonie per fini umanitari, ritenendola un mezzo necessario per poter civilizzare le popolazioni extraeuropee; rifiuta però la concezione contrattualistica groziana della schiavitù che, a suo avviso, rischierebbe di giustificare l’introduzione di tale istituto anche nei paesi europei. Ma in Locke, così come poi in Nietzsche, la civiltà è il frutto delle fatiche anonime della maggioranza 1 Faremo qui riferimento in particolare al ciclo seminariale “Il filosofo e la schiavitù. Lavoro salariato e lavoro servile nel pensiero moderno”, svoltosi a Napoli dal 21 al 25 novembre 1992 presso la sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, e all’intervento “Nietzsche, il moderno e la tradizione liberale” al convegno “Metamorfosi del moderno”, svoltosi a Cattolica dal 18 al 20 1986. Una sintesi del seminario dal titolo “Il filosofo e la schiavitù”, a cura di PERFETTO, Pino, è su Informazione Filosofica, n. 11, pp. 56/57. Per l’intervento su Nietzsche, si vedano gli Atti del Convegno “Paradossi del moderno”, Urbino, QuattroVenti, 1988, pp. 115140. 2 É celebre, a puro titolo di esempio, la tesi aristotelica secondo cui vi sarebbero uomini per natura incapaci di autogovernarsi e quindi bisognosi di un padrone che li guidi; altrettanto celebre l’altra sua tesi secondo la quale il lavoro manuale sarebbe sinonimo di condizione servile. Per questa ragione Grozio 3 considera “giuste”, ovvero improntate alla giustizia formale, la conduzione di tali guerre. 86 1 LOCKE, John, Saggio sull’Intelletto Umano, traduzione italiana a cura di ABBAGNANO, Nicola, Torino, 1971, 148. 2 Cfr. su questo punto LOSURDO, Domenico, “Nietzsche, il moderno e la tradizione liberale”, op. cit., pp. 1201-21. PERFETTO, Giuseppe degli uomini, costretta a lavorare e che per tale motivo è incapace di sollevare i suoi pensieri al di sopra della bruta materialità. Pertanto egli afferma nel Saggio sull’Intelletto Umano che “non ci si può aspettare che un uomo che sgobba tutta la vita in un mestiere faticoso conosca la varietà delle cose che ci sono al mondo più che un cavallo da soma, che è portato avanti e indietro dal mercati per un sentiero ristretto ed una strada sporca, possa essere esperto della geografia del paese.” Ciò che emerge dal pensiero di questi autori, al pari del pensiero politico dell’antichità classica, è la mancanza di una concezione universalistica dell’uomo. Tale mancanza conduce al culto di una pseudouniversalità falsa e mistificatoria, dove la maggioranza degli uomini ha diritto di vivere solo per realizzare un “Utile Collettivo” dal quale, però, per definizione sono esclusi e ne costituiscono solo le vittime sacrificali. La mancanza di una concezione universalistica dell’uomo, fa notare Losurdo, è presente anche in una delle poche voci antischiavistiche del pensiero liberale inglese del Settecento, Adam Smith. Questi difatti argomenta la sua condanna con ragionamenti meramente economicistici: il rapporto di lavoro servile è un rapporto fondamentalmente improduttivo, poiché lo schiavo deve essere mantenuto per tutta la vita e per di più produce poco a causa della mancanza d’incentivi. Esso continua ad esistere, e qui Smith ricorre ad una spiegazione psicologistica, solo in virtù dell’irrazionale sete di potere del padrone. Nell’Illuminismo le considerazioni sulla schiavitù vengono influenzate dalle diverse realtà politiche presenti nei differenti paesi europei. Si assiste difatti in Inghilterra alla difesa massiccia della tratta dei negri condotta da questo stesso paese, mentre in Francia il dibattito politico è assai più vivace e conflittuale. In questo clima di scontro politico la posizione di Montesquieu si attesta su posizioni moderate, e le sue considerazioni sull’istituto della schia- vitù presentano delle palesi contraddizioni: da una parte egli sembra condannare la schiavitù sottoponendo a critica spietata tutte le tradizionali giustificazioni, dall’altro però sostiene che in certi paesi, dove il clima è torrido, la disciplina del lavoro può essere mantenuta solo facendo ricorso all’assoggettamento servile. Sicché, se analizziamo il problema alla luce della ragione, la schiavitù è senz'altro da condannare ed abolire, ma se ricorriamo alla “ragione naturale” bisogna accettarne l’esistenza come dato di fatto irrimediabile. Le tesi di Montesquieu non si distaccano quindi sostanzialmente da quelle degli illuministi inglesi, ma in lui è presente un ideologico pathos dei diritti dell'uomo che si manifesta attraverso una sorta di autocritica dell’Europa considerata responsabile delle sterminio di indios e negri. Paradossalmente le voci di condanna dell’istituto della schiavitù ci giungono da teorici dell’assolutismo monarchico come Bodin ed Hobbes, i quali scardinano le giustificazioni contrattualistiche proposte dai liberali. Per quanto riguarda il diritto di guerra, Bodin sostiene che la donazione della vita da parte del vincitore non costituisce affatto un atto di generosità, bensì un puro calcolo basato esclusivamente sull’interesse personale. Inoltre egli evidenzia la mancanza di una concezione universalistica dell’uomo nell’in- VECELLIO, Tiziano, Allocuzione di Alfonso d’ Avalos 87 L’Espressione del Consenso alla Schiavitù... terpretazione del cristianesimo da parte della tradizione cristiano/liberale, mostrando l’inconciliabilità tra predicazione evangelica e istituto della schiavitù. Le tre grandi religioni monoteistiche hanno tagliato a metà la legge di Dio, interpretando la tesi che non bisogna fare prigionieri nell’ambito del proprio popolo in chiave etnocentrica piuttosto che universalistica. Il punto di partenza di Hobbes è simile a quello di Grozio e di Locke, ma egli non utilizza le trasfigurazioni ideologiche di questi ultimi per quanto riguarda l’istituto della schiavitù. Infatti, mentre Grozio e Locke si richiamavano alla tradizione greco/classica per sostenere che esistono uomini schiavi “per natura”, Hobbes ritiene al contrario che, “per natura”, tutti gli uomini sono uguali: dunque, se si vuole trovare la causa della disuguaglianza e della stessa schiavitù, non bisogna ricorrere a spiegazioni pseudonaturalistiche ma fare appello alla dinamica sociale e storica. L’istituto della schiavitù, per Hobbes, è pertanto un rapporto fondato esclusivamente sulla diversa forza del padrone da una parte e dello schiavo dall’altra, e si configura pertanto come frutto diretto ed anzi continuazione dello stato di guerra. L’analisi di Losurdo porta poi questi a riflettere sul fatto che la realizzazione del consenso alla schiavitù nell’età tardo moderna e contemporanea necessitava della liberazione dal sentimento della compassione, che continuava a serpeggiare fra alcuni uomini delle classi agiate. Accade così che all’interno della tradizione liberale inizia a configurarsi, con Mandeville, un’esplicita condanna del sentimento della compassione, vista come un’imperdonabile debolezza da bandire senz’altro se si vuol proseguire secondo le inesorabili leggi generali della civiltà. Sentimento d’altronde tanto più pericoloso in quanto genera come suo contraltare il sentimento dell’invidia e del risentimento nelle classi più povere, le quali tendono così a rivendicare l’uguaglianza e le libertà sociali. Man mano che le masse popolari entrano nella vita poli- tica e sociale rivendicando un ruolo da comprimari, il pensiero liberale moderno erige delle barriere ideologiche condannando con sempre più forza tali rivendicazioni come “invidia” e “risentimento”. Ne La Democrazia in America, Tocqueville si scaglia contro il “gusto depravato per l’uguaglianza che porta i deboli a voler degradare i forti al loro livello e che riduce gli uomini a preferire l’uguaglianza nella schiavitù alla disuguaglianza nella libertà.” Solo in Rousseau, non a caso definito da Nietzsche come “uomo del risentimento plebeo”, si trovano parole di fuoco contro la schiavitù e la povertà delle classi popolari. Egli sostiene che la tesi secondo la quale il colonialismo è indispensabile per la civilizzazione e la felicità dei popoli extraeuropei è un’ipocrisia che riveste ideologicamente interessi economici, così come è altrettanto ipocrita sostenere che le classi povere europee devono rimanere tali in quanto abituate a tal punto a vivere nella povertà da esserne addirittura felici. Il ricco, afferma Rousseau, “vede senza pietà quegli infelici, oppressi da un lavoro incessante, ricavare a stento un pane secco e nero che serve a prolungare la loro miseria. Non trova strano che il prodotto sia in ragione inversa del lavoro, e che un fannullone spietato e voluttuoso si ingrassi del sudore di un milione di miserabili stremati dalla fatica e dal bisogno. É la loro condizione, egli dice, vi sono nati, l’abitudine fa tutto uguale e io non sono più felice, sotto i miei ricchi soffitti, che un bovaro nella sua capanna, né, dovrebbe aggiungere, il bue nella sua stalla.” Ciò che viene denunciato con forza da Rousseau, con il riferimento al bue, è che il ricco non sussume sotto la categoria di uomo il povero ma lo riduce alla pura funzione animale della prestazione del lavoro. Un ulteriore elemento nuovo delle componenti più radicali dell’Illuminismo francese è, infine, l’appello che viene lanciato agli schiavi perché essi stessi si liberino da questo indegno sopruso agendo in prima persona. 1 TOCQUEVILLE, Alexis de, La Democrazia in America, traduzione italiana a cura di MATTEUCCI, N., in TOCQUEVILLE, Alexais de, Opere politiche, Torino, 1968, vol. II, p. 74. 2 ROUSSEAU, Jean-Jacques, “Discorso sulla ricchezza”, riportato in appendice a FETSCHER, Irving, La filosofia politica di Rousseau, Milano, 1968, p. 272. Da questo punto di vista, 3 potrebbe risultare significativa la terminologia della riflessione nietzscheana (l’“uomo del gregge”). L’antischiavismo inglese in4 vece si limita solitamente a rivolgere appelli alle classi dominanti affinché esse si “illuminino” e procedano a riforme nei confronti delle masse popolari. 88 Uno degli ultimi pensatori che agisce e riflette in un periodo in cui la schiavitù esisteva ancora come concreto istituto politico/sociale nell’ambito della società occidentale è Nietzsche, e la riflessione di Losurdo su quest’autore è di notevole interesse. Nietzsche, difatti, conduce un accostamento tra schiavitù nera e lavoro salariato, affermando che la continuità tra queste due forme di schiavitù mostra l’inseparabilità tra istituto della schiavitù e sviluppo della civiltà. Egli a giudizio di Losurdo prosegue la corrente nominalistica della filosofia moderna, ancora lungi da un concetto universale di uomo, leggendo in maniera assai spregiudicata e dura l’importazione massiccia in Occidente delle popolazione Asiatiche ed Africane schiavizzate e sostenendo, in più occasioni, che la marcia della civiltà assomiglia a quella di una carro trionfale – cui sono aggiogati gli schiavi catturati. In un solo punto Nietzsche pare divergere dalla tradizione cristiano/ liberale, e ciò accade notoriamente per quanto riguarda le considerazioni sul cristianesimo, ritenuto la religione del risentimento, dell’odio, della vendetta dei mal riusciti contro le classi ricche. Tale rancore presente nel cristianesimo viene perpetuato, a suo giudizio, da quelli che definisce gli “intellettuali plebei”. In quest’ottica è interessante notare la convergenza della sua critica di Rousseau con quella di molti esponenti liberali: il ginevrino, “l’uomo del risentimento plebeo”, avrebbe avuto la colpa d’aver distrutto la salutare innocenza dello schiavo, aumentandone le sofferenze ed eliminando la “serenità” con cui essi erano attaccati – in un mitico ed ideologicamente richiamo al passato – al carro della civiltà. Come crediamo risulti evidente, la riflessione di Domenico Losurdo giunge a portare alla luce come non ci sia stato istituto sociale inegualitario che, per quanto oggi possa essere disprezzato ad ogni pie’ sospinto, non abbia trovato ieri la sua corte di estimatori e giustificatori. E, volendo, l’oblio che circonda oggi queste posizioni è a sua volta un fondamentale meccanismo ideologico consensuale, teso a presentare la teoria politica liberale, alla base delle attuali forme politiche planetarie, come un inno senza macchia alla libertà politica e magari sociale. RUBENS, Pieter Paul, La Trinità Adorata dalla Famiglia Gonzaga
Scaricare