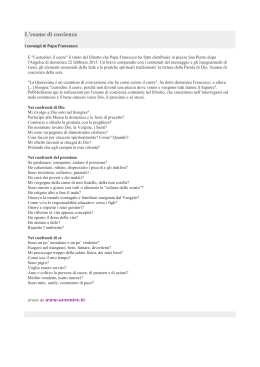Domenica La di DOMENICA 27 AGOSTO 2006 Repubblica la memoria Il compagno americano nei gulag di Mao FEDERICO RAMPINI il racconto Jesse James, la saga del bandito razzista ANTONIO MONDA Quarantesimo compleanno per un impero industriale made in Italy venuto dal nulla a forza di buone idee e voglia di rischiare Benetton FOTO GIUSEPPE PINO, 1991 Repubblica Nazionale 31 27/08/2006 così ho colorato il mondo NATALIA ASPESI L’ CORTINA D’AMPEZZO azienda che ha colorato il mondo compie quarant’anni e il suo fondatore, in attesa della gran festa del 10 ottobre al Centre Pompidou di Parigi, sta per raggiungere la Siberia, la Bielorussia, il Kazakistan, alla ricerca degli ultimi luoghi sulla terra non ancora invasi da quei rutilanti colori, da quei vestiti giovani, da quel celebre marchio. Agli inizi dell’avventura Luciano Benetton aveva trent’anni, era un giovanotto dall’aria severa e forse un po’ triste, capelli neri lisci, occhiali da vista scuri come li portano i timidi, rigidi abiti manageriali per affrontare la foresta sconosciuta dell’imprenditoria italiana di allora, sapendo già che quei confini gli sarebbero stati stretti; e che oltre c’era l’Europa, c’erano i continenti a lui ignoti, che aspettavano di essere conquistati. Oggi il presidente del Gruppo Benetton è uno di quei nuovi settantenni che cancellano le vecchie e ormai obsolete regole degli anni, vivono il presente con l’intensità di una sapiente giovinezza illimitata, mantengono fermamente il potere, pianificano un futuro senza fine. E impegnano con disinvoltura e distacco la loro immagine fisica per confermare questa idea di energia, di potere, di successo sconfinato. Un’immagine, la sua, che col tempo ha perso la gravità degli inizi di carriera, è diventata leggera e leggiadra: i capelli candidi, ariosi e lunghi, la figura snella e impaziente, gli occhiali quasi invisibili che non nascondono più gli occhi azzurri, e un modo di vestire molto Be- netton, anche quando il gran cappello da cacciatore e la camicia a quadri sono casual americani. Nelle foto da bambino, figlio della lupa, marinaretto, in mutandine, canottiera e valigino della merenda, non sorride mai, imbronciato, pensieroso, insicuro, come se la vita di allora, semplice, angusta, forse difficile, non gli andasse per niente bene, e già sognasse altro, senza sapere cosa. Poi l’ha saputo, e con sicurezza, e infatti da tempo sorride sempre, candidi denti ovviamente perfetti, e in modo addirittura smagliante nelle occasioni ufficiali, quando lo ritraggono assieme alla sorella Giuliana e ai fratelli Gilberto e Carlo, con addosso magliette e jeans della casa, oppure, per eventi più formali, lo smoking classico portato con sommessa ironia. I sorrisi saranno trentotto nella copertina di Vanity Fair in occasione della mostra parigina: una foto davvero unica, perché i tanti Benetton non si ritrovano mai tutti insieme, se non forse una sola volta l’anno, quando però manca sempre qualcuno. In più il primogenito Luciano ha sempre sfuggito il ruolo di patriarca, che non sente come suo, e già essere padre di cinque figli, quattro dalla moglie Teresa, uno da Marina Salamon, («ma l’amore tra industriali non è una grande soluzione»), e nonno di dieci nipotini, non lo commuove più di tanto. Ma per amore del marchio ha fatto anche questo: una fotografia con tutti i Benetton, i quattro capostipiti, i loro figli, quindici, i figli dei figli, diciassette, nessun coniuge. Di tutta questa folla familiare, solo Alessandro, secondogenito di Luciano, compagno di Deborah Compagnoni, padre dei piccoli Tobias e Agnese e presto di un terzo figliolino, occupa un ruolo importante nel gruppo Benetton, come vicepresidente. (segue nelle pagine successive) cultura I quadri di Michelangelo Antonioni BEPPE SEBASTE la lettura L’insostenibile leggerezza del maiale DARIO FO e MICHELE SERRA spettacoli Star Trek, quarant’anni nell’iperspazio ERNESTO ASSANTE e PINO CORRIAS l’incontro Alda Merini, le mie parole di latte DARIO CRESTO-DINA 32 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 27 AGOSTO 2006 1958 Maglione “Très jolie” 1968 Cardigan giallo “Godiva” 1970 Abito sportivo in lana la copertina Colorare il mondo NATALIA ASPESI (segue dalla copertina) Repubblica Nazionale 32 27/08/2006 M a, come si sa, gli interessi di una famiglia valutata cinque miliardi di euro dal mensile economico americano Forbes sono molto vasti, vanno ampiamente al di là dei 120 milioni di capi di vestiario che ogni anno si irradiano in più di 5000 negozi in 120 paesi. Usciti dalla Benetton per decisione comune nel 2003, i fratelli si sono divisi le competenze nell’impero di famiglia, e adesso un figlio per uno — Franca, 38 anni, figlia di Giuliana; Christian, 34 anni, figlio di Carlo; Sabrina, 31 anni, figlia di Gilberto; oltre naturalmente ad Alessandro, tutti carichi di lauree e master prestigiosi — sono diventati consiglieri delle cassaforte di casa, la Edizione Holding, che come si usa adesso controlla di tutto e con diverse fortune non sempre vincenti. Tra cui, ma non solo, le partecipazioni in Telecom, Autostrade, Autogrill, Grandi Stazioni, più il cento per cento di due immense tenute, Maccarese in Italia e Compania Tierras Sud in Patagonia: 900mila ettari, 16mila bovini, 260mila pecore, un milione e 300mila chili di lana esportata in Europa, risentimenti e contrasti con la popolazione locale, scambio di lettere con il premio Nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel, e alla fine una donazione di terreno ai contadini mapuche, con una lettera firmata Luciano Benetton, «…La nostra donazione non ha e non potrà mai avere l’ambizione finale di accelerare i ritmi quotidiani del tempo e della storia. Ma può essere una piccola luce per guidarci nel buio, passo dopo passo, lungo il sentiero tormentato del progresso socialmente responsabile». Sono le grandi ricchezze di oggi, saldamente disperse in mille rivoli, e Luciano Benetton è di quelli che ne godono appieno ma non le ostentano o peggio ancora le sprecano negli orrori dell’estate di gusto celebrity: ha trascorso le sue vacanze a Cortina, nel grande fienile del Seicento che apparteneva all’architetto Vietti e che della sua monumentale antichità conserva i pavimenti, i soffitti, le pareti di rustico legno. Con la più giovane e vivace compagna degli ultimi dieci anni, Laura Pollini, amministratore delegato di Fabrica, il centro di ricerche sulla comunicazione nella bellissima sede di Ponzano Veneto costruita da Tadao Ando, fa colazione in pieno sole su un tavolinetto nel retro della casa, servito da un omino in maglietta, guardando il grande prato su cui si affacciano altre case. A Cortina non ci sono steccati, né cancelli, tutto è libero, tale è il mito elegante del luogo che nessuno, neppure Benetton, teme intrusioni, sorprese, molestie. Al potere finanziario che la famiglia ha accumulato, Luciano guarda con apparente distacco, perché in questo momento è molto più impaziente di riprendere il suo girovagare di lavoro, per rinsaldare il gruppo Benetton su nuovi indispensabili mercati. «Ci vado io stesso, non solo perché gli eventuali soci e clienti sono più contenti, ma perché mi diverto, mi affascina addentrarmi in queste nuove realtà. In Siberia per esempio non sapevano nulla di mercato, adesso tutti vogliono commerciare, abbandonano le professioni di medico, di avvocato, e aprono negozi. Vogliono arricchirsi, come tutti, ma non sempre si incontrano persone affidabili. È per questo che in certi paesi non promuoviamo più il franchising, i negozi li compriamo noi nei punti strategici e li affidiamo a gestori-soci. Per evitare, co- 1987 Vestito stretch me è capitato, c h e quando il negozio è avviato, arriva un altro marchio, offre più soldi e noi ci ritroviamo senza punto vendita». Eppure è stato proprio Luciano Benetton a inventare il franchising, il negozio di proprietà di altri cui affidare il marchio e vendere il prodotto, ed è stato questo l’inizio del successo. Lui è forse uno degli ultimi imprenditori di grande fortuna che hanno cominciato dal nulla: la sua leggenda dice che, nato a Treviso nel 1935, primogenito di Leone che mantiene la famiglia noleggiando automobili e biciclette, resta orfano di padre a quattordici anni e per questo lascia la scuola. Va a lavorare, commesso in un negozio di tessuti, e qui comincia a innervosirsi perché nella povertà dell’economia di quegli anni, sente che c’è bisogno di qualcosa di nuovo per accendere il mercato. «C’è stato un fatto determinante per me, e sono state le Olimpiadi del 1960 a Roma. Io amavo molto il canottaggio, avrei dato qualunque cosa per partecipare alle gare, ma mi accontentai di andarci come spettatore. Fu una emozione inimmaginabile: venivo dalla provincia di allora, chiusa e ancora arretrata, e lì in mezzo a quella folla immensa venni a contatto col mondo, mi ritrovai tra gente di ogni razza e colore, tra le bandiere di decine e decine di nazioni. Avevo venticinque anni e mi prese una grande voglia di far parte di quei colori, di quelle bandiere, di quella moltitudine, del mondo. Era tutto da conquistare, bastava farsi venire un’idea, sperare nella fortuna, non temere nulla». L’idea venne da un maglione che la sorella Giuliana gli aveva confezionato: non aveva nulla di speciale, se non che era giallo, e i giovanotti non portavano allora maglioni colorati. Quindi lui suscitava curiosità, e tutti lo guardavano e gli chiedevano come mai avesse osato e gli amici alla fine ne chiesero uno simile: «Capii in quel momento che attirare l’attenzione, imporre un’immagine soprattutto se imprevista, fare eco, suscitare discussioni, poteva essere una strategia imprenditoriale vincente». Non se l’è mai dimenticato, arrivando per una delle tante campagne Benetton, seguite da reazioni scandalizzate, a farsi fotografare nudo. Era il 1993, Luciano aveva cinquantotto anni ed era senatore della Repubblica eletto per il partito repubblicano; sfrontato, coraggioso e sorridente, non un pezzo di stoffa sul corpo, si protesse soltanto con la scritta gigante trasversale, naturalmente in inglese, «I want my clothes back» e poi «Empty your closets». Era una delle tante campagne pubblicitarie concordate con Oliviero Toscani, questa volta a scopo umanitario e in collaborazione con la Caritas svizzera, la Croce rossa e il Crescente rosso di Ginevra, un piano mondiale di ridistribuzione di capi di abbigliamento usati da destinare alle popolazioni indigenti. «Ridammi i miei vestiti» e «Vuota i tuoi armadi» ebbe molto successo, forse perché non si era mai visto un imprenditore nudo, e alla fi- 1989 Maglione a rombi ne i contenitori posti nei negozi Benetton raccolsero 460mila chili di indumenti. L’immediato successo commerciale dei primi anni era arrivato con idee nuove, nate da una intuizione imprenditoriale ma anche dalla natura parsimoniosa di Luciano. La prima idea fu aprire negozi nei centri storici o comunque nei luoghi più eleganti delle città, però in franchising, cioè a spese degli altri. E poi, illuminazione semplice, pratica e del tutto nuova, produrre capi di maglia di lana color naturale e poi tingerli al momento, secondo le richieste, in una gamma di colori vastissima, almeno una sessantina. Quasi vent’anni dopo, negli anni Ottanta, con più di 1.000 punti vendita in Italia, 250 in Germania, 280 in Francia, 100 in Inghilterra, 25 in Olanda e in Belgio, il marchio consolidato come simbolo del vestir giovane, Luciano cominciava a divertirsi meno. Che soddisfazione c’è a vendere milioni di magliette se però nessuno ne parla più, non fanno più notizia, sono tornate alla loro natura di semplice anche se fortunata merce, senza contare che ci sono ancora continenti, mondi, non ancora benettonati? Racconta Oliviero Toscani: «Una sera, mentre assistevo al parto di una delle mie cavalle Appaloosa, mi telefona Luciano. Il puledro nacque da lì a poco e in quella mezzanotte di buon auspicio nacque anche una straordinaria collaborazione». Un sodalizio artistico-mercantile che univa due personaggi appassionati del potere dell’immagine e del piacere di far notizia, di sorprendere e provocare. Ma ancor prima dell’arrivo in azienda di Toscani, il marchio negli anni Settanta già tendeva all’anticonformismo (fotomontaggi di Jimi Hendrix, Andy Warhol con addosso la nuova linea Jean’s West, una Laura Antonelli seminuda e un Salvador Dalì che attacca un manifesto in favore dell’aborto). Dice Luciano: «I giovani avevano idoli trasgressivi, contestavano, occupavano le università, sognavano di cambiare il mondo. Ero giovane anch’io, e non sentivo la differenza di pensiero: e poi quei ragazzi mi piacevano perché li vedevo tutti come potenziali clienti». La rivoluzione vestita, colorata Benetton. «Anch’io contestavo, nel mio caso la categoria imprenditoriale, che non aveva attenzione per i lavoratori. Io ce l’avevo, e anche se abbiamo avuto rapporti burrascosi coi sindacati rispettavamo le regole del gioco, erano la controparte con cui trattare. E poi io mi sentivo davvero uno di loro, uno degli operai, e alle sei di mattina arrivavo in fabbrica con la Due cavalli per il primo dei tre turni. Lavoravamo tutti come pazzi, ma non bastava: sino al 1978 non riuscimmo a soddisfare tutte le ri- 1999 DINASTIA La famiglia Benetton in una foto del 1937: Luciano con la sorella Giuliana e la mamma Rosa Fabrica, la mostra Il nome stesso lo suggerisce, Fabrica è un luogo del fare, un laboratorio. Ma non in senso stretto. Nata nel 1994 e fiore all’occhiello culturale di Benetton, è un’“officina” di comunicazione: grafica, cinematografica, musicale, editoriale e fotografica Vi lavorano pochi giovani creativi selezionati in base ai loro progetti e ospitati in una grande struttura a Treviso. “Les yeux ouverts”, una mostra organizzata al Centre Pompidou di Parigi dal 6 ottobre al 6 novembre, intende far conoscere i progetti nati a Treviso. È divisa in sezioni: comunicazione visiva, reportage fotografici, sperimentazioni interattive Maglia metalizzata DOMENICA 27 AGOSTO 2006 1971 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 33 1972 Completo a strisce 1974 Maglia a righe 1974 Maglia colorata Cardigan patchwork Alla vigilia della mostra al Beaubourg che celebrerà i quarant’anni del marchio, Luciano Benetton racconta la storia di uno straordinario successo imprenditoriale fatto di idee nuove, gusto del rischio e della provocazione chieste perché lo sviluppo era fino al settanta per cento all’anno. Gli altri imprenditori ci guardavano male, come alieni della categoria. Quando nel 1963 costruimmo la prima fabbrica a Ponzano Veneto, installammo subito l’aria condizionata per tutti, ed era una cosa rivoluzionaria. L’entusiasmo era tanto, non potevamo spendere molto, ma pensavamo a una struttura non usuale, più intelligente, più ottimista del solito capannone. Volevamo farci conoscere, anche attraverso l’architettura, e infatti affidammo il progetto a Tobia Scarpa, che conoscevo perché era di Motebelluna, aveva vent’anni, era ancora studente e, malgrado la fama del padre, poco costoso, in più condivideva con me il piacere del rischio. In questo caso un’unica trave vuota di cemento di ottanta metri che sosteneva tutta la costruzione. Gli esperti dissero che non sarebbe rimasta in piedi, e invece è ancora lì, tuttora moderna e affascinante». Con Oliviero Toscani, e per i diciotto anni della loro collaborazione, ogni campagna pubblicitaria divenne uno shock, uno scandalo, una rivoluzione permanente nel modo di comunicare. «Volevamo una pubblicità nuova, moderna, soprattutto internazionale: eravamo ormai così solidi da poter osare. Certo, quando cominciarono ad arrivare le prime proteste, rimanemmo male, pensammo persino di smettere e chiedere scusa. Ma capimmo che si trattava di posizioni razziste, e noi il razzismo non potevamo accettarlo. E poi, dal punto di vista degli affari, quelli che protestavano non erano il nostro pubblico, non erano interessati al nostro prodotto, quindi dovevamo andare avanti». Infatti più la gente si indignava, i giornali polemizzavano sino a rifiutare l’inserzione e il gran giurì della pubblicità stigmatizzava (ci furono persino picchetti fuori dai negozi inneggianti al boicottaggio) per la suora che bacia il pretino, per il neonato bianco sul seno nudo di una donna nera, per quella specie di pietà caravaggesca attorno a un malato di aids morente, più Benetton vendeva, prosperava, ingigantiva. Di anno in anno, scomparso il prodotto dalla pubblicità, solo in un angolo un tassello verde con la scritta “United Colors of Benetton”, la dispettosa genialità di Toscani e la partecipazione ideologica e mercantile di Luciano continuarono a provocare con la brutalità del reale: nascita, sesso, dolore, morte, razzismo, pena di morte, antimilitarismo, pacifismo; il neonato attaccato al cordon e 1999 Abito spray printed 2000 Felpa floreale 2000 Girocollo “Tye & Dye” ombelicale, i preservativi, le carrette del mare grondanti clandestini, il delitto di mafia, i bambini lavoratori, il cimitero di guerra, la serie di sessi femminili e maschili (opera invitata in gigantografia alla Biennale d’arte veneziana nel 1993, rifiutata da tutti i giornali tranne Liberation). Sempre più scomoda, beffarda e brutale, la pubblicità dell’azienda affronta tabù impensabili per la comunicazione commerciale: ecco la divisa insanguinata, vera, di un soldato bosniaco morto in guerra, donata dal padre (1994); ecco i ragazzini disabili di un istituto bavarese (1998); e l’ultima campagna, quella che suscita massimo scandalo e probabilmente incrina il rapporto tra Benetton e Toscani: i ritratti di 28 condannati nel raggio della morte di un carcere americano (2000). I magazzini Sears che hanno 400 negozi negli Stati Uniti rompono il contratto di distribuzione; un intero stato, il Missouri, fa addirittura causa (poi rientrata) all’azienda. L’imprenditore chiederà pubblicamente scusa ai parenti delle vittime di quei criminali, mentre Toscani respinge ogni accusa. Il genio della pubblicità e il genio dell’imprenditoria si separano, e da gentiluomini, eviteranno polemiche. Anche adesso: «È stata una decisione comune. Era finita una stagione, e non solo tra noi: stava cambiando la società, cambiavano i giovani, il modo di consumare e i desideri. Noi dobbiamo interpretare il mondo che viene non come lo vorremmo ma come è, per vendere bisogna essere contemporanei». Poi oggi i problemi sono altri, giganteschi: Benetton era il solo marchio internazionale che assicurava abbigliamento di qualità a buon prezzo, adesso la concorrenza è durissima. «Ma il nostro sistema industriale è buono, investiamo ovunque, cresciamo in termini di fatturato, apriamo sempre più negozi, in Cina per esempio, in India l’anno prossimo saranno un centinaio. Resta da conquistare l’Africa che, a parte i paesi affacciati sul Mediterraneo e il Sudafrica, dove già sventolano gli United Colors, è ancora soggiogata dalla povertà, dalla fame, dalla sudditanza delle donne e da quelle guerre civili che Benetton illustra ancora nella sua comunicazione. «Però cominceremo presto dall’Angola che, tra diamanti e petrolio, sta avviandosi verso una forma di benessere». Le magliette continuano a trionfare in luoghi sempre più esotici, lo spirito libertario e mondialista del marchio si è addolcito ma esiste ancora, come per la campagna promossa assieme al World Food Program, con i bei ritratti di persone che vivono in paesi disagiati e le semplici scritte, in inglese, Cibo per studiare, Cibo per lavorare, Cibo per la pace, Cibo per la vita. «Nel 1969 aprimmo il primo negozio all’estero, e fummo tanto temerari da scegliere Parigi, rue Bonaparte, nel cuore della massima eleganza mondiale. Era come sottomettersi a un duro esame con professori molto esigenti. Eravamo coscienti del rischio, ma se non rischi, che divertimento c’è? È per quella prima sfida di noi provinciali neoimprenditori, che oggi abbiamo scelto Parigi e il suo celebre Centre Pompidou per festeggiarci». 2000 “Metallic pull” 34 LA DOMENICA DI REPUBBLICA la memoria DOMENICA 27 AGOSTO 2006 Amicizie pericolose A 85 anni Sidney Rittenberg è in ottima forma. Nella sua casa di Pechino racconta una vita eccezionale: fu uno stretto collaboratore del padre della rivoluzione cinese, ma due volte cadde in disgrazia e venne incarcerato per un totale di sedici anni. Nel trentennale della morte del “Grande Timoniere”, il suo giudizio è equanime: “Fece grandi cose e gravi danni” Il “compagno americano” finito nelle prigioni di Mao FEDERICO RAMPINI «L PECHINO ’ultima volta che parlai a tu per tu con Mao fu la festa del Primo maggio 1967, mentre imperversava la Rivoluzione culturale che lui aveva scatenato. Quel giorno ero nel gruppo di dignitari insieme a lui, mentre passava in rassegna le giovani Guardie rosse su piazza Tienanmen. Mi aveva regalato una copia del suo Libretto rosso con autografo, scambiammo due chiacchiere. Mao scherzò: “Io non ho fatto nulla, sono questi ragazzi che fanno tutto, io ho solo scritto qualche poema”. Sembrava sicuro di sé, allegro, ironico, rilassato, al culmine della sua potenza. Pochi minuti dopo lo rividi, si era allontanato dal palco ed era seduto a riposare in disparte, da solo. Improvvisamente la sua faccia era cambiata: gonfia, livida, con uno sguardo tra l’odio e la disperazione. In seguito per anni, rinchiuso in prigione, ripensai a quel contrasto. Era come se capisse di aver suscitato dei demoni che non avrebbe saputo controllare». Sidney Rittenberg mi racconta questi ricordi nel lussuoso salotto della sua casa cinese, un moderno appartamento in un grattacielo di Pechino vicino all’hotel Peninsula. È un quartiere da ricchi e Rittenberg potrebbe confondersi con tanti uomini d’affari americani che prosperano nel boom della Cina. A 85 anni è in gran forma, è un sinologo autorevole, alterna incarichi universitari e attività di consulenza per le multinazionali che investono in Estremo Oriente. Ma Rittenberg è un personaggio unico, con una biografia eccezionale. È il solo occidentale ad essere stato al tempo stesso uno stretto collaboratore di Mao Zedong e ad essere precipitato per due volte in disgrazia, sperimentando di persona sia l’ebbrezza del potere che la feroce violenza del maoismo. In Cina ha scontato due condanne al carcere di massimo isolamento, due purghe politiche per un totale di sedici anni. A differenza di tanti suoi compagni di sciagura, è sopravvissuto alle torture degli interrogatori ed è ancora qui per testimoniare. Molti dettagli sono agghiaccianti. Pochi mesi dopo l’ultimo incontro con Mao l’immagine di Rittenberg sparì di colpo dalla foto di gruppo pubblicata sulla stampa di regime: fu l’indizio che il grande capo lo aveva abbandonato, il segnale premonitore dell’orrore che stava per abbattersi su di lui, una delle ricorrenti persecu- Paracadutato in Cina nel 1945, decide di restare per aiutare i comunisti. Il primo arresto è del ’49 e finisce con le scuse del governo zioni che Mao scatenava nei ranghi del partito colpendo alla cieca anche i suoi fedelissimi. «Il 21 febbraio 1968, nella notte più fredda di tutti i miei inverni di Pechino, alle undici di sera bussarono alla porta di casa. Erano due guardie del ministero della Propaganda, dove lavoravo. Dissero: “Il capo vuole parlarti di un nuovo incarico”. Mia moglie capì subito. Sarebbero passati nove anni, otto mesi e un giorno prima che io rivedessi lei, i miei figli, e la luce del sole». Quella sera d’inverno del ‘68 la storia per lui si ripeteva. Rittenberg piombava in un incubo già vissuto il 21 gennaio 1949, quando un compagno gli aveva mentito annunciandogli che sarebbe stato nella prima colonna dell’Esercito di liberazione popolare in marcia su Pechino, poi una volta salito sulla jeep gli aveva det- to: «La Commissione militare ti dichiara in stato di arresto. Hai avuto istruzioni dall’imperialismo americano, sei una spia mandata a sabotare la rivoluzione cinese». Eppure l’essere stato sepolto vivo per due volte nei gulag maoisti non ha intaccato l’affetto di Rittenberg per la sua seconda patria. Trent’anni dopo la morte di Mao, l’ex «compagno americano» oggi ha uno sguardo imparziale sul tiranno che fu all’origine delle sue disgrazie. La storia d’amore con la Cina inizia un po’ per caso, anche se le premesse ideali ci sono dall’infanzia. Rittenberg nasce da una famiglia ebrea e atea nell’America razzista e bigotta del profondo Sud (Charleston, South Carolina), ha un nonno materno russo che si è distinto nella rivoluzione bolscevica. Da ragazzo “Sid” si appassiona per le lotte operaie e si iscrive al piccolo Partito comunista americano. Arruolato per la Seconda guerra mondiale, lo addestrano a una missione in Estremo Oriente insegnandogli il mandarino a Stanford. La vera passione per la Cina la accende una bambina di dodici anni, Li Muxian ovvero “Li la fata del bosco”, che lui non ha mai conosciuto. Nel 1945 i comandi militari lo paracadutano in Cina dove gli americani assistono Chiang Kai-Shek nella sua duplice guerra contro il Giappone e contro i partigiani comunisti. Il primo incarico di Rittenberg 24enne è una triste incombenza amministrativa: smaltisce pratiche per il risarcimento alle vittime di incidenti provocati da soldati americani. A Kunming, nello Yunnan, un giorno Rittenberg consegna la miserabile somma di 26 dollari a un tiratore di risciò, il padre di Li Muxian, per “rimborsargli” la sua bambina investita e uccisa da un G.I. ubriaco. Con grande sorpresa del giovane americano, il povero tiratore di risciò non protesta di fronte all’esiguità della somma. Anzi, il padre della vittima offre la metà dei soldi al militare straniero che lo sta pagando: un riflesso condizionato, l’abitudine alla dilagante corruzione cinese. Quel ricordo della “fata del bosco” e della rassegnata disperazione di suo padre di fronte all’ingiustizia accompagnerà Rittenberg per tutta la vita. Nei suoi giudizi sul maoismo, non dimenticherà mai in quali condizioni versava la Cina prima della rivoluzione. Disgustato dal sostegno americano ai nazionalfascisti di Chiang Kai-Shek, alla fine della guerra Rittenberg resta in Cina per aiutare i comunisti. Incontra Mao Zedong in persona per la prima volta nel 1946, sulle montagne di Yanan, dove il leader è rifugiato nelle grotte al termine della Lunga marcia. L’americano si rivela utile come interprete e redattore dei testi diffusi via radio nelle prime trasmissioni internazionali della propaganda maoista. Ha inizio la sua lunga carriera nella nomenklatura del partito, interrotta dal primo arresto nel ‘49. I primi sei anni di carcere, tra interrogatori brutali e lunghi isolamenti, sono un viaggio nella follia autodistruttiva: lungi dal criticare il regime, Rittenberg dà ragione ai suoi aguz- LE TAPPE LA GIOVENTÙ LA LOTTA PARTIGIANA Mao Zedong nasce il 26 dicembre del 1893 nel villaggio di Shaoshan, provincia di Hunan. È figlio di contadini agiati. Nel 1918 ottiene il diploma magistrale Dal 1921 milita nel Partito comunista cinese Guida le rivolte contadine del 1927 e poi la lotta partigiana contro il governo nazionalista di Chiang Kaishek. Durante la Lunga Marcia (1934-35) emerge come capo del Partito comunista cinese DOMENICA 27 AGOSTO 2006 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 35 Sidney Rittenberg nasce in una famiglia ebrea e atea della South Carolina. Il nonno materno era un bolscevico, lui sceglierà la rivoluzione cinese. Nella foto qui sotto è con Mao, che ha in mano una copia del suo celebre “Libretto rosso”. In basso, un ritratto del 1979; a sinistra, oggi, a 85 anni, nella sua casa di Pechino con la moglie Wang Yulin Repubblica Nazionale 35 27/08/2006 zini, colpevolizza se stesso. «Scrutando nel mio passato trovavo tante ragioni che avevano di sospettare di me. A Yanan avevo avuto una relazione sentimentale non approvata dal partito. Avevo messo in dubbio la dottrina leninista sulla dittatura del proletariato. Avevo auspicato l’indipendenza del Tibet. Ora trovavo la tranquillità identificandomi con la verità di partito, l’unica verità. Sopravvivevo alla sofferenza persuadendomi che me l’ero meritata». Quando il 4 aprile 1955 il direttore del carcere lo dichiara innocente e gli presenta «le scuse del governo popolare», Rittenberg si è talmente convinto di essere nel torto che non riesce a capire quelle scuse. Rieducarsi alla vita normale è difficile. «Dopo sei anni in cui avevo chiesto il permesso anche per usare la latrina, dovevo riabituarmi a stare in mezzo ad altre persone, mi venivano attacchi di panico, avevo paura di prendere la parola, l’apparizione di una uniforme mi terrorizzava. Ero stato rilasciato da una cella ma ne avevo costruito un’altra dentro di me». Lo aiuta il matrimonio con Wang Yulin, coraggiosa compagna di una vita, che nelle avversità metterà sempre l’amore coniugale al di sopra della fedeltà di partito. La riabilitazione di Rittenberg è totale: viene promosso ai vertici dell’apparato di propaganda, con incarichi di fiducia come la traduzione in inglese delle opere di Mao. Diventa uno dei più autorevoli comunisti stranieri residenti in Cina, il leader di una singolare diaspora di “rossi” americani — alcuni fuggiti dagli Stati Uniti durante la caccia alle streghe del maccartismo — tra cui figura Jane Sachs, figlia del fondatore della banca Goldman Sachs. Nel 1966 Mao lancia la Rivoluzione culturale e Rittenberg ne è affascinato per la stessa ragione che accende gli animi dei giovani cinesi: la parola d’ordine «Bombardate il quartier generale» autorizza la base a criticare i vertici. Il popolo può scagliarsi contro la burocrazia del partito. «Prima che degenerasse nell’anarchia e nella dittatura delle piazze, fu l’unico esperimento di democrazia di massa mai tentato in Cina. C’era una spontaneità vera, nelle assemblee la gente eleggeva i propri leader, nascevano organizzazioni politiche dal basso, si pubblicavano giornali senza chiedere permessi». Rittenberg si lancia nel movimento con ardore, diventa un trascinatore, i suoi comizi lo rendono famoso, è nella cerchia dei favoriti di Mao. Nella sua ingenuità non si accorge che il vento gira in fretta. Dopo avere usato la Rivoluzione culturale per sgominare “Una notte del febbraio 1968 bussarono alla porta. Sarebbero passati nove anni, otto mesi e un giorno prima di rivedere moglie e figli” la corrente moderata che stava prendendo il controllo del partito, Mao abbandona le Guardie rosse quando il caos rischia di sfuggirgli di mano. Rittenberg continua a esaltare la rivolta antiautoritaria mentre già dall’alto è partito il contrordine. Quando nel ‘68 lo sbattono in una gelida e lurida cella larga due metri e mezzo, «l’impossibile, l’inconcepibile ricominciò di nuovo: eccomi ancora una volta in un carcere di massimo isolamento per qualche reato che non avevo commesso, sottoposto a pratiche disumane che credevo fossero state abbandonate; tutto si ripeteva daccapo, come se i 13 anni di libertà dopo la prima galera fossero stati solo un sogno». Gli interrogatori da Grande Inquisizione, le umilianti preghiere in ginocchio davanti al ritratto di Mao, le urla strazianti dei torturati LA PRESIDENZA IL DECLINO Vinta la guerra civile contro il Kuomintang e proclamata la Repubblica popolare cinese, nel 1949 Mao è eletto presidente Dopo aver dato avvio al “Grande balzo in avanti”(‘58) nel ’60 rompe con Mosca Nel 1966 Mao lancia la Rivoluzione culturale Il suo potere è ormai assoluto. Dal ’69 per il Grande Timoniere inizierà però il declino. Ormai stanco e malato di Parkinson, Mao muore il 9 settembre del ‘76 nella notte: è un calvario micidiale ma stavolta la sua psiche non cede. Sa di essere innocente e la sua certezza non vacilla mai, fino a quel 19 novembre 1977 in cui la porta del carcere si apre una seconda volta e un colonnello gli annuncia: «Sei stato vittima di un errore. Sei un bravo compagno». Torna libero in una società irriconoscibile, già in evoluzione sotto l’effetto delle riforme di Deng Xiaoping. Il capitalismo diventa il nuovo Verbo, le nuove generazioni sono materialiste e filoamericane, rinnegano gli ideali che avevano legato Rittenberg alla Cina. E così nel 1980 per la prima volta dopo 35 anni lui si riconcilia con il suo Paese, torna in America, porta con sé la moglie e i quattro figli cinesi, inaugura una seconda vita da studioso e businessman, pendolare tra le sponde del Pacifico. Sa di avere sbagliato molto, ma ha pagato tutto fino all’ultimo, e di persona. È un uomo sereno, senza rancori né rimpianti. Ha conservato amicizie importanti nella nomenklatura di Pechino (ci volle l’intercessione di Rittenberg per convincere Deng Xiaoping a dare la prima ed unica intervista a una tv straniera, l’americana Cbs). Ha fatto pace anche con il ricordo del suo carnefice. «Ho conosciuto Mao troppo bene per liquidarlo solo come un mostro. È stato due persone diverse, ha avuto due vite. Quando lo conobbi nel 1946 emanava già quel carisma da cui io fui affascinato, eppure era anche un attento ascoltatore, un ex contadino autodidatta dalla mente aperta e brillante, capace di assorbire molto dagli altri. Vent’anni dopo non ascoltava più nessuno, si era trasformato in una figura imperiale, un sovrano assoluto e distante. Nessuno più di lui è stato corrotto dal potere. Ha creduto di poter governare la Cina con gli stessi metodi usati nella guerriglia partigiana. Ha rovinato la vita di un numero immenso di persone. Decine di milioni di cinesi sono morti, non per una volontà deliberata di sterminio, ma per gli errori catastrofici della sua politica. Inseguiva un gigantesco esperimento di ingegneria sociale, sognava di plasmare il mondo con la mente di un uomo solo. Nessun altro ha fatto così grandi cose e così gravi danni come lui». 36 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 27 AGOSTO 2006 il racconto Leggende del West Torna sugli schermi col volto di Brad Pitt il mito di Jesse Woodson James, guerrigliero sudista, alleato del Ku Klux Klan e poi rapinatore. Un criminale feroce ma anche un abile costruttore della propria immagine di Robin Hood Jesse, il bandito schiavista che ha stregato l’America ANTONIO MONDA NEW YORK È stato un criminale capace di agghiaccianti efferatezze, e non se ne è mai pentito. È stato un uomo introverso e selvaggio, animato da confusi ideali politici e motivato in primo luogo da rancore, frustrazione, voglia di vendetta. È stato un bandito da strada che non conosceva la fatica e la paura, eppure era in grado di manipolare la stampa illudendosi di non esserne a sua volta manipolato. Insieme al fratello Frank, ha terrorizzato il Missouri, il Kansas e poi l’intero West, in un crescendo di azioni audaci, inaspettate e violentissime. Ha amato due donne che portavano lo stesso nome, Zerelda, la madre e una cugina che poi divenne sua moglie, ma neanche con loro si è mai aperto completamente, neanche a loro ha confidato cosa lo tormentava al punto di scegliere senza remore la strada del crimine e cercare ossessivamente la fama attraverso gli omicidi e le rapine. Chi lo ha conosciuto da vicino lo ha descritto come un ribelle feroce e velleitario, solitario e disperatamente bisognoso della ribalta, che nel momento della massima gloria riuscì ad essere celebrato come il “Robin Hood americano”. La sua parabola ha molte affinità con quelle dei nostri briganti, e per alcuni versi è stato il precursore dei moderni terroristi, ma nello stesso tempo l’icona di un mondo indifendibile che rifiuta di arrendersi all’ineluttabilità del proprio tramonto. Come molti dei protagonisti dell’epopea del West, Jesse Woodson James si è trovato a recitare il personaggio che era riuscito a creare, intuendo che i contemporanei, e soprattutto i posteri, avrebbero sempre preferito la leggenda alla realtà. Ma più di ogni altra cosa è stato e continua ad essere un mito, come testimoniano la magnifica biografia di T. J. Stiles recentemente pubblicata dal Saggiatore (Jesse James, storia del bandito ribelle), la riproposizione della ballata tradizionale che ne celebra le gesta da parte di Bruce Springsteen, e l’ennesimo film agiografico che questa volta vede come protagonista Brad Pitt e sin dal titolo mette in chiaro chi sia l’eroe della vicenda: L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford. Jesse era nato in un piccolo villaggio del Missouri chiamato Centerville, ribattezzato in seguito Kearney senza cambiare la propria natura di desolata entità nel centro del nulla. Il padre era un reverendo battista di nome Robert, noto per le sue prediche infervorate a difesa del diritto di possedere schiavi, che un bel giorno abbandonò la moglie Zerelda e se ne andò in cerca di fortuna in California, dove visse di espedienti e morì in miseria durante la corsa all’oro. Ridotta ai limiti della povertà, Zerelda cercò di riscattare la propria condizione economica sposando Benjamin Simms, un uomo d’affari che la lasciò nuovamente vedo- L’incontro-chiave della sua vita fu con John Edwards, giornalista e razzista militante, che ne divenne l’agiografo e costruì il suo personaggio va nel giro di poco tempo, e quindi un medico di nome Reuben Samuel. Il terzo marito era un uomo dal carattere fragile e sin dai primi giorni fu soggiogato dall’energia della donna, che riuscì a impiantare una coltivazione di tabacco e acquistare alcuni schiavi. Dopo un lungo periodo di stenti ed umiliazioni sembrava che le cose si mettessero finalmente bene per Zerelda e i suoi figli, ma in quegli anni l’America si ritrovò immersa nella tragedia della guerra civile e il Missouri, diviso tra unionisti e simpatizzanti per il Sud, fu uno degli stati che visse il conflitto in maniera più lancinante. Zerelda fu molto orgogliosa quando il figlio Frank decise di arruolarsi per combattere gli «orribili invasori abolizionisti» del Nord. La contea di Clay, dove sorgeva la fattoria dei James, era continuamente teatro di violentissime razzie, e una sera Zerelda e il giovanissimo Jesse videro arrivare un gruppo di unionisti che trascinarono l’imbelle Reuben nell’aia, lo massacrarono di botte e lo appesero a un albero minacciando di impiccarlo se non avesse rivelato dove si nascondeva Frank, che si era unito ai bushwackers, i temutissimi guerriglieri confederati. Terrorizzato, Reuben rivelò le poche cose di cui era a conoscenza e ebbe salva la vita, ma da allora campò circondato dal disprezzo della famiglia. Jesse, che era stato a sua volta umiliato e malmenato dal gruppo di unionisti, decise di darsi alla macchia e dopo aver raggiunto il fratello si unì con lui ad una banda di bushwackerschiamata “Quantrill Raiders”. Si trattava di uomini che vivevano con vergogna e furore l’invasione del proprio stato e propugnavano attraverso la guerriglia la difesa dei principi nei quali erano cresciuti, a cominciare dalla schiavitù. Jesse, che aveva solo sedici anni, si trovò immediatamente a proprio agio con questi uomini che ammantavano di ideali politici le razzie e i linciaggi: i “Quantrill Raiders” erano capaci di ogni efferatezza, come testimonia l’attacco condotto alla cittadina abolizionista di Lawrence, che portò al massacro di duecento persone. Nulla al confronto con quello che successe in seguito, quando Jesse e Frank si arruolarono nella banda di Bill “Bloody” Anderson, un bushwacker noto per l’a- bitudine di fare a pezzi le proprie vittime. L’episodio più barbaro del loro sodalizio è quello avvenuto nel settembre del 1864 a Centralia, quando la banda bloccò il passaggio di un treno sul quale tornavano a casa dei soldati unionisti, che vennero massacrati dopo essere stati costretti a denudarsi. L’orrore suscitato dall’episodio mise in moto una gigantesca caccia all’uomo, ma i centoventi soldati del reggimento inviato per catturare i bushwackers vennero attirati in una imboscata e a loro volta trucidati. Per lungo tempo Anderson e compagni mostrarono con orgoglio gli scalpi delle vittime, e continuarono a organizzare spietate azioni di guerriglia per tenere in piedi un fronte che si stava avviando alla disfatta. Può risultare sconcertante che un uomo coinvolto in simili atrocità sia diventato un personaggio positivo del folklore americano. Ma dopo l’uccisione di “Bloody” Bill per mano dei soldati, più esperti e numerosi, di un secondo reggimento, e dopo la resa di Appomattox che decretò la vittoria degli stati del Nord, ci furono una serie di episodi che segnarono l’inizio del mito di Jesse James, a cominciare dal suo graduale passaggio da sanguinario partigiano al servizio di una causa sconfitta a vero e proprio bandito. La resa dei confederati non attenuò minimamente i conflitti nati negli anni della guerra, e la devastazione dei territori di frontiera finì per inasprire ulteriormente le tensioni, l’odio e la voglia di riscatto. All’interno di un mondo che aveva visto crollare i propri principi fondanti, a cominciare dal “diritto” a possedere schiavi, Jesse intuì che sarebbe potuto diventare un punto di riferimento e persino un modello: era giovane, bello, coraggioso e ribelle, e non riusciva ad accettare che quelli che considerava dei valori irrinunciabili fossero stati spazzati via dai repubblicani abolizionisti, dai «rapaci predatori» del Nord. È importante ricordare che, a cominciare da Lincoln, in quel periodo erano i repubblicani a combattere per la causa abolizionista, mentre i democratici difendevano con ogni mezzo lo status quo. L’incontro più fortunato di Jesse James in vista della costruzione del suo mito fu quello con John Edwards, uno spregiudicato giornalista di fede democratica e di sicure convinzioni razziste. Nello stesso momento in cui Jesse, insieme a Frank e ai fratelli Younger, cominciò a rapinare le banche e i treni, Edwards divenne l’agiografo della banda, celebrando le formidabili gesta della «cavalleria del crimine», del gruppo di banditi che offriva una risposta «personale e coraggiosa» allo sfascio di un paese minato nelle fondamenta dai «soprusi dei nordisti». Nella stragrande maggioranza dei casi, la banda JamesYounger non derubò i passeggeri dei treni né i clienti delle banche, ma puntò direttamente alle casseforti di istituzioni finanziarie solidamente nelle mani degli odiati nordisti, e questo diede gioco facile a Edwards per costruire il mito del nuovo Robin Hood. In uno dei pezzi più osannanti, paragonò la banda ai DOMENICA 27 AGOSTO 2006 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 37 Ispirato all’omonimo romanzo di Ron Hansen e diretto da Andrew Dominik, “The assassination of Jesse James” (nei cinema italiani, “L’assassinio di Jesse James”) racconta l’ultimo giorno di vita del bandito più amato del West. La storia è nota: Jesse James (Brad Pitt) si trova nella propria fattoria e riceve la visita di un “collega” di banda, Robert Ford. Il bandito è salito su una sedia per spolverare un quadro e dà le spalle a Ford. All’improvviso l’ospite spara a James con la sua Colt 45 e lo colpisce alla nuca. Ford si meriterà così i dollari della taglia messa su James. Ma non potrà goderseli... Il film sarà nelle sale americane dal prossimo 15 settembre EROE POPOLARE Jesse James sulle copertine di alcune riviste dell’epoca Nella pagina di sinistra, I fratelli-banditi Jesse e Frank James con la madre, Zerelda Samuel IL MITO Anche la sua morte fece sensazione Gli sparò alle spalle Robert Ford, I FILM/1 I film girati sulla figura di Jesse James sono almeno una ventina Il primo della serie, “The James boys of Missouri”, è del 1908 Tra i tanti, spiccano “The true story of Jesse James” di Nicolas Ray (1957) e “I cavalieri dalle ombre lunghe”, del 1980, con regia di Walter Hill FOTO CORBIS Repubblica Nazionale 37 27/08/2006 I FILM/2 I LIBRI “The assassination of Jesse James” è ispirato all’omonimo romanzo di Ron Hansen Da leggere anche il ritratto biografico di T.J. Stiles “Jesse James” LE CANZONI La più popolare è la folk song intitolata Jesse James e interpretata anche da Bruce Springsteen. Il bandito è stato cantato anche da Bob Dylan e Elton John il suo braccio destro che era al soldo del governatore del Missouri cavalieri della tavola rotonda e esaltò il fatto che i suoi componenti rubassero «alla luce del sole e di fronte alla folla». Inebriato dall’improvvisa celebrità e dalla simpatia crescente di una popolazione che vedeva in lui l’eroico vendicatore, Jesse cominciò ad arricchire le sue scorrerie con gesti ad effetto e battute studiate per essere immortalate dalla stampa. Cominciò a scrivere lettere ai giornali, revisionate dallo stesso Edwards, nelle quali celebrava le proprie azioni, negando gli addebiti più gravi. La strategia si rivelò perfetta, e Jesse divenne per molti un eroe popolare. Poco importava che non esitasse a massacrare chi tentava di resistere alla rapine, e agisse spesso in simbiosi con gli esponenti del Ku Klux Klan, celebrati a loro volta da Edwards, che individuava nelle loro azioni, come in quelle del bandito, la residua speranza di restaurare il vecchio regime sudista. Ma l’apoteosi fu al termine della lunga battaglia con l’agenzia Pinkerton, assoldata dai proprietari delle ferrovie per dargli la caccia. Jesse riuscì a individuare e uccidere due agenti che avevano tentato di infiltrarsi nella sua banda. In risposta, il capo dell’agenzia guidò personalmente un assalto notturno alla fattoria della madre Zerelda, pensando che lì fosse nascosto Jesse. La spedizione punitiva si concluse con un sanguinosissimo fiasco: fu ucciso il fratellino di dieci anni dei due banditi e venne ferita la madre, che fu poi costretta a farsi amputare un braccio. Agli occhi della popolazione e dei lettori di Edwards, Jesse divenne immediatamente la vittima di cacciatori di taglie sanguinari e inetti. Un effetto del fiasco fu l’immediato abbassamento delle taglie sul suo capo, e quindi la proposta di immunità per i suoi delitti attraverso un’amnistia, proposta avanzata dall’amministrazione democratica, che aveva preso il potere nello stato del Missouri anche grazie alle sue azioni, e che aveva restaurato la segregazione razziale. Dopo aver ottenuto questa doppia vittoria, personale e politica, Jesse e Frank assaltarono insieme ai fedelissimi Younger una banca a Northfield, nel Minnesota. Il colpo fallì per la resistenza di un impiegato che rifiutò di aprire la cassaforte, e con sgomento la banda si rese conto in quell’occasione di non avere alcun supporto da parte della popolazione. All’uscita dalla banca si trovarono sotto il tiro di una moltitudine di fucili e pistole. Due dei tre fratelli Younger rimasero uccisi, Jesse e Frank riuscirono miracolosamente a defilarsi dalla caccia che per molti giorni gli diedero più di mille uomini armati. Quando seppe che erano stati traditi da un informatore infiltrato nella banda, Frank decise di abbandonare per sempre la vita di bandito. Jesse, che non riusciva a capire come i tempi fossero ormai cambiati, si convinse invece di non avere altro destino. Scrisse all’amico Edwards in cerca di aiuto, ma il giornalista non rispose. Jesse ne fu profondamente ferito e da quel momento cominciò a cercare la morte. Cambiò identità e si ritirò a St. Joseph, nel natio Missouri, con la moglie Zerelda che gli aveva dato quattro figli. Formò una nuova banda con uomini di cui non si fidava e, in un crescendo paranoico, cominciò a giustiziarli ogni volta che cominciava a sospettare della loro lealtà. Morì per mano di colui che considerava il suo nuovo braccio destro, un uomo capace di sparargli alle spalle mentre stava appendendo un quadro. Il suo nome era Robert Ford. Insieme al fratello Charlie era al soldo del nuovo governatore del Missouri Thomas Crittenden, che aveva promesso alla popolazione di liberare il paese dal pericoloso criminale. La notizia si sparse rapidamente per tutto lo stato e una folla enorme accorse per vedere il cadavere e partecipare al funerale. Le due Zerelde della sua vita maledissero pubblicamente l’assassino, che venne graziato dal governatore ma fu accusato ferocemente da tutta la stampa. Per l’occasione scrisse un necrologio anche John Edwards, che si chiese «cosa altro poteva fare un uomo come Jesse James se non quello che ha fatto?», descrisse come «vigliacca e inutile» l’uccisione e concluse: «Volesse Iddio che fosse vivo oggi per massacrare giustamente qualcun altro». La sorpresa per la morte inaspettata generò un’emozione dagli esiti imprevisti: Frank James si consegnò personalmente a Crittenden e venne assolto dopo uno spettacolare processo che vide opposta la stampa repubblicana, propugnatrice di una condanna esemplare, a quella democratica che giustificava ogni azione criminale con il disordine morale dei tempi. Quando tornò in libertà, Frank organizzò insieme all’unico fratello Younger rimasto in vita uno spettacolo nel quale metteva in scena le loro gesta più celebri. Fecero lo stesso i due fratelli Ford, fin quando Charlie decise di togliersi la vita e Robert venne misteriosamente assassinato. John Edwards rientrò nell’oscurità, vide fallire i suoi ideali politici e morì alcoolizzato. Ma Jesse, la sua più grande creazione, si trasformò in un mito, celebrato da canzoni, libri e film bellissimi come I cavalieri delle lunghe ombre, prendendo negli anni le sembianze di Tyrone Power, James Keach, Robert Duvall e, tra breve, Brad Pitt. 38 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 27 AGOSTO 2006 i luoghi Sorge nel sud-est dell’India, ha meno di 2000 abitanti che vivono secondo le regole dettate da Sri Aurobindo, uno dei padri dell’indipendenza convertitosi al misticismo. Da 35 anni la comunità degli aurovilliani, venuti un po’ da tutto il mondo, si nutre di filosofia e scienza per prepararsi al salto spirituale che renderà l’anima degli uomini, diceva il guru, “spaziosa come l’universo” Sogni e realtà VITA DA AUROVILLIANI/1 Un guardiano al cancello della spiaggia di Auroville, due architetti aurovilliani al lavoro e una vecchia casa della città Auroville, la città perfetta «C RAIMONDO BULTRINI AUROVILLE i dev’essere un posto sulla Terra che nessuna nazione rivendica come sua proprietà, un posto dove tutti gli uomini di buona volontà, dall’aspirazione sincera, possono vivere liberamente come cittadini del mondo, obbedendo a una sola autorità, la Verità Suprema». Il sogno della città utopica di Auroville nasce da questa preghiera-auspicio recitata all’inizio del secolo scorso da Mirra Alfassa, compagna spirituale di Sri Aurobindo, uno dei guru dell’indipendenza indiana. Negli ultimi trentacinque anni la “creatura” di questa coppia unita da grandiose visioni mistiche ha continuato lentamente ma senza sosta a prendere forma. Si chiama Auroville, una città con meno di duemila abitanti di ogni razza e classe sociale: 1.200 ettari di terra rossa, un tempo arida e ora ripopolata di alberi, lungo la costa equatoriale tra il Tamil Nadu e la piccola, incantevole ex colonia francese di Pondicherry, a tre ore d’auto a nord di Madras. Aurobindo non ha mai spiegato come sarebbe dovuta essere in concreto la città, destinata a ospitare al massimo cinquantamila abitanti, ma ha fissato i principi dell’esperimento: nel perimetro urbano vanno progressivamente abolite tutte le forme di competizione per soldi, fama, potere. Per riuscirci bisogna cominciare a cancellare alcuni tra i fattori che causano le competizioni: politica, sistema monetario, religioni istituzionalizzate, sesso, droga, inquinamento, eserciti, polizie e, soprattutto, il concetto del possesso. Tra viali sterrati e abitazioni dalle architetture bizzarre disseminate in di- Chi sceglie di vivere qui lascia i suoi averi alla Fondazione e rinuncia Repubblica Nazionale 38 27/08/2006 a ogni forma di competizione Sono banditi politica, droga e sesso. Ma non ci sono guardiani a imporlo sordine lungo i tracciati di un piano regolatore a forma di galassia ellittica (in gran parte ancora sulla carta), gli aurovilliani si nutrono di filosofia e scienza nel ventre-laboratorio che costruisce la «Nuova razza umana», una «Superrazza» che sarà — a detta dei suoi profeti — l’ultima evoluzione dell’homo sapiens. «L’utopia dell’uguaglianza tra gli uomini ha condizionato tanti movimenti dell’Asia e dell’Occidente, ma Auroville vuole dimostrare che la vera uguaglianza non si raggiunge per voto unanime di un comitato centrale», spiega Paulette Hadnagi, una ex militante di Potere Operaio negli anni di piombo italiani, che sperimenta qui la sua seconda vita di rivoluzionaria, stavolta della coscienza. Mirra Alfassa rappresenta per Paulette e per gli altri aurovilliani una personalità eccentrica rispetto ai canoni femminili del primo Novecento: origini turco-egiziane, due matrimoni burrascosi, l’abbandono del secondo marito per correre da Parigi a Pondicherry ai piedi del guru visto in un sogno d’infanzia. Posseduta fin dalla tenera età da questa e da altre visioni oniriche, Mirra adeguò nei trent’anni passati con Aurobindo i suoi poteri psichici all’immane compito che le era stato assegnato dal guru: dare forma ai disegni ultramondani della “Supermente”, o “Supercoscienza generatrice”, da lei descritta come una forma d’energia e di saggezza inesauribili posta esattamente al centro di ogni essere umano e dunque al centro dell’universo. Per questa sua capacità di attingere alla fonte della creatività universale, Mirra fu chiamata “Madre” e ispirò uno stuolo di architetti, esecutori del primo nucleo storico di Auroville. «Un giorno Madre disse che la Città già esiste a un livello sottile», ha raccontato in un’intervista il primo architetto, Roger Anger. «È già costruita e basta portarla giù, farla discendere sulla Terra». La nascita di Auroville, ritardata dai lunghi periodi di malattia di Mirra dovuti forse ai frequenti stati di trance, avvenne il 29 febbraio 1968, diciotto anni dopo la morte di Aurobindo. Come una sacerdotessa, Mirra Alfassa impartì la benedizione all’urna riempita con le terre provenienti da 124 nazioni e 23 stati indiani che fu collocata al centro dell’anfiteatro dove sarebbe sorto, tre anni dopo, il cuore della futura città, il Matrimandir. Della forma di una gigantesca palla da golf a piccoli ottagoni verniciati di oro vero, il tempio senza statue né icone è un monumento surreale dedicato all’evoluzione dell’umanità. Un’evoluzione della quale Auroville, col suo 55 per cento di verde obbligatorio, si considera la capitale presente e futura. L’Unesco e il governo dell’India si sono ritrovati fin dall’inizio artefici del progetto-esperimento anche se l’utopia è stata affidata a una fondazione senza fini di lucro, commissariata fino al 1988 a causa di cospicui ammanchi di “vile” denaro. Ma da allora la fondazione è tornata a essere quasi del tutto indipendente e almeno formalmente «Auroville», come scrisse Madre, «non appartiene a nessuno in particolare ma all’umanità intera». Lontano dalla visione di Dio delle re- ligioni monoteistiche e dal politeismo di quella hindu, Sri Aurobindo crebbe in Inghilterra, lesse Nietzsche e Freud, si ispirò a Mazzini e alla rivoluzione americana. Dopo il suo rientro in India, mentre Gandhi predicava la non violenza, organizzò gruppi di indipendentisti in Bengala e li spedì in Europa a imparare come costruire bombe, finché l’impatto con la cultura vedica e i poteri dello yoga risvegliarono il suo genio mistico. Paradossalmente, fu in una prigione degli inglesi che fece la sua prima scoperta spirituale, il “silenzio interiore”, uno stato privo di quel dialogo conflittuale della psiche che impedisce all’uomo di comprendere i messaggi più sottili del cosmo e disturba la percezione dell’entità unica e inscindibile DOMENICA 27 AGOSTO 2006 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 39 ALTRE UTOPIE SAN GIOVANNI IN FIORE LE REDUCCIONES NEW LANARK LA NUOVA SION Fu fondata nel 1189 dall’eretico Gioacchino da Fiore sui monti della Sila La vita dei suoi abitanti era ispirata a ideali di povertà, ascetismo e di spiritualismo mistico Piccoli nuclei fondati dai gesuiti a partire dal 1606 in Cile, Brasile Uruguay e Argentina Il modello sociale era collettivistico e teocratico Ispirarono il film “Mission” Nata in Scozia come villaggio industriale nel 1800 fu acquistata da Robert Owen che mise in pratica gli ideali del socialismo utopistico facendone una sorta di industria-modello Si trovava sul monte Amiata (Gr) e fu fondata nel 1868. Fu la patria dei giurisdavidici, i seguaci di Davide Lazzaretti La comunità si ispirò a un socialismo mistico VITA DA AUROVILLIANI/2 Una scultura che adorna il tempio indù della città, due aurovilliani in moto e una casa moderna. Nella foto in basso, il Matrimandir creata dalla “Supermente” Repubblica Nazionale 39 27/08/2006 alla quale tutti saremmo collegati, la “Supermente”. Per questo all’interno del Matrimandir, considerato l’anima di Auroville, l’isolamento acustico è quasi totale e a migliaia ogni giorno vengono qui muniti dei “passi per la meditazione” necessari soprattutto per accedere alla “camera interna”, dove una sfera di cristallo di settanta centimetri di diametro costruita in Germania dalla Zeiss riflette nel buio totale un sottile raggio di luce solare captato dall’alba al tramonto grazie a un complesso sistema computerizzato di specchi ed eliostati. Il raggio simboleggia il processo di ricezione della chiarezza (la conoscenza) nella mente umana, mentre tutt’attorno, tra marmi di Candoglia come quel- li del Duomo di Milano, sono in costruzione dodici stanze chiamate petali, dai diversi nomi e colori, dedicate a riflessioni come “Pace ed eguaglianza” (l’unica già pronta e accessibile su prenotazione), “Sincerità” (di colore celeste), “Generosità” (violetto), “Coraggio” (rossa) e via elencando. Tutto attorno, carezzate dall’Oceano e dal vento caldo equatoriale, tra il verde intenso di palme, banyan e frangipane, spuntano come oggetti marziani le palazzine e gli uffici della città utopica con le loro forme avveniristiche. Spesso le costruzioni sono lasciate alla fantasia di architetti giunti da mezzo mondo per sbizzarrirsi — come nell’eccentrico complesso a tratti gotico di Auromodel — a tradurre in forma i concetti universali di perfezione e armonia predicati da Aurobindo e Madre. Ad Auroville non ci sono leggi codificate, né agenti in divisa per far rispettare le regole contro il fumo, le droghe, il sesso che vigono spontaneamente tra i mistici, i residenti-monaci vestiti sempre di bianco. Sebbene siano tutti consapevoli che ogni attaccamento mondano rallenta il distacco dalle “imperfette” forme fisiche attuali, in questa fase cosiddetta di transizione agli aurovilliani è ancora concesso di sbagliare e di correggersi con i propri tempi. Per diminuire la dipendenza dal denaro il negozio Pour Tous (per tutti) offre mercanzie in baratto. Un falegname può offrire il suo lavoro in cambio di buoni merce, lo stesso un elettricista, un maestro di yoga, un ingegnere di computer, un architetto. «Ognuno dovrebbe dedicare un terzo del suo tempo a lavori per la collettività», diceva Madre. Ma anche gli scansafatiche, se sono benvoluti per il loro buon carattere, trovano ospitalità in qualche stanza della città in perenne costruzione. L’aurovilliano diventa tale a tutti gli effetti dopo due anni di prova come “nuovo arrivato” e dovrà lasciare da quel momento ogni suo avere precedente. In cambio potrà sperimentare le proprie potenzialità creative liberate dall’assillo dei problemi quotidiani. È la comunità che mantiene i singoli disposti a condividere gli ideali e le aspirazioni dei fondatori, chi costruendo case (la casta degli architetti ha un ruolo speciale ad Auroville), chi insegnando nelle speciali scuole della futura umanità, oppure scrivendo libri e articoli per il bollettino comunitario o i giornali, coltivando e distribuendo i prodotti organici delle terre di proprietà della Fondazione, inventando e installando pannelli e pompe solari o impianti eolici, producendo incensi, essenze e tessuti naturali nelle fabbriche relativamente ecologiche dell’area industriale. È questo lo yoga integrale insegnato da Aurobindo: per praticarlo non pochi ricchi indiani, europei, sudafricani, statunitensi hanno affidato tutti i loro averi alla Fondazione. Un terzo degli attuali 1.800 abitanti viene dall’India. Seguono i francesi (300), i tedeschi, gli olandesi e gli italiani (un’ottantina), ben inseriti nella direzione collettiva della città. Uno di questi è Luigi Zanzi, ex viaggiatore hippy che da circa trent’anni si è stabilito qui e ora è responsabile del padiglione internazionale dedicato «all’u- manità dei cinque continenti». «Non siamo borghesi dell’avventura mistica, siamo molto pratici e lavoriamo sodo», spiega. «Continuamente vengono qui scienziati e consulenti per studiare ogni soluzione ecologica esportabile altrove. Stiamo anche lavorando a un’enciclopedia di parole chiave che definiscano concetti comuni a diverse culture e tradizioni». Luigi ammette però che l’utopia di Auroville è certamente ancora molto al di sopra delle capacità ricettive dell’attuale stato di coscienza del pianeta. Ma per la ex rivoluzionaria Paulette Hadnagi, che ha scritto diversi libri sulle linee guida dettate da Madre, gli stessi aurovilliani sono ancora ben lontani dalla meta. Paulette alloggia nell’area residenziale, in un complesso di casette un po’ buie e dal disegno semplice, dove vivono scrittori e artisti, distribuiti anche in molte delle altre aree chiamate “Creatività”, “Perfezione”, “Nuova creazione”. Molti residenti con capitale personale non hanno lesinato spazio e costose soluzioni architettoniche ed è difficile stabilire quanti tra loro abbiano abbandonato davvero tutti i beni per vivere di quello che la comunità produce e vende per mantenersi nel mondo assai poco utopico di oggi. «Il motivo è semplice», commenta con passione Giorgio Molinari, un fotografo e architetto ancora “aurovilliano in prova”. «Molti di noi non sanno se dopo qualche anno riusciranno ancora a vivere qui, abbandonando tutto per mettersi al servizio della comunità e della divina coscienza. Ci vuole un grande e difficile salto interiore». Lo stesso Aurobindo disse una volta di trovarsi solo al primo dei tre stadi che danno accesso a quella dimensione dove i veri superuomini evocati nel laboratorio di Auroville «hanno la mente spaziosa come l’universo». Il cuore del progetto è la grande cupola dorata del “Matrimandir” All’interno il silenzio è quasi perfetto e un unico raggio di luce riflessa simboleggia l’illuminazione 40 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 27 AGOSTO 2006 Quattro anni fa il grande regista, non domato dall’età né dalla malattia, ha dato inizio a una nuova avventura: instancabilmente dipinge, scegliendo i toni freddi e opachi che predilige. A settembre, in occasione dei suoi 94 anni, esporrà a Roma al Tempio di Adriano S ROMA i chiama Silenzio a colori, e sembra la didascalia di un suo film, ma è una mostra di dipinti su carte e tele di Michelangelo Antonioni. Anche il lessico per descriverli richiama le parole con cui generazioni di spettatori hanno cercato di evocare lo stile di quello che il grande regista ha narrato sullo schermo: plastici silenzi, appunto, ellissi narrative, storie costruite intorno al vuoto; l’eloquenza del vuoto, l’espressività straordinaria di inquadrature tanto più parlanti quanto più indirette, fino alla potenza del colore degli ultimi film (ma forse già l’intensità, l’evidenza del bianco e nero de L’avventura, La Notte, L’Eclisse, era una sorta di colore); la sua sottigliezza infine, «sincope del senso», come la definì Roland Barthes celebrando Antonioni ventisei anni fa, paragonato già allora ai pittori (Braque e Matisse) e all’estetica dell’Oriente. Ovvero il suspense di immagini e storie che coglievano le realtà interstiziali, i cosiddetti tempi morti delle avventure. Esiste qualcosa di più vero? Dal 2002, cioè dal suo novantesimo anno, nel silenzio della sua casa sul Tevere a Tor di Quinto, per nulla domato dalla malattia e dall’età, Michelangelo Antonioni passa ore e giorni a dipingere il vuoto, a disegnare altri tipi di ellissi e di curve, di pieni e di vuoti, di linee frastagliate e riccioli che sembrano ideogrammi cinesi, geometrie non euclidee e coloratissime. Ha cominciato a dipingere in campagna guardando i bambini, i nipoti. Un amico gli regalò un quaderno bianco e cominciò a fare disegni col pennarello. La moglie Enrica lo incoraggiò offrendosi di aiutarlo a mettere il colore. Trascorsero l’estate del 2002 a Roma a dipingere sul tavolo, il rumore lieve del traffico fuori simile al brusio del mare, immersi nell’arancio, nel verde, nel rosa. A stendere i colori sono subentrate come assistenti Alessandra Giacinti e Monica Dabbicco, diplomata in pittura all’Accademia di via Ripetta: «Sono solo un pennello per lui, uno strumento», dice Monica, e mi parla della concentrazione, della determinazione di colui che, pur dandogli del tu, chiama rigorosamente “Maestro”: «A differenza di me, Michelangelo non è mai stanco». Entrambe hanno raggiunto una rara empatia nel silenzio della pittura, come testimonia il film realizzato da Enrica Antonioni: Con Michelangelo. È lì che ho scoperto i suoi quadri, guardando la mano anziana che traccia linee sulla tela, le istruzioni assorte e appena percettibili che dà all’assistente per scegliere e disporre i colori in un sovrapporsi di forme che suggerisce una tridimensionalità della tela. A chi fosse stupito (il regista de L’avventura divenuto espressionista astratto?), dico che questi quadri illuminano magicamente tutto il lavoro di Antonioni. Se è vero, come scrisse Walter Benjamin, che ogni testo letterario contiene in sé tutte le future e possibili traduzioni in altre lingue, l’espressività pittorica di Antonioni rivela una coerenza anteriore a ogni categoria e a ogni facile definizione. Non ha forse detto lui stesso che «sotto l’immagine rivelata ce n’è un’altra più fedele alla realtà, e sotto quest’altra un’altra ancora, e di nuovo un’altra sotto quest’ultima?». Il celebre passaggio, del 1964, così concludeva: «Fino alla vera immagine di quella realtà, assoluta e misteriosa, che nessuno vedrà mai. O forse fino alla scomposizione di qualsiasi immagine, di qualsiasi realtà. Il cinema astratto avrebbe dunque una sua ragione di essere». È per rendermi conto della visibilità di ciò che prima era invisibile che sono andato da Michelangelo Antonioni. È quasi un genere letterario la “visita all’atelier” dell’artista, ma è con apprensione, oltre all’onore per l’invito, che mi sono trovato nella casa-studio dove vive da cinquant’anni. Faccio parte, confesso, di quella generazione il cui entusiasmo per il cinema di Wenders (almeno i primi film) era in fondo un succedaneo a quello per i film di Antonioni (ero troppo piccolo per parlarne in presa diretta). Del resto anche Wim Wenders ha Plastici silenzi, ellissi narrative, storie costruite intorno al vuoto: tra le sue pellicole e la sua pittura corre un filo di grande coerenza Già Gilles Deleuze lo aveva descritto come “uno tra i più grandi coloristi del cinema” FOTO DI ENRICA ANTONIONI BEPPE SEBASTE espresso la sua venerazione per il Maestro in un memoriale che racconta la realizzazione di Al di là delle nuvole (Il tempo con Antonioni. Cronaca di un film, edizioni Socrates). Eccomi dunque qui, di fronte alle vetrate che offrono una vista a 360 gradi, compresa la curva del Tevere e le pinete, i campi da tennis di un centro sportivo, e altre pareti coperte di libri e quadri tra cui, oltre a una delle bellissime Montagne incantate che il regista cominciò a dipingere negli anni Settanta, riconosco le sue nuove geometrie colorate. Accanto al tavolo da lavoro noto le decine di boccette di colori acrilici (polycolor), varietà di verde, giallo, lilla, rosa, tutti i colori “freddi” e opachi che Antonioni predilige. Quindi ci sediamo fianco a fianco, e guardiamo i suoi quadri già scelti per la mostra che sarà inaugurata a Roma in settembre. Prima i grandi formati, un metro per uno e mezzo, che Enrica e Monica ci mettono davanti agli occhi. Michelangelo Antonioni è impaziente quanto me di riguardarli. Il primo si chiama Cornucopia, e il fondo color oro è l’ultima cosa che ha messo. Emergono forme azzurre, verde acqua, rosa e rosse, le sue “icone”, riccioli e altre forme a volte morbide a volte appuntite che fanno pensare a segni calligra- fici, caratteri cinesi stilizzati, kangji, ma anche a una sua firma reiterata. Alla domanda se abbia influito su di lui il viaggio in Cina e il documentario che ne fece negli anni Settanta, la risposta è che l’Oriente (Cina e Giappone) lo hanno sempre affascinato e coinvolto, e di viaggi ne fece parecchi (Roland Barthes, l’autore de L’impero dei segni, non aveva torto). È in Cina che Antonioni inventariò una serie infinita di tonalità di blu. Guardiamo ora un quadro caotico e imponente, grandi righe nere verticali, e forme dai colori delicati. Poi Tanti punti, un quadro dal fondo nero da cui emergono diramazioni come cactus dense di colori rossi, gialli e verdi primaverili, una primavera frizzante come una canzone di Brian Wilson. Così come Fuoco d’artificio, esplosione di colori gioiosi, blu e verde soprattutto, su un fondo rosso-rosa. Totem, una superficie verde chiaro, una spazialità quasi desertica, e poi Festival del cinema, frutto di mesi di lavoro, dove prevale il particolareggiamento, una varietà di forme minuziose, caleidoscopio di colori e linee che si intersecano o si costeggiano in una miriade di scene di colori e forme astratte, dove ancora prevale il verde, un verde creato dal pittore. Il verde, dice Monica, è il colore preferito dal maestro, insieme al viola. Vedo nei qua- DOMENICA 27 AGOSTO 2006 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 41 I DIPINTI IN MOSTRA A SETTEMBRE La mostra dei dipinti su tela e su carta di Michelangelo Antonioni sarà inaugurata a Roma il 29 settembre prossimo, nel giorno del novantaquattresimo compleanno del grande regista, al Tempio di Adriano, e si concluderà il 22 ottobre. L’allestimento è stato curato da Renzo Piano, Massimo Alvisi, Junko Kirimoto e Enrica Antonioni, moglie di Michelangelo. La mostra è una delle iniziative legate alla “Festa del cinema di Roma”, in programma dal 13 al 21 ottobre Michelangelo Antonioni Il silenzio a colori, dai film ai quadri Si riconosce il verde-giallastro del cappotto di Monica Vitti in “Deserto rosso”, il blu e rosso delle baracche di Ravenna, DALLA MANO ALLA TELA I titoli delle tre tele di Michelangelo Antonioni, dall’alto: “Totem”, “Cornucopia”, “Festival del cinema”, foto di Luca Pron Le foto del Maestro che dipinge sono di Enrica Antonioni dri il verde giallastro del cappotto di Monica Vitti in Deserto rosso, il blu e il rosso delle baracche del porto di Ravenna, i colori delle camicie di Jack Nicholson in Professione: reporter, e così via. E penso a una frase altrettanto ellittica di Antonioni all’epoca del suo primo film a colori: «Se c’è ancora dell’autobiografia, è nel colore che essa deve essere trovata». Guardo col Maestro una grande tela verticale dove domina l’ocra. Guardo le carte, le tempere, una bellissima dal titolo African rug. Tutti i suoi quadri inducono un andirivieni continuo dell’occhio dello spettatore, tutti evocano una tridimensionalità raggiunta dall’accostamento delle forme e dei colori, che lungi dall’apparire grafici acquistano rilievo. A proposito di alcuni dipinti che all’inizio la sconcertano, Mo- FOTO DI LUCA PRON Repubblica Nazionale 41 27/08/2006 le tinte delle camicie di Nicholson in “Professione: reporter” nica mi dice che «il Maestro arriva sempre a un equilibrio, è capace alla fine di armonizzare tutto», anche i segni apparentemente più incongrui. E guardo il Maestro osservare i propri quadri, seguirne con le dita le superfici, accarezzarli senza toccarli, guardarli con le mani, infine controllarne la firma (idea, ancora, che le sue “icone” ricorrenti siano altrettante firme). È spettatore divertito e intrigato delle sue stesse creazioni, come se non ne fosse l’autore. Guarda se stesso come un altro. Finché li licenzia con un gesto, non senza avere pronunciato un commento: «Bello», «molto bello», oppure un ironico «mamma mia!», come a dire: che follia avere fatto questo quadro. Il distacco dai suoi quadri, mi dice Enrica, ripete l’atteggiamento che aveva nei confronti dei suoi film, e va connesso col detto pascaliano che amava ripetere citando il pittore Giorgio Morandi (che Antonioni frequentò e amava molto): «Il vero artista è colui che sa stare da solo in una stanza». Ma nel suo atteggiamento, come nei suoi dipinti, c’è anche una componente di gioco e di audacia che forse solo la senilità — infanzia riconquistata — può dispiegare con tanta anarchica leggerezza: le sue opere sono una festa della libertà. La loro tridimensionalità trova conferma in altri suoi lavori, sculture e collages, fatti di cartoncino con dentro polistirolo oppure legno. Intagli di diversi colori, incastrati e incollati creando scenografie complesse, spesso impossibili (come si diceva delle ipotesi spaziali e volumetriche dell’architetto Frank Gehry), prolungano il piacere tattile della sua ricerca. Monica, l’assistente di Antonioni, sottolinea di nuovo la capacità del Maestro di trovare sempre una ricomposizione a ciò che si presenta all’inizio come una frammentazione irredimibile, di giungere ogni volta a una soluzione armoniosa dell’informe, anche a dispetto della sua incredulità. La mostra di Michelangelo Antonioni sarà accompagnata, tra l’altro, dal testo di un patologo americano e studioso di cinema, David Kaminsky. Alludendo all’aspetto terapeutico di questo “silenzio a colori”, parla di «una dimensione comunitaria di colori che sembra violare l’austerità e la solitudine dello stile dei suoi film». Può darsi. Ma a me viene in mente che il filosofo Gilles Deleuze, nel suo primo libro sul cinema (L’immagine-movimento), scriveva già di Antonioni come di «uno tra i più grandi coloristi del cinema». Ne tratta nel capitolo dedicato al “volto”, cioè al primo piano, “immagine-affezione” che conferisce qualità di volto a ogni inquadratura, cioè intensità, capacità di rilanciare l’affettività e la potenza dell’immagine con un effetto più ampio e duraturo di ogni causa e di ogni logica rappresentativa. Questa qualità di volto, o primo piano, sarebbe data proprio dal colore. Deleuze notava quindi «l’uso di colori freddi spinti a massimo della loro pienezza o della loro intensificazione, per oltrepassare la funzione assorbente», in cui «il colore porta lo spazio fino al vuoto, cancella quanto ha assorbito», fino ad arrivare (scopo del cinema di Antonioni secondo Deleuze) «al non-figurativo», «un’avventura il cui termine è l’eclisse del volto, la cancellazione dei personaggi». È la vocazione al deserto di Antonioni (Deserto rosso, Zabriskie Point, Professione: reporter, ma anche il parco e il campo da tennis di Blow up). L’amore di Antonioni per i quadri di Mark Rothko, attestato da un loro carteggio, conferma questa estetica, dove il silenzio delle storie e delle relazioni umane, quella “incomunicabilità” fin troppo insistita dai critici, è viatico e tensione verso lo spazio puro, e da esso al vuoto. Penso tutto questo riguardando i quadri del Maestro nel silenzio dell’attico che si affaccia sul vuoto, e sulle pinete lungo il Tevere, e sui campi da tennis rossi che macchiano quel verde. Che cosa è il colore? Ricordo un dialogo centrale di Deserto rosso. Lei: «Che cosa vogliono che faccia coi miei occhi? Cosa devo guardare?» Lui: «Lei dice: “cosa devo guardare”. Io dico: come devo vivere? È la stessa cosa». Ha detto Michelangelo Antonioni all’epoca di quel film: «Non esiste il colore in assoluto. È sempre un rapporto. Un rapporto tra l’oggetto e l’osservatore (addirittura lo stato fisico dell’osservatore), tra l’oggetto e la direzione dei raggi che l’illuminano, tra la materia di cui è formato l’oggetto e lo stato psicologico dell’osservatore, nel senso che entrambi si suggestionano a vicenda. L’oggetto cioè con il suo colore ha una determinata suggestione sull’osservatore, e questi contemporaneamente vede il colore che in quel momento ha interesse o piacere a vedere in quell’oggetto». E ancora: «È con l’abitudine che si impara a guardare i colori. È dopo una certa esperienza che riusciamo a distinguere quanto c’è di grigio in un giallo o quanto c’è di blu in un grigio. E questi sono fattori dai quali non si può prescindere nel cinema a colori perché la pellicola riproduce molto più fedelmente di quanto l’occhio umano non sia in grado di vedere e riprodurre quel colore in un determinato oggetto. […] Ma nel cinema tutto ciò che nella vita comune è inconscio deve diventare consapevole. E lo diventa appunto con l’abitudine, l’abitudine a guardare i colori così come sono, a guardare la realtà così com’è. Colorata». Il cinema di Michelangelo Antonioni continua nel silenzio a colori delle carte e delle tele. 42 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 27 AGOSTO 2006 la lettura Animali-simbolo Angelicato e demonizzato, leccornia e alimento-tabù Ora questa bestia controversa sarà protagonista al Festivaletteratura di Mantova grazie a un libro di Stefano Scansani, arricchito dall’opera teatrale in gramelot di Dario Fo che qui anticipiamo Il maiale, istruzioni per l’uso MICHELE SERRA er misteriosissime ragioni (il caso? remote epidemie? ossessioni private di individui influenti poi divenute tabù sociali?) il maiale è, tra tutte le bestie, quella più controversa nel giudizio degli uomini. Oggetto del più radicato e diffuso veto religioso-alimentare presso alcuni, divorato con devozione e passione presso altre culture che lo hanno posto su un vero e proprio altare gastronomico. In ogni caso, l’animale sacro per eccellenza: demonizzato oppure angelicato, impuro o viceversa così puro da poter essere consumato dalle orecchie al codino, comprese le trippe e i grassi garretti, comunque levato dalla mediocrità per assurgere a un ruolo di notevole eccellenza simbolica. Repubblica Nazionale 42 27/08/2006 P Porcelli con le ali in paradiso e ritorno DARIO FO GIULLARE Dario Fo dietro una tavola con le zampe di maiale Lo sguardo umano, le orecchie che paiono una pettinatura estrosa, il grugno vibratile, il codino riccio: tutto in lui, per sua sventura, è simpatico e affabile, irresistibile già da vivo In alcuni luoghi della Terra, per esempio la Pianura Padana, questa bestia cilindrica, in forma di boiler semovente, è in pratica deificata. Le si dedicano mostre piuttosto colte (memorabile quella di una ventina d’anni fa a Reggio Emilia, che è un po’ la città santa dei suini), scienza zootecnica e culinaria raffinatissima, culto iconografico diffuso (molti i collezionisti di maialini di ceramica, panno, legno e altri materiali). In Spagna li si nutre di sole castagne per ricavarne prosciutti famosissimi, contadini di ovunque allevano il loro personal-maiale nutrendolo da pascià prima della sinistra cerimonia della mattanza, e l’allevamento intensivo è così intensivo da interessare il bacino del Po, fino al delta e al mare, di un allarmante inquinamento da cacca e pipì di porco, oggi un po’ più sotto controllo ma fino a pochi anni fa da allarme rosso. Questo testo di Dario Fo, intitolato “La presunzione del maiale”, è tratto dal libro “Fenomenologia del maiale”, in uscita a settembre L’attore e premio Nobel lo recitò a Castell’Arquato nel 2004 per il programma di Raidue “Teatro in Italia”. I disegni, sempre di Fo, sono tratti dalla “Bibbia dei villani” Q uando ol Segnòr Padreterno Iddio u l’ha creato ol porco, u l’ha dit: «Bon, sperémo de no’ avér combinàt ‘na purselàda». El porco l’era felìz, beato de la so’ condisiùn. Lü, porsèl, maiàl, puórco, quàrche volta ciamà anca vèrro... l’era satisfà, alègro d’avérghe cossì tanti nomi. Ol stava tüto ol ziórno, inséma a la sóa fémena, a roversàrse, a sgorgonciàr inta la buàgna, nello smerdàsso, nello scòrco, nello scagàsso che ol faséva: ol se sprignàva, ol criàva, ol ciapàva dei srobodón, ol cantava e ol rideva. Faséva dei sgrogognà, no’ soltanto ne’ lo sòo de smerdàsso, ma anca in quèlo de tüti j artri anemàli, perché ol diséva: «Pü spüssa, pü qualetà!». I fasévan l’amor a sbàtisbàte che l’era un obséno scàndelo! I criàva de plazér che pareva se scanàsse! I sbròffi e i schìsi degli smerdàssi ‘rivàva fin al ziél, co’ tüti i rumori e le spüsse, ‘me stciòpo de sboàsso, che un ziórno el Padreterno, fa per vegnìr fora de ‘na nìvola... puhaa... ghe ‘riva ‘na sbruffàda che par poco no’ el lava tüto! «Ohi!, se l’è? Ehi, porsélo! Ma te sèit proprio un puórco! Ma no’ te vergogni andàrte a srotolàrte in ‘sta manéra a sgrofón, a sbati-sbate, a far l’amor! Fra ti e la tua fémena, sit proprio la zozza sporselénta del creàt!». «Ma Segnòr Padreterno... — sgrógna mortefecàt ol maiàl — te sèit stàito pròpi ti che me gh’ha creàt con ‘sto sfìsio gaudurióso de sguasàr in la fanga de scagàsso. Noàltri no’ ghe se pensava mìga!». «D’acòrdo, ma ti ol te sèit esageràt! Te ghe va dentro sànsa creànsa e co’ gran solàzzo in ‘sta boàgna e a farghe l’amor. Ma dico, te set già inta la merda... state bon! No! Ti te va a cantàr l’Excèlsis Gloria a Deo! Va ben... ad ogne manera, se te va ben e sèit cuntènto de ‘sta condesión, staghe pure tranquìlo!». «No, en veretà Segnor, no’ per sopèrbia... no’ vorrìa che te se offende... ma mi no’ so’ tanto sotisfàtto de la mia condesión». «Cossa te voi? Che te torga via la spüssa a la merda?». «No! Sarìa come cavàrghe l’ànema a un cristiàn!». «E allora, cosa te voi?». «Vorarìa le ali!». «Le ali?!». «Sì... pe’ volare!». «Ahahaaa!... Ma sèit proprio mato! Ma te pensi... ti che te vai volando?! Un porsèlo volante che va spantegàndo tanfo e smerdasso par tüto ol creato! Co’ gli anemàli de sóto che i crìa: oh cos’è ‘sto desàstro!». «No, nol sarìa spantegàr boàgna, ma ol sarésse conzéme maravegiòso per ogne lògo... despàrgere sanetà e ‘bondànzia per fiori, frutti e frumenti!». «Ohé, tu gh’ha un bel zervélo! Porsélo questo de lo smerdàzzo che va a conçemàre nol gh’avéa miga pensào! Bravo! Te me gh’hai convenzùo. Te fàgo le ali». «Grazie Deo!». «Ma soltanto a ti, al verro... la fémena niente! A pìe!». La fémena se mette a piàgnere desperàda: «Ecco, ol savéo... sempre de contro a noàltre fémene! Me l’avéan dit che ti, Deo, ti era un po’ mesògeno!». Tàse fémèna e sta in la tòa boàgna! Basta! Pitòsto ti verro, se te voi proprio portàrte la tòa fémena per el ziélo, te lo poi fare: te la embràsi tütta ben bene e ten vai volando». «No, non pòdo Segnor. È emposìble, perché mi gh’ho le brassa cürte... sémo slarghi... sémo co’ de le panze che no’ finìsse. Come che se stregnémo ambrassàdi, co’ tutto lo smerdàsso che gh’émo adòso, entànto che volémo, la méa scrofa scarlìga dei man e me slìsega de föra... puhaam... la presìpeta... se schìscia par le tere e me resto senza fémena!». «Ehee, ma mi so’ miga vegnü Deo per racomandasión! Ti te pensi che mi te pòdo farte le ali se no’ gh’ho già avüt il pensiér, ante, de la solusiùn?». «Che solusiùn?». «Faghe mente! Mi t’ho fàito apòsta un pindorlón tüto sbìrolo come un cavabusción... ti t’ambràssi la tua fémena e te lo ghe sfrìssi profùndo, te la strìsi de fròca de amòr e te poi andàr volando anca senza man! Nol te la devi tegnìre!». «Grazie Deo! Nol gh’avéo pensàito!». «Bon, adeso pónete en genógio che fago ‘sto meracolo meravegiòso!». El Segnòr volse i ögi al ziél, fa un segn co’ la mano santa e... sfrum, sfram... su la stcéna del verro ghe spónta le ali meravegiòse, d’argento! La fémena lo ambràssa e dìse: «Ohi, l’è nasùo l’ànzelo dei porsèli!». Ol Deo dìse: «Férmete, no’ te andar de prèscia. Ol gh’è ‘na condesiòn: stàit aténto, le ali so’ legàt co’ la ciéra!». «Co’ la ciéra? — fa il porco — Come quèle de Icaro?». «Sì, te gh’hai endovenàt. Ma cosa te ne sai ti dell’Icaro?». «No’ te se desméntegare che noàltri porséli sémo dentro tüte le fàvule de Fedro!». «Ohi!, a gh’émo un porsèlo classico! Chi l’avarìa mai ditto?! Alóra, tel cognóse ben quèl che gh’è capetàt a l’Icaro, che volando verso el sole ghe se son sparghegnà tüte le ale e l’è sprofondàt par tèra e ol s’è tüto stcepàt! Quèlo el pò succéder anca a ti. DOMENICA 27 AGOSTO 2006 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 43 IL LIBRO Il libro da cui è tratto questo testo è “Fenomenologia del maiale” (Tre Lune Edizioni, 220 pagine, 30 euro) di Stefano Scansani, giornalista e antropologo culinario È un’esplorazione dell’universo del maiale in ogni sua dimensione: fisica, chimica, religiosa, sociale, magica, economica, psicanalitica. Il volume, corredato da un ricco apparato iconografico, sarà presentato al Festivaletteratura di Mantova il 7 settembre da Scansani e dallo stesso Fo alle 21,30 in Piazza Castello Repubblica Nazionale 43 27/08/2006 Probabile che questa tradizione contribuisca al disgusto che alcuni popoli semiti hanno per noi mangiatori di maiale, ulteriore prova a carico della nostra impurità. Per altro, il clima temperato o meglio ancora freddo pare stemperare parecchio, fino a cancellarli del tutto, i tabù alimentari, quasi tutti nati nel deserto e nei climi caldi, quando solo il preziosissimo sale, o l’ancor più prezioso miele, servivano a conservare gli alimenti. La scoperta del frigorifero e del sotto-vuoto è evidentemente ancora troppo recente, rispetto ai ritmi solenni della storia umana, per disinnescare gli antichi anatemi contro il porco e altre mirabilia proteiche. Nell’attesa che, entro qualche millennio, gli uomini trovino ragioni meno arcaiche per scannarsi, noi di quassù possiamo continuare a godere del porco sotto una quantità di forme qua- Aténto, alóra!». «Sì, d’accordo!». E ol vola via ol Deo. Ol porsélo e la sòa fémena i resta lì un momento; ol porsélo prova a volare, fa un ziro, zira de novo: «L’è un plazér!». «Ferma, aspècia, ambràssame, spìrcame!» vusa la scròfa. Proock... Svrip, svop, svuom... fra le nìvole i vola. La fémena crìa: «Che maravégia! Me par de esser in del Paradiso!». «Paradiso? Ol tu gh’hàit rezòn! Andremo in Paradiso, mi e ti!». «Ma no, non se pol. No’ deméntegarte coss l’ha dit ol Deo Patreterno... che gh’è el sole... «. «Ma no’ gh’è besogna d’andàrghe col sole! Speciémo che ghe sia el tramonto, andarém con lo scuro, quando che gh’è note!». «Ti ha un zervèlo davéra! Ma come fasémo a ciapàr ‘na rencórsa tanto da rampegàrse, tüti embrassàdi, lassù?». «Basta far ‘na zivolàda!». «Come, ‘na zivolàda?». «Prima se spargémo bélo ungi de grassa e de smerdàsso. Andémo, ecco, qua, végne, végne, végne, andémo sulla salìda longa che gh’è in su ‘sta montagna, slassighémo giò per le valli, vai, vai, vai... Strìgneme! Vai, aténta che slargo le ali!... puhaa!... ieheee!». I monta, i monta, i monta, cala una maravegiòsa ùffia de vento che va e che tira e arriva in fondo, i salta la luna e arriva in Paradiso. Come i sont in Paradiso, oh Deo, Deo, maravegióso! A gh’è la fémena che quasi desvégne, a gh’è dei frùcti!, a gh’è delle pérseghe!, delle ciréise!, grande, grande... Oheu che grande! I par che i se pol stàrghe dentro in dói, imbrassài a sgorgognàr in de la polpa: «Varda quèlo, pare ‘na cupola de catedràle, che meravégia!, andémo dentro!». Puhaa! I va dentro, se sròtola, se sprégna, i fa l’amore, i crìa. Entanto, en quel momento, appresso, o gh’è tüti i santi del Paradiso e i ànzeli che canta le glorie del Signore. «Oheu che spüssa!... che tanfo tremendo!». «Ma chi stona?! — ariva ol Padreterno — Che spüssa tremenda! Chi è che l’ha scurrezzà?». E tütti se volta a sguardàrse entórno, e allora il Padreterno el dise: «Ohi, so ben mi da dove vegne ‘sta spüssa sgragagnàda! Jè el tanfo de ‘sto maiale porsélo che l’è vegnüd chi lò in Paradis e che s’è si incredibile. Un glossario improvvisato (prosciutto, salame, mortadella, coppa d’inverno e coppa d’estate, culatello, braciole, cotolette, arrosti, nervetti, strutto, cotechino, zampone, zampetto, testina, lardo, fegato, orecchie…) schiude un universo sterminato di alimenti e dunque di tradizioni, cotture, conservazioni, metodi di tritatura e insaccatura, stagionature, tagli (il salame sempre e solo al coltello, gli altri insaccati anche con l’affettatrice). Il pane, nella sua santa umiltà, rimane il compagno ideale del porco, che pure viene ottimamente usato anche in connubio con legumi, verdure e minestre di ogni genere, in agrodolce (la braciola con le banane è un portento…), secco, in umido, alle braci, freddo, bollente. Neanche la prodigiosa vacca può vantare un ventaglio di usi così vario e fantasioso. Si deve aggiungere che l’animale, allo sguardo umano, si presenta irresistibile già da vivo. Dalle orecchie che paiono una pettinatura estrosa al codino riccio, dal grugno vibratile al doppio unghiolo che affonda nel fango, tutto nel maiale è, per sua sventura, simpatico e affabile, anche se il suo carattere forte, tipico delle persone intelligenti, spesso dissuade dagli eccessi di confidenza. Pare che il morso del maiale sia tra i più dolorosi e ferini. Il solo dettaglio che potrebbe giustificare la fama di bestia immonda è — quello sì — il fallo dall’inverosimile forma a cavaturaccioli, che se non vado errato è il solo pezzo del maiale che non abbia dato vita a pietanze rinomate. Probabile che finisca anche lui negli impasti per insaccati. E dunque, in fondo alla catena alimentare, nel fondo della nostra anima, che è pur sempre un pochino a cavaturaccioli anche lei. Impura anche lei. infricà de següro deréntro la polpa dei frùcti! Alàrme, alàrme! Santi e beàti, catéme el porsélo e la sòa fémena! Chi de voi altri santi riussirà a catàrli, ghe fàgo un cerción d’aurèola come ‘na cupola! Via!». I ànzeli sòna le trombe: «Tàtàtàtàtàtààà!». Tüti i córe, i vanno! Par de essere a la caccia al cervo! E sübeto a gh’è la fémena che sente el criàre: «Andémo, scapémo, lanzémose giò per la terra!». Se ambràssono, co’ le ali strengiüde, i bórla a picco: «Uuuahaaa!». «Slàrga le ali adéso... sémo dopo la luna!». Puuhuaa!, se spalanca le ali... quarche pluma vola via... ma le tegne, le tegne, le tegne! «Sémo salvi, ol sole non l’è ancora spuntào! Non è ancora spuntàooo!». Praamm! El sole no’ a l’è ancora spuntao ma spunta el Segnor Padreterno de una nìvola: «Ahaahaa, porsélo! Che te credevi ti? Sole! Spunta!». «No, non vale Padre! Non è ne le regole, l’è contro la natura... l’equilibrio del creato!». «Son mi l’equilibrio del creato! Mi fago le regole, e fago spuntare el sole come e quando me pare!». Wuuoomm! El sole végne fora: «Brüsaghe le ale!» ordina el Deo. Bruuhaa... arriva ‘na sfèrzula sovra le ali, brüsa... böje... còte! Va via le plume, le penne va via. El porsélo resta sanza nagòta, pelà come un polàstro... presipeta: «Uuhaaaa! Se schiscémooo!». Meravégia de tutte le meravégie, i va a spaloccàrse deréntro ‘na gran possa de buàgna, fanga e smerdasso... Pruuahaaa! Pruumm! Tüti li sprüzzi de lo smèrdo so’ sparà in alto, nel ziélo. Ol Padreterno che se spórge a controlà el porsèlo ch’ol bórla giò, de bòto se scansa... che per puòco no’ s’è sgorgognàa! E pruuhaamm! Prooff... puhaa... sciaffrrr... vuuaa... ploploplo... plo... glo... gloglogloff! Ol porsélo sorte dal mastelón: glogloglo... A gh’ha tüto ol naso schisciàdo coi do’ bögi, che ghe resta per l’eterno, schiscià per puniziùn de quel volo... proprio come adéso. Piàgne, piàgne el porsélo: «Deo!, che pünisiun tereménda che te m’gh’hait dàito! Le mie ale maravegiòse! Vèrra mèa... no’ anderò gimài plu in Paradisooo!». La fémena ol càta e ol tira derentro nello smerdàsso: «Vegne, bel porcón! Vegne co’ mi embrassàto e conténtess, che ognùn gh’ha ‘l suo Paradiso!». 44 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 27 AGOSTO 2006 L’8 settembre 1966 cominciava sulla Nbc un viaggio da record nel campo della science-fiction: settecento episodi tv, dieci film, otto romanzi, milioni di fan, ma soprattutto più mondi, più alieni, più tecnologia di ogni altra saga. La ricetta di questa spettacolare longevità? Tolleranza, ottimismo, fiducia nell’uomo Repubblica Nazionale 44 27/08/2006 Da qua rant ’ a nni A nell ’ipe rspa zio PINO CORRIAS ndiamo. Luce bianca dell’Enterprise che frigge sui bordi neri della Galassia. Tenente Hikaru Sulu alla consolle: «Motori pronti per la curvatura. Chiedo il permesso di partire, signore». Comandante James Tiberius Kirk: «Permesso accordato. Andiamo». Andiamo, d’accordo. Da quaranta anni (decodifica in tempo terrestre) la chiave di Star Trek è già tutta qui. In quell’andiamo da viaggio perpetuo. In quel lontanissimo West da cavalcare senza invadere. Da esplorare senza distruggere. Da conoscere senza conquistare. Perché è sempre proibito (per il bene comune, il bene planetario) interferire con gli altri mondi, le altre forme di vita, le altre civiltà cresciute nel ghiaccio, sotto a cinque lune o dentro a una bolla di idrogeno o governati da un finto dio misogino. Altro che guerre preventive. Andiamo: c’è una traiettoria da seguire. Una destinazione da raggiungere. Altri mondi da visitare, dopo quelli dei Klingon e dei Romulani. Perché lo spazio non è freddo e non è vuoto. Ma ha uno scopo che viaggia lungo ogni frontiera valicata: la vita. In movimento perpetuo. Come la luce che si espande tra le stelle. Come le avventure che si intrecciano su ogni quadrante galattico lungo le rotte elaborate dal dottor Spock, il vulcaniano che non prova mai emozioni. Come tutti i sentimenti pressurizzati nei cuori degli equipaggi che nella sala comando della Nave decidono infine di abbassare gli schermi protettivi Faser e trasformare il nero dello Spazio nell’iperbianco che corre alla velocità della luce. Andiamo. In questi quaranta anni Star Trek ha macinato molti più anni luce di Guerre stellari. Molta più cibernetica di Isaac Asimov. Molti più universi paralleli di Philip K. Dick. Nei suoi settecento episodi televisivi, dieci film, otto romanzi, ha generato più mondi, più imperi stellari, più facce aliene, più costumi, più armi, più medicine, più androidi, più tecnologie di qualunque altra saga della fantascienza. Ha pensato in anticipo i computer palmari, i telefoni satellitari, i minidischi. Ha reso plausibile la magia del teletrasporto lungo i cunicoli dello spazio tempo. Le guarigioni istantanee nell’infermeria del medico di bordo Leonard McCoy. E naturalmente il magnifico replicatore inox, capace di sintetizzare qualunque alimento dalle molecole dei rifiuti, al quale il comandante Jean-Luc Picard, nella serie più bella, la seconda di sei, Next Generation, chiede: «Tè Earl Gray caldo, per favore». Pure la storia dell’ideatore di Star Trek avrebbe diritto a un film o alme- no a un episodio specchiante. Si chiamava Gene Roddenberry. Nato nel 1921. Texano di El Paso. Duro. Pilota di caccia nella Seconda guerra mondiale. Poi sulle rotte civili Pan Am. Poi detective a Los Angeles. Poi all’improvviso morbidissimo scrittore di science-fiction, ma senza pistola a raggi gamma per liquidare gli alieni. Pacifista in piena Guerra Fredda. Perciò primo episodio addirittura rifiutato dalla Paramount per assenza di sangue, sparatorie, inseguimenti, eccetera. «Troppo cerebrale», dirà la stroncatura: tanto sballata da passare alla storia, anno 1964. Il che voleva dire riscrivere con un po’ più di muscoli americani in azione. Cosa che Roddenberry fece senza forzare mai troppo, lasciando quel sovrappiù di introspezione ai suoi personaggi, che sempre sorvolano non solo le differenti atmosfere analizzate dai sensori dell’Enterprise, ma anche i misteri del bene e del male, gli equilibri fragili della coesistenza, la chimica che lega il potere alla violenza, l’odio all’amore. «Forse un giorno scopriremo che il tempo e lo spazio sono più semplici dell’equazione umana», dice in un finale d’avventura il comandante Picard. Memorabile. Via libera alla serie due anni più tardi, esordio sulla rete Nbc, prima serata dell’8 settembre 1966. Equipaggio con tute in maglia elasticizzata, niente effetti speciali a parte la nebbiolina del “raggio traente”, le porte elettriche degli alloggiamenti, e le orecchie a punta del dottor Spock. Ma specialmente equipaggio interrazziale: un russo in plancia, un giapponese al timone. E perfino una donna nera con funzioni di comando, il tenente Uhura, che giusto in un episodio del turbolento 1968 avrebbe baciato il comandante Kirk, bianco caucasico, americano, come mai sarebbe potuto accadere sul Pianeta Terra, meno che mai in televisione, con telefonata di congratulazioni dell’autentico Martin Luther King alla autentica attrice Nichelle Nichols. Da lì in avanti, ingranaggi in moto e decollo stabile della serie. Apoteosi di Roddenberry che nella vita vera macina due mogli, quattro figli, molti soldi, un po’ di libertà creativa. Vara i 178 episodi di Next Generation che gli assomigliano di più. Scrive: «Mi accorsi che creando un mondo a parte, un mondo nuovo, con nuove regole, si poteva parlare con più facilità di sesso, religione, Vietnam, missili intercontinentali». Si gode un po’ del successo planetario che gli sareb- be assai sopravvissuto. Lui muore nell’anno 1991: incenerito per sua volontà e congedato dal pianeta dentro a una capsula spedita in orbita perpetua. Andiamo. La serie televisiva è cresciuta come fanno le immense stazioni orbitanti nello Spazio, un pezzo alla volta, una ramificazione alla volta, ma poggiandosi tutte su un solo bullone indeformabile: il principio universale della Prima direttiva, parente stretta della Tolleranza. La Prima direttiva governa la Galassia dall’inizio del ventitreesimo secolo. I fuochi delle antiche guerre si sono spenti. I pianeti convivono dentro alla Federazione dei pianeti. La Federazione governa la Flotta stellare. La Flotta stellare ha una missione da compiere, l’esplorazione dell’universo. L’Enterprise è la nave più potente, quella che forza tutte le colonne d’Ercole, tutte le barriere di energia, verso lo «spazio, ultima frontiera», al di là di quel diciassette per cento di universo cartografato, «where no man has gone before», dove nessun uomo si è mai spinto prima. La Prima direttiva proibisce alla flotta di interferire con la vita dei singoli pianeti, le loro civiltà progredite o remote. Le guerre in corso o i disastri imminenti. Non più piegare il flusso degli eventi, né correggerli. Ma naturalmente la storia infinita di Star Trek e del suo equipaggio, quello che muove le sue avventure astrali e che riempie le pagine del diario di bordo, sono la trasgressione a quella prima legge. Le sue violazioni, talvolta piccole ma cariche di conseguenze. Talvolta inevitabili. Perché ci sono sempre altri imperi e altri mondi in conflitto. Ci sono civiltà in espansione, ognuna con le proprie ragioni, desideri, ossessioni. I Ferenti per conquistare ricchezze. I Klingon per difendere l’onore. I Cardassiani per il potere. E i Borg per programmata distruzione altrui. I Borg sono metà umani e metà macchine cibernetiche. La metà cibernetica rende inderogabilmente cieca la loro volontà. Ma è la metà umana che alimenta la loro crudeltà totalitaria: distruggere per nutrirsi. Nutrirsi «perché vogliamo miglio- rarci». I Borg operano per mutilazione, trasformando gli altri corpi in aggregati di carne e circuiti elettronici. Sono i nemici puri, gli invasori perpetui. Vengono dal nulla. Sono inarrestabili. Possiedono tecnologie superiori. Non si preoccupano delle loro perdite. Sono la vera minaccia alla sopravvivenza di tutte le specie. Il Buco nero. Il Male da combattere e da sconfiggere. Andiamo. Stavolta neppure forzando la Prima direttiva: legittima difesa. Né tradendo troppo il pacifismo di Roddenberry. Meno che mai riuscendo a scalfire davvero il cielo rassicurante di Star Trek. Che è poi la ragione più profonda della sua longevità spettacolare. Quel futuro dell’avventura umana pensato sempre al meglio e non al peggio. Dove nessun cielo post-nucleare ha sbiancato i volti dei suoi personaggi. Dove non c’è la fame e la miseria radioattiva che ha trasformato la Terra di Dune, nel nuovo medioevo raccontato da Frank Herbert. E neppure la solitudine senza scampo, l’infinito Nulla dentro a cui fluttua l’astronave di Stanley Kurbick, al largo di Giove. L’umanità di Star Trek è rimasta umana. Si è liberata (o quasi) della sua volontà di potenza. E di tutti gli dei vendicativi che nei venti secoli intermedi hanno trasformato in sangue e in guerra la propria verità monoteista. «Non abbiamo più quel tipo di fede da centinaia di anni», dice in un episodio il comandante Picard. Che poi sarebbe il sogno anche nostro, la nostra desiderabile Prima direttiva. La nostra desiderabile ultima frontiera. Prima che le molte catastrofi terrestri perfezionino l’assedio quotidiano in una qualche collisione finale: fare atterrare l’Enterprise una buona volta. Scambiarci i comandanti in capo. E poi spegnere la tv. Nel turbolento ’68 il tenente Uhura, ragazza nera, baciò sugli schermi il comandante Kirk, bianco caucasico Martin Luther King si congratulò DOMENICA 27 AGOSTO 2006 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 45 Tutti gli equipaggi, i capitani, le astronavi succedutisi nei decenni Storia di un successo megagalattico ERNESTO ASSANTE S tar Trek, non è una serie televisiva, ma molte serie differenti. La prima, quella leggendaria, con il capitano James T. Kirk al comando dell’Enterprise, è andata in onda (80 episodi, tre stagioni) dal 1966 al 1969. La seconda vede ancora Kirk come protagonista, ma è una serie a cartoni animati, andati in onda per due stagioni dal 1973 al 1974. I viaggi spaziali riprendono ufficialmente nel 1987, con il capitano Jacques Picard al comando della serie Next Generation, la più duratura (178 episodi, otto stagioni, in onda fino al 1994), seguiti dalle avventure “statiche” di Deep Space Nine, ambientate in una stazione orbitante capitanata da Benjamin Sisko, il primo nero al comando. Deep Space Nine è andata in onda fino al 1999 (con 176 episodi), ma nel 1995 a sostituire Picard e il suo equipaggio arriva Voyager, una nuova serie con novità radicali: l’Enterprise viene mandata in pensione, la nuova nave si chiama Voyager e il suo capitano è una donna, Kathryn Janeway. Dopo 172 episodi i viaggi terminano e la serie fa un balzo indietro nel tempo, proponendo nel 2001 Enterprise, ambientata in un futuro molto prossimo, con la nave guidata dal capitano Archer prima dell’arrivo del capitano Kirk, un “prequel” insomma delle avventure classiche della nave spaziale. Enterprise è arrivata fino al 2005 ed è l’unica serie ad essere stata interrotta prima della sua fine naturale, lasciando i fan, per la prima volta da 25 anni, privi di nuove avventure. Ma i fan non si sono dati per vinti e, visto che nessuno 16 le produzioni: 6 serie tv (una animata) e 10 film 700 gli episodi complessivi delle serie televisive produceva nuovi episodi, hanno optato per il “fai da te”. Il New York Times qualche settimana fa dava notizia di almeno due dozzine di progetti in lavorazione in varie parti del mondo, dal Belgio dal quale partono le avventure della nave spaziale Intrepid (www. ussintrepid. org. uk) agli organizzatissimi losangelini che hanno già realizzato 40 episodi di Hidden Frontier(www. hiddenfrontier. com); ai fan di Austin, Texas, che hanno realizzato le avventure della nave Exterer (www. starshipexeter. com); a quelli che hanno prodotto le avventure della “starship” Farragut (www. starshipfarragut. com); ai fan autori di New Voyages (www. newvoyages. com). I fan di Star Trek sono legioni, e sono organizzati in moltissime associazioni sparse su tutti e cinque i continenti del pianeta Terra. Ogni anno si svolgono decine di convention che raccolgono gli appassionati, molti dei quali partecipano vestendo i costumi delle diverse serie televisive. Uno dei prossimi appuntamenti è previsto il 21 e il 22 ottobre all’hotel Le Conchiglie di Riccione, organizzato dallo Stic, Star Trek Italian Club. Il 5, 6 e 7 ottobre a New York, inoltre, una delle più celebri case d’aste del mondo, Christie’s, celebrerà i 40 anni di Star Trek con una straordinaria vendita di oggetti legati alla serie televisiva ed ai film: costumi, arredi, armi, modelli di astronavi usati nei diversi episodi, accessori e molto altro ancora. 70 i romanzi ispirati alla saga e divisi in otto serie 181 i popoli o specie aliene dell’universo Star Trek 5 mila le voci contenute nell’enciclopedia ufficiale 18 mila gli articoli su “Memory Alpha”, la Wikipedia dei fan 46 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 27 AGOSTO 2006 i sapori Agrumi di successo Lo usiamo come medicina, come serbatoio di vitamine, come base per liquori e cocktail, per dare freschezza ai cibi o per cuocerli senza calore, per fare dolci, granite e sorbetti Difficile trovare qualcosa di altrettanto prezioso e versatile, ma attenti alla qualità... Sfusato d’Amalfi Igp Caratterizzato dalla forma affusolata, ha dimensioni importanti, buccia ruvida, profumo intenso, gusto gradevole, pochissimi semi. Tra i più ricchi in vitamina C, viene coltivato in tutta la Costiera amalfitana, dove matura tra marzo e ottobre Interdonato Deve il nome al colonnello garibaldino Giovanni Interdonato, appassionato agrumicoltore Nato da un incrocio tra cedro e “ariddaru”, è delicato e di buccia finissima. Coltivato sulla costiera ionica messinese, è protetto dal presidio Slow Food Factotum della frutta Limoni Repubblica Nazionale 46 27/08/2006 LICIA GRANELLO U Ovale di Sorrento Igp Grosso, succulento, di buccia spessa, è diffuso in tutta la Penisola sorrentina, Capri compresa. Malgrado sia presente tutto l’anno sul mercato, il migliore è quello estivo, la cui maturazione viene protetta e ritardata grazie alla tradizionale copertura fatta con stuoie e pagliarelle Limetta Conosciuto in Italia grazie alla cucina caraibica e ai cocktail cui fornisce la base, il lime è un agrume molto simile al limone, piccolo, rotondo, fine. Suddiviso in più varietà, dal dolce all’agro, viene abitualmente raccolto verde per catturarne tutti i profumi primari n tesoro di limone. Alzi la mano chi conosce un altro frutto capace di guarire le malattie (scorbuto) e schiarire i capelli, trasformarsi in liquore e dar freschezza ai cibi, disinfettare ferite e sfiammare la gola, cuocere i cibi senza calore e impreziosire dolci, marmellate, sorbetti. Infiniti sono gli impieghi salutari e golosi: una tazza di acqua calda — ma non caldissima, la vitamina C teme aria, luce e calore — con limone e un cucchiaio di miele ha funzioni digestive, lassative e concilia il sonno; qualche goccia aggiunta nell’acqua di cottura del cavolfiore ne abbatte l’odore; il succo riduce la quantità di alcool nel corpo, impedisce l’annerimento enzimatico della frutta e, in rapporto uno a due, tampona l’acidità della spremuta d’arancia. Tale è la sua versatilità da aver ispirato perfino un neologismo paraerotico, se è vero che nel Nord Italia il verbo limonare sta per pomiciare. Gli studiosi sostengono che l’espressione sia stata mutuata da quella usata dai vecchi venditori milanesi («Cinq ghei due i limonitt», cinque centesimi due limoni), quando vedevano una coppia d’innamorati... È tosto, il limone: capace di esibire sulla stessa pianta quasi contemporaneamente foglie, fiori, frutti ancora immaturi e, tra ottobre e primavera, anche quelli di color giallo squillante. Da inizio a fine estate, i limoni sugli scaffali dovrebbero essere verdastri, con la sola eccezione dei verdelli di vecchia raccolta o dei frutti in arrivo dal sud del mondo. Ma i limoni verdi non piacciono granché, e quindi vengono ingialliti artificialmente nelle cosiddette “camere di sverdimento”, dove viene immesso un gas, l’etilene, che attiva forzatamente gli enzimi della maturazione. Procedura che, tra l’altro, uccide gran parte degli oli essenziali, responsabili di profumo e qualità benefiche. Altra scorciatoia, quella del difenile (E230), sostanza di origine petrolchimica che penetra nella buccia ritardando il deperimento. A scelta, si irrorano direttamente gli agrumi o si impregnano le cartine con cui vengono avvolti. In questo modo, l’assorbimento è graduale e perfino più dannoso. Come se non bastasse — messaggio per i cultori del Limoncello — l’alcol ha un effetto solvente sui pesticidi, che dopo la filtratura passano nel liquore. Per fortuna, esistono anche produttori che preservano il ciclo biologico dei frutti e si distaccano dalla pessima abitudine di trattare i limoni: soprattutto nelle aree di coltivazione storica, in Sicilia come in Campania, dove a inizio Novecento i limoni di Maiori erano quotati alla Borsa Merci di New York, con un export annuo di oltre trecento milioni di frutti. Oggi, di tutta la raccolta a denominazione protetta, oltre la metà finisce nel Limoncello. Peccato che nella maggior parte dei casi i limoni compaiano solo sulle etichette, mentre nel liquore trionfano gli aromi chimici. I responsabili del Consorzio di tutela raccontano che testando oltre trecento marchi presenti sul mercato mondiale con la denominazione Sorrento, la materia prima certificata sia stata accertata in non più di sei bottiglie. La nuova normativa dovrebbe impedire il dilagare degli abusi ai danni di un liquore soave, ridotto spesso a bicchierino d’alcol con pronunciato sentore di detersivo per piatti. Del resto, un buon limone, come il prezzemolo, sta bene quasi dappertutto. Il quasi riguarda i fritti, dal pesce alla milanese: dove lo zic di limone spremuto vanifica tutta la fatica fatta per realizzare una cottura asciutta e croccante. I cuochi tremano all’idea, ma non sanno sottrarsi a certe malsane abitudini dei clienti. Se vi arriva il fatidico spicchio nel piatto, spostatelo sulla tovaglia. Vi tornerà utile per una sana limonata digestiva. DOMENICA 27 AGOSTO 2006 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 47 Limone sul Garda (Bs) Menton (Francia) itinerari Livia Iaccarino, donna simbolo dell’ospitalità campana, gestisce con marito e figli il celeberrimo “Don Alfonso” e l’azienda agricola biologica “Le Peracciole”, largo spicchio di collina orlato di limonaie a picco sul mare di Sant’Agata sui due Golfi Sorrento (Na) A pochi passi dal confine con l’Italia, tra mare e delizioso centro storico. Grazie a un microclima mitissimo, ogni febbraio qui si celebra la festa dei limoni. E a Palazzo Carnolès trionfa la più importante collezione d’agrumi in Europa Cuore della Riviera dei Limoni, l’ex borgo di pescatori ricco di uliveti e limonaie, è il paese natale di Daniele Comboni, fondatore dei Missionari Comboniani I limoni, arrivati qui nel XIII secolo, hanno segnato a lungo la tradizione agronomica del lago Protagonista di mosaici pompeiani, il limone è storico re della Costiera, dove terrazze e giardini di limoni rallegrano lo sguardo e profumano l’aria Intorno alla produzione Igp si è sviluppata una variegata economia locale, che va dalle ceramiche ai liquori DOVE DORMIRE DOVE DORMIRE DOVE DORMIRE HOTEL RESTAURANT PARIS-ROME 79 Avenue Porte de France Tel. (0033) 04.93357345 Camera doppia da 69 euro, colazione esclusa HOTEL GARDEN Via IV Novembre 14 Tel. 0365.954067 Camera doppia da 86 euro, colazione inclusa CASA ASTARITA Corso Italia 67 Tel. 081.8774906 Camera doppia da 85 euro, colazione inclusa DOVE MANGIARE DOVE MANGIARE DOVE MANGIARE AU PISTOU 9 Quai Gordon Bennett Tel. (0033) 04.93574589 Chiuso lunedì, menù da 15 euro AL VOLT Via Fiume 73, Riva del Garda Tel. 0464.552570 Chiuso lunedì, menù da 32 euro LA CONCA III Traversa Alimuri, Meta di Sorrento Tel.081.5321495 Chiuso domenica sera e lunedì, menù da 35 euro DOVE COMPRARE DOVE COMPRARE DOVE COMPRARE CITRONNERAIE MAS FLORALO Colline de l’Annonciade Tel. (0033) 04.93357786 EL GARGNÀ Via Don Primo Adami 11, Gargnano Tel. 0365.791038 COOPERATIVA SOLAGRI Via San Martino 8, Località Sant’Agnello Tel.081.8772901 Sorbetto Sciroppo di acqua e zucchero, succo e scorzette in sorbettiera per il più popolare dei chiudipasto. Si può anche mettere il liquido in freezer e poi frantumare nel frullatore con un bianco d’uovo, che lo rende più cremoso. Vodka per la versione alcolica Insalata Ricetta golosa e rinfrescante, a patto di usare limoni dolci come l’Interdonato. Una volta tagliati a spicchi, si condiscono con extravergine, aceto e sale A fine pasto, invece, gli spicchi si gustano spolverizzati con zucchero e lasciati riposare in frigo Limoncello Nato agli inizi del '900 nelle case patrizie della Costiera (ma c'è chi sostiene fosse già preparato secoli prima nei conventi della zona), negli ultimi vent'anni il Limoncello è diventato progressivamente uno dei liquori più amati dagli italiani, tanto che nel 2000 l'Istat l'ha inserito nel paniere della spesa su cui calcolare l'incremento dell'inflazione. La ricetta originale prevede l'utilizzo di scorze di limoni di Sorrento o Amalfi, rigorosamente non trattati chimicamente, meglio se raccolti all'alba, quando i profumi sono più intensi. Ingrediente-base, infatti, è la buccia, che va asportata senza la parte bianca, amara, e messa in infusione nell'alcol da liquori al buio e a temperatura ambiente. Dopo un mese di macerazione, si Da Alessandro Magno a Trimalcione, a Goethe: gli alti e i bassi di un gusto nazionalpopolare aggiunge lo sciroppo di acqua e zucchero. Altre quattro-sei settimane di riposo, poi il filtraggio e la dimora in freezer. Così la nostra storia si tinse di giallo MARINO NIOLA P er fare la prima limonata della storia ci volle una fatica bestiale. Addirittura una fatica di Ercole. L’invincibile eroe fu costretto a scarpinare fino all’estremità occidentale del mondo, per saccheggiare il giardino delle Esperidi e regalare ai mortali il prezioso agrume. Così almeno dice il mito. La storia invece vuole che il limone venga dalla parte opposta, dall’Estremo Oriente. Forse dalla Cina, forse no. Certo è che il frutto giallo era di casa nella Media, l’antica Persia, dove Alessandro Magno lo vide, se ne invaghì e lo portò in Europa. Da quel momento la storia del Mediterraneo si tinge di giallo. Il pomo della Media fa il suo ingresso trionfale a Roma, come pianta ornamentale e profumata, ma anche come ingrediente per ricette sofisticate. Apicio, il Brillat Savarin dei Quiriti, consiglia addirittura di adoperarne la parte bianca per esorcizzare l’afrore del maiale. Un frutto da signori con la puzza sotto il naso, insomma, uno status symbol. Esibito da un parvenu come Trimalcione, il furbetto del quartierino del Satyricon, per ostentare la sua ascesa sociale. Le tenebre barbariche che avvolgono l’Italia nel primo medioevo si inghiottono anche il limone che viene letteralmente dimenticato. Per ritornare fra noi dopo il mille. Questa volta da Occidente, proprio come nel mito di Ercole, seguendo la scia della conquista araba del Mediterraneo. Prima l’Andalusia, poi la Sicilia, finché gli astuti mercanti amalfitani fiutano il business e impiantano agrumeti a tappeto nella loro divina costiera e nella penisola sorrentina. È il trionfo definitivo del citrus limonum. Le virtù terapeutiche, il sapore deliziosamente rinfrescante, l’inebriante profumo esperideo, la bellezza della pianta, la fioritura perenne sono le ragioni dell’irresistibile ascesa di un frutto che finisce per diventare l’icona del Sud. Con il contributo davvero straordinario dei viaggiatori del Grand Tour che creano una vera e propria mitologia del limone, facendo degli scintillanti giardini di Sorrento, di Amalfi e delle limonaie della Conca d’oro l’immagine stessa dell’abbagliante solarità mediterranea: la goethiana «terra dove fioriscono i limoni». E proprio in quel Sud idealizzato da Goethe stava nascendo l’industria dell’agrume. Che, all’inizio dell’Ottocento, grazie alle coltivazioni intensive diventa un frutto sempre più democratico, una vitamina alla portata di tutti. Tra l’altro proprio in quegli anni gli Inglesi scoprono che il succo di limone cura lo scorbuto e la marina britannica include la limonata nella razione kappa della flotta di Sua Maestà. In verità, che il limone fosse una panacea per molti mali era cosa ben nota alla saggezza popolare che con il citrus conciliava da sempre gusto e salute. Tant’è che in città come Napoli e Palermo la spremuta scorreva a fiumi dai banchi stradali degli acquafrescai. Ben prima che l’ungherese Albert Szent-Gyorgyi scoprisse nel 1932 quell’ascorbina, che sotto il nome di Vitamina C è diventata un mantra del salutismo moderno. Insomma, un po’ per passione un po’ per necessità, il Sud ha elevato il limone a gusto jolly trasformando un ingrediente così locale in un aroma globale, un contrappunto planetario del sapore: dalla mayonnaise alla scaloppina, dal sorbetto al lemon pie, per non dir dei frutti di mare. Un vero universale popolare della gastronomia. Quintessenza di liquori “fai da te” come il limoncello, che una ecumenica spinta dal basso ha trasformato in uno spirito del tempo. Nazionalpopolare, of course. Delizia Creata in onore di Luigi Carnacina dal pasticciere sorrentino Carmine Marzuillo, è un dolce-culto della Costiera. I sospiri (mezze sfere di pan di spagna scavate), inzuppati di sciroppo al liquore, sono farciti e ricoperti con una ricca crema a base di limone Alici marinate Per cuocere delicatamente le regine del pesce azzurro, si emulsiona il limone con l’extravergine, e poi si aggiungono sale, pepe, aglio, peperoncino, prezzemolo a piacere I filetti puliti, lavati e asciugati, vanno appoggiati sul dorso, irrorati e fatti riposare in frigo 48 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 27 AGOSTO 2006 le tendenze Venerato negli anni Ottanta, finito alla gogna nei Novanta, il marchio si prende la sua grande rivincita. Si riproduce Vivere griffati all’infinito, in dimensione king size, su abiti e accessori, cambia gli arredi delle case, sostituisce gioielli e ciondoli diventando la loro stessa essenza. È il trionfo dello stilista e della maison, la vittoria totale del concetto di brand VERDE INGLESE Borsetta flap in tweed e braccialetto di metallo, resine, strass e pietre dure per Chanel. La doppia C? Ça va sans dire POLVERE DI STELLE Ametista, topazio cristallo, citrino ciondolanti e incastonati nella stella di Montblanc È la collezione di gioielli “Bohème” IRENE MARIA SCALISE T ra i protagonisti della moda estiva c’è un cavallo di ritorno. Non a tutti gradito. È quel ripetersi sino all’esasperazione di un marchio, un nome e un simbolo. Insomma, il logo che, incurante delle critiche, non solo ha ripreso a far parlare di sé, ma lo ha fatto in modo impudico colpendo ovunque: su borse, scarpe, cappelli e occhiali da sole. Le signore dell’estate, dimentiche dell’understatement, si presentano ogni giorno in barca con sacche platealmente griffate, oppure tintinnano tra un ombrellone e l’altro esibendo fieramente collane e bracciali che, al posto dei ciondoli, hanno le iniziali della maison di turno. Il logo non si limita a tappezzare i fondali effimeri delle vacanze. Ora invade anche gli spazi domestici ricoprendo sfacciatamente divani e poltroncine, che hanno abbandonato le classiche fantasie o i sobri rigati estivi in favore della griffe riprodotta all’infinito. Il nemico giurato del politicamente corretto si è preso la sua rivincita. E risplende, su spiagge e non solo, alla faccia dei fiumi d’inchiostro che lo hanno contestato e di chi, come la catena di negozi giapponesi Muji (che non a caso sta per Mujirushi Ryohin: letteralmente beni di qualità senza etichetta), si è inventato un impero per contrastarlo. Ma che fine hanno fatto i partigiani del No Logo? Sembrano essere scomparsi, oscurati da questo simbolo aggressivo ed estremo. Venerato negli anni Ottanta e messo alla gogna nei successivi Novanta, il logo è l’icona incontrastata delle fashion victim e il trionfo assoluto del mito dello stilista. Non solo. È purtroppo anche il simbolo della contraffazione. Diventa sempre più difficile capire se quelle “C”, o quelle “L” incrociate con le “V”, siano la prova di un’autenticità a molti zeri o un’abile imitazione da cinquanta euro. Chi, in questa estate che non ha risparmiato nessuno, ha riproposto con maggiore insistenza il logo? In realtà praticamente tutti i grandi nomi dell’haute couture. Prada ha ideato addirittura Heritage, che tradotto significa eredità, una linea d’accessori che raffigurano lo stemma e i nodi dei Savoia. Nel frattempo, in casa Fendi, l’iniziale maiuscola è stata mostrata in un’infinità di variazioni, specialmente su poltrone e divani. Gucci, per ferma volontà della direttrice artistica, Frida Giannini, ha fatto stampare la doppia “G” sulla pelle di tutti gli accessori. E lei, a chi la interroga sull’imperversante mania, dichiara: «Sono molto affezionata al simbolo “GG”, che ha origine nelle iniziali del nostro fondatore Guccio Gucci. Queste due lettere racchiudono storia e tradizione del marchio e ancora oggi i prodotti con la doppia “G” hanno un gran successo perché siamo riusciti a rinfrescarli con ironia e a presentarli in modo nuovo». E se il logo non fosse un’imposizione ma una scelta? O meglio se il fatto di tenere o togliere il logo fosse affidato al gusto di chi acquista un vestito o una sedia? Un caso per tutti: Stone Island, marchio destinato all’abbigliamento informale, al suo esordio sul mercato (negli anni Ottanta) ha deciso di applicare il logo a vista con il proprio simbolo, la rosa dei venti, offrendo un’alternativa. L’etichetta, ricamata su un rettangolo di stoffa e abbottonata sulla manica di giubbotti, maglie e camicie, era infatti una sorta di badge e poteva essere anche sbottonata e rimossa. «Il risultato è che la rosa non solo è rimasta al suo posto — assicurano da Stone Island — ma è diventata un simbolo d’appartenenza per i clienti più fedeli». Niente da fare dunque. Vince il popolo del Sì Logo. o L r e p Su Il “cattivo” è tornato e stavolta è ovunque MOSAICO Décolleté in canvas con riporti in vitello color miele. La “R” di Fratelli Rossetti si ripete ossessivamente come un intreccio È anche il simbolo della contraffazione È sempre più difficile capire se quelle “C” o quelle “LV” siano una prova di autenticità da parecchi zeri o la buona imitazione Repubblica Nazionale 48 27/08/2006 di un falso da pochi euro ZEPPA SÌ MA DI CLASSE Zeppa a tacco medio in raso bianco e finiture in pelle bianca. La stampa di Gucci si incrocia sul collo del piede fasciandolo PUNTO E BASTA Una sola grande “P” puntata per questa felpa bicolore di Pirelli Un esempio per tutti dell’oggetto dal quale è ripartita la “reconquista” del logo: le felpe appunto SPECCHIO DELLE MIE BRAME Il logo Monogram oro in una nuova abbagliante versione impressa su vinile a specchio. È la borsa “Alma” di Louis Vuitton DOMENICA 27 AGOSTO 2006 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 49 IN VIAGGIO CON GIORGIO Un beauty da uomo in ecopelle bianco con dettagli in rosso e bianco. L’immancabile logo Emporio Armani è saldato in alta frequenza LOGO A PIOGGIA Borsa con rifiniture in ecopelle con stampa a struzzo e logo Denim per la stagione autunno-inverno di Guess Che buon affare perdere il nome STEFANO BARTEZZAGHI M AVANTI SAVOIA Repubblica Nazionale 49 27/08/2006 o Lo stivale da donna Heritage di Prada con il logo volutamente reso antico e arricchito dallo stemma di casa Savoia GENTE DI MARE Una sacca da viaggio che ricorda fughe per il mare e porti lontani Ma non possono mancare il levriero e la scritta in caratteri cubitali della maison Trussardi PIEDI RICOPERTI Canvas e pelle per questa décolleté in canvas e pelle di Dior il cui logo si dissolve su tutta la superficie SECCHIELLO La Palazzo bag di Fendi in tessuto jaquard con tracolla torchon e riporti in pelle miele, cornici borchiate con profili neri. La doppia “F” è color tabacco e moro ORA X Unisex, automatico vetro in zaffiro e cassa in ceramica bianca, nera o con oro rosa e lunetta tempestata di diamanti. E al posto dell’ora zero, la caratteristica greca di Versace arca, marchio, brand, griffe, logo, label, firma, etichetta, simbolo... un’intera galassia di lemmi circonda l’universo della merce. Dato che la Lingua batte dove l’Ente duole non sarà troppo maligno sospettare che questi fuochi d’artificio lessicali impieghino le loro scie luminose per lasciare al buio il centro da cui si sprigionano. I lemmi di questa catena di sinonimi (o meglio quasi-sinonimi) sono tutti eufemismi che ci permettono di non menzionare il termine che, nel contesto del marketing, sarebbe osceno: la semplice parola nome. Se dicessimo a Giorgio Armani che “Giorgio Armani” è un nome — proposizione del tutto sensata dal punto di vista linguistico —, probabilmente l’interessato si offenderebbe. Dopo una vita di lavoro, e di successi planetari, il nome non è più un nome neppure per chi lo porta: diventa qualcos’altro, ha qualcosa in più. Ma a pensarci, e senza offesa, è forse vero il contrario. “Giorgio Armani” è qualcosa di meno di un nome. Sui segreti e i paradossi del nome, il comune e il proprio, la filosofia del linguaggio ha riempito biblioteche: ma è certo che un nome rimanda a un significato, a un’identità, a una possibile delimitazione della sostanza del mondo. Ciò che è il contrario dello stile. Chiese un amico a Joan Mirò: perché se io raccolgo un sasso quello è un sasso, se lo raccogli tu quello è un Mirò? Perché il cognome dell’amico è rimasto un cognome; mentre il cognome di Mirò non lo era già più, non si riferiva più a una persona, bensì a un modo d’essere: non a una figura ritagliata dal continuo del mondo, ma al modo di ritagliarla. Lo stile non ha sostanza. Un libro, come sostanza, è un assieme di pagine rilegate, e tutti i libri sono uguali; il libro di un grande scrittore o di un editore raffinato desidera uscire dall’identità comune a tutti i libri, distinguendosi per lo stile in cui è scritto o confezionato. Oltre una certa soglia stilistica i “bei libri” perdono la loro sostanza di libro, al punto che non desiderano neppure essere letti, ma si limitano a esibire uno stile editoriale. Il vanto di un editore, il vanto di qualsiasi produttore, è riuscire a sconnettere il proprio nome dalla propria attività immediatamente produttiva e farlo entrare in quello che l’interessato pensa sia il mondo platonico delle idee, e invece è lo zoo immateriale degli stili. Dalle marche di sigarette che negli anni Settanta diventavano marchi di abbigliamento, all’invasione delle griffe di moda sugli accessori e i profumi il meccanismo è lo stesso: cedere significato in cambio di leggerezza simbolica. Così il significato della vistosa scritta FIAT sulla felpa è prima di tutto negativo. Dice: «Questa non è una Fiat» (idea venuta nel 1911 con i cioccolatini della stessa casa automobilistica: la novità è che il cioccolatino lo mangia chi ce l’ha, la felpa la vedono soprattutto coloro che non la indossano). Finché il consumatore percependo la scritta FIAT pensa immediatamente a carburatori e marmitte — anzi: finché percependola pensa — il marketing sa di sbagliare qualcosa. La marca è ancora troppo nome, ha un significato, quando invece non deve averne più. Ogni ora di lavoro su un nome va nella direzione di togliergli significato: lo si riduce a una lettera iniziale, a un monogramma, gli si dà una forma grafica, un colore e tutto è pensato per spostarne la percezione da parte del consumatore dalla testa in giù verso la pancia. Un nome lo si ascolta con le orecchie o lo si legge con gli occhi. Un logo deve essere odorato, sentito attraverso le papille gustative della Lingua. Anche la presenza ossessionante del logo serve allo stesso scopo, come nel gioco dei bambini che ripetono una parola tante volte di seguito fino a non sapere più cosa significhi (e non solo i bambini. Laura, e l’aura, l’aureo, l’auro, lauro, l’aria... che gran copywriter, Petrarca...). Esaurito il significato di un nome, il suo riferimento a un’entità del mondo, il suo vuoto resta a disposizione per qualsiasi investimento di senso, e affettivo, possibile. Il nome non ha più una cosa precisa da significare, e quindi può diventare cosa esso stesso, aggiungendo valore simbolico, ma il più delle volte anche economico, a una felpa, a un accendino, a una qualsiasi sciocchezza. 50 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 27 AGOSTO 2006 l’incontro Ha 75 anni, è una delle più grandi poetesse italiane del Novecento Il “presunto premio Nobel”, come lei stessa ironicamente si definisce, fuma 70 o 80 sigarette al giorno (buttandone i mozziconi, senza spegnerli, sul parquet della sua minuscola casa): “Mi hanno allungato la vita”, dice Da ragazzina tentò di entrare in convento, poi ebbe un marito, quattro figlie Lavora ancora molto e commenta: “Ho avuto una bella vita” Vita e poesia Alda Merini tia attento, sa! Io sono un presunto premio Nobel», sussurra con tono ironico e fintamente minaccioso Alda Merini piegata sulla cornetta del telefono. Ammicca nella mia direzione. «Lei che ne dice?». Si tocca la pancia, una smorfia le si ricama sulla faccia intelligente e maliziosa, spiega che sta aspettando il medico. Era lui all’apparecchio. «Faceva storie». Sono le due del pomeriggio. Mi racconta che stava per fare il bagno, si era dimenticata dell’appuntamento. Lascia che l’acqua scorra nella vasca, dopo un po’ il suo gorgoglìo diventa una nuova forma di silenzio. Ride, spezza il filtro di una Diana, se la infila tra le labbra e l’accende. Sul parquet brucia ancora il mozzicone di quella precedente, una sottile voluta di fumo si alza tra libri, fogli, disegni, stoffe, abiti non stirati, panni che da giorni attendono di finire in una misericordiosa lavatrice, scatole di gomma da masticare e paletò macchiati appesi a un unico tronfio trespolo che sembra un babbo natale impalato da qualche crudele ragazzino. Alda Merini è una delle più grandi poetesse italiane del Novecento. Di sigarette ne fuma settanta, a volte ottanta il giorno. «In manicomio ce le passavamo gli uni con gli altri. Stavamo in fila, a testa bassa, dentro i nostri camicioni, nel darci la cicca indugiavamo un po’ per accarezzarci le mani. Erano le uniche ricchezze che avevamo, la sola cosa da fare, il solo gesto umano che ci univa nell’illusione di un breve spazio di normalità». In giro non si vedono posacenere, il pavimento assomiglia a un campo di stoppie annerite dai falò autunnali. «Le sigarette mi hanno allungato la vita». Solleva appena il vestito, mostra le gambe bianche: «Guardi che bella pelle che ho. Lei che ne dice?». La sua simpatia è dolce, nostalgica, attraversata da tenerezze e pudori di bambina. viene a trovarmi mio marito». Ettore Carniti è scomparso nell’81. «Non credo ai fantasmi, anche se sarei una buona giallista. Fu Manganelli a insegnarmi la tecnica del romanzo giallo. Ettore entra dalla stessa porta dalla quale è passato lei. Arriva all’improvviso, come faceva sempre, nel timore o nella voglia di scoprirmi con qualcun altro. Io lo sento. Portiamo i morti con noi fino a quando moriamo a nostra volta». Non potrei vivere senza la fede, scrisse in passato. Quand’era ragazzina, affezionata alla storia di Santa Teresina del Bambin Gesù, tentò di entrare in convento. Fu una fugace esperienza. «Sono una contemplativa, non mi piacciono i rumori, amo la solitudine». La famiglia andò a riprendersela. Finì a fare pratica da stenografa negli studi di alcuni avvocati fallimentari. Il primo impiego lo perse subito perché componeva poesie durante l’orario di lavoro. «Mi buttarono fuori. Erano taccagni, mamma mia, lei non ne ha idea dell’avarizia degli avvocati. Ma adoravo il loro modo di scrivere gli atti. Mi accorsi che gli avvocati scrivono bene». Nel centro di Milano percorreva ogni mattina la stessa strada. Era il 1948. Le capitava di incontrare sovente un signore minuto, curvo, silenzioso, di un’eleganza dimessa. A lui dedicò una delle sue prime poesie, Il gob- Le parole sono per me modelli di virtù. Le bevo come i bambini attaccati al capezzolo della madre o al loro dito FOTO FOTOGRAMMA Repubblica Nazionale 50 27/08/2006 «S MILANO I poeti sono spesso poveri. Quasi mai tristi. Si portano dentro l’allegria dei naufraghi. Oppure lo sberleffo, che è la vanità degli artisti. È così per la Merini. La immaginavo, chissà perché, sempre sola nel cerchio tracciato dalla sua musa e invece scopro che ha dietro moltitudini di anime, amori, vite, dolori e piccole felicità passeggere, un’esistenza spezzata in tanti fiumi alcuni dei quali si sono seccati nella terra mentre altri, alla fine e fortunosamente, sono riusciti a riemergere e ricongiungersi. I poeti non perdono mai nulla, o abbandonano soltanto ciò di cui vogliono liberarsi. Alda Merini parla per esempio di Eugenio Montale, uno dei suoi uomini preferiti. Dice proprio così, «uomini», anche se con Montale non c’è stato nulla di più di un’amicizia. Ricorda quei versi indimenticabili che riportano tanti di noi al sapore dell’infanzia: Qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza, ed è l’odore dei limoni. Anche lei, a settantacinque anni, quindici dei quali, da quando ne aveva ventisette a quando ne ha compiuti quarantadue, trascorsi da matta tra i matti, fa il conto della sua ricchezza. «Ho avuto quattro figlie. Allevate poi da altre famiglie. Non so neppure come ho trovato il tempo per farle. Si chiamano Emanuela, Barbara, Flavia e Simonetta. A loro raccomando sempre di non dire che sono figlie della poetessa Alda Merini. Quella pazza. Rispondono che io sono la loro mamma e basta, che non si vergognano di me. Mi commuovono». Ha avuto un marito, Ettore Carniti, molto amato, molto geloso e, dice lei, anche parecchio infedele. Una notte che era rientrato a casa con addosso il profumo di un’altra donna, come il Tomàs dell’Insostenibile leggerezza dell’essere di Kundera, lei gli spaccò in testa una sedia dorata. «Quella lì», me la indica. La spalliera è tutta incerottata. Mi invita a sollevarla. È pesantissima. Lui sopravvisse eroicamente allo schianto, chiamò l’ambulanza e la portarono in ricovero coatto al Paolo Pini, l’ex manicomio di Milano ora diventato un parco e un teatro. «Ma io laggiù non ci ho mai più messo piede, ho paura. Terrore purissimo». Lei è così. Salta da un argomento all’altro. Li accatasta alla rinfusa, come gli oggetti di questa minuscola casa al 47 su Ripa di Porta Ticinese. Di fronte ci sono una chiesa di mattoni bruniti e l’acqua scura come la pece del naviglio. Camera da letto, bagno, cucinino, studio. Ci si sposta solamente mettendosi di fianco, schiacciandosi come acciughe contro gli indecifrabili relitti che coprono le pareti. Nel gioco dei pieni e dei vuoti, questi ultimi hanno avuto clamorosamente la peggio. Lei ce l’ha con il padrone di casa che l’ha obbligata a liberare la soffitta e con gli operai che spaccano, battono, impolverano. Ma è un rancore fragile, forse nient’altro che un aneddoto al quale si è ormai affezionata come un reumatismo che si risveglia nelle ossa quando cambia il tempo. «Qui, adesso, è impilata tutta la mia vita. Il mio lavoro. A volte bo: Mi viene a volte un gobbo sfaccendato, un simbolo presago d’allegrezza che ha il dono di una strana profezia. Quell’uomo era Enrico Cuccia, il leggendario banchiere. «Una mattina lo fermai e gli dissi: io ho fame. “Buon segno”, mi rispose. E tirò dritto». Dio, invece, da lei si fermò, nonostante la rinuncia alla clausura. E non se n’è più andato dalla sua anima. Anche da altre parti del suo corpo. Dagli inguini — scrive la Merini nella raccolta La Terra Santa — può germogliare Dio. «La mia religiosità è molto pagana. Pagana e gaudente. Mi sono sempre comportata da grande peccatrice e non mi sono mai pentita. Non vado in chiesa a mormorare, d’altra parte le chiese sono sempre vuote. Non prego. Ma credo che Dio sia qui con me. Ne avverto la presenza, annuso il suo odore, sento dentro di me la pace divina. Due cose sopra tutte mi convincono dell’esistenza di Dio: che non sono padrona delle mie volontà e che l’Oceano Pacifico non possono averlo creato gli scienziati. Mi basta questo. Nego l’aldilà e la resurrezione. Se guardo tutto ciò di meraviglioso che Dio ha creato su questo terra, come posso credere che mi regali anche il paradiso? Sarà per questo motivo che non penso mai alla morte. A meno che non sia già morta. Lei che ne dice?». Dai muri gli oggetti appesi con mano malferma danno l’impressione di poter precipitare da un momento all’altro. Ci sono molte immagini di Giovanni Paolo II. «Lo amo. Era bello, coraggioso, ostinato. Non sembrava neanche un Papa. Ha saputo tenere annodati i cordoni della pace, ha parlato con tutti i popoli del mondo. La sua agonia è stata terribile, penosa. Dopo i suoi funerali non ho più acceso la tv». C’è un poster del film Vacanze romane. Gregory Peck e Audrey Hepburn. «I nostri grandi amori. Oggi non ne esistono più, si è persa la favola. Telefonini, computer, sms. Mi trovi uno che scriva ancora lettere alla fidanzata, se ne è capace. Gli italiani sono sempre più cretini, malati di padreternismo, egoisti e primitivi. E sempre più tristi. Mi era rimasto Berlusconi, il solo che mi facesse ridere in un paese che non ride più. Con la sua caduta è morto l’ultimo pagliaccio d’Italia, aveva una stupidità che incanta». In camera, proprio sopra il letto c’è una riproduzione dell’Origine del mondo di Gustave Courbet. «Guardi l’offerta piena che c’è tra le gambe di quella donna. Maria Corti diceva che le donne non hanno sesso. Io mi considero una donna fallica. Non ho l’ossessione del sesso, ma so per esperienza che il sesso annienta le nevrosi. Sono molti anni che non faccio più l’amore. A volte provo il desiderio di scopare un uomo, ma mi passa in fretta. In realtà non ne ho più voglia. Noi anziani trascorriamo le giornate con un obiettivo fisso nella testa. Prima di sera — ripetiamo a noi stessi — , riuscirò a fare questo e quello, e quell’altro ancora. Ci illudiamo di essere forti, autosufficienti. Viene notte e non abbiamo combinato nulla. A fatica ci manteniamo in vita. Io sono una vecchia che sta bene, vado a letto presto e so che ogni giorno nuovo è un giorno regalato». Alda Merini lavora ancora. Molto. Con Milva, Lucio Dalla, Roberto Vecchioni, Giovanni Nuti. Ha appena terminato i Vangeli apocrifi. «Scrivo per non annoiarmi. Non ho mai avuto il piacere della lettura, non so come la gente possa leggere le mie poesie. Credo di non avere mai letto un libro fino alla fine». Confessa di fermarsi alla prima frase dalla quale viene folgorata. Di lì in poi la sua mente spicca il volo e si perde. Acrobazie, evoluzioni, salti mortali sul filo delle parole. «Le parole sono per me modelli di virtù. Le bevo come i bambini attaccati al capezzolo della madre o al loro dito. Sono stata matta d’amore per Rainer Maria Rilke. Mi piacevano Hölderlin, Valéry, Melville, Gide, Pirandello, Dante, Manzoni. L’errore è farci leggere I promessi sposi a scuola. Ho avuto la fortuna di conoscere altri grandi letterati: Quasimodo, Manganelli, Montale, Raboni, la Spaziani. Alcuni li ho amati, li ho avuti. Non Giovanni Raboni. Giovanni era bellissimo. Ricordo che una sera lo incontrai al bar in un albergo di non so più quale città. Era appoggiato al bancone e mi dava le spalle, alto, bianco, elegantissimo, un attore del cinema, un dio. Pensai: chissà che cosa beve un uomo così. Mi avvicinai e lo sentii ordinare al cameriere una camomilla. Avrei voluto abbracciarlo, ma non ne ebbi il coraggio». Lascia cadere sul pavimento la sigaretta ancora accesa, ne prende un’altra dal pacchetto. Dice: «Ho avuto una bella vita. Sa qual è il più bel complimento che ho ricevuto? Me lo fece la mia vicina, una signora che non c’è più e che non dimenticherò mai. Mi raccontò che in Sardegna abitava nella stessa casa di Grazia Deledda e che io gliela ricordavo perché come lei non mi davo arie e stavo bene anche con uno straccio addosso. Io non ho più niente da dire. E lei, lei che mi dice?». ‘‘ DARIO CRESTO-DINA
Scarica