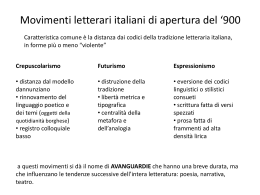LIRICA, EPIGRAMMA La lirica nella prima età imperiale Le Silvae di Stazio Gli epigrammi di Marziale La lirica nel II secolo: i poetae novelli e il Pervigilium Veneris Francesco Piazzi, HORTUS APERTUS - Autori, testi e percorsi - Copyright © 2010 Cappelli Editore 532 Lirica, epigramma Condizioni della rinascita di una nuova lirica A LTO IMPERO trad. di L. Rusca Calpurnio Siculo, Carmina Einsidlensia, Cesio Basso La lirica nella prima età imperiale Nell’età imperiale venne meno alla lirica la sua motivazione etica profonda, che nel periodo tardorepubblicano e augusteo era consistita nell’affermazione polemica del diritto all’otium letterario e individuale. Non era più necessario difendere la priorità della dimensione privata, personale, intima, né occorreva più giustificare il proprio disimpegno nei confronti della politica e del sociale, dal momento che un tale atteggiamento era addirittura auspicato e incoraggiato dal principe. Il quale, nella propaganda imperiale, era un filantropo che sacrifica la propria privacy sobbarcandosi il pondus gravoso del governo della cosa pubblica, per garantire ai cittadini la securitas e la tranquillitas. Queste condizioni, se da un lato precludevano la nascita di una lirica «alternativa», avanguardistica e modernizzante come quella di Catullo, dei neòteroi e di Properzio, dall’altro lato favorivano la pratica dilettantesca di questo genere tradizionalmente ancorato alla sfera del privato. Nel Dialogus de oratoribus di Tacito Curiazio Materno assegna alla poesia una funzione di solacium non diversa da quella che Seneca riconosceva alla filosofia. All’oratore Apro, che lo rimprovera di trascurare l’oratoria per scrivere versi, Materno risponde tessendo l’elogio della poesia intesa come svago e serena consolazione. Analoga concezione è espressa in una lettera (4, 14) di Plinio il Giovane: Caro Paterno … riceverai insieme a questa lettera dei miei endecasillabi che ho scritti in carrozza, al bagno, durante la cena per occupare piacevolmente il tempo. Con essi io gioco, scherzo, amo, mi dolgo, mi lamento mi adiro … Dalla tua sincerità esigo che tu dica a me ciò che dirai agli altri del mio libretto. Non è difficile ciò che ti chiedo. Giacché se questo lavoretto fosse il più importante o il solo dei miei potrebbe forse sembrar duro il dirmi: «Cerca qualcosa di meglio da fare», ma benevolo e cortese è il dire: «Hai di meglio da fare». Addio. In questa veste di hobby, di ornamento decoroso di una vita gravata da ben altre e più impegnative incombenze, nella prima età imperiale la lirica ebbe numerosi cultori, anche di rango imperiale come Tiberio e Nerva, quest’ultimo autore di elegie. Ma si trattava di una produzione letteraria che s’avvitava su se stessa, ripetendo i modelli classici, senza produrre innovazioni significative. Durante il principato di Nerone il genere bucolico – che si prestava a celebrare l’età neroniana come novella età dell’oro, sull’esempio del IV egloga di Virgilio – fu praticato da Calpurnio Siculo, autore di sette egloghe d’intonazione encomiastica e propagandistica. In esse si accentua l’allegorismo, già presente nelle Bucoliche virgiliane e che caratterizzerà la poesia pastorale fino all’Arcadia settecentesca. Le egloghe di Siculo saranno un modello per la poesia bucolica di Nemesiano (vedi p. 632). Analoghi per il contenuto bucolico e il carattere smaccatamente panegiristico sono i due frammenti noti come Carmina Einsidlensia (da Einsiedeln, dove fu trovato il manoscritto nel 1869). In essi è elogiato Nerone come dio potente, che segna il ritorno dell’età dell’oro. Pochi anni dopo apparvero i Lyricorum libri di Cesio Bas- La lirica nella prima età imperiale so, perduti, di imitazione oraziana e caratterizzati dalla complessità e varietà dei metri. L’epigramma è il genere più coltivato in questo periodo, per la grande disponibilità ad accogliere contenuti differenti (erotici, funebri, celebrativi, di protesta). Ricordiamo una raccolta di epigrammi erotici di Cornelio Lentulo Getulico, attivo sotto Tiberio e Caligola, e una attribuita a Seneca. A quest’ultima appartengono una settantina di epigrammi in distici elegiaci di dubbia autenticità. L’argomento è vario: encomiastico (per la campagna britannica di Claudio), erotico, d’occasione. Due componimenti descrivono il paesaggio inospitale della Sardegna, due fanno riferimento all’esilio dell’autore. È possibile che si tratti di esercitazioni scolastiche falsamente attribuite a Seneca, come spesso accade con gli autori importanti. L’epigramma Giardino (viridarium). 533 534 La lirica nella prima età imperiale Le Silvae di Stazio L’ideologia dei burocrati A LTO IMPERO Reimpiego di materiali retorici Carmi di contenuto autobiografico Di Stazio, oltre alla produzione epica (vedi p. 520), restano 5 libri di Silvae, cioè – secondo la definizione di Quintiliano (X 3, 17) – liriche d’occasione d’argomento vario per lo più in esametri (ma anche in versi lirici), nate dal piacere di abbandonarsi alla subitanea ispirazione del momento: mihi subito calore et quadam festinandi voluptate fluxerunt, «Mi sono sgorgate sotto lo stimolo di ispirazioni improvvise e con un certo gusto di fare in fretta» (Praef. I). Al carattere occasionale ed estemporaneo, oltre che alla varietà dei contenuti, farebbe in particolare riferimento il termine silva; ma anche all’elaborazione formale incompleta, come di materiali solo sbozzati, non rifiniti (silva corrisponde al gr. hyle nel senso di «materiali letterari» raccogliticci, disordinati). L’autore insiste sulla rapidità d’esecuzione (celeritas) di questi «schizzi», nessuno dei quali lo ha impegnato per più di due giorni. Questi abbozzi, che potenti personaggi di corte commissionavano a Stazio nella sua qualità di poeta professionista, sono un prezioso documento della vita ufficiale del tempo, dei gusti della società imperiale e dei nuovi ceti burocratici ripiegati nel privato, estetizzanti, dediti al lusso e alle raffinatezze, portatori della nuova «ideologia del pubblico servizio». Da questo punto di vista sono di particolare interesse composizioni come quella funebre dedicata al segretario finanziario di Nerone, Claudio Etrusco. In essa è celebrata la fulminante carriera del defunto, dalla schiavitù ai vertici della burocrazia, attraverso i topoi celebrativi del funzionario modello: fedeltà all’imperatore, senso del dovere, dedizione al lavoro nel superiore interesse della securitas dei concittadini (questa virtù appartiene sia al principe sia ai suoi alti collaboratori), esercizio del potere considerato come un onere (pondus) che comporta rinunce piuttosto che vantaggi personali. Segue l’immancabile elogio servile delle virtù dell’homo novus e della Fortuna che ha consentito a un umile di costruirsi con le sole sue forze una posizione sociale tanto prestigiosa. Il carattere professionale dei carmi trova riscontro nella modalità compositiva, che rivela la capacità artigianale di variare, adattandoli alla richiesta del committente, alcuni schemi retorici e di riutilizzare in abili assemblaggi materiali topici, esempi mitologici, figurazioni manierate, espressioni prefabbricate adattabili a circostanze e contesti diversi: lutti, nozze, compleanni, viaggi, inaugurazione di ville di facoltosi personaggi. Non mancano prove d’impronta neosofistica come l’epicedio di un pappagallo e di un leone addomesticato; c’è perfino il carme per la consacrazione di una ciocca di capelli. Si tratta per lo più di composizioni manierate, prolisse, appesantite dall’erudizione e dal concettismo. I modelli sono Virgilio, Ovidio, Catullo e i neòteroi, gli elegiaci. Meno superficiali e retoriche sono alcune liriche nate da spunti autobiografici come quella, indirizzata alla moglie per persuaderla a ritornare a Napoli, nella quale sono celebrate con sincera nostalgia le bellezze della sua città natale, o l’epicedio per la morte del padre o di un figlioletto. In questi casi il poeta mette da parte il bagaglio ingombrante del professionismo poetico e ci regala versi intensi e sinceri. Le Silvae di Stazio Il paesaggio partenopeo (III 5, 81 ss.). La descrizione dei luoghi cari all’infanzia del poeta rievocati con idillico abbandono è uno dei carmi migliori di Stazio. La nostalgia impedisce l’impiego del consueto apparato retorico, i versi suonano sinceri e delicati. Has ego te sedes (nam nec mihi barbara Thrace nec Libye natale solum) transferre laboro, quas et mollis hiems et frigida temperat aestas, quas imbelle fretum torpentibus adluit undis. pax secura locis et desidis otia vitae et numquam turbata quies somnique peracti. nulla foro rabies aut strictae in iurgia leges: morum iura viris solum et sine fascibus aquum. quid nunc magnificas species cultusque locorum templaque et innumeris spatia interstincta columnis, et geminam molem nudi tectique theatri et Capitolinis quinquennia proxima lustris, quid laudem litus libertatemque Menandri, quam Romanus honos et Graia licentia miscent? nec desunt variae circa oblectamina vitae: sive vaporiferas, blandissima litora, Baias, enthea fatidicae seu visere tecta Sibyllae dulce sit Iliacoque iugum memorabile remo, seu tibi Bacchei vineta madentia Gauri Teleboumque domos, trepidis ubi dulcia nautis lumina noctivagae tollit Pharus aemula lunae, caraque non molli iuga Surrentina Lyaeo, quae meus ante alios habitator Pollius auget, Dinarumque lacus medicos Stabiasque renatas. mille tibi nostrae referam telluris amores? In queste terre io ti voglio condurre (non sono io nato nel suolo della barbara Tracia o della Libia), io ti voglio condurre colà, dove fresca trascorre l’estate e mite l’inverno, dove il tranquillo mare move lente le onde sue. Là troverai una pace serena, troverai il riposo di una vita che si può condur placidamente, là una quiete senza preoccupazioni e sogni senza turbamento. Non vi si trovano le accanite liti e le contese del foro: nell’animo degli uomini vive la giustizia e la equità, per tutti e senza bisogno di fasci… In quel luogo una saggia vita ti offre piaceri senza numero, sia che tu voglia andar a visitare le tepide acque di Baia, o la spelonca della fatidica Sibilla, o il giogo che il duce troiano rese memorando, sia che ci si aprano alla vista i fertili vigneti di Gauro o la sede degli antichi Telèboi, dove un faro manda i raggi benefici ai nocchieri impensieriti, raggi emuli della vagante luna; o ci stiano dinanzi le dolci colline di Sorrento, cui tanto predilige l’irruento Bacco e cui Pollio mio, che ne è padrone, migliora sempre più; sia infine che ci stia dinanzi il lago d’Enaria salutifero o Stabia risorta nuovamente dal mare di lava che l’aveva sepolta. Dirò dunque tutte e mille le delizie della mia terra? (trad. di Sozzi) 535 536 La lirica nella prima età imperiale Gli epigrammi di Marziale La vita Marco Valerio Marziale nasce a Bilbilis, in Spagna, intorno al 40 d.C. A Roma viene in contatto con l’importante famiglia spagnola di Seneca e con Calpurnio Pisone. Dopo il suicidio dei suoi protettori in seguito alla scoperta da parte di Nerone della congiura dei Pisoni (65 d.C.) la vita del poeta divenne difficile. Condusse sempre vita modesta di cliente e, sebbene raggiungesse una discreta fama come scrittore di epigrammi e raggiungesse anche la carica di tribuno militare, ebbe sempre a lottare con le necessità economiche, come lamenta spesso nei suoi versi. I libri di epigrammi ebbero notevole successo di pubblico, ma non furono remunerativi sul piano economico. Nel 98 decise di tornare a Bilbilis – e sarà Plinio il Giovane a pagargli il viaggio – dove morì intorno al 104. Le opere Di Marziale restano 12 libri di epigrammi, prevalentemente in distici elegiaci, a cui si devono aggiungere: • la raccolta nota come Liber de spectaculis contenente la descrizione degli spettacoli con cui Tito inaugurò l’Anfiteatro Flavio; • i due libri Xenia e Apophoreta, contenenti brevi iscrizioni anche di un solo distico, biglietti di dedica che accompagnavano i doni fatti nella festa dei Saturnali. Il rapporto con l’epigramma greco A LTO IMPERO Già s’è visto che cosa fosse l’epigramma greco arcaico e quale evoluzione avesse avuto in età ellenistica. Già Catullo si era cimentato in questo genere – che più di ogni altro pareva accordarsi con i precetti della poetica callimachea della brevità e della perfezione formale – raggiungendo pregevolissimi risultati. Marziale fa dell’epigramma il genere esclusivo della propria arte: da un lato potenzia la dimensione realistica dell’interesse per il popolaresco e per le tematiche d’ambiente cittadino, tipica della scuola dorico-peloponnesiaca; dall’altro sviluppa il gusto per il comicosatirico perfezionando la tecnica dell’epigramma alessandrino consistente nell’orientare tutta la composizione verso una conclusione arguta e inattesa: la pointe conclusiva o fulmen in clausola, stoccata finale corrosiva e imprevista (aprosdóketon). Basti un esempio: Licoride, la guercia, si è presa come amante, caro Faustino, un giovane bello come Ganimede: ci vede bene la guercia! La conclusione paradossale che scioglie l’attesa creata nel lettore nel segmento narrativo iniziale «è l’espressione di una sorta di “nuovo ordine” imposto dal poeta alla realtà, con la sostituzione al modello interpretativo più ovvio di un nuovo modello che si contrappone al precedente e lo annulla» (Stupazzini). Dall’epigramma alessandrino deriva anche l’allusività, intesa come gusto del doppio senso o del gioco di parole, ma anche come riecheggiamento di un motivo letterario tradizionale che il lettore colto è invitato a riconoscere. In particolare abbondano le citazioni da Catullo, Virgilio, Orazio ed Ovidio. Gli epigrammi di Marziale Il realismo La tendenza a filtrare la realtà attraverso la lente deformante della satira – che induce l’autore a ripartire l’umanità in tipi più o meno loschi e meschini (poetastri, vanagloriosi, cacciatori di eredità, femmine dall’eros insaziabile e pervertiti d’ogni risma, patetiche tardone che bimbeggiano, medici-becchini, ecc.) – non implica un atteggiamento moralistico. L’obiettivo dell’autore è solo quello di fare sorridere, forse anche di condannare il peccato, ma non i singoli peccatori (parcere personis, dicere de vitiis, X 33, 10). Il «mondo alla rovescia» che emerge dagli ambienti degradati della metropoli è visto con distacco se non proprio con indulgenza e viene preso in considerazione nei suoi aspetti paradossali e grotteschi solo per la ricerca dell’effetto, per suscitare il riso nel lettore. Le tematiche sono varie, ma sempre legate alla quotidianità (hominem pagina nostra sapit, X 4, 10): commemoriazioni di eventi importanti o comunque memorabili per il destinatario (matrimoni, nascite, morti, festività), rievocazioni di spettacoli (nel De spectaculis), descrizioni di paesaggi o oggetti, arguti biglietti di accompagnamento per un dono o un invito a cena. Ma ci sono anche epigrammi di confessione autobiografica e psicologica, né mancano quelli di contenuto metaletterario (dichiarazioni di poetica, critica di opere o di poeti). Si veda in particolare il seguente, che definisce la poetica dell’autore, basata ad un tempo sul realismo dei contenuti, ma anche sull’elaborazione formale d’impronta callimachea: Tu che leggi di Edipo e di Tieste cui s’oscura la vista, di Medee e di Scille, che altro leggi se non mostruosità? […] Che gusto ci provi per le illusorie fantasie di un misero foglio di carta? Leggi piuttosto questo di cui la vita possa dire: «Mi appartiene». Non troverai qui né centauri, né Gorgoni, né Arpie: le mie pagine sanno di uomo. Ma tu non vuoi, Mamurra, comprendere i tuoi costumi, né conoscere te stesso: allora leggi le Origini di Callimaco. La fortuna Gli epigrammi di Marziale incontrarono l’immediato favore del pubblico, anche se il successo non gli valse una vita economicamente tranquilla. La sua fortuna nei secoli s’identifica in buona misura con la fortuna dell’epigramma. Nel IV e V secolo l’ammirano e lo imitano Ausonio, Claudiano, Sidonio Apollinare. Le connessioni degli epigrammi con la filosofia popolare (diatriba) e il genere stesso, che si presta a tradurre brevi insegnamenti, agevola la lettura di Marziale in chiave moralistica, soprattutto nel Medioevo, dove è ben noto attraverso i florilegi, cioè le raccolte di testi esemplari. Il suo nome compare negli elenchi degli autori letti nelle scuole. Petrarca e Boccaccio lo ammirano e lo imitano. Durante il Rinascimento è il modello di squisiti saggi di versificazione latina di Poliziano, Sannazaro, Valla, Pontano, Alamanni. Ispira Erasmo da Rotterdam, Joachim du Bellay, Clément Marot. Verso la fine del Cinquecento la struttura dell’epigramma di Marziale, dove la parte iniziale prepara la punta finale, contribuisce a formare il gusto per l’arguzia e lo spirito concettoso e metaforico dei poeti barocchi. Lo scrittore spagnolo Gracián (1601-58), che nell’opera Acutezze e arte dell’ingegno fornisce una teorizzazione del gusto concettista, assume il poeta di Bilbilis come il «progenitore dell’aguteza». Nel Settecento l’epigramma è il genere satirico per eccellenza, privilegiato per ogni sorta di battaglia verbale, per le polemiche letterarie, sociali, morali, politiche. Viene teorizzato come genere specifico sia in Francia sia in Italia da Saverio Bettinelli (1718-1808). Annovera fra i suoi innumerevoli cultori nomi illustri come, nella letterature straniere, quelli di Racine, Voltaire, Lessing e Goethe e, nella letteratura italiana, Parini, Alfieri, Monti, Foscolo, Giusti, Carducci. X4 537 538 La lirica nel II secolo La lirica nel II secolo I poetae novelli e il Pervigilium Veneris La ripresa della lirica nel II secolo A LTO IMPERO I poetae novelli Adriano e Floro Al gusto «barocco» della prima età imperiale, influenzato dalle declamationes e incline alla spettacolarità, l’epica e la poesia drammatica erano state più congeniali della lirica. Ma quei generi, legati a tensioni etiche e sociali, finivano per perdere attualità durante l’impero di Traiano e Adriano, quando la nuova felicitas temporum creata dagli optimi principes restringeva i margini della contrapposizione al potere politico, lasciando agli intellettuali aperte due sole vie: quella della celebrazione del presente, seguita da scrittori come Plinio e dalla Nuova Sofistica, e quella di un ripiegamento individuale e privato, che è l’ambito naturale della lirica. Così, soprattutto nel II secolo, alla delega esclusiva del potere fatta al principe e all’apparato burocratico che lo affianca, con conseguente chiusura degli spazi pubblici, corrisponde un accresciuto interesse per la sfera privata, quindi per il genere lirico. Quando ormai non si avevano più testi epici e la poesia drammatica, dopo Seneca e l’Octavia, si avviava all’estinzione, molti personaggi di rilievo si dilettavano di poesia. Si tratta di poesia in tono minore, che, come appare negli scritti di Plinio il Giovane, è considerata nulla più di un passatempo raffinato delle classi elevate: una sosta ricreativa (remissio) nella vita impegnata dagli affari politici e amministrativi. Dei cosiddetti poeti novelli restano alcuni nomi e pochi frammenti. La denominazione di questi versificatori è dovuta al metricista Terenziano Mauro e rinvia da un lato all’elocutio novella teorizzata da Frontone (con tutte le implicazioni di recupero del lessico arcaico e desueto), dall’altro ai poetae novi del I secolo a.C. Ma le due tendenze finiscono per coincidere, in quanto il recupero dei neoterici (Catullo, Cinna, Calvo, Valerio Catone) e preneoterici (Levio) rientrava nel programma dell’arcaismo frontoniano, che questi poeti preferiva ai classici d’età augustea. I novelli rappresentano quindi il pendant, nel genere lirico, delle tendenze arcaiste e neosofistiche. Probabilmente l’aggettivo novelli indica anche la volontà di rinnovare il gusto, come avevano fatto i neòteroi. In che cosa consisterebbe la novitas? Essenzialmente nel riportare la poesia ad un livello più popolare nelle tematiche – scene campestri, feste contadine, vendemmie e consigli per coltivare la vite, paesaggi idillici, giochi d’amore en plen air – e lontano dalla solennità aulica dei generi letterari classici. Ma è una popolarità solo apparentemente spontanea, in realtà riflessa e manierata, perché si tratta di eruditi che non hanno vera esperienza della cultura popolare. Anticipatore dell’esperienza dei novelli è l’imperatore Adriano. Uomo di cultura e poeta di lingua greca e latina (omnium curiositatum explorator, come lo definì Tertulliano), fu egli stesso autore di epigrammi dotti e raffinati sui temi dell’amicizia e della morte. Seguace del nuovo indirizzo arcaistico, preferiva Catone a Cicerone, Ennio a Virgilio, amava leggere autori arcaici. Di lui è famosa la delicata apostrofe alla propria anima, una poesiola di ispirazione anacreontea che riportiamo sotto. Con Adriano va ricordato Floro (per l’opera storica, vedi p. 453). I suoi carmi sono di tono lieve e delicato, vicini alla maniera dei novelli. Sono note in particolare una fresca composizione De rosis e la «polemichetta» con Adriano, un contrasto in dimetri anacreontei, che riportiamo sotto, insieme con la spiritosa risposta dell’imperatore. I poetae novelli e il Pervigilium Veneris Un po’ più giovani di Floro sono i rappresentanti del gruppo dei novelli. Di questi ricordiamo alcuni nomi. Anniano scrisse dei Carmina Falisca e dei Fescennini. Di analoga ispirazione arcaicizzante dovevano essere il poemetto Lupercalia (antica festa campestre in onore del dio Lupercus) di Mariano e i due Libri excellentium «Il libro delle grandi gesta» (storia romana presentata attraverso fatti e personalità esemplari) di Alfio Avito. Settimio Sereno compose carmi pastorali (Opuscula ruralia). Anche Apuleio si cimentò nel genere lirico: restano di lui due epigrammi erotici e il biglietto poetico che accompagnava un dentifricio, citati nella sua Apologia (vedi p. 592). La poetica dei Novi si fonda sul canone della brevitas, sulla compresenza di forme arcaiche, espressioni dialettali e colloquiali, su un lessico non più omogeneo come quello della tradizione classica, ma vario, oscillante tra arcaismi e neologismi. Vi coesistono parole del sermo cotidianus, volgarismi tratti dalla lingua preclassica, neoformazioni ricreate sui termini arcaici secondo le raccomandazioni di Frontone. Un tratto vistoso è l’uso abbondante dei diminutivi per descrivere oggetti ricercati e graziosi, sentimenti delicati, stati d’animo languidi, malinconici, «decadenti». I temi sono, come già s’è accennato, il mondo della natura, i quadri di vita campestre con scene di ispirazione realistica, la celebrazione della vita dell’antica Italia rurale, la storia delle origini riesumata e mitizzata. Spesso la natura è umanizzata, come in questo frammento di Anniano: Uva, uva sum et uva Falerna et ter feror et quater anno. Sono uva, uva Falerna! Mi raccolgono tre, quattro volte l’anno. I versi più intensi riguardano sottili e delicate notazioni psicologiche, malinconiche descrizioni da cui traspare l’inquietudine, il disorientamento, il senso angoscioso della fine che caratterizza la società imperiale. Proprio per questa sensibilità «decadente», per questo sentimento dell’effimero dell’esistenza umana la poesia dei novelli eserciterà un certo influsso su quella cristiana dei secoli seguenti. Sulla fine del II secolo Terenziano Mauro, il coniatore dell’etichetta di poetae novelli, scrisse un trattato metrico in tre parti (De litteris, De syllabis, De metris) sulle soluzioni adottate da questi versificatori. La metrica è infatti il campo nel quale soprattutto essi si cimentano con esiti virtuosistici. Riesumano forme desuete, compongono carmi figurati sull’esempio di quelli d’età alessandrina, escogitano combinazioni lambiccate come i versi echoici in cui l’emistichio iniziale dell’esametro si ripete alla fine del pentametro, i rhopalici ottenuti aggiungendo sempre una sillaba al precedente (così la composizione assume sulla pagina la forma crescente verso il basso di un rhopalum o clava), i versi «reciproci» leggibili dalla prima all’ultima parola e viceversa. Ecco un esempio «reciproco», citato dal grammatico Diomede: I nomi più noti La poetica Temi prevalenti Ann. fr. 1 Büchner La sperimentazione metrica Nereides freta sic verrentes caerula tranant, flamine confidens ut Notus Icarium. Icarium Notus ut confidens flamine tranant, Caerula verrentes sic freta Nereides. Talora sono creati metri nuovi, talora quelli usuali sono applicati in modo incongruo rispetto alla tradizione: ad esempio, il poema di Avito non è nei consueti esametri ma in dimetri giambici, mentre nei suoi carmi agresti Sereno rinuncia ai distici elegiaci. Un aspetto interessante della versificazione dei Novi è anche nella tendenziale coincidenza degli ictus con gli accenti tonici, che denota il carattere d’imitazione popolaresca di questa poesia e annuncia il tramonto della metrica classica. Strette analogie con la poesia dei Novelli rivela il Pervigilium Veneris «La veglia di Il Pervigilium Veneris 539 540 La lirica nel II secolo Venere», un inno in 93 settenari trocaici. Non ne conosciamo l’autore, e neppure il periodo: si oscilla dall’età degli Antonini – questa è la datazione più largamente condivisa dagli studiosi (c’è chi ha proposto l’attribuzione a Floro) – a quella di Odoacre o addirittura di Teodorico. Si tratta di una nitida decrizione di sapore popolare, in realtà assai raffinata, dei festeggiamenti notturni per l’arrivo della primavera a Ibla in Sicilia. L’assegnazione al periodo degli Antonini è giustificata dai caratteri tipici della poesia dei Novelli: l’interesse antiquario per la festività arcaica, lo sfondo agreste e bucolico, la coesistenza di preziosità stilistiche e raffinatezze compositive con tratti tipici della poesia popolare come il tono colloquiale, il ritornello rituale che invita all’amore e alle gioie della vita (cras amet qui numquam amavit, quique amavit cras amet), il metro (settenario trocaico, usato dai comici). I modelli sono il Catullo degli epitalami, per l’insinuante delicata sensualità, e soprattutto Virgilio e Lucrezio. Del proemio primo del De rerum natura il Pervigilium conserva il vitalismo cosmico e la centralità di Venere come potenza fecondatrice della natura. Ma il tono malinconico – comune a tutta la poesia dei novelli – di questa esortazione al piacere e alla vita «ci avverte che la visione pagana sta perdendo consistenza» (Perelli). L’anonimato accresce il valore emblematico del carme, che ci appare come voce di un’epoca più che di un singolo poeta. Lo spaesamento è evidente soprattutto nel finale, nostalgico e inatteso, che introduce il senso della fugacità della vita (ma un tale sentimento era già in Catullo, in Orazio e nei lirici greci): Illa cantat, nos tacemus. Quando L’usignolo canta, noi taciamo. [ver venit meum? [Quando verrà la mia primavera? Quando faciam uti chelidon, ut Quando diventerò come la rondine [tecere desinam? [e cesserò di tacere? Perdidi Musam tacendo nec me Tacendo ho perduto il mio canto e [Phoebus respicit. [Apollo non mi guarda più. A LTO IMPERO Invocazione all’anima. L’odicina composta da Adriano sarebbe un’invocazione all’anima nell’imminenza della morte. Un’interpretazione diffusa ne fa quasi l’emblema della sensibilità «decadente» del tempo, espressione dell’angoscia e del sentimento della fine, che caratterizza la società imperiale. Ma è più probabile che si tratti solo di un pàignion, di un gioco letterario sul modello neoterico: «È uno scherzo grazioso, dove il verso breve, il metro saltellante e l’abbondanza dei diminutivi stemperano nel sentimentalismo arguto e manierato la malinconia del pensiero della morte» (Perelli). La poesiola, tradotta nei secoli in molte lingue e interpretata in vario modo, ha ispirato poeti come T. Stearn Eliot. Animula vagula blandula hospes comesque corporis, quae nunc abibis in loca pallidula rigida nudula? Nec, ut soles, dabis iocos? Hadr. fr. 3 Büchner Animuccia, vaguccia, caruccia, ospite e compagna del corpo, dove andrai a finire, ora? palliduccia, gelata, nuduccia? E non scherzerai più come suoli? (trad. di C. Carena) Anima piccolina, errabonda e delicata, ospite del corpo e sua compagna, ora dove te ne andrai? In una landa nuda, rigida, pallida, né come fai sempre scherzerai. (trad. di A. Soverini) Povera anima mia leggera e dolce, ospite e compagna del corpo, in quali luoghi or te ne andrai smorta, intirizzita spoglia? E non scherzerai come sai tu? (trad. di G. Rosati) I poetae novelli e il Pervigilium Veneris Botta e risposta tra Floro e Adriano. All’amico Floro, che gli aveva rivolto un carme scherzoso, l’imperatore Adriano risponde per le rime. FLORO A ADRIANO Ego nolo Caesar esse, ambulare 〈 per Pelasgos latitare〉 per Britannos, Scythicas pati pruinas. ADRIANO A FLORO Ego nolo Florus esse ambulare per tabernas latitare per popinas culices pati rotundos Non voglio fare come l’imperatore, passeggiare fra i Pelasgi, nascondermi fra i Britanni sopportare il gelo della Scizia. Non voglio fare come Floro, passeggiare per le bettole, nascondermi nelle osterie, sopportare le grosse zanzare. Flor. fr. 1 Büchner Hadr. fr. 1 Büchner Il tema delle rose. A Floro si attribuisce il grazioso e fresco epigramma che riportiamo. Il tema delle rose, cui si sovrappone l’altro antico tema lirico dell’effimero dell’esistenza umana, ritornerà in molti componimenti di epoca tardo imperiale. Anche nel Pervigilium Veneris i vv. 22-26 sono dedicati alle rose: «Son nate dal sangue di Cipride, sono nate dai baci d’Amore,/ da gemme e da vampe di porpora e sole,/ domani il rossore celato al di sotto di un velo di fiamma/ al richiamo dell’unico amore sarà senza vergogna profuso». Venerunt aliquando rosae. Pro veris amoeni Ingenium! Una dies ostendit spicula florum, altera pyramidas nodo maiore tumentes, tertia iam calathos, totum lux quarta peregit floris opus. Pereunt hodie nisi mane leguntur. fr. 87 Riese Sono tornate a fiorire le rose. O vigore dell’amena primavera! Il primo giorno ha mostrato il germoglio dei fiori, il secondo, con un bocciolo maggiore, i gonfi boccioli, il terzo i calici, il quarto giorno compì l’intera opera del fiore. Se non li cogli al mattino, muoiono in una giornata. Il Pervigilium Veneris (vv. 1-26, 59-93). Riportiamo una parte dell’inno in traduzione. Domani è tempo d’amare per chi non conosce l’amore, per chi già conosce l’amore è tempo d’amare domani (ritornello). Primavera giunta appena e già piena di canti primavera! Nasce il mondo in primavera e si stringono gli amori e si uniscono gli uccelli, all’abbraccio delle piogge; scioglie il bosco la sua chioma quando viene primavera. E tra l’ombre degli alberi domani la regina degli amori con la fronda del mirto intreccerà le verdi capanne e Dione1 in alto poggiata sul tronco detterà la sua legge domani. (rit.) Allora il mare dal sangue del cielo in un nugulo di spume tra i branchi azzurri di fiere e cavalli rampanti ha fatto sorgere Dione sull’onda dell’acque marine. (rit.) È lei che l’anno colora di gemme di porpora in fiore, è lei che schiude e che gonfia bocci vividi al soffio di Zefiro, è lei che sparge le umide perle della rugiada lucente che la brezza notturna ha lasciato, e ne brillano lacrime che tremano al peso stillante, ed incerta nel piccolo cerchio 1. Dione è qui epiteto di Venere stessa. 541 542 La lirica nel II secolo è la goccia che ancora non cade. E certo rivela un pudore il rossore dei fiori, e quella rugiada che irrorano nelle notti serene le stelle intenerisce con l’umida coltre i vergini bocci al mattino. È lei che ha voluto al mattino sposar le vergine rose nella rugiada. Son nate dal sangue di Cipride, son nate dai baci d’Amore, da gemme e da vampe da porpora e sole, domani il rossore celato al di sotto di un velo di fiamma al richiamo dell’unico amore sarà senza vergogna profuso. (rit.) ...................................................................................................... Sarà domani il giorno delle prime nozze dell’Etere: per creare l’anno intero con le nubi in primavera il padre s’è in pioggia profuso per amore dentro il grembo della sua feconda sposa, s’è unito al grande suo corpo per nutrirne ogni creatura. Ma dentro le vene e dentro la mente, penetrata con soffio sottile, con i suoi segreti poteri è la dea stessa che guida l’intera generazione. E nel cielo e sulle terre sul mare che a lei obbedisce ha pervaso di flusso seminale le strade aperte al suo regno ed all’ordine suo che fece il mondo capace di dare la vita. (rit.) Fu lei a render Latini i suoi nipoti Troiani, fu lei che diede al figlio la fanciulla di Laurento poi a Marte dal santuario quella vergine pudica, fu lei che volle le nozze dei Romulidi con le Sabine per trarne a Romolo Ramni e Quiriti la sua discendenza e i due Cesari2 eredi tanto il padre che il nipote. (rit.) A LTO IMPERO Nel piacer la campagna è feconda, risenton di Venere i campi, Amore stesso il figlio di Dione è nato, si dice, in campagna; fu lei che tra i solchi in travaglio nel grembo l’accolse e fu lei a nutrirlo di teneri baci di fiori. (rit.) E già sotto le ginestre i tori distendono il fianco ed è ciascuno sicuro in legame d’amor coniugale; ecco all’ombra coi mariti stanno in gregge le belanti. Ha voluto la dea che non tacessero gli uccelli canori, sugli stagni mandano i cigni le fitte voci arrochite; sotto l’ombra del pioppo risponde la sposa di Tereo e diffondere pare col canto emozioni d’amore, non lamento per una sorella oltraggiata dal barbaro sposo. Ella canta, noi taciamo. Quando verrà la mia primavera? Quando sarò come la rondine e smetterò di tacere? Ho perduto la musa tacendo e Febo più non mi guarda. Così Amicle3 silenziosa col silenzio fu perduta. (rit.) (trad. di P. P. Fornaro) 2. Giulio Cesare (padre) ed Ottaviano (nipote) fondatori dell’impero, nato, come Roma stessa, sotto gli auspici di Venere. 3. Città del Peloponneso o, secondo altra tradizione, del Lazio. Per evitare notizie tendenziose una legge vietava di far circolare voci su invasioni nemiche: fu così conquistata una volta quando nessuno dette l’allarme per non violare la legge. I poetae novelli e il Pervigilium Veneris I carmina figurata. L’idea di una poesia-divertissement è evidente nei carmi figurati, il cui modello è da ricercare nella Zampogna (sýringx) di Teocrito: ll carme è un abile, un po’ vacuo esercizio di tipo enigmistico consistente nell’imitare con la struttura grafica (e metrica) del testo la forma della siringa, strumento a fiato formato da una serie di canne di lunghezza decrescente. I carmina figurata di questo tipo erano molto comuni in età ellenistica. Un esempio latino è la «locandina» pompeiana di uno spettacolo pantomimico, che abbiamo riportato a p. 530. Diamo ora un esempio di carme figurato cristiano del IV secolo d.C., realizzato da Ausonio (310-393 d.C.): SA TOR AREP O TE NE T O P E R A1 R O T A S2 1. opera è ablativo: «con fatica». 2. Sottintendi aratri. Come sciogliere l’enigma: «Al centro del quadrato il verbo TENET forma una croce che inizia e termina con una T, ossia con il profilo della croce stessa, attorniata da A e O, l’Alfa e l’Omega attribuite dall’Apocalisse a Cristo. E ancora, le cinque parole, anagrammate, producono due volte le parole PATER NOSTER disposte in croce con centro sulla N e con l’Alfa e l’Omega alle estremità dei bracci … Si approderebbe così all’interpretazione conclusiva: una formula criptica con cui i cristiani celavano e si comunicavano la propria fede in tempo molto duri» (C. Carena). 543 POESIA La poesia nel III secolo: Nemesiano La poesia nel IV secolo: Ausonio Poesia di corte tra IV e V secolo: Claudiano L’inno a Roma di Rutilio Namaziano La lirica cristiana: Commodiano Ambrogio e la nascita dell’innografia liturgica Il maggior poeta cristiano: Prudenzio Francesco Piazzi, HORTUS APERTUS - Autori, testi e percorsi - Copyright © 2010 Cappelli Editore 632 L’ultima poesia pagana L’ultima poesia pagana La poesia nel III secolo: Nemesiano L’imitazione di Virgilio vv. 1-8 Vissuto nella seconda metà III secolo, di nazionalità africana (forse di Cartagine), Marco Aurelio Olimpio Nemesiano è autore di una composizione esametrica dal titolo Cynegètica e di quattro Egloghe. Si ha notizia anche di opere perdute sulla pesca e sulla navigazione. I Cynegètica, di cui restano 325 esametri, rientrano nella tradizione della poesia didascalica risalente alle Georgiche virgiliane. Alla trattazione delle tecniche venatorie e degli strumenti per la caccia (inclusi i cani e i cavalli) si alternano descrizioni raffinate di paesaggi ameni virgiliani, affatto improbabili nel degrado ambientale dell’epoca provocato dai saccheggi e dallo spopolamento delle campagne, dopo le oscure vicende dell’anarchia militare. In realtà l’autore, dedicando l’opera all’imperatore Caro, «trasforma la realtà in crisi in una sorta di paradiso per cacciatori spensierati» (G.F. Giannotti) immaginando un’ideale continuità tra il luminoso passato augusteo e i tempi presenti della restaurazione voluta da Caro e dai figli Carino e Numeriano associati al trono (282-285). Virgilio è, ovviamente, anche il modello pressoché esclusivo delle Egloghe. Qualcuno le ha definite come «pseudocentoni» per la densità delle citazioni del testo del poeta mantovano. Ecco un esempio eloquente: Mentre intrecci, o Titiro, un cesto con giunchi di fiume e nei campi tacciono le roche cicale, intona il canto, che già hai composto, sulla tenue zampogna. Infatti Pan ti insegnò a suonare lo zufolo e Apollo ti ha donato l’ispirazione poetica. Comincia, ora che i capretti brucano i salici e le giovenche le erbe, mentre la rugiada e il mite sole del mattino ti consigliano di affidare il gregge al verde campo. BASSO IMPERO L’idealizzazione arcadica e il travestimento virgiliano del paesaggio ritorneranno nei versi dei poeti del secolo seguente, Ausonio, Claudiano, Rutilio Namaziano. Mosaico con bambini cacciatori. Villa «Erculia», Piazza Armerina. La poesia nel IV secolo: Ausonio La poesia nel IV secolo: Ausonio Decimo Magno Ausonio, nato a Burdigala (Bordeaux) intorno al 310, di ricca famiglia gallica romanizzata, insegnò grammatica e retorica nelle scuole pubbliche della sua città ottenendo larga fama. Valentiniano I gli affidò a Treviri, sede imperiale presso i confini del Reno, l’educazione del figlio Graziano. Rimase vent’anni alla corte imperiale, partecipò alla spedizione militare contro gli Alemanni nel 368, raggiunse i vertici dell’apparato statale: fu nominato comes, quaestor sacri palatii (collaboratore diretto del principe), prefetto d’Italia e Africa (376), prefetto al pretorio delle Gallie e infine, nel 379, console. Dopo l’assassinio di Graziano (383), rientrò a Bordeaux, dove morì nel 395 circa. La vita La produzione poetica, nota col titolo complessivo di Opuscula, è ampia. Gli argomenti delle composizioni, per lo più in distici elegiaci, sono vari: il ricordo dei defunti colleghi della scuola di Bordeaux (Commemoratio professorum Burdigalensium); la celebrazione della Pasqua (Versus Paschales prosodici) che attesta la formale e tiepida conversione dell’autore al Cristianesimo; l’amore, nella raccolta di epigrammi erotici Bissula dedicati alla schiava avuta in dono da Valentiniano; la corrispondenza poetica intrattenuta, nelle Epistole, con personaggi famosi del tempo come Paolino di Nola e Simmaco; episodi di vita quotidiana, spunti autobiografici, affetti familiari nell’Ephemeris («Diario») che descrive la giornata del funzionario imperiale, nei Parentalia (iscrizioni per i parenti defunti, in particolare per la moglie Sabina morta giovanissima), nell’Epicedion in patrem. E ancora, poesie di scherzi e motteggi, di celebrazione di serene cerchie di amici, encomi di personaggi e luoghi. Ci sono opere di scuola, come l’Eclogarum liber, l’Ordo nobilium urbium (elogio di venti celebri città dell’impero), il Ludus septem sapientium in cui ciascuno dei sette sapienti riferisce le proprie massime (in greco, incastonate nel testo latino), gli Epitaphia, iscrizioni sepolcrali fittizie per i caduti della guerra di Troia. Ci sono prove di virtuosismo come il Technopaegnion («Scherzo artistico») fatto di versi tutti terminanti con un monosillabo; il Cento nuptialis, centone (cioè un mosaico di elementi poetici altrui, un pastiche) di versi virgiliani assemblati in modo da ottenere nuovi significati, talora osceni e scabrosi; l’Oratio consulis Ausonii versibus rhopalicis, preghiera in versi ropalici (composti di parole che progressivamente crescono di una sillaba: si cas-tis pre-cibus ve-ni-a-les in-vi-gi-la-mus); il Griphus ternarii numeri («L’enigma del numero tre»), un indovinello denso di reminiscenze pitagoriche. Anche gli Epigrammata, sul modello di Marziale, Catullo e i novelli, rappresentano un esercizio elegante e ingegnoso. L’opera più famosa è la Mosella, componimento in 483 esametri a mezza via tra la satira odeporica (i cui modelli erano Lucilio e Orazio), l’encomio (di luoghi) e l’idillio. Il poemetto descrive il viaggio compiuto dal poeta da Bingen a Treviri, lungo il corso della Mosella. L’opera I due nuclei generatori della poesia di Ausonio sono la scuola e la corte. Alla corte si legano le opere di carattere encomiastico e celebrativo, tra le quali spicca la Gratiarum actio, panegirico di Graziano. L’imperatore, cui il poeta esprime gratitudine per essere stato nominato console, è paragonato ai grandi eroi omerici per regalità, senno e virtù atletiche («Chi più rapido nella corsa? Chi più agile nello svincolarsi nella lotta? Chi in grado di saltare più in alto?» 14, 64). Anche la Mosella, il fiume che attraversa Treviri e su cui si affaccia il palazzo imperiale, ha un intento celebrativo. Dalla corte derivano anche la raffinatezza e l’eleganza espressiva, gli scherzi, i pettegolezzi, le battute di spirito e il tono brillante e disinibito degli epigrammi, che ricordano Marziale: La corte Ti sei fatto una libreria di migliaia di libri, o Filomuso: perciò ti credi un sapiente e un grammatico. E allo stesso modo collezioni corde, plettri, cetre. Il giorno dopo che li avrai pagati, sarai un citaredo. Vorrei avere un’amica facile ai litigi, anche senza motivo, e che non parli come se fosse casta; bella, procace, lesta di mano, che pigli busse e le restituisca e, percossa, si rifugi nei baci. Se non avesse questo carattere, infatti, se fosse casta, modesta, pudica, sarebbe – lo dico con orrore – una moglie. Epigrammata 7 Epigrammata 81; trad. di A. Pastorino 633 634 L’ultima poesia pagana La scuola Il classicismo Dalla corte ormai cristianizzata viene anche l’adesione formale, che non intacca la sostanza pagana della sua visione del mondo, al cristianesimo ormai religione ufficiale dell’impero. Dalla scuola derivano i modelli letterari di Ausonio, il quale nel Protrepticus ad nepotem definisce il canone degli Auctores irrinunciabili per un’adeguata formazione: Omero, Menandro, Terenzio, Virgilio, Orazio, Sallustio. Dalla pratica scolastica derivano gli espedienti formali e i funambolismi tecnici, l’abilità versificatoria dei giochi metrici e il virtuosismo espressivo, i temi leggeri che richiamano l’esperienza dei poeti neoterici filtrata attraverso l’arte dei novelli (vedi p. 538). Il classicismo è il filtro che seleziona i temi, per lo più topici e ampiamente trattati nella poesia tradizionale, di modo che il poeta che li rinnova può contare su un ricco bagaglio di formulazioni collaudate dai poeti precedenti: Virgilio (soprattutto nel Cento nuptialis), Orazio, Catullo (nella Bissula). Ad esempio, i versi con i quali il poeta saluta la Mosella, Salve magne parens frugumque virumque, Mosella!, riecheggiano le Georgiche virgiliane (magna parens frugum Saturnia Tellus, II 173). Il passo che descrive la visione, dopo un percorso tra cupe selve, delle rive della Mosella richiama quello virgiliano dell’arrivo di Enea, attraverso luoghi tenebrosi, ai Campi Elisi: Largior hic campos aether et [lumine vestit purpureo solemque suum, sua [sidera norunt. Qui il cielo più limpido veste di luce viva le pianure: un loro sole e [loro stelle conoscono. Aen. VI 640-64 BASSO IMPERO Una visione serena Lo stile Purior hic campis aer [Phoebusque sereno lumine purpureum reserat iam [sudus Olympum. Qui, in queste pianure più pura è [l’aria e Febo, ormai libero da nuvole, dischiude [con luce serena il purpureo Olimpo. Mosella 12-13 Classici sono i temi prevalenti, come l’amicizia, gli otia letterari, le rive placide popolate di ninfe e satiri, lo splendore delle ville e delle terme, l’orgoglio di appartenere a una civiltà considerata superiore. Classica è la visione equilibrata, idealizzante, serena a dispetto del crollo imminente del mondo pagano. Nelle regioni renane, in cui il contemporaneo Ammiano Marcellino trova solo briganti, Ausonio non vede che luoghi ameni, oasi paradisiache. Egli non pare avere la percezione della fine di un’era. Dei Germani minacciosi ai confini dell’impero vede solo la fresca figurina di Bissula, la Sueba virguncula dagli occhi azzurri e dai capelli biondi donatagli dall’imperatore: «Gioia, carezza, gioco, amore, piacere, barbara, ma che vinci, mia pupilla, tutte le fanciulle del Lazio, o Bissula» (v. 5). Raffinato versificatore, Ausonio è un esempio di classicismo scolastico. Egli eccelle nella capacità di delineare con tratti essenziali paesaggi esteriori, ma anche interiori. In particolare nella Mosella troviamo quadretti di rara incisività: il fiume ricco di pesci (sul modello degli Halieutica di Ovidio), l’amoenitas delle rive, le splendide villae che si specchiano nell’acqua, le divagazioni mitologiche. In particolare sono pregevoli le descrizioni di paesaggi, dove la scelta dell’aggettivazione è in funzione degli effetti cromatici. Nonostante la visione classica, la lingua rivela fenomeni tipici del latino tardo, ad esempio un uso libero delle preposizioni (de con genitivo, ad col dativo, ecc.). La poesia nel IV secolo: Ausonio L’elogio della Mosella (23-72). Riguardo all’incipit di questo passo, abbiamo già ricordato il debito nei confronti di Virgilio. Un secondo modello è rappresentato dalla descrizione delle fonti del Clitunno di Plinio il Giovane (Epist. VIII 8). La specificità stilistica prevalente, consistente nell’aggettivazione, è colta da Von Albrecht: «L’impiego degli aggettivi nella Mosella contribuisce sostanzialmente all’effetto poetico: i contrasti cromatici – verde, rosso, bianco (vv. 69 ss.) – la trasparenza dell’aqua (v. 55) ed i giochi di luce incantano il lettore. Anche l’attenzione per i toni verdi e azzurri del paesaggio corrisponde ad un rafforzato interesse per gli effetti coloristici nei poeti latini tardi». Salve, o fiume esaltato per i tuoi campi, lodato per i tuoi coloni: a te i Belgi son debitori delle mura degne di accogliere le sede imperiale; o fiume i cui colli sono coltivati a vigne dai vini fragranti, o fiume dalle acque verdissime tra rive tenute a pascolo erboso! Navigabile come il mare, le tue onde scorrono in pendio come quelle di un fiume, il tuo fondo cristallino ti rende simile a un lago, per la trepida rapidità della tua corrente puoi eguagliare i ruscelli e, grazie alla limpidezza delle tue acque potabili, sei superiore alle fonti più fresche; tu, da solo, possiedi tutte le qualità di una sorgente, di un ruscello, di un fiume, di un lago e del mare col suo alterno flusso e riflusso di marea. Placide trascorrono le tue acque e non le turba né sibilo di vento né l’urto contro rocce nascoste. Nessun bassofondo, col suo ribollire, rende precipitosa la tua rapida corrente e dal mezzo del tuo letto non emerge alcuna terra che si opponga al tuo fluire e che, dividendo le tue acque con un’isola, ti tolga l’onore del nome di fiume. La sorte ti ha concesso di offrire due vie alle imbarcazioni, l’una quando sono favorite dalla corrente – e allora i remi battono rapidamente le tue acque agitandole –, l’altra quando i marinai rimontano le tue rive e, trainando a rimorchio senza fermarsi la loro imbarcazione, tendono con le spalle le gomene fissate alle antenne; quante volte tu stesso osservi con stupore i riflussi del tuo corso e hai l’impressione che il tuo moto naturale quasi rallenti! Erbe limacciose non ricoprono le tue sponde né, per il tuo pigro fluire, fango sporco si deposita sul lido: si arriva a piedi asciutti fino al limitare delle tue acque. Orsù, dunque, ricopri pure 〈,lettore,〉 i lisci pavimenti con mosaici frigi, stendendo lastre di marmo nelle tue sale con soffitto a cassettoni. Io, per mio conto, disdegno gli splendori che offrono fortuna e ricchezze per contemplare ammirato l’opera della natura, dove non si dispiega il lusso dei dissipatori, i folli eccessi di una povertà che gioisce della propria rovina. Sabbia compatta ricopre qui le umide rive, e i passi che premono su di essa non lasciano tracce d’impronte. Attraverso la tua superficie senza increspature, nella trasparenza della tua profondità, ti si vede, o fiume che non hai alcunché di segreto; e come l’aria benefica si apre con ampia visuale al limpido sguardo e i venti, se son calmi, non pongono limite alla vista nello spazio infinito, allo stesso modo possiamo avere la visione continua di quello che è sommerso lontano e possiamo scoprire il segreto delle tue profondità misteriose quando il tuo corso rallenta e quando il fluire delle tue acque limpide rivela, in un chiarore ceruleo, forme di oggetti sparsi; qui s’increspa la sabbia, solcata da lieve corrente, là, sul fondo verde, oscillano incurvandosi le erbe e, continuamente rimosse dal loro sito natale, sopportano l’urto della corrente, or brilla ora si cela un sassolino, risalta, tra la ghiaia, il muschio verde. È lo stesso quadro che ai Britanni di Caledonia offre la costa quando la bassa marea mette a nudo alghe verdi, coralli rossi, e quelle perle bianche, frutti delle conchiglie, che formano la delizia degli uomini e che, tra i tesori del mare, somigliano a vere collane e ci fan pensare agli ornamenti del nostro lusso. (trad. di A. Pastorino) La Porta Nigra (IV secolo). Treviri. 635 636 L’ultima poesia pagana Poesia di corte tra IV e V secolo: Claudiano Claudiano, nato ad Alessandria d’Egitto nel 370 circa, visse prima a Roma alla corte di Teodosio (395), poi nel 396, in seguito alla spartizione dell’impero tra Arcadio e Onorio, si trasferì a Milano presso quest’ultimo, dove assunse il ruolo di poeta ufficiale. Entrò nelle grazie dell’onnipotente generale vandalo Stilicone, che ai letterati chiedeva un preciso impegno di propaganda politica. Scrittore professionista – in quanto viveva dell’attività poetica – ottenne dal senato l’alto riconoscimento di una statua nel foro di Traiano (nel 404), alla cui base un’epigrafe lo celebrava come poeta praegloriosissimus incarnante «lo spirito di Virgilio e la Musa di Omero». Probabilmente morì giovane prima della morte di Stilicone (408) e del sacco di Roma (410), eventi che difficilmente avrebbe trascurato di ricordare nella sua poesia. Egiziano di madre lingua greca, orientale e occidentale a un tempo, convinto assertore della grandezza di Roma ma anche fedele servitore di un barbaro, convertito al cristianesimo (ma da Agostino considerato a nomine Christi alienus e da Orosio paganus pervicacissimus) e aperto ai culti orientali e misterici, Claudiano rispecchia nella sua stessa persona la complessità storica e culturale del primo decennio di vita dell’impero romano d’Occidente. Testimone attento del proprio tempo, egli, rispetto a Ausonio che ritraeva un mondo sereno e privo di ombre, ebbe forse una più esatta percezione della decadenza del mondo antico, tuttavia aderì con entusiasmo al programma politico di Teodosio e di Stilicone, condividendo l’illusione di una ritrovata stabilità dell’impero di Roma. Opere BASSO IMPERO Giganti colpiti a morte. Piazza Armerina, Villa «Erculia». L’epica mitologica Il panegirico epico Scrisse in greco composizioni varie in esametri e distici elegiaci, oltre a una Gigantomachia successivamente tradotta in latino. In particolare restano sette epigrammi. Tra le opere latine, ricordiamo il Panegirico per i consoli Probino e Olibrio, con cui esordì a Roma nel 395 come poeta di corte, e tre panegirici di elogio dell’imperatore Onorio (in occasione dei ripetuti consolati dell’imperatore). Compose un epitalamio per le nozze della figlia di Onorio con Stilicone, De nuptiis Honorii et Mariae, accompagnato da quattro Fescennina. A Stilicone sono dedicati la Laus Stilichonis (per il consolato del generale vandalo nel 400) e due poemetti epico-encomiastici: il De bello Gildonico (vittoria di Stilicone, in Africa nel 398, sulle truppe del ribelle Gildone che aveva sospeso l’invio di frumento a Roma), e il De bello Gothico o Getico (vittoria di Stilicone, nel 402 a Pollenzo, sui Goti di Alarico). Alla moglie di Stilicone, benefattrice e protettrice del poeta, è dedicata la Laus Serenae; l’elogio della potente signora, lodata come matrona esemplare per fides e pudicitia, indirettamente si estende anche al marito. Restano due poemetti mitologici, la Gigantomachia e il De raptu Proserpinae (incompiuto, in tre libri) che, per la tematica infernale e la rilevanza accordata a elementi della tradizione orfica, ha fatto supporre un’ispirazione misterica. Ci sono infine componimenti d’occasione dedicati a personalità eminenti del tempo, epigrammi, idilli, invettive (In Rufinum e In Eutropium, due ministri dell’imperatore d’Oriente Arcadio, nemici di Stilicone) e un De Salvatore, inno a Cristo scritto per compiacere a Onorio e Stilicone, che erano cristiani. È difficile non leggere la Gigantomachia in una prospettiva, se non proprio allegorica, almeno di forte rispecchiamento nei confronti del frangente storico. La vicenda mitologica dei Giganti che assaltano l’Olimpo pare adombrare lo scontro, ugualmente titanico, tra l’impero e le popolazioni barbariche, tra la gloriosa civiltà di Roma e la non-civiltà delle genti non romanizzate. Il mito era già presente nell’opera giovanile scritta in greco: «L’ossessiva presenza di questo racconto mitico lascia intendere le dimensioni cosmiche che il drammatico scontro di civiltà assume agli occhi di Claudiano» (Pennaccini). I poemetti storici celebrano i potenti della corte. Il legame stretto con la contemporaneità si lega all’intento celebrativo e segna la distanza rispetto all’epica di Virgilio, Poesia di corte tra IV e V secolo: Claudiano Ovidio, Stazio, Lucano. Si tratta di panegirici epici, cioè di opere che sul registro dell’epos innestano i toni della tradizione panegiristica. La peculiarità sta, oltre che nella brevità della composizione, nel coniugare i procedimenti formali elaborati dalla retorica greca per il panegirico in prosa con temi, motivi, stilemi dell’epica. Un modello latino era il panegirico di Plinio a Traiano. Nei poemi De bello Gildonico e De bello Gothico (o Getico) è, ovviamente, centrale la figura di Stilicone, nel quale rivive la grandezza immortale di Roma. Egli è considerato il vero erede dei grandi condottieri romani, che assomma le virtù di Scipione e di Annibale; di questo, quale appare nel ritratto di Livio, ha le doti di resistenza fisica (capacità di esporsi al freddo, alla fame, alla fatica). Austero e morigerato come i generali romani (moderato nel mangiare, quasi astemio, dorme in un povero giaciglio), egli rivela una solitaria grandezza epica che lo contrappone all’ignavia e allo scoramento dei più: «Mentre tutti erano presi dalla disperazione, solo Stilicone, fattosi augure, prometteva un esito felice con l’aiuto della sua spada. In quel frangente egli fu guida e oracolo per coloro che disperavano della salvezza» (Bell. Goth. 265-269). Una peculiarità dell’arte di Claudiano è la commistione dei generi. Da un lato egli presenta la realtà nella veste dei grandi modelli epici greci e latini, dall’altro innesta nell’epica i precetti della retorica encomiastica e panegiristica. Dal ricco bagaglio di forme e temi dell’epos trasceglie gli elementi più confacenti all’intento celebrativo, come il topos omerico dell’impossibilità di esprimere adeguatamente le virtù di un eroe: «Se anche la mia bocca si aprisse con cento voci, e Febo molteplice mi scorresse per cento petti, non riuscirei a narrare le imprese di Probo» (Paneg. Prob. Olybr. 395). Caratterizzano lo stile la purezza del verso ricalcato sui classici, il nitore delle immagini rese in un latino appreso solo sui libri, la precisione pittorica dei quadri descrittivi, l’attenzione al particolare prezioso, come la goccia d’acqua inclusa in un cristallo. Nel De raptu Proserpinae, le ekphràseis contenenti la descrizione della veste di Proserpina e la fioritura della campagna di Enna sono autentici pezzi di bravura. Il limite dell’arte di Claudiano è nella letterarietà, che degenera facilmente in artificiosità ed eleganza stucchevole. Abbondano le immagini enfatiche e barocche, tipiche della poesia del IV secolo. A rendere freddi e manierati i versi di Claudiano concorre la presenza massiccia della retorica. Ricorrono, come s’è detto, tutti i luoghi e i procedimenti dell’encomio, ad esempio la synkrisis, confronto con un eroe del mito o con un grande del passato puntualmente superati in virtù dal celebrato (così Onorio è superiore ad Achille). Abbondano le espressioni enfatiche ed eccessive, in particolare nelle invettive, che sono poi il rovescio dell’encomio. L’enumerazione di eventi mostruosi, che non sono più tali dopo la nomina a console di Eutropio, enfatizza l’abiezione dell’odiato eunuco: La figura di Stilicone Lo stile La componente retorica Il mondo non prova più stupore nel vedere figli mostruosi, metà uomini e metà animali … pecore che si mettono a parlare dinnanzi al pastore allibito, terribili tempeste di pietra, nubi insanguinate nel cielo minaccioso, due lune muoversi in cielo e due soli: tutte le mostruosità non sono più tali, da quando è diventato console un eunuco. In Eutropium 1, 1-8 Alla perizia descrittiva corrisponde lo scarso interesse per la narrazione, che procede pigramente, senza ritmo, indugiando sui momenti statici, sui numerosi discorsi (talora pronunciati da personificazioni di elementi naturali o concetti astratti), sul- L’esilità narrativa 637 638 L’ultima poesia pagana L’epos La fortuna le pitture di ambienti e personaggi, primo tra tutti Stilicone che nel De bello Getico è reso efficacemente con pochi tratti rapidi e incisivi (vedi sotto). Anche nei poemi manca un intreccio, la trama narrativa è esile a vantaggio della componente encomiastica. Le vicende belliche non sono raccontate, ma accennate o date per note. Dunque, l’adesione all’epica non implica la presenza del tratto fondamentale di questo genere, la narrazione, ma consiste nell’adozione di ingredienti topici (i concili degli dei, le battaglie, ecc.), di formule e schemi espressivi, di grandiose figurazioni mitologiche. Al registro epico-tragico, solenne e magniloquente, si conformano gli spazi smisurati che fanno da sfondo agli eventi, gli slanci titanici, le grandiose figurazioni mitologiche funzionali alla resa del tema della lotta tra il bene (l’autorità imperiale) e il male (i nemici interni ed esterni di Roma). Questa polarità genera le coppie oppositive luce tenebre, divinità infere e celesti. Del successo decretato dai contemporanei già s’è detto. Aggiungiamo che la poesia di Claudiano è un modello di stile neoclassico per i poeti cristiani del V e VI secolo. Imitato da Poliziano nelle Stanze per la giostra, da Marino che fa pronunciare a Claudiano un singolare autoelogio, è apprezzato anche da scrittori dell’Ottocento come Coleridge, che lo definisce il «il primo dei moderni», e Huysmans, che lo elogia nel suo À rebours. Il ritratto di Stilicone (De bello Getico 340-356). Contaminazione del ritratto di Annibale di Livio XXI 4-5 con la descrizione del passaggio delle Alpi di Livio XXI 36, questo profilo del generale vandalo Stilicone è abbozzato con efficacia descrittiva, sullo sfondo di un nevoso paesaggio montano. Il fianco, per il quale la Rezia si unisce all’Italia, con gioghi precipiti tocca le stelle e d’estate apre a stento un orrendo passaggio. Si congelarono molti come all’apparire della Gòrgone, le altissime nevi altri ingoiarono nell’enorme massa. Spesso carri e buoi precipitano e scompaiono nel candido baratro. Talora quando slittano i ghiacci, il monte trascina frane improvvise e nella mite stagione scalza il terreno che male si appoggia al ripido suolo. Per tali regioni Stilicone si affretta al colmo del freddo. Non un bicchiere di vino; scarso pane; egli, pago di assaggiare in armi un cibo affrettato, gravato da un intriso mantello, incita il cavallo intirizzito. Mai un morbido giaciglio lo accoglie stanco, e se le tenebre della cieca notte arrestano il cammino, si ripara in tane di belve o si distende sotto un tetto di pastori, ponendo il capo sullo scudo. BASSO IMPERO (trad. di F. Serpa) L’arrivo della primavera (II 88 ss.). La vicenda del De raptu Proserpinae è la stessa narrata da Ovidio nel V libro delle Metamorfosi. A Plutone, che chiede a Giove una sposa, il padre degli dei indica Proserpina, figlia di Cerere. Mentre la fanciulla sta cogliendo fiori in un prato ameno, Plutone emerge dalle profondità sotterranee e la trascina agli Inferi. Cerere, non trovando la figlia, si abbandona a una disperata ricerca. A questo punto rimane interrotto il poemetto, che doveva concludersi con l’accordo tra Giove e Cerere: in cambio del dono dell’agricoltura fatto agli uomini, la dea avrebbe potuto riavere la figlia per una parte dell’anno. Le implicazioni ctonie e misteriche del mito hanno fatto supporre che Claudiano aderisse a culti misteriosofici d’impronta orfica e neoplatonica. Il passo qui proposto, che descrive l’arrivo della primavera nei luoghi attorno a Enna, è un esempio della maestria descrittiva dell’autore. Così dice1 e quello2 scuote le penne grondanti nettare novello e impregna le zolle di feconda rugiada; per dove egli passa, al suo volo s’accendono i colori della primavera. Tutta la terra effonde erbe dal turgido seno, serena si stende la volta del cielo; purpurea veste e splendida egli conferisce alle rose, di nero tinge i glicini, d’un bel turchino le viole. Quali cinture partiche, destinate a cingere fianchi regali, sono tempestate di gemme sì fulgide e varie? Quali velli prendono sì vivo colore dalle pregiate spume del vaso sirio? Né l’uccello sacro a Giunone dispiega ali così variopinte, né l’incipiente tempesta s’incorona d’un arcobaleno che cambi così innumerevoli colori, quando in mezzo alle nubi, separandole con una linea ricurva, s’apre un varco splendente tra la pioggia. La 1. Il soggetto è Enna, la madre dei fiori. 2. È il dio Zefiro. Poesia di corte tra IV e V secolo: Claudiano bellezza del luogo è superiore a quella dei fiori: la pianura, incurvatasi a mo’ di tenue gibba ed elevandosi con molle declivio, va crescendo sino a formare un colle. Le fonti, scaturendo dalla roccia viva, lambiscono l’erbe irrorandole coi mobili rivi, e la selva, temperando la bruciante calura con la fresca ombra dei suoi rami, rivendica a sé le brume nel mezzo della canicola: l’abete atto alla fabbricazione delle navi, il corniolo a quella delle armi, la quercia cara a Giove, il cipresso che ombreggia i sepolcri, l’elce che ospita i favi, l’alloro che predice il futuro. Qui il bosso scuote la sua folta chioma, l’edera serpeggia e i pampini rivestono gli olmi. Non lungi si stende un laghetto – Pergusa lo chiamano i Sicani –, sulle cui rive cresce frondosa una selva, che rende oscure le acque vicine alla sponda, mentre quelle lontane non solo lasciano penetrare gli sguardi, ma sono tanto trasparenti che, lungi dall’ostacolare la vista, l’attraggono sotto la limpida corrente, svelando i più riposti segreti dello scrutabile fondo. (trad. di V. Paladini) Dittico di Stilicone (400 circa). Monza, Tesoro della cattedrale. 639 640 L’ultima poesia pagana L’inno a Roma di Rutilio Namaziano La fine di un mondo Contro Cristiani, Ebrei, Germani BASSO IMPERO La poesia dell’esilio Di origine gallica, forse di Tolosa, Rutilio Namaziano ricoprì cariche importanti nell’amministrazione (fu prefetto di Roma nel 414). Rientrò in Gallia nell’autunno 417 (o nel 415) a causa di notizie inquietanti riguardo ai suoi possedimenti, attraversati dai Visigoti. Scrisse il De reditu suo, «Il proprio ritorno», in distici elegiaci, giuntoci incompleto. Il poema, di cui ignoriamo il titolo originale (De reditu suo o anche Reditus ab urbe Roma ad Gallias sono stati inseriti dagli editori), appartiene al genere odeporico nel quale si erano cimentati Lucilio (Iter Siculum), Orazio (Itinerarium Brundisinum), Ovidio nel resoconto del viaggi a Tomi, Stazio (Propemptikón), Ausonio (Mosella). Vi si narra il viaggio di ritorno in Gallia, per mare lungo le coste del Lazio e della Toscana fino a Luni, dove il racconto s’interrompe. Un frammento aggiunge il tratto di itinerario fino ad Albenga. All’interno della cornice narrativa del diario di viaggio, si collocano descrizioni di luoghi, riflessioni sulla situazione politica e sociale del tempo, racconti di miti, invettive contro i presunti responsabili del crollo di Roma. La poesia di Namaziano esprime il senso di un mondo che volge alla fine. Il confronto con Ausonio è rivelatore: ai paesaggi idilliaci della Mosella subentra una natura ferita e desolata, che predice il disastro imminente. Di fronte alla caduta inesorabile, il solo rifugio è nel passato glorioso vagheggiato acriticamente, celebrato con nostalgia in una «poesia della storia di Roma» di tono virgiliano. Nei versi di Rutilio risuona l’elogio incondizionato di Roma portatrice di civiltà e unificatrice del molteplice (fecisti patriam diversis gentibus unam, urbem fecisti quod prius orbis erat). L’inno di commossa esaltazione assume un tono sinistro nell’imminenza della catastrofe, sullo sfondo di paesaggi desolati, città in declino, templi abbandonati, rovine, devastazioni. I responsabili di questa desolazione sono, secondo l’autore, i Cristiani e gli Ebrei, considerati corrotti e avari, causa della disgregazione del mondo antico. In particolare i monaci – «odiatori della luce» e «setta peggiore dei veleni di Circe» (I 438 e 515) – sono giudicati rei di disinteressarsi, nel loro egoistico isolamento, della società civile. Anche Stilicone ha concorso al crollo, in quanto ha tradito Roma svendendola ai Germani. Con questa accusa Rutilio condivide la posizione della letteratura favorevole a Onorio, che aveva deciso di sbarazzarsi del potente generale vandalo, accusandolo di connivenza con la sacrilega gens dei Goti di Alarico. Nondimeno, in uno scatto di ottimismo irrazionale, Namaziano prevede che Roma sopravviverà. Alla città «regina del mondo, madre degli uomini e degli dei» (I 4749) non può applicarsi la legge che vige per le altre città («vediamo dagli esempi che le città possono morire», I 44). Per Roma vale la legge della rinascita (ordo renascendi) che consiste nel prendere vigore dalle proprie stesse sventure. Ma il poeta sa che non gli toccherà di constatare di persona questa resurrezione, e forse intimamente nutre qualche dubbio che essa possa mai avvenire. Di qui il tono malinconico di questo «ritorno», che è un viaggio verso l’esilio, come provano le continue allusioni alla poesia ovidiana dell’esilio e l’adozione del distico elegiaco, scelto proprio in vista di «un allineamento della propria vicenda biografica con quel lontano dolore … Rutilio si specchia su Ovidio, le cui vicende esistenziali e letterarie si pongono come archetipo e punto di riferimento sentimentale» (A. Fo). L’inno a Roma di Rutilio Namaziano L’inno a Roma (I 47-66). Riportiamo un brano del commosso inno a Roma, ricco di reminiscenze della poesia di Virgilio, Stazio, Ovidio. «Ascoltami», regina bellissima del mondo ormai tuo, Roma assunta fra gli astri celesti! «Ascoltami», madre degli uomini, madre degli dèi: per i tuoi templi ci accostiamo al cielo. Te cantiamo e sempre canteremo, finché i fati vorranno; nessuno, finché vive, può dimenticarti. Coprano il sole criminosi oblii, prima che si spenga la tua gloria nel nostro cuore. Ché tu offri doni uguali ai raggi del sole, dovunque muova i flutti l’Oceano che ci circonda. Per te ruota anche Febo che tutto abbraccia e i cavalli, levatisi dalle tue terre, in terre tue nasconde. Te non ha fermato l’Africa con le sue sabbie infuocate, né ha respinto l’Orsa armata del suo gelo: quanto la zona abitata si stende verso i poli, tanto la terra s’apre alle tue conquiste. Delle diverse genti unica patria hai fatto; un bene è stato, pei popoli senza legge, il tuo dominio. E, offrendo ai vinti d’unirsi nel tuo diritto, tu del mondo hai fatto l’Urbe. (trad. di E. Castorina) 641 642 La lirica cristiana La lirica cristiana Commodiano Le Instructiones Il Carmen apologeticum BASSO IMPERO Lingua e metrica Del primo apologista e unico poeta cristiano di lingua latina, Commodiano, non conosciamo né la data né il luogo di nascita. Si tende a collocarlo nella seconda metà del III secolo al tempo delle persecuzioni di Decio e Valeriano, ma c’è anche chi lo pone nel V secolo. Si suppone un’origine africana o palestinese. Di lui conserviamo le Instructiones, «Istruzioni cristiane», e il Carmen apologeticum contra Iudaeos et Graecos, «Carme apologetico contro Giudei e Greci» (il titolo non è originale). Le Instructiones sono una raccolta di 80 componimenti esametrici acrostici (le iniziali di verso formano in verticale una parola) in due libri: il primo lancia invettive contro pagani e giudei, il secondo fornisce insegnamenti morali per i cristiani, in toni apocalittici e millenaristici (il millenarismo predica l’avvento di un regno di Dio sulla terra e corrisponde alle attese dei diseredati, che preferiscono un concreto miglioramento di questa vita alle promesse del Paradiso). Il Carmen apologeticum è un poema di 1059 esametri che tratta la storia del mondo, dall’Antico Testamento all’impero di Roma, fino all’apocalisse e al giudizio universale. La dottrina cristiana è opposta con forza al paganesimo e al giudaismo. Gli argomenti sono quelli comuni agli apologisti: disprezzo verso la cultura pagana e le morenti istituzioni classiche, intransigente rigorismo morale, la fede nel prossimo avvento del regno di Dio, la vita terrena come dura milizia al servizio di Cristo. L’ultima parte dell’opera svolge il tema escatologico della fine del mondo. Modesta appare la cultura teologica dell’autore, che sostiene tesi grossolane e singolari, come quella secondo cui gli dei pagani sono nati dal congiungimento degli angeli con donne mortali. La lingua non è quella della tradizione classica ma rivela – nella sintassi semplificata e nel lessico povero, ripetitivo, denso di barbarismi e solecismi – i tratti del sermo humilis, in sintonia con la dimensione popolare della cultura cristiana dei primi secoli. A un orizzonte popolaresco ci riportano anche le forme della polemica, condotta con esigua strumentazione retorica, attraverso argomentazioni scontate e poco cogenti, col frequente ricorso a improperi volgari e pesanti. La metrica, ormai insensibile alla quantità delle sillabe, tende a fare coincidere gli ictus con gli accenti tonici delle parole, anticipando il carattere accentuativo, e non più quantitativo, della versificazione romanza. La fine del mondo (Carmen apologeticum, 1007 ss.). Soprattutto nelle descrizioni apocalittiche, come questa che proponiamo, Commodiano rivela «energia primitiva» e capacità di costruire quadri dotati di singolare forza icastica. Allora uno dopo l’altro i fulmini sono scagliati dagli astri, una tempesta di fuoco infuria, riservata da tanti anni, rugge la pestifera strage, trema la terra sconvolta. Né dove trovare riparo sa tutta la gente umana. Commodiano Le stelle del cielo cadono, sono giudicati gli astri con noi. … Rapito sarà il cielo nell’ombra da subita forza di morte, in parte la terra tremando allenta tutti i sostegni, in parte i tuoni disrompono solide mura, e sono sconvolti i muri come polvere all’aure. Volano i sassi, dai venti sono spogliati i tetti delle case. … Saranno abbattuti anche i tumuli, sorgeranno i corpi dei giusti, che le nubi rapiscono e portano al cospetto di Dio. (trad. di Q. Cataudella) L’Impero, miniatura dal De civitate Dei di Agostino. Manoscritto del XIV secolo. Parigi, Bibliothèque Nationale. 643 644 La lirica cristiana Ambrogio e la nascita dell’innografia liturgica Aurelio Ambrogio nacque a Treviri, forse nel 334, da una famiglia di nobili origini. Fu governatore a Milano, dove poi fu acclamato vescovo (373) da ariani e ortodossi, quando, pur vicino al cattolicesimo, non era ancora battezzato. Tale scelta era motivata dall’aspettativa di una sua posizione neutrale. In realtà Ambrogio esplicò la sua attività pastorale in direzione antiariana. Combatté strenuamente anche il paganesimo e in tal senso poté influire sulla legislazione religiosa e sull’azione politica degli imperatori Graziano e Teodosio. Morì il 4 aprile 397. Le opere Le Sacre Scritture ispirano le omelie che, rielaborate per la pubblicazione, trattano e commentano libri e passi della Bibbia (Exameron, Enarrationes in XII Psalmos Davidicos, Expositio Evangeli secundum Lucam). Rilevante è la presenza biblica anche nelle opere di carattere morale-ascetico (De bono mortis, De fuga saeculi, De officiis ministrorum, De virginitate ecc.) e dogmatico (De fide, De Spiritu Sancto, De mysteriis, De sacramentis). Ambrogio è importante anche per aver dato vita all’innologia liturgica cristiana. Tra i tanti Inni a lui attribuiti, solo cinque sono certamente autentici: Aeterne rerum conditor, Deus creator omnium, Iam surgit hora tertia, Veni redemptor gentium, Intende qui regis Israel. Il metro è il dimetro giambico, la struttura prevalente è quella di otto strofe di quattro versi ciascuna. Anche se apparentemente la metrica è quantitativa, spesso l’accento ritmico coincide con quello tonico. L’inventore dell’innodia cristiana Creatore dell’innodia latina cristiana, Ambrogio introdusse l’antifonia, cioè il canto a cori alterni dei Salmi. La composizione degli inni nasceva dall’intento di motivare i fedeli alla preghiera. Narra Paolino da Milano che Ambrogio, perseguitato dall’imperatrice ariana Giustina, occupò nel 385 con un gruppo di fedeli la basilica Porziana, per impedire che fosse destinata al culto ariano e qui rimase asserragliato per molti giorni. Durante questo periodo compose vari inni sulla Trinità – oggetto della contesa con gli ariani – per rafforzare la fede degli occupanti e alleviare la loro noia. Il gradimento per queste composizioni fu tale, che il vescovo fu accusato dagli avversari di avere sedotto e ingannato il popolo col canto. In seguito gli inni ambrosiani entrano nell’ordinaria liturgia cristiana. Le circostanze della nascita dell’innografia liturgica sono rievocate anche da Agostino. BASSO IMPERO Confess. IX 7, 15; trad. di C. Carena Era passato un anno da quando Giustina, madre del giovane imperatore Valentiniano aveva cominciato a perseguitare Ambrogio, istigata dall’eresia degli ariani. Vigilava la folla dei fedeli ogni notte in chiesa, pronta a morire con il vescovo … Fu allora che s’incominciò a cantare inni e salmi secondo l’uso delle regioni orientali, per evitare che il popolo deperisse nella noia e nella mestizia, innovazione che fu conservata da allora a tutt’oggi e imitata da molti, anzi ormai da quasi tutti i greggi dei tuoi fedeli nelle altre parti dell’orbe. Hymnus matutinus. L’inno, destinato alla recitazione mattutina, svolge il tema della notte che lascia il posto al nuovo giorno. È il momento in cui si dissipano le tenebre, luogo metaforico del peccato. Il gallo, quasi allegoria di Cristo, col suo canto annuncia la fine del buio e riporta il dominio della luce sulla terra. L’invocazione a Gesù si condensa negli ultimi otto versi. L’inno si compone di quartine con versi costituiti da rapidi metri giambici acatalettici. Aeterne rerum conditor noctem diemque qui regis et temporum das tempora1, ut alleves fastidium; 1. temporum … tempora: richiama il biblico saecula saeculorum. Eterno creatore di tutte le cose, che governi il giorno e la notte, fai seguire le ore alle ore, allevi la nostra stanchezza, Ambrogio e la nascita dell’innografia liturgica praeco diei2 iam sonat, noctis profundae pervigil, nocturna lux viantibus, a nocte noctem segregans. Hoc excitatus3 Lucifer solvit polum caligine, hoc omnis erronum chorus viam nocendi deserit. Hoc nauta vires colligit pontique mitescunt freta, hoc ipsa petra ecclesiae4 canente culpam diluit. Surgamus ergo strenue, gallus iacentes excitat, et somnolentos increpat, gallus negantes5 arguit. Gallo canente spes redit, aegris salus refunditur, mucro latronis conditur, lapsis fides revertitur. Iesu, labantes respice et nos videndo corrige; si respicis, lapsus cadunt fletuque culpa solvitur. Tu lux refulge sensibus mentisque somnum discute, te nostra vox primum sonet, et ora solvamus tibi. 5 10 15 20 25 già canta l’araldo del giorno, sentinella della notte profonda, luce notturna per i viandanti, che interrompe la notte. Da lui incitato, Lucifero libera il cielo dalle tenebre, ogni banda di vagabondi abbandona la via del male. Al suo canto, il marinaio raccoglie le forze, si placano le onde del mare, al suo canto l’apostolo Pietro si avvide della propria colpa. Alziamoci allora con slancio, il gallo sveglia chi dorme, rimprovera i dormiglioni, il gallo rimbrotta quelli che rinnegano Dio. Al canto del gallo ritorna la speranza, ai malati ritorna il vigore, il bandito nasconde la spada, ai peccatori si riaccende la fede. O Gesù assisti chi sbaglia, e guardandoci correggici. Se volgi il tuo sguardo, i peccati vengono meno e col pianto la colpa si cancella. Tu, luce, risplendi ai nostri sensi e dissipa il sonno della mente, la nostra voce chiami te per primo e apriamo la nostra bocca per invocarti. 30 2. praeco diei: è il gallo che annuncia la nascita del nuovo giorno. 3. Hoc excitatus: il gallo incita Lucifero (il pianeta Venere) a liberare il cielo (polum) dalle tenebre. 4. petra ecclesiae: la «pietra» è Pietro il quale, come narrano i Vangeli, al terzo canto del gallo si avvide del tradimento commesso quando aveva rinnegato Cristo. 5. negantes: allusione all’episodio di Pietro e, in generale, agli apostati. Sant’Ambrogio. Milano, Basilica di Sant’Ambrogio. 645 646 La lirica cristiana Il maggiore poeta cristiano: Prudenzio BASSO IMPERO Aulo Prudenzio Clemente nasce in Spagna (a Calahorra, la città di Quintiliano) nel 348 circa, da famiglia cristiana. Dopo una vita pubblica spesa nell’avvocatura e nell’amministrazione imperiale al servizio di Teodosio, a cinquantasette anni, deposta ogni stoltezza mondana, volle offrire a Dio il dono della propria poesia: «Ormai prossima al traguardo, l’anima mia peccatrice, abbandoni ogni insensatezza, celebri almeno Dio con i suoi canti, dato che non può farlo con i suoi meriti» (Praef. 34 ss.). Le ultime notizie su di lui risalgono al 405: probabilmente muore prima del sacco di Roma (410). Opere I 45 coriambi della Praefatio, scritta nel 405, introducono l’intera opera, che può idealmente considerarsi tripartita in inni, poesie didascaliche, un poemetto apologetico. Il Cathemèrinon raccoglie 12 inni polimetri. Il Peristephanon («Le corone») comprende 14 inni polimetri, che celebrano martiri cristiani famosi. L’Apotheòsis, in esametri, svolge il mistero della Trinità, confutando le tesi eretiche dualistiche dei patripassiani e dei manichei. L’Hamartigenìa tratta del problema del male e della sua origine, dei vari tipi di peccato, delle manifestazioni del male nella terra (uragani, inondazioni, piante e animali dannosi), della libertà morale dell’uomo e della sua responsabilità di fronte agli assalti del demonio. Particolarmente vivace è la sezione contro la sfrenatezza delle donne. La Psychomàchia descrive, in 915 esametri, la battaglia epico-allegorica ingaggiata dalle Virtù contro i Vizi per il possesso dell’anima. Il Dittochaeon, serie di 48 quartine in esametri su episodi dell’Antico e Nuovo Testamento: i due libri che costituiscono il «doppio nutrimento» a cui allude il titolo (ma questa interpretazione è controversa). È probabile che le composizioni fossero didascalie di quadri raffiguranti gli episodi corrispondenti o un suggerimento per scene da realizzare pittoricamente. Nel poema apologetico Contra Symmachum, l’autore prende partito sulla questione, sorta una ventina d’anni prima tra Ambrogio e Simmaco, dell’altare della Vittoria in senato, smantellato dai cristiani contro il volere dei pagani. La disputa fornisce l’occasione per una fiera requisitoria contro la religione pagana (superstitio veterum) ormai debellata da Teodosio, elogiato nella prefazione del poema. I 34 versi ipponattei dell’Epilogus chiudono il complesso dell’opera. Il Cathemèrinon Il Cathemèrinon liber («Libro degli inni del giorno») contiene 12 inni polimetri. I primi sei scandiscono le ore della giornata del cristiano (canto del gallo, mattino, prima e dopo pranzo, accensione delle lampade, prima del sonno); gli altri celebrano le grandi festività (Natale, Epifania) e altri momenti di rilevanza religiosa (inni per il digiuno, per i defunti). La struttura dei componimenti è fissa e tripartita: invocazione (o allegoria), digressione narrativa su temi biblici, preghiera. L’influsso di Ambrogio è evidente, anche se, diversamente dagli inni del vescovo di Milano, quelli di Prudenzio non hanno prevalente destinazione liturgica, ma piuttosto ambiscono a fondare una lirica cristiana all’altezza della tradizione poetica pagana. Dai grandi lirici latini e greci sono tratti gli elementi stilistico-formali, mentre i contenuti biblici sostituiscono il mito classico. Nel III inno (ante cibum) sono esposte le linee di questa poetica cristiana: Cathem. 3, 25-35 Il Peristephanon Sdegna, o Camena, le edere leggere di cui sei solita cingere le tempie; impara a tessere ghirlande mistiche e circonda di un diadema dattilico le chiome, coronandole con le lodi di Dio. Qual più generoso ossequio può rendere a Dio un’anima generosa, originaria del cielo e della luce, se non cantare i doni ricevuti lodando con ritmi melodiosi il Creatore? Il Peristephanon («Le corone») raccoglie 14 inni polimetri, che celebrano martiri cristiani famosi, per lo più spagnoli e italici: i diciotto martiri di Saragozza, Eulalia, Cipriano, Lorenzo, Agnese, gli apostoli Pietro e Paolo e altri. Il maggiore poeta cristiano: Prudenzio Il titolo fa riferimento alla corona (stephanos) che il martire ha meritato in quanto ha riportato la vittoria sulle forze del male. La ripetitività dello schema narrativo anticipa la letteratura agiografica: interrogatorio (spesso retoricamente dilatato), martirio, miracoli, ascesa dell’anima in cielo. La Psichomàchia («Battaglia per l’anima») è un poemetto epico-allegorico sulla battaglia ingaggiata dalle Virtù contro i Vizi (la Fede contro l’Idolatria, La Pudicizia contro la Lussuria, ecc.) per il possesso dell’anima. I duelli tra le personificazioni – più raccapriccianti di quelli dell’epica classica (l’Umiltà decapita la Superbia, la Pudicizia sgozza la Lussuria, la Fede soffoca l’Idolatria) – avvengono in base al codice dell’epica omerica e virgiliana e fondano la nuova epopea cristiana da contrapporre all’Eneide. Di qui la fortuna dell’opera che divenne l’archetipo di molta letteratura allegorica medioevale (Boezio, Ildegarda di Bingen) e ispirò anche le arti figurative del Medioevo e del Rinascimento. È evidente l’intenzione di competere con i classici, coi quali l’autore instaura un rapporto di tipo agonistico, basato sull’aemulatio e sorretto dalla certezza di risultare, con l’aiuto di Dio, superiore ai modelli. Definito da Bentley «il Virgilio e l’Orazio dei Cristiani», Prudenzio rivaleggia con Orazio lirico e satirico, che imita nella complessità e varietà della metrica, nelle espressioni, nelle immagini. Virgilio è riecheggiato esplicitamente, come in Hamart. 330, Felix, qui indultis potuit mediocriter uti che riprende il celebre incipit di Georg. II 458. I fantasmi dell’inferno dell’Eneide tornano nella Psychomachia; l’età aurea e l’Arcadia delle Bucoliche rivivono nella visione del Paradiso perduto del Cathemèrinon; dalle Georgiche deriva la tecnica consistente nell’incastonare un epillio sulla trama didascalica. Altri modelli sono Lucrezio (di cui utilizza le argomentazioni contro la religio per confutare le eresie e il paganesimo), Catullo, Ovidio, ma anche la poesia eccessiva e baroccheggiante di Seneca e Lucano. Il classicismo dell’autore è confermato anche dal suo patriottismo romano, che coesiste con lo spirito cristiano. Come il pagano Claudiano, il cristiano Prudenzio si sente parte integrante dell’impero. Nel Peristephanon San Lorenzo, prima di morire nell’atroce supplizio della graticola, ringrazia Dio che ha voluto porre «lo scettro di Roma ai vertici del mondo» e benedice la città che ha saputo unificare i popoli nel segno di Cristo ed è un baluardo contro l’incombente barbarie: «Ma fra il mondo romano e quello barbaro corre la medesima distanza che separa il bipede dal quadrupede, l’essere dotato di parola da chi ne è privo» (Contra Symm. II 816). Nella fusione di epos, tragedia e lirica è il maggior interesse sul piano della teoria dei generi. Così nel Peristephanon, l’inno di San Romano di Antiochia (1140 versi) diventa un dramma, con dialoghi serrati; nel Cathemèrinon, l’inno ad incensum lucernae include l’epica narrazione della fuga dall’Egitto attraverso il Mar Rosso. In questa commistione di codici propria di una poesia colta, ricca di citazioni dalle scritture e reminiscenze classiche, l’elemento unificante è nel sentimento popolare cristiano, nello zelo di devozione, nel gusto del meraviglioso. Gli inni in particolare offrono al lettore visioni splendide e quadri di estrema delicatezza: cieli infuocati, spazi cosmici sterminati e sereni, colorite visioni paradisiache, prati teneri e fioriti, sublimi preghiere, ma anche potenti figurazioni di cupe e sataniche immagini del male. Al lirismo ispirato, al vigore delle immagini, al gusto narrativo e pittorico fanno da contraltare, soprattutto nella parte didascalica e apologetica della produzione, numerosi difetti: la verbosità e la dismisura, le fratture logiche, la propensione declamatoria, l’insistenza – come s’è detto – sui particolari orrorosi. In realtà, piuttosto che di difetti, si tratta di caratteri di un nuovo genere di poesia, che riflette lo spirito popolare e non si può giudicare secondo i parametri dell’arte classica. La Psichomàchia «Il Virgilio e l’Orazio dei Cristiani» Lo stile e il genere 647 648 La lirica cristiana Enfasi retorica II 397-408; trad. di C. Marchesi La lingua BASSO IMPERO La fortuna In particolare nelle sezioni epico-didascalica e apologetica, prevalgono la retorica, la pesante dissertazione moralistica, l’enfasi oratoria che nasce dalla professione forense dell’autore, ma anche dall’acceso fervore religioso, dall’ispirazione intensa e tardiva che lo porta nel volgere di pochi anni a produrre oltre diecimila versi. Ironia e sarcasmo – le armi tipiche degli apologisti – dominano nel poema Contra Symmachum. Frequenti, anche nel Peristephanon, le descrizioni insistite e barocche, che si compiacciono del particolare orripilante e sanguinario. Le piaghe, il sadismo dei carnefici, l’imputridire della carne sono descritti con pedantesca minuzia e prolissità talora estenuante. È il caso dell’interminabile agonia di San Romano protettore dei muti che, quasi a risarcimento dell’amputazione della lingua subita nel martirio, pronuncia discorsi fiume. Talora quest’orgia di orrori e torture – che indulge al gusto popolaresco e prelude alla sensibilità medioevale – cade nell’ingenuo, nel grottesco, perfino nell’umorismo involontario, come nel supplizio di San Lorenzo che, mentre «cuoce» sulla graticola, esorta i carnefici a rosolarlo bene, prima su un lato poi sull’altro: Poi che il continuo ardore maturò il fianco abbrustolito, di sulla graticola per primo rivolge al giudice poche parole: – È un pezzo che brucio da questo lato, rivoltatemi; e vedi un po’ cos’abbia fatto quel tuo ardente Vulcano. Lo fa rivoltare il prefetto. E quegli: – È cotto, divorami, e prova se sia più gustoso crudo od arrostito. Un altro tratto che anticipa il Medioevo è l’uso insistente dell’allegoria. Al lettore moderno la Psicomàchia appare un poema macchinoso e freddo per l’eccesso delle personificazioni. La lingua è quella dei classici con frequenti inserzioni di voci ecclesiastiche (hymnire, anathema, charisma, trinitas,), neoformazioni (primoplastus, «foggiato per primo», detto di Adamo, artistifer, christicola, offensacula), locuzioni colorite vicine all’ingenuità del racconto popolaresco. Frequenti sono poi, in particolare nella Psychomachia, le formule epiche virgiliane (dixerat, talia vociferans, haec ubi dicta dedit, ecc.) e le espressioni tratte dai classici citati sopra. Notevoli sono la varietà dei metri, secondo il modello oraziano, e l’abilità nel riprodurre cadenze metriche tradizionali. Della grande fortuna che avranno nel Medioevo e Rinascimento gli scontri epici tra vizi e virtù della Psychomàchia s’è già detto. Molti inni del Peristephanon e del Cathemèrinon – le opere poeticamente più felici, per le quali Prudenzio può considerarsi il maggior poeta cristiano latino – entreranno nella liturgia ecclesiastica ufficiale. La poesia come espiazione (Praef. 4-33). La Praefatio è una dichiarazione di poetica. L’autore, ritornato verso il 403 nella nativa Calagurris, decide di celebrare Dio con la poesia, intesa come mezzo per riscattare un’esistenza dissipata e vuota. L’umile dono (munus fictile, «una modesta argilla») dei suoi versi forse varrà a procurargli un angulus in Paradiso. Già il Signore m’appressa la vecchiezza. Che mai feci di buono in così lungo volger d’anni? Pianse la prima età sotto la sferza. La toga m’istruì nella menzogna, non senza colpa di me peccatore. Poi (vergogna e rimorso!) la sfrontata lussuria, il fango del peccato, il vizio insozzarono gli anni giovanili. Ai miei pugnaci spiriti fornirono armi i processi. E il voler sempre vincere, anche a torto, mi espose a gravi rischi. Due volte ressi nobili città: resi giustizia ai buoni cittadini e mi feci temere dai cattivi. Ad alti uffici la bontà del principe volle innalzarmi; mi ordinò di assumere un’importante carica al suo fianco. Mentre così fuggiva la mia vita, il capo mi s’imbianca, a ricordarmi che sono nato sotto il vecchio Salia [console nel 348]. Quanti inverni da allora, quante volte dopo i geli tornarono le rose! Questa neve sul capo lo dimostra. Gioverà quel che feci, bene o male, dopo la fine della carne, quando la morte struggerà quello ch’io fui? Già debbo dirmi, che chiunque io sia, quel mondo che ho servito è perduto. Nulla feci per Dio, ch’è il mio Signore. (trad. di E. Bossi) Il maggiore poeta cristiano: Prudenzio Ad incensum lucernae (Cathemer. 141 ss.). Negli inni sono frequenti le immagini di serena luminosità che – con polarità che riflette, come nell’arte di Agostino, il contrasto tra male e bene, luce e tenebra – si oppongono a cupe e sataniche immagini del male. L’opposizione tra luce della verità e tenebre dell’ignoranza, già presente in Lucrezio, negli autori cristiani si arricchisce di valenze simboliche nuove incrociando il tema biblico della luce dei Salmi: 26 (27), 1 Dominus inluminatio mea; 35 (36), 10 In lumine tuo videbimus lumen: Pendono dalle mobili funi infisse nelle volte i lumi splendenti e la fiamma, alimentata dall’olio su cui pigra galleggia, getta luce attraverso il trasparente vetro. Crederesti che si stenda su noi la volta del cielo ornata dei due Carri, e là dove il timone regge il giogo boreale brillino sparsi purpurei esperi. O cosa degna d’essere offerta a te dal tuo gregge, o Padre, sul principio della notte, la luce, della quale nulla ci largisci di più prezioso, la luce, con la quale scorgiamo gli altri tuoi doni! Tu sei luce vera agli occhi, tu luce anche alla mente; tu specchio in cui vediamo il nostro interno e le cose esterne: il lume, che in devoto servizio ti offro, accogli, bagnato nell’olio del pacifico crisma: per Cristo tuo figlio, o sommo Padre, in cui sussiste visibile la tua gloria, che, nostro Signore e tuo unigenito, spira dal paterno cuore il Paraclito: per il quale lo splendore, l’onore, la lode, la sapienza, la maestà, la bontà e la pietà tua regna perenne nella trina divinità, intessendo senza fine secoli a secoli. (trad. di Pellegrino) La nuova epopea cristiana (Psich. 417-431 e 178-182). Nel primo passo, il duello tra le due personificazioni della Pudicizia e della Lussuria esemplifica bene il carattere cruento del nuovo epos cristiano, mentre la successiva raffigurazione della bellicosa Superbia ricalca le descrizioni di eroi omerici o virgiliani. La Pudicizia aggiunge un colpo mortale alla sua nemica, prostrata a terra: scaglia un grosso macigno, che trovò a caso, tra le rocce, mentre teneva il vessillo tra le mani, occupate non da giavellotti, ma dall’insegna di guerra. Il macigno colpì la nemica così da troncare il respiro nella bocca e da ricacciare le labbra in fondo al palato. I denti sono divelti del tutto, la lingua in frantumi, tra grumi di sangue, riempie la gola. Per gli insoliti cibi la gola si irrita nell’inghiottire ossa stritolate, ma ricaccia fuori quanto ha ingerito. «Ed ora», grida ad alta voce la Vergine, «bevi il tuo stesso sangue dopo tanta varietà di coppe, ed in cambio dei pasti del passato, troppo dolci, divora finalmente questi tristi cibi; l’amaro sapore di una crudele morte, l’estremo assaggio di una coppa orrenda avveleni le lascive dolcezze godute nella tua vita». (trad. di E. Rapisarda) Intanto la Superbia, gonfia d’orgoglio, arriva caracollando fra gli squadroni sparsi nel campo, sul suo focoso cavallo, che essa aveva rivestito di pelli di leone e coperto i fianchi robusti di pelli, per apparire più spavalda, ritta su le pelli ferine, e volgere dall’alto del suo insolente fasto il suo sguardo sprezzante sulle schiere. (trad. di Q. Cataudella) 649 Storiografia L’Historia Augusta Storici minori del IV secolo: le epitomi di Eutropio e Festo L’Epitome rei militaris di Vegezio e il De rebus bellicis Ammiano Marcellino Inizi della storiografia cristiana: Acta e Passiones dei martiri Le vite dei santi Agostino e la teologia della storia Orosio e Salviano 652 L’ultima storiografia romana L’ultima storiografia romana L’Historia Augusta Base della colonna di Antonino Pio con apoteosi di Antonino e Faustina (II secolo). Città del Vaticano, Cortile della Pigna. Il modello svetoniano BASSO IMPERO La visione filosenatoria L’Historia Augusta («Storia degli imperatori») è una raccolta di trenta biografie di imperatori del II e del III secolo, da Adriano a Numeriano (117-284), con lacune per gli anni 244-260. L’opera figura scritta in età dioclezianea-costantiniana da sei distinti autori a noi del tutto ignoti: Elio Sparziano, Giulio Capitolino, Volcacio Gallicano, Trebellio Pollione, Elio Lampridio, Flavio Vopisco. Non pochi indizi fanno supporre che sia stata redatta in età successiva, in quanto i biografi rivelano conoscenze inconciliabili con l’epoca alla quale dichiarano di appartenere. Alcuni studiosi pensano all’età di Giuliano (361-63), altri a quella di Teodosio (379-395), altri ancora al V o al VI secolo. Anche la pluralità degli autori sarebbe una finzione e i sei nomi celerebbero un’unica persona, un falsario che con l’anonimato sperava di rendere più attraenti i suoi scritti. L’Historia è sciattamente cronachistica, inattendibile, piena di incongruenze, esagerazioni macroscopiche, profezie post eventum, al punto che qualcuno l’ha intesa come una parodia della storiografia ufficiale. Inclini al pettegolezzo e alla curiosità aneddotica, queste biografie sono la degenerazione del modello svetoniano, al quale intendono riallacciarsi (forse sono perduti i ritratti di Nerva e Traiano, che avrebbero continuato le Vitae). Anche lo schema compositivo è lo stesso dei ritratti di Svetonio: esposizione cronologica fino all’assunzione del potere imperiale e, nella fase successiva, per categorie tematiche (per species). Fine prevalente dell’opera, ad onta delle dichiarazioni di documentazione rigorosa (conscientia, fidelitas, diligentia), è l’intrattenimento del lettore, ma anche il suo ammaestramento morale. Infatti l’autore dichiara che è compito dello storico presentare ai lettori modelli positivi di comportamento. La prospettiva ideologica è quella senatoria, infatti gli imperatori sono valutati positivamente o negativamente in base al loro comportamento verso il senato. Così Massimino il Trace (235-238), che si batté contro il latifondo e l’evasione fiscale della nobiltà, è raffigurato come una «belva crudelissima», brutale e ingorda, solo muscoli e niente cervello; Gallieno, che escluse i senatori dalla carriera militare, è presentato come lussurioso, disonesto e incapace: «Regge lo stato con la competenza dei bambini quando giocano a fare l’imperatore» (10, 2). Invece il filosenatorio Alessandro Severo è presentato come un principe modello, idealizzato al punto che il suo profilo pare una «goffa imitazione della Ciropedia» (Gibbon). Anche le biografie di Commodo, Caracalla, Eliogabalo sono un vero e proprio «museo degli orrori» (C. Carena). L’inattendibilità storica non esclude l’interesse sul piano della documentazione del costume e della lingua, ricca di termini dell’uso volgare, burocratico, giuridico, castrense. Storici minori del IV secolo: le epitomi di Eutropio e Festo Storici minori del IV secolo: le epitomi di Eutropio e Festo Dopo Tacito possiamo affermare che, fatta eccezione per Ammiano Marcellino, non esistono grandi storici. La perdita della libertas repubblicana, l’ascesa dei nuovi ceti burocratici legati al principe segnano lo scadimento del genere storiografico, del quale in passato la nobilitas aveva avuto l’appannaggio pressoché esclusivo. I nuovi autori sono amministratori e dignitari di corte che scrivono manualetti agili e superficiali destinati a colmare le lacune storiche di funzionari ignoranti o dell’imperatore stesso. Nel IV secolo si accentua la tendenza a scrivere epitomi e riscuotono un grande successo le opere di compilatori di modesta levatura, come il Breviarium ab Urbe condita del retore di origine italica Eutropio e il Breviarium di Rufio Festo. L’epitome di Eutropio (in 10 brevissimi libri) va dalle origini mitiche di Roma fino all’imperatore Valente (Augusto d’Oriente dal 364 al 378), del quale l’autore era segretario particolare (magister memoriae) e dal quale gli fu commissionata l’opera. Le fonti sono Floro e Livio (forse noto solo attraverso altri compendi) per il periodo repubblicano, Svetonio per i succinti profili dei primi imperatori. L’opera scarna, priva di analisi storica e di una qualunque idea direttrice, ebbe grande successo, tanto che ne furono fatte traduzioni greche. Le ragioni del gradimento presso i contemporanei sono in parte le stesse che ne decretarono la fortuna come testo per l’apprendimento del latino: lingua piana e scorrevole, esposizione chiara ed elementare, semplicità nella sintassi. Il compendio non è del tutto privo di interesse storico, soprattutto quando espone i fatti in modo discordante rispetto alla narrazione liviana e sembra attingere ad autori per noi perduti. Il Breviarium rerum gestarum populi Romani di Rufio Festo – forse da identificare con un proconsole, di cui parla Ammiano Marcellino (XXIV 2, 21-28), nato a Trento nel 365 e magister memoriae di Valente – tratta la storia romana secondo la scansione cronologica delle guerre d’Oriente. Particolare attenzione è rivolta ai rapporti tra Roma e i Parti, contro i quali Valente è esortato ad intervenire. Un altro compilatore del IV secolo è l’africano Aurelio Vittore, che scrisse un Liber de Caesaribus, sintetica storia dei Cesari da Augusto a Costanzo II organizzata secondo lo schema biografico svetoniano. Diversamente dagli altri compendi, quello di Vittore è scritto in uno stile retoricamente adorno. Sempre in questo secolo furono redatte le Perìochae, «sommari» dei monumentali Ab Urbe condita libri di Livio, e le Epitomi di Valerio Massimo ad opera di Giulio Paride e Ianuario Nepoziano. Di Giulio Ossequente – di cui non sappiamo con certezza se sia vissuto nel IV secolo – è il Liber prodigiorum, rassegna di prodigi e interventi divini tratti dall’opera liviana. Un filone a parte è quello delle storie romanzate, come le Res gestae Alexandri Macedonis di Giulio Valerio Alessandro Polemio e l’Itinerarium Alexandri di autore ignoto. È un romanzo a tutti gli effetti l’Historia Apollonii regis Tyrii, storia di un inesistente re di Tiro. Decadenza della storiografia Eutropio Festo Altri epitomatori Biografie romanzate Quattro versioni dello stesso fatto. Per mostrare la tecnica seguita dagli epitomatori, riportiamo tre riassunti dell’episodio liviano (Ab Urbe condita V 22), che abbiamo presentato a p. 8. Livio è riassunto da Valerio Massimo (vedi p. 431), che a sua volta viene compendiato da Nepoziano e Giulio Paride. a) Il racconto di Valerio Massimo. [1] Captis a Furio Camillo Veis, milites iussu imperatoris simulacrum Iunonis Monetae, quod ibi ingenti religione cultum erat, in ur- Quando Furio Camillo ebbe preso Veio, i soldati, per ordine del generale cercavano di muovere la statua di Giunone Moneta, che era og- 653 654 L’ultima storiografia romana bem translaturi ex sede sua movere conabantur. Quorum ab uno per iocum interrogata dea an Romam ire vellet, velle se respondit. [2] Hac voce audita, lusus in admirationem versus est, iamque non simulacrum, sed ipsam ex caelo Iunonem petitam portare se credentes, laeti in ea parte montis Aventini, in qua nunc templum eius cernimus, collocaverunt. getto di grande devozione. A uno di questi che per gioco le chiedeva se volesse recarsi a Roma, la dea rispose di sì. Udita questa voce, il gioco volse in sorpresa e i giovani, convinti ormai di trasportare non la statua, ma Giunone stessa discesa dal cielo, la collocarono in quella parte dell’Aventino in cui oggi vediamo il suo tempio. b) Il racconto di Nepoziano [1] Furius Camillus Veios cepit iussitque statuam Iunonis Monetae transferri. [2] Unus e militibus per iocum interrogavit simulacrum num vellet ire Romam. Respondit: «Volo». Furio Camillo prese Veio e comandò di portar via la statua di Giunone Moneta. Uno dei soldati per gioco chiese alla statua se volesse venire a Roma. Questa rispose di sì. c) Il racconto di Giulio Paride Captis a Furio Camillo Veis, Iunonis Monetae simulacrum, cum per iocum a milite interrogatum esset an Romam vellet transferri, velle se respondit. Dopo che Furio Camillo ebbe preso Veio, la statua di Giunone Moneta, interrogata per scherzo da un soldato se volesse essere portata a Roma, rispose di sì. L’Epitome rei militaris di Vegezio e il De rebus bellicis BASSO IMPERO L’Epitome di Vegezio Di notevole interesse documentario sono l’Epitome rei militaris scritta, forse su commissione di Teodosio, da Flavio Renato Vegezio e il De rebus bellicis di un ignoto autore attivo nella seconda metà del IV secolo. L’opera di Vegezio, in quattro libri, tratta del reclutamento, della disciplina militare, della strategia negli scontri in terra e in mare. Massima rilevanza è data all’aspetto tecnico: Praef. 3 In guerra non il numero o il coraggio temerario procurano la vittoria, bensì la preparazione tecnica (ars) e l’esercizio costante … Chi vuole la vittoria, istruisca con cura i soldati. Chi brama risultati favorevoli, combatta con arte e non a caso. Nessuno ardisce provocare, nessuno ha il coraggio di offendere un nemico di cui riconosce la superiorità. Il De rebus bellicis Partendo dalla considerazione che l’impero è premuto in ogni parte dalle soverchianti forze barbariche, anche l’anonimo compilatore del De rebus bellicis propugna la necessità di migliorare la qualità tecnica delle milizie romane e riaccendere la virtus militare delle legioni ormai demotivate e inefficienti. Soprattutto nel De rebus bellicis sono contenuti progetti originali di nuovi armamenti più efficaci (balestre, macchine per l’assedio, tipi d’imbarcazione), ma anche acute considerazioni di carattere storico e politico. Ad esempio, egli critica la politica monetaria di Costantino che, rafforzando l’aureus dei ceti abbienti, ha indebolito la divisa di rame delle classi popolari e accresciuto la divaricazione tra ricchi e poveri. L’imperatore Costantino incoronato dalla mano di Dio. Vienna Kunsthistorisches Museum. Ammiano Marcellino Ammiano Marcellino Greco di Antiochia in Siria, di famiglia agiata, Ammiano Marcellino (330-400 circa) è l’ultimo dei grandi storici di Roma. Ricoprì incarichi amministrativi e militari sotto gli imperatori Costanzo e Giuliano, partecipò a varie missioni in Gallia, in Tracia. A fianco di Giuliano combatté in Oriente nel 359 nella sfortunata campagna contro i Persiani. Dopo la morte dell’imperatore venne a Roma, dove approfondì la conoscenza del latino e attese alla composizione dei Rerum gestarum libri XXXI, l’ultima grande storia di Roma imperiale. L’opera narra gli avvenimenti dal principato di Nerva (96) alla morte di Valente (nella battaglia di Adrianopoli del 378) e si pone come continuazione delle Storie di Tacito, che giungevano alla fine del principato di Domiziano. E qui conclude, circolarmente, la parabola della storiografia latina: «Dai primi storici latini che scrissero in greco si arriva a lui, greco autentico che scrive nella lingua di Roma, per l’ultima volta, componendo un lungo epos storico come quello di Livio e di Tacito, sulla Roma pagana dei Cesari» (Agozzino). Dei Rerum gestarum restano gli ultimi 18 libri relativi agli anni 353-378: un periodo vissuto dall’autore, che ne affronta lo studio con la competenza derivatagli dall’esperienza militare, dalla permanenza sulle frontiere, dai contatti con gli ambienti politici più disparati. Ben undici libri sono destinati al solo periodo di Giuliano (361363), mentre i primi tredici perduti contenevano quasi 300 anni di storia. La sproporzione si spiega sia con l’intento di dare più spazio alla contemporaneità, sia col particolare significato che Ammiano attribuiva al tentativo compiuto dall’Apostata di ridare vita alla cultura pagana. Dilatando la trattazione degli eventi osservati personalmente o dei quali possedeva testimonianze dirette, Ammiano si poneva nel solco di una tradizione storiografica, tucididea e polibiana, che basava la ricerca storica sull’autopsia, cioè sulla conoscenza diretta dei fatti. Al pari di Tacito, l’autore fa professione di veridicità e imparzialità di giudizio, dichiarando di voler considerare come materia degna della storia solo ciò che serve a illuminarla in profondità. Egli rifiuta le minuzie aneddotiche, giacché «[la storia] percorre le vette dei grandi eventi, non i fatti umili e irrilevanti» (XXVI 1, 1). Di qui la centralità accordata agli eventi politico-militari e la svalutazione del modello biografico-aneddotico alla moda, considerato adatto a un pubblico grossolano. Di qui anche l’assunzione dello schema cronologico della storiografia filosenatoria, anche se il criterio annalistico non era più rigorosamente applicabile alla nuova realtà dell’impero. Il fatto che i centri decisionali fossero Milano, Treviri, Antiochia comportava la necessità per lo storico di volgere alternativamente l’attenzione sui vari teatri d’azione, frantumando la narrazione cronologica. A Tacito Ammiano si ricollega anche per l’onestà professionale e l’obiettività (fides), per l’idea di storia come veritas, per la distanza dalla propria materia, che anch’egli intende valutare sine ira et studio. La personale condizione di greco pagano, integratosi con difficoltà negli ambienti di una corte cristianizzata, faceva di lui un osservatore «esterno» e ne favoriva la libertà di opinione e di giudizio: Ho esposto questi avvenimenti nei limiti delle mie capacità, come può farlo un greco e ex soldato, e non ho mai osato, almeno così mi pare, tacendo o mentendo affermare coscientemente il falso in un’opera che ha per scopo di dire la verità. Ammiano non lesina le critiche all’aristocrazia degenerata e neppure a Giuliano, l’imperatore che ama e ammira come il re saggio della tradizione platonica e stoi- La vita Una storia vissuta in prima persona Il modello storiografico senatorio Obiettività e libertà di giudizio XXXI 16, 9 655 656 L’ultima storiografia romana Il moralismo 14, 6, 18-19; trad. di M. Simonetti BASSO IMPERO 14, 6, 25 L’idea di Roma ca. Di lui condivide pienamente il progetto di restaurazione della cultura pagana, ma non approva la legge che vietava ai maestri cristiani di insegnare i classici, considerandola «crudele, tale da dovere essere sepolta in un perenne silenzio». Gli rimprovera inoltre gli eccessi nelle persecuzioni contro i cristiani, mentre elogia l’atteggiamento di tolleranza (moderamen) di Valentiniano. Pur lodando la politica anticristiana di Giuliano, sa riconoscere il coraggio dei martiri e apprezzare la spiritualità dei vescovi di provincia, che considera «uomini schietti e puri» (28, 3, 14). L’amore per la verità lo spinge finanche ad avvertire il lettore che i discorsi e le lettere, cui fa spesso ricorso, sono fittizi e frutto di fantasia. Con Tacito Ammiano condivide il tradizionalismo e il moralismo, comuni anche a Sallustio e Livio. Abbondano, nei Rerum gestarum libri, gli esempi edificanti della storia repubblicana ed è costante la contrapposizione tra la felicitas del passato e la degenerazione del presente, tra Roma antica sede di ogni virtù (aliquando virtutum omnium domicilium, XVI 6, 26) e la Roma contemporanea, dove non si compie più nulla «che sia degno di ricordo» (ib.). La difesa dei valori antichi fa tutt’uno con la polemica contro la nobilità degenere, oziosa, insensibile alla cultura, interessata più ai cantanti e al circo che alla filosofia: Al posto del filosofo si fa venire il cantante e in luogo dell’oratore il maestro di ballo; chiuse per sempre le biblioteche a mo’ di tombe, si costruiscono organi idraulici, e lire di grandi dimensioni dall’aspetto di carri, e flauti e strumenti non leggeri per l’accompagnamento degli istrioni … senza indugio sono buttati fuori i cultori delle arti liberali, assai pochi invero, e invece sono trattenuti gli accompagnatori delle ballerine. Ancor maggiore è il disprezzo mostrato per la plebe urbana, canagliesca e rozza, vittima del vino e della passione circense: Quanto poi alla gente d’infima condizione, alcuni passano la notte nelle osterie, altri si nascondono sotto i tendoni dei teatri, oppure giocano a dadi con accanimento e provocano rumori ributtanti aspirando fragorosamente l’aria con le narici; e dal mattino alla sera la più importante occupazione di tutti consiste nello stare a bocca aperta sia col sole che con la pioggia, ad osservare scrupolosamente i pregi e i difetti dei cocchieri e dei cavalli. A Tacito il nostro autore è unito anche dal cupo pessimismo nei confronti delle dinamiche sottese al corso della storia, che gli pare governata ora dai capricci della fortuna e del caso, ora da entità irrazionali, magiche e demoniache, ora da un determinismo desolato e inflessibile: «mai alcuna forza o capacità umana ha potuto ottenere che non accadesse ciò che aveva prescritto l’ordine fatale delle cose» (23, 5, 5). Sulla desolante realtà contemporanea afflitta da mali incurabili – si sfalda la compagine dell’impero, dilagano intrighi e corruzione, divampano conflitti religiosi, insorgono le plebi urbane mentre cresce il divario tra ricchi e poveri, i barbari premono sui confini – non si spegne l’idea dell’eternità di Roma, «destinata a vivere finché vivrà l’umanità» (14, 6, 3). È un’idea che resiste a dispetto dell’evidenza storica e dei molti sintomi che annunciano la fine. È una contraddizione, che neppure il ricorso alla teoria biologica che fissava l’omologia tra gli stati e le età dell’uomo riesce a sciogliere. Alla luce di questa concezione organicistica, seguita da Seneca Retore e da Floro, Ammiano può solo assimilare lo stato presente alla senescenza, senza indicare i segni della rinascita. Ma l’eternità di Roma, oltre che essere un’idea retorica, conserva comunque un valore consolatorio. A Roma faro di civiltà so- Ammiano Marcellino no contrapposti i barbari considerati con disprezzo, immagini di una bruta e grottesca animalità (rabies et furor): i Traci che bevono sangue umano nei crani delle vittime, gli Arimaspi con un occhio solo, gli Unni con un aspetto raccapricciante, non uomini ma bipedes bestiae. Ai canoni della storiografia drammatica e retorico-moralistica (Sallustio, Livio, Tacito) si conformano la gravità dello stile, le scene cariche di pathos, le vaste digressioni dove abbondano gli artifici retorici, i discorsi sul modello delle declamationes (sappiamo che brani delle Storie venivano presentati in pubbliche letture). In particolare i ritratti, talora schizzati secondo lo schema per species (rassegna di vizi e virtù), sono intensamente drammatici, delineati con evidenza visiva ed espressionistica attenzione allo sguardo, al tic, al gesto isolato e memorabile. Ci sono personaggi impauriti, tesi in un perenne stato di ansia, pronti a sfogare il loro isterismo come Valentiniano che in una accesso d’ira mozza la destra al servo che l’ha male aiutato a scendere da cavallo. Ci sono personaggi forsennati e sanguinari la cui bestialità è resa con barocche metafore animalesche; altri allucinati, disumani, bloccati in pose ieratiche, come l’imperatore Costanzo, che incede tra la folla con la fissità di un robot, tamquam figmentum hominis (16, 10). Ci sono personaggi surreali e grotteschi, come Valente, nero e con un occhio bianco, una gran pancia e le gambe arcuate; Gioviano, per il quale, data la stazza (vasta proceritate et ardua), al momento della nomina a imperatore non si trova un vestito della taglia giusta; Costanzo, bassissimo, che sul carro del trionfo fissa il vuoto, inespressivo, «come se avesse il collo chiuso in una morsa» (XVI 10, 10). Lo stesso Giuliano ha qualcosa di inquietante: la barba caprina, il continuo grattarsi la testa, il trattenere il fiato per allargare il torace esile, l’incedere a gran passi sproporzionati alla bassa statura. E poi, sebbene l’autore dichiari di trascurare le minutiae, c’è il gusto del dettaglio, del particolare strano apparentemente fuorviante, per esempio l’elmo caduto all’imperatore Valentiniano e non più ritrovato. Al grottesco si lega l’ironia, come nella descrizione del perpetuo viaggiare dei preti cristiani da un sinodo all’altro con l’esito, non già di convertire gli avversari alla propria fede, ma solo di stremare i cavalli. Sallustiana e tacitiana è la predilezione per la variatio, l’inconcinnitas (asimmetria), la brevitas: spesso Ammiano dichiara di volere esporre i fatti sinteticamente (breviter, brevi textu, carptim). Abbondano i grecismi lessicali e sintattici, com’è logico in un autore di lingua madre greca, che fin dall’autopresentazione considera la grecità come un tratto distintivo della propria scrittura, che è quella, appunto, di un miles quondam et Graecus. All’altro tratto caratterizzante (del miles e del funzionario), sono dovuti i prestiti dai linguaggi militari, cancellereschi, cortigiani, fusi in un impasto linguistico originale. Alla cultura retorica e alla conoscenza libresca del latino sono dovuti i poetismi, le metafore barocche, le stranezze stilistiche. Il rigore dello storico non impedisce ad Ammiano di indulgere con misura alle tendenze della storiografia del tempo: la curiositas aneddotica, il gusto del romanzesco celebrato da Auerbach, l’interesse per le narrazioni di presagi, sogni, profezie, dicerie (d’altronde anche Tacito riportava, sia pure con esibito distacco, i rumores della gente). I ritratti La lingua La morte di Giuliano (XV 3, 21-23). I modelli sono rappresentati dalla letteratura degli exitus virorum illustrium, le morti gloriose delle vittime della tirannide imperiale riferite da Tacito negli Annales (i suicidi di Trasea Peto, Seneca, Petronio), il cui archetipo è la morte di Socrate descritta da Platone. Nonostante la letterarietà che implica l’idealizzazione dell’Apostata ritratto come un santo laico, il brano rivela la sincera commozione dell’autore, che era stato personalmente presente al trapasso di Giuliano. 657 658 L’ultima storiografia romana Dopo queste parole serene, mentre distribuiva come per estrema volontà i beni familiari agli intimi, chiamò Anatolio, il magister officiorum. Avendogli risposto il prefetto Saluzio che Anatolio era stato fortunato, comprese che era stato ucciso, e pianse dolorosamente la sorte dell’amico, egli che con animo superiore aveva disprezzato la propria. E con autorità ancora intatta rimproverava tutti i presenti che intanto piangevano, dicendo che era meschino piangere un imperatore caro al cielo e alle stelle. Quindi, mentre essi ormai tacevano, egli disputava in modo profondo con i filosofi Massimo e Prisco sulla sublimità dell’anima; ma quando si aprì di più la ferita del fianco trafitto e il respiro gli fu impedito dal gonfiarsi delle vene, dopo aver chiesto e bevuto dell’acqua fredda, nell’orrore della notte profonda spirò serenamente… Solido di Giuliano l’Apostata (361-363). Parigi, Bibliothèque Nationale. (trad. di M. Caltabiano) BASSO IMPERO La cattura di Pietro Valvomeres (Rerum gestarum libri, XV 7, 1-5). L’arresto di Pietro Valvomeres – vescovo di Roma reo di non avere sottoscritto un decreto di Costanzo II che destituiva il vescovo Atanasio – è considerato da E. Auerbach un esempio «cupo, sommamente patetico» di quel realismo occidentale che attraversa tutta la letteratura europea. Mentre un turbine funesto1 provocava queste sciagure di stragi generali, Leonzio2, che amministrava la Città Eterna, si dimostrava in molti casi un magistrato degno di ammirazione. Dava prontamente ascolto, era giustissimo nelle decisioni che prendeva, benevolo di carattere, sebbene ad alcuni sembrasse aspro e piuttosto incline alle condanne pur di conservare intatta la sua autorità. Dunque la ribellione suscitata contro di lui scoppiò per un motivo assolutamente trascurabile e futile. Siccome era stato arrestato l’auriga Filoromo, tutta la plebe lo seguì come per difendere un proprio figlio e con incredibile violenza attaccò il prefetto, ritenuto un timido. Ma costui, fermo e deciso, sguinzagliò tra la folla i suoi sgherri. Furono arrestati e sottoposti alla tortura alcuni cittadini che egli poi condannò alla deportazione nelle isole, senza che alcuno protestasse o facesse opposizione. Alcuni giorni dopo, allorché la plebe, accesa similmente dalla solita passione, con il pretesto della mancanza di vino, si raccolse nei pressi del Settizodio3, luogo assai frequentato, dove l’imperatore Marco Aurelio aveva fatto costruire un pretenzioso Ninfeo, il prefetto vi si diresse intenzionalmente, sebbene tutti i magistrati e gli impiegati subalterni lo scongiurassero di non spingersi in mezzo ad una folla la quale, arrogante e minacciosa, era furiosa per l’eccitazione dei giorni trascorsi. Egli però, inaccessibile alla paura, continuò diritto il suo cammino, cosicché una parte del séguito lo abbandonò, pur sapendo che andava a capofitto incontro al pericolo. Salito pertanto su un cocchio, osservava con mirabile padronanza di sé e con sguardo attento i volti, simili a quelli dei serpenti, delle masse che d’ogni parte tumultuavano. Dopo aver sopportato che gli si lanciassero molti insulti, riconobbe un tale che si distingueva tra la massa per l’enorme corporatura e la chioma rossiccia e gli chiese se si chiamasse Pietro soprannominato Valvomere, come aveva udito. Ed avendoglielo costui confermato in tono insolente, il prefetto, che aveva riconosciuto in lui un ben noto provocatore di disordini, ordinò, a dispetto delle proteste che da molte parti si levavano, che fosse sospeso alla corda con le mani legate dietro la schiena. Vistolo sospeso ed invocante invano l’aiuto dei suoi compagni, tutta la folla, che poc’anzi era stata compatta, si disperse per i vari quartieri della città ed a tal punto si volatilizzò che quel violentissimo provocatore di sedizioni, dopo essere stato fustigato come se fosse stato nel segreto di una prigione, fu relegato nel Piceno. Ivi, successivamente, osò violentare una fanciulla di non oscura schiatta e perciò fu condannato a morte dal consolare Patruino. (trad. di A. Selem) 1. È la vendetta di Costanzo contro i suoi avversari: gli Alemanni e Silvano, il generale che in Gallia si è proclamato Augusto e perciò è stato trucidato. 2. Prefetto di Roma. 3. Fontana «dei sette pianeti», sul colle Palatino, fatta costruire da Settimio Severo e non, come crede Ammiano, da Marco Aurelio. Medaglia di Costanzo II (338). Berlino, Staatliche Museen. Ammiano Marcellino Ingresso trionfale di Costanzo in Roma (XVI 10, 4-10). Nel 357 Costanzo giunge a Roma, con l’intento di celebrare il trionfo per la vittoria sugli usurpatori Magnenzio e Decenzio. In realtà non ne aveva il diritto, perché non aveva vinto alcun popolo straniero (quella vittoria era contro cittadini romani), né accresciuto l’impero, che a quel tempo non poteva certo dirsi pacificato. La bellissima descrizione del corteo trionfale lascia trasparire l’antipatia dell’autore per Costanzo, soprattutto nelle righe in cui è descritta la fissità ieratica del sovrano sul carro d’oro. Dunque, dopo che furono spesi molti denari per il corteo imperiale e ciascuno fu ricompensato secondo i suoi meriti, durante la seconda prefettura di Orfito1, Costanzo attraversò Otricoli2, ed esaltato con grandi onori, circondato da temibili schiere in armi, avanzava accompagnato dall’esercito schierato quasi in ordine di battaglia, mentre gli occhi di tutti si fissavano su di lui con insistente attenzione. 5. Avvicinandosi alla città, contemplava con espressione tranquilla gli atti di deferenza del senato e le venerabili immagini delle famiglie patrizie, e non pensava, come il famoso Cinea, ambasciatore di Pirro, di trovarsi alla presenza di un gran numero di re riunitisi insieme, ma nel luogo che offre ricetto sicuro al mondo intero. Quindi, volgendo lo sguardo verso il popolo, si meravigliava di vedere con quale prontezza uomini di ogni parte del mondo fossero confluiti a Roma. E, come se stesse per atterrire con lo splendore delle armi l’Eufrate o il Reno, preceduto da una parte e dall’altra dalle insegne, sedeva da solo su un carpento d’oro3, sfolgorante per lo splendore di diverse pietre preziose, al cui scintillio pareva si levassero insieme guizzi di luce di diversa intensità. 7. Lo precedevano numerosi reparti e lo circondavano dragoni4, tessuti con fili di porpora, legati alla punta coperta d’oro e di gemme delle aste, sibilanti come in preda all’ira per l’aria che attraversava loro la gola e con le grandi code ondeggianti al vento. Sfilavano al suo fianco due schiere di soldati armati di scudo, con gli elmi ornati di pennacchio, scintillanti di luce corrusca, rivestiti di splendide loriche; in mezzo a loro cavalieri catafratti, che chiamano clibanarii, con il volto nascosto dalle visiere, coperti da una corrazza a maglie, cinti da bande di ferro, tanto che avresti potuto crederli statue levigate dalle mani di Prassitele, non uomini; portavano alle giunture anelli sottili di lamine, che consentivano a tutte le membra del corpo di muoversi in modo che, qualunque movimento essi dovessero compiere, l’armatura vi si adattasse, tanto le connessioni erano idonee. Così acclamato Augusto da grida augurali, non rabbrividì per il fragore rimbombante sui monti e sulle rive, mostrandosi imperturbabile, come appariva nelle sue province. Basso di statura, tuttavia si curvava entrando attraverso le altissime porte e, come se avesse il collo impedito, tenendo lo sguardo fisso davanti a sé, quasi fosse una statua, non volgeva il volto né a destra né a sinistra; né fu mai visto muoversi pur fra gli scossoni delle ruote del carro, né sputare né tergersi o sfregarsi il naso, né asciugarsi il viso, né agitare la mano. Sebbene affettasse tali atteggiamenti, tuttavia questi ed altri comportamenti della vita privata erano prova di una non comune resistenza, che si poteva ritenere concessa a lui solo. (trad. di M. Caltabianco) 1. Memmio Vitrasio Orfito aveva rivestito la prefettura urbana negli anni 353-355. 2. Municipio umbro. 3. È il carro d’oro previsto dal cerimoniale. 4. Sono gli stendardi imperiali, cosiddetti perché avevano veramente forma di draghi, nei quali il vento entrava producendo un sibilo sinistro. L'imperatore Teodosio, al centro del baldacchino, circondato dai dignitari. Basamento dell'obelisco di Teodosio a Costantinopoli. 659 660 Inizi della storiografia cristiana Inizi della storiografia cristiana Acta e Passiones dei martiri Gli Acta martyrum BASSO IMPERO Le Passiones I modelli All’epoca delle persecuzioni il martirio è l’esperienza cruciale del cristiano, è il vero onomastico (dies natalis) che segna la nascita alla vita eterna. Questo evento decisivo provoca il sorgere di un genere storiografico che narra la testimonianza di fede del martire – mártyr in greco significa, appunto, «testimone» – dinanzi ai giudici e la sua eroica morte. Gli acta o gesta martyrum («Atti dei martiri») riportano in forma diretta il dialogo del martire col magistrato e il resoconto dell’esecuzione. Lo stile, asciutto ed essenziale, è quello impersonale dei verbali dei processi, anche se spesso il racconto tradisce l’emozione del compilatore. Il più noto di questi testi è rappresentato dagli Acta martyrum Scillitanorum, atti del martirio subito nel 180 da un gruppo di cristiani della colonia di Scillum in Numidia, condannati dal proconsole Saturnino. Altri documenti analoghi sono gli Atti del martirio di san Cipriano (258), di Fruttuoso, di Marcello, di Massimiliano (295). Dagli acta differiscono le Passioni, per il maggiore respiro narrativo, per la trama più articolata e complessa, per l’apporto creativo del compilatore che aggiunge particolari edificanti, commoventi, meravigliosi. Si tratta di biografie semiromanzate di eroi della fede, narrazioni più o meno leggendarie della loro vita o per meglio dire, della loro morte. In questi racconti – che potevano avere anche la forma del dialogo o della lettera – al nucleo storico originario si sovrappongono leggende nate dalla fantasia popolare. Nei primi secoli cristiani, il testo di maggiore suggestione è quello della Passio Perpetuae et Felicitatis, databile ai primi del secolo III. Il racconto del supplizio subìto a Cartagine da Vibia Perpetua sviluppa un nucleo narrativo originario rappresentato dal diario tenuto dalla donna durante la detenzione. L’autore (da alcuni identificato con Tertulliano) interviene nella seconda parte, narrando il martirio eroico nell’anfiteatro. Nell’opera si respira «il clima esaltante del cristianesimo primitivo» (A. Ronconi). Acta e passiones finiscono per subire una codificazione retorica, dando luogo a un vero e proprio genere, che prevede uno schema narrativo fisso e personaggi con determinati requisiti e atteggiamenti (l’accusatore è sempre tirannico e meschino, l’accusato è sicuro di sé, sprezzante e provocatorio, ecc.). In particolare le «Passioni epiche» – come quella di Sebastiano, Agnese o Cecilia – si caratterizzano per i tratti iperbolici e l’esaltazione esagerata dell’eroe martire. Un modello per gli Acta e le Passiones era la letteratura degli exitus virorum illustrium, le morti gloriose delle vittime della tirannide imperiale riferite da Tacito negli Annales (morti di Trasea Peto, Seneca, Petronio), il cui archetipo era la morte di Socrate descritta da Platone. L’influenza della letteratura profana è confermata da un opuscolo di Tertulliano, Ad martyras, che raccoglie esempi di morti valorose della tradizione pagana (Muzio Scevola, Didone, ecc.) offerte all’imitazione dei cristiani. In ambito giudaico-ellenistico, un esempio poteva venire dai racconti della «passione» dei fratelli Maccabei perseguitati da Antioco IV Epifane. Acta e Passiones dei martiri Passio sanctorum Scillitanorum. Proponiamo la lettura del verbale del martirio subito nel 180 da alcuni cristiani di Scillum in Numidia, davanti al proconsole Saturnino. Il resoconto scarno e documentario, lo stile disadorno, le risposte ferme ed essenziali delle vittime conferiscono all’episodio grande forza di verità e pathos senza enfasi. 1. Essendo consoli Presente, per la seconda volta, e Claudiano, sedici giorni prima delle calende di agosto (17 luglio), in Cartagine, furono convocati in tribunale Esperato, Nartzalo, Cittino, Donata, Seconda e Vestia. Il proconsole Saturnino disse loro: «Cambiate opinione ed otterrete il perdono del nostro signore, l’imperatore». 2. Rispose Esperato: «Non abbiamo mai fatto del male a nessuno, non abbiamo mai commesso iniquità, non abbiamo mai parlato male del prossimo, anzi abbiamo sempre ringraziato anche del male ricevuto: in questo modo noi abbiamo onorato l’imperatore». 3. Disse il proconsole Saturnino: «Anche noi siamo religiosi e la nostra religione è semplice. Giuriamo per il genio del signore nostro, l’imperatore, preghiamo per la sua salute, cosa che dovete fare anche voi». 4. Esperato disse: «Se mi ascolterai tranquillamente, ti spiegherò il mistero della semplicità». 5. Saturnino lo interruppe: «Non posso ascoltare i tuoi insulti alla nostra religione; piuttosto giurate per il genio del nostro signore, l’imperatore». 6. Esperato gli disse: «Io non riconosco il potere di questo mondo, ma servo quel Dio che nessun uomo ha mai visto né può vedere con occhi di carne. Del resto io non ho mai rubato; se esercito un commercio, pago le tasse, poiché conosco il mio Signore, re dei re e imperatore di tutte le genti». 7. Il proconsole Saturnino disse agli altri: «Abbandonate la vostra persuasione». Esperato ribatté: «Cattiva persuasione è uccidere, testimoniare il falso». 8. Il proconsole Saturnino disse: «Non partecipate alla sua stoltezza». Disse Cittino: «Non temiamo che il nostro Signore, che è nei cieli». 9. Disse Donata: «Noi tributiamo onore a Cesare come Cesare, ma temiamo solo Dio». Disse Vestia: «Sono cristiana». Disse Seconda: «Voglio essere quello che sono». 10. Il proconsole Saturnino disse a Esperato: «Seguiti ad essere cristiano?». Rispose Esperato: «Sono cristiano»; e con lui tutti si professarono cristiani. 11. Saturnino disse loro: «Volete un po’ di tempo per decidere?». Rispose Esperato: «In una cosa tanto giusta non serve riflettere». 12. Saturnino domandò: «Che avete in quella cassa?». Rispose Esperato: «Libri e le lettere di Paolo, un uomo giusto». 13. Disse il proconsole Saturnino: «Avete trenta giorni di tempo per decidere». 14. Esperato ripetè: «Sono cristiano»; e tutti ripeterono la stessa cosa. Il proconsole Saturnino lesse la sentenza sulla tabella: «Esperato, Nartzalo, Cittino, Donata, Vestia, Seconda e gli altri che hanno confessato di vivere secondo la religione cristiana, poiché hanno ostinatamente rifiutato la possibilità ad essi offerta di tornare al costume romano, siano puniti con la spada». 15. Esperato disse: «Ringraziamo il Signore». Nartzalo disse: «Oggi saremo martiri in cielo; ringraziamo il Signore». 16. L’araldo, per ordine del proconsole Saturnino, proclamò la sentenza di morte per Esperato, Nartzalo, Cittino, Veturio, Felice, Aquilino, Letanzio, Gennara, Generosa, Vestia, Donata, Seconda. 17. Tutti dissero: «Ringraziamo il Signore», e tutti insieme ottennero la corona del martirio e regnano col Padre, il Figlio e lo Spirito Santo per tutti i secoli. Amen. (trad. di C. Allegro) I 40 martiri cristiani di Sebaste (Asia Minore). Rilievo bizantino in avorio (particolare). Berlino, Staatliche Museen. 661 662 Inizi della storiografia cristiana Le vite dei santi I modelli classici Gli Atti degli Apostoli L’agiografia BASSO IMPERO Il carattere non realistico La nascita di una storiografia cristiana La biografia romanzata era un genere noto nell’antichità classica, affine al romanzo e alla novella. L’esempio più illustre è rappresentato dalla Ciropedia di Senofonte (vedi p. 122), ritratto di Ciro idealizzato come monarca ideale, giusto, pio. La morte del vecchio re – che non avviene in battaglia contro i Massageti, secondo la realtà storica, ma nel letto attorniato da parenti e amici, dopo un sereno colloquio d’ispirazione platonica sull’immortalità dell’anima – sarà un modello letterario anche per le agiografie cristiane. Il genere della biografia romanzata in lingua greca è rappresentato in età imperiale dalla Vita di Apollonio di Tiana di Filostrato (II-III secolo d.C.), che narra la vita di un mago e taumaturgo vissuto nel I secolo d.C. Almeno in parte, rientrano in questo genere anche gli Atti degli Apostoli cristiani (fine I secolo d.C.) e gli Atti degli apostoli apocrifi. I primi – che continuano il Vangelo di Luca e narrano le fasi della diffusione della dottrina di Cristo ad opera di apostoli, in particolare di Paolo di Tarso – contengono dettagli meravigliosi, guarigioni miracolose, eventi soprannaturali. Negli scritti apocrifi il carattere fantasioso e romanzesco è ulteriormente accentuato. Verso la fine del III secolo iniziano le biografie vere e proprie. La prima è la Vita di Cipriano, vescovo di Cartagine, scritta dal diacono Ponzio. Seguono nel IV secolo la Vita di Antonio di Atanasio, La vita di Martino di Sulpicio Severo e, nel V secolo, la Vita di Ambrogio di Paolino e la Vita di Agostino di Possidio. Il filone della biografia romanzata si prolunga nelle biografie dei santi veri e propri, cioè nell’agiografia, che il Parry considera come la continuità cristiana del romanzo e che diviene il genere letterario più popolare della cultura cristiana. Si tratta di una produzione che ha per oggetto uomini considerati venerabili per le eccezionali virtù cristiane (martiri, eremiti, monaci, vescovi). La loro vita, proposta come modello da imitare, è narrata secondo uno schema elementare, nel quale l’intreccio quasi coincide con la fabula, cioè con la sequenza cronologica dei fatti. La biografia ricalca uno schema ricorrente. La santità è annunciata fin dalla nascita, talora prima della nascita (da sogni premonitori della madre, dalle stesse caratteristiche fisiche del territorio). Segue la conquista della santità attraverso un’estenuante autodisciplina che prevede l’allontanamento dalla casa paterna come segno del disprezzo delle cose terrene, l’isolamento ascetico al di fuori dalla cerchia urbana, il superamento di prove e tentazioni. Dalla santità derivano la capacità di dominare la natura e la pratica miracolistica, narrata in vari quadri spesso assai suggestivi. È evidente il carattere non realistico di questo genere, che introduce a piene mani elementi romanzeschi, meravigliosi, talora grotteschi o surreali, spesso desunti dalla tradizione culturale classica o anche asiatica. Il genere agiografico non intende dare del santo un racconto storico preciso. Ha un altro scopo: quello di presentare un uomo la cui vita rappresenta esemplarmente il suo incontro con Dio. Spesso la vita reale del martire o del santo non è neppure nota a chi la scrive: «Gli agiografi non possono uscire dall’anonimato del martire se non “inventando” una biografia, cioè ricorrendo ai pochi elementi storici eventualmente pervenuti e a tópoi, cioè a quelle frasi caratteristiche che definiscono in linea generale il martirio» (C. Leonardi). Questo tipo di narrativa popolare ebbe una diffusione enorme in tutta Europa, come ricorda Auerbach a proposito dei Dialoghi di Gregorio Magno. Alla fine del III secolo Eusebio di Cesarea scrisse in greco un’opera che concepiva la storia universale, e soprattutto quella dell’era cristiana, in prospettiva teologica, come l’attuarsi di un progetto provvidenziale. In tal modo il cristianesimo iniziava ad elaborare una critica storica, conducendo un’analisi della propria evoluzione. Le vite dei santi Dal IV secolo in poi, in parallelo alla produzione degli atti dei martiri, si andò costituendo la prima grande storiografia cristiana latina a cui appartennero Agostino ed Orosio, che tentarono di dare un’interpretazione della storia universale che influenzò la cultura europea per tutto il Medioevo. San Martino dona il mantello al povero. Dalla Vita di Martino (3, 1-2) di Sulpicio Severo riportiamo il celebre episodio – un classico dell’agiografia cristiana – della donazione del mantello. Un giorno, quando non aveva altro fuor che le armi e la semplice veste militare, in mezzo all’inverno, che era più rigido del solito sì che molti soccombevano alla violenza del freddo, incontrò alle porte di Amiens un povero che era nudo. Poiché quello implorava i passanti ad aver pietà di lui ma tutti tiravano avanti senza curarsi del misero, l’uomo pieno di Dio comprese che, poiché gli altri non prestavano soccorso, quel povero era riservato per lui. Ma che fare? Non aveva altro che il mantello che indossava: aveva infatti dato fondo a tutto il resto per simili opere di elemosina. Allora tratta la spada che aveva al fianco, divide il mantello a metà, una parte dà al povero, l’altra l’indossa di nuovo. Allora fra quelli che osservavano alcuni si misero a ridere perché il suo aspetto era deforme per l’indumento dimezzato: ma molti che sapevano ragionare meglio, si dolsero profondamente di non aver fatto niente di simile, mentre avrebbero potuto vestire il povero senza spogliare se stessi. (trad. di G. Cerri) Gregorio Magno e il suo scriba. Registrum Gregorii, Maestro del Registrum Gregorii (Treviri), 984 ca. 663 664 Inizi della storiografia cristiana Agostino e la teologia della storia La vita Agostino, uno tra i principali e più famosi esponenti della cristianità di tutti i tempi, nacque a Tagaste, in Africa, da famiglia di umili origini, nel 354. Il padre, Patrizio, riuscì a garantire una buona educazione al figlio, che iniziò nella città natale gli studi proseguendoli a Madaura e a Cartagine. Nell’età giovanile Agostino era lontano dal cristianesimo, nonostante l’insegnamento della madre Monica, battezzata. Questi anni furono vissuti all’insegna della ricerca dei piaceri e culminarono con l’adesione al manicheismo (374-383), una religione orientale di origine gnostica (incentrata sul dualismo tra Dio e il mondo identificato con il male, dal quale ci si può redimere attraverso una superiore conoscenza di Dio). Intanto Agostino aveva intrapreso l’insegnamento della retorica a Tagaste. Successivamente l’attività professionale lo portò a trasferirsi a Cartagine, a Roma, infine a Milano. L’insoddisfazione nei confronti della propria religione e soprattutto l’influenza di Ambrogio e degli amici provenienti da ambienti cristiani di ispirazione platonica – che lo indussero a leggere i filosofi neoplatonici Plotino e Porfirio – lo portarono nel 387 al battesimo. Ritornato a Tagaste (durante il viaggio perse la madre, cui era particolarmente legato), condusse in un primo tempo una vita monastica. Ordinato sacerdote e poi vescovo di Ippona, si dedicò con particolare intensità alla predicazione contro le eresie. Scrisse opere di carattere apologetico, esegetico, teologico. Morì ad Ippona nel 430 mentre i Vandali di Genserico assediavano la città. Opere I testi più importanti per definire il pensiero storiografico di Agostino sono il De civitate Dei, opera apologetica in 22 libri scritta tra il 413 e il 427, e l’autobiografia spirituale le Confessiones. Sono rimaste inoltre più di duecento lettere di vario argomento e diversa estensione (vedi p. 689), più di cinquecento sermoni (non tutti autentici), una raccolta di prediche che uniscono alla chiarezza dell’esposizione l’efficacia della nuova retorica cristiana. Della vastissima produzione apologetica, dottrinale, esegetica trattiamo a p. 709 ss. BASSO IMPERO Il De civitate Dei Una teologia della storia Il De civitate Dei è l’ultima tappa della ricerca, iniziata nel pensiero antico con la Repubblica platonica, di uno stato ideale. Scritto in 22 libri tra il 413 e il 426-27, il trattato nasce con lo scopo apologetico di confutare l’accusa, che i pagani rivolgevano ai cristiani, d’essere responsabili del crollo dell’impero, in quanto avevano contribuito a logorare le forze tradizionali che ne erano alla base. In particolare il sacco di Roma ad opera delle truppe di Alarico aveva cancellato il mito di Roma eterna, invitta dai tempi di Brenno e dei suoi Galli (390 a.C.). L’evento – che assumeva un profondo significato simbolico: Quid salvum est si Roma perit?, si chiedeva sgomento Girolamo equiparando il disastro alla caduta di Troia – veniva dai pagani interpretato come la vendetta degli dei antichi, rinnegati a favore del Dio cristiano. Per confutare questa accusa con argomentazioni filosoficamente fondate Orosio scriveva, in quegli stessi anni e su sollecitazione di Agostino, le sue Historiae (vedi p. 671). Il De civitate Dei va oltre il motivo polemico, svolto nella prima metà dell’opera, dal quale trae lo spunto per costruire un’interpretazione della storia del mondo alla luce del messaggio cristiano. In un’epoca in cui le istituzioni romane crollano sotto i colpi delle invasioni barbariche, Agostino vuole rafforzare la fede nel vero Dio, contrapposto agli inconsistenti dei pagani, confermando l’idea della sua costante presenza nella storia degli uomini. Nel contempo elabora una concezione storiografica in grado di spiegare la decadenza dello stato romano, come di ogni altra forma di realizzazione politica terrena. Agostino e la teologia della storia L’opera sviluppa, secondo una dialettica polare, l’idea di una «città terrena» a cui è contrapposta una «città celeste», che è il fine ultimo e la ricompensa dell’uomo virtuoso. L’umanità fin dalle origini è stata divisa in due civitates, quella degli uomini che seguono solo i propri istinti e quella di coloro che ubbidiscono alla legge di Dio: Da testimonianze che sarebbe troppo lungo riferire per intero, abbiamo appreso l’esistenza di una città santa di Dio, ed è nato in noi il desiderio di esserne cittadini, sotto la spinta di quell’amore che ci ispirò il suo Fondatore. Ma al Fondatore della città santa i cittadini della città terrena preferiscono i loro dèi, ignorando che lui è il Dio degli dèi. Si tratta di due regni distinti, uno terreno e uno ultraterreno, ma anche di due categorie morali che separano da sempre gli uomini: «Due diversi amori generano le due città: l’amore di sé, portato fino al disprezzo di Dio, generò la città terrena; l’amore di Dio, portato fino al disprezzo di sé, generò la città celeste» (14, 28). I due regni non hanno confini politici – anche se gli stati sono certamente espressione della città terrena e come tali destinati ad estinguersi – e riflettono un dualismo esistente anche nell’animo di ogni individuo. Questo dualismo in Agostino ha forse ascendenze manichee, ma soprattutto ha radici nella Sacre scritture e ricalca la contrapposizione tra Gerusalemme, città santa, e Babilonia, città dannata, del Libro dei Salmi o dell’Apocalisse. Interpretata in base a questa dialettica binaria (tra divino e terreno, spirito e carne, sacro e profano) la storia del mondo procede secondo un itinerario – dal peccato originale alla fine dei tempi – il cui andamento rettilineo, e non più ciclico come nella visione pagana, è un tratto tipico della nuova concezione cristiana della storia. Le due città Civ. Dei XI 1 La storia come processo lineare verso qualcosa All’influsso del pensiero cristiano, il cui punto più alto è la Città di Dio di Agostino, dobbiamo l’affermarsi di una visione della storia umana come un processo che va verso qualcosa. È il declino dell’idea, statica, della storia come cerchio (kyklos) […] È a partire da Agostino che, accanto, e in antitesi, al pensiero pessimistico-conservatore, a base classica, si è venuta affermando la veduta opposta, della storia come movimento «in avanti»: il che non ha significato sempre e necessariamente movimento proiettato fuori della storia, cioè verso la civitas Dei. Peraltro grandi sviluppi in questo medesimo senso erano impliciti nella visione stoica di una provvidenza immanente. L. Canfora, Noi e gli antichi, Rizzoli, Milano 2002, pp. 16-17 L’impero romano fondato dal fratricida Romolo, che ripete in modo inquietante il gesto di Caino, e la Chiesa nata da un atto d’amore riflettono le due civitates, ma solo parzialmente. Infatti, la Chiesa temporale – «prigioniera nel corso del suo pellegrinaggio terreno» (civitas Dei peregrinans) e tenuta ad obbedire alle leggi della civitas terrena – potrà identificarsi compiutamente con la civitas celeste solo alla fine dei tempi. Neppure l’impero romano s’identifica compiutamente con la civitas diaboli, anche se ne è la più compiuta rappresentazione. Tra i due termini della polarità non è possibile alcuna mediazione: la collaborazione tra Stato e Chiesa è solo un’utopia per Agostino. Egli non condivide l’idea di Orosio che l’impero romano sia il braccio secolare della provvidenza divina e neppure il tentativo di Girolamo di conciliare la fede con la conoscenza della cultura pagana. La teologia della storia elaborata nel De civitate Dei ebbe una certa diffusione tra i contemporanei e un notevole riscontro nel pensiero politico-religioso medioevale, dove però prevarrà la teorizzazione orosiana di una sinergia tra potere temporale e potere spirituale. Inconciliabilità tra le due civitates 665 BASSO IMPERO 666 Inizi della storiografia cristiana Le Confessiones Autobiografia spirituale scritta per rispondere alle critiche mossegli per il passato manicheo, le Confessiones già nel titolo danno l’idea di un’opera di meditazione e riflessione: infatti l’uso di confiteri nelle versioni latine della Bibbia prelude più alla preghiera e alla lode di Dio che alla confessione dei peccati, anche se i tre significati (confessio peccatorum, confessio fidei, confessio laudis) sono intimamente fusi. L’opera, in tredici libri, è nella prima parte (libri I-IX) un’autobiografia spirituale che va dalla puerizia alla morte della madre. Più esattamente, questa sezione ripercorre le tappe dell’avvicinamento a Dio, costituite da episodi importanti o ordinari, esaltanti o deludenti che, riletti alla luce della coscienza, rivelano la presenza di una Guida superiore. L’autore narra, rivolgendosi a Dio, le vicende della sua vita, soffermandosi ad analizzare, con acuta capacità di introspezione, i momenti delle proprie crisi spirituali risolte infine con la conversione. Episodi della fanciullezza apparentemente irrilevanti, rimeditati ora al cospetto di Dio si rivelano emblematici all’adulto «profondamente impaurito dal peso dei suoi peccati». Così il furto delle pere consumato da bambino, non motivato dalla fame o dal desiderio di mangiarle, appare proprio per questo sommamente significativo della naturale inclinazione dell’uomo al peccato: «Eppure colsi proprio quei frutti, al solo scopo di commettere un furto, infatti appena coltili li gettai, senza avere assaporato che la mia cattiveria (è) così inebriante a praticarla» (2, 8). Scorrono alla luce del ricordo e filtrati attraverso la meditazione le fasi di un percorso travagliato culminante nell’incontro con Dio: «Mi portavo dentro un’anima dilaniata e sanguinante, insofferente di essere portata da me; e non trovavo dove deporla. Non certo nei boschi ameni, nei giochi e nei canti, nei giardini profumati, nei conviti sfarzosi, fra i piaceri del letto, neppure sui libri e poemi posava» (4,7, trad. di C. Carena). La risposta alla domanda di un senso della propria vita è data alfine in un giardino, dove Agostino sente una voce infantile che lo invita a leggere il primo verso che trova nella Lettera ai Romani di S. Paolo: «Lo afferrai, lo aprii e lessi tacito il primo versetto su cui mi caddero gli occhi. Diceva: «Non nelle crapule e nelle ebbrezze, non negli amplessi e nelle impudicizie, non nelle contese e nelle invidie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo, e non assecondate la carne nelle sue concupiscenze» (8, 12, trad. di C. Carena). Il culmine mistico dell’opera è nella descrizione della visione estatica che precede la morte della madre: «Giungemmo alla nostra mente e la superammo per attingere alla regione dell’abbondanza … e mentre ne parlavamo e vi anelavamo, la toccammo appena in uno slancio totale del cuore (toto ictu cordis)» (IX 10). La seconda parte, che comprende gli ultimi quattro libri, tratta vari problemi filosofici a sostegno delle verità di fede; il più importante è quello dei rapporti tra eternità di Dio e temporaneità del mondo, che Agostino risolve intendendo il tempo come entità esistente e misurabile solo nello spirito umano. Scritti tra il 397 e il 401 durante i primi anni dell’episcopato dell’autore, i tredici libri di cui si compone il testo narrano di avvenimenti passati. In tutta la letteratura greco-romana non esistono precedenti di un’opera autobiografica in senso moderno: di tale genere letterario Agostino è quindi l’iniziatore. Lo stile Agostino ha scritto in ogni genere di prosa letteraria con uno stile personalissimo, che si caratterizza per l’efficacia di espressioni e immagini, il lessico nuovo e ricco, l’intensità del pensiero che rivela il continuo tormento dell’ascesi spirituale. Lo stile Agostino e la teologia della storia del De civitate Dei si uniforma alle esigenze di un pubblico colto, sia cristiano che pagano, abituato a un periodare complesso ed elaborato, sensibile alla magniloquenza. La lingua comprende elementi umili tipicamente cristiani, ma assume un tono decisamente elevato con lunghi e complessi giri di frase e rifugge dall’uso di costrutti (come la completiva con quod in luogo della infinitiva) ormai diffusi, ma non corrispondenti alle regole del latino puro. Anche le Confessiones sono scritte in una lingua colta, tuttavia vi si trovano raramente ampi periodi, ai quali vengono preferite rapide frasi legate paratatticamente: predomina la semplicità dello stile biblico, che peraltro caratterizza l’intera produzione di Agostino. A creare un «clima scritturale» concorre la densità delle citazioni dalle Scritture. I Romani scelgano la città celeste (De civ. Dei II 29). Il passo è un protrettico, cioè un invito ad aderire a una nuova visione del mondo (filosofia, religione), rivolto ai Romani, perché abbandonino il politeismo ed entrino nella città di Dio. Data la loro nobiltà originaria e la naturale inclinazione alla virtù – riconosciuta nell’apostrofe iniziale (o indoles Romana laudabilis) e attestata da uomini come Regolo, Scevola, Fabrizio, gli Scipioni – non sarà difficile per i Romani aderire ai valori cristiani: «È ormai evidente che il cristianesimo è pronto ad assumere su di sé l’eredità del mondo che sta per finire, integrandola nei nuovi valori religiosi che, soli, possono garantire continuità e durata» (G. F. Giannotti – A. Pennacini). Desidera piuttosto questi beni, o nobile natura romana, o progenie dei Regoli, degli Scevola, degli Scipioni, dei Fabrizi. Desidera questi beni, ma riconoscili come diversi da quella infame vanità e ingannevole malvagità dei dèmoni. Se spicca in te una qualche dote naturale degna di stima, soltanto la vera pietà può purificarla e portarla a perfezione: l’empietà può solo disperderla e deprimerla. Scegli ormai la via da seguire per essere lodata senza errore, non in te, ma nel vero Dio. Un tempo tu godesti grande gloria tra i popoli, ma per un segreto giudizio della divina provvidenza alla tua scelta mancò la vera religione. Svegliati, è tempo, come ti svegliasti in certi tuoi figli, della cui perfetta virtù ed anche del martirio per la vera fede noi cristiani ci gloriamo: essi hanno lottato fino al fondo contro potenze affatto ostili, le hanno vinte con una morte coraggiosa e «col loro sangue ci hanno procurato questa patria»1. A questa patria noi ti invitiamo e ti esortiamo ad aggiungerti al numero dei suoi cittadini, perché essa ha come asilo, in certo modo, la vera remissione dei peccati. Non ascoltare i tuoi figli degeneri che calunniano Cristo e i cristiani e li incolpano della nequizia dei tempi, mentre ricercano tempi in cui godere non di una quieta vita, ma piuttosto della sicurezza dei vizi. Questi tempi non ti sono mai piaciuti neppure per la tua patria terrena. È tempo ormai di afferrare la tua patria celeste, che ti costerà pochissima fatica, ed in essa veracemente ed in eterno regnerai. E là non vi sarà il fuoco di Vesta, o la pietra capitolina2, ma il Dio unico e vero che «non pone limiti alle cose o ai tempi, ma ti darà un impero senza fine»3. Cessa di andare in cerca di dèi falsi e bugiardi: rigettali piuttosto con disprezzo e spicca il volo verso la vera libertà. Essi non sono dèi, ma spiriti maligni, per i quali è sofferenza la tua eterna prosperità. (trad. di G. F. Giannotti – A. Pennacini) 1. Verg., Aen. XI 24. 2. Sul Campidoglio Giove era rappresentato da un simbolo aniconico – una pietra chiamata Jupiter lapis – a cui erano attribuiti particolari poteri: cfr. Aulo Gellio 1, 21. 3. Verg., Aen. I 278 ss. Il furto delle pere (Conf. II 9, 16-17). Da un furto di pere, commesso con amici quando era ancora quindicenne, Agostino trae spunto per una delle più famose pagine delle Confessioni. La riflessione, condotta con penetrante analisi psicologica, riconduce i motivi di quel gesto al desiderio fine a se stesso di compiere il male, di violare sprezzantemente la giustizia divina, di affermare titanicamente sé di fronte a Dio. Proprio per il suo carattere disinteressato e gratuito, il gesto assume un valore emblematico della naturale predisposizione a peccare dell’uomo. In quella ragazzata compiuta con la complicità del «branco» dei cattivi amici, Agostino scopre le radici del male allo stato puro, conseguente al peccato originale: un peccato, che il furto delle pere richiama anche per la sua somiglianza col gesto di Adamo (sottrazione di un frutto proibito). 667 BASSO IMPERO 668 Inizi della storiografia cristiana [9] La tua legge, Signore, condanna chiaramente il furto, e così la legge scritta nei cuori degli uomini, che nemmeno la loro malvagità può cancellare. Quale ladro tollera di essere derubato da un ladro? Neppure se ricco, e l’altro costretto dalla miseria. Ciò nonostante io volli commettere un furto e lo commisi senza esservi spinto da indigenza alcuna, se non forse dalla penuria e disgusto della giustizia e dalla sovrabbondanza dell’iniquità. Mi appropriai infatti di cose che già possedevo in maggior misura e molto miglior qualità; né mi spingeva il desiderio di godere ciò che col furto mi sarei procurato, bensì quello del furto e del peccato in se stessi. Nelle vicinanze della nostra vigna sorgeva una pianta di pere carica di frutti d’aspetto e sapore per nulla allettanti. In piena notte, dopo aver protratto i nostri giochi sulle piazze, come usavamo fare pestiferamente, ce ne andammo, da giovinetti depravatissimi quali eravamo, a scuotere la pianta, di cui poi asportammo i frutti. Venimmo via con un carico ingente e non già per mangiarne noi stessi, ma per gettarli addirittura ai porci. Se alcuno ne gustammo, fu soltanto per il gusto dell’ingiusto. Così è fatto il mio cuore, o Dio, così è fatto il mio cuore, di cui hai avuto misericordia mentre era nel fondo dell’abisso. Ora, ecco, il mio cuore ti confesserà cosa andava cercando laggiù, tanto da essere malvagio, senza motivo, senza che esistesse alcuna ragione della mia malvagità. Era laida e l’amai, amai la morte, amai il mio annientamento. Non l’oggetto per cui mi annientavo, ma il mio annientamento in se stesso io amai, anima turpe, che si scardinava dal tuo sostegno per sterminarsi non già nella ricerca disonesta di qualcosa, ma della sola disonestà. […] [16] Quale frutto raccolsi, allora, miserabile, da ciò che ora rievoco non senza arrossire, e specialmente da quel furto ove amai solo il furto e null’altro? E anch’esso era nulla, quindi più grande era la mia miseria. Tuttavia non l’avrei compiuto da solo. Ricordo bene qual era il mio animo a quel tempo, da solo non l’avrei assolutamente compiuto. In quell’azione mi attrasse anche la compagnia di coloro con cui la commisi. Dunque non amai null’altro che il furto. Ma sì, null’altro, poiché anche una tale società non è nulla. Cos’è in realtà? Chi può istruirmi in merito, se non Colui che illumina il mio cuore e ne squarcia le tenebre? Come accade che mi viene in mente d’indagare, di discutere, di considerare questi fatti? Se in quel momento avessi amato i frutti che rubai e ne avessi desiderato il sapore, avrei potuto compiere anche da solo, se si poteva da solo, quel misfatto, appagando il mio desiderio senza unirmi a qualche complice per infiammare il prurito della mia brama. Senonché i frutti non avevano nessuna attrattiva per me; dunque ne aveva soltanto l’impresa e a suscitarla era la compagnia di altri che peccavano insieme con me. [17] Quale sentimento provavo allora in cuore? Senza dubbio un sentimento proprio turpe assai, ed era una sventura per me il provarlo. Ma pure in che cosa consisteva? I peccati chi li capisce? Era il riso che ci sollecitava, per così dire, il cuore al pensiero di ingannare quanti non sospettavano un’azione simile da parte nostra e ne sarebbero stati fortemente contrariati. Perché dunque godevo di non agire da solo? Forse perché non è facile ridere da soli? Certo non è facile, però avviene talvolta di essere sopraffatti dal riso anche stando soli, tra sé e sé, alla presenza di nessuno, se appare ai nostri sensi o al pensiero una cosa troppo ridicola. Invece io quell’atto da solo non l’avrei compiuto, non l’avrei assolutamente compiuto da solo. Ecco dunque davanti a te, Dio mio, il ricordo vivente della mia anima. Da solo non avrei compiuto quel furto in cui non già la refurtiva ma il compiere un furto mi attraeva; compierlo da solo non mi attraeva davvero e non l’avrei compiuto. Oh amicizia inimicissima, seduzione inesplicabile dello spirito, avidità di nuocere nata dai giochi e dallo scherzo, sete di perdita altrui senza brama di guadagno proprio o avidità di vendetta. Uno dice: «Andiamo, facciamo», e si ha pudore a non essere spudorati. (trad. di C. Carena) I vasti palazzi della memoria (Conf. X 8, 12-13). Le riflessioni sulla natura del tempo e della memoria sono tra le pagine più luminose della letteratura mondiale su questo argomento. Il brano che riportiamo fonde in una visione originalissima suggestioni tratte da Platone (non le cose entrano nella memoria, ma la loro immagine), Cicerone, Quintiliano. Dunque oltrepasserò anche questa mia potenza naturale, ascendendo per gradi a quello che mi ha fatto: ed eccomi giunto ai campi e ai vasti palazzi della memoria, dove si accumulano tesori di innumerevoli immagini, per ogni sorta di oggetti della percezione. Lì è custodito tutto ciò che ci avviene di pensare, amplificando o riducendo o comunque variando i dati dei sensi, e quant’altro vi sia stato riposto in consegna, purché l’oblio non l’abbia ancora inghiottito o sepolto. E lì mi basta chiedere, quando mi ci trovo, che mi si presenti qualunque cosa io desideri: alcune arrivano subito, Agostino e la teologia della storia altre si fanno cercare più a lungo, come se occorresse stanarle da più segreti ricettacoli, altre ancora irrompono in massa, e mentre non le si cerca affatto saltano quasi fuori a dire «Siamo noi per caso?». E io con la mano del cuore le caccio via dalla sua vista, dal ricordo, finché lo sguardo non si snebbi e non appaia proprio la cosa nascosta che cercavo. Altre cose si offrono docilmente e di seguito, senza interruzioni, nell’ordine in cui eran state richieste, così che le precedenti fanno posto alle successive per tornare ai loro depositi, pronte a uscirne di nuovo a mio piacere. Tutto questo avviene quando recito a memoria. Lì si conservano, distinte per genere, tutte le cose che vi sono entrate – ciascuna dall’ingresso suo proprio: la luce e tutti i colori e le forme dei corpi dagli occhi, dalle orecchie ogni sorta di suoni, tutti gli odori dalle narici e tutti i sapori dalla bocca, e attraverso la sensibilità di tutto il corpo il duro e il molle, il caldo e il freddo, il liscio quanto il ruvido, e peso e leggerezza – insomma tutte le qualità dei corpi, esterne o interne che siano. E il grande antro della memoria tutto questo accoglie in certe sue pieghe segrete e ineffabili, perché si possa all’occorrenza richiamarlo e disporne: e ciascuna cosa che vi si ripone ha il suo ingresso riservato. Certo, non sono le cose stesse ad entrarvi: sono le immagini delle cose percepite che stanno lì, pronte a offrirsi al pensiero che le richiama alla mente. E chi può dire quale sia il loro segreto di fabbricazione? Palese è solo quali sono i sensi che le hanno catturate e consegnate in custodia. Io posso anche starmene in silenzio, al buio: ma se voglio rimetto a fuoco i colori nella memoria e distinguo il bianco dal nero e da qualunque altro colore: e non accade che i suoni si intromettano disturbandomi nella considerazione di ciò che ho appreso dalla vista. Eppure anch’essi si trovano lì: ma sono come latenti, in disparte. Tanto che se mi aggrada di richiamare anche loro, subito si presentano: e io senza muover la lingua, a gola muta, canto finché ho voglia: e a loro volta le immagini di colore, pur essendo ancora lì, non vengono a interferire e a disturbarmi nella mia rassegna di quest’altro tesoro confluito dalle orecchie. E così via, per tutte le altre cose immesse dagli altri sensi e lì ammassate: le richiamo alla memoria a mio piacimento, e senza annusarlo distinguo il profumo dei gigli da quello delle viole, e mi basta il ricordo per continuare a preferire il miele al decotto di mosto e il liscio al ruvido, senza nulla gustare né palpare al momento. (trad. di R. De Monticelli) La morte della madre (Conf. IX 8-12). È questa una delle pagine più toccanti delle Confessiones. La morte della madre, avvenuta ad Ostia nel viaggio di ritorno da Milano in Africa, fu un forte trauma nell’animo del giovane Agostino, che le era particolarmente legato. Il groviglio di sentimenti che lo attanagliava, acuiti dalla superiore esigenza di contenere le lacrime perché in contrasto con la fede nella vita eterna, sono descritti con profonda e delicata attenzione psicologica. [27] Cosa le risposi, non ricordo bene. Ma intanto, entro cinque giorni o non molto di più, si mise a letto febbricitante e nel corso della malattia un giorno cadde in deliquio e perdette la conoscenza per qualche tempo. Noi accorremmo, ma in breve riprese i sensi, ci guardò, mio fratello1 e me, che le stavamo accanto in piedi, e ci domandò, quasi cercando qualcosa: «Dov’ero?»; poi, vedendo il nostro afflitto stupore: «Seppellirete qui, soggiunse, vostra madre». Io rimasi muto, frenando le lacrime; mio fratello invece pronunziò qualche parola, esprimendo l’augurio che la morte non la cogliesse in terra straniera, ma in patria, che sarebbe stata la migliore fortuna. All’udirlo, col volto divenuto ansioso gli lanciò un’occhiata severa per quei suoi pensieri, poi, fissando lo sguardo su di me, esclamò: «Vedi cosa dice», e subito dopo, rivolgendosi a entrambi: «Seppellite questo corpo dove che sia, senza darvene pena. Di una sola cosa vi prego: ricordatevi di me, dovunque siate, innanzi all’altare del Signore». Espressa così come poteva a parole la sua volontà, tacque. Il male aggravandosi la faceva soffrire. [28] Io, al pensiero dei doni che spargi, Dio invisibile, nei cuori dei tuoi fedeli, e che vi fanno nascere stupende messi, gioivo e a te rendevo grazie, ricordando ciò che sapevo, ossia quanto si era sempre preoccupata e affannata per la sua sepoltura, che aveva provvista e preparata accanto al corpo del marito. La grande concordia in cui erano vissuti le faceva desiderare, tanto l’animo umano stenta a comprendere le realtà divine, anche quest’altra felicità, e che la gente ricordasse come dopo un soggiorno di là dal mare avesse ottenuto che una polvere congiunta coprisse la polvere di entrambi i congiunti. Quando però la piena della tua bontà avesse eliminato dal suo cuore questi pensieri futili, io non sapevo; ma ero pervaso di gioia e ammirazione che mia madre mi fosse apparsa così. Invero anche durante la nostra conversazione presso la finestra, quando disse: «Ormai 1. Il fratello di Agostino, di nome Navigio. 669 670 Inizi della storiografia cristiana cosa faccio qui?», era apparso che non aveva il desiderio di morire in patria. Più tardi venni anche a sapere che già parlando un giorno in mia assenza, durante la nostra dimora in Ostia, ad alcuni amici miei con fiducia materna sullo spregio della vita terrena e il vantaggio della morte, di fronte al loro stupore per la virtù di una femmina, che l’aveva ricevuta da te e alla loro domanda, se non l’impauriva l’idea di lasciare il corpo tanto lontano dalla sua città, esclamò: «Nulla è lontano da Dio, e non c’è da temere che alla fine del mondo egli non riconosca il luogo da cui risuscitarmi». Al nono giorno della sua malattia, nel cinquantaseiesimo anno della sua vita, trentatreesimo della mia, quest’anima credente e pia fu liberata dal corpo. [29] Le chiudevo gli occhi, e una tristezza immensa si addensava nel mio cuore e si trasformava in un fiotto di lacrime. Ma contemporaneamente i miei occhi sotto il violento imperio dello spirito ne riassorbivano il fonte sino a disseccarlo. Fu una lotta penosissima. Il giovane Adeodato2 al momento dell’estremo respiro di lei era scoppiato in singhiozzi, poi, trattenuto da noi tutti, rimase zitto: allo stesso modo anche quanto vi era di puerile in me, che si scioglieva in pianto, veniva represso e zittito dalla voce adulta, dalla voce della mente. Non ci sembrava davvero conveniente celebrare un funerale come quello fra lamenti, lacrime e gemiti. Così si suole piangere in chi muore una sorta di sciagura e quasi di annientamento totale; ma la morte di mia madre non era una sciagura e non era totale. Ce lo garantivano la prova della sua vita e una fede non finta e ragioni sicure. (trad. di C. Carena) BASSO IMPERO 2. È il figlio di Agostino. Particolare della «Gerusalemme celeste» in un mosaico della Basilica di S. Clemente a Roma. Orosio e Salviano Orosio e Salviano Prete spagnolo di Tarragona, dove nacque intorno al 390, Paolo Orosio (ma il praenomen Paolo non è certo), dopo essere fuggito dinnanzi all’invasione dei Vandali, conobbe Agostino in Africa (nel 414) e Girolamo in Palestina (nel 417). Scrisse due opere di carattere dogmatico: il Commonitorium de errore Priscillianistarum et Origenistarum contro le eresie diffuse in Spagna e il Liber apologeticus contra Pelagianos contro l’eresia pelagiana. L’opera principale sono le Historiae adversus paganos («Storie contro i pagani»). Dopo il 418 di lui si perdono le tracce. Le Historiae sono in 7 libri: i primi sei sulle vicende che vanno dalle origini del mondo all’avvento di Cristo, l’ultimo sull’età imperiale fino al 417. In base a una periodizzazione che risale alla Bibbia, ripresa da Eusebio e Girolamo, la storia del mondo è scandita dalla successione di quattro imperi (Babilonia, Macedonia, Cartagine, Roma). La nascita di Cristo segna la svolta radicale nella storia dell’umanità e l’inizio di un nuovo corso. L’interesse dell’opera, la prima storia universale cristiana, non risiede nell’originalità della trattazione e neppure nella rilevanza delle notizie offerteci, bensì nell’idea direttrice che l’impero romano sia il braccio secolare della provvidenza divina, da questa voluto per favorire la diffusione del cristianesimo. Scritte su invito di Agostino – che allora stava componendo il De civitate Dei e s’impegnava a confutare la tesi dei pagani che le sventure del presente fossero imputabili al cristianesimo – le Historiae servono a suffragare la tesi opposta: nell’era cristiana l’umanità vive tempi di maggiore prosperità. Prima di Cristo, gli uomini erano afflitti da un’infinita serie di calamità e guerre. Ma con l’avvento della vera fede, che ha introdotto costumi più miti e più vivo senso della giustizia, le sventure sono diminuite e cesseranno completamente. Già l’età presente sembra all’autore più prospera delle precedenti. La vita di Orosio Scrutando così nel passato, è apparso chiaro che allora regnava la morte avida di sangue, giacché non si conosceva la religione che dal sangue tiene lontani; a mano a mano che questa cominciava a risplendere, la morte restava come attonita, mentre ormai la religione prevale; in avvenire non vi sarà più morte, quando la religione sola regnerà. I Prol., 14-15 Questa concezione provvidenzialistica e teleologica implica una visione ottimistica delle sorti future dell’umanità, ma anche una selezione tendenziosa degli eventi della storia pagana. Questi infatti sono scelti in modo da confermare la tesi dell’infelicità dell’era precristiana. I grandi avvenimenti e i personaggi dell’antichità sono demitizzati, mentre sono sottovalutati i mali presenti, in particolare il pericolo dei barbari. Nonostante il sacco di Roma (410) – che comunque è interpretato come la conseguenza del decadimento morale dei pagani – Orosio è convinto che i barbari, convertendosi al verbo di Cristo, si integreranno pacificamente nel tessuto della nuova civiltà romano-cristiana. L’idea di un concorso sinergico tra impero romano – voluto da Dio, che nella persona del figlio accettò di farsi civis Romanus sotto Augusto – e cristianesimo avrà grande successo nel Medioevo e sarà alla base della concezione politico-religiosa di Dante. Una diversa posizione assume nei confronti del problema dei barbari il monaco Salviano, nato intorno al 400 a Treviri (o a Colonia), nel trattato in 8 libri dal titolo De gubernatione dei. L’opera intende fornire una risposta in chiave fortemente moralistica alla domanda che si leva insistente dalle varie comunità cristiane sul perché delle invasioni barbariche. Il sacco di Roma ad opera dei soldati di Alarico nel- Una visione provvidenzialistica Una storiografia apologetica Il De gubernatione di Salviano 671 672 Inizi della storiografia cristiana l’agosto del 410 a.C. aveva prodotto un’intensa emozione e assunto un forte significato simbolico: Girolamo aveva paragonato l’evento alla caduta di Troia cantata da Virgilio e alla distruzione di Gerusalemme di cui avevano parlato i profeti. Anche le Historiae di Orosio e il De civitate Dei di Agostino intendevano rispondere, se non proprio a questa specifica domanda, al quesito più generale del perché della decadenza dell’età presente. Sollecitavano una risposta forte e teologicamente fondata anche le critiche dei pagani, che interpretavano la decadenza come punizione degli dei pagani sostituiti dal Dio cristiano. Le invasioni dei barbari, sostiene Salviano, sono la punizione divina per le colpe di cui si sono macchiati i cristiani, dei quali biasima la tiepidezza nel culto, nelle opere e contro i quali rivolge la propria indignazione morale. I cristiani – e non più i pagani ormai privi di ogni influenza – sono il bersaglio della polemica. In questa prospettiva i barbari, non solo sono lo strumento di una giusta pena, ma sono considerati assai migliori dei cristiani, i nuovi favoriti di Dio. Arricchiti di virtù che non hanno riscontro nella loro realtà culturale e morale, i barbari subiscono un processo di idealizzazione che li rende il termine positivo rispetto al quale si misurano le mancanze e le miserie dei cristiani. Cristo, civis Romanus (7, 22). Riportiamo il passo cruciale delle Historiae di Orosio che contiene la legittimazione cristiana dell’impero romano. La provvidenza divina avrebbe voluto l’ascesa di Roma a signora del mondo, perché Cristo potesse diffondere il suo Verbo su scala universale. Questa tesi diventerà presto la dottrina ufficiale della Chiesa. Allora dunque nacque Cristo che subito, appena nato, fu iscritto nel censimento romano. E questa iscrizione così augusta suggellò in modo clamoroso ed evidentissimo la proclamazione di Cesare a signore universale e i Romani a dominatori degli uomini, individualmente e collettivamente considerati … E non ho il minimo dubbio che chiunque ha intelligenza, fede e capacità di discernere è in grado di vedere chiaramente che è stato il nostro Signore Gesù Cristo a far crescere con il suo volere questa città e a portarla al culmine della potenza, dal momento che, alla sua venuta in questo mondo, ha voluto esserne cittadino, poiché infatti Cristo, in virtù della sua iscrizione al censimento romano, si deve chiamare cittadino romano. BASSO IMPERO (trad. di E. Corsini) Grammatica, erudizione Macrobio Vittorino, Donato, Servio, Marziano Capella 674 Grammatica, erudizione Macrobio La vita I Saturnali BASSO IMPERO I contenuti V 1, 7 I personaggi Della vita di Ambrogio Teodosio Macrobio non sappiamo quasi nulla, tranne che dovette essere un personaggio di rango senatorio (lo prova la formula vir clarissimus et illustris assegnatagli nei codici) forse di origini africane, legato alla famiglia dei Simmachi. È incerto se lo si debba identificare col Macrobio prefetto di Spagna nel 399 o con quello che fu prefetto del pretorio nel 430. La questione non è irrilevante e ha conseguenze nell’interpretazione dei suoi scritti, che sono i Commentarii in Somnium Scipionis (commento in chiave neoplatonica del finale del libro VI del De repubblica ciceroniano), i sette Saturnaliorum convivia («Conviti durante i Saturnali»), il trattato grammaticale De differentiis et societatibus Graeci Latinique verbi («Differenze e analogie fra il verbo greco e quello latino») di cui restano scarsi frammenti. Queste opere assumono un significato diverso a seconda che siano state composte alla fine del IV secolo, quando la cultura pagana conservava una certa vitalità, o verso la metà del V, quando ormai il cristianesimo aveva celebrato il suo trionfo. I Saturnaliorum convivia sono un dialogo che si svolge per tre giorni (dal 17 al 19 dicembre), durante la festa dei Saturnali, tra personaggi di primo piano della cultura pagana riuniti a convivio: Aurelio Simmaco, Avieno (forse figlio del poeta omonimo), il grammatico Servio, l’oratore Eusebio, il filosofo Eustazio e altri esponenti dell’intellettualità del tempo. L’anno dell’ambientazione è il 384. La serena cornice letteraria del banchetto dei sapienti, un espediente narrativo non nuovo il cui archetipo è nel Simposio di Platone, movimenta l’esposizione e rende più gradevole la lettura. Gli argomenti dibattuti nella prima giornata sono di varia erudizione e spaziano dalla linguistica alla letteratura, dalla medicina alla filosofia, dall’astronomia ai motti di spirito arguti degli antichi. Nei due giorni successivi l’oggetto della discussione è soprattutto Virgilio, considerato fonte d’ogni sapere (anche in campo scientifico, giuridico, filosofico) e modello di ogni stile: Quattro sono, disse Eusebio gli stili del discorso: quello copioso (copiosum), in cui prevale Cicerone; quello conciso (breve), in cui domina Sallustio; quello sobrio (siccum) di cui è maestro Frontone; quello ampolloso e fiorito (pingue et floridum), nel quale si distinse in passato Plinio il Giovane ed ora, non inferiore ad alcuno degli antichi, il nostro Simmaco. Ma nel solo Virgilio troverai questi quattro generi di stile. Il poeta dell’Eneide è oggetto di un culto, da parte dei convitati, che fa presagire la fortuna che avrà nel Medioevo. La sua opera comincia già ad essere interpretata in senso mistico-allegorico. I personaggi, e in particolare i tre anfitrioni (Pretestato, Simmaco, Flaviano), sono ben caratterizzati e i loro interventi riflettono le specifiche competenze di ciascuno: il Vittorino, Donato, Servio, Marziano Cappella gran sacerdote e seguace di culti orientali Pretestato disquisisce di questioni di carattere religioso, di Virgilio trattano Simmaco, Eustazio, e Servio: il primo ne discute lo stile, il secondo la filosofia, il terzo commenta alcuni passi controversi. Un personaggio petulante e solo letterario, Evàngelo, svolge il ruolo di denigratore di Virgilio (obtrectator Vergilii), innescando vivaci scambi polemici con gli altri convitati. Nonostante il carattere compilatorio dell’opera – che assembla materiali di varia provenienza, spesso trasferendoli di peso dall’originale, come avviene per alcuni passi delle Notti Attiche di Gellio – l’autore mira a dare organicità e ordine all’insieme: «Non ho certo raccolto senz’ordine, come in un mucchio, le cose degne di ricordo … ma le disparità dei vari argomenti … ho disposte in un complesso organico, di modo che … risultassero ordinate e ben connesse come le membra di un corpo» (Praef. 3). Oltre a Gellio, figurano tra le fonti Varrone, Svetonio, Plutarco. L’interesse antiquariale non concerne aspetti futili o secondari, ma focalizza problemi nodali della cultura pagana, concernenti il significato attuale e la sopravvivenza di questa nei tempi del cristianesimo trionfante, anche se di cristianesimo Macrobio, curiosamente, non parla mai. Pur nella serena finzione del dialogo conviviale tra dotti, si ha l’impressione di un arroccamento come per un’estrema, vana difesa. Questi rappresentanti prestigiosi dell’intellettualità pagana, simboli della grande tradizione classica, percepiscono la fine d’un mondo e s’affrettano a rievocarlo, ben consapevoli che non potrà più tornare. Essi «sembrano intenti a redigere un inventario globale del loro sapere, prima che si disperda o taccia sopraffatto da altre culture, da altre concezioni del mondo» (G.F. Giannotti). Incrollabile è infatti la loro certezza che quel patrimonio culturale meriti d’essere conservato: Se siamo assennati dobbiamo avere una sconfinata ammirazione per i tempi antichi. Sono quelle le generazioni che crearono questo immenso impero col sudore e col sangue. Certo non vi sarebbero riusciti, se non li avessero sorretti grandi doti di virtù. L’intento enciclopedico L’arroccamento culturale III 14, 2 Vittorino, Donato, Servio, Marziano Capella Africano d’origine, Mario Vittorino fu maestro di retorica famoso sotto Costanzo II, al punto da ricevere nel 353 l’onorificenza di una statua nel Foro di Traiano. La vicenda della sua conversione al cristianesimo – esemplare per la notorietà del personaggio, la cui scuola era frequentata da membri dell’aristocrazia pagana – è riferita da Agostino, che rievoca il momento in cui «tra lo stupore di Roma e la gioia della Chiesa» Vittorino, ormai in extrema senectute, prese il battesimo. In seguito al decreto di Giuliano che vietava ai cristiani d’insegnare nelle scuole, si ritirò a vita privata e attese alla composizione di molti scritti. Vittorino curò varie traduzioni dal greco (perdute) di opere filosofiche di Aristotele, Porfirio, Plotino; scrisse il trattato di logica De definitionibus (sulla teoria della definizione), l’Ars grammatica (conservataci solo nelle parti relative alla fonetica e all’ortografia); compose commenti al De inventione di Cicerone e alle epistole di S. Paolo (agli Efesini, ai Gàlati, ai Filippesi), scritti teologici contro l’arianesimo e il manicheismo: De homousio recipiendo («Sulla necessità di accogliere la dottrina della consustanzialità», cioè dell’uguaglianza nella sostanza tra Padre e Figlio), Adversus Arium, Ad Candidum Arianum, De generatione divini Verbi. Restano anche tre inni ritmici sul tema trinitario, privi della struttura metrica tradizionale e notevoli per il lirismo ispirato ai Salmi. L’interesse per i filosofi neoplatonici, in particolare per Porfirio – nel cui pensiero, ammette Agostino, «almeno si suggerisce l’idea di Dio e del suo Verbo» – dovette Le opere 675 676 Grammatica, erudizione Elio Donato BASSO IMPERO Servio Marziano Capella facilitare la conversione al cristianesimo, col quale il neoplatonismo condivideva la trascendenza divina e il monoteismo. Le traduzioni di Plotino e Porfirio attestano anche un fervore di studi filosofici neoplatonici a Roma verso la fine del IV secolo. L’apprezzamento di Agostino, che lo elogia come «dottissimo maestro, grande conoscitore di ogni disciplina liberale» (Conf. VIII 2), non è condiviso da Girolamo, che ne critica le oscurità e le sottigliezze. Forse africano, nato intorno al 310, il grammatico Elio Donato fu protagonista, insieme con Vittorino, della rinascita di studi filologici e antiquariali del IV secolo. Grande cultore di classici, dei quali sapeva trasmettere l’amore ai propri discepoli (tra questi, Girolamo e Rufino), scrisse due manuali scolastici di grammatica, un’Ars minor per i principianti e un’Ars maior per gli studi avanzati. Nel primo si analizzano le otto parti del discorso (conservate nell’analisi grammaticale fino ai nostri tempi), nel secondo sono trattati argomenti di stile e di metrica. Di un commento a Virgilio restano un’introduzione alle Bucoliche e una biografia del poeta dipendente da Svetonio. Un commento alle commedie di Terenzio, pervenuto quasi integro (manca solo la parte relativa all’Heautontimorùmenos), è di grande interesse per gli interpreti del commediografo, in quanto ci informa sulle circostanze delle rappresentazioni e sui rapporti con gli originali greci, che Donato leggeva ancora mentre per noi sono perduti. In particolare le due Artes ebbero grande fortuna durante il Medioevo fino a tutto l’Umanesimo, al punto che Donatus finì col designare, per antonomasia, la grammatica. Divenuti un classico della grammatica latina, i due manuali furono variamente rimaneggiati: fusi in uno solo, ampliati oppure ridotti, trasformati in commenti. Dante ricorda nel Paradiso «quel Donato/ ch’a la prim’arte degnò porre mano» (XII 137-138), intendendo con prim’arte la grammatica che apriva gli studi del Trivio. Probabilmente allievo di Donato di cui curò un commento delle Artes (Explanatio in artem Donati), Servio è uno dei convitati dei Saturnales di Macrobio. Vissuto a Roma tra il IV e il V secolo, scrisse un celebre commento a Virgilio (all’Eneide, alle Bucoliche, alle Georgiche), del quale sono rimaste due stesure: una scolastica breve e una più ampia consistente in una serie di annotazioni (scolia) di carattere grammaticale, stilistico, antiquariale. La seconda redazione – denominata Servius Danielinus da Pierre Daniel, che ne curò l’edizione parigina del 1600 – fu incrementata nel tempo con l’aggiunta di materiali eruditi di altri autori (in particolare di Donato), pertanto si configura come la summa di una lunga tradizione scolastica di esegesi dei testi di Virgilio: perciò è denominata anche Servius auctus, cioè accresciuto da materiali medioevali. Le note «danieline» sono di grande interesse, oltre che per lo studio di Virgilio, perché riportano citazioni di testi perduti che altrimenti non potremmo leggere. Inoltre ci fanno conoscere i metodi della critica letteraria nell’antichità. Virgilio nel commentario serviano comincia ad assumere i tratti del maestro di sapienza, quale sarà nel Medioevo. Iniziano qui le interpretazioni allegoriche dei testi virgiliani (ad esempio dell’egloga IV, del VI libro dell’Eneide), nate anche per favorire il sincretismo tra mondo classico e cristiano. Sempre, nel corso della storia, la tradizione sopravvive se è in grado di accogliere le istanze dei nuovi tempi. Così la cultura pagana, per non morire, doveva integrarsi nella visione cristiana del mondo. Alla sintesi tra cultura classica e cristianesimo, tra vecchio e nuovo, preludono i nove libri del De nuptiis Mercurii et Philològiae dell’avvocato cartaginese Marziano Capella, vissuto nella prima metà del V secolo. L’opera, mista di versi e prosa (prosimetro) sul modello delle sature Menippeae, è l’enciclopedia delle arti liberali: grammatica, dialettica, retorica, geometria, aritmeti- Vittorino, Donato, Servio, Marziano Cappella ca, astronomia, musica. Queste, ridotte a sette rispetto alla suddivisione tradizionale che includeva anche l’architettura e la medicina, costituiranno il Trivio e il Quadrivio del Medioevo. Nell’allegoria del De nuptiis, Mercurio sposa la Filologia, doctissima virgo cui gli dei concedono l’immortalità. Le sette arti, ciascuna delle quali si presenta a partire dal terzo libro (i primi due narrano le mistiche nozze), saranno le sue ancelle. Le parti poetiche riecheggiano versi di Lucrezio, Catullo e dei poeti augustei. Il modello dell’allegoria è la favola di Amore e Psiche di Apuleio, da cui le nozze di Filologia derivano molte immagini e situazioni narrative, il gusto per l’allegoria, lo stile turgido e ricercato. Soprattutto apuleiano è l’elemento iniziatico e misterico di ascendenza neoplatonica, che agevola il sincretismo religioso e culturale ricercato da questi autori della tarda latinità. 677 Oratoria, retorica, epistolografia I Panegyrici Latini Simmaco e la reazione pagana Retorica e Cristianesimo: Tertulliano, Minucio Felice, Cipriano, Ambrogio, Girolamo, Lattanzio La nuova eloquenza cristiana di Agostino Epistolografia cristiana: Ambrogio, Girolamo, Agostino 680 Retorica e tarda latinità Retorica e tarda latinità I Panegyrici Latini BASSO IMPERO Gli stereotipi del genere encomiastico Lo stile Il corpus dei cosiddetti Panegyrici Latini comprende 12 composizioni encomiastiche in onore di imperatori pronunciate in un arco di tempo che va dal 289 al 389. La raccolta, che probabilmente fu approntata in Gallia e aveva una destinazione scolastica, si apre col Panegirico di Plinio il Giovane, che di questo genere oratorio è il modello indiscusso. Dei 12 componimenti (includendo anche quello pliniano), cinque sono anonimi. Gli autori dei rimanenti sono uno sconosciuto Memertino, i due retori gallici Eumenio e Nazario, Flavio Claudio Mamertino, Latinio Pacato Drepanio. Gli imperatori dedicatari sono Massimiano, Costanzo, Costantino, Giuliano, Teodosio. Le circostanze sono il compleanno dell’imperatore, un matrimonio o una vittoria, l’assunzione di una carica pubblica da parte dell’autore. Il carattere ufficiale e propagandistico, l’aderenza a schemi retorici assai vincolanti, la selezione dei soli contenuti positivi e la rimozione di quelli più imbarazzanti per il celebrato rendono tutti simili tra loro i panegirici e comportano che il loro interesse storico-documentario sia limitato. Il fatto stesso che nella raccolta sia incluso il panegirico di Plinio a Traiano, scritto quasi tre secoli prima, dimostra la fissità nel tempo delle forme dell’oratoria elogiativa. Certo, la veste retorica e la visione obbligatoriamente ottimistica non sempre riescono ad occultare le difficoltà dell’impero (i barbari ai confini, le condizioni dell’economia, ecc.), ma il celebrato quasi sempre è presentato come colui che a questi problemi cruciali ha saputo dare una soluzione. Ad esempio, nel panegirico di Massimiano, si ammette che ad ogni secca del Reno sorge il timore che i Germani lo attraversino, ma ciò riguarda il passato precedente alle vittoriose campagne militari di quell’imperatore: «Ma tu, invitto signore, hai sottomesso quelle genti fiere e indomite … Da allora noi siamo finalmente liberi da ogni preoccupazione» (2, 7, 6-7). Non si deve sottovalutare la funzione «mediatica» di pubblicizzazione della politica dell’imperatore, svolta da queste composizioni. Ma al di là dell’enfasi propria del genere encomiastico, questi scritti attestano la sincera convinzione dell’importanza della cultura tradizionale e la certezza di una sua rivincita sul trionfante cristianesimo, che nei panegirici viene semplicemente ignorato. Inoltre costituiscono un prezioso documento sull’insegnamento della retorica e quindi sul tipo di istruzione impartita ai ceti dirigenti del tempo. Queste composizioni d’apparato risultano fastidiose e stucchevoli per il gusto del lettore moderno a causa della magniloquenza, delle iperboli inverosimili, delle espressioni fatte per compiacere al celebrato, cui l’elogio era stato preventivamente sottoposto per l’approvazione. Disturbano la ricorsività monotona dei motivi, la fissità dello schema espositivo simile a quello degli antichi elogia: si inizia con la descrizione della patria e della formazione del celebrato, poi si passa alle sue imprese e virtutes rafforzando le lodi con exempla tratti dal mito e dalla storia, infine si formulano gli auguri di fortuna e prosperità. Naturalmente abbondano poetismi e forme ricercate, espressioni di sentenziosità astratta e solenne, dotte allusioni ai classici. Simmaco e la reazione pagana Simmaco e la reazione pagana Il più audace tentativo di restaurazione pagana è rappresentato dalla politica di Giuliano, detto l’Apostata per avere abiurato il cristianesimo, ormai divenuto religione di stato. Attorno a questo imperatore filosofo, imitatore di Marco Aurelio, si strinsero i massimi esponenti dell’intellettualità pagana. L’azione di Giuliano concerneva il rilancio della religione tradizionale rivisitata in chiave neoplatonica, il restauro dei templi, l’abolizione dei privilegi della Chiesa, il divieto ai cristiani di insegnare nelle scuole pubbliche. La morte dell’imperatore nella campagna contro i Parti del 363 troncò il progetto, tuttavia non pochi esponenti dell’aristocrazia romana continuarono ad impegnarsi nella difesa della cultura tradizionale. In particolare due famiglie della nobiltà senatoria, i Simmachi e i Nicomachi, furono il punto di riferimento della ripresa pagana, che in un primo tempo non fu ostacolata dalla politica tollerante di Gioviano e Valentiniano, i successori di Giuliano. Ma con Teodosio i culti antichi furono vietati e non ci fu più lo spazio politico per una restaurazione classicistica. In tale contesto si svolge l’attività di Quinto Aurelio Simmaco, esponente dell’aristocrazia senatoria romana nato verso il 340, oratore famoso, prefetto di Roma nel 384-385 e console nel 391. Alla corte di Valentiniano I (364-375) conobbe il poeta Ausonio. È il paladino della cultura negli anni cruciali in cui il cristianesimo diviene religione di stato e il paganesimo è posto al bando. La parentesi anticristiana di Giuliano Di lui ci restano otto orazioni incomplete, tre panegirici (dedicati a Valentiniano e Graziano, pronunciati alla corte di Treviri) e un copioso epistolario di circa 900 lettere indirizzate a personaggi pubblici tra i quali lo stesso Stilicone, il potente generale vandalo di Teodosio. 49 lettere sono Relationes, cioè rapporti ufficiali inviati all’imperatore da un magistrato, altre hanno carattere privato (epistulae salutatoriae cioè di saluti e convenevoli, commendaticiae cioè di raccomandazione, consolatorie, di ringraziamento, ecc.). L’epistolario è ordinato secondo il modello pliniano: dei nove libri in cui è diviso, i primi otto contengono lettere private, il decimo quelle di carattere pubblico. Opere In particolare nella Relatio III Simmaco chiede che venga ricollocata nella Curia l’ara della Vittoria, rimossa da Graziano. Il monumento, voluto da Augusto dopo la battaglia di Azio nel 31 a.C., era un simbolo della paganità e il segno visibile della protezione accordata dagli dei pagani all’impero romano: sull’ara i senatori gettavano granelli d’incenso entrando nella Curia. Simmaco presenta la petizione alla corte di Milano nel 384, nella sua veste di praefectus urbi. La restituzione dell’insigne monumento s’impone, secondo Simmaco, per motivi di tolleranza religiosa e per garantire la sicurezza dell’impero: La questione dell’altare della Vittoria Restauriamo, quindi, i riti e i culti, che così lungamente protessero il nostro stato. Possiamo certo noverare prìncipi seguaci dell’una o dell’altra fede: d’essi i primi hanno professato la religione dei padri; altri, più vicini a noi, pur non professandola, non l’hanno soppressa. Ora, se non serve a voi d’esempio la religione dei primi, vogliate almeno ispirarvi alla tolleranza di quegli altri. Chi è così amico dei barbari da non rimpiangere l’altare della Vittoria? Noi siamo pensosi delle future sorti dell’impero e temiamo che l’avvenuta rimozione di quell’ara possa essere per l’impero presagio di sventure. Un parere contrario alla ricollocazione fu espresso in due discorsi da Ambrogio, il cui punto di vista intransigente finì col prevalere presso l’imperatore Valentiniano II. L’ara della Vittoria non ritornò più nella Curia. Al nobile pagano che affermava un principio di relativismo culturale e di rispetto La battaglia di Simmaco III 3; trad. di L. Canfora 681 682 Retorica e tarda latinità O lingua che spande una fonte mirabile di parole, gloria dell’eloquenza romana, di fronte alla quale s’inchinerebbe perfino Cicerone, tanto è il fulgore della sua mirabile facondia! Bocca degna di risplendere eternamente d’oro, se mai volesse un giorno lodare Dio, al quale ha preferito orridi mostri, profanando con un delitto la sua voce armoniosa. BASSO IMPERO Contra Symm. I 632-637 delle diversità («Che importa se ognuno cerca la verità a modo suo? Non si può conoscere un così grande mistero per un solo cammino», 3, 10) il vescovo cristiano rispondeva così: «La salvezza non potrà essere ottenuta se non si adora il vero Dio, cioè quello dei cristiani … gli dèi pagani sono demòni» (par. 1). La durezza della contrapposizione tra pagani e cristiani in questi anni cruciali per il rapporto tra le due culture non impediva tuttavia al cristiano Prudenzio di esprimere stima e ammirazione per Simmaco, auspicando che egli ponesse la propria eloquenza al servizio della vera fede: Dittico dei Nicomachi e dei Simmachi (400 circa). Parigi, Museo di Cluny; Londra, Victoria and Albert Museum. Retorica e Cristianesimo Tertulliano, Minucio Felice, Cipriano, Ambrogio, Girolamo, Lattanzio Tertulliano, Minucio Felice, Cipriano, Ambrogio, Girolamo, Lattanzio Il rapporto degli scrittori cristiani con il patrimonio retorico classico – nei secoli che conducono dalla tarda antichità al Medioevo – si articola lungo due direttive principali: da un lato essi conoscono gli strumenti della persuasione retorica e se ne valgono, soprattutto nella predicazione o negli scritti a difesa del pensiero cristiano; dall’altro ne rifiutano il carattere di artificio contrapposto alla semplicità anche stilistica del messaggio evangelico. Tra i tipi canonici di orazioni, quella di genere giudiziario è ben conosciuta dagli autori che, all’epoca delle persecuzioni, si propongono di difendere i cristiani come davanti a un tribunale. È il caso evidente dell’Apologeticum (scritto apologetico, ossia di difesa) del cartaginese Tertulliano, composto verso la fine del II secolo d.C. da uno scrittore che ben conosceva i procedimenti della giurisprudenza e della retorica. Indirizzando la propria difesa ai governatori romani, egli da un lato respinge le accuse infamanti rivolte alle prime comunità cristiane, dall’altro, in perfetto stile processuale, controbatte passando all’attacco. La terminologia oratoria giudiziaria appare evidente all’inizio del capitolo II: I padri della Chiesa Se dopo tutto è certo che noi siamo dei grandi delinquenti, perché mai veniamo trattati da voi stessi diversamente dai nostri simili, cioè dagli altri delinquenti, mentre per una stessa colpa dovrebbe esservi trattamento uguale? Quando gli altri sono accusati di tutte le cose che a noi vengono imputate, essi possono, con la propria voce o per mezzo di una voce pagata, provare la propria innocenza; essi hanno facoltà di risposta, di contraddittorio, perché non è affatto lecito condannare qualcuno senza che sia stato difeso ed ascoltato. Ai cristiani non è invece permesso di dire ciò che li discolperebbe dall’accusa, farebbe rifulgere la verità dei fatti, impedirebbe al giudice di commettere un’ingiustizia … Apologeticum II 1 ss.; trad. di L. Rusca Probabilmente conobbe l’Apologeticum tertullianeo Minucio Felice, che ne riecheggia alcuni passaggi nel dialogo Octavius. Nato nell’africana Numidia, Minucio Felice visse a cavallo dei secoli II e III e fu avvocato: conobbe quindi anch’egli le procedure dell’oratoria giudiziaria e le leggi della retorica classica. Il dialogo si svolge tra l’autore stesso, il cristiano Ottavio ed il pagano Cecilio, che, scettico all’inizio, si convertirà infine al cristianesimo. Si tratta quindi sempre di un’opera apologetica, ma condotta nei toni più temperati e moderati del dialogo e con notevoli aperture nei confronti della cultura classica, di cui traspare nel testo la conoscenza da parte dell’autore. Echi dell’Octavius si ritrovano a loro volta nell’Ad Donatum di Cipriano (III secolo). Anch’egli africano e famoso professore di retorica prima della conversione, così esprime nell’Ad Donatum la differenza tra la forma esteriore dell’oratoria giudiziaria e l’importanza del contenuto della Parola divina: Nei tribunali e nei discorsi che si tengono al foro, facciano pure sfoggio di ricca facondia messa al servizio della volubile ambizione. Quando si parla Minucio Felice Tertulliano Cipriano Ad Donatum; trad. di G. Toso 683 684 Retorica e Cristianesimo del Signore e di Dio la nostra parola dev’essere chiara e sincera; per documentare la fede dobbiamo far uso dei fatti, non della forza che deriva dall’eloquenza. Ascolta quindi gli argomenti che hanno della sostanza e non si curano della forma. Accetta le parole che non sono artificiosamente costruite ed esposte in modo elegante per adescare le orecchie della gente, ma sono semplici parole dette sulla falsariga di una disadorna verità, però adatte a divulgare la bontà di Dio. De habitu virginum XXI 1 ss.; trad. di G. Toso Ambrogio BASSO IMPERO Girolamo Epistola 22; trad. di S. Cola Lattanzio Dal trattato De habitu virginum («La condotta delle vergini»), nato da una raccolta di omelie (i discorsi di insegnamento ed esortazione tenuti dal predicatore durante il rito religioso), si legga inoltre l’inizio del paragrafo XXI come esempio della facoltà oratoria di Cipriano predicatore: Ascoltatemi dunque, o vergini, come un padre: vi prego di ascoltarmi, mentre mi preoccupo di voi e vi ammonisco. Date ascolto a uno che con sincerità si preoccupa del vostro bene e del vostro vantaggio. Siate come vi ha fatto Dio Creatore. Siate come le mani del Padre vi ha fatte. Conservate il volto senza trucco, il collo libero da collane, l’aspetto naturale. La maggior parte degli scritti esegetici del grande vescovo di Milano (vedi il profilo, p. 644) rappresentano la rielaborazione di precedenti omelie. La destinazione originaria traspare dall’intento pratico e didattico dei testi. Di qui anche la frequenza dei modi del parlato. Della suggestione esercitata sui fedeli dall’oratoria di Ambrogio fu testimone anche il giovane Agostino, giunto a Milano dall’Africa. Parte dei discorsi di Ambrogio hanno una valenza politica e si legano all’alto magistero ricoperto e agli obblighi conseguenti. È il caso delle orazioni funebri Sulla morte di Valentiniano II e Sulla morte di Teodosio (pronunciato nel 395 davanti al figlio ed erede Onorio). Originarie omelie sono anche gli scritti dei trattati De sacramentis e De mysteriis. L’oratoria cristiana di Ambrogio testimonia l’impegno di adeguare al messaggio cristiano le forme dell’oratoria epidittica insegnate nelle scuole, fondendo motivi retorici tradizionali con i temi della liturgia ecclesiastica. Di qui l’impiego degli strumenti retorici tradizionali, usati a fini parenetici e persuasivi. Nel IV secolo si collocano Elio Donato e Girolamo. Elio Donato è autore di quella famosa Ars grammatica che avrebbe costituito durante il Medioevo il manuale di riferimento per l’educazione elementare (vedi p. 676). Allievo di Elio Donato a Roma fu Girolamo, che dal maestro apprese i fondamenti della cultura classica, la cui approfondita conoscenza avrebbe contrassegnato, come una trama sotterranea, la sua successiva produzione letteraria. Egli avverte con intensità il contrasto del pensiero cristiano con i testi pagani. Nei confronti di questi prova sia attrazione che repulsione, ritenendo infine possibile una loro convergenza secondo una prospettiva cristiana. Famosa è al proposito l’epistola 22: … me ne ero andato a Gerusalemme a militare per Cristo. Ma dalla mia biblioteca, messa assieme a Roma con tanto amore e tanta fatica, proprio non avevo saputo staccarmi. Povero me! Digiunavo, e poi andavo a leggere Cicerone. Dopo molte notti trascorse vegliando, dopo aver magari versato fiumi di lacrime che sgorgavano dal profondo del cuore al ricordo dei peccati d’un tempo, prendevo in mano Plauto. Se talvolta, rientrando in me stesso, aprivo i libri dei Profeti, il loro stile disadorno mi dava la nausea. Insegnanti di retorica furono Arnobio – vissuto sotto l’imperatore Diocleziano e nel territorio dell’Africa proconsolare, autore anch’egli di un’opera di stampo apologetico, dal titolo di Adversus gentes – ma soprattutto Lattanzio (IV secolo). Questi fu definito da Girolamo nel De viris illustribus «una sorta di fiume di eloquenza ciceroniana», per il Tertulliano, Minucio Felice, Cipriano, Ambrogio, Girolamo, Lattanzio suo bagaglio di conoscenze classiche, che egli mira a conciliare con quelle cristiane. Dalla retorica classica vorrebbe trarre gli ornamenti stilistici per avvicinare al messaggio evangelico anche i pagani, sospettosi nei confronti dello stile troppo spoglio delle Sacre Scritture. La sua opera maggiore, le Divinae Institutiones, modella, per ammissione dello stesso autore, il titolo sulla denominazione di Institutiones civilis iuris («Istituzioni di diritto civile») e l’impostazione apologetica – come di un avvocato che conduca la difesa in tribunale – emerge subito dalla Prefazione: Il parlar bene può riguardare pochi, ma il ben vivere è cosa che tocca tutti. Tuttavia quel nostro esercizio di trattare cause, questioni immaginate, ci ha giovato molto, così che ora possiamo difendere la causa della verità con più numerosi e più gravi argomenti: essa, per altro, potrebbe essere sostenuta anche senza l’aiuto dell’arte oratoria, come fu appunto per parte di molti; tuttavia ci pare di doverla illustrare con chiarezza e splendore di espressione, perché essa si fissi più stabilmente negli spiriti, forte della sua stessa forza, illuminata dalla luce della parola. L’inizio del libro III bene esprime l’utilità per la fede cristiana di un’eloquenza di scuola classica: … io vorrei mi fosse concessa – sia pure non come quella che rifulse in M. Tullio Cicerone, veramente grande e magnifica – una certa facoltà oratoria, da poter far sì che la verità – per quanto essa valga prima e soprattutto per la sua intima forza – risplendesse in tutto il suo splendore, e, confutati tanto gli errori del volgo, quanto di coloro che sono reputati saggi, potesse apportare agli uomini luce magnifica e fulgidissima. Ed io desidererei di poter fare ciò per due cause: prima, perché gli uomini potrebbero, certamente con maggior ragione, prestar fede alla verità luminosa, essi che credono anche alla menzogna, se attratti da quello che sia lenocinio di forma e magnificenza di espressione; seconda, perché certamente gli stessi filosofi sarebbero confutati e confusi da noi con quei mezzi, e con quelle stesse armi delle quali sono soliti compiacersi e in cui fermamente confidano. Lattanzio introduce anche il tema della diffidenza degli intellettuali pagani verso lo stile dimesso delle Sacre Scritture: … presso i sapienti, i dotti, e i luminari di questa età, la Sacra Scrittura non riscuote autorità e fede; perché i Profeti parlarono con parola semplice e piana, qual si conviene a chi deve parlare al popolo. Sono tenuti in poca considerazione da coloro che non intendono di ascoltare o di leggere, se non quello che sia elegante, forbito e presentato in una forma veramente squisita, e nell’animo loro non può restare se non ciò che molce l’orecchio con soavità di suono. Tutto quello, invece, che riveste un carattere di pura semplicità e schiettezza, è considerato inutile ciarla, cosa volgare e non degna di considerazione alcuna. È così che essi non stimano vero, se non quello che a loro fa piacere ad ascoltare; non v’è niente a cui si debba prestar fede, se non ciò che possa svegliare una certa soddisfazione e lusingare; è per questo che nessuno giudica una data cosa nel suo giusto valore, ma dall’apparenza. Non credono quindi questi pretesi saggi a quanto vi è di divino, perché ogni orpello è lontano dalle cose di Dio, e non prestano fede neppure a coloro che delle cose divine sono gli interpreti e i banditori, perché anche essi vivono in tutta semplicità, e sono addirittura rozzi, o, almeno, hanno un limitato grado di cultura. È rarissimo il caso che essi abbiano il dono di un’eloquenza fluente e magnifica, e la ragione di ciò, del resto, è chiara: la parola è in servigio delle cose del mondo; desidera di farsi valere fra le genti e rifulgere in quanto possa magari non esser buono; se pure, come avviene assai spesso, non arriva a voler abbattere la verità, per dimostrare così la sua potenza; aspira ad aprire la strada alle ricchezze, ha brama di onori, rivendica a sé il più alto grado di dignità e di onore. Divinae Institutiones, Prefazione; trad. di G. Mazzoni ibidem, III 1 ss. ibidem, V 1 ss. 685 686 Retorica e Cristianesimo La nuova eloquenza cristiana di Agostino Confessiones III 9; trad. di C. Carena BASSO IMPERO De Doctrina Christiana IV 2, 3 ss.; trad. di M.Simonetti Sarà Agostino (354-430, vedi il profilo a p. 664) a porre le fondamenta di una nuova eloquenza cristiana, la quale non prende a modello gli artifici retorici dei Greci, ma ha il fondamento nello stile stesso delle Sacre Scritture. Queste sono criticate dai sapienti pagani a causa del loro aspetto apparentemente poco curato, che invece esprime per ciò stesso lo «scandalo della Croce». Come infatti il Dio cristiano si rivela agli uomini non nella figura vittoriosa di un regnante ma nelle semplici spoglie di un bambino e nella sconfitta umana della morte sulla croce, allo stesso modo la Bibbia sceglie parole umili per esprimere un contenuto sublime. Come la linearità del linguaggio biblico rende il messaggio comprensibile anche ai semplici, allo stesso modo la profondità del suo significato costituisce degno alimento per l’intelletto dei dotti. Nelle Confessiones Agostino descrive la propria iniziale incomprensione per lo stile delle Sacre Scritture: … mi proposi di rivolgere la mia attenzione alle Sacre Scritture per vedere come fossero. Ed ecco cosa vedo: un oggetto oscuro ai superbi e non meno velato ai fanciulli, un ingresso basso, poi un andito sublime e avvolto di misteri. Io non ero capace di superare l’ingresso o piegare il collo ai suoi passi. Infatti i miei sentimenti, allorché le affrontai, non furono quali ora che parlo. Ebbi piuttosto l’impressione di un’opera indegna del paragone con la maestà tulliana. Il mio gonfio orgoglio aborriva la sua modestia, la mia vista non penetrava i suoi recessi. Quell’opera invece è fatta per crescere con i piccoli; ma io disdegnavo di farmi piccolo e per essere gonfio di boria mi credevo grande. Certo, anche l’oratore cristiano dovrà munirsi di armi retoriche, per non presentarsi sprovveduto nel suo ufficio di persuadere il prossimo al bene e alla verità: Dato che con la retorica si sostengono argomenti sia veri sia falsi, chi oserà dire che contro la menzogna i difensori della verità debbono essere del tutto disarmati? Perché mai quanti cercano di accreditare il falso sanno accattivarsi coi loro esordi l’ascoltatore rendendolo attento e arrendevole, mentre invece costoro non lo sanno fare? Perché quelli sanno esporre il falso con brevità chiarezza verisimiglianza, mentre questi espongono il vero in modo che l’ascoltatore s’annoi, non riesca a capire e non resti convinto? Perché quelli riescono con argomenti ingannevoli a impugnare la verità e affermare la falsità, mentre questi non sono capaci né di difendere il vero né di confutare il falso? Perché quelli con le loro parole sanno smuovere e spingere all’errore gli animi degli ascoltatori atterrendoli rattristandoli rallegrandoli esortandoli col massimo impegno, mentre questi in difesa della verità sonnecchiano pigri e fiacchi? Chi può essere tanto sciocco da pensarla così? Dato perciò che la capacità di parlare è moralmente neutra ed è molto efficace per sostenere argomenti sia cattivi che buoni, perché mai la persona dabbene non si dovrebbe mettere in condizione, grazie a questo studio, di battersi per la verità, dal momento che i malvagi se ne servono per far prevalere cause disoneste e prive di fondamento a beneficio dell’iniquità e dell’errore? L’oratore cristiano si potrà valere dunque dei tre stili ciceroniani (umile, medio e alto) mescolandoli all’interno della stessa omelia. Dovrà di preferenza docere, «insegnare» con stile umile, nella spiegazione del testo sacro; saprà vituperare o laudare, «rimproverare» ed «elogiare» in stile medio, ornato da figure retoriche; potrà movere, «convincere» con stile alto: La nuova eloquenza cristiana di Agostino Se si devono istruire gli ascoltatori, bisogna esporre in modo da far conoscere l’argomento di cui si tratta, purché ce ne sia necessità. Se poi si vuol rendere certo ciò che è dubbio, bisogna far uso del ragionamento, confortandolo con elementi di prova. Se invece chi ascolta, più che apprendere, deve essere stimolato perché non si impigrisca nel fare ciò che già sa e dia il proprio assenso a ciò che riconosce essere vero, in questi casi c’è bisogno di maggiore capacità di eloquio, perché qui è necessario far uso di preghiere e rimproveri, di esortazioni e divieti, e di tutto ciò che è capace di muovere gli animi. Si preferiranno le figure retoriche che permettono un più stretto collegamento con la sostanza del messaggio (ad esempio le parabole) o che conferiscono al discorso un ritmo incalzante (come le ripetizioni di parole o la loro collocazione parallela). Per apprendere gli strumenti oratori non tanto servirà studiarne accuratamente le regole, quanto seguire l’esempio di valenti predicatori: Chi poi ha intenzione di apprendere a parlare non solo con sapienza ma anche con eloquenza, perché certo riuscirà di maggiore utilità se sarà capace di fare l’una cosa e l’altra, lo invito a leggere ascoltare e imitare con l’esercizio chi è abile nel parlare, piuttosto che consigliargli di andare a scuola dai maestri di retorica. Pagina miniata del XV sec. raffigurante i grandi difensori della dottrina cristiana. Milano, Collezione Mario Crespi Morbio. Gregorio di Nazianzo, Padre della Chiesa di lingua greca, Ambrogio, l’imperatore Graziano, Girolamo, Giovanni Crisostomo, Padre della Chiesa di lingua greca, Agostino, Giovanni Damasceno, Padre della Chiesa di lingua greca, Paolo Orosio, storico latino cristiano e il Papa Leone Magno. ibidem, IV 4, 6 ibidem, V 5, 8 687 688 Retorica e Cristianesimo Epistolografia cristiana: Ambrogio, Girolamo, Agostino Le epistole di S. Paolo L’epistola consolatoria BASSO IMPERO Epistolografia di lingua greca Ambrogio Il primo esempio di epistolografia cristiana è rappresentato da quattordici lettere di S. Paolo, scritte tra il 50 e il 66 d.C. Nella struttura e nei contenuti si ritrovano le caratteristiche dell’epistolografia tradizionale pagana, ma in ogni epistola è presente il messaggio cristiano che influenza i contenuti e finanche le formule di saluto e di congedo. Le tipologie sono varie: lettere di viaggio, dottrinali, pastorali, polemiche, «aperte». Egli sfrutta le potenzialità comunicative della lettera e la sua forma polivalente per fare circolare il messaggio cristiano, sostenuto dalle continue citazioni dei passi biblici. Dopo S. Paolo la lettera diverrà lo strumento comunicativo più usato dalle comunità cristiane, in quanto risulterà un utile mezzo per organizzarle ed anche una valida forma di propaganda religiosa. Le lettere, redatte con cura e con arte, sono «aperte», cioè rivolte ad un pubblico e destinate ad essere diffuse, per questo spesso il destinatario assume il volto anonimo di un’intera comunità, senza un’apparente precisa individualità storica. Tra le tipologie epistolari dell’antichità i Padri della Chiesa svilupparono e trasformarono soprattutto l’epistola consolatoria, la più adatta a mostrare la misericordia di Dio nel momento del dolore. Le consolationes della tradizione pagana erano costituite generalmente da due parti, una personale che si adattava alle circostanze del destinatario ed una generale rappresentata da massime, esempi, luoghi comuni sulla morte e sul dolore. Seguendo questo schema topico, ereditato da scrittori come Cicerone e Seneca, i Padri della Chiesa trasformarono in particolar modo la parte generale, dedicata alla glorificazione di Dio, all’elogio delle virtù evangeliche, all’insegnamento della dottrina e delle verità bibliche: «la consolatio diventa esortazione, esegesi, insegnamento teologico, guadagnando in varietà ciò che perde in unità» (Ciccarese). In lingua greca, oltre alle lettere di San Paolo, ci sono stati tramandati numerosi epistolari, soprattutto di vescovi. Alcuni sono giunti in forma completa, altri in frammenti, altri, pur essendo perduti, ci sono noti da altri epistolari coevi. Al III secolo risale l’epistolario di Cipriano, vescovo di Cartagine, che si rivela un’ottima fonte documentaria per testimoniare un momento di crisi della Chiesa, vessata all’esterno dalle persecuzioni di Decio e spaccata, all’interno, su questioni dogmatiche. Nel IV secolo si assiste ad una fioritura di epistolari cristiani, che, sulla scorta della teorizzazione retorica sia latina (Giulio Vittore) che greca (Pseudo Libanio), tendono ad assorbire i canoni tradizionali del genere. In particolar modo i proemi delle lettere tendono a retoricizzarsi e a divenire modelli per i secoli a venire. Tra gli scrittori del IV secolo è importante ricordare Gregorio di Nazianzo, che fu il primo autore greco a divulgare in modo sistematico le proprie lettere; egli inoltre, nell’epistola 51, ha delineato i tratti peculiari dell’epistolografia, contribuendo alla codificazione del genere epistolare. Anche in ambito latino il IV secolo mostra una fioritura di epistolari cristiani. Il primo importante è quello di Ambrogio (vedi p. 644), costituito da 92 lettere, distribuite in 10 libri e scritte tra il 379 e il 396 d.C. La maggior parte di esse sono legate alla sua attività di vescovo, indirizzate agli uomini che ricoprivano le più alte cariche dell’amministrazione imperiale e ai confratelli. I temi trattati sono prevalentemente dogmatici o morali. Anche le lettere di Ambrogio risentono dei canoni retorici formulati in quegli anni e si mostrano attente a tutte le regole del genere e alle norme relative all’elaborazione stilistica. Epistolografia cristiana: Ambrogio, Girolamo, Agostino A cavallo tra il IV e il V secolo vive ed opera Girolamo (vedi p. 707), il cui epistolario è costituito da 154 lettere, in parte scritte da lui, in parte risposte dei corrispondenti. Furono redatte tra il 374 e il 410 e fu lui stesso a curarne l’edizione. Dall’epistolario emerge la figura di Girolamo non solo come uomo di Chiesa, ma anche come erudito. Possediamo lettere di vario genere: occasionali, consolatorie, polemico-apologetiche, didattiche ed altre che affrontano temi letterari. Interessanti quelle che testimoniano il suo lavoro di esegesi biblica che lo condusse a pubblicare il primo testo della Bibbia tradotto in latino, a tutti noto con il nome di Vulgata. La corrispondenza epistolare fu per Girolamo il modo più naturale per esprimere i suoi pensieri. Per la sua capacità di modularli variamente e di piegare lo stile epistolare a rendere i più svariati contenuti e a servire a scopi molteplici, «ci ha dato il vero modello del genere epistolare moderno» (Moricca). Tra le più note sono le epistole che affrontano il problema del rapporto tra cristianesimo e cultura pagana. Girolamo, lettore e conoscitore dei classici, visse sempre in modo lacerante il dissidio tra cultura classica pagana e cultura cristiana, come è dimostrato da questo sogno raccontato in un’epistola inviata ad una sua discepola: […] D’un tratto ho come un rapimento spirituale. Mi sento trascinato davanti al tribunale del Giudice, e mi vengo a trovare tra un tale sfolgorio di luce che irradia da ogni parte, che io, sbattuto a terra, non oso levare in alto lo sguardo. Mi chiede chi sono. «Un cristiano!» rispondo. Ma il giudice dal suo trono esclama: «Bugiardo! Sei ciceroniano, tu, non cristiano! Dove è il tuo tesoro, là è il tuo cuore!». Resto di colpo senza parola. […] comincio a giurare, a dare la mia parola, invocando Lui stesso a testimone: «Signore se d’ora innanzi avrò ancora fra le mani un’opera profana, o la leggerò, vorrà dire che t’ho rinnegato!». […] Da quel giorno mi sono messo a leggere la Scrittura con un ardore che mai ne avevo messo l’eguale nelle letture pagane. Girolamo Di Agostino (354-430, vedi il profilo a p. 664) restano 267 lettere indirizzate, tra il 386 ed il 429-30, a diversi destinatari, tra cui spicca Girolamo. Fu lo stesso autore a curarne la pubblicazione, dopo aver apportato alcune correzioni. Le tipologie epistolari sono le più varie: lettere consolatorie, dottrinali ed esegetiche, ufficiali, pastorali-organizzative, alcune di carattere intimo. I modelli latini erano ben presenti ad Agostino, il quale però mostra in molte occasioni di staccarsi dalla tradizione pagana, per segnare anche a livello stilistico e formale la sua conversione al cristianesimo. Questo atteggiamento si nota in particolar modo nelle lettere consolatorie. Rispetto alla tradizione pagana, in Agostino si riscontra l’assenza delle laudes del defunto, che invece erano sempre presenti negli autori classici, anche in Ambrogio e Girolamo. Inoltre gli exempla storici vengono sostituiti con esempi tratti dalle Sacre Scritture. Ampio spazio viene dedicato al tema della sofferenza. Agostino comprende il dolore dei fedeli e ritiene che non debba essere soffocato dalla ragione, ma debba trovare conforto nella fede, nelle promesse evangeliche e nella speranza della resurrezione dei corpi: Tuo fratello, cara figliuola, dorme nel corpo ma vive nello spirito; forse che uno che dorme non si ridesterà mai più? Dio, che ha accolto il suo spirito, gli restituirà il corpo che gli ha tolto, non già perché andasse perduto ma perché è rinviato il tempo in cui gli sarà restituito […] Questa speranza non l’hanno i pagani che ignorano la S. Scrittura e la potenza di Dio, il quale può rinnovare le cose andate in rovina e far tornare in vita quelle morte, restituire nella loro integrità quelle corrotte, riunire di nuovo quelle Agostino trad. di S. Cola Epist. 263, 4; trad. di L. Carrozzi 689 690 Retorica e Cristianesimo disgiunte e conservare senza fine quelle prima corrotte e arrivate alla fine. Questo ha promesso di fare colui il quale ce ne dà la certezza in virtù delle promesse che ha già mantenute. BASSO IMPERO 155, 2, 6; trad. di L. Carrozzi Vetro dorato con l’apostolo Paolo (IV secolo). Città del Vaticano, Museo Sacro. Anche le epistulae exhortatoriae della tradizione pagana sono modificate e adattate alla nuova cultura cristiana. L’esortazione alla sapientia non è più identificabile con la filosofia dei pagani, bensì con la dottrina cristiana. La finalità delle lettere è conquistare nuovi proseliti, diffondere il messaggio cristiano, invitando tutti a leggere le Sacre Scritture: […] se vogliamo essere veramente felici – né possiamo non volerlo – teniamo bene a mente la massima imparata dalle stesse Sacre Scritture: Beato chi ripone la propria speranza nel Signore e non segue la falsità né le pazzie menzognere. […] Riflettiamo quindi, te ne prego, le stolte e pazze menzogne dei falsi filosofi […]. Apologia, catechesi e dottrina negli autori cristiani Tertulliano e la letteratura apologetica Minucio Felice Cipriano Lattanzio Ilario Ambrogio Girolamo e la Vulgata Agostino 692 Apologia, catechesi e dottrina negli autori cristiani Tertulliano e la letteratura apologetica Gli apologisti La vita di Tertulliano Si chiama apologetica la produzione letteraria che, dal II al IV secolo, è impegnata a difendere la nuova religione dagli attacchi dei pagani e a diffonderne i principi. Alle prime apologie scritte in greco (da Giustino, Aristide di Atene, Atenagora e altri) seguirono quelle in lingua latina, nelle quali il cristianesimo trovò una compiuta espressione letteraria. I primi apologisti latini furono Tertulliano e Minucio Felice. Di essi non è possibile stabilire con certezza chi sia l’autore più antico. Avvocato cartaginese di famiglia pagana nato verso la metà del II secolo, in grado di scrivere sia in greco sia in latino, Quinto Settimio Fiorente Tertulliano dimorò per un certo periodo a Roma esercitando la professione forense. Si convertì al cristianesimo intorno al 190. Divenuto prete (secondo la testimonianza di Girolamo), si distinse per il vigore polemico, il rigorismo e l’intransigenza dottrinale. Dopo avere combattuto strenuamente le eresie, aderì alla setta ereticale dei montanisti dedita a forme di ascetismo estremo, poi ne fondò una propria, detta dei tertullianisti. Morì dopo il 220. a) Opere di carattere apologetico e dottrinale: Ad martyras, esortazione al martirio rivolta a un gruppo di cristiani imprigionati nel carcere di Cartagine; Ad nationes, indirizzata ai pagani (nationes sono i popoli non cristiani), contesta la procedura giuridica usata nei processi contro i cristiani; Apologeticum, l’opera più nota e importante, difesa appassionata della religione cristiana e critica serrata di quella pagana; De testimonio animae, sull’inutilità delle argomentazioni dei filosofi per dimostrare l’esistenza di Dio, sufficientemente provata dalla testimonianza dell’anima, che è naturaliter christiana; Ad Scapulam, epistola apologetica contro Scàpula, proconsole romano d’Africa persecutore della comunità cristiana; Adversus Marcionem, confuta un’eresia secondo la quale il Dio d’amore del Nuovo Testamento è inferiore al Dio punitivo del Vecchio Testamento e dimostra l’impossibilità di distinguere tra le due divinità; Adversus Praxean sul dogma trinitario (in quest’opera è usata per la prima volta la parola trinitas). b) Opere di carattere morale (che prescrivono il comportamento del cristiano): De praescriptione hereticorum («Sulla prescrizione contro gli eretici»), nega agli eretici il diritto di appellarsi alle Scritture per sostenere i loro errori, in quanto solo i cattolici sono depositari della dottrina apostolica; De spectaculis, vieta ai cristiani di partecipare agli spettacoli circensi; De cultu feminarum («L’abbigliamento delle donne»), condanna di ogni forma di seduzione femminile; De virginibus velandis, esortazione, rivolta alle donne, a portare il velo in Chiesa e nei luoghi pubblici; De pudicitia, requisitoria contro il sesso fuori del matrimonio; De patientia, lode della pazienza come virtù eminentemente cristiana; De corona, contro il servizio militare considerato incompatibile con la dottrina cristiana e contrapposto alla militia Christi; De idolatria, rassegna dei mestieri pagani incompatibili con l’adesione al cristianesimo (ad esempio, il gladiatore, il mago, il matematico). L’avvocato e il giurista Tertulliano svolge i vari argomenti con sottile dialettica e sicura conoscenza del diritto, che gli derivano dall’esercizio dell’avvocatura. Spesso la struttura delle opere ricalca quella dei discorsi forensi. Così, l’Apologeticum è ripartito secondo lo schema previsto per l’orazione epidittica nei manuali di retorica: exordium (capp. 1-3), proposta dell’argomento (4), discussione preliminare o praemunitio BASSO IMPERO Opere Tertulliano e la letteratura apologetica (5-6), confutazione o refutatio (7-49), peroratio (50). Spesso l’apologia si trasforma in una requisitoria antipagana che ritorce sugli avversari le accuse rivolte ai cristiani. Frequenti sono il ricorso a tecniche o artifizi processuali e l’interpretazione in termini giuridici di una questione dottrinale. Ad esempio, nel De praescriptione haereticorum, l’autore invoca l’istituto giuridico della praescriptio – invalidazione preventiva della tesi degli avversari, confutati prima che prendano la parola – negando agli eretici il diritto di appellarsi alle Scritture, in quanto rifiutano l’autorità della Chiesa. Sempre nell’Apologeticum, si rilevano le incongruenze della procedura usata contro i cristiani. Traiano, istruendo Plinio il Giovane (Epist. 10, 96), allora governatore di Bitinia, su come comportarsi coi cristiani, consigliava di non ricercarli (conquirendi non sunt), ma di punirli solo se, denunciati, si rifiutassero di sacrificare al genius dell’imperatore. Il commento di Tertulliano, sarcastico e sostanziato di cultura giuridica, è un esempio insigne della sottigliezza argomentativa. La dialettica dell’antico avvocato non si limita a rilevare le contraddizioni della politica anticristiana o confutare le calunnie dei pagani (delitti occulti, ostilità verso l’umanità, ecc.), ma mette a nudo l’inconsistenza dei fondamenti dell’impero, la cui stabilità non può dipendere dal culto di idoli assurdi. A questi egli oppone il vero Dio, che l’anima semplice spontaneamente riconosce, in quanto essa è naturaliter christiana. Adorare il Dio della nuova fede, in luogo del genius dell’imperatore, non significa essere nemici dello stato ma il contrario, infatti proprio da quel Dio discende l’autorità imperiale. I cristiani onorano l’imperatore come «l’essere umano più vicino a Dio, che da Dio riceve tutto il suo potere, inferiore a Dio soltanto» (Ad Scap. 2). Essi pregano per il princeps e la loro preghiera è certo più efficace di quella dei pagani, in quanto è indirizzata al vero Dio. Dal riconoscimento di una legittimazione divina dell’impero – che dopo Costantino sarà ufficialmente cristiano – discende un fiero monito: il Dio cristiano non consentirà che il proprio ministro e braccio secolare sparga impunemente il sangue di tanti fedeli innocenti. Il discorso apologetico non è solo difensivo, ma anticipa un progetto di largo respiro: «sostituire le tradizionali forze egemoniche con la nuova concezione religiosa, senza intaccare le strutture di potere di cui, anzi, i cristiani cercheranno di avere prima la protezione e poi la direzione» (G.F. Giannotti-A. Pennaccini). Tertulliano ha la certezza della vittoria. L’orgoglio d’essere cristiano, la consapevolezza della forza della nuova fede sono espressi ovunque nell’opera dell’avvocato africano: I cristiani non sono nemici dello stato Sostituirsi alle forze tradizionali Siamo appena di ieri, e abbiamo già riempito la terra e tutti i vostri domìni, le città, i sobborghi, i luoghi fortificati, i municipi, le assemblee, le tribù, i collegi, la corte, il Senato, il Foro: a voi sono restati soli i templi. Apolog. 37 Le persecuzioni serviranno solo a rafforzare l’esercito cristiano, giacché semen est sanguis Christianorum, «Il sangue è semente dei cristiani» (50, 13). Il risvolto più «antipatico» – almeno per il lettore moderno – della focosa religiosità di Tertulliano riguarda il rigorismo degli scritti che regolamentano il comportanto dei fedeli. Al cristiano sono preclusi determinati mestieri (gladiatore, matematico, mercante, ecc.), sono fornite prescrizioni concernenti il vestiario: gli uomini devono portare il pallio, l’austero mantello dei filosofi cinici, in luogo della troppo lussuosa toga tradizionale. Alle donne è vietato il trucco, strumento di perversione diabolica – ma la donna stessa è considerata una creatura demoniaca – e raccomandato il velo, Il moralista intransigente 693 694 Apologia, catechesi e dottrina negli autori cristiani La lotta contro le eresie Adversus Marcionem 4, 4 BASSO IMPERO Stile non solo durante le funzioni liturgiche ma anche sulla pubblica via, per sottrarsi agli sguardi maschili. I divertimenti sono vietati, e non solo gli spettacoli circensi e gladiatorii, ma anche quelli teatrali, essendo ogni tipo di spettacolo considerato una forma di idolatria. In particolare l’asceta tuona contro la sessualità, considerata un’incresciosa incombenza anche all’interno del matrimonio, per non dire dell’adulterio e di ogni pratica extramatrimoniale del sesso. Alle vedove sono sconsigliate le nuove nozze. Risultano disturbanti non tanto le prescrizioni in sé, che hanno motivazioni culturali e dottrinali, quanto l’astiosità e l’acredine con cui sono espresse. C’è nel moralista qualcosa di angusto e rancoroso, soprattutto c’è assenza di carità cristiana. «Figura tragica che non riesce ad amare l’umanità» (Conte), Tertulliano sadicamente pregusta il male che immagina dovrà capitare, non solo agli avversari, ma anche ai compagni di fede che incorrano nel peccato. Nella lotta contro le eresie, Tertulliano affronta il problema spinoso di chi debba dirimere le contese e con quale autorità, concludendo che solo la Chiesa cattolica è depositaria della vera interpretazione dei testi sacri, in quanto erede diretta della predicazione degli apostoli. L’antichità della tradizione è di per sé garanzia di veridicità: Io affermo che è vero il mio Vangelo, Marcione il suo. Io dico che è falso quello di Marcione, Marcione il mio. Chi deciderà la disputa se non il criterio dell’antichità, che assegna autorità al più antico e considera corrotto il più recente? Il rigorismo intransigente e la passionalità del temperamento lo portarono a condividere le tesi – in odore di eresia a causa dell’ascetismo estremo che propugnavano – di Montano. Il montanismo era congeniale alla spiritualità cupa e focosa di Tertulliano per la prospettiva apocalittica e millennaristica (il millennarismo predicava l’imminente fine del mondo), per l’acceso misticismo che includeva l’esperienza dell’estasi. L’adesione al Montanismo nocque alla sua fama. Di lui scriverà Ilario di Poitiers: «L’errore da lui commesso successivamente tolse ogni autorità anche agli scritti ortodossi» (Ad Matt. 11, 1). Lo stile sublime, il tono risentito, l’espressione serrata e impetuosa rendono il forte sentire dell’autore, la visceralità del temperamento. Al vigore e alla vivacità della polemica concorrono la ricca strumentazione retorica, il linguaggio acceso, sferzante, sarcastico e paradossale, il periodare irregolare e inquieto. Il gusto per le frasi spezzate irte di antitesi e parallelismi, la predilezione per le espressioni sentenziose e oscure si conformano allo stile «moderno» senecano e ancor più all’asianesimo coltivato dalla Nuova Sofistica (certamente Tertulliano dovette assistere alle conferenze che Apuleio teneva con successo, proprio a Cartagine, in quegli anni). All’effetto di un turgore barocco contribuiscono l’energia visionaria delle metafore, il concettismo e la tendenza a rendere nozioni astratte con immagini concrete (come l’anima che siede sul banco dei testimoni). Da queste scelte epressive discendono l’oscurità e la difficoltà del latino di Tertulliano: difficilis in loquendo, dice di lui Girolamo; in eloquendo parum facilis … et multum obscurus lo definisce Lattanzio. Sul piano lessicale i testi del primo apologeta rappresentano la prima significativa testimonianza del cosiddetto «latino cristiano», caratterizzato dai numerosi neologismi (episcopus, evangelium, ecc.) e dai tecnicismi della lingua giuridica, che spesso subiscono uno slittamento semantico nell’ambito morale (damnare, assolvere, ecc.). Tertulliano e la letteratura apologetica Una procedura giudiziaria assurda (Apologeticum II, 6-11). Fra il 111 e il 113 Plinio, nella sua qualità di governatore di Bitinia e del Ponto, chiese all’imperatore Traiano come si dovesse comportare nei processi contro i Cristiani (Epist. X 96 e 97). L’imperatore rispose così: i Cristiani conquirendi non sunt, cioè non vanno perseguiti d’ufficio. Se però c’è una denuncia, non anonima, che comprovi l’appartenenza alla nuova setta, si dovrà punire l’accusato, qualora questi non rinneghi la sua fede sacrificando agli dei e al genius dell’imperatore. Tertulliano coglie il carattere contraddittorio di una tale procedura: «Proibisce di ricercarli come fossero innocenti, poi comanda di punirli come fossero colpevoli ... Se li condanni, perché non li fai ricercare? Se non li fai ricercare, perché non li assolvi?» (2, 8). Analoga è l’argomentazione dello storico moderno: «Un reato che l’autorità ignora, in conformità alle disposizioni, finché non è costretta a prenderne atto, e che comporta la pena di morte per gli irriducibili, ma viene completamente ignorato dopo un singolo segnale di dissociazione, è un reato singolare» (H. Last). Plinio Secondo, mentre era governatore di una provincia, dopo aver condannato certi cristiani, averne fatti abiurare altri, turbato tuttavia dal loro stesso numero elevato, consultò allora l’imperatore Traiano su come dovesse comportarsi per i casi futuri: e riferiva che, tranne l’ostinazione a non sacrificare, non aveva potuto trovare altro a proposito dei loro misteri che riunioni antelucane per cantare inni a Cristo come se fosse un dio e per rinsaldare tra di loro una disciplina che vietava l’omicidio, l’adulterio, la frode, la perfidia e tutti gli altri crimini. Allora Traiano gli rispose che questa categoria di persone non doveva essere inquisita, ma, se erano denunciate, bisognava punirle. O sentenza illogica per necessità! Dice che non vanno ricercati, come se fossero innocenti, ma raccomanda che siano puniti come se fossero colpevoli. Risparmia e infierisce, finge di non sapere e condanna. Perché esponi te stessa alla censura? Se li condanni, perché non li ricerchi anche? Se non li ricerchi, perché non li assolvi anche? Per rintracciare i briganti vi sono guarnigioni militari distribuite a sorte per tutte le province; contro i colpevoli di lesa maestà e i nemici pubblici ogni uomo è soldato; l’inchiesta si estende sino ai complici e testimoni. Solo il cristiano non è permesso ricercarlo, ma è permesso deferirlo al giudice, come se l’inchiesta avesse altro fine che la denuncia. Voi dunque condannate una persona denunciata, che però nessuno volle che fosse ricercata: e costui, a mio avviso, non subì il castigo perché colpevole, ma perché si lasciò scovare, lui che non doveva neppure essere ricercato. Ma neppure su questo punto voi applicate nei nostri confronti la normale procedura giudiziaria contro i malfattori: voi ricorrete alla tortura per ottenere la confessione, quando gli accusati negano; solo con i cristiani la usate per ottenere una risposta negativa; ma, se si trattasse di un delitto, noi certo negheremmo e voi ci costringereste a confessare con la tortura. Ma voi potreste rispondere che non ritenete necessario inquisire i nostri delitti con la tortura, poiché siete sicuri che essi sono ammessi con la stessa confessione del nome di cristiano, proprio voi che ogni giorno di fronte ad un omicida confesso, pur sapendo bene che cosa sia un omicidio, gli strappate nondimeno con la tortura le circostanze del crimine confessato. Ma – e qui si arriva al culmine della iniquità – mentre presumete i nostri delitti dalla confessione del nome, ci costringete con la tortura a ritrattare la confessione, affinché con la negazione del nome noi senza dubbio possiamo negare egualmente anche i delitti che voi in base alla confessione del nome presumevate a nostro carico. Ma, io immagino, non volete che noi siamo sterminati, noi che a vostro giudizio siamo i peggiori degli uomini. Perché è vostra abitudine dire questo ad un omicida: «Nega»; è vostra abitudine comandare di fare a pezzi un sacrilego, se persevera nella confessione. Orbene, se così non vi comportate nei riguardi dei colpevoli, vuol dire che ci giudicate del tutto innocenti, dal momento che, ritenendoci del tutto innocenti, non volete che noi insistiamo in quella confessione, che per necessità, non per un principio di giustizia, credete di dover condannare. Un uomo grida a gran voce: «Sono cristiano»: dice quel che è, ma tu vuoi udire quel che non è. Voi magistrati, incaricati di strappare la verità, soltanto nel nostro caso vi date un gran da fare per sentire una menzogna! Dice l’accusato: «Tu vuoi sapere se sono cristiano? Lo sono. Perché mi torturi contro ogni regola del diritto? Io confesso e tu mi torturi. Che faresti, se io negassi?». Bisogna ammettere che, quando altri negano, voi non prestate loro facilmente fede: ma a noi, se neghiamo, subito credete. (trad. di G. Ravenna) La «testimonianza dell’anima» (De testimonio animae I 5-6). L’anima semplice e allo stato naturale – non addottorata, non nutrita di argomentazioni filosofiche – è il più attendibile testimone dell’esistenza del vero Dio, in quanto essa è naturaliter christiana. 695 696 Apologia, catechesi e dottrina negli autori cristiani A una nuova testimonianza io ricorro, più nota anzi di ogni letteratura, più viva di ogni teoria, più diffusa di ogni libro pubblicato, più grande dell’intero uomo: tutto ciò che costituisce l’uomo. Vieni avanti, o anima: sia tu cosa divina e eterna secondo molti filosofi, tanto più non mentirai; sia tu niente affatto divina in quanto mortale, come ritiene il solo Epicuro, tanto più non dovrai mentire; sia tu derivata dal cielo, oppure concepita dalla terra, sia tu composta di numeri o di atomi, sia che cominci a esistere col corpo, o dopo la nascita del corpo vi sia introdotta; qualunque sia la tua provenienza e in qualsiasi modo tu faccia dell’uomo un animale dotato di ragione, capace in sommo grado di intelligenza e di conoscenza. Ma io intendo appellarmi a te non in quanto, formata nelle scuole, allenata nelle biblioteche, nutrita nelle accademie e nei portici dell’Attica, erutti la tua sapienza. Mi rivolgo a te semplice e grezza e non istruita e priva di esperienza, quale ti posseggono coloro che te sola posseggono: quell’anima stessa che tutta appartiene ai crocicchi, ai trivi, all’opificio. (trad. di C. Tibiletti) Le donne dovrebbero vestire a lutto (De cultu feminarum I 1-2). Espressione di un antifemminismo viscerale, il De cultu feminarum afferma il dovere per la donna di vestire con umiltà rinunciando a ogni forma di ornamento e trucco. Non si tratta d’una generica esortazione all’austerità e alla pudicizia, virtù apprezzate anche nella matrona romana. Per Tertulliano l’obbligo di un abbigliamento castigato s’impone per motivi teologici connessi al peccato di Eva, che fu la causa prima della cacciata dell’umanità dal paradiso terrestre. [1, 1] Se ancora rimanesse in terra una fede pari al premio che se ne aspetta in cielo, senza dubbio nessuna di voi, sorelle amatissime, una volta conosciuto il Dio vivente e preso coscienza della propria condizione, ossia di quella femminile, avrebbe bramato un abito più elegante, per non dire più vanitoso, al punto che si troverebbe più a suo agio in abiti dimessi e desidererebbe piuttoso ostentare vesti da lutto, presentandosi come un’Eva afflitta e in penitenza, in modo da riscattare, con ogni sorta di abbigliamento da discolpa, il retaggio che le deriva da Eva – vale a dire l’ignominia della prima colpa – e l’odiosità di aver mandato in rovina il genere umano. Tu, donna, partorisci tra dolori angosciosi, la tua tensione è per il tuo uomo ed egli è il tuo padrone: e non sai di essere Eva? [2] In questo mondo è ancora operante la sentenza divina contro codesto tuo sesso: è necessario che duri anche la condizione di accusata. Sei tu la porta del diavolo, sei tu che hai spezzato il sigillo dell’Albero, sei tu la prima che ha trasgredito la legge divina, sei stata tu a circuire colui che il diavolo non era riuscito a raggirare; tu, in maniera tanto facile hai annientato l’uomo, immagine di Dio; per quello che hai meritato, cioè la morte, anche il figlio di Dio ha dovuto morire: e hai ancora in animo di coprire di ornamenti le tue tuniche di pelle? BASSO IMPERO (trad. di G. Pontiggia) Cena eucaristica. Particolare del coperchio del sarcofago di Baebia Hertoflia (seconda metà del III secolo). Roma; Museo delle Terme. Minucio Felice Minucio Felice Avvocato africano forse di Cirta, Minucio Felice visse a Roma a cavallo tra II e III secolo. La cronologia è dibattuta e non è sicuro se l’opera di questo autore preceda o segua quella di Tertulliano, a cui si lega per molti aspetti. Minucio scrisse un trattato De fato perduto e l’Octavius, controversia in forma di dialogo ambientata sulla spiaggia di Ostia. I contendenti sono il pagano Cecilio e il cristiano Ottavio, il terzo partecipante è Minucio stesso che funge da arbitro. Lo spunto per la disputa è offerto da un cenno di riverenza compiuto da Cecilio verso una statua di Serapide. L’oggetto del dibattito – che avviene su un sfondo paesaggistico suggestivo, versione «marina» del locus amoenus dei dialoghi filosofici – è il confronto tra la religione tradizionale e la nuova fede. O meglio, è la difesa e l’esaltazione del cristianesimo contro i pregiudizi pagani, in forma di protrettico, cioè di discorso di esortazione ad aderire alla nuova fede. L’Octavius Schernito da Ottavio per l’omaggio reso al dio egizio, Cecilio dà inizio al dialogo, che prende la forma di un dibattito forense nel quale egli gioca il ruolo dell’accusatore. L’esordio è improntato a una concezione di tipo scettico e probabilistico: data l’impossibilità di conoscere Dio e l’improbabilità dell’esistenza di un Dio provvido, sostiene il pagano, conviene mantenere la religione dei padri, indispensabile alla conservazione dell’impero. Rivolge poi ai cristiani, considerati uomini rozzi e privi di cultura, le consuete accuse: di praticare l’antropofagia e l’incesto, di compiere sacrifici umani, di vivere tramando nell’ombra (latebrosa et lucifuga natio, in publicum muta, in angulis garrula, «gente tenebrosa e che fugge la luce, muta in pubblico, loquace quando è nascosta»). Con garbo signorile e distaccato Ottavio replica alle calunnie ritorcendole contro i pagani, il cui impero nasce dalla violenza: «I Romani sono così potenti, non per la loro religiosità, ma per l’impunità dei loro sacrilegi» (25, 7). La fortuna di Roma si fondava «sulla sventura degli altri e sulla scelleratezza propria» (25, 4). Dei cristiani invece sono esaltati lo spirito di giustizia e fratellanza e il rispetto della dignità di ogni persona. Ottavio passa poi a dimostrare che dalla stessa amenità del paesaggio in cui è ambientato il dialogo e dall’armonia del cosmo si deduce l’esistenza della Provvidenza divina. Non occorre che il giudice proclami il vincitore, perché Cecilio si arrende spontaneamente alle cogenti argomentazioni dell’amico miranti non all’effetto retorico ma alla dimostrazione della verità (non laudi sed veritati). Entrambi i contendenti sono vincitori: Ottavio su Cecilio, questo sull’errore da cui si è liberato: «Ci allontanammo di là allegri e gioiosi: Cecilio era felice di avere conquistato la fede, Ottavio di avergliela ispirata, vincendo la disputa» (39-40). Scrittore raffinato, nonostante qualche eccesso d’ornamento e la ricerca esasperata di effetti fonici (clausole ritmiche, parallelismi, rime), Minucio Felice si attiene fondamentalmente al modello ciceroniano. Equilibrato, più vicino alle posizioni moderate dell’apologetica greca che all’intransigenza di Tertulliano, egli basa l’argomentazione su una razionalità composta e pacata. Come i dialoghi ciceroniani (il De natura deorum, il Dialogus de oratoribus), il contraddittorio dell’Octavius è condotto secondo un codice di «buone maniere» che addolcisce la vis comica bandendo ogni animosità. Il fair play, il garbo signorile estraneo all’apologetica cristiana soprattutto tertullianea, gli ha valso l’accusa di preferire l’effetto stilistico e letterario ai contenuti religiosi, la filosofia alla teologia. In effetti l’Octavius è un testo apologetico anomalo, sia per la forma (il dialogo), sia per i toni concilianti e distesi. Minucio è interessato a evidenziare piuttosto i punti di contatto col paganesimo che quelli di rottura e a dimostrare ai lettori non cristiani, ai quali si rivolge, come la nuova fede s’innesti facilmente sul filone della più alta spiritualità classica. Ad esempio, Ottavio difende il monoteismo e l’immortalità dell’anima con argomentazioni stoiche e platoniche. Manca invece ogni riferimento a dogmi o ad aspetti dottrinali. Mancano le citazioni dal Nuovo e dall’Antico Testamento, a conferma del fatto che l’autore si rivol- Lo stile 697 698 Apologia, catechesi e dottrina negli autori cristiani ge prevalentemente a intellettuali pagani, per i quali l’autorità delle Scritture sarebbe stata nulla. Tuttavia, nonostante il tono conciliante e pacato, nonostante la ricerca di un’integrazione tra cultura pagana e cristiana, emerge netta dall’Octavius la contrapposizione tra la comunità cristiana e il resto del mondo, al punto che s’è voluto vedere in quest’opera un’anticipazione del dualismo agostiniano tra città celeste e città terrena. BASSO IMPERO Sarcofago con Giona, filosofo, Buon Pastore e scena battesimale (260-280). Roma, Santa Maria Antiqua. L’ambientazione dell’Octavius (2-3). In una dolce mattina d’autunno i tre amici passeggiano lungo il mare. Dopo l’episodio del bacio dato da Cecilio a Serapide, viene la descrizione della spiaggia di Ostia, cornice lirica ideale di un dialogo che vuole rasserenare le coscienze. Un vero pezzo di bravura è rappresentato dalla scena dei ragazzi impegnati in un gioco ancora oggi praticato: lanciare un ciottolo piatto che rada il pelo dell’acqua rimbalzando più volte prima di sparire. Era venuto a Roma per affari e per rivedere me, lasciando la casa, la sposa, i figli, e figli che erano ancora nell’età dell’innocenza (la più cara) e spiccicavano ancora le parole a mezzo, in un frasario tutto loro che lo stesso impaccio della lingua inesperta rendeva più delizioso. Non posso esprimere a parole quale gioia prorompente mi avesse fatto vibrare al suo arrivo: aumentava la mia letizia soprattutto il fatto che un così prezioso amico fosse apparso all’improvviso. Pertanto, trascorsi due giorni, quando già il continuo stare insieme aveva soddisfatto l’ansiosa brama di rivederci e a furia di raccontare eravamo venuti a sapere ciò che, a causa della lontananza, ignoravamo l’uno dell’altro, decidemmo di recarci ad Ostia, piacevolissima residenza: ché ivi, per mezzo dei bagni di mare, trovavo una cura blanda e appropriata per asciugare gli umori del corpo; per di più, nell’imminenza della vendemmia, le ferie avevano rallentato l’urgenza dei processi. Eravamo infatti nel tempo in cui, cessati i calori, l’autunno si avviava alla sua normale temperatura moderata. Un giorno, mentre di buon mattino ci dirigevamo alla marina per passeggiare lungo la spiaggia, sì che l’arietta, soffiando leggermente, abituava le membra alla sua frescura e la sabbia, ispirandoci un sottile brivido di piacere, ci faceva sentire la sua leggerezza, perché i nostri piedi lasciavano su di essa solo una tenue orma, Cecilio, scorto un simulacro di Serapide, avvicinò la mano alle labbra e vi impresse un bacio, come suol fare il volgo degli sciocchi credenti. Allora Ottavio disse: «Non è da uomo degno di lode, fratello Marco, lasciare che un amico, il quale ti sta sempre a fianco in casa e fuori, rimanga impigliato nella cecità dell’errore, volgare a tal punto che, nella piena luce del giorno, tu permetta che egli intoppi nei sassi, sia pure scolpiti e unti e inghirlandati, pur sapendo che il biasimo di questo errore ridonda su te non meno che su lui». Mentre egli così diceva, avendo attraversato il centro della città, eravamo già arrivati alla zona aperta della spiaggia. Colà l’onda, fluendo lieve, rassodava l’estremità sabbiosa della riva, quasi a disporla, ben battuta, come pista da passeggio. E siccome il mare, anche quando il vento non soffia forte, non è immobile, benché in quel momento non s’abbattesse sulla terra con flutti di bianca spuma, pure ci infondeva un gran diletto con le sue increspature e le volute capricciose del suo ondeggiare, dato che noi bagnavamo le piante proprio sul limite, che di volta in volta l’acqua ora spingeva scherzosamente fino ai nostri piedi, ora ritraendosi e cancellandone il tracciato riassorbiva in sé. Procedendo con calma e lentezza lungo il limite della spiaggia capricciosamente incurvata, ingannavamo il cammino coi piacevoli discorsi fatti da Ottavio che ci intratteneva sul suo viaggio per mare. Ma avendo percorso un tratto di strada sufficiente ad esaurire quest’argomento, ritornavamo sui nostri passi e, giunti a quel punto in cui le barche tirate in secco stavan ferme, sollevate a mezzo di paranchi dal terreno inclinato e sdrucciolevole, scorgemmo alcuni fanciulli che si divertivano a scagliare a gara sassolini nel mare. Questo giuoco consiste nello scegliere sulla spiaggia un ciottolo rotondo, levigato dall’urto delle onde, e, tenendolo dalla parte del palmo e ruotandolo, scagliarlo nell’acqua, stando inclinati in avanti e quanto più si può verso terra, in modo che quella specie di dardo, nel cadere con calcolato impeto, rada la superficie del mare e rimanga a galla, e nel saltellare dalla cima di un’onda all’altra, continui ad essere visibile nei suoi balzi sfiorando la sommità dei flutti. Si riteneva vincitore tra i fanciulli quello il cui sasso giungesse più lontano e compisse un maggior numero di rimbalzi. (trad. di E. Paratore) Cipriano Opere apologetiche Ad Dem. 14; trad. di G. Auletta Opere dottrinali 699 700 Apologia, catechesi e dottrina negli autori cristiani Cipriano Tascio Cecilio Cipriano, nato a Cartagine intorno al 200, fu professore di retorica famoso nella prima parte della sua vita, secondo la testimonianza di Girolamo (primum gloriose rhetoricam docuit). Convertitosi al cristianesimo nel 246, donò i suoi beni ai poveri, in seguito divenne per volere popolare vescovo di Cartagine. Da allora alla cura pastorale unì sempre, come riferisce il biografo Ponzio, l’impegno a prodigarsi per malati e bisognosi. Ebbe un lungo contrasto col vescovo di Roma, Stefano, sulla dottrina battesimale. Durante l’episcopato di Cipriano imperversarono le persecuzioni nei confronti dei cristiani; durante quella voluta dall’imperatore Decio (250), egli fu proscritto e riuscì a mettersi in salvo continuando a organizzare in clandestinità la comunità cristiana. Nella persecuzione scatenata da Valeriano (257) fu prima esiliato, poi condannato alla decapitazione. Il 14 settembre 258 affrontò il martirio con eroica fermezza, come ci è attestato, oltre che dalla biografia di Ponzio, dalla Passio S. Cypriani (vedi p. 660) e dalle ultime lettere dell’Epistolario. L’epistola autobiografica Ad Donatum, prima opera composta dopo il battesimo dell’autore, descrive la gioia dell’evento e gli effetti della grazia divina sulla sua conversione. È una lettera aperta indirizzata a un pubblico non cristiano (Donato era un amico pagano dell’autore) per esortarlo ad abbracciare le retta fede e a rigenerarsi nel battesimo. Tra le opere d’impronta più esplicitamente apologetica ricordiamo l’Ad Donatum e Opere di carattere l’Ad Demetrianum, dove l’autore compie, con toni apocalittici che richiamano Ternormativo tulliano, un’analisi impietosa dei tempi presenti afflitti da guerre, carestie, siccità, improduttività agricola. Ma questi flagelli non possono turbare i cristiani, la cui speranza affonda le radici nella roccia della fede e la cui patria non è in terra: BASSO IMPERO Anche se le vigne non danno uve né gli oliveti olio, e i campi inaridiscono bruciati dall’arsura, che importa tutto questo ai cristiani, che sono alleati del paradiso, dove è preparata ogni abbondanza di delizie? Noi infatti, rinnovati in una nascita che non è terrena, ricreati nello spirito, non viviamo più per il mondo ma per Dio, e quando ci saremo congiunti a Dio nei cieli, allora riceveremo i doni promessi. Nell’Ad Demetrianum l’accusa rivolta ai cristiani di essere responsabili, col loro rifiuto degli dei tradizionali, dei mali che affliggono l’impero è attribuita all’empietà e all’immoralità dei pagani. La conversione non è dilazionabile perché si sta approssimando la fine del mondo, cui seguirà l’avvento del regno di Dio. Il motivo escatologico della fine dei tempi, caro alla spiritualità cristiana delle origni, è svolto con toni apocalittici e lucreziani (ad esempio, è lucreziano il motivo dell’insterilimento progressivo della terra). Sull’autenticità di altre due opere apologetiche, Adversus Iudaeos e Quod idòla dii non sint («perché gli idoli pagani non sono divinità», bensì antichi personaggi divinizzati), si nutre qualche dubbio. Nel trattato De catholicae ecclesiae unitate Cipriano difende l’unità della Chiesa contro le tesi di Tertulliano e dei montanisti (vedi p. Lo stile 694). L’idea guida è quella di una feconda varietà nell’unità: «La Chiesa è una sola e, nella sua fecondità, si estende largamente: come i raggi del sole sono molti, ma la luce è una; e molti sono i rami dell’albero, ma il Cipriano tronco è unico aggrappato a una robusta radice» (4-5). La preoccupazione per l’unità episcopale è alla base anche del De dominica oratione. Il De mortalitate affronta il tema della morte prendendo spunto da una peste verificatasi nel 252. Ai fedeli che s’interrogano sul perché il morbo non distingua tra cristiani e pagani, Cipriano risponde che gli inconvenieti della carne sono comuni a tutti gli uomini. La differenza è nel diverso significato attribuito alla morte dai cristiani. I quali, avendo rinunciato al mondo, Epist. 74, 11 sono stranieri in questa vita e accolgono con gioia il giorno in cui è loro assegnata la vera patria, cioè il paradiso. Sono riecheggiati, anche se resi in una veste biblica, passi di Lucrezio, Cicerone, Seneca. In alcune lettere dell’epistolario (vedi p. 688) è svolto il tema del valore del battesimo impartito dagli eretici. Contro il parere di Stefano, vescovo di Roma, secondo il quale il sacramento ha una validità assoluta indipendente dal ministro, Cipriano riteneva che gli eretici dovessero esser ribattezzati: Come … chi non stava nell’arca di Noè non poté essere tratto in salvo attraverso l’acqua, così neppure ora può essere salvato per mezzo del battesimo chi non è stato battezzato nella Chiesa, che secondo il simbolo di quell’unica arca, è stata fondata sull’unità del Signore. Il dissenso con Stefano in parte esulava dalla questione sul valore del battesimo conferito dagli eretici e finiva col riguardare l’autonomia delle singole sedi vescovili rispetto al vescovo di Roma che, in quanto successore di Pietro, rivendicava per sé un’autorità superiore agli altri vescovi. La polemica fu troncata dalla persecuzione scatenata da Decio. Inseriamo in questo gruppo le opere che definiscono il giusto comportamento da tenere, la norma a cui attenersi per la risoluzione di un problema pratico o dottrinale. Gli scritti Ad Quintum e Ad Fortunatum si propongono di corroborare gli animi dei fedeli nell’imminenza di una persecuzione e sono interamente costruite di citazioni bibliche. Il motivo risiede nella vanità della parola umana, che deve cedere di fronte a quella di Dio: «In esortazione ... al martirio bisogna troncare le nostre parole ... e riportare solo le parole di Dio, con le quali Cristo esorta al martirio i suoi servi» (Ad Fort. 4). Nel De lapsis («I caduti») si affronta il problema del trattamento da riservare ai lapsi, cioè ai cristiani che, per evitare il martirio, avevano fatto sacrifici agli dei pagani (sacrificati) o bruciato incenso in loro onore (thurificati) o comperato un libello di abiura (libellatici). Cipriano sceglie una via intermedia (temperamentum) tra rigorismo esasperato (richiesto da Tertulliano) e l’eccessiva indulgenza: coloro che avevano abiurato la fede potevano ritornare in seno alla Chiesa, solo dopo un’adeguata penitenza. Riecheggiano motivi tertullianei il De habitu virginum, che loda le fanciulle consacrate a Dio esortandole alla modestia e alla pudicizia, e il De bono patientiae in cui elogia la virtù cristiana della sopportazione. Nel De eleemosynis è svolto il tema, già sviluppato nella diatriba stoico-cinica, della vanità della ricchezze e della necessità del fare beneficienza: «Hai paura che il tuo patrimonio s’estingua se farai molte elemosine … temi di perdere il patrimonio e invece del patrimonio perdi te stesso» (Epist. 14). Lo stile è solenne e gradevolmente pacato, come lo definì Girolamo: Beatus Cyprianus instar fontis purissimi dulcis incedit et placidus ... (Epist. 58, 10). L’eleganza e la dignità delle forme classiche – sebbene nei suoi 701 702 Apologia, catechesi e dottrina negli autori cristiani scritti non venga mai nominato un autore pagano – si fondono con la maestà delle citazioni bibliche. Frequenti sono i preziosismi lessicali, gli artifici retorici (parallelismi, antitesi, omoteleuti, ricerca di clausole ritmiche), l’assunzione di temi, motivi, topoi della letteratura classica. Ad esempio, l’esordio dell’Ad Donatum ricalca i tratti La vita distintivi del locus amoenus (vedi il passo riportato). Per le doti di equilibrio e armoniosa fluidità la scrittura di Cipriano rappresenta «il modello dello stile pastorale, splendido, suadente e pervaso di serafico ardore che sarà proprio di molti vescovi, pontefici e predicatori cristiani» (L. Perelli). IlIl De travaglio della conversione (Ad Donatum III ss.). Nell’Ad Donatum, prima opera composta dopo la conversione, è demortibus scritta l’esperienza personale dell’incontro con la vera fede. I passi che riportiamo di questa autobiografia spirituale anticipersecutorum pano – per la capacità di scavo introspettivo, per l’intimità del colloquio istituito con la propria anima – le Confessioni di Agostino. Quando giacevo nelle tenebre e nella notte oscura e quando, vacillante nel mare agitato di questo mondo incerto, ondeggiavo lungo la via dell’errore, senza sapere cosa fosse la mia vita, estraneo alla verità e alla luce, immaginavo fosse cosa difficile e dura, per quelle che erano allora le mie abitudini, ciò che mi prometteva per la salvezza la divina misericordia: che uno potesse rinascere e che animato a nuova vita per il bagno dell’acqua di salvezza, lasciasse quello che era stato e cambiasse l’uomo nell’animo e nel cuore pur restando la compagine del corpo. Come è possibile, dicevo, tanta trasformazione, che così all’improvviso e così rapidamente ci si spogli di ciò che o innato è indurito per la corruzione naturale della materia o una volta acquistato si è sviluppato per abitudine inveterata? Queste cose si sono attaccate con radici molto profonde… Questo ripetevo spesso a me stesso. Infatti ero tenuto invischiato dai numerosi errori della mia vita anteriore, dai quali non riuscivo a credere che avrei potuto sbarazzarmi: io assecondavo i vizi inveteratiDivinae e disperando di migliorare fomentavo i miei mali come già naturali e assimilati. Ma dopo che fu Le Institutiones lavata la macchia della mia vita precedente con l’aiuto dell’acqua di rigenerazione e si infuse dall’alto la luce nel mio spirito trasformato e purificato, dopo che, per aver attinto lo Spirito dal cielo, la seconda nascita mi trasformò in uomo nuovo, subito straordinariamente prese fermezza ciò che era incerto, si aprì ciò che era chiuso, s’illuminò ciò che era oscuro, si mostrò facile ciò che prima sembrava difficile, fu possibile ciò che sembrava impossibile, così che potevo comprendere che era cosa terrena la mia vita carnale di prima soggetta al peccato, che cominciava ad essere di Dio ciò che adesso lo Spirito santo animava. (trad. di I. Mariotti) BASSO IMPERO Il locus amoenus della conversione (Ad Donatum I ss.). Il teatro della conversione ha i tratti allettanti del locus amoenus: luogo ridente, piacevolmente fresco e separato, sfondo ideale della meditazione filosofica (l’archetipo è nel Fedro di Platone). Carissimo Donato, fai bene a richiamarmi all’ordine: infatti e ricordo di averti fatto una promessa, e questo è certamente il tempo più adatto per mantenerla: col favore della vendemmia l’animo libero da preoccupazioni sceglie per riposarsi la tregua abituale e fissa dell’anno che declina. Anche il luogo Una svolta nell’apologetica armonizza con il giorno e, per accarezzare e ricreare i sensi, l’aspetto gradevole del giardino è in consonanza con le dolci brezze dell’autunno che ci alletta con le sue lusinghe. È meraviglioso trascorrere un giorno qui a conversare e a formare la propria anima ai precetti divini attraverso discorsi impegnativi. Ma affinché nessun testimone profano disturbi il nostro conversare o le grida senza ritegno e gli schiamazzi degli schiavi non ne limitino la percettibilità, dirigiamoci in questo posto: il vicino luogo appartato, dove, mentre i tralci delle viti che corrono in diverse direzioni si avvolgono con penduli e intrecci sulle canne di sostegno e le sommità frondose hanno formato come un portico coperto di pampini, ci offre la possibilità di essere soli. Qui possiamo ben offrire alle orecchie l’ascolto di un’esposizione dottrinaria e, mentre guardiamo gli alberi e le viti, deliziamo la nostra vista con uno spettacolo attraente, cosicché nello stesso tempo l’udito istruisce l’anima e la vista la nutre. Ma per te l’unica cosa gradita e l’unica preoccupazione è il discorrere; disdegnando le attrattive di uno spettacolo gradevole hai occhi fissi su di me e mi ascolti completamente rivolto a me con il volto, con la mente e con l’amore che nutri per me. (trad. di A. Matrella) Lattanzio Lattanzio L’africano Lucio Cecilio Firmiano Lattanzio, forse allievo di Arnobio, fu professore di retorica a Nicomedia negli anni a cavallo tra III e IV secolo, su incarico di Diocleziano. Convertitosi al cristianesimo, dopo la persecuzione scatenata da questo imperatore (a partire dall’anno 303), fu costretto a rinunciare all’insegnamento. In seguito fu da Costantino chiamato a Treviri come istitutore De delira figlio Morì dei proDei,Crispo. De opificio babilmente dopo il 324. Sotto la spinta emotiva di eventi vissuti di persona, Lattanzio scrisse l’opera apologetica De mortibus persecutorum, una storia delle persecuzioni da Nerone a Massimino: storia drammatica e cruenta, che tuttavia corrispondeva a un disegno provvidenziale, come si evinceva dal fatto che la nuova religione non era stata stroncata e tutti gli imperatori responsabili degli eccidi avevano subito una morte orrenda, da Nerone a Domiziano, da Decio a Diocleziano: «Perché i posteri potessero imparare che vi è un solo Dio e che questi è un giudice che infligge agli empi e ai persecutori pene proporzionate alla sua grandezza» (I 7). L’individuazione di una provvidenza come motore della storia pone le condizioni per la nascita della storiografia cristiana di Agostino (vedi p. 664). Inoltre, il fatto palazzo che la fortuna degli imperatori dipenda dalla provvidenzaIngresso divina principale anticipa del la concedi Diocleziano (300 circa). Spazione, che sarà del greco Eusebio, dell’imperatore cristiano lato. come rappresentante in terra dell’Imperatore celeste. Una più impegnativa opera apologetica sono i sette libri delle Divinae Institutiones, esposizione sintetica dei principi della dottrina cristiana ad uso dei pagani colti, che la condannavano senza conoscerla. È il primo esempio di presentazione organica del cristianesimo in lingua latina (in greco erano già apparsi i Principii di Orìgene), è una summa della nuova religione, quasi un manuale come suggerisce il titolo: il termine institutio usato in ambito giuridico (Institutiones civilis iuris, i manuali di diritto civile) o retorico (Institutio oratoria di Quintiliano) indica l’insegnamento dei fondamenti di una disciplina. Dato il tipo di destinatario, la trattazione non è supportata da troppi esempi tratti dalle Scritture, ma condotta con argomentazioni pacate e dimostrazioni razionali. Lontano dagli eccessi e dall’irruenza polemica di Tertulliano, Lattanzio si rivela un ragionatore sistematico, misurato al punto da essere considerato il «Cicerone cristiano»: fluvius eloquentiae Tullianae, «fiume di ciceroniana eloquenza», lo definì Girolamo. Del resto egli conosce bene Cicerone, che ammira e del quale cita spesso le opere, in particolare il De republica e il De natura deorum. Con Lattanzio l’apologetica si rasserena, passando dal terreno astioso della polemica tertullianea a quello di un pacato dibattito di idee. Non è più conflittuale il rapporto con la cultura pagana, con la quale il cristianesimo tende ad istituire un rapporto non più di contrapposizione, ma di continuità. Ai cristiani l’autore rivolge l’accusa di non avere appreso a sufficienza le tecniche della comunicazione e la retorica, che egli considera un mezzo efficace di diffusione del messaggio evangelico. I classici della letteratura latina sono citati e considerati maestri di stile, non disprezzati neppure per i contenuti, ai quali si riconosce una parte di verità: è il caso dell’interpretazione, che avrà fortuna nel Medioevo, in chiave messianica e cristiana dell’egloga IV di Virgilio, il quale – conviene Lattanzio – spesso «non fu lontano dalla verità» (I 5, 10). Persino ai Libri Sibillini è riconosciuta una verità, sia pure frammentaria e parziale. Del resto anche nel De mortibus persecutorum, 703 704 Apologia, catechesi e dottrina negli autori cristiani la più polemica delle opere di Lattanzio, gli imperatori malvagi non rappresentano il mondo romano, del quale hanno tradito lo spirito di tolleranza. Prende corpo l’idea, che si consoliderà nei secoli seguenti, che i migliori spiriti pagani si siano avvicinati a Dio, per quanto è possibile con le sole forze umane. Il cristianesimo non si contrappone alla sapientia classica, ma ne rappresenta l’inveramento, il completamento, il frutto. Si tratta di un progetto di unificazione culturale proposto con grande tempestività, negli anni in cui nasce l’alleanza tra Chiesa e Impero. Il De ira Dei e il De opificio dei («Sull’opera creatrice di Dio») sono trattati che confutano le posizioni razionalistiche della filosofia greca, in particolare quelle epicuL’arianesimo ree riguardanti la natura della divinità vista come indifferente e distante dalle vicende umane. Il Dio cristiano non solo non si disinteressa dei fatti degli uomini, ma regge la storia secondo un disegno provvidenziale. Inoltre non è affatto imperturbabile, anzi si adira, anche se la sua collera è piuttosto una giustizia punitiva, finalizzata a ristabilire un ordine infranto dalle forze del male. Dio è presentato con i tratti, ben accetti al lettore pagano, di un pater familias e il suo potere rientra nella concezione romana di un imperium giusto. Pur nella polemica, permane l’attenzione alle linee di continuità con le filosofie antiche, in particolare la stoica e la platonica, delle cui aspirazioni la nuova religione viene considerata la più completa realizzaTeologia zione. La designazione dei cristiani con la formula philosophi sectae nostrae «i filosofi della nostra scuola» (Opif. Dei 1, 2) laicizza il cristianesimo, quasi fosse una delle tante scuole di pensiero del mondo antico. BASSO IMPERO La verità è un dono divino (Divinae Institutiones I 1, 1-7). Nell’esordio delle Divinae Institutiones Lattanzio riconosce l’impegno profuso dai migliori spiriti antichi nella ricerca della verità, che tuttavia non può essere raggiunta con le sole forze umane. Quegli uomini di grande intelligenza, appassionati del sapere, dediti alla virtù per raggiungere la quale rinunciarono agli agi e ai piaceri, sarebbero stati ben degni di conseguire la verità, se questa fosse alla portata dell’uomo. Da questa impossibilità umana di elevarsi autonomamente alla vera sapienza consegue l’obbligo di conoscere la verità rivelata da Dio e di diffonderla tra gli altri uomini. È questo lo scopo dell’opera che l’autore si accinge a scrivere. Uomini di grande e singolare intelligenza si dedicarono appassionatamente allo studio e, spregiata Esegesi ogni attività privata o pubblica, rivolsero all’impegno di cercar la verità ogni loro sforzo, giudicando che investigare e conoscere la natura delle realtà umane e divine fosse molto più nobile del rivolgersi ad ammucchiar ricchezze o ad accumulare cariche: [2] poiché queste son realtà fragili e terrene e riguardano la cura del solo corpo, da esse nessuno può esser reso migliore, nessuno più giusto. [3] Erano costoro certamente degnissimi di conoscer la verità, perché ebbero tanto desiderio di sapere e in modo tale da anteporla a tutto: [4] si sa che alcuni trascurarono le loro sostanze e rinunciarono ad ogni piacere per seguire, liberi da ogni impedimento, la sola e nuda virtù, e tanta forza ebbero per loro la rinomanza e l’autorità della virtù, da giudicare che il premio del sommo bene fosse in essa riposto. [5] Ma non conseguirono ciò che volevano, e consumarono invano tutte le loro energie, perché la verità, cioè il mistero del sommo Dio creatore dell’universo, non può essere afferrata con le sole capacità della mente umana: non ci sarebbe differenza tra Dio e l’uomo, se il pensiero umano comprendesse i disegni e le decisioni dell’eterna maestà. [6] Poiché non era possibile che l’uomo da solo conoscesse la natura di Dio, egli però non permise che l’uomo, nella sua ricerca della luce della sapienza, errasse più a lungo e vagasse senza alcun risultato in tenebre da cui non sarebbe potuto uscire: gli aperse infine gli occhi e gli fece dono della conoscenza della verità, per mostrare la vanità dell’umana sapienza e per indicare, all’uomo che andava qua e là vagando, la via per giungere all’immortalità. [7] Ma pochi profittano di questo favore e di questo dono divini: la verità rimane nascosta, avvolta nelle tenebre, ed è disprezzata dai dotti, perché Apologia è priva di difensori capaci, ed è odiata dagli ignoranti per il suo proprio carattere austero, che la natura umana, proclive ai vizi, non può sopportare: alle virtù è congiunta un’impressione di asprezza, mentre i vizi sono addolciti dal piacere: perciò gli uomini, provando repulsione per quella e lusingati da questo, scelgono il male invece del bene. Per questi motivi ho ritenuto mio dovere porre rimedio a questi errori, perché i dotti siano indirizzati alla vera sapienza e gli ignoranti alla vera religione. (trad. di E. Gallicet) Ambrogio Iliario Il grande teologo Ilario nacque a Pictavium (oggi Poitiers) in Aquitania intorno al 315. Fu strenuo avversario dell’arianesimo, movimento eretico che godeva della protezione dell’imperatore Costanzo. Da questo, Ilario, per l’attività antiariana, fu esiliato in Asia Minore nel 364. Qui ebbe modo di conoscere il pensiero teologico orientale (in particolare lesse Origene) e compose la maggior parte delle sue opere. Ritornato in Gallia intorno al 360, riprese la lotta contro l’arianesimo. Girolamo nel Chronicon ne fissa la morte al 367. L’insegnamento del prete di Alessandria Ario (256-336) diverge dal cattolicesimo nella concezione della Trinità, in particolare del rapporto che unisce il Padre al Verbo incarnato. Il Figlio è una creatura di Dio, ma distinta da Dio, non coeterna al Padre ma a questo subordiOpere dottrinali nata e dissimile (anòmoios) nella sostanza. Più precisamente, il Figlio è una sorta di deed esegetiche miurgo generato ai fini della creazione. Nel 325 il Concilio di Nicea, voluto da Costantino, respingeva la formulazione ariana affermando la consustanzialità del Padre e del Figlio: questo è homousios (in lat. consubstantialis) al Padre. L’eresia ebbe una ripresa sotto l’imperatore Costanzo, che la protesse per motivi di opportunità politica: l’indebolimento della figura di Cristo, fondatore della Chiesa, era funzionale alla politica di subordinazione della Chiesa all’impero. In seguito all’editto di Teodosio, che identificava col cattolicesimo l’ortodossia, l’arianesimo perse ogni vigore, tranne presso le popolazioni germaniche. In Matthaeum 19, 3 Nel trattato dogmatico De trinitate, una delle vette dal pensiero teologico occidentale, Ilario definisce con rigore speculativo il dogma trinitario. Alla concezione ariana egli oppone la tesi nicena della consustanzialità e coeternità di Padre e Figlio, due «persone» distinte ma della medesima natura divina. Del Figlio è affermata, accanto alla natura divina, anche quella umana, in virtù della quale Cristo ha potuto immolarsi per la salvezza degli uomini. Il problema cristologico è al centro dell’interesse speculativo di Ilario, il quale appare debolmente interessato alla terza persona della Trinità, lo Spirito Santo, cui accenna con termini generici (res, munus, donum). Di rilevante interesse storico è il trattato De synodis, storia dei concili orientali sulla Il metodo allegorico disputa trinitaria, che presenta il mondo vario della religiosità orientale. Alla riflessione teologica Ilario affianca un’intensa attività esegetica, condotta prevalentemente col metodo allegorico (vedi p. 705). Ricordiamo i commenti In Psalmos e In Mattaeum, nei quali l’autore ricerca un equilibrio tra senso letterale e figurato. Ne è un esempio l’esegesi del passo famoso in cui, agli apostoli che allontanano i bambini da Cristo, questi dice: Sinite parvulos, et nolite eos prohibere ad me venire (Matt. 19, 14). È strano che i discepoli abbiano proibito ai bambini di avvicinarsi a Cristo … È certamente vero che i bambini furono portati, come è vero che furono allontanati. Ma essi sono l’immagine dei pagani, ai quali viene resa la salvezza per la fede in ciò che hanno ascoltato. E viene loro impedito di avvicinarsi dai discepoli, per il loro desiderio di salvare prima Israele. Certo, la volontà di allontanarli non si addice alla clemenza degli apostoli, ma in essa s’insinua l’impulso di sgridare i bambini per compiere un gesto tipologico. Nel Tractatus mysteriorum, al metodo allegorico si aggiunge quello tipologico che interpreta eventi e personaggi (Adamo, Noè, ecc.) dell’Antico Testamento come prefigurazioni («tipi» o «figure») di Cristo e della Chiesa. Opere apologetiche, sempre legate all’impegno antiariano, sono i Collectanea antiariana, il Liber ad Constantium imperatorem (per indurre l’imperatore a schierarsi dalla parte dell’ortodossia cattolica), il Contra Constantium imperatorem, fiera invettiva scritta dopo la morte dell’imperatore (361) paragonato ai peggiori persecutori della fede. Ilario compose anche un Liber hymnorum giuntoci frammentario, che è la prima raccolta di inni in lingua latina e anticipa l’innodia di Ambrogio. 705 706 Apologia, catechesi e dottrina negli autori cristiani BASSO IMPERO Opere ascetiche Pagina-incipit di Sant’Ambrogio, Hexameron, Corbie, seconda metà dell’ottavo secolo. Girolamo e la Vulgata Ambrogio Nella vita di Ambrogio, il leggendario vescovo di Milano (vedi il profilo, p. 644), esegesi e catechesi si fondono con gli impegni politici legati al magistero esercitato nella città divenuta sede imperiale. È Ambrogio che consiglia Graziano di rimuovere la famosa ara della Vittoria dalla Curia del senato (vedi p. 681); che impedisce la concessione – sollecitata da Giustina madre di Valentiniano II – agli ariani di una basilica milanese (vedi p. 644); che pronuncia le orazioni funebri Sulla morte di Valentiniano II e Sulla morte di Teodosio. Pastore d’anime, asceta, difensore dei poveri, uomo politico, Ambrogio è una delle figure più nobili e complete che abbia avuto la Chiesa. Tra le opere di contenuto dottrinale e apologetico ricordiamo quelle contro l’eresia ariana: De fide, De Spiritu Sancto. Questa dottrina, già condannata nel Concilio di Nicea (325), fu da Ambrogio combattuta con tale vigore che l’iconografia cristiana lo raffigurò sempre con la sferza rivolta contro l’arianesimo. Contro il rigorismo di Novaziano è il De paenitentia. Il De Sacramentis tratta dei sacramenti battesimo, cresima, eucarestia. Alla produzione di carattere esegetico, che è la più abbondante di questo autore, appartengono in particolare i commenti all’Antico Testamento e al Vangelo di Luca e un commento della creazione del mondo (Genesi I 1-26) intitolato Hexameron («I sei giorni della creazione»). L’Hexameron è una raccolta di nove omelie tenute durante la settimana santa (fra il 386 e il 390) che trattano, nell’ordine: il cielo e la terra, la luce, le stelle, i mari, le piante, il sole, la luna, gli uccelli, gli animali e l’uomo. L’esegesi è condotta talora verso per verso, talora un intero passo fornisce lo spunto per riflessioni di carattere morale o dottrinale. Il metodo interpretativo è prevalentemente quello allegorico e morale, basato sull’insegnamento di Orìgene. La vita Le opere Orìgene, scrittore cristiano di lingua greca (nato ad Alessandria intorno al 185 e morto nel 253 d.C.) impiega nei suoi Commentarii il metodo allegorico. La teoria dell’allegorismo, che nel Medioevo ci è resa familiare da Dante, era nata con S. Paolo (videmus nunc per speculum in aenigmate, tunc autem facie ad faciem) e fu ripresa da Girolamo, Agostino, Tommaso fino a divenire un cardine dell’esegesi medioevale. Ecco come Dante chiarisce il metodo: «Questa maniera di trattazione si può guardare in questi versi: In exitu Israel de Egypto, domus Jacob de populo barbaro, facta est Judea santificatio ejus, Israel potestas ejus. Se guardiamo solo la lettera è significata l’uscita dei figli di Israele dall’Egitto al tempo di Mosè; se guardiamo l’allegoria è significata la redenzione nostra per opera di Cristo; se guardiamo al senso morale è significata la conversione dell’anima dal lutto e dalla miseria del peccato allo stato di grazia» (Epistola XIII). Un esempio d’interpretazione allegorica è nel passo dell’Hexameron in cui è descritta la nascita della rosa, simbolo della vita umana (humanae speculum ... vitae, III 4, 48). Come il fiore più bello di tutti era stato creato senza spine, anche la vita dell’uomo era, prima del peccato originale, priva di sofferenze e tribolazioni. Ricca è, soprattutto nell’Hexameron, la tessitura intertestuale con citazioni da Platone, Plotino, Omero, Plauto, Lucrezio (nella descrizione dell’universo nascente), poeti augustei, Seneca. Non mancano squarci lirici che fanno pensare all’Ambrogio innografo (vedi p. 644). A questo gruppo di opere appartengono anche il De Tobia e il De Nabuthe che affrontano il tema della ricchezza. In particolare nel secondo sono presenti motivi e stilemi che riconducono alla satira stoico-cinica e alla filosofia popolare: personificazioni di concetti astratti, domande poste ex abrupto a interlocutori fittizi, espressioni colorite e tali da far presa sull’uditorio. Girolamo filologo San Girolamo, in un celebre dipinto del Caravaggio (16051606). Roma, Galleria Borghese. 707 708 Apologia, catechesi e dottrina negli autori cristiani All’ambito ascetico appartengono gli scritti sul tema della verginità: De virginibus, De virginitate, De institutione virginis, Exhortatio virginitatis, De viduis («Le vedove»), De lapsu virginis consecratae («La caduta di una vergine consacrata»). Netta è l’esaltazione di questa virtù ascetica: Enumero i frutti della verginità consacrata a Dio … regno, oro, bellezza. Regno, perché sei sposa del Re eterno …; oro perché, come questo metallo è più prezioso, così la bellezza di un corpo verginale consacrata allo Spirito divino diventa più grande; e chi si può ritenere più bella di colei che è amata dal re, lodata dal giudice, consacrata al Signore? I 7 35-36 Praef. 7; trad. di A. Cerasa-Gastaldo Le versioni della Bibbia prima di Girolamo BASSO IMPERO Girolamo traduttore La Vulgata Spesso l’argomentazione poggia su esempi tratti dal mondo classico, come quando nel De verginitate (XV 94 ss.) l’autore reimpiega l’immagine dell’auriga e dei cavalli alati – che in Platone simboleggiavano la ragione e gli impulsi irrazionali – facendone l’allegoria di Cristo che tiene a freno le passioni dell’animo (ira, cupidigia, piacere, timore). Di notevole interesse sono i tre libri del De officiis ministrorum, riscrittura cristiana del De officiis di Cicerone, contenente esortazioni alla virtù rivolte al clero e ai fedeli. Dell’opera ciceroniana è conservata la struttura tripartita (trattazione della materia in base all’honestum nel primo libro, all’utile nel secondo, al rapporto tra i due concetti nel terzo), mentre gli exempla non sono tratti dalla storia romana, ma dalla Bibbia. Della romanità pagana sono recuperati valori e nozioni fondanti dell’etica, come la nozione di diritto naturale, la priorità del pubblico sul privato, l’autorità della ragione sulle passioni, la virtù come sommo bene, l’imperturbabilità del saggio. Anche se, precisa l’autore, questi comportamenti e concetti raggiungono la loro pienezza solo in ambito cristiano: ad esempio fides, che in Cicerone indicava «la parola data», assume ora il significato più alto e completo di «fede in Dio». La convinzione è che sia possibile una mediazione culturale tra paganesimo e cristianesimo, e che da questa dipenda l’integrazione – che molto sta a cuore ad Ambrogio – tra Chiesa e Impero. La produzione apologetica, dottrinale, esegetica di Agostino Girolamo e la Vulgata Sofronio Eusebio Girolamo (o Gerolamo) nacque a Stridone, ai confini tra Pannonia e Dalmazia, poco prima della metà del IV secolo. Ancora fanciullo si recò a Roma, dove intraprese gli studi classici ricevendo un’educazione accurata soprattutto in campo grammaticale: fu allievo di Elio Donato, da cui trasse la passione per la letteratura pagana. Successivamente si trasferì a Treviri, per proseguire nella sua formazione culturale e cristiana; qui probabilmente maturò la sua vocazione monastica. Dopo una seconda permanenza in Italia si recò in oriente per dedicarsi alla vita eremitica ed ascetica. Peregrinò tra Antiochia, il deserto siriaco di Calcide e Costantinopoli, non senza conoscere la rissosità dei monaci coi quali era venuto in contatto, tutti presi della loro dispute teologiche: « … meglio abitare in mezzo alle fiere che insieme a cristiani di tal genere» (Ep. 17, 3). In questo periodo iniziò lo studio dell’ebraico, che gli tornò utile successivamente quando si dedicò all’opera della traduzione della Bibbia. Quando tornò a Roma nel 382, papa Damaso gli affidò il compito di tradurre o comunque supervisionare una nuova versione delle Sacre Scritture: nacque la Vulgata, che soppiantò tutte le altre traduzioni nel mondo cristiano. Alla morte del pontefice, a causa anche di calunnie che si diffondevano sul proprio conto, si trasferì ad Alessandria e poi a Betlemme, ove proseguì nella sua attività di traduttore ed esegeta, nonché di propagatore del modello di vita ascetico e di polemista e difensore dell’ortodossia cristiana dalle sette eretiche. Morì nel 419 o 420. Tra le principali opere che ci restano, oltre alla Vulgata ed ai Commentari biblici (i suoi testi più famosi), ricordiamo il Chronicon, una sorta di cronologia dei fatti della storia da Abramo ai suoi giorni basata sui Chronica di Eusebio (vescovo di Cesarea, 265-340), il De viris illustribus, le Vite di santi monaci e un ricco Epistolario (vedi p. 689). Interessanti sono le opere esegetiche, nelle quali emergono l’erudizione e la preparazione filologica dell’autore. Tra queste spiccano i commenti alle Epistole di S. Paolo, all’Ecclesiaste, al Vangelo secondo Matteo, ai Libri dei profeti; il Liber interpretationum Hebraicorum nominum, che indaga le etimologie dei nomi biblici. Rivelano doti di narratore vivace e raffinato le agiografie: Vita Malchi, Vita Hilarionis, Vita Pauli. Vasta è infine la produzione del polemista, sulla quale sorvoliamo perché non riveste uno specifico interesse letterario. Spesso in queste opere Girolamo rivela un vis polemica astiosa, al limite dell’attacco personale. Toni pesantemente offensivi caratterizzano i tre libri Contra Rufinum rivolti all’ex-amico Rufino (per confutare il metodo d’interpretazione allegorica della Bibbia seguito da Orìgene), il Dialogus adversus Pelagianos contro l’eresia di Pelagio, l’Adversus Iovinianum contro Ioviniano (satiricamente definito Epicurus christianorum). Le opere apologetiche, dottrinali, esegetiche Contro i manichei Il manicheismo Contro i donatisti Già s’è accennato al contrasto, nell’animo di Girolamo, tra l’adesione al cristianesimo e lo sviscerato amore per la letteratura pagana (si rilegga il passo dell’epistola 22 riportato a p. 684). Si tratta di un contrasto drammatico, che culmina nel sogno in cui l’autore è trascinato davanti al tribunale divino con l’accusa d’essere ciceroniano, non cristiano (Ciceronianus es, non Christianus) e nel conseguente rifiuto dei classici: simul bibeIl donatismo re non debemus calicem Christi et calicem daemoniorum. Ma l’amore di Girolamo per la romanità pagana non venne mai meno, come si può giudicare anche dall’intensa commozione che egli prova per il sacco di Roma (410): «La voce mi si strozza in gola e i singhiozzi troncano le parole mentre sto dettando. È conquistata la città che conquistò il mondo». D’altronde Girolamo avvertiva l’esigenza di irrobustire la cultura cristiana, immettendo in essa l’erudizione del mondo classico greco-latino. A questo scopo, forte della preparazione grammaticale ricevuta alla scuola di Donato, curò la versione del Chronicon di Eusebio di Cesarea – raccolta di biografie dalla nascita di Adamo (collocata nel 2017 a.C.) all’anno 303 d.C. – completandola fino alla morte di Valente (378) e aggiungendo molte notizie tratte dal De viris illustribus di Svetonio. Egli stesso compose un De viris illustribus, raccolta di 155 biografie di autori latini, greci e soprattutto cristiani (da S. Pietro a sé stes- 709 710 Apologia, catechesi e dottrina negli autori cristiani so). Lo scopo era di dimostrare il valore degli scrittori cristiani, considerati mediocri e rozzi dall’intellettualità pagana: Imparino dunque Celso, Porfirio, Giuliano, cani rabbiosi contro Cristo, imparino i loro seguaci che pensano che la Chiesa non abbia avuto nessun filosofo né oratore né dottore, quanti e quali uomini l’hanno fondata, edificata, adornata, e cessino di tacciare la nostra fede unicamente di rozza semplicità, ma piuttosto riconoscano la loro ignoranza. Praef. 1, 1 Contro i pelagiani BASSO IMPERO Il pelagianesimo L’attività esegetica L’intento apologetico non contraddice l’assunzione a modello dell’opera svetoniana, di cui Girolamo riprende programmaticamente il titolo, considerandosi il continuatore dei biografi latini e greci: Mi esorti, Destro, ad esporre in ordine, sull’esempio di Tranquillo (Svetonio) gli scrittori della Chiesa, e a fare per i nostri autori ciò che egli ha fatto per quelli pagani ... Tale impresa compirono presso i Greci il peripatetico Ermippo, Antigono, Caristio ... presso i Latini Varrone, Santra, Nepote, Igino, e quel Tranquillo che tu mi spingi ad imitare. La perizia filologica di Girolamo si rivela soprattutto nella versione latina del Nuovo e dell’Antico Testamento. La situazione relativa alle traduzioni della Bibbia era piuttosto caotica. Nell’Oriente cristiano di lingua greca si leggevano i testi originali (in greco, appunto) per il Nuovo Testamento e la traduzione dall’ebraico, detta dei Settanta (operata in epoca ellenistica e attribuita a settanta mitici traduttori), per il Vecchio Testamento. Nel mondo di lingua latina vi erano diverse redazioni distinte su base geografica, chiamate Afra, Itala, Vetus Latina. Si trattava di «versioni in cui la particolare natura del testo aveva imposto ai traduttori criteri di assoluta fedeltà e pedissequità, col risultato di fare spesso violenza alla lingua, sia nel lessico sia nella sintassi. Il risultato era quel latino grossolano e barbarico che tanto scandalizzava il giovane Agostino, ma che ha fatto sentire forte la sua influenza sul costruirsi del latino dei cristiani» (M. Simonetti). Già nel 382 Girolamo ricevette da papa Damaso l’incarico di mettere ordine tra le versioni latine del Nuovo Testamento. Successivamente egli tradusse dal greco il Salterio sulla base degli Hexapla di Orìgene (una sorta di edizione critica della versione dei Settanta, che accostava le principali traduzioni della Bibbia nelle diverse lingue). A tale redazione – poi accolta nella Vulgata e intitolata Salterio gallicano o Iuxta LXX – fece seguito un’altra dall’Ebraico (Iuxta Hebraeos) motivata dall’esigenza di offrire un testo filologicamente aderente alla versione originale, tale da porre un freno alle calumniae degli Ebrei relative alla scarsa correttezza dei testi usati dai Cristiani. Infine, nel periodo compreso tra il 390 e il 406, Girolamo si dedicò alla poderosa opera di traduzione dall’ebraico dell’intero Vecchio Testamento: nacque così la Vulgata. L’autore, pur avendo viva l’esigenza di usare fedeltà nei confronti di un testo nel quale anche l’ordine delle parole era un mysterium, cercò tuttavia di rifuggire da incomprensibili letteralismi «a calco» tipici delle precedenti versioni e s’impegnò a rendere la Parola divina nella purezza espressiva del latino, per quanto possibile (a tale fine utilizzò anche le versioni greche e latine preesistenti). La produzione apologetica, dottrinale, esegetica di Agostino La produzione apologetica, dottrinale, esegetica di Agostino Di Agostino abbiamo studiato la concezione della storia nel De civitate Dei (vedi p. 664), il travaglio della ricerca di Dio nelle Confessiones (vedi p. 666), le forme dell’eloquenza (vedi p. 686), i caratteri dell’epistolario (vedi p. 689). Restano da considerare le opere di tipo dottrinale, esegetico, ascetico. Sterminata è in quest’ambito la produzione del vescovo di Ippona. Non c’è questione cruciale e secolare del pensiero cristiano con la quale egli non si sia misurato, dal rapporto tra fede e ragione a quello tra grazia (quindi, predestinazione) e libero arbitrio. Al periodo giovanile risalgono i trattati Contra Academicos, De vita beata, De origine, Soliloquia. Dopo il rientro a Tagaste, egli terminò il De musica, il De magistro, il De vera religione. Divenuto vescovo di Ippona, dedicò vari scritti alla confutazione di eresie. Contro il manicheismo: De utilitate credendi, De libero arbitrio, Contra Faustum. Contro i donatisti: De baptismo, Psalmus contra partem Donati, Contra Gaudentium Donatistarum episcopum, Contra litteras Petiliani, Breviculus collationis cum Donatistis. Contro gli ariani scrisse, tra il 399 e il 419, il De Trinitate che tratta il dogma trinitario con pura riflessione teologica. Contro i pelagiani: De natura et gratia, De gestis Pelagii, De gratia et libero arbitrio, De dono perseverantiae. Opere di carattere esegetico e teologico: De Genesi contra Manichaeos, De Genesi ad litteram, De doctrina Christiana, Sermones, Enarrationes in Psalmos; i commenti al Vangelo, a Giovanni e al Genesi, il De Fide et Symbolo. Nel 426 scrisse le Retractationes, con le quali passava in rassegna tutti i suoi scritti. Molti sono gli scritti contro il manicheismo, dottrina di cui Agostino stesso era stato un seguace. Dei manichei Agostino condanna il dualismo esasperato, il razionalismo e l’intellettualismo, le implicazioni antisociali della concezione ascetica. Iniziata dal predicatore persiano Mani (216-277), la dottrina del manicheismo è tutta incentrata sulla polarità tra due principi distinti e contrapposti, il bene e il male. Il bene è la luce destinata a prevalere sulle tenebre della materia. Dalla nettezza della contrapposizione consegue per i fedeli l’imperativo di rifiutare tutto ciò che attiene al mondo fisico e corporeo, considerato come creazione delle tenebre. Il dovere dell’uomo è di separare in sé l’io divino dall’io demoniaco liberando l’anima-luce dalla materialità di questo mondo. Il grado perfetto di purificazione implica sacrifici estremi (digiuni, astensione dal sesso, diete vegetali, ecc.). Dei donatisti, particolarmente attivi in Africa, Agostino rifiuta lo spirito elitario, incompatibile con la vocazione popolare del messaggio cristiano, la convinzione che l’efficacia dei sacramenti dipenda dalla qualità della persona che li somministra, l’idea che possa esistere, prima del giudizio universale, una Chiesa «pura» non contaminata da compromessi col potere politico. È un movimento scismatico, nato in Africa alla fine del secolo IV, denominato da Donato, vescovo di Cartagine (morto nel 355 circa). Il contrasto con i cattolici concerne il trattamento dei lapsi (o traditores «coloro che hanno consegnato i libri sacri», vedi p. 700) e il valore del battesimo. Per i Donatisti la validità del sacramento dipende dallo stato di grazia di chi lo impartisce, pertanto deve essere ripetuto nel caso in cui il ministro sia un eretico. Inoltre il donatismo ha una concezione elitaria della comunità ecclesiale: si propone come «Chiesa dei martiri», ovvero dei cristiani perfetti, contrapposta alla “grande Chiesa” di tutti i fedeli. Nel 313, sotto Costantino, lo scisma fu condannato anche perché esprimeva fermenti di rivoluzione sociale e nazionale contrari a Roma. La protesta antiromana e anticattolica assunse forme di vera e propria guerriglia, quando bande di disperati, i circumcelliones, si sollevarono contro i latifondisti e il clero cattolico. Il movimento sopravvisse a Donato, ma dopo la repressione di Onorio probabilmente cessò di esistere. L’interpretazione allegorica 711 Dalla lirica come genere alla codificazione petrarchesca alla lirica «moderna» La lirica dal Duecento al Cinquecento La lirica dal Duecento al Cinquecento Agli scrittori del Medioevo è estranea la nozione di genere, cioè l’idea che la letteratura si possa ripartire in classi di opere omogenee per caratteristiche formali o contenutistiche. Dall’antichità sono ereditate alcune forme (il poema epico, l’epistola, l’orazione) che vengono variamente combinate, senza che i nuovi modelli ricevano una codificazione precisa. C’è chi ha proposto di non usare il termine «genere» per la letteratura medioevale, ma «registro», con riferimento alla teoria degli stili (umile o comico, mediocre, sublime o tragico), una tripartizione che di fatto si riduce alla bipartizione fra uno stile alto e uno basso: più elaborato formalmente il primo, più immediato e dimesso il secondo. In assenza di una definizione normativa del sistema dei generi, non è facile descrivere le specificità della lirica medioevale. In contrasto col carattere prevalentemente educativo della letteratura di questo periodo, la lirica si connota in primo luogo per l’assenza di intenti moralistico-didattici. Essa rifiuta programmaticamente la funzione pedagogica, anche se non è affatto escluso l’insegnamento indiretto, nel senso che il lettore può uscire arricchito dal confronto tra l’esperienza del poeta e la propria. Altri elementi caratterizzanti sono: • la forma versificata e l’adozione di schemi strofici (sonetto, canzone, ballata). Questo tratto rimarrà sempre distintivo della lirica, che solo nell’Otto-Novecento abbandonerà questi vincoli; • la presenza della prima persona e il rilievo dato al poeta che esprime, in forma di monologo o confessione, i propri sentimenti. Nella poesia d’amore ha forte risalto anche la persona (la donna) che ispira quei sentimenti; • l’assenza – nelle forme più liricamente «pure» – di un’azione esterna al soggetto che esprime i propri sentimenti; • l’acronicità, nel senso che l’esperienza espressa tende a collocarsi su un piano assoluto, al di là della contingenza spazio-temporale. Questo tratto si lega al carattere «disinteressato» della lirica, a cui, come s’è detto, è per lo più estraneo l’intento di educare, esortare, convincere. Ma questi aspetti esprimono solo una tendenza. L’acronicità e il «disinteresse» non sono mai totali. Infatti non mancano nella lirica gli spunti narrativi, descrittivi, argomentativi. Né potrebbero mancare. Secondo Bàrberi Squarotti la lirica si caratterizza per una «continua tensione tra la puntiformità della dichiarazione patetica e le trasgressioni … inevitabili per dare durata e continuità a quel grido». La necessità di dilatare questo grido – cioè il nucleo sorgivo della composizione lirica – obbliga il poeta a contaminare la «purezza» con «trasgressioni» che vanno nella direzione del racconto, della dimostrazione, del dialogo, cioè di forme testuali che appartengono ad altri generi (romanzo, trattato, dramma). La commistione è poi agevolata nel Medioevo dal fatto che, come s’è detto, non esiste una normativa dei generi. Abbiamo allora la lirica di Guido Guinizelli, che alla stregua di un trattato argomenta tesi filosofiche: ad esempio, la tesi che l’amore penetra nei cuori gentili per un’adesione spontanea e che la gentilezza consiste non nella nobiltà ereditaria, ma nelle qualità morali: Caratteri generali 731 732 Dalla lirica come genere alla codificazione petrarchesca alla lirica «moderna» Al cor gentil rempaira sempre amore1/ come l’ausello in selva alla verdura …/ ché non dé dar om fé/ che gentilezza sia fòr di coraggio/ in degnità d’ere’2… Drammatizzazione e spersonalizzazione Quanto alla prevalenza della prima persona, questo non significa che sia sempre il poeta ad esprimersi in forma diretta. Il soggetto può essere sostituito da personificazioni (di concetti astratti, ma anche delle parti del corpo) o rappresentato da oggetti, come in questa composizione di Cavalcanti dove parlano gli strumenti di scrittura al posto del poeta: Noi siam le triste penne isbigottite,/ le cesoiuzze e ’l coltellin3 dolente,/ ch’avemo scritte dolorosamente/ quelle parole che vo’ avete udite. Ecce ancilla Domini, dipinto di Dante Gabriel Rossetti del 1850, Londra, Tate Gallery. Nel particolare, l’angelo e Maria risentono di una stilizzazione che nelle intenzioni di Rossetti dovrebbe essere «pura», «primitiva», stilnovistica. Guinizelli Si è tentati di fare un confronto col «mutuo scambio personificato» che nella poesia greca arcaica si istituiva tra il soggetto e un organo (thymós, kradíe, phrénes, nóos, ecc.), come nell’invito che Archiloco rivolgeva al proprio cuore (v. p. 269). Forse anche le ragioni di questo modo di rappresentare la vita psichica non sono troppo diverse. Nel caso della poesia greca si trattava di pubblicizzare il soggettivo per renderlo percepibile all’uditorio. Nella poesia medioevale la drammatizzazione attraverso la personificazione degli oggetti mirava ugualmente a spersonalizzare il sentimento del poeta. I lirici medioevali – Dante (1265-1321), Cavalcanti (1255-1300), Guinizelli (1230-1276) – non vogliono esprimere il loro amore negli aspetti più personali, contingenti, irripetibili, che lo distinguono da altri amori. Al contrario, «le situazioni sentimentali sono depurate dei riferimenti esplicitamente personali, che appaiono troppo legati a occasioni determinate di luogo e di tempo» (Ceserani). Alla spersonalizzazione di Cavalcanti corrisponde l’analoga tendenza di Dante ad attribuire all’amore per Beatrice una valenza simbolica, un significato assoluto: «Convinto che ci sia una verità universale, si propone di rivelarla attraverso la rappresentazione di un amore che, pur muovendo da una donna realmente esistita, diventa un esempio, valido per tutti, di avvicinamento al divino» (Ceserani). In questo atteggiamento, che mira all’astrazione e sottrae l’esperienza del poeta al suo contesto, può apparire grande la distanza rispetto alla lirica greca arcaica, che proprio dal contesto (del simposio, della festa religiosa, della vittoria agonale) traeva ogni alimento. Ma anche nel tìaso saffico, come nel simposio maschile, la comunità di vita faceva sì che la vicenda personale fosse sentita come evento esemplare, valido per tutti i componenti. All’astrazione della lirica medioevale concorre anche il fatto che i poeti del nostro Due, Trecento operavano all’interno di una tradizione letteraria consolidata – quella della poesia cortese – che aveva elaborato un insieme codificato di temi, motivi, ruoli, figure complessivamente estranei alla tradizione classica, ecc. Ad esempio il motivo dell’incedere della donna accomuna, pur nella varietà degli esiti formali, questi versi di diverse poesie: Passa per via adorna, e sì gentile/ ch’abbassa … Cavalcanti Chi è questa che vèn … e mena seco Amor … Dante quando va per via, / gitta nei cor villani Amore un gelo Dante Dante Ella si va … benignamente d’umiltà vestuta … ov’ella passa, ogn’uom ver lei si gira Anche da questo punto si può istituire un parallelo con la lirica greca arcaica, che era costruita artigianalmente a partire da elementi parzialmente precostituiti, di volta in volta riadattati e assemblati nella nuova performance. 1. rempaira: «amore trova sempre la sua vera sede nel cuore nobile». 2. ché … ere’: «perché non si deve credere che vi sia nobiltà fuori dal cuore in dignità ricevuta quale erede». 3. cesoiuzze … coltellin: piccole cesoie per tagliare le penne e coltellino per temperarle. La lirica dal Duecento al Cinquecento A mezza via tra Medioevo e Umanesimo – anzi, tra i fondatori dell’Umanesimo – è Francesco Petrarca (1304-1374), autore del Canzoniere, che costituirà il modello per la lirica italiana fino a Leopardi e Foscolo, fissando nella letteratura europea una forma nuova, quella del canzoniere, appunto, cioè della raccolta di liriche curata e voluta dall’autore: una forma, spesso applicata retroattivamente anche agli autori antichi (si parla, ad esempio, di canzoniere catulliano). Al livello più semplice di comprensione, il Canzoniere è la storia dell’amore non corrisposto del poeta per Laura, una donna di cui nulla sappiamo sul piano biografico. Per noi è una creatura letteraria al pari della Beatrice di Dante, anche se appare oggetto di un amore terreno e vive nel tempo: Laura sfiorisce, invecchia, muore. Ma più ancora di Laura è centrale nel Canzoniere l’«io lirico» del poeta, con i suoi sentimenti di gioia e dolore, entusiasmo e disperazione. Il rapporto tra la poesia del canzoniere e il personaggio di Laura è emblematico del rapporto che intercorre in genere, nella lirica, tra il poeta e la figura dell’amata, sia questa l’Anattoria di Saffo, la Lesbia di Catullo, la Leuconoe di Orazio, la Cinzia di Properzio. Si tratta sempre di distinguere la convenzione letteraria dall’esperienza vissuta. Il canzoniere di Petrarca, modello della lirica Il debito dei lirici italiani ed europei nei confronti del Petrarca è enorme. Basti questo breve elenco di riecheggiamenti petrarcheschi in Leopardi: Francesco Petrarca Passer mai solitario in alcun tetto … Vago augelletto che cantando vai … Le stelle vaghe e il loro viaggio … Disciolta di quel velo/ che qui fece ombra al fior degli [anni suoi … Mira quel colle, o stanco mio cor vago… Quanta invidia io ti porto, avara terra … Lingua mortale al suo stato divino/ giunger non puote Giacomo Leopardi D’in su la vetta della torre antica/ passero solitario, alla campagna/ cantando vai … Vaghe stelle dell’Orsa … E non vedevi il fior degli anni tuoi … Or poserai per sempre, stanco mio cor … Quanta invidia ti porto! … Lingua mortal non dice … Ma l’influenza di Petrarca non riguarda solo sparsi elementi lessicali o movenze ritmiche sedimentate nella memoria poetica di altri autori. Egli, partendo dalla propria storia d’amore, ha elaborato un modello letterario – che influenzerà la lirica italiana e europea – con tratti distintivi ben definiti, ad esempio: • la lode della donna nelle sue qualità fisiche e morali, sempre descritte in termini iperbolici (la luminosità di Laura rende chiaro il giorno e fa vergognare il sole); • gli attributi fissi della donna: capelli biondi, fronte d’avorio, denti di perla, guance di rosa, ecc. e, sul piano morale: il comportamento di diamante, ecc.; • la celebrazione dei luoghi dell’incontro (che hanno i tratti del locus amoenus: «Chiare, fresche, dolci acque…») e dei tempi (il fatidico «dì sesto d’aprile» del 1327, giorno dell’innamoramento). Petrarca rappresenta per la letteratura europea fino al Romanticismo un modello di naturalezza espressiva basato sulla nitidezza dello stile, sulla regolarità metrica, sulla ricerca di una tonalità media e costante, sull’impiego temperato di figure (antitesi, parallelismi, chiasmi, ecc.) che smorzano i conflitti componendoli in un’alta malinconia. Il miracolo di questa poesia nitida, elegante, levigatissima e appassionata ad un tempo, è svelato da Foscolo nel Saggio sopra le poesie del Petrarca: Mentre esso geme sotto le angosce proprie, cercherebbe indarno di esaminare ciò che svolgesi nel suo cuore; e i lirici versi che il Petrarca durò trentadue anni a scrivere, possono leggersi in pochi dì. Molte composizioni furono concepite ne’ momenti che la passione più poteva sopra di lui, ma furono scritte assai giorni, forse assai mesi, e certamente perfezionate assai anni dopo. E se la mente di lui non avesse avuto intervalli di riposo, egli sarebbe stato inetto a vestire que’ concepimenti, e vie più emendarli. 733 734 Dalla lirica come genere alla codificazione petrarchesca alla lirica «moderna» La lirica in lingua latina Riflettendo sui versi di Petrarca, Foscolo non solo elabora la sua personale poetica del «calore di fiamma lontana», cioè di una poesia nella quale il dato passionale è stato filtrato dal trascorrere del tempo e dal lavoro di lima; ma soprattutto formula una definizione di lirica in parte ancora attuale: quella di una poesia che decanta – liricamente, appunto, attraverso il ricordo – l’irruenza dello stato affettivo contingente. Questa idea di lirica interessa il nostro discorso – che mira al confronto continuo tra poesia antica e recente – perché alla sua definizione hanno concorso in misura determinante i poeti latini e greci. Ma anche, inversamente, perché è alla luce di questo modello autorevole di lirica che sono spesso stati interpretati, e fraintesi, gli autori antichi. Alla morte di Petrarca (1374) segue quello che Croce definì «il secolo senza poesia». I maggiori letterati, Poliziano, Boiardo, Lorenzo de’ Medici, Sannazaro, non diedero le migliori prove nella lirica. Fa eccezione Giovanni Pontano (1426-1503), che però si espresse esclusivamente in latino. Figura centrale dell’Umanesimo napoletano, scrisse tra l’altro componimenti funerari che si immaginano scolpiti sulla tomba e danno la parola al defunto, come questo dedicato alla fanciulla Pruina, che nella morte si è sciolta come al sole la brina (che in latino si dice pruina): Tumulus Pruinae puellae. Ipsa loquitur Tomba della fanciulla Pruina. Lei stessa parla Nec mihi tristis hiems nocuit, nec saeva aestas non terrae, aut tumidi vis inimica maris; tabida vis rapuit, rapuit violentia febris; delicui, ut rapido sole pruina liquet. Heu nomen fatale; perinde ut sole pruina, sic ego pallenti tabe linquens perii. Non mi uccise l’inverno triste né la torrida estate, non la forza ostile della terra o del mare; una malattia mi rapì, e una violenta febbre; mi sciolsi come la brina al sole rapido. Era scritto nel nome; come la brina al sole, sono morta consumandomi di pallido morbo. La struggente malinconia, il rimpianto sommesso per la vita richiamano l’elegia antica sulla caducità umana e le espressioni del pessimismo greco e latino, ma anche le liriche della celebre Antologia di Spoon River. In quest’opera – uno dei documenti più intensi della lirica moderna (1905) e il cui debito nei confronti della poesia epigrafica antica è evidente – l’americano Edgar Lee Master immagina che i morti medesimi parlino dai loro tumuli, in forma di epigrafi. La lirica fino al Settecento Le poetiche della poikilía e del rampino La lirica barocca, dato il suo carattere antipetrarchesco e anticlassicista, potrebbe non rientrare nel nostro discorso, che mira a cogliere permanenze della poesia antica. Tuttavia esistono nelle poetiche di questo movimento aspetti che lasciano istituire utili parallelismi col mondo classico. Si tratta, in primo luogo, di analogie legate a un’idea di barocco come categoria metastorica, momento eterno e ricorrente nell’arte umana, secondo la prospettiva del D’Ors. E allora si può parlare di concettismo, di argutezza che produce meraviglia a proposito di Pindaro, degli epigrammisti alessandrini, di Ovidio del quale in particolare abbiamo indicato la sintonia con la civiltà barocca (v. p. 405). Ma l’analogia più forte sta nella concezione artigianale della poesia, intesa come il risultato di un’operazione di assemblaggio di elementi preesistenti. Il continuo riutilizzo dei materiali letterari tradizionali – che è un carattere fondamentale della poesia di Marino (1569-1625) e dei marinisti – è certo comune anche a tutta la poesia antica. Del procedimento sono consapevoli sia Bacchilide sia Marino. Il primo così enuncia la sua poetica della mìmesi: «Il poeta deve al poeta, come nel passato così ora: non è molto facile trovare le porte di canti non mai detti» (fr. 5 Sn.). Il secondo scrive: «… infin dal primo dì ch’io incominciai a studiar lettere, imparai sempre a leggere col rampino, tirando al mio proposito ciò che io trovava di buono, notandolo nel mio Zibaldone e servendomene a suo tempo». Questa idea comportava nel primo il riutilizzo di materiali poetici del repertorio mnemonico secondo la prassi della poikilía, «capacità di variare a tempo debito (in omaggio alla legge del kairòs) e secondo l’occasione toni e temi La lirica fino al Settecento del canto, senza venir meno alle attese di chi ascolta» (Giannotti). In virtù di quest’abilità euristico-mimetica, il poeta realizzava «un variopinto ordine di discorsi» (poikìlos kòsmos lógon). Per Marino, non molto diversamente, si trattava di tesaurizzare un repertorio di parole, frasi, luoghi, strutture formali, situazioni topiche, in vista di un reimpiego originale. Nel Novecento anche D’Annunzio procederà in modo simile, saccheggiando le letterature europee e dichiarando che per cominciare una poesia bisogna prendere il la – ma spesso egli prendeva l’intera partitura – da testi di altri autori. La nozione di poikilìa quasi tocca quella di aemulatio, che tanta parte ha avuto nella poesia alessandrina e nelle «gare» intraprese dai poeti latini con quelli greci. Una poetica della poikilía e del rampino presuppone una considerazione artigianale della professione del poeta, che infatti era designata, nella lirica corale del V secolo, con termini e metafore legati alla carpenteria e al mondo dei mestieri (teúchein, thésis, sýnthesis, syntíthemi, kósmos epéon, ecc.) e, negli scritti teorici dei secentisti, con termini che alludono ad operazioni di assemblaggio. Alla poikilía dei poeti antichi corrisponde, nei barocchi, la «rifunzionalizzazione dei materiali» (Getto), i quali vengono rinnovati attraverso un processo che ne muta la fisionomia originaria facendone una realtà nuova e autonoma. Ad esempio, i tratti topici petrarcheschi della bellezza femminile quali i capelli d’oro, i denti di perla, ecc. non sono più il segno di una bellezza astratta, ma attraverso l’insistenza metaforica pongono in primo piano la materia (l’oro, le perle) facendo della donna un minerale o un lussurioso gioiello. Il «leggere col rampino» implica il gusto per la catalogazione di figure, oggetti, forme espressive, per la manipolazione e la variazione combinatoria su un tema o uno spunto letterario. In un «grande gioco combinatorio» (Getto) consiste appunto la poesia del Marino. Gli schemi riferiti dalla tradizione petrarchesca alla «bellissima bionda» vengono applicati alle belle castane, alle brune, alle rosse, alle donne che nuotano o leggono (con o senza occhiali), alla «bellissima mendica», alla «bella pollarola» in una inesauribile attività associativa. L’intenzionalità della procedura e la franchezza con cui viene dichiarata – si sa che i riecheggiamenti e i «furti» in letteratura possono anche essere involontari o, come nel caso di D’Annunzio, possono essere volontari ma inconfessati – riflette una concezione dell’arte intesa artigianalmente come tecnica di montaggio. U. Eco nel suo saggio La poetica dell’opera aperta individua proprio negli autori barocchi l’inizio di una concezione «aperta» tipica dell’arte moderna, basata sulla modularità e l’assemblabilità di «pezzi» preconfezionati, poi variati con precedure argute e ricorsive. Ma da questo punto di vista avrebbe potuto cogliere aspetti di «apertura» anche in tutta la poesia orale greca. Le forme di lirica fin qui esaminate non sono influenzate, almeno non direttamente, dai classici latini e greci. La poesia medioevale, dal «dolce stil novo» alla Scuola Siciliana al Petrarca stesso, si rifà soprattutto alla lirica provenzale. Al di là delle affinità tematiche – dipendenti dal carattere soggettivo della lirica di tutti tempi – viene meno l’elemento tecnicamente decisivo per individuare il genere lirico, cioè l’insieme dei metri classici. Non mancano però, a partire dal Rinascimento, tentativi di riprodurre i metri usati in particolare da Pindaro, Anacreonte, Orazio. La canzone pindarica, introdotta nel Cinquecento da Giovan Giorgio Trissino (1478-1550) riprendeva la triade delle odi di Pindaro: strofe, antìstrofe, epòdo. Seguirono questo schema anche Gabriello Chiabrera (1552-1638) e, fra i moderni, il Pascoli negli Odi e inni e nei Canti di Castelvecchio. Anacreonte – o meglio lo Pseudo-Anacreonte delle Anacreontiche (v. p. 288) – fornì il modello all’ode-canzonetta, portata in auge da Chiabrera oltre che, nella poesia francese della Pléiade, da Ronsard. L’ode-canzonetta avrà un grande avvenire nel melodramma col Metastasio, ma anche nella poesia d’impegno civile del Parini. Ecco la strofa di una anacreontica del Chiabrera: «La violetta/ che in sull’erbetta/ apre al mattin novella/ di’ non è cosa/ tutta odorosa,/ tutta leggiadra e bella?». L’ode oraziana fu imitata da Leonardo Dati (1408-1472), Bembo, Bernardo Tasso, Fulvio Testi e Chiabrera. Dati sperimentò una trasposizione in italiano degli schemi oraziani, che sarebbe rimasta un tentativo marginale se non avesse trovato un continuatore in Giosuè Carducci (1835-1907). Mentre i precedenti esperimenti imitavano le strutture strofiche lati- Le imitazioni italiane della metrica classica 735 736 Dalla lirica come genere alla codificazione petrarchesca alla lirica «moderna» ne utilizzando versi italiani e senza considerare la quantità delle sillabe (sulla quale si fonda il verso latino), questi autori tentavano di comporre versi italiani secondo le regole classiche. Si trattava soprattutto di definire criteri in base ai quali le sillabe italiane si possano considerare brevi o lunghe: criteri, inevitabilmente artificiosi, data la natura non quantitativa della prosodia dell’italiano. A questi tentativi si dà il nome di metrica barbara, dal titolo delle carducciane Odi barbare («barbare», perché – spiega Carducci – «tali sarebbero sembrate al giudizio dei greci e dei romani»). Si vedano questi esametri del Dati: Esametro –, –, –, –, , , ¯´ ˘˘ ¯´ ˘˘ ¯´ ˘˘ ´¯ ˘˘ ¯´ ˘˘ ¯´ ˘¯ I’ son Mercurïo, di tutto l’olympico regno Nuntiïo, tra gli omini varïi inunctura salubre, splendor de’saggi; porto al certamine vostro … Quando il tempo forte del piede coincide con una sillaba atona, come in splendor del terzo verso, la parola deve adattarsi all’accentuazione richiesta dal metro (quindi si pronuncia, artificiosamente, spléndor). Paolo Rolli (1687-1765), traduttore ed editore di classici latini, si cimenta nell’imitazione quantitativa dell’endecasillabo falecio di Catullo: Falecio ¯˘´ ¯˘ ¯´ ˘˘ ¯´ ˘ ¯ ˘ ¯´ ¯˘ Cui dono il lepido nuovo libretto Pur or di porpora coperto e d’oro? Leonardo Dati riproduce la strofe saffica usata da Catullo e Orazio, uno schema su cui si misurerà anche Pascoli: Strofe saffica ¯´ ˘ ¯´ ¯ ¯´ ˘ ˘ ¯´ ˘ ¯ ¯˘ ¯´ ˘ ¯´ ¯ ¯´ ˘ ˘ ¯´ ˘ ¯ ¯˘ ¯´ ˘ ¯´ ¯ ¯´ ˘ ˘ ¯´ ˘ ¯ ¯˘ ¯´ ˘ ˘ ¯´ ¯˘ Eccomi; i’ son qui dëa degli amici, quella qual tucti gli omini solete mordere et, falso, fugitiva dirli; or la volete. (Dati, Certame coronario del 1441) Togli il pianto. È colpa. Sei del poeta nella casa, tu. Chi dirà che fui? Piangi il morto atleta: beltà d’atleta muore con lui. (Pascoli, Solon 64-67) Si vedano infine una strofe alcaica e due distici elegiaci del Carducci: Strofe alcaica ¯˘ ¯´ ˘ ¯´ ¯ ¯´ ˘ ˘ ¯ ˘ ¯˘ ¯˘ ¯´ ˘ ¯´ ¯ ¯´ ˘ ˘ ¯ ˘ ¯˘ ¯˘ ¯´ ˘ ¯´ ˘¯ ¯´ ˘ ¯´ ¯˘ ¯´ ˘ ˘ ¯´ ˘ ˘ ¯´ ˘ ¯´ ¯˘ Questo la inconscia zagaglia barbara prostrò, spegnendo li occhi di fulgida vita sorrisi da i fantasmi fluttuanti ne l’azzurro immenso. (Per la morte di Napoleone Eugenio) Distico elegiaco – , ´ – , ´ – , ´ – , ´ , ´ ¯, ´ ˘˘ ˘˘ ˘˘ ˘ – , ¯ ˘˘ – , ¯ ˘˘ / ¯ , ¯ ,´¯ ¯´ ˘˘ ¯´ ˘˘ ¯´ ¯´ ˘˘ ¯´ ˘˘ ¯˘ Surge nel chiaro inverno la fosca turrita Bologna, e il colle sopra | bianco di neve ride. (Nella piazza di S. Petronio) Lenta fiocca la neve pe’l cielo cinerëo: gridi, suoni di vita più | non salgon dalla città. (Nevicata) Nel secondo distico le parole tronche (più, città) rendono bene i tempi forti finali degli emistichi del pentametro. Dalla lirica dell’Ottocento alla lirica «moderna» L’Accademia d’Arcadia (dal nome della regione anticamente popolata da soli pastori) rappresenta nella prima metà del Settecento un movimento letterario e culturale che si oppone al Barocco. Tra le esperienze precedenti la lirica d’Arcadia, ricordiamo la tradizione aulica dell’egloga dialogata coltivata nel Quattrocento alla corte estense sia in latino (Strozzi), sia in volgare (Boiardo). La Tirsi (1506) del Castiglione apre la strada al dramma pastorale, che culmina nell’Aminta (1573) di Tasso e nel Pastor fido (1590) del Guarini, per fondersi nel Seicento col melodramma. In parallelo si svolgeva la linea parodica delle farse rusticali, che trovavano i loro precedenti nella Nencia da Barberino di Lorenzo de’ Medici (1449-92), pungente idillio in cui si finge che un contadino tessa l’elogio della propria donna. Il modo pastorale aveva interessato anche il romanzo, come nel caso del Ninfale d’Ameto di Boccaccio e della imitatissima Arcadia (1480) di Sannazaro. I poeti arcadi sottostavano a norme e riti precisi: ogni accademico prendeva il nome di un poeta greco, il presidente era il «custode», l’insegna era la siringa di Pan, la sede delle riunioni era il Bosco Parrasio, ecc. Obiettivi programmatici erano quello di estirpare il «cattivo gusto» e le astruserie introdotte dalla lirica marinista, riportando la poesia al linguaggio semplice e spontaneo della tradizione classica. Due furono le correnti dell’Accademia: una proponeva un classicismo integrale, l’altra si riallacciava al petrarchismo e all’anacreontismo di Chiabrera perseguendo un ideale estetico di «correttezza e leggiadria». Tutti gli arcadi condivisero la pars destruens del programma, che combatteva i «vizi» del barocco (concettismo, ampollosità, artificiosità di linguaggio, metaforismo esasperato, desiderio di stupire) e miravano a un tipo di poesia che non richiedesse al lettore sforzi interpretativi, ma si caratterizzasse per la sobrietà e la trasparenza dei significati, la tecnica raffinata, la delicatezza dei contorni. Un esempio, del Rolli: «La neve è alla montagna, / l’inverno s’avvicina;/ bellissima Nerina,/ che mai sarà di me?». Non sempre l’obiettivo fu raggiunto, spesso mutandosi la naturalezza e semplicità in leziosaggine e artificio, come in questi versi dello Zappi: «Era in un praticello, ove sedea/ Clori, di Ninfe un bel coro eletto:/ io d’ella ella di me prendea diletto;/ dicea: – Corri, Lesbino – ed io correa». I modelli furono soprattutto Pindaro, Anacreonte, Orazio, Ovidio, che offrirono, come s’è visto sopra, sia le forme metriche da applicare ai versi italiani, sia spunti tematici, situazioni topiche, immagini. Ad esempio questi versi del Rolli: «La selva, oh ciel! la selva/ … o delle nevi carica/ vedremo curva gemere/ o d’aquilone l’impeto/ appena sostener» riprendono l’immagine di Orazio, Carm. I 9. I contenuti, per lo più tenui e banali – che rispecchiano da un lato «un costume sociale fatto di rituali galanti, di incontri furtivi, di corteggiamenti graziosi e di timide ripulse … sullo sfondo di una natura un po’ convenzionale» (Grosser) – richiamano sia la poesia di Anacreonte sia l’epigramma ellenistico. I lirici d’Arcadia I pastori (1717 ca.), dipinto di Antoine Watteau. Berlino, Museo di Charlottenburg. Dalla lirica dell’Ottocento alla lirica «moderna» Nell’Ottocento romantico la lirica è il genere letterario più importante. Secondo Giacomo Leopardi (1798-1837), era l’unico vero genere poetico, il più vicino alla musica e al sentimento, il più antico presso ogni popolo. Il termine lirica per i romantici indica una composizione in versi di stile elevato e di breve estensione, espressione sorgiva di sentimenti intensi e soggettivi, con forte presenza di elementi musicali. Passiamo in rassegna alcuni tratti distintivi della lirica romantica – molti dei quali caratterizzano anche la lirica del Novecento – sottolineando analogie e differenze rispetto alla lirica greca e latina. La lirica è per il poeta inglese Wordsworth (1770-1850) «lo spontaneo traboccare di sentimenti potenti». Secondo M.me de Staël (1766-1817) il poeta ha «il dono di rivelare con la parola ciò che prova nel profondo del cuore» e la poesia «libera il sentimento imprigionato in fondo all’anima». Per Leopardi la lirica è «espressione libera e schietta di qualunque aspetto vivo e ben sentito dell’uomo», canto che sgorga dal petto prima e al di fuori di ogni mediazione critica e culturale. In particolare è il genere letterario dell’immediatezza: «Il sen- Il primato della lirica Spontaneità, sincerità 737 738 Dalla lirica come genere alla codificazione petrarchesca alla lirica «moderna» La brevità e la frammentarietà L’universalità timento che l’anima al presente è la sola musa ispiratrice del poeta». Esula dall’ambito della lirica «un piano ordinato e concepito con freddezza». In realtà queste affermazioni di principio non vanno sempre d’accordo con l’esigenza del rigore espressivo e di una forma perfetta e sono in parte smentite sia dalle riflessioni di Ugo Foscolo (1778-1827) sulla poesia di Petrarca riportate sopra – che definiscono una poetica del labor limae – sia dalle infinite correzioni apportate negli anni da Leopardi ai suoi Canti. Il canone della sincerità e dell’immediatezza applicato retroattivamente anche alla lirica antica – che invece ha sempre dichiarato la propria natura artigianale e letteraria – ha generato gravi fraintendimenti, soprattutto riguardo ai poeti «romantici» come Saffo e Catullo. Dall’idea di lirica come sgorgare intenso e spontaneo del sentimento conseguono i caratteri della massima concentrazione dei contenuti, della brevità e frammentarietà. A favore dell’inevitabile brevità si esprime Leopardi: «l’entusiasmo, l’ispirazione essenziali alla poesia non sono cose durevoli». E ancora: «la poesia sta essenzialmente in un impeto…; i lavori di poesia vogliono per natura esser corti; e tali furono e sono tutte le poesie primitive (cioè le più poetiche e vere) presso tutti i popoli». La valorizzazione di questi tratti, in particolare dell’incompiutezza (si pensi alle molte «incompiute» anche in campo musicale), ha concorso spesso al fraintendimento della lirica greca arcaica, la cui frammentarietà non dipende dalla volontà dell’autore ma dai capricci della tradizione testuale. Non si può porre sullo stesso piano la brevissima lirica di Quasimodo Ed è subito sera e il frammento di un poeta greco. La brevità poi agevola, se non proprio autorizza, la lettura «aperta» e decontestualizzata, che rende possibili tutte le interpretazioni generando l’equivoco dell’universalità e metastoricità del messaggio poetico. Il primato della lirica, rispetto all’epica e alla drammatica, starebbe appunto nel carattere universale. Lo sostiene sempre Leopardi, che in pratica identifica la lirica con la Poesia tout court: «… genere, siccome primo di tempo, così eterno e universale, cioè proprio dell’uomo perpetuamente in ogni tempo e in ogni luogo, come la poesia; la quale consisté da principio in questo genere solo, e la cui essenza sta principalmente in esso genere, che quasi si confonde con lei, ed è il più veramente poetico di tutte le poesie, le quali non sono poesie se non in quanto son liriche. Ed anco in questa circostanza di non aver poesia se non lirica, l’età nostra si riavvicina alla primitiva». L’identificazione della liricità col valore poetico comportò che termini come lirica e lirismo fossero riferiti anche a testi in prosa. La convinzione di esprimere sentimenti universali – alimentata dalla fiducia, tutta romantica, nella magica consonanza tra coscienza individuale e collettiva – è espressa di frequente dai poeti dell’Ottocento. Le poetiche romantiche, quella foscoliana della poesia come «calore di fiamma lontana» e quella leopardiana della poesia come «rimembranza», mirano proprio a depurare il dato affettivo immediato e soggettivo, per attingere a valori universali. Due uomini di fronte al mare al levarsi della luna, dipinto di Caspar David Friedrich del 1817. Berlino, Nuova Galleria Nazionale. A proposito del celebre sonetto in cui rievoca la morte del fratello Giovanni, scrive orgogliosamente Foscolo (nel 1802): «e darà meraviglia che sì fatta poesia possa essere uscita in sì fatti tempi, e da un’anima angosciata dalla fortuna», ossia di avere scritto una lirica che «solo apparentemente è di affetti domestici; in realtà poesia della solitudine pellegrinante dell’uomo su questa terra» (Russo). La citazione di Catullo (CII) e di Petrarca dilata nel tempo l’esperienza personale e concorre a rendere esemplare e simbolicamente pregnante il lutto del poeta: Un dì s’io non andrà sempre fuggendo di gente in gente, me vedrai seduto sulla tua pietra, o fratel mio, gemendo il fior dei tuoi gentili anni caduto. La madre or sol, suo dì tardo traendo, parla di me col tuo cenere muto … Multas per gentes et multa per aequora vectus Advenio has miseras, frater, inferias, ut te postremo donarem munere mortis et mutum nequiquam adloquerer cinerem (Catullo) …traendo poi l’antiquo fianco (Petrarca) Dalla lirica dell’Ottocento alla lirica «moderna» Analoga intenzione, nell’odicina anacreontica Pianto antico di Carducci, dove il pianto per la perdita del figlioletto Dante è «antico», cioè di ogni padre che ha perso un figlio. L’idea che la lirica tocchi corde universali del cuore umano ha ricevuto l’avallo autorevole del filosofo Benedetto Croce (1866-1952), per il quale la poesia è «intuizione cosmica», in quanto in essa «il singolo palpita della vita del tutto, e il tutto è nella vita del singolo. In ogni accento di poeta, in ogni creatura della fantasia, c’è tutto l’umano destino, tutte le speranze, le illusioni, le gioie, le grandezze, le miserie umane, il dramma intero del reale». Questa idea – sempre vera in una lettura acritica, proiettiva, decontestualizzata – ha nociuto non poco all’interpretazione di una poesia come quella greca arcaica, che più di ogni altra trae il proprio significato dal contesto della performance (simposiale, agonale, liturgica, ecc.). Nell’ambito del romanticismo è oggetto privilegiato di riflessione estetica il rapporto con la musica, che è poi da sempre il tratto distintivo della lirica, anche intesa nell’accezione tecnica originaria di «poesia con accompagnamento musicale». Scrive ancora Leopardi: «Le altre arti imitano ed esprimono la natura da cui si trae il sentimento, ma la musica non imita e non esprime che lo stesso sentimento in persona, ch’ella trae da se stessa e non dalla natura, e così l’uditore. Ecco perché la Staël dice: “di tutte le arti è la musica quella che agisce più direttamente sull’anima. Le altre la dirigono verso questa o quell’idea, ma solo la musica si rivolge alla sorgente intima dell’esistenza e muta del tutto la disposizione interiore”». Al carattere originario e primitivo della lirica indicato da Leopardi si collega l’idea di un’arcana connessione tra moti non solo psicologici, ma anche biologici e fisici, e la poesia, in particolare il ritmo e le strutture foniche in genere. Mano a mano che ci si avvicina alla lirica del Novecento l’importanza della musicalità nella composizione lirica cresce, dalle formulazioni di Baudelaire – che riconosceva alla musica di Wagner il potere di esprimere quella parte non definibile del sentimento che la parola, troppo positiva, non sa rendere – all’Art poétique di Verlaine, vero e proprio manifesto della poesia del Decadentismo che inizia col comandamento: «Musica, sovra ogni cosa …». Che la lirica non sia solo espressione di sentimenti ma anche una forma di conoscenza – seppure di tipo intuitivo e diversa da quella scientifica – e abbia una valenza in certo senso filosofica è un’idea comune ai teorici romantici. È un’idea espressa più volte da Leopardi, del quale è ben nota l’opzione per una «poesia sentimentale», cioè ricca di succhi filosofici ed esistenziali. Charles Baudelaire (1821-1867) assegna alla poesia il compito di acquisire nuove zone prima inesplorate dell’animo umano, di sondare il mistero «di tutto ciò che al di là e che rivela la vita», di rischiarare l’ignoto: «Che cos’è il poeta se non un traduttore, un decifratore?». In particolare Baudelaire teorizza il carattere analogico della conoscenza poetica che coglie le connessioni tra realtà distanti, rivelando la profonda unità del reale e il senso spirituale delle cose. Anche per Paul Verlaine (1844-1896) compito del poeta è di accostarsi alle cose per coglierne, non già l’apparenza fenomenica, ma l’essenza: «La proclamazione di questa capacità della poesia di scendere al nocciolo, all’intimo senso delle cose e della realtà penetrando oltre il muro dell’apparenza sensibile è un momento essenziale nella strada della poesia» (Guglielmino). Analoghe formulazioni in Arthur Rimbaud (1854-1891) secondo il quale il poeta è un «veggente», «è il sommo sapiente. Egli giunge infatti all’ignoto … Dunque il poeta è veramente un ladro di fuoco», un nuovo Prometeo che ruba per gli uomini la Verità. Stéphane Mallarmé (1842-1898) assegna alla parola poetica la funzione non solo e non tanto di indagare il mistero della vita, quanto quella di creare nuovi universi immaginari, che costituiscano la «vera realtà», tutta interiore e mentale, opposta a quella negativa della vita concreta e quotidiana. Nelle poetiche dell’Ottocento si fa strada l’idea che la composizione lirica debba essere «unitaria e governata da un’interna organicità … nella forma esterna del testo si riflette la forma interna dell’ispirazione» (Ceserani). La questione dell’unità della composizione ha avuto riflessi anche sull’interpretazione della lirica greca, nella quale spesso si è preteso di rinvenire un’unità che, in quanto espressione di una cultura orale, non poteva avere. Spesso in essa un blocco ha una sua autonomia, ma nello stesso tempo può essere giustapposto ad altri blocchi per formare una sequenza più ampia, che varia in rapporto alla performance simposiale. La musica La lirica come strumento di conoscenza La lirica come unità organica 739 740 Dalla lirica come genere alla codificazione petrarchesca alla lirica «moderna» La dissoluzione della struttura logica del discorso La lirica «moderna» La dissoluzione della struttura logica del discorso è un processo avviato nell’Ottocento e culminante nella lirica del Novecento. Prima riguarda la metrica col passaggio da forme «chiuse» a forme «aperte» (non più vincolate da schemi fissi, rime, ecc.). Poi riguarda la sintassi del periodo, che non si snoda più con un suo prima e un suo poi: «E s’aprono i fiori notturni,/ nell’ora che penso a’ miei cari./ Sono apparse in mezzo ai viburni/ le farfalle crepuscolari» (Pascoli). Con i Futuristi saltano i bulloni della frase e si hanno «parole in libertà»: «… ruote copertoni intrico di corna creste delle colline …» (Marinetti). Talora si scende al di sotto della soglia della parola, come nel linguaggio «pregrammaticale» o «fonosimbolico» dei passeri in questi versi di Pascoli: «Videvitt: la neve? il gelo?/ ei di voi, rondini, ride:/ bianco in terra, nero in cielo,/ v’è di voi chi vide … vide … videvitt?». Con l’espressione «lirica moderna» s’intende la lirica successiva al periodo romantico. Paul Valéry (1871-1945), continuando le esperienze dei grandi poeti del Decadentismo francese (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé), inaugura alcune tendenze che caratterizzeranno tutta la lirica moderna: l’idea della lirica come esercizio aristocratico e intellettuale, «Festa dell’intelletto», e l’idea di una «lirica pura», assoluta, libera da ogni contingenza: «L’idea di poesia si è purificata, smaterializzata, assolutizzata, la poesia ha risolto ogni nesso con la rappresentazione diretta della realtà, è divenuta pura vicenda interiore, astratta tensione spirituale» (Guglielmino).
Scaricare