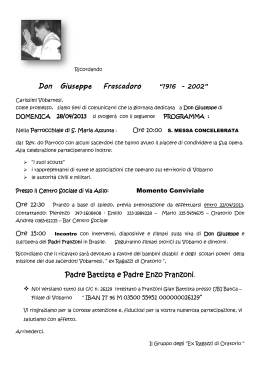. Benito Poggio 1945-2015 “La Resistenza italiana ha settant'anni” riflessioni, digressioni e racconti Sommario: Origini, significati e personaggi eroici della “Resistenza”: ribellione e lotta a favore dell'Uomo e della sua umanità – Cattolici e “Resistenza” nei sotterranei della “Casa dello Studente” a Genova – Felice Cascione (1918-1944), un eroe leggendario e figura esemplare della “Resistenza” in Liguria – 1945-2005: L'eroica figura dell'antifascista e partigiana Liana Millu (1914-2005), efficace scrittrice deceduta nel sessantesimo della “Resistenza” – A ricordo dei martiri e delle stragi della “Resistenza *** 1.Origini, significati e personaggi eroici della “Resistenza”: ribellione e lotta a favore dell'Uomo e della sua umanità Non ricordo chi l'ha scritta o dove m'è capitato di leggerla, ma è la più azzeccata definizione – secondo me – che ha illuminato ieri e illumina oggi, nella concretezza, il concetto ideale, morale e, perché no?, religioso, storico e politico di “Resistenza”, peraltro strettamente connesso a “Liberazione”, da intendersi “Giustizia e Pace nella Libertà” e che – dal 9 settembre 1943, quando in accordo i sei partiti antifascisti (democristiano, comunista, socialista, liberale, d'azione e democratico del lavoro) diedero vita al C.L.N. (Comitato di Liberazione Nazionale) – coinvolse e convinse a lottare e “resistere” persone di ogni età, di ogni formazione culturale e di tutte le classi sociali. Eccola riportata qui di seguito per la sua concezione sovratemporale: “[Resistenza] è l'urgere dell'azione a difesa di valori umani ferocemente (e, aggiungo io, bestialmente) aggrediti dai demoni dell'irrazionale”. Personalmente la ritengo valida e adatta in tutti i tempi e in tutte le epoche (compresa quella in cui viviamo) per lottare contro e “resistere” con determinazione ad analoghe manifestazioni di ferocia e di irrazionalità che si manifestano nel corso di ogni guerra e di ogni conflitto, quali che siano. Se oggigiorno, a distanza di ben settant'anni, consideriamo a mente fredda e con occhio sereno, il “movimento resistenziale” non possiamo per nessuna ragione fare a meno di coglierne il valore permanente e transgenerazionale. Per quale concreto motivo è di così notevole importanza? Perché esso portò alla “liberazione” del nostro paese dalla dittatura, dalla guerra, dall'irrazionale demone nazifascista: un movimento per il quale calza a pennello l'indicazione di “secondo risorgimento” data dal fisico, saggista (sua l'opera: “Classi e generazioni nel secondo risorgimento”, postumo 1955) e partigiano comunista Eugenio Curiel (1912-1945), condannato a cinque anni di confino a Ventotene dove si ritrovò, tra le centinaia di confinati antifascisti, a contatto di figure storiche e di eroici personaggi da non dimenticare e da continuare anzi a proporre ai giovani d'oggi. Ed intendo qui elencarne alcuni in ordine alfabetico: Lelio Basso (1903-1978), Luigi Longo (1900-1980), Sandro Pertini (1896-1990), Pietro Secchia (1903-1973), Alberto Spinelli (1907-1986), Umberto Terracini (1895-1983), senza tralasciare quell'Eugenio Colorni (1909-1944, che morì sotto il falso nome di Franco Tanzi), filosofo e politico oltre che fidato amico dello stesso Curiel , e che venne assassinato a Roma dai componenti fascisti della famigerata e crudele “Banda Koch”, specialista in sevizie e torture. Nell'anno in corso, in cui ricorre il 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri, come possiamo non richiamare e connetterci alle sue imprescindibili parole che vengono proposte nel canto XXVI dell'Inferno (vv. 118-120) e che sono da rimeditare proprio nel tempo in cui viviamo: “Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir vertute e canoscenza.” È drammatico come l'Uomo debba sempre riflettere e ricordare il proprio passato fatto da una sequela ininterrotta di guerre nate da contrapposizioni immotivate e odio irrazionale di qualsivoglia natura, sempre sacrificando e mandando per giunta al massacro “la meglio gioventù”. Quest'anno, nel 2015, si commemora la “Prima Guerra Mondiale” d'un secolo fa e protrattasi dal 1915 al 1918. A cent'anni da quella che l'inascoltato Papa pegliese Benedetto XV definì “l'inutile strage”, i cosiddetti “Ragazzi del '99” che furono chiamati alle armi nel fiore della loro gioventù e non ancora ventenni, sono ormai scomparsi tutti (o quasi), ma – graziaddio! – il ricordo del loro sacrificio, anche attraverso eventi, manifestazioni e mostre in corso un po' ovunque, si perpetua nel tempo e nelle generazioni. Con la sia pur lenta ma inevitabile scomparsa di chi ne fu parte e linfa viva e vitale, anche la “Resistenza”, fulcro della “Seconda Guerra Mondiale” combattuta dal 1939 al 1945, si sta inesorabilmente avviando a diventare mero e nebuloso ricordo, specie nella memoria dei più giovani: *di qui, a settant'anni ormai di distanza nel tempo, l'urgente e cogente necessità di non lasciarla cadere nella tetra oscurità di un insopportabile e vergognoso oblìo; *di qui, per volontà di alcuni volenterosi e appassionati studiosi non dimentichi di chi nella lottato ha donato la propria vita e saldamente legati ai valori autentici e impareggiabili della “Resistenza”, la pubblicazione e la diffusione di un numero speciale, se non specialissimo, nei “Quaderni del Tempietto” a far sì che resti valida documentazione e traccia indelebile, fornendo ai giovani d'oggi e di domani seria e pacata occasione di riflessione e, per dirla con Primo Levi, efficace opportunità di ripensamento su “ciò che è stato” in Italia e in Europa. Venendo all'origine prima, se ci rifacciamo ad un'indagine storico-filologica, siamo portati a sostenere che, con ogni plausibile probabilità, il temine “Resistenza”, accolto e adottato in seguito non solo dall'Italia, ma anche da tutta l'Europa, conta e si fonda su un'origine francese. Pare infatti che nel corso di un appello trasmesso via radio dall'Inghilterra sia stato pronunciato per la prima volta – si era nel giugno del 1940 – dal generale De Gaulle: col suo appello mirava a rinfrancare e risollevare gli animi abbattuti dei Francesi sopraffatti e sconfitti. In realtà si può affermare che in Italia la “Resistenza” ebbe inizio circa vent'anni prima di analoghi movimenti resistenziali europei: tanto come manifestazione di lotta contro il “fascismo”, quanto come “antifascismo” attivo e sempre più diffuso da intendersi quale motivata e legittima reazione all'oppressione della sempre più imperante ed estesa dittatura fascista. Mussolinì teorizzò e avviò il “fascismo” nel 1919, lo costituì in partito nel 1921 e, come esito della “marcia su Roma” del 1922 – non avendo incontrato alcuna azione di contrasto né dal re Vittorio Emanuele III né da Luigi Facta, presidente del consiglio nel governo di transizione – ricevette il mandato di dare forma al nuovo governo. Dopo un primo apparente rispetto delle regole democratiche, nel medesimo anno Mussolini, ormai in determinata ascesa, creò il “Gran Consiglio” e l'anno successivo la “Milizia”, avviando una feroce e violenta lotta squadristica in occasione delle elezioni politiche del 1924. Fu in questa situazione che si verificò il rapimento e l'assassinio di Giacomo Matteotti, di cui Mussolini, respingendo le accuse dei secessionisti dell'Aventino, si dichiarò responsabile politicamente e moralmente. In conseguenza del gravissimo fatto, personalità del calibro di Gramsci e Gobetti e i partiti democratici uscirono allo scoperto e, nonostante la promulgazione delle cosiddette “leggi fascistissime” che soffocarono ogni forma di vita politica e di opposizione al regime, si coalizzarono per “resistere”, contrastare e far decadere il regime fascista opprimente e illegale fin dalla sua nascita. Data l'impossibilità di una legittima vita democratica e di una libera attività politica in Italia, molte personalità (Salvemini, don Sturzo, Turati, et al.) e migliaia di lavoratori scelsero di vivere fuori dell'Italia, da “fuoriusciti”, fomentando e portando avanti quell'azione di intensa e meticolosa propaganda antifascista destinata a sfociare in quello che sarà il vittorioso “movimento resistenziale”. Gli storici concordano nel sostenere che in Italia la vera e propria “Resistenza”, come movimento e come guerra di liberazione, ebbe il suo inizio con l'8 settembre 1943, allorché, quale conseguenza dell'armistizio firmato dal governo Badoglio con gli Anglo-americani, le truppe tedesche procedettero all'occupazione del territorio italiano e si concluse, esattamente settant'anni fa, il 25 aprile 1945 quando l'Italia settentrionale insorse vittoriosamente e si sbarazzò finalmente e per\ sempre dell'obbrobrio nazifascista così a lungo subìto. C'è sùbito da dire che, sul piano militare, i partigiani favorirono e portarono avanti la “resistenza italiana” soprattutto in montagna per ovvie ragioni di libertà di movimento e di autodifesa, ma la lotta partigiana si sviluppò anche nelle campagne e nelle città. Per nostra grande fortuna, a perpetuare il ricordo dei partigiani – d'età matura, giovani e giovanissimi appartenenti a tutti i ceti sociali – ci sono simbolicamente le lapidi e le targhe di vie e piazze d'Italia a loro dedicate: qui a Genova, come in tante altre città grandi e piccole. Percorrere, ad esempio, le vie di San Pier d'Arena è tutto un ricordare i nomi di quei giovani ventenni o poco più, semplicemente definiti “caduti per la libertà” (ma sarebbe bene e decoroso che ogni nome fosse arricchito da brevi ed essenziali notizie sul martire), che, convintamente e coraggiosamente, hanno lottato e combattuto nella “Resistenza”. Ricordo qui quattro figure di giovani esemplari: Giacomo Buranello (1921-1944), studente alla Facoltà di Ingegneria; Stefano Dondero (1924-1944), operaio dell'Ansaldo e calciatore dilettante; Walter Fillak (1920-1945), studente, espulso dal Liceo Scientifico “Cassini” per motivi politici, che completò gli studi da privatista e si iscrisse poi alla Facoltà di Chimica; Walter Ulanowski (1923-1944), studente alla Facoltà di Economia e Commercio. Con loro dovrei citarne tanti altri che erano membri del “Comitato antifascista” di San Pier d'Arena e che, sorpresi in agguati, caddero vittime della furia nazifascista. Il ricordo non si ferma alle targhe e alle lapidi, ci sono anche numerose e importanti opere letterarie, prevalentemente in prosa, che dovrebbero (ma auguriamoci che lo siano davvero!) essere doverosamente proposte e lette nelle scuole. Per citarne solo alcune, si va dalle raccolte di Lettere di condannati a morte della resistenza italiana (1952) e Lettere di condannati a morte della resistenza europea (1954) a opere di singoli autori quali Uomini e no (1945) di Elio Vittorini, Il sentiero dei nidi di ragno (1947) di Italo Calvino, L'Agnese va a morire (1949) di Renata Viganò, I ventitré giorni della città di Alba (1952) di Beppe Fenoglio, Si fa presto a dire fame (1954) di Piero Caleffi, per non dire di quell'insieme significativo e memorabile di epigrafi, orazioni e meditazioni riunite in Uomini e città della resistenza (1955) di Piero Calamandrei. Sono narrazioni e resoconti che rendono palpabili i momenti di lotta e fanno comprendere quanto è costata, in coraggio e abnegazione, la ri-conquista della libertà e della democrazia, quanti sacrifici sono stati necessari da parte di chi la “Resistenza” l'ha vista con i propri occhi e l'ha vissuta di persona tanto da poterla descrivere in prima persona, tramandarla alle generazioni future perché continuino ad apprezzare e non si stanchino di difendere quei valori supremi di giustizia e pace conditi dalla libertà per i quali tanti e tanti hanno dato la loro vita. 1a Zona operativa Liguria -imperiese- Garibaldini della V Brigata L. Nuvoloni nella quale militò Italo Calvino E, soprattutto, sono testimonianze che, opportunamente portate a conoscenza dei giovani e di tutti coloro che non l'hanno né vista con i propri occhi né vissuta sulla propria pelle, fanno sì che “Resistenza” non suoni né oggi né mai come parola vuota di senso, ma conservi e mantenga ancora e sempre un alto significato anche col trascorrere del tempo, anche a ben settant'anni di distanza. 2. Cattolici e “Resistenza” nei sotterranei della “Casa dello Studente” a Genova -Premessa. Quello della presenza operativa e della partecipazione fattiva dei Cattolici alla Resistenza, anche se ormai storicamente assodate e confermate, continua tuttavia ad essere (ed è), se non proprio, come sosterrebbe Fedro, causa iurgii, certo argomento assai controverso e assai dibattuto, soprattutto perché, a mio modo di vedere, ai Cattolici, per non averne mai sentita la necessità essendo la loro non un’adesione di programma (e di ideologia) ma un’adesione di coscienza (e di fede), è sempre venuta meno o, meglio ancora, è del tutto mancata la spinta all’eccesso dell’esaltazione retorica e dell’eroismo a tutti i costi delle loro azioni; azioni che – dal punto di vista di uomini di concordia e di pace (i pacifici delle Beatitudini evangeliche) quali i Cattolici (Laici e Sacerdoti, s’intende), come fedeli seguaci del pensiero della Chiesa (e dei Papi, su tutti Pio XII in tempore belli; e in seguito, fino a tutt’oggi, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco), intendevano di essere – erano (e rimanevano) pur sempre azioni di violenza e di guerra, cui la loro coscienza e la loro fede si opponevano, contro nemici o avversari che, essendo tali e tali restando, non perdevano mai i connotati evangelici di prossimo. Il comportamento dei Cattolici resistenti, intendo, al pari di quello delle migliaia di martiri cristiani vittime delle feroci persecuzioni sotto gli imperatori Diocleziano, Nerone e Domiziano, per citare le più cruente, non mirava né all’approvazione né alla gloria su questa terra, ma teneva presente la finalità ultima dell’uomo che deve comportarsi ed essere, in ogni circostanza, vir iustus: giusto primamente agli occhi di Dio e coerente con la propria coscienza e con la propria fede, vale a dire disposto sempre al perdono, alla misericordia e alla riconciliazione. Compito indubbiamente arduo e difficile quant’altri mai, mi si dirà; ma possibile e realizzabile come esemplarmente dimostrò quella piccola e ristretta ma compatta e unita “comunità di Sacerdoti Cattolici” descritta nella pubblicazione (esaurita e fuori commercio, difficile pertanto da ritrovare, ma che meriterebbe una riedizione) di Adriano Guglielmi, “Sacerdoti Cattolici nella Resistenza” (edita per conto dell’Associazione Partigiani Cristiani e col contributo della Cassa di Risparmio di La Spezia), oggetto della presente riflessione. Senza rispetto alcuno per la loro veste e per la loro missione, quei Sacerdoti furono trattati al pari dei peggiori delinquenti comuni e, dopo un interrogatorio con botte e torture nei famigerati sotterranei della “Casa dello Studente” di Genova in Corso Gastaldi (già Corso Giulio Cesare), furono gettati e rinchiusi nel carcere di Marassi e colà, dopo essere stati sottoposti a brutali e bassi ulteriori interrogatori, si trovarono costretti a soffrire violenze e sopportare angherie d’ogni sorta perpetrate con estrema ferocia e malvagità nei loro confronti. Colpendoli e abbrutendoli, si voleva debilitare, e soffocare se possibile, la forza delle loro testimonianze pubbliche, specie, ma non solo, nelle prediche domenicali tenute nelle rispettive chiese; testimonianze, sempre collegate al messaggio evangelico, cariche e dense di forti principi morali e di giustizia in grado di smascherare e di sgretolare le nequizie e le falsità delle teorie ideologiche in auge, vuoi fascistiche, vuoi nazistiche. Di loro ci dice, non per sentito dire, bensì per testimonianza diretta (essendo anch’egli, tra loro, nel medesimo carcere), Adriano Guglielmi (alias Pietro Sirte I delle Organizzazioni Franchi e Stella), a quel tempo giovanissimo studente d’Ingegneria (oggi ingegnere), il quale, dopo essere stato catturato, interrogato e seviziato con l’amico Leopoldo Gamberini nei sotterranei della “Casa dello Studente”, aveva ottenuto di essere trasferito in cella con loro e con loro ebbe a condividere le atroci e disumane sofferenze e con loro patì gli insopportabili e gravi disagi. Adriano Guglielmi e l’amico Leopoldo Gamberini, entrambi scomparsi non molti anni fa, avevano frequentato a Genova il rinomato Liceo Classico Statale “A. D’Oria” ed avevano avuto tra i loro insegnanti quel don Giuseppe Siri – dapprima segretario del card. Pietro Boetto (riconosciuto Defensor Civitatis) e in seguito per lunghi anni arcivescovo di Genova – il quale aveva consigliato e spronato il giovane Guglielmi e altri, a lui rivòltisi per consiglio, “a lottare senza paura e secondo coscienza, per la libertà e per la giustizia”. E proprio il card. Siri, a guerra conclusa, unì in matrimonio l’ing. Adriano Guglielmi con la prof.ssa Annaviola Costaguta, per lunghi anni docente di latino e greco proprio al D’Oria (l'attore Luca Bizzarri fra i suoi studenti!). -Il contenuto del libro. Non si tratta certamente né di pettegolezzo né di gossip come taluno crede e l’ha definita; si tratta, invece, di una autentica e verace testimonianza vissuta e raccontata in prima persona dall’autore, allo stesso modo che sono da considerare autentiche le sofferte testimonianze vissute sulla loro pelle: in passato, le vicende di Le mie Prigioni narrate (Chi oserebbe definirle pettegolezzo?) dal patriota e scrittore Silvio Pellico; in tempi recenti e a noi più vicini, le esperienze di deportati rievocate – per citarne solo alcune – in Se questo è un uomo da Primo Levi, in Il fumo di Birkenau da Liana Millu, in La risiera di San Sabba da Ferruccio Folkel, in Tu passerai per il camino da Vincenzo Pappalettera, in Le cavie dei Lager da Luciano Sterpellone, in Marzabotto da Renato Giorgi, e molti altri scritti-testimonianza ancora. Senza alcuna acrimonia e senza recriminazioni di sorta, Adriano Guglielmi l’ha fortemente voluta e amorevolmente curata tanto sul piano del “vero storico” quanto sul piano prettamente documentale; proprio lui che da sempre, con obiettività, si batté perché emergessero le eroiche virtù di sopportazione e di santità di “quel gruppetto di Sacerdoti”, con lui e con altri “420 rastrellati” nel territorio di La Spezia, detenuti nelle tetre e dure celle del carcere di Marassi a Genova, ov’erano stati condotti via mare per evitare che, sul passo del Bracco, i partigiani – come s’era sparsa notizia – tentassero di liberarli. Quei religiosi non soltanto furono a lui di esempio e di sostegno, ma, com’egli ebbe a scrivere, manzonianamente “videro ogni loro atto coordinarsi nei disegni del loro Dio”. Il libretto, una cinquantina di pagine, non è altro, come afferma l’autore, che una lunga “Testimonianza di un compagno di prigionia”, tal quale l’autore si ritiene, confortata in aggiunta da “quanto appreso dalla lettura del Diario di Don Mario Devoto, integrato da quanto scritto da Padre Pio Rosso e da Don Bruno Duchini”. A buon diritto e a tutti gli effetti, essa rientra, come l’altra opera dello stesso autore “Il piano inclinato. (1943-1945). Giovani nello spionaggio (L’arma segreta)”, EL (Editrice Liguria), Savona, nella cosiddetta letteratura resistenziale, che varrebbe la pena conoscere. Vi si dice, con tutta l’obiettività e con tutto il distacco possibili, di come quell’innocuo manipolo di poveri Sacerdoti cattolici venissero, di continuo, si passi il termine, martirizzati e immotivatamente, sottoposti a pesanti maltrattamenti con impietose battiture che provocarono lividure ed ecchìmosi, costole rotte e ossa dissestate, mascelle massacrate e ginocchia frantumate, unite ad altri simili, si fa per dire, rudi complimenti tali da giungere fino al limite della vera e propria tortura: maltrattamenti che, per non rivelare alcunché e per non essere di danno ad alcuno, da quei santi e pazienti religiosi, autentici martiri, furono, “nel loro silenzio discreto”, accettati sempre ad maiorem Dei gloriam e per la conversione e il pentimento dei loro torturatori, nazisti o fascisti che fossero. -Come i Dodici Apostoli. Chi erano quei Sacerdoti, compagni di prigionia del giovanissimo Adriano Guglielmi, incarcerato assieme all’amico Leopoldo Gamberini, anch’egli giovanissimo, ma già allora – lui destinato a diventare, qual è poi diventato, notissimo musicologo e compositore – innamorato della musica al punto di formare, proprio all’interno del carcere, e dirigere, per le feste pasquali, un coro formato da altri prigionieri? Chi erano quei Sacerdoti la cui “presenza – così come scrive il Guglielmi – era sentita, come aiuto e conforto, da tutti nel carcere” e la cui “ora della preghiera collettiva era un momento che ritmava gradevolmente la giornata carceraria”? Nel libro si dice di quei Sacerdoti singolarmente e della loro forza d’animo ché quasi mai traspaiono sentimenti di paura o di vigliaccheria; e di ognuno di loro vengono tratteggiati anche i lati umani: dagli abiti goffi e rappezzati che indossavano sotto la veste talare all’obbligo mattutino di svuotare in gran fretta i buglioli e le catinelle d’alluminio e altri recipienti con la propria orina e i propri escrementi; dalle piccole e pervicaci manìe notturne di fare il bucato per lavare alla meglio i poveri laceri indumenti e i calzini bucati alla generosa e non richiesta cessione di parte del misero rancio (altrimenti detto “sbobba”) fino, indossate con religiosa ufficialità le tonache per quanto sgualcite e malridotte, alla recita vespertina delle preghiere e del canto di “qualche inno religioso popolare” dopo che, la sera, il carceriere era passato a “spegnere la fioca luce in ogni cella”. Le accuse, a dire degli inquisitori inoppugnabili e cavillose, per sorprenderli e sequestrarli, schedarli e, data, si fa per dire, l’estrema gravità e fondatezza delle motivazioni addotte, gettarli senza alcuna preventiva istruttoria, senza alcun ulteriore interrogatorio o procedimento giudiziario e senza tanti complimenti direttamente in prigione, erano (se si esclude quella inventata di sana pianta di “nascondere depositi di armi nelle sacrestie”) sempre le stesse e riconducibili principalmente a due: *di aver aiutato e nascosto nelle loro chiese o nelle loro canoniche nuclei di “Ebrei”, non solo non rispettando, ma andando anzi contro le famigerate e deprecabili Leggi razziali imposte, a partire dal 1938, dal regime fascista; *di aver procurato cibo e conforto ai “ribelli partigiani”, agendo nella più palese illegalità e ponendosi così, e consapevolmente, a favore della parte avversa al – si fa per dire – legale regime dittatoriale. Ma certamente ci sarà chi si chiederà: Come erano potuti finire tutti insieme, e in un unico blocco, nelle mani dei Fascisti e dei Nazisti? Tal “Aurelio Gallo, già autista dell’allora vescovo di La Spezia, Mons. Giovanni Costantini”, era stato allontanato dall’incarico per manifesta pedofilia ed era caduto anche in disgrazia delle autorità italo-tedesche del luogo. Pertanto, per risalire la china, aveva voluto farsi bello agli occhi dei gerarchi nazi-fascisti locali e, prove alla mano di cui lui subdolamente era venuto a conoscenza in Arcivescovado, insieme ai nominativi di oltre quattrocento civili (uomini e donne d’ogni ceto e delle più varie professioni trasportati a Genova, come detto, via mare, dopo essere stati ammassati “nel ventre della bettolina... con gran celerità e brutalità”), da novello Giuda non solo aveva tradito, ma altresì aveva “soffiato”, per vendicarsi, i nomi di quei sacerdoti rei di aver prestato aiuto e sollievo, senza esigere “purezza di razza” o “tessera di partito”, a quanti erano venuti a trovarsi in gravi difficoltà o in situazioni di pericolo: Ebrei e Partigiani compresi. Riuniti in carcere dapprima in un gruppo di dieci, tanti erano i Sacerdoti della Diocesi della Spezia presi contemporaneamente nella retata, a loro si aggiunsero quasi subito Don Gianluca Spadoni, parroco nella Diocesi di Massa-Carrara e Don Giovanni Battista Parodi, parroco di Cravasco, nella Diocesi di Genova. E fu così che, dopo violenti interrogatori nei sotterranei della “Casa dello Studente”, quei Sacerdoti, proprio come era stato per i dodici Apostoli che s’erano adunati nel Cenacolo, si ritrovarono forzatamente adunati in dodici anch’essi, ammassati e “immagazzinati” (il termine è quello usato dall’autore, così come tutti i corsivi virgolettati riportano le precise parole dell’autore) nella medesima cella, un po’ più grande delle altre e di “circa due metri per cinque”: tra gli uni, gli Apostoli nel Cenacolo, e tra gli altri, i Sacerdoti nella cella, la presenza confortatrice di Maria, spesso invocata con preghiere e canti, fu di massimo conforto e sollievo; così come sugli uni nell’evangelico Cenacolo e sugli altri nella “cella di Marassi”, rinnovato e autentico Cenacolo, l’assistenza ispiratrice dello Spirito Santo infuse il suo soffio vivificatore e la sua forza spirituale ed emise nei loro animi il suo vigore divino. -I Sacerdoti, uno per uno. Come non fornire di seguito un brevissmo ritratto di ciascuno dei dodici Sacerdoti cattolici, novelli martiri? Una volta caduti nella retata, erano stati tradotti nel supercarcere di Marassi a Genova, sorvegliati dalle SS armate e guardati a vista quasi si trattasse dei peggiori e più pericolosi malfattori, essendo essi considerati “rei soprattutto di non aver adeguato il loro ministero alle direttive di imposizioni della dittatura... perché con la loro chiarezza e indipendenza di pensiero e di parola, ottenevano largo consenso infondendo in chi li seguiva dignità e coraggio... vizi imperdonabili per le dittature di qualsiasi colore esse siano”. *Don Giovanni Bertoni, parroco di Migliarina, era “uomo di poche parole”, “di statura normale, con i capelli corti, non poteva chiudere completamente la bocca, perché la mandibola, sotto i colpi e le percosse ricevute, non combaciava più con i denti superiori”. Al suo riguardo Guglielmi precisa: “Non sentii mai da lui recriminazioni per quanto gli era successo. Sapevo dai suoi confratelli che era stato massacrato con particolare accanimento...”; *Mons. Ferruccio Casabianca, “chiuso e dolentemente ieratico”, “alta figura avvolta dal lungo mantello consumato”, il quale, nell’ora d’aria concessa ogni quindici giorni dalle SS, “non passeggiava, ma si fermava ritto in un angolo... con i grandi occhi rassegnati che guardavano lontano”, in direzione di Sarzana, ove, “ignaro del suo arresto e della sua vicenda”, era morto suo padre; *Don Mario Devoto, “simpatico prete musicista”, è il sacerdote che rivela al Guglielmi l’umana sofferenza di Mons. Casabianca ed è ancora il sacerdote di cui Guglielmi ha l’opportunità di leggere il diario, “integrato da quanto scritto da Padre Pio Rosso e da Don Bruno Duchini”, che dà il supporto della verità e costituisce gran parte della presente testimonianza; *Don Bruno Duchini, “esile figura, quasi serafica”, dalla “voce squillante in cui l’accento spezzino si sposava ad un linguaggio sonante e aulico”; “era noto per la chiarezza inequivocabile delle sue prediche in parrocchia nelle quali sosteneva i principi evangelici coraggiosamente incurante se apertamente in contrasto coi principi fascisti di violenza e razzismo”; egli, essendo giovane come Don Scarpato, viveva “un po’ all’ombra dei confratelli più anziani”; *Mons. Antonio Mori, parroco alla Scorza, “non alto e abbastanza minuto di persona, la faccia larga e pallida, la bocca sottile, lo sguardo freddo e severo”, “grande educatore di giovani”, dotato di “una notevole forza d’animo interna” e in grado di “confortare o distrarre i suoi compagni di cella” abbandonandosi al racconto di lunghi aneddoti e interminabili fantasie. “I tedeschi e i repubblichini erano particolarmente attenti alle mosse di Don Mori e di Don Scarpato”, specialmente per “la sfacciata azione di protezione che svolgevano in difesa di Ebrei spezzini”. *Can. Giuseppe Pieroni, “un vecchio sacerdote, ex cappellano della milizia fascista, grassottello, con una faccia cotta dal sole e due occhi azzurri fanciullescamente maliziosi”, oggetto di... aneddoti e invenzioni da parte di Don Mori e che, la mente sconvolta, cedette allo sconforto, ma, prontamente soccorso dai confratelli e “aiutato dalla grazia di Dio”, ricuperò rassegnazione e serenità. Di fronte alla figura di don Pieroni, sacerdote che “per propria determinazione aveva accettato l’umiliazione e il dolore delle torture per non confessare” e nel momento in cui lo coglie “uomo come gli altri”, il Guglielmi esprime tutta la propria ammirazione per lui; *Don Vittorio Reali, “vocazione tardiva di un uomo risoluto e coraggioso”, già inviso ai tedeschi per “il libero parlare da lui spesso usato dall’altare”, mise tutto il suo impegno col prefetto Turchi in “trattative, spesso rischiose, per ottenere scambi di prigionieri tra tedeschi e partigiani”; fu altresì accusato, pretestuosamente e senza alcun fondamento di verità, di aver “nascosto un deposito d’armi nella sua sacrestia”; *Padre Pio Rosso, che portava spesse lenti, era un domenicano, alto e massiccio, al quale i suoi – si fa per dire – benefattori, avevano provveduto a dissestargli le ossa, a rompergli le costole e un ginocchio sì che procedeva claudicando; questi fu richiesto come confessore dal Guglielmi, allorché, “terrorizzato dal cattivo andamento dei suoi interrogatori”, era convinto d’essere ormai prossimo alla fine; *Don Mario Scarpato e Don Bruno Duchini (di cui sopra) erano “i due più giovani e probabilmente più affamati”. “Figlio di un operaio, repubblicano per antica convinzione”, Don Scarpato, parroco di Pagliari, “aveva gravi reati sulla coscienza perché da anni svolgeva attività cospirative”: aiutava e confortava cioè, senza distinzione di colore politico o di razza, tutti quelli che a lui si rivolgevano, sicuri sempre della sua “segretezza”... tanto che lui e Don Mori “avevano materialmente aiutato” perfino quel tal Aurelio Gallo di cui s’è detto e che, con altri complici, “cercò prove per poter muovere accuse gravissime, quelle che allora venivano chiamate reati di sangue: reati che, generalmente, venivano pagati col piombo dei mitra o peggio con l’invio in vagoni piombati a Bolzano, Mauthausen, Dachau, Auschwitz, Birkenau, ecc.”; *Don Rinaldo Stretti, insieme a “un certo numero di intellettuali, dottori, avvocati, alcuni operai”, fu il prete scelto dal solito, e infido, Aurelio Gallo, che “cercò prove per poter muovere accuse gravissime” contro lui e contro gli altri, torturandoli e usando tutti i mezzi per far “loro confessare anche reati mai commessi”. Don Stretti, “previamente massacrato a dovere” e “spinto dalla volontà tedesca di operare in odium religionis”, fu letteralmente “terrorizzato” al punto che “arrivò ad indossare addirittura la divisa fascista” e fu portato a “falsamente testimoniare”, creando inspiegabile sconcerto tra i suoi parrocchiani, ma specialmente tra i confratelli; *Don Gianluca Spadoni, “mandato in campo di concentramento” prima dell’entrata del Guglielmi “in canonica” (così il Guglielmi definiva la cella di Marassi con i Sacerdoti), apparteneva alla Diocesi di Massa-Carrara e, pur non rientrando nella famigerata “operazione Gallo”, era stato rinchiuso in carcere perché “reo di essere stato il cappellano dei partigiani”; *Don Giovanni Battista Parodi, arrestato per rappresaglia a seguito dell’uccisione di 9 tedeschi proprio a Cravasco, il paesino della Val Polcevera ov’era parroco, venne sottoposto a “interminabili interrogatori al Comando prima, a Marassi poi”. Rinchiuso nel carcere di Marassi “prega in silenzio, prega sempre: per i cinque tedeschi uccisi (dallo scoppio di una bomba al cinema Odeon in via Vernazza a Genova), per i suoi parrocchiani lasciati al paese tra gli incendi e le razzie” e quando viene a sapere che, per ritorsione, 32 prigionieri politici rinchiusi nella IV sezione del carcere di Marassi e “18 partigiani (i martiri dell’eccidio nel Vallone della Benedicta del 9 aprile 1944) sono morti, fucilati, prega per loro”. Sopravvisse agli orrori della guerra (tra cui l’eccidio di Cravasco del 23 marzo 1945) e, alla sua morte, il card. Giuseppe Siri, arcivescovo di Genova, ebbe a dire di lui “non fece mai chiasso, ma fece bene tutto”. -Conclusione. Occorre ricordare, prima di concludere, l’atto finale. Grazie all’intervento perentorio e alle indomite trattative col comando nazista dell’arcivescovo di Genova, card. Pietro Boetto e del suo giovane segretario don Giuseppe Siri, fu il maresciallo Rudholf Lassner, uno dei responsabili delle SS di stanza in città, ad annunciare “ai sacerdoti con nazistica impudenza che erano risultati innocenti, facendo loro le sue scuse e annunciando la loro immediata scarcerazione”. Il farsesco voltafaccia, che portò alla liberazione dei dodici Sacerdoti, “questi miti e terribili testimoni”, era il frutto della “certezza che a La Spezia i repubblichini avrebbero provveduto nel proprio interesse a farli tacere per sempre”. Così non fu. I preti furono avvisati di rimanere a Genova, perché “a La Spezia si preparava per loro una trappola mortale”; così essi, vissuti nascosti e in clandestinità fino alla liberazione di Genova, “il 5 maggio 1945 raggiunsero le loro parrocchie, che li accolsero con le loro campane nell’aria della primavera spezzina”.Si chiude qui quella che, pur nella sua tragicità, mi piace metaforicamente definire la favola bella dei dodici Sacerdoti. Da parte mia penso che le numerose e qualificate testimonianze, che ho a lungo indagate e di cui ho dato conto con la massima fedeltà possibile, debbano risultare oltremodo preziose e oltremodo valide non solo e non tanto per chiarire, ma altresì, ove e qualora ce ne fosse bisogno, per giustificare la consistenza e avvalorare lo spessore dell’apporto dei Cattolici – Laici (e sono numerosi, oltre che noti a tutti), ma anche, come in questo caso specifico, Sacerdoti (forse non meno numerosi, ma, fiaccole sotto il moggio, assai meno noti) – al grande evento storico della Resistenza. L’autore, allora poco più che ventenne, Adriano Guglielmi, saggiamente osserva e saggiamente giunge a scrivere un pensiero forte e un concetto profondo pur se certamente già espresso da tanti altri che ebbero, prima di lui, a soffrire, immeritatamente, la durezza del carcere: “Solo quando si perde la libertà se ne afferra il valore nel suo significato più ampio”. E la sua validità va intesa tanto sul piano civile quanto su quello religioso. Sempre lui, il giovane Guglielmi, francescanamente, con parole clarite et belle, chiude e conclude il suo scritto-testimonianza, mi sia consentito sostenerlo e riaffermarlo, dal contenuto e dal peso altamente storico: “Sono cattolico, e per me il seme vero della libertà l’ho scoperto in quella cella fra quei dodici preti, alla luce della loro dignità e fede”. Sono parole che, al giorno d’oggi in cui si tende a generalizzare le macchie e le colpe di alcuni (sempre troppi, comunque, e per i quali Papa Francesco esprime la sua più totale), rivalutano tante e tante figure di Sacerdoti che, uomini tra gli uomini, in ogni continente, danno con generosa abnegazione il loro aiuto e il loro conforto a chi più ne ha bisogno e a tutti coloro che indistintamente a loro si rivolgono. 3. Felice Cascione, un eroe leggendario e una figura esemplare della “Resistenza” in Liguria “Il mio pensiero è questo: il dottore e il sacerdote debbono seguire l’esempio del grande Maestro dell’Umanità: passare beneficando.” Di chi sono mai queste parole sublimi? Le ha pronunciate non un mistico o un religioso, ma un partigiano, sì, proprio un partigiano verace: un coraggioso ed eroico partigiano imperiese, indimenticabile eroe e indimenticabile simbolo della “Resistenza”. Com’è facilmente intuibile, le parole in avvio esprimono, senza se e senza ma, un indiscutibile amore totale verso il prossimo, richiamandosi a Cristo e mettendo sullo stesso piano due nobilissime professioni: quella del medico e quella del sacerdote. È pur vero che il medico cura le malattie del corpo e il sacerdote cura i mali dell’anima, ma entrambi sono convintamente uniti nel preoccuparsi – materiale o spirituale che sia – del benessere di ogni persona. Non lo si può negare: quelle citate in apertura suonano parole ricche davvero di sconfinata bontà e dense di disinteressato altruismo tanto da sembrare scaturite e prese direttamente dal Vangelo. Si chiamava Felice Cascione, il giovanissimo medico (s’era laureato a Bologna nel 1942) che le aveva pronunciate con determinata convinzione scrivendole in una delle sue numerose lettere inviate alla madre, la maestra Maria Baiardo, rimasta vedova (il marito Giobatta Giacomo Cascione morto di ritorno dalla I Guerra mondiale) quando il figlio contava soli cinque mesi. Felice era nato a Porto Maurizio (Imperia) nel 1918 e di lui la madre era orgogliosa: *bravissimo nella pallanuoto (con la sua bravura trascinò l’Imperia a vincere addirittura uno scudetto!); *bravissimo come medico (anche se sua madre non era del tutto d’accordo: nel suo studio lui curava, con competenza, tutti i pazienti, bisognosi o meno, senza farsi mai pagare… come poteva fare solo un santo quale lui era!); *bravissimo come capo del suo manipolo di ribelli partigiani (seguendo la mammamaestra di paese in paese nei suoi trasferimenti punitivi perché antifascista, aveva imparato a conoscere e conosceva i monti alle spalle dell’Imperiese e del Cuneese come le sue tasche!). Il coetaneo Alessandro Natta, suo primo biografo, delineando personalità e carattere di Felice, scrisse che egli volle “essere medico per fare il bene, per sacrificarsi a favore del prossimo” e affermò: “Se una nota prima dev’essere posta in luce dell’animo nobile e puro di Felice Cascione, è la bontà. Un evangelico e disinteressato amore del prossimo e soprattutto degli umili, dei sofferenti, dei vinti”. Convinto comunista della primissima ora (era nato solo un anno dopo la Rivoluzione russa), decise di aderire alla “Resistenza” e assunse il nome di battaglia di “u megu” alla guida della Prima Divisione partigiana di Imperia: per lui “comunismo” non era certo un’utopia, ma significava mettere integralmente in pratica (come ha detto anche Papa Francesco!) le parole del Vangelo ed essere “compagno” vero di tutti gli umili e di tutti i poveri, di tutti i reietti e di tutti gli emarginati, ma soprattutto, da autentico “buon samaritano”, l’amico sempre pronto, anche rischiando in proprio, ad accorrere in aiuto di chiunque avesse bisogno o si trovasse in difficoltà. La sua bontà d’animo era tale che giunse al punto di vietare agli uomini della sua Divisione di uccidere seduta stante, come avrebbero voluto fare, due fascisti che erano stati catturati e riuscì a convincere tutti i suoi compagni, anche i più ritrosi, affermando: “Ho studiato da dottore per curare e salvare la vita degli altri, non per uccidere!” Purtroppo uno dei due riuscì a evadere e a mettersi in salvo fuggendo a rotta di collo: fu certamente lui la spia che, rivelando i nascondigli della Divisione comandata dall’intrepido Felice Cascione, fece sì che fascisti e nazisti della zona arrivassero a lui, l’astuto comandante che aveva dato loro tanto filo da torcere, l’imprendibile “primula rossa delle Resistenza del Ponente Ligure” e su cui volevano mettere le mani. E lui, ferito ad una gamba, sanguinante e impossibilitato a fuggire come aveva fatto tante altre volte, visto che avevano catturato un membro della sua Divisione e, credendolo il comandante, stavano per fucilarlo, alla pari di quanto aveva fatto Padre Massimiliano Kolbe ad Auschwitz, ebbe l’altruistico coraggio e l’ammirevole ardimento di attirarli su di sé dicendo: “Lasciatelo, sono io Felice Cascione, sono io il Capo che cercate!” Tanta erano la rabbia e l’odio contro di lui che non fu risparmiato e venne fatto fuori immediatamente con una raffica sul posto. C’è un cippo, oggi, a Case Fontane di Alto, che ricorda il luogo esatto in cui il nostro eroe – davvero leggendario e, lasciate che lo dica, davvero santo – fu ucciso sacrificandosi per salvare quel suo compagno e, con lui, tutti gli altri della sua Divisione, che così ebbero il tempo di darsi alla fuga e mettersi in salvo. Alto e bello, intelligente e buono: era l’idolo delle donne; non temeva il rischio e, da medico, correva sempre a curare chiunque lo cercasse, anche nel paesino più sperduto o nell’angolo più difficile da raggiungere: e per questo era ammirato e benvoluto proprio da tutti, nessuno escluso. Un giorno i ribelli partigiani della sua Divisione, mentre ascoltavano uno di loro che suonava sulla chitarra, che non abbandonava mai, il melanconico motivo russo di “Katjuša”, dissero al loro comandante che non avevano un loro canto per riconoscersi e gli proposero di comporne lui uno tutto per loro. Felice non se lo fece dire due volte e, adattandole alla nostalgica musica del popolare canto russo, ideò e buttò giù a Curenna, nel comune di Castell’Ermo, alcune strofe che dovevano diventare una sorta di universale inno partigiano: “Soffia il vento, urla la bufera ecc. ecc.”. E quelle strofe buttate giù su un foglietto di sottile carta velina le inviò per una revisione a sua mamma, l’integerrima maestra antifascista convinta e proprio per questo inviata, per punizione, ad insegnare e a fare la maestra in disagiati paesini di montagna. La mamma-maestra, più che vere e proprie correzioni, apportò qui e là alcuni ritocchi stilistici. Tanto per cominciare l’iniziale “Soffia” (verbo proprio del vento) diventò “Fischia” (un verbo che univa a quello del vento il sibilo delle sparatorie) e tale è rimasto per sempre sulle bocche e nei cuori di tutti gli antifascisti che ancor oggi lo cantano. “Fischia il vento”, certo il più noto canto partigiano al mondo e che rievoca atmosfere e coraggio della “Resistenza”, è anche il titolo che la scrittrice Donatella Alfonso ha voluto dare alla sua ultima fatica: che sia sussurrato in sordina o cantato a squarciagola, quel canto – nato da “u megu” per i suoi compagni di battaglia per la giustizia e la libertà – trasmette nostalgìa e ricrea quel clima di solidarietà che idealmente affratellava tutti i partigiani nella loro dura lotta resistenziale contro l’efferata dittatura nazifascista. Anche se sono trascorsi ben settant’anni dal tempo della “Resistenza”, il dottor Felice Cascione non è certo sorpassato né un personaggio fuori tempo: le sue imprese non solo sono ancora in grado di stupire e di affascinare, ma di essere anche di esempio per i giovani d’oggi. Dobbiamo, pertanto, essergli grati e riconoscenti per l’eroica prova che ha saputo dare fino a cadere vittima a soli 26 anni, nel 1944, della spietata crudeltà di fascisti e nazisti. Lui, che, da comunista verace, aveva messo in pratica le parole del Vangelo, amava sì il prossimo, ma amava nella stessa misura anche i nemici tanto da non volerli uccidere, semmai convincerli che avevano scelto la parte sbagliata perché nessuno aveva loro insegnato la parte giusta; e convincerli, soprattutto, d’aver commesso un grave errore nel sostenere coloro che, giungendo fino alla tortura, soffocavano democrazia e libertà. Per questo – e me ne assumo tutta la responsabilità civile e morale – meriterebbe proprio d’essere proclamato “santo” dalla Chiesa e scelto come “santo protettore” di tutti i partigiani uniti nella condivisa buona “Resistenza” e di tutti coloro che, credendo nella giustizia e nella libertà, nel rispetto per gli altri e nell’amore del prossimo, combatterono perché fossero sconfitti i seminatori d’odio e i sopraffattori nazifascisti. 4. 1945-2005: L'eroica figura dell'antifascista e partigiana Liana Millu (19142005), efficace scrittrice deceduta nel sessantesimo della “Resistenza” -Premessa. La mia conoscenza dell’autrice, rafforzatasi nel tempo, risale a svariati anni fa. Insegnavo allora al Liceo Classico Mazzini di Sampierdarena e, a nome della scuola, ebbi l’incarico di invitare la scrittrice ad un incontro assembleare con gli studenti del mio liceo. Liana Millu (1914-2005) ed io abitavamo nella stessa via per cui mi recai a casa sua. Mi accolse con quella affabilità che le era consueta e fu oltremodo felice di rispondere positivamente al mio appello, felice com'era sempre di portare la sua testimonianza fra i giovani, indagando nel contempo se le loro coscienze si manifestavano reattive o acquiescenti a “disvalori” quali “violenza, indifferenza, disprezzo”. Venne e catturò l’attenzione di quel pubblico giovanile, inizialmente irrequieto e chiassoso, con la sua pacatezza espositiva, con le sue rievocazioni meditate ed esposte con voluta lentezza e soprattutto con le sue risposte sempre esaurienti ai molteplici interrogativi che aveva sollevato nei giovanissimi studenti e che gli stessi le avanzarono. “La vita è bella” di Benigni non era ancora uscito (ma quando uscì mi disse che non ne condivideva né la forzata e giocosa impostazione né la falsa atmosfera) per cui l’incontro voleva offrire spunti di riflessione e di discussione su un altro film che i giovani studenti avevano visto: “Schindler’s List” di Spielberg, assistendo al quale, realistico e veritiero, mi confermò che aveva rivissuto il suo dramma e aveva pianto. -Presentazione dell’autrice. Chi era Liana Millu? Poiché accorreva a portare il suo messaggio ovunque la chiamassero, a me piaceva definirla “un vivente libro di storia resistenziale vagante”. Scomparsa dieci anni fa, proprio nell'anno del 60° anniversario della Resistenza e quando aveva appena compiuto 90 anni, Liana Millu era personalità molto nota non solo a Genova, ma in tutt’Italia e all’estero, anche se non faceva pesare per nulla la sua notorietà tanto era alla mano, disponibile, sempre vitale e pronta – pur con qualche fatica per l’età – a prender parte a incontri pubblici e convegni, e in ispecie a recarsi nelle scuole, tra i giovani, per portare, come sopra detto, la sua testimonianza (lo scrive lei: “ho l’abitudine di presentarmi subito come testimone che parla sul filo della memoria, che è depositario di memoria”), e, ancorché vittima degli orrori nazisti, non certo per spargere semi d’odio o per recriminare, ma per far sì che i giovani, fàttisi adulti, non avessero a ricadere negli orrori provocati da violenza, indifferenza e disprezzo – disvalori scaturiti da idee assassine e da concetti errati di superiorità razzistica e religiosa e che, ahinoi, sono sempre in agguato e si manifestano atrocemente anche nell'epoca in cui viviamo. Qual era, dunque, la forza della Millu fra i giovani? Non tanto quella di limitarsi a dire e a raccontare nel dettaglio la vita dei “lager” giacché – riteneva lei – i giovani “qualcosa ne hanno letto e qualcosa ne sanno”; ma era quella di far scoprire e di presentare loro – diametralmente opposti a quei disvalori sopra ricordati e che tanto male e tante turpitudini hanno generato e prodotto (e continuano a generare e produrre) contro l’umanità tutta – i valori umani della tolleranza e della ragionevolezza, della partecipazione e della reciproca stima: valori celati o seppelliti nei loro animi; e tutto ciò al fine di farli emergere dal silenzio dei loro animi, di farli venire dal buio alla luce suscitando in loro quella presa di coscienza che li portasse a capire, a riconoscere e a rendersi conto con chiarezza “dove e fino a che punto” quei disvalori hanno condotto l'uomo e ancora lo possono condurre, se non vengono continuamente e senza sosta contrastati dai valori. La sua preoccupazione prima, anche nelle sue opere, era proprio quella di far comprendere a tutti, ma ai giovani specialmente, che nella violenza, nell’indifferenza e nel disprezzo sono da ricercare le radici di nazismi e fascismi, di razzismi e intolleranze, anche di natura religiosa; e che se tali disvalori germinano e prevalgono negli animi degli uomini sopraffacendo i valori e facendoli venir meno, allora ogni forma di mistificazione, ogni forma di abbrutimento e ogni forma di violenza sono ancora possibili: sempre e in ogni momento. -I suoi scritti. Autrice di alcune opere fondamentali tradotte in più lingue e diffuse nel mondo e che sono da affiancare a quelle degli autori più sopra citati e che, nel contempo, dovrebbero, a mio avviso, entrare a far parte della biblioteca di ogni studente: opere destinate a far sì che non si perda la memoria dei campi di sterminio e delle torture in essi perpetrate né la memoria della “Resistenza”, messa in atto da lei come da migliaia e migliaia di altre donne e uomini d'ogni età e d'ogni ceto sociale. “Il fumo di Birkenau” (1947) scritto nell’immediatezza del ricordo e dell’esperienza vissuta e “I ponti di Schwerin” (1978), tradotti in tedesco a distanza di mezzo secolo e diventati “proprio in Germania” autentici best-sellers. Se è vero che entrambe le opere hanno avuto varie ristampe, non hanno però potuto contare su quella diffusione che, secondo chi scrive, meriterebbero e che, grazie al battage pubblicitario, hanno altri libri e altre autrici di spessore di gran lunga minore. Innoccasione e a fianco della “giornata della memoria” (a significare “l’apertura dei cancelli di Auschwitz”) che si commemora ogni 27 gennaio come “Giornata mondiale dell’Olocausto”, si dovrebbe anche proporre un congruo numero di libri da essere obbligatoriamente presenti e a disposizione degli studenti in ogni aula di ogni scuola del territorio italiano: a cominciare proprio dai libri di Liana Millu e, via elencando, fino a “Se questo è un uomo” di Primo Levi, del quale la Millu fu amica e in costante contatto. Il titolo di un altro suo libro è “Dopo il fumo (...di Birkenau). Sono il n. A 5384 di Auschwitz Birkenau”. Si tratta di una silloge tanto degli scritti della Millu, partigiana ed ebrea, apparsi su quotidiani o riviste quanto delle testimonianze da lei portate in incontri pubblici e convegni: un libro “parlato”, dunque. Gli scritti e le testimonianze sono incentrate su quello che lei definisce il tentativo di perversa metamorfosi che i nazisti tendevano ad operare in lei, trentenne prigioniera a Birkenau, nel “grande campo di sterminio” che sorgeva a tre chilometri da Auschwitz: sterminio agevolato, si fa per dire, grazie agli “inceneritori Topf” e alle “camere a gas” introdotte dal comandante Hoss). In apertura di libro, a metà e in chiusura si leggono tre intensi ed efficaci interventi dovuti allo studioso Piero Stefani al quale si deve la meritoria opera di raccolta di questi, che a me piace definire, “gridi muti di un cuore inquieto”: quelli del cuore di Liana Millu, che era incapace di gridare, sapeva tutt’al più mormorare – come per la preghiera ad Auschwitz: in piedi, in silenzio. Quelle di “Dopo il fumo” sono pagine da leggere, da rileggere e da far leggere, sono pagine su cui riflettere e far riflettere, sono pagine che il tempo – oggi che siamo a settant'anni esatti da quei misfatti – sta rendendo (e sempre più renderà), pur nel trapasso di figure eroiche come quelle di Liana Millu, memorabili sul piano storico vero e proprio, ma anche su quello estetico e letterario. I nove capitoletti ripercorrono solo apparentemente l’itinerario, diciamo così esteriore, di spersonalizzazione e di abbrutimento cui l’autrice, ridotta a semplice matricola “n. A 5384”, venne sottoposta, ma cui cerca di resistere per non perdere la propria umanità. E il filo rosso che unisce i capitoletti o il rivolo sotterraneo che fluisce dall’inizio alla fine del libro è quel percorso tutto interiore, tutto d’anima che fa passare la Millu, attraverso meditate riflessioni e ben ponderati pensieri, dall’ateismo – per la via del “senso del mistero” – all’agnosticismo fino quasi alla “fede” intesa come “necessità di credere in qualcosa” e fino alla “preghiera”: “Fa, o Signore, che io non divenga fumo”; percorso interiore e d’anima che fa distaccare la Millu “da tutto quello che la circondava” e che ancora la fa passare dalla violenza senza senso (il virulento attacco per massacrare di botte la povera e incolpevole ragazza greca) alla “pietas” per sè e per gli altri, gli aguzzini compresi: dal “biasimo” alla “compassione”, allo “stupore” di fronte a tanta crudeltà e a tanta malvagità degli animi, per far ricorso ai termini stessi dell’autrice. Quanti episodi (tra tutti, almeno il viaggio Mestre-Venezia e il mozzicone di matita) vorrei richiamare e quanti personaggi (tra tutti, almeno Edith Stein e Padre Kolbe) vorrei rievocare: episodi e personaggi che sono frutto non del mero ricordo, ma di una sorta di convinta missione di cui la Millu, finché visse, si sentì investita: far sì che tali orrori non avessero mai a cadere nell’oblio, far sì che la sua esperienza e quella di tanti altri “che c’erano” fosse trasmessa aagli uomini d'oggi, in particolare ai giovani che saranno gli uomini di domani, i quali a loro volta dovranno assumersi il compito di trasmetterla ai loro figli, gli uomini di dopodomani. Senza spirito alcuno di vendetta, Liana Millu intese essere, per gli uomini tutti, voce della memoria e testimone fedele, ma con quel distacco che si legge nei versi di chiusura: “Andate, o umani. Più niente voglio a che fare con voi”. Con quanta più forza lo griderebbe se ancor oggi fosse viva di fronte agli orrori perpetrati in gran parte del mondo e di cui l'uomo, ignorando il suggerimento dantesco, continua ad essere brutale autore! 5. 25 APRILE 1945-2015: a ricordo dei martiri e delle stragi della “Resistenza” Come trascorre inesorabile il tempo! Esattamente un secolo fa la “Prima Guerra Mondiale” con milioni e milioni di giovani morti in una guerra guerreggiata nelle trincee e sui campi di battaglia e a cent’anni di distanza viene giustamente ricordata in varie e importanti manifestazioni in numerose città italiane, San Pier d’Arena compresa. Anche la “Seconda Guerra Mondiale” e la “Resistenza”, ahinoi! stanno sempre più sbiadendo nel ricordo perché risalgono ad un tempo lontano e che si fa sempre più remoto. Ciò che, però, non deve essere cancellato dalle nostre menti e dai nostri cuori è il sacrificio di quei tantissimi partigiani che, con animo onesto e pulito, lottarono e affrontarono impavidi i nazifascisti. Per nostra fortuna non ci sono solo poeti che scrivono poesie di fantasia o dicono d’amore, di tramonti e di stelle, ma anche ispirati poeti che, come il sapido e petroso filosofo-poeta Carlo Olivari, compongono intensa “poesia civile” perché gli eroi partigiani non siano mai dimenticati. Egli ha pubblicato, seppure misconosciuto dai consueti “pappagalli lusingatori”, un aulico libretto titolato “Poesie partigiane”. Tutti, proprio tutti Carlo Olivari – il quale conobbe di persona la mamma della staffetta partigiana Adele Rossi più sopra ricordata – li ha nel suo cuore i giovani (per lui “Gioventù sui monti”) e forti eroi partigiani (descritti in “Momento di fucilazione”), i quali esattamente settant’anni fa lottarono fino al sacrificio della loro vita perché, liberi dalla dittatura nazifascista, tutti gli Italiani potessero vivere in democrazia, in pace e in giustizia, e non sotto il giogo crudele e sanguinario del nazifascismo. Si tratta – suddiviso in una sorta di vera e propria Via Crucis in dodici stazioni – di un poemetto di “lirica civile” che tratta dei fatti connessi alla loro coraggiosa e sofferta esistenza di partigiani. Il poeta, in versi essenziali, ma densi di commossa partecipazione e accorati davanti lo spettacolo di tanto strazio, rivive nel suo ricordo e fa rivivere a noi lettori eccidi e stragi, massacri e fucilazioni, vittime e martiri della “Resistenza”. *Perpetua così il ricordo dell’“Eccidio all’Oliveta” a Portofino: i versi sono dedicati alla tragica fine dei “21” antifascisti e che fu svelata, solo dopo la Liberazione, da Vito Spiotta, uno dei più spietati fascisti operanti in Liguria. *Rievoca il “Calvario della Benedicta”, località presso le Capanne di Marcarolo, nel comune di Bosio sull’Appennino ligure: ove furono ben “75” i partigiani vigliaccamente fucilati e crudelmente massacrati. *Dice, in versi secchi e crudi, del carcere di “Via Tasso”: luogo davvero drammatico di umiliazione, di tortura e di morte perpetrate dal Comando tedesco ivi installatosi per centinaia di innocenti perseguitati. *Medita sull’attentato del 23 marzo in “Via Rasella 1944” in cui perirono “33” tedeschi e “2” civili italiani e che, pur se giudicata “legittima azione di guerra”, viene considerata da Olivari “Come peso, ineluttabile, su noi/dentro di noi”, concludendo drammaticamente: “Nulla di certo, nulla… nulla, nulla”. *Piange, in “Fosse Ardeatine”, i “335” prigionieri che il 24 marzo 1944 vennero fucilati senza pietà come rivalsa per l’attentato del giorno precedente; il poeta li rievoca così: “A luce ululanti, indistinte, le ombre”. Tre stazioni olivariane sono dedicate a singoli eroi della “Resistenza”: *“A Leonardo Cocito”, giovanissimo partigiano cui Genova ha dedicato una via che mi è familiare perché si trova proprio nel quartiere in cui abito anch’io; il giovane Leonardo è visto e descritto mentre, “senza tremito minimo”, stringe “quella corda, per lui, di impiccagione”. *“A Jenny Marsili. S. Anna 1944”, vittima del disumano eccidio di “560” inermi civili tra donne, anziani e ben “130” bambini a Sant’Anna di Stazzema; una vittima di quella feroce ecatombe contava solo 20 giorni: “neonati dalle madri divelti”, così il poeta riassume l’immane carneficina e la tragica “strage di innocenti”. *“Al partigiano siculo Giorgio Renda”, fatto rivivere per noi tutti perché, lui nato nella lontana Sicilia, fu, come recita il poeta, “ucciso nella mia Liguria”. L’ultima stazione della Via Crucis olivariana è intitolata “Viaggio e arrivo in Germania” e ricrea l’orribile promiscuità dei vivi e dei morti su quei treni piombati, con “fermata subitanea” in “acherontica luce”, prima di dirigersi ad Auschwitz, Birkenau, Mauthausen, Buchenwald, Dachau e ad altre infernali mete che hanno mille e mille volte sollevato l’interrogativo “Dov’era Dio?” a cui il poeta risponde: “Laggiù/assente-presente, in quello spazio” di immane tragedia. Una lezione, quella del poeta-civile Olivari, in bilico fra la riflessione civile su così efferati misfatti di un passato da non dimenticare; il ripensamento storico sulla disumanità dell’uomo che, ahinoi, ancor oggi si ripropone con accentuata crudeltà e violenza omicida; la rievocazione sofferta con spasimi interiori espressi in componimenti lirici carichi a un tempo di piena sincerità e interiore durezza.
Scarica