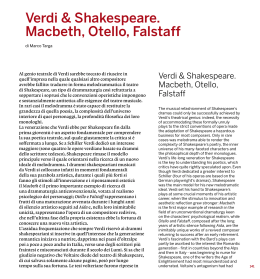Tra Busseto e Stratford-upon-Avon. Verdi esegeta di Shakespeare. Anche il melodramma deve essere considerato come un textum, un prodotto che nasce dall’intreccio (tèxere) di più materiali. Così, per limitare il discorso alla cosiddetta ‘trilogia scespiriana’ di Giuseppe Verdi, è possibile considerare Macbeth, Otello e Falstaff come logoi, come ‘narrazioni’, ‘storie’, ‘racconti’ – questi sono alcuni dei significati della parola greca logos, dalla cangiante polisemia – da cui far emergere la filigrana concettuale e filosofica. Lo ‘specifico’ del melodramma non consiste solo nella peculiarità del linguaggio melodrammatico, ma anche nella contaminazione di linguaggi diversi. Un melodramma, insomma, è un testo plurimo che non solo consente, ma addirittura pretende di essere costantemente riferito ad un più ampio orizzonte artistico per potere essere compreso fin nelle sue più intime giunture. Tanto si è scritto sull’incontro tra il genio di Roncole di Busseto e quello di Stratford-upon-Avon, un incontro, forse, predestinato se solo si considera che entrambi sono tra i massimi drammaturghi di sempre che, come pochi altri, sono riusciti a calarsi nei precipizi dell’anima. Due frammenti tratti da altrettante missive scritte rispettivamente ad Antonio Somma, l’autore del libretto di Un ballo in maschera, e a Marie Escudier, l’editore francese, dicono come meglio non si potrebbe la passione di Verdi per il Bardo: «Preferisco Shaspeare a tutti i drammatici, senza eccettuarne i Greci»; «C’è chi trova il soggetto di Macbeth sublime e chi non musicabile. E c’è chi trova che io conoscevo Shaspeare quando composi l’opera. Può darsi che io non abbia reso bene il Macbeth, ma che io non conosca, che io non capisca, che non senta Shaspeare, no, per Dio, no! È un poeta di mia predilezione, che ho avuto fra le mani dalla mia prima gioventù e che leggo e rileggo continuamente». Era dunque pressoché inevitabile per un uomo che «conosceva, sentiva, capiva» a tal punto Shakespeare farsene anche interprete. Verdi, però, legge Shakespeare non da filologo, ma da esegeta, e in questa veste non solo – con Macbeth e Otello – ne chiarifica il magistero, ma porta altresì a compimento – con Falstaff – ciò che nel teatro del Bardo era solamente abbozzato (ma l’influenza del «gran maestro del cuore umano», come Verdi chiamava il drammaturgo di Stratford, travalica Macbeth, Otello e Falstaff: non vi sono forse chiare suggestioni shakespeariane anche nella cosiddetta ‘trilogia popolare’, nell’Aida e nella Forza del destino?). Dunque, Verdi esegeta, non filologo, di Shakespeare. La parola esegeta deriva dal verbo greco exêgèomai che significa ‘essere guida di qualcuno’, ‘condurre qualcuno attraverso un luogo’, un luogo che può essere anche letterario, il quale presenta non di rado pericoli e insidie non certo inferiori a quelli che si trovano in natura. Si badi: ‘condurre attraverso un luogo’, non già ‘portare a destinazione’. In questo senso l’esegesi è un viaggio diuturno, è una infinita inquisitio, è un dialogo aperto, serrato, a volte persino un cruento corpo a corpo con il testo. L’esegeta non dirà mai ‘la cosa è’, ma sempre ‘la cosa potrebbe essere’. Grazie anche alla fondamentale mediazione dello scapigliato Boito – il quale «aggiustò le gambe» del Simon Boccanegra e consegnò alla storia del melodramma due dei libretti più raffinati di sempre, al netto di alcuni preziosismi lessicali –, Verdi si rivela un grande esegeta scespiriano perché la sua musica coglie e restituisce all’ascoltatore il thauma del teatro del grande Bardo, l’incanto, lo stupore, la meraviglia, ma anche il brivido, l’inquietudine e l’orrore che lo tramano. Macbeth e Otello sono due dei più potenti drammi dell’intero canone scespiriano. A questi, però, potremmo aggiungere anche Re Lear, pur sapendo che la versione in melodramma di questo capolavoro purtroppo non si è spinta oltre a una mera dichiarazione di intenti. Tre drammi che mettono in scena altrettante passioni: Macbeth, ossia la passione del potere, la quale rivela impudicamente il deficit ontologico del Politico, come, cioè, la civitas hominis non possa non trasformarsi in civitas diaboli; Otello, ossia la passione della lussuria; e infine Re Lear, ossia la passione dell’ira, che è libido dominandi. Impetuose, sfrenate, implacabili sono queste passioni; e lo sono al punto da sottoporre il tragico a una radicale metamorfosi. Nel teatro verdiano-scespiriano, infatti, saltano tutti i cardini della tragedia classica – drân, pathos, mathos, katharsis. Se Antigone poteva affermare «Kai femì drasai», «Dichiaro di aver fatto la mia scelta» (quella di dare sepoltura al cadavere del fratello Polinice), non così, invece, i personaggi di Shakespeare e di Verdi. Al drân, verbo massimamente tragico che sempre si sostanzia in un’azione e di conserva in un risultato, poco importa se dall’esito fausto o infausto, si sostituisce il to act, la mera recitazione che non conclude. Il drân diventa question, interrogazione inane, autistica sulla sua natura e sulla sua necessità. Ne deriva che questo teatro non è più capace di porsi quale exemplum allo spettatore, e di conseguenza nega qualsiasi certezza metafisica capace di preservarlo dalla caduta nell’assurdo. Codesta metamorfosi del tragico, iniziata a dire il vero con Il Trovatore, raggiunge in Verdi la sua compiuta formulazione nel Credo di Jago, il quale ha singolari analogie con il celeberrimo monologo di Macbeth (V, v): «Spegniti, spegniti breve candela! La vita non è che un’ombra che cammina, un povero attore che per un’ora sola vanità e affanni mostra sulla scena, e poi più nulla. È una storia narrata da un idiota, piena di rumori e furia che non significa niente». Eppure sono proprio gli idioti a dare un significato alla storia della vita: dalla spaventosa eclissi di Dio messa in scena dal teatro verdiano-scespiriano sopravvivono solo due figure, la donna straniera e l’uomo che ride. Straniere sono quelle donne che ancora custodiscono la memoria del Deus patibilis, del Dio che patisce la turpissima mors della croce. Ofelia nell’Amleto, Desdemona nell’Otello, Cordelia nel Re Lear, Leonora nel Trovatore annunciano (euangellein) un Novum che suona come uno sgradevole e barbaro idioma agli orecchi dei più, al punto che i più non solo lo disprezzano, ma anche lo respingono. Anzi: il loro rifiuto è così radicale che mettono addirittura a morte questi nuovi evangelisti. Esse sono figure dell’idiozia modellate sull’Idiota per antonomasia, il Santo di Nazareth, colui che parla un sermo straniero, durus, incomprensibile e intraducibile. Insieme alle donne straniere il solo personaggio che riesce a scampare dall’immane naufragio messo in scena dal teatro di Verdi e di Shakespeare è Sir John Falstaff, l’uomo che ride. Fino ad Otello la poetica di Verdi mostra una solida coerenza concettuale. Ma con Falstaff ecco accadere qualcosa di assolutamente imprevisto che sembra sconfessare un magistero rimasto inconcusso fino dai tempi del Trovatore. ‘Sembra’ sconfessare, perché ad un esame più attento Falstaff è la prova schiacciante, se mai ce ne fosse ancora bisogno, del genio drammaturgico di Verdi, il quale raccoglie l’intuizione scespiriana sul comico quale estrema metamorfosi del tragico, sottoponendola a un’ulteriore torsione che avrà il suo compimento nel teatro di Samuel Beckett. Si badi, però: il comico del Falstaff non ha nulla a che vedere con quello della commedia greca, il quale, esattamente come il planctus della tragedia, ammaestrava gli uomini, recando loro il mathos. Ancora una volta Verdi si dimostra un acuto esegeta scespiriano perché radicalizza ciò che il grande Bardo aveva anticipato nella figura del fool, il quale ride, sì, da folle della follia degli uomini, ma sa bene che il suo riso non ha più nulla da insegnare a nessuno. Per Massimo Cacciari il comico rivela l’incapacità del threnos ad esprimere l’infelicità: questa, ormai, può essere detta solo «nella sua similitudine più lontana: anzi, in ciò che nessuno modo potrebbe essere confuso con essa, in ciò che sembra addirittura negarlo». Il comico, insomma, ride di ogni tentativo esperito per rappresentare il mysterium iniquitatis. Se nel Re Lear accanto al buffone compare ancora l’eroe tragico che molto ha vissuto e patito, che leva il suo grido escruciante quasi gareggiando in violenza con la tempesta che squassa la brughiera, nel Falstaff resta solo il buffone, testimone attonito di come il grido non riesca più a rappresentare quella sconcia «burla» che è il mondo. Ma se il mondo è una burla, allora deve cambiare anche il linguaggio: il riso e il comico – che nella partitura verdiana assumo la forma ora dell’ironica autocitazione ora della gustosa parodia della tradizione melodrammatica – sono i soli mezzi per dire l’indicibile. Così al Confiteor disperato di Otello si sostituisce ora quello comico di Falstaff (e siamo al celebre fugato dell’Atto Terzo che suggella l’opera); si tratta, tuttavia, di una comicità che ha quale suo occulto suggeritore Qohélet, il grande poeta del disincanto, l’uomo che più di ogni altro ha compreso come tutto in questo mondo sia «hevel hevelim», sia, più che «vanitas vanitatum» come erroneamente traduce la Vulgata, ‘fumo di fumi’, ‘vapore di vapori’, ‘cenere di ceneri’: «Tutto nel mondo è burla. L'uom è nato burlone, La fede in cor gli ciurla, Gli ciurla la ragione. Tutti gabbati! » Andrea Panzavolta
Scaricare