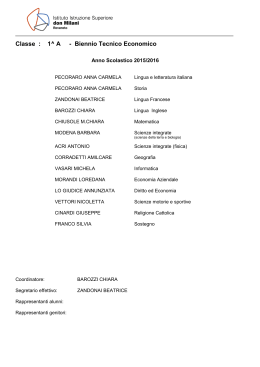APPENDICE 6 3.2.6. MEMORIE 462 Mario Rinaldi, Zandonai, «La Gazzetta» I/2, 3-10.12.1944 - p. 1, col. 4-5 / p. 2, col. 1 (con un disegno di Zandonai) Per comprendere a dovere Riccardo Zandonai uomo era necessario stargli molto vicino. Chi lo avesse giudicato per averlo intravisto nel corridoio di un teatro o per la via sarebbe certamente caduto in errore. Nulla aveva esteriormente, quel nostro musicista, che potesse palesare la sua bontà. Madre natura lo aveva fatto piccolo, sproporzionato, con due piccole braccia che faticavano a gesticolare. A vederlo si provava una strana sensazione: invece era un uomo con un cuore d’oro, che amava il suo prossimo, che non riusciva a concepire cosa fosse o dove abitasse il male. Era un artista che figurava “al negativo”. Una giovane signora che lo ammirava soltanto per aver ascoltato un paio di volte la Francesca da Rimini se lo figurava “alto, slanciato, con chioma abbondante spiovente sulle spalle, con due grandi occhi trasognati e ardenti, faccia estremamente pallida, sensibilissimo e nervoso, raffinato nella vita come nei gusti”. Niente di tutto questo. Bisogna andare esattamente all’opposto. Uomo “al negativo”. Il suo fisico faceva immaginare una voce rauca, chiusa, diremmo cavernosa, ovvero una voce che poteva ricordare quella del wagneriano Mime. No. Il suono della sua voce era invece armoniosissimo, tutto dolcezza, tutto velluto. Una bella voce. Per comprenderlo, quest’uomo, bisognava avvicinarlo. Ebbene, per ciò che riguarda la sua arte si potrebbe dire qualche cosa di simile. Per comprendere Zandonai musicista, infatti, bisogna conoscere un po’ a fondo la sua musica, anche perché nella sua produzione esiste più d’un contrasto che merita la pena di essere illustrato. Noi non siamo davvero ammiratori sviscerati della produzione sinfonica di questo autore; diremo anzi che non ammiriamo nemmeno tutti i suoi lavori teatrali. Giudichiamo però Francesca da Rimini, nel suo genere, un autentico capolavoro; anche in quest’opera sono evidenti i difetti (specialmente nel secondo atto), ma quante bellezze nel primo e nel quarto e specialmente nel terzo! Quale creazione ambientale, quale controllo d’ispirazione, quale accuratezza di strumentale. Bisogna riconoscere, con dolore, che gran parte della creazione di Zandonai è già lontana da noi. Lontana com’è lontano l’uomo, scomparso nel momento più tragico della nostra storia. Il 23 giugno u. s. il giornale ufficiale romano riportava una laconica notizia che tra l’altro diceva: «Si apprende che all’Ospedale di Pesaro, ove era stato ricoverato in questi giorni, è morto il grande compositore italiano Riccardo Zandonai... Grande patriota, esule dal paese natìo all’inizio dell’altra guerra, fu dall’Austria condannato a morte assieme a Cesare Battisti, suo compagno d’idee e di lotte politiche. Alcuni mesi or sono aveva dovuto abbandonare il suo tranquillo rifugio sul colle San Bartolo di Pesaro, estromesso dai tedeschi che ne avevano occupata l’abitazione e trovare asilo in un Convento di Francescani sui monti circonvicini...». Poca cosa, invero, ma la nostra Italia sanguinante, allora, ancor meno di oggi aveva possibilità di piangere i suoi figli. E Zandonai fu sepolto senza l’ombra di un ricordo, senza il minimo saluto. La notizia era giunta a Roma con otto giorni di ritardo. Il 151 giugno 1944 fu il Suo giorno fatale. Anch’egli fu vittima delle amare sorti della Patria. *** Un contrasto evidente esiste nella musica di Riccardo Zandonai. Vediamo. È indubitato che la sua musica possiede una caratteristica fondamentale: l’accuratezza e la sapienza dello strumentale. («S’io valgo qualche cosa – diceva lo stesso Maestro ai suoi amici – è per lo strumentale»). Ebbene, nonostante ciò, i suoi migliori lavori non si trovano fra quelli sinfonici, bensì fra quelli teatrali. 1 [sic]: ma 5. 3.2.6/1 Non è giusto, a nostro modo di vedere, quello che ha detto parte della critica: cioè che le opere del musicista trentino, anche quelle più quotate, appartengono più al passato che al presente. Non è vero, non fosse altro che per quel terzo atto della Francesca da Rimini, musicalmente “dantesco”. Nessuno negherà che lo spirito del compositore sia uno spirito romantico per eccellenza; nessuno negherà che in molte pagine – per esempio nella Giulietta e Romeo – l’enfasi prenda la mano del musicista, ma esiste sempre nella produzione operistica del maestro un gusto particolare, uno spirito teatrale limpidissimo che, in tempi come gli attuali, acquista la sua importanza. Così non è il caso di dire che Zandonai, rispettoso ammiratore della tradizione, spanda nelle sue opere melodie su melodie di facile rilievo e di spiccata originalità. Sarebbe più giusto dire che egli fece largo uso di declamato melodico, ma questo declamato non manca di muscoli, non è senza fisionomia. La musica del maestro trentino si riconosce abbastanza facilmente per il suo “calore” e, diremmo, per il suo “profumo”. Se nel principale duetto della Giulietta c’è qualcosa di caldo che ravviva lo spirito, nel primo incontro con Paolo c’è un profumo che inebria tutta l’aria. Tutto ciò dipende essenzialmente dalla chiara comprensione ambientale. I luoghi preferiti sono rivissuti attraverso le note. A Francesca si è accennato; ricordiamo ora i Cavalieri di Ekebù che, in molti punti, sorprendono per la loro eccezionale comprensione d’ambiente. *** Più d’un’opera teatrale dello Zandonai è mal conosciuta dal nostro pubblico. Le cause di tutto ciò dipendono da più fatti. Uno di questi fu denunciato dallo Zandonai stesso il quale, in un incontro giornalistico a Trieste, ebbe a dichiarare direttamente: «Una volta le opere erano commesse agli autori direttamente dagli impresari e non dagli editori. Sicché padrone dell’opera, l’impresario aveva tutto l’interesse di farla rappresentare; e, quasi sempre, se lo spettacolo lirico cadeva in una piazza risorgeva in un’altra, compensando lo speculatore della sua tenacia e affermando infine la notorietà e, spesso, il valore degli autori». Parole che possono essere oggetto di facile critica, ma che hanno la loro importanza. *** Merito dello Zandonai è stato certamente quello di non lasciarsi trascinare dalla falsa moda del tempo. Si sa che egli non disprezzava Puccini, Mascagni e compagni, ma si sente, attraverso la sua musica, che egli non voleva ammettere questi autori con tutto il bagaglio dei loro difetti. Così egli, da Strauss volle apprendere quello che gli sembrò opportuno apprendere, senza divenire per questo un suo schiavo. Anche il moderno indirizzo italiano (da Respighi a Pizzetti, da Casella agli ultimi “sinfonici”: la giovane scuola romana) non lo rapì in alcun modo. Quello che premeva allo Zandonai era il progresso tecnico; ammetteva senza riserve che una grande differenza, una necessaria differenza, esisteva in questo campo tra ieri e oggi. Si avvicinava però ai moderni controllando ogni suo movimento. Amava quel calore, aveva passione per questa nuova fiamma, ma temeva di scottarsi. Disse una volta il compositore ad un amico: «È errato affermare che in Italia non ci siano oggi autori d’opere liriche». A giudicare dalla produzione del Maestro trentino può anche sembrare che quelle parole siano esatte. 463 Emidio Mucci, Memoria di Riccardo Zandonai, «Il Mondo musicale», 18.3.1945 - p. 3, col. 1-2-34-5 (con un grande ritratto di Zandonai) Il sei giugno dello scorso anno una radio dell’Italia del nord comunicava che Riccardo Zandonai si era spento in un ospedale di Pesaro. Ma l’annuncio funebre veniva travolto nella commossa festività per la liberazione di Roma. Soltanto i cuori degli amici e degli ammiratori dolorarono, procurando la notizia sgomento e ansia di particolari. Il sette ottobre infine, in occasione della inaugurazione della Radio Audizioni Italia, si svolgeva un concerto vocale e istrumentale in commemorazione del Maestro, alla presenza del Sottosegretario all’Istruzione Pubblica, che ne rievocava brevemente la figura civile ed artistica. 3.2.6/2 Ma occorre trascorra altro lungo tempo perché, avvenuta la liberazione di Pesaro, si abbiano notizie sull’inaspettata catastrofe. *** All’ingresso della Villa San Giuliano in territorio Monte S. Bartolo di Pesaro, si legge forse ancora la scritta: «Ogni pianta apre il suo cuore e canta». È un verso del prologo dell’opera Giuliano, ispirato dal bosco spesso e vivo che coronava il poggio, sulle pendici del quale Zandonai aveva da molti anni fissato la sua residenza. Quel bosco esercitava su di lui un fascino ineffabile; risuonava di vaghi incantesimi; pullulava di sogni e fantasmi. Il suo cuore si accordava con quello degli alberi, s’intonava ai nidi canori, vibrava come una lira alla carezza dell’aura, al trascorrer della luce. Ma un giorno il comando tedesco, per dare inizio agli apprestamenti della linea gotica, fece pervenire al Maestro l’intimazione perentoria di abbandonare la villa nel termine di ventiquattro ore. Eseguito l’ordine in un dolore muto e raccolto, non senza avere preventivamente nascosto in un cunicolo i manoscritti e la biblioteca, il Maestro con la sua famigliola si rifugiava nel Convento del Beato Sante a Mombaroccio, circa venti chilometri da Pesaro. Egli non ignora che la villa, realizzazione delle sue più ambite aspirazioni, oggetto delle sue più sollecite cure, viene ben presto trasformata in cantiere di lavoro per l’organizzazione Todt; ma, sorretto da robusta tempra spirituale, anche se da qualche tempo la salute fisica sia insidiata da penose crisi, infonde fiducia ai familiari, raccoglie l’ammirata simpatia dei francescani. E poi, invisibili ma presenti, lo circondano Melenis, Conchita, Francesca, Giulietta, Lucia, amorosamente accoglienti la capricciosa sorella Vistilia. La protagonista di una nuova opera? Sì: un’opera il cui titolo – Il bacio – non suona perfettamente ortodosso ai seguaci di S. Francesco; alla quale egli attende con fervido e gioioso slancio; il cui soggetto – suggeritogli dal devotissimo amico Nicola D’Atri – è stato ricavato da una novella di Keller. Un’opera dove Vistilia, a somiglianza dell’autore, è stata indotta, sebbene per motivi ben diversi, a rifugiarsi in un cenobio! In pochi giorni, tra febbraio e marzo, egli compie l’istrumentazione dei primi due atti, mentre converge l’attenzione sulla sceneggiatura del terzo, steso, a causa della morte di Arturo Rossato, da altro librettista2. L’occupazione dei tedeschi diviene ogni giorno più rigorosa e preoccupante; le incursioni aeree da parte degli Alleati si fanno sempre più frequenti e dannose; la minaccia dal mare si acuisce. Ma il Maestro oppone alle circostanze la più salda resistenza, e non si dispiace che alcuni amici, insieme con il Trio Pesarese, si accingano a salire al Convento per celebrare, secondo la tradizione, l’anniversario del trionfo della Francesca: si stapperanno perfino alcune bottiglie di vin prelibato, rinvenute per caso in una cantina del mistico asilo. Malauguratamente la festicciola non può aver luogo. Il Maestro, di nuovo ghermito dal male, vien trasportato d’urgenza all’ospedale di Trebbiantico, nella zona periferica di Pesaro, essendo stato l’ospedale principale distrutto da un bombardamento aereo. Un’operazione al fegato è giudicata improrogabile. «Io non mi faccio illusioni – scrive Egli a Renato Pompei, ragioniere capo del Comune di Pesaro, suo amico e coadiutore in tutte le iniziative musicali della città – ma dopo due anni e mezzo di sofferenze, rinunzie e sacrifizi, la vita non avrebbe per me più valore se non mi sorridesse questo esperimento radicale ed energico. E così, se sfuggirò all’acuto traguardo del bisturi, potrò con rinnovata energia, a guerra finita, riprendere il nobile e appassionante lavoro di valorizzazione artistica della nostra cara Pesaro. Se il traguardo mi sarà fatale... quel poco che abbiamo fatto insieme al Conservatorio e al Teatro – poco, ma alto, nobile e di vera gran classe – potrà servire di esempio a colui che prenderà il mio posto nella direzione del “Conservatorio Rossiniano”». In questa lettera, scritta pochi giorni prima del trapasso, è consegnata la figura spirituale dell’uomo il quale, lungi dall’isolarsi nella torre eburnea della sua arte, tende consapevole il pensiero esclusivamente alla nobiltà della missione didattica e dell’elevazione culturale della città adottiva, divenuta sommamente cara al suo cuore. 2 Mucci allude a se stesso. 3.2.6/3 «Nulla può esprimere l’artista – fu scritto – se il suo mondo interiore è povero, o artefatto o meccanico». Ed il mondo spirituale di Riccardo Zandonai fu sintesi armonica di passione politica, attività didattica e direttoriale, affetti familiari, sforzo creativo. *** Nato a Sacco di Rovereto, le sue manifestazioni politiche verbali e musicali (una Messa da Requiem in memoria di Re Umberto, un Inno degli studenti Trentini, un altro inno Alla Patria, scritto per invito di Cesare Battisti) gli procurarono una condanna per alto tradimento da parte dell’I. R. Tribunale Austriaco di Innsbruck. Allorché riceve la nomina di direttore del Conservatorio Rossiniano, egli impegna tutte le sue energie e il suo fervore per la riorganizzazione e il perfezionamento dell’Istituto, trascurando per anni la composizione. E, sulle soglie della morte, come abbiamo detto, alla vita del Conservatorio volge tutte le sue preoccupazioni, senza neppure un accenno all’opera in gestazione. La direzione orchestrale rappresenta un mezzo di divulgazione non soltanto dei propri lavori, ma di quelle pagine che più ama e più approfondisce: la resurrezione della Gazza ladra è fiamma e devozione sull’altare del grande Gioacchino. Dall’affetto della compagna e della figliola attinge perennemente tutte le purezze ideali che lo aiutano a distaccarsi dalle banalità terrestri, a perseguire i suoi caldi sogni d’arte. Dieci opere teatrali edite e vari poemi sinfonici ci palesano, meglio che un’analitica biografia, le note essenziali e determinative dell’artista, il quale, pur ligio alla forza viva e operante della tradizione, riuscì tuttavia giovanissimo a dipanarsi dal vischio della “giovane scuola italiana”, affermandosi in una impronta nuova di sostanza e di forma. Così come, giunto all’età matura, non subirà alcuna influenza dalla “politica fascista delle arti”, proseguendo sul sentiero da lui intrapreso e sviluppandolo in senso del tutto autonomo. A un’arte dissolvente egli oppone un’arte unitaria e, schivando perturbazioni maliose e malefiche che emanano dal nord e dall’est, accosta sempre più cuore e orecchio alla terra natale. Chi non rammenta il tepore familiare della scena iniziale del Grillo, presso il focolare?: «Eccomi, signor Grillo, eccomi presso alla vostra dimora»; e l’agreste profumo che si leva dal coretto dei fienatori nella Via della finestra, ove si addensa tutto il sentimento georgico dell’autore?: «Odor di fieno: il tuo sorriso è come il sole, come il cielo sereno»; e l’amore per il lavoro che prorompe in inno squillante nel grandioso finale dei Cavalieri di Ekebù?: «L’incudine sia un limpido sonaglio! E i nostri cuori, lieti ritornelli! Accendi! Accendi!». La critica gli rimproverò l’ingombro di un wagnerismo invadente, e cadde in equivoco. Egli infatti non ricalcò, come altri suoi confratelli, le orme di Riccardo Wagner né tanto meno quelle esasperate di Riccardo Strauss, pur rinnovellando il melodramma – come per primo ebbe a rilevare Nicola D’Atri – con l’apporto dell’elemento sinfonico. Ma tale elemento sinfonico plasmò in forme nuove, accentuando di luci vive i valori timbrici, squadrando compatti blocchi sonori, lanciando le sue figure meliche sulle onde di vaghe sorprese tonali. E fu proprio in virtù di cotesti caratteri che altri critici, di indubbia autorità, gli attribuirono una tecnica impressionista. In verità Riccardo Zandonai, animato da un palpito incessante, spesso esuberante, è un neoromantico, che in quasi tutti i soggetti trattati tende a distaccarsi dalla realtà per vagheggiare una vicenda di fantasia (Francesca, Giulietta, Giuliano, I Cavalieri) e per comunicare la foga del suo sentimento a fragili trame ritagliate nell’umana commedia (Grillo del focolare, Via della finestra, Farsa amorosa). E tutto esprime in quadri pittorici, con visione larga e incessante ardore. Anzi non si accontenta di presentare il quadro innanzi agli occhi dello spettatore (l’offerta della rosa nel finale del 1° atto di Francesca ne è il tipico esempio), ma lo crea anche a traverso le sole parole dei personaggi: «Un giorno tre fanciulli andarono sul mare» nel Grillo del focolare; «Cadeva bianca bianca la neve» in Conchita; «Vi ronzan l’api intorno ed è il lor miele dolce come i miei baci» in Melenis. Molti altri esempi potrebbero essere annoverati. E sia vasto l’affresco o contenuto il quadro, i colori sempre fremono sia sotto l’abbagliante ardore delle luci, sia nella cupa zona delle ombre. E sempre il paesaggio, la figura o il complesso denunciano un profondo amore per il mondo esterno e quello interiore. 3.2.6/4 *** La sensibilità pittorica dell’artista trova poi conferma nei poemi sinfonici (tra i quali può essere compresa anche la Cavalcata nella tempesta della Giulietta), che si risolvono quasi tutti in seducenti affreschi (Terra nativa, Serenata medioevale, Ballata eroica, Tra gli alberghi delle Dolomiti, Flauto notturno), quando non consistono addirittura in una trasposizione da un mezzo d’espressione ad un altro, come nei Quadri di Segantini. Dal sentimento, che l’artista coglie al suo primo irrompere, traggono origine le fertili linfe di un melos italianissimo e inconfondibile, ricco di ansie e di superamenti, legato al finito e tuttavia tendente all’Infinito. Nodi, viluppi, distorsioni, spasimi modali, conseguenti a cotesta speciale essenza melica, andranno però man mano dissolvendosi. E la parola assumerà un rilievo se non perfettamente dominante, certo spiccatamente scolpito. Giacché è singolare il fatto che l’esame critico sulla musica dello Zandonai si sia indugiato sul fattore sinfonico, mentre è nel verso, è nel verbo, ricreato dal sentimento dell’autore, che risiede la cellula generativa non soltanto della figura melica, ma di quella armonica e sinfonica. Il singolo vocabolo determina gli intervalli del melos, la sua accentuazione, le sue allusioni, così come il verso determina i nessi armonici, le pause, il periodare del sinfonismo; e non è raro il caso che parola e verso inducano talvolta l’autore a sacrificare l’intima geometria della strofe, così propizia alla ricettività dell’ascoltatore. Vasta la tavolozza del Nostro, comprendente oltre al dramma la vicenda comica e mistica. Ma il sorriso e la caricatura appaiono sovente soverchiati dall’onda del sentimento, mentre il misticismo ripiega dalla trascendenza all’immanenza etica. *** Melenis, Conchita, Francesca, Giulietta, Lucia! Ora esse sono discese tutte dal Convento del Beato Sante e vegliano – invisibili – presso il letto ove il Maestro giace, nell’ospedale di Trebbiantico. L’operazione si giudica ben riuscita, ma il paziente sprofonda in un pauroso abbattimento. I velivoli incursori tessono e ritessono la loro tela funerea. E alcuni giorni trascorrono, acutamente ansiosi per la compagna e la figliola del Maestro, per i pochi amici che, pur sfidando pericoli gravi, riescono ad avvicinarlo. La dura presenza dei tedeschi si appesantisce a misura che la sorte degli eventi bellici si delinea favorevole a Roma. Quattro giugno! La notizia esulta dalle radio, si propaga rapidamente, si diffonde dalla luce degli occhi. Ma le forze del Maestro declinano, si perdono. Cinque giugno. Un amico sacerdote, accorso al capezzale dell’infermo, gli comunica l’avvenuta liberazione di Roma. Zandonai, sollevandosi un poco, mormora: «Viva l’Italia!»; e dopo qualche attimo: «la buona». Ricade esausto. Alle 17,50 il generoso cuore trentino cessa di battere. La salma viene poi trasportata al cimitero di Mombaroccio, in attesa di raggiungere Sacco, secondo la precisa volontà testamentaria. Avvenuta alcuni mesi dopo la liberazione di Pesaro, la vedova e l’orfana risalgono a Villa S. Giuliano. Una squallida vista si offre loro: la casa danneggiata, profanata, depredata, occupata da gruppi di senza tetto segnati dalle sofferenze morali e materiali; il bosco abbattuto dalla scure, sconvolto dalla dinamite. Le due donne fuggono col cuore in pianto, col gelo nelle vene. Gli alberi non cantano più! Canterà il cuore di Vistilia, nel duetto finale del Bacio, oppur le pagine sono rimaste bianche e mute? È quel che tuttora s’ignora. 464 Giovanni Tebaldini, Ricordando Zandonai, «Il Mondo musicale», 6.5.1945 - p. 2, col. 2-3-4 3.2.6/5 La fine immatura e compianta dell’autore di Francesca da Rimini mi richiama alla memoria il mio primo incontro con lui al tempo del suo noviziato scolastico. Al Liceo Musicale Rossini di Pesaro, nel giugno del 1900, con Giovanni Sgambati faccio parte della Commissione esaminatrice. Sta dinanzi a noi una schiera di giovani dei quali Pietro Mascagni, Direttore del Liceo, a buon diritto si vanta. Purtroppo parecchi di quella schiera sono oggi scomparsi. Ricordo Adriano Ariani pianista valoroso, che il pubblico dell’Augusteo ha ripetutamente ammirato e che, dopo prolungato soggiorno nell’America del Nord, tornava insegnante alla scuola da dove era partito. Ricordo Primo Riccitelli, futuro autore dei Compagnacci. Tra i sopravvissuti, Balilla Pratella, per un periodo di tempo, spirito ribelle ma saldo e solido nelle sue ricerche ed evocazioni folcloristiche; Luigi Ferrari Trecate, anima ardente – ai suoi inizi, allora – sorretta dal puro ideale dell’arte che lo condusse dall’organo della Basilica Lauretana alla direzione del Conservatorio di Parma. Ai nominati si accompagnano il Marini di Ancona ed il Cirenei che a Roma tutti conoscono quale valoroso direttore della Banda dei Granatieri. Bella corona, come ognuno vede, da inorgoglire il paterno cuore di Colui che in quel momento, amorosamente, curava le sorti avvenire della propria famiglia scolastica. Eppure sin da quei giorni Pietro Mascagni – natura non burocratica certo, ma fervida ed animatrice – era già discusso ed insidiato dagli stessi che lo avevano chiamato a succedere allo sventurato Carlo Pedrotti, finito tragicamente in Adige. Uno per uno rivedo innanzi al tavolo i due giudici Sgambati e il sottoscritto, i sette candidati. Della bontà dell’insegnamento ben presto gli esaminatori si accorgono, in ispecie portando la loro attenzione sul trentino Riccardo Zandonai. Aveva appartenuto questi, prima che alla scuola di Mascagni, a quella di contrappunto dell’austero Cicognani. Due forze, in quella scuola, distanti in apparenza, ma pur vicine perché entrambi convergenti verso un unico fine: l’Arte nella sua più pura espressione. E l’Arte ebbe appunto nel discepolo Zandonai non un cultore ma un sacerdote consacrato e devoto. L’opera sua copiosissima lo attesta ampiamente. Direttore d’orchestra sicuro, energico ed animatore appassionato, ebbe momenti felicissimi anche come interprete delle opere altrui. E l’Italia musicale, che sa quale artista abbia perduto nello Zandonai, deve rimpiangere l’opera efficace e proficua di sì fervido ingegno creatore ed animatore, che – certamente come il di lui Maestro – recò lustro e decoro non effimeri al Liceo Musicale pesarese che si gloria del nome di Rossini. Passarono gli anni, circa quaranta, da quel giorno lontano che abbiamo rammentato. Lo Zandonai, affezionato a Pesaro, vi elesse stanza, riconducendosi verso San Bartolo, in una villa caratteristica, poco discosta dalla città. Quando nel 1940 il posto di direttore del Regio Conservatorio – non più Liceo – si rese vacante, parecchi temettero qualche sorpresa del genere di tante altre per le quali il defunto regime si rese noto anche nel campo di Euterpe. I ben pensanti auspicarono tosto la nomina, al posto rimasto libero, dello Zandonai. Ma egli non pareva troppo persuaso a sottomettersi a sì grave peso in un momento in cui la falange degli alunni era diventata sì esigua da contare in tutto appena ottanta allievi: dei quali una metà signorine pianiste senza avvenire. Un’orchestra di allievi anche ridotta in quel momento al Conservatorio di Pesaro sarebbe stato impossibile costituirla. Quali prospettive per domani, in siffatte condizioni? Ci scambiammo alcune lettere. Tornato a mia volta – dopo quaranta anni – all’ufficio di Commissario Ministeriale, lo esortai – anche se l’eredità sembrava dura – di non disertare il campo, di sacrificarsi per il bene e per l’avvenire della scuola che lo aveva educato. Gli feci rilevare i pericoli cui essa avrebbe potuto essere esposta se egli avesse insistito nel rifiuto. Alla fine cedette, e la sua nomina, in breve, divenne fatto compiuto. Due grandi esecuzioni di musica rossiniana – lo Stabat e la Messa – preparò a Pesaro nelle due stagioni estive del 1941-1942. Poi la bufera s’è scatenata anche sulla città adriatica. Chiuso il Conservatorio, sfrattato lo Zandonai dalla villa di San Bartolo, amico com’era dei frati minori – fra i quali aveva avuto diversi condiscepoli: Padre Guido della Verna e Padre Marabini di Forlì, entrambi organisti e compositori 3.2.6/6 esimii – fu accolto fraternamente nel Claustro di Montebaroccio. Ed ivi – fra la severa quiete francescana, ove tutto spira pax et bonum – l’autore della Francesca chiudeva la sua troppo breve e nobile esistenza. Parecchi dei più giovani di noi, e valorosi, ci hanno abbandonato in questi ultimi anni! Quale sciagura per l’Arte italiana, tanto più in questa tragica ora, privata in breve tempo dei suoi campioni più eletti e fattivi. Potrà la nostra generazione ripetere ancora il classico Post nubila Phoebus? Quod est in sotis! 465 Orione, Voce della memoria per Riccardo Zandonai, «Maschere», 1-18.6.1945 (con ritratto di Zandonai) Quella sera dell’estate 1919 vidi per la prima volta Zandonai. Ventisei anni: bisogna contarli sulle dita, per crederci. Passava sul mondo, per lui, una delle più belle ore della sua vita. Ne riparlavamo, pochi mesi prima ch’egli se ne andasse per sempre, nella sede romana dell’editore Ricordi. Gli piaceva che avessi testimoniato quell’ora e potessi ricordarla. Eravamo nella sua terra natia, a Rovereto. La guerra era finita da una decina di mesi. Cominciava l’armistizio che si chiamò pace: l’armistizio che doveva durare vent’anni e finire com’è finito e portarci dove siamo. Zandonai ritornava in patria dopo il lungo esilio iniziato quand’egli, italiano di passione e di convinzione, aveva abbandonato ancora giovanissimo l’Austria. Ritornava dopo quasi un ventennio, non più giovane ormai, ma già toccato dalla celebrità. E la patria lo accoglieva nel miglior modo possibile: facendogli trovare la sua più bella e più cara creatura, la sua «Francesca da Rimini». Dalla Scala di Milano erano venuti a Rovereto i cantanti, gli orchestrali, i coristi: un intero treno speciale, i cui bagagliai avevano portato sale e torri malatestiane e polentane, e velluti, sciamiti, broccatelli, armature, balestre, mangani e marmittoni per il fuoco greco. Ben altro fuoco greco, però, era passato su Rovereto in quegli anni; e il suo teatro n’era rimasto scheletrito. Allora il Genio militare italiano s’era messo all’opera per restaurarlo e in pochi giorni, con mezzi di guerra che in tempi pacifici si chiamano mezzi di fortuna, aveva fatto il suo dovere. Sedie e panche di legno grezzo in luogo delle poltrone. Leggii di legno bianco gocciolante di resina per l’orchestra. E alle porte dei palchetti, al posto degli usci, portiere “arrangiate” con le coperte da campo dei nostri soldati, di lana grigia. Per la sera della rappresentazione scesero a Rovereto, dai monti della zona, ufficiali e soldati in moltitudine. Io scendevo con un compagno dalle montagne di Val Terragnolo. Il comandante della compagnia s’era rassegnato a concederci il permesso, crollando il capo con ostentata commiserazione: era un capitano che non tollerava alcuna musica se non quella della fanfara del reggimento, come il primo re d’Italia. E Francesca cantò; cantarono Paolo, Gianciotto, Malatestino, Ostasio, Samaritana e il Notaio e il Giullare e Smaragdi e le noiose fanciulle di Francesca; cantarono e urlarono i malatestiani e, a suo tempo, il Parcitade. Zandonai appariva, sul podio, più fragile e minuto che mai. Era anche sofferente quella sera. Il suo viso non era pallido soltanto per l’ebbrezza della musica e l’emozione del trionfo. Dirigeva con un ramoscello strappato a una siepe e sfrondato. A un punto accorciò quel ramoscello con un gesto irato e se ne buttò alle spalle il pezzo superfluo. Al finale del secondo atto fu levato a braccia dagli armigeri. Lo rivediamo ancora oggi – e la sua scomparsa vela il ricordo d’una malinconia nuova – pencolante su quelle quadrate spalle di tenori e di bassi, affogato nella grande corona d’alloro che gli avevano appesa al collo. Fuori, nella notte serena, ci ritrovammo esitanti, trasognati. Dentro di noi persisteva, insieme con un esaltante presagio d’insonnia, l’eco delle melodie e delle parole udite: come se ci portassimo in petto un cuore innamorato. Eravamo molto giovani. Poi cominciò il nostro pellegrinaggio per tutti gli alberghi, le locande, le pensioni di Rovereto, alla ricerca d’un letto, un divano, una poltrona, una sedia, magari uno sgabello, o anche soltanto un angolo di pavimento ove riposare aspettando 3.2.6/7 l’autocarro che, al mattino, ci avrebbe riportati al reparto. Ricerca inutile. Un’ultima sedia di vimini era già contesa da un maestro sostituto, da un comprimario e da un sonatore d’oboe. Allora c’incamminammo a piedi. Portammo su per la montagna, sotto le stelle, il nostro cuore innamorato. Legammo passo a passo, sospiro a sospiro, per oltre dodici chilometri. Non era la prima prova d’amore che davamo all’arte, né sarebbe stata l’ultima. Giungemmo a Piazza di Terragnolo col primo barlume del giorno. Ci adagiammo insonni sul letto, fissi gli occhi al riquadro della finestra. E il cielo si faceva bianco, come tutti i giorni, come sempre. Ma per noi non era come sempre. Per noi il cielo, quel giorno, si faceva bianco come il mare che Francesca aveva additato a Paolo. E non poteva essere che così. 466 Marcello Cocco, Tutti i fiori di selva a Zandonai, «Il Momento», 9.7.1948 - p. 3, col. 3-4-5-6-7 (con foto di Zandonai) Una pausa senza fine pareva, un numero infinito di battute d’aspetto per la città rossiniana; unico suono, ma sgradevole e nemico, il passo ritmato e pesante di soldati stranieri. Abbandonata e deserta, Pesaro era una sola cassa armonica per i più macabri suoni senza colore. *** Il Conservatorio sul punto più alto, massiccio quadrato e freddo, non risuonava di vaghe melodie; un contrabasso dimenticato in un’aula, triste e goffo, aveva perduto l’anima. Solo Rossini, in alto, più grande di ogni potenza di fuoco e di morte, sorrideva tra due palme nel cortile circondato di bambù. Zandonai dalla selva del convento distante una cannonata, a sera, guardava la gran luce dei razzi lontani, cercava un punto remoto fra il mare e filari e filari di monti e colline e non capiva; a “Villa San Giuliano” bivaccavano gli ultimi tedeschi. Quando giunse il maestro con un pianoforte e molto amaro nel petto, il convento era pieno di profughi: nei corridoi, nel chiostro, nelle piccole celle una folla tormentata non cercava che un angolo riparato, sporco che fosse, per strappare alla strage vecchi e bambini; e avanzava la guerra, lenta e terribile come la lava che vomita un vulcano. Padre Sante, qualcosa di mezzo tra Padre Cristolfo [sic] e fra’ Galdino, aveva un gran da fare per l’arrivo del maestro; correva tra i campi, spariva nella selva, non si fermava più nelle case coloniche. «Molto lavoro Padre Sante?», azzardavano i contadini. «È arrivato il maestro Zandonai...» «E chi è?...» Ma il frate era già lontano nel bosco, e non rispondeva. Qualcuno più informato diceva che era «uno che suona la musica» e «importante l’ha da essere», aggiungeva un altro, «ché Padre Sante parla sempre de ’sto Zandonai...». Poi, dopo pochi giorni, tutti intorno al convento seppero ogni cosa di lui, di una sua opera che intendeva finire lassù e del suo male seppero, che lo consumava. *** Io andavo a trovarlo qualche volta ché a lui faceva bene parlare del Conservatorio. Gli portavo da Pesaro carta da musica e notizie della sua “Villa San Giuliano”; ma non sorrideva più; il gran male fisico e morale aveva sciupato la lucentezza del suo sguardo. Pure, in quella sua nuova ultima vita nell’eremo francescano, aveva trovato gli elementi per le sue calde immagini. «Stamattina nella selva ho trovato le prime viole...». Brek, il cane kocher [sic] bianco e marrone, gli leccava una mano; il maestro sorrideva un poco, poi continuava: «la sera, attorno a un fuoco enorme, discorro coi frati; mi raccontano la vita del Beato, di un lupo che faceva strage in queste campagne e che ammansito da un certo Padre Alberigo di Montefabbri, portava legna per il convento; di poche ciliege maturate nel mese di gennaio e di una rosa, dicevano, di una rosa rossa fiorita fra la neve sulla tomba del Beato cento anni dopo la sua morte». 3.2.6/8 Da Pesaro giungevano boati tremendi di mine tedesche, saltavano le nostre case, saltavano ponti e officine sotto i colpi alleati, arrivava lenta la guerra. Io guardavo il maestro... «ho trovato le prime viole...», aveva trovato le ultime viole. E mi piaceva pensare al rosso di quella rosa sbocciata sulla tomba del santo, fra tutta la neve di gennaio come a significare l’ardore in Cristo; nei secoli dei secoli. *** Poi, alla fine di maggio, quando si afflosciarono le ultime rose, Padre Sante, il viso scuro, entrò in tutti i crocchi di sfollati che parlavano di “Gotica” e rifugio. «Il maestro s’è aggravato, stasera lo portano a Trebbiantico per tentare l’operazione...». Quando al tramonto passò la macchina, io ero nel bivio per salutarlo ma non mi vide; accanto al guidatore, scheletrito, una fascia fino al mento, si allontanò senza sguardo. *** Lo riportammo pochi giorni dopo nella chiesa del convento. Padre Sante colse tutti i fiori che fanno nella selva, poi suonò la campana più stonata per dire il dolore di morte per la fine del cantore di mille armonie. Il primo sole di giugno avea bruciato i fiori dei pochi giardini e per trovare 2 rose girai tutte le campagne intorno. Il mattino dopo, a sciupare la semplicità campagnola degna del grande montanaro, vennero dalla città i capi della provincia, ma prima che visitassero la salma io avevo posto le 2 rose dalla parte del capo, poi mi allontanai nella selva. Il piccolo funerale fece le “coste” della selva, apparve e disparve tra i boschi, mentre il vento caldo portava a ondate le preci dei frati, e le campane nascoste fra i monti si rispondevano “lento” e dissonanti. 467 Vittoria Camozzini Canizza, Ricordo di Riccardo Zandonai, «La voce repubblicana», 6.11.1952 p. 3, col. 3-4-5-6 Nel quadro delle celebrazioni nazionali per Riccardo Zandonai, l’Ente autonomo del Comunale di Bologna organizzò due rappresentazioni dell’opera «I Cavalieri di Ekebù» di cui la prima andò in scena al Teatro Sociale di Trento, la sera del 16 ottobre scorso. Grandiose e commosse furono le onoranze tributate a questo Maestro, che ha onorato l’Italia e il Tempio di Euterpe portando una parola nuova all’opera, innalzata ad un livello solo da Lui raggiunto nella musica contemporanea. In un “maso” della borgata di Socco [sic] di Rovereto, nella Val Lagarina, nacque Riccardo Zandonai nel 1883, da umile famiglia, e di quella dignitosa umiltà Egli mai si spogliò né si vantò per posa. Piccolo e fragile il Suo corpo, quanto alta e forte la Sua fronte, come la cima delle Sue montagne. Diritto e fermo il Suo carattere. Le cantilene che zio Decimo traeva dalla chitarra, nelle “montanare” nostalgiche, destarono in Lui il genietto musicale. Ne tentò le corde ancor bambino e ne rimase incantato e incatenato. I clarini e gli ottoni Lo portarono, non ancora decenne, a comporre marce per la banda del paese, coretti, Ave Marie, canti. I violini Lo misero poi a contatto con le orchestre, così che Egli si sentì spalancare le porte del magico reame musicale, senza più bisogno di mediazione di strumento alcuno, perché ogni strumento già in Lui cantava per trasformare in musica di getto ogni dolore, ogni passione, ogni fiaba. A dodici anni ancora è l’istinto che Lo guida. Impara anche a conoscere il pianoforte, ed il maestro Gianferrari Lo accosta alle prime leggi dell’armonia, alle matematiche musicali. A quindici anni parte per Pesaro dove insegnava Mascagni, e dove nel 1940 Egli pure sarà chiamato per reggere la direzione di quel “Conservatorio” dedicato a Gioacchino Rossini, di cui Egli vorrà rinnovare la memoria, riesumando «La gazza ladra» e «Il Conte Ory». 3.2.6/9 Compie gli studi brillantemente e giunge al saggio finale di composizione con un poemetto sinfonico «Il ritorno di Ulisse»3 musicato su testo di Giovanni Pascoli, e cantato dalla soprano PoliRandaccio, allieva di canto del medesimo “Conservatorio”. Il Suo ingresso nell’arte è decisamente fissato. Più tardi, Egli farà Suo il “credo” di Riccardo Wagner, per dare all’opera “il dramma musicale” sognato e concepito dal grande teutone, ma per darcelo alitato da uno spirito essenzialmente italiano, che ne scolpisce inequivocabilmente la Sua inconfondibile personalità. Fu dura assai per Lui la salita. Nulla Gli fu donato. Ma tutto fu “conquistato”. Dopo gli studi era tornato al paese. Era “clarino” nella banda di Rovereto. Poi suonò nei “primi” violini delle orchestre sinfoniche. Lo si cercava per la Sua abilità di violinista. Rubava al sonno le ore per scrivere le Sue musiche, giacché per guadagnarsi un pane Egli doveva lavorare! Nel 1905 vince un premio di 400 corone con il poema sinfonico scritto per il concerto finale del Suoi studi. Scrive «La coppa del re» e «L’uccellin d’oro». Nel 1906 un grande «Te Deum» che viene eseguito la vigilia di Natale. Va a Milano. Conosce Arrigo Boito, che ne intuisce il valore, e Lo presenta a Ricordi, il quale, con quell’innato istinto, Lo invita a scrivere «Il Grillo del focolare», su favola di Dickens. Musica che aderisce al significato del suo titolo e va in scena al “Chiarella” di Torino nel 1908. Tre anni dopo è la volta di «Conchita», che riporta le Sue impressioni del viaggio in Spagna. Rappresentata al Dal Verme di Milano, consolida l’affermazione del Maestro. Poi «Melenis», tragedia greca [!?] che non ebbe fortuna. Gabriele D’Annunzio Lo tenne per la Sua «Francesca da Rimini». Tito Ricordi si accinge a dedurne il poema, assumendosi il difficilissimo compito di fungere da “trait d’union” fra i due Cigni di opposta natura, e sudando freddo prima di ottenere il “licet” dell’impaziente e dispotico Abruzzese. Viene rappresentata la sera del 19 febbraio al Teatro Regio di Torino. Pubblico, critici, esecutori ne escono ammaliati ed entusiasti, e da allora questa più significativa creatura del Maestro cammina da sola, nonostante gli intermezzi tenebrosi di due guerre, richiamandosi un pubblico sempre più numeroso non solo in Italia, ma anche all’estero, e nei Nuovi continenti. Immediatamente dopo la guerra, viene alla luce «La via della finestra» opera giocosa ed agreste, che veramente diffonde «l’odor del fieno» del cantore e termina con una “settima diminuita”. Dopo alcune rappresentazioni in Verona, il Maestro inizia i Suoi notturni vagabondaggi veronesi per gli amori di «Giulietta e Romeo». Gli amici di Verona Gli sono instancabili accompagnatori, Lo portano “alle Case del Capuleti” donde uscì la “Giulietta” «per cui tanto piansero i cuori gentili e i poeti cantarono». Sono parole di Carducci, che il Maestro trovava «di una suggestione miracolosa». L’alba, alla tomba di “Giulietta”, Lo sorprendeva pensoso ad ascoltare la “cavalcata” dell’infelice Romeo. Nel dicembre del 19214, al Costanzi di Roma, va in scena la «Giulietta e Romeo» che tutti trovano del tutto diversa da «Francesca». E certo omaggio superiore non poteva esserGli fatto, perché “del tutto diversa” doveva essere infatti. Quattro anni dopo, la Leggenda di Gosta [sic] Berling, dalle saghe di Belma Lagerlof [sic], Lo attrae ed ecco «I Cavalieri di Ekebù». La Svezia ne fa la Sua opera nazionale. Va in scena alla “Scala” di Milano nel 1925. Poi il «Giuliano» del 19335. E poi ancora la Spagna Lo chiama con un «Don Giovanni»6 da un dramma di Dumas. Nello stesso anno a Roma «La Farsa amorosa» che ne rivela lo spirito arguto e vivace. Ma il male lo minava. Probabilmente fin dal 1920-1921. Egli soffriva di disturbi della digestione. La Sua forte fibra Gli ha resistito tenacemente. Era un ammalato difficile, come tutti i grandi che vibrano dello spirito e ne vivono, e sono insofferenti di dover badare alle miserie del corpo. Ma la guerra, pure Lui travolse nella sua bestiale furia di rovina. Si voleva fare dell’Italia “terra bruciata”. Ci si ritrovava in pieno Medioevo. «Quel che avanza, il Vinilo barbuto – ridiscendendo dai castelli immuni – sparte – reliquie, cenere, deserto, – con l’alabarda». Il Maestro Lo pensava e ne gemeva. 3 [sic]: ma Odisseo. [sic]: ma febbraio 1922. 5 [sic]: ma 1928. 6 Ovvero Una partita. 4 3.2.6/10 È il 5 giugno 1944. In una piccola stanza della villa Guerini, trasformata in ospedale, a Trebbio Antico, presso Pesaro, il Maestro, circondato dai Suoi cari, agonizzava. Il bisturi non poté più operare un miracolo! Qualcuno Gli sussurrava qualche parola di speranza, di conforto per la decisa liberazione della Patria. Forse Egli si sovvenne della condanna a morte che il governo di Vienna Gli inflisse per il Suo sentimento e per la Sua diserzione nella guerra per la redenzione di Trento e Trieste. Forse la speranza Gli sorrise! Si spense. In silenzio, naturalmente, passò allora la Sua morte. Nemmeno il Suo corpo fu poi lasciato in pace. Venne più volte trasportato da un luogo all’altro. Finalmente è tornato alla Sua Terra. Il coro di Mendelssohn, cantato davanti al tumulo, l’esecuzione della Sua «Missa pro defunctis» a 4 voci, nel Duomo di Trento, hanno strappato lagrime a più d’uno spettatore. Chiesa, Sacello e Teatro erano trasformati in altrettante serre colme di fiori. Su di un apposito palchetto erano presenti alle cerimonie la vedova, signora Tarquinia, e la figlia Jolanda. Il Sindaco di Bologna, espressamente giunto per recare il saluto della città raffinata cultrice di musica, che Lo ebbe sommamente caro, le massime Autorità della Regione. Numerosissimi invitati. Un largo stuolo della popolazione di Trento, della Val Lagarina, della Val di Sole cui dedicò i Suoi deliziosi poemi sinfonici [!] «Primavera in Val di Sole». «I Cavalieri di Ekebù» tra poco risentiremo al “Comunale” di Bologna. La «Giulietta e Romeo» alla Fenice di Venezia. La “Scala”, che già tenne innumerevoli “esauriti” con «Francesca» speriamo vorrà ricordare Riccardo Zandonai, e che l’omaggio reso da Trento non sia l’isolato tributo che la patria rivolse a questo eletto Maestro, che è gloria italiana, la cui musica è musica italiana, che commuove ed unisce l’umanità. Di «Francesca da Rimini», la più personale e significativa delle Sue opere, diremo in seguito. 468 Alberto De Angelis, Poesia e patriottismo di Riccardo Zandonai - L’“arca di Noè” di Sacco Rovereto - «Vorrei saper cantare in faccia all’austriaco le note che sgorgano sempre così espressive dalla sua anima» disse Cesare Battisti, «Il Giornale d’Italia», 13.3.1954 - p. 3, col. 3-45-6-7 (con un ritratto fotografico di Zandonai del 1920) L’idea di ricordare la ricorrenza decennale della scomparsa di Riccardo Zandonai, diffusa da solleciti ammiratori del Maestro trentino, ha trovato subito larga eco di concordanze e di collaborazioni da parte del Sindacato Nazionale dei Musicisti, del Comune di Rovereto, del Comune e del Conservatorio di Pesaro (dove lo Zandonai studiò e di cui fu direttore) e di altre istituzioni musicali. Il Presidente della Repubblica ha concesso il suo alto patronato alle celebrazioni, cui sarà in tal modo assicurata la organicità. Si parla di un ciclo di rappresentazioni de «I Cavalieri di Ekebù» e della «Giulietta e Romeo» a Pesaro, durante la stagione estiva: ciclo che si aprirebbe con un discorso commemorativo del Maestro Franco Alfano. Opere del musicista verrebbero inoltre allestite dalla “Scala” di Milano, dal “Comunale” di Bologna e da altri teatri. Frattanto l’inizio della manifestazioni è avvenuto con una trasmissione, della sezione milanese della RAI, dell’opera postuma del Maestro: «Il bacio», in forma di oratorio, cioè senza scene, perché il Musicista lasciò l’opera incompiuta. Il soggetto era stato proposto allo Zandonai dall’amico ed ammiratore ferventissimo Nicola d’Atri, il quale era rimasto piacevolmente impressionato dalla lettura di una novella intitolata «Eugenia» dello scrittore svizzero Alfredo Keller. Ma il Maestro, e perché attraversava una crisi di sfiducia, e per le peggioranti condizioni di salute, e poi perché, ansioso per le sorti dell’Italia che s’avviava alla fatale sconfitta, esitò ad accogliere il suggerimento. Ma infine lo accettò; si stabilì che l’opera comica, in tre atti e di una gentile e briosa levità, si sarebbe intitolata «Il bacio». Arturo Rossato ebbe incarico di stendere il libretto; ma venuto a morte nel 1942, il compito fu trasferito ad Emidio Mucci. Il quale, trovandosi a Roma, con grandi difficoltà riusciva a far passare i poetici manoscritti attraverso la linea gotica, fino al convento del beato Sante in quel di Pesaro, dove il 3.2.6/11 musicista aveva trovato scampo ed asilo. Con riacceso estro, Zandonai aveva già delineato l’intera opera e ne aveva istrumentato i primi due atti. Di questi la RAI ha offerto l’audizione musicale. Volto massiccio e profondamente solcato fra le sopracciglia e ai lati della bocca tumida, naso prominente, solido mento, occhio cilestrino: dolce ma forte, Zandonai era lo specchio umano della natìa terra trentina. Parco di parole, nell’apparenza freddo, custodiva invece in fondo al cuore una grande bontà. Coi colleghi fraterno; soccorrevole con gli umili, i bisognosi, i sofferenti; onesto fino allo scrupolo; schivo da intrighi e da polemiche; egli suscitava ovunque simpatie ed amicizie. Verso Boito e Toscanini che, con «Il grillo del focolare», scoprirono in lui l’artista nuovo, ispirato e sapiente; verso Giulio e Tito Ricordi suoi unici e fedeli editori, mantenne una gratitudine costante. Predilesse i compaesani di Sacco di Rovereto, dove era nato nel 1883. Nella sua casa di campagna viveva con una vera arca di Noè: i cani, compagni nelle cacce alle beccacce e ai galli cedroni, e ai quali dette i nomi dei personaggi delle sue opere: “Giosta” (da «I Cavalieri di Ekebù») un mascalzone di puro sangue; “Lolita”, ricordo della Spagna ispiratrice di «Conchita»7; i gatti “Ekebù” e “Biancofiore” (personaggio della «Francesca da Rimini», ma soprannominato per la trascuratezza “Sporcofiore”); le galline “Giulietta” e “Romeo”; il maestoso gallo “conte Orloff”8 con la legittima sposa “Salomè”; la somarella sardegnola “Checca” ragliante comprimaria ne «La farsa amorosa». E i tordi, le gazze, i frusoni, i fringuelli, che gorgheggiavano nelle gabbie appese ai tronchi. Intorno alla casa alberi, fiori e piante di rose rarissime. Soleva dire: «Conosco le abitudini delle piante come quelle degli uomini e, in parola d’onore, preferisco le piante. Per ritrovare la fede che in qualche momento si oscura, e vincere la pena che dànno talvolta le mascherate del mondo, io prendo cani e fucile e me ne vado allegramente per i monti, in cerca d’aria, di fatica e di selvaggina. I cani sono sempre stati i miei migliori amici». Dello Zandonai, ardente patriota irredentista, Cesare Battisti aveva detto: «Vorrei saper cantare là, in faccia all’austriaco, le note che sgorgano sempre così espressive dall’anima dello Zandonai; quanto più fuoco della mia terra mi metterebbero in corpo!». Chiamato al servizio militare in Austria, non risponde all’appello. E il governo di Vienna, anche a motivo dell’offerta di venticinque lire fatta dal Maestro alla Società di Mutuo Soccorso dei rifugiati irredenti a Milano e di alcune sue patriottiche composizioni, giudica lo «Zandonai abbia portato aiuto alle forze belliche nemiche», e decreta la confisca dei suoi beni. Carolina, la mamma di Riccardo, una donnina piccola come il figlio e intelligente e pia ma di forte carattere, sarebbe stata felice se il figlio si fosse fatto prete. Non riuscì che a mantenere vivo in lui il sentimento religioso ed a fargli comporre qualche pezzo per la chiesa paesana. Il padre, bell’uomo, faceto, di schietti sentimenti italiani, era un semplice artigiano e suonava il bombardino nella civica banda di Sacco. Da lui Riccardo eredita l’amore per la musica; dallo zio Decimo apprende a suonar la chitarra. Come clarino è associato alla centenaria banda di Sacco: una vera banda... di capiscarichi, ma anche di patrioti. Come dimostrò nella prima guerra mondiale, quando s’insinuò in territorio austriaco, riuscendo a recuperare il tricolore che le era stato confiscato. Il Sindaco di Sacco, Giuseppe Grariola [sic], telegrafava le congratulazioni al suo amministrato ogni volta che andava a battesimo una nuova opera. Ma, dopo il successo di «Francesca», Zandonai non ricevette il telegramma. «Quel giovanotto – aveva esclamato il sindaco – mi scrive un’opera al mese. Se gli tengo dietro coi telegrammi, mando in malora il bilancio comunale». Quando Tito Ricordi si propose di ridurre la «Francesca» dannunziana a libretto per Zandonai ed entrò in trattative col Poeta, questi pretese venticinquemila lire oro e i diritti di vendita sul libretto. E malgrado le insistenze dell’editore, non mollò di un centesimo. Zandonai ebbe invece, come premio dell’opera, soltanto tremila lire. 7 8 Nessun personaggio operistico zandonaiano ha comunque nome Lolita. Personaggio del film La principessa Tarakanova, la cui colonna sonora Zandonai compose nel 1938. 3.2.6/12 Il primo atto venne composto dal Maestro d’un fiato. Dubitando che quella facilità potesse essere piuttosto faciloneria, fu sul punto di distruggerlo. Per fortuna un amico d’infanzia9 lo dissuase da quel suicidio artistico. La bella e valorosa soprano toscana Tarquinia Tarquini, già protagonista di «Conchita», avrebbe dovuto esserlo anche di «Francesca». «Ma la mia gola – ella racconta in un “Diario” – da quel giorno rifiutò di obbedirmi». Ed ella non fu più che la compagna devota ed amorosa del Maestro, che sposava nel 1916 con modestissimo rito, in una piccola chiesa di Firenze. Basandosi su ricordi personali, lettere e documenti faticosamente recuperati dopo che i tedeschi ebbero distrutta la villa pesarese del Maestro, la cognata di questo, Vittoria Bonajuti Tarquini, ha composto un libro che è una preziosa miniera di notizie e di aneddoti. Impossibile riassumerli e neppure condensare, dal «Diario», la dolorosa odissea del musicista che, già mortalmente malato, è scovato dai tedeschi nel convento del Beato Sante. Il tesoro delle partiture è in fretta sotterrato. E il Maestro, con la moglie e la figlia adottiva Jolanda, portando con sé sulle ginocchia soltanto la gabbia degli uccellini prediletti, ripara a Trebbio Antico. La malattia di fegato che cova in lui dall’infanzia gli produce sofferenze indicibili. Un chirurgo estirpa i calcoli ma il Maestro non s’illude: è la fine. Ed invia ai suoi cari estreme parole di commiato. Don Pietro Damiani, che gli impartisce i Sacramenti, domanda al morente: «V’interessa sapere che Roma è stata liberata?». «M’interessa». La lotta con la morte è tremenda. «Questo vecchio cuore di trentino – egli mormora – non vuol cedere». Ma alfine dovette arrendersi. Era il tramonto del 5 giugno 1944. L’anima del geniale compositore trasvolava nei cieli della sua gloria. Ma il martoriato corpo neppure allora poté trovare la sua pace. Tre volte, nel cimitero di Montebaroccio, fu dovuto cambiare di posto. Finalmente, sempre infuriando la guerra, la salma, nascosta in un furgoncino sotto un cumulo di verdure, fu trasportata al cimitero di Pesaro. Di dove soltanto nel 1947 venne trasferita al luogo del definitivo riposo, nel cimitero di Sacco Rovereto. 469 Renzo Rossellini, Zandonai - L’insegnamento di un grande operista, «Il Messaggero», 23.7.1958 p. 3, col. 1-2 (con una foto di Zandonai) In ritardo ed in debito, come tutti i musicisti ed i critici italiani, pago il mio tributo di ammirazione a Riccardo Zandonai, gli restituisco in misura purtroppo trascurabile il bene che egli ha fatto al teatro lirico, all’arte dei nostri giorni. Sono anni che questo desiderio mi preme dentro e mi sollecita la coscienza: non so neppur io perché tanto affetto, tanta devozione, tanta riconoscenza, che ho sempre sentito, abbiano atteso così lungo tempo a manifestarsi pubblicamente ed anche solennemente. La fatalità, forse, perché tutta la vita, l’opera ed infine la morte di Riccardo Zandonai furono dominate dalla fatalità. Ma voglio risparmiare al mio cuore la pena di dover rievocare una drammatica esistenza, i dolori disumani che travagliarono quel nostro caro e grande musicista, fino a farne un martire. La fede e l’amore per la sua opera, invece, qualsiasi cosa costino, debbono non più attendere e comunicare con tutti coloro che hanno la sensibilità per capire, l’entusiasmo per far loro una causa giusta. Aggiungo infine a questa premessa che una recente ingiuria lanciata da quattro barbari ignoranti contro quella geniale e mirabile opera che è la «Francesca da Rimini» mi ha dato la misura delle responsabilità che gravano su una intera classe dirigente, per la mancata affermazione della nostra arte e della nostra cultura nel mondo. Appunto, è così: tutti gli artisti italiani stanno ancora pagando le spese di una guerra sbagliata e di una sconfitta crudele. Solo il cinematografo ha saputo, con un eroico momento creativo che ha avuto fortuna, affermare il patrimonio spirituale ed ideale di un popolo infelice. Breve momento che già non è più, insieme ai suoi protagonisti. Panorama desolato di ingiustizie, di amarezze, di 9 Lino Leonardi. La minacciata distruzione riguardava comunque non l'intero atto ma solo la scena finale dell'arrivo di Paolo (v. Appendice III, nota 5). 3.2.6/13 miserie, di inutili sacrifici: questo noi vediamo ed è il risultato di un’altra e ben più atroce sconfitta, quella che può ascriversi agli errori di una classe dirigente presuntuosa e servile. Perché l’artista italiano è sempre stato solo, abbandonato e combattuto con subdole armi, quando più aveva bisogno di affettuose attenzioni, di onesti riconoscimenti. Confuso, sperduto, umiliato nel fasto di un baillamme di miliardi che sono stati spesi, incredibile a dirsi, per distruggere il patrimonio nazionale, per sostenere la vanità dei singoli, per sovvertire la gerarchia dei valori. Riccardo Zandonai è uno dei martiri di questa epoca dell’ingiustizia e se ancora sopravvive il suo nome, se la sua opera ogni tanto si affaccia in questo o in quel programma musicale, ciò significa che la forza interiore del suo genio può aver ragione del disordine, dell’incompetenza, della selva di pregiudizi ed infine della disonestà che presiedono la vita musicale italiana. Pensate su quale metro si è costretti a misurare la vitalità di un’opera, il valore di un compositore. Quale sia l’importanza del teatro di Riccardo Zandonai, prima delle ragioni sostanziali e della valutazione estetica che più oltre cercherò di sintetizzare, lo dimostrano i caratteristici segni che recano alcune opere recenti, considerate tra le più belle della produzione moderna. Questo vuol dire che il teatro di Zandonai o ha esercitato una decisiva influenza sul gusto e le idealità di taluni importanti compositori contemporanei o ha anticipato, ed è conquista altrettanto certa, il linguaggio dei nostri giorni. Di inconfondibile colore e sentimento zandonaiano sono numerose pagine del «Peter Grimes» di Britten, del «Troilo e Cressida» di Walton, esempi che tornano subito a mente. Ma tutta la discendenza verdiana dell’opera lirica, straniera ed italiana, deve qualcosa a Riccardo Zandonai ed è tributaria del suo teatro, il primo a trasfondere in moderno e animato linguaggio i valori insiti nella compiuta, e per ciò inimitabile, opera di Giuseppe Verdi. Come e perché il teatro di Zandonai sia direttamente discendente di quello verdiano, non è difficile a dirsi. Anzitutto per i suoi valori drammatici, per la profondità dei sentimenti, per l’alta tematica e le supreme aspirazioni dei personaggi. Poi per la vivida penetrazione della psicologia umana, nel conflitto dei grandi problemi che offrono eletta materia alla scena lirica ed alla poesia. L’atto, la scena, il quadro sono per taglio, equilibrio, misura e forza di contrasti, squisitamente verdiani; e verdiano è il canto nella sua mirabile estrinsecazione melodica o quando nel declamato sintetizza e scolpisce il significato delle azioni, la realtà dei caratteri. Quando si pensa, per esempio, al quarto atto di «Francesca da Rimini», al duetto tra Gianciotto e Malatestino, si potrebbe addirittura affermare qualcosa di più: che quelle pagine non sono soltanto di discendenza, ma hanno la statura verdiana. Dolce ricordo di «Francesca», pieno di commozione e pieno di amarezza. Un’opera che era arrivata alle soglie della popolarità, che cominciava ad essere nella coscienza di un pubblico enorme: a poco a poco abbandonata all’abulìa dei cantanti, alla indifferenza dei fiacchi, increduli e quasi sempre incompetenti reggitori dei teatri. Non sembra vero, non sembra possibile, tanto luminosa è la sua bellezza, ovvia la sua forza, consolante la sua poesia. Fresca e sognante opera con il suo arcaico tono di cantafavola, la malinconia morbida e sottile delle lunghe, trepide attese, i ciechi abbandoni amorosi, la solennità della vita e della morte. E la sua gamma vastissima di colori, il perfetto trapunto cromatico, la trasparenza dei suoni, infine il suo potere evocativo, sentimento e realtà di un mondo sofferto e vissuto. Caro ricordo di «Francesca», con le sue pagine tra le più belle del teatro musicale italiano. Dal culmine di quest’opera, che fu conquista luminosa di un grande musicista, lo sguardo spazia fino a lontani orizzonti, su paesaggi straordinari per varietà, dolcezza e stimolante poesia. Il quadro è perfetto: una pittura dell’italica terra, piena di commozione, entusiasta, ricca di palpiti, palpiti d’amore. Le ombre e le luci della Romagna, i tenui colori dell’Adriatico, il profumo dei campi, la irrequietezza dei colli, la opulenza della terra, la bianca distesa degli arenili, sono gli elementi stessi, una parte stessa del grande sogno, appassionato ed infelice, dei due protagonisti dell’opera. Tutto ciò è nella musica di Zandonai, vasta di richiami e prodigiosa per fantasia. Silenzioso e dolente, sdegnoso ma dignitoso, senza mai un gesto d’impazienza, con la generosità e la tolleranza tipica degli spiriti superiori, Riccardo Zandonai compì il suo infelice transito terreno circondato dall’amore, sostenuto dalla fedeltà di pochi amici, pochi ma tutti eletti. Dalle loro parole, dalla loro certezza attinse la forza per durare, per lavorare e per sognare. Di fronte ai crescenti suffragi di pubblico, come è sempre avvenuto nel nostro paese, ancora una volta si coalizzò la 3.2.6/14 banda degli intellettuali di professione: lenta e costante volontà di demolizione che non colpì soltanto l’opera del musicista, ma il nostro stesso patrimonio artistico, di cui essa era fulgida gemma. E vengono gli altri qui da noi, culla di tanta civiltà musicale, a mietere allori e lodi, negati a chi dette loro l’esempio e la coscienza. Una lezione che andrebbe lungamente meditata e dovrebbe fare arrossire molta gente. Una fervida preghiera rivolge un musicista italiano, che ha avuto nella sua intensa vita il piccolo ma non trascurabile merito della coerenza e della moderazione, a quei cantanti, a quegli artisti che per primi e con la più esplicita delle risoluzioni potrebbero imporre l’opera di Riccardo Zandonai: ossia con il gusto e la volontà di esserne interpreti. Quando penso che nel passato legarono il loro nome alla «Francesca da Rimini» Rosa Raisa e Miguel Fleta, Carmen Melis ed Angelo Minghetti, Montesanto e Maugeri, direttori d’orchestra come Guarnieri, Marinuzzi e Serafin, vuol dire che a chiedere la collaborazione dei migliori non si pretende da loro temerarie imprese, rinunzie e spirito di sacrificio, ma la buona volontà di osare il rilancio di nuovi e più significativi successi. Un piccolo gesto per una grande causa: l’arte si serve con umiltà e coraggio. 470 Renzo Rossellini, Caso di coscienza, «Il Messaggero», 30.10.1963 Quanta tristezza e disinganno e senso di intimo, spirituale disagio di fronte alle cose che ormai senza freno, misura ed equilibrio si vanno determinando nel mondo della musica ed in quello assai più delicato e fragile del teatro lirico. A mano a mano che ci arrivano le notizie sui programmi delle prossime o imminenti stagioni, per ciò che riguarda la doverosa presenza della produzione contemporanea, il quadro si fa cupo e fosco, se non addirittura, come accade qualche volta, orrido. Che cosa ci offende, ci impressiona, sollecita la nostra coscienza ad una chiara, precisa, ferma presa di posizione? È presto detto: l’invadenza sempre più massiccia, distruttrice, sibillina di una politica musicale di parte, che non concede nulla e nulla ammette a chi non vi si vuole conformare. La situazione peggiora di mese in mese, di ora in ora: è l’asservimento totale alla fazione, con una preconcetta rinunzia a qualsiasi sollecitazione della propria coscienza, per snobismo, o viltà, o ignoranza, o disfatta intellettuale o, peggio ancora, per cieca obbedienza agli ordini di scuderia di una politica la quale sa quello che si deve fare per sovvertire una società anche dal punto di vista culturale, ridurla in poltiglia, annientarla. Si scontano oggi, in una volta, le colpevoli tolleranze e gli errori che si sono accumulati in anni ed anni di cedimenti morali, di frodi alla legge, di mercimoni disgustosi. Io faccio colpa, si badi bene, alla stessa classe musicale italiana di non aver trovato quella saggia, moderatrice, operante unità che le avrebbe permesso – si è detto più volte, ma è stato come parlare al vento – di fronteggiare con dignità e piena difesa dei propri interessi, il progressivo, umiliante asservimento alla politica di tutte le cariche responsabili e direttive della vita musicale e sovrattutto teatrale italiana. È una pagina dolorosa della nostra recente storia, di cui troppi sono corresponsabili e per troppe cose di carattere particolaristico che hanno soffocato quelle di ordine generale, le quali si dovevano tenere in altro conto per ragioni di principio. Sta di fatto che nella politica di sottogoverno di cui i consigli comunali sono spesso la più deteriore espressione, si sono mercanteggiate cariche con soddisfazione illecita di tutti gli interessi di parte, ma non di quello che doveva essere primario e sacrosanto, ossia la competenza specifica del teatro e della musica. Si sono viste talune sovrintendenze – un posto di responsabilità che la legge aveva, anzi ha, con precisa ragione classificato, determinato, delimitato – finire, per certi baratti politici, nelle mani di gente totalmente sprovveduta di ogni cognizione, non dico specifica, ma appena appena generica. Che cosa, anzitutto, ci offende – parlo per bocca di molti altri – nel caos che si è determinato in una situazione patologicamente assurda e ridicola se non finisse, purtroppo, in tragedia? La distruzione, l’annientamento del nostro patrimonio musicale, dei valori della nostra tradizione, di un repertorio sul quale si era saggiamente costruito e si fondavano legittime speranze per un domani nobile, quanto nobile era stato il passato. Il pretesto nasce, esteriormente, da una utopistica concezione del “nuovo” e del “moderno”, due termini vuoti di ogni significato nel mondo dell’arte, 3.2.6/15 e quindi nel campo dell’estetica, eppure con abilità manovrati come mezzo di rottura in quella pavida società conformista e snobistica, senza idee, ignorante per la totale mancanza del senso della difesa che le è congeniale, a precisi interessi di parte. Gli obbiettivi finali di questa “rottura” sono scientificamente perseguiti da un imponente e bene organizzato esercito di attivisti. Racconto cose vecchie come il cucco: eppure la schiera degli ingenui e degli sciocchi, che si lascia prendere alla pania, cresce di giorno in giorno. Ogni oltraggio è ormai permesso, perché la impunità è garantita da un netto margine di sicurezza. A tanto siamo arrivati. È sconfitta, immeritata ed ingiusta, il fatto che operisti come Zandonai, Alfano, Respighi, Rocca, Wolf Ferrari, Montemezzi – cito a caso qualche nome e le omissioni sono moltissime – siano ignorati, o quasi, pervicacemente dai nostri teatri, con la conseguenza prima ed ineluttabile di averli fatti totalmente dimenticare fuori dai confini del nostro pese. Essi rappresentavano, con genio, la continuità della nostra storia per cui il teatro musicale italiano è stato grande e vittorioso nel mondo. Io arrossisco dalla vergogna, come musicista e come cittadino, quando mi giunge l’appello accorato della figlia di Franco Alfano, ad esempio, la quale mi ricorda che dalla morte di quel grande musicista, ossia da dieci anni, non più una sua opera è stata eseguita nei nostri teatri: parlo dell’autore di «Resurrezione», di «Sakuntala», di «Cirano di Bergerac». Scusate se è poco. E quando la vedova di Riccardo Zandonai sbalordita si domanda, con la sua purezza di vecchia gentildonna dai sentimenti dolci e soavi, la dignità decorosa e silenziosa della sua povertà, come è possibile che il fremito d’entusiasmo, la dedizione appassionata di migliaia e migliaia di spettatori, siano stati soffocati fino al punto da non più costituire una sacrosanta richiesta di far sopravvivere le opere di quel grande che le fu compagno. Parlo di opere come «Conchita», «Francesca da Rimini», «Giulietta e Romeo», «I cavalieri di Ekebù», «La farsa amorosa». La lista può diventare immensa, ma insieme alla lista cresce l’onta di ciò che si è distrutto, polverizzato, annientato. È così. Gente che come me ha vissuto nel teatro e per il teatro tutta una vita, ne conosce i valori significativi fino a quelli minuti, reconditi e segreti, sa, con aperto animo e piena coscienza, di quali cose autentiche si è nutrita la storia, si domanda per quale cinica determinazione non abbiano più diritto di cittadinanza opere di magica poesia come «La campana sommersa» e «Belfagor» di Respighi, o di sofferta, trepida, alta umanità come «Il Dibuk» e «Monte Ivnor» di Lodovico Rocca, o di civilissimo e delicatissimo linguaggio, quanto di elegante stilizzazione, come «Le donne curiose», «Il Campiello», «I quattro rusteghi», «La vedova scaltra» di Ermanno Wolf-Ferrari. Così come si è pronti e proni a raccattare certi processi di rivalutazione, di valutazione stessa, che si fanno altrove, si è invece pigri e sordi e ciechi di fronte al significato che potrebbero avere certe pagine nostre, come ad esempio quelle dell’«Amore dei tre Re» di Montemezzi. Per non dire della falsa, pretenziosa impostazione culturale che si vuol dare a certi avvenimenti, i quali sono di trascurabile significato o addirittura inutili o comunque annullati dalla insipienza delle esecuzioni. Ciò pensavo proprio in questi giorni, nel lecito accostamento che si doveva fare all’opera di ricostruzione stilistica, di trascrizione prudente e coscienziosa dell’«Orfeo» di Monteverdi, che costò anni di oculato, paziente, ponderato lavoro a Giacomo Benvenuti, sotto la guida geniale, il controllo rigoroso di Arturo Toscanini. So che cosa si suole rispondere dall’altra sponda, con sufficienza e disprezzo, a considerazioni come queste, dettate da una realtà ingiusta ed inaccettabile. L’ho detto altre volte e non c’è che da ripetere parole che non hanno bisogno di essere modificate di una virgola. Non si parla in termini nazionalistici, di cui si conosce molto bene, e se ne può anche tenere cattedra, l’angustia del pensiero e la grettezza dei sentimenti: ma guai ad ignorare, per altro verso, quelli che sono i valori rappresentativi di un popolo, quale la loro realtà e quindi la loro missione. Il profumo, la poesia, la qualità di certi sentimenti, l’apporto proficuo di ciò che scaturisce dall’immenso patrimonio spirituale di una secolare tradizione, sono elementi che concorrono in modo determinante al progresso ed alla civiltà. La distruzione di un patrimonio culturale conduce fatalmente, sulla distanza, alla perdita di tutte le prerogative di un popolo civile, ossia alla sua presenza operante nell’universo del pensiero e dell’arte: conduce, in una parola, alla perdita della libertà. Un’ora triste quella che si sta vivendo. Ma un’ora, forse l’ultima possibile, che incita alla riscossa, alla riunione, alla fratellanza di tutti coloro che, con legittimo sdegno, non vogliono sottostare al malcostume di cui siamo ormai quotidianamente spettatori, alle violenze di parte, alle 3.2.6/16 sopraffazioni. Ci vuole fermezza, determinazione, coraggio: bisogna sapere, conoscere, avere coscienza dei pericoli che stiamo correndo. Perché nel campo della cultura si tenta e si vuole la instaurazione di un regime, che sia operante di un altro regime, di quello che dovrebbe venire dopo. Se si trattasse di puro e semplice contrasto, opposizione dialettica, onesta concorrenza di questa o di quella corrente artistica, saremmo i primi, come è sempre stato, a difenderne la presenza e l’azione. Lo dice chi ha speso anche gran parte della sua vita a fare partecipi gli autori italiani, nella loro toccante varietà, ai benefici di quell’istituto che allevia in qualche modo la spesso triste e pesante vecchiaia dell’artista. Ma si tratta di altro, invece: lo si è detto e non sono cose che hanno bisogno di ulteriore illustrazione. Per questo occorre che, senza più compiacenze colpevoli, con azione unitaria e fermezza di propositi, si ristabilisca la gerarchia dei valori, l’ordine attraverso il quale, soltanto, si può proficuamente lavorare. 471 Renzo Rossellini, Il santo, «Il Messaggero», 15.6.1964 - p. 3, col. 1-2 Venti anni fa. In questi giorni, nella convulsa Roma liberata, durante quelle ore che furono, di tutta la nostra vita, le più vivide di speranza, mi giunse una notizia tanto dolorosa, che offuscò di colpo l’esultanza di avvenimenti attesi e sofferti. La radio nemica, dall’altra parte dell’Italia, aveva annunziato laconicamente la morte di Riccardo Zandonai. Non si seppe altro, se non quella notizia, così data. La pena non era grande soltanto per la perdita inattesa del musicista, ma anche perché noi, suoi amici fedeli, devoti, affettuosi sentivamo come una colpa di averlo lasciato solo. Nel momento in cui avrebbe avuto più bisogno di noi. L’attaccamento di Zandonai per la sua terra natale e per quella di adozione, Rovereto e Pesaro, fu semplicemente morboso: per quanti sforzi facemmo, nei giorni perigliosi della guerra e della invasione, di chiamarlo presso di noi, a Roma, di ripararlo dai troppi rischi a cui si esponeva, dalle possibili rappresaglie dei tedeschi contro un eroe dell’irredentismo quale era stato lui, condannato a morte insieme con Cesare Battisti, non ci fu nulla da fare. La piccola casa che era andato ad abitare sul Colle S. Bartolo, quello stupendo poggio che sembra equamente suddividere una campagna prorompente di vita, tra Romagna, Marche e Carpegna, era il suo Sacrario. Fuori di lì, sembrava perdere il gusto di tutto. Solo Rovereto, anzi la frazione di Sacco, dove era nato, poteva conciliarlo con altre cose a lui care. Zandonai non volle accogliere il pressante invito di venire fra noi. Più tardi, anche quando quei luoghi furono restituiti all’unità d’Italia, apprendemmo quale inaudito calvario aveva sofferto il nostro venerato maestro ed amico. L’ordine di sfollare, nel giro di ventiquattro ore, la sua villetta sul Colle S. Bartolo, giunse a Zandonai dal comando germanico in un momento straordinariamente delicato della sua vita. Dopo un silenzio durato alcuni anni, ricchi di ansiose e tumultuose ricerche, il maestro aveva cominciato la composizione della sua undicesima opera lirica: «Il bacio», tratta da una novella dello scrittore svizzero Gottifred [sic] Keller. Ma Arturo Rossato, collaboratore fedele di Zandonai, era morto senza aver potuto condurre a termine la stesura del libretto. A questo provvide, con animo nobilissimo e paziente cura, Emidio Mucci, ridonando allo sconvolto cuore del musicista speranza e fiducia. Gli assalti di un male atroce, atroce anche per la violenza dei dolori fisici, che avevano tormentato la giovinezza di Zandonai, si andavano ora susseguendo ad un ritmo che non dava requie né al lavoro né al riposo del musicista. Zandonai, la diletta sua compagna, la figlia adottiva, in tenera età, dovettero su due piedi abbandonare la casa e tutto il patrimonio di ricordi, di manoscritti, di cose sacre alla vita umana, che ivi si era accumulato. Li accolse un umile convento posto sulle balze appenniniche della Carpegna: i fraticelli fecero di tutto per rendere meno disagevole, in qualche modo accogliente, l’improvvisato rifugio del grande musicista italiano. E lì Zandonai, guardando la vallata sottostante della sua terra d’elezione, lo stesso Colle S. Bartolo che forse credeva qualche volta di individuare ai limiti della linea luccicante e filiforme del mare, all’orizzonte, riprese, anche, coraggiosamente a lavorare. Ma gli attacchi del male si susseguirono incalzanti, sempre più dolorosi, sempre più gravi ed insopportabili. Fu da lui presa una decisione penosa ma ineluttabile: di sottoporsi ad una delicata operazione chirurgica. L’ospedale di Pesaro era anch’esso “sfollato” a 3.2.6/17 causa dei bombardamenti aerei, dei danni subiti, delle necessità di casermaggio ed ausiliarie dell’esercito germanico. Era stato trasformato in ospedale da campo, alla meglio, per poter provvedere, comunque, alle necessità dolorosissime di una popolazione tartassata, ammalata, grondante sangue, ferita a morte. Ivi fu trasportato, con fatica inaudita per le condizioni del malato e quelle altrettanto precarie di un primitivo mezzo di trasporto, l’amato nostro maestro. All’intervento chirurgico provvide, con trepido cuore, il direttore dell’ospedale di Pesaro, amico fedelissimo del musicista. Ma lui, stroncato dalle sofferenze, non ebbe la forza di sopravvivere: e ci lasciò. Le sue ultime parole, colte dai pochi che, chini sul suo letto di dolore, cercavano di interpretare il suo affannoso respiro, furono di augurio per l’Italia e sgorgarono dalla sola cosa che sembrava averlo per un attimo lenito: la notizia della liberazione di Roma. Venti anni sono passati: ed io ho vissuto nel culto della sua memoria e del suo retaggio spirituale. Ne sono fiero e la mia fedeltà placa, da un lato, la mia coscienza, sostiene, dall’altro, la battaglia che conduco, ormai solo, per la verità, la giustizia e la musica italiana. Sarà in tal modo finché avrò vita e le ragioni sono infinite, inesauribili. Ma a Zandonai guardo, anche, con religioso trasporto di amore, di riconoscenza, di insaziabile devozione: egli era un santo e, come si fa coi santi, ne venero la memoria. La sua bontà fu evangelica, il suo altruismo caritatevolmente cristiano, la sua modestia ed umiltà intrepide, come quelle dei missionari che hanno votato la loro vita ai dolori umani ed alla gloria di Dio. Dalla sua bocca non uscì mai una parola che non fosse di rispetto, di tolleranza, di perdono, di slancio generoso per tutti, tutti, tutti, anche per quelli che lo offesero nella sua sacra concezione dell’arte e del servire, con la musica, l’umana società. Attraverso l’offerta delle sue sofferenze, che furono atroci e lunghe durante tutta la vita, cercò di essere degno della misteriosa volontà del Signore. Quando Zandonai veniva da Pesaro a Roma e ci incontravamo nella casa di Nicola D’Atri, che fu il suo amico numero uno, il suo consigliere, le ore trascorrevano quiete e piacevoli, rasserenate dal reciproco rispetto, dalla sollecitudine attenta e calorosa con cui ciascuno di noi cercava di essere in qualche modo utile all’altro. L’insegnamento che scaturiva al contatto di uomini di così meraviglioso animo e grandezza morale, era in ogni senso prezioso. Da loro ho appreso alcune virtù che, tanto sono rare ormai, non sembrano più umane: la moderazione, la tolleranza, la fedeltà. La fedeltà che nasce dall’amicizia e dall’affetto, senza dubbio, ma si sublima negli ideali. Senza fedeltà ai propri ideali, non si può essere né uomini di coscienza, né artisti. L’oblìo delle opere di Riccardo Zandonai, dei suoi meriti di grande italiano, è un’onta che ricade sulla cultura del nostro paese ed io non voglio condividere una simile responsabilità. Per questo elevo la mia protesta a voce alta, come posso, come mi consentono, ossia, le mie deboli forze. L’ho sempre fatto: lo seguiterò a fare, perché so qual è il retaggio della sua musica, del suo teatro. Di essere presente nella coscienza dei musicisti italiani, di coloro che sentono la poesia di essere dei “musicisti italiani”, ossia gli eredi, i propugnatori, i continuatori di una tradizione dove i valori umani sono al primo posto, la semplicità, la chiarezza, il sentimento lirico, la virtù del canto, la vocazione popolare, gli inconfondibili attributi di un nostro teatro. Questo da «Francesca da Rimini» ai «Cavalieri di Ekebù», da «Conchita» e «Giulietta e Romeo» alla «Farsa amorosa», seppe indicarci il solo musicista di autentica discendenza verdiana che la storia del teatro musicale italiano contemporaneo può vantare di avere avuto. L’oblìo delle opere di Riccardo Zandonai si giustifica in un solo modo: con il fallimento totale, clamoroso e fraudolento della politica musicale attuata in Italia. La poesia dell’Italia, non come espressione o sentimenti soverchiatori, dettati da una retriva concezione nazionalistica, ma come afflato spirituale, storica realtà di un operante pensiero, egli l’aveva nel sangue, da quando fanciullo errava in cerca di emozioni, forti e saporite, sugli aspri colli e gli arditi picchi del suo Trentino. Figlio di umile gente contadina, così com’era stato il più grande operista italiano, poverissimo: grazie alla generosità di pochi amici che si erano consorziati per permettergli di studiare – pagina nobilissima scritta con un inchiostro che non esiste più – Zandonai era andato a Pesaro dove Mascagni teneva cattedra, allora, nel Liceo Musicale Rossini. È di quei tempi una umilissima sua pagina, che s’intitola umilissimamente: «Ave Maria». Bella quanto la più bella delle melodie belliniane. Così cominciò la sua carriera di musicista italiano. E per essere italiano, per soffrire la passione dell’Italia, per viverla fino in fondo, fu insieme coi suoi fratelli 3.2.6/18 irredenti, che si batterono per la libertà della propria terra: fu condannato a morte, insieme con Cesare Battisti. Lo ricordo nel parco ombroso della sua villetta sul Colle S. Bartolo, intitolata a “Giuliano l’ospitaliero”. Ero accanto a lui, perché mi volle accanto a lui, quando accettò di dirigere quel Conservatorio Rossini che lo aveva avuto irrequieto e geniale alunno. Lo ricordo nella sua pace a contatto con la natura, che io cercavo di non turbare, tenendomi discretamente lontano da lui. Gli uccelli gli facevano festa impazzendo in gioiosi, assordanti gridii: e lui rispondeva come parlasse a personaggi umani. Intorno gli si affollavano le innumerevoli creature che egli prediligeva: i suoi cani, il suo gatto, la chioccia, i pulcini e tanti altri animaletti da cortile. Sentivo la sua semplicità francescana, la purezza del suo animo, l’amore che traboccava dal suo cuore. Nei suoi occhi acuti, intelligenti, contemplativi, si stemperava una malinconia che sembrava, in quel momento, non avere ragione d’essere: eppure è fatale in coloro che soffrono per noi, per cercare di farci migliori, per volerci dare quel che a loro sembra sempre poco averci dato. Venti anni: ma è come fosse di ieri la tua dipartita, maestro caro. Ed alla pena del ricordo, si unisce la pena di non poter fare nulla per sottrarre dall’oblìo la tua opera: cosa che offende, più ancora della tua memoria, la verità e la giustizia. 472 Renzo Rossellini, Poesia di un’amicizia, «Il Messaggero», 19.7.1965 - p. 3, col. 1-2-3 Nel 1927 andammo a cercare una casa a Riccione per passarvi l’estate. Già l’anno prima avevamo trascorso su quella spiaggia tre mesi piacevoli. Ci piacquero molto quel lembo di terra, la campagna, le colline che sono ai limiti tra la Romagna e le Marche. Mio padre si innamorò di Gradara, di Fanano e vi dedicò alcune pagine della sua calorosa poesia. Io mi sentii pervaso da una curiosa sensazione: quella natura, quei paesaggi, quell’aria, quel mare stimolavano in me, quasi morbosamente, il gusto di una musica che era stata scritta in quei luoghi, per un dramma di quei luoghi. Parlo della «Francesca da Rimini» di Riccardo Zandonai. Con l’entusiasmo dei giovani, andavo pazzo per poter conoscere l’autore di quell’opera e ne cercavo una propizia occasione. Venne con noi in gita a Riccione il direttore della succursale romana della Casa Ricordi, il giovane, brillante, intelligente avvocato Raffaele, con il quale già da due anni, nonostante io ne avessi soltanto diciannove, avevo rapporti editoriali. Da Riccione l’amico Raffaele telefonò a Pesaro, dove abitava Zandonai, e il maestro, affabile e ospitale come era, fu subito lieto di darci udienza. Conoscendolo attraverso la musica, mi immaginavo Zandonai affascinante: conosciutolo di persona lo trovai, sotto altro aspetto, due volte più affascinante. Egli era piccolo di statura, goffo e impacciato nei movimenti, aveva una grossa testa, sproporzionata per il suo corpo: ma la spiritualità di quel volto, il lampo e l’acutezza di quegli occhi, l’intelligenza scritta sulla fronte, avevano un potere di suggestione straordinario. A questo si aggiungeva la forza quasi aggressiva della sua personalità: temperata da una modestia e una semplicità del tratto, anch’esse cattivanti. Alla modestia dell’uomo si allineava la modestia della sua dimora: una piccola, anonima casa, sperduta in una piccola, anonima via di una città di provincia. Uno “studio” e un salotto minuscoli, oltre che arredati senza alcuna ricercatezza, infine un piccolo pianoforte verticale, strumento di lavoro invero non all’altezza della fama e dell’estro del musicista. Quella casa, lo imparai dipoi, era rivelatrice dell’animo di Zandonai: un animo nobilissimo nel quale presiedevano la fedeltà, l’amicizia, la riconoscenza e la poesia dei ricordi. *** Zandonai era andato giovinetto a Pesaro per studiare alla scuola di Pietro Mascagni. Poverissimo, di famiglia contadina trentina, aveva trovato appoggio presso una modesta famiglia pesarese che gli aveva locato una stanza della propria casa. Questa umile gente di provincia amò quel giovane, sperduto musicista trentino e lo tenne come un figlio, [ed egli] venerò la memoria di coloro che gli avevano fatto sentire, in tempi penosi, miseri e difficili, il calore di una famiglia. Non ebbe il coraggio di staccarsi, divenuto famoso e favorito dal successo, dalla povera casa dove era cresciuto musicista, dalla stessa città che, con amore e generosità, lo aveva ospitato. Ci fu un momento, tra gli anni quindici ed i trenta del nostro secolo, che si guardò a Zandonai come 3.2.6/19 all’erede legittimo della tradizione del grande melodramma italiano: fu personalità dominante e dominatrice del nostro mondo musicale. Ma l’animo di Zandonai, il suo modo di vivere, rimasero quelli umili e semplici della sua origine contadina. Solo negli ultimi anni della sua esistenza si permise un piccolo lusso, che quasi non riuscì a godere: si trasferì in una villetta sull’ameno, armonioso, ombroso e pittoresco Colle San Bartolo, ancor più restìo ai contatti mondani e professionali, ancor più semplice nel suo appassionato divagare intorno alla suggestiva lezione della natura. Già raccontai altra volta come quell’estremo rifugio gli fu sottratto dal tedesco invasore, che lo distrusse. Ai tempi della mia prima visita, Zandonai stava componendo l’opera «Giuliano l’ospitaliero» che fu rappresentata, l’anno successivo, al S. Carlo di Napoli e all’Opera di Roma. Le esperienze contano molto nella vita ed io, quella volta, mi arricchii di una singolare cognizione. Vidi il manoscritto dell’opera, che era straordinariamente esplicativo del modo di sentire e di impostare sinteticamente una partitura. Zandonai suonava con scioltezza il piano ed accennava la parte del canto con la sua voce rauca, ma molto espressiva. Io girai le pagine dello spartito e mi sentii fiero di quel compito, che adempii non senza trepidazione: mi sembrava che Zandonai giudicasse la mia preparazione musicale dalla tempestività dei miei movimenti. L’audizione durò a lungo e ne uscii, per quel poco che avevo fatto, madido di sudore ma intimamente soddisfatto. La mia timidezza e la soggezione del personaggio non mi permisero di articolare una frase di compiacimento e di ammirazione: mi sarei preso a schiaffi per questo e credetti che la sospirata occasione di avere incontrato il musicista si fosse risolta in modo meschino per me. Invece, da quell’incontro, nacque un’amicizia che si consolidò poco alla volta, si fece intensa e bella per la schiettezza dei sentimenti che la ispirarono ed ebbe, infine, peso determinante nella mia vita. *** Mio padre morì due mesi dopo il mio primo contatto, come compositore, con il pubblico dell’Augusteo. Io avevo appena compiuto ventitre anni ed il mio interprete, il geniale, indimenticabile Willy Ferrero, non ne aveva ancora ventiquattro: non facevamo, insomma, quarantacinque anni in due. Sono pago di molte poche cose della mia vita; addirittura quasi di niente: ma di aver dato la soddisfazione a mio padre di avermi visto al primo traguardo importante della mia attività di musicista, questo sì, ancor oggi placa l’animo mio. Dovetti lasciare Roma, travolto dagli avvenimenti conseguenti la repentina scomparsa di un uomo impegnato in tante imprese onerose, disfatto moralmente e malato di nervi fino ai limiti dell’annientamento. In una cittadina del nord dove, a trecento lire al mese, dicendo grazie alla Provvidenza, andai a dirigere il Liceo Musicale, ritentai dal niente la mia ricostruzione spirituale. La quale fu lunga, penosa e incerta, dopo essermi sembrata, per troppe volte, impossibile. E finalmente, a capo di non so più quanto tempo, riuscii a condurre a termine un lavoro sinfonico, che dedicai alla memoria di mio padre. Che cosa potesse valere, non sapevo: era quasi orbitassi nel vuoto. Tanti sospiri sparsi su quelle pagine e la volontà di distruggerle mi sembrò ineluttabile. Debbo alla mia dolce madre, la cui cara memoria ancora mi sorregge oggi, se ebbi la forza, come estremo tentativo, di andare a trovare Zandonai, di ascoltare il suo consiglio, di sollecitare il suo giudizio. Partii una notte nebbiosa, rannicchiato nell’angolo di uno squallido scompartimento di terza classe, con il mio fagottello di musica sotto il braccio, il quale mi pesava come fosse di piombo. Ma a Pesaro, l’indomani mattina, il sole splendeva e salii con un trepido affanno, che era già speranza, l’erta del Colle S. Bartolo. Dopo l’audizione, sciolsi, tra le braccia di Zandonai, tutto il pianto che avevo trattenuto per mesi dentro di me. E ritornai umano. Al pubblico dell’Augusteo, dell’Adriano – le sedi successive dell’orchestra di S. Cecilia – allora il più qualificato d’Italia, Zandonai fece conoscere alcuni dei miei lavori, che poi portò nei suoi giri direttoriali in varie città del nostro Paese, e all’estero. La consuetudine di vederci e d’incontrarci divenne costante, specie in casa di Nicola D’Atri, a Roma, nella città dove ero tornato ad abitare. Ora si era nell’anno iniziale, corrusco ed orrido, della seconda guerra mondiale. Zandonai aveva vissuto fino allora nel suo eremo pesarese, rifiutando ogni offerta che lo potesse portare stabilmente lontano dal suo luogo di elezione. Aveva respinto con ostinazione la direzione dei principali Conservatori d’Italia e sembrava con l’animo molto lontano da qualsiasi compromesso che potesse limitare la sua libertà personale, alla quale teneva sopra a tutte le cose. Ma un giorno la stessa sua 3.2.6/20 Pesaro venne a chiedergli un sacrificio ed un gesto di affettuosa solidarietà: di assumere la direzione del Conservatorio Rossini, la scuola dove egli si era laureato musicista ed alla quale la città fieramente teneva. Il Conservatorio Rossini ha una lunga, gloriosa storia: sorto per volontà e legato del grande Gioacchino, fu nel corso dei vari lustri, per la fama dei suoi docenti, il richiamo che esercitò su giovani di particolare talento, uno dei centri musicali più importanti non solo d’Italia. E Zandonai non seppe resistere, dopo molta riflessione e una tormentosa incertezza che durò vari mesi, alla pressante richiesta di tutta una popolazione. Rivelo ora a distanza di venticinque anni, ed il tempo trascorso credo che mi consenta di farlo, che l’accettazione di Zandonai fu quasi subordinata ad una condizione: di avere me al suo fianco, come suo sostituto nella carica direttiva e titolare della cattedra di composizione. *** Troppo dovevo a quell’uomo e tali erano, per esso, la mia dedizione e la mia fedeltà, che non potei rifiutare. Chi mi conosce, può credermi: fu per me sacrificio, e le infinite ragioni non è luogo di dire, assai grande e non garantii al maestro di avere l’animo di poterlo sopportare. Per un lungo anno, mentre la guerra infieriva e faceva sentire il suo peso sulle popolazioni civili che, forse, per una volta nella storia, furono tutte in prima linea insieme alle truppe combattenti, portai a compimento la mia missione. Ricordo: partivo da Roma la sera con un treno che mi conduceva a Falconara Marittima, dove attendevo la coincidenza per arrivare fino a Pesaro. Ma era una coincidenza che non coincideva mai: a volte si aspettava due, tre, quattro ore sul marciapiede della stazione di Falconara e arrivavo stremato a Pesaro, intirizzito, alle prime luci dell’alba. Il ritorno a Roma era altrettanto arduo e problematico: dalla stazione mi portavo direttamente al «Messaggero», dove a mezzanotte e mezzo cominciavo il mio orario di lavoro. Fu in quell’anno di lotta, di sacrifici, di duro impegno e di defaticante vita, che l’amicizia tra Zandonai e me si consacrò dei sentimenti più belli che un animo umano può concepire: e divenne poesia. Poi mi ammalai e fui costretto alla rinunzia, con disinganno del maestro, che confinò con l’amarezza. L’invasione ci separò definitivamente ed io appresi dalla flebile voce di una radio nemica, qualche mese dopo, come ho raccontato altra volta, l’immatura, drammatica fine del grande musico, uno dei cuori più nobili dell’italica terra e che troppi immemori hanno indegnamente dimenticato. Ora, ogni tanto, rileggo le sue lettere: mi aiutano a vivere ed a volgere indifferente le spalle a coloro che non perdonano la mia fedeltà alla musica italiana, al melodramma italiano, alla tradizione di cui sono figlio, alla mia volontà restauratrice di certi valori, forte, a volte, del consenso popolare. Non per me, ma per la verità strenuamente difesa in nome del sentimento umano. 473 Renzo Rossellini, Datemi pace, «Il Messaggero», 29.7.1970 - p. 3, col. 1-2-3 Con grande sorpresa ho visto che una casa grammofonica di primaria importanza ha edito un disco con larghi estratti dell’opera Francesca da Rimini di Zandonai. La cosa mi è sembrata di lieto auspicio, dopo aver perduto, ormai, la speranza che il più bel repertorio operistico italiano, postverdiano e post-pucciniano, si è frantumato e disperso. Anche se si tratta di un disco che parzialmente riproduce – ed anche senza acume vero, nella selezione dei brani – il capolavoro di Zandonai e D’Annunzio, il fatto sembra assumere un significato non disdegnevole. E se fosse, come da più parti mi si dice e specie nel mercato americano, che è divenuto il più grande del mondo nel campo musicale, il segno, pur piccolo per ora, di un rilancio che deve, nei prossimi anni, fatalmente venire, ancora maggiore sarebbe in me – antico ed inascoltato difensore di un certo teatro lirico italiano – la soddisfazione. *** Non voglio farmi prendere la mano dall’entusiasmo e preferisco, anzi, guardare i fatti con grande prudenza. Ma la cosa nella sua palpabilità, ossia il disco della Francesca, già m’induce, di per sé, come avvenimento realizzato, a riflessioni e sentimenti che tra di loro si armonizzano. Ho riascoltato la musica (che, tuttavia, conosco a memoria; ho riletto il testo): dal primo contatto con quest’opera, il quale risale a circa mezzo secolo fa, nulla è mutato quanto a suggestioni, a poesia, a 3.2.6/21 stati d’animo di trascinante commozione. L’interrogativo lecito, che mi sono posto tante volte, ritorna a martellarmi le tempie. Perché Francesca così difficilmente sopravvive nel mondo di oggi, perché con gli anni la sua popolarità si è ristretta, invece di allargarsi, perché, infine, è rimasta nell’ambito del pubblico italiano, non ha aderito al gusto di quel pubblico internazionale pur tanto fedele ed amante del nostro repertorio? Le risposte sono varie, anche se non giustificano, in nessun modo, certi lati dell’oblio e del disinteresse che risalgono a responsabilità precise. Ma di queste parlerò altra volta. Intanto una prima considerazione si può fare: i due grandi amori tipici della storia sono quelli di Romeo e Giulietta e di Paolo e Francesca. L’uno cantato da Shakespeare, l’altro da Dante. Ebbene la poesia dantesca, anche se ha toccato i vertici della bellezza totale, assoluta, non ha sopravanzato in popolarità il racconto scespiriano. Nella tragedia di D’Annunzio, che prende lo spunto proprio dal canto dantesco (ossia è stato esso ad averle offerto la tematica), certo preziosismo verbale, il clima ricostruito a cesello di un mondo delicatissimo, sognante e forte nello stesso tempo, prerinascimentale, la tessitura narrativa e la cadenza poetica – così nostrana e così personalizzata – rimangono incomprensibili ai paesi di altra tradizione (per esempio nordici, di una sensualità opposta alla nostra) e più che mai a quelli senza antica tradizione, ossia senza storia di passioni umane. Se D’Annunzio fosse traducibile nella sua intraducibile essenza poetica, rimarrebbe incomprensibile, per esempio, al popolo americano. Ma rimanendo nella musica, che è linguaggio universale, quindi alla portata di tutti, fatti così controversi e stranamente compressi rispetto alla grandezza ed alla bellezza del loro contenuto, certamente non mancano. Si prenda, ad esempio, Bruckner, che nonostante talune aperture recentissime, è rimasto autore di marca teutonica, adatto e sollecitante il gusto teutonico. E Pfitzner, autore del mirabile «Palestrina», opera rappresentata in tutti i teatri germanici, ma totalmente, o quasi, sconosciuta al pubblico internazionale. Così si può dire di Lortzing, il cui teatro fa “esauriti” in ogni sala teatrale tedesca, ma rimane fenomeno puramente locale, senza risonanza alcuna extra-paesana. In Francia, altro esempio, è saldamente in repertorio l’opera «Mireille» di Gounod, ignota a qualsiasi pubblico straniero. Altro fenomeno, questa volta più ancora inesplicabile e sconcertante, è quello che riguarda Ildebrando Pizzetti ed in particolare il suo teatro, che è tra le più alte e significanti espressioni d’arte del nostro secolo. Al di fuori dell’Italia (e di una “mosca bianca”: il Teatro Colon di Buenos Aires), l’opera di Pizzetti è ignota al mondo intero. Se dài un’occhiata ai cataloghi della discografia, rimani atterrito: vi leggi nomi di autori e titoli di opere che sono nulla e rimarranno nel nulla. Invano vi ricercherai quelli di potentissimi operisti, sui quali si può trovare il consenso generale ad ogni livello ed in qualsiasi area geografica. Aggiungo a questo massiccio “muro del pianto” che l’opera «Adriana Lécouvreur» solo nel 1971 arriverà in Francia, ossia dopo sessantadue anni di rigogliosa vita e dopo essere stata il cavallo di battaglia, a titolo esemplificativo, come modello, ossia, delle più belle e famose voci del mondo. C’è tanta parte di mistero, in tutto questo, che è inutile ragionare con il metro del buonsenso. Torno alla mia cara «Francesca»; al disco “sorpresa” che mi è caro anche perché reca la firma di un’orchestra ormai legata al mio nome e di due interpreti che per varie ragioni entrano nel sacrario dell’animo mio: Magda Olivero, creatrice indimenticabile del mio primo lavoro operistico, e Mario Del Monaco. Quelli di ora sono i soliti giorni di lontananza che vivo annualmente: mi racchiudo in me, penso con tale intensità fino a sentirne lo spasimo, i ricordi, le sensazioni, le ore passate, vicine o lontane, di tutte le ansie che hanno animato la mia esistenza, tornano a stimolarmi la mente ed arricchire di nuove, variate luci l’animo mio. Sono giorni di clausura che durano a lungo: ma non è letargo, riposo, al contrario è contemplazione che si traduce e si trasfigura in dinamismo, in opera di interiore rinnovamento. E se fedeltà rimangono, in tutto questo logorìo di sentimenti, vuol dire che tali fedeltà sono quelle imperiture, che mi hanno arricchito di sensazioni, che mi hanno fatto uomo ancora capace di dedizione produttiva, di infaticabile lena. E parlo e scrivo e penso sotto lo stimolo, appunto, di queste fedeltà. La mia cara amica Tarquinia Zandonai, tarda di anni ma con la penna netta, senza tremolii, mi scrive parlando del suo Riccardo, a proposito del disco che ha ricevuto in omaggio e che io, doverosamente, le ho fatto inviare. È una lettera semplice, ma di una tenace volontà. La leggo e la rileggo, nel mentre ripasso più volte la musica della sempre più mia e 3.2.6/22 sempre più solitaria «Francesca». Seppure sappia tutto a mente, mi diverto a sentire la musica, seguendo nel contempo il testo poetico. Lo percorreremo un poco insieme, ora, perché mi si è fatto pressante il bisogno di trovare amici, lontani, segreti, sconosciuti, capaci di rivivere all’unisono una poesia, che è vera, grande poesia. E se non ci sarà per essi la musica, basterà già la parola a rivelare ciò che l’altra, con ulteriore grandezza, sprigiona. La tecnica che si adopera nello scrivere un articolo non mi permetterà di indicare i versi e i capoversi: stenderò per intero il periodo, come se fosse prosa o pura narrativa. Penso che tale licenza, a mio avviso inderogabile, mi sarà perdonata. *** Dice Paolo: «Ecco, sono venuto, avendo udito i suoni, per portarvi il mio saluto, il saluto del mio ritorno». Gli risponde Francesca: «Assai presto siete tornato, con la prima rondine». E di rimando il cognato, posseduto da lei: «Nulla più seppi di voi, da quella sera perigliosa che m’offeriste una coppa di vino e mi diceste addio con la buona ventura». «Non è nella memoria questo, signore. Io ho molto pregato». Carico di tante cose è questo «Io ho molto pregato» che dice Francesca, per cui un significato d’intensa naturalezza e verità si trova nella risposta di Paolo: «Io ho molto sofferto». Francesca prorompe allora, pur contenendosi, nelle seguenti parole, rivelatrici della sua virtù, della sua nobiltà femminile, di quella riservatezza e decoro e morale che erano la forza della classica donna, a cui il “dolce stil novo” diede animo e personalità: parole nello stesso tempo illuminanti, pur nella discrezione del dire, di tutto l’amore segreto dalla cui negazione essa cercava liberazione e dominio dei propri sensi. «Paolo, datemi pace! È dolce cosa vivere obliando, almeno un’ora fuor della tempesta che ci affatica. Non richiamate, prego, l’ombra del tempo in questa fresca luce che alfine mi disseta. Pace in questo mare che tanto era selvaggio ieri, et oggi è come la perla. Datemi, datemi pace». Su questa invocazione di pace mi soffermo e prenderò licenza da voi, cari lettori. Vorrei, intanto, che mi seguiste nella serenità del mio giudizio e riconosceste che mai poesia fu tanto semplice e umana, tanto vicina, con l’umiltà del suo dire, al soffrire ed all’ansia quotidiana di tutti quelli che sanno idealmente amare. Che questa poesia distrugge il “cliché” di un D’Annunzio decadente e convenzionale, anche, per renderlo mondo da ogni estetismo di maniera. E vorrei dire, infine, quel che più profondamente tocca la segreta corda che può e sa farci migliori. L’invocazione alla pace, alla pace umana, di cui ogni essere vivente, se rivolto ad un preciso ideale, ne sente l’ansia senza mai conoscerne la sazietà. È la «tempesta che ci affatica», di cui parla Francesca, che sempre più ci sospinge ad invocare questa pace. Tanto più bello, mi sembra, che la parola sia rivolta alla persona la quale tutto vuole donarti di sé, per cui la pace diventa desìo reciproco, ma contrastante. Attraverso tali e tante minute frazioni si ricompone il mistero della vita, che fu nei secoli e per sempre sarà. «Datemi pace»: anche la tua angelica ombra, caro maestro, caro Zandonai, si unisce, attraverso la tua musica, a questa invocazione, ora come mai, perché te ne è stata negata la giustizia. E si riflette nelle parole che la tua esemplare compagna mi scrive, per ringraziarmi di quel disco esile come una fetta di pane, ma che pure si fa, come il pane, nutriente. Ciò dico mentre il mare, in questo lento e brumoso albeggiare si fa bianco: come lo vide Francesca e lo indicò a Paolo, per distoglierlo, con un ultimo sforzo innocente, da lei, prima di cedere all’attimo che, comunque, li ha entrambi condotti all’immortalità. 474 Mario Rinaldi, Morte senza pace di Riccardo Zandonai, in Ritratti e fantasie musicali, Roma, De Santis 1970, pp. 306-910 Pochi artisti furono amati dai loro concittadini come Riccardo Zandonai. Quando la sera del 28 novembre 1908 si diede al Teatro Chiarella di Torino la prima assoluta del Grillo del focolare, a Sacco non si dormì. Il telegrafo rimase aperto tutta la notte per poter ricevere le notizie sull’esito dell’opera. E quando nelle prime ore del 29 giunse la notizia del successo, la banda di Sacco traversò le vie della cittadina al suono di un inno dettato dallo stesso compositore, preceduta da un cartello su cui era scritto: «Viva Zandonai». 10 L’articolo era stato pubblicato sul «Messaggero» in data non specificata, ma comunque anteriore al 1947. 3.2.6/23 Purtroppo le gioie natìe erano amareggiate da altri motivi. Nell’anno in cui il compositore sposò la Tarquini, la prima interprete di Conchita (1917)11 – si era in piena guerra – rischiò di essere impiccato. L’Austria, considerandolo suo cittadino, lo aveva condannato come renitente. Fu l’amore per l’arte che gli fece dimenticare tante controversie. La musica era la sua grande passione. Per Zandonai le difficoltà maggiori stavano nel trovare il soggetto per le sue opere. Scrivendo nel 1926 alla casa Ricordi riguardo al libretto di Giuliano, tratto dal racconto di Flaubert, precisava: «Trovare un libretto che entri immediatamente nel favore del pubblico vuol dire vincere un terno al lotto». Con i poeti, però, si mostrava remissivo. Giuseppe Adami, che fu tra i suoi più fedeli collaboratori, affermava: «Nei miei lunghi contatti con tanti musicisti, uno solo ne trovai fermo, deciso, irremovibile e perfino scrupoloso nel non dare noie al suo poeta: Riccardo Zandonai». E aggiungeva che il maestro «non chiedeva versi da adattare alla musica, ma scriveva la musica sui versi già composti». Un gentiluomo estremamente sensibile. Quando si decise a musicare Francesca da Rimini, dovendo la casa editrice retribuire con venticinquemila lire oro Gabriele D’Annunzio, per aver dato il nullaosta alla riduzione della tragedia, Zandonai dichiarò che si sarebbe accontentato soltanto di tremila lire. Quando la Francesca venne data per la prima volta a Trieste, il poeta scrisse al compositore: «Mi rammarico di non poter venire al teatro se non con una auto-blindata, che è un veicolo incomodo e forse pericoloso». D’Annunzio era a Fiume e precisava: «Siamo qui. Passiamo di pena in pena e non disperiamo mai». Oltre l’arte, il compositore amava la famiglia e quanto di bello lo circondava; amava molto anche le bestie e le piante. Allorché a Carpegna, a una disgraziata partita di caccia, un suo amico12 gli uccise per errore la cagnetta Pax, il maestro riprese subito la via del ritorno, muto e col volto rigato di lacrime. Partì da Carpegna e non volle tornarvi più. Scrisse in un articolo autobiografico del 1928: «Amo i fiori e in particolare le rose. Conosco le abitudini delle piante come quelle degli uomini e, in parola d’onore, preferisco le prime». Dopo tanti successi e tante soddisfazioni la morte venne a ghermirlo appena oltrepassati i sessanta anni. Scrisse agli amici in data 17 maggio 1944: «Da oltre due mesi vado sempre peggio. Questa è la verità. È probabile che l’intervento abbia luogo lunedì. Raccomandatemi alla dolcissima Santa Rita». Un male che non perdona al fegato. Morire? «Se il buon Dio mi vorrà concedere ancora qualche anno di vita, non intendo che questa vita sia inutilizzata dal male, tanto più che sento ancora tanta energia e tanta forza dentro di me da sfidare chiunque». Ma facendo da sé il bagaglio per andare alla clinica per farsi operare, mise nella valigia, con le sue stesse mani, un abito nero, cravatta e scarpe nere. Ebbe dunque il presentimento della morte. Undici giorni dopo, il dottor Costa sentenziava: «È un uomo finito, si spegne pian piano; l’organismo già esaurito non si riprende; colpa del fegato». E infatti poco dopo lo Zandonai diceva al buon don Pietro che era venuto ad assisterlo: «Non c’è più niente da fare. Ci rivedremo lassù...». Aveva lasciato scritto alla moglie: «Qualora il destino mi fosse nemico, finita la guerra voglio essere sepolto nel cimitero di Sacco accanto a mio padre e a mia madre, dove a suo tempo ti attendo con Jolanda». Don Pietro Damiani precisò poi: «Ci tengo si sappia della morte cristiana e perfetta del maestro, al quale ho dedicato il mio Collegio». Sono noti i sentimenti patriottici dello Zandonai. Alludendo alla sua ultima opera Il Bacio, rimasta incompiuta, scriveva nel febbraio 1944 in piena occupazione tedesca: «Spero poter preparare qualche cosa pel giorno tanto agognato della liberazione. L’Italia avrà bisogno di tutto, anche di opere d’arte, l’unica materia che potrà esportare subito al di là dei confini». E aggiungeva, non sospettando il male che lo consumava: «Sto bene di salute e di spirito». Quattro mesi dopo giaceva moribondo nell’ospedale di fortuna di Trebbiantico. Il sacerdote, don Pietro gli si avvicinò all’orecchio per dirgli: «Vi interessa, maestro, sapere che Roma è stata liberata». «Mi interessa moltissimo». La moglie ha precisato – nel volume «Riccardo Zandonai nel ricordo dei suoi intimi», pubblicato dalla cognata Vittoria Bonajuti Tarquini per la casa Ricordi, editrice del compositore – che Zandonai passò da questo all’altro mondo come un bambino. Ricevette i sacramenti. Negli ultimi momenti si rammaricò che il suo forte cuore di montanaro non volesse cessare di battere. 11 12 [sic]: ma 1916. Carmelo Maugeri. 3.2.6/24 Il suo corpo, dopo la morte, non ebbe subito la desiderata pace. Sepolto nel piccolo cimitero di Montebaroccio, la provvisoria tomba venne scoperchiata dai bombardamenti. Fu l’amico Pompei che, insieme alla governante, avvolse allora la salma in due coperte e la caricò su di un camioncino. Bisognava però passare dinanzi alle sentinelle. Nascose la salma fra la verdura e quando il soldato straniero fece la rituale visita sentenziò: «Va bene, patate, andate pure». Fu così che Zandonai poté riposare nel cimitero di Pesaro ove è tuttora. Poi la salma sarà portata su, a Sacco, come egli aveva scritto. Fu detto che la corrispondenza personale, che oggi potrebbe formare materiale prezioso per i biografi, venne distrutta dal maestro prima di abbandonare ai tedeschi la villa di San Giuliano, per chiedere rifugio al convento del Beato Sante, sopra Pesaro. Molte cose preziose erano state chiuse in casse e, quindi, nascoste. Più tardi vennero ritrovate in un paesello del Trentino. Portavano un indirizzo: quello di un ufficiale della Todt che aveva fatto da padrone alla villa San Giuliano, paradiso perduto dei coniugi Zandonai. Ma una cassetta era stata donata [d]agli eredi del critico Nicola D’Atri, grande amico dello Zandonai, al Comune di Rovereto, con l’obbligo che fosse aperta dopo venticinque anni dalla morte del maestro, avvenuta il 5 giugno 1944. Il contenuto è risultato costituito da 2500 lettere, la maggior parte delle quali dirette al D’Atri, fotografie, ritagli di giornale, critiche di opere del maestro eseguite all’estero, bozzetti di scene, oltre a qualche altro scritto. 3.2.6/25
Scarica