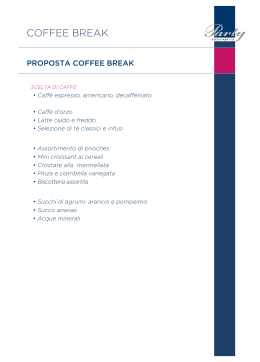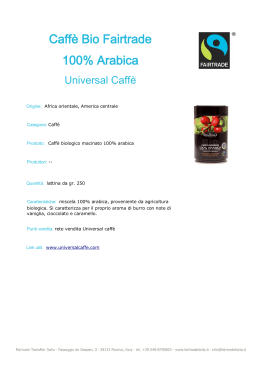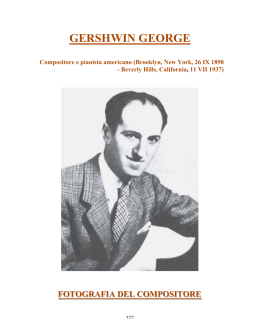LADOMENICA DOMENICA 8 APRILE 2012 NUMERO 371 DIREPUBBLICA CULT All’interno La copertina Da YouTube alle piazze la letteratura in viva voce BARTEZZAGHI E MURGIA Uomini soli 1982: Pio La Torre e il generale Carlo Alberto dalla Chiesa 1992: i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 2012: nell’anniversario degli omicidi dei grandi avversari della mafia non sappiamo ancora chi li ha voluti morti. Ma sappiamo il perché Il racconto e il documentario del cronista di “Repubblica” dal fronte La recensione Il comunista che scoprì il crollo del Muro FRANCO MARCOALDI L’intervista Irving Yalom “Capire la psicoanalisi con Spinoza” SUSANNA NIRENSTEIN Teatro La storia ATTILIO BOLZONI Quando i ragazzi andarono a cercare Federico Caffè uella mattina sono anch’io là, con il taccuino in mano e il cuore in gola. Saluto Giovanni Falcone, saluto Rocco Chinnici, non ho il coraggio di guardare Paolo Borsellino che è con le spalle al muro e si sta accendendo un’altra sigaretta con il mozzicone che ha già fra le dita. Mi avvicino al commissario Cassarà e gli chiedo: «Ninni, cosa sta succedendo?». Mi risponde, l’amico poliziotto: «Siamo cadaveri che camminano». Un fotografo aspetta che loro — Falcone e Cassarà, Chinnici e Borsellino — siano per un attimo vicini. Poi scatta. Una foto di Palermo. Una foto che dopo trent’anni mi mette sempre i brividi. Sono morti, uno dopo l’altro sono morti tutti e quattro. Ammazzati. Tutti vivi me li ricordo, tutti ancora vivi intorno a quell’uomo incastrato dentro la berlina scura e con la gamba destra che penzola dal finestrino. Sono lì, in una strada che è un budello in mezzo alla città delle caserme, vie che portano i nomi dei generali della Grande guerra, brigate e reggimenti acquartierati dietro il sontuoso par- DANIELE ARCHIBUGI Le idee Siamo oltre Orwell La provocazione di Enzensberger HANS MAGNUS ENZENSBERGER Q lamento dell’isola, Palazzo dei Normanni, cupole arabe e lussureggianti palme. Chi è l’ultimo cadavere di una Sicilia tragica? È Pio La Torre, segretario regionale del Partito comunista italiano, deputato alla Camera per tre legislature, figlio di contadini, sindacalista, capopopolo negli infuocati anni del separatismo e dell’occupazione delle terre. È Pio La Torre, nato a Palermo alla vigilia del Natale del 1927 e morto a Palermo alla vigilia del Primo maggio del 1982. L’agguato non ha firma. Forse è un omicidio di stampo mafioso. Forse è un omicidio politico. Chissà, potrebbe anche avere una matrice internazionale. Magari — come qualcuno mormora — si dovrebbe esplorare la «pista interna». Indagare dentro il suo partito. Nella sua grande famiglia. Cercare gli assassini fra i suoi compagni. Supposizioni. Prove di depistaggio in una Palermo che oramai si è abituata ai morti e ai funerali di Stato, cadaveri eccellenti e cerimonie solenni. Il 30 aprile 1982, trent’anni fa. (segue nelle pagine successive) Il principe di Kleist per Cesare Lievi è un giovanotto sognatore e irreale ANNA BANDETTINI Il libro Una certa idea di mondo: “La luce nelle storie di Rebecca West” ALESSANDRO BARICCO Repubblica Nazionale LA DOMENICA DOMENICA 8 APRILE 2012 ■ 30 La copertina Uomini soli Il comunista, il carabiniere, i due magistrati Uniti dallo stesso senso del dovere e contro lo stesso nemico Uccisi venti e trent’anni fa esatti. Un libro e un documentario del cronista di “Repubblica” che li ha conosciuti spiegano perché il potere li ha voluti morti e perché i mandanti restano oscuri PIO LA TORRE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA “Prima o poi ce la faranno pagare per quello che stiamo facendo in Sicilia Palermo è una città dove si fa politica con la pistola” “Ho capito la regola del gioco Si uccide quando avviene questa combinazione fatale: è diventato troppo pericoloso, ma si può uccidere perché è isolato” Quattro destini incrociati U ATTILIO BOLZONI (segue dalla copertina) ccidono l’uomo che prima di tutti gli altri intuisce che la mafia siciliana non è un problema di ordine pubblico ma «questione nazionale», il parlamentare che vuole una legge che segnerà per sempre la nostra storia: essere mafioso è reato. Chiede di strappare i patrimoni ai boss, tutti lo prendono per un visionario. Dicono che è ossessionato da mafia e mafiosi, anche nel suo partito ha fama di “rompicoglioni”. Al presidente del Consiglio Giovanni Spadolini propone di inviare a Palermo come prefetto il generale Carlo Alberto dalla Chiesa, il carabiniere che ha sconfitto il terrorismo. Non fa in tempo a vederlo sbarcare, l’ammazzano prima. Pio La Torre aveva conosciuto dalla Chiesa nel 1949 a Corleone, lui segretario della Camera del lavoro dopo la scomparsa del sindacalista Placido Rizzotto e il capitano volontario nel Cfbr, il Comando forze repressione banditismo. Il loro primo incontro avviene nel cuore della Sicilia. Quindici anni dopo si ritroveranno uno di fronte all’altro in commissione parlamentare antimafia, uno deputato e l’altro comandante dei carabinieri della Sicilia occidentale. Il terzo incontro non ci sarà mai. Destini che s’incrociano in un’isola che non è ricca ma sfrenatamente ricca, superba, inespugnabile. Il giorno dell’uccisione di Pio La Torre in Sicilia arriva il generale. «Perché hanno ucciso La Torre?», gli chiedono i giornalisti. «Per tutta una vita», risponde lui. È il cinquan- tottesimo prefetto di Palermo dall’Unità d’Italia. L’hanno mandato giù «per combattere la mafia». Informa il capo del governo che non avrà riguardi per la «famiglia politica più inquinata del luogo». È la Dc di Salvo Lima e di Giulio Andreotti. Non gli concedono i poteri promessi, solo contro tutti Carlo Alberto dalla Chiesa resisterà per centoventi giorni. Il 3 settembre 1982 tocca anche a lui. E alla sua giovane moglie Emmanuela. Omicidio premeditato, annunciato, dichiarato. Omicidio fortemente voluto per chiudere un conto con un generale diventato troppo ingombrante. Una leggenda per i suoi carabinieri, una minaccia permanente per un’Italia che sopravvive fra patti e ricatti. Dicono che a farlo fuori è stata la Cupola. Come per Pio La Torre. Un alibi perfetto per RBA2 U T A PIAZZprile 198 30 a seppellire e dimenticare un generale fatto a pezzi dallo Stato. Nei giorni precedenti al 3 settembre le sabbie mobili siciliane se lo sono divorato Carlo Alberto dalla Chiesa. Le prime pagine del giornale L’Ora, sono fotocopie con numeri al posto dei titoli: 81…84…87…Gli omicidi a Palermo dall’inizio dell’anno. L’11 agosto sono già 93, il 14 sono 95. A fine mese l’inchiostro rosso si spande sulla foto dell’ultima vittima. Il titolo che va in stampa dice 100. «L’operazione da noi chiamata Carlo Alberto l’abbiamo quasi conclusa, dico: quasi conclusa», è la telefonata che arriva dopo una “sparatina” a Villabate. Una rivendicazione così a Palermo non l’hanno fatta mai. Sembra un proclama terroristico. Una dichiarazione di guerra, in stile militare. Sono a Casteldaccia quando arriva quella te- lefonata. Mi arrampico su una stradina che sale fino alla caserma dei carabinieri. Lì c’è già il capitano Tito Baldo Honorati, il comandante del nucleo operativo di Palermo. È davanti a un’utilitaria impolverata, la parte posteriore dell’auto è “abbassata”, schiacciata verso l’asfalto. Ormai si riconoscono anche da lontano le macchine con un grosso peso nel bagagliaio. Significa che lì dentro c’è un uomo. Il capitano apre. È un “incaprettato”, mani e piedi legati con una corda che gli passa intorno al collo. Quando i muscoli delle gambe cedono, la vittima finisce per strangolarsi. «È un altro regalo per il nostro generale», dice l’ufficiale mentre via radio gli arriva la notizia che è stato ritrovato un cadavere sulla piazza di Trabia. Ed è già morto anche lui — l’agguato a colpi di kalashnikov in via Isidoro INI 1982 R A C VIA ttembre 3 se MITRAGLIATORI E REVOLVER KALASHNIKOV Ore 9.20: una pioggia di proiettili uccide Pio La Torre insieme all’autista e amico Rosario Di Salvo mentre sta andando in auto alla sede del Pci Ore 21: Carlo Alberto dalla Chiesa viene ucciso a colpi di kalashnikov in via Isidoro Carini insieme alla moglie Emmanuela. Stavano andando a cena Repubblica Nazionale DOMENICA 8 APRILE 2012 ■ 31 L’INIZIATIVA Dal 13 aprile è in libreria Uomini Soli (Melampo editore, 232 pagine, 16 euro), le biografie di quattro italiani che facevano paura al potere scritte da Attilio Bolzoni. Tutti uccisi a Palermo. Il segretario del Pci siciliano Pio La Torre e il generale dei carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa assassinati nel 1982, i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino fatti saltare in aria nell’estate del 1992 È il racconto - nel ventennale e nel trentennale della loro morte – dei misteri e dei drammi di una Sicilia insanguinata Il libro sarà distribuito il 16 maggio prossimo anche in edicola con Repubblica insieme al film-documentario Ritorno a Palermo di Paolo Santolini: un viaggio nella memoria dove parlano i sopravvissuti delle stragi, i familiari delle vittime, i protagonisti di una spaventosa stagione iniziata nel 1979 con l’uccisione del giornalista Mario Francese e conclusa quasi un quarto di secolo dopo con l’esplosivo di Capaci e di via Mariano D’Amelio Il documentario, girato in Sicilia nel marzo scorso, è prodotto dalla Faber Film e da Libera e sostenuto da Arcoiris Tv, Coop, Cgil, Arci e Coldiretti Sicilia GIOVANNI FALCONE PAOLO BORSELLINO “Ma io sono un siciliano, un siciliano vero Per me la vita vale quanto il bottone di questa giacca” “Non sarà la mafia a uccidermi ma saranno altri E questo accadrà perché qualcuno lo permetterà E fra quel qualcuno, ci sono anche i miei colleghi” «un piccolo evento sismico con epicentro fra i comuni di Isola delle Femmine e Capaci». Non è un terremoto. È una carica di cinquecento chili di tritolo che fa saltare in aria Giovanni Falcone. È il magistrato più amato e più odiato del Paese. Da vivo è solo. Da morto è esaltato e osannato, il più delle volte dagli stessi nemici che ne hanno voluto le sconfitte. Sepolto in una piccola stanza dietro una porta blindata, in mezzo ai codici e alla sua collezione di papere di terracotta, è il primo italiano che mette veramente paura alla mafia. Prigioniero nella sua Palermo, è l’uomo che cambia Palermo. Porta i boss alla sbarra con il maxi processo. Vengono condannati in massa. Detestato, denigrato, guardato con sospetto dai suoi stessi colleghi in toga, temuto e adulato dalla politica, resiste fra i tormenti schivando attentati e tranelli governativi. Prima tremano per la forza delle sue idee, poi si impossessano della sua eredità. È celebrato come eroe nazionale solo quando è nella tomba. Mario Pirani lo descrive come l’Aureliano Buendìa di Cent’anni di solitudine, che ha combattuto trentadue battaglie e le ha perse tutte. Giuseppe D’Avanzo ricorda «l’umiliante sottrazione di cadavere» compiuta dopo la strage di Capaci. Chi l’ha violentemente intralciato in vita, lo invoca in morte. Ha cinquantatré anni e cinque giorni quando vede per l’ultima volta la sua Sicilia. Al suo funerale c’è una folla straripante nella basilica di San Domenico, il Pantheon di Palermo. Una pioggia violenta lava la città. Sono quasi le due del pomeriggio, la piaz- za adesso è deserta. C’è solo un uomo, inzuppato, che avanza guardando nel vuoto. È Paolo Borsellino, l’amico e l’erede di Giovanni Falcone. Altri due uomini con lo stesso destino. Nascono alla Kalsa a distanza di pochi mesi uno dall’altro, da ragazzini si rincorrono fra i vicoli, si ritrovano trentacinque anni dopo in un bunker di tribunale. Se ne vanno insieme, nella stessa estate. Cinquantasette giorni di dolore. Per il fratello perso e per uno Stato che tratta. Paolo Borsellino si sente abbandonato, mandato allo sbaraglio da gente di Roma che nell’ombra sta negoziando la resa. Sono in molti a tremare per i suoi segreti. Sa che è già arrivato l’esplosivo anche per lui. Si getta nel vuoto il procuratore di Palermo, assassinato da un’autobomba e dal cinismo di un’Italia canaglia che l’ha visto mo- rire senza fare nulla. Tradito e venduto. Il 19 luglio del 1992 salta in aria. Come Falcone. L’agenda rossa che ha sempre con sé non si troverà mai. Dicono che è stata ancora la Cupola. È sempre e solo la Cupola che ha deciso la sorte di tutti loro. Così ci hanno raccontato. Così ci hanno portato sempre lontano dalla verità. Depistando. Inventandosi falsi pentiti. Scaricando tutto addosso a Totò Riina e ai suoi corleonesi. Prima usati e poi sacrificati, sepolti per sempre nei bracci speciali. Trent’anni dopo, non sappiamo ancora chi ha voluto morti Pio La Torre e Carlo Alberto dalla Chiesa. Vent’anni dopo, non sappiamo ancora chi ha voluto morti Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Sappiamo solo che erano quattro italiani che facevano paura al potere. © RIPRODUZIONE RISERVATA LIO E M A ’ VIA Duglio 1992 19 l I 992 1 o i CAPAC g g 23 ma ©TOMMASO BONAVENTURA/CONTRASTO Carini, una settimana dopo — Carlo Alberto dalla Chiesa, carabiniere figlio di carabiniere, nato a Saluzzo, provincia di Cuneo, Piemonte. Dall’altro capo dell’Italia. Palermo è laboratorio criminale e terra di sperimentazione politica, è porto franco, capitale mondiale del narcotraffico, regno di latitanti in combutta con questori e prefetti, onorevoli mafiosi e mafiosi onorevoli. Il giudice Falcone indaga sui “delitti politici” siciliani, indaga sulla morte di Pio La Torre e Carlo Alberto dalla Chiesa. Scopre tutto e niente. Sospetti. Trame. Mandanti sempre invisibili. Palermo è dentro una guerra permanente. Poi, l’atto finale. Nel 1992. Il 23 maggio, vent’anni fa. Alle 17, 56 minuti e 48 secondi gli strumenti dell’Istituto di Geofisica e di Vulcanologia di monte Erice registrano CINQUECENTO CHILI AUTOBOMBA Ore 17.56 e 48 secondi: 500 chili di tritolo fanno saltare in aria le auto blindate di Giovanni Falcone e della scorta Muoiono anche la moglie e tre poliziotti Ore 16.58: una Fiat 126 con cento chili di tritolo esplode e uccide Paolo Borsellino mentre sta andando dalla madre. Muoiono cinque agenti Repubblica Nazionale DOMENICA 8 APRILE 2012 LA DOMENICA ■ 32 La storia Nella notte del 15 aprile 1987 il grande economista scomparve nel nulla Si pensò al suicidio, a un incidente oppure a una fuga perfetta per lasciarsi ogni cosa alle spalle. In quei giorni quasi tutti i suoi allievi intrapresero una grande ricerca, perlustrarono tutta Roma e non scartarono nessuna ipotesi Cold case Dopo venticinque anni, il racconto di uno di loro DANIELE ARCHIBUGI n mercoledì mattina Federico Caffè scomparve di casa con la discrezione che lo aveva accompagnato per tutta la vita. Saranno state le sette quando mi arrivò la telefonata di suo fratello minore Alfonso, anche lui celibe e professore, con cui conviveva. Mi disse «Vinicio (così lo chiamavano in famiglia) è scappato di casa». Ci misi pochi minuti a raggiungere la loro casa di via Cadlolo, dove trovai i suoi nipoti e Nicola Acocella, uno dei suoi allievi che più si era preso cura di lui nelle ultime settimane. Non sapevamo che cosa attenderci: la sua fuga sarebbe stata di breve durata come quella di un adolescente o avrebbe preso una piega ben più tragica? La domenica prima ero andato a trovarlo a casa. Da tre mesi, Caffè era stato preso da una profonda crisi depressiva e non andava più, come aveva sempre fatto, tutti i giorni in facoltà. Negli anni in cui frequentai l’Università, dal 1976 al 1982, è stato l’amico più vicino, nonostante fossi quasi mezzo secolo più giovane. Come altri affezionati allievi che avevano saputo della sua depressione, cercavo di aiutarlo passando qualche ora nel suo studiolo. La mia amicizia con Caffè è iniziata ben prima che nascessi: mio padre era il suo migliore e forse unico amico, e lui fu il testimone di nozze dei miei genitori. Era un uomo assai riservato e sin da bambino ho pensato che fosse la sua statura — era alto un metro e mezzo — a renderlo così schivo. Celibe, era generosissimo con i figli dei suoi amici: solo pochi mesi fa sono venuto a sapere che gli stessi giocattoli che ci faceva pervenire negli anni Sessanta giungevano anche ai figlioli del suo amico Paolo Sylos Labini e chissà a quanti altri. Unico tra i miei fratelli, mi iscrissi a economia e commercio, la facoltà nella quale lui passava dodici ore al giorno. Scoprii in quel frangente che l’uomo riservatissimo che avevo conosciuto si trasformava dietro la cattedra e tramite l’eloquio, sempre sostenuto da un sano pragmatismo di mai ripudiata marca abbruzzese, riusciva a persuadere e, soprattutto, ad accendere la curiosità. Mi accorsi presto che ero stato arruolato nella confraternita dei suoi allievi che, senza bisogno di riti iniziatici, si ispirava ai valori coltivati dal Maestro: rigore e sobrietà. Per sopraggiunti limiti di età, Caffè aveva da pochi mesi smesso di insegnare, riportandone un tracollo emotivo. Il circolo di persone che gli era più vicino ne era rimasto sorpreso: come era possibile che lui, l’uomo che aveva sempre sostenuto tutto e tutti, avesse ora bisogno di sostegno? Aveva retto in piedi un’intera facoltà, reclutato i più promettenti insegnanti e contribuito al dibattito politico. Con discrezione, ma anche con passione civica, aveva sempre usato gli strumenti dell’economia per difendere i più deboli. Aveva tempo per tutti e per tutto, e a nessuno aveva negato il suo sostegno e conforto. Eppure, ora, si dimostrava incapace di abbandonarsi alle persone che gli volevano bene. Da quel mercoledì iniziarono giorni terribili: non volevamo dare la notizia in pasto alla stampa nel timore che, se fosse stato travolto dal clamore dei media, avrebbe potuto compiere atti inconsulti che speravamo fosse ancora possibile scongiurare. Telefonammo ai molti suoi amici sparsi per Roma e per il mondo, nella speranza che si fosse rifugiato a casa di uno loro. Cercammo di immaginare quali potevano es- U VIA CADLOLO 42 È la notte tra il 14 e il 15 aprile 1987 Sul tavolino accanto al letto Federico Caffè ha lasciato orologio, occhiali, chiavi, passaporto e libretto degli assegni In tasca non ha più di 30mila lire Alle 5.30 un vicino di casa sente aprire la porta dell’appartamento dove vive il professore MONTE MARIO Nessun tassista o autista di bus dice di aver preso a bordo Caffè Si perlustra tutta la zona dove il professore era solito passeggiare PONTE DUCA D’AOSTA Si teme il peggio e si battono le sponde del Tevere sotto il Ponte Duca d’Aosta, il più vicino alla casa di Caffè PONTE MARCONI Un fotografo per caso scatta l’immagine di un uomo che il 15 aprile si getta nel Tevere. Non è Caffè TARQUINIA Si ricorre anche ai sensitivi: alcuni indicano che Caffè è in campagna, forse nel paese poco fuori Roma. Alcuni studenti si precipitano là PIAZZA FONTANELLA BORGHESE Uno dei primi posti della ricerca è la zona della libreria dove l’economista si forniva regolarmente I ragazzi che cercarono il professor Caffè sere state le sue mosse e trovammo un interlocutore di rara sensibilità umana nel capo della squadra mobile di Roma, Nicola Cavaliere. Se stava vagando per la città in stato confusionale, aveva bisogno di essere aiutato. Iniziammo a cercarlo sulle pendici della collina di Monte Mario, dove abitava, e nelle zone limitrofe. Ci fu chi perlustrò gli argini del Tevere, chi cercò nei dintorni della nuova facoltà di via Castro Laurenziano e della vecchia sede di Piazza Fontanella Borghese. Inseguimmo falsi indizi, come quello di un gioielliere che riteneva di averlo visto seduto sui gradini di una stazione della metropolitana. Negli stessi giorni, un altro anziano si buttò nel Tevere da Ponte Marconi ma ben presto, visti gli ingrandimenti delle foto scattate da un passante, escludemmo che si potesse trattare di lui. Bussammo alle porte dei conventi e chiedemmo aiuto al Vaticano. Armati di penna e taccuino, parlavamo con le persone che conosceva ricercando qualche indizio e raccomandando mille volte di mante- nere la riservatezza. Per cinque lunghissimi giorni non abbiamo dato la notizia all’opinione pubblica, per paura che la vita di un uomo sensibile e straordinario come Caffè potesse essere insudiciata. Tramite Marco Ruffolo, uno dei suoi amati allievi, chiedemmo a Eugenio Scalfari di pubblicare su Repubblica un an- Repubblica Nazionale DOMENICA 8 APRILE 2012 ■ 33 Le ipotesi ARICCIA Un esposto indica che il corpo di Caffè sarebbe in un pozzo nella cittadina laziale È il 14 agosto del 1999. Non è vero PIAZZA FIUME Tre anni dopo la scomparsa, alcuni familiari di Ezio Tarantelli, ex allievo e amico di Caffè ucciso dalle Br, sono sicuri di aver visto l’economista scendere dal bus 58 e correre verso via Salaria SUICIDIO Federico Caffè confessò in una lettere la sua depressione. In pochi anni aveva perso le persone più care, la madre, la vecchia tata, tre amici come Tarantelli, Franciosi e Vicarelli e doveva accudire il fratello Alfonso AMNESIA Nell’ultima lettera scritta all’amico Carlo Ruini, Caffè si lamenta che le “abituali amnesie senili sono diventate totali” Il professore potrebbe essersi smarrito FUGA ILLUSTRAZIO NE DI CARLO STANGA È la teoria dello scrittore Ermanno Rea: Caffè, con l’aiuto di qualcuno si sarebbe fatto portare in un convento. Un suo santino ritrovato diceva: “La vera carità non nasce dalla pienezza ma dalla povertà” L’ultima lezione a sera si fa lunga senza coloro che amiamo». Incomincia con queste parole prese in prestito da Montale Federico Caffè, le riflessioni della stanza rossa. Sono scritte a mano dallo stesso Caffè nella prima pagina del libro di Bruno Amoroso che esce in occasione dell’anniversario della scomparsa del grande economista abruzzese. Amoroso, che di Caffè è stato prima allievo e poi amico di una vita e che a lui deve il consiglio di lasciare l’Italia per cercare una carriera accademica in Danimarca, ha messo insieme anni di ricordi, carteggi, colloqui, riflessioni e li ha rielaborati e trasformati in un dialogo ininterrotto e durato anni. Il libro, ricco di fotografie e documenti rari o inediti, ripercorre non soltanto la vicenda umana del professore e gli eventi sociali di quegli anni ma anche l’evoluzione del suo pensiero keynesiano, le sue preoccupazioni di fronte all’avanzare delle teorie neoliberiste e le vere e proprie profezie amare su come il capitalismo di natura finanziaria avrebbe finito per riversarsi contro le classi lavoratrici, i risparmiatori e il ceto medio. Una raccolta di lettere di Caffè fa da appendice al volume. Edito da Castelvecchi (186 pagine, 17,50 euro) il libro uscirà il 13 aprile. «L PIAZZA DELLA PIGNA Il 29 aprile dell’88, un anno dopo la scomparsa, un falso allarme: viene individuato un sosia perfetto del professore e per di più senza documenti. In realtà l’uomo si chiama Egidio Colella STAZIONE TERMINI VIA DEL CASTRO LAURENZIANO La sede della facoltà di economia dove Caffè insegnava: altra zona battuta palmo a palmo nuncio criptico dettato dal fratello: «Vinicio, torna a casa, sto male. A. «. In queste poche parole c’è forse il dramma estremo con cui Federico aveva costruito la sua esistenza: anche nel momento tragico in cui stava probabilmente pensando di porre fine alla propria vita, chi gli era più vicino sperava di convincerlo a cambiare idea richia- vamo la passione per il giallo scandalistico dei mass media. Così nessuno di noi parlò della sua crisi depressiva e per anni e anni siamo stati reticenti nel descrivere lo stato in cui si trovava negli ultimi mesi. La scomparsa del piccolo grande economista non doveva inficiare l’aura che si era meritato con un’esistenza esemplare. Dopo un quarto di secolo, possiamo solo constatare che, qualsiasi sia stato il destino del nostro maestro, è stato quello che lui si è scelto. La sua vicenda non sarebbe ancora un mistero se nelle ore successive alla sua scomparsa non avesse dimostrato di avere le doti professionali di un agente segreto assai più che quelle di un austero docente. Anche la sua ultima pagina l’ha scritta senza farsi aiutare da nessuno. Quando la notizia divenne di pubblico dominio, giunsero numerosissimi allievi per aiutarci nelle ricerche. Il 22 aprile un gioielliere, Eugenio Marcuzzi, dice di aver visto Caffè alla Stazione Termini. “Sembrava un barbone, gli ho dato qualche moneta Mi ha detto, signore non si preoccupi, non ho bisogno di nulla” Anche i familiari del gioielliere confermano la somiglianza L’APPELLO Gli studenti pubblicano su Repubblica il 20 aprile un annuncio utilizzando il suo soprannome Vinicio Nessuna risposta mandolo ai suoi doveri verso gli altri piuttosto che a quelli verso se stesso. Del resto, era lui che da sempre aveva avuto tanta facilità a dare quanto difficoltà a ricevere. Portai la notizia all’Ansa una domenica pomeriggio. Fui bombardato di domande e ognuna di esse mi parve una violenza esercitata nei confronti del mio professore. Ci trovavamo in una situazione contraddittoria: da una parte, il clamore suscitato dalla sua scomparsa aumentava la possibilità che fosse rintracciato, dall’altra teme- Spesso non ci conoscevamo, ma bastava uno sguardo per capire che appartenevamo alla medesima confraternita. Agli studenti degli ultimi anni si accompagnavano quelli dei decenni anteriori, e ognuno di loro chiedeva che cosa potesse fare di utile. Non era facile trovare una risposta perché neppure la polizia aveva fornito una casistica. Nell’organizzare le squadre che battevano la città palmo a palmo, chiedevo spesso qualche informazione sugli anni in cui lo avevano frequentato all’università. Mi sentivo ripetere sempre la stessa frase: «È stato il periodo più bello della mia vita». Ma lui, Federico Caffè, lo avrà mai saputo? (Daniele Archibugi oggi è dirigente del Cnr, docente all’Univeristà di Londra Birkbeck College e professore onorario all’Università del Sussex) © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale DOMENICA 8 APRILE 2012 LA DOMENICA ■ 34 Le idee Poteri forti “Il Grande Fratello” non ha più bisogno di una dittatura come quella immaginata dall’autore di “1984”. Secondo l’intellettuale tedesco a far sì che le persone perdano la propria libertà oggi ci pensano Google e Facebook A cui ogni giorno con un clic diciamo “Mi piace!” SORVEGLIATI HANS MAGNUS ENZENSBERGER Orwell non lo aveva previsto HANS MAGNUS ENZENSBERGER U n uomolungimirante, questo Eric Blair, meglio noto con lo pseudonimo di George Orwell. Uno che di regimi totalitari se ne intendeva, assai prima che il termine entrasse a far parte del lessico degli storici. Uno che nel 1943, quando Stalin, Churchill e Roosevelt si incontravano a Teheran, già vedeva profilarsi l’antagonismo tra le superpotenze e la guerra fredda. Qualche anno dopo la Seconda guerra mondiale Orwell pubblicò il suo più celebre romanzo, 1984. Il futuro che vedeva all’orizzonte non gli piaceva. Dipinse il panorama infernale di un regno del terrore nel bel mezzo dell’Europa, che in un futuro non lontano avrebbe perfezionato i metodi di Stalin e di Hitler: un partito unico ai comandi di un “Grande Fratello”; una “neolingua” ideata per capovolgere il significato delle parole; l’abolizione della sfera privata; un regime di sorveglianza a 360 gradi, rieducazione e lavaggio del cervello dell’intera popolazione, e infine un’onnipotente polizia segreta per soffocare sul nascere qualunque tentativo di opposizione, con la tortura, i campi di concentramento e l’assassinio. Fortunatamente quella profezia non si è avverata, almeno per quanto attiene alla nostra parte del globo: con essa George Orwell ha ingannato sia noi che se stesso. Ma non avrebbe immaginato neppure in sogno che per ottenere almeno in parte quel risultato — e in particolare un sistema di sorveglianza a tutto campo — non c’era bisogno di una dittatura. Si poteva raggiungerlo anche all’interno di un sistema democratico, senza l’uso della violenza, con metodi civili, se non addirittura pacifisti. Viviamo in celle spaziose e dalle pareti di gomma I nostri sorveglianti arrivano a passi felpati Si fanno chiamare manager e hanno modi cordiali Più di quattro secoli fa un giovane francese, Etienne de la Boétie, aveva già incominciato a riflettere su questo tema: nel suo Discorso sulla servitù volontaria, non pago di mettere alla berlina i despoti assoluti del suo tempo, l’autore si rivolgeva soprattutto alle coscienze di chi si adattava alla tirannide: «Sono gli stessi popoli — scriveva — a subire questa piaga, o anzi a farsi male da sé; se solo cessassero di sottomettersi alla servitù, sarebbero liberi. Il popolo si assoggetta, accondiscende alla sua miseria, o addirittura la insegue… Non crediate che un uccello si lasci impaniare, né che un pesce abbocchi all’amo con più facilità di un popolo pronto a farsi allettare dalla servitù, per poco che gli si spalmi un po’ di miele in bocca». Di fatto però, già da tempo non abbiamo più a che fare con la figura del monarca unico, personalmente identificabile e attaccabile, contro cui insorgeva Etienne de la Boétie. E neppure subiamo, come nel libro di Orwell, la tirannia di un Grande Fratello, ma piuttosto il dominio di un sistema simile a quello descritto da Max Weber negli anni Venti del secolo scorso. «L’organizzazione burocratica, con le sue professionalità e specializzazioni, la separazione delle competenze, i regolamenti e i rapporti d’obbedienza in base a una scala gerarchica, sta portando avanti, di concerto con la morta macchina, l’edificazione della struttura, di quel futuro assoggettamento, nel quale forse un giorno gli uomini saranno costretti a inserirsi nella più totale impotenza, come i fellah dell’antico Stato egizio, se per essi l’unico e ultimo valore in base al quale si decida la natura e l’amministrazione dei loro affari sarà un buon sistema — buono e razionale in senso puramente burocratico — di tutela, rifornimento e gestione. Perché in questo la burocrazia è incomparabilmente più efficiente di qualsiasi altra struttura di dominio». Nelle sue previsioni, quella struttura di assoggettamento sarebbe stata «dura come l’acciaio»: ma per quanto chiaroveggente, in questo almeno Max Weber si era sbagliato, dato che nel frattempo la gattabuia si è trasformata in un abitacolo relativamente confortevole, qualcosa come una cella spaziosa ed elastica, dalle pareti di gomma. I nostri sorveglianti arrivano a passi felpati, cercando, per quanto possibile, di conseguire i loro principali obiettivi strategici — sorveglianza a tutto campo e abolizione della sfera privata — senza far rumore. Ricorrono al manganello solo quando proprio non c’è altro da fare. Preferiscono rimanere anonimi; non portano uniformi ma abiti civili; si fanno chiamare manager o commissari, e non operano più in caserme, bensì in uffici con l’aria condizionata. Nell’espletamento dei loro compiti hanno modi amabili e cordiali. Ai residenti garantiscono la sicurezza, l’assistenza, il comfort e i consumi. Perciò possono contare sulla tacita approvazione degli abitanti, e non dubitano che i loro protetti premeranno con zelo un pulsante invisibile con la scritta «mi piace». Anche su un altro punto l’analisi di Weber appare oggi anacronistica: la sua disarmante fiducia nella forza e capacità d’azione dello Stato. Se a noi questa fiducia viene meno, non è solo perché gli Stati sono incalzati, braccati dai mercati finanziari globali, ma anche perché oggi né Berlino, né Bruxelles e neppure Washington sarebbero in grado di garantire da soli il controllo totale della popolazione; e ciò semplicemente perché i loro funzionari sono troppo sprovveduti e maldestri. Oltre tutto, non riescono neppure a stare al passo con i progressi della tecnologia. Perciò le autorità dipendono dal “mondo economico”, cioè dalle corporation dell’informatica. Solo se le due parti procedono fianco a fianco — i governi da un lato, e dall’altro imprese come Google, Microsoft, Apple, Amazon o Facebook — la presa a tenaglia sulle libertà dei cittadini raggiunge il massimo dell’efficacia. È comunque chiaro che in questa fragile alleanza, il ruolo delle istanze politiche è quello del partner più debole, dato che solo le corporation dispongono delle competenze indispensabili, del capitale e della necessaria manovalanza: informatici, ingegneri, programmatori di software, hacker, matematici e crittografi. Nel Ventesimo secolo, né la Gestapo, né il Kgb o la Sta- Repubblica Nazionale DOMENICA 8 APRILE 2012 ■ 35 E CONTENTI IL DISEGNO Sopra, un’illustrazione degli Stenberg Brothers si avrebbero neppure lontanamente immaginato i mezzi tecnologici oggi a disposizione: le onnipresenti telecamere di sorveglianza, il controllo automatizzato dei telefoni e della posta elettronica, le immagini satellitari ad alta definizione, i profili di movimento superdettagliati, i sistemi di riconoscimento biometrico del volto; programmi gestiti grazie a stupefacenti algoritmi, memorizzati in banche dati di sconfinata capienza. L’ultimo accenno di reazione, ormai quasi dimenticato, contro lo zelo delle autorità tedesche e delle megaimprese risale al lontano 1983 — un anno prima della data che ha fornito il titolo al romanzo di Orwell. Un censimento relativamente innocuo suscitò allora un certo allarme, e le denunce di molti cittadini furono accolte dalla Corte costituzionale. Non solo i giudici di Karlsruhe condannarono l’iniziativa del governo, ma istituirono una nuova legge costituzionale sull’“autodeterminazione informatica”, a tutela della personalità. Una sentenza che oggi appare ingenua: di fatto, nessuno ne ha mai tenuto conto. Nella cyberguerra contro la popolazione i sostenitori della riservatezza dei dati sono impotenti, e da tempo hanno gettato la spugna. Su un punto invece — quello dell’evoluzione linguistica — George Orwell ha colto nel segno: la “neolingua” da lui descritta è assurta ormai al rango di gergo ufficiale della sociologia. La Costituzione non piace ai cosiddetti servizi. Distinguerli dai criminali informatici è tutt’altro che facile. Le nuove tessere sanitarie di fatto altro non sono che una card elettronica di censimento delle malattie, facilmente decriptabile da un qualsiasi hacker. E quanto ai social network, fanno leva sull’esibizionismo dei loro utenti per sfruttarli senza pietà. Un ultimo, molesto residuo di sfera privata è il contante. È dunque logico che lo Stato, di concerto con le corporation, metta in campo un impegno coerente per abolirlo, mediante la proliferazione di carte di credito, client card e altri sistemi di pagamento (tramite telefonia e chip) di prossima introduzione. L’obiettivo non potrebbe essere più chiaro: esercitare una sorveglianza capillare sulla totalità delle transazioni. A ciò sono inte- ressati, oltre al fisco, i network asociali, il commercio online, gli istituti di credito, la pubblicità e la polizia. Un altro effetto sarà quello di cancellare persino il ricordo della materialità del denaro, ridotto a una serie di dati manipolabili a piacimento. Al solo scopo di completare il quadro daremo infine uno sguardo a un settore collaterale, segnalando i tentativi in atto di abolire i diritti d’autore. Il copyright è una conquista recente, che risale al Diciannovesimo secolo. Fino a quel momento, la lettura di libri era un privilegio riservato a una piccola minoranza. All’improvviso, il romanzo divenne un prodotto di massa. Gli scrittori si resero conto che grazie ai diritti sulle tirature e sulle traduzioni, la letteratura poteva essere fonte di guadagni sostanziosi. Purtroppo non hanno avuto molto tempo per stare allegri. Il libro stampato, oggi denominato print, è diventato un modello di fine serie per le maggiori case editrici. Le quali considerano ormai il copyright come un ostacolo, con grande giubilo delle avanguardie digitali. Per questi allegri pirati, l’obbligo di pagare un prezzo per ciò che l’industria informatica definisce content è comunque assurdo. D’ora in poi gli autori, come venivano chiamati, dovranno rassegnarsi a lavorare gratis; in compenso potranno twittare, chattare e bloggare a piacimento. Nessuno sembra preoccuparsi del fatto che ormai il tempo di decadimento delle tecniche a nostra disposizione varia da tre a cinque anni — lo stesso ritmo dei cicli economici dei grandi gruppi informatici. Mentre un testo su pergamena o carta deacidificata rimane perfettamente leggibile a distanza di cinque secoli o anche di un millennio, i media elettronici devono essere riversati con una certa frequenza per non diventare inservibili dopo soli dieci o vent’anni: un dato che ovviamente collima con lo spirito dei loro inventori. L’abolizione del libro stampato non è peraltro un’idea nuova. Fu preannunciata nel lontano 1953 da Ray Bradbury, nel suo bestseller (!) Fahrenheit 451, che ne descrive gli sviluppi fino alle estreme conseguenze. In quel racconto utopistico, il possesso di un libro è consi- derato un crimine e punito con la pena di morte. Nelle loro visioni del futuro i grandi pessimisti tendono a esagerare; ma il fatto di essere confutabili depone in loro favore, e non contro di loro. Ciò è vero sia nel caso di Bradbury e Orwell che in quello di Max Weber. Ovviamente, per saperne di più col senno di poi non c’è bisogno di essere un genio. A fronte dei pronostici più tetri sorge una domanda, inevitabile come l’amen in chiesa: possibile che non ci sia qualche elemento positivo? La risposta è facile, visto e di grande soddisfazione: tutto ciò che è sopravvenuto grazie alla nostra volontaria servitù non ha richiesto spargimenti di sangue. I «residui del passato» non sono stati liquidati, come Lenin cercò di fare in Russia, ma continuano a esistere. E ciò per un motivo evidente: la tolleranza dei nostri sorveglianti si basa su un semplice calcolo costibenefici. Sarebbe troppo dispendioso tentare di stanare gli ultimi refrattari, di sopprimere una piccola minoranza caparbia, che per puro e semplice puntiglio si oppone al fato digitale. Ecco perché ci si accontenta di una sorveglianza al 95 per cento. Dunque, non è il caso di farci prendere dal panico: anche perché il restante 5 per cento equivale pur sempre a quattro milioni di persone. E così anche in futuro, chi proprio non potrà farne a meno, potrà continuare a mangiare e bere, amare e odiare, dormire e leggere analogicamente senza preoccuparsi più di tanto, e restare relativamente inosservato. Il controllo non è totale, un cinque per cento della popolazione resta refrattario. Ma viene tollerato in base a un semplice calcolo costi-benefici Traduzione di Elisabetta Horvat © Hans Magnus Enzensberger 2012 © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale DOMENICA 8 APRILE 2012 LA DOMENICA ■ 36 Spettacoli Revival Dopo il dominio del pop e le mega-produzioni stile “Spiderman”, Broadway riscopre il genio dell’autore di “Porgy & Bess” e fa il pieno al botteghino con due spettacoli in cartellone Un omaggio al primo compositore a portare il jazz nei musical e i musical all’opera. E a dare scandalo suonando le melodie dei “negroes” ANGELO AQUARO C’ NEW YORK è sempre qualcuno che la sa più lunga degli altri. «Ascoltando questa immondizia di facile presa, come il duetto tra Porgy e Bess You Is My Woman Now, c’è domandarsi come il compositore potrà più rinunciare a piegarsi a queste facili e inutili conquiste». Parola di Lawrence Gilman, l’allora celebratissimo — e oggi, Dio l’abbia in gloria, sconosciutissimo — critico musicale del New York Herald, giorno del Signore 11 ottobre 1935. Oppure prendete quell’altro genio di Oscar Thompson, esegeta di Claude Debussy, autore lui stesso di dotti trattati di estetica e critica, esimio professore alla Columbia University: «Come pensare — scriveva sull’Evening Post, 21 dicembre 1928 — che tra una ventina d’anni ci possa essere ancora un pubblico disposto ad ascoltare con pazienza e piacere le pagliacciate musicali del signor Gershwin?» E già: come pensare? E soprattutto: cosa pensare di fronte alle migliaia di persone che, più di ottant’anni dopo, si mettono ogni sera in fila a New York per l’ennesimo spettacolo di George Gershwin? Al diavolo i vecchi tromboni: portarono pure sfiga. Appena due anni dopo la profezia dell’Herald, 1937, invece di «piegarsi» ai facili successi, il più grande musicista d’America fu piegato da un tumore. E pure lontano della sua amata Broadway: addirittura nel campo nemico, Hollywood, dov’era volato per gli ultimi film con Fred Astaire. Al diavolo i vecchi tromboni. E invece fiato alle trombe, ai clarinetti — ah, l’inizio della Rhapsody in Blue che Woody Allen immortalò nell’inizio di Manhattan — e soprattutto alle voci e alle gambe, e che gambe e che voci, che stanno riportando Gershwin sulle scene. Per carità: vero è che il vecchio George non se n’era mai andato. E da Lady, Be Good! a Show Girl i suoi musical — ne scrisse una trentina — sono stati sempre saccheggiati per rilanciare qui e là quell’«immondizia di facile presa». Ma dice Laurence Maslon - il più grande storico dell’argomento, professore della New York University e autore del- Quando debuttò negli anni Trenta i critici parlarono di “immondizia di facile presa” e “pagliacciate” Pochi capirono che aveva trasformato il folk in musica classica le 470 pagine di Broadway: The American Musical trasformate col regista Michael Kantor in un documentario ormai cult - che era appunto dagli anni Venti e Trenta che mai s’erano visti, come ora, addirittura due suoi show nella stessa stagione. Proprio così. New York riscopre lo swing al ritmo indemoniato di Nice Work If You Can Get It, il musical appena aperto che costringe Matthew Broderick, l’ex ragazzino di War Gamesoggi sposo e padre felice accanto alla Sarah Jessica Parker di Sex & The City, a cimentarsi nelle evoluzioni che la regista e coreografa Kathleen Marshall confessa di aver rubato ai film di Ginger Rogers Un americano a New York super GERSHWIN Repubblica Nazionale DOMENICA 8 APRILE 2012 ■ 37 LA CARRIERA L’ESORDIO A BROADWAY RHAPSODY IN BLUE PARIGI SUMMERTIME CUBA Nato a Brooklyn nel 1898, inizia a scrivere canzoni a quindici anni Nel 1916 compone il primo capolavoro: When You Want’em, You Can’t Get’em Con Swanee, cantata da Al Jolson, nel 1919 diventa famoso e inizia la sua lunga carriera a Broadway che lo porterà poi a Hollywood Nel 1924 in meno di tre settimane scrive Rhapsody in Blue: sintesi di stili diversi, è ancora oggi uno dei pezzi più eseguiti in tutto il mondo Mentre si trova in Europa per rappresentare il suo Concerto in fa, nel 1928 a Parigi compone An American in Paris: l’opera strega il pubblico Ma il capolavoro assoluto resta Porgy & Bess, melodramma moderno che contiene alcune delle sue arie più famose come Summertime Nel 1932 un soggiorno all’Avana gli ispira l’Overture Cubana dove attinge a piene mani alla musica popolare delle Antille LE IMMAGINI FOTO © THE AL HIRSCHFELD FOUNDATION. WWW.ALHIRSCHFELDFOUNDATION.ORG. AL HIRSCHFELD ISREPRESENTED BY THE MARGO FEIDEN GALLERIES LTD., NEW YORK A sinistra, George Gershwin e Michael Tilson Thomas in un’illustrazione di Al Hirschfeld del 1976. A destra, la locandina di Nice Work If You Can Get It e, sotto, Porgy & Bess a New York nel 2011 e Fred Astaire. Una vera operazione vintage. Perché la storia del playboy di buona famiglia che si innamora di un trafficante di liquori non arriva dall’America del Proibizionismo e di Gershwin, ma è stata scritta nei giorni nostri per poter squadernare in scena il meglio del meglio di George: da Let’s Call the All Things Off a But Not For Me. Non solo. Malgrado la profezia malefica dei critici spocchiosi, Gershwin è in scena, per esempio, proprio con Porgy & Bess, l’opera che fece scandalo perché aveva per protagonisti quei negroes, come si diceva allora, che il compositore aveva scelto come «espressione della musica americana» e che — scriveva — «sono perfetti per il mio scopo: perché si esprimono non soltanto attraverso la parola parlata ma anche, e con naturalezza, attraverso la canzone e la danza». Canzone e danza sullo stesso piano della parola, e per di più sulla bocca, e sulle gambe, dei “negri”: più scandalo di così. Nei panni di Bess una star del calibro di Audra McDonald — quattro Tony Awards, cioè gli Oscar del teatro, e il successo tv con Private Practice — e in quelli di Porgy un baritono dalla solida reputazione come Norman Lewis (Les miserables, Chicago), la storia del mendicante disabile che cerca di salvare la bella nera dalle grinfie di un amante violento è già un fenomeno. Anche se proprio Maslon, forse per tenere anche lui fede alla tradizione dei prof criticoni, storce il naso. «No» dice «a Gershwin non sarebbe piaciuta. Questa è una di quelle produzioni che definirei uccisa dai troppi tagli: ci sono così tanti piccoli tagli alla musica, ma specialmente alla storia, che il suo valore viene sminuito di molto». Non che la regista Diane Paulus, anche lei vincitrice di un Oscar teatrale per la riedizione di Hair, sia impazzita: i tagli di cui parla il professore sono dovuti alla “traduzione” di Porgy & Bess, che è un’opera lirica, nel linguaggio più pro- fano di Broadway. Ma l’iniziativa è davvero più che ardita. Perché proprio con Porgy & Bess lo stesso Gershwin aveva già operato ai tempi una di quelle coraggiosissime sintesi per cui è diventato famoso: inventando l’“opera folk”. «Mi sono sentito chiedere spesso perché parlo di opera folk», scriveva il compositore, che era anche una bella penna, sul New York Times. «La risposta è semplice; Porgy & Bess è un racconto folk. E i suoi protagonisti avrebbero naturalmente cantato canzoni folk. Ma quando ho cominciato a lavorare sulla musica decisi di non utilizzare canzoni folk perché volevo che si sentisse una certa unità. Così ho scritto io stesso i miei spiritual e le mie canzoni. Ma resta comunque musica folk — e per questo, visto che è messa in forma operistica, Porgy & Bess è diventata un’opera folk». L’argomentazione è rivoluzionaria nel suo rinnovo della tradizione. Nell’America del 1935 questo figlio di immigrati ebrei di Odessa, venuto su tra Brooklyn e il Lower East Side, iscriveva se stesso nel solco dei grandi. Dai romantici come Robert Schumann, che tra i primi pescò nel folk scrivendo i suoi Lieder ispirati alle musiche campestri. Fino a quell’Antonin Dvorak con cui in America tutto cominciò, che per la sua Sinfonia dal Nuovo Mondo saccheggiò le melodie dei nativi e dei neri: «Sono convinto che il futuro della musica di questo paese», scriveva il musicista ceco, in visita alla fine del Diciannovesimo secolo negli States, «vada cercato nelle cosiddette negro melodies. Sono queste le canzoni folk d’America». Resta da chiedersi perché l’America abbia deciso di riscoprire la sua tradizione proprio ora. Resta da chiedersi perché senta il bisogno di riabbracciarsi a Gershwin proprio ora: a ritmo di jazz e di swing. «La verità è che negli ultimi dieci anni i musical avevano tutti strizzato l’occhio al pop: da Hairpsray a Jersey Boys. Era la musica dei baby boomer», spiega sempre Maslon, «e il risultato sono state commedie musicali che non sempre avevano anche buone canzoni. Ecco perché l’idea di riportare Porgy & Bess, ha funzionato subito. Stiamo parlando della più bella musica americana mai scritta per il palcoscenico: c’era bisogno di tornare a quel livello». Eccolo il tema dolente: l’eredità. Dopo Gershwin nessuno mai? In fondo in questi giorni anche un altro signore, e vivente, può vantare il record di due spettacoli a Broadway in contemporanea, Evita e Jesus Christ Superstar: e quel signore si chiama Andrew Lloyd Webber. «La prego», si inalbera il professore, «non ci sarà mai più nessuno come George Gershwin. L’uomo che portò il jazz a Broadway, che portò Broadway all’opera...». D’accordo: ma non è quello che in altri termini sta facendo oggi un altro grande? Dal rock a Broadway: ecco a voi Spiderman di Bono e gli U2. «Non lo nomini nemmeno! L’era di Gershwin fu un periodo di così grandi trasformazioni che no, nessuno potrebbe più ritrovarsi in quelle circostanze. E nessuno potrebbe quindi dare il contributo che diede lui». Mai contrastare i critici: la sanno sempre più lunga degli altri. © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale DOMENICA 8 APRILE 2012 LA DOMENICA ■ 38 Next Super Mario 2.0 Finali multipli decisi su Facebook, ambienti digitali sovrapposti alla realtà creati dai gps degli smartphone, nuovi personaggi inventati dalle app dei tablet, suggerimenti e varianti in tempo reale grazie a Twitter Ecco a cosa stanno lavorando i più grandi programmatori del mondo: la piattaforma del divertimento globale CONSOLE Oggi le console da casa e portatili sono la punta di diamante del mercato dei videogiochi. Il giro d’affari che producono è valutato tra i 50 e i 60 miliardi di dollari iamo nel caos e nessuno sa cosa sta per succedere. Ma sappiamo che sarà una rivoluzione». Warren Spector sembra a un tempo spaventato e divertito. Affastella parole rapide passando dal futuro al presente senza riuscire a trovare un punto fermo al quale ancorarsi. Classe 1955, aspetto da intellettuale newyorchese, è il game designer di punta della Walt Disney. Quello che è riuscito con Epic Mickey, a ottobre la seconda avventura, a rianimare un personaggio come Topolino ormai privo di qualsiasi profondità. E ora, dopo aver realizzato ben ventidue giochi elettronici dal 1990 a oggi, vede davanti a sé una prospettiva completamente nuova: «Un videogame per console che venga influenzato da Facebook, che interagisca contemporaneamente con un’applicazione per tablet e per smartphone, a sua volta legata alla versione per console portatile. Un gioco che permetta di costruire e condividere universi digitali, storie e personaggi, sfruttando tutte le potenzialità delle piattaforme ora disponibili». Basta un po’ di fantasia per immaginare il risultato. Videogame con finali multipli decisi sui social network. Ambienti digitali ad alta definizione sovrapposti al reale che, grazie al gps degli smartphone, riproducono in diretta quel che avviene per le strade di una città. Applicazioni che permettono di inserire nuovi protagonisti sfruttando la macchina fotografica del tablet e software per la manipolazione delle immagini. L’idea di Spector appena due anni fa sarebbe sembrata una follia. Improbabile oltre che impossibile. Og- «S GLOSSARIO Console Dal francese antico “sole”, tavola, associato al prefisso “con” è passato all’inglese e in ambito tecnologico è sinonimo di pannello di controllo e di macchina per videogame La console è game over con uno per Xbox 360», spiega David Reeves, a capo della filiale europea della Capcom, l’editore giapponese che ha pubblicato titoli come Resident Evil e Street Fighter. «Quel che già si potrebbe fare è collegare i videogame, ovunque escano, con musica e video. Domani? La visione di Spector potrebbe avverarsi, oppure potrebbe succedere che si arrivi a un’unica console. Di sicuro i giochi elettronici cominciano a essere un servizio, qualcosa che in futuro si sottoscriverà con un abbonamento per essere fruito ovunque e comunque». I pesi, in termini di giro d’affari, sono noti. Quello dei videogame tradizionali vale fra i cinquanta e i sessanta miliardi di dollari, ma è in calo quasi ovunque. Gli app store al contrario sono un business da 11 miliardi, mentre web e social network toccano quasi i cinque miliardi. Eppure sono proprio questi ultimi due i campi che avranno la crescita maggiore nei prossimi anni. Per gli app store si parla di 25 miliardi nel 2015, nove quelli per i browser. E la differenza fra i tablet e le varie Sony Playstation o Nintendo Wii, dal punto di vista della qualità della grafica, si sta assottigliando. Nel frattempo le persone che usano Flash, il software per le animazioni per browser e dunque anche per Facebook, hanno raggiunto quota un miliardo e 300 milioni. Adesso la Adobe sta per lanciare un motore grafico, Unity 3D, con il quale sviluppare videogame ad alta definizione. Che si aggiunge al progetto della Epic, colosso delle console e del pc, che vuol trasferire il suo Unreal Engine 3 usato nei blockbuster per Xbox 360 proprio su browser. «Flash diventerà la console per il web», ha sintetizzato Diana Helander di Adobe. Che suona come una dichiara- JAIME D’ALESSANDRO gi invece le cose stanno cambiando così rapidamente da renderlo un passaggio quasi inevitabile. Esistono già titoli che vivono su diversi dispositivi. Anzi, nel caso del gioco di calcio Fifadella Electronic Arts, su tutti i dispositivi e le piattaforme disponibili, incluso Facebook. Campi separati fra loro che hanno come vertice l’edizione per PlayStation 3 e Xbox 360, tecnicamente la più raffinata, poi convertita e resa compatibile con tutto il resto. Malgrado l’incomunicabilità fra i vari giochi, Fifa ha comunque smesso di essere un semplice videogame. È un brand che evolve 365 giorni l’anno nei tre ecosistemi digitali: console, tablet e smartphone, web e social network. Operazione da circa seicento milioni di dollari, che coinvolge sei o sette team sparsi per il mondo e sta accrescendo esponenzialmente la popolarità del marchio. «Tecnicamente è ancora difficile mettere in comunicazione un videogame per iPhone Social games Cross-platform Flash Per esteso tutti i giochi sociali da quelli da tavolo a quelli elettronici Ultimamente è la definizione più usata per indicare i videogame per social network Un software pensato per diverse piattaforme, che siano console (portatili o da casa), smartphone o tablet. Da noi viene tradotto a volte con “portabilità” fra i diversi device Il programma che dal 1996 è il più usato per creare animazioni su web. Sta diventando il mezzo principale per portare videogame in alta definizione sui social network Repubblica Nazionale DOMENICA 8 APRILE 2012 ■ 39 WEB E SOCIAL NETWORK I giochi in Flash, compresi quelli per Facebook come Farmville, hanno un giro di affari di cinque miliardi di dollari che dovrebbe arrivare a nove entro due anni ‘‘ Siamo nel caos e nessuno sa cosa sta per succedere Ma sappiamo che sarà una rivoluzione WARREN SPECTOR Game designer Walt Disney SMARTPHONE E TABLET Il mondo delle app su dispositivi mobili come iPhone e iPad è fatto per il 70 per cento da videogame. Vale 11 miliardi di dollari e dovrebbe crescere a 25 miliardi entro il 2015 zione di guerra, ma anche come una possibilità per costruire un ponte fra mondi diversi. In più si assiste a un travaso continuo di competenze da un settore all’altro. Dai videogame tradizionali alle applicazioni, ai social game. E viceversa. Nascono network dedicati a singoli videogame, le app si moltiplicano e la grafica è sempre più raffinata, nascono esperimenti di ogni genere e si chiede che le console del futuro abbiano un legame forte con Twitter, come ha auspicato Tim Sweeney, gran capo della Epic. «Cambia l’approccio allo sviluppo di videogame», conferma Tameem Antoniades con il suo accento britannico da salotto letterario. Vestito tutto di nero, stile rockstar new wave anni Ottanta, Antoniades è il direttore creativo della Ninja Theory di Cambridge, una software house che in passato ha lavorato con scrittori come Alex Garland e musicisti del calibro di Nitin Sawhney. Sta finendo il nuovo Devil May Cryper Capcom, ma già pensa al futuro. «La distinzione fra le diverse tipologie di giocatori si sta facendo labile, al pari di quella fra le piattaforme». Il mantra che molti colleghi di Antoniades ripetono sempre, da Peter Molyneux di Fable a David Cage di Heavy Rain, è che il settore dei giochi lo si può paragonare al cinema degli anni Venti, all’epoca del muto. Guardando il livello di raffinatezza di certe produzioni ad alto budget, sembra un’affermazione impietosa. Ma se invece consideriamo la prospettiva tracciata da Spector allora il paragone comincia a calzare. «Abbiamo ancora tante cose da sperimentare», conclude lui. «Siamo davvero solo all’inizio». FIFA Uno dei primi ad andare dalle console da casa a quelle portatili, dai tablet agli smartphone fino al pc e a Facebook SKYLANDERS CLOUD PATROL Appena uscito su iPad e Android, è l’ennesimo gioco per console che passa agli app store © RIPRODUZIONE RISERVATA App store Negozio virtuale di applicazioni per tablet, smartphone, computer e smart tv. Inventato dalla Apple nel 2008, oggi è diventato paradigma di una nuova concezione di internet BALDUR’S GATE Uscito nel 1998, ora è in versione per browser e cross-platform: pc, mac e iPad. E i giocatori potranno sfidarsi tra loro Repubblica Nazionale DOMENICA 8 APRILE 2012 ■ 41 La paranza francese, il maialino castigliano, l’immancabile Guinness irlandese e i piatti a base di latte cagliato dalla Finlandia alla Russia Mai come adesso il cibo diventa simbolo della natura che risorge dopo il gelo dell’inverno Pescado calzado EL SALVADOR Lamb cake STATI UNITI Dayenu ISRAELE Kutya RUSSIA Pasha FINLANDIA A base di tvorog, cioè latte acidificato filtrato, il dolce della Pasqua finnica va lavorato con burro, uova, panna e servito con pane dolce al cardamomo (pulla) Il dolce di grano e miele, simbolo di fertilità, apre il pranzo della Pasqua ortodossa A seguire, pesci, polpette e la pasta con ricotta e prugne (vareniki) Tra le ricetta rituali della Pasqua ebraica, il brodo di carne con pane azzimo spezzettato e uova sbattute, profumato di cannella. Variante con gli spinaci Farina, latte, uova, zucchero e semi di papavero nella ricetta della torta americana a forma di agnello Panna arricchita con cioccolato bianco per la glassa Per la Pasqua in Salvador, filetti di boca colorada (cernia) fritti, rifiniti in pentola insieme a ceci, patate e brodo di pesce addensato con farina di mais Hot Cross Buns REGNO UNITO Sulle tavole inglesi fin dal venerdì santo, le brioschine speziate (cannella, chiodi di garofano, noce moscata) decorate con una croce di glassa di zucchero A tavola La danza della torta verde per il “merendino” del lunedì ENZO BIANCHI n Monferrato e nelle Langhe al lunedì dell’Angelo, “Pasquetta”, tutti si affrettano a cercare un lembo di prato dove batta il sole, per fare il “merendino”: si arriva verso mezzogiorno con cestini carichi di cibi preparati la sera prima o il mattino stesso, si stende una tavola sull’erba ancora bassa, mentre “gli uomini” stappano le bottiglie di vino. È il canto di vittoria sull’inverno e sul freddo che costringevano tutti in casa: finalmente si sta all’aria aperta, quasi a celebrare il sole che ricomincia a scaldare. Tra i piatti preparati, fa da regina la “torta verde” o “pasqualina monferrina”, una torta fatta con le prime erbe raccolte nei campi o negli orti: spinaci, radicchio verde, cicoria, punte di asparagi selvatici. Passate in padella con olio e aglio, tritate e mescolate con uova e parmigiano, esaltate dal profumo-sapore della maggiorana, le erbe creano un impasto che accoglie an- I cora del riso cotto al dente prima di finire in forno, impreziosito da qualche ricciolo di burro. Le fette compatte, di un verde splendente, esaltano i grani di riso che luccicano ormai trasparenti. Così la torta verde fa da regina e pietanze più consistenti — dai salumi ai formaggi, alle cotolette di coniglio impanate — le danzano attorno come damigelle d’onore. E lei, spodestato per un giorno il pane, si accompagna gioiosa a tutti i piatti. L’allegria è resa piena da un bicchiere di grignolino o di freisa secca, ormai preziosa rarità: i cuori si accendono, i canti si rincorrono da una collina all’altra, preludio di altra musica di festa che accompagnerà la vendemmia, quando la stagione apertasi sul verde dei prati si spegnerà nei colori di fiamma dell’autunno. Ricordi di un tempo che fu? Non credo: io, come tanti altri, Pasquetta la vivo ancora così, con questi sapori sul palato e nel cuore. © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale DOMENICA 8 APRILE 2012 LA DOMENICA ■ 42 L’incontro Maestri Da bambino leggeva un libro al giorno. La passione per il cinema è venuta dopo, quando era postino e correva da una sala all’altra dalle tre del pomeriggio a mezzanotte. E ora che ha cinquantacinque anni, di cui trenta passati a fare il regista, rivela: “Da tempo dico che il prossimo film sarà l’ultimo Così potrò finalmente andare per funghi e riparare cianfrusaglie” Aki Kaurismäki on s’è ancora seduto che ha già acceso una sigaretta: «Non si spaventi: è elettronica, nessuno qui morirà. La nebbiolina che vede uscire è vapore acqueo. Surrogato necessario ma non sufficiente: nemmeno l’ombra del primo tiro mattutino dopo il caffè. “Nessuno è perfetto”...». Ecco il primo dei virgolettati da film celebri che continueranno a srotolarsi, alternandosi a battute di spirito e annotazioni lunari, nella conversazione fuori del mondo con Aki Kaurismäki, cinquantacinque anni appena compiuti (il 4 aprile) e tanta voglia di scherzare, dietro gli abituali impacci. La faccia rossa di timidezza e di birra, di cui affiora sul tavolino la bottiglia agli sgoccioli, il regista distillerà i suoi pensieri quasi sempre a occhi bassi e a denti stretti, come se parlasse a se stesso. Ricorre l’amata-odiata Finlandia, il Paese dove si sente un esule, anzi, un alieno sin da quando ci viveva e lavorava a tempo pieno, prima di trovare altre patrie, magari provvisorie, come adesso la Francia o il Portogallo, in cui trascorre la maggior parte dell’anno vicino a Porto, circondato e rassicurato dalle vigne generose: «La Finlandia è una patria fantasma, priva d’una sua ‘‘ finlandese. Noi non abbiamo nemmeno il petrolio! E avevo aggiunto un post scriptum per Donald Rumsfeld, invitandolo piuttosto al viaggio inverso, a raggiungermi nelle foreste per andare insieme a raccogliere funghi.: “Questo forse la calmerà”». L’incetta di funghi è tra i suoi precetti distensivi più frequenti: «Vale anche per me. Da anni prometto che il prossimo film sarà l’ultimo: dopo di che potrò finalmente seguire con tranquillità l’epifania dei funghi e riparare vecchie cianfrusaglie. Prima però ho da terminare la trilogia portuale iniziata da Le Havre con un film da girare in Spagna e uno in Germania. E poi: sipario!» Oltre ai funghi, la musica ha per lui un effetto calmante: «Mi piace tutta, dalla classica alle canzonette. Ho una quantità sconsiderata di cassette e dischi, che mi porto dietro in una cesta di legno, anche se poi ascolto sempre gli stessi, quelli che metto insieme, a ca- Non metto piede negli Usa: hanno rifiutato Kiarostami, perché dovrebbero volere un finlandese Noi non abbiamo nemmeno il petrolio FOTO CORBIS N PARIGI identità. Helsinki? Irriconoscibile. Possedeva la bellezza delle grandi città dell’Est: oggi sembra un albero di Natale, tutto luci al neon e pizzerie. Il panorama cosiddetto finnico è oggi una selva d’insegne pubblicitarie: Nestlé, Nokia, Shell. È un Paese che si è venduto agli stranieri, come aveva profetizzato venticinque anni fa il mio Amleto, vano oppositore della chiusura di segherie e stabilimenti poco produttivi a profitto di multinazionali specializzate nella produzione di anatroccoli di plastica». E il cinema finlandese, che lei continua a alimentare, coprendone, insieme a suo fratello Mika, quasi un quarto dell’intera produzione? «Tra cinema finlandese e cinema italiano, io farei il cambio subito: soprattutto al mattino, la sera non so più». La fiera marginalità che fin dall’inizio ha contraddistinto Kaurismäki regista lo guida anche nella spigolosa quotidianità, dove ha l’aria d’essere solo un ospite di passaggio della vita ordinaria, inafferrabile e astratto, erede dal vero del diletto Buster Keaton: «Il mio modello nella superiore dignità con cui affronta il mondo avverso». L’acqua, per esempio, la grande nemica: non a causa, come si sospetterebbe, della gradazione alcolica zero. «Vede la scritta in piccolo sull’etichetta?», addita il cineasta, respingendo la minerale italiana da tempo inghiottita da una multinazionale. «La colonizzazione commerciale è indicata a caratteri microscopici, ovviamente, ma in questo io sono un campione di pointillisme: nulla mi sfugge, a costo di trascorrere ore nel fare la spesa, il che rende mia moglie furiosa. Ma con me ogni etichetta passa sotto la lente d’ingrandimento». Anche il continente nordamericano è diventato per lui una piccola etichetta, ogni volta da svergognare: «L’autunno scorso, a promuovere nei festival statunitensi Miracolo a Le Havreho mandato il mio attore André Wilms, perché mi rifiuto di mettere piede negli Usa: non intendo piegarmi all’imposizione di controlli antropometrici dell’identità, lasciando le impronte digitali in balìa della loro polizia». Già dieci anni fa, aveva declinato l’invito del Festival di New York dopo che era stato rifiutato il visto ad Abbas Kiarostami: «Avevo risposto però con un biglietto: se il governo Bush non vuole saperne d’un iraniano, a maggior ragione non avrà nulla da spartire con un saccio, nei film, occupandomi io stesso di mixarli nella sala di montaggio che ho ricavato dalla mia casa a Karkkila». La sua oasi musicale, celebrata per la pista di danza all’aperto dell’hotel Oiva da lui diretto: «Adesso non più: troppo stress. Ma per anni, d’estate, è servito a diffondere, anche con dischi da me prodotti, una rarità assoluta, di cui mi vanto d’essere promotore e teorico: il tango finlandese. Si meraviglia? Ho in Carlos Gardel un padre spirituale. Secondo studi recenti, era una marinaio finlandese, che la famiglia della madre non ha mai voluto riconoscere. Per anni ha trascorso le notti in un giardino pubblico a cantare sommessamente sotto le finestre i refrain del suo Paese, prima che lo obbligassero a prendere il largo. La leggenda vuole che le sue lacrime abbiano fatto crescere un’enorme quercia». Rimasta senza tanghi la pista estiva dell’hotel Oiva, l’altra “discoteca” di Kaurismäki continua a essere la berlina nordica fuori tempo massimo, arruffato bazar a quattro ruote di cartacce, riviste, casse di birra, libri e montagnole delle melodie finlandesi preferite, quelle di esasperante sentimentalismo di un amico crooner da poco scomparso: «Le metto a tutto volume quando, con moglie e cane, attraverso l’Europa. Per rassicurare entrambi, prima di salire e mettermi al volante, faccio loro una dimostrazione con il mio alcoltest portatile, di ferro nero. Questo. Fa un po’ Kgb degli anni d’oro, no?». Mai nessuna lamentela dai suoi compagni di viaggio? «Il miracolo della mia vita è stato incontrare mia moglie. È lei che dirige i cani nei miei film. Dopo tre giorni che scrivo una sceneggiatura, lei bussa alla porta: “Aki, hai preso in considerazione una parte per il cane?”. Nel mio cinema si sono avvicendate cinque generazioni di quadrupedi. Li adoro, perché non fanno mai critiche e non si perdono in inutili analisi». Come nascono i timidi, impacciati, quasi afasici personaggi di Kaurismäki, che in trent’anni, da La fiammiferaia a Ho affittato un killer, a Nuvole in viaggio, L’uomo senza passato, hanno conquistato le platee? «Da una passione confessabile: la letteratura. Ho sempre letto moltissimo, fin da bambino: quasi un libro al giorno, come una macchinetta. A Karkkila ho più di cinquemila volumi, molti riletti più volte. La mia vera mania, anche più dei film, resta la lettura, da Kafka a Gogol, al vostro Tomasi di Lampedusa: Il Gattopardo è forse il miglior libro di tutti i tempi. La passione per il cinema è cominciata più tardi, nel quartiere operaio di Kurvi dove ho trascorso la giovinezza: ero postino, mestiere che mi permetteva di assistere alle proiezioni dalle tre del pomeriggio a mezzanotte. I quartieri periferici erano allora ricchi di sale: andavo dall’una all’altra spostandomi in tram. La mia preferita era il Savoy, sede della cineteca: avevo il mio posto fisso, al centro della prima fila, mi si riconosceva dai capelli lunghi e lisci alla Jean-Pierre Léaud di cui fin da ragazzo ero un fan assoluto». Da spettatore è poi divenuto esercente: «Quando ho cominciato con mio fratello a rastrellare le sale di quartiere, per prima cosa le ho svuotate dei distributori di pop-corn, riempiendo gli schermi di film di rara distribuzione, come quelli dell’ancora sconosciuto Almodóvar, aprendo poi sotto i bar del centro un altro cinema: quando Helsinki ha esaurito le capacità di assorbimento cinematografico, ho calamitato le pellicole in Lapponia, al mio Festival del sole di mezzanotte». «Let’s Go» («Andiamo») è l’improvviso commiato di Kaurismäki. È il virgolettato d’un altro film di leggenda: «Indovinato? Mucchio selvaggio, l’inizio della carneficina». © RIPRODUZIONE RISERVATA ‘‘ MARIO SERENELLINI Repubblica Nazionale LA DOMENICA DOMENICA 8 APRILE 2012 ■ 40 I sapori C’è il capretto al forno e il pesce impanato, la zuppa d’agnello o il dolce di grano. E poi naturalmente le uova Di rito In questi giorni di celebrazioni cattoliche, ebraiche e ortodosse, che arrivano fino a sabato prossimo, ecco cosa si mangia nel mondo Il giorno che la Terra diventa ovale LICIA GRANELLO C’ è chi serve il capretto al forno e chi il pesce impanato, chi non prescinde dalle erbe amare e chi abbonda con l’uvetta nel pan dolce. La Pasqua degli altri assomma i sapori e i colori del mondo, in nome di una celebrazione tutta da godere a tavola, laica o religiosa che sia. Questione di ingredienti. Che dall’Europa al Nuovo Mondo coincidono con i diversi piani di lettura della Pasqua: testimonianze di resurrezione e miti di fertilità, bandiere della primavera appena sbocciata e simboli del sacrificio più grande, il legame con la terra e la forza generatrice del mare. A partire dalle uova: non c’è Pasqua che possa prescindere dall’emblema della vita in fieri all’interno del guscio, con il suo carico di valenze simboliche, come testimonia la novella secondo la quale Maria Maddalena, ammonita da Pietro al quale si era rivolta dopo la scoperta del sepolcro vuoto («Crederò a quanto dici solo se le uova di quel cestello diverranno rosse»), le vide davvero arrossarsi e le portò all’imperatore Tiberio, per testimoniare l’avvenuta resurrezione di Cristo. Molto più delicata la questione dell’agnello, “sacrificale” per antonomasia. La Pasqua ebraica si chiama Pesach (dal verbo ebraico pasoah, passare oltre, da cui anche il nome italiano) in memoria della notte in cui l’angelo della morte uccise tutti i primogeniti egiziani, “passando oltre” le case degli ebrei, marchiate preventivamente con sangue d’agnello. Da allora, tra i cibi rituali della Pesach figura la zampa d’agnello arrostita. Una tradizione religioso-culinaria, estesa ai cristiani, che ha spopolato per molti anni, trasformando le varie ricette a base di agnelli e capretti in altrettanti “must” del pranzo pasquale. Per soddi- sfare le richieste del mercato si è creata una catena alimentare collegata agli allevamenti dell’Est europeo concentrata a inizio primavera, con migliaia di ovini lattanti stipati e trasportati fin qui per diventare i nostri arrosti della festa. Proteste, sensibilizzazione al problema e le proposte di ottimi piatti alternativi hanno fatto lentamente scendere i numeri delle macellazioni, che l’anno scorso si sono fermate a quota 711mila. Ancora tante, ma cinquantamila in meno. Per fortuna i dolci non richiedono altro sacrificio che la remise en forme alla fine dei festeggiamenti. Ricotta e latte cagliato firmano le ricette più golose, omaggio alla primavera e alla leggiadria dei suoi aromi. Questo infatti è il periodo in cui il latte — quello serio, munto da mucche, pecore e capre ben alimentate e libere dal giogo degli allevamenti intensivi — profuma della prima erba fresca, con la sua carica di micronutrienti. Un tesoro olfattivo e gustativo che si trasferisce pari pari nel siero — dal cui riscaldamento si ottiene la ricotta — e nelle cagliate, primo passo della lavorazione dei formaggi, dove il gusto lievemente acidulo rinfresca i sentori grassosi del latte. Visto che i giorni della Pasqua cattolica, ebraica e ortodossa sono racchiusi nella settimana che corre fino a sabato prossimo, saltabeccate allegri tra una ricetta e l’altra, deliziandovi con i piatti rituali, che in questi giorni mettono allo stesso tavolo qualche miliardo di persone. Alla fine, una fetta di colomba, pastiera o cassata chiuderanno il cerchio. O meglio, l’ovale. Di cioccolato, of course. Pasqua con chi vuoi Maghiritsa GRECIA Stufato alla Guinness IRLANDA Cochinillo asado SPAGNA Friture de pays FRANCIA © RIPRODUZIONE RISERVATA La zuppa che chiude il sabato santo è una minestra di riso e cipolla con brodo d’agnello, le sue frattaglie, uova battute con succo di limone e aneto La bevanda nazionale irlandese firma il piatto principe della Pasqua: controfiletto a tocchetti,cipolla, pancetta e un fiume birra. Si serve con salsa di lamponi Tipico della Pasqua castigliana, il maialino cotto al forno dopo averlo cosparso di lardo (lavorato con sale, aglio e pepe nero) e adagiato su foglie di alloro La versione francese del nostro fritto di paranza rallegra la tavola pasquale in alternativa alle carni tradizionali, soprattutto nelle regioni marittime Repubblica Nazionale
Scarica