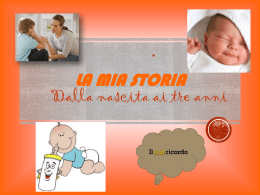LINDA INDA DE E MARCHI ARCHI SOTTO IL GONFALONE DI S. GIORGIO La mia fanciullezza in tempo di guerra CENTRO STUDI BERICI Il gonfalone di S. Giorgio è il vecchio stendardo rosso dell’antica parrocchia di Toara, lo stendardo fiammeggiante dietro cui si raccoglieva tutto il paese nei grandi momenti religiosi e civili che ne segnavano la vita. Nel presente libro il “gonfalone” diventa il simbolo della storia e della vita di tutto un popolo, a cui l’autrice dedica questi ricordi. Il libro ci parla infatti della vita, com’era sessanta anni fa, in una piccola frazione del basso vicentino. Leggerlo è aprire una di quelle vecchie cassettiere, d’antico legno odoroso, appena ne tiri un cassetto sei sorpreso nel trovarvi lenzuola fresche di spigo, lavate e stirate ier l’altro. Il libro della maestra De Marchi è uno spaccato di storia minore, quotidiana, sconosciuta ai libri, del nostro ventesimo secolo. Esso rievoca dieci o dodici anni a cavallo fra la seconda metà degli anni trenta, e gran parte degli anni quaranta (il racconto finisce con il 1948). Davanti gli occhi incantati d’una bimba inquieta e ribelle scorre il film della vita quotidiana di un piccolo e povero villaggio del nostro Veneto, immerso in una natura generosa e splendente. Con lei è come stare dietro una telecamera curiosa ed impertinente che immortala le situazioni di vita d’ogni giorno. Nel libro sfilano i lutti, le sofferenze e le fatiche delle famiglie, i momenti di festa, le testimonianze sui tanti mestieri così come si svolgevano allora, i giochi dei bimbi, le loro imprese scolastiche, la vita quotidiana del paese, con le sue speranze, i sacrifici, le povertà, gli affetti, i riti religiosi. Tutto viene riferito con sorprendente vivacità, ed una freschezza di particolari che ci riporta dentro il clima di quegli anni, duri ma ricchi di speranza. Non è il solito libro nostalgico sul come eravamo, ma un modo d’assolvere un debito di riconoscenza dell’autrice verso la gente, semplice e grande del suo paese. Occorre ringraziare la De Marchi, e l’editore. Pubblicare questo libro è un’operazione di grande civiltà, il ricordare è infatti un dovere etico e civile. Soprattutto oggi che, in nome d’un presunto rispetto di altre culture, sembra quasi sembriamo divenuti tutti paurosi restii a coltivare l’amore, la difesa, il ricordo della nostra civiltà, e della nostra fede. Il popolo che appare nel libro è animato da un insopprimibile anelito di riscatto e, sotto il Gonfalone di San Giorgio s’incammina verso un mondo migliore. L’attualità del libro sta in questo: la resistenza al male dei nostri padri e nonni, è un richiamo a risvegliarci dal torpore. Abbiamo bisogno d’essere risvegliati dall’ignavia, e di ritrovare antiche, sopite energie, per iniziare anche noi, prima che sia troppo tardi, una nuova resistenza, morale, ed etica, al male, alla volgarità ed alla disonestà dilaganti. Dobbiamo anche noi di ritrovare un nuovo gonfalone di S. Giorgio…. O almeno dire sotto quale stendardo vogliamo camminare. Così la marcia del popolo descritta dalla maestra De Marchi diventa per noi richiamo, appello, esortazione, stimolo a non cedere, a non mollare, a non darla vinta al male, a resistere! Questo è un libro che piacerà e commuoverà gli anziani, che hanno vissuto quei tempi, poiché in questi ricordi ritroveranno se stessi e la loro vita; incuriosirà i giovani, stuzzicando la loro sete di conoscere le loro radici, ed il ceppo da cui provengono (senza conoscere il proprio passato non ci può essere orientamento per il futuro), infine confermerà gli adulti, ridando loro motivazioni e voglia d’impegnarsi sempre più nel nostro, non facile, presente. P. ANDREA ARVALLI Alla mia carissima Toara, a coloro che sono qui vissuti, a coloro che qui vivono e che qui vivranno, dedico questi ricordi, con grande amore. LINDA DE MARCHI SOTTO IL GONFALONE DI S. GIORGIO La mia fanciullezza in tempo di guerra. Altissimo 2007 INDICE Cap.1. La mia amata famiglia: un nido messo alla prova… 1.1. Amore geloso per la mamma 1.2. Vari ricordi d’infanzia 1.3. La mia mamma muore. 1.4. Prima comunione e cresima 1.5. Ai tempi di nonno Gustinello 1.6. La mia famiglia e la guerra. 1.7. Utensili domestici 1.8. La morte del babbo 1.9. L’affetto di zio Luigi, e zia Carolina Cap.2. La fontana del villaggio: una folla di volti nella piazza del paese. 2.1. Presso la fontana della morarona 2.2. Le funzioni religiose della domenica pomeriggio 2.3. Venivano tutti a cantare il vespro. 2.4. I conti Piovene, la villa, e l’oratorio 2.5. Un fattore antipatico 2.6. Ci divertivamo così Cap. 3 Una folla di poveri. Accomunati da una stessa fatica. 3.1. La fila dei poveri del giovedì Testi a cura dell’autrice aprile 2007 3.2. Figure caratteristiche Stampato «pro manoscripto» 3.4. Le forme sociali, il modo di vestire 3.3. Tutti eravamo poveri. 3.5. Carriole ad uso promiscuo… Foto di copertina: Maria, Linda (sulla sedia) e Giuseppe davanti alla casa degli zii Elena e Cesare. Sulla porta della casa, la piccola Rosetta, guarda curiosa. 3.6. Rimedi pratici per la salute: Silvio cotto al forno. 5 Cap.4. Dall’album di scuola. Imparare a leggere e scrivere in tempo di guerra. 6.4. Giochi di fanciulli 4.1. A scuola da Colorinda 6.5. Il vecchio delle ciliegie. 4.2. Il fossile donato dal papà: un’inutile crudeltà. 6.6. Piccola apostola… 4.3. Arpalice ed il soldato tedesco 6.7. La spigolatura 4.4. A proposito di Maranteghe e rastrelli senza sangue…. 6.8. Famigliari in vacanza. 4.5. Il coprifuoco 6.9. Moralizzare i costumi… 4.6. La quarta elementare a Belvedere 4.7. Andare a scuola in tempo di guerra Cap.7. Il gonfalone di S. Giorgio: tutto il paese sotto il campanile! 4.8. La morte dell’Orlando 7.1. La vigilia delle feste. 4.9. La liberazione 7.2. La grande Settimana Santa 4.10. Un grande premio: ripetere la quinta! 7.3. La festa dei oto 7.4. Il Corpus Domini: sotto il gonfalone di S. Giorgio. Cap.5. I cento mestieri. Antichi lavori nel mio villaggio, il sudore del pane. 7.5. Le Rogazioni. 5.1. Il mugnaio 7.6. Le feste mariane. 5.2. La lissia: il grande bucato. 7.7. Cristo Re, Ognissanti, e Fedeli Defunti. 5.3. La sabbia per lucidare. 7.8. Il ritiro parrocchiale. 5.4. Prisco il ciabattino. 7.9. Il tempo delle Novene. 5.5. La vendemmia 7.10 Il Santo Natale. 5.6. Il bachi da seta. 5.7. Canapa, fibre, e filature. Epilogo. 5.8. I cavatori di ghiaia, e il povero Silvio Moreto. Un’infanzia terminata anzitempo. 5.9. L’azienda trasporti del paese, e la vaca mora. 5.10. L’allevamento degli animali. 5.11. Frutta e verdura dal el Montàn 5.12. Anche i preti mangiano? 5.13 La ghiacciaia, e altre meraviglie. Cap.6. Nei mesi estivi. Crescevano nello splendore del creato. 6.1. Liberi dalla scuola 6.2. La casetta rossa e altre mete. 6.3. La Sguizzara 6 7 PRESENTAZIONE E’ motivo di grande gioia, e di onore, per me poter presentare questo libro di memorie sulla vita, com’era sessanta anni fa, a Toara, frazione del piccolo comune di Villaga, nel Basso Vicentino. Il libro pare scritto tutto d’un fiato, ma è frutto d’antiche memorie, sedimentate come buon vino per decenni, eppure ancora fresche, che, ad ascoltarle, ti sembran di ieri. Leggerlo è come aprire una di quelle vecchie cassettiere, d’antico legno odoroso, appena ne tiri un cassetto sei sorpreso nel trovarvi lenzuola fresche di spigo, lavate e stirate ier l’altro, che è una bellezza sentirne la leggerezza sulle dita, averne negli occhi il candore, e nei sensi il profumo del pulito d’un tempo. Cosa ha permesso all’autrice, la maestra Linda De Marchi, di conservare così freschi e nitidi quei ricordi d’infanzia, è uno di quei prodigi di cui è capace il cuore dell’uomo. Ri-cordare significa mettere nel cuore, e quando un cuore è puro, tutto ciò che vi è conservato non invecchia, né si consuma. Come il fuoco del roveto ardente, che bruciava e non si consumava, simbolo mirabile d’un eterno presente, i veri ricordi non conoscono l’usura del tempo. Forse era questo cui alludeva Gesù nel suo Vangelo quando ci invitava a ritornare come bambini? Quasi un invito a ritornare, attraverso la grazia del ricordo, alla freschezza della nostra fanciullezza: se avete un cuore puro potrete sempre essere nuovi. Abbiate però attenzione ad essere fanciulli quanto a malizia, ma adulti quanto a giudizio! Il libro va letto con questi due occhi, quello del fanciullo, ma anche con quello critico dell’adulto che non s’attarda in nostalgie fuori luogo. Leggiamo il libro per quello che è, con la sapienza dello scriba evangelico che cava dal suo tesoro le cose preziose del ricordo, ma anche quelle nuove del giudizio consapevole. Se ci volgiamo a vedere cosa c’è alle nostre spalle, è per andare con più sicurezza in avanti, e non per precipitarci a mettere una disastrosa marcia indietro…. 9 Niente nostalgie dunque! Non è il solito libro sul come eravamo. E’ qualcosa di diverso: un atto di amore verso il proprio mondo, un modo d’assolvere un debito di riconoscenza dell’autrice verso gente, semplice e grande, verso quel mondo che l’ha generata, e nutrita, e che ha ancora tanto da darci e da dirci, perché in esso affondano le nostre radici. E’ un atto eucaristico, e di fede verso le proprie radici, ben piantate nell’alma terra vicentina, e verso alcuni valori intramontabili, vissuti e testimoniati con una chiarezza che non ha bisogno di parole di spiegazione, né di difensori d’ufficio. Occorre ringraziare la De Marchi, e l’editore. Pubblicare questo libro è un’operazione di civiltà, perché il ricordare è un dovere etico e civile. Soprattutto oggi che in nome d’un presunto rispetto di altre culture, e altre religioni, sembra siamo divenuti tutti paurosi e restii nel promuovere l’amore, il rispetto, la difesa, della nostra civiltà, della nostra patria, della nostra religione, della nostra fede. Un uomo, ed una civiltà senza memoria, senza patria, senza tradizioni, sono un uomo ed una civiltà senza futuro... Una pianta senza radici presto cessa di fare frutto e muore. Forse il disagio che viviamo sta anche in questa mancanza di memoria. In anni recenti ci siamo tanto protesi nel progresso verso il futuro, da esserci dimenticati del nostro passato, quasi fosse qualcosa di superfluo, o da mettere in soffitta… Così, paradossalmente, il futuro si è rivoltato contro di noi, ed ora anziché costituire una promessa, è un incubo ed una minaccia. Come uscirne? Ci aiuterà ritrovare le nostre nascoste radici. Più profonde, fresche e vitali sono queste radici, più verde, fronzuta, e fruttuosa è la chioma dell’albero! Più siamo innestati nel passato, più serenamente saremo aperti al futuro…. Così appoggiai volentieri l’idea della maestra De Marchi di pubblicare i suoi ricordi. La mia fatica è stata quella di ridistribuire i contenuti, suddividendoli in capitoli, e paragrafi per facilitarne la lettura, dando un minimo di ordine rimaneggiato alla sequenza dei ricordi. Mi pare ne sia venuto un testo che potrà suscitare l’interesse degli studiosi delle nostre tradizioni popolari, e che saprà commuovere ed appassionare il cuore di tanta gente semplice. soffre, crede, spera, fatica, senza mai salire agli onori della cronaca. Il libro della maestra De Marchi è uno spaccato di storia minore, quotidiana, sconosciuta ai libri, dell’Italia e del Veneto del nostro ventesimo secolo. Esso rievoca, senza pretese cronachistiche, dieci o dodici anni a cavallo fra la seconda metà degli anni trenta (la maestra De Marchi è nata infatti nel ’36), e gran parte degli anni quaranta (il racconto finisce con il 1948). Davanti agli occhi incantati d’una bimba inquieta e ribelle, scorre il film della vita quotidiana d’un piccolo e povero villaggio del nostro Veneto, nel basso vicentino, povero come tanti, immerso in una natura generosa e splendente. Con lei è come se fossimo dietro una telecamera curiosa ed impertinente, che immortala le situazioni di vita d’ogni giorno. Mi sia permesso anche di elogiare la grande delicatezza con cui viene trattata tutta la materia. Sarebbe stato facile, alla De Marchi, cadere nella denuncia facile. A qualcuno il libro potrà sembrare troppo idealista: non è così. La De Marchi tace volutamente tante cose, coprendo d’un velo di discreto e rispettoso silenzio tante pagine poco belle della vita del suo villaggio… Non vuole lanciare denuncie né fare polemiche. Neppure romanticizza una situazione sociale che era tutt’altro che romantica. Non erano tutti santi, l’autrice lo sa, ma ritiene opportuno tacere, e velare tante sofferenze e miserie, serbandole nel cuore, d’altronde ciò che esprime è assai di più di quanto tace. Nel libro sfilano i lutti, le sofferenze e le fatiche delle famiglie, la vita d’ogni giorno, i momenti di festa, le commoventi testimonianze sui tanti mestieri così come si svolgevano allora, i giochi dei bimbi, le loro imprese scolastiche, la vita quotidiana del paese, con le sue speranze, i sacrifici, le povertà, gli affetti, i riti religiosi. Tutto viene riferito con sorprendente vivacità, e con una freschezza di particolari che ci riporta dentro il clima di quegli anni duri ma ricchi di speranza. Già Manzoni ci aveva insegnato che non esiste solo una “grande storia”, una storia “maggiore”, fatta dai “grandi”, grandi personaggi, re, condottieri di eserciti, uomini politici, diplomatici, papi, e di grandi eventi, battaglie, guerre, decreti ecc…, ma che c’è anche una “storia minore”, fatta dalla “piccola” gente, la gente di ogni giorno, umile, senza potere, senza fama, nascosta, che La maestra De Marchi però in questo libro fa qualcosa di più. Ella colora un affresco, tratteggia una specie di teologia della storia che immortala l’eterna e sempre attuale lotta tra il bene ed il male. Nel libro il male appare con le forme dei quattro oscuri cavalli dell’Apocalisse: la guerra, la carestia, la malattia, la morte, mentre il bene è simboleggiato dalla visione trasfigurata, quasi onirica, dello stendardo di S. Giorgio, l’antico gonfalone rosso, in cui campeggia il cavallo bianco del prode cavaliere cristiano che sconfigge il male, dietro cui si 10 11 schiera compatto tutto il villaggio. Così la bimba irrequieta, testarda ed indisciplinata, l’orfanella Linda, diviene in realtà l’emblema della resistenza, e dell’irriverenza di tutto un popolo che si oppone al male rappresentato dalle ingiustizie, dal freddo, dalla guerra, dal cibo scarso ed insufficiente, dalle malattie, dall’ignoranza, ecc…. Il gonfalone, in una sorta di apoteosi, diviene, agli occhi incantati della nostra fanciulla, e del lettore rapito dalla prosa della De Marchi, lo stendardo della lotta quotidiana contro il male, la colonna di fuoco che guida il popolo fuori dalla terra di schiavitù. Un popolo che nel libro appare animato da un insopprimibile anelito di riscatto. L’attualità del libro sta in questo: la resistenza al male dei nostri padri e nonni, può divenire per noi un richiamo a risvegliarci dal torpore. Sì, abbiamo bisogno d’essere risvegliati dall’ignavia, e di ritrovare le antiche, sopite energie dei nostri anziani, per iniziare anche noi, prima che sia troppo tardi, una nuova resistenza, morale, ed etica, al male, alla volgarità ed alla disonestà dilaganti. Dobbiamo anche noi ritrovarci sotto un nuovo gonfalone di S. Giorgio…. O almeno dire sotto quale stendardo vogliamo camminare! Così la marcia del popolo descritta dalla maestra De Marchi diventa per noi richiamo, appello, esortazione, stimolo a non cedere, a non mollare, a non darla vinta al male, a resistere! Ovvio che ricordando si sfiorino sempre le corde della nostalgia, ed era inevitabile che il libro qua e là indulgesse in qualche nota nostalgica, o ristagno sentimentale, in esso tuttavia troveremo numerosi valori: - il senso profondo dei legami sociali (se ci confrontiamo con quel mondo …come siamo divenuti individualisti!), - la bellezza e la gioia, del fare le cose insieme ( quella coralità del pane, del grande bucato, della lucidatura delle pentole ecc….!) - il senso commovente d’una autentica solidarietà famigliare (noi e le nostre famiglie iper-fragili…) - il sostegno concretamente vissuto verso i poveri, e soprattutto il rispetto verso di loro - colpisce poi come nel libro emerga un grande senso di dignità che i più deboli, umili, e fragili riuscivano a mantenere anche nelle situazioni più drammatiche (una delle cose più alte del libro: questi poveri sono bellissimi!). Anche qui il confronto con il nostro mondo in cui sembra che la dignità personale sia direttamente legata alla quantità di beni posseduti ci fa arrossire… 12 - la salvaguardia ed il rispetto per l’ambiente: i nostri padri, ed i nostri nonni, vivevano facilmente quello che oggi è per noi un disegno quasi utopistico, e cioè uno sviluppo eco-sostenibile, erano in piena armonia con il creato, e l’ambiente in cui erano immersi. Si guardi la descrizione della casa di Prisco il ciabattino un capolavoro d’armonia e rispetto ambientale, in cui la semplice essenzialità della casa la fa divenire più bella della casa di un re! - infine la vivacità e la concretezza d’una fede cristiana capace di dare un’anima al popolo, e d’immettere in esso nuova speranza e rinnovati sentimenti di riscatto, un fede profonda ed interiorizzata che sosteneva e dava senso nei momenti più drammatici, si veda la reazione piena di compostezza e dignità di nonno Gustinello alla morte del papà di Linda…. A me, che ho vissuto per ventisei anni gomito a gomito con la comunità di Toara, e di cui sono stato cittadino per tre anni, questo libro ha dato tanto, in termini di comprensione, consapevolezza ed amore. Questo è un libro che piacerà e commuoverà gli anziani, che hanno vissuto quei tempi, poiché in questi ricordi ritroveranno se stessi e la loro vita; incuriosirà i giovani, stuzzicando la loro sete di conoscere le loro radici, ed il ceppo da cui provengono (senza conoscere il proprio passato non ci può essere orientamento per il futuro), infine confermerà gli adulti, ridando loro motivazioni e voglia d’impegnarsi sempre di più nel nostro, non facile, presente. Buona lettura. F. ANDREA S. Ruffino 9 febbraio 2007 13 ARVALLI PROLOGO Era da tanto che meditavo di mettere per iscritto i miei ricordi d’infanzia. Ecco sento già alcuni che diranno “Toh, eccola qua, un’altra che vuole ricordare…” E’ vero nella terza età si fanno tanti ricordi, si vive di ricordi, e poi magari ci si dimentica di avere gli occhiali sul naso! Forse anche per me è così, forse anche a me la terza età ha portato in dono questo speciale carisma del ricordare, del fare memoria, con cui riviviamo nel nostro cuore i momenti belli della nostra vita per gustarli ancora, e quelli tristi per riconciliarci con le ferite, le delusioni, le amarezze, i fallimenti. Sono anch’io una di quelle che poi magari si scorda di dove ha poggiato gli occhiali, le chiavi di casa, la sciarpa, o il borsellino. E’ però anche Veduta del borgo di Toara. La foto risale agli anni ‘60 del secolo scorso. 14 15 vero che sono stata sempre dotata d’una memoria molto viva, ed attenta. Così ho portato per tutta la mia vita vivissimi e nitidi i ricordi della mia fanciullezza, fin nei minimi particolari. E’ come se io mi sentissi interiormente abitata dai molti mondi vissuti nella mia, ormai, non corta esistenza: il mondo della mia infanzia, della fanciullezza, dell’adolescenza, giovinezza ecc…. Però, tra tutti, è il mondo della mia fanciullezza a conservare in me un sapore particolare, tutto speciale. Sono i ricordi di un “piccolo mondo antico” quello del mio borgo natìo, Toara, frazione di Villaga, nel Basso Vicentino, un angolo nascosto ai piedi dei Berici. Un villaggio da nulla, quattro case aggrappate ad una piccola pieve, abbracciate e protette da una schiena di collina solleticata da un incantevole vento perenne, che ne discende con briosa sapienza la china precipitando, dalla dorsale berica, verso la vasta, immensa pianura. Lì sembra che la natura si sia stancata di costruire i verdi monti Berici ed, avendo finito i sassi calcarei e la terra, si sia finalmente decisa di lasciar spazio alla pianura, che nei giorni sereni, dalle prime balze, si vede sconfinata, estesa fino all’arco lontano degli Appennini da un lato, e della laguna veneta dall’altro. Protetta da quei monti ho visto la luce, sono venuta al mondo, battezzata, cresciuta, istruita, divenuta grande, in un “piccolo mondo antico”, fatto di volti indimenticabili, di incontri, di gioie e di dolori, di fatiche e di allegrie, di turbamenti e di serenità, di fede e di preghiera, ma soprattutto di tanta voglia di vivere. Da alcuni lustri ormai ho lasciato Toara per Altissimo, ma ogni volta che vi torno tutti questi ricordi mi vengono incontro, bussano alla porta del mio cuore, mi abbracciano, mi fanno festa, mi consolano. In quei momenti è come se mi venisse incontro una folla di volti che mi si fanno attorno, sorridenti e colmi d’una serenità che non avevo mai veduta in loro quando erano in vita. Talora è come se sentissi le loro voci incoraggianti, che mi esortano a raccontare la loro vita, di testimoniare come erano fedeli alla Chiesa, di come, nonostante le avversità, la guerra, la fame, il dolore, le malattie essi conservassero l’unità fra di loro, di come fossero fedeli alla famiglia, al lavoro, alla patria, nonostante tante loro miserie, fisiche e anche morali…. tava ancora a Toara, convinta mi consigliasse di rinunciare. Egli invece m’incoraggiò a portare a termine la mia fatica, mi disse infatti tante belle cose sull’importanza del narrare, e su come sia un compito speciale nei confronti delle generazioni più giovani. Mi disse che gli anziani sono la memoria vivente della società, e che pertanto abbiamo il dovere di raccontare la nostra vita. Attraverso tale narrazione, mi diceva il buon padre, noi svolgeremmo un’importante ministero morale. Mi disse anche che non avrei dovuto assolutamente preoccuparmi di chi stava ad ascoltarmi o meno, queste cose avrebbero fatto certo del bene a tutti coloro che avessero accettato di leggerle e di stare un po’ ad ascoltare il mio racconto. Sarà….! Veramente mi sembrò che il mio frate esagerasse nei complimenti, ma il suo tono convinto alla fine mi persuase, e volli credergli. Mi misi di buzzo buono e finii in fretta di scrivere un buon numero di fogli. Quando glieli consegnai, ecco che quello prende su e inizia a traslocare da Toara nelle Marche. Benedetto uomo anche lui, anziché aiutarmi…! Così passarono diversi mesi di silenzio, e quando arrivò l’autunno io ero convinta che ormai si fosse perso anche il mio manoscritto…. Invece no: lesse e si entusiasmò. Lui ama Toara, i paesi ed i borghi viciniori, quanto me. E’ innamorato dei Berici, dei loro sentieri, e panorami, ma ama particolarmente Toara ed i suoi abitanti, e ne indaga appassionato la storia. Fra l’altro so che sta pubblicando, proprio in queste settimane, un altro libro su Toara, un suo diario sui venticinque anni di vita all’eremo, con le edizioni Messaggero di S. Antonio di Padova. Non solo conosce ogni pietra, ogni viottolo, ogni albero, di quelle colline, ma si direbbe che conosca allo stesso modo ogni sfumatura dell’animo dei toaresi, e villaghesi… Non per niente iniziò a frequentare le nostre colline nella sua giovinezza. In tutti questi anni di frequentazione, e di vita vissuta fra di noi, in mezzo alle nostre famiglie, condividendone gioie e dolori, è divenuto, anzi, si è fatto toarese come noi. Lui ha un animo semplice, riservato, ama le cose piccole, umili, ed in più è un attento osservatore, così mi fu e mi è di conforto il suo incoraggiamento nel pubblicare i miei ricordi. Così un po’ alla volta è nata in me l’esigenza di obbedire a queste voci, e d’iniziare la mia narrazione, ed iniziai a scrivere…. Facendolo mi accorsi che tutto era già scritto, e registrato nel mio cuore, così non fu difficile metterlo sulla carta, perché era qualcosa di vivo, sempre presente in me. Quando fui ad uno stato abbastanza avanzato sorse un problema: pubblicare o no? Mi dicevo infatti: Linda mia, ma a chi vuoi che possano interessare i tuoi ricordi? Non vedi che sono cosette da nulla? lasciali lì, certe cose non è meglio farle cadere nell’oblio? Condivisi questi dubbi con un frate francescano, f. Andrea Arvalli, che allora abi- Il lettore sia generoso e paziente con me, non si attenda grandi cose! Questi sono solo i “miei” ricordi, ricordi d’infanzia e fanciullezza, così come mi sono rimasti impressi nella memoria. Non pretendo fare ricostruzioni storiche, né tanto meno dare giudizi d’alcun genere su di un’epoca, su di un mondo, né men che meno, sulle persone che qui vengono rievocate! Tutti i personaggi qui citati sono guardati da me con un affetto infinito, con nostalgia e riconoscenza. Nessuno si senta giudicato, anche se a volte il racconto potrà apparire un poco “irriverente”, in realtà tutto, tutto è stato scritto con grande amore! Nessuno, riconoscendosi, si senta offeso da qualche mia osservazione o descrizione, lo fosse a lui chiedo per- 16 17 dono, non è di offendere il mio intento. E’ possibile anche che qualcuno in questi racconti si riconosca, o che non riconosca affatto se stesso, i suoi compaesani, o le situazioni descritte, abbia pazienza, compatisca e perdoni! I miei ricordi sono il frutto delle impressioni e dell’immaginazione, soggettive e personali, d’una povera bambina, qual’ero. Quelle sensazioni s’impressero tuttavia in maniera indelebile in me, ed in nessun giorno della mia vita le ho mai dimenticate. Sono grata al Signore per avermi dato una memoria tanto limpida e dettagliata da rendermi in grado di rivivere episodi, avvenimenti ed esperienze della mia fanciullezza. Questo modesto scritto vuole essere un rendimento di grazie, fatto con tutto il cuore, soprattutto ai miei zii Luigi e Carolina, che hanno accolto, custodito e protetto me ed i miei tre fratelli, in tempi duri e difficili. E’ anche un ringraziamento a tutti gli abitanti del mio paesello che mi hanno dato esempi non comuni e preziosi di sopportazione, laboriosità, semplicità, fede e fortezza cristiana. Di fronte a loro non resta che chinarsi con deferenza. Ed ecco i miei ricordi, li ho distribuiti in sette capitoli, sette come i giorni della settimana: in ogni capitolo – giorno ho cercato di racchiudere alcuni contenuti specifici, che dessero unità a ricordi altrimenti frammentati. Il settimo capitolo si parlerà delle festività religiose: auguro al lettore di soggiornare con piacere in questa “settimana di capitoli”, giungendo felicemente fino al settimo giorno! Ma prima il lettore abbia pazienza, e legga, se vuole questa piccola poesia, non scritta per essere pubblicata, ma che esprime bene il mio cuore… TACI E ASCOLTA Taci! Ascolta! Trema il ramoscello dell’argenteo ulivo, quando lui intona l’inno dell’amore. E’ l’usignolo, che fa la serenata alla sua bella Toara addormentata. Dormi paesello par che dica il canto, domani primavera ti coprirà di veli e sul tuo capo poserà un diadema di gemme in fiore, di seriche corolle. Piccolo borgo ancora addormentato dai giorni miei lontani di ricordi, piccolo borgo mai io t’ho scordato. Riodo ancora il canto d’usignolo, che nelle notti tra gli argentei ulivi cantava la canzone dell’amore facendo pianger di tenerezza il cuore. A me che importa se tu sei piccino? Ti tengo intero tutto nel mio cuore. Povero sei, ma raggi di splendore sempre vestito d’amore e umiltà. 18 19 CAPITOLO PRIMO LA MIA AMATA FAMIGLIA: UN NIDO MESSO ALLA PROVA. 1.1. Amore geloso per la mamma. Desidero iniziare questo libro parlando della mia carissima mamma, che purtroppo conobbi, e godetti troppo poco, morì infatti quando eravamo, io, le mie sorelle e mio fratello, ancora in tenera età. Di mia madre conservo un ricordo chiaro dei suoi gesti, delle sue parole e del suo volto, soffuso di grande dolcezza e serenità. Rammento ancora ciò che un giorno disse, rivolta ad una persona, che ci era venuta a visitare. Quelle parole mi risuonano ancora agli orecchi specialmente quando devo riordinare la mia persona. Mi stava aggiustando i capelli ed io mi agitavo, perchè non sopportavo il pettine tra la mia folta capigliatura, nera come l' ala di un corvo e ribelle. Mamma Pia da signorina Ogni volta che mi pettinava avevo l’aspetto di un merlo arrabbiato, che occhieggiasse attraverso un cespuglio di rovi. Disse all'Adele - così si chiamava quella persona: -Questa bimba cresce in unghie, capelli e cattiveria - poi, sospirando e scrollando il capo concluse -che ne sarà di lei se io non la potrò controllare?! Presagiva forse la sua prossima fine? Era vero, ero ribelle, testarda, in compenso però estremamente sincera, dicevo tutto quello 20 21 che pensavo, come fanno spesso i bambini, detestavo la menzogna e, spesso, a causa del mio essere sincera fino all'osso, me le buscavo. -Tu non hai mai parlato come gli altri bambini.. mi disse qualche tempo fa Caterina, mi conosceva bene perché, ancora ragazzina, mia madre le affidava qualcuno di noi fratelli perché ci custodisse. Disse che parlavo correttamente, senza quelle inflessioni comuni a tutti i bambini piccoli. Aggiunse che me ne uscivo, spesso, con delle frasi che sconcertavano gli adulti e li mettevano in grande imbarazzo e che ero testarda come un mulo. Oh sì, e quanto ero testarda! Ero pure gelosa di mia sorella Delia, l'ultima nata. Prima di me c'erano: Maria, Rosalinda, morta all’età di tre anni, Giuseppe, e poi io Rosalinda, per tutti Linda, (volevano così ricordare la sorellina morta, che dicevano fosse molto buona e carina ) e in fine, come ho detto, Delia. Ricordo quel venti gennaio 1940, appena tornati dall'asilo, io e mio fratello, ci precipitammo, come al solito, in casa. Zia Carolina, tutta festosa, ci disse: - Mamma vi ha preparato un bel regalo. Lì però mamma non c'era, zia ci fece salire nella stanza dei genitori e, nel lettone, Rosalinda, la sorellina di Linda, morta di difterite assieme a mamma, si scorgeva appe- all’età di tre anni. na un piccolissimo visetto tutto raggrinzito. Non dissi verbo, guardai accigliata ed in fine, rivolta alla mamma, che stancamente ci sorrideva, indicando quel piccolo fagottino esclamai: -Questo sarebbe il regalo? Non mi piace! e, con quattro salti raggiunsi la cucina dove mi buttai rabbiosamente a divorare un pezzo di pane. Ricordo che quando mamma doveva salire di sopra per le sue faccende e lasciava Delia adagiata tra i cuscini, in cucina, raccomandandomi di badarla, lo facevo malvolentieri. Mamma, di tanto in tanto, la chiamava. Non sopportavo quella voce carezzevole che diceva: -Delia, Delia! la piccola rispondeva con dei gridolini, ma io, ad ogni suo richiamo, urlavo: -Muri, muri! (muori, muori!). Vedendo l'attenzione di tutti rivolta a Delia io ne soffrivo terribilmente. Amavo molto mia madre, ma non riuscivo a manifestarglielo. Mi sarei fatta picchiare piuttosto che coccolare, però quella 22 dolcezza rivolta a quella piagnucolona, che poverina, tra l’altro, non stava mai bene, mi irritava. Ma alla mamma volevo un bene immenso. 1.2. Vari ricordi d’infanzia. La monetina smarrita. Un giorno mamma, che si chiamava Pia, mi regalò una moneta, l’aveva trovata vicino al secchiaio, mi disse che mi sarei potuta comperare un confetto, di quelli tanto buoni che vendeva zia Monica nel suo negozio. Tutta felice mi avviai all'asilo (allora non si chiamava scuola d’infanzia), portai la moneta con me per farla vedere alla maestra, poi, con il suo permesso mi sarei recata ad acquistare quel dolcetto. All'asilo c'era un po’ di fermento perchè Zita, una mia compagna , aveva perduto una monetina simile alla mia e tutti erano intenti a cercarla, compresa la maestra. La moneta di Zita non si trovò. Dopo un po’ mostrai all'insegnante la mia moneta, dicendole, con orgoglio, che me l'aveva regalata la mamma, aspettavo che si congratulasse con me, invece si mise a fissarmi in modo severo chiedendomi se era la moneta della mia compagna che avevo trovato. Rimasi con la bocca aperta, incapace di profferir parola, sconvolta e dolorosamente stupita nel constatare che la maestra, della quale avevo grande rispetto e che pensavo potesse sapere tutto di noi bimbi, mi ritenesse capace di un simile crimine. Vedendomi così sconvolta la maestra si persuase della mia colpa. Mi tolse la moneta e la consegnò a Zita. Il mio pensiero corse a mamma, e la mia pena aumentò, perchè nel torto fatto a me vedevo il torto fatto a mia madre, era come avessero dato della ladra a mia madre e questo, per me, era intollerabile. Dopo circa mezz'ora da quella scena, un bambino trovò, sotto il banco di Zita, la moneta tanto cercata, la portò all'insegnante che, senza nessuna parola di scusa, dopo avermi restituita la mia, ci invitò tutte e due ad uscire per comperarci i confetti. Io non volli andare, mi limitai a fissare tristemente la maestra, come a ricordarle che, avendomi dato della ladra, mi aveva atrocemente offesa e con me aveva offeso anche mia madre. La carta argentata. Ciò che mi donava mamma per me era molto importante, qualsiasi cosa fosse, anche la più insignificante. Un giorno alla mamma regalarono una scatola di biscotti, allora era ammalata. Erano avvolti in una carta argentata molto bella che mamma mi regalò, dopo aver diviso i biscotti tra noi bimbi. Me la tenevo cara quella carta come fosse un tesoro. Era una carta, solo una carta, ma mi era stata donata dalla mia mamma! Corsi a farla vedere a due mie amichette, inseparabili compagne di gioco. Spiegai davanti ai loro occhi il prezioso tesoro, certa che avrebbero gioito con me davanti a tutto quel luccichio, ma come piccole furie Tecla e Agnese mi s'avventarono addosso e me la strapparono di mano, riducen23 dola in frantumi. Non ebbi la forza di reagire tanto fu lo stupore, il dolore, l'amarezza che provai. Rimasi un bel po’ incapace di profferir parola, ma poi gridai a quelle dispettose: -Me l'aveva regalata la mamma! La mia mamma, capite?. Quelle, per tutta risposta cominciarono a motteggiarmi dicendo che ero proprio scema piangere per una carta. Quella, però, non era una carta qualsiasi, era la carta argentata della mia mamma! Ma sì, vallo a raccontare agli altri questo cocente dolore, chi ti capirebbe?! Quanto piansi quella volta e per quanto tempo ricordai quel dispetto! Le prime ortiche…. Nel mese di maggio quasi tutto il paese si riversava in Chiesa per onorare la Madonna, quella sera, papà e i miei fratelli erano già usciti, mamma rimase a casa per badare a Delia, io rimasi con lei. Ad un certo momento dissi che mi dovevo assentare perchè urgeva la pipì. Mamma, mi voleva aiutare, ma io la volevo fare nel campo perchè così, pensavo, avrei dato da bere all'erba. Mia madre, in quel momento, non mi potè raggiungere perchè Delia piangeva e mi gridò che tornassi da lei. Feci orecchi da mercante e, calate le mutandine, posai il sederino sopra un rigoglioso cespuglio di verdi ortiche..... Tornai mogia mogia in casa, trattenendo a stento le urla che mi premevano alla gola, ma due lacrimoni non li potei fermare. Cercai di sfuggire lo sguardo indagatore della mamma, ma non le si poteva nascondere proprio niente e così scoprì un povero sederino tutto rosso e martoriato, che doveva fare tanta pena se, appena tornato il babbo, glielo fece vedere dicendo: -Guarda un po’ sta povera creatura com'è ridotta! Me lo rinfrescarono quel “poveretto” e mi portarono a letto mettendomi con la pancia in giù. Ogni tanto, mamma, mi veniva a mettere delle bende intrise di fresca acqua. bolotto, me lo cullavo come vedevo fare mamma con Delia. Ma...... povero bambolotto! Bisogna sapere che mio fratello Giuseppe, da tutti chiamato Beppino, aveva la mania di voler scoprire come fossero fatte le cose, quando arrivava vicino ad un orologio, ad una scatola che emetteva suono, tipo carillon oppure altri oggetti che eccitavano la sua curiosità, demoliva tutto, poi, se ne era capace, ricostruiva, alle volte senza riuscirci. Quel pomeriggio mi trovò seduta sul gradino della porta di casa intenta a rivestire il mio bambolotto, me lo tolse di mano e cominciò a premergli il pancino dicendo che, certamente, lì dentro ci dovevano essere nascoste delle monete d'oro, io lo guardavo perplessa e dubbiosa, ma lui tanto disse e tanto fece che, alla fine lusingata dalla prospettiva di poter regalare tutti quei soldi alle mamme che avevano debiti nel negozio degli alimentari cedetti e gli diedi il permesso di "operare" lo stomaco del bambolotto. Cominciò a sventrarlo con il suo piccolo coltello a serramanico e lo fece velocemente per paura che me ne pentissi. Mentre attendevo la fine di quella strana operazione la mia testolina faceva mille progetti, ma quando, con un sorriso sornione, l'improvvisato chirurgo, mi presentò un dischetto di metallo, attraversato nel mezzo da un piccolo taglio, ammutolii, lo guardai smarrita e, quando m'accorsi che non solo le monete non c'erano, ma il mio bambolotto era tutto rovinato, tentai di schiaffeggiarlo, ma lui, più svelto di me, se la diede a gambe levate. I poveri ed il bambolotto di pezza. A casa nostra non si è mai patito la fame, ma si sapeva benissimo che molte persone soffrivano per mancanza di pane, e di tante altre cose, ne sentivo parlare in continuazione. Ciò mi procurava tanta pena. Anche se piccola, di quello che potevo, ne facevo parte con gli altri bimbi e mi rammaricavo di avere solo qualche pezzo di pane o della frutta da dividere con loro. Avrei voluto possedere qualche monetina da regalare a tutti, specialmente alle mamme, che si recavano nel negozio di zia Monica per acquistare le cose strettamente necessarie. Le poverette segnavano il debito in uno sdruscito libretto con tante cifre messe una sotto l'altra, lunghe come le litanie dei Santi. Mi era stato regalato, non ricordo da chi, un piccolo bambolotto, con la testa, le mani e le gambe di gesso e il corpo di pezza. Premendogli il pancino emetteva uno strano suono, si sentiva che aveva dentro un qualche cosa di metallico. Mi chiedevo cosa fosse quel pezzetto di ferro. Ci giocavo volentieri con quel bam- L’albero delle palanche… Mio fratello conosceva questo mio desiderio di possedere denaro da poter distribuire ai poveri e cercava in tutti i modi di coinvolgermi nelle sue avventure, quasi sempre pericolose. Ero tanto “oca” e troppo piccola, credevo ciecamente a ciò che mi raccontava, anche se ero appena uscita da qualche brutta esperienza. Fra le monete correnti di allora c'era la così detta “palanca”, che corrispondeva a dieci centesimi, era una moneta di rame con l'effigie del Re Vittorio Emanuele terzo da una parte e dall'altra vi era incisa un'ape. Un pomeriggio, mentre mi trovavo sull'aia, mio fratello, dopo essersi assicurato che nessuno fosse presente, mi s'avvicinò mostrandomi appunto una “palanca”. Me la fece osservare bene e poi, con aria di mistero, a voce bassa mi disse: -Tu vorresti avere tanti soldini da dare ai poveretti, vero? Tutta eccitata assentii, lui proseguì - se ingoi questa "palanca", ti crescerà nella pancia un albero pieno di monete, i suoi rami usciranno dalla tua bocca, dal naso e dalle orecchie. Lo guardai perplessa ricordando l'infelice esperienza del bambolotto, ma non scorsi nessun segno di beffa sulla sua faccia impassibile, così presa la moneta, abbastanza grande per la mia gola, me la posi in bocca e, con uno sforzo enorme la trangugiai. Mi spuntarono le lacrime perchè la gola mi fece male al suo passaggio. Beppino sparì e, come sempre, sarebbe rientrato a bufera sedata. A me non rimaneva che attendere la crescita della pianta. Mi misi ritta sotto l'albero di fico, che era di fianco alla casa, vicino ai pollai. Stetti lì parecchio tempo. 24 25 Venne mamma a portare il grano per le galline e si meravigliò molto nel vedermi immobile, con gli occhi chiusi. Mi chiese per quale motivo mi trovassi in quel luogo invece che assieme ai fratellini, le risposi che attendevo la crescita dell'albero. Mamma volle vederci chiaro e si fece dire tutto. Io, candidamente raccontai.... Man mano che parlavo il suo viso esprimeva stupore, sgomento e infine terrore. Mi portò in casa, mi fece bere qualcosa di dolciastro, mi fece camminare su e giù per il cortile e, ogni tanto, mi chiedeva se avessi bisogno di fare la “popò”. Non capivo perchè mamma fosse così insistente sia nel farmi camminare come nel chiedermi dei miei bisogni corporali. Finalmente avvenne ciò che lei desiderava così tanto. Il mio sbalordimento crebbe a dismisura quando la vidi rovistare, con un'asticciola di ferro, su ciò che a me faceva schifo! E che respiro di sollievo emise, povera mamma, quando scoprì la "palanca"! Sedette, sfinita, su una sedia e fissandomi seriamente disse: -Se ingoi ancora una moneta, l'albero lo farai crescere al cimitero, ma non sarà un albero di monete! Non ricordo quale castigo abbia avuto mio fratello. Le sartine del paese. Passavamo molte ore in casa dei Cacciavillani, la famiglia di Catinella, la ragazza che ci custodiva; c’erano le sorelle: Antonia che faceva la sarta, aiutata da Nina e Maria, Eleonora, la più giovane, che poi si sarebbe fatta Suora, i fratelli Giuseppe e Giovanni e la mamma Rosa. In quella casa non ci si annoiava mai. Era un divertimento per me raccogliere i piccoli ritagli, che cadevano per terra quando Antonia tagliava la stoffa per un nuovo vestito. Mio fratello, invece, vedendo la macchina per cucire per qualche tempo ferma, cercava di metterci le mani combinando così guai a non finire. Antonia gli diceva sempre: -Quando vieni a casa nostra le mani lasciale dai Moreti. Quelli che venivano chiamati “Moreti” era la famiglia della Luigia Ferrari e abitavano in quella via. Mio fratello però era troppo interessato alle cose per lasciarle in pace. Ma anch’io qualche volta ero birichina con quelle buone creature. Sapevo che Nina e Maria non sopportavano il velluto: ebbene, quando me ne capitava tra le mani qualche ritaglio, gongolavo di gioia e, furtivamente, arrivavo loro dietro le spalle e lo strofinavo sul collo ora dell’una ora dell’altra, mentre erano con la testa china e cucivano. Quando quella detestata carezza le sfiorava, rabbrividivano e si mettevano a gridare, io me la svignavo ma alla prima occasione ci riprovavo. Quante volte, in seguito, mi sono pentita d’aver fatto quella cattiveria. Eppure mi hanno voluto tanto bene lo stesso. fosse accaduto ieri. Mamma non c’era ed io me ne stavo a letto nel suo posto. Era una mattina di domenica. Ero sveglia. Quando arrivò la mamma aveva ancora il velo nero sulla testa. Era stata alla santa Messa che si celebrava alle prime luci dell’alba. Si appoggiò alla grande cassa di legno chiaro dove teneva la biancheria. Mi guardò a lungo e disse: -Lino è andato in cielo. Lino era il fratellino di Lodovico, un mio coetaneo. Tenevo gli occhietti sbarrati e guardavo mamma. Lei mi guardava assorta, il suo volto era pallido, ma non triste. La morte allora non era un evento così raro come adesso, anche per i bambini, od i ragazzi giovani. La gente era più abituata alla morte, che giungeva a tutte le età, e bussava assai di frequente alle porte delle nostre povere case. Io tenevo gli occhi fissi addosso alla mamma. Si direbbe che stesse accompagnando il piccolo Lino per le strade del cielo. Stetti zitta, ma poi: -Mamma -le dissi- come ha fatto Lino ad andare in cielo? E lei, seria, ma serena, abbracciandomi: – Era buono –rispose –e Gesù gli ha messo le ali, così è potuto volare lassù. Mamma mi diede un bacio, poi si levò il velo dalla testa, lo piegò e lo ripose nell’armadio. Io pensavo al cielo e mi dicevo che non ci potevo andare, perché ero cattiva, così tutti mi dicevano, per cui Gesù a me non avrebbe mai messo le ali… Ricordo il turbamento legato a quel momento, ma non un particolare dolore. Però durante la mia infanzia mi accadeva spesso di pensare spesso a Lino e al cielo. Davanti a casa mia c’era un campo, lo chiamavano il campazzo perché era più grande degli altri. Ero grande come un soldo di cacio e me ne andavo tutta sola, al tramonto del sole, in mezzo all’erba di questo campo, per goderne l’ultima luce, come berne una tazza fumante…. Allargavo le piccole braccia per trattenere con le manine quel disco, che spariva in una gloria di luce e colorava il cielo con stupende pennellate di rosso fiamma. Che nostalgia in quel grande mistero! Fissavo quella luce sperando di poter scorgere, prima o poi, in mezzo a tutto quel fulgore, il piccolo Lino con la mia sorellina, salita lassù prima di lui. Forse mamma, quando mi disse di Lino, pensava alla sua piccola Rosalinda che, come un angioletto, da qualche anno era stata portata in cielo. Non riuscii mai a vedere né la mia sorellina Rosalinda, né Lino, camminare nello sfondo del disco arancione del sole, ma quell’immaginazione infantile mi è rimasta sempre viva nell’anima. Penso che veramente Lino passeggia ancora per i prati del cielo tenendo per mano la piccola Rosalinda, …chissà se saranno loro i primi ad accogliermi, ed a guidarmi verso S. Pietro, quando sarà il mio turno! Così m’imbattei per la prima volta in vita mia con sora nostra morte corporale come, con fantasia, S. Francesco seppe chiamare sorella morte, con la quale ahimè, troppo piccola, di lì a poco avrei dovuto fare duramente i conti… Lino: primo incontro con sorella morte… Come se l’avessi ancora davanti agli occhi. E’ un ricordo talmente vivo, come 26 27 1.3. La mia mamma muore! Dopo la nascita di Delia mia madre cominciò a sentirsi debole, rimaneva lunghi momenti seduta in camera sua, spesso le tenevo compagnia, mi facevo dare il suo libro di preghiere, la “Filotea”, un libro molto voluminoso con tante immagini sacre, fra quelle ce n'era una che era il mio cruccio, sì, proprio così, era un'immagine che mi faceva arrabbiare e che, quando mamma girava lo sguardo, tempestavo di pugni. Ero caparbia, volevo riuscire a capire da sola il significato di tante cose. Quell’immagine di Murillo rappresentava San Francesco nell'atto di staccare il Cristo dalla Croce, un piede poggiava per terra, l'altro lo teneva su un globo, ma a me pareva un pallone. Pensavo lo volesse staccare dalla Croce per costringerlo a giocare con lui e, vedendo come il povero Cristo era conciato, mi rodevo dalla rabbia. Possibile -dicevo tra me- possibile, non si renda conto di quanto stia male quel povero Gesù! Povera me, più avanti avrei scoperto chi fosse San Francesco e quanto il Poverello amasse la croce di Cristo! Mia madre morì il 14 Settembre del 1941, avevo circa cinque anni e mezzo. Ricordo tutto della sua morte, ricordo pure il vestitino che indossavo al suo funerale, era bleu a minuscoli pois bianchi. Per tutta la mia vita non ho mai voluto parlare di quella dolorosissima esperienza, essa era una parte dei miei ricordi, che tenevo chiusa in uno dei cassetti che non aprivo mai. Ne conoscevo a memoria il contenuto ma, al solo avvicinarmi, mi si ripresentavano tutte le scene nella loro crudezza, così vive e così presenti da procurarmi, acerbo dolore. Com'è possibile raccontare un dolore così? Adesso tuttavia, incoraggiata, sento che è giunto, finalmente, dopo oltre sessanta anni, il momento di farlo, sarà un modo d’esprimere la mia riconoscenza alla mia cara mamma, e i riconciliarmi con questa parte dolorosa della mia vita. Quando dunque mamma iniziò ad aggravarsi il medico veniva a vederla ogni giorno. Era di poche parole il Dottor Antonio, metteva soggezione anche agli adulti e noi giravamo alla larga quando lo vedevamo spuntare dalla strada. Arrivava in bicicletta, qualche volta usava la moto. Ricordo il giorno che uscendo dalla casa, dopo aver visitato mamma, si fermò davanti al nostro gruppetto di bambine, stavamo giocando, tutte spaventate lo guardavamo senza fiatare. Lui ci guardava e taceva. Ad un tratto disse: - Chi di voi è la figlia della Pia? Rimasi muta, ma Tecla, senza parlare, mi indicò. Lui mi fissò a lungo senza profferir parola. Tremavo e…me la feci addosso tanto era il terrore che mi ispirava. Dopo di lui passò il parroco. Era andato per l’unzione degli infermi. Ma io non ci capivo niente. Il mio cuore però era stretto da un’indefinibile angoscia. Andavo in silenzio in camera sua. C’era sempre qualche zia che l’assisteva, ma lei non parlava più. Le passavano sulle labbra secche una pezzuola imbevuta d’acqua. Una mattina sentii un insolito andirivieni. Salii in camera senza che nessuno si accorgesse. Rimasi sulla porta incantata a guardare. Zia Paola con le zie Enrica e Monica cercavano di sorreggere mamma e di infilarle il vestito, ma lei si afflosciava ciondolando le braccia inerti e senza vita. Non capivo che era morta e tra me dicevo: Ma guarda mamma che fa i capricci come me quando non voglio essere vestita! Povera me! Appena si accorsero della mia presenza, zia Monica mi prese tra le braccia e mi portò giù in cucina da zia Carolina, che stava accudendo gli altri miei fratellini. asciugandosi gli occhi in continuazione. Capivo che qualcosa di terribile era avvenuto, lo capivo dal pianto delle persone e dal volto di mio padre. Il mattino che ci fu il funerale mi vennero a prendere per dare ancora un saluto a mamma. Avevo dormito, quella notte, a casa della Rosa Cacciavillani. Sfiorai il volto di lei con un bacio. Era di ghiaccio. Mi restarono impressi i colpi di martello con cui inchiodavano la bara e il mio papà che si aggirava lì attorno muto e con il volto spaventosamente pallido. Poi ci recammo in chiesa. Dopo il funerale della mamma i coniugi Radin, Antonio ed Eugenia, che in seguito sarebbero stati lui il padrino per Giuseppe, lei madrina per me e Delia, portarono con loro la piccola, con il consenso di papà. La volevano adottare, ma papà non acconsentì, voleva che crescesse assieme a noi La piccola Delia e gli amici (zii) di mamma Pia, Eugenia e Antonio Radin 28 29 suoi fratelli. Si erano affezionati molto a Delia e soffrirono indicibilmente il giorno che la riportarono a casa. Delia era molto ammalata agli occhi ed Eugenia si prodigò in tutti i modi perché la piccola avesse tutte le cure possibili per poter guarire. E così avvenne. Divennero per tutti noi fratelli gli zii di Vicenza e lo furono per sempre. Da ragazzina, adolescente, provai ad esprimere il mio tormento con questi versi: Alla mamma morta Alla tomba venivo ogni mattina per vedere se t'eri risvegliata, ero, allora, troppo piccolina, non riuscivo ad aprir la cancellata. Il sonno tuo pensavo fosse breve, perciò non mi dolevo così tanto e ti chiamavo sì con tono lieve senza timore, senza voce in pianto. Al fine ch'eri morta un dì m'accorsi e tutto si schiantò dentro il mio cuore, come raminga per le strade corsi sempre portando appresso il mio dolore. Bimba non fui mai più da quel momento, ma curva d'anni e d'amarezza piena, come quel giorno ancora il vuoto sento, come quel giorno viva è la mia pena! 1.4. Prima Comunione e Cresima. Il 22 Aprile del 1943 feci la mia prima Comunione, eravamo in guerra quindi niente festa. Zia Paola, sorella di mamma, quella che abitava a Villaga, aveva regalato la stoffa per il vestito bianco sia a me che a Rosetta, mia cugina. Le sorelle Cacciavillani ce lo confezionarono, uguali per tutte e due. La strada allora non era asfaltata, era piovuto durante la notte ed era fangosa, pregai l'Angelo Custode che mi facesse salire sulle sue ali per non sporcare il vestito. In Chiesa ero piuttosto ansiosa, temevo di toccare con i denti la particola. Il Sacerdote mi porse l'Ostia, ma non feci in tempo a gustarmi il momento cosi intimo che una 30 persona mi s'avvicinò per porgermi, insistentemente, dell'acqua. Temeva che la particola mi fosse rimasta appiccicata al palato. Ciò mi disturbò molto e non riuscii più a concentrarmi. Alla fine della Messa, in Canonica, ci offrirono latte, pane e qualche biscotto. Avevo fatto notare sia alla catechista che alla perpetua che non potevo prendere latte, perché ne avevo nausea, ed il solo vederlo mi avrebbe procurato il voltastomaco. Quando nacqui mamma non mi poté allattare, mi portarono allora a Villaga dalla zia Paola e lì passai a succhiare il latte di tutte le donne che a quel tempo avevano avuto figli e che si offrirono di darne anche a me. Quando da grandicella facevo i capricci, c’era sempre qualcuno che diceva che, con il latte, avevo succhiato anche la cattiveria di chi me l’aveva dato, compresa una che, a sentir loro, non era tanto per bene. Ma se aveva accettato di darmi il latte, qualcosa di buono ci sarà stato pure in lei! Comunque, in quel momento, la zelante catechista, credette opportuno farmi osservare che, essendo un giorno “speciale”, sarebbe stato gentile da parte mia, dimostrare a Gesù quanto Lo amassi facendo un piccolo sforzo per Suo amore, e quindi di bere il latte senza fare tante storie. Non me lo feci ripetere: presi la scodella e trangugiai tutto d'un fiato quella bevanda per me nauseante, non feci in tempo a posare la tazza sul tavolo che oplà, come era entrato, con lo stesso impeto uscì. Parte di quel liquido andò a disegnare strani ricami sul vestito nero della Catechista, che mi rivolse uno sguardo per niente adatto alla cerimonia appena conclusa. Zia quel giorno aveva preparato zuppa di verze, che a me non andava, ma pazienza, mi aveva accompagnata alla chiesa, quindi non aveva avuto tempo per far di meglio. Papà aveva comperato alcune immagini e il parroco sul retro aveva scritto a macchina parole di circostanza, ricordando anche la mamma defunta. Nel pomeriggio di quel giorno mi recai dalla contessina Amalia conti Barbaran per donarle un’immagine - ricordo della mia prima comunione. Mi ricevette con la solita cortesia, m'intrattenne per qualche momento e mi donò un santino che raffigurava l’ultima cena poi, chiamata Ines, la cameriera, mi fece portare un sacchetto di nocciole e mi congedò. In quelli anni anche i ricchi erano poveri. Uscita dalla villa rigirai più volte quel santino tra le mani, di simili non ne avevo mai veduti, era gommoso e, credendo fosse commestibile, cominciai a rosicchiarlo. Giunta a casa, del santino non c'era più traccia. Mi recai pure dalla Barbara, per tutti "Barbari", una signorina che viveva con la madre anziana e che possedeva delle pecore. Lei mi regalò una ricotta. M'aspettavo il regalo anche dal buon Dio, gliel'avevo chiesto al mattino, cioè quello di restituirmi la mamma. Quella sera, però, dal cielo non scesero gli Angeli per portarmi ciò che desideravo, ma rumori d'aerei, che facevano tremare i cuori e talvolta anche le case. La santa cresima mi fu impartita dal vescovo Carlo Zinato il 14 Maggio del 1944 31 giorno tragico e doloroso. Il Vescovo, proprio mentre si trovava a Toara, ebbe la cattiva notizia del bombardamento di Vicenza, della distruzione della cattedrale e dell'episcopio. Il dolore di tutti fu intenso. Del rito della confermazione ricordo soltanto gli occhi penetranti del vescovo mentre, pronunciando le parole della formula, mi ungeva sulla fronte con il sacro crisma e mi dava un leggero schiaffo sulla guancia. Non ricordo di essere stata preparata a ricevere questo Sacramento. Forse i sacerdoti di allora erano sicuri che lo stesso Spirito Santo si sarebbe incaricato di illuminarci, spiegandoci la grandezza di questo grande sacramento, che è luce, forza e amore. Quel giorno con me, ricevette la Cresima anche mio fratello Giuseppe. La mia madrina fu zia Eugenia, l'amica di mamma, e lo zio Antonio suo marito, fece da padrino a Giuseppe. Come ricordo di quel giorno mio fratello ebbe un orologio, anch'io ne ebbi uno, ma il mio non era nuovo, era un piccolo orologio appartenuto a mia nonna, era rotto e lo fecero riparare. Non riuscivo a capire il perchè di quella preferenza, lo giravo e rigiravo tra le mani con il cuore stretto, lo confrontavo con quello di mio fratello che era bello, nuovo, e luccicava. Il mio piccolino, placcato di azzurro, forse era più prezioso di quello di Giuseppe, ma io l’ebbi come un torto. Non protestai, il mio orgoglio me lo impedì, ma non fui capace di sorridere e ringraziare. Buona parte dei miei compagni, figli degli operai del conte, ebbero per padrino e madrina il conte Alessandro e la contessa Berta. Sia i maschi come le femmine ricevettero in regalo un vestito, che venne confezionato dalla Antonia Cacciavillani, con la collaborazione delle sorelle. Uguali per i maschi e uguali per le femmine. A tutti loro veniva offerto il pranzo nella villa. 1.5. Ai tempi di nonno Gustinello…. Un personaggio molto caro, e molto importante nella vita della mia famiglia era sicuramente il mio nonno Agostino, ovvero Gustinello, per non confonderlo con il suo omonimo, (stesso nome e cognome). A lui mi rivolsi in un momento solenne della mia fanciullezza, per farmi aiutare a realizzare un grande sogno. Nella soffitta della nonna, il mio rifugio segreto dove sempre mi ritiravo, come dirò poi parlando delle mie letture di scolaretta, avevo infatti trovato il libro di Robinson Crusoe che faceva volare la mia sfrenata fantasia verso terre lontane. Come mi entusiasmava quell’avventura, e come m’identificavo col suo protagonista! Ma io, piccolo scricciolo, avrei potuto confidare a qualcuno i miei ardenti desideri di evasione quando, gli adulti, a malapena ci davano ascolto? Mi arrovellavo il cervello per escogitare un modo per raggiungere il mare e trasportarvi un'imbarcazione. Fu allora che mi venne la geniale idea che per fabbricare una canoa avrei potuto chiedere l'aiuto del nonno Gustinello, che faceva il falegname. Tuttavia un dubbio mi turbava: per trascinare la canoa fino al 32 mare come avrei fatto? Abitavo in un paese del basso vicentino, la spiaggia era ben lontana...... Sentite un po’ come andarono le cose. Quel giorno nonno Gustinello se ne stava seduto all'ombra delle acacie, con in mano una grossa lente, intento a leggersi il suo giornale: De Marchi Agostino nato a Toara di Villaga il 27/02/1866 da fu Antonio e fu Scavazza Carolina, deceduto a Vicenza il 02/01/1958. L’Operaio Cattolico. Di Campesato Edelinda nata a Vicenza nell’anno 1866 da fu Luigi e fu tanto in tanto prendeva Daizoti Caterina, deceduta in Villaga a Toara all’età di 67 anni in dalla tasca una scatola di data 18/10/1933 latta piena di tabacco, ne annusava una presa poi, soddisfatto, pulendosi le dita sui pantaloni, si rimetteva a leggere. Quando ciò che leggeva gli sembrava importante dava in esclamazioni piuttosto vivaci e colorite, strizzava i suoi furbi occhietti e sorrideva beato. Vedendolo di buon umore, come del resto lo era sempre, mi avvicinai e mi sedetti ai suoi piedi, per terra. Lui continuò a leggere fingendo di ignorarmi, in realtà mi osservava di sottecchi, io rimanevo zitta, anche perchè sapevo che non amava essere disturbato mentre leggeva. Alla fine piegò meticolosamente il giornale, starnutì rumorosamente facendo scappare le anatre, che stavano appisolate anch'esse sotto le acacie, godendosi un po’ d'ombra in quell' infuocato meriggio estivo, mi prese per il ganascino e m’apostrofò: -Bene, che mi racconti Morettina? Allora prendendo la parola cominciai a parlare di terre lontane, di canoe, di selvaggi di naufraghi e di mille altre cose. Parlavo, parlavo come fossi già in luoghi sconosciuti, in mezzo a pericoli dove ci sarebbero voluti coraggio e audacia , sola in un’isola sperduta, alle prese con cannibali, bestie feroci e alla ricerca di tesori, di erbe commestibili, di qualche pesce per calmare la fame..... Ero talmente eccitata nel dire che riuscii a creare soltanto confusione. Nonno mi lasciò parlare, quando ebbi finito di vuotare il sacco lo supplicai di aiutarmi a costruire una canoa e un carrettino per trasportarla sulla riva del mare. Sicura d'averlo convinto interpretavo come grande ammirazione lo sguardo che teneva fisso su di me. Già pensavo a tutto ciò che avrei dovuto caricare sull'imbarcazione quando il birichino, prima di rispondermi, asciugandosi il sudore con il suo grande fazzoletto a scacchi, mi prese per le spalle e mi portò con sé in cantina. 33 Il latte di vite. Devo dire che quando il nonno credeva d'avermi fatto un torto, oppure dopo una sua sgridata, o ancora quando mi mollava qualche solenne scapaccione (e Dio sa se lo meritavo!) mi portava tra le botti dove io, con i gessi della nonna, a caratteri cubitali, sulla più grande avevo scritto: LATTE DI VITE e per fare la pace mi offriva due dita di vino. Alle volte con il vino, mi faceva annusare anche una presa di tabacco, che mi faceva starnutire in continuazione e lacrimare abbondantemente. I suoi occhi allora ridevano compiaciuti e si ritornava più amici di prima. Anche quel giorno dunque, dopo avermi fatta sedere su uno sgabello, prese un bicchiere, da una botte spillò del vino, lo guardò controluce, infine me lo porse dicendo: -Morettina, credo tu debba schiarirti le idee, bevi un goccio di questo, ma non tutto, mi raccomando! E' un vino vecchio e molto forte, in questo momento ne hai bisogno, ma -aggiunse- pure io ne ho bisogno e fra sé continuò -Mio Dio che fantasia! Questa qui è pericolosa...... Alla fine capii che sull'aiuto del nonno non avrei potuto contare e se non mi aiutava lui, addio avventura! Infatti nonno Gustinello non volle più sentir parlare di canoe e simili, ma il mio sogno non era svanito e se non potevo andar per mari non mi restava che tentare l'avventura in altro modo...... I braccianti In quel tempo, da noi, si lavorava soltanto in campagna, quasi tutti gli uomini del paese, con alcune donne, erano braccianti del conte Alessandro Piovene. Lavoravano quindi le sue terre. Partivano all'alba e, verso le ore otto, mamme, figlie, sorelle, mogli s'incamminavano verso i luoghi dove si trovavano i loro congiunti con un cesto appeso al braccio, coperto da un tovagliolo bianco di bucato, portavano la colazione, che veniva consumata tra l'erba odorosa, accompagnati dal canto degli uccelli, risate di fanciulle, grida festose di bimbi e da un appetito formidabile. Quei cesti di vimini non contenevano certo prelibatezze, ma profumavano di pane casereccio, di polenta abbrustolita, di pan moio condito con lardo e cipolla. Era bello vedere con che voracità quelli uomini cotti dal sole, affondavano i grossi cucchiai su quel pane bagnato e lo facevano sparire gustandolo con piacere. La polenta, accompagnata da fette di salame fatto in casa, per chi se lo poteva permettere, era inghiottita in un lampo. Alcuni si dovevano accontentare di polenta e cipolla. Una breve pausa poi, le donne, dopo aver riposto le stoviglie nei cesti, riprendevano la via di casa e gli uomini il lavoro. A mezzogiorno si ripeteva lo stesso rito. Nelle case, quindi, tutto era silenzio nei meriggi estivi. derio d'avventura non era affievolito in me, ma pressante, incessante mi martellava dentro. Se non potevo recarmi in qualche isola sperduta, mi sarei fatta una capanna all'interno del bosco di proprietà del nonno. Agii. Dopo aver staccato rami e fronde costruii qualcosa che, lontanamente, assomigliava ad una capanna. Appesi a qualche ramo, sistemato per traverso, i pochi indumenti che possedevo e che avevo portato con me, poi tornai a casa e, dai cassetti della cucina, presi un coltello, un po’ di spago, alcuni fiammiferi e me ne andai furtivamente per iniziare la mia avventura, non più splendida come l'avevo preparata nella mia mente, ma abbastanza misteriosa e interessante. Vivevo proprio di sogni, completamente fuori dalla realtà. A quel tempo gli svaghi e i passatempi di tutti i ragazzi del paese consistevano nel vagabondare per i boschi, scorrazzare per i prati e catturare animaletti, oppure, alla ricerca di bacche per far tacere la fame mai del tutto saziata. Ero appena sistemata nella mia nuova dimora e stavo dando corso a meravigliosi pensieri, sdraiata su un letto di fresche foglie, quando un vociare concitato mi riscosse e tra il fogliame vidi far capolino i visetti curiosi e sbalorditi di tanti miei compagni. Li apostrofai piuttosto malamente e, visto che con le parole non si decidevano ad andarsene cominciai con il linguaggio dei sassi. Anche se monelli, abituati a ben altro, se la dettero a gambe. Seppi in seguito che corsero ad avvisare i miei. Nonno Gustinello avendo intuito i miei progetti ordinò a tutti di lasciarmi in pace, certo che, con il passar delle ore, sarei arrivata a più miti propositi. Infatti quando iniziò il crepuscolo e le ombre della notte ebbero invaso il bosco, fui presa da brividi. Gli animali nell'oscurità cominciarono i loro movimenti che, uniti a versi un po’ lugubri riempirono il mio animo di terrore. La brezza notturna muoveva i rami che, alla mia fervida immaginazione, sembravano mostri dalle lunghe braccia, pronti a ghermirmi. Ma ciò che mi faceva più spavento era il lugubre canto della civetta. Il cuore cominciò una danza folle, sembrava salirmi in gola, tremavo, ma ancora non mi volevo arrendere, finché, sentendo qualcosa che con foga mi si gettava addosso leccandomi le guance e il collo, fece capitolare la mia resistenza. Era il mio gatto, che mi era venuto a cercare. Me ne tornai a casa. Nessuno chiese il perchè di quella mia, seppur breve, fuga ed io me ne guardai bene di parlarne. Soltanto il nonno, di tanto in tanto, mi guardava divertito e sorrideva sotto baffi. Quando mi guardava così l'avrei strozzato. Mi volevo in qualche modo vendicare e decisi di fargli uno scherzo memorabile. La capanna nel bosco…. I miei lavoravano in proprio, ma sempre nei campi, eccetto il nonno. Quindi, nei momenti di afa e di sonnolenza collettiva, non ero osservata. Come dissi, il desi- Come la Vergine Santa apparve a nonno Gustinello. Nonno, rimasto vedovo, si era avvicinato in modo totale alla chiesa. Buon cri- 34 35 stiano lo era anche prima, ma si limitava all'essenziale. Morta la nonna dunque, imitò in tutto i suoi esempi. La memoria di lei rimase indelebile nel cuore della gente del piccolo paese. Nel santino ricordo, che venne distribuito a tutti coloro che la conoscevano, tra l'altro si legge: .....Amò e beneficò largamente i poveri e tutti sapeva consolare e confortare...... Nonna era un modello di vita cristiana per la comunità, primo fra tutti per il nonno che, come ho detto, divenne un frequentatore assiduo della chiesa. Dopo la sua morte, ogni sera, sia che infuriasse la bufera oppure che la neve fosse alta un metro, non mancava di recarsi al cimitero a salutarla. Nella sua stanza da letto sopra un'enorme cassapanca, teneva, ben allineate, un'infinità di immagini sacre e di medaglie con l'effigie di Madonne, di Cristi e di Santi. Ogni sera s'inginocchiava per terra e baciava una ad una quelle figure, poi passava di stanza in stanza e mandava un bacio a tutte le immagini sacre dei quadri appesi alle pareti. Quando arrivava dove dormivamo io e mia sorella Delia, appena lui entrava, ficcavamo la testa sotto le lenzuola sbirciando il nonno e facendoci le più matte risate vedendo l'atteggiamento estatico del caro nonno. Si alzava ogni mattina quando tutto era ancora buio pesto per recarsi alla messa, che un tempo veniva celebrata prima del baluginar dell'alba, quando usciva di chiesa, in qualsiasi stagione, immancabilmente, si avvicinava alla fontana situata nel mezzo della piazza e che l'acqua fosse potabile o no, ne beveva delle lunghe sorsate. A sera per anni e anni, fino alla sua morte, si portava davanti all'altare della Vergine per recitare il rosario. Diceva che si doveva preparare alla morte con tante preghiere e penitenze perchè da giovane si era divertito troppo…., figurarsi! Sapendo dunque quanto amasse la Madonna ed essendo decisa a fargli uno scherzo, invitai mia sorella a fare un gioco: le feci indossare una bianca camicia da notte, che la copriva fino ai piedi, ai fianchi le annodai una fascia azzurra, sulle mani congiunte le misi una corona del rosario. Sollevai Delia, che era molto più piccola di me, l'aiutai a salire sul grande armadio del nonno, che era ben visibile dall'ultimo gradino delle scale, le promisi un regalo magnifico, se in cambio se ne fosse stata zitta ed immobile fino ad un mio segnale. Sembrava proprio una Madonnina. Avevo accostato le finestre, tirato le tende, creando così una dolce e suggestiva penombra. Mi nascosi dietro un grosso mobile, ma in modo da poter osservare bene la scena. Nonno non tardò a salire, era assorto e già cominciava a biascicar preghiere quando, arrivato all'ultimo scalino, alzò la testa. Un vivo stupore gli si dipinse sul viso, un'intensa emozione lo invase nello scorgere la bianca visione, Delia era proprio una statuina perfetta! Quando nonno aprì le braccia e dalla sua bocca uscì un oh!! di meraviglia e di gioia, non seppi trattenere una risata, che mi sfuggì nonostante, in tutti i modi, avessi tentato trattenerla mor36 dendomi le labbra. Quel che poi successe ve lo lascio immaginare..... per parecchi giorni dovetti girare alla larga dal nonno. Ma la storia non poteva finire così facilmente, infatti dovevo ancora saldare il conto con la mia complice… Delia continuava infastidirmi per il regalo che le avevo promesso, aveva pienamente ragione, infatti il suo compito l'aveva svolto coscienziosamente, anche se non era pienamente riuscito, ma ciò non era dipeso da lei. Come cavarmela? Alla fine scovai una scatola, di quelle a scatto, che era stata di mia nonna, di seta azzurra, dentro era foderata con velluto dello stesso colore, poi mi procurai una grossa cavalletta tutta verde, perfetta, tanto bella da sembrare di vetro. La rinchiusi nella scatola e chiamai Delia. Portai la bimba un po’ lontana da casa e le porsi la scatola invitandola ad ammirare il mio “regalo” davvero speciale. Delia tutta emozionata armeggiò un po’ con la bella scatola, chissà quali tesori poteva contenere, ed alla fine riuscì ad aprirla. Quando la molla scattò, la cavalletta uscì che sembrava impazzita, e si scontrò di brutto con il visetto terrorizzato della piccola, che si mise ad urlare richiamando mezzo paese. L'avevo fatta troppo grossa, e dovetti subirne le conseguenze. Avevano tutte le ragioni. Nonno Gustinello erborista. Anche se monella nonno mi voleva un gran bene. Spesso mi portava con sé nel vigneto, nel bosco, nei campi, alle Riveselle a raccogliere erbe, che poi usava per farne decotti. Quando zia Carolina coceva il radicchio oppure il tarassaco le proibiva di gettare l'acqua, se la faceva mettere nelle bottiglie e poi ne beveva due tazze di seguito ogni giorno. Diceva che non c'era nulla di meglio per purificare il sangue. Nelle grandi feste religiose mi prendeva per mano e assieme si andava nel campo, dove i miei avevano riservato un pezzo di terra per seminarvi e piantarvi la verdura che occorreva per la famiglia. Zia Carolina ci mandava a prendere il sedano per il brodo. Di solito si andava prima della messa, quando le campane sembravano impazzire dalla gioia e liete facevano risuonare le note argentine tra la natura in festa. Io allora, tenendo stretta la mano del nonno, camminavo con gli occhi fissi al cielo e immaginavo lunghe file di Santi, di Patriarchi e di Profeti accompagnati da schiere di Angeli, scendere e salire verso il sole e prendere tra le mani i suoni melodiosi delle campane per spargerli su ogni angolo della terra. Dicevo al nonno di sentirmi il cuore scoppiare dalla gioia, un'ineffabile dolcezza avvolgeva tutto il mio essere, l'azzurro del cielo, in quei momenti, sembrava avvolto da veli di vivissima luce, dentro i quali vi danzavano bianche figure alate. Nonno ascoltava e annuiva commosso. Ecco -diceva il nonno- questo è un pezzettino della gioia che un giorno gusteremo completa quando saremo nell'aldilà. 37 Del nonno potrei parlare all'infinito tanti sono i ricordi che mi legano a lui e tutti pieni di grande tenerezza e nostalgia. Visse fino a novantadue anni. Si recava alla Chiesa due o più volte al giorno, fino a qualche giorno prima della sua morte. Alla sua dipartita bruciai tutte le immagini sacre da lui tante volte baciate, erano irriconoscibili, sembrava avessero fiutato un chilo di tabacco ciascuna, tanto ne erano impregnate. Anche le medaglie erano patinate di tabacco. Quelle le lavai perchè non le potevo bruciare. Tra le varie Madonne e Santi ne trovai una che il nonno aveva sempre baciato con fede, ma che, dopo una drastica pulitura si rivelò essere nientemeno che una medaglia del Re Vittorio Emanuele III. Caro nonno, quanto affetto ci legava! Quanto mi sei mancato! 1.6. La mia famiglia e la guerra. Vidi le lacrime sul volto di mia madre il giorno che due carabinieri vennero a casa nostra e le porsero una lettera. Rivedo la scena: mia madre seduta su una sedia con Delia fra le braccia, i carabinieri la guardavano impacciati, io, che ero andata nel secchiaio a prendere dell'acqua con il tazzone di rame, (da noi chiamata, in dialetto cazza) alla vista dei due, lasciai cadere la tazza e mi rovesciai addosso tutta l'acqua, qualche spruzzo se lo presero pure i carabinieri. Pensavo Papà Antonio e mamma Pia, sposi. avessero fatto del male a mamma perciò li guardai in cagnesco, pronta a chissà cosa, se il sacro terrore che mi incutevano le loro divise non m'avesse frenata. Era cominciata la seconda guerra e papà veniva richiamato, per questo lei piangeva. Per fortuna rimase sotto le armi solo per poco tempo, infatti lui e il nostro zio, suo gemello, avevano già combattuto durante la prima guerra mondiale, entrambi erano nella cavalleria. Eugenia portò un vestitino di percalle che era esattamente della mia misura. Possedere allora due vestiti per la domenica era un lusso che si potevano permettere soltanto i ricchi. Ero felice. Quando arrivò il tempo della mietitura lo zio ed il mio papà dovettero essere aiutati da altre persone oltre i soliti braccianti, uomini e donne. Io mi rendevo utile portando loro dell'acqua fresca e, di tanto in tanto, mi portavo sulla riva del fosso che separava il campo dalla strada per raccogliere fiori. Anche mio fratello era spesso con me e quel giorno, assieme ad un suo amico, era lì che mi osservava mentre raccoglievo dei fiori, a mio fratello non era passata la voglia di fare scherzi a chiunque, specialmente a me. Disse: -Linda guarda, guarda che bellissimi fiori in mezzo al fosso, raccoglili dunque! Gli feci osservare che le mie braccia erano troppo corte, però mi sforzavo di raggiungerli, erano tanto belli! In quel momento lui mi diede una spinta e scivolai nell'acqua. L'incosciente sbottò in una fragorosa risata vedendomi annaspare. Non sapevo nuotare e cominciai a gridare. Accorsero i mietitori e mi trassero dall'acqua. Giuseppe se la svignò assieme al suo amico. In quel momento, di lì, passava Ettore Ferrari (el Moreto) in bicicletta. Mi affidarono a lui che mi portò a casa. Zia Carolina era nell'aia con la prozia Lucia, si misero a strillare come aquile vedendomi in quello stato. Dopo avermi tolti gli indumenti bagnati mi asciugarono strofinandomi energicamente. Zia Carolina mi fece indossare il vestitino che mi aveva portato la madrina Eugenia ed io tornai nel campo dai mietitori. Al mio arrivo una delle donne, la Caterina, mi guardò a lungo e sospirando disse: -Anche la mia Milena se fosse caduta in acqua avrebbe avuto di che cambiarsi! Come a dire che avrebbe dovuto rimanere avvolta in un asciugamano perché due vestiti, la sua bambina, non li aveva. Quelle parole e specialmente quel tono di voce, mi sono rimasti impressi nella memoria in maniera indelebile. L’abitino di percalle. Non si parlava che di bombardamenti, di morti, di fame e di tante altre cose tristi. Gli amici della povera mamma, Antonio ed Eugenia, venivano da Vicenza in bicicletta per avere, in cambio di indumenti usati: farina, legumi, insaccati e qualche pollo. I miei, sia in nome dell'amicizia che ci legava e sia perché qualche vestito o qualche paia di scarpe ci facevano comodo, davano quanto potevano. Una volta zia 1.7. Utensili domestici. Il sale! C'era poco da vestire, ma meno ancora da mangiare in tempo di guerra e neppure c'era abbastanza sale per dare un po’ di sapore alle scarse vivande. Qualche persona fra le più coraggiose tentava di procurarselo sfidando gravi pericoli. Ricordo che anche lo zio Luigi, forse esasperato nel dover mangiare quotidianamente cose insipide, un giorno inforcò la bicicletta e se ne andò alla ricerca di quel minerale, allora, così prezioso. Si portò in una località piena di pericoli, fortunatamente li superò. Portò a casa un sacchetto di sale, dal colore piuttosto marrone, ma sempre sale. Lo pagò a caro prezzo, ma ricordo che, mostrandolo con orgoglio diceva: -Ora, per un bel pezzo, non mangeremo più dissavio, cioè senza sapore! Il nonno, che era falegname, aveva costruito un grosso pestasale. Un recipiente di legno molto duro, fatto a scodella. Dentro si metteva una manciata di sale e, con un altrettanto duro manico, un po’ più largo e appiattito ad un’estremità, lo si pestava fino a ridurlo in polvere. Quando lo pestavo io , talvolta, mi venivano i brividi perché frantumandolo 38 39 sembrava vetro che stridesse. Avevamo anche il pestalardo, ma quello era adoperato più dalla zia, Era fatto di legno molto resistente, alto venti centimetri circa e con lo stesso diametro. Zia metteva sopra questo legno un pezzo di lardo e, con un coltello molto grande, batteva tagliando finché il lardo era ridotto un brandello. C’era poi anche il tagliapane. Anche quello fatto di legno, ma un più leggero degli altri due. Il coltello era inserito nel mezzo del bordo che era attorno alla base e agganciato allo stesso. Tutti lo adoperavamo il tagliapane, specialmente quando il pane era raffermo. Questi tre utensili, mi erano cari, anche se logorati dall’uso che se ne faceva quotidianamente nella nostra cucina di casa. Una volta mi venne da scrivere una breve poesia, che ora riporto: CUORE Zia mi diceva di schiacciare il sale, …ed io schiacciavo. Nonno chiedeva di pestare il lardo, …ed io pestavo. Zio comandava di tagliare il pane, …ed io tagliavo. Mi é stato chiesto di strapparmi il cuore: …era strappato! Altri l'avean schiacciato, altri ben frantumato, altri pure tagliato… Oh cuore mio, dove sei ora? focolare dove le donne di casa dovevano rimanere più a lungo per preparare il cibo e scaldare l’acqua, si notavano delle conche. Molte volte mi soffermavo a fissare quei mattoni così consumati e pensavo ai mille e mille passi che li avevano calpestati. Dicevo tra me: - Se potessero parlare, ne avrebbero di storie da raccontare! Il giorno che li hanno tolti per sostituirli con le moderne mattonelle provai vivissimo dolore. Certo, non fiatai, m’avrebbero presa per scema, ma io soffrii molto, come provai vivo dispiacere quando cambiarono la pietra del focolare. Quella pietra era impregnata di sogni e di speranze, d’amore e di dolore, di pianto di bimbi e lacrime amare di adulti. Gioie e dolori lì avevano avuto il loro sfogo o il loro riposo. La nuova pietra non scaldava il cuore, non parlava alla mia anima. Quanti ricordi legati a quei mattoni rossi del pavimento, a quella pietra del focolare, che bellezza, quale gioia, quando nel calore, e nell’intimità della nostra famiglia la mamma scodellava la gialla polenta…. Sentite cosa scrissi una volta per esprimere questi bei sentimenti di gioia domestica, e di affetti tonificanti, rappresentati dal bel sole giallo di una bella polenta versata sul tagliere della cucina di casa. SOLE La cucina di casa. Cara vecchia cucina quanti ricordi! Il suo pavimento, con i suoi rossi mattoni, veniva lavato per bene con la scopa di saggina e, talvolta, si dava una polvere rossa per ravvivarne il colore. Quei mattoni erano logorati, ma in certi punti lo erano di più. Davanti al secchiaio, dove si sostava per lavare le stoviglie e le pentole, davanti al Sembrava un sole tanto era gialla ed il calore era tanto forte che il ditino, goloso e indaffarato, si ritraeva sgomento e spaventato. Lì sul tagliere, rozzo e un po’ sciupato, mamma scagliava con forza la polenta, che dal paiolo usciva borbottando. E che festa figlioli, che allegria! Spuntava in sulla sera il sole a casa mia! 40 41 Un tempo c'era lo schiacciasale, il pestalardo, il tagliapane e ricordo che erano tutti e tre consumati dall'uso. Ora quegli oggetti non si usano più. Quante volte li ho usati anch'io da ragazzina! Ma il pesta-schiaccia- taglia cuori erano, sono e saranno sempre usati, perché la cattiveria non verrà mai consumata dall'uso. Stufe e camini. Quasi nessuna famiglia, allora, possedeva una stufa. A casa nostra ce n’era una in tinello, cioè nella sala adibita a vari usi. Ricordo che veniva accesa soltanto in rare occasioni, ad esempio quando si faceva la cena per l’uccisione del maiale e venivano invitati parenti e amici. L’unica fonte di riscaldamento e per cuocere il cibo per uomini e animali rimaneva sempre il fuoco acceso sul focolare. D’estate non era per niente piacevole lavorare con casseruole, pentole, paioli o bricchi e si accendeva soltanto quando era necessario come: cuocere il cibo, scaldare acqua, produrre braci per il ferro da stiro…., ma d’inverno era una vera delizia, allora non occorrevano le sollecitazioni delle mamme, nonne, zie per alimentarlo, perché anche noi bambini, facevamo a gara per ravvivare la fiamma, per aggiungere pezzi di legna o bei ceppi profumati di bosco. Pentole e paioli venivano agganciati alla catena del camino che, pian piano, si riempiva di nera caligine. Quando il camino veniva pulito, veniva staccata pure la catena dove si agganciavano le pentole e i paioli perché anche lei aveva bisogno di venire liberata dalla fuliggine. Ricordo che ciò succedeva nel tardo autunno, quando il fuoco si accendeva prima dell’alba e lo si spegneva a notte inoltrata. Alla pulizia del camino erano addetti gli uomini, aiutati dalle donne, mentre per quella della catena il compito era dei ragazzini. Se era nevicato era un divertimento trascinare su e giù per la strada o in giro per la piazza le catene che, come lunghi serpenti di ferro, regalavano alla neve il loro nero vestito e mettevano in mostra, seppure per poco, il lucore del metallo. Anche se la neve tardava a cadere i camini dovevano essere puliti, così pure le catene, che venivano trascinate sempre per le strade ma, a ricevere la nera fuliggine non era la bianca e soffice neve, bensì la ghiaia delle strade che, a quel tempo, quando le buche si facevano più profonde e le piogge le riempivano d’acqua, erano pressoché impraticabili. Allora si provvedeva con la ghiaia. Veniva portata con carriole o carretti e si ingiaravano (inghiaiavano), nel gergo paesano si diceva così. Gli uomini l’accomodavano bene e, per pressarla, non occorrevano rulli, bastava il peso dei carri o di altri veicoli. Dopo la pulizia del camino e delle catene si accendeva il fuoco che allegramente infilava le fiamme su per la cappa scoppiettando come a ringraziare per il passaggio reso più agevole e veloce. E così ci si preparava per la stagione invernale, quando attorno al focolare ogni famiglia avrebbe trascorso lunghe ore conversando, e sognando la prossima calda stagione. qualcosa che lo facesse soffrire, non lo sopportavo! Diventavo una belva. Un giorno che, per l'ennesima volta, avevo colto lo sguardo triste di papà mentre in casa si parlava di certe persone, che continuavano nelle loro cattiverie, che lasciavano a bella posta i loro animali liberi di pascolare per i nostri campi venendo così danneggiati, mi sentii ribollire e giurai di vendicare quegli sgarbi: lui non l'avrebbe mai fatto, essendo troppo paziente e buono. Zia, aderendo alla mia richiesta, aveva comperato delle oche, così potevo portarle al pascolo come facevano i miei compagni. Quel giorno presi dal cassetto della credenza le forbici, quelle grosse. Le misi in tasca e m'avviai a portare al pascolo le oche, che lasciai un po’ sulla proda del campo. Entrai nel vigneto di quelle persone per me poco oneste, e cominciai a tagliare più grappoli che potei, li tagliavo e li lasciavo cadere per terra, alla fine, stanca, chiamai le oche, che ne fecero una solenne scorpacciata. L'eco dell'effetto di quella prodezza mi arrivò smorzato. Non lo manifestai ad anima viva, ovvero sì, a qualcuno lo dovetti confidare: al parroco in confessione. In realtà quella vendetta, anche se ero convinta fosse stata una buona azione, non mi rese contenta. Ricordavo e ricordavo...... Attaccata al papà come un’ostrica al guscio. Stavo con papà più che potevo. Mi ero attaccata a lui come l'ostrica al guscio. Ricordo i lunghi trepidi sguardi che mi avvolgevano quando certe persone, credendo di rendergli un servizio, lo informavano di qualche mia marachella. E' vero, talvolta lo facevo disperare, ma guai se qualcun altro, avesse fatto o detto 1.8. La morte del babbo… Non avevamo ancora finito di soffrire. Era appena terminata la guerra, poco tempo dopo la liberazione, che mio padre morì. Era andato a pescare nei nostri fossi, aveva una grande passione per la pesca, spesso l'accompagnavo, era una gioia per me sedere accanto a lui tra l’erba odorosa, il ronzio degli insetti, il canto delle cicale e il volteggiar delle farfalle variopinte. Qualche rana saltava dalla sponda all’acqua e viceversa, facendo muovere l’acqua e scappare i pesci. Osservavo papà che, dopo aver sistemato per bene la rete nel punto del Papà Antonio fosso che lui riteneva più adatto, reggeva il manico tra le sue mani robuste e abbronzate e, quando riteneva che qualche pesce si fosse introdotto tra le sue maglie, la ritirava adagio. Che bello vedere i pesci saltellare nella rete, sembrava giocassero. Mi facevano anche pena quando li vedevo boccheggiare, ma papà assicurava che il buon Dio li aveva creati perché noi ce ne cibassimo e per questo aveva fatto nascere anche le pannocchie di grano per la polenta, che si accompagnava molto bene sia con il pesce fritto che quello in umido. Quel pomeriggio d'agosto assieme a tanto pesce, papà “pescò” la leptospirosi. Dopo qualche giorno morì. Da quattro anni eravamo orfani di mamma quando in pochi giorni questa terribile infezione si portò via anche papà. Avevo nove anni, Delia ne aveva cinque, gli altri due erano un po’ più grandicelli. Quel pomeriggio papà aveva fatto una pesca abbondante e tutti eravamo contenti ma, verso sera, cominciò a sentirsi male. La febbre, dapprima lieve, cominciò a salire vertiginosamente. Venne il 42 43 medico , non so cosa disse al nonno ed agli zii, so che due giorni dopo venne fatto un consulto con un professore dell’Ospedale di Padova, ma durante la notte papà morì, tutto era stato inutile, non s’era trovato alcun rimedio. Il primo giorno che rimase a letto gli tenni compagnia, non lo volevo lasciare solo. Dopo la morte di mamma gli stavo sempre appresso, non lo lasciavo mai. Dormivo in camera con lui e, molte volte di notte lo chiamavo, o perché avevo sete, o perché volevo un pezzo di pane. Lui paziente scendeva barcollando, pieno di sonno poi mi pregava di star buona, di dormire….. Quel pomeriggio aggrappata a lui, lo accarezzavo, lo guardavo, sentivo però qualcosa d’insolito: un nodo mi serrava la gola e il mio piccolo cuore era stretto da indicibile angoscia, e da un terrore oscuro e tremendo. Non ricordo se fu il giorno dopo il manifestarsi della malattia che zia mi prese con sé e mi portò a Monte Berico a supplicare la Madonna per la guarigione di papà. Ricordo che donò alla Vergine la sua catenina d’oro. Zia sperava e pregava. Che faresti Linda? Il giorno prima che papà morisse, ero con lui seduta sul suo letto. Ad un tratto mi abbracciò e stringendomi a sé, disse :- Che faresti Linda se il tuo papà non ci fosse più, se andasse a trovare la mamma e rimanesse con lei per sempre? Forse mi voleva fare delle raccomandazioni, dirmi qualcosa sapendo quanto fossi istintiva e ribelle….-Papà..! aprii la bocca, ma non riuscii ad articolar parola... Ma che stava dicendo! Che significavano quelle parole? Lui mi fissava così intensamente che, a distanza di anni, ancora quegli occhi nerissimi, teneri e dolci mi stanno impressi nel cuore e nella mente. Era come se un’immensa montagna di dolore mi fosse caduta addosso. Mi sentivo impregnata, assorbita da qualcosa che mi toglieva il respiro. Volevo piangere, urlare ma non potevo. Rimasi intontita a guardarlo. Sconvolta gridavo dentro di me che non era possibile, che lui non mi poteva lasciare sola, che senza di lui sarei stata come un piccolo pulcino travolto da uno scroscio d’acqua, che sarei stata sola anche se c’erano i fratelli, nonno, zii. In quei momenti la luce del sole d’agosto, filtrava dai balconi socchiusi, l’odore dell’uva che stava maturando nella pergola sotto le finestre, entrava a flotti e si mescolava all’odore dei medicinali. Il silenzio era solenne e i nostri cuori avevano rallentato i battiti per il dolore che l’uno dava all’altro. Se mi ami perché te ne vuoi andare? Nella mia ingenuità mi chiedevo come mai papà, che mi voleva un bene immenso, che mi stringeva tanto affettuosamente a sé, che mi consolava quando mi vedeva triste perché ero stata rifiutata dai fratelli o dai compagni nei loro giuochi, che prendeva sempre le mie difese quando si accorgeva che qualcuno mi picchiava senza ragione, che quando poteva mi portava con sé nei campi, a pescare lungo i fossati, che coglieva le buone bacche quando in autunno si reca44 va nei boschi per la legna perché sapeva quanto mi piacessero, che mi comperava le scarpe con la suola di legno perché i miei piedini non prendessero i geloni quando il freddo era tanto intenso, che asciugava le mie lacrime quando sentivo più acuta la nostalgia di mamma, come mai se ne voleva andare senza di me? Come era possibile? Papà intuiva tutto ciò che passava nella mia piccola anima e, forse per questo non seppe trattenere una lacrima, che scivolando lungo le gote mi diede la risposta che lui non mi poteva dare e cioè : - Piccola mia, non sono io che ti voglio lasciare, è questo male che mi ha aggredito come un mostro ed io non ho le armi per combatterlo, ma ci soffro in maniera indicibile……. Ma come! Non ero già stata privata delle carezze e dei baci della mamma? Anche l’affetto più grande che mi rimaneva mi veniva tolto? Prima delle parole di papà tutto mi sembrava bello, pensavo che la sua malattia si risolvesse in qualche giorno di letto come, di solito, avveniva per l’influenza e che tutto sarebbe tornato come prima. Insieme avremo ancora guardato il sole sorgere, al mattino gli avrei portato ancora la colazione nei campi, l’avrei aiutato a raccogliere le grosse pesche, a vendemmiare l’uva e, soprattutto, avrei sempre goduto del suo sguardo amoroso, dei suoi abbracci affettuosi, dei suoi teneri baci, della sua protezione vigile e costante. Sì, alle volte meritavo qualche ceffone, ma un giorno che nonno me lo diede in faccia vidi papà, che stava frenando il carro lungo la strada in discesa, lo vidi trasalire come l’avesse ricevuto lui. Pensavo a Dio, che mi avevano insegnato essere Padre buono, pensavo che Lui sapesse quanto amavo papà e perciò non poteva togliermelo come aveva fatto con mamma. Papà intuiva che quel male lo avrebbe ucciso e, non per se stesso, ma per i suoi bambini, da poco rimasti orfani di mamma trepidava ed era angosciato. Soprattutto trepidava per la sua Linda, sapeva com’era impastata la sua bambina più caparbia e più sensibile, sapeva che ero fin troppo sincera e che a causa di ciò, senza una guida amorosa, avrei sofferto molto. Sapeva che mi sarei fatta picchiare piuttosto che raccontare frottole, e sapeva pure che non gli andavo a raccontare le cattiverie di cui molte volte ero fatta oggetto. Non da me, ma da altra fonte veniva alle volte a conoscenza di cattiverie che mi erano fatte e soffriva per questo. Sapeva che non mi piegavo davanti a nessuno se non si parlava con sincerità. Sapeva che, senza le sue difese, castighi e rimproveri non mi sarebbero stati risparmiati. Per questo, lo strazio di papà, seppure in modo diverso, era grande in quei momenti, quanto il mio. Mi sentivo come una piccola formica che si sforzava di spingere da parte una montagna. Volevo allontanare la malattia di papà, e cominciai ad accarezzare il suo viso, i suoi bei capelli ondulati, baciavo i suoi occhi, gli stringevo le mani…ma dalla gola non mi usciva alcun suono. Poi, per non gettarmi a terra e urlare il mio dolore, e per non far piangere papà, mi svincolai dalla sua stretta, saltai giù dal letto e scappai………. 45 La grossa campana. Fuggii correndo, mi rifugiai tra le alte erbe del campo. Le parole di papà mi martellavano la testa, si ripercuotevano nel cuore, mi prendevano tutta chiudendomi in una morsa di dolore talmente spaventoso da togliermi anche la possibilità di versare una lacrima. Quando a sera rientrai in cucina, nessuno mi chiese dove fossi stata perché tutti erano presi, come me, da un’angoscia dolorosa e terribile che ci annientava completamente. Il mattino seguente, la grossa campana che era stata issata sul campanile nel pomeriggio del giorno precedente, suonò il transito di papà. Papà era morto durante la notte, nessun rimedio aveva potuto salvarlo. Zia Carolina prese in disparte me e Delia, ci disse che papà era con la mamma, in cielo. Lo avevo capito dal suono solenne lento e mesto della campana. Che strana e cattiva quella bambina… Non partecipai ai funerali. Prima che venissero a prendere la bara, eludendo la vigilanza delle zie e dei fratelli, me ne andai a girovagare attraverso il bosco. Qualche ora dopo me ne tornai a casa. Alle domande degli zii rispondevo a monosillabi. Mi chiusi in un mutismo tetro e sfuggivo le persone più che potevo. Avevo un piccolo gattino, che mi seguiva ovunque, mi accompagnava a scuola ed era sempre lì ad attendermi all’uscita, mi teneva compagnia anche quando facevo i compiti a casa Saliva sul tavolino e si sdraiava accanto al calamaio, con gli occhi seguiva la mia mano che intingeva il pennino nell’inchiostro e poi mi guardava. Non disturbava mai. Finiti i compiti si prendeva la sua razione di coccole e strofinava il musetto sulla mia spalla. Era per me una profonda consolazione, una maniera di rimanere in contatto con una vita divenuta improvvisamente troppo dura e difficile da poter sostenere. Un giorno non lo vidi aggirarsi per la casa e non mi accompagnò a scuola come di consueto. Lo cercai invano per una settimana. Un giorno che me ne stavo sull’aia pensando a papà vidi venirmi davanti mio fratello con alcuni suoi amici. Lui , mio fratello , teneva le mani dietro la schiena . Mi si accostò e disse: Linda, è questo il gatto che cerchi? E nel dire mi mostrò il mio gattino tutto straziato. Lo avevano ucciso. Dapprima lo guardai impietrita, poi scoppiai in un pianto irrefrenabile. Quando, sfinita, i singhiozzi si furono attenuati sentii una voce, non ricordo di chi, so solo che era voce di donna, che diceva: -Che strana e cattiva quella bambina, per la morte di suo padre non ha versato una lacrima, mentre per il gatto sembra un fiume in piena. Che ne sapeva quella del mio dolore? Come lo poteva misurare? Chi capirà il cuore schiacciato da un’angoscia troppo grande ed insopportabile di un bambino? Il pianto, il mio pianto, era trattenuto tutto dentro di me, congelato, e bloccato come un blocco di marmo, esso mi straziava l’anima ma non riusciva ad uscire perché impedito dall’im46 mane diga di tutto il dolore che mi soffocava e che mi circondava. La visione terribile del mio gattino squartato aveva funzionato, come in uno psicodramma, da macabro e drammatico detonatore. La morte giungeva ancor a sfiorarmi, mi raggiungeva un’altra volta, ed io che cercavo disperatamente di sfuggirla, non potevo più rifugiarmi, ed evadere, in un simbolo di vita. La diga crollava, ma il pianto che m’inondava era angosciato, e senza speranza, non certo liberatore e risanante. Ancora oggi ho davanti agli occhi l’orrenda visione, e odo ancora la raggelante e sgangherata sghignazzata di mio fratello e dei suoi amici nell’assistere all’esplosione del mio dolore. Un raggio di luce: qui Dio è rispettato e amato Tante cose, fatti, situazioni tornano sovente alla mia mente, ma un ricordo, in particolare, è sempre vivo e presente in me, e riguarda nonno Gustinello. Allora non potevo, capirne la grandezza, ero troppo piccola, con il passar degli anni tutto divenne chiaro e capii quanto grande e granitica fosse stata la fede cristiana del nonno. Ricordo il nonno staccare dalla pianta dell'oleandro, addossato al muro vicino alla porta di casa, un rametto di fiori e posarlo sulla bara di papà. Lì, in quel momento, c'erano pure i nostri padrino e madrina, che venivano da Vicenza per partecipare al funerale. Lei, Eugenia, disse rivolta al nonno, in tono risentito: -Perchè Dio non si è accontentato della mamma? Almeno il padre avrebbe potuto lasciare a questi bimbi! Ora sono quattro orfani e di entrambi i genitori! Nonno la guardò severamente e rispose: -Signora, le proibisco di parlare in questo modo. Dio sa quello che fa, non si erga a giudice di Dio! E continuò -Se queste sono le sue idee la prego di non farsi più vedere a casa mia, perchè qui Dio è rispettato e amato. Come un animale braccato. Forse non era vero, forse semplicemente gli adulti erano preoccupati, ma io mi sentivo osservata, controllata, soppesata, come un animale speciale, braccato per spiarne le reazioni. Così mi spingevano sempre più a ricercare la solitudine, ed io mi recavo in qualche luogo isolato per pensare a papà, volevo stare qualche momento sola per passare in rassegna i momenti belli trascorsi assieme, ma ricordavo pure i capricci che lo facevano soffrire, le mie caparbietà che lo facevano sospirare. Mi facevano invece rabbia e schifo certe frasi che udivo qua e là. Se gli zii e il nonno ci rimproveravano, ed era loro sacrosanto dovere e segno che ci amavano, le pie donne si esprimevano così: -Poveri bambini, se avessero i loro genitori non verrebbero trattati in quel modo. Se, al contrario, dopo qualche marachella non venivamo castigati la loro indignazione raggiungeva il colmo e sentenziavano: -Guarda quei poveretti, crescono come piccoli selvaggi, senza controllo e senza educazione! Fortunatamente la zia era tal47 mente oberata da mille faccende, che non aveva un attimo per ascoltare le maldicenze ed i pettegolezzi che si facevano, soprattutto sul suo operato. Quando quelle anime “caritatevoli e pietose” bussavano alla nostra porta, e lo facevano giornalmente, per chiedere alla paziente e santa donna di mia zia se avesse da dar loro qualche cosa, non avendo nulla per imbastire una minestra, oppure chiedevano del companatico (eravamo nell’immediato dopo guerra), lei non rifiutava mai. Dava sempre e dava a tutti. Di questo sono stata attenta osservatrice. -Hanno del bel coraggio -mi dicevo- a presentarsi dalla zia, dopo che tutto il giorno l'avevano criticata. Anch'io, povera zia, contribuivo con i miei capricci a renderle più difficile la vita, ma quelle donne mi erano antipatiche e odiose tanto che, quando qualcuna tentava di baciarmi, fuggivo per non prenderla a morsi. Uno strazio indicibile. Soffrii per la morte di mamma, ma per papà fu uno strazio indicibile. La morte di papà mi frantumò il cuore. Niente più m’interessava. La natura che prima era il mio libro preferito dove mi tuffavo a leggere tutto ciò che trovavo scritto e che faceva esultare il mio spirito mi sembrava piatta, senza colore e vita, senza più voce e canto. Quando a sera ci si radunava per la cena non guardavo mai il posto di papà. Ero un corpo senz’anima. Stavo sempre zitta, tenendo nel cuore il ricordo di lui quasi con gelosia. Se qualcuno mi parlava di papà non rispondevo, se qualche oggetto di lui mi capitava tra le mani lo riponevo e poi non lo guardavo più. Ero sempre scontrosa, mi ero rifugiata in un mondo tutto mio, un mondo dove nessuno poteva entrare. Non sopportavo le frasi: -Poveri bambini, sono rimasti soli, chissà cosa dovranno patire. Se qualcuno tentava di farmi una carezza giravo la testa dall'altra parte perché non sopportavo l'ipocrisia e avevo la sensazione che quelle parole fossero false, dettate solo da morbosa curiosità. Una mia compagna, incontrandomi qualche giorno dopo il funerale, mi chiese se avevo pianto, ma lo chiese in un modo così stupido e rivoltante da farmi venire una collera incontrollabile. Per non mollarle un ceffone scappai via guardandola come si guarda un cane rabbioso. Ero vista dagli altri come la bambina solitaria e triste. A me non importava niente di come mi giudicavano gli altri. Non sopportavo gli sguardi pietosi e tanto meno le carezze. Se richiesta aiutavo nelle faccende domestiche, altrimenti me ne andavo senza meta girovagando per la collina e per i campi. fatto tornare in vita. Credevo fermamente che papà sarebbe uscito un giorno dalla tomba. Vivere senza di lui? Impossibile! Eppure mi ci dovetti abituare, ma stavo diventando scontrosa e taciturna. I giorni e i mesi passavano ed io ero sempre triste. Un giorno mia sorella pose tra le mie braccia una pila di piatti perché li andassi a riporre nella credenza, si vede che erano troppi per le mie forze e mi caddero con enorme fracasso, rompendosi tutti. Zia e sorella mi sgridarono forte. Non dissi nulla, ma me ne andai di casa. Mi misi a salire la collina. Arrivata alla Zela, una casetta con una parete formata dalla roccia del monte, in mezzo ai sassi e che, allora era abitata, vi passai accanto per salire ancora. Camminavo già da tempo e il sole, lentamente stava sparendo. Non volevo tornare a casa ma anche lo avessi voluto ormai mi ero perduta. Non avei saputo come tornare indietro. Mi trovavo in un luogo dove abbondavano cespugli di rovi, di ginepri, di spino e di altra vegetazione che non ricordo. C’erano pure delle bianche rocce che sporgevano qua e là, attorno c’era dell’erba non alta dove si poteva benissimo camminare senza pericolo. Mi guardavo attorno smarrita, ma ero decisa a proseguire il cammino senza pensare minimamente a ciò che stavo per fare. Il silenzio di quel luogo era interrotto da qualche strido d’uccello che se ne tornava al nido, tutto intorno silenzio, neppure un alito di vento. Improvvisamente, a pochi passi da me, vidi un uomo. Da dove fosse sbucato non me lo seppi spiegare, perché attorno a me non c’erano alberi, ma solo cespugli e piccole rocce. L’uomo rimase scostato al mio fianco ma, mentre io me ne andavo, lui era come mi fosse venuto incontro. Mi guardò in silenzio. Anch’io lo guardai senza riuscire a spiccicar parola. Era di statura normale, vestito dignitosamente ma senza ricercatezze. Mi chiese dove fossi diretta, risposi che non lo sapevo. Allora, guardandomi con serietà mi disse: - La tua casa è laggiù, torna subito prima che sia notte e, indicandomi un punto aggiunse – cammina sempre dritto, non ti perderai….. M’incamminai, mi voltai per salutare ma era sparito. Era arrivato lì come per incanto e, nello stesso modo se ne andò. Chi era? A distanza di anni penso proprio fosse stato il mio papà venuto ad impedirmi di fare una sciocchezza. Cammina sempre dritto, non ti perderai! Ho portato questa frase sempre nel mio cuore come un talismano celeste, che mi ha aiutato in tanti momenti bui e difficili, in cui, nella solitudine della vita, la strada verso casa pareva davvero smarrita. Ripensando a quell’episodio, ed a quel periodo della mia vita mi capitò una volta di scrivere la seguente poesia: Cammina sempre dritto, non ti perderai! La maggior parte del tempo la trascorrevo al cimitero. Mi recai per tanto tempo alla sua tomba, come feci per la mamma, rimanevo ore seduta su quella pietra, senza avvisare i famigliari. Ero sicura che il mio immenso affetto l'avrebbe 48 49 1.9. L’affetto di zio Luigi e di zia Carolina. Mio padre aveva un gemello. Ebbene mentre lo zio era bianchissimo di carnagione, i capelli biondo - ramato e gli occhi azzurri, mio padre di carnagione era olivastro, i capelli neri ondulati ed aveva gli occhi nerissimi. Alla morte della mamma, ci trasferimmo alla casa del nonno e degli zii, a sera, finché ci fu papà, si tornava a dormire nella nostra casa poi, alla morte di lui rimanemmo sempre con loro. Zio Luigi e zia Carolina non formarono una loro famiglia, a mio parere decisero di rimanere nubili per accudire a noi. Questo l'ho sempre pensato io, perché da loro non uscì la più piccola parola riguardo a ciò. Meglio così, altrimenti ci avrebbero diviso e spediti in qualche orfanatrofio. Zio era un po’ burbero e di poche parole, ma era buono. Zia era una santa. Povera zia! Quanta pazienza le ho fatto esercitare! Non basterà un'eternità per chiederle perdono di tutte le noie che le ho proZia Carolina curato. Ero di un'incredibile caparbietà. Vorrei dedicare un ricordo particolare, e pieno di affetto, a zia Caterina. Quando ripenso a lei trovo il mio cuore sempre intriso di rimorso, ma anche d’immensa gratitudine e riconoscenza: zia Carolina ci accudì ed allevò con amore. Nonostante la fatica e il lavoro che gravava sulle sue povere spalle, alle sante funzioni domenicali non mancava mai. Ricordo che mandava noi bambine a riposare, lei rimaneva a riordinare, a lavare le stoviglie poi, alla fine, sedeva e scioglieva i suoi lunghissimi e folti capelli per pettinarli. Erano meravigliosi i capelli di zia, allora non c’erano le parrucchiere, e neppure venivano tagliati, se non raramente. Zia li aveva biondi e molto ondulati, li raccoglieva in trecce, ma erano troppi, sicché doveva sacrificare tutto il tempo del suo breve riposo pomeridiano per poter essere pronta e recarsi alla Chiesa. Ho capito troppo tardi, quanto bene ci hai voluto, e quanto hai dovuto sacrificarti per noi! Cara zia, spero che ci pensino gli Angeli ora ad accomodarti i capelli in paradiso, così tu potrai finalmente riposare. La messa veniva celebrata, sia di giorno feriale che festivo, quando l'alba non era ancora annunciata, d'inverno poi era buio Papà Antonio e zio Luigi (gemelli) con la divisa da soldati (cavallepesto. Una mattina di ria). Antonio, tiene la mano sulla sedia domenica, in pieno inverno, piombai in chiesa con addosso solo gli indumenti intimi, zia, quando mi vide poco mancò venisse presa da infarto. Dovette riportarmi a casa coprendomi con la sua grande sciarpa, trascinandomi a stento tanto il mio gesto l'aveva scossa. La facevo disperare anche perché talvolta, quando 50 51 RICHIESTA Ho chiesto al vento di portarmi sulle sue ali, ho chiesto al mare di cullarmi sulle sue onde, ho chiesto al cielo di rimanere sempre serena, ho chiesto al sole di tuffarmi nella sua luce, ho chiesto alle nubi di nascondere il mio volto, ho chiesto all'arcobaleno tutti i suoi colori, ho chiesto alla terra un po' di spazio, allora riposerò serenamente. apriva l'armadio per farmi indossare qualche indumento, succedeva che questo fosse introvabile. Era andato a finire assieme alla farina, nella bisaccia di qualche povero… Così sparivano tanti miei indumenti, da non aver quasi più nulla da mettermi addosso. Non mi rendevo conto di quanto disagio provocassi con quel mio modo di fare così sconsiderato. Quello che facevo e che agli adulti non andava mai bene per me invece era un dovere, una necessità, un obbligo...... Non ci avevano insegnato loro che si dovevano aiutare i poveri? E allora perché tante storie? CAPITOLO SECONDO LA FONTANA DEL VILLAGGIO: UNA FOLLA DI VOLTI NELLA PIAZZA DEL PAESE… 2.1. Presso la fontana della morarona…. La piazza del paese, quella della mia infanzia, non esiste più. Rimane appena la fontana, ma sola e triste in mezzo al cemento, un tempo un gelso enorme, detta la morarona, la copriva, tanta verde erbetta faceva da tappeto. Era graziosa la piazza con tutta quell’erbetta, con il grande gelso, con la fontana che donava acqua in abbondanza e poi due file di gelsi, un piccolo viottolo che li divideva e che conduceva alla casa di Prisco il calzolaio. Una piazzetta da fiabe. La scuola elementare era lì a due passi, la chiesa, con il suo bel campanile faceva da sfondo, prima della guerra il vociare dei bimbi si confondeva con i trilli degli uccelli. A sera su una finestra mettevano una radio e tutto il paese si radunava attorno alla fontana, gli uomini sdraiati per terra, le donne a crocchi, sedute qua e là sui muriccioli degli orti a raccontarsi tante piccole grandi cose. Noi bambini facevamo le corse su e giù dal sagrato della chiesa, qualche volta ci piaceva fare degli scherzi innocenti, che facevano infuriare qualcuno, ma il colpevole non lo si scovava mai. Lì era il ritrovo dei bimbi, degli uomini, dei vecchi, delle donne che andavano ad attingere acqua con i grandi secchi di rame appesi ai ganci del bigolo, cioè al legno ricurvo che si metteva sulle spalle. L’acqua corrente non c’era nelle case, ci si doveva recare in piazza, alla vaschetta. Quell’acqua era sempre freschissima, ma si doveva attraversare il paese con i secchi appesi al bigolo. Alle volte si andava volentieri, ma quando il sole non dardeggiava sulla testa o non c’era il gelo che paralizzava le mani. Un giorno, proprio attraverso la radio messa su di una finestra, perché tutto il paese riunito in piazza potesse sentire, ascoltammo Mussolini annunciare che si doveva entrare in guerra. Ho ancora nitido quel ricordo d’infanzia: fu come se un piede 52 53 enorme avesse schiacciato, d'un solo colpo, un nido di uccellini con tutta la famiglia riunita. La nostra cara piazza, sempre festosa, ed affollata di volti, rimase per anni deserta, non fu più la stessa… 2.2. Le funzioni religiose della domenica pomeriggio. Nel primo pomeriggio di ogni domenica le campane invitavano tutti i parrocchiani alle sante funzioni per il canto del vespro, per il catechismo e per ricevere la benedizione eucaristica. La chiesa si riempiva di persone che, dopo il canto dei salmi, arrivato il momento della catechesi, accomodate nelle sedie di paglia, dormivano saporitamente, anche se non comodamente. Le donne resistevano di più, ma qualcuna crollava e cominciava a russare, sussultando ogni volta che la vicina la scuoteva con una gomitata. A me recavano un mondo di gioia i salmi, che si cantavano sempre in latino. Seguivo tutto il canto con un libretto, che conteneva anche la traduzione in italiano. Mi sembrava impossibile che le persone non fossero entusiaste nel cantare quei versetti così pieni della sacra parola. Allora le donne, nella casa di Dio, non potevano mescolarsi agli uomini, così, confinate nel fondo della navata, ce la mettevano tutta perché la loro voce giungesse forte fino alle orecchie del parroco. Alle volte non potevo trattenermi dall'esplodere in una fragorosa risata, che faceva indignare le pie donne e volgere il capo agli uomini. Ciò avveniva quando qualcuna la sparava troppo grossa. Come ho detto i salmi si cantavano in latino e, quasi tutte li avevano memorizzati, perché erano sempre gli stessi, salvo quando si cantavano quelli delle feste della Madonna, oppure si cambiavano gli Inni in occasione delle varie solennità. Con una grande fede e la più pura intenzione, quelle sante anime cantavano a squarciagola una enorme quantità di parolacce, di frasi storpiate e ritoccate a modo loro, lodando così, nella maniera più fervorosa e suggestiva, il Signore. accomodato sopra quella testa piccina, con i capelli pettinati a dovere e talmente tirati da sembrare dipinti più che veri. Lei non cantava, ma sgranava una grossa corona del Rosario tenendo fissi i suoi grandi occhi neri sull’immagine della Madonna. Poi c’era Teresa, che tutti chiamavano zia tereseta. Era una donnina talmente minuscola che io credevo fosse una bambina travestita da vecchia. Veniva dal Montesello, faceva parte della famiglia Procacci, ma non era neppure parente, l’avevano accolta nella loro casa perché era sola. Le volevano molto bene. Alla domenica, quando veniva alle funzioni, cercavo di mettermi accanto a lei più vicino che potevo, perché quella dolce creatura mi allungava sempre una palanca che, regolarmente, mettevo nella borsetta del sagrestano quando veniva per raccogliere l’elemosina. Quella strana borsetta bislunga, suscitava in me i più bizzarri pensieri, anche perché situata all’estremità di un lungo e sottile bastone di legno, volteggiando sulle teste dei fedeli sembrava spiarne i pensieri e raccogliere sia la generosità che le silenziose proteste. A me la Tereseta faceva pensare agli elfi del bosco, perché il suo visetto furbo e mite nello stesso tempo, ispirava pensieri da fiaba. Ero molto affezionata, ed attratta dalle vecchiette del mio paese, con cui m’intrattenevo spesso a parlare. Vorrei parlare riportare questo mio ricordo di loro che scrissi quando fui un po’ più grandicella: ALLE VECCHIETTE DELLA MIA INFANZIA Che ne sai, mocciosetta? Una volta che suggerii ad una nonna di correggere un versetto, un vero sproposito, mi sentii gridare, con estrema indignazione: -Che ne sai tu mocciosetta, sei nata solo ieri e pretendi di insegnare a noi, che cantiamo da una vita? Non m'intromisi più, ma le risate mi era difficile trattenerle. Penso però che il Signore sia stato felice anche di quegli strafalcioni perché pronunciati da anime semplici e buone, che sacrificavano ogni domenica i pochi momenti di riposo per recarsi a cantare i Vespri. Arrivavano sollecite le buone donne, indossando i loro vestiti della festa, tutti molto scuri, lunghi che sfioravano il pavimento. Non tutti si potevano permettere il lucido per le scarpe, allora le buone massaie, con una spazzola, prendevano la fuliggine dall’esterno del paiolo e lucidavano scarpe e, zopei (zoccoli da festa). Ricordo zia Giulia, tutta odorosa di spigo, il vestito decoroso e sempre impeccabile, i “zopei” lucidati che ci si poteva specchiare, il velo nero ricamato di fiori ben Quanti bei giorni, quante dolci ore con voi trascorsi o care e pie vecchiette. Lì sul sagrato, dopo le funzioni, assieme sedevam sulle panchette e novellando di lontani giorni raccontavate a me svariate cose....... e parlavate ancor d'amore e fede, commiserando chi odia e chi non crede. Care vecchiette dell'infanzia mia, che al parco desco sedevate a sera dopo fervente e umile preghiera, chiedendo a Dio per tutti un po’ di pane e di saziar ciascuno la sua fame. Or nel silenzio riodo vostra voce e con voi traccio il segno della Croce. 54 55 2.3. Venivano tutti per cantare vespro. Erano rarissime le persone che alla domenica mancavano alle funzioni. Zia Monica, che gestiva l’ unica osteria del paese, rimaneva a casa contro la sua volontà, tuttavia lo faceva perché non voleva che i figli mancassero della catechesi. Era vedova, ma se non poteva recarsi alla Chiesa pregava lì, nell’osteria ed era inflessibile con gli avventori che, quando le campane suonavano per la benedizione eucaristica, non si fossero alzati in piedi in segno di rispetto, e non avessero chinato il capo, rimanendo in quella posizione fino al cessare del suono. Tante persone scendevano dalla collina per cantare il vespro, sfidando il gelo d’inverno e il solleone d’estate. La fede, l’amore ed il rispetto per Dio li faceva eroi. La chiesa si riempiva di giovani e anziani, di ragazzi e di bambini. Non esistevano i banchi, ma sedie di legno impagliate, per niente comode, eppure, quando il sacerdote cominciava la catechesi, tanti uomini ed anche alcune donne, cominciavano a ciondolare vinti dal sonno e la sedia allora diventava una poltrona. Le persone erano gomito a gomito, così si sorreggevano a vicenda ed anche fossero ciondolate in avanti avrebbero sempre trovato l’altra fila a fermarle. Le funzioni si facevano ad un orario non adatto, e poi di domenica il pranzo era un po’ più abbondante e si poteva bere anche qualche bicchiere di vino, così a qualcuno conciliava il sonno, a qualche altro metteva voglia di cantare con entusiasmo. L’Ernesta delle caprette. I primi ad arrivare erano sempre quelli che abitavano più lontano. Ricordo l’Ernesta che scendeva dai Bodoli, un umile cascinale immerso nelle balze boschive sopra Toara, calzando ciabatte sdruscite e rabberciate, che poi nascondeva in un cantuccio dietro la chiesa per indossare calzature più dignitose per la casa di Dio. Il viottolo che la portava alla chiesa era tutto sassi ora aguzzi e sporgenti, ora levigati ma pieni di buchi e quindi di insidie perché, corrosi dal tempo, diventavano nidi per qualche animaletto. Ernesta assomigliava alle sue caprette. Esile e flessibile come un giunco scendeva saltellando, il suo volto sereno sprizzava serenità, dolcezza, affabilità. Qualche volta le chiedevo di portarmi con sé finite le funzioni e lei lo permetteva. Adeguava i suoi passi ai miei, ogni tanto mi doveva sorreggere perché mentre m’incantavo a guardare la fresca vegetazione che faceva da siepe al viottolo, ed uscivo in gioiose esclamazioni nel vedere tanti bellissimi fiori dai più svariati colori, non vedevo dove posavo i piedi e, più di una volta, se non ci fosse stata lei, sarei rovinata per terra. Rimanevo con lei lassù finché il cielo, ad occidente, si tingeva di forti e bellissimi colori e assieme alla brezza serotina, arrivavano brividi rossi ed arancioni ad avvolgermi, e profumi silvestri a deliziarmi. Sulla vecchia Ernesta delle caprette ho scritto tante pagine, era una persona unica, che irradiava attorno a sé una luce speciale, capace di com56 muovere la persona più dura, viveva in uno stato ininterrotto di preghiera continua, vicina a lei sentivo una pace profonda, una serenità, mi sentivo amata, accolta, protetta. La casa dell’Ernesta era una piccola oasi dove, non solo nella mia fanciullezza, ma finché ella visse, potevo trovare tutto ciò che occorreva al mio cuore ed al mio spirito. Con la sua vita esercitava senza minimamente sospettarlo, e senza nemmeno che noi lo sapessimo, una forma di nobile e profetico magistero spirituale per tutto il paese. Semplice, umilissima, chiara come l’acqua sorgiva dei suoi ruscelli, silenziosa come l’aurora che sorge e come il tramonto del sole, eppure sono eloquenti, e ti riempiono di musica il cuore. Ero turbata? bastava una corsa, la cercavo nei boschi, ai margini dei prati, tra le rocce, al pascolo con le sue caprette, e lei veniva incontro con le braccia spalancate, il sorriso buono, gli occhi ridenti e chiari, celesti come un cielo d’estate, luminosi come una fiaccola ardente. Un abbraccio, uno sguardo, un bacio sulle gote rugose, una parola: -Che c’è? Piano piano tutto si placava, e tornava sereno. Mi guardava e poi: -Ti voglio bene, sai? Te ne voglio tanto, tu soffri sempre, hai sempre sofferto, povera piccola… I miei occhi luccicavano, il mio cuore era gonfio. Qualcuno mi amava, in un rifugio nascosto, lassù tra i boschi della collina, qualcuno pensava a me, e mi riconosceva come persona degna di essere amata, riconosciuta, stimata. Lei non aveva niente, ma io con lei avevo tutto…. Tra le cose che ho scritte su di lei, ecco un paio di piccole poesie. PROFUMO Quando l'Ernesta lavava il pavimento dell'umile cucina, un po’ sdruscito, e strofinava sino a far brillare i rami appesi ai ganci del secchiaio tutt'intorno profumo si espandeva di pulito, di sano, di gioioso che rallegrava e deliziava il cuor. UN DOLCISSIMO RICORDO S’allarga il cuore mio come cielo immenso quando il ricordo mi porta lassù, o Ernesta. 57 La povertà santificata, l’umiltà delle cose, il silenzio solenne e misterioso del tuo nido, l’incanto dei tuoi occhi, sono in me rinchiusi e mai li scorderò. Scintillio di fiammelle sfavillanti, nella notte scendevano a baciare le mani tue sfinite di fatica, ingioielliate di graffi, dorso e dita. Quella dolcezza che m’impregnava il cuore, quando malinconia lassù portavo, io mai non ho scordato. O cara Ernesta mia, in quella grande pace, che bello riposare ancor con te! Queste due poesie riflettono ricordi di struggente nostalgia, amore profumato, umiltà e semplicità che fanno arrossire i superbi. Sono balsamo alle ferite, e tonici per la mia cronica stanchezza. O Ernesta, quanto vorrei che nel Paradiso ci fosse dato ancora quel pezzetto di terra profumata ed adornata di fiori, semplici e belli, di erbe vellutate, dove api, libellule, e farfalle screziate giocavano festose in armonia, dove il cielo si specchiava nei serpeggianti ruscelli e il belato delle tue caprette inteneriva. Quante cose ci potremmo raccontare, oppure no, ci parleremo con gli occhi noi due, due piccoli niente per i prati di Dio… chiamato così perché, dominava un po’ la campagna. Erano in trenta. Il capo famiglia si chiamava Fortunato, era massiccio, alto, imponente, con due baffi sotto un naso sempre rubizzo. La sua consorte, Caterina, gli stava bene accanto: forte, robusta pure lei, ma dolce e riservata. Una famiglia patriarcale che, da ottobre a maggio, si radunava nella grande cucina o nella stalla per la recita del Rosario. Una volta la settimana, i due coniugi, scendevano dal Montesello e si portavano sulla strada con due enormi ceste appese al “bigolo” piene di uova. Da lì passava la Pavana, un donna che veniva da Sossano con una carrozzella attaccata ad un cavallo per comperare le uova dei contadini. I Procacci, oltre alle uova, vendevano anche animali da cortile e, con il ricavato, provvedevano stoffe dagli ambulanti o al mercato nella vicina Sossano, che poi distribuivano a ciascuna sposa che confezionava gli indumenti per i propri cari. Vestire quella famiglia numerosa non era una bazzecola. Zia Enrica. Dopo le funzioni, in primavera e in estate, noi ragazzini ci radunavamo per giocare, recandoci nelle colline o tra i campi. Una domenica, con alcuni di essi, mi recai verso le Riveselle. Nei campi di zia Enrica, situati all'inizio di quella collina, c'era un enorme ciliegio con i frutti abbondanti e maturi. Era una tentazione troppo forte, ma chi avrebbe avuto il coraggio di salire sulla pianta? Tutti, maschi e femmine, puntarono gli occhi su di me. Certamente pensavano che, essendo la nipote di zia Enrica potevo senz'altro servirmi di quei frutti senza bisogno di chiedere il permesso. Sapevo però che la zia era molto severa e che non avrebbe esitato ad adoperare la verga se ce ne fosse stato bisogno, comunque la tentazione era troppo forte e, incoraggiata dall'entusiasmo dei miei compagni, salii in mezzo a tutto quel ben di Dio. I ragazzi gridavano: -Dai, getta! A me, a me! Non ero riuscita a metterne in bocca una che, improvvisamente, si fece silenzio assoluto. Guardai giù e vidi che tutti correvano verso il bosco ma, con mio grande spavento, vidi pure avanzare zia Enrica che, spingendo una carriola, avanzava con la stessa furia di un leone che si accinge a saltare addosso alla preda. La zia portava ogni mattina, dentro ad una specie di gabbia, chiamata “caponara”, nei campi i suoi polli, li lasciava poi in libertà a scorazzare tra l’erba fino a tarda sera, quando li andava a riprendere per paura che le volpi o altri animali, glieli divorassero. Non sapevo che di domenica la zia anticipasse il suo arrivo. Povera me! I Procacci del Montesello Fra i più lontani ad arrivar per primi alla Chiesa erano i Mazzucco, i Trevisan, i Faccio, i Bonato, i Procacci…… Quanti ricordi!! I Procacci, famiglia patriarcale, abitavano in una casa colonica, un po’ fuori paese, e precisamente al Montesello, Un paracadute particolare…. Tentai di scivolare giù appendendomi ai rami, allora alle donne, sia pur bambine, era proibito indossare i pantaloni così, con i miei indumenti leggeri, nella foga della discesa, dopo aver strappato il povero vestito, rimasi appesa ad un ramo soltanto con l'elastico delle mutandine. Pesavo, allora, come uno scricciolo, per mia 58 59 fortuna. Oscillavo agganciata a quel ramo come una fronda sbattuta dal vento, o come un paracadutista appeso ad un ramo, ma devo ammettere che il mio “paracadute”, in quel caso, era alquanto singolare. Zia Enrica, con la testa in su e le braccia sui fianchi, m'ingiungeva di scendere. Una parola! Finalmente provando e riprovando riuscii ad afferrare un ramo, da lì m'attaccai al tronco e, con le gambette che a malapena mi reggevano, toccai terra. Oltre agli strappi sul vestito e sugli indumenti intimi, mi graffiai per bene le gambe ma, tutto sommato ero ancora intera. Zia Enrica assistette alla mia ingloriosa discesa con un sorriso che sembrava fatto tutto di punte acuminate. Mi apostrofò con una valanga di rimproveri, minacciò di raccontarlo agli zii Carolina e Luigi, infine, stanca di parlare, si fermò asciugandosi, con la manica il sudore. Rimasi impalata a sorbirmi la filippica non so per quanto tempo. I miei compagni se l'erano svignata lasciandomi tutta sola sotto quella furia. Lentamente mi avviai verso casa pensando come presentarmi al resto della famiglia senza ricevere...... degli scapaccioni, ma non trovai nulla. In quel momento la mia fantasia era in sciopero. Decisi allora di raccontare la solita bugia: ero scivolata lungo il sentiero accidentato, quello dietro alla Chiesa. L’Isandro di via Longhe In via Longhe possedeva qualche po’ di terra anche Alessandro Priante, chiamato da tutti Isandro, forse per rispetto al signor conte, che si chiamava con lo stesso nome o meglio perché allora tutti i nomi venivano storpiati. Il vecchio Isandro, all’arrivo degli scolaretti, si faceva sempre trovare sdraiato sotto un albero al limitare del suo campo; i ragazzi gli si raccoglievano attorno e lui raccontava storie, fatti, aneddoti, che facevano volare la fantasia dei piccoli ascoltatori, trasportandoli nel regno incantato dove anche il più povero può essere ricco e il più debole diventare invincibile. I ragazzi ascoltavano affascinati quel vecchio dall’apparenza rude e scontrosa, ma che, in realtà era un eterno sognatore che, dalla vita a contatto con la natura, attingeva a piene mani e godeva di far partecipe del suo tesoro anche i suoi piccoli amici. Isandro era anche un mio vicino, la sua casa era circondata dall’orto, dal vigneto e dal frutteto di mio nonno. Un giorno mentre me ne stavo sotto un albero di pesche e mi accingevo a gustarne una di bella e succosa, scorsi il vecchio sdraiato sotto una pianta, di prugne gialle e mature al punto giusto, che sonnecchiava. Ero sola. Potevo mettere in atto l’idea che mi era appena balenata nella mente. Chi m’avrebbe veduta? Chi m’avrebbe fatto la spia? Proprio nessuno! Quindi? – All’opera- mi dissi – e, afferrati i rami più bassi della pianta cominciai a scrollarla finché non vidi il vecchio Isandro tutto coperto di prugne. Poveretto! Cominciò ad imprecare e ad annaspare da sotto quella dolce coperta. Il vecchio era claudicante e non poteva alzarsi sveltamente, sicché ebbi tutto il tempo di allontanarmi senza essere scorta ed assistere pure all’affannosa e grossolana pulitura che il poveretto fece alla sua persona. Da quella prodezza, però, non ricavai nessun diletto. 2.4. I conti Piovene, la villa, l’oratorio. Un mondo di lieti ricordi. Non sarebbe completa la piccola galleria di volti del mio paese se trascurassi Villa Piovene, la famiglia che vi dimorava, ed il piccolo oratorio che la completava. Quella piccola chiesetta di villa Piovene racchiude un mondo di lieti ricordi e di dolci emozioni. L’oratorio, la villa, le scuderie, il verziere e tutto ciò che vi ruotava attorno, mi affascinava, mi rendeva pensosa e faceva lavorare alacremente la fantasia. Talvolta m’inoltravo tra la folta vegetazione che cresceva sotto le annose piante dietro alla villa e rimanevo delle ore a fissare i muri grigiastri che raccontavano di generazioni passate, di ragazzine felici sedute all’ombra delle magnolie in fiore mentre si dilettavano ad eseguire delicati ricami o sfogliavano riviste di moda alla ricerca di novità. La contessina Amalia. L’ala sinistra della villa era occupata dalla contessina Amalia conti Barbaran, sorella della contessa Antonietta, mamma del conte Alessandro, poi sposato con l’indimenticabile contessa Berta. Con la contessina Amalia c’erano Ines la came- Contessa Berta (la guidatrice) con le zie contessina Amalia e Contessa Virginia 60 61 riera e Catina la cuoca. Sempre m’incantavo ad osservare la contessina, rimasta nubile, quando nel pomeriggio si recava nella chiesa parrocchiale per una visita. I capelli chiarissimi e molto ondulati non scendevano sulle spalle ma erano raccolti in una sottilissima e quasi invisibile reticella, appuntato al petto teneva un orologio chiuso con sul coperchio lo stemma gentilizio. Quando la vedevo salire lungo il viale della Chiesa mi mettevo da un lato guardandola affascinata, mentre mi passava accanto tendevo il braccio, alla maniera fascista, salutandola: -Riverisco Contessina! Lei gentile si fermava e, rispondendo al mio saluto, sorrideva. Anche il conte Sandro e la contessa Berta erano persone squisite, per niente autoritarie. Ci si rivolgeva loro con rispetto misto a un po’ di timore, ma erano semplici e si accostavano alle persone con affabilità e gentilezza. Il conte lo s’incontrava spesso nei paraggi della villa o nei campi dove erano i suoi operai, anche se bambina mi salutava sempre con tanta gentilezza. Talvolta sostava chiedendo della mia salute, dei miei fratelli, del nonno e degli zii. Quando morì papà, venne con la contessa a porgere le condoglianze alla famiglia, ricordo ancora il suo sguardo pieno di sincero dolore, affetto, e mestizia. Ogni sera accompagnava la moglie nei pressi della chiesa dove lei si recava per la recita del Rosario. Qualsiasi persona incontrasse, fosse il suo fattore o l’ultimo degli operai, oppure un mendicante si levava il cappello e salutava con rispetto. Un giorno assistetti ad una scena che accrebbe in me la stima verso il conte: sul sagrato della chiesa c’era il parroco con dei ragazzini, un po’ più in là si trovava Angelo Tombolan, una persona che agli occhi del mondo contava ben poco, ebbene il conte Sandro per primo salutò con deferenza Angelo togliendosi il cappello, poi si volse e fece altrettanto verso il sacerdote. La maestra Emma e l’asilo. A Toara la scuola d’infanzia, che allora veniva chiamata Asilo infantile, esisteva da tanti anni. La maestra, per lunghissimo tempo, fu la signorina Emma Cichellero che, con la sorella Armida ed i genitori Prisco e Carlotta abitava vicino alla chiesa. Emma insegnava e Armida preparava il pranzo, con ciò che la Provvidenza mandava. I conti Alessandro e Berta Piovene Porto Godi erano i principali benefattori assieme alla loro zia, la Contessina Amalia. Ogni anno, nel tardo autunno, portavano per ciascuno, una volta una felpa da sotto, che tutti dicevano la fanela, un altro anno le sgalmare, cioè degli scarponcini con la suola di legno chiodato, un anno hanno portato un mantello nero, quello lo chiamavamo el tabarin. Insomma era una vera manna, specialmente per quelle famiglie che, all’asilo, avevano più figli. 62 Il tasso dalle rosse bacche. Vicino all’oratorio della villa c’era una pianta che dava delle piccole bacche rosse, noi bambini, quando il grande portone era aperto per gli spostamenti delle carrozze o dell’auto, lo prendevamo d’assalto per gustarci quelle bacche un po’ dolciastre. Credo proprio che i nostri Angeli Custodi ci abbiano salvati più di una volta perché si seppe, un po’ tardi in verità, che quelle bacche erano molto tossiche, noi ne facevamo delle grandi scorpacciate. Un giorno che mi trovavo vicino alla pianta da sola mi passò vicino il Conte, si fermò a guardarmi mentre succhiavo una bacca. Il suo viso, buono come sempre, mi spinse a chiedergli come si chiamasse quella pianta. –Si chiama “tasso”, proprio come un animale che si trova qualche volta nei boschi… rispose, ma non disse che le bacche non erano commestibili, forse neppure lui lo sapeva. Quando mi dovevo recare a scuola nel vicino paese di Villaga, alla fine della lezione passavo a salutare zia Paola, quindi, senza fretta m’incamminavo verso casa. Qualche volta il conte, mi passava accanto con l’automobile, allora una rarità per i nostri paesi. Con la sua innata gentilezza si fermava e mi faceva salire sui sedili posteriori. Mi sentivo un po’ a disagio, ma l’affabilità del conte e della contessa quando era accanto a loro, me lo facevano subito sparire. Accadeva spesso che ci trovassimo, io con i compagni, a scorazzare tra i campi o i vigneti e, spesso, qualche grappolo d’uva o qualche frutto ce lo prendevamo, se il conte Sandro si accorgeva ci faceva un sorriso e noi, un po’ imbarazzati, lo ricambiavamo. Tutto lì. Mai una volta ci sgridò. El zelese. I miei famigliari quando avevano bisogno di far asciugare il grano chiedevano in prestito al Conte il grande cortile, da tutti chiamato el zelese che, tutto di cemento, con il bordo alto alcuni centimetri, impediva la dispersione del grano o delle sementi, che lì venivano posti per completare l’asciugatura. Quel giorno, i miei famigliari, portarono il grano che era stato trebbiato da qualche giorno, sul zelese. Era una giornata piena di sole. Vedevo lo zio sorridere, cosa che avveniva raramente, dopo la morte di mio padre. Alcuni uomini lo aiutavano. Quando il grano fu tutto steso per bene lo zio mi chiamò e mi disse che me ne dovevo rimanere lì finché mia sorella non m’avesse dato il cambio. Dovevo badare che le galline non andassero a far merenda con il frumento; di galline ce n’erano tante: quelle che le cuoche del conte allevavano per i Signori, quelle del fattore e quelle dei bovari. Di solito quei pennuti vagavano per i vigneti, per i prati e i campi, in prossimità della villa, ma quando grano e sementi varie se ne potevano trovare in grande quantità senza dover cercare altrove, anche loro non resistevano alla tentazione di “nuotare” in quell’abbondanza. Perciò l’ingiunzione dello zio: - Attenta alle galline, senza chiasso e niente giochi, siamo in casa d’altri! Mentre tutta compresa del mio nuovo ufficio di sentinella me ne stavo tutta impettita, sudando 63 abbondantemente sotto il solleone, con vestito di tela, maniche che mi coprivano fino a tutto il polso, gonna sotto al ginocchio e calze lunghe di cotone, due cani del conte si erano accomodati poco lontano da me e, sonnecchiando, di tanto in tanto aprivano un occhio, sbadigliavano e riprendevano a dormire. –Bene - dicevo tra me – quei cani anche se sono grandi e grossi non mi fanno paura - e aggiungevo – se m’avessero voluto mordere l’avrebbero già fatto. Una brutta avventura Poi accadde tutto d’un tratto. Improvvisamente vidi i due cani scambiarsi un’ occhiata, proprio come tra due persone che stanno combinando qualcosa di speciale, assieme. Fu un attimo: balzarono in piedi contemporaneamente e, con un salto uno mi circondò il collo con le zampe anteriori, tenendo il muso sul mio viso, l’altro fece altrettanto dal di dietro. Sentivo l’alito caldo dell’uno, sul viso e sulla nuca quello dell’altro, ma io sudavo freddo. Fortunatamente non mi mossi, gli operai del conte, che si trovavano nei pressi e stavano conversando con il padrone videro, si precipitarono addosso ai cani, che li guardarono come a dire: - Be’, non si può fare neppure uno scherzo? Furono allontanati e legati alla catena. Il conte si preoccupò, chiese se mi fossi spaventata, ma quello si vedeva chiaramente. Mi stette vicino e si mostrò molto dispiaciuto per l’accaduto. Mi accarezzò e rimase con me finché vennero a darmi cambio. Anche se presi un bello spavento, ancora oggi, rivedendo, come in un filmato, la scena, mi chiedo il perché di quell’abbraccio simultaneo, tanto perfetto da sembrare programmato da un regista di film. A me dispiacque vedere il conte Sandro così rattristato per causa mia. Lui sempre tanto buono! 2.5. Un fattore antipatico. Il dovere di non toccare…. Altra musica invece si sentiva quando ci s’imbatteva con il suo fattore, allora si che erano dolori! Personalmente avevo un sacro timore di quella persona, non mi garbava il modo con cui apostrofava noi ragazzini quando andavamo a scorazzare nei campi, nel tardo autunno, per scoprire qualche frutto lasciato lì per terra, forse perduto dai raccoglitori oppure lasciato sulla pianta perché maturato male o imperfetto. Ci faceva delle lezioni sul dovere di non toccare nulla dell’altrui proprietà e neppure di calpestare il suolo degli altri, anche se tutto era già stato raccolto e la terra stava per mettersi a riposo. Ma allora dovevamo rimanere sempre in casa o in chiesa, oppure a scuola, visto che quasi tutto il paese apparteneva ai conti Piovene! Un giorno, verso la fine di novembre, con alcune mie compagne ci spingemmo in un vigneto sotto la collina, verso la località detta “La Pila”. Le vigne erano spoglie, sembravano persone con i capelli sciolti e scomposti. Il cielo era plumbeo e, dalle viti, gocciava del liquido, che sembrava pianto. Tra i filari 64 c’erano dei meli, i frutti erano stati raccolti dagli operai del Conte, e portati in villa. Noi cercavamo tra le foglie che facevano letto nel terreno ed uscivamo in grida di gioia ogni volta che trovavamo una piccola mela seppure mezza vizza o deturpata in vario modo. Alle volte ce n’erano di piccine e tutte raggrinzite, ma talmente dolci e gustose che erano vere leccornie. Ma guarda dove sono queste femmine! Quel giorno, mi rivedo ancora inginocchiata per terra a frugare tra le foglie quando, all’improvviso, una voce secca come una sferzata mi fece sussultare di spavento. Era il signor fattore che diceva, non certo solo a me: -Guarda un po’ dove sono queste femmine invece di starsene a casa a lavorare! Ma non sapete – continuò – che state nella proprietà altrui? E state portando via dei frutti che non vi appartengono? Io tenevo stretta la piccola mela che avevo appena tolta dalle foglie bagnate ed era ancora coperta di terriccio umido. Ma lo sguardo imperioso mi fece aprire la mano e la mela cadde per terra. Intanto le altre se l’erano data a gambe levate. Io, come paralizzata, fissavo quell’uomo che a sua volta mi squadrava dalla testa ai piedi senza pietà, mi dava fastidio quel fissarmi, quello ammiccar di occhi. Ad un certo momento, per fortuna qualcuno lo venne a chiamare. Con le gambe che mi tremavano cercai di raggiungere le mie compagne, ma prima raccolsi la piccola mela, che se non fosse stata scorta da me, sarebbe certamente marcita dando così nutrimento alla terra. Anche se dolce quel piccolo frutto, aveva un non so che d’amaro. L’amaro della cattiveria e della superbia. Alle volte, durante le veglie, i grandi raccontavano di cene abbondanti, che si facevano nella casa del fattore. Si parlava di piatti forti innaffiati da vino generoso…….. e, nel raccontare, deglutivano come se le pietanze fossero lì davanti per essere gustate. Potenza della fame e della memorizzazione di quei racconti! La fame era il problema di quasi tutto il paese, per la fame si andava nel bosco o lungo le prode dei campi a raccogliere erbe commestibili ed ogni cosa che si potesse mettere in bocca e riempire un po’ lo stomaco. Quando i frutti dei gelsi erano maturi, si potevano mangiare a volontà, ma non erano tanto sazianti. 2.6. Ci divertivamo così. Il teatrino parrocchiale. Nelle lunghe sere autunnali e invernali i giovani della Parrocchia si radunavano in Canonica e, sotto la guida di Ottavio De Marchi, fratello di Riccardo, maestro di coro e di Giulio il sagrestano, si esercitavano come attori. Il Parroco incoraggiava tale attività anche per dare ai giovani motivo di non oziare. A quei tempi nei piccoli paesi l’unico svago per gli uomini e giovani era l’osteria, ma quando si cominciò l’attività teatrale, spesso c’era la possibilità di recarsi alla “Commedia”. Il teatro era aperto a tutti. Si attendeva con ansia l’annuncio e ci si 65 preparava come ad un evento straordinario. Ottavio era un attore nato. Peccato che anche i più dotati non potevano accedere a qualsiasi genere di studio. Troppo grande era il divario tra il povero e il ricco, tra il villaggio e la città. Il “granaròn” di Piovene diventava allora il teatro dove si allestiva il palco, e si portavano le sedie, che venivano prese in prestito dalla Chiesa. Essendo molto capiente ci potevano stare comodamente molte persone, così si passava parola ai paesi vicini e la gente veniva. Gli attori, finita la rappresentazione, si accontentavano di una bicchierata fatta assieme e, talvolta, si aggiungevano le castagne o qualche dolce casereccio. L’allegria era assicurata. Anche le giovani, sotto la guida della maestra Emma incominciarono ad esercitarsi come attrici, alle volte, quando occorreva la presenza di qualche bambina, venivo chiamata anch’io assieme a delle compagne. Ci sembrava d’essere delle “celebrità”, poverine, non avevamo visto film e tanto meno conoscevamo il teatro. Ma noi eravamo felici. La fiera di S. Caterina. Un divertimento speciale era costituito dalle sagre, una speciale, che tutti aspettavano con impazienza, compresi noi bambini, era il 25 novembre per recarci a Barbarano alla fiera di Santa Caterina d'Alessandria: fiera molto importante anche per i paesi limitrofi. All'arrivo di quel giorno, di buon mattino, galvanizzati dall’attesa, ci s'incamminava a gruppetti verso Barbarano, da Toara sono circa cinque chilometri e già incontravamo i primi che tornavano indietro avendo fatto i loro acquisti, e portavano sulle spalle zappe, vanghe, falcetti, roncole, pentole, padelle.... Alcuni, sulle spalle portavano dei maialini che sarebbero stati ingrassati l'anno successivo. Il cappellino di panno rosso. C'ero stata ancora alla fiera, ma quella volta, avevo nove anni e mezzo, la gioia era maggiore perchè quella volta, con zia Carolina, c'eravamo io, mio fratello Giuseppe e la sorellina Delia. Zia Carolina ci esortava a rimanere uniti, a non scostarci da lei, ma noi, come animaletti di bosco, correvamo qua e là impazienti di arrivare alla meta. Lungo la strada ci accompagnavamo ad altre persone, allora era tutto un vociare, tutto un chiamare, tutta una festa.....Arrivati al Castello, situato in alto rispetto al paese, sostammo per ammirare incantati tutto l'insieme della fiera: la piazza, le strade, i vicoli, un'incredibile folla sostava davanti a banchi e bancarelle, e nei cortili dove si vendevano animali. Fin lassù saliva anche il profumo di dolci appena sfornati, di caldarroste, e altre vivande che venivano cotte. Quando finalmente si arrivava dove cominciavano le bancarelle, zia Carolina aveva il suo bel daffare per trattenerci. Quel giorno, ci fermammo incantati di fronte ad un banco che vendeva berretti, zia ci esortava a passare oltre affermando che di banchi con berretti ce n'erano ancora tanti, ma noi c'eravamo 66 fissati con alcuni appena adocchiati e quelli volevamo ad ogni costo. Mio fratello scelse, per sé, un berretto che, all'occorrenza, aveva anche il copri orecchie, Delia un cappellino di panno rosso, io..... Bé sono sempre stata strana e m'ero fissata in un berretto tipo basco, con il frontino e un vistosissimo fiocco nel mezzo della testa. Era di color rosso cardinale ed era di velluto. Il fiocco era di fili di seta e s'afflosciava di qua e di là. Ero talmente affascinata da quel berretto che, tolto dal banco e, messo a sghimbescio sulla testa, come un fulmine, corsi via all'impazzata imitata dai fratelli. Zia, disperata, ci esortava ad aspettare, a vedere, e discuteva con il venditore circa i prezzi ma, noi tre, ce la demmo a gambe così, alla poveretta, non rimase che pagare il venditore il quale avrà pensato che se tutti i clienti fossero stati come noi avrebbe fatto grossi affari. Per la cronaca: quel berretto lo indossai una volta sola per recarmi alla Messa ma, visto l'effetto ottenuto, mi accontentai di riporlo nell'armadio e andarmelo ad ammirare e accarezzare di tanto in tanto. Sogno di diventare nomade… L'anno seguente alla fiera, ci andai con delle mie amiche, dagli zii avevo ricevuto qualche soldo da spendere a mio piacere. Quella volta fui attirata da un uomo anziano, vicino aveva una bambina e un bambino molto piccoli, che suonavano il violino ed erano vestiti con un bel costumino di velluto rosso e azzurro con dei ricami dorati, una minuscola scimmietta ballava e girava tra i presenti tenendo nella mano un piattino dove tutti gettavano delle monete. Mi venne un forte desiderio di chiedere a quell’ uomo se potevo aggregarmi al gruppetto, desideravo da tanto far parte di una famiglia di nomadi, ero convinta che girare per il mondo, visitando paesi e città, liberi come uccelli, fosse il massimo della felicità. Così fantasticando stavo per avvicinare quel vecchio quando, bruscamente, qualcuno mi afferrò per un braccio. Era una mia compagna che, stanca di aspettarmi, mi spinse via, in malo modo, da quel luogo. Chissà poi se quella persona m'avrebbe voluta con sé! Non tutta è crema quella che luccica! Passando vicino ad un banco dove vendevano mandorlato ed altre cose commestibili, fui attirata da un piatto dove erano allineati dei pezzi di crema gialla. Ero convinta fosse crema, a me piaceva così tanto! Ed avevo pure tanta fame..... Rigirai tra le mani i pochi spiccioli quindi, un po’ emozionata, m'avvicinai al venditore che, sollecito, mi porse ciò che avevo chiesto. Il primo boccone mi rimase fermo in bocca per un bel po’. Povera me! Il desiderio di mangiarmi un pezzo di crema svanì appena gustai quella fredda polenta. Sì perché l'oggetto del mio grande desiderio non era crema, bensì polenta senza sale, polenta da me mangiata ogni giorno e che era anche molto più saporita di quella. Che profumata e che 67 buona quella che zia Carolina rovesciava, con un colpo secco, sul tagliere! Delusa non mi rimase che andarmene, con le amiche, a gironzolare per la piazza ed a saziare la mia fame con i mille odori che uscivano dalle trattorie e dai caffè. Anche lo zio si recava alla fiera di Santa Caterina, ma vi andava da solo perché aveva sempre qualche cosa di importante da acquistare. Noi attendevamo con impazienza il suo ritorno perché ci portava il mandorlato e le patate dolci, che si potevano mangiare soltanto in qualche occasione. Era veramente l’avvenimento più importante dell’anno quello della fiera. Marcellino pane e vino. Finita la guerra anche il cinema di Sossano iniziava a divenire, talora, una meta ambita per il nostro divertimento. Ricordo in particolare il grande successo che stava avendo il film Marcellino pane e vino. Tutti i miei compagni si erano organizzati quella domenica pomeriggio per andare a Sossano a vedere quella pellicola, ma io piccola orfana ero lasciata indietro, e nessuno si preoccupava di me. Nessuno tranne una brava massaia, a quegli anni ancora giovane, la Romilda Ferrari, sposa di Ettore Ferrari detto Moreto. Ho di questo episodio un ricordo indimenticabile, che vale la pena riferire. Cara Romilda, mi rivedo lì, davanti a casa tua, triste e supplichevole, intenta a fissare lo sguardo su gruppetti di ragazzi che, sordi ai miei richiami, se ne andavano in bicicletta verso Sossano per assistere al film Marcellino pane e vino, la storia di quel bimbetto che per tanti aspetti somigliava alla mia storia. Tutti andavano a quella proiezione, solo io ne ero esclusa. Ero lì con gli occhi spalancati e il piccolo cuore stretto da infinita tristezza. Tu ti sei affacciata all’uscio, e ti è bastato uno sguardo. Sei scesa dai pochi gradini e, con il tuo modo brusco e sbrigativo mi dicesti: -Allegra ragazzina, nessuno ti vuole portare a Sossano? Ebbene, ti ci porto io! Un attimo per prendere il borsellino e per chiudere con uno strattone la porta, poi, presa la bicicletta sempre lì a portata di mano, mi hai fatto salire sulla piccola assicella posta tra il manubrio e la sella e…. via come un razzo! Il mio cuore scoppiava di felicità, e la fantasia correva verso l’oggetto del mio più grande desiderio, talmente grande era la mia gioia che quasi non m’accorsi della brusca frenata, che ci fece rovinare addosso ad un mucchio di ghiaia, ornamento, a quei tempi, delle nostre strade. Un piccolo graffio alle ginocchia è stato la conseguenza di quel volo, ma per l’ineffabile gaudio che in quel momento riempiva la mia anima, non lo sentii. Cara Romilda, questo gesto è ancora qui, impresso nella mia memoria, e sono certa, avrà fatto pendere la bilancia in tuo favore davanti al Cristo Giudice perché quello che tanti anni fa hai fatto al piccolo scricciolo triste, l’hai fatto a Gesù! E ti par poco? Grazie Romilda e, se puoi, fammi fare ancora un bel volo verso quella gioia, che si trova solo lungo le strade del cielo! Ciao! 68 CAPITOLO TERZO UNA FOLLA DI POVERI. ACCOMUNATI DA UNA STESSA FATICA. 3.1. Le file di poveri del giovedì. La fame era tanta sia in tempo di guerra che dopo. Di giovedì lunghe file di persone si fermavano davanti alla nostra porta e, con voce querula supplicavano: Carità per amor di Dio! Carità per amor di Dio! Innumerevoli volte veniva ripetuta questa frase e, altrettante volte, zia ci mandava alla madia grande, piena di gialla farina dove, con un recipiente di legno, nel nostro dialetto chiamato sessola attingevamo. Se ero io per prima a vederli non lasciavo che aprissero bocca mi precipitavo alla madia e, se mi era possibile, davo il doppio del solito. Qualche volta, con la farina, mettevamo nel loro sacchetto delle grosse pagnotte di pane. Un giorno Delia fece la spia, a fin di bene s'intende. Raccontò a zia che quando facevo io la carità ne davo sempre il doppio. Zia mi chiamò in disparte e con bontà mi spiegò che se avessi continuato così, presto avremmo dovuto rimandare quei poveretti senza niente. Capii e, a malincuore, rispettai gli ordini. Aprivano il loro sacchetto di un colore indefinibile dove, mescolati alla farina c'erano pezzi di pane, ce n'erano di minuscoli, delle croste e qualche rara pagnotta. Talvolta zia dava loro anche un piatto di minestra, una fetta di salame, ma c'era tanto poco allora! Italico Moneda. Non tutti venivano sul mezzodì. L'uomo che suonava la fisarmonica veniva di mattina, il suo vero nome non lo si è mai saputo, ma da tutti era chiamato: Italico Moneda. Dicevano che fosse un nobile decaduto. I suoi panni, anche se poveri, erano sempre puliti ed in ordine. Da tutta la sua persona emanava un qualche cosa di misterioso, di orgoglioso. Ripugnava, forse, alla sua dignità, chiedere l'elemosina così, in qualche modo, voleva ripagare il beneficio suonando un pezzo del 69 suo repertorio, che ignoro se fosse vasto, perché quando s'avvicinava alle case del nostro paese dove gli abitanti erano tutti molto religiosi, suonava inni e canzoni appropriate, cosa che non faceva quando, nei paesi vicini, qualche nucleo familiare era noto a tutti essere di altre idee. Allora era altra musica. Ricordo che parlava poco, come pure ricordo i suoi occhi severi ed i bianchi capelli che gli incorniciavano un volto dai lineamenti distinti. Bepe la Boie. C'erano poi: Nanei, Isi Coa, Piri, Tilio da Mosàn...., si diceva che nonno Gustinello fosse stato il padrino di cresima di Isi Coa, forse per questo gli dava qualche soldino, poi c'era la Pigra, la Grisa, la Scuccata, c'era Bepe la Boie....e tanti altri. Io li ho conosciuti con questi nomi, che non saranno stati quelli di battesimo, ma una volta erano rare le persone che venivano chiamate con il proprio nome. Non tutti però accettavano di buon grado quegli appellativi. Ricordo un giorno, il 17 gennaio, i campi del Conte Alessandro, quelli che costeggiano lo stradone, erano tutti arati; il mio sguardo correva alla grande distesa di grosse zolle rossicce, pensavo che anche la terra avesse diritto di riposare. Con alcuni compagni, compresi i miei fratelli Giuseppe e Delia, stavamo tornando da Belvedere, dove avevamo preso parte alla cerimonia religiosa in onore di Sant’Antonio Abate, patrono di quella parrocchia. Il ricordo di ciò che ci capitò quel giorno divenne l'incubo di tante notti e fu la corsa che dovetti fare attraverso quei campi. Lungo lo stradone quel giorno con noi transitavano altre persone, fra le quali c'era anche Bepe la Boie. Tanto io che Delia credevamo fosse il suo vero nome, perciò quando nostro fratello c'invitò a chiamarlo così per parecchie volte come fosse una cantilena, questi ci s'avventò addosso urlando come un forsennato. Al momento non ci rendemmo conto del perché di quella furia, ma Giuseppe, intuendo il pericolo che la sua voglia di scherzi aveva provocato, ci gridò di fuggire. Bepe ci rincorse e quasi aveva la meglio quando mio fratello ci suggerì di correre attraverso i campi. Le zolle, viste dalla strada, erano una cosa, ma camminarci e, addirittura correrci sopra, era pazzesco. Il nostro vantaggio su Bepe la Boie era quello di non avere ingombri, mentre lui teneva al collo la bisaccia, che era pesante, l'avevo vista prima che cominciasse l'inseguimento. Delia si mise a piangere, anche lei non ce la faceva più. Sentivamo sul collo il suo respiro affannoso e il nostro spavento cresceva, ci urlava che se ci avesse prese ci avrebbe strozzate. Quanto corremmo! Ad un certo punto non lo sentimmo più, con terrore io mi voltai e lo vidi lungo disteso tra le zolle. Presi Delia per mano e tornammo sullo stradone, sudate ed esauste. Ci venne spiegato poi che quell’ uomo veniva chiamato con quel soprannome perchè beveva molto ed era spesso ubriaco, chiamarlo così era come dirgli: - Bepe, il vino che hai bevuto ti bolle in corpo, vero? 70 Una volta scrissi anche una poesia per parlare di questi poveri. IL SORRISO DI NANEI sassi per la tua bocca sdentata, farina bianca e gialla mescolata. Una cipolla, un torsolo, una patata. Un cappello di feltro, reliquia dei tuoi avi, due scarpe grandi e pure scalcagnate, dove mettevi i piedi lacerati dai sassi e dai geloni. Di tanto in tanto agli angoli degli occhi, come rigagnolo scendeva un umidore, che pareva di pianto mai finito. Una zimarra tutta rattoppata copriva le tue spalle curve e stanche. Per cintura una corda sfilacciata reggeva alla tua vita i pantaloni, lisi e deformi, con mille toppe rozze. Ma quando la bruna mia manina ti porgeva timida il mio pane, tu sorridevi. Che dolce e bel sorriso raggiava sul tuo volto, sembravi allora un angiolo sceso dal Paradiso! La bisaccia, chissà di qual colore, pendeva dalla schiena curva e secca. Dentro tenevi celato il tuo tesoro: tozzi di pan secco, (Nanei, uno dei tanti poveri che venivano a chiedere: - Carità per amor di Dio!) 71 3.2. Figure caratteristiche. La Tilia. Sia sotto il solleone d’agosto, come nei rigidi mesi invernali, quando si incontrava per strada la Tilia, si provava l’impressione che gli elementi atmosferici, per lei, non esistessero. Era sempre serena e sorridente. Eppure viveva in una buia cucina, nella più grande povertà. Non era sola, aveva marito e figli, ma il marito era ammalato e non lavorava e i figli erano molto giovani. Se per la strada o lungo le siepi trovava un pezzo di ramo secco, o anche dei ramoscelli sottilissimi, tutta felice li raccoglieva per il suo fuoco. –Come va Tilia?! qualcuno le chiedeva, e lei, sorridendo, immancabilmente rispondeva: -Bene, bene! e magari in casa non c’era niente da mangiare e il fuoco era spento per mancanza di legna. Sempre diceva “sì” a coloro che le chiedevano qualcosa. Qualcuno, stupito, esclamava: Ma come fa la Tilia ad essere sempre così contenta?! Forse dai più era ritenuta troppo semplice, bonaria, poco furba. Ma no! Lei era una francescana senza aver mai conosciuto S. Francesco, perché sorrideva al sole, non s’arrabbiava se la pioggia l’inzuppava. Lodava il Signore quando trovava l’indispensabile per sfamare i suoi cari. Amava e rispettava tutti e non invidiava nessuno. Il suo vestito era sempre quello, le sue ciabatte anche, ma anche la sua dolcezza e il suo sorriso. Un giorno, nel percorrere lo stradone, m’accompagnai a lei che tornava dall’essersi recata a Belvedere per il pane. Allora in molti avevano la tessera dei poveri e con quella si aveva un po’ di pane dal colore strano e dal gusto non proprio di pane. Con la sua povera sporta lisa e smunta appesa al braccio, ogni tanto si chinava per raccogliere, dal ciglio della strada, qualche pezzetto di legno. Arrivate nel tratto di stradone dove ci sono le mura del castello di Belvedere, proprio accanto a queste, scorse un pezzo di legno dalle dimensioni di mezzo manico di scopa. Si vedeva che per lei era molto importante perché lo raccolse mirandolo come fosse un tesoro. La guardavo imbambolata cercando di capire cosa ci fosse di speciale in quel legno, lei, notando il mio stupore disse che quel giorno era stata fortunata. Ed era solo un semplice legno per ravvivare il fuoco. di sigarette, insomma tutto ciò che trovava. Allora le nostre strade non erano asfaltate, lo stradino le puliva una volta la settimana, ma quando passava la Betìa si era sicuri che la pulizia era perfetta. Teneva sempre la testa abbassata come temesse di lasciare indietro qualche cosa. Camminava con la schiena curva e ripeteva in continuazione la frase: - Sanpignatto, sanpignatto!!, che tradotto sarebbe: -san pentolino o santa pentola. Io la seguivo come la sua ombra e l’aiutavo. Le chiedevo cosa ne facesse di tutta quella immondizia, lei rispondeva invariabilmente che la portava a casa. Quando trovava una carta un po’ più grande ( come il palmo di una mano) un sorriso soddisfatto le si dipingeva sul volto, che sembrava meno incartapecorito. Per lei tutto valeva un tesoro. Qualche volta con i miei fratelli, ci recavamo a Barbarano per salutare lo zio Bortolo, fratello della nostra mamma, la zia Maria sua moglie e i cugini. Allora abitavano un po’ fuori dal centro del paese e precisamente nella località chiamata Scaranto (rivo d’acqua), in mezzo al verde della collina fitta di alberi. Si andava a piedi ed era una lunga camminata. In quella località abitava anche la Betìa. Un giorno, vinti dalla curiosità, spingendo una finestrella malconcia della sua casupola sbirciammo in quel regno, per noi, misterioso. Ai nostri occhi si presentò un cumulo enorme, che occupava tutta la stanza, di ogni sorta di spazzatura. Qualcuno ci vide e ci sgridò. E noi ce la demmo a gambe levate. La Betìa. C’era una vecchietta strana, non era di Toara, veniva da Barbarano di tanto in tanto. Quando spuntava dalla croce, quella che si trova sotto l’arco d’ingresso alla proprietà dei Piovene, la voce si spargeva in un baleno: -Arriva la Betìa! Era una donna tutta rinsecchita, di una magrezza scheletrica, qualcuno la paragonava alla quaresima. Un gran fazzolettone le copriva i capelli, teneva sempre la testa abbassata. Quando sentivo che stava per arrivare mi precipitavo di corsa ad incontrarla. Aveva una enorme bisaccia, che trascinava tra i ciottoli e la polvere della strada. Non chiedeva l’elemosina, ma raccoglieva meticolosamente qualsiasi pezzetto di carta, ogni piccolo fuscello, noccioli di frutti, fiammiferi consumati, carte 3.3. Tutti eravamo poveri. La fame. La fame era proprio un tormento per molte persone. Ricordo che, nell’immediato dopoguerra, a casa nostra, erano spesso ospiti un cugino del nonno con i suoi due figli, già adulti. Abitavano a Stanghella, in quel di Rovigo. Venivano a portare delle canne palustri, che chiamavamo canevere. Non è che rimanessero un giorno, si fermavano sempre per un po’ e facevano onore alle minestre ed ai minestroni della zia. C’era sempre del buon vino in tavola e sia il padre che i figli ne approfittavano. Io, sempre la solita, che traducevo subito in parola ogni pensiero, fosse anche il più strampalato, un giorno con fare serafico rivolgendomi ai tre chiesi loro se avevano intenzione di rimanere sempre a cavarsi la fame a casa nostra. Gli zii e il nonno mi fecero gli occhiacci e tentarono di cambiar discorso, ma non dimenticherò mai la tristezza degli occhi di uno degli uomini. Ero tremenda, ma non insensibile. Ricordo ancora con pena e mi rimprovero ancora. Il cugino del nonno, una sera che aveva bevuto forse un po’ troppo, finito di cenare leccandosi i baffi, tutto soddisfatto esclamò: -Buoni, veramente buoni, questi crauti! Noi ci guardammo sconcertati perché non aveva mangiato crauti, bensì dell’ottima e squisita polenta e baccalà. La fame era tanta, ed allora tutto era buono, anche polenta e cipolla. Le donne, quando cominciavano a farsi vedere i raperonzoli, il radicchio selvatico, il tarassaco, il tanus, i polloni del rusco, i ger- 72 73 mogli della vitalba, l’asparago selvatico, erano là a contendersi anche l’ultima radice. Povera collina! Non occorreva falciatrice, se non arrivavano gli uomini ci pensavano mucche, pecore, capre. Finita l’erba si attaccavano ai cespugli, alle chiome degli alberi finché era possibile arrivarci. In conclusione, alla fine la collina sembrava una testa rasata, con qualche capello ancora attaccato qua e là. Per il cibo si faceva di tutto. In una famiglia una capra morì di malattia, la seppellirono nel letamaio ma, pentiti, dopo qualche giorno l’andarono a riesumare e se la mangiarono ben cotta. Era frollata al punto giusto…! La magra cena. A sera le mamme oppure le altre donne di casa preparavano la parca cena. L’odore di fritto della pancetta, del salame, delle salsicce e della cipolla si espandeva per le vie ed arrivava fin su verso il sagrato della Chiesa. Chi non poteva allevare il maiale si doveva accontentare di fichi arrostiti con un po’ d’olio, oppure di polenta e frittata con la cipolla. Un po’ di lardo o di strutto qualcuno lo regalava a chi ne era privo, così poteva intingere la polenta e saziare la fame. Spesso se il camino non tirava bene, un fumo denso inondava la cucina facendo lacrimare gli occhi e pungendo la gola. I vestiti che si indossava assorbivano gli odori, che rimanevano appiccicati anche il giorno seguente. Si sentiva venire dalle stalle il muggir delle mucche e qualche belato di pecora. Qua e là un cane abbaiava e il frignar dei bambini si univa a quel coro di voci assonnate, stanche e imploranti, sì da formare un’orchestra armonica tutta naturale. Attorno al focolare ci si stringeva, perché lo spazio era quello che era e i componenti della famiglia non erano pochi. La legna scarseggiava. Le donne, durante il giorno, si recavano sulla collina a raccogliere dei secchi arboscelli, li chiamavano “ambrogni”. Erano dei cespugli di erbe che rimanevano ritti, dopo lo spoglio delle foglie, non si accasciavano a marcire per terra. Le donne ne facevano dei fastelli e ne portavano a casa facilmente sulle spalle perché erano leggerissimi. Ma questi “ambrogni” facevano presto a bruciare, duravano un po’ più che la paglia, sicché, in certe famiglie, le belle braci resistenti anche tutta la notte, non c’erano. Quando alla sera suonava la campana per le novene che, come dirò più avanti, caratterizzavano quel periodo dell’anno, io scappavo di corsa per raggiungere le mie compagne, che a loro volta uscivano saltellando dalle loro cucine. I genitori mandavano i figli alle varie novene del tempo liturgico e, potendolo, li raggiungevano in chiesa. Io attraversavo il paese di corsa, sia per il freddo pungente, sia per arrivare per prima e così prendermi il libro con i canti. Rallentavo la corsa passando davanti alla casa dei Ferrari, che si trovava sul mio tragitto verso la chiesa, perché la piccola stalla di Ettore era sempre socchiusa e a me 74 piaceva vedere la lanterna che oscillava attaccata alla trave disegnando sulle scure pareti strane figure, che a me, sempre di fervida fantasia, sembravano fantasmi. Il freddo. L’arrivo dell’inverno portava con sé nebbie, freddo intenso, e neve. Il freddo era l’incubo dei lunghi inverni sempre gelati e nevosi. Nelle case il fuoco veniva acceso solo in cucina, che doveva servire per cucinare, scaldare le persone e la cucina, le altre stanze erano sempre gelide. Nei letti si mettevano le moneghe con lo scaldaletto per chi se lo poteva permettere, oppure con le fogare. Le moneghe erano costruite con assicelle di legno con due quadrati, sempre di legno, coperti con lastre sottili di ferro, in modo che le braci dei contenitori non facessero danni. Venivano infilate nel letto e, qualche ora prima di coricarsi le donne portavano le braci coperte con la cenere e le mettevano nelle moneghe, accomodando le coperte in modo che il calore non venisse disperso. Alle volte però in qualche famiglia il fuoco era scarso oppure le braci non erano di legna buona, così si pativa. La Neta, nostra vicina di casa, ci confidava che, quando il freddo pungeva troppo e gli spifferi gelati entravano dalle fessure delle finestre sconnesse, prendeva i rotoli di corda usata per stendere i grandi bucati e li accomodava sopra le coperte, per sentire un po’ più di calore. Chi a quei tempi non soffriva di buganze, cioè di geloni? Ma tutti li avevamo, specialmente ai piedi, oltre che alle mani. Poveri piedi sempre ghiacciati! Per forza si formavano i geloni quando li mettevamo accanto al fuoco. Si passava dal gelo al caldo, così le buganze erano sempre lì belle rosse, che facevano venire un prurito feroce così, gratta che ti gratta, scoppiavano, provocando grande dolore e altrettanto disagio quando dovevamo infilarci le scarpe o le sgalmare. L’inverno era freddo, triste, uggioso, interminabile particolarmente per noi bambini che lo pativamo molto, una volta scrissi una poesia sulle uggiose giornate invernali di noi bambini, di sicuro una delle forme di povertà di quei tempi che oggi, con le comodità delle nostre case ben riscaldate non possiamo comprendere. 75 L’INVERNO: UGGIOSI GIORNI DELLA MIA INFANZIA. Grigiore, umidità, freddo pungente, e l’aia è colma di vapore stanco, che esce dal liquame un po’ discosto dalla stalla dove il bestiame rumina sdraiato sulla paglia. pennuti razzolanti, senza forze, uomini muti, grigi e corrucciati odoranti di terra e di pannocchie. Cigolanti carriole di letame portato negli orti e giù nei campi. Odori di pancetta sfrigolante nelle padelle ammaccate e nere. Profumo di buon pane appena cotto e di polenta su ciotole di latte. Starnazza un’anitra correndo goffamente a cercare un granello da beccare. Ghiotto, il maiale, immerge il grasso muso sul trogolo di avanzi ben riempito e la massaia va cercando l’uovo che la gallina deposto ha sul pagliaio. Ma quanto dureranno questi giorni per me bambina? Un’eternità! Il tempo dell’inverno è tanto lungo per il fanciullo che non sa aspettare… Attorno al fuoco il nonno s’addormenta cullato dalla nenia scoppiettante della legna che arde e si fa fiamma guizzante allegra su per il camino. E sogno prati verdi e cieli azzurri, campi di grano biondeggianti e dolci clivi e garrule fontane e prode ricche di fiori e di verzura, e squilli di campane tutte in festa e tanto, tanto sole sulle aie… Il naso ben schiacciato addosso al vetro della finestra, tutta a ghirigori disegnati da me, col dito sporco di zucca, cotta da zia per gli animali, guardo la natura che intristisce, sento serrarsi in una morsa il cuore. Ma ora nebbia, gelo, neve e brina fasciano la natura ed il mio cuore, che si tormenta perché non sa che la vita è luce, ma anche oscurità. D’ora in avanti i giorni saran questi: muggiti di buoi là nelle stalle, 76 Le tante scomodità. Mancavano le minime comodità, anche negli aspetti igienici. Allora le case erano tutte prive dei servizi per i bisogni fisiologici e ci si doveva arrangiare in qualche modo. Era una cosa normalissima imbattersi in persone che si recavano al limitare di un campo, oppure sotto qualche siepe per i propri bisogni. In mancanza di carta igienica si adoperavano le foglie ma, guai al malcapitato che, magari al buio, strappava qualche foglia, per la pulizia, e questa era di natura un po’…aggressiva! Povero sedere, si pativano le pene dell’inferno. Le donne dovevano provvedere, ogni mattina, allo svuotamento dei vasi da notte. Sempre a loro toccava quel rivoltante lavoro, ma lo facevano con semplicità. I vasi da notte, logorati dall’uso, non venivano gettati, ma servivano per festeggiare marzo. Infatti, ai primi di questo mese, si accendevano i fuochi sulla collina e sul prato del conte si facevano i “mascoli”, ovvero i botti. I ragazzi si procuravano vasi vuoti di conserva, di sgombro ecc., ma anche vasi da notte, chiamati “orinali”. In questi recipienti fuori uso, vi accomodavano il “carburo”, specie di esplosivo, lo mettevano capovolto e vi davano fuoco. Il fracasso era assordante e il vaso da notte finiva pure lui con un momento di gloria. Volando per aria credo si sentisse purificato da tutte le lordure che aveva sopportato per lungo tempo. Arriva marzo degli scalzi… Ai primi de marzo ogni mato va descalzo. Era questo il detto che veniva ripetuto nel nostro paese quando, il primo giorno di marzo, alcune ragazzine del paese si presentavano in piazza senza zoccoli e senza calze. Infatti quel giorno, ci si svegliasse con il cielo sereno oppure piovesse a rovesci, le solite amichette, felici e garrule come rondini, correvano, saltavano e giocavano allegramente, con i piccoli piedi nudi ancora segnati dalle cicatrici dei geloni. Poi, quasi subito, venivano imitate da altri ragazzi e adulti. Per le mamme era un grande risparmio: calze, zoccoli, sandali e qualche paio di scarpe, venivano indossati soltanto alla domenica quando si andava in chiesa oppure per la scuola. Le strade piene di sassi e buche, i viottoli con spuntoni di radici, le siepi, gli orti, i campi tutti celavano qualche insidia per i poveri piedi. Le mamme, le nonne e le sorelle maggiori avevano un bel daffare a togliere spine da quelle tenere carni. Qualche lacrimone spuntava dagli occhi dei più piccoli, quando lo spino era profondo e si doveva frugare ben bene con l’ago sotto la cute per poterlo estrarre. Quando ci si radunava alla sera in piazza, tutti volevano immergere i propri piedi sia sul lavatoio che sulla vaschetta, per lavarli e rinfrescarli. Era un grande sollievo. Ma i piedi puliti duravano poco per chi se li andava a lavare in piazza e non portava con sé né zoccoli, né ciabatte. 77 Dal prete a pié par tera! Anch’io andavo volentieri a piedi nudi, ossia descalza, come si diceva. Ricordo il giorno che Antonia, la sarta, una volta mi pregò di portare al parroco un paramento liturgico, era una pianeta verde, cui aveva cucito delle fettucce che s’erano rotte. Nel porgermi il paramento mi esplorò dalla testa ai piedi e, preoccupata, mi disse: -Ciò, no sta mia ‘nare dal prete a pié par tera! ( guarda di non andare dal parroco scalza!). Non le detti retta e andai così com’ero, cioè a piedi nudi.La chiesa era aperta e il parroco stava leggendo il breviario andando su e giù per la navata. In quel momento si era fermato e girato verso l’altare, quando gli capitai alle spalle senza fare il minimo rumore. Stetti immobile e, quando lui si girò per riprendere a camminare quasi gli venne un colpo. Lo capii perché il breviario gli cadde dalle mani, e sussultò. Mi apostrofò in malo modo dicendomi che in chiesa non si andava scalzi e che lo avrei potuto avvisare almeno con lo schiarirmi la gola. Si camminava così bene sul pavimento fresco della Chiesa! Mi mostrai dispiaciuta, ma dentro di me ridevo. Com’era buffa l’espressione del parroco, sembrava avesse visto uno spirito! Certo che non lo raccontai a nessuno, men che meno all’Antonia. …se calza le bele… Alla fine di settembre il detto era questo: da san Michele se calza le bele. Cioé: a San Michele anche le ragazze indossano le calze. Ed era vero, si cercava di tirare avanti senza calze il più a lungo possibile, sempre per risparmio. Dunque dal primo giorno di marzo alla fine di settembre, niente calze e…. piedi nudi. Però per andare in chiesa ci si doveva coprire. Soltanto il viso poteva andare scoperto, la testa doveva essere coperta da un velo. Pure noi bambine dovevamo avere o il berretto oppure il capellino, che era di lana o panno d’inverno e di paglia nell’estate. E si era felici e contenti anche senza calze e a piedi nudi. Quando inavvertitamente li si posavano su cespi di ortiche e si gridava dallo spasimo, Armida, la figlia di Prisco, ci diceva: Allegri che fa passare i dolori, e fa bene alla circolazione del sangue! così dicendo strappava le ortiche, e se le strofinava su braccia e gambe ridendo. Era il suo modo di consolarci. 3.4. Le forme sociali, il modo di vestire. All'asilo avevo imparato a salutare alzando il braccio destro, la mano tesa e pronunciando le parole: -Riverisco signor dottore, riverisco signorina maestra, riverisco signor conte, e così via..... Quando la maestra Emma ci faceva assistere ai funerali di qualche persona del paese, prima di arrivare al cimitero, ci disponeva in fila sulla strada che saliva sulla collina, dovevamo tenere teso il braccio, leggermente inclinato, e rimanere in quella posizione finché l'ultimo accompagnatore del feretro non si fosse dileguato. Le signore contesse, per le cerimonie sia civili che religiose, avevano fatto confezionare un grembiule a quadretti rosa per le bimbe e azzurro per i bam78 bini. Eravamo in tanti allora. Lo dovevamo indossare per ogni circostanza, anche quando ci si doveva recare alla santa messa feriale, di buon mattino, nell’oratorio dei conti. La stoffa del grembiule non era leggera per cui, d’estate, sudavamo come salsicciotti messi ad asciugare. Allora era severamente proibito mostrare gli arti sia inferiori che superiori, specialmente in chiesa. Le calze erano lunghe e di cotone pesante, le camiciole, sottovesti e vesti non erano certo di stoffa leggera, aggiungervi, poi, il grembiule in certe occasioni diventava una vera tortura. Il parroco non tollerava la minima libertà per quanto riguardava l’abbigliamento. Ricordo che zia Carolina aveva fatto confezionare, per me e Delia, un grembiule di tela quadrettata, di un colore abbastanza scuro. Doveva essere lungo fino alle caviglie, le maniche dovevano coprire i polsi e coperto doveva essere pure il collo. Il giorno che l’indossammo per la prima volta io e Delia ci guardammo abbastanza mortificate, sembravamo due fraticelli in miniatura, pronti ad uscire per la questua. Ci mancava solo la bisaccia. Una sera che, vestita in quel modo, mi recai in Chiesa con il nonno, all’uscita dalle funzioni, il parroco ci avvicinò e, dopo essersi complimentato con il nonno per il vestito della nipotina, a me chiese un bacio. Lo stupore che provocò in me quella richiesta mi lasciò senza fiato. Era una cosa inaudita e senza precedenti, almeno per me. Fissai sbalordita il nonno, che se ne stava impassibile a guardare, poi avvicinai le labbra alla guancia del Sacerdote con tremore e sacro timore e gliela sfiorai, ma proprio leggermente. Quel bacio era il premio per il mio grembiule assurdo…, ne avrei fatto volentieri a meno. Mia sorella, di qualche anno più grande di me, aveva la divisa di “piccola italiana”: gonna nera e camicetta bianca. Anche i “Balilla” avevano la loro divisa, che indossavano nelle varie cerimonie. I “Balilla” e le “Piccole Italiane” durante una esercitazione a Villaga, davanti al Municipio. Fra le bambine anche Maria sorella di Linda. 79 Ricordo che mia sorella, una volta alla settimana, saliva con altre bambine su un carro trainato da un cavallo guidato da Mattio, il cocchiere del conte, che le portava a Villaga dove, davanti al Municipio, eseguivano vari esercizi ginnici. Io l'invidiavo, non per la divisa, ma per la lunga trottata che poteva fare sul carro di Mattio, Avevo chiesto d'esservi ammessa, ma mi si disse ch'ero troppo piccola. 3.5. La carriole ad uso promiscuo! Le carrozzine per portare a passeggio i bambini ai miei tempi non esistevano. I neonati si lasciavano nella culla per molti mesi e tutti fasciati come salamini. Qualche mamma, se doveva recarsi nei campi a dare una mano agli uomini, sistemava nella carriola un grande cuscino che qui, in dialetto, veniva chiamato “pissotto”, cioè recipiente per ricevere la pipì dei bimbetti. Anche la famiglia più povera possedeva una carriola, che veniva adoperata per mille necessità, fungeva anche da carrozzina là dove nascevano bambini e, a quei tempi erano delle belle nidiate. Cinque, sette, dieci, otto… e le case piccole, le stanze poche…il lavoro tanto, e il pane …scarso. I fratellini più grandi avevano il compito di portare a passeggio i piccoli e, come ho detto sopra, si metteva il grande cuscino, sia per la pipì come pure per evitare ammaccature e rotture di ossa agli indifesi. Le strade non erano lisce, asfaltate e pulite e, i sobbalzi del cigolante veicolo potevano provocare molti danni. Le mamme che si portavano appresso i bimbi nei campi, come arrivavano, prendevano i loro tesori, li accomodavano lungo le “cavezzagne” (carreggiate), e questi rimanevano fermi lì oppure si trascinavano carponi e staccavano i fiorellini che attiravano la loro attenzione. Se qualcuno, infastidito da qualche insetto o solleticato da qualche filo d’erba un po’ ruvido si fosse messo a strillare accorreva la mamma, che però non poteva rimanere a consolarlo più di tanto. Sembrava che i poveri pargoli si astenessero dai capricci perché consapevoli di non poter venire accontentati. Le mamme, quando affidavano i loro bimbi ai fratelli più grandi, raccomandavano di stare molto attenti di non lasciarli mai soli, di non lasciare le carriole sotto il sole. Promettevano i ragazzi, ma poi….. era troppo invitante il lavatoio con la sua fresca acqua per non entrarci e guazzare un po’, era troppo riposante l’ombra che la vecchia “morarona” stendeva sull’erba fresca, e sulla fontana dall’acqua che scendeva dal suo lungo braccio di ferro, limpida copiosa e fresca. Sistemate le carriole in luogo sicuro, si davano alla pazza gioia, liberi come animaletti del bosco, come gli uccelli del cielo e come le farfalle che volavano ricamando di colori l’aria, l’erba, le piante. Si ricordavano dei fratellini quando qualcuno si metteva a strillare come 80 aquila perché magari punto da un insetto, o colpito dai frutti del vecchio gelso, o dagli spruzzi d’acqua fredda provenienti dai lanci che le piccole birbe si gettavano per gioco. Allora ognuno controllava il danno, rimetteva un po’ di ordine sulla carriola, puliva il nasino del fratellino, o gli ficcava per bene il “ciuccio” in bocca, poi se ne tornava ai suoi giochi. Che gioia però! I piccoli non crescevano con estranei e, all’aria aperta, imparavano presto a godere del sole, dell’aria pura, del canto degli uccelli, del colore dei fiori, ed erano circondati dall’amore dei propri cari, da quell’amore vigile e forte, sola ricchezza della famiglia, alle volte molto ampia con genitori, nonni, fratelli e zii. Care e gloriose carriole dalla ruota cigolante, quanti sonni avete custodito e quanti dolci pesi avete portato! 3.6. Rimedi pratici per la salute: Silvio cotto al forno. In via Longhe, in località Faustine, abitavano i Faccio in una comoda casa colonica con annesso un grande forno per la cottura del pane. A pochi passi dai Faccio viveva allora la vecchia Anna Zen Trevisan, con due figli non ancora sposati, uno di nome Silvio e l’altro Ernesto, la figlia Maria, sposata, abitava in paese. Tengo sempre nella memoria questa donna magra, allampanata, che d’inverno si metteva sulle spalle una coperta a guisa di scialle e s’incamminava lesta, dondolando l’esile corpo, verso la chiesa. Mi affascinava quella figura dal volto sempre austero e raccolto, che non si fermava per la strada nemmeno un momento e sembrava spinta da un interiore richiamo noto a lei sola. Rimanevo incantata a guardarla finché non scompariva là dove la siepe sembrava allargarsi sulla strada impedendomi di guardare oltre. Una componente la famiglia Faccio e precisamente Lavinia, che un giorno sarebbe stata la suocera di mia sorella Delia, raccontava che, essendo il figlio di Anna, Silvio, ancora giovanetto, affetto da acerbi dolori alle ossa, un giorno, appena tolto il pane dal forno, ve lo introdussero. Il povero malcapitato, ammutolito dallo spavento, giustamente pensava lo volessero cuocere, lo lasciarono in quel forte calore per circa mezz’ora. Ci si può immaginare quando uscì in che stato fosse! Ma, sia la madre che Lavinia erano convinte d’essere state, per quel ragazzo condannato a vivere seduto su una sedia a rotelle sino alla fine dei suoi giorni, medico e medicina infallibili. E fu così. Silvio non ebbe più per tutta la vita, che si concluse ad un’età molto veneranda, (circa 92 anni) il minimo disturbo. Ancora oggi il forno della famiglia Faccio è lì a ricordare tante vicende liete e tristi, ma soprattutto a rievocare i giorni gioiosi del pane fragrante, che spandeva tutto intorno il suo delizioso profumo, per la gioia di quelle bocche 81 sempre affamate e dei poveri che sostavano in quell’aia dove, oltre il forno, c’era anche il pozzo che dava chiara, fresca e dolce acqua e piante cariche di frutta saporita. Pane, acqua e frutta e tutto ciò che si poteva, donati a tutti con il sorriso della carità. Tra i ragazzi della famiglia Faccio si distingueva il secondogenito Bonifacio, aveva un anno meno di me. Possedeva una voce meravigliosa. Quando venne come insegnante il maestro Ivo Pavan, una persona veramente eccezionale, ci insegnò parecchie cose, fra le quali tante belle poesie e canzoni. CAPITOLO QUARTO DALL’ALBUM DI SCUOLA. IMPARARE A LEGGERE E SCRIVERE IN TEMPO DI GUERRA… 4.1. A Scuola da Colorinda… Le prime tre classi delle elementari le frequentai nella scuola del paese, a Toara, in seguito l'edificio venne requisito dai tedeschi. L' Asilo infantile ( allora la scuola materna si chiamava così ) era stato sistemato in un locale di casa nostra, con il permesso di nonno Gustinello. In un' altra famiglia del luogo venne trasferita la Scuola Elementare. Ricordo una buia cucina, in quella stanza, riscaldata da ceppi posti ad ardere sul focolare e dalla parete impregnata di nera caligine, di tanto in tanto, la padrona, Clorinda che tutti chiamavano "Colorinda", entrava per alimentare la fiamma con altra legna, o per scambiare parole sussurrate all'orecchio della maestra, che si guardava attorno spaventata. Nei primi anni di scuola non ho avuto difficoltà, tutto mi sembrava meraviglioso: scrivere, leggere, studiare storia, geografia, scienze, religione erano per me dilettevoli e gratificanti. La matematica, invece, non mi piaceva, anche se riuscivo benissimo, ma avevo deciso che era una materia antipatica, così me la sbrigavo in qualche modo, senza approfondirne i metodi deduttivi per le varie applicazioni. La lettura ed i componimenti, invece, mi entusiasmavano. Ancor prima dell'età scolare leggevo e scrivevo con una certa padronanza; mi appropriavo spesso del libro di lettura di mio fratello, di due anni più grande di me che, talvolta, me le suonava, anche perchè al mattino, quando si preparava per la scuola, spesso non riusciva a trovare il suo sillabario (allora il libro di lettura lo si chiamava così). Devo dire però che i miei ricordi di scuola s’intrecciano con tanti ricordi dei tempi di guerra, non era facile studiare, imparare a leggere e scrivere durante la guerra… A scuola, i primi libri di lettura, ricordo, erano di carta straccia, poveri di figure, privi di colori. 82 83 Quello che emergeva di più era il disegno del fascio, ricordo che rimanevo tanto tempo ad osservare quella strana figura cercando di collegarla alla parola, perché quel nome ricorreva sovente sulle labbra delle persone, infatti sentivo dire: Quello è un fascista…, nella tal famiglia sono tutti fascisti… Ma non capivo cosa c'entrassero le persone con le figure del fascio. Fascio, fascisti, fascisti, fascio….cosa voleva dire? Chiedere spiegazioni? Nemmeno per sogno! Il materiale scolastico. Il primo giorno di scuola fu una grande avventura! Non c’era allora la consuetudine di venire accompagnati dai genitori. Il paese era piccolo e la scuola tutti si sapeva dove fosse situata, quindi….. Eccomi con il grembiule nero, colletto bianco, ricamato dalla zia Suora, fiocco di nastro in testa, che si sforzava di tenere uniti una massa di capelli ribelli. La zia mi aveva preparato la cartella, non di pelle s’intende, ma di cartone di color marrone. Dentro ci aveva messo: un portapenne di legno, molto robusto, fatto come una scatola bislunga e stretta, con una tavoletta scorrevole a mo’ di coperchio, dove ci potevano stare la matita, il penale (la penna), ed una gomma per cancellare. Il penale era un’asticella di legno, in una delle estremità c’era un piccolo cerchietto di metallo dove veniva inserito il pennino. Ce n’erano di tanti tipi di penali: di legno laccato, di ferro, di legno colorato, tanti avevano un rigonfiamento nel mezzo, ma tanti erano semplici asticelle di legno che alle volte si spezzavano. Il pennino ce lo procurava la maestra. Io e i miei fratelli eravamo fortunati perché la nostra nonna, che aveva insegnato per 43 anni nella nostra scuola, aveva fatto scorta di cancelleria, così attingevamo sempre dal suo cassetto, ne aveva uno apposito nel grande armadio della stanza da letto. Lì c’erano matite, gomme, pennini, carte assorbenti in quantità. Anche se avevo il penale nell’astuccio, in prima elementare non l’ho mai usato, ma solo la matita. Cenere e inchiostri…. In seconda cominciai ad avvicinarmi all’inchiostro che, povera me, mi spaventava un po’. Eravamo due in un banco, ma ognuno aveva il suo calamaio, che era inserito in un foro fatto sul legno dello stesso. Alle volte succedeva che quando si intingeva il pennino nell’inchiostro, si andasse troppo in giù e allora, oltre che il pennino, anche la povera manina veniva bagnata da quel ….nero. Il calamaio della maestra, invece, era sopra la cattedra. Avevamo sempre a portata di mano la carta assorbente perché le macchie erano continue e, alle volte, molto vistose. Accadeva specialmente quando il pennino era schinco, cioè con la punta spuntata, allora non solo venivano i ricami dell’inchiostro, ma si bucava anche la pagina. Che fatica, ragazzi, scrivere con quegli arnesi! L’asciugapenne era fatto di stoffa, qualcuno sembrava una presina, altri erano due pezzuole messe unite. A me la zia suora ne aveva mandato uno fatto a forma di cane; ricordo che era di velluto blu all’esterno, e panno nero all’interno, cucito con cotone rosso. Per occhi aveva due piccole perle. Era una bellezza! Mi piaceva tanto quel cagnolino, me lo strofinavo sempre sulle guance e, qualche volta, ci lasciava il segno. Ma per asciugare il pennino ci voleva anche un po’ di abilità perché succedeva spesso che le punte s’infilassero nella stoffa e allora, quando si ricominciava a scrivere era una tragedia….per via delle macchie. Chi non aveva il tirapenne (temperino), si faceva prestare dai più grandi, un piccolo coltello a serramanico, però poteva anche succedere che si arrivasse alla fine della matita senza aver fatto uscire la punta. Per i compiti a casa noi avevamo un bel portacalamaio che la nonna adoperava quando non era a scuola, ma chi non ce l’aveva, l’inchiostro lo metteva in una boccetta di vetro munita di stroppolo cioè tappo. Poteva mancare anche l’inchiostro, allora le buone mamme, prendevano le bacche di sambuco, o di qualche altra pianta, e le pestavano bene, quindi le setacciavano con della stoffa di canapa, ed ecco l’inchiostro, tutto vegetale! Se ne faceva scorta anche per la stagione fredda poiché le bacche non si trovavano in tutte le stagioni. Alle volte si era scarsi anche di carte assorbenti, allora si ricorreva alla cenere, di quella, poca o tanta ce n’era sempre. Ricordo che un mio compagno un giorno si presentò a scuola con una pagina del compito fatto a casa, tutta a buchi. La maestra, scandalizzata, gliene chiese la ragione. Lui, poveretto, quasi piangendo, le disse che quando la mamma aveva messo la cenere per asciugare l’inchiostro, non s’era accorta che in mezzo c’erano delle ….piccole braci! Succedeva anche questo… La carta scarseggiava e, i quaderni, li dovevamo tenere cari, non saltare righe, non strappare pagine. Le mamme raccomandavano di Zia Maria, sorella di papà che poi si fece Suora Francescana 84 85 non far le recce (le orecchie) agli angoli delle pagine. Quante poche cose si avevano! I capricci non si potevano fare allora, e non ci si immaginava neppure che esistessero. In inverno c’era una stufa per aula, ma il caldo era poco. Qualche volta la canna fumaria non tirava bene, o perché c’era vento o perché la legna era umida e così si pativa il freddo, anche perché non si era vestiti adeguatamente. Tempi duri, di povertà, ma anche di gioie fatte di piccole cose: una matita nuova, un’immaginetta da mettere sul libro, un elogio della maestra, un bel voto, uno sguardo fuori dalla finestra e vedere che gli alberi cominciavano a mettere le gemme, un volo di rondine sotto la grondaia, un suono di campane che annunciava la festa…. Piccole – grandi gioie, per piccoli – poveri bambini. Troppo brava! In prima elementare, un giorno, la maestra ci propose di scrivere alcuni pensierini sulle piante; io, che amavo smisuratamente la natura, scrissi parecchie pagine sull'argomento, con grande facilità e scioltezza, adoperando un lessico appropriato e vario. Tutta felice consegnai il mio lavoro alla maestra che, allibita e strabiliata, mi guardò come se invece di una piccola mocciosa, alta quanto un soldo di cacio, e tutta occhi, avesse davanti a sé un mostro preistorico. Alla fine, riavutasi dallo shock, mi scrollò ben bene e mi sgridò severamente dicendomi di attenermi soltanto alle sue istruzioni e richieste. Cioè, secondo lei, avrei dovuto scrivere soltanto i tre soliti pensierini. Forse la urtavo, forse le facevo scuotere i nervi…. Altre volte se la prendeva con me perché, quando vedevo che qualche compagno non riusciva a rispondere o non aveva imparato la poesia, rispondevo e recitavo io la poesia al suo posto. Quel giorno avevo disobbedito, avevo scritto troppo, e bene, perciò fui punita. Ma allora - pensai mortificata- che ci vengo a fare a scuola se non posso scrivere tutto quello che sento, che vedo e che amo? Poi, però, la cara maestra, si recò nell'aula vicina per far sapere all'altra insegnante (le classi erano plurime) che in quella scuola c'era un piccolo mostro, il quale scriveva troppo bene per essere una creatura normale, per esserlo avrei dovuto riempire il quaderno di strafalcioni. Ci provai ancora a fare qualche altro componimento d’italiano, ma da quel giorno il mio entusiasmo per la parola scritta pian piano si affievolì, scoraggiata com’ero, e preferii invece immergermi nella lettura di libri, talvolta più grandi di me. Nella soffitta della nonna. Mi nascondevo in soffitta dove la nonna paterna, che era stata insegnante, aveva ammassato una grande quantità di riviste, libri e pubblicazioni scolastiche che i miei non avevano pensato di eliminare dopo la sua morte, così trascorrevo parte del mio tempo a sfogliare e leggere senza essere indirizzata o controllata. Rimanevo ore e ore a leggere e fantasticare, e così mi allontanavo dagli altri che 86 mi ritenevano una bimba introversa, scontrosa e strana. Tra tutta quella stampa trovai il libro di Robinson Crusoe, che m’infiammò, lo lessi decine di volte, facendo volare la mia sfrenata fantasia verso terre lontane, lidi fantastici, mari sconfinati, dove la sete di avventura poteva essere ampiamente appagata. Avrei voluto confidare a qualcuno i miei ardenti desideri di evasione, e fu allora, come ho già raccontato, che pensai che per fabbricare una canoa avrei dovuto chiedere l'aiuto al nonno Gustinello, falegname…. Legittima difesa. Frequentai con profitto le prime due classi della scuola elementare; la maestra mi capiva e mi voleva bene, sapeva compatire certe mie stranezze e non ironizzava sul suo mio modo di vestire a volte fantastico e bizzarro. Alle volte infatti capitavo a scuola con la cuffia da notte che era stata della nonna, o con gli stivaletti della stessa; talvolta, sopra i capelli, mettevo dei fiori o dei rami di edera. I bambini, miei compagni di classe, ridevano di me, mi punzecchiavano e mi facevano sgarberie che ricambiavo raramente, ma quando ciò avveniva, allora si che per un pezzo mi lasciavano in pace! A me i rospi, le rane, le lucertole non facevano ribrezzo, me ne riempivo le tasche e, a quei compagni che mi maltrattavano sapevo far trovare nella cartella, sotto il banco, oppure tra gli indumenti, uno di questi animaletti. Per questo motivo, un po’ alla volta, mi lasciarono in pace sia i compagni di classe che gli altri della scuola. Non profumavamo di colonia. Nel secondo ciclo della scuola elementare ebbi un'altra maestra, che era sempre molto truccata. La signorina veniva dalla città e mal si adattava a quella piccola scuola di campagna. Molti di noi si recavano a lezione dopo aver portato al pascolo, per qualche ora, pecore, capre e mucche se la stagione era adatta; altrimenti dopo aver aiutato i familiari nelle stalle, se non potevamo uscire all'aperto, e certo non odoravamo di acqua di colonia. La signorina maestra si strofinava spesso il naso con un piccolo fazzoletto profumato, specialmente quando passava tra i banchi, o doveva chiamare a sé qualche ragazzino per la correzione dei compiti. Io cercavo di andare a scuola sempre pulita; mi lavavo viso collo e mani con una meticolosità sbalorditiva per quella piccola selvaggia che ero. Finito poi di lavarmi mi strofinavo il viso con sacchetti di spigo e di lavanda, che la zia teneva tra la biancheria. Certo il profumo se ne andava dalle mani quando, recandomi a lezione, per la strada, lungo le prode dei ruscelli e sotto le siepi catturavo tutte le bestiole che potevo trovare, dando loro libertà, dopo averle accarezzate una ad una, nei pressi della scuola. Una volta, a scuola, la combinai grossa, con quella irriverenza smodata, provoca87 toria, e maleducata che solo i bambini possono avere. Guardando la maestra infatti notai che aveva le labbra dipinte di rosso vivissimo, le guance e gli occhi truccati in maniera vistosa. Così non riuscii a trattenermi e le chiesi se alla sua morte avesse avuto piacere di essere messa nella bara con il trucco rifatto. La maestra, indignata, per tutta risposta voleva, molto giustamente, appiopparmi un ceffone quando, invece di colpire me, che mi ero scansata, colpì il calamaio pieno d' inchiostro, che era sul banco. Il calamaio volò in mezzo all'aula schizzando il viso della maestra di nero liquido, così che la povera insegnante somigliava ad una maschera di carnevale, suscitando le risa e gli schiamazzi di tutta la classe. 4.2. Il fossile donato dal papà: un’inutile crudeltà. Un ricordo doloroso è legato a quei primi anni di scuola. Un giorno papà, tornando dai campi, mi aveva regalato un bellissimo fossile. Sembrava un cono tutto attorcigliato, ma aveva anche la forma di un pane, di quelli che faceva la zia per noi bambini. Tutta orgogliosa lo portai a scuola per farlo vedere alla maestra. Oltre ad essere un bel fossile, me l'aveva regalato papà, perciò, per me, aveva un valore immenso. La maestra, quando glielo porsi per farglielo ammirare, lo prese e, con gli occhi cattivi, mentre lo gettava dalla finestra, urlò: -Un'altra volta che porti a scuola dei sassi, assieme a quelli butterò pure te dalla finestra. Nel momento che l'insegnante gettava dalla finestra il mio sasso, davanti agli occhi vidi la figura di papà nell'atto di porgermelo. Fu come se “quella” m'avesse pestato il cuore. Rimasi zitta per tutto il tempo che rimasi a scuola, ma quando tornai mi precipitai da papà e, gettandomi sulle sue braccia, piangendo in modo inconsolabile, gli raccontai ciò che aveva fatto e detto la maestra. Papà promise che me n'avrebbe trovato un altro, ma la sua voce, nel cercare di quietarmi, era molto triste. Quel gesto, anche se dopo molto e molto tempo riuscii a perdonarlo, non l'ho mai potuto dimenticare. Quando si parla di fossili al mio sguardo si presentano sempre gli occhi mesti di papà. Chi è lo stolto che dice: -E' piccolo/a, dimenticherà presto, si distrarrà..... Ho sofferto terribilmente e dentro di me c'è sempre un angolo pieno di dolore, per me sacro. Non si può del tutto comprendere che cosa sia rimanere orfani a nove anni. E’ un dolore che segue un percorso del tutto opposto agli altri dolori: gli altri sono affievoliti dal tempo, questo è misurato e accresciuto nel tempo. scuola, a pochi passi da casa mia, vidi alcuni tedeschi armati di mitra e fucili che si guardavano attorno tutti agitati. La gente che frettolosamente passava per l'unica strada del paese mormorava parole appena percettibili. Riuscii ad afferrare qualcosa come: -Stanno facendo un rastrellamento, via, via.....! Addossata ad un muricciolo, c'era l' Arpalice, una donna del paese. Un tedesco le teneva puntato addosso un mitra. Lei tremava come una foglia e farfugliava alcune parole. Io, paurosa per quanto riguardava ciò che d'inverno si raccontava nelle stalle o accanto al camino di streghe, gnomi, spiriti, folletti, maranteghe, e rastrelli senza sangue (non so poi perchè questi ultimi dovessero fare tanta paura) non lo ero affatto quando si trattava di cacciarmi in situazioni davvero pericolose. Eccomi allora, incurante del momento tragico che quella povera donna stava vivendo, con la mia cartella sottobraccio. Mi avvicinai al gruppo e misi il mio curioso visetto proprio sotto il naso del tedesco, che stava terrorizzando la povera donna. 4.3. L’Arpalice ed il soldato tedesco. Erano tempi duri, tempi di guerra, i tedeschi spadroneggiavano in paese mettendo spavento ed angoscia anche in noi piccoli. Andare a scuola in tempo di guerra voleva dire poter incorrere anche in avventure nient’affatto piacevoli, né adatte per una povera bambina. Una mattina, verso le ore otto, mentre mi avviavo alla Arpalice aveva saputo del rastrellamento e si stava recando dal fratello per avvisarlo, i figli di lui si nascondevano tra i boschi, ma, talvolta tornavano a casa. In quel periodo Arpalice si recava tutte le sere a dormire nella casa della sorella, che abitava vicino al fratello, così alla richiesta del tedesco, che voleva sapere dove si stesse recando, rispose balbettando in dialetto: -Mi sò drìo ‘nare a torme el fazoleto da naso ca go assà da me sorela, parchè a son ‘nà a dormire da ela stanote. (Io sto andando da mia sorella a prendermi il fazzoletto da naso, che ho lasciato lì, perchè questa notte ho dormito da lei). Era evidente che la poveretta non stava dicendo la verità, ed il tedesco, pur non capendo una parola di dialetto si stava innervosendo sempre più. Vedendo l'Arpalice in quello stato e sentendo le sue parole scoppiai in un’irrefrenabile risata, che fu provvidenziale, anche se rischiai di grosso. Infatti mentre il tedesco, irritato, abbassava gli occhi su di me, alzando i miei vidi poco lontano, a mezza collina dietro un cespuglio, un giovane che s'allontanava correndo, scomparendo poi nel folto del bosco. Anche il tedesco lo vide, ma non fece in tempo ad imbracciare il mitra, che aveva allentato un po’ sentendo la mia risata, forse aveva voglia di appiopparmi un ceffone. Ripresosi mirò al cespuglio di dove era uscito il giovane, sparò ma per fortuna non colpì nessuno. A quel punto me la svignai di corsa senza voltarmi per non vedere l'agitazione che si era venuta a creare dopo l'episodio della fuga del giovane. Arpalice fu lasciata dopo una severa rampognata, fatta per niente perchè sia la poveretta che altri, di tedesco non capivano una parola, mentre il linguaggio della paura lo capivano tutti! Arrivai a scuola un po’ in ritardo. La maestra stava confabulando con la Clorinda e quando mi vide, notando in me una certa agitazione, me ne chiese la ragione. Raccontai tutto soffermandomi sulla descrizione della faccia di 88 89 Arpalice e del fazzoletto da naso. L'insegnante mi guardava allibita, poi, mettendosi le mani tra i capelli e quasi piangendo andava ripetendo, come una cantilena: -L'hai scampata bella, l'hai scampata bella! A distanza di anni ho ancora davanti agli occhi l'Arpalice con i capelli scapigliati, la sua faccia buffa, il tedesco con il mitra puntato sul petto della donna, il giovane che balzava da dietro il cespuglio e lo sguardo burrascoso di quell'ufficiale piccoletto e tarchiato, che sembrava volermi annientare. Ogni volta che mi reco a Toara e passo vicino a quel muretto non posso fare a meno di ricordare quel mattino di primavera così terribile, così colmo di paura per tutti. Anche se noi bimbi non eravamo consapevoli della tragicità dell'ora, le facce angosciate degli adulti, i loro sguardi talvolta disperati, le poche parole sussurrate in sordina, mettevano nei nostri piccoli cuori brividi di terrore e di sgomento. 4.4. A proposito di Maranteghe e rastrelli senza sangue Quando gli adulti, per qualsiasi motivo, si volevano sbarazzare di noi bambini, ci mettevano paura minacciandoci che avrebbero chiamato il rastrello senza sangue oppure la Marantega. Sentire la parola “sangue” per noi piccoli era una cosa che sapeva di mistero, di dolore, di morte. Molte volte me ne andavo di nascosto sotto la tettoia di casa dove si tenevano gli attrezzi di lavoro rimanendo parecchio tempo ad osservare i rastrelli che servivano per raccogliere il fieno o la paglia, e cercavo di capire se avevano il sangue. Mi arrovellavo nel voler capire perché il rastrello senza sangue doveva far paura, semmai, pensavo, doveva essere il contrario. - Mah!? Valli a capire i grandi… – mi dicevo. Però la paura rimaneva. E guai a chiedere spiegazioni! Quando qualcuno piangeva o faceva qualche capriccio era il solito ritornello: - Zitto, zitto, senti la Marantega come scalpita... E cominciavano la tiritera recitata in un misto di dialetto e italiano: Tradizionale filastrocca popolare della Marantega Ecco la Marantega che zimpega che zampega, che batte all’uscio mio: vattene con Dio, che in letto ghe xe’ mè marìo…! Poveri noi, chi ci capiva qualcosa? Però, che fantasia questi adulti…..! 90 4.5. Il coprifuoco. I compiti che la maestra ci dava da eseguire per casa li dovevamo svolgere nelle ore pomeridiane, perchè, di sera vigeva il coprifuoco. Chi aveva i telai delle finestre sconnessi, li rabberciava alla meglio incollandovi carte o mettendo stracci nei buchi. Era angosciante sentire, tutte le sere il rombo di Pippo, l'aereo che passava per la ricognizione, il passo cadenzato degli ufficiali tedeschi, che di notte facevano la ronda. Il nostro piccolo paese aveva un'unica via, perciò passavano e ripassavano decine di volte per quella. Quando li sentivi fermarsi vicino alla porta di casa, se stavi mangiando, il boccone del povero cibo ti si fermava nella strozza, se stavi attorno al focolare ad ascoltare i discorsi sommessi dei grandi, questi s'interrompevano, si sentivano soltanto i battiti dei cuori, se stavi pregando la preghiera si faceva supplica accorata e straziante. Ad ogni momento potevi sentire una voce gutturale o il bussare forsennato che t'imponeva di aprire, allora il cuore ti veniva in gola ed eri preso dal panico. Quando bombardavano Vicenza, Padova e Verona gli aerei, nell'andare e nel tornare sorvolavano sempre Toara. Una notte, un grande rumore e rombi paurosi ci svegliarono, ci alzammo tutti e vedemmo nel cielo, sopra i monti Euganei, scie di fuoco, lampi di bombe scoppiate, il cielo illuminato da sembrare giorno. Tremavamo tutti. Stavano bombardando Padova. Quello spavento me lo portai dentro per molti anni e quando mi coricavo la sera, mi coprivo la testa, trasalivo al minimo rumore, il cuore mi saliva in gola e tremavo tutta. Non riuscivo a dimenticare. 4.6. La quarta elementare a Belvedere… Sdrucciolare sul ghiaccio. Anche quell’ anno scolastico ebbe termine, ma dopo i tre anni di elementari frequentati a Toara la quarta classe fu spostata a Belvedere. Toara, il mio paese, è collegato a Belvedere da uno stradone lungo due chilometri, che noi percorrevamo, tutte le mattine a piedi. Lo stradone allora non era asfaltato e quando pioveva a nulla valevano gli ombrelli; si arrivava a scuola fradici e raffreddati. D'inverno poi, quando era nevicato e le strade si presentavano ghiacciate facevamo di quelle slizzegate o sdrucciolate, memorabili, ma per far ciò tante volte ci toglievamo le scarpe e, con le calze, che erano pesanti perchè fatte a mano con lana e cotone, si andava che era una meraviglia. Che botta! A scuola si arrivava magari alle undici, bagnati fradici, cercavamo di impietosire la maestra con mille scuse e lei, quando ci vedeva in quello stato, ci metteva vicino alla stufa, ci toglieva le calze e rabbrividiva nel vedere i nostri poveri piedini così malamente conciati. Il profitto scolastico era proprio scadente quell'anno, non studiavamo anche perchè si partiva di buon mattino e si tornava tardi nel 91 pomeriggio, non perchè l'orario fosse continuato, ma per la voglia di starsene a gironzolare per i campi e i prati, a casa c'erano soltanto tristezza e volti senza sorriso. In quel di Belvedere c'è un castello circondato da molti campi e questi protetti tutt'intorno da alte mura, una parte di queste, quella che delimita i campi del conte Piovene, è divisa da un fossato, che d'inverno, a quei tempi, era sempre ghiacciato, adatto così alle sdrucciolate. Un giorno, tornando da scuola, ragazze e ragazzi decidemmo di divertirci un po’ sdrucciolando sul ghiaccio di quel fosso. Ci levammo le scarpe e.... via! Tutto andò bene per un po’ finché caddi malamente indietro e svenni. Quando riaprii gli occhi mi ritrovai distesa sul ghiaccio, completamente sola. Seppi in seguito, da una mia compagna, che Vico aveva gridato: -Linda è morta! Pieni di paura i miei coraggiosi ed eroici compagni del paese, con grande generosità se la svignarono, lasciandomi tutta sola. Mi rialzai e mi tolsi da quel luogo barcollando. Poco lontano, sulla strada, passava la carrozza della contessina Amalia, vicino a lei sedeva impettito un ufficiale tedesco, il cocchiere era Matteo (noi lo chiamavamo Mattìo). Come mi vide in quelle condizioni, tutta sola per la strada, la contessina ordinò a Mattio di fermarsi, mi invitò a salire, ma io che nell'ufficiale sedutole accanto, avevo riconosciuto quello che aveva spaventato la povera Arpalice, con una scusa, in verità poco plausibile, declinai l'invito. Ho molti ricordi di quell’anno particolare di quarta elementare, trascorso interamente in tempo di guerra. promossa con il massimo dei voti e con lode, invece che per il rotto della cuffia! La guardai dritta negli occhi e, con ribellione, le gridai: -Non me ne importa, studierò quando i tedeschi se ne saranno andati! Eravamo molto presi dalle difficoltà della vita per poterci applicare veramente sui libri: bombardamenti, fame, morti, erano le vicende di ogni giorno… Qui sotto descrivo alcuni di questi ricordi di guerra, alcuni simpatici, ed altri drammatici, tutti ancora tanto vivi in me. 4.7. Andare a scuola in tempo di guerra…. La ronda. Ricordo: una sera m'ero intestardita nel voler partecipare alle prove di canto in parrocchia, era d'inverno. Il parroco, un patito del canto, non ci mollava mai. S'era fatto buio. Era d'inverno. Allora le strade non erano illuminate e neppure un lume si poteva scorgere nelle case. Quella sera non c'era la luna. Non volendo attendere mia sorella e le altre ragazze mi misi a correre all'impazzata verso casa, tutto un tratto andai a sbattere addosso a qualcosa di duro e nello stesso tempo mi sentii afferrare per le braccia e sollevare in alto. Ero andata a finire tra le gambe di uno dei due tedeschi che facevano la ronda. Accesero una pila, io li guardavo curiosa, ma non spaventata, credo sia stato meglio così perchè scoppiarono a ridere, mi fecero una lunga filippica sempre tenendomi per aria, quindi posatami a terra mi fecero cenno di andarmene, cosa che feci e di corsa senza voltarmi. Devo ammettere, per la verità, che non tutti i tedeschi erano cattivi. Studierò quando i tedeschi se ne saranno andati! Alla fine di quell’ anno scolastico di quarta elementare la mia pagella risultò un vero disastro, con grande dispiacere dei miei, e della maestra, che nel porgermela disse: - Date le tue capacità avresti potuto essere stata Scolarette che rubano le albicocche. D'inverno c'era la scusa del freddo, ma in primavera andavamo a scorrazzare per i prati alla ricerca di fiori da portare alla maestra, poi lungo i fossati a raccogliere fragole e more, allora le stagioni facevano il loro dovere, il calore lo si sentiva già alla fine di marzo e la frutta maturava presto. Ricordo ancora la scena di un giorno di prima estate, mentre si tornava da scuola: avevamo fame, vera fame… Lungo lo stradone dalla parte sinistra per chi viene da Toara, c'erano allora soltanto due abitazioni. Nell'orto di una di queste, ben recintato, c'erano alcune piante da frutto. Una era una bella pianta di albicocche ed ostentava i suoi frutti sebbene non ancora ben maturi, ma troppo invoglianti. Gli altri compagni erano a zonzo per i campi, eravamo solo in tre. Le due mie compagne, di quel momento, si chiamavano entrambe Maria, ma ognuna veniva chiamata con un nomignolo, che non voglio ripetere, non erano belli per delle bambine…. C'erano tante Marie al paese, in quel tempo: la Maria Caccia, la Maria Coccia, la Maria Gnagna, la Maria Mora, la Maria Alvezzola, la Maria Favara, la Maria Bonata e tante altre che non ricordo bene. Volevamo farcela in barba alla signora X che ci guardava sempre con compassione quando ci vedeva passare. Dovevamo scendere dalla scarpata, che era abbastanza alta. Ma chi avrebbe fatto il bottino? Alle mie com- 92 93 pagne dissi che avrei fatta la guardia, sul ciglio della strada, la coscienza mi rimordeva di grosso, non volevo “rubare”. Come se il fare la guardia non lo fosse! La rete era alta per noi, così si decise che una delle Marie, la più alta e robusta, avrebbe fatto da sgabello, mentre l'altra Maria sarebbe salita sulla sua schiena, e avrebbe staccato i frutti dalla pianta gettandoli a me, che facevo da palo sulla strada. La cosa riuscì per metà, infatti dopo aver staccato le prime albicocche, Maria si accorse che la signora X la stava guardando dalla finestra. Scorgerla e scendere precipitosamente da quello “sgabello” mobile fu un attimo. L’una, perduto l'equilibrio sotto lo scossone ricevuto dall'altra, rotolò giù per la scarpata sbucciandosi le ginocchia ed i gomiti. Risalita poi, anche lei, come già avevamo fatto noi, ci raggiunse piagnucolando, perchè l'avevamo lasciata sola a subirsi le sgridate della signora X . Quella frutta acerba, mangiata troppo in fretta, mi straziò lo stomaco ed anche la coscienza. Andai a confessarmi ritenendolo un peccato gravissimo. A scuola portando le uova… Quando nel tempo pasquale il Sacerdote passava per la benedizione delle case veniva anche alla scuola; allora, in ogni casa, si usava preparare, come offerta, un cestello di uova. Tutti a quel tempo, chi più e chi meno, possedevano delle galline. La maestra, il giorno precedente la venuta del Sacerdote, ci raccomandò di portare almeno un uovo per ciascuno. Tenere un uovo in mano per tutto il tragitto da casa a scuola era veramente difficile per noi ragazzi. Le bambine erano sempre le più attente a non romperlo, mentre i ragazzi, già a metà strada, fingendo d'essere stati urtati o adducendo altri pretesti, se lo gustavano con grande piacere. Quel giorno anch'io tenevo un mano, con infinita attenzione, il mio uovo, ricordo ancora molto bene la scena: il ciglio della strada era tutto coperto d'erba novella e tanti piccoli fiori occhieggiavano qua e là. Desideravo tanto tuffare le mani tra l'erba e raccoglierne qualcuno, ma quel benedetto uovo, per quella mattina, non mi lasciava scampo. A liberarmi da quell’ ingombro ci pensò Ludovico, un mio compagno. Il suo uovo se l'era già bevuto e continuava guardare il mio. Alla fine mi s'avvicinò, chiese se il mio fosse un uovo speciale, visto che lo tenevo con tanto riguardo. Lo guardai perplessa e aprii un po’ la mano: in quel momento, il furbo, mi diede un colpetto sul polso e l'uovo rimbalzò sull'erba incrinandosi. Rimasi mortificata e m'arrabbiai, ma Vico se l'era già preso e bevuto tutto d'un fiato, quindi pulendosi le labbra col dorso della mano, prima che io riuscissi a spiccicare una parola mi disse, fingendosi dispiaciuto: -A Don Giosuè ne portano tante di uova in questi giorni che non gli spiacerà perderne qualcuno… -poi aggiunse - volevi forse portarglielo già sbattuto per la frittata?! 94 Vico era molto birichino, ne combinava sempre di tutti i colori, ma avendo una parlantina sciolta, se la cavava in ogni situazione. Quella volta però, dalla maestra, si prese un bel castigo. 4.8. La morte dell’Orlando. Risalgono a quell’anno però anche ricordi drammatici. Ero decisamente una bambina molto caparbia e, non servivano preghiere o minacce per farmi desistere dall'alzarmi di buon mattino per la Messa, che allora veniva celebrata quando era ancora buio. L' undici marzo 1945, mattina di domenica, sul sagrato della chiesa, vidi dei gruppetti di persone con i volti atteggiati a grande mestizia, che parlavano sottovoce. Qualche donna s'asciugava furtivamente le lacrime. Vicino a casa mia, proprio sotto il poggiolo della Togna, alcuni miei parenti, uniti ad altri, parlavano di un tragico fatto accaduto ad alcuni giovani del paese. I tedeschi avevano ucciso l’Orlando Ferraro, un ragazzo di vent'anni che abitava in collina, ai Bodoli, una mini contrada formata da due famiglie. Ero troppo piccola per far domande su come si fossero svolti i fatti, sentivo frammenti di discorsi confusi, si diceva che Orlando, con alcuni compagni, avesse cercato di assaltare un camion tedesco pieno di viveri e altre cose, voleva emulare altri che, prima di lui e i suoi compagni, c'erano riusciti. Gli fu sparato alla testa, altro non seppi, ma capii lo strazio che aveva provocato quella tragedia dai volti di quelle persone. Un'angoscia terribile ci prese tutti. Augusta, la sorella di Orlando, che abitava a due passi da noi, con la famiglia, si portò sul colle a consolare la madre che, con gli altri fratelli, e la sorella Nina, piangevano il loro caro. Quel giorno un silenzio di morte gravava su tutto il paese. Essendo di domenica la gente se ne stava in casa e non usciva se non costretta da qualche necessità. I tedeschi non restituirono il morto alla famiglia e neppure diedero il permesso per il funerale, anzi, proibirono al Sacerdote di visitare la salma. Si seppe, per vie segrete, l'ora in cui i tedeschi avrebbero portato la salma al cimitero. Il sacerdote fratello del parroco, padre Vitale, si portò di nascosto sul colle da dove si poteva vedere il Cimitero. Anche la mamma ed i fratelli di Orlando, da lassù poterono seguire il tragico corteo, formato da quattro soldati che reggevano una rozza barella con il morto adagiato nella misera bara. Prima era stato portato con il carro funebre dal Cimitero di Barbarano fino all'inizio della piazza del paese. Gli abitanti di Toara da dietro le finestre chiuse accompagnavano con la preghiera e le lacrime il caro giovane. Io invece, con qualche ragazzino, mi misi, a fianco della portantina incurante delle occhiate bieche lanciate dai tedeschi. Nelle vicinanze del Cimitero alzai furtivamente gli occhi e vidi il Sacerdote che, semi nascosto dalle piante, aspergeva e tracciava nell'aria segni di croce. Vidi pure Orsola, la madre, sorretta dalla figlia Nina e dall'Ernesta la vicina di casa. 95 Arrivati al Cimitero i tedeschi deposero, quasi con rabbia, la bara sul tavolo di pietra della cella mortuaria. Mentre lo facevano mi nascosi dietro alla cella, poi, quando se ne furono andati, mi avvicinai, entrai e mi accostai al morto. Fu allora che m'accorsi dei piedi che sporgevano. Lo feci notare ai due compagni che m'avevano seguita, ma questi, alla vista della bara chiusa male e soprattutto delle punte dei piedi se la dettero a gambe lasciandomi sola. Non avevo paura, ero di casa al Cimitero. Vi andavo sovente infatti ad aiutare Gino detto “Ciavin” quando doveva scavare le fosse per i nuovi arrivati, mi affascinava quel mucchio enorme di ossa che si trovava sotto il pavimento della cella. Molte volte alzavo il sigillo per vedere quei teschi dalle occhiaie vuote, rimanevo là per lungo tempo cercando di immaginare a chi fossero appartenuti, ma siccome erano tutti uguali, salvo qualcuno di più grande o più piccolo, concludevo che, alla morte le differenze sparivano. Facevo, per conto mio s'intende, tante di quelle riflessioni da far invidia ai più austeri Frati Trappisti! Ero lì dunque, sola, a tenere un po’ di compagnia a quel ragazzo Ho ancora davanti agli occhi quelle punte di piedi, con le calze che le donne dicevano spiocinà, cioè fatte con fili di vari colori, lavorate a mano dalla mamma o dalla sorella. Volevo entrassero nella bara quei piedi e, tenendoli in mano, cercavo con tutte le mie forze, di spingerli dentro, ma erano rigidi, sembravano di ferro. Ci provai in tutti i modi, ma invano. Allora mi venne da piangere e li baciai quei piedi con le calze di rozzo cotone, li baciai a nome della sua mamma e di tutti i suoi cari poi, staccati dalla siepe dei rametti di mirto, li posi sulla bara e tra i piedi del morto. Le ombre della sera cominciavano a coprire la campagna e la collina. Salutai Orlando e me ne tornai a casa. Quella notte sognai tante file di bare, tutte allineate, tanti piedi calzati da scarpe pesanti che vi camminavano sopra, le frantumavano e queste diventavano polvere, che si perdeva pulviscolo nel sole. La vicenda di Orlando la volli scrivere anche in versi, perché lasciò nel mio cuore, assieme a tanta tristezza, anche un'immensa tenerezza. RICORDO TRAGICO Ognuno ricorderà sempre l'età dell'infanzia sua, bella, là dove fioriva l'incanto guardando una fulgida stella. Anch'io da bambina sognavo e lieta correvo tra i prati, tuffando felice le mani nei freschi ruscelli azzurrati. Ma un giorno la gioia si spense: un vento impetuoso di guerra passò distruggendo e gettando il lutto su tutta la terra. .... E vidi e conobbi l'orrore d'un tragico giorno di sangue, un dì al cimitero portaron un giovane inerte ed esangue. L'uccise la furia nemica, Orlando, colpito alla testa, cadeva all'indietro, morendo... ed era un giorno di festa. Distesa su d'una barella, più corta del corpo la cassa, né prete, né ceri, né madre, nessuno a vederlo che passa. Ma solo il nemico reggeva il giovane figlio caduto, l'immenso dolor dei suoi cari sul colle era tragico e muto. Io bimba curiosa e incurante del bieco nemico, seguivo la bara gettando ogni tanto sul morto uno sguardo furtivo. 96 97 Scendeva la sera ed allora a casa dovetti tornare, ma prima un rametto di mirto a Orlando io volli portare. Ma dietro le imposte serrate, gli occhi di tutta Toara piangevan del figlio perduto la sorte spietata ed amara. Lo misi tra i piedi del morto. -Io vado -gli dissi pian piano.... Su in cielo una stella brillava d'un oro un pò pallido e strano. Lo misero nella celletta nel mezzo del Camposanto, la cassa era corta, l'ho detto e i piedi gli uscivano intanto. E l'Ave suonò quella sera più mesta, più lugubre e pia e tutta Toara ad Orlando pensò in quell'Ave Maria. I quattro soldati tedeschi usciron impettiti e arroganti, dall'angolo ov'ero nascosta mi misi alla bara davanti. Vedendo quei piedi sporgenti volevo rimetterli a posto, premevo con forza, ma invano, tornavano lì ad ogni costo. 4.9.La liberazione. Jeep e cioccolata…. Dopo un tempo che sembrava eterno, si cominciò a parlare di “liberazione”, vedevo i volti dei miei cari più sereni, la gente usciva per le strade e le campane suonavano con maggior frequenza.... Finché arrivò il giorno della “liberazione”. Ricordo bene una lunga fila di soldati tedeschi, che camminavano sulla sommità della collina sopra Toara. Se ne andavano. Sembravano ombre cinesi stagliate sullo sfondo madreperlaceo del cielo. Poi improvvisamente, sbucata chissà da dove una Jeep di giovani soldati americani si fermò anche nella piazza del nostro paese! Ero lì con i miei compagni che, all'invito dei soldati, si precipitarono sulla macchina, i più audaci salirono sui sedili che erano stati lasciati liberi da alcuni di essi. I militari cominciarono a distribuire barrette di cioccolata. Allora ci fu uno spingere, un gridare, un chiamare veramente assordanti. Desideravo da morire un po’ di cioccolata ma, mentre nelle imprese di gruppo ero sempre pronta a collaborare, in quell'assalto alla Jeep non partecipai, ero letteralmente incantata ad osservare un giovane soldato, con un berretto rosso scuro, posato a sghimbescio sulla testa che, in piedi sulla Jeep, sorridendo, distribuiva tutta quella manna. Alla fine anch'io allungai la mano, ma il soldato, dispiaciuto, a gesti, mi fece capire che non ne aveva più. Figurarsi, gliela strappavano di mano! Rimasi lì imbambolata, a nessuno dei miei compagni venne in mente di offrirmene un pezzettino, anche piccolo come un'unghia, ed io ero troppo orgogliosa per chiedere. La cioccolata restò per un bel pezzo, uno dei miei grandi desideri. Ancora adesso quando, raramente, assaggio un po’ di cioccolato, il mio pensiero torna a quel 28 aprile del 1945 e vedo, ritto sulla Jeep quel volto sorri- Quei poveri piedi coperti da calze di rozzo cotone, stringevan il mio cuore piccino, che intanto faceva orazione. Bambina, eppure capivo che ero al posto di mamma e nel mio cuore s'accese improvvisa vivida fiamma. Chinata sul morto, le labbra posavo sui piedi induriti baciandoli adagio e piangendo pensando ai parenti là afflitti. La mamma era ancora sul colle, ed io la vedevo piccina, lontana, sorretta da mani pietose di Ernesta e di Nina. 98 99 dente col berretto rosso sulla testa, un raggio di sole e due file di gelsi dalle foglie verdi come la speranza. Assalto ai magazzini di viveri. La gente, prima della guerra, non nuotava nell’abbondanza, figurarsi con la guerra! E da noi, bene o male si mangiava… I tedeschi avevano ammassato nelle stanze del Castello di Belvedere un'ingente quantità di zaini, scarponi, contenitori di metallo ed anche generi alimentari. Alle Fornaci di Villaga avevano raccolto quintali di zucchero, marmellata, farina e altri alimenti. La notizia che i tedeschi fuggivano si diffuse in un baleno e fu tutto un accorrere verso quei magazzini con carretti a mano, carriole, asini, cavalli, buoi, uno spettacolo allegro e indescrivibile. Prima di partire i tedeschi, tentarono di incendiare il castello, ma le gente riuscì ad entrare ed a raccogliere parecchio di quel ben di Dio. Mia sorella Maria assieme a Beppino, si precipitarono alle Fornaci. Lì c'era già tanta gente che faceva man bassa di tutto ciò che era disponibile. I miei fratelli raccolsero zucchero, marmellata e quant'altro poterono, misero tutto in disparte ed andarono in prestito, dalla famiglia Dani, di un carretto e di una carriola. Vi caricarono tutta quella roba e attesero papà che, nel frattempo, aveva attaccati i buoi al carro per recarsi loro incontro alle Fornaci e portare a casa tutto. Là c'era una confusione indescrivibile, i contenitori di marmellata, sventrati, perdevano tutta quella dolcezza e la gente, urtandosi scivolava impantanandosi in mezzo alla marmellata e cadendovi sopra. Papà arrivò, ma caricò pure molti sacchi di altre persone, che non avevano mezzi per portarsi a casa tutto quel ben di Dio. La storia vera di Nani e Caterina. I tedeschi se n'erano andati lasciando dietro di sé lutti, devastazione e angoscia senza fine. I primi uomini cominciarono a tornare dalla guerra e dalla prigionia, ma Giovanni Cacciavillani, familiarmente Nani, non tornò. Ricordo: era di domenica, il Parroco portò la luttuosa notizia alla famiglia, che piombò nell’angoscia più profonda. Soffrii tanto pure io, perchè Nani era un ragazzo buono e festoso, mi prendeva sotto le ascelle e mi faceva volare in alto, giocava con me, i miei fratelli e gli altri bambini. Lui pure era quasi un bambino quando lo costrinsero ad andare in guerra. In casa Cacciavillani le sorelle, la mamma ed il fratello, finché il loro caro era in guerra, e in seguito prigioniero in Albania, dove morì, procuravano di inviargli dei pacchi con generi alimentari, indumenti e sigarette che non fumava, ma dava ai compagni in cambio di qualcosa da mangiare. La sorella Caterina, non ancora ventenne, partiva con la bicicletta per portare i pacchi a Vicenza. Lì, al ponte Degli Angeli, c’era un’associazione, che s’incaricava di spedirli. Alle volte succedeva che suonasse la sirena, allora lei, Caterina, con il suo carico, si riparava sotto qualche ponte fino all’annuncio del cessato allarme. Quel coraggio di sfidare i bombardamenti e altri pericoli, le veniva dal vivo desiderio di attenuare un po’ le sofferenze del fratello, ed era davvero commovente, una testimonianza di quell’amore che allora scaldava e riempiva i nostri focolari domestici, rendendoli magnifiche fucine di personalità forti, sane, coraggiose e costruttive. Marmellata a volontà! Anch'io volevo partecipare e presi con me la federa di un guanciale. Ricordo che, alcune donne ridevano a crepapelle vedendo che mi davo da fare nel cercare di rovesciarla e di scuoterla. Mi arrabbiai perché dicevano di non voler mocciosi tra i piedi, così me ne dovetti star lì, in piazza, ad attendere il ritorno dei familiari. Come ho detto, i tedeschi prima di andarsene avevano tentato d'incendiare il Castello, ma ciò riuscì loro solo in parte. Lo stradone per Belvedere e la strada per Villaga, erano tutto un via vai di persone e di carri. Papà arrivò. Cioccolato no, ma di marmellata ne ho mangiata a volontà. Chi avesse sparso la voce non si sa, ma passati pochi giorni cominciò un accorrere di gente che chiedeva zucchero, in cambio offriva pezzi di stoffa o altro. Zia Carolina ne dava a tutti. Per tanti anni il calzolaio fece le tomaie per scarpe e sandali con la stoffa degli zaini, che era davvero robusta ed era adoperata anche dalle donne per cucire pantaloni per i ragazzi. Doni degli americani. Alla fine della guerra, la maestra Emma, dell’Asilo d’infanzia, saputo che si potevano ottenere aiuti dagli Americani, si prodigò affinché anche a Toara arrivasse un po’ di ben di Dio. Il suo interessamento, alla fine, portò i suoi frutti e furono: latte condensato, grandi barattoli di formaggio, carne in scatola, che suscitò in tutti grande meraviglia e stupore perché mai si era vista una cosa simile, poi altre cose buone. Arrivarono anche contenitori di vestiario, che la signorina Emma sistemò nella saletta delle adunanze, in canonica. Erano vestiti, scarpe e altri indumenti che non potevano essere usati dalla nostra gente perché eccentrici e inadatti alle esigenze locali. Tuttavia, per noi bambine, quelle scarpe a spillo, quei vestiti fatti di veli e di sciffon dalle vertiginose scollature avevano il fascino dei palazzi incantati delle fate. Quando la Signorina Emma ce lo permetteva e, talvolta, anche senza il suo permesso, ci mettevamo sedute sopra quei mucchi di vestiti e, dopo averne indossato più di uno per volta, e ancora ci stavamo ben comode, pavoneggiandoci come gran dame, davamo inizio alle sfilate. Essendo però le scarpe di misura tre volte più grandi del nostro piede, con tacchi sottilissimi, appena la sfilata iniziava, rovinavamo tutte una sopra l’altra scoppiando in risate talmente squillanti da far intervenire il parroco assieme alla perpetua che, 100 101 pur tentando di fare la voce grossa, alla fine univano le loro risate, magari più contenute, alle nostre. Quei vestiti, che nessuna donna o signorina del paese volle mai indossare, servirono a meraviglia per le mascherate di carnevale. Forse in America, quando raccoglievano indumenti per spedirli in Italia, pensavano che splendesse sempre il sole e quindi non si potesse soffrire per il freddo. 4.10. Un grande premio: ripetere due volte la quinta elementare! Come già ho detto, fino alla terza elementare rimanemmo tutti a Toara, sia pure alloggiati in una famiglia, la quarta a Belvedere, mentre la quinta fu organizzata a Villaga. Intanto la guerra era finita e le scuole riaprirono anche a Toara. Ma io non potevo tornarci a scuola perché avevo terminato il ciclo elementare e le medie allora da noi non esistevano. Supplicai, piansi, domandai a destra e sinistra. Non so chi intercedette per me, ma alla fine riuscii ad avere un grande premio: mi ripresero a scuola e potei frequentare ancora una seconda volta, nonostante fossi stata promossa, la quinta elementare! Fu bellissimo! Ho un ricordo caro e grato di quell’anno di scuola. Il maestro Ivo mi aprì un orizzonte di luce e di speranza, anche se poi tutto si fermò, purtroppo, di nuovo, ed il mio desiderio di conoscere, imparare, e capire doveva essere destinato ad essere frustrato un’altra volta di più. Quanta sete avevo d’imparare, avrei divorato interi libri, se solo avessi potuto, invece proprio questo mio desiderio mi faceva apparire un po’ strana e diversa dai miei compagni. Intanto in quell’anno molta luce nuova venne in me. Il maestro Ivo sapeva valorizzare le doti di ognuno dei suoi scolaretti e ci deliziava con le sue chiare e interessanti spiegazioni. Quando le giornate erano buone ci portava in collina e lì, in mezzo al grande libro della natura, ci istruiva, con spiegazioni che ci affascinavano e lasciavano a bocca aperta. Ci svelava i segreti nascosti negli alberi, sotto terra, tra le foglie. Ci raccontava la vita degli animali del bosco, ci faceva attenti ai profumi silvestri, all’utilità delle piante, delle erbe. Le poesie, anche quelle molto lunghe, con lui non erano memorizzate solo meccanicamente, ma ce le faceva comprendere e gustare nella loro bellezza, sicché venivano da noi veramente interiorizzate. Ancora oggi ricordo a memoria i versi di G. Pascoli intitolati “In Oriente” che raccontavano la nascita di Gesù e il meditar dei pastori. Ci insegnava canti meravigliosi, che in parte ricordo ancora, come ricordo alcuni degli stornelli che fece cantare a Bonifacio nel tempo natalizio, uno è questo: CAPITOLO QUINTO I CENTO MESTIERI. ANTICHI LAVORI NEL MIO VILLAGGIO, IL SUDORE DEL PANE. 5.1. Il mugnaio. Una volta la settimana veniva il mugnaio a prendere il grano e ci riportava poi la farina: frumento per il pane, granoturco per la polenta. Di mugnai ce n'era più d'uno, venivano da Calto, in quel di Pozzolo, quel luogo era una valle molto stretta incassata tra due monti dove c'erano molti mulini. Venivano con dei grossi carretti colmi di sacchi di farina, trainati ciascuno da un mulo, e se ne tornavano carichi di grano. Erano talmente bianchi i mugnai da sembrare fantasmi avvolti in sudari. Toara dista da Pozzolo circa un chilometro, ma è quasi tutto in salita. Mi divertivo un mondo quando il mugnaio s'avviava per tornare a Pozzolo, a sua insaputa salivo sul carretto; molte volte con qualche amichetta e ci nascondevamo tra gli ultimi sacchi. All'inizio della salita quando il povero mulo cominciava ad arrancare faticosamente, il mugnaio correva dietro il carro per vedere se ci fosse qualche impedimento, ci scorgeva ed allora faceva schioccare la frusta ma, con un salto, eravamo già sparite. Ci minacciava di raccontarlo ai nostri familiari, noi facevamo spallucce. Fiore di noce, ridona al mondo inquieto la Tua Pace, Tu che sei nato per morire in Croce, fiore di noce! Era appena finita la guerra. Fare il pane: un impegno corale. Fare il pane era quasi un avvenimento, un rito complesso, che assorbiva molto impegno ed ingegno, che avveniva con una certa frequenza solo per coloro che se lo potevano permettere, ma per la maggior parte questa era una benedizione abbastanza rara! Ricordo la sera precedente gli uomini di casa prendevano la gramola e la mesa, quest'ultima era un grande recipiente di legno rettangolare, e le por- 102 103 tavano in cucina. Dall'ultima famiglia che aveva fatto il pane si andava a prendere il lievito (un grosso pezzo di pasta) e lo si poneva in un cantuccio della mesa a lievitare. Prima dell'alba veniva la Neta oppure la Milia, queste due, che erano sorelle, venivano chiamate nelle famiglie quando c'era da fare il pane. Da noi, quasi sempre, veniva la Neta. Quando arrivava metteva la farina sulla mesa e cominciava ad impastare, poi si tagliavano grossi pezzi di pasta che si mettevano sulla gramola e, mentre gli uomini tiravano su e giù i manici che facevano muovere l'asse, la Neta passava e ripassava la pasta sotto di essa perchè venisse uniformemente amalgamata. La pasta poi, veniva divisa in tanti pezzetti e consegnati a ciascun componente della famiglia e ad eventuali aiutanti, che provvedevano a modellare pagnotte in forme diverse. La pagnotte nel letto. Anch'io mi facevo dare un pezzo di pasta e mi divertivo a darle forme bizzarre e strane. Le pagnotte poi venivano messe nei nostri letti, perciò, tutti ci dovevamo alzare molto presto, per consentire alle donne di casa di cambiare le lenzuola di grossa canapa, bianche e odorose di bucato, mettervi le moneghe con gli scaldaletto, perchè il pane riposasse e potesse lievitare bene, prima di venire portato al forno. Il forno per la cottura del pane era di proprietà dello zio Augusto, un fratello di mamma. Però solo zia Enrica, sua moglie, lo gestiva. A decidere quando si sarebbe potuto fare il pane era sempre zia Enrica: si dovevano rispettare le esigenze di tutti. Noi bambini facevamo la spola tra forno e casa per sentire dalla zia se il forno fosse pronto e il pane fosse lievitato al punto giusto. Al momento appropriato le pagnotte venivano tolte dal letto, si mettevano bene allineate sulle porte che gli uomini di casa, per l'occasione toglievano dai cardini e fungevano da tavole, coperte da tovaglie immacolate, e poste sul carriolon, carriola dalle grandi proporzioni che serviva per molteplici usi. Poi via, si partiva alla volta del forno. Vicino a questo si metteva la mesa pronta per accogliere il pane appena sfornato. Noi aiutavamo zia Enrica a mettere, su una pala lunga e stretta, le pagnotte, quindi lei le inseriva nel forno. La preziosa cottura. Alla fine zia, chiudeva la minuscola porticina, fatta a mezzaluna, la sigillava con sterco di bue e lasciava così per tutto il tempo che lei credeva necessario. Dimenticavo di dire che il forno lo si scaldava con la legna di spino, perchè il pane, così, prendeva un sapore migliore. Ad un certo punto, zia, apriva il forno e prendeva una pagnotta, la spia, così chiamata perchè serviva a controllare il punto di cottura. Zia vedeva dai nostri volti quanto grande fosse il desiderio di mangiarne un po’ di quel pane - spia, ce ne dava solo un pezzettino perchè, diceva, era indigesta. A cottura avvenuta, quando veniva aperto il forno, si sprigiona104 va un buon profumo di pane e, quella deliziosa fragranza si espandeva per tutto il paese. Ognuno di noi poteva mangiare tutto il pane che voleva. Zia Carolina teneva da parte il pane che doveva essere consumato nel giro di qualche giorno. Nel frattempo il calore del forno diminuiva e così si rimetteva, con il giusto tepore, il pane che era rimasto, dopo fatta la selezione. Quel pane sarebbe rimasto ancora nel forno per parecchie ore fino a che non fosse stato biscottato al punto giusto. Lo si andava a prendere il giorno seguente con due enormi ceste, fatte appositamente, quindi, portato a casa. Lo si riponeva in un grande cassetto dell’ armadio più capiente che c'era in casa e che era tenuto sempre a disposizione proprio per questo scopo, per accogliere e conservare il pane, quasi una madia – tabernacolo domestico, per il buon pane d’ogni giorno… Tornando al pane appena sfornato, zia Enrica si prendeva quello che le era dovuto per il noleggio del forno e per il suo lavoro, quindi, caricata la mesa sopra il cariolon si tornava festanti a casa. Questo avveniva per la mia famiglia, circa una volta al mese. Purtroppo però erano poche le famiglie che si potevano permettere di fare il pane con questa frequenza. La cerimonia, però, non era ancora finita, appena a casa zia Carolina prendeva le pagnotte più belle, quelle meglio riuscite, le metteva in un grande e immacolato tovagliolo, ce le consegnava e noi le dovevamo portare al Parroco, alla Contessina e alle persone che, secondo la zia , avevano diritto alla nostra riconoscenza oppure erano bisognose. Maria e il generale…. A portare il pane alla famiglia del conte di solito era Maria, essendo la più grande la ritenevano anche la più adatta per certe commissioni. Un giorno, come al solito, andò alla villa con quel dono di Dio appena sfornato ma, nonostante avesse ripetutamente chiesto il permesso di entrare, né le cameriere e neppure qualcuno della famiglia risposero. Stava per tornarsene a casa quando si presentò il generale tedesco. Si era in tempo di guerra e, mentre i semplici soldati avevano requisito la scuola per alloggiarvi, gli ufficiali si erano accomodati a palazzo, relegando questi e i familiari nelle stanze della servitù, quest’ ultima costretta nei solai della villa. Maria dunque consegnò il pane al generale e - come poi ci raccontò - rimase imbambolata a contemplarlo, perché la sua giacca spariva sotto il cumulo di medaglie, distintivi e simili, così da sembrare un gagliardetto zeppo di insegne. Rise poi di cuore rammentando quell’ufficiale così decorato, con ai piedi un paio di babbucce da camera, di pelle color marrone, che stridevano enormemente con il resto dell'abbigliamento. Quando le sorelle Mizzon, Emilia e Anna ( Milia e Neta) nelle prime ore dopo la mezzanotte si recavano nelle famiglie per preparare la farina per impastare il pane, s'imbattevano nella ronda tedesca, non ebbero però mai nessun fastidio. 105 5.2. La lissia: il grande bucato! Due volte l'anno si faceva la lissia, ovvero il bucato grande, lo si faceva così di rado perché si aspettava ad avere cenere a sufficienza, essendo quello, allora, l'unico detersivo. Le donne, per questo lavoro, dovevano essere almeno quattro, più quelle di famiglia. La sera precedente veniva sistemata in una stanza una enorme tinozza, che noi chiamavamo il mastello grande, le donne prendevano dalla soffitta la biancheria accumulata durante quei mesi, la mettevano su delle grandi assi, quindi su delle carriole veniva portata al lavatoio per essere bagnata. Nel frattempo, nell'aia, veniva acceso il fuoco sotto un grande recipiente di metallo, chiamato, da noi, il bandòn. In questo recipiente si versava tanta cenere perchè cocesse. Sulla tinozza, nel frattempo, le donne mettevano tutta la biancheria, bene distesa. Alla fine tutto veniva coperto con un telo ampio e spesso, che era chiamato bugarolo. Era un telo tessuto appositamente per poter trattenere anche le più piccole impurità. Veniva poi versato tutto il contenuto del bandon dentro la tinozza e si lasciava in ammollo per l'intera notte. Al mattino successivo si toglieva il bugarolo, la biancheria veniva tolta dal mastello e la si poneva su delle tavole, quindi sulla carriola e si andava al lavatoio a lavare. Tutto ciò si ripeteva per due giorni seguendo la stessa procedura. Il terzo giorno si risciacquava tutto. La sera precedente si allentava la spina del grande mastello per far uscire il lisciazzo, cioè il detersivo ottenuto con la cenere, si andava a svuotare il lavatoio, che doveva essere minuziosamente lavato, perché l'acqua, in quella occasione, doveva risultare limpidissima. Strizzare le lenzuola. A me piaceva osservare le donne quando strizzavano le lenzuola che, essendo per la maggior parte di canapa, pesavano molto. Le dovevano arrotolare fino a che queste non erano ridotte a budello, più strizzavano e meno dovevano faticare quando le mettevano sulle carriole per poi portarle ad asciugare. Il compito degli uomini, quando si faceva il bucato, era quello di piantare nelle cavezzagne (le carreggiate in mezzo ai campi), dei pali e tendere le corde, dove poi veniva stesa la biancheria. Ricordo che la nostra lissia era sempre molto grande, infatti le corde tese occupavano ambedue le parti della lunga carreggiata. Noi bambini avevamo il compito di custodire la biancheria ed era per noi una gioia. Era bello correre passando in quel tunnel di così splendido candore, mentre tutto intorno era una festa di colori e di suoni. C'erano schiere di contadini, che lavoravano nei prati, nei campi, in collina e cantavano sempre. La cenere, oltre che a rendere bianchissima la tela, l'impregnava di un odore buono, che si conservava per mesi. Quando il bucato era ben asciutto, nel pomeriggio, venivano le donne, che lo piegavano meticolosamente, poi, 106 tutto veniva riposto in grandi casse di legno, senza stiratura, infatti, con quel peso, si stiravano da sé. La zia, anche se il profumo di bucato era ottimo, nelle casse ci metteva qualche mazzetto di lavanda. Il bucato settimanale. La lissia si faceva, come ho detto, un paio di volte l'anno, mentre il solito bucato lo si faceva ogni settimana. Non albeggiava ancora e già il caro lavatoio era preso d'assalto da numerose massaie, perchè ognuna sperava di lavare con l'acqua pulita. Ce n'era molta di acqua, scendeva fresca e abbondante dalla canna posta nel mezzo della parte superiore del lavatoio, quella più vicina alla strada. Una parete, a fior d'acqua, divideva il lavatoio grande da quello piccolo, in questo ultimo si lavavano i pannolini dei bambini. Era anche il ritrovo serale dei ragazzi, che si andavano a lavare i piedi, a giocare, a lanciare e spruzzarsi addosso l'acqua. Tanti bei tigli davano ombra nelle giornate estive e, il lavare, era così meno faticoso. Le cicale facevano un concerto assordante e monotono, non la smettevano mai. Misericordia, che trambusto! Anche noi bambine eravamo spesso attorno al lavatoio. Qualche ragazzo saliva sulle piante, prendeva una cicala e, per farci dispetto, ci rincorreva e ce la metteva nell'orecchio. I nostri strilli, allora, superavano di gran lunga quelli degli insetti. Tutte le massaie arrivavano al lavatoio con mastelli più o meno capienti, posti sopra ad una carriola. Come detersivo era in uso solo la cenere e il sapone. Mentre le mani strofinavano i panni con il bruschetto (spazzola rigida), strizzavano, sbattevano, le lingue si muovevano con uguale, se non con maggiore velocità. Talvolta il sapone scivolava e cadeva nel fondo del lavatoio ed allora si correva di qua e di là in cerca di un rastrello per tentare di recuperarlo. Molte volte ho contribuito anch'io a far scivolare il sapone, senza che le donne se n'accorgessero, solo per godermi l'affannoso spettacolo del suo recupero. Chiacchiere, racconti, mormorazioni, pettegolezzi si alternavano a brevi momenti di pausa. Noi bambine tendevamo l'orecchio quando, magari per la scabrosità dell'argomento, il tono della voce veniva abbassato e così la nostra curiosità si acuiva. Succedeva che, talvolta, nella foga del discorso, quando il fatto era interessante, le comari non s'accorgessero che il tempo era volato. Dal campanile, inesorabilmente, scoccavano le ore.......... mezzogiorno, misericordia che trambusto! I panni venivano riposti nella tinozza così, alla rinfusa, le carriole venivano mosse con spintoni e strattoni, come la colpa del ritardo fosse dovuta solo alla ruota cigolante o poco scorrevole. Al mattino seguente si ripeteva la stessa musica, magari con comari diverse. 107 5.3. La sabbia per lucidare. Un altro momento particolare, legato anch’esso alla fontana della Morarona, era la lucidatura dei secchi. Di sabato tutte le massaie portavano alla vaschetta (la fontana) sotto la Morarona, i secchi e gli altri utensili di rame per la lucidatura. Allora non c’erano detergenti speciali per la pulitura del rame e le donne si servivano della sabbia sottilissima che raccoglievano dai camion che transitavano di lì. A Pozzolo c’era la cava della sabbia, e ogni giorno passavano per il paese grossi camion che l’andavano a prendere. Molte volte ne perdevano, ma qualcuna se la prendeva direttamente dal rimorchio, perché gli autisti dovevano rallentare passando per il paese. La strada era unica e non ampia, perciò, le donne più svelte e intraprendenti se ne prendevano anche per le altre. Noi ragazzini ci divertivamo un mondo ad osservare tutto quell’affannarsi, quel lucidare, quel risciacquare che faceva brillare i rami che scintillavano sotto il sole, quando venivano posti sull’erba rasata della piazza. Qualche volta, per fare un piccolo scherzo a quelle brave massaie, facevamo cadere qua e là, sopra secchi, casseruole e tazze (cazze), dell’acqua sporca di terra. Allora era tutto un gridare, un rincorrere, un minacciare, ma chi l’aveva fatto?! Era festoso il sabato così, tra suoni di campane e il cicaleccio di donne e bambini. Anche i secchi di casa nostra il sabato venivano puliti e lucidati a dovere. 5.4. Prisco il ciabattino. Quando i fratelli Faccio venivano in paese per la scuola o per le funzioni religiose e il catechismo, si fermavano sovente in casa dei nonni, che erano Prisco e Carlotta, con loro abitavano le figlie nubili: Emma e Armida, delle quali ho già parlato. Le altre due figlie erano: Sira, la madre dei sette fratelli Faccio, cinque maschi e due femmine ed Elena suora della congregazione della Divina Volontà, con il nome di suor Genoveffa. Prisco faceva il ciabattino, sedeva al deschetto vicino alla finestra, indossava un grembiule di cuoio tutto dipinto di strani disegni, che erano il risultato della pulizia delle sue mani sempre piene di lucido per scarpe, di colla e di grasso. Sembrava scolpito nel legno, anche se la sua vita era sedentaria conservava l’agilità di un capriolo, e la flessuosità dei giunchi. Le sue arguzie dilettavano i clienti che, a quei tempi, erano sempre lì a farsi rabberciare le scarpe scalcagnate e, talvolta inservibili, ma che Prisco sapeva trasformare, come per magia, in qualcosa di ancora passabile. Qualche volta gli si chiedeva un paio di scarpe nuove, era un evento abbastanza raro nella vita della povera gente e quindi doveva essere iniziato con una cerimonia. Dovendo prendere le misure sia per le scarpe chiodate degli uomini che per i zopei (zoccoli per le buone occasioni) delle donne, invitava i nuovi possessori di tali calzature ad assumere una posizione particolare, adatta ad un rendimento impeccabile del lavoro, li faceva sdraiare sul pavimento, che era di terra battuta. Questa sua stravaganza però non faceva che accrescere il buon umore e mitigava la preoccupazione di quella nuova spesa. Una pace introvabile… Possedeva un campicello nonno Prisco e, di buon mattino, vi si recava spingendo l’inseparabile carriola. Attendeva che i bovari tornassero dal pascolo con i buoi, le mucche e i vitelli poi, con un badile, raccoglieva tutto lo sterco che i placidi e soddisfatti animali, senza curarsi degli umani, mollavano sulla strada, lo metteva sulla carriola e….via verso il campo, che era situato proprio di fianco al cimitero. Così concimava il suo campetto con tutto quel ben di Dio senza spendere una lira e, nello stesso tempo, aiutava nel suo lavoro il povero stradino che, allora, non si chiamava operatore ecologico. Qualcun altro, però, raccoglieva lo sterco al passaggio dei buoi e poi lo faceva essiccare e così diventava buono per il fuoco. Presentava un quadretto veramente idilliaco quella casetta di Prisco: un piccolo viottolo coperto di erba, ai lati due file di gelsi, un orticello, un minuscolo ruscelletto, una finestra sempre spalancata con quella figuretta che si stagliava nitida sullo sfondo di pareti annerite dal fumo, un focolare con il fuoco sempre acceso dove, vicino alle braci un piccolo tegame dall’indefinibile colore, pieno di pece si arroventava senza mai poter arrossire. La dolce Carlotta, che andava e veniva sempre discreta e silenziosa, il telaio di Armida sempre in moto e, tendendo l’orecchio, da lì si poteva sentire la cantilena dei bimbi del vicino asilo dove Emma insegnava, oltre alle preghiere, mille altre cose belle e interessanti per la crescita armoniosa di quei piccoli fiori ancora in boccio. Lì vicino, a due passi, la cara chiesetta. Una pace così dove la si potrà più trovare?! Una recita alla scuola materna (allora asilo infantile) Linda, prima da sinistra. 108 109 5.5. La vendemmia. Il tempo della vendemmia era per tutti una festa. Quando c'era ancora papà avevamo alcuni vigneti che producevano dell'ottima uva. Prima della vendemmia, quando i contadini tornavano dai campi, sul mezzogiorno, dovevamo noi ragazzi recarci nei vigneti a badare che qualcuno non facesse man bassa di grappoli. Purtroppo era così e, talvolta, erano proprio persone che tu non avresti mai immaginato che si andavano a riempire ceste di uva. Arrivavano come una liberazione i giorni della vendemmia. Di buon mattino papà oppure lo zio portavano il carro con il grosso tino, ceste e tinozze al limitare del vigneto, poi arrivavano tutte le persone che si era potuto reclutare. Ed era tutto un vociare, un cantare, un chiamarsi, insomma era tutta una festa. L'uva matura era presa d'assalto anche dalle vespe e da altri insetti, il mosto si appiccicava alle mani, ai fazzoletti che le donne tenevano sulla testa per non imbrattare i capelli, il suo profumo fluttuava nell'aria e si spargeva ovunque. I grandi tini, poi, venivano portati sull'aia e gli uomini, lavati i piedi e rimboccati i calzoni, pigiavano allegramente fino a ridurre l'uva tutta in poltiglia. Il liquido usciva da un foro che si trovava nel fondo del tino e si riversava nella tinozza posta lì sotto. Non ci si poteva avvicinare al mosto con altre cose commestibili che non fosse uva. Ricordo: quella volta a pigiare l'uva c'era Gaetano, il marito della mia cugina più anziana assieme ad un'altra persona. Stavo sbocconcellando un pezzo di pane. Come Gaetano mi vide mi gridò di andarmene, io, che non facevo mai ciò che mi si diceva, facendo orecchi da mercante, mi avvicinai di più e, non contenta sedetti sull'orlo della tinozza, lui mi disse ancora di scostarmi, non fece in tempo di terminare la raccomandazione che caddi all'indietro e sprofondai nel recipiente. Vennero a recuperarmi papà e zio che, forse mossi a pietà nel vedermi in quelle condizioni, tutta rossa come un gamberone appena fritto, si limitarono a consegnarmi alla zia che, poveretta, dovette ancora una volta occuparsi di me. Una sgridata, però, da lei me la presi. Avrei meritato qualcosa di più… 5.6. I bachi da seta. Un vivo ricordo che mi fa sempre gioire è quello dei bachi da seta. Quasi ogni famiglia li teneva, tutti li chiamavamo "cavalieri", non so poi perchè, infatti di "Cavaliere" non avevano proprio niente quei piccoli bruchi molli, ma forse sì, sembrava avessero dei pesi da portare perchè si muovevano dondolando la testa qua e là. A casa nostra venivano sgomberate delle stanze, si costruivano specie di impalcature e, ad una certa distanza l'una dall'altra, si stendevano le "arele", specie di stuoie fatte di canne. Sopra, le donne di casa, sparpagliavano i piccoli bachi. Si doveva poi, per le prime volte, sminuzzare le foglie di gelso per dar loro da mangiare, in seguito divoravano le foglie 110 intere. A me piaceva vedere quando abbassavano i tralicci osservare con che voracità i bachi si gettavano sulle verdi foglie che le donne spargevano dappertutto con abbondanza. Ogni tanto dovevano essere puliti attraverso apposite carte o reti. Quando le donne di casa finivano di spargere la foglia per i bachi e se ne andavano per altri impegni io rimanevo in silenzio ad ascoltare il brusio che questi producevano mentre mangiavano, era come una musica sempre uguale, ma dolce, misteriosa ed insistente, sembrava essere in Chiesa, quando il parroco cantava i salmi sempre con la stessa cantilena, ed assomigliava pure alla preghiera fatta sottovoce dalle donne quando moriva qualcuno e si andava nelle loro case a recitare il Rosario. Ero convinta che comunicassero tra loro attraverso quel sottile brusio e che esprimessero la loro gioia nell'essere immersi in tutto quel verde luccicante delle foglie di gelso. Ricordo pure che seguivo sempre la Rosa Cacciavillani quando andava a raccogliere le foglie dai gelsi. Ero spesso a casa dei Cacciavillani e Rosa, se io lo desideravo, mi portava sempre con sé. Lei era agile e svelta, saliva sui gelsi e in un batter d'occhio riempiva sacchi. A casa mia, invece, ci andavano altre persone, che venivano sempre ad aiutare la zia. Quando i bachi non mangiavano più significava che erano pronti per diventare bozzoli, allora anche noi bambini dovevamo essere disponibili nell'aiutare a trasportare, con ceste o altri recipienti: ceste, pentole scolapaste, i bachi nel granaron del Conte. Sopra le scuderie del Conte Piovene vi era un enorme solaio, detto dalla gente del paese el granaron, ovvero il granaio grande. Per bontà del Conte, chi voleva, poteva portarvi i suoi bachi che necessitavano di un luogo buio e lontano dai rumori per poter costruire in pace il loro bozzolo. Gli uomini confezionavano delle leggere fascine fascinei di legna e sopra si adagiavano i bachi, che in pochi giorni diventavano belle e gialle gallette, ossia bozzoli. Costruito il bozzolo si provvedeva a staccarlo, con delicatezza, dalle fascine. In quei giorni era tutto un vociare, un chiamarsi, un accorrere su e giù per il paese. Era insomma una festa quando si poteva tenere in mano il frutto del proprio lavoro. Nonno Gustinello aveva costruito un aggeggio per pulire i bozzoli, cioè separare la "spelaia", la seta sporca che avvolgeva il bozzolo, per poterlo così presentare al compratore nel miglior modo possibile. Era una tavola di legno con ai lati due piccole sponde forate da un buco per ciascuna e un ferro abbastanza grosso infilato in questi ultimi. Si riempiva la tavola di bozzoli, si girava il ferro ed a questi si attorcigliava la spelaia, che veniva poi utilizzata in vari momenti e per le più disparate necessità. 111 5.7. Canapa, fibre e filature. Negli anni della mia infanzia ricordo che i miei, nei loro campi, seminavano anche la canapa, che cresceva alta e diritta ed era di un verde un po’ smorto. Io me la ricordo così. Quando il papà e lo zio l'andavano a tagliare, la mettevano poi in grandi fasci a macerare nell'acqua. Veniva in seguito un uomo che la gente chiamava el chijarolo, portava con sé un aggeggio e sbatteva la canapa fino a farne delle matasse chiare. Gli scarti della canapa venivano chiamati stoppa. Sia la canapa che la stoppa venivano filate per farne lenzuola e altro. Della coltivazione della canapa e del chijarolo conservo pochi ricordi, mentre della filatura di canapa e stoppa di ricordi ne ho a bizzeffe. Mi ricordo le lunghe serate in stalla, al filò, non mi stancavo di guardare le donne che facevano prillare il fuso, ch’era una bellezza. La rocca e la joa. Quasi tutte le donne filavano: sia con la rocca, che con la joa.La rocca era un'asta di legno con alla sommità un rigonfiamento fatto di asticelle sottili, alle volte intagliate, traforate che sembravano ricami, attorno a questo rigonfiamento si avvolgeva la matassa di canapa in maniera uniforme, s'infilava l'asta su una cintura, oppure sul laccio del grembiule e....via, il fuso prillava che era un piacere. La joa pure era un'asta, soltanto che, la sua sommità, era tagliata in quattro parti, cioè venivano fatti quattro denti, abbastanza lunghi. Lì venivano infilate le scarmele di stoppa, cioè dei fagottini di scarti della canapa. Anche la stoppa era preziosa per i canovacci e per tovaglie grossolane. Quando la massaia aveva filato canapa e stoppa a sufficienza, l'avvolgeva in matassa che veniva lavata a dovere, poi si portava tutto dalla Armida, che faceva la tela. Il filò. I miei avevano una stalla con diverso bestiame e, nelle serate invernali, le persone che abitavano vicino a noi, con il permesso degli zii, venivano a filò, cioè passavano tutta la sera, fino a verso mezzanotte in quell'ambiente. Anch'io ci andavo. Noi bambini ci mettevamo nel centro, le donne che filavano o eseguivano altri lavori erano disposte a cerchio un po’ allungato, gli uomini stavano un po’ in disparte. Un giorno alla settimana le donne filavano la canapa per la zia, cioè per noi, per ripagare l'ospitalità e la luce, che era prodotta dal canfin, cioè da una lampada a petrolio, poi venne anche la luce elettrica. Ricordo la Milia, la Togna, la Bice, quest'ultima, sorella della Togna, abitava vicino alla piazza e veniva sempre con una piccola lanterna perchè, a quei tempi, la luce pubblica era ancora un sogno. La Bice non si perdeva mai una serata ed era sempre l'ultima a lasciare la stalla. M'incantavo a guardare la Milia, che faceva prillare il fuso velocemente, con la saliva bagnava la canapa che, sotto le sue agili dita diventava filo molto sottile. Era una donnetta piccina e rotondetta, il suo viso sembrava una mela rubizza, bella e buona. La Togna, con i suoi racconti e le sue arguzie c'incantava. Anche in mezzo alle difficoltà ed alle prove della vita sorrideva sempre e il suo buon umore lo trasmetteva pure ai figli, che avevano perennemente stampato sul volto il sorriso. Poi c'era la Gusta, l'ascoltavamo con interesse, ci raccontava che, quando era giovane, per prendere qualche soldino, lei e i suoi fratelli, avevano chiuso in una gabbia un tasso e, collocata su di un rudimentale carretto, facevano il giro del paese. Amalia, arguta pure lei, elencava le notizie della giornata, ma si andava sempre a finire sulle difficoltà della vita, sulla stagione e sull'andamento della guerra. Paolina veniva con le sue figlie, era sempre riservata; talvolta ci raccontava avventure successe ai suoi parenti oppure a persone del suo paese. Lei veniva dall'alto vicentino. Barbara, (per tutti, Barbari) lavorava a maglia. Il telaio dell’Armida. Armida possedeva un telaio e, di tanto in tanto, la si vedeva davanti alla sua casa ad ordire. Io la vedevo spostarsi avanti e indietro sempre con bracciate di filo che avvolgeva attorno a dei pali. Poi sistemava tutto sul telaio. M'incantavo a guardarla quando, con la navetta, passava e ripassava sulla trama. Mentre lavorava, senza staccare gli occhi dal lavoro, raccontava episodi della sacra scrittura che sapeva a memoria. Armida era pure un barometro, quando la si vedeva avvicinare alla Chiesa con l'ombrello, si era sicuri che di lì a poco sarebbe piovuto. Ed era così. Non lo faceva per lei che, con un salto era già in Chiesa, ma voleva essere utile a tutti coloro che abitavano lontano. Diseducazione sessuale… Le serate invernali erano davvero lunghe e nella stalla ci si andava presto, ma noi ragazzini ciondolavamo dal sonno e allora posavamo la testa sul grembo delle donne che continuavano a lavorare ed a parlare. Molte volte però i discorsi che facevano queste brave massaie, non erano adatti ai nostri orecchi e questo lo sapevano, perciò di quelle cose scabrose parlavano soltanto quando ci credevano profondamente addormentati. Appena mi resi conto della cosa, cercavo di non dormire, ma fingevo di esserlo. Allora cominciavano a raccontare di mariti, di nascite, di fidanzamenti, di storie poco edificanti..... Io che, come ho detto in altra parte, volevo comprendere senza chiedere spiegazioni, mi arrovellavo il cervello per capire da dove venivano i bambini, ed ero presa da grande spavento quando sentivo raccontare di parti difficili, di bambini che stentavano nel venire alla luce, di urla strazianti continuate per ore di questa 112 113 o quella donna, di uomini che non erano mai contenti e volevano sempre la moglie a loro disposizione, di figli che nascevano con troppa frequenza senza permettere alle madri di riaversi, ecc... Dentro di me si veniva a creare una tal confusione e spavento per quanto concerneva le nascite che avevo fatto il proposito di non prender marito. Quando in paese qualche ragazza si sposava e la vedevo felice, rimanevo sbalordita, pensavo non sapesse cosa l'aspettava. Mi feci a quel tempo una cultura sui rapporti coniugali e sulle nascite, ma una cultura deformata, piena di ansie, e timori drammatici. Loro, le care e buone signore, non immaginavano nemmeno che testoline curiose e bizzarre come la mia potessero registrare senza filtri critici quelle terribili lezioni di vita, le assimilassero in maniera distorta, e se ne facessero allo stesso tempo barriera per non cadere, più avanti, dalla teoria alla pratica. Le persone conversavano in mia presenza e trattavano di qualsiasi argomento incuranti di quella bimba ritenuta un po’ tonta e corta di comprendonio. Ma non era così. Parlavo poco, ma sapevo ascoltare e pensare; certe cose, troppo grandi le andavo rimuginando nella mia piccola mente. Rare volte chiedevo spiegazioni alla zia su ciò che udivo, ma mi faceva gli occhiacci e mi allungava uno scappellotto dicendo: - Non sono cose per te, vergognati! Stupita mi chiedevo perchè si arrabbiasse tanto…: ripetevo solo frasi udite da persone adulte. Alla lunga mi stancai e me ne stette zitta. La spiegazione di certi dialoghi, di certi discorsi, di certi problemi riguardanti soprattutto come avvenivano le nascite, cercavo di trovarmela da sola, anche se non potevo sapere quanto esatta fosse. 5.8. I cavatori di ghiaia e il povero Silvio Moreto. La strada che da Toara conduce a Pozzolo allora era tutta bianca di polvere. Ogni tanto s’incontravano degli uomini seduti per terra ai lati della strada, che rompevano sassi con un martello riducendoli a piccole dimensioni, poi li sistemavano a piramide e, quando questa arrivava ad una certa altezza, era pronta per la vendita. Con quel lavoro raggranellavano qualche soldo sempre urgente per la famiglia. Così, coperti di polvere, sembravano statue antiche emergenti da scavi. La collina veniva sfruttata anche per la sabbia, qua e là si vedevano delle buche profonde da dove veniva estratto questo materiale, che poi si vendeva, come la ghiaia, si scavava anche con le mani, rompendosi le unghie. Anche i ragazzini facevano questo lavoro, e non mancava il rischio di rimanere vittime di tragici incidenti. Fu così che una volta, il figlio della Luigia, uno dei Moreti, rimase intrappolato nella buca che stava scavando, e furono inutili i soccorsi. Lui morì soffocato. Come Rosso Malpelo nella novella del Verga! Ma questa era una storia vera. La povertà non conosce i confini, e non distingue tra Nord 114 e Sud. Aveva quattordici anni. Si chiamava Silvio. Sì, si lavorava come bestie da soma per una misera moneta, e rischiando anche la vita. Tornando a casa poi, quei poveri uomini non trovavano di sicuro una doccia calda pronta per una buona pulizia ristoratrice, sarebbe stato un lusso da re! 5.9. L’azienda trasporti del paese, e la Vaca Mora… Vicino alla Canonica c'era una vecchia scuderia, che in paese, veniva chiamata la stalona del prete. Allora era la sede dell’Azienda trasporto pubblico di Toara! Alcune persone del paese portavano lì i loro arnesi da lavoro, se non li potevano tenere nelle loro case. Anche i miei, ricordo, portavano il grande tino che serviva quando c'era la vendemmia. Noi ragazzi, eludendo la sorveglianza delle perpetue, ci portavamo spesso vicino alla stalona per prenderci i fichi, l'uva ed altra frutta che abbondava attorno a quella vecchia scuderia e per spiare Pio Cichellero che lì teneva il suo asino, che nel nostro dialetto chiamavamo musso. Tutte le sere, alla stessa ora, Pio, tenendo in mano un pentolino, si recava nella stalla del prete. Noi bambini pensavamo che andasse a mungere il musso, invece quel pentolino gli serviva per andare da un contadino a prendersi il latte e, approfittava di quell'uscita per andare ad accudire l'asino. Il musso di Pio, a quel tempo, fungeva da taxi per tutto il paese, escluso s'intende per la famiglia Piovene che possedeva carrozze e automobile. A Vicenza, ci si recava soltanto per necessità ed allora si chiedeva il musso di Pio, che portava i viaggiatori fino alla stazione di Ponte di Barbarano. Pio attaccava un carretto al suo musso, vi sistemava sopra, secondo il numero delle persone da trasportare, delle assi o delle piccole panche e via..... alla stazione! Lì si aspettava l'arrivo della Vaca Mora, cioè del treno che, dopo numerose fermate, finalmente portava i viaggiatori a Vicenza. Le persone che non potevano permettersi il lusso di quel taxi si recavano a piedi fino alla stazione per prendere il treno. Da Toara a Ponte di Barbarano sono sette chilometri. Allora non era necessario che i medici consigliassero oppure imponessero lunghe camminate, se ne facevano così tante! Forse per quello si era tutti agili, snelli e.....sottopeso. Anch'io qualche volta sono stata a Vicenza con il taxi di Pio. Di solito si partiva molto presto, quando le prime luci dell'alba appena si annunciavano. La gioia immensa che provavo nel sedere su quelle assi traballanti era indescrivibile. Ma quale principessa! Una regina seduta sul trono mi sentivo! Dal mio seggio guardavo i contadini che a quell'ora, a gruppi, si affrettavano a raggiungere i campi, li guardavo e mi sbracciavo nel salutarli, volevo comunicare a tutti la mia gioia...... Quando Pio faceva schioccare il frustino e il musso correva un po’ più forte, con il visetto proteso alla brezza mattutina socchiudevo gli occhi per gustarne la carezza e odorare il profumo dell'erba e dei fiori provenienti dai 115 campi che l'aria portava qua e là. La bellezza della verde campagna, il cielo azzurro, il lieto fruscio di ali e il festoso cicaleccio degli uccelli, i fiori che ricamavano i bordi della strada contribuivano a rendermi ancor più felice. 5.10. L’allevamento degli animali. In quei tempi, almeno qui da noi, in macelleria si andava raramente, ogni famiglia s'industriava come poteva per avere un po’ di carne, quasi tutti allevavano il maiale, galline, polli, conigli, anatre, oche e piccioni. Alcuni possedevano un piccolo gregge, che portavano al pascolo sulla collina. Ricordo d'essermi recata più volte con i miei amici quando, appena tornati da scuola e dopo aver mangiato un boccone, portavano al pascolo il piccolo gregge. Si vedevano allora le pecorelle e qualche capretta, a gruppetti, ferme su magri ciuffi d'erba. Allora le colline e i boschi erano sempre ben rasati e puliti. Erano loro, sempre alla ricerca di cibo che scarseggiava anche in estate, che li tenevano in ordine. Erano quadretti deliziosi, idilliaci. A me piaceva correre di qua e di là ad accarezzare il vello caldo delle pecorelle, a sedermi vicino alle nonne che, mentre custodivano il gregge, sferruzzavano. Ora ero con Milia, ora con Rosa, poi con Annetta e, pure, con i miei compagni. Quando facevano il formaggio, in casa della Rosa Cacciavillani, immancabilmente mi ci trovavo pure io, con me c'era sempre anche mio fratello Giuseppe, che beveva non so quante tazze di scolo, cioè di quel liquido che rimaneva dopo aver scolato il formaggio. Mio fratello era ghiottissimo di quella bevanda, che certamente non noceva alla salute, visto che tutto il buono era nel formaggio. Gli poteva far fare soltanto pipì in abbondanza. L’uccisione del maiale. Quando cominciava il grande freddo s' iniziava ad uccidere i maiali. Per me era una vera tragedia. Nell'aia, gli uomini di casa, preparavano un enorme calderone pieno d'acqua, sotto vi accendevano un grande fuoco, nel mezzo dell'aia mettevano il mesotto, recipiente in legno abbastanza capiente per contenere un maiale che poteva arrivare al peso di un quintale e mezzo o un quintale e ottanta. Arrivava il norcino che, aiutato dai proprietari del maiale, si recava al porcile per prelevare il povero animale, che sembrava capire perchè opponeva fiera resistenza emettendo delle grida acute e continue. Per mia disperazione quelle uccisioni venivano compiute sempre di mattina, quando mi dovevo recare a scuola ed era per me una vera tortura. Un'angoscia terribile mi prendeva, mi sentivo agghiacciare dallo spavento, provavo una pena indescrivibile. Anche se mi turavo con forza gli orecchi, quel suono mi lacerava. Se potevo mi andavo a nascondere in un luogo ben chiuso e mettevo la testa sotto un cuscino. Ucciso il maiale gli si buttavano addosso secchi di acqua bollente e, con dei coltelli, gli uomini lo rasavano per bene. Il pelo che cadeva per terra insieme all'acqua veniva raccolto dalle donne di casa, le quali lo vendevano allo straccivendolo che, in quella stagione, comperava anche le setole di porco, queste servivano per la creazione di spazzole. Il maiale veniva poi portato in casa, appeso alle travi del soffitto e tagliato, verticalmente, a metà. A me procurava sempre sgomento vedere il maiale tagliato e quando per necessità gli dovevo passare vicino, chiudevo gli occhi. Ricordo molto bene quella volta che zia Carolina mi mandò a prendere, nell'altra casa, quella che abitavamo quando c'era mamma, un cestello di patate, ma lì, appeso nell'atrio c'era il maiale; chiusi gli occhi andando proprio ad infilargli la testa fra le due metà, con mio raccapriccio e conseguente svenimento. Due giorni rimaneva appeso alle travi perchè s'asciugasse, poi, la sera precedente la sua lavorazione veniva staccato e posto su tavole, quindi tagliato e preparato per essere, il giorno seguente, ridotto in salami, musetti, salsicce, braciole e altro. Sul focolare di casa c'erano sempre pronte delle belle braci con sopra una graticola, lì venivano adagiate delle braciole e delle costicine che mandavano un odore molto invitante. Si abbrustoliva poi la polenta e si faceva colazione. Tutti mangiavano volentieri. Io mi limitavo a guardare. Provavo un po’ di ribrezzo e avevo sotto il naso sempre l'odore del sangue. Alla fine il povero maiale esisteva solo a pezzetti. La sera di quel giorno si faceva una grande cena dove, oltre coloro che avevano lavorato, si invitavano altre persone che potevano essere parenti, amici o conoscenti. Per l'occasione zia Carolina copriva la lunga tavola con bianche tovaglie di fiandra e toglieva dal suo isolamento il servizio buono di piatti della nonna. 116 117 Quando vedevo arrivare la Vaca Mora mi prendeva una viva emozione, quel treno che arrivava fischiando e strepitando i suoi ciuff - ciuff mi faceva soggezione, a me sembrava un mostro sacro. Guardavo quelle piccole ruote che se ne stavano come incollate su quelle strisce sottili di ferro, mi chiedevo come potessero reggere tutti quei vagoni senza cadere...... Quante domande mi ponevo! Ma quando il treno, dopo che i viaggiatori erano tutti saliti, ripartiva tra lo sbuffar della macchina, allora nessuno mi poteva staccare dal finestrino. Qualcuno voleva che tutti i finestrini fossero ben chiusi, qualche altro reclamava che ne voleva di aperti e così c'era sempre un vociare ora pacato ora assordante. Lo sporgersi dal finestrino voleva dire tuffare il capo nella caligine e, quando lo si ritraeva il viso sembrava quello d'uno spazzacamino. Ricordo che in un viaggio zia mi aveva fatto indossare un vestitino bianco ma, a causa del mio voler mettere sempre il naso fuori del finestrino, la mia bella vestina, all'arrivo a Vicenza, era tutta color fumo. La causa di quel cambio di colore era la motrice della Vaca Mora, che andava a carbone. L’anitra. Altra causa di grande sofferenza per me, oltre che l'uccisione del maiale, era quando zia (incocconava) l'anitra. Mi spiego: c'era la consuetudine di mangiare l'anitra in brodo per la festa del Rosario. Zia, qualche settimana prima, prendeva l'anitra più bella grossa, la teneva stretta ad un tavolo e, con una mano le teneva spalancato il becco e con l'altra le ficcava in gola una grande quantità di cibo, poi, pian piano, prendeva la testa della poveretta e faceva scorrere la mano lungo il collo prima che questa si strozzasse per aiutarla a mandare il cibo nello stomaco, ripetendo più volte l'operazione. Assistevo a questo, che a me sembrava delitto, trattenendo il fiato. Dentro bollivo d'indignazione, ma a poco valevano le mie proteste. Mi si diceva che ero una stupidella, che non capivo niente ed aggiungevano che, in quel modo, le anatre ingrassavano velocemente e diventavano anche più buone. A me ripugnava il solo pensiero che dopo aver subito una tortura così spaventosa finissero poi in pentola. Non ci capivo nulla! Ai miei occhi tutti coloro che uccidevano gli animali erano degli assassini. Sono sempre stata troppo sensibile. Se vedevo maltrattare anche il più piccolo insetto mi veniva da piangere, se vedevo abbattere un albero mi si stringeva il cuore, se poi mi capitava di vedere un vecchio con le lacrime agli occhi la mia sofferenza era intollerabile. Ero insomma una frana. 5.11. Frutta e verdura da el Montàn. In casa ogni famiglia cercava di arrangiarsi il più possibile, ma non mancava la possibilità di qualche approvvigionamento, ad esempio in paese, ogni settimana, capitava el Montàn; un ometto piccolino, con un’espressione buffa dipinta sul viso e due occhietti piccoli e furbi, che ti squadravano dalla testa ai piedi prima di intavolare una conversazione. A noi bambini piacevano tanto i suoi occhi, specialmente quando li strizzava. Veniva sempre di pomeriggio, sembrava un pappagallo appollaiato sul trespolo quando, tutto sudato, arrancava sulla vecchia bicicletta. Davanti, attaccata al manubrio, teneva una cassetta di legno colma di frutta secca o fresca a seconda della stagione e un po’ di verdura. In prossimità del paese si sgolava a gridare: - Lllimonii, straccaganassee, carroobole, puumi bei, pometti lazzaroni…! e tutto il resto. D’estate, quando si appoggiava all’ombra di qualche muro, gli tenevamo compagnia. Sapeva l’ometto che noi eravamo senza una palanca, perciò, con la maestà di un Re che distribuisce i suoi doni, toglieva di tanto in tanto qualche frutto vizzo, che non avrebbe venduto e ce lo porgeva sorridendo con gli occhi. D’estate di frutta se ne poteva avere, ma d’inverno era una rarità. Che squisitezze! Caro Montàn, almeno hai fatto sognare dei bambini, che ti vedevano come un buon mago mentre gustavano la frutta che regalavi loro. Sei immortalato nella mia mente e, finché vivrò sentirò in bocca il gusto dei pometti lazzaroni e la dolcezza un po’ acre delle straccaganasse. 118 5.12. Anche i preti mangiano? A una cena i miei invitarono anche il Parroco e fu proprio quella sera che feci una sensazionale scoperta. Bisogna sapere che sia a Catechismo che in famiglia, la figura del sacerdote veniva presentata in modo angelico, paragonabile alle statue di angeli e santi nelle chiese. Fino allora non avevo mai fatto domande, accettavo tutto ciò che mi si diceva senza discutere, perché dei sacerdoti, nei miei ambienti, tutti parlavano con rispetto. Ero dunque convinta che ad essi venissero risparmiate le funzioni fisiologiche dei comuni mortali. Erano o non erano come gli angeli?! Quella sera vedendo il parroco che mangiava con appetito ciò che zia Carolina gli metteva davanti rimasi esterrefatta. M'incantai a guardarlo tanto che lo zio, imbarazzato per quel mio atteggiamento, mi prese per un braccio e m'allontanò dalla stanza. Zia in quel momento era molto indaffarata e non s'accorse di nulla, quando però ebbe un po’ di respiro, vedendomi accigliata e pensierosa me ne chiese il motivo. Le risposi con una domanda: - Dimmi zia, ma anche i preti mangiano? - Certo rispose la zia e continuò -credevi che campassero d'aria? -Ma allora - obiettai - se mangiano dovranno poi andare ai servizi pure loro! Zia mi guardò come mi vedesse per la prima volta, fece un sorriso che sembrava una smorfia. Mi spiegò che erano come tutte le altre persone, cioè uomini, ma che avevano una grande dignità perché ministri di Dio, ma come uomini, avevano gli stessi bisogni, gli stessi limiti, le stesse necessità di tutti. Rimasi folgorata e da quel giorno, quando vedevo il mio parroco, mi veniva da pensare ai suoi bisogni fisiologici....... 5.13. La ghiacciaia e altre meraviglie. Per la conservazione delle carni si doveva ricorrere alla ghiacciaia, allora il frigorifero non c'era. D'inverno, gli operai del Conte Alessandro, prendevano i carri e si portavano lungo i fossati che allora erano sempre ghiacciati, ne toglievano un bel po’ adoperando il piccone perché era molto spesso e lo portavano dietro la villa dove c'era la ghiacciaia facendolo scivolare lungo una scanalatura fino all’interno della stanza ricavata nel monte. Lì, tutte le persone del paese che lo desideravano, portavano i loro cartocci di carne. Ricordo che, zia Carolina, dopo la prima messa della domenica, mi mandava dalla Catina, la cuoca della Contessina Amalia, per prelevare un involto di carne. Catina era sempre disponibile e gentile, mi portava dietro il palazzo e mi faceva entrare in quella stanza fredda perchè, tra i tanti cartocci, trovassi il mio. Zia Carolina mi spiegava bene di che si trattava, ma una domenica, ricordo, portai a casa l'involto di un'altra famiglia, con sgomento della zia che si premurò di correre a riportare ciò che non ci apparteneva. 119 La Catina, o Caterina, l'ho sempre veduta là, nella casa della Contessina, lei era la cuoca mentre Ines era la cameriera. A me piaceva molto quando al sabato, la maestra Emma, mi mandava con altre bambine a chiedere fiori per adornare gli altari della chiesa. Catina ci accoglieva sempre con esclamazioni gioiose, Ines ci portava nei giardini e, talvolta, lungo il viale del frutteto dove, pure lì, c'erano dei fiori. Molte volte ci permetteva di raccogliere della bella frutta che cadeva tra l'erba. Per noi era una gioia poter gustare le grosse pere, le mele, l'uva e tante altre dolcezze. Per accedere alla villa della Contessina dovevamo percorrere tutto il porticato delle scuderie, una lunga fila di colonne sosteneva il portico, a destra c’era la stella, cioè il giardino fatto come una grande stella dove il giardiniere, con arte, piantava i fiori in modo che la grande stella, con nel mezzo una piccola fontana zampillante emergesse in tutta la sua bellezza. CAPITOLO SESTO NEI MESI ESTIVI. CRESCEVAMO NELLO SPLENDORE DEL CREATO. 6.1. Liberi dalla scuola. Da Giugno ad Ottobre si era sempre liberi dalla scuola e certo non si andava in villeggiatura, almeno da noi. Disponendo di tanto tempo libero, noi bambini e ragazzi, lo trascorrevamo tra la piazza, i campi e le colline. A quel tempo i campi erano tutti divisi da fossati e questi circondati da gelsi ( morari) e salici (stroppari) in grande quantità, i primi per i bachi da seta, i secondi per le stroppe, o giunchi flessibili che i contadini nei giorni invernali, quando non potevano recarsi nei campi, pulivano e preparavano per legare le fascine di legna e costruire ceste per le varie necessità. Nella località detta Piscina, c'era un fossato un po’ più largo degli altri, l'acqua, abbondante, arrivava quasi a livello del campo. Ricordo che papà, molte volte, lì pescava con la rete. Nei mesi estivi chi mi poteva costringere a rimanere in casa? Soltanto la febbre, che sovente mi prendeva. Nei lunghi silenzi dei caldi e afosi meriggi, con alcuni compagni, mi portavo nei campi e lì, sulle rive dei fossati, catturavo le colorate libellule, con del refe legavo loro la codina poi, allentato il filo, correvo mentre le libellule si alzavano verso il cielo e il sole faceva brillare i colori iridescenti delle loro ali trasformandoli in manciate di bellissimi gioielli appesi a raggi di luce poi, stanca di correre, con precauzione le scioglievo e le lasciavo andare. Talvolta accadeva di incontrare, tra la folta vegetazione che cresceva lungo i fossi, qualche serpente arrotolato o allungato tra l'erba, quando per prima lo scorgevo io diventavo un blocco di ghiaccio, tremavo terrorizzata, ma non riuscivo a 120 121 spiccicar parola. Avevo un tal ribrezzo per i rettili da sentirmi morire quando m'imbattevo in qualcuno. Se invece erano i miei compagni a scorgerli per primi, si mettevano a strillare e tutti fuggivamo impauriti. Fortunatamente mio fratello non si univa mai alle nostre scorribande pomeridiane altrimenti me ne sarei astenuta io. Lui i serpenti li catturava, se li avvolgeva attorno alle braccia e poi, se arrivava vicino a qualche malcapitato, glieli gettava addosso. Prendeva ramarri e serpenti con la stessa gioia con cui io raccoglievo i fiori. Una volta aveva preso un grosso serpente e, mentre il postino consegnava una lettera ad una signora, glielo ficcò nella borsa sistemandolo per bene sotto la posta. Povero postino! Poco mancò lo cogliesse un malore fatale quando, riaprendo la borsa per estrarre alcune lettere il serpente gli si attorcigliò attorno al braccio. 6.2. La casetta rossa e altre mete. Fra le nostre mete abituali c’erano: la casetta rossa e i Bodoli. La casetta rossa, situata davanti all’Uliveto sulla collina, era un luogo pieno di fascino e di mistero, e non solo per me, abituata alle fantasticherie suscitate da letture di fiabe, leggende e racconti epici. Talvolta desideravo recarmi colà da sola per poter pensare a mio agio. I miei compagni non gradivano le mie riflessioni sulla natura, mi dicevano che li stancavo con le mie osservazioni e mi piantavano in asso quando mi succedeva di rimanere imbambolata a fissare un cespuglio, oppure a contemplare un fiore perciò, spesso, munita di bastone, in primavera e in estate, per paura d’imbattermi in qualche serpe, m’incamminavo baldanzosa per il viottolo che conduceva alla casetta e che aveva inizio da dietro la casa di Achille l’ortolano di famiglia Piovene (Cà dell’Ortolàn), passava per la Boschetta e terminava nel piccolo cortile della casa. Allora nella casetta rossa abitava il camparo con la sua famiglia. Costui era una persona incaricata dai conti a guardare i campi sottostanti. Dal cortile della casetta rossa infatti si domina tutta la campagna, e il lungo stradone che conduce alla strada provinciale. Con il cannocchiale, si poteva benissimo vedere ciò che succedeva tra le coltivazioni, se in qualche modo qualcuno avesse recato danno con ruberie o altro. A me sarebbe piaciuto abitare lassù per sentire di notte il vento frusciare tra gli ulivi e, quando c’era la luna, ammirare l’argenteo colore delle foglie rese brillanti dal suo chiarore. Vedevo davanti alla casetta gli alti cipressi che svettavano al cielo, rimanevo incantata a contemplarli, sembravano una lunga infinita preghiera costantemente rivolta a Dio. Nel terreno erboso di cui era ricco l’uliveto che proteggeva da ogni parte quella magica casetta, crescevano minuscoli fiori di tante varietà e dai colori stupendi. Indugio contemplativo. Alle volte mi sedevo tra l’erba ad osservare i fiorellini più piccoli, ad ammirare i 122 petali minuscoli e ben accomodati attorno al calice, m’inginocchiavo per toccare quasi con gli occhi le seriche piccole foglie e il velluto dei petali. Avevo timore di far loro del male e mi rammaricavo quando dovevo camminare tra l’erba dei viottoli dove la flora abbondava. Altre volte indugiavo ad osservare le radici sporgenti degli ulivi vetusti, quelle radici contorte e stanche come le braccia e le gambe degli anziani che sudavano e si sfinivano nei campi, le accarezzavo quelle umili radici pensando alla pazienza, alla tenacia del loro succhiare il nutrimento dal terreno alle volte scabroso. Pensavo all’olio profumato e nutriente dei loro frutti ed il mio piccolo cuore commosso, s’elevava a Dio. Poi, di corsa, saltando come una capretta, ritornavo godendo dei soavi effluvi che fiori, erba, cespugli e alberi spargevano nell’aria refrigerante della sera, che s’avvicinava a rapidi passi. Certo allora, piccola fanciulla, non avrei potuto mai immaginare che in quel luogo speciale sarei tornata ancora tante e tante volte, nella mia terza età, per frequentare alcuni frati eremiti francescani che l’avevano trasformata, all’inizio del 1980, in un eremo silenzioso, colmo di preghiere, di benedizione e contemplazione. Corse e ruzzoloni dai Bodoli. Anche i Bodoli era una meta delle scorribande mie e dei miei coetanei, sul dorso della collina non c’erano alberi, ma qualche cespuglio e tanta verde erbetta. Il bosco era nell’altro versante. Una vegetazione che andava via via infittendo, cominciava appena sotto il dorso del colle. Giù infondo in una stretta valle piena di voci, di fruscii d’ali, di festosi cicalecci di creature alate, di squittii, di dolci melodie scorreva, serpeggiando tra l’erbe, un rivolo d’acqua che partiva dalla fontana delle Tarche . Quel piccolo ruscello, scendendo a valle, specchiava il cielo azzurro, i peschi in fiore, l’ erba delle prode e quando incontrava qualche dislivello nel terreno un po’ sassoso spruzzava tutto intorno le sue gocce d’acqua che ricadevano sul tappeto erboso come splendidi diamanti. Per i giuochi si rimaneva lassù sopra la collina. Quante capriole, quante corse, quanti ruzzoloni giù per i declivi erbosi, tra lo splendor del sole e il sorriso della natura. Risate, richiami, trilli di gioia, che si univano ai gorgheggi degli uccelli, ai belati delle capre e delle pecore dell’Ernesta e dell’Orsola. L’intenso profumo del fieno appena tagliato, unito a quello del timo, di menta, di cedrina, di madreselva, ci avvolgeva e ci rendeva lieti e festosi. In quell’ incanto si dimenticavano i rimbrotti, le facce meste dei nostri cari, la mancanza di tante altre cose e, per tanti miei compagni, l’incubo dei compiti assegnati per casa dalla maestra. Dai Bodoli io poi ci tornavo quasi ogni sera, perché Agnese, mia amica, si recava a prendere il latte da nonna Orsola. La casa dei Bodoli ospitava due famiglie: quella dell’Orsola con i figli e quella dell’Ernesta, con mamma Lucia, papà Angelo e i fratelli. 123 Gli zii di Agnese. Al limitare dell’aia e dietro la casa, enormi alberi di spaccapietre, piene di minuscole bacche scure, da noi chiamate “fransigoli” che, appena mature, mangiavamo, anche se erano per tre quarti nocciolo, proiettavano la loro ombra e rendevano frescura nei caldi meriggi estivi. Arrivavamo sempre quando i greggi e le mucche tornavano all’ovile e gli altri animali: galline, anatre, oche dopo l’ultima beccata tra i sassi dell’aia, si disponevano nei luoghi loro assegnati. Davanti alla casa le piante di melograno, con i loro fiori rossi prima e poi con gli splendidi frutti, rallegravano la vista e facevano gioire il cuore. Quando gli zii di Agnese, finito di mungere, le riempivano di latte il pentolino, raccomandandole che non lo facesse oscillare per via del latte che avrebbe potuto uscire, incamminandoci giù per il colle spingevamo lo sguardo lontano da dove saliva il suono delle campane dei paesi sparsi nella pianura, il suono dell’Ave che, anche a noi, seppure bambine, inondava il cuore di dolcezza e ci riempiva di nostalgia. Una volta sentii il bisogno di esprimere la gioia di tutti questi momenti di libertà che la natura meravigliosa in cui crescevamo ci donava con questa poesia: CORREVO Correvo come piccola cerbiatta, salivo sulle rocce a piedi nudi, il sole mi baciava e il vento scompigliava i miei capelli cospargendoli di petali rosati. Nel cielo azzurro sostavano i bei cirri bianchi come fiocchi di bambagia, ed io cantavo e il canto mio riempiva il colle, la valle e la campagna. Ero regina del bosco e delle rocce, ero padrona dei viottoli e dei sassi, ero la bimba selvaggia e solitaria, che gioia e amore trovava sol lassù. A braccia aperte lodavo il mio Signore, perché mi regalava la Sua luce. Attorno a me cantavano gli uccelli e volavano gioconde le farfalle. Profumo di timo e di cedrina, di madreselva, di muschio e di vitalba giungevano ad ondate ed io esultavo. 124 6.3. La Sguizzara. Noi bambini ci recavamo spesso alla località detta Piscina per giocare, attratti dal fascino dello specchio d’acqua del fossato. C'è stato un periodo che c'eravamo ogni giorno per assistere ad una specie di rito. In paese c'era una donnetta molto minuta, si chiamava Maria, ma tutti la conoscevamo per la Sguizzara, il perché di questo nomignolo proprio non lo so, i grandi non ce l'hanno mai detto e noi bambini credevamo venisse dalla Svizzera, tanto quel nome assomigliava a quello della Nazione Elvetica. Le sue vesti nere toccavano le punte dei zopei, calzature nere, lisce e chiuse solo sul dorso dei piedi, tutti di cuoio, che venivano calzati solitamente per andare in chiesa o al mercato..... A me sembrava una formica con quel corpino sottile, le gonne ampie e tutte arricciate, i radi capelli raccolti a crocchia sulla sommità del capo e fermati da un lungo e vistoso spillone, i piedini saltellanti, il visetto rotondo e abbastanza liscio come una prugna che cominciava appena ad avvizzire. Sotto il braccio l'inseparabile ombrello che teneva, però, sempre chiuso. Quando la sentivamo arrivare ci nascondevamo sotto i gelsi, i salici, dietro alle siepi, che abbondavano in quel luogo. Lei deponeva, con cura, sull'erba l'ombrello, si avvicinava allo specchio d'acqua e..... cominciava il rito. Divaricava un po’ le gambe, si lisciava i capelli, si guardava le mani, accomodava le pieghe della gonna ed infine cominciava , quasi furtivamente a protendere il busto verso l'acqua sempre recitando la stessa cantilena: -Mi annego, mi voglio annegare, sicuro, io mi voglio annegare, mi annegherò…. ma quando vedeva il suo tondo visetto riflesso su quello specchio, un po’ deformato per qualche movimento dello scorrer dell'acqua, gettava un gridolino e si ritraeva indietro con un piccolo saltello, poi riprendeva, adagio, adagio, ad allungare il collo ripetendo la stessa filastrocca finché, guardando l'acqua come fosse una nemica le gridava, minacciandola con il movimento agitato del braccio : -Mi annegherò, vedrai, sì lo vedrai, domani verrò e mi annegherò… Quando la Sguizzara arrivava, uno di noi, a turno, correva a chiamare la figlia, che abitava con lei vicino alla chiesa, dall'altra parte del paese, e questa poverina, tutta agitata e ansante, arrivava giusto in tempo per vedere sua madre mentre minacciava lo specchio d'acqua a cerimonia conclusa. Prendeva allora la donnina sottobraccio e, lentamente, se ne tornavano a casa. Prima però ci ringraziava. A me faceva molta pena vedere l'angoscia della figlia e mi dispiaceva notare che, molti miei compagni ridevano a crepapelle, mentre assistevano a quella, diciamo, rappresentazione. La donnina era molto furba nell'eludere la sorveglianza della figlia: gliela faceva ogni volta, nonostante gli accorgimenti da lei addottati per impedire che questa s'allontanasse. Ma un giorno la vecchietta non si mosse più da casa. S'addormentò per sempre, forse sognando il suo piccolo viso dai grandi 125 occhi spaventati, riflesso sull'acqua di quel fossato. A me dispiacque, era una piccola graziosa figura, faceva parte del grande presepe vivente che era allora mio piccolo paese. 6.4. Giochi di fanciulli. Mia madre era l'ultima di tredici fratelli, qualche figlio dei figli degli zii era quasi mio coetaneo. Con uno di questi -cugino in secondo grado- mi recavo spesso nei campi a zonzo o ad eseguire qualche incarico datoci dagli adulti. Aldo aveva anche il compito di portare al pascolo gli animali, lavoro riservato ai ragazzini o a qualche nonna. Luoghi dei nostri divertimenti, come ho detto sopra, erano le colline, i campi oppure la piazza del paese. Anche quel giorno, dunque, Aldo portò i suoi animali in campagna, eravamo una bella squadretta: si giocava a “ciupa - scondare” (nascondino), a “sassetti”, questo gioco, anche se tutti lo sapevano giocare, era adatto più per le bambine che per i maschi. Dovevamo procurarci cinque sassi, rotondi il più possibile e un po’ più grandi di una biglia di vetro di quelle normali. Si lanciavano per terra tutti e cinque, ma molto vicini, quindi se ne doveva raccogliere uno facendo attenzione di non sfiorare gli altri, che via via dovevano venire raccolti con la stessa mano e tenendo quelli già presi, sempre facendo attenzione a non toccarne nessuno, pena la perdita della partita. Se ne potevano raccogliere più d’uno per volta, anche tutti, ma ciò accadeva piuttosto raramente. Era molto difficile portare a termine in bellezza tale gioco, ma era tanto il tempo che impiegavamo ad esercitarci che, alla fine, eravamo tutti campioni. Giocavamo pure a palla, che era fatta dalle nostre sorelle, zie, nonne, mamme…., palle di stoffa, piene di stracci che non rimbalzavano certo come quelle di gomma, ma servivano ugualmente perché le gettavamo addosso ai muri delle case facendole passare sotto il ponte, cioè sotto una gamba, oppure prendendole al volo con le braccia incrociate. Si faceva anche un po’ di sosta sdraiati sull'erba mentre gli animali pascolavano tranquilli e ci raccontavamo storie fantastiche o di spiriti, quelle storie che erano il passatempo preferito nei filò. Aldo era un po’ preoccupato perchè, quella sera, si sarebbe dovuto recare dal barbiere per il taglio dei capelli, quindi non avrebbe potuto unirsi al gruppo per il gioco serale, in piazza. te sulla proda del campo ed io cominciai a tagliare. I compagni ci stavano a guardare ed io tagliavo, tagliavo..... Ad un certo punto m'accorsi che il lavoro non era proprio perfetto e che, su quella testa le scale erano troppe, allora lo rapai del tutto. Guardai l'opera mia e vidi che era proprio un disastro. Aldo si toccava la povera testa in continuazione, io non fiatavo. Gli altri distoglievano lo sguardo dal povero ragazzo, che sembrava un cane bastonato. A sera tornammo a casa con gli animali. Lungo la strada incontrammo Amedeo, il papà di Aldo che, vedendo il figlio rimase senza parola, il suo sguardo correva dal ragazzo a me e.... capì. Anch'io lessi quello sguardo e, velocemente, me la detti a gambe levate. Mio cugino Amedeo era molto buono, non venne dai miei a recriminare ma, per lungo tempo, quando m'incontrava, mi fissava in modo severo come a dire: -Sei proprio una peste! Per parecchio tempo cercai di evitare d’incontrarmi con Vittoria, la madre di Aldo. Allora sì sarebbero stati dolori…….. Aldo dal barbiere. Chissà perchè, ma nelle mie tasche c'era sempre ciò che occorreva: forbici, aghi, refe, spaghi....... Ero come il fabbro che si porta appresso i ferri del mestiere. Proposi ad Aldo di mettergliela a posto io la sua testa facendogli da barbiere, così quella sera sarebbe stato libero. Lui mi guardò alquanto perplesso e dapprima non ne volle sapere, ma fui talmente persuasiva che, alla fine capitolò. Non avevo mai tagliato capelli, però pensavo fosse una bazzecola e mi sentivo sicura. Aldo sedet- La bicicletta. A casa mia c'era una bicicletta da donna, ma guai chi la toccava! Solo i grandi la potevano adoperare, ed era sempre sotto chiave. Un giorno mi recai a far visita ad una cugina di mio papà, che faceva la maestra d'asilo in quel di Belvedere. Allora le maestre d'asilo erano tali anche senza diploma, ed il regolamento, i programmi erano facoltativi. Questa cugina possedeva una bicicletta, quando mi recavo da lei me la faceva provare, m'insegnava a stare dritta sui pedali ed a pedalare veloce. Mi dava la bicicletta a patto che l'andassi a trovare spesso, non so poi perché. I miei non sospettavano nemmeno che io sapessi usare questo veicolo. In paese coloro che possedevano la bicicletta si potevano contare sulle dita di una mano. Quel giorno era stata appena adoperata dallo zio, che non si premurò di metterla, come al solito, sotto chiave. Vederla lì, tutta sola, che sembrava invitarmi, non le volli fare torto. Data attorno un'occhiata e veduta sgombera la via l'inforcai e....... via di corsa verso la campagna. C'era una piccola discesa che cominciava da sotto casa mia fino alla Caovila. Non avevo mai usato i freni in quella della cugina e mi trovai in grande imbarazzo quando la bicicletta, cominciò a volare nella discesa. Passata la Caovila, a velocità sostenuta, prima di arrivare alla Piscina vidi in mezzo alla strada due gambe con sopra un enorme fascio di fieno. Il volto e tutto il resto del corpo non si vedevano. Cominciai a suonare il campanello e ad urlare ma sì, chi mi sentiva? Il poveraccio tutto curvo sotto quel cumulo di fieno penso non avrebbe sentito neppure le campane. La strada era stretta e lo scontro fa inevitabile. In prossimità di quel pagliaio allargai le braccia e d'un tratto mi sentii avvolta in un dolce profumo di fieno secco, adagiata su di un soffice cuscino, mentre una voce piuttosto burbera urlava: - Sacripante..., cosa succede!? In quel momento mi sentii afferrare per le braccia e sollevare in alto...ma, il mio soccorritore, misericordia! era lo zio Luigi, che, vedendomi tutta d'un pezzo, si pre- 126 127 cipitò ad aiutare il malcapitato giacente ancora sotto il cumulo di fieno. Era Giorgio Cichellero, uomo burbero, ma non cattivo che, data un'occhiata allo scricciolo tutto spaurito e frastornato, disse a zio Luigi: - Non farle niente, dovevo stare attento io, è successo e basta..... Lo zio, presa la bicicletta con una mano e con l'altra tenendomi ben stretta mi rimorchiò a casa dove ebbi... uno zuccherino piuttosto amaro che del resto mi ero meritato. 6.5. Il vecchio delle ciliegie. Legato al fiorire dell’estate è il ricordo seguente: in uno dei giorni precedenti la festa del Corpus Domini, che come si vedrà nell’ultima sezione del libro, era per tutti noi una festa di particolare ed unica importanza, un certo Augusto, che noi fratelli chiamavamo “il vecchio delle ciliegie”, scendeva dalla collina portando un cesto grande, pieno di grosse ciliegie, che sembravano rubini tanto erano rosse. Allora si viveva anche così, coi piccoli commerci del proprio campicello. Un modesto frutteto di ciliegie poteva fruttare quei pochi soldini sufficienti a sbarcare il lunario. Lo vedevamo spuntare dalla sommità del colle, là dove s'intravede la casa dei Bodoli. Il primo di noi che lo scorgeva correva in casa gridando: -C'è il vecchio delle ciliegie, c'è il vecchio delle ciliegie! E tutti lo attendevamo sulla porta di casa. Lui entrava e subito la zia gli porgeva la sedia perchè Augusto, per arrivare da noi, aveva molta strada da percorrere, infatti abitava nell'altra collina, sopra Sossano, nella località detta “Meschini”. Gli versava un bicchiere di vino, poi, con il nonno e con lo zio avviava una conversazione sulla caccia, sul tempo, sui raccolti.......Il suo arrivo portava a noi bimbi, assieme alle succose ciliegie, anche tanta gioia, gioia semplice e schietta che si mescolava a quella per la raccolta dei fiori da spargere nella processione, al profumo della casa pulita e ornata di verdi fronde, alla serenità delle persone che liete si preparavano alla grande festa. trasportava le loro poche e povere masserizie. Un somaro (il loro) pascolava l'erba che circondava il lavatoio. Ad un tratto il padre e la madre si misero ad armeggiare con delle casseruole ed avevano lasciato libera la bimba, che tentava di camminare reggendosi a malapena sulle traballanti gambette. 6.6. Piccola apostola… Il seguente episodio non è esattamente legato alle nostre vacanze estive, ma può ugualmente essere qui collocato in quanto considerabile frutto di un’intera stagione di catechismo. E’ un ricordo legato indissolubilmente al lavatoio del paese. Avevo circa otto anni quando, nel primo pomeriggio di una tiepida giornata di primavera, seduta sulla parete del lavatoio, giocherellavo con l'acqua gettando dei sassi dentro alla vasca per vedere i cerchi concentrici che formavano mentre cadevano. Nessun compagno e nessuna massaia nei paraggi. Lì vicino, sull'erba, era accampata una famigliola di zingari. C'erano mamma, papà e una piccola bimba. Stavano seduti tutti e tre per terra vicino al carretto che Cosa passò in quel momento per il mio balzano cervello? Bisogna sapere che la mia fantasia, sempre in movimento, era fervidissima, alimentata dai racconti della Catechista, del Parroco e da tante altre persone, che ci facevano entrare nella testa il Catechismo di San Pio Decimo, con il supporto di racconti, parabole e fatti accaduti ai Santi. Ci veniva spesso descritta, con calore e "colore" la situazione di tanti bambini africani, indiani, eschimesi......, che morivano senza battesimo, quindi non destinati al Paradiso. A me facevano sempre impressione tali discorsi e sovente mi appartavo a pensare ed a fantasticare sulla possibilità di recarmi un giorno nei lontani Continenti per battezzare quelle creature. In quel momento, per me, quella bimba era una povera derelitta, senza speranza di Paradiso. L'istinto di futura apostola scattò in quel momento, poi, pensare e agire fu un tutto uno. Presi la bimba sotto le ascelle e le ficcai la testa sotto il getto dell'acqua pronunciando, contemporaneamente, la formula del Battesimo, che sapevo a memoria. Non feci in tempo a dire 128 129 Amen che i due poveretti mi si scagliarono addosso riprendendosi la bimba che, spaventata, non aveva voce per piangere. Si misero loro a gridare come forsennati! Certamente avranno creduto che la volessi affogare! Me la detti a gambe nascondendomi poi sotto la siepe dell'orto della famiglia Priante da dove spiai quei due che nel frattempo, con un panno, asciugavano la testa alla piccola. Tutto intorno non si vedeva anima viva. Rimasi lì, immobile ad assistere alla partenza di quei poveri disgraziati che, terrorizzati, avranno creduto d'essere capitati in un paese di selvaggi. Ci rimasi male, anche perchè mi sembrò di non averla battezzata bene quella piccolina. Quando, fiera della mia prima azione missionaria, raccontai tutto al Parroco, poco mancò che questi fosse preso da un colpo. Mi disse che prima di fare un gesto simile avrei dovuto informarmi se fosse già stata battezzata e che, comunque, quello non era un compito per mocciose. - Ma allora - pensai - cosa ci vengono a raccontare durante le ore di catechismo! Tuttavia il catechismo a me piaceva molto. I brani della sacra scrittura, le risposte alle tante domande formulate in ogni lezione, erano da me imparate a memoria, inoltre leggevo anche i libri di religione appartenuti a nonna. 6.7. La spigolatura. La spigolatura era un altro rito estivo, che si svolgeva durante il nostro tempo di vacanza scolastica. Quando la mietitura era terminata nei campi del Conte accorrevano le donne, i ragazzi ed anche noi bambini per la spigolatura del grano. In quel tempo si mieteva con una macchina molto semplice, tirata da buoi e guidata da un contadino, nei campi. Invece nei luoghi impervi e ai bordi dei campi si adoperava il falcetto. Era bello vedere i contadini prendere un manipolo di spighe e, con un solo colpo, reciderlo. La macchina così trovava la strada libera e non sciupava le spighe dei bordi, però durante la falciatura, molte spighe sfuggivano e venivano lasciate lì nel campo, in mezzo alle stoppie, con grande gioia di coloro che le andavano a raccogliere. Quando la trebbiatura del frumento, del conte era finita, veniva trebbiato anche il grano della spigolatura ed ognuno si portava a casa, con grande gioia, il suo sacco di grano. In qualche pomeriggio domenicale, bambini e bambine ci recavamo a spigolare, sotto la direzione dei catechisti. Il ricavato della vendita del grano, poi, veniva mandato alle missioni e, parte, veniva utilizzato per pagare il tesseramento all’Azione Cattolica. Il parroco dava il suo consenso per questo lavoro fatto di domenica e lo dava anche ai contadini quando il tempo minacciava di distruggere raccolti o bagnare il fieno essiccato e pronto per essere portato nei fienili. Ma ciò accadeva di rado. Il riposo festivo veniva scrupolosamente osservato salvo, come ho detto, in qualche rara occasione. Nella mia infanzia ebbi molti compagni di scuola e di catechismo, allora le famiglie erano molto numerose, abbondavano di figli 130 anche se costava tanta fatica sfamarli. C’erano i Procacci, i Trevisan, i Faccio e i Bonato di via Longhe. La strada di campagna allora era tutto un vociare, un gridare, le risate argentine si confondevano con i trilli degli uccelli e il canto di qualche contadina che, al mattino si recava nei campi a dare una mano agli uomini. 6.8. Famigliari in vacanza. Tra i figli della sorella del nonno, zia Lucia, uno, Giovanni, abitava a Lucca, era Maresciallo dei Carabinieri e, durante l’estate, veniva in vacanza con la famiglia a Toara. Zia Lucia abitava con lo zio Cesare, che non aveva stanze sufficienti per far dormire nella sua casa quelle persone, così zia Carolina, sempre disponibile, metteva loro a disposizione la camera matrimoniale dei miei genitori. L’ho detto: non ne tacevo una, quando mi sembrava che qualcuno non dicesse la verità, oppure mancasse in qualche cosa che a me sembrava disdicevole, intervenivo facendo arrossire qualche malcapitato o mettendolo in grande imbarazzo. Quello che feci una volta al tempo degli ospiti di zio Cesare non lo seppe mai nessuno, e nessuno, dei miei famigliari, questa volta, ebbe da arrossire per colpa mia, perché neppure lontanamente immaginavano che osassi dire una cosa simile, solo zia Carolina ne rimase un po’ meravigliata. Questi parenti ad ogni loro visita, portavano in dono alla famiglia di zio Cesare, oppure a quella della sorella Amalia, qualche taglio di stoffa, scarpe e altre cose che suscitavano ammirazione e curiosità in tutto il vicinato. Allora si era scarsi di tutto… Quella volta zia Carolina uscì in un’espressione insolita, per lei che non si lamentava mai, disse: -Guarda un po’ in tutti gli anni che sono venuti a casa nostra ed abbiamo messo a disposizione la stanza, non hanno mai portato un piccolo segno di riconoscenza –ed aggiunse– basterebbe così poco alle volte per far contente le persone! Avevo udito, ma stetti zitta. Aspettai che Franca, una delle figlie, fosse sola e l’apostrofai così: -Perché venite tutti gli anni a disturbare la zia, che vi deve preparare la stanza più bella e non le portate mai niente? L’anno seguente zia, ricevendo con la solita cortesia cugino e famigliari, ebbe anche un bellissimo taglio di vestito in dono. Rimase meravigliata e commossa e ringraziò. D’allora, ogni anno, qualche cosa portarono sempre. E io zitta. Pensavo: - Così si fa con coloro che non capiscono… Ero sicura d’aver agito bene! Se i miei avessero saputo! 6.9. Moralizzare i costumi…. Un giorno d' estate me ne stava comoda seduta nascosta fra i rami fronzuti d’ un vecchio gelso. Sotto il gelso un gruppo di donne lavorava a rammendare indumenti e la biancheria appena tolta dalle corde tese nel prato, sotto il sole; parlavano sottovoce per non disturbare i loro uomini che, in quelle ore afose, non potendo recarsi nei campi, riposavano sotto gli alberi dietro alle case. Ad un trat131 to, una donna del gruppo, a cui do un nome di fantasia per celarne la vera identità, così come farò con le altre protagoniste dell’episodio veramente accaduto, che qui riferisco, l’Erminia, abbassando ancor più la voce, invitò le comari ad udire la novità. Il gruppo si restrinse per sentire meglio e l' Erminia trionfante cominciò: -Certo, voi non sapete ancora, ma a me l' ha detto la Tilde, quindi è un' autentica novità, e nel dire ciò, calcava le parole come per ribadire che "lei" era più importante di loro, almeno in quel momento. Le pettegole incitarono: - Avanti, parla! Allora, alzandosi in piedi e girando attorno lo sguardo trionfante esclamo: - La Clelia è un' altra volta incinta! Un oh! di meraviglia uscì da quelle bocche protese ad ascoltare e cominciarono i commenti per niente benevoli. - Ma io, sapete - continuò l' Erminia - ho già provveduto, ho consigliato alla Clelia di sbarazzarsi di quel nuovo peso, Clelia mi ha guardato di sbieco come se fossi stata un demonio, mi ha chiesto chi m'avesse avvertito che lei aspettava un figlio e chi le avesse detto che fosse indesiderato, cosa falsa, perchè lei il figlio lo voleva, lo desiderava! Un altro oh più lungo di quello precedente accolse queste parole e poi si scatenò il putiferio, tanto che le galline intente a razzolare nell'aia, scapparono terrorizzate, come avessero sentito il sibilo di un serpente. - Un altro figlio dopo i quattro che ha! - Un' altra bocca da sfamare! - Quel povero uomo si deve ammazzare di lavoro! - E lei gracile com' è! -Vergogna, con quei denutriti...... E il coro avrebbe continuato all' infinito se a troncarlo non ci avesse pensato io, che dall' alto del mio osservatorio, avevo seguito con interesse il discorso e avevo capito che a farne le spese era Clelia, la buona Clelia che, quando poteva, dava una mano a tutti. Mi arrampicai svelta sui rami più sottili del gelso e cominciai a scrollarli con forza, facendo cadere una fitta grandine di more mature, dal colore bruno, sopra il gruppo. Le malcapitate non fecero in tempo a spostarsi ed a spostare la biancheria, che tutto quel bianco bucato diventò nero d' un colpo. Il gelso era veramente enorme e prendeva di largo, così neppure una cesta di indumenti si salvò da quella grandinata. Le donne, dapprima stupefatte, cominciarono a stridere come cicale, tanto da svegliare gli uomini, che corsero sull' aia brandendo forche e bastoni credendo di dover combattere con chissà quale animale. Io, intanto, approfittando della confusione che si era venuta a creare, scivolai giù dall' albero e, inosservata, me la svignai, contenta d' aver dato una lezione a quelle pettegole. 132 CAPITOLO SETTIMO SOTTO IL GONFALONE DI S. GIORGIO: TUTTO IL PAESE SOTTO IL CAMPANILE! Ciò che dava veramente unità ed una specie di nobile, ed insieme umile, dignità al paese era però la sua dimensione religiosa. Il senso sacro della vita, del nascere, del morire, del passare del tempo cadenzato, ritmato da celebrazioni, i riti, processioni, funzioni, predicazioni, catechismo. Le festività religiose, ordinarie, e straordinarie, nel nostro paese erano sentite, vissute, celebrate da tutti, coralmente, direi all’unisono, e lo rendevano un’unica grande famiglia. Le sofferenze, le miserie, materiali e morali, le meschinerie, le difficoltà del vivere, tutto in quei momenti veniva come riscattato, messo da parte, e noi entravamo in una dimensione d’esistenza diversa, più grande, che ci redimeva, e ci dava un’incrollabile speranza di riscatto. Tutti gli eventi della nostra vita avevano allora sempre una dimensione sacra e religiosa, che oggi è difficile, se non impossibile, non dico ritrovare, o rivivere, ma anche solo ricordare nella sua ricchezza emotiva, e simbolica collettiva. Senza questa dimensione la nostra vita sarebbe stata ben povera, ridotta ad una serie di preoccupazioni, senza aperture verso qualcosa che ci nobilitava, e ci aiutava tutti ad essere migliori, più aperti al prossimo, più ricchi di speranza, in una parola sola, più buoni…! Sembrava che il tempo, allora, non avesse fretta di passare e noi ragazzini contavamo i giorni che separavano una festa dall’altra. Tutta 133 la nostra gioia era lì, nella piccola chiesa parrocchiale, attorno al campanile, e sul sagrato. Non si poteva nemmeno lontanamente immaginare una domenica senza andare in Chiesa almeno due volte, sarebbe stato impensabile, e nelle solennità, non poteva mancare la processione o qualche altra espressione di culto. 7.1. La vigilia delle feste. Il mio cuore si scioglieva in un mare di dolcezza all'avvicinarsi delle feste religiose, nelle vigilie m'inondava l'anima una tale gioia da non saper esprimere. Il sabato, Giulio, il campanaro, saliva sul campanile e cominciava a suonare il campanòn, cioè la campana grossa. A quel suono i contadini smettevano di zappare, di rastrellare o di fare qualsiasi altro lavoro; le massaie si affacciavano all'uscio, noi ragazzetti correvamo sul sagrato della Chiesa e tutti, grandi e piccoli puntavamo i nostri occhi al campanile. Il suono della grossa campana annunciava l'approssimarsi della festa e tutti gioivano, e tutti erano invasi d'allegrezza. Nelle feste che cadevano durante la bella stagione noi bambini eravamo spediti in collina, oppure nel grande prato del conte Sandro con cestini per raccogliere fiori da spargere, il giorno seguente, per esempio davanti alla statua della Madonna durante la processione nel mese di maggio, oppure davanti all'ostensorio retto dalle mani dal Parroco nella festa del Corpus Domini. Cogliere fiori era una festa per tutti i bimbi; si sentiva un allegro vociare, un chiamarsi continuo, scoppi di risa festose, grida di giubilo......Le colline venivano prese d'assalto, così pure i campi, i prati, gli orti ed in fine anche i giardini, sì perché chi era più piccolo o più lento non riusciva ad averne tanti come i più scaltri e veloci, allora le mamme, nonne, zie prendevano dai giardini... ed era una gioia incontenibile quando i cesti si riempivano di petali di rose, dalie, petunie, astri, garofani profumati, violacciocche....... Tutti i fiori raccolti venivano poi portati nella saletta delle riunioni, in canonica e, il giorno dopo, alcune giovani ragazze, riempiti dei grandi cesti, seguivano la processione controllando che i bimbi vestiti di bianco avessero sempre i loro cestellini pieni di fiori da lanciare davanti a Gesù oppure alla Madonna. 7.2. La grande Settimana Santa. Non c’è dubbio che il momento più solenne di tutti era anche allora la Settimana Santa con la solennità di Pasqua, certo tutto era celebrato con tempi, ritmi e modi diversi dagli attuali, ma l’importanza era la stessa. La vigilia della domenica delle Palme, che apriva la Settimana Santa, gli operai del conte portavano nella sagrestia tanti fasci di rami d’ulivo che il mat134 tino seguente venivano benedetti e distribuiti ai fedeli. A Toara c’è il bellissimo uliveto di proprietà del conte Piovene, proprio sulle balze alle spalle di Villa Piovene, dove si staglia la cosiddetta casetta rossa, quindi non era difficile avere le palme, cioè le fronde di olivo. Per il parroco veniva scelta quella più grande e più ben fatta, io mi trovavo sempre tra i piedi di coloro che avevano il compito di ornarla, vi attaccavano, qua e là, delle piccole colombe bianche, fatte con il midollo dei rami della pianta di fico. Ci mettevano pure dei fiocchi di nastro colorato. Il mattino seguente, dopo la benedizione delle palme, la processione e la santa messa si aprivano le “ore”, cioè il sacerdote esponeva l’eucaristia, in alto sull’ostensorio e si dava inizio alle quaranta ore di adorazione. Il sacerdote, con un confratello del Santissimo, detto cappato, che portava la croce astile, si recava all’oratorio Piovene e di lì, al canto del Miserere partivano, seguiti in processione dalle persone lì radunate, alla volta della chiesa. Il parroco, con il cappato e le persone che avevano partecipato all’ora precedente, in processione, le riaccompagnava all’oratorio e, con una benedizione, le congedava. Le ore si chiudevano con una solenne processione la sera del martedì santo portando attraverso il paese l’ostensorio con il corpo di Cristo. Tutto il popolo vi partecipava, le case venivano illuminate e, per l’occasione, anche i più poveri ce la mettevano tutta per onorare il Santissimo. Era emozionante e bellissimo. Tutta quella settimana era impregnata di santità, persino l’aria sembrava portasse odori di luoghi lontani, si respirava il mistero. Il giovedì santo si era tutti compresi di ciò che si faceva memoria. La chiesa gremita, la maestà della cerimonia mettevano nell’anima anche del più scettico, un qualche cosa di arcano, di divino. Dopo il canto del Gloria, le campane che avevano suonato a festa, venivano fatte tacere, il campanaro legava le corde, e venivano sostituite dal “racolòn”. I chierichetti mettevano a riposo i campanelli e prendevano le “racole”, anche altri ragazzi, in quei giorni si recavano in chiesa con questi aggeggi. A quel tempo gli uomini usavano indossare il mantello, quando si arrivava al momento di adoperare le “racole”, che facevano un rumore assordante, poteva accadere che qualche ragazzo talora ne profittasse per inchiodare alle sedie oppure ai banchi, un lembo del mantello di qualche malcapitato che, ignaro dello scherzo, alla fine della cerimonia, alzandosi per uscire rischiava di cadere. Una volta volli scrivere una poesia per ricordare quelle intense funzioni della settimana santa. 135 VENERDÌ SANTO. Miravano le piaghe del tuo corpo. Gli occhi lucidi di pianto, schiuse le labbra, in tacita preghiera, donne di fede semplice, ma forte, che capivano bene il tuo soffrire. Come rondini vestite di nero venivano alla chiesa per il sepolcro, che era lì ai piedi dell’altare di tua madre. Entravano come ombre ad una ad una e accanto a te, disteso sulla croce trattenevano il fiato, quasi che il loro respirare ti recasse disturbo. Profumava di giacinti e di narcisi il sepolcro ove tu adagiato ti lasciavi mirare, chè la compassione dell’umili paesane per te era balsamo, per loro un misto di amore e di dolore. Dimentiche del peso di lor vita, piena di grevi affanni e di dolori, ben celati sotto quel nero e dentro nel lor cuore, pensavano a te e tua madre. Di tanto in tanto, un sospiro come soffio di mantice sdruscito, usciva da quei petti, logorati d’affanni, di lacrime, di pene. 136 Le spine sulla corona del crocifisso. Il racconto della Passione di Gesù mi faceva star male, sentivo per Gesù una grande compassione, il sacerdote e i catechisti ci esortavano a fare dei piccoli sacrifici per alleggerirlo dai suoi dolori. Proprio durante il periodo quaresimale il parroco ci aveva detto che, ad ogni sacrificio fatto, noi avremmo potuto togliere una spina dalla corona conficcatagli sulla testa. Ce la misi tutta perché desideravo dargli sollievo togliendogli tutte le spine, a questo scopo facevo tanti piccoli sacrifici. La nostra chiesa era sempre aperta, tranne di notte, ed io ogni giorno entravo e mi recavo in sagrestia, quella vecchia, dove c'era il grande crocifisso dalla corona con le spine molto lunghe e grosse. Stavo lì a controllare se qualche spina gli fosse caduta dalla testa, passa un mese, passa l’altro, ma quelle erano sempre là. Un giorno, la Pasqua era già passata da un pezzo, non avendo visto risultati, mi stancai. Entrata, mi posi davanti al Cristo e gli dissi: -Ebbene, io ho fatto tanti e tanti fioretti, ma di spine neppure una te n'è caduta, ora mi sono stufata e ci penserò io… Salii su una sedia e ruppi una spina, qualche giorno dopo feci lo stesso e così via, un po’ alla volta fino a che gliene rimasero poche. Quel Crocifisso lo si toglieva dalla sagrestia solamente in alcune occasioni, nella settimana Santa, in qualche processione e altre rare volte, sicché nessuno s’accorse dell’accaduto, la cosa andò liscia, ed io mi gloriavo dentro di me di aver fatto cadere tutte le spine della corona di Gesù…. Non dissi però nulla a nessuno. Dovevano essere più chiari! Dopo alcuni mesi mi recai in chiesa per la consueta apertura del Perdon D'Assisi, era il mezzogiorno d’un due d’agosto, ed il sagrestano aveva portato il crocifisso in mezzo alla navata, come faceva sempre in quella circostanza e ve lo avrebbe lasciato fino alla sera del giorno seguente. In quel momento attorno al Cristo, oltre che al sagrestano e al parroco, c'erano altre persone che osservavano e commentavano concitatamente. M'avvicinai incuriosita, ma una parola, detta da qualcuno, mi fece drizzare le orecchie. Si diceva: - Chi sarà il criminale che ha compiuto un tale scempio? Come avranno fatto a scovare il Cristo in quella vecchia sagrestia? Cosa ne avrà fatto di quelle spine? Avesse preso tutto il Cristo, ma solo le spine! Che delinquente........ e via con ingiurie ed epiteti da non credere. Fui presa da grande sgomento e da infinito stupore, e io che pensavo che tutti si sarebbero compiaciuti! Erano proprio strani questi adulti! Ci volle alfine un mio parente falegname per porre fine a quelle litanie e, rivolgendosi al parroco, lo assicurò che il Cristo sarebbe tornato come prima: ci avrebbe pensato lui, era veramente un artista per certe cose! Mi sentii sollevata, ma giurai in cuor mio che non avrei preso mai più alla lettera ciò che mi veniva insegnato. Nessuno seppe mai chi fu il teppista che rovinò la corona di spine, pensai anche non fosse necessario doverlo confessare al parroco, perché, in fin dei conti, mi ci aveva spinto 137 “lui” a quell'azione. Secondo la mia logica dovevano essere più chiari nelle spiegazioni del catechismo! Il canto delle Lamentazioni. Ricordo pure che, a quel tempo durante la settimana santa venivano cantati il “mattutino delle tenebre” e le “Lamentazioni”. non ricordo bene tutto, ma davanti agli occhi mi rivedo seduta, tutta protesa al canto ed alla visione di un grande candelabro cui veniva spenta una candela ogni volta che terminava una Lamentazione. La prima era sempre cantata da Alcide Faccio, non essendoci chierici i canti venivano eseguiti da persone abituate alla lettura di testi in latino. Ricordo come Alcide cominciava a cantare la prima lamentazione, che diceva così: Incipit Lamentatio Jeremiae Prophetae. Aleph eeeee… noi ragazzi ridevamo perché ci sembrava una nenia. Non ci veniva spiegato il significato di queste letture, che in verità, erano difficili anche per gli adulti, non credo le comprendessero più di tanto. Il venerdì santo dopo le varie cerimonie si faceva la processione. Era molto suggestiva e commovente. Qua e là si vedevano croci tutte fatte di luce, le case venivano addobbate con simboli di dolore. Si cantavano inni maestosi e severi, che parlavano di sangue, di croce, di amore e di vittoria. Mi appiccicavo alle ragazze che cantavano con grande fervore l’inno: Del Monarca s’avanza il vessillo, della croce rifulge il mistero…, cioè Vexilla Regis prodeunt che poi si cantava in Chiesa, in latino. Il sabato santo la partecipazione alle cerimonie era piuttosto scarsa, forse perché si svolgevano di primo mattino e la gente era tutta impegnata nei campi. Il giorno di Pasqua invece si sentiva la gioia effondersi dappertutto. Il suono gioioso delle campane invitava alla chiesa che, tutta splendente della luce che irradiava sugli altari addobbati con candide tovaglie ricamate, sui candelieri lucidati, sui fiori aulenti, con uno sfavillio di scintille dorate e argentate che era un incanto.Veniva cantata la Messa a più voci, il coro allora era veramente grandioso, ben preparato, molto attivo. Le voci bianche sembravano cori di Angeli, rapivano l’anima e facevano esultare il cuore. 7.3. La festa dei Oto. Quando arrivava la festa dei Oto, l’otto settembre, festa della diocesi di Vicenza che onora nella natività di Maria, la sua protettrice, la Madonna di Monte Berico, tutti coloro che potevano salivano a Monte Berico per ringraziare la Madonna. Si aspettava quella data preparandosi mesi prima. Ricordo che, mia sorella Maria, più grande di me di qualche anno, poteva aggregarsi alle altre ragazze del paese e recarsi in pellegrinaggio senza la sorveglianza degli adulti. La sera precedente si radunavano in piazza per gli ultimi accordi; ognuna doveva premurarsi di chiamare quella che era senza la sveglia e così, quando l'alba ancora non si annunciava, tutte fresche e sprizzanti gioia, passavano di casa in casa e, cinguettando come uccelli fuggiti dalla gabbia, chiamavano le compagne facendo starnazzare le anatre e spaventare le galline nei pollai. Poi via a piedi o con il carretto a prendere la vaca Mora a Ponte di Barbarano, con le sporte piene di quel che si poteva avere a quei tempi compresa anche qualche bottiglia di quello buono che metteva in loro un'allegria alle volte incontrollata. Dopo la Messa al Santuario e le varie devozioni, accampate sull'erba sopra il Piazzale della Vittoria affamate e assetate divoravano cibo e bevanda con il sano appetito di giovani lupi. Scendendo poi in città si divertivano a suonare i campanelli delle villette, fuggendo poi e trascinandosi dietro le sporte con gli avanzi del cibo, felici come bimbette, certe d'aver compiuto chissà quale prodezze, con disappunto delle persone disturbate più volte da quella ciurma vociante. Il coro di Toara. Quel coro era allora tutta la ricchezza di Toara e della sua Chiesa. Quasi tutti gli uomini partecipavano al coro ed anche tutti i fanciulli che possedevano una bella voce. Nel pomeriggio ancora le funzioni solenni che, terminate, nella Chiesa rimaneva per ore il profumo dell’incenso e l’eco gioioso dei canti. Nella settimana dopo Pasqua il sacerdote si recava nelle case per la benedizione. Gli si dava, come offerta, qualche uovo. C’era poco allora, ma anche il parroco doveva vivere. Lo seguiva il sagrestano oppure un chierichetto, che portava l’aspersorio e il secchiello, più una borsa piena di candele che il sacerdote lasciava in ogni casa visitata. Un’ altra sporta era per mettervi le uova. Ricordo una volta che, una giovane del mio paese, tornata dalla festa dei Oto, raccontò ciò che era successo a due giovani spose facendo ridere, a crepapelle tutti coloro che, sulla piazza del paese erano lì ad attendere il ritorno dei pellegrini. Al tempo della mia infanzia, quando i figli si sposavano rimanevano tutti in famiglia, così assieme ai nonni, ai genitori c'erano i figli con le loro spose e i loro figlioletti. In una di queste buone e patriarcali famiglie per il giorno della festa dei Oto due giovani spose chiesero al suocero di potersi servire del carretto e del musso per potersi recare, con i loro bambini, a Monte Berico. Il suocero, benignamente, acconsentì. Il mattino sistemarono sul veicolo i loro bambini, prepararono la focaccia, il pane con la soppressa, un bottiglione di vino e.... via, all'alba, verso il Santuario tanto amato. Il mattino lo trascorsero a Monte Berico e, nel pomeriggio, per far godere di più i bambini, si recarono al Campo Marzio, dove c'erano bancarelle di ogni genere, giochi e altri divertimenti. Le poverette, ancora tanto giovani, si divertivano un mondo tanto quanto i loro bambini e , forse, anche di più. Tutte prese dall'incanto di quei suoni e colori s'accorsero dell'arrivo della sera che le ombre si stavano già allungando e...... lo sgomento le prese. Il suocero era buono, ma molto severo. Che avrebbe detto se fossero arrivate in ritardo?! Un rapido consulto poi, fatti adagiare i bambini sul carretto, preso il bot- 138 139 tiglione di vino che ne conteneva ancora la metà, una di loro tenne aperta la bocca al “musso”, l'altra gli fece bere tutto il vino rimasto. L’asino non rifiutò quella bevanda e le due sposine aspettarono sicure il benefico effetto, cioè speravano che la povera bestia, tutta allegra, si mettesse a correre veloce verso casa, ma lo spavento le prese quando, il povero asinello cadde a terra sbronzo e intontito. Così dovettero trascinare, loro stesse, sia il carretto che l'animale, arrivando a casa a tarda notte. 7.4. Il Corpus Domini: sotto il gonfalone di S. Giorgio. Ma la processione che mi faceva vivere momenti d'indicibile emozione e m'immergeva tutta in un'atmosfera fatta di maestà e sacralità era quella del Corpus Domini. Quella processione si faceva di mattina. La ricordo così: all'alba zia ci faceva alzare perchè si dovevano spalancare le finestre per addobbarle. Si toglievano dalle grandi casse tutto ciò che vi era di bianco e ricamato: copriletto , lenzuola, copri cuscino, tende, tovaglie, in una parola tutto ciò che in casa c'era di più bello. Se c'erano dei drappi rossi si mettevano sotto ai bianchi ricami affinché questi risaltassero di più. Ogni finestra, anche la più piccola, veniva addobbata. In ogni famiglia c'erano vasi di fiori dai vivi colori che venivano messi nel mezzo delle finestre sia per fermare i drappi che per abbellire. Terminato di addobbare tutti ci si recava in Chiesa per la Santa Messa Solenne. Anche la natura per l'occasione, indossava la sua veste migliore: il cielo azzurro splendeva di luce chiara , sembrava che l'aurora, prima d'andarsene, stendesse nel cielo un bianco velo di sottilissima trina con sfumature rosate e dorate, l'aria mite, le colline rivestite di verde dalle varie tonalità, le messi biondeggianti di grano e punteggiate dal rosso colore dei rosolacci e dagli azzurri fiordalisi. Le spighe dorate, mosse da una leggerissima brezza, sembrava chinassero riverenti il capo in attesa del grande passaggio. Le prode dei ruscelli e le carreggiate in mezzo ai campi, abbondavano di erbe e fiori dagli incredibili colori........ Gli uccelli sfrecciavano nel cielo e si perdevano nella luce mattutina modulando i loro canti festosi. Avevo l'impressione che tutto l'universo trattenesse il fiato quando il sacerdote, reggendo e alzando l'ostensorio, scendeva i gradini della chiesa. C'era qualcosa di straordinariamente solenne, maestoso e insieme gioioso in tutto ciò che potevo vedere. Fissando il cielo avevo l'impressione che questi si aprisse e di scorgere schiere e schiere di esseri celesti, immobili e adoranti, seguire con lo sguardo stupefatto e ammirato il passaggio di Gesù Eucaristia. Anche il creato sembrava assorto in estatica ammirazione e, dallo stesso, si elevava una voce di lode incessante, una lode visibile più che udibile. Noi bambine venivamo vestite di bianco. Appena terminata la santa messa il sacerdote indossava il piviale più bello e prezioso, metteva nell'ostensorio ricco di fregi dorati e di simboli, l' ostia consacrata, l'incensava al canto del Pange Lingua, poi quattro confratelli del Santissimo Sacramento, detti i cappati tutti vestiti di bianco, con una mantella rossa, un cordone rosso ai fianchi e uno al collo con appeso il simbolo dell'eucaristia, prendevano il baldacchino di broccato e lo tenevano sospeso sopra il sacerdote che, con l'ostensorio, lentamente si avviava per la processione. Per primo, davanti a tutti, usciva lo stendardo rosso, retto da un uomo molto forte, lo stendardo é enorme, dico è perché esiste ancora, e viene tuttora esposto nelle feste del paese. Come ho detto è rosso, nel mezzo è dipinto un San Giorgio a cavallo, che, con la lancia, si accinge ad uccidere il drago. San Giorgio è il santo patrono della parrocchia di Toara, il suo difensore, e tutore. Due ragazzini, ai lati, allargavano il grande stendardo tenendo nelle mani i grossi fiocchi dorati che erano attaccati ai suoi bordi. Poi venivano gli uomini, i confratelli del Santissimo con grandi ceri in mano, la banda e i cantori. Sotto quel gonfalone si riuniva tutto il paese, tutti radunati insieme sfilavamo come un corpo solo lungo l’unica via del nostro villaggio. Immersa in questa incredibile meraviglia il mio piccolo cuore era tutto un fremito, s'infiammava d'amore e un inesprimibile gaudio mi toglieva il respiro. Il rosso gonfalone, che garriva al sole, mi affascinava, lo vedevo come una enorme fiamma protesa verso il cielo e con lui unita nella lode al Santissimo. Era come la colonna di fuoco del libro dell’Esodo che conduceva il popolo d’Israele fuori della terra di schiavitù, l’Egitto dei Faraoni, verso la terra promessa, la terra in cui Israele avrebbe servito il suo Dio in libertà. Anche noi, popolo di straccioni, ma ricco di fede e di voglia di riscatto, camminando dietro quel gonfalone esprimevamo, come un corpo solo, ed un’anima sola, la nostra speranza di uscire un giorno dalla terra di schiavitù: schiavitù della miseria, dell’ignoranza, della guerra, della sofferenza, dei molti disagi, del freddo, e della fame, della marginalità, e delle malattie fisiche, come un sol corpo volevamo camminare verso una terra migliore, più buona e più giusta. Una terra in cui una bambina che avrebbe voluto tanto andare a scuola avrebbe potuto farlo, una terra dove non sarebbero più mancate le fascine di legna per scaldare le nostre cucine, e dove ci sarebbe stato abbastanza pane per tutti, dove si sarebbe potuto attraversare il paese senza paura di prendersi una raffica di mitraglia, una terra dove alfine tutti avremmo sofferto di meno. Era il nostro sogno, il sogno che avevamo tutti nel cuore, e che ci faceva camminare insieme, uniti, con un solo cuore, ed una sola anima. Stare sotto il gonfalone dava ad ognuno di noi un grande senso di dignità, e di fierezza, una forza 140 141 misteriosa che entrava nelle vene, ci rendeva capaci di affrontare qualsiasi difficoltà, e ci faceva guardare il futuro con l’indomita speranza di chi attende il suo riscatto. Apriva la processione la banda musicale, magistralmente diretta da Riccardo De Marchi, quando suonava dava maestà e solennità al nostro marciare processionale. Mille sentimenti prendevano la mia anima e la mia immaginazione correva.... Al suono del Sacris Solemnis immaginavo d'essere immersa nella gloria dei cieli. Provavo qualcosa d'indescrivibile. Poi venivano suonati e cantati altri inni dall'effetto maestoso: Lauda Jerusalem, il Pange Lingua processionale, O Via, Vita, Veritas, Te Lodiamo, Noi Vogliam Dio...... Davanti al baldacchino con l'eucarestia c'eravamo noi bambine tutte vestite di bianco, le cestelline appese al collo, tutte ornate di trine e piene di fiori che gettavamo, con gesti misurati, davanti al Santissimo. Attorno al baldacchino c'erano i chierichetti. Subito dietro venivano le ragazze che cantavano alternandosi agli uomini. Poi due a due, le consorelle del Santissimo con i grossi ceri dove, attorno alla fiamma, perchè il vento non la potesse spegnere, c'era come una scatola di ferro rotonda, di colore rosso. Poi venivano tutte le altre donne. Tutti, uomini e donne, camminavano ai lati della strada perchè nel mezzo doveva esserci lo spazio per le persone che reggevano i gagliardetti. Ricordo: l'Armida reggeva , sempre lei, quello del Terz'Ordine Francescano, poi quello del Sacro Cuore che, a turno, lo reggevano zia Carolina, oppure Ernesta o Augusta...... C'era quello di San Luigi Gonzaga tenuto da ragazzini, poi c'erano le bandiere di Azione Cattolica, sia maschili che femminili e i vari gagliardetti con i simboli dell'Azione Cattolica. Un confratello del Santissimo era incaricato per l'ordine: doveva badare che la processione si svolgesse nel migliore dei modi e che nessuno chiacchierasse. Era uno spettacolo imponente. Tutto il paese era pavesato a festa per il passaggio del corpo del Signore! All'uscita dalla Chiesa le campane suonavano a distesa, ma poi smettevano per permettere sia alla banda di suonare ed ai cantori di cantare. Era una cosa talmente grandiosa da non sapersi descrivere. Tenevo costantemente gli occhi rivolti al cielo e, più d'una volta dovevano intervenire le persone addette a noi bambini perchè sconfinavo e mi trovavo magari o sotto il baldacchino del Santissimo o davanti con gli uomini o addirittura addosso a qualche malcapitato col rischio di farlo cadere. In quei momenti ero fuori di me. Quando si tornava in chiesa le campane ricominciavano a suonare, il sacerdote poneva sul piccolo trono l'ostensorio e lo incensava. L'odore dell'incenso saliva, avvolgeva l'altare e si disperdeva sulle volte della chiesa impregnando tutto con il suo profumo. Qualcuno che non tollerava l'incenso cominciava a tossire o a schiarirsi la gola. Una dolce melodia 142 saliva dall'organo, i cantori cantavano il Tantum Ergo e il sacerdote, saliva l'altare, prendeva dal trono l'ostensorio con il Santissimo e benediva la folla tra il più grande silenzio. Tutto il popolo cantava il Dio sia benedetto e poi con voce possente l'inno solenne e maestoso: il Christus vincit........ 7.5. Le Rogazioni. Tre giorni prima della festa dell’Ascensione si facevano le Rogazioni, cioè delle preghiere speciali per implorare dal Signore la benedizione sulle coltivazioni dei campi e delle colline. Per tre mattine ci si radunava in chiesa e da lì con il parroco e i chierichetti che portavano la Croce astile, il secchiello e l’aspersorio con l’acqua benedetta, ci s’incamminava in processione cantando le Litanie dei Santi. Si toccavano tutti i confini della parrocchia. Sostavamo spesso e il Parroco aspergeva con l’acqua benedetta i piccoli poderi come le grandi estensioni di campi del conte Piovene e di altri possidenti. Era uno spettacolo incantevole: il sole appena sorto illuminava la terra inondandola di luce, che faceva scintillare il manto erboso dei campi, dei prati, delle prode dei ruscelli smaltati di fiori bagnati di rugiada, sembrava che la natura tutta avesse pianto ma che al sorger del giorno in mezzo al chiarore sfolgorante, quelle lacrime venissero trasformate in brillanti, perle iridate, rubini, smeraldi, topazi……. Una ricchezza patrimonio di tutti. Di tanto in tanto il sacerdote ci sollecitava a cantare con più lena ma, mentre si cammina, non è così facile far uscire bene la voce. A me e a qualche compagna scappava da ridere quando qualche persona sbagliava a pronunciare le invocazioni. Tutto veniva cantato in latino perciò era facile qualche sproposito. Un mattino il parroco si fermò per correggere l’invocazione rivolta a S. Michele che sulla bocca di chi aveva sbagliato suonava così: -Sante Miche ora pro nobis Il Sacerdote corresse: Sante Michael e aggiunse –Gnocche! che voleva dire: siete proprio delle oche. Le poverine obbedirono subito cantando: -Sante Miche gnocche ora pro nobis! Il prete scosse la testa , ma gli scappò anche una bella risata. Ogni tanto nelle aie o vicino ai capitelli le donne di casa allestivano un altarino e sopra mettevano un cesto di uova cosparse di petali di rose, qualche immagine di santi o di Madonne. Gli uomini preparavano fasci di piccole croci che venivano poste sugli altarini per essere benedette. Venivano poi piantate ai margini dei campi per allontanare la grandine. La vigilia dell’Ascensione, ultimo giorno delle Rogazioni, la santa messa veniva celebrata nell’oratorio dei conti. Anche lì si preparava il cesto pieno di uova che poi veniva offerto al parroco. Ricordo la gioia che provavo dentro quella piccola chiesetta, in cui giungeva a 143 zaffate il delizioso profumo di rose e dei tanti fiori del giardino della villa, e dove m’incantavo a contemplare le immagine sacre, le grandi teche contenenti sacchetti ricamati, che a loro volta custodivano reliquie di beati e di santi. Nell’attigua sagrestia una cordicella scendeva dal soffitto e, quando Giulio il campanaro la tirava, un suono argentino si diffondeva per tutto il paese ed annunziava l’inizio della messa. Sopra il tetto della piccola sagrestia la campana stava appollaiata sul minuscolo campanile e sembrava ridesse come una petulante fanciulla tra i rami delle piante vetuste che le stavano attorno, quando veniva tirata la cordicella, quasi le facessero il solletico. C’era nell’aria azzurrata e mite, come un incanto che riempiva l’anima di sensazioni ineffabili. 7.6. Le feste mariane. Il mese di maggio. Quando arrivava il mese di maggio il mio cuore era preso da incontenibile gioia, che esternavo con canti, corse frenetiche per i colli, per i prati e per i campi. A sera la campana ci chiamava tutti alla chiesa per la recita del Rosario. Le porte spalancate, lasciavano entrare mille profumi e il pispiglio degli uccelli, unito alla nostra preghiera, formava un'armonia sublime. M'incantavo ad ammirare la statua della Vergine e pensieri di cielo avvolgevano la mia piccola anima sempre assetata d'infinito e d'amore. All'uscita crocchi di persone si attardavano sul sagrato per scambiare qualche parola. A me piacevano tanto le vecchiette che, lentamente se ne tornavano a casa e, talvolta, sedevano in cerchio a raccontarsi tante cose. Anch'io mi mettevo lì incantata ad ascoltare. Piccolina, ma provavo un’immensa gioia nell’udire quelle parole piene di saggezza, che penetravano nella mia anima e la rendevano più quieta. Le processioni con la statua della Madonna. Tutte le processioni eccetto, come ho detto, quella del Corpus Domini e delle Rogazioni, si facevano dopo le Sante Funzioni solenni, nel pomeriggio. Se la festa era in onore della Madonna prima di mezzogiorno, l'Antonia Cacciavillani, sarta del paese, si recava alla Chiesa per cambiare il vestito alla Vergine Maria e al suo Bambino. Giulio toglieva la statua dalla nicchia e la metteva su una specie di predella. Antonia toglieva il vestito di tutti i giorni alla Madonna ed al Bambino con grande delicatezza e rispetto, quindi faceva loro indossare quello di broccato tutto tessuto d'oro. Accomodava il velo azzurro alla Madonna e, alla fine, le metteva sulla testa la corona tutta tempestata di pietre, non so se fossero preziose, ai miei occhi lo erano. 144 La statua della Vergine del Rosario, donata dai Conti Piovene in occasione della nascita del Contino Mario Antonio, viene portata in processione. La festa del Rosario. Mi piacevano tutte le processioni, ma quella della Beata Vergine del Rosario mi metteva nel cuore una dolcezza infinita. La festa del Rosario cade sempre nella prima domenica di Ottobre, un mese, dall'incantevole bellezza, quando la natura come una madre che, appesantita dalla maternità, pur avendo nello sguardo una dolcezza infinita, si adagia, spossata e illanguidita per dare il suo frutto. Ammiravo l’incanto della natura che nelle colline, nei campi, nei prati, nei vigneti e negli orti sfoggiava la gamma di tutti i suoni e la tavolozza superba dei suoi colori più caldi e dorati che, mescolati, componevano quadri d'insuperabile bellezza. Il mio piccolo paesello diventava un immenso cesto pieno di bellezze colorate e di succose bontà. Quella processione si faceva dopo il canto del Vespro ed era serena, calma, dolce e metteva nel cuore una grande nostalgia di cielo. La Madonna, portata a spalle da quattro giovani, attraverso le vie del paese sembrava una mamma che, passando per le stanze dei figli, si sofferma a guardare se tutto è in ordine. Negli occhi ho sempre la visione di quelle processioni e nel cuore ne conservo il ricordo soave che il tempo non cancella. 145 7.7. Cristo Re, Ognissanti, e Fedeli Defunti. Alla fine di ottobre, allora, si celebrava la festa di Cristo Re. Ci parlavano tanto delle missioni, in chiesa ed al catechismo, ed in quel giorno particolare, come frutto della catechesi missionaria la maestra Emma ci faceva portare una “pannocchia” per la Santa Infanzia, cioè per i bambini delle missioni cattoliche nel mondo. La Emma portava davanti alla chiesa dei grandi cesti e noi bambini portavamo la pannocchie. Ricordo che tanti ragazzini venivano dai miei zii in prestito di pannocchie, che regolarmente non venivano restituite, perchè non ne avevano. Emma poi vendeva il grano al mugnaio e mandava i soldi ricavati ai missionari. Alla festa di Cristo Re seguiva quella di Ognissanti. Alla vigilia mi recavo al Cimitero con le mie sorelle per riordinare le tombe, abbellirle con fiori ed accendervi lumi. Il Cimitero, in quella vigilia, pullulava di persone ed era tutto una tavolozza di colori vivaci posati sulle fosse. Parenti, amici e conoscenti passavano tra le tombe per ricordare un volto, un nome, una data... La corona in ferro battuto. Nella nostra soffitta, c'era una corona di fiori in ferro battuto; in quella ricorrenza veniva tolta da lì e portata sulla tomba della nonna. L'appendevamo sul bordo della lapide e lì doveva rimanere per tutto il giorno dei Santi e quello dei Defunti, poi la si riponeva in soffitta per l'anno successivo. Quando i resti del corpo della nonna sono stati riesumati per deporli nella nuova tomba, quella corona sparì dalla soffitta come sparirono tante altre cose a me care. Mi tornano sempre alla memoria quei fiori in ferro battuto e sento ancora all'orecchio il loro suono quando, mossi dal vento, sbattevano contro la lanterna di bronzo inchiodata sulla lapide. Mi faceva uno strano effetto quel suono, specialmente quando il sacerdote commemorava i defunti e pronunciava parole ora severe, ora di speranza, ora di ammonimento per tutti. Quel ticchettio, nel silenzio che accompagnava le pause di quelle riflessioni, sembrava un segno di approvazione a ciò che il prete diceva e, siccome era l'unico rumore, faceva sì che la gente si voltasse per cercarne la provenienza. A me non garbava proprio che quei fiori attirassero l'attenzione di tutti, perchè distraevano le persone. Io, che in quella fase della vita sentivo una forte attrazione per ciò che concerneva la vita eterna e l'aldilà, avrei voluto che tutti ascoltassero, le parole del sacerdote, e si sentissero commossi e contriti.... Quella corona, unica nel nostro camposanto, mi era cordialmente antipatica. Nel pomeriggio della festa di Ognissanti, ci si recava in chiesa per cantare i vespri dei Santi e, terminati quelli, il sacerdote, tolti i bianchi paramenti segno di festa, indossava quelli neri o violacei, in segno di lutto. Poi, al suono mesto delle campane, in processione, ci si recava tutti al cimitero cantando il Dies irae. Era un 146 momento di grande emozione, fortemente suggestivo, e direi drammaticamente spettacolare, immaginatevi tutti i paesani attraversare per intero tutto il paese e giungere al cimitero cantando in tono grave, ed a pieno fiato il canto intenso e lugubre del Dies irae…. La sera dei morti. Alla sera dei morti ogni tomba del cimitero sembrava una piccola casetta, con il suo lume acceso fuori della porta, quasi a ricordare che un giorno, pure noi, avremmo varcato quella soglia per attendere, da lì, la risurrezione promessaci da Cristo. A me era dolce sostare, all'imbrunire, accanto alla tomba dei miei cari e poi, passare in rassegna, una ad una, tutte le altre. Questo lo facevo quando ero sicura d'essere sola perchè così potevo conversare con le persone defunte da me conosciute e dare un saluto anche a tutti gli altri. Ero convinta che, in quei giorni, le anime dei defunti, si aggirassero per il cimitero a raccogliere le nostre preghiere e il nostro ricordo. Non avevo paura, infatti il sacerdote ci diceva che esse si trovavano nelle mani di Dio ed erano immensamente felici. La sera di Ognissanti ci si recava nell'oratorio dei Piovene per la recita del rosario guidata dal parroco; dopo circa un'ora le campane cominciavano a suonare meste e solenni per ricordare i nostri morti. Continuavano così fino a mezzanotte, tacendo ad intervalli regolari per permettere ai campanari di riprendere fiato, questi si procuravano una damigiana di vino e così, con quell'aiuto, tiravano le corde delle campane con più coraggio. Noi, attorno al camino, mangiavamo le caldarroste ascoltando, in silenzio, quel suono che sembrava un'invocazione, un lamento, una supplica e fasciava il cuore di mestizia. 7.8. Il ritiro parrocchiale. Quando tra gli avvisi della settimana il parroco annunciava il ritiro mensile per tutta la parrocchia a me venivano i brividi. Come ho detto in altra parte, al camposanto mi muovevo con disinvoltura, aiutavo Gino Ciavin a togliere le ossa e tante altre cose, che non mi facevano nessuna impressione, invece il ritiro non mi garbava. Questo ritiro prevedeva: esposizione del Santissimo, recita del rosario, meditazione sui novissimi, preghiere per ottenere la grazia di una buona morte e benedizione eucaristica. Tutto ciò avveniva di sera, quando si è più predisposti alla malinconia, alla nostalgia ed alla riflessione. Era santo e salutare questo ritiro, ma a me mettevano spavento, terrore e un senso d'indefinibile angoscia le preghiere per la buona morte. C'era quel passo che diceva: Quando i miei piedi immobili mi avvertiranno che la mia carriera in questo mondo è presso a finire, misericordioso Gesù, abbiate pietà di me! - e poi di seguito ancora -Quando la mia immaginazione, agitata da orrendi e spaventevoli fantasmi, sarà immersa in mortali tristezze, ed il mio spirito, turbato dal147 l'aspetto delle mie iniquità e dal timore della vostra giustizia, lotterà contro l'Angelo delle tenebre....... Le altre invocazioni, tutte ugualmente lugubri e angoscianti, mi tenevano sveglia tutta la notte in un mare di sudore durante l'estate perchè mi coprivo tutta e tremavo come una foglia. Ogni volta che tornavo dalla Chiesa dopo questi ritiri, mi prendevo i piedi tra le mani e mi sforzavo di comprendere le parole: quando i miei piedi immobili......, mi chiedevo cosa volesse dire immobili e me li palpavo, me li stringevo quei poveri piccoli piedi, che certo immobili non stavano mai, e che erano ammaccati, scorticati, pieni, talvolta di pezzetti di spino, perché d'estate, molte volte, si andava scalzi per essere più liberi di guazzare nei ruscelli, nel lavatoio, nelle fontane. Me li prendevo tra le mani ripetendo all'infinito la cantilena: immobili, immobili....... Intuivo che era qualcosa di poco allegro anche perchè, all'uscita dalla Chiesa, osservando le persone, le vedevo tutte con un velo di malinconia steso sui volti. 7.9. Il tempo delle novene. La novena dell’Immacolata. Il tempo delle novene si annunciava con nebbie, freddo intenso e neve. S’incominciava con la novena dell’Immacolata, che portava nei cuori della gente come un messaggio di luce, di gioia, di pace e di bellezza. I canti facevano intravedere la luce sfolgorante della Vergine. Sembrava che Maria fluttuasse sopra le teste chine di tutta quella umile schiera e alitasse su tutti il suo respiro fatto di profumo celeste. Quando uscivamo dalla Chiesa c’era sempre la galaverna ad imbiancare tutto. Sembravano trine delicate, merletti di rara bellezza ciò che il ghiaccio ricamava sulle siepi, sui tetti, sui fili tesi tra gli orti e sulle pozzanghere gelate delle strade. Non c’era l’illuminazione allora e, quando il cielo era sereno, miriadi e miriadi di stelle sfoggiavano tutta la loro bellezza come splendide perle di luce. Un fremito d’ali angeliche sfiorava il sagrato dove la povera gente s’accingeva a tornare accanto al focolare oppure a recarsi nelle stalle. Il sussurro dell’Ave, ultimo suono della sera, penetrava nelle umili dimore come per dare la buonanotte e ad implorare benedizioni per ognuno. E il vecchio che alla chiesa non aveva potuto andare, e la mamma che teneva il suo ultimo nato tra le braccia, e il contadino appena rientrato dalla stalla dopo aver accudito i suoi animali, chinavano il capo e, con devozione e amore, facevano il segno di Croce e lo tracciavano su coloro che non lo potevano fare. 148 La novena di Natale. La sosta di qualche giorno e poi incominciava la novena del Santo Natale. Sentivo che s’avvicinava la grande festa dall’aria sempre più rigida, dal vento che soffiava giù dai colli, dalla terra, che sembrava farsi più attenta, in attesa di un evento cui era chiamata a partecipare. Sentivo e vedevo lo stupore di tutte le cose create, il bosco si faceva silenzioso, la campagna coperta di brina pareva una monaca bianca, coperta del suo velo, orante e raccolta. Qualche raro uccello si attardava sopra i nudi arboscelli o sui rami degli alberi scheletriti e muti, sembrava chiedere il perché di tanto silenzio, di tanta attesa. La mia anima si riempiva di luce ed il mio cuore esultava pieno di gaudio, colmo di affetti e sentimenti d’amore. La novena si cantava in latino. Quanto commoventi quelle preci! Le invocazioni cantate dei profeti, tutte in latino, che davano un senso di maestà e solennità, le invocazioni del popolo che attendeva il Messia, le preghiere amorose, fervide, insistenti chiamavano, imploravano sua venuta. M’immergevo allora nel mondo dell’arcano, vivevo nell’attesa del grande evento. E quando cantavo la commozione mi impediva di terminare il versetto. Quando si arrivava alle parole: - Ecce veniet Dominus protector noster, Santus Israel, corona regni habens in capite sua… E poi: -Nascetur nobis parvulus et vocabitur Deus fortis........, mi sentivo avvolta da qualcosa di misterioso, che riempiva tutto il mio essere e saziava il mio spirito immergendolo nella profondità dei cieli dove perenne è l’azzurro e sempre scintillante la luce. A sera avvolta nel grande scialle che zia Carolina mi faceva indossare, zitta, zitta andavo fuori a vedere le stelle. Incredibile! Di cielo se ne vedeva qualche piccolo pezzettino, perché lo spazio lo occupavano tutte le stelle, che brillavano, brillavano come oro purissimo. Da tanti anni non si vede più il cielo trapunto di stelle come allora. Il Natale, che la sapeva più lunga di me, mi raccontava che nelle notti precedenti il grande evento, gli angeli, incaricati da Dio, lucidavano le stelle fino a farle diventare sfolgoranti di splendore. Mi raccontava pure che il Buon Dio faceva provare ogni giorno il canto del Gloria a tutti gli angeli, arcangeli, cherubini, e serafini per accompagnare degnamente suo Figlio sulla terra. 7.10. Il Santo Natale. Le nostre case non sfavillavano di luci, non si preparava il presepe, perché non c’erano statue, l’albero non si sapeva neppure cosa fosse, ma c’era tanta dolcezza e serenità. Nel tardo pomeriggio della vigilia si andava a sbirciare nelle case per vedere i preparativi della festa nelle singole famiglie, e davvero, c’era tanta gioia pur in mezzo alla più grande povertà. C’era un non so che di sacro, di ineffabile, un silenzio intriso di dignità, di umiltà, di trepida attesa. Si poteva quasi toccare qualcosa di divino che fluttuava in quelle povere cucine annerite dal fumo del fuoco e di qualche candela accesa. I 149 vecchi, sembrava ascoltassero echi di voci provenire dalla fonda notte dei tempi e gli occhi fissi, sembravano guardare lontano, verso orizzonti infiniti. I bambini più piccoli, con il dito in bocca, buoni buoni, seguivano i passi delle mamme e delle nonne, che facevano la spola tra il focolare, dove abbrustoliva la polenta, e la tavola con le scodelle già pronte per essere riempite del povero cibo tanto atteso da quelle bocche sempre affamate. Gli uomini, tornando dalle stalle, portavano in casa l’acre odore degli escrementi degli animali, unito a folate di aria rigida e umida che riempiva per un attimo la cucina, facendo arruffare anche il pelo del gatto raggomitolato sulla cenere del focolare. I ragazzi più grandi, con l’aiuto delle mamme, si rassettavano un po’ i vestiti per correre alla chiesa al primo tocco delle campane. Nessun problema per i regali da preparare, neppure per la casa da addobbare, il presepe da costruire, e tanto meno l’albero. Erano tutte cose da ricchi quelle, ma la dolcezza, l’amore, la tenerezza, il mistero che regnavano in quelle umili dimore, rendeva la semplice e povera vita di quelle creature, un’oasi di pace e di serenità. Parlava soltanto il cuore, agiva soltanto il cuore, ed esultavano insieme anima e cuore. Zia Carolina cercava che il pranzo fosse più abbondante, il bollito era sempre di gallina o cappone, le verdure dell’orto non erano varie, in compenso erano molto saporite. Anche il dolce c’era quel giorno. Ma i preparativi più grandi per la grande festa ruotavano tutti attorno alla chiesa dove ferveva alacremente il lavoro per l’allestimento del presepe. Padre Vitale, fratello del Parroco, aveva dipinto uno scenario molto bello, il sagrestano lo appendeva sulla parete dell’altare della Santa Croce. C’erano le case della Palestina, c’erano pastori che andavano e venivano. Sotto lo scenario, poi, si costruiva il presepe, con sassi , muschio e tutto il resto. Anche noi bambini ci rendevamo utili. Chi portava il muschio, chi qualche sasso, altri dei rami di abete, tutti eravamo affaccendati e gioiosi. Spesso però sentivo il bisogno di rimanere sola, allora mi recavo nel bosco per pensare: fissavo lo sguardo sui rami scheletriti degli alberi che sembravano braccia imploranti. Mi fermavo accanto ai cespugli coperti dalla galaverna che li copriva di bianca trina, ascoltavo il fruscio del vento che movendo i rami gelati li scuoteva facendoli rabbrividire e gemere. Ascoltavo il silenzio che mi raccontava di una notte lontana nel tempo, di lunghissime attese, di speranze premiate e mi sentivo trasportare da questo saggio vegliardo in luoghi pieni di sole, là nella terra di Giuda, in un campo di pastori pazienti che, di notte in notte, fissando il cielo, speravano scorgere la stella nunziante la venuta del Messia. La vigilia. Avrei voluto che la mia gioia, i miei sentimenti, la mia luce avvolgessero tutto il paese, facendo ritornare il sorriso e la pace in tutti i cuori. Avrei voluto essere ricca per portare nelle case di chi aveva il focolare spento, la madia vuota, la tavola spoglia il necessario per vivere dignitosamente, avrei voluto far nascere il sorriso nei cuori gelati dal dolore….., ma ero solo un piccolo scricciolo, che saltellava qua e là, ma non possedeva che un cuore, forse più grande del suo magro corpicino. La sera della vigilia, seduta accanto al focolare, mentre il fuoco sprigionava fiamme e mitigava il rigore del gelo, assorta nella dolce attesa ascoltavo le campane che, festanti e gioiose, annunciavano al mondo il lieto evento. Il loro suono giungeva nelle valli, nelle forre, nei campi e nei boschi e, nella mia fantasia, immaginavo la terra coperta di una coltre luminosa, calda dove tutte la creature piccole e grandi, animate e inanimate si sentissero amate e protette. Il nonno rimaneva accanto a me, seduto sulla piccola sedia, al lato del focolare e, di tanto in tanto, attizzava il fuoco appoggiandosi, con una mano, agli alari. Anche lui stava il silenzio, forse ricordava i Natali passati quando, con la nonna, seduti nello stesso posto dove ci trovavamo noi, aspettavano la mezzanotte santa. Il mattino, quando l’alba non s’era ancora annunciata, accorrevo alla chiesa. Le strade buie si popolavano di figure imbacuccate con mantelli e scialli, tutti alla stessa meta: la chiesa. 150 151 Il S. Natale nella chiesa parrocchiale. Entrare nel luogo sacro era come entrare in paradiso! Fuori buio pesto, dentro un fulgore di luce. Mi dirigevo subito accanto al presepe, sempre lo stesso ogni anno e pure dalla gente definito un capolavoro sempre più bello. In realtà le statue erano sempre quelle, come pure la sacra Famiglia, ma lo spirito si vede che cambiava e si faceva sempre più mistico. Oh il bambino! Chi mi poteva staccare dal presepe? Gli occhi incollati alla capanna, il cuore che si faceva sempre più grande fino a dolermi, la dolcezza, la tenerezza e l’amore erano tutti in me e mi facevano gustare il paradiso. Quando alla fine il canto Tu scendi dalle stelle annunciava che la messa era finita, mi sembrava di scorgere una scia luminosa di stelle che partendo dal cielo, si veniva a posare sopra la capanna. Mi toglieva dall’incanto qualche gomitata che mi voleva scostare. C’erano altre persone che ambivano accostarsi al presepe e, a malincuore, dovevo cedere loro il posto. Nel pomeriggio, dopo le sante funzioni, quando tutti se n’erano andati, potevo accostarmi a quella visione che m’incatenava l’anima. Rimanevo lì tutto il pomeriggio, incurante del freddo, con gli occhi fissi alla culla e il mento appoggiato all’asse che reggeva tutto il presepe. A sera, quando il sagrestano veniva per chiudere la chiesa, faceva tintinnare le chiavi accanto le mie orecchie ingiungendomi di uscire. Tutta intirizzita lo seguivo, ma avevo negli occhi impressa quella culla e nel cuore una gioia soffusa di tenerezza, di infinita dolcezza e di accorata nostalgia. Mi sentivo ricca di gioie troppo grandi per tenerle tutte dentro di me. Ma con chi le potevo condividere? Con le stelle che ridevano in cielo, con la brina che ricamava le siepi, oppure con la collina che attonita e silenziosa sembrava pregasse?! A sera rimanevo sola seduta accanto al fuoco perché nel silenzio della notte mi era più facile immergermi nel mistero di Dio fatto Bambino. E così trascorrevano i miei Natali. Durante la mia lunga vita ho scritto tanti componimenti e poesie sul Natale, ma quelli più belli riguardano quegli indimenticabili della mia infanzia, vissuti nella povertà, così lontani ed immuni dalla profanazione consumistica e godereccia della solennità natalizia cui siamo oggi costretti, impotenti, ad assistere. Ecco alcune di quei componimenti. SULLO SCALINO CORROSO. Voglio ascoltare il Natale che arriva come faceva una volta, nell’aria impregnata di odori di povertà. Lo aspetterò Seduta sullo scalino Corroso dal tempo E dalle intemperie, dove mia madre, di sera, metteva, furtiva, una scodella di gialla polenta, e un po’ di formaggi, dicendo a noi bimbi: -Vedrete, qualcuno che ha fame, si fermerà! TRA LE PIEGHE DELL’ANIMA Tra le pieghe dell’anima lo tengo, coi profumi di canti e le preghiere, quel ricordo di fanciulla così caro di povertà, di gioie sante e vere. 152 Tutta raccolta l’armonia gustavo, nel silenzio del giorno che moriva ed il pensiero, di tenerezza colmo, al cielo immenso pian piano saliva. O ricordi intrisi di dolcezza, com’è dolce riposarvi accanto, con voi ritorno ancora un po’ fanciulla gustando di quel giorno il dolce incanto. Ora il Natale sembra triste e stanco, forse perché coperto è di tanti orpelli e al grande evento del Dio fatto bambino, gli uomini stolti preferiscono quelli. Piccolo bimbo, che all’uomo appari povero, mite, grande umiliato, ripeti al mondo, invaso da menzogna, che solo dal tuo amor sarà salvato. RICORDI ERNESTA? Ricordi Ernesta, quando all’imbrunire tra gli stecchi di rovo ti cercavo, e tu ridevi di gioia al mio scostare con trepido timore quelle spine. Insieme cercavamo il pungitopo dalle bacche di fiamma, con le puntite foglie che stringevi con mani callose senza timore di ferirti ancora. Il silenzio del bosco era interrotto dai nostri passi calpestanti il suolo coperto di foglie ben ghiacciate e scricchiolanti di muto dolor. Il verde muschio liscio e vellutato 153 staccavi dalla roccia con tremore e quasi ti scusavi per quell’atto che privava quel sasso di beltà. Era per il presepe poveretto con un pastore e qualche pecorella, e quella povertà a te sorella dolcezza immensa donava ad ogni cuor. Ricordi? In chiesa la novena antica si cantava implorando a tutto cuore, mentre la solenne voce dei profeti parlava di salvezza, pace, amore. Galaverna, neve, e gelo intorno ornavano gli sterpi irrigiditi di preziosi ricami, di bianchi veli, di gemme favolose, che il ladro non ruba e di festoni per la notte più bella, e la più attesa. Il tuo scialletto ben bucherellato appena ti copriva il corpicino minuto e snello, ruvido e segnato col marchio d’un lavoro aspro e duro. Il vento entrava nella tua cucina ravvivando la fiamma al focolare gemendo e borbottando tra fessure, e sulla cappa del camin vetusto. per ascoltare i suoni della valle, o per capire se le tue bestiole, sazie di mentastro e di buon fieno placidamente facessero il lor sonno. Ronfavano i gattini acciambellati nella cenere calda e sui gradini della scala sconnessa del solaio. Guardinga mi porgevi un bicchier dal fosco vetro con dentro un po’ di vino fatto con l’uva della scarna vite piantata sulla roccia in faccia al sole. Ernesta, ogni Natale ho nostalgia di te, dei boschi, e i prati, e della tua stamberga, delle tue mani ruvide, incallite, che lievi carezzavano il mio volto, lasciandomi il profumo buono e santo, del tuo affetto che sento ancor nel cuore e che infondemi coraggio e forza nel dolore. (L’Ernesta, i suoi prati, la sua casa, il suo tenore di vita così povero, semplice, la sua preghiera mi aiutava ogni anno a prepararmi in maniera speciale al Santo Natale). NADALE Di tanto in tanto all’uscio t’affacciavi Nadale, che belo Che festa de amore, come chel bate sto picolo core, na gioza de brosema me incanto a vardare, on oseleto me fa anca criare, se sente ‘nte l’aria qualcosa de fìn, 154 155 Il pentolino ormai corroso e nero di caligine antica, mai raschiata, sulla calda cenere e la brace teneva per te in serbo una brodaglia per riscaldar lo stomaco sfinito. qualcosa che parla del bocia divìn e tuti se varda coi oci che sluse se frena la lengua che taja e che cuse, ma solo parole de tanta bontà se conta ogni omo, che ben che se sta! IL NATALE PERDUTO Dove sei Natale dei miei sogni dei desideri ardenti, della fiamma accesa al focolare e dentro al cuore? Natale dei miei sogni e dei sospiri che trepidi affollavano il mio petto, se guardo attorno più io non ti vedo, anche il profumo che sempre ti seguiva, io non avverto più nei sensi miei. Oh, bel Natale dell’infanzia mia tutto dolcezza e tutto poverello, dimmi perché la veste semplice hai mutato? Oppur qualcuno te l’ha strappata via? Eri vestito di muschio e di fuscelli le povere lanterne miserelle spandevano un chiarore mite e fioco. Un’armonia tutta pastorale era il belato di bianche pecorelle, col muggito dei buoi, là nelle stalle. O bel Natale, come t’han conciato! sembri un pupazzo pieno di lustrini, che offuscano il chiarore della grotta e lo stupito incanto dei bambini. 156 Il capodanno. L’ultimo giorno dell’anno non c’erano feste e non ricordo d’essere rimasta alzata per attendere l’anno nuovo, invece era un po’ rumoroso il primo giorno dell’anno. Dopo la prima Messa, una processione di uomini veniva a porgere gli auguri a casa nostra. Lo zio preparava sulla tavola della cucina una bottiglia di grappa ed offriva a ciascuno un bicchierino di quel forte e bruciante liquido. Qualcuno lo inghiottiva tutto d’un fiato, senza scomporsi, qualche altro strizzava gli occhi o torceva la bocca. Tutti, però, lo accettavano, era un po’ raro averne a quei tempi. Zia invece preparava una manciata di monete, le metteva su un piccolo contenitore e ne dava una a ciascun bambino che veniva a ripetere la cantilena: - Buon principio dell’anno!Buon principio dell’anno! I grandi facevano qualche sbronza e noi piccoli ci divertivamo a guardarli. Le donne non potevano entrare nelle case a porgere gli auguri, perché si credeva portassero sfortuna. Ricordo che una mattina di un primo giorno dell’anno, mentre mi recavo alla messa, vedendo una donna, e credendo di farle piacere le feci gli auguri. Non l’avessi mai fatto. Si fermò di botto e, tutta inviperita, cominciò ad insultarmi dicendo che le avrei portato sfortuna per tutto l’anno, e dovevo saperlo che ad una donna, un’altra donna non avrebbe mai dovuto fare gli auguri. La guardai disorientata, ma questa non si addolcì, dovette trascorrere tutto l’anno prima che mi sentissi guardata ancora con una certa benevolenza da quella megera. L’Epifania. Anche la festa dell’Epifania esercitava un fascino speciale in me ma non per la Befana, bensì per i Re Magi. Credevo che una volta o l’altra sarebbero venuti anche a Toara. Ricordo una vigilia di tale festa, ero convinta che quella sera sarebbero venuti. Senza avvisare in casa, al tramonto, m’incamminai verso la collina. Il cielo era terso e il sole aveva lasciato lunghe scie di colori dalle mille sfumature. Correvo, ma più ancora correva il mio cuore. Mi fermai nel grande spazio che si estende a lato della casa dei Soterni, che allora era abitata da mamma Angela e suo figlio Berto. Guardavo lontano fino dove lo sguardo poteva spaziare e rimasi immobile per ore finché il buio m’avvolse e il freddo pungente cominciò a pungermi e ad intirizzirmi tutta. Gli Angeli avevano già cominciato ad accendere le stelle e la luna a passeggiare per il cielo quando, capii che anche quella sera non sarebbero venuti. E me ne tornai pensosa al paese. Pure la Befana a quei tempi era molto povera, i suoi doni li metteva dentro le 157 nostre calze con parsimonia. Portava qualche piccola mela, due arance, un cartoccio di fichi secchi e qualche noce. Qualche volta c’era il carbone, quello vero e qualche tutolo di pannocchia, che gettavamo lontano indispettiti.-Ecco- dicevano i grandil’Epifania ogni festa la si porta via…… EPILOGO Fine della scuola E venne il tempo che dovetti lasciare la scuola. Leggevo e leggevo, ma mi mancava un maestro. Fosse stata in vita la nonna, m’avrebbe certamente aiutato, ma appena andò in pensione, morì. Io non la conobbi. Scuole medie nei dintorni non ce n’erano. Lo zio disse che non poteva mantenere in collegio quattro ragazzi, e far proseguire gli studi a uno solo di noi non gli sembrava giusto. Così me ne dovetti rimanere a casa ad aiutare e, nelle ore libere, a leggere e scrivere qualche cosa. Ma un giorno il Parroco venne dagli zii per dire che in un orfanotrofio a Vicenza, tenuto dalle Suore di Maria Bambina, mi avrebbero accolta e così avrei potuto frequentare una scuola in città con le altre orfane. Ero felice: finalmente avrei potuto continuare gli studi e imparare un’infinità di cose nuove. Un nuovo orizzonte mi si apriva dinanzi! Mi condussero a Vicenza, dalle suore di Maria Bambina, mia sorella Maria e Pasqua, la figlia di Teresa e Vittorio Gassa. La strada fino a Ponte di Barbarano la facemmo a piedi, poi, la famosa vaca mora, cioè il treno, ci portò a Vicenza. I primi giorni ero un po’ disorientata, poi mi abituai. Attendevo con ansia il giorno in cui le suore m’avrebbero fatta uscire con le altre ragazzine per incominciare anch’io la scuola, ma i giorni passavano senza che si accennasse a ciò che m’interessava. Vedevo le altre uscire, a me nessuno parlava di scuola. Eravamo lasciate a casa in due. Per comando di una suora dovevamo tenere in ordine alcune stanze: spazzare, spolverare, ecc… Un giorno mi feci coraggio e chiesi alla suora che ci seguiva sempre quando m’avrebbero portata a scuola con le altre. Si fermò, mi squadrò bene da capo a piedi, poi, con tono ironico mi rispose così: - Tu studierai solo quando avrai vent’anni, ma esclusivamente se ti farai suora... Rimasi senza fiato. Aspettare fino a vent’anni? Farmi suora? Ma come potevo sapere se avrei avuto 158 159 la vocazione? Quelle parole mi fecero crollare il mondo addosso, e divennero un’ossessione! Ma allora cosa mi avevano detto? Cosa avevano dato ad intendere al parroco?! Seguì un periodo di profonda tristezza, delusione, sofferenza. Le suore dovettero accorgersi alla fine del mio profondo malessere, ma anziché risolverlo incoraggiandomi ed aiutandomi nella prosecuzione degli studi, preferirono avvisare la mia famiglia, solo perché i miei parenti venissero a prendermi per riportarmi a casa. Non so se tutti gli istituti per le orfane facessero così allora, certo che per me fu una ferita che mi portai dentro per tutta la vita, anzi posso dire che solo da poco tempo mi sono riconciliata col mondo delle suore, e sono in grado di raccontare questa storia con serenità. Era stata infatti una grande sconfitta, ed una grande delusione, sia per me che per i miei famigliari. Il mio sogno s’era infranto, ed ora giaceva nel fondo del mio cuore, con le ali strappate, perché ero stata illusa così? Tornata a casa il mio villaggio, le case, le persone, tutto mi pareva divenuto diverso, l’avevo lasciato pochi mesi prima; in fondo ero stata via da casa solo poche settimane, eppure tutto mi pareva mutato. Il fatto è che io ero cambiata, era finita definitivamente la mia fanciullezza, quell’esperienza mi aveva insegnato che non era più tempo di sognare. Allora si cresceva in fretta, e non c’era tempo per rimanere a lungo bambini. La magia incantata della vita era svanita dai miei occhi, in poche settimane, ed ora la vita era lì, davanti a me, dura ed impegnativa. Ormai avevo compreso sin troppo bene che nessuno, nella vita, m’avrebbe regalato nulla per niente, anch’io come gli altri avrei dovuto sbrigarmi a divenire grande in fretta. Divenni adolescente, e dopo alcuni anni ebbi anch’io la possibilità di studiare e di diplomarmi…... Ma quelli sono altri ricordi! APPENDICE IL NATALE DI ADNIL Novella. Ho ritenuto utile collocare qui in appendice una mia novella: mi è assai cara. Essa riferisce i sentimenti profondi, e quasi inesprimibili, d’una bambina durante le celebrazioni natalizie, è una visione onirica che esprime molto di quello che portavo nel cuore da fanciulla. La fatica di esprimere queste realtà così profonde premute dentro il mio cuore, e la loro quasi indicibilità, fu per me motivo costante di sofferenza nella mia crescita di ragazza. Poterlo comunicare ora forse può aiutare qualche adulto a comprendere quali sentimenti si possono nascondere nel cuoricino di un bimbo… Quando le foglie cominciavano a cadere dagli alberi, le giornate ad accorciarsi, il vento a soffiare, ed i camini delle case a soffiare, un brivido di esultanza scuoteva il corpicino di Adnil. -Ecco – diceva tra sé la bimba- Natale arriverà presto, sento la sua voce tra i rami sbattuti della bufera, sento il suo canto fra le stelle che affollano il cielo blu e le fa ridere di gioia, sento il suo profumo nell’aria che, gelida e frizzante, mi accarezza le guance…e il piccolo cuore di Adnil si riempiva di gioia, tenerezza, amore. Poi arrivava il tempo della novena, e Adnil correva alla chiesa al primo tocco delle campane. In un lampo attraversava il piccolo paese che odorava di fritto, e di polenta appena rovesciata sul tagliere, sentiva il frignare dei bambinetti, numerosi a quei tempi, unito al muggito delle mucche, al belar delle pecore, ed all’abbaiare dei cani fedeli, un insieme di note che formavano l’armonia della vita quotidiana. Correva, correva incurante del freddo piuttosto rigido. La chiesa non veniva riscaldata ma era sempre piena di bimbi, uomini, donne, che pregavano cantando gli oracoli dei profeti…L’anima della bimba veniva sommersa da un mare d’inesprimibile dolcezza e rimaneva muta, incapace di unire la sua voce, al coro de fedeli. Tutto il suo essere cantava, era tutto un canto d’amore, di fede, di gioia. Troppo grande il pensiero che la riempiva, immenso il mistero che la rapiva! Quando usciva dalla chiesa il gelo le paralizzava i muscoli del viso, le arrossava e gonfiava le mani, i piedi erano pezzi di ghiaccio, ma lei non sentiva, il suo cuore bruciava d’amore, c’era solo la gioia e il calore dell’attesa della festa più bella. Le case erano poco riscaldate, i vestiti inadeguati a proteggere dal freddo. Alla sera la piccola sedeva sulla pietra corrosa del focolare e, mentre fissava la fiamma, che si perdeva in mille faville ingoiate dal camino, pensava alle parole dei salmi e delle antifone, e immaginava i profeti mentre annunciavano ai popoli la venuta del Messia. 160 161 Adnil era per natura silenziosa, i sentimenti, le emozioni, le sensazioni che le riempivano il cuore e l’anima non riusciva ad esprimerle, teneva tutto dentro di sé, perciò i compagni, le persone del paese, gli stessi famigliari, la ritenevano scontrosa e scostante, invece lei avrebbe voluto condividere la gioia e l’entusiasmo che l’arrivo del Natale e di altre festività portavano nella sua vita. Nei gelidi pomeriggi che precedevano il Natale Adnil correva sulla collina per vedere gli alberi scheletriti ed irrigiditi dal gelo, si fermava a fissare la galaverna (brina) che copriva di bianchi ricami quei rami spogli di foglie come volesse nascondere quell’estrema nudità donando loro una bellezza nuova. La piccola rimaneva incantata, era convinta che il bosco, le piante, i viottoli, i cespugli di spine, e di rovi, immersi in quel candore, pregassero in silenzio attendendo riverenti la nascita di Gesù. Ai tempi di questo racconto, nel piccolo paese di Adnil, non si preparavano gli alberi di Natale e, nelle case, nessuno costruiva il presepe. Si era molto poveri allora. Il presepe però veniva allestito in chiesa. La piccola si rendeva utile trasportando rami, qualche sasso e muschio. Ogni anno si sentivano le stesse parole quando la gente, il mattino di Natale, entrava in chiesa, diceva: quest’anno il presepe è molto più bello dell’anno scorso. Ma i personaggi erano sempre gli stessi, le casette non venivano cambiate, la capanna, l’angelo, le pecore, lo scenario che faceva da sfondo forse si presentavano un po’ più malandati, ma erano, anche quelli, sempre gli stessi. Spesso accadeva che alla vigilia scendesse, abbondante, la neve. Il paese di Adnil era proprio come un presepe. La bambina esultava di gioia perché nell’immenso silenzio le sembrava di udire gli angeli annunzianti l’imminente nascita di Gesù. Rimaneva con il naso appiccicato ai vetri della finestra, incurante dei richiami, più o meno gentili, che la volevano interessata ad altro. Al mattino del giorno tanto atteso, in un lampo, si alzava per recarsi alla prima messa, quando ancora il buio fasciava il paese, ma la chiesa, all’interno, era tutta illuminata. Sembrava che, con il Bambino Gesù, fosse entrato un sole fulgidissimo. Correva Adnil accanto al presepe, il cuoricino scoppiava di gioia, la commozione s’impadroniva della sua anima semplice, ardente e lo stupore le faceva spalancare gli occhi e socchiudere le labbra. Il bambino era lì, sorrideva a lei, piccola bimba, dal cuore troppo grande, e gonfio di emozioni, che la schiacciavano. A casa il pranzo natalizio era più abbondante degli altri giorni. Zia preparava il dolce, ma niente di più. Doni, pacchi da sciogliere sotto l’albero scintillante, viaggi, vacanze…. erano cose inimmaginabili a quei tempi. Ma c’era la gioia, tanta gioia che rallegrava l’anima. Nel pomeriggio di quel giorno Adnil, dopo le sante funzioni, si accostava al presepe, il mento appoggiato al muschio, gli occhi incollati su quella visione pastorale, non udiva e non vedeva nient’altro. Rimaneva lì fintantoché 162 il sacrestano faceva che tintinnare le chiavi vicino alle sue orecchie e impaziente, la invitava ad uscire. Lei come una sonnambula, camminava dietro all’uomo che borbottava chissà quali gentilezze. Il cuore però lo lasciava lì, accanto alla culla. Arrivata a casa nessuno le chiedeva dove era stata fino a quell’ora, ingoiava qualcosa, poi sedeva su di una piccola seggiola accanto al focolare e rimaneva zitta incurante di tutto ciò che la circondava. Una sera di Natale rimase alzata finchè il ceppo fu tutto consumato. S’era scatenata una bufera violenta, il vento soffiava e dal camino sembrava scendessero lamenti, fischi, rumori che mettevano brividi. Adnil pensava ai pochi uccelli che non se n’erano andati nei paesi caldi, avrebbe voluto mettersi lo scialle e correre sotto gli alberi alla ricerca di qualche passerotto privo di forze per portarlo accanto alla cenere calda e dargli un po’ di latte, ma non poteva. Pensava alla Maria, quella che abitava nella casa dalle imposte rabberciate alla meglio, con i vetri che lasciavano passare non solo gli spifferi, ma anche il vento. Avrebbe voluto portarle una delle coperte che coprivano il suo letto, ma la sua sorellina se ne sarebbe accorta perché dormivano insieme. Avrebbe voluto recarsi nella fredda cucina di Tita per tenergli compagnia. Il vecchio era sempre solo e triste… Avrebbe voluto… ma lei era una povera, piccola bambina, con il cuore che le doleva nel vedere le altrui sofferenze. Soffriva per gli uomini, ma soffriva pure per gli animali, per la natura tutta, anche per le foglie calpestate e che sembrava gemessero quando venivano schiacciate dagli uomini che si recavano nel bosco. Pensando a tutte quelle sofferenze la bimba salì le scale cercando di non farle scricchiolare. S’infilò nel letto accanto alla sorellina. Quella notte, quando finalmente il sonno la vinse, sognò un angelo bellissimo che, chinato su di lei, toccandole il petto, le toglieva il cuore. Adnil guardava l’angelo attonita e muta, il cuore intanto diventava sempre più grande, ma così grande da riempire tutta la stanza. Improvvisamente da quel cuore enorme, uscirono velocemente, tanti piccoli cuoricini, tutti rossi e luminosi, che si posavano sui tetti della case, entravano in chiesa, salivano sulla collina e si fermavano sulle piante coperte di neve, illuminandole di luce meravigliosa. L’angelo, dagli occhi ridenti, disse ad Adnil: -Tu vorresti aiutare tutte le creature, ciò è impossibile per te, ma il Signore ha veduto il tuo cuore, ha veduto la tua anima, sa che soffri per tutti, anche per lui bambino. E’ molto contento ed ha voluto ringraziarti mostrandoti il tuo cuore moltiplicato in un numero che non si può contare. L’angelo sparì e la bambina si addormentò felice. Il giorno seguente tutti coloro che incontrarono Adnil si accorsero che i suoi occhi avevano una luce nuova, bella e serena. Ma lei, per lunghissimi anni, tenne chiuso nel suo piccolo- grande cuore il bel segreto. 163 L’autrice LINDA DE MARCHI maestra elementare in pensione, ha diviso la sua vita tra i nativi Colli Berici, è infatti nata e cresciuta a Toara di Villaga, nel basso vicentino, ed il paese di Altissimo nella Val di Chiampo, dove andò a vivere negli anni ottanta, ha vissuto per un periodo anche a Sossano, non lontano dalla casa paterna. Ha al suo attivo un’altra pubblicazione dal titolo L’Amen della vita in cui parlò, con parole semplici e toccanti, della sua unione matrimoniale col marito Tony Dal Cengio. Con il patrocinio COMUNE DI VILLAGA COMUNE DI SOSSANO
Scarica