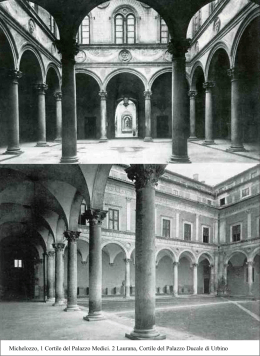LADOMENICA DIREPUBBLICA DOMENICA 7 APRILE 2013 NUMERO 422 CULT Ci hanno abitato trentuno papi, quattro re e undici presidenti In attesa di sapere chi sarà il prossimo inquilino All’interno La copertina Dai romanzi ai nuovi saggi la storia riscritta con i “se” viaggio tra i segreti del Quirinale UMBERTO GALIMBERTI e SIEGMUND GINZBERG Il libro La fiaba neorealista di Evelina bambina tra fate e partigiani CASA LA ALESSANDRA ROTA DEGLI ITALIANI Straparlando Vittorio Sermonti “Leggendo Dante so che la morte non esiste davvero” DISEGNO DI MASSIMO JATOSTI FOTO © EMANUELA DE SANTIS / ANZENBERGER / CONTRASTO ANTONIO GNOLI Il reportage FILIPPO CECCARELLI Ho incontrato una kamikaze a Kabul B MONIKA BULAJ La storia Archeotennis la grande scoperta delle sei “balette” GIANNI CLERICI ROMA ellissimo, grandissimo, costosissimo, ingombrante e un po’ vuoto, il palazzo del Quirinale, detto anche di Monte Cavallo per via delle statuone dei Dioscuri con relativi destrieri che maestosamente lo fronteggiano, è impiantato a 57 metri e 20 centimetri sul livello del mare e nonostante sia di poco più basso dell’Esquilino è da tutti considerato “il colle più alto” — il che già dice abbastanza sui provvidi equivoci, ma anche sulle nefande e indispensabili ambiguità del potere. Sarebbe giusto che fosse per davvero la Casa degli italiani, come la definiva Carlo Azeglio Ciampi. In realtà è molto di più, il Quirinale, e parecchio di meno, o di peggio, se si vuole: città proibita, gabbia dorata, caserma di lusso, museo d’arte e di capricci, crocevia inesorabile di nevrosi, grand hotel a tempo. Vi hanno abitato trentuno papi, quattro re sabaudi, undici presidenti della Repubblica. L’imperatore Napoleone, per il quale il palazzo venne ancora una volta riccamente decorato, non ha fatto in tempo a mettervi piede. In compenso dopo il sisma del Belice (1968) Saragat volle ospitare sedici famiglie di terremotati. Una giovane coppia procreò e il presidente fece da padrino al piccolo, battezzato Giusep- pe. Come succede, fu poi molto complicato per l’amministrazione riprendere possesso degli appartamenti. Con ispida diffidenza piemontese Vittorio Emanuele III definiva il Quirinale “Ca’ preive”, la casa dei preti. Dopo aver sfrattato il pontefice, temeva evidentemente la doppia maledizione di don Bosco («gran funerali a corte») e Pio IX (dopo la presa di Roma ci furono in effetti alluvioni, epidemie e «flagelli — chiosò il pontefice — cui sembra che Dio abbia dato libero corso»). Quando anche i re sabaudi furono cacciati, nel 1946, lasciarono un debito di 165mila lire «per fornitura distintivi nodo di Savoia e corona», che la neonata Repubblica saldò con la vendita dei pinoli della tenuta di San Rossore. La nuova classe dirigente, in primis Andreotti, aggiornò il sortilegio, sia pure limitandolo ai presidenti Dc: oblìo per Gronchi, infarto per Segni, dimissioni per Leone, sofferenza per Cossiga; tutto sommato Scalfaro se l’è cavata. Ma in termini di potere l’incantesimo pare estendersi anche a chi troppo agogna il Quirinale e quindi mai l’otterrà. Lungo l’elenco: Sforza, Merzagora, Fanfani, Moro, Spadolini, lo stesso Andreotti e anche Berlusconi che tre anni orsono, per l’ennesima volta chiamato a commentare l’ipotesi di una sua ascesa al Colle, si toccò scaramanticamente i testicoli, a riprova dell’energia magica e un po’ pazzoide che si tira appresso quel luogo, e non solo in Italia. (segue nelle pagine successive) Il teatro L’Odissea secondo Wilson è una favola triste fatta di luci RODOLFO DI GIAMMARCO L’arte Il Museo del mondo Ecco l’Uomo vitruviano MELANIA MAZZUCCO Repubblica Nazionale DOMENICA 7 APRILE 2013 LA DOMENICA ■ 30 La copertina 4 La casa degli italiani “Chi troppo lo agogna mai lo avrà”, dice una delle tante leggende che lo circondano. Dalla maledizione di Pio IX ai trenini di Gronchi, dal letto di De Gaulle alle microspie di Segni, tour guidato tra le sfarzose stanze di un Palazzo sempre più al centro della scena 1 1. IL TORRINO Fu Gregorio XIII, nel 1583, a chiedere al Mascarino di progettare una torre sul punto più alto del suo palazzo. Nel 1967, in occasione della visita di De Gaulle, il presidente Saragat vi inaugurò la spettacolare sala da pranzo “Belvedere” ancora oggi utilizzata per colazioni ristrette. Sul pennone, sopra le due campane e l’orologio, sventola il tricolore. Accanto, appena più in basso, lo stendardo presidenziale e la bandiera dell’Europa 2 3 2. LO STUDIO Nella sala d’angolo all’estremità del palazzo, il Presidente incontra i capi di Stato e i segretari di partito in occasione delle consultazioni Gli appartamenti presidenziali si trovano alle spalle dello studio, verso i giardini: li hanno utilizzati le famiglie Einaudi, Gronchi, Segni, Saragat, Ciampi e Napolitano (il cui appartamento privato è poco lontano, in vicolo dei Serpenti) 11 3. LA VETRATA Nella Loggia d’onore, nota come “La Vetrata” per via dei cinque finestroni affacciati sul Cortile, i leader politici rilasciano le loro dichiarazioni alla stampa dopo l’incontro con il Presidente È in quest’ala del palazzo che si trova anche la famosa scala elicoidale del Mascarino FILIPPO CECCARELLI (segue dalla copertina) el periodo della follia più acuta (1888-89) Nietzsche scrisse del resto al suo amico Gast: «Il mio indirizzo non lo so più: poniamo che per il momento possa essere il palazzo del Quirinale». Di lì a poco, cantando canzoni napoletane, fu trasferito a Basilea, ma il filosofo si era convinto di essere il re d’Italia e giustamente non intendeva rinunciare a quella reggia dove pure — e ancora adesso, in omaggio allo specifico nazionale — la magnificenza finisce per convivere con un clima un po’ da operetta. Fino a qualche anno fa la facciata dell’edificio era rossiccia, dal 2002 ha ripreso l’originale tinta bianco travertino che polemicamente Sgarbi ha designato «color meringa», e che fa il suo effetto soprattutto nelle giornate in cui il cielo è molto blu. Sul pennone sventola anche la bandiera della presidenza della Repubblica che Cossiga, appassionato vessillologo, ha ridisegnato di persona, pure imponendola alla magnifica Flaminia decapottabile su cui il presidente appena eletto fa il suo primo giro per Roma. Nel 1920 il Quirinale fu sorvolato dall’aviatore dannunzian-futurista Guido Keller che vi precipitò delle rose rosse «per la regina e il popolo in segno d’Amore». Analogo omaggio floreale fu gettato sul Vaticano, «per frate Francesco», mentre il palazzo di Montecitorio N 11. LE QUATTRO SALE Dalla Sala d’Ercole si passa a quella detta degli Ambasciatori (usata per ricevere diplomatici e capi di Stato), quindi alla Sala d’Augusto e infine alla sala Gialla. Due anni fa i lavori di restauro hanno portato alla riapertura delle finestre prima tamponate I SEGRETIDEL QUIRINALE ebbe in dono un pitale ripieno di carote e rape. Non molto tempo fa è stato proposto di ribattezzare l’area antistante al Quirinale “Piazza degli italiani”. Proposito fortunatamente scartato. Come spesso capita nella Città Eterna, all’ombra dell’obelisco, di Castore e Polluce e dei loro cavalli di marmo si contemplano ricordi belli e brutti. Per rimanere al passato prossimo, nel 1944 durante una dimostrazione un manifestante si fece scoppiare una bomba in faccia e il cadavere del poveretto, issato su un camioncino, prese a girare per Roma fino ad essere depositato al Viminale. Ma durante il settennato di Ciampi, sempre in piazza, furono allestiti concerti e spettacoli all’aperto, anche la notte di Capodanno, condotti da Paola Sa- luzzi. Negli ultimissimi tempi vale ricordare la folla che ancora in questo spazio festeggiò la caduta di Berlusconi al suono dell’ Hallelujah di Handel, ma anche con un rapido lancio di monetine e sembra pure di una scarpa sull’automobile del Cavaliere. Ogni giorno si può assistere al cambio della guardia. Di tanto in tanto viene qualcuno a protestare, anche disperatamente. Nell’ottobre scorso un autotrasportatore rumeno, disoccupato e con cinque figli, si è spogliato e si è dato fuoco. Il cortile d’onore è molto vasto. Là dove Grillo due settimane orsono si è fatto la foto-ricordo con i capigruppo del M5S, qualche secolo fa il primo maggio si impiantava l’Albero della Cuccagna ed erano allestite feste cui partecipavano anche trentamila persone. Pure i lus- sureggianti giardini del Quirinale coprono un’area così vasta che in passato alcuni funzionari si prendevano lo sfizio di attraversarli a cavallo. È qui che di norma si ambienta il ricevimento del 2 giugno. Saragat volle aprire la festa della Repubblica a migliaia e migliaia di comuni cittadini, però in quel caso sparivano troppi cucchiaini e una volta, a party concluso, dentro una siepe di mortella venne rinvenuta una signora ubriaca come una cocuzza, come si dice. La descrizione di un ricevimento al Quirinale, però svoltosi al chiuso, è presente nel romanzo postumo di Pier Paolo Pasolini, Petrolio: “In cerchi concentrici attorno al Capo dello Stato, il verminaio era tutto un agitarsi di capini ora pelati ora canuti, ora folti ora radi: ma tutti assolutamente dignitosi”. All’interno del palazzo, pure segnato da un’indimenticabile scala elicoidale a misura di cavallo, opera del Mascarino, domina lo sfarzo e si accresce lo stupore, quest’ultimo stimolato da impreviste presenze e stranianti tipo mobili cinesi e salottini giapponesi. I corridoi degli uffici sono talmente larghi lunghi e lucidi che come in un film lo storico Segretario Generale Gaetano Gifuni, soprannominato “Prudenziano”, li percorreva silenziosamente in monopattino. Gli appartamenti presidenziali sono stati utilizzati dalle famiglie Einaudi, Gronchi, Segni, Saragat, Ciampi e Napolitano. In quelli degli ospiti, fra i tanti hanno dormito Hitler, in compagnia di un busto di Augusto acquistato per l’occasione; e poi de Gaulle, per il quale fu costruito un enorme lettone, ma solo Repubblica Nazionale DOMENICA 7 APRILE 2013 ■ 31 4. I GIARDINI 6. IL SALONE DELLE FESTE Padiglioni, fontane, statue impreziosiscono i lussureggianti giardini del Quirinale In fondo, di fronte alla Fontana di Caserta, l’elegante Coffee House Gigantesco (il tappeto di 300 mq che ne ricopre i pavimenti è considerato il più grande d’Europa) ospita le cerimonie che prevedono un elevato numero di invitati Qui si tiene anche il giuramento del nuovo governo e si allestisce la tavola per i pranzi di Stato I PRESIDENTI Enrico De Nicola 1946~1948 5. LA SALA DEGLI SPECCHI Qui si svolgono alcune udienze del capo dello Stato e il giuramento dei giudici della Corte Costituzionale Luigi Einaudi 1948~1955 Giovanni Gronchi 1955~1962 5 Antonio Segni 1962~1964 ILLUSTRAZIONE DI FRANCESCO CORNI 6 8 Giuseppe Saragat 1964~1971 Giovanni Leone 1971~1978 7 Sandro Pertini 1978~1985 7. LA MANICA LUNGA ll primo tratto del lato sud del Quirinale fu iniziato da Sisto V per ospitare le abitazioni della Guardia Svizzera. Al piano nobile gli Appartamenti Imperiali, sedici stanze e quattro foresterie, ancora oggi destinati ad alloggiare gli ospiti in occasione di visite di Stato 9 Francesco Cossiga 1985~1992 Oscar Luigi Scalfaro 8. LA SALA DEI CORAZZIERI L’attuale denominazione si deve alla rivista del reparto dei Corazzieri che qui si tiene in occasione di alcune importanti cerimonie. Date anche le vaste dimensioni, nel salone hanno luogo molte delle attività di alta rappresentanza del Presidente 10 9. LA CAPPELLA PAOLINA In occasione delle feste di Natale e di Pasqua qui viene celebrata la messa alla presenza del Presidente A doppia altezza, ha le stesse caratteristiche e proporzioni della Cappella Sistina in Vaticano È qui che si tengono ogni domenica i “Concerti del Qurinale” 10. IL BALCONE Si affaccia sopra il portone principale sulla piazza del Quirinale Qui sono esposti i tre stendardi: della presidenza (che “segue” ovunque il Presidente) d’Italia e d’Europa perché il leader francese era un gigante. In occasione di quella visita (1967) Saragat inaugurò il Torrino, la torre dell’orologio rifatta con materiali originali tardo cinquecenteschi, insediandovi la più alta e spettacolare sala da pranzo da cui si domina l’Urbe a 360 gradi. Saragat ebbe scontate critiche per gli acquisti massivi di champagne Krug, peraltro non italiano. Così come anche più fastidiose ne aveva dovute subire Einaudi per via del vino che produceva in Piemonte e con cui riforniva le cantine del Palazzo: in una vignetta Guareschi, che proprio per questa fu condannato alla galera, lo raffigurò mentre passava in rassegna delle bottiglie come se fossero corazzieri. Uno di questi ultimi, mezzo secolo dopo, si infatuò di Mariana Scalfaro, fastidiosamente chiamandola di continuo con uno dei primi telefonini, ma fu presto messo al suo posto. Fra i capricci di Gronchi si annovera una sala interamente dedicata ai trenini elettrici e l’allestimento di una fantomatica, chiacchieratissima porticina sul retro del palazzo, da cui la leggenda che fosse riservata a giovani amiche per bunga bunga ante litteram. Donna Ida Einaudi si dedicò ai 200 preziosi orologi, molti a pendola, favorendo una com- plessa e quotidiana opera di sincronizzazione. A Cossiga si deve un centralino a prova d’intercettazione, una “Sala Situazione” iper tecnologica e l’esposizione, previo recupero dalle cantine, del trono dei Savoia, già appartenuto a Maria Luisa d’Austria. Per la verità il presidente picconatore spedì anche in Vaticano il Segretario Berlinguer per ottenere il trono papale, ma invano. Segni, su cui ebbero una certa influenza consiglieri militari, poliziotti e generali dei carabinieri, aveva un po’ il vizio delle microspie. Nei suoi colloqui politici Scalfaro coltivava invece il vezzo di un registratore tenuto acceso in bella posa su un tavolinetto. Sul soggiorno dei Leone al Quirinale, dalla Cederna a Mino Pecorelli, si è scritto molto, anzi troppo e almeno a dar ret- ta ai processi pure ingiustamente. Pertini aprì le porte ai giovani, espose i Bronzi di Riace e invitò a pranzo quelli del settimanale satirico Il Male che con dissacrante ribalderia si presentarono avendo in tasca una canna già pronta, ma poi non l’accesero perché a tavola il presidente se ne uscì: «Droga leggera o pesante, io darei a tutti la pena di morte». Per il resto, che è ancora tantissimo, il Palazzo offre inesauribili risorse narrative. Basti pensare ai tesori d’arte che esso esibisce e al tempo stesso un po’ nasconde: 300 dipinti antichi, 2000 opere dell’Ottocento e del Novecento, 261 arazzi, 38mila pezzi di porcellana, capolavori di ebanistica e menuisiers, più 90 carrozze, una splendida collezione di livree, e tappeti, argenti, maioliche, cristalli, bronzi, stampe, marmi classici. 1992~1999 Carlo Azeglio Ciampi 1999~2006 Giorgio Napolitano 2006~in carica Xxx xx Yyyyyy 2013~2020 Neanche a farlo apposta, in questi giorni è aperta una mostra sui “Capolavori ritrovati” del Quirinale. Anche il sottosuolo offre infatti sorprese archeologiche che a loro volta aprono il campo a indizi, coincidenze e cortocircuiti che ci si farebbe anche scrupolo a sottolineare, ma tant’è. Per cui i dieci Saggi o Facilitatoresnominati da Napolitano si riuniscono a Palazzo Sant’Andrea, e forse non tutti sanno che proprio lì sotto è resistita nei millenni l’ara che delimitava le fiamme dell’incendio appiccato da Nerone nel 64 dc, e su cui fin dai tempi di Domiziano si facevano sacrifici per scongiurare fuochi violenti e incontrollati come quelli che s’intravedono nell’infiammabile Italia della primavera 2013. © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale DOMENICA 7 APRILE 2013 LA DOMENICA ■ 32 Il reportage Sotto il burqa “È accaduto in un giorno di sole e di polvere a Kabul, dentro un piccolo santuario in cui non si respirava...” Lo straordinario racconto della fotografa polacca che partita per l’Afghanistan in cerca del sacro incrocia il volto più crudele della guerra Ho incontrato la donna kamikaze MONIKA BULAJ H KABUL o incontrato la donna kamikaze un giorno di sole e di polvere, in un piccolo santuario, oltre una piccola porta di legno, in una strada che non saprei ritrovare nel labirinto della vecchia Kabul. Mi si è avvicinata tra una folla di donne, accanto al sarcofago di un santo, una tomba di marmo coperta di tessuti con scritture dorate. Da quel momento non ho avuto pace, lei mi segue ancora nel pensiero. Non so se sia viva o morta. Le sfuggo e la cerco, mi spaventa e mi attrae. La ritrovo negli sguardi di tante donne in Afghanistan. Immagino la sua ombra magra, allucinata, sgomitare nelle strade intasate, infilarsi tra i carretti e il filo spinato, saltare sugli autobus in partenza infilandosi tra le porte appena socchiuse. È successo dopo mesi di viaggio dal confine dell’Iran a quello cinese sulle nevi del Pamir, un viaggio compiuto da sola, affidandomi al buon senso della gente del posto ed evitando con cura i luoghi pattugliati dai militari. Cercavo luoghi sacri, taumaturghi erranti, nomadi e storie di donne, e in quella porticina che dà sulla strada della vecchia Kabul vedo entrare donne, fagotti plissettati che vanno sotto il nome di burqa. La soglia è piccola, devo chinarmi, l’ambiente è soffocante ma si riempie di altri corpi ancora. Dentro è penombra ma fuori il sole è allo zenith, i muezzin chiamano alla preghiera di mezzogiorno. L’ora in cui Kabul respira di sollievo. L’incubo quotidiano è finito. Qui i kamikaze si fanno esplodere al mattino. Lo fanno per arrivare in paradiso all’ora di pranzo, in tempo per banchettare col Profeta. Sono vestita all’afgana, ho una veste lunga e nera, col velo che copre i capelli ma lascia libero l’ovale della faccia. Sotto ho il mio taccuino e la mia Leica. Non oso toccarli. Le donne mormorano preghiere, scoprono i volti bruciati dal sole d’alta quota, si tolgono il burqa, mostrano bellezza e sofferenza, si cercano, si toccano, liberano tra loro una complicità sensuale. Poi, dopo qualche minuto, una bambina col velo bianco, la divisa della scuola, mi nota, tocca il mio viso e si mette a piangere. «Perché piangi?» le chiedo in lingua dari. «Perché sei straniera e porti il velo, come noi». È allora che la diga si rompe, la voce corre, sono una cristiana che ama l’Islam, e tra le altre donne si innesca una reazione a catena fuori misura. Il mio corpo è già reliquia, vi strisciano contro, lo baciano, vi depongono caramelle e banconote per santificare qualcosa di loro e poi infilarsela nelle tasche o nei IL CORRIDOIO. Una donna esce da un santuario a Kabul reggiseni. Cercano barakà, la benedizione, perché sono un’ospite e mi sono fidata. Piangono, asciugano le lacrime, si soffiano il naso nei burqa, mi infilano le dita inanellate nei capelli, mi sfiorano la guancia col dorso delle mani. Una di loro esige da me la grazia speciale di avere figli. Come in un sogno. Sono in ostaggio, ma non mi oppongo, mi affido. Sono in imbarazzo, ma sorrido. Tutto quello che ho cercato in mesi di lavoro mi piomba addosso all’improvviso. Dal ruolo di testimone invisibile a quello, non voluto, di protagonista al centro di un culto. “Volevi gli uomini di Dio? Guaritori erranti? Donne in estasi?” chiedo a me stessa quasi ad alta voce. “Eccoti accontentata...”. Credendo che io stia pregando le donne alzano le mani al cielo. Tra le tante che mi stanno addosso ce n’è una che non sorride né piange. Il suo velo è buttato senza cura sopra i capelli maltinti di hennè. Un corpo magro, le sopracciglia accentuate da un segno maldestro di kajal. Cerco di sottrarmi al suo contatto fisico. Ma lei mi stringe verso il muro, come per isolarmi dalle altre e si sbottona il vestito per mostrarmi qualcosa. Mi aspetto una ferita, e invece vedo il suo corpo magro impacchettato in una maglia di cilindri verticali legati da fili elettrici. Non capisco, forse non voglio capire. Penso alle armi di un agente segreto, all’autodifesa di una donna più emancipata. Ma le cose che ha intorno alla pancia non sono pistole, è dinamite. Sembra un’insegnante delle elementari in- IL LIBRO Di Monika Bulaj, autrice del testo e delle foto pubblicati in queste pagine, il prossimo autunno uscirà per Electa Nur. Appunti afgani (32 euro, 277 pagine) vecchiata troppo presto. Quanti anni avrà: trenta? Cinquanta? Da dove viene? Dove sta andando? Perché mostra proprio a me la sua macchina di morte? Fingo di non aver capito. Le chiedo: «Dove sono i tuoi figli?». Il modo con cui volta la testa mi gela. Vuol dire che non ne ha più. Forse sono morti. Smetto di chiedere. Le domande si fermano sulle labbra. Ho paura, guardo altrove. Dico a mia volta: «Man se farzand daram», ho tre figli maschi. È la frase che meglio mi protegge in questo Paese. Il mio mantra, il mio lasciapassare, il mio elmetto in kevlar, la mia personale guardia del corpo. La donna che fa figli maschi qui è una donna vera, rispettata. Nella valle di Khost, durante un matrimonio, mi hanno quasi festeggiata per questo. Ora la pelle della donna è sudata, pallida, gli occhi sono folli, stanchi, freddi, asciutti. Sento il suo gomito ossuto, i muscoli duri delle cosce. La guerra ha portato a questo. La morte è un affare fiorente in Afghanistan. La carne umana è in vendita, diventa arma che si fa esplodere. Stragi a opera di kamikaze. Rapimenti di bambini e di adulti sospettati di avere risparmi. Omicidi su richiesta. «Duemila dollari — mi hanno detto amici afgani — sono la tariffa per uccidere qualcuno, e tutti sanno come trovare un sicario». Anche i kamikaze fanno lo stesso, per comprare la casa alla famiglia o saldare un debito. Economia di guerra, non martirio. Sento ogni fibra del mio corpo e ho la certezza incosciente che non accadrà nulla. Eppure temo che le parole possano svegliare qualcosa, far tremare la corda di un nervo, spezzare il filo della sua follia. Così cerco di esprimere uno sguardo indifferente per sorvolare la sua faccia piatta piena di rughe, le mezzelune nere delle unghie, la cintura sfatta della borsetta, l’odore del sapone e l’acido del suo respiro. Intorno le altre donne non si sono accorte di nulla. Continuano a ignorare il santo per guardare me, affascinate, piangendo. Esco a fatica. Lei mi segue, mi aderisce come un’ombra. Fuori, una barriera di burqa in nylon con macchie di respiro all’altezza delle labbra. Anche queste mi stringono. «Guardatela — dice una di loro — una issawì che ama l’Islam! Una haredzì che ama l’Afghanistan!». Issawi vuol dire “seguace di Issa”, il Cristo. Haredzi significa straniero. Ecco, io sono questo per loro. Infedele e straniera, eppure ho una faccia, odore, occhi, voce. Sono occidentale, eppure non sono chiusa in un blindato, non sto dietro il mirino di un mitra. Mi allontano senza salutare, come per dire “non c’entro”, “non c’ero”. Non dico nemmeno “Khoda Hafez”, che Dio si ricordi di te, l’arrivederci degli afgani. Ma lei mi segue. Cammino lentamente per comunicare una tranquillità che non ho, lo faccio con passi lunghi, per seminarla. Ne esce una camminata abnorme. Scherzo con venditori ambulanti, mi infilo nella folla senza voltarmi e senza fretta apparente, per non far vedere che la mia è una fuga. Passo davanti agli ultimi Sikh della città che, con dadi e conchiglie, predicono il futuro alle musulmane al riparo di grandi ombrelli. Stavolta mi giro, lei non c’è. E Kabul ridiventa reale, con la sua puzza di fogna, le grida dei bambini di strada che danno manate sui blindati che passano come sul culo degli asini, il ronzio degli elicotteri d’assalto che volano così bassi che il soffio delle loro eliche spaventa i pappagalli verdi sugli eucalipti. Kabul, con i carillon dei gelatai ambulanti che strillano Per Elisa e Jingle Bells, vittoria sui divieti talebani contro la musica. Cerco di mimetizzarmi nel passo disinvolto delle donne afgane, un linguaggio mimetico del corpo che ho imparato ad assumere in fretta, anche per la mia incolumità. Ma stavolta la paura si è insinuata in me senza che me ne rendessi conto, è già diventata riflesso fisiologico. Bagnerò il mio letto quella notte, e da allora non riuscirò a dormire che a brevi intervalli. Ora riconosco i luoghi. Torno d’istinto nel quartiere dei musicisti, dove ho il mio dentista privato. Un santuario con chiodi magici piantati sullo stipite della porta, ogni chiodo guarisce un dente. Poi trovo un barbiere con una foresta di capelli abramitica che mi invita a bere un tè e mi svela allegramente di avere interpretato Osama Bin Laden in un film. L’Afghanistan è così, dalla tragedia alla farsa nel giro di un’ora. Non so più dove ho fatto quel terribile incontro. Il mio sentimento per quella donna è un grumo fatto di pietà, condanna e paura. So che se la denunciassi non mi crederebbero, oppure partirebbe una rappresaglia di sangue. Sparisce l’ultimo raggio porpora sulle cime immacolate dell’Hindukush. Le luci tenui nelle case d’argilla si accendono sui colli che ora paiono il presepe di Betlemme. Un asino porta in salita una donna incinta con un’ombra accanto. Pare quella di Giuseppe, il falegname. E intanto la donna imbottita d’esplosivo, da qualche parte, si toglie la “cintura del martirio”, come la chiamano gli estremisti dell’Islam, e srotola per terra la trapunta colorata nella sua casa senza figli. Ma non dorme. © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale DOMENICA 7 APRILE 2013 ■ 33 LA MOSCHEA. Il cortile interno di Abu Fazl a Kabul, dove durante una festa dell’Ashura nel 2011 morirono in un attentato decine di fedeli L’ALTALENA. Una ragazzina afgana si diverte durante un pic-nic nelle valli intorno a Herat LA SCUOLA. A Herat si trova la più grande scuola femminile del paese, dove studiano tredicimila bambine e ragazze Repubblica Nazionale DOMENICA 7 APRILE 2013 LA DOMENICA ■ 34 La storia © SANTA BARBARA Bel colpo Delle antenate delle palline da tennis esistevano solo raffigurazioni: un bassorilievo del 1300, qualche dipinto settecentesco. Ora però alcuni esemplari sono stati trovati per davvero. A Mantova © PALAZZO TE Come ci racconta, foto alla mano, un grande cultore della materia GIANNI CLERICI anno finalmente trovato le palline. Di quello che ora chiamiamo Tennis, ma che nel 1500 chiamavano Giuoco di Rachetta. Pallina che allora chiamavano balla, o baletta. Nei miei lunghi studi, nelle mie ricerche negli anni Settanta, già ne avevo rinvenuta un’immagine contrassegnata “di Palazzo Labia”, e subito pubblicata nel mio librone 500 anni di tennis. Ma avrei saputo in seguito dal collega Massimo De Luca che della pallina esisteva, in un quadro di Palazzo Labia, solo l’immagine dipinta, così come, sempre a Venezia, nel Museo Querini Stampalia, c’è uno dei più importanti quadri che raffigura un doppio del 1750 di Gabriel Bella, e quindi ben più tardo. Un giorno mi ritrovo a Mantova, all’uscita da una chiacchiera del Festival di Letteratura, e un bel signore mi si avvicina, si presenta, Professor Ugo Bazzotti, e sorridendo apre una busta, e ne trae tre foto. Recano, le foto, l’immagine di tre palline, diverse una dall’altra, ma tutte con un diametro tra i quaranta e i cinquanta millimetri, tra i trenta e i quaranta grammi — mi dice — a soppesarle. Non diversamente dev’essere accaduto a un cercatore d’oro nell’inciampare in una pepita, per caso, occupato com’era a tutt’altro. H La struttura delle palline me le fa subito apparire come le bisnonne di quelle tuttora in uso nel gioco definito Real Tennis nei paesi di lingua inglese, e Jeux de Paume in quelli francesi. Gioco ancora praticato, nel mondo, secondo il grande esperto parigino Gil Kressmann, in tre club francesi, nove americani, ventitré inglesi e tre australiani, su uno dei quali, nelle mie gite a Melbourne, ho tirato qualche racchettata, insieme ad un amico, Michael Wooldridge, che ha svolto un’attività che più lontana dal Rinascimento è difficile immaginare, quella di ministro degli aborigeni. Il Jeux de Paume è ormai purtroppo semisconosciuto in Italia, il paese che nel Quattro-Cinquecento rivaleggiava con Francia e Spagna nel primato di quello che ancora non si chiamava sport, ma faceva parte dei divertimenti di corti e monasteri. Ora simile tennis vivissimo durante il Rinascimento è da noi quasi dimenticato nonostante il tentativo della mia amica e storica Alessandra Castellani di ridar vita al campo rinvenuto nel Castello di Venaria, la residenza dei Savoia. In effetti, il tennis di quei tempi, lo si voglia chiamare Giuoco di Rachetta, Giuoco di Balla o Baletta, oppure in spagnolo Pelota, o Trinquete, o ancora in francese Jeux de Paume (“palmo”, come quello della mano, precedente l’invenzione della racchetta, strumento che esiste in cento documenti ma non è mai stato ritrovato, a differenza delle pal- Sorprendente match ball a Palazzo Te line mantovane) questo gioco, insomma, è il padre del Lawn Tennis, adattato, ma non certo inventato dagli inglesi. Infatti, con molta probabilità, confermata addirittura dai miei studi, questo passatempo chiamato tra l’altro Tenez (“prendete”, sottinteso la palla, lanciata dal battitore con l’aiuto, “servizio”, di un collaboratore), emigrò di Francia in Gran Bretagna, insieme ai cavalieri che accompagnarono Marie de Couci, andata sposa ad Alessandro terzo Re di Scozia. E, insieme all’ambasceria, emigrarono anche i termini della paume che permangono nel gergo tennistico contemporaneo. Oltre al citato Tenez che forse si tramutò in Tennis, il Loveche significa zero discese da l’Oeuf, “l’uovo”, rotondo come uno zero, e Volley, “volata”, fu neologismo da Volée, Quel che scrivo è largamente illustrato da molti documenti, tra i quali alcune righe di Shakespeare che nomina una “tennis ball” nell’Enrico V, dramma che si svolge all’inizio del 1400. Accadde che, in seguito all’importazione ottocentesca e all’utilizzazione della gomma, i britanni avessero l’idea di trasportare l’antico gioco, dai selciati in pietra indoor, sui prati (Lawn) dei giardini, dove precedentemente non era possibile il rimbalzo delle palline similmantovane, costruite come ancora accade con quelle del Real Tennis. Costruite, cioè, in pelle, con una schele- Repubblica Nazionale DOMENICA 7 APRILE 2013 ■ 35 Santa Barbara FIORI Qui sopra le tre palline ritrovate durante i restauri della Basilica Palatina di Santa Barbara, a Mantova. La prima da destra ha dei fiori dipinti sul cuoio, la prima da sinistra è la meglio conservata. Tutte e tre erano state murate in uno spioncino “IL GIOCO DELLA RACCHETTA” È il titolo del dipinto (risalente al 1779-1792) di Gabriele Bella conservato alla pinacoteca veneziana Querini Stampalia: per la prima volta le linee di caccia sono segnate verticalmente, e non sul terreno Le altre immagini storiche che illustrano queste pagine sono tratte dal volume di Gianni Clerici 500 anni di tennis (Mondadori) Palazzo Te TOPI A lato le tre “balette” ritrovate nel Palazzo Te di Mantova Hanno un diametro di 40-50 millimetri e pesano circa 30-40 grammi. Ricoperte di pelle e riempite di pelo (di donna o animale) sono state rosicchiate dai topi tro di filo rigido e, all’interno, un denso pelo espanso, spesso di capigliature femminili, oppure di qualche animale, come ad esempio il gatto — ormai roso dai topi — delle balette mantovane. Ma ritorniamo all’inizio. Ricordo che in quel giorno dedicato ai libri del Festival, come fui ritornato alla mia biblioteca con le tre incredibili foto aprii subito uno dei miei testi più cari, Il Trattato del Giuoco della Palla del mio antenato adottivo Antonio Scaino da Salò, il maggior esperto di “Balla e Rachetta” del Cinquecento, un genio col quale mi accade di colloquiare durante le sedute spiritiche. Il suo trattato esiste ormai soltanto in una quindicina di copie nel mondo, e io stesso sono riuscito a ottenerne una, devolvendo, nella combattutissima asta dell’hotel Druot di Parigi, lo stipendio di un’intera annata di collaborazioni al giornale. Nei disegni contenuti nel Protolibro la baletta non era dissimile a quelle mostratemi a Palazzo Te, ma le loro struttura giungeva a ricordare anche quelle raffigurate nella Grande Encyclopedie di Diderot e d’Alambert (1751), che alla Paume e al suo sviluppo dedica addirittura otto pagine. Nel 1610 l’arte di produrre palle e racchette aveva condotto in Francia all’istituzione di una Comunità di Maestri — Rachettieri, Produttori di Palle — i soli abilitati a tali attività artigianali. Ma, ritornando a Mantova per ammirare dal vero le balette, sarei venuto a conoscenza di una mol- to più antica presenza a Corte di “Mastri Balonari”. Varcata la soglia del Palazzo, sarei trasecolato prendendo addirittura nel palmo (paume) della mano doverosamente guantata, le palline che Chiara Pisani, conservatrice del Museo Civico, mi andava offrendo, con cautela eguale allo charme. Terminata l’osservazione delle palline, sarei stato condotto a visitare le fondamenta che restano del campo, dopo l’abbattimento del 17001800, “il quale era benissimo ad ordine, né cosa alcuna vi mancava di balle piccole”. Campo in cui, durante una visita nell’aprile 1530, l’Imperatore Carlo V si impegnò nel “giocare a detta palla, lui e Monsignor di Balasone da una banda, e dall’altra il principe di Besignano e Monsignor de la Cleva, spagnolo. Giocarono a palla forsi quattr’ore, dove sua Maestà si esercitava molto bene et assai ne sa di tal gioco, e giocavano di vinti scudi d’oro la partita, dove alla fine sua Maestà perse sexanta scudi ”. Simili partite delle quali rimangono cronache che potrei definire storico-sportive, sono citate in più di un documento. Nel benedetto libro sovramenzionato, la causa della pubblicazione — e insieme della dedica ad Alfonso II° d’Este — viene infatti attribuita a un “puntiglio avvenuto, giocando, a vostra Eccellenza” e cioè a un’interpretazione del punteggio sul quale il Duca e il giovane filosofo si erano trovati in dissenso. Si trattava di una partita tra due dei maggiori professionisti dei tempi, giocatori che offrivano i loro servizi alla nobiltà. Si trattava in questo caso di tale Gian Antonio Napoletano e Gian Fernando Spagnuolo, probabilmente impegnati in quella che chiameremmo esibizione. Il punteggio di allora prevedeva, come oggi, una successione di tre punti, denominati quindici, trenta e quarantacinque (ora divenuto quaranta), complicati dalla necessità di superare le “cacce”, e cioè i luoghi nei quali l’avversario aveva segnato il punto nel game precedente. Ma c’era, in più, un dettaglio importante. Il giocatore che si fosse trovato avanti per tre punti a zero, e avesse perduto i successivi cinque, doveva concedere all’avversario quel che veniva definita “vittoria rabbiosa”, e cioè un punteggio di maggior valore di una vittoria semplice, quel che oggi denominiamo, in inglese, un game. Proprio da un dissenso sul tipo di vittoria relativo ai cinque punti successivi nasceva “quistione, se questo tal giuoco vinto dal Napolitano sia semplice, o rabbioso, che di ciò qui non accade dubitare”. Dalla lettura di simile libretto, che non a torto reca il titolo di Trattato, sarebbe sorta la mia curiosità per una ricerca, i cui risultati avrebbero condotto alla sorpresa, all’incredulità e, a volte, addirittura a ribellione sciovinista i presunti inventori del gioco tardottocentesco. Ma, dopo essermi un tantino allontanato dal te- ma del mio compitino, mi sembra il caso di ritornare a Mantova, dove le sorprese di quella per me incredibile giornata non erano finite. Non lontano da Palazzo Te sorge infatti la Basilica Palatina di Santa Barbara, innalzata per volontà del Duca Guglielmo Gonzaga nel cuore del Palazzo Ducale a partire dal 1561 “con poca spesa …nel gioco della balla”. Monsignor Giancarlo Manzoli spiega che, nel corso dei lavori di restauro condotti dall’architetto Mori, son state rinvenute altre tre palline, una delle quali addirittura dipinta a fiori, che erano murate in uno spioncino. Mi verrebbe da pensare che i ritrovamenti di tre più tre palline siano simbolicamente proporzionali al punteggio del gioco che, come ho detto, già da allora si svolgeva con definizione simile a quella odierna. Ma occuparci ancora delle modalità dell’antico divertimento porterebbe a uno studio superspecialistico, all’esegesi che del Trattato fece nel 2000 il Professor Giorgio Nonni dell’Università di Urbino, altro centro del giuoco rinascimentale. Limitiamoci alla sorprendente duplice scoperta, e auguriamoci che, tra un secolo, un presunto perditempo non abbia a darne incredula notizia, delle palline, nuovamente dimenticate in qualche ripostiglio. Siamo i soli a possederle, nel mondo, ma siamo anche tristemente famosi per l’incuria del nostro patrimonio artistico. © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale DOMENICA 7 APRILE 2013 LA DOMENICA ■ 36 Spettacoli Overlook Dal mito dell’allunaggio al mito del minotauro Stanley Kubrick avrebbe nascosto vari messaggi subliminali nel suo film cult. Ora un documentario li ha finalmente scovati. O almeno crede NON APRITE QUELLA PORTA Il numero 237 è quello della stanza degli omicidi nell’Overlook Hotel Su quella porta il piccolo Danny con il rossetto scrive “Redrum” ovvero “Murder” (omicidio) se letto allo specchio MASSIMO VINCENZI NEW YORK P ensate che Shining sia uno dei migliori horror di sempre, uno dei capolavori di Stanley Kubrick, o anche solo il film che ha fissato nella storia del cinema il ghigno di Jack Nicholson con le sopracciglia alzate? Allora credete anche che Jim Morrison sia morto davvero e non stia invece ballando con Elvis e Marilyn, ascoltando al contrario i dischi satanici dei Beatles. Se invece amate i complotti, le teorie della cospirazione o comunque vi piace il lato oscuro dell’arte, Room 237 è il vostro documentario. Presentato prima al Sundance poi a Cannes, arriva ora nei cinema di New York, dove per assonanza ha riportato in sala pure l’originale, ottenendo un ottimo successo. Diretto da Rodney Ascher è un flusso indistinto di parole, interviste a persone di cui non si vedono mai i volti, che scorre sopra frammenti di Shining, immagini di repertorio e continui rimandi cinematografici e storici: come in quelle fotografie ipnotiche dove c’è un uomo che guarda una foto dove c’è un uomo che guarda una foto dove... Una tecnica visio- Siete proprio sicuri di averlo visto Shining? Le allusioni al genocidio dei nativi americani sarebbero nella marca del cibo nella dispensa (Calumet) e nei disegni tribali degli arazzi nel salone L’Overlook Hotel, inoltre, è costruito su un cimitero pellerossa: dettaglio inserito da Kubrick nel film ma assente nel libro di King naria: giornalisti, professori universitari, autori di teatro e studiosi autodidatti, aprono la porta sulla loro privata ossessione per le leggende che accompagnano il film di Kubrick e sui messaggi subliminali che lo inzuppano rendendolo ancora più misterioso. La più affascinante delle teorie è un classico dei complotti. Il film serve a Kubrick per scusarsi della sua partecipazione diretta nel grande imbroglio dell’Apollo. Sarebbe stato lui infatti, nonostante anni di smentite, a girare per conto del governo Usa la finta scena del primo passo dell’uomo sulla Luna (mai avvenuto). Da qui la stanza 237, che nel romanzo di Stephen King da cui è tratto il film è la 217 ma che il regista cambia: non per una richiesta dei proprietari del vero Overlook Hotel come “sostiene la versione ufficiale”, ma perché 237mila sono le miglia che separano la Terra dal suo satellite. Altro indizio: il piccolo Danny indossa un maglione proprio con la famosa navicella spaziale. E il litigio tra Jack e Wendy quando lei scopre che lui non sta scrivendo il romanzo ma riempie i fogli con la stessa frase (“Solo lavoro e niente divertimento rendono Jack un ragazzo noioso”, nella versione originale)? Simboleggia la discussione avvenuta tra il regista e la sua compagna tenuta all’oscuro del ruolo da lui assunto nella balla spaziale. È poi anche un film sulla Shoah. Perché la macchina da scrivere su cui Nicholson sfoga la sua frustrazione è di marca tedesca, una Adler, “aquila”, dunque “la follia della feroce burocrazia tedesca” Repubblica Nazionale DOMENICA 7 APRILE 2013 ■ 37 La teoria più ardita dà anche il titolo al documentario: 237, il numero della stanza (che nel libro è la 217), alluderebbe alla distanza tra la Terra e la Luna e sarebbe anche il numero della sala degli studios dove Kubrick (secondo gli amanti del complotto) avrebbe girato il falso allunaggio di Armstrong per conto della Nasa; i disegni sulla moquette sono la pianta della base da cui partì la missione; Danny indossa una maglia dell’Apollo 11; e in dispensa ci sono le scatolette di Tang, cibo creato negli anni ’60 per gli astronauti Sarebbero molteplici i riferimenti alla Shoah. La macchina da scrivere usata da Jack Torrance (Nicholson) è tedesca, una Adler, “aquila” in tedesco, simbolo delle SS (del resto l’aquila è presente in molte altre scene del film). Il numero 42, essendo il 1942 l’anno della Soluzione finale: Danny, il bambino, ha un 42 disegnato sulla maglietta; Wendy, la mamma, oltre a guardare in tv il film L’estate del ’42, fa oscillare 42 volte la mazza da baseball prima di colpire Jack sulle scale; infine: 2 x 3 x 7 (il numero della stanza) = 42 Un numero ci seppellirà ENNIO PERES numeri (soprattutto quelli interi) si prestano a speculazioni esoteriche, molto più delle parole. Infatti, qualsiasi insieme di cifre genera un numero, mentre non sempre un aggregato di lettere corrisponde a una parola di senso compiuto. In linea di massima, tanto è più alto il valore di un numero, tanto minori sono gli spunti che se ne possono trarre. In particolare, il numero 237, che dà il titolo al documentario di Rodney Ascher, non presenta proprietà molto interessanti, a parte il fatto che può essere ottenuto, in due modi diversi, come differenza di due quadrati: 237 = 41²-38² = 119²-118². Se, però, si considera la trama del film Shining (oggetto del documentario in questione), non si può fare a meno di notare che, in base a una classificazione di John Conway, il 237 è un numero malvagio (per la particolare configurazione che assume, nella codifica binaria). L’unico numero di valore relativamente alto che ha fortemente colpito (e continua a colpire...), l’immaginario collettivo, è il famigerato 666, citato nell’Apocalisse di Giovanni, con le seguenti parole: «Una mostruosa bestia infetterà la Chiesa: questa bestia sarà un uomo, il cui nome conterrà il numero seicentosessantasei». Nel corso dei secoli, ricorrendo a vari cervellotici sistemi per legare i numeri alle parole, questo numero è stato attribuito praticamente a tutti i personaggi di una certa notorietà: da Maometto a Lutero, da Napoleone a Stalin, dall’Anticristo al Papa, da Piergiorgio Odifreddi a Silvio Berlusconi. Simili applicazioni, però, a seconda dello spirito con cui vengono effettuate, oscillano tra la sacralità e la beffa... Per esempio, se si attribuisce a ogni lettera dell’alfabeto il valore del proprio numero d’ordine (A=1, B=2, C=3, ... Y=25, Z=26), dalla parola Bestia si ricava: 2+5+19+20+9+1 = 56. Sommando le due cifre di questo numero, si ha: 5+6 = 11. Ebbene, esaminando le prime 11 parole del versetto dell’Apocalisse, prima citato, si ottiene il seguente dissacrante risultato. UNA: 21+14+1 = 36 MOSTRUOSA: 13+15+19+20+18+21+15+19+1 = 141 BESTIA: 2+5+19+20+9+1 = 56 INFETTERÀ: 9+14+6+5+20+20+5+18+1 = 98 LA: 12 +1 = 13 CHIESA: 3+8+9+5+19+1 = 45 QUESTA: 17+21+5+19+20+1 = 83 BESTIA: 2+5+19+20+9+1 = 56 SARÀ: 19+1+18+1 = 39 UN: 21+14 = 35 UOMO: 21+15+13+15 = 64 TOTALE = 666 I Il mito ellenico del Minotauro sarebbe citato nel labirinto del giardino (riferimento al labirinto di Cnosso dove Minosse fece rinchiudere la mostruosa figura); la struttura dell’hotel sarebbe labirintica tanto da costringere Danny a circoli viziosi sul triciclo; inoltre il poster dietro le gemelline raffigura uno sciatore-Minotauro, e nella stanza del direttore dell’hotel la finestra è - cartina alla mano - impossibile — mentre di aquile, simbolo delle SS, è cosparso tutto l’albergo. E perché c’è il numero 42, che compare sulla maglia del piccolo Danny e su quella di un cliente. Inoltre Wendy fa oscillare 42 volte la mazza da baseball prima di colpire il marito sulle scale. E quanto fa 2 per 3 per 7? Fa ancora 42. E il 1942 è l’anno in cui ha inizio la Soluzione finale. È poi anche un film sui nativi d’America trucidati dall’uomo bianco. Dove sono gli indiani? Intanto l’hotel (cosa che non viene specificata nel romanzo) sorge sopra un antico cimitero di pellerossa, poi ci sono simboli sulle pareti. E per chi avesse ancora qualche dubbio: di che marca sono i barattoli nella dispensa? Calumet, la pipa della pace che testimonia i tradimenti dei cowboy e la rottura all’interno della famiglia Torrance. È poi anche un film sul mito del Minotauro: lo provano il labirinto di siepi, il poster dello sciatore che sarebbe in realtà il mostro metà uomo e metà toro, la finestra impossibile dell’ufficio (studiando la mappa dell’hotel quell’affaccio non è possibile) e i circoli infiniti che il piccolo compie col suo triciclo. È poi anche un film palindromo, che può essere visto in entrambe le direzioni (altro grande classico complottardo). Per questo il bambino cammina all’indietro nella neve, Wendy mentre si difende da Jack risale di spalle le scale. E le scene, in un gioco di immagini, si sovrappongono perfettamente. È poi anche un film con qualche errore. Ma conoscendo la maniacale precisione di Kubrick non sono sviste bensì messaggi cifrati: sedie che ci sono in un’inquadratura e non nella successi- IL DOC Room 237 di Rodney Ascher è stato presentato al Festival di Cannes e al Sundance Film Festival Ora è uscito negli Usa mentre in Italia è in programmazione televisiva su Sky Arte va, Pisolo che appare e scompare sulla porta del bagno... È poi anche un film sulla Cia: impossibile non notare la somiglianza del padrone dell’hotel che offre il lavoro a Jack con John F. Kennedy — e qui il cortocircuito è perfetto. È infine anche un film sulle ossessioni sessuali di Kubrick (che poi si dispiegheranno nel suo Eyes Wide Shut), la ragazza della stanza 237 ne è la lampante prova, oltre al cassetto che si trasforma in erezione e alla rivista Playgirl letta da Jack nella hall dell’hotel. E un film sulla psicanalisi e sulla passione che il regista ha sempre avuto per Freud. Ma qui si esce dal lato oscuro per entrare nel rassicurante terreno della critica cinematografica. Room 237 è un gioco con cui divertirsi senza farsi troppe domande, ammirando la passione che sconfina nell’adulazione, che a sua volta cammina fianco a fianco con la follia: «Sono come chiacchiere in un dormitorio notturno. Ok: saranno pure sciocchezze poi tutti le ascoltano e nessun va a letto», dice all’Huffington Post il regista del documentario. Dunque inutile leggere sul New York Times uno dei più stretti collaboratori di Kubrick, Leon Vitali, che si affanna a spiegare: «Quando ho visto il documentario mi sono fatto due risate. Sul set noi facevamo scelte dettate dal senso pratico. Il maglione del piccolo Danny l’ha fatto a mano un’amica della costumista sul modello di mille altri. La macchina da scrivere? Stava bene sul tavolo di quercia, era grande. Insomma, stupidaggini». Sì, certo, e gli Ufo non sono mai atterrati nel deserto del Nevada. © RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale DOMENICA 7 APRILE 2013 LA DOMENICA ■ 38 Next Dica 33 ELABORAZIONE DATI IL BRACCIALE Il progetto più innovativo è quello messo a punto da una startup italiana (Empatica). Si tratta di un bracciale simile a quelli che misurano le calorie perdute durante uno sforzo. Questo misura il grado di stress. E lo fa attraverso la interpolazione di diversi dati: battito cardiaco, variazione, conduttività della pelle e temperatura corporea RACCOLTA DATI Così mi misuro le emozioni RICCARDO LUNA ul telefonino si è appena aperta una finestrella con un messaggio. “Ehi! È ora di ricontrollare il tuo livello di stress”. L’ultimo check non era andato benissimo. Poggiando l’indice sulla fotocamera dello smartphone per un minuto, era emerso che in effetti “you may be experiencing some stress”. Sì, un po’ stressato lo sono. E così mi era stato subito consigliata la visione di una clip di “scene verdi della natura”. Seguiranno “l’onnipotenza dell’acqua” e “la foresta prende vita”. Una sorta di terapia yoga fatta attraverso lo schermo dell’iPhone. L’obiettivo è arrivare rapidamente allo stadio “you are feeling balanced” e poi al nirvana dei nostri giorni: “You are in sync”. Che vuol dire “sei in sintonia con mondo”, ma suona come se avessi appena sincronizzato te stesso come si fa appunto con un telefonino. Questa cosa che può apparire stravagante assai è l’ultima frontiera per combattere lo stress: si chiama Gps for the Soul, ovvero “bussola per l’anima”, uno strumento per tenere sotto controllo le emozioni negative. È la app lanciata qualche settimana fa dalla giornalista-imprenditrice Arianna Huffington, direttore dell’Huffington Post Media Group: sviluppata in collaborazione con i ricercatori di Hearthmath, misura il battito cardiaco e le sue variazioni, ricavandone, con un algoritmo, il nostro indice di auspicato benessere. La app della Huffington non è affatto isolata. Anzi, per la verità utilizzare il telefonino o un sito web come terapia antistress sembra la moda del momento. Il fenomeno si inserisce in quel- S IL PROBLEMA Ansia, stress, depressione: ne soffrono, in modo più o meno grave, milioni di persone Monitorare questi disturbi, anche quando il “paziente” non è fisicamente dal medico, è il problema che si sono posti diversi ricercatori Tra le “soluzioni” un bracciale e una app Repubblica Nazionale DOMENICA 7 APRILE 2013 INFOGRAFICA DI ANNALISA VARLOTTA ■ 39 Un dito poggiato sullo smartphone. Oppure un bracciale intorno al polso. Raccogliendo i dati inviati dal nostro corpo saranno loro a dirci, ovunque ci troviamo, qual è il livello di stress e quali i rimedi immediati da adottare. È questa l’ultima frontiera del self-tracking L’APP GLI STATI D’ANIMO LA RILEVAZIONE Lo smartphone rileva il grado di stress durante le varie fasi della giornata LA LOCALIZZAZIONE I PICCHI Il paziente comunica attività “stressante” e propria posizione Elaborando i dati raccolti l’app segnala i picchi di stress (quando e dove) I CONSIGLI Dieci minuti di respirazione profonda, 30 a passeggio: alcuni consigli antistress GLI ALTRI MISURATORI ACCELEROMETRO UP è il braccialetto di Jawbone per misurare l’attività fisica con un accelerometro Subito un successo, dopo un po’ ci si è accorti che si rompeva facilmente CONNESSO ALLA BILANCIA FitBit è stato il primo braccialetto di grande diffusione pensato per un uso familiare Collegato wi-fi con una bilancia e una app cui inviare i dati da elaborare lo che negli Stati Uniti prende il nome di self-tracking, ovvero monitoraggio di se stessi, per arrivare a un quantified-self, ovvero a un insieme di indicatori che ci aiutino a migliorare le prestazioni. Nello sport è uso comune: braccialetti o cinturini che misurino per tutto il giorno i nostri movimenti, indicando le calorie bruciate, sono gadget diffusissimi. Ma un conto è tenere traccia del movimento che facciamo, grazie a un accelerometro, tutt’altro discorso è misurare lo stress. Il battito cardiaco e le sue variazioni sono una strada possibile. Prima della Huffington, per esempio, la app Azumio faceva (e fa) praticamente la stessa cosa. Dalla Svezia poi è arrivata Viary, una app che chiede ai pazienti in cura per la depressione di annotare quello che fanno nei vari momenti della giornata: pare che il 73 per cento di quelli che l’hanno utilizzata non fossero più depressi al termine della cura (ma stare tutto il giorno a prendere appunti non è pratico). È stato quindi il turno di Mequilibrium, una piattaforma web per il coaching psicologico online che si avvia risolvendo un test della personalità che divide il mondo in cinque categorie rispetto allo stress. Infine è notevole l’approccio del progetto Ginger.io: promosso da un gruppo di ricercatori del Mit e disponibile solo su Android, calcola il nostro livello di stress da come ci comportiamo con il nostro telefonino; e quindi, quanto rapidamente digitiamo i tasti, il tono di voce, il numero di messaggi ai quali rispondiamo. Funzionerà? Lo sapremo presto. Intanto il progetto sulla carta più innovativo è quello di una startup tutta italiana. Si chiama Empatica, e ha alle spalle tre giovani genietti: Matteo Lai, Simone Tognetti e Maurizio Garbarino. Si sono incontrati nel 2011: Lai è un architetto cresciu- CALORIE BRUCIATE Fuelband, il braccialetto della Nike, pensato soprattutto per gli sportivi consente di misurare le calorie bruciate correndo camminando, ma anche ballando o facendo basket ALLA CINTURA Mywellness Key, firmato dalla Technogym, si aggancia alla cinta dei pantaloni per registrare i movimenti in maniera più precisa rispetto al braccialetto sul polso to alla scuola del Senseable City Lab di Carlo Ratti, Tognetti e Garbarino avevano appena concluso un dottorato su come legare i segnali fisiologici che manda il nostro corpo alla misurazione delle emozioni. Le applicazioni di questo filone sono infinite e quasi tutte molto remunerative: ai tre ricercatori, per esempio, venne offerto di usarla per il neuromarketing e aiutare una multinazionale a vendere più detersivi. Ma loro avevano in mente un utilizzo socialmente utile. E si sono buttati sullo stress che comunque non è un mercato piccolo, visto che solo negli Stati Uniti ne soffrono 28 milioni di persone. Sono quindi partiti da studi scientifici molto seri, per arrivare alla conclusione che il nostro stress può risultare da una interpolazione di quattro dati: il battito cardiaco e la sua variazione, ma anche la conduttività della pelle e la temperatura corporea. La tecnologia per misurare questi parametri esiste, ma è in clinica o negli ospedali. Siccome i pazienti non vivono in ospedale, ‘‘ Lo stress è il primo killer della vita moderna Matteo Lai Ricercatore e fondatore di Empatica SCOPO TERAPEUTICO E2, è il braccialetto di Empatica. Pensato per fini terapeutici, misura battito cardiaco (attraverso l'ossigenazione del sangue nelle vene), conduttività e temperatura della pelle da qui l’idea di un braccialetto, simile a quelli che misurano le calorie perdute tanto di moda, ma che misuri lo stress e lo trasmetta al telefonino. Il primo prototipo è stato presentato un anno fa ad Amsterdam in una grande conferenza sull’innovazione, The Next Web. Quel giorno la blogstar Robert Schoble ha chiamato sul palco Matteo Lai che gli ha passato il braccialetto. Schoble l’ha indossato e per fare lo spiritoso ha chiesto a Lai: «E quindi adesso se io ti chiedessi se tu vuoi andare nel quartiere a luci rosse tu avresti un picco di stress?». Lai fu pronto a ribattere: «Sì, ma il braccialetto ce l’hai tu e quindi sono io che te lo chiedo». Un grafico trasmise alla platea il picco di imbarazzo di Schoble e il nome di Empatica fece il giro del mondo. Ora arriva il braccialetto vero. Si chiama E2 e al momento è destinato solo a ospedali e centri di ricerca. Ma intanto i tre ricercatori (in attesa di finanziamenti, destino comune a troppi prima di “fuggire” all’estero) hanno in corso una sperimentazione che è davvero la frontiera più estrema. Usare il braccialetto per i dipendenti delle grandi aziende, in modo da monitorare il loro livello di stress sul lavoro e, visto che lo stress è causa di malattie, suggerire percorsi alternativi. Il test è stato avviato per la validazione scientifica: dovesse funzionare, i costi sociali del lavoro sarebbero molto più bassi. Almeno si spera. C’è poi quel piccolo problemino che si chiama “privacy”: è pensabile mettere un braccialetto ai dipendenti per misurarne le emozioni? No. E ancora no. Ma le frontiere della privacy si sono così spostate in questi anni che Empatica scommette che quel no possa domani diventare un sì. © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale DOMENICA 7 APRILE 2013 LA DOMENICA ■ 40 I sapori Reinventati Non solo ragù e besciamella: le variabili all’antica ricetta dei cuochi bolognesi e napoletani sono infinite. Pesce, tofu, hummus o verdure, a ciascuno la sua LICIA GRANELLO er fare lasagne prendere pasta fermentata e trasformarla in una forma più sottile possibile. Poi dividere in quadrati di tre dita trasverse per lato. Poi prendere acqua bollente salata e cuocere in essa le lasagne. E quando sono a cottura ultimata, aggiungere il formaggio grattugiato. E, se volete, potete anche aggiungere sopra buone spezie in polvere. Poi mettere su un altro strato di lasagne e polvere di nuovo, e sopra un altro strato e la polvere, e continuate fino a quando il tagliere o la ciotola è piena. Poi si mangiano prendendoli con un bastone appuntito». Sembra tratta da un manuale di cucina salutista del terzo millennio, la ricetta pubblicata nel Liber de Coquina agli albori del Trecento e frutto della sapienza cuciniera della corte napoletana di Carlo II d’Angiò. Come dire che le lasagne sono state diverse da subito, e che da subito l’unico comandamento certo è stato l’utilizzo primigenio della sfoglia di acqua e farina. Quasi duemila anni più tardi, le lasagne sono ancora e sempre in bilico tra la sontuosità grassosa della preparazione bolognese e le infinite varianti che abitano i ricettari. Dismessi i panni cicciotti di cibo delle feste, dove assommare due campioni dell’arte culinaria franco-napoletana come béchamelle e ragù, la seducente stratificazione di pasta — si badi bene: da zero a quaranta tuorli per chilo! — ha saputo accogliere farciture polpose o magroline, in beata solitudine o creativamente assemblate, cibo del mondo o local come nessun altro. «P L’importante è stratificare I primi a ribellarsi alla dittatura del macinato di carne sono stati i vegetariani, pronti a rivendicare il potere goloso delle verdure. In scia, i vegani, che — azzerate buona parte delle proteine animali — si sono limitati a sostituire burro e latte con soia e tofu o, in versione ancora più restrittiva, brodo vegetale e agar agar. In quanto agli amanti del pesce, declinare il mare in lasagna richiede una sensibilità speciale — soprattutto riguardo ai crostacei — per evitare che la cottura in forno trasformi la fragranza in stopposità. Tradotto in ricette, cottura tradizionale per il ragù ittico, ma costruzione nel piatto per tandem delicati e suadenti come zucchine e capesante o gamberi e pesto (così da preservare anche la delicatezza del basilico). Poi, proprio come prescriveva l’anonimo cuoco degli Angioini, largo alle spezie e alle combinazioni della gastronomia etnica, che spaziano dalla dadolata di verdure con hummus (puré di ceci con crema di sesamo e limone) agli sfilaccini di pollo e salsa Teriyaki (soia, sake, olio e zucchero), arrivando fino alle tipologie dolci — fondente fuso e noci sbriciolate, carpaccio d’ananas e salsa vaniglia — e alle sfoglie fritte invece che bollite. Se le lasagne diverse vi intrigano, organizzate una gita a Bologna, dove mercoledì 10 aprile la benemerita associazione TOur-tlen, forte dei sui tredici supercuochi cittadini, ospita e sfida sette chef in nome della tradizione reinventata. In caso di crisi abbandonica, infilatevi in una delle osterie-culto del centro e regalatevi una porzione abbondante di lasagne bolognesi doc. © RIPRODUZIONE RISERVATA L’altra lasagna Repubblica Nazionale DOMENICA 7 APRILE 2013 ■ 41 Bologna. Gli indirizzi Tricolore Una lasagna bianca, rossa e verde a base di scamorza affumicata, speck e zucchine preparati a parte e stesi sulla sfoglia da infornare, con crema di latte e maizena, grana, menta, pistacchi tritati DOVE DORMIRE DOVE MANGIARE DOVE COMPRARE SUITE HOTEL ELITE Via Aurelio Saffi 40 Tel. 051-554379 Doppia da 80 euro, colazione inclusa SCACCO MATTO Via Broccaindosso 63/b Tel. 051-7018968 Chiuso lunedì a pranzo, menù da 38 euro SFOGLINE Via Belvedere 7/b Tel. 051-220558 4 VIALE MASINI DESIGN HOTEL Viale Masini 4/3 Tel. 051-255035 Doppia da 105 euro, colazione inclusa OSTERIA BOTTEGA Via Santa Caterina 51 Tel. 051-585111 Chiuso domenica e lunedì, menù da 30 euro HOTEL METROPOLITAN Via dell'Orso 6 Tel. 051-229393 Doppia da 120 euro, colazione inclusa MARCO FADIGA BISTROT Via Rialto 23/c Tel. 051-220118 Chiuso domenica e lunedì, menù da 40 euro LA BOTTEGA DELLA PASTA Via Orfeo 38/b Tel. 347-1303417 LA BOLOGNINA Via Di Vincenzo 33/d Tel. 051-370780 Asparagi e scamorze Pane carasau Vegetale Rape bianche Farcitura con gli ortaggi simbolo di primavera, sbollentati, affettati e spadellati, alternati a provola normale e affumicata, più besciamella leggera ILLUSTRAZIONE DI CARLO STANGA Il meglio dell’orto di stagione (zucchine, carote, piselli, porri) ridotto in dadini minuscoli (brounoise) e insaporito in extravergine, con o senza pomodoro Spianata sarda al posto della sfoglia tradizionale Una volta bagnata con brodo caldo di pecora, si farcisce con sugo di pomodoro e pecorino grattato A tavola Doppio pesto Versione double: a crudo (fogli di pasta cotti, assemblati in piatto con gamberi) oppure infornati con patate e fagiolini, aggiungendo besciamella o ricotta Mare Misto di scorfano e pescatrice a tocchetti, rosolato in olio extravergine profumato d’aglio Al posto della besciamella abbinamento con vellutata al fumetto di pesce Funghi Galletti o porcini tagliati sottili, trifolati in padella con prezzemolo A parte, preparare la pancetta affumicata a dadini, rosolata senza olio, e infine mescolare alla ricotta Radici tagliate sottilissime, cotte due minuti e quindi immerse in acqua fredda Asciugate, disponete in teglia con rigaglie di pollo saltate, salsa di yogurt, sedano Mais Le lacrime dei monaci MASSIMO MONTANARI ici lasagne e ti vengono in mente Bologna, il ragù, la besciamella. Ma la più antica ricetta di lasagne è in un testo scritto a Napoli agli inizi del Trecento. E il ragù non è previsto: nel Medioevo non solo le lasagne, ma ogni genere di pasta si condisce solo con burro e formaggio (la besciamella arriverà solo nel XVIII secolo). Perciò le lasagne possono comparire come vivanda “di magro”: in una novella quattrocentesca di Sabadino degli Arienti, i monaci bolognesi di San Procolo le mangiano di venerdì, «giorno di passione». Le attingono col cucchiaio da un «catino» appena sfornato, caldissimo. E proprio il calore della vivanda sarà protagonista del racconto: un monaco particolarmente affamato (o goloso) non riesce ad attendere e si affretta a imboccare una cucchiaiata di lasagne. Il volto gli si infiamma, il calore insopportabile lo opprime, dagli occhi gli escono lacrime. «Perché piangi?» gli chiede un fratello. E lui, per non svelarsi: «Piango la sorte dei nostri compagni che quest’anno sono morti di peste». Poco dopo, anche l’altro monaco addenta le lasagne bollenti, e pure lui si mette a piangere dal dolore: «Perché piangi?» gli chiede il primo. «Della stessa cosa di cui piangevi tu» gli risponde. Il ricettario napoletano del Trecento raccomandava di prendere le lasagne con un «punctorio ligneo», una posata di legno con le punte. Per far prendere aria alla vivanda, ed evitare di scottarsi. Nel racconto di Sabadino c’è anche un curioso retroscena: il «catino» di lasagne è preparato e servito in tavola da un cuoco «ch’era tedesco» e lavorava nella cucina del monastero. Forse fu proprio a Bologna che quel tedesco apprese l’arte di far lasagne. Ma i libri di cucina medievali sembrano attestare una larga presenza di questa pratica culinaria, in Italia e fuori d’Italia. In ogni caso, il particolare rivela un’interessante contaminazione di culture. Lasagne vuol dire Bologna, ragù, besciamella. Ma anche altri luoghi, e altri condimenti. D © RIPRODUZIONE RISERVATA Farina gialla versata a pioggia in acqua bollente per una polenta morbida da stendere a cucchiaiate con prosciutto cotto, carciofi rosolati e mozzarella Moussaka Patate a rondelle e melanzane affettate con la buccia fritte separatamente, allineate, sovrapposte, ricoperte con ragù di carne rossa e besciamella Vegana Sfoglia integrale, latte di soia per la besciamella, tofu al posto del formaggio Il resto vien da sé: zucchine trifolate, filetti di peperoni arrostiti, anelli di cipolla LA RICETTA LA CUCINA ITALIANA © GIANDOMENICO FRASSI Andrea Sarri, presidente dei Jeunes Restaurateurs italiani, è lo chef-patron del ristorante "Agrodolce", adagiato sulla banchina del porto d'Imperia, dove la Liguria profuma i piatti di mare e di terra. Come pure questa ricetta ideata per i lettori di Repubblica 1/2 kg di farina 20 tuorli, 8 gamberi 500 g di calamaretti spillo 200 g di muscoli, 200 g di vongole pisellini, fave 1 pomodoro cuore di bue cipolla, sedano, carota 1 bicchiere di vino bianco olio extra vergine di oliva 1 testa d’aglio basilico e maggiorana Impastare farina, uova e un pizzico di sale, fare riposare almeno un’ora. Stendere la pasta e tagliarla a quadretti di 5 cm. Pulire i pesci, tenendo da parte teste e carapaci dei gamberi. Soffritto con cipolla, sedano, carote, aglio, aggiungere gli scarti dei gamberi e il pomodoro a cubetti. Sfumare con un bicchiere di vino bianco, far ridurre e passare al colino Cuocere in abbondante acqua salata per pochi istanti i pisellini sgusciati e passare al mixer con un filo di extra vergine fino a ottenere una crema liquida Rosolare con aglio e olio calamari, vongole e muscoli, aggiungere i crostacei. Bollire le lasagnette, unirle a molluschi e crostacei, aggiungere qualche cucchiaio di salsa di gamberi. Impiattare il tutto, aggiungere la crema di piselli, le fave e qualche foglia di basilico ✃ Lasagnette in guazzetto di frutti di mare e primizie dell'orto Ingredienti per 4 persone Repubblica Nazionale DOMENICA 7APRILE 2013 LA DOMENICA ■ 42 L’incontro Antidive Cinquanta film in ventisette anni “Finora mi è andata bene ma ho sempre il terrore che la favola finisca da un momento all’altro” confessa una delle attrici più premiate del cinema italiano Che a domanda risponde: “No, non sono nevrotica come i personaggi che interpreto, ma ormai mi sono rassegnata: se qualcuno ancora me lo chiede io mi limito a sorridere” Margherita Buy el volto e nello sguardo si mescolano un velo di malinconia e una vena di ironia. E forse proprio questo strano mix è il segreto del fascino di Margherita Buy. Un dono di natura che, abbinato a una seria preparazione professionale all’Accademia d’Arte Drammatica, le ha consentito di esprimere sentimenti e proporre personaggi autentici, anche quando sul copione apparivano solo abbozzati. La prima a sorprendersi del successo, nonostante stia per arrivare in sala il suo cinquantesimo film in ventisette anni, è proprio lei. «Ho iniziato questa carriera molto seriamente, forse anche perché cresciuta in una famiglia dove la cultura ha sempre contato molto, ma senza alcuna illusione. Convinta, anzi, che sarebbe finita male. Così, ancora adesso, mi meraviglio di ciò è accaduto e qualche volta ho perfino la tentazione di mollare, perché finora è andato tutto per il meglio, ma sotto sotto continuo ad avvertire il vago terrore che la favola possa finire da un momento all’altro». La sua filmografia sembra sfatare la leggenda che oltre gli “anta”, per le attrici in genere e per le interpreti italiane ‘‘ in particolare, non ci sia più spazio. «È vero» ammette la cinquantunenne vincitrice di cinque David di Donatello, «con la maturità sono arrivati i personaggi più interessanti, le cose più belle. La mia fortuna è stata quella di cominciare con un gruppo di coetanei, da Daniele Luchetti a Giuseppe Piccioni, da Sergio Rubini a Cristina e Francesca Comencini fino a Ferzan Ozpetek, con i quali non ci siamo più lasciati. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo raccontato le nostre vite, le nostre esperienze». Dal prossimo 24 aprile tornerà sugli schermi accanto a Stefano Accorsi, con cui recitò Le fate ignorantidodici anni fa, nel film di Maria Sole Tognazzi Viaggio sola. Ma curioso è soprattutto il rapporto con Sergio Rubini, il suo ex marito col quale, anche dopo il divorzio, ha continuato a frequentarsi artisticamente. Così sul set Margherita e Sergio si sono spesso ritrovati a formare, con grande naturalezza, quella coppia che nella vita reale non c’era più. Tanto che, anche nel nuovo film di Rubini Mi rifaccio vivo, presentato al Bif&st di Bari e nelle sale dal 9 maggio, ancora una volta la protagonista femminile sarà proprio la Buy. «Le emozioni provate in questo lavoro spesso sono così forti che si trasformano in ricordi personali, come se ciò che si è vissuto solo nella finzione del set fosse accaduto davvero nella vita reale. Certi personaggi ti restano dentro. Mi è capitato più volte: di recente, con Maria, la protagonista de Lo spazio bianco, che mi ha fatto scoprire realtà inedite sulla maternità, o con Elsa di Giorni e nuvole, un film quasi profetico, che ha raccontato in anticipo la crisi dei nostri giorni e mi piace pensare che abbia aiutato la gente a prepararsi alle difficoltà del momento. Amo interpretare personaggi che esistano realmente, nei quali gli spettatori, e soprattutto le spettatrici, possano riconoscersi con grande facilità. Ciò non toglie che se mi chiamasse Tim Burton per un fantasy andrei di corsa...». Il tema della maternità ricorre molte volte nei film interpretati dalla Buy, che della sua esperienza di mamma di una figlia unica quasi dodicenne, avuta dal secondo marito, il chirurgo Renato De Angelis, dice: «Mi sento una miracolata, nel senso che mia figlia è stata la cosa più bella che mi sia accaduto di vivere. L’esperienza di madre mi ha migliorato e mi ha fatto crescere, mi ha reso più responsabile. Penso di essere stata una mamma molto apprensiva ma, seppure con fatica, credo di essere riuscita a non diventare troppo invadente. Oggi con mia figlia condivido già molte cose. Del resto ho sempre avuto un ottimo rapporto con l’universo femminile, come dimostra il fatto di aver girato molti film con registe donne. Anche sul lavoro, trovo che fra donne il rapporto sia facile perché si comunica attraverso un codice conosciuto e condiviso; non ci sono vergogne né pudori, inevitabili con i registi uomini. È accaduto di recente anche con Susanna Nicchiarelli per La scoperta dell’alba: un film particolare, emozionante, che sfugge a ogni classificazione di genere, stando a metà strada fra il fantasy e il politico, e che pretende dallo spettatore di lasciarsi andare alle emozioni. Con Susanna, fin dal primo istante, siamo state perfettamente in sintonia». Ciò che invece a Margherita non è Sul lavoro trovo che i rapporti fra donne siano più facili Perché si comunica attraverso un codice conosciuto e condiviso FOTO CAMILLA MORANDI / AGF N ROMA ancora riuscito è il tentativo di liberarsi dalla maschera di donna nevrotica, timida, scostante, ansiosa e ansiogena con cui il pubblico, a partire da Maledetto il giorno che ti ho incontrato di Verdone del 1992, l’ha identificata. Amici e conoscenti assicurano che Margherita non sia affatto così, ma intanto anche nel film Boris è stata proposta una parodia della Buy che puntava proprio su questo aspetto. «Non mi sono sentita affatto offesa anche perché, se mi volevano prendere in giro, potevano farlo ancora più ferocemente. D’altronde mi sono convinta che, almeno sullo schermo, emano qualcosa che mi sfugge e, poiché i personaggi nevrotici mi vengono bene, il pubblico pensa che io sia davvero così. Non c’è scampo, ormai mi sono rassegnata e non provo più a negare: quando mi chiedono “ma tu sei davvero così?” mi limito a sorridere». Tuttavia qualcosa di vero deve pur esserci, perché c’è chi ricorda che nella conferenza stampa alla Mostra del Cinema di Venezia nel lontano 1986 dopo la proiezione del suo primo film, La seconda notte di Nino Bizzarri, alle domande dei giornalisti le risposte di Margherita furono poco più che monosillabi. Ma l’unica insicurezza che lei riconosce a se stessa riguarda le scelte professionali: «Certe volte non è facile accettare una proposta e ancora più difficile rifiutarla. Naturalmente conta moltissimo la presenza del regista. Da attrice mi piace essere diretta, avere la sensazione che sul set ci sia un capo che abbia ben chiara in testa la direzione che il film deve prendere. Quando ciò non accade, è il disastro. Le mie scelte non derivano quasi mai da una riflessione sul personaggio che mi viene proposto, ma dipendono da un giudizio complessivo sul film. Meglio scegliere un ruolo più piccolo e meno interessante in un film che funziona, piuttosto che avere una grande parte in un’operazione complessivamente zoppicante. Sbagliare qualche scelta è inevitabile, anch’io ho dei cadaveri nell’armadio, ma non mi pento di niente: alla fine anche i film meno riusciti, a volte, offrono occasioni di crescita professionale e umana. Per esempio ho recitato in quello che è forse il film più brutto di Mario Monicelli, Facciamo Paradiso, ma sono felice di aver avuto l’opportunità di entrare in contatto con un uomo unico e straordinario». Il segreto di Margherita sembra essere quello di vivere il ruolo di attrice simbolo di un generazione con lievità, sobrietà, senza mai neppure sfiorare atteggiamenti da diva. Contrariamente alle attrici d’altri tempi, alle incombenze di una vita normale e a certi doveri domestici la Buy non si è mai sottratta: sebbene parzialmente nascosta sotto un cappello e con enormi occhiali da sole sul viso, anche in giornate poco luminose, è facile incontrarla in fila al supermercato sotto casa. Proprio per questo, nonostante l’infinità di riconoscimenti ricevuti, spesso portatori di velenose antipatie, Margherita non suscita sentimenti ostili neppure fra le colleghe. Lei, del resto, i vari premi ricevuti non li esibisce neppure nel salotto di casa. «Ciak d’Oro e Nastri d’Argento — racconta — sono stipati in un baule, anche perché si possono comodamente inscatolare. È un po’ più complicato con i David, che sono sparsi nelle varie stanze...». Recentemente, in un programma televisivo, ha ammesso di aver perduto una di quelle preziose statuette che si assegnano ogni anno al miglior attore italiano della stagione cinematografica. «Ma anche se faccio finta di niente non creda che io non tenga ai premi. Anzi, e lo confesso pubblicamente: intendo continuare a collezionarne». © RIPRODUZIONE RISERVATA ‘‘ FRANCO MONTINI Repubblica Nazionale
Scarica