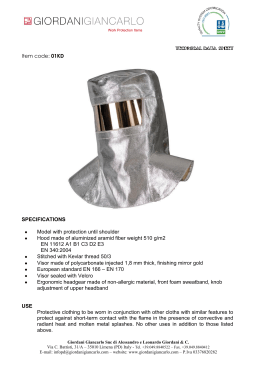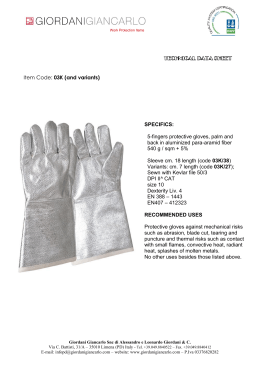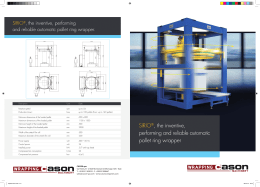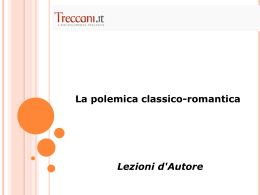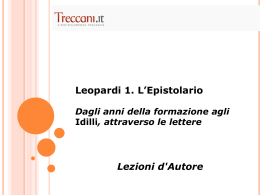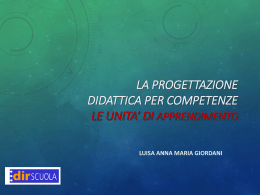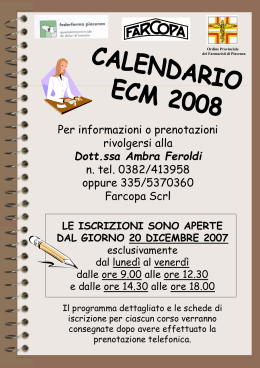GIUSEPPE GIORDANI Offertori per canto e organo Daniela Nuzzoli, mezzosoprano Marcello Rossi, organo 750701_Booklet.indd 1 7/12/12 3:15 PM Tactus Termine latino con cui, in epoca rinascimentale, si indicava quella che oggi è detta battuta. The Renaissance Latin term for what is now called a measure. ℗ 2012 Tactus s.a.s. di Serafino Rossi & C. www.tactus.it In copertina: Pompeo Batoni (1708-1787) Madonna con Bambino e Santi Si ringrazia per la squisita ospitalità a Morrovalle il parroco di San Bartolomeo Apostolo, Don Giordano Trapasso e il curato Don Salvatore Sica, per la speciale cortesia Giordano Moriconi, per il prezioso aiuto Raul Hernandez, per la disponibilità e perizia organaria Michel Formentelli, per l’interessamento al progetto e le precisazioni sull’organo “Callido” il Prof. Paolo Peretti e il Prof. Fabio Quarchioni, per l’aiuto nelle trascrizioni e le edizioni dei manoscritti il Dott. Alejandro Garri di Garri Editions. Si ringraziano infine i soci dell’Associazione “Dimostrazioni Armoniche” che hanno contribuito concretamente alla realizzazione di questo progetto. 1a Edizione 2012 24 bit digital recording Tecnico del suono, editing e mastering: Giuseppe Monari English translation: Marta Innocenti Computer design: Tactus s.a.s. L’editore è a disposizione degli aventi diritto. 750701_Booklet.indd 2 7/12/12 3:15 PM Secondo il certificato di nascita ritrovato recentemente, Giuseppe Tommaso Giovanni Giordani (o Giordano, o «Giordaniello», soprannome con il quale soleva firmarsi), nacque a Napoli il 19 dicembre 1751 da Domenico Giordani e Anna Maria Tosato. Compì i suoi studi musicali al Conservatorio di S. Maria di Loreto a Napoli (uno dei quattro conservatori napoletani, dalla cui fusione nacque l’attuale Conservatorio «San Pietro a Majella»). Ebbe maestri come Gennaro Manna, Antonio Sacchini, Pietro Antonio Gallo e Fedele Fenaroli e per compagni di studi, il celebre Domenico Cimarosa e Nicola Zingarelli. Nel 1774 divenne maestro soprannumerario della Cappella del Duomo di Napoli (la celebre Cappella del Tesoro di S. Gennaro) con la fama di essere «uno dei migliori soggetti della Città», sostituendo così il suo maestro Gennaro Manna. Alla produzione sacra di questo periodo affiancò probabilmente l’attività didattica: gli è attribuito infatti un divertente e articolato trattato di contrappunto, svolto nell’usuale forma dialogica tra alunno e maestro: Prattica della Musica, cioè Dell’Arte del Contrapunto, Quel che sia Contrapunto, e perché sia così nominato. Sul fronte teatrale, il 25 luglio 1776 la «Giunta dei Teatri del San Carlo» respinse la sua richiesta di scrivere un’opera in quanto non ne aveva ancora rappresentata alcuna nei teatri minori. Il 25 maggio 1779, nella Chiesa collegiata di Foggia, sposò per procura l’amica d’infanzia e cantante Emanuela Cosmi (Napoli, 1754 - ?) detta la «Positanella», all’epoca attiva in compagnie itineranti nel meridione. Il suo esordio operistico avvenne con successo a Firenze nell’autunno 1779 quando inaugurò il «Teatro degli Intrepidi» detto «della Palla a corda» con il dramma Epponina. A questo dramma seguirono, nei trent’anni successivi, quasi quaranta diverse composizioni tra opere serie, buffe e oratori, per un numero complessivo di ottanta allestimenti. Nel 1780 divenne membro dell’Accademia Filarmonica di Modena e in seguito di quella di Parma: da questo momento, salvo alcune brevi parentesi a Napoli e a Roma, la sua attività si svolse, nei maggiori centri del Nord Italia. Durante la quaresima del 1787 fu allestita al S. Carlo di Napoli (replicata nello stesso periodo dell’anno successivo) La distruzione di Gerusalemme, primo dramma sacro portato in teatro. Ebbe uno strepitoso successo, a questa prima fu presente Goethe che ne parlerà nel suo saggio Italienische Reise (Napoli 9 marzo 1787) come «di un genere di spettacoli oramai pressoché assimilati alle opere profane e del pari fiorettati il più possibile». Nella primavera 1788 inaugurò il Teatro Comunale di Faenza con il Cajo Ostilio su libretto del bolognese Eustachio Manfredi, dettando all’impresario la scelta del libretto e del primo violino di spalla. Il 14 febbraio 1789, dopo il successo scaligero de La Disfatta di Dario, ricevette il posto di maestro di cappella alla Chiesa Metropolitana di Fermo, al quale affiancò il 4 agosto, quello di organista, succedendo ad Antonio Conforti di Camerino, morto nell’aprile del 1790. Il 4 novembre 1791 assunse i medesimi uffici presso la chiesa filippina di S. Spirito. Con La morte di Abele nel 1790 e La distruzione di Gerusalemme nel 1791, inaugurò il Teatro dell’Aquila di Fermo. Rimarrà nella provincia marchigiana solo durante il periodo della Settimana Santa e della fiera locale, dal 15 agosto 1 750701_Booklet.indd 1 7/12/12 3:15 PM al 3 settembre. Dopo Ines De Castro alla Fenice di Venezia nel 1793, Giordani si ritira nelle Marche dedicandosi principalmente alla composizione di oratori e musica sacra. Tra questi lavori ebbe particolare risonanza Le Tre ore di agonia di Nostro Signore Gesù Cristo (Fermo, 1793) di cui rimane un libretto relativo ad un allestimento a Dresda. Alla sua morte, avvenuta a Fermo il 4 gennaio 1798, le sue musiche furono raccolte nell’Archivio Musicale Capitolare della città. Giordani godette all’epoca di un’altissima reputazione: i suoi lavori, oltre che in Italia, furono rappresentati anche a Lisbona, Madrid e Dresda. Vissuto negli stessi anni di W. A. Mozart e a lungo dimenticato, Giordani è a tutti gli effetti uno degli esponenti di spicco del periodo classico italiano e registra attualmente un crescente interesse nelle edizioni e nei programmi da concerto. Daniela Nuzzoli Il genere vocale ‘con organo obbligato’ I brani per voce e organo obbligato di Giuseppe Giordani costituiscono probabilmente, allo stato attuale delle conoscenze musicologiche, il più significativo corpus di composizioni con tale organico di tutto il settecento. In relazione a questo settore di musica sacra sette-ottocentesca si comincia a delineare, grazie a recenti ricerche d’archivio, un vero e proprio repertorio di brani sacri con l’organo in funzione concertante, quasi sostitutiva dell’orchestra. Probabilmente a causa di questa veste ‘ridotta’ l’attenzione degli studiosi e degli esecutori ha a lungo trascurato questo repertorio, unitamente al fatto che si tratta di musica sacra con modelli schiettamente operistici di grande virtuosismo vocale, tali da aver scoraggiato riprese in epoca ceciliana. Va notato tuttavia come i brani oggetto della registrazione siano stati pensati innanzitutto per un uso liturgico, documentato dallo stato di consumo dei manoscritti originali in dotazione della cappella di Fermo anche dopo la morte di Giordani: un’annotazione ci avverte che si cessò di eseguire tali brani solo nel 1889. A rendere possibile il trasferimento post-mortem della musica di Giordani nella cappella di Fermo fu un legato nei confronti dell’Archivio Capitolare da parte di Giovanni Bonafede, illuminato protettore del Giordaniello. L’esecuzione di brani sacri con l’organo concertante in sostituzione di un ensemble orchestrale più o meno nutrito sembra essere una prassi di surrogazione priva di riscontri storici precisi ma connaturata piuttosto nelle esigenze musicali di cappelle musicali prive di risorse finanziarie cospicue. Uno degli esempi più rappresentativi di questa usanza è la trascrizione originale settecentesca, per mano di anonimo, del celebre Stabat Mater di G. B. Pergolesi (1710-1736) con una parte d’organo al posto dell’ensemble di archi. Tuttavia, in questo caso, si tratta di un arrangiamento successivo e non ancora di un brano pensato 2 750701_Booklet.indd 2 7/12/12 3:15 PM ab origine a destinazione ibrida (orchestrale e organistica). Un esempio di questo tipo del primo settecento napoletano ci può venire da un brano di uno dei fondatori della cosiddetta scuola napoletana, Leonardo Leo (1694-1744) dal titolo Praebe, Virgo, benignas aures. Al Conservatorio di Musica di S. Maria di Loreto a Napoli, frequentato da Giordani, si era formato qualche anno prima Alessandro Speranza (1728-1797), autore di alcune antifone per contralto e organo obbligato. Nel medesimo Conservatorio, coetaneo e collega di studi di Giordani ricordiamo il nome di Nicola Zingarelli (1752-1837), che lascia due Salve Regina per Basso e organo concertante. Una splendida Salve Regina, per soprano e organo concertante, è dovuta alla penna del romano Pietro Terziani (17651831) che studiò musica dapprima nella propria città con Casali e poi dal 1780 a Napoli, al Conservatorio di Sant’Onofrio sotto la guida di Carlo Cotumacci e Giacomo Insanguine. Francesco Basili (1767-1850), autore di un Qui sedes per soprano e organo obbligato (rimasto tristemente famoso come il Direttore del Conservatorio di Milano che decise di bocciare Verdi), ebbe tra i suoi vari incarichi quello di Maestro di Cappella a Macerata (1789–1803) proprio mentre Giordani operava a Fermo. Interessante è notare come grandi nomi della composizione italiana di fine settecento e inizio ottocento dedicarono alla voce con organo concertante la preghiera del Tantum ergo: Giovanni Battista Martini (1706-1784), Pietro Morandi (1745-1815), Gaetano Donizetti (1797-1848), Gioacchino Rossini (1792-1868). In questa panoramica non certo esaustiva di tale genere musicale si colloca la produzione di Giordani che si caratterizza per quantità di opere, originalità di soluzioni, freschezza melodica e inventiva nelle modulazioni. Anche gli organici utilizzati da Giordani risultano molto variegati passando da composizioni per cantante solista a duetti e terzetti, per concludere con pagine più propriamente corali. La selezione di brani presente in questo CD vuole semplicemente offrire una prima ricognizione di questo ampio corpus, concentrandosi sugli offertori per soprano e toccando anche il genere più ampio della lamentazione (Quomodo sedet), che offre l’occasione a Giordani per esprimersi su dimensioni più vaste, con un notevole sforzo creativo e situazioni musicali di precisa aderenza testuale. A completare il disco sono stati selezionati due brani di matrice clavicembalistica del Giordaniello che tuttavia mostrano caratteristiche ‘orchestrali’ cui l’esecuzione organistica conferisce profondità e spessore timbrico di assoluto interesse. Note all’esecuzione I brani oggetto della presente registrazione presentano un’incognita esecutiva dal momento che non viene indicata la strumentazione delle parti prive di testo. Probabilmente non si tratta di brani ad esclusiva destinazione organistica e anzi, proprio per il modo con cui la musica risulta dalle fonti, si 3 750701_Booklet.indd 3 7/12/12 3:15 PM potrebbe pensare a ragione di affidare il pentagramma superiore a due parti di violino, con frequenti unisoni e considerare il pentagramma inferiore come una parte di basso continuo (indicata da Giordani con le parole «accompagno», oppure «sona»). In questa direzione sembrano concordare vari indizi: la posizione della parte vocale è intermedia tra un rigo superiore di carattere melodico e un rigo inferiore di accompagnamento; la parte superiore, quando propone più note contemporaneamente, sia all’interno di un accordo che di linee melodiche distinte, presenta le gambette delle note nettamente separate, permettendo una chiara divisione tra una linea di primo e una linea di secondo violino; la parte inferiore propone occasionalmente la cifratura del basso continuo. L’esecuzione di questi brani con l’accompagnamento dell’organo appare tuttavia la migliore soluzione, sia come normale destinazione della musica liturgica, sia soprattutto per almeno due chiare indicazioni autografe del compositore stesso: nel brano Illumina oculos meos sta la scritta: «Offertorio per la domenica IV dopo Pentecoste con musica del Sig. Maestro Giordani di Fermo, a canto solo con Organo obligato»; nell’offertorio Terra tremuit è indicata esplicitamente la presenza del registro organistico del «tamburro». All’epoca in cui Giordani prestava servizio liturgico era presente un imponente organo a due tastiere a base 12 piedi nella Chiesa di Fermo, firmato dal prestigioso organaro veneto Callido. Tale circostanza rende ulteriormente convincente l’esecuzione del rigo superiore con l’intensità sonora dell’organo italiano classico. La presenza di tonalità molto diverse tra loro (fino a quattro alterazioni in chiave, diesis e bemolle) e l’estensione della parte melodica superiore sembrano ulteriormente precisare le caratteristiche dello strumento a disposizione di Giordani, esigendo un organo del tardo settecento per versatilità di temperamento e estensione della tastiera nella zona acuta. La scelta, quindi, di utilizzare l’organo callidiano di Morrovalle del 1804, recentemente restaurato con criteri filologici da Michel Formentelli, è stata dettata da tali requisiti, offrendo in particolare una variegata possibilità di registri concertanti, volti a rendere il dialogo con la voce su un piano paritario ma sempre vario dal punto di vista timbrico. Marcello Rossi L’organo della Collegiata di S. Bartolomeo in Morrovalle, opera 408 (1804) del Professor d’organi Gaetano Callido Veneziano. L’organo della Collegiata di S. Bartolomeo in Morrovalle è l’opus 408 del grande Gaetano Callido1, che in quell’anno 1804 – secondo il suo catalogo2 – collocò altri cinque strumenti in territorio marchigiano. La produzione callidiana riguarda infatti per circa un quarto le Marche: questa per gli studiosi si è rivelata 1. Per la biografia di Gaetano Antonio Callido cfr. R. Lunelli, Studi e documenti di storia organaria veneta, Olschki, Firenze 1973, pp. 165-167 o l’omonima voce del DBI, a cura di Oscar Mischiati. 2. Pubblicato su R. Lunelli cit., pp. 132-144. Esiste qualche dubbio sull’autenticità del catalogo, che sarebbe da attribuire al figlio Antonio. 4 750701_Booklet.indd 4 7/12/12 3:15 PM significativa soprattutto per le eccezionali condizioni di conservazione in cui ci è pervenuta. Del suono e della timbrica di un organo callidiano si può avere un’impressione precisa solo con l’ascolto di uno strumento ben restaurato, sotto le dita di un abile esecutore che esegue musiche per esso concepite. Possiamo attribuire queste caratteristiche ai brani incisi nel presente CD: anche il lievissimo “colpo di vento” all’attacco delle note più spiccate, oltre che essere una testimonianza di autenticità, risulta gradevole. Scheda essenziale Lo strumento è collocato entro cassa lignea in cantoria, sulla controfacciata della chiesa. Tastiera originale di 47 tasti con prima ottava corta ed estensione DO1-RE5:: tasti diatonici ricoperti di bosso, cromatici di ebano; diatonici con i classici frontalini ‘a chiocciola’. Pedaliera originale a leggio, costituita di 18 pedali con prima ottava corta ed estensione DO 1 LA 2 ; l’ultimo è finto e aziona l’accessorio del Tamburo acustico. Unione alla tastiera costante. Registri azionati da pomelli di legno duro, posti in doppia colonna su tavola in noce a destra della tastiera e sovrastati dalla manovella del Tiratutti. I cartellini a stampa, ricostruiti, indicano la seguente disposizione fonica: Principale Bassi. [8’] Voce Umana. [soprani, accordata calante] Principale Soprani. [8’] Flauto in VIII. Bassi [reale da D02] Ottava. Flauto in VIII. Soprani Quinta Decima. Flauto in XII. Decima Nona.Cornetta. [soprani, in XVII] Vigesima Seconda. Tromboncini Bassi. [8’] Vigesima Sesta.Tromboncini Soprani.[8’] Vigesima Nona.Tromboni. [pedale, 8’] Trigesima Terza. [fino a FA2] Trigesima Sesta [fino a DO2] Contrabassi. [pedale, 16’] Ottava di Contrabassi. [pedale 8’, solidale col precedente] Accessori: Tiratutti a manovella e a doppio pedale, Tamburo acustico. Corista = 433 Hz. a 19 °C, temperamento Tartini-Vallotti, pressione del vento = 65 mm. H2O. Fabio Quarchioni 5 750701_Booklet.indd 5 7/12/12 3:15 PM According to his birth certificate, which has been found recently, Giuseppe Tommaso Giovanni Giordani (or Giordano, or “Giordaniello”, nickname he was in the habit of using in his signature) was the son of Domenico Giordani and Anna Maria Tosato, and was born in Naples on 19 December 1751. He died in Fermo on 4 January 1798. His musical education took place at the Conservatorio di S. Maria di Loreto in Naples (one of the four conservatories of that city, which merged later, becoming the presentday Conservatorio “San Pietro a Majella”). Among his teachers there were Gennaro Manna, Antonio Sacchini, Pietro Antonio Gallo and Fedele Fenaroli, and among his schoolfellows the famous Domenico Cimarosa and Nicola Zingarelli. In 1774, he became supernumerary kapellmeister of the choir of the Duomo of Naples (the celebrated choir of S. Gennaro’s Treasure), won the reputation of being “one of the best individuals in the city”, and replaced his teacher Gennaro Manna. During this period, he composed sacred pieces, and probably was also active as a teacher: a well-organised, amusing treatise on counterpoint is attributed to him. It is expressed in the customary form of a dialogue between a teacher and a pupil, and its title is Prattica della Musica, cioè Dell’Arte del Contrapunto, Quel che sia Contrapunto, e perché sia così nominato (“The practice of music, i.e. the Art of counterpoint. What counterpoint is, and why it has been given this name”). As regards his activity in the area of the operatic compositions, on 25 July 1776 the “Board of the San Carlo Theatres” rejected his request to compose an opera, because he had not staged any in the smaller theatres yet. On 25 May 1779, in the Collegiate Church of Foggia, he married by proxy a childhood friend of his, the singer Emanuela Cosmi (Naples, 1754 - ?), nicknamed “la Positanella”, who at that time was active in touring companies in southern Italy. Giordani’s debut as an opera composer took place, successfully, in Florence in the autumn of 1779, when he inaugurated the Teatro degli Intrepidi, also called Teatro della Palla a corda, with his drama Epponina. In the subsequent thirty years, this drama was followed by almost forty serious and comic operas and oratorios, totalling eighty productions. In 1780 he became a member of the Accademia Filarmonica of Modena and later of that of Parma: from this year onwards, except for a few short stays in Naples and Rome, he carried out his activities in the main cities of northern Italy. During Lent of 1787, the Teatro S. Carlo of Naples staged his opera La distruzione di Gerusalemme, first sacred drama performed in a theatre (this staging was repeated the next year in the same period) with huge success. Goethe was present on the first night and wrote about it in his essay Italienische Reise (Naples, 9 March 1787), stating that it was “a sort of show that by now has become almost similar to profane operas, and, like those, is as rich in embellishments as possible”. In the spring of 1788, Giordani inaugurated the Teatro Comunale of Faenza with his Cajo Ostilio, based on a libretto by Eustachio Manfredi, from Bologna, and asserted his own right to choose the libretto and the First Violin. On 14 February 1789, after the success of his La Disfatta di Dario at the Teatro alla Scala, he was appointed kapellmeister at the Metropolitan Church of Fermo, and on 4 August he also became the organist of that church, replacing Antonio Conforti of Camerino, who died in April 1790. On 4 November 1791, he took 6 750701_Booklet.indd 6 7/12/12 3:15 PM on the same posts at the Oratorian Church of S. Spirito. With La morte di Abele, in 1790, and La distruzione di Gerusalemme, in 1791, he inaugurated the Teatro dell’Aquila of Fermo. He remained in the Marches only during the period of the Holy Week and of the local fair, from 15 August to 3 September. After the staging of Ines De Castro at the Teatro alla Fenice of Venice in 1793, Giordani retired to the Marches and engaged chiefly in the composition of oratorios and church music. One of the most successful of these works was Le Tre ore di agonia di Nostro Signore Gesù Cristo (“The three hours of death agony of Our Lord Jesus Christ”) (Fermo, 1793), of which there remains a libretto relative to a staging in Dresden. When Giordani died, his scores were entrusted to the Archivio Musicale Capitolare. At that time, he had an excellent reputation: his works were staged both in Italy and in Lisbon, Madrid and Dresden. His death at a comparatively early age (he lived approximately during the years of W. A. Mozart’s life) prevented him from becoming really famous, as a highly important exponent of Italian classicism like him might have deserved. Daniela Nuzzoli The vocal genre “with organ obbligato” Giuseppe Giordani’s pieces for voice and organ obbligato are probably – according to the present state of musicological knowledge – the most significant corpus of pieces for that combination of performers in the entire 18th century. As regards this area of 18th- and 19th-century church music, recent archive researches have started outlining a real repertoire of church pieces with the organ in a concertante function, almost replacing the orchestra. Probably because of this “reduced” form, scholars and performers have neglected this repertoire for a long time, also because these kind of church music is based on operatic models with great vocal virtuosity, two characteristics that discouraged their revival in the Cecilian era. We should point out, however, that the pieces recorded here have been created above all for liturgical purposes: this is confirmed by the state of wear and tear of the original manuscripts that were used in the choir of Fermo also after Giordani’s death: a note informs us that these pieces stopped being performed only in 1889. The relocation of Giordani’s music, after his death, to the Archivio Capitolare of Fermo was made possible by a bequest of Giovanni Bonafede, enlightened protector of Giordaniello. The performance of sacred pieces with the concertante organ replacing a more or less large orchestra seems to be based not on historical practice, but on the needs of choirs that were lacking in substantial funds. One of the most representative instances of this practice is the anonymous 18th-century transcription of the well-known Stabat Mater by G. B. Pergolesi (1710-1736), where organ replaces the group of strings. In this case, however, it is a successive arrangement and not a piece that has been conceived from the start for a hybrid use (orchestra and organ). An example of this kind, in this instrumental area, from the early 7 750701_Booklet.indd 7 7/12/12 3:15 PM 18th century in Naples is a piece by one of the founders of the so-called Neapolitan School, Leonardo Leo (1694-1744), entitled Praebe, Virgo, benignas aures. At the Conservatorio di Musica di S. Maria di Loreto in Naples, a few years before Giordani, was Alessandro Speranza (1728-1797), who composed some antiphons for alto and organ obbligato. A contemporary and schoolfellow of Giordani’s in that Conservatory was Nicola Zingarelli (1752-1837), who left two Salve Reginas for bass and an obbligato part for organ. A splendid Salve Regina, for soprano and concertante organ, was composed by Pietro Terziani, from Rome (1765-1831 ), who studied music first in his city under the guidance of Casali, then, from 1780 onwards, in Naples at the Conservatorio di Sant’Onofrio, under the guidance of Carlo Cotumacci and Giacomo Insanguine. Francesco Basili (17671850), who composed a Qui sedes for soprano and organ obbligato (and became notorious as the head of the Conservatory of Milan who decided to fail Verdi), held, among his various posts, that of kapellmeister in Macerata (1789–1803) precisely when Giordani was active in Fermo. An interesting fact to be pointed out is that the Tantum ergo prayer was set to music for voice and concertante organ by several important Italian composers of the end of the 18th century and the early 19th: Giovanni Battista Martini (1706-1784), Pietro Morandi (1745-1815), Gaetano Donizetti (1797-1848) and Gioacchino Rossini (1792-1868). In this far-from-complete overview of this particular musical genre, Giordani’s production stands out for its number of works, the originality of its solutions, the freshness of its melodies and the inventiveness of its modulations. The combinations of performers adopted by Giordani are also quite varied, and range from solo singers (in different vocal ranges) to duos, trios and choirs. The selection of pieces presented in this CD means to offer an initial view of this extensive corpus, focusing on the Offertories for soprano, and also touching on the broader genre of the lamentation (Quomodo sedet), which gives Giordani the occasion for a wider breadth of expression, a considerable creative effort, and musical situations of precise closeness to the text. The CD is completed by two pieces of harpsichord origin by Giordaniello that show “orchestra-like” characteristics: the fact that they are performed on an organ lends them an absolutely compelling depth and richness of timbre. Remarks about the performance The performance of the pieces contained in this recording arise an interesting problem due to the fact that the instrumentation of the parts that have no text is not indicated. Probably these pieces were not composed exclusively for the organ: because of the way the music is presented in the sources, it would be reasonable to entrust the upper staff to two violin parts with frequent unisons, and to regard the lower staff as a basso continuo part (indicated by Giordani with the words accompagno, “accompaniment”, or sona, “play”). Several clues seem to confirm this: the position of the vocal part is intermediate between a melodic upper staff and a lower accompaniment staff; the upper part, when it proposes several notes simultaneously, both within a chord and in distinct melodic lines, has the stems of the notes decidedly separated, allowing a clear division 8 750701_Booklet.indd 8 7/12/12 3:15 PM between the line of the first violin line and that of the second violin; the lower part occasionally offers the basso continuo figuration. The performance of these pieces with the accompaniment of the organ, however, seems to be the best solution, not only because of the normal liturgical use of this music, but also, and above all, because of two clear autograph indications of the composer: in Illumina oculos meos, he wrote: “Offertory for the Fourth Sunday after Pentecost with music by Sig. Maestro Giordani of Fermo, for solo singing with Organ obligato»; In the Offertory Terra tremuit, the presence of the “tamburro” organ stop (“drum”) is explicitly indicated. The fact that at the time of Giordani’s presence the Church of Fermo owned an impressive twokeyboard, 12-foot base organ by the prestigious organ maker Callido, from Veneto, further corroborates the correctness of performing the upper staff with the intensity of classical Italian organs. The presence of very different tonalities (with up to four accidentals in the key signature, both sharps and flats) and the range of the upper melodic part seem to further specify the characteristics of the instrument available to Giordani, making it necessary to use a late-18th-century organ because of the versatility of its temperament and the extent of its keyboard in the high range. The choice of using the Callido organ of Morrovalle of 1804, recently restored with philological criteria by Michel Formentelli, was dictated by these requirements. In particular, this organ offers diversified possibilities of concertante stops that can hold their own in the dialogue with the voice, while preserving a constant variety of timbres. Marcello Rossi The organ of the Collegiata di S. Bartolomeo in Morrovalle, opus 408 (1804) by Professor d’organi Gaetano Callido Veneziano. The organ of the Collegiata di S. Bartolomeo in Morrovalle is opus 408 of the great Gaetano Callido1, who, during the year 1804 – according to his catalogue2 – made other five organs in the territory of the Marches. Approximately one fourth of Callido’s organs are situated in the Marches, and have turned out to be quite interesting to scholars, above all because they are unusually well preserved. The sound and timbre of a Callido organ can be adequately appreciated only by hearing a well-restored instrument played by a skilled organist who is performing music expressly conceived for it. We can attribute these characteristics to the pieces recorded in this CD: even the very slight “gust” that precedes the most articulated, besides being a mark of authenticity, is pleasant to hear. 1. For the biography of Gaetano Antonio Callido, see R. Lunelli, Studi e documenti di storia organaria veneta, Olschki, Firenze 1973, pp. 165-167, or the relevant entry by Oscar Mischiati in the Dizionario Biografico degli Italiani. 2. Published in R. Lunelli, op. cit., pp. 132-144. There are some doubts about the authenticity of the catalogue, which may have been drawn up by Callido’s son Antonio. 9 750701_Booklet.indd 9 7/12/12 3:15 PM Basic Report The organ is fitted in a wooden case in the choir on the counter-façade of the church. Original 47-key manual with short first octave and C1-D5 compass: diatonic keys covered with box-wood, chromatic ones covered with ebony; the diatonic keys have classical fronts with fronts scroll. Original pedalboard formed of 18 pedals with short first octave and C1 -A 2 compass; the last pedal is a dummy and activates the Acoustic Drum accessory. The pedals are permanently connected to the manual. Stops operated by means of hardwood knobs arranged in two columns on a walnut panel to the right of the manual; above them there is the Tiratutti handle. The printed labels, which have been restored, indicate the following stoplist Principale Bassi. [8’] Voce Umana. [sopranos] Principale Soprani. [8’] Flauto in VIII. Bassi [real from C2] Ottava. Flauto in VIII. Soprani Quinta Decima. Flauto in XII. Decima Nona. Cornetta. [sopranos, in XVII] Vigesima Seconda. Tromboncini Bassi. [8’] Vigesima Sesta. Tromboncini Soprani.[8’] Vigesima Nona. Tromboni. [pedal, 8’] Trigesima Terza. [up to F2] Trigesima Sesta [up to C2] Contrabassi. [pedal, 16’] Ottava di Contrabassi. [pedal, 8’, integral with Contrabassi] Accessories: Tiratutti with handle and double pedal, Tamburo acustico. Pitch = 433 Hz. at 19 °C, Tartini-Vallotti temperament, wind pressure = 65 mm. H2O. Fabio Quarchioni 10 750701_Booklet.indd 10 7/12/12 3:15 PM L’ organo Gaetano Callido opera 408 (1804) Collegiata di S. Bartolomeo in Morrovalle 11 750701_Booklet.indd 11 7/12/12 3:15 PM Daniela Nuzzoli si laurea brillantemente in violino, canto e con il massimo dei voti in Musica Vocale da Camera. Segue corsi di perfezionamento in canto barocco con Gloria Banditelli e per il canto lirico con Hilde Zadek, Dunja Vejzovic, Raúl Hernández e Gualtiero Negrini a Los Angeles. Debutta a Radio France (Parigi) nell’Iphigenie en Tauride di Piccini sotto la direzione di Enrique Mazzola. Si esibisce in vari importanti Festival nazionali e internazionali: Festival degli Organi antichi di Bologna, Festival Organistico Internazionale di Senigallia, Festival di Vallombrosa, Musica in Valcerrina ed è regolarmente ospite del Festival of Opera & Arts di Palm Desert in California. Svolge intensa attività concertistica come solista e con l’Ensemble Dorico di cui è membro fondatore. Daniela Nuzzoli completed brilliantly a degree in violin, singing, vocal chamber music and oratorio. Following postgraduate courses in early music with Gloria Banditelli and lyrical singing with Hilde Zadek, Dunja Vejzovic, Raul Hernandez and Gualtiero Negrini in Los Angeles. She made her début on Radio France (Paris) in Piccinni’s opera “Iphigenie en Tauride” under the direction of Enrique Mazzola. She has performed in various, National and International, festivals: Festival degli Organi antichi di Bologna, Festival Organistico Internazionale Senigallia, Festival of Vallombrosa, Musica in Valcerrina, between others and she is regularly invited to the Festival of Opera & Arts in Palm Desert, California. She has an intense concert activity as a soloist and as a part of the “Ensemble Dorico”, which is a founding member. Marcello Rossi, si è diplomato in Organo, Composizione e Clavicembalo (cum laude), si è poi specializzato con G. Murray presso l’“Universität für Musik” di Vienna. Ha suonato in vari festival in Italia, Germania, Francia, Repubblica Ceca, Svezia e Lituania, prevalentemente nel campo della musica antica. Ha lavorato sulle opere di Monteverdi con R. Gini (Ensemble Concerto) e con M. Longhini (Delitiae Musicae). Dopo aver vinto il concorso di musica da camera dell’ERTA (European Recorders’ Association), ha registrato le trio-sonate di J. H. Roman per “Bottega Discantica”. Lavora spesso con musica antica inedita: il giornale nazionale “Il Sole 24 Ore” e l’emittente “Radio 3 Suite” hanno dato entrambi largo spazio al suo lavoro con Emanuele Gasparini su un mottetto inedito di G. Frescobaldi (2007). Con scopi di ricerca ha fondato l’Ensemble “Vago Concento” con il quale esegue specialmente musica italiana rinascimentale e barocca. Marcello Rossi, graduated in Organ, Composition Studies and Harpsichord (cum laude), then he specialized with G. Murray, at the “Universität für Musik” in Wien. He played in various festival in Italy, Germany, France, Czech Republic, Sweden and Lithuania, mainly in the early music field. He worked on Monteverdi’s works with R. Gini (Ensemble Concerto) and M. Longhini (Delitiae Musicae). After winning the ERTA (European Recorders’ Association) chamber music competition he recorded trio-sonatas by J. H. Roman for “Bottega Discantica”. He often works on unpublished early music: the national newspaper “Il Sole 24 ore” and the national broadcasting company “Radio 3 Suite” gave both large space to his work with Emanuele Gasparini on an unpublished motet by G. Frescobaldi (2007). With research aims he founded the Ensemble “Vago Concento” which performs mainly Italian Renaissance and baroque music. 12 750701_Booklet.indd 12 7/12/12 3:15 PM Daniela Nuzzoli · Marcello Rossi k I testi delle composizioni sono disponibili al seguente link / the texts of the compositions are available on our website: www.tactus.it/testi Codice prodotto / Product Code: TC750701 13 750701_Booklet.indd 13 7/12/12 3:15 PM TC 750701 ℗ 2012 Made in Italy GIUSEPPE GIORDANI (1751-1798) Offertori per canto e organo Offertorios for Voice and Organ Prodotti correlati / Related products TC 680401 FRANCESCO DURANTE XII duetti a soprano e contralto. FRANCESCO SAVERIO MERCADANTE TC 711601 GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI Cantate da camera op. 2 TC 771302 GIOVANNI MORANDI Sonate per organo a quattro mani 750701_Booklet.indd 14 TC 791301 Musica sacra e stile operistico 7/12/12 3:15 PM
Scarica