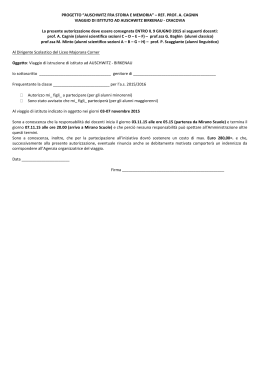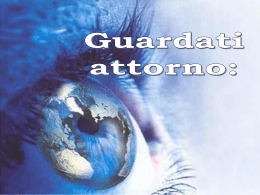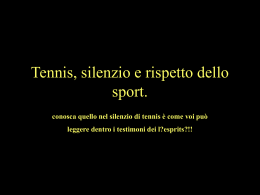Opera prima di un regista nato a Milano, ma che vive e lavora da molti anni in Germania, il film racconta con regia impeccabile e con esattezza storica il “secondo processo di Auschwitz”, gettando luce su una pagina poco nota della storia tedesca e mondiale. Uscito in prossimità della Giornata della Memoria, il film è entrato nella short list per la nomination all'Oscar come miglior film straniero, rappresentando la Germania. scheda tecnica titolo originale: durata: nazionalità: anno: regia: soggetto: sceneggiatura: fotografia: montaggio: musiche: scenografia: distribuzione: IM LABYRINTH DES SCHWEIGENS 124 MINUTI GERMANIA 2014 GIULIO RICCIARELLI ELISABETH BARTEL AMELIE SYBERBERG, ELISABETH BARTEL E GIULIO RICCIARELLI MARTIN LANGER E ROMAN OSIN ANDREA MERTENS SEBASTIAN PILLE E NIKI REISER MANFRED DÖRING E JANINA JAENSCH GOOD FILMS interpreti: ALEXANDER FEHLING (Johann Radmann), ANDRÉ SZYMANSKI (Thomas Gnielka), FRIEDERIKE BECHT (Marlene Wondrak), GERT VOSS (Fritz Bauer), JOHANNES KRISCH (Simon Kirsch), JOHANN VON BÜLOW (Otto Haller), ROBERT HUNGER-BÜHLER (Walter Friedberg), HANSI JOCHMANN (segretaria). festival: presentato in anteprima al Toronto International Film Festival, selezionato per rappresentare la Germania ai premi Oscar 2016 per il miglior film straniero (short list). Giulio Ricciarelli Giulio Ricciarelli è nato a Milano il 2 agosto 1965. Trasferitosi giovanissimo in Germania con la famiglia, ha studiato recitazione alla scuola d'arte drammatica Otto Falckenberg di Monaco. Ha quindi iniziato la sua carriera come attore di teatro, ingaggiato nelle compagnie dei teatri di Basilea, Stoccarda, Monaco e cimentandosi anche in ruoli televisivi. Debutta al cinema recitando nel film Rossini, in un piccolo ruolo. (1996)DaNel 2000 fonda una sua casa di produzione (Naked Eye Filmproduction). Nel 2005 il suo cortometraggio Vincent viene presentato a vari festival dove ottiene premi e riconoscimenti. Il labirinto del silenzio è il film che lo impone all'attenzione internazionale. La parola ai protagonisti Intervista a Giulio Ricciarelli Il labirinto del silenzio ci restituisce lo spaccato poco noto di una Germania di fine anni '50 tutt'altro che consapevole delle sue colpe e del massacro nazista. Com'è possibile? Che ricerche storiche ha fatto? È questo il paradosso del film. È incredibile in effetti e anche io non lo credevo, ma quello che raccontiamo è vero. Abbiamo lavorato strettamente con molti storici, in particolare con Werner Renz dell'Istituto Fritz Bauer dell'Università di Francoforte. Abbiamo avuto la collaborazione anche di Gerhard Wiese, uno dei tre giovani procuratori che avevano lavorato al primo processo di Auschwitz, e gli abbiamo chiesto: 'Signor Wiese, lei come ha saputo di Auschwitz?'. Ebbene, Wiese a 17 anni è stato soldato, negli ultimi mesi della guerra, ed è stato catturato dai russi: nel campo di prigionia c'era affisso un articolo con tutti i campi di concentramento tedeschi; i prigionieri tedeschi hanno però pensato che non fosse vero e che si trattasse di propaganda. Da allora Wiese si è dimenticato tutto, è poi rientrato in Germania nel '48, ha studiato legge, è diventato un procuratore e nel '62 il pubblico ministero generale Fritz Bauer lo fatto assistente di questo processo. Gli altri altri due procuratori già operativi gli hanno dato un libretto su Rudolf Höß, un comandante di Auschwitz catturato dai polacchi. Gli hanno detto: 'Leggi cos'è successo in questo posto'. Non sapeva, eppure era un avvocato, un uomo educato. Si deve inoltre considerare che all'epoca c'era una generazione nuova: chi aveva 5 anni quando la guerra è finita, è cresciuto in un'atmosfera in cui nessuno parlava mai del passato. C'era un misto di negare, non sapere, sapere un po', si dovrebbe sapere ma non si vuole sapere: ci sono tutti i colori in questo quadro e questo è quello che Il labirinto del silenzio tenta di raccontare. Il tuo film mescola finzione e realtà storica Sì, ma in fondo prevale la verità storica: la figura di Fritz Bauer, il procuratore capo che incoraggia, sostiene e guida un gruppetto di giovani procuratori nel loro lavoro di ricerca dei colpevoli, è storica. Bauer è una personalità importante nella storia della Germania, molti dei dialoghi del film vengono da lui. Quanto a Johann, è un personaggio inventato, ma abbiamo incontrato due giudici che lavorarono al processo e il personggio è stato scritto sulla base delle loro esperienze. Ho voluto un personaggio di finzione per avere la libertà di inserirlo nella verità del contesto storico e volevo essere molto esatto con la storia. Uno dei giovani procuratori, Kügler, con cui abbiamo parlato scrivendo la sceneggiatura (è morto prima che girassimo il film), era davvero deluso dalla giustizia tedesca. Ha smesso di fare il procuratore, è diventato avvocato penale e anche difeso alcuni criminali di guerra. Questo aspetto, ad esempio, l'abbiamo messo nel personaggio di Johann. Johann si ispira molto alla verità storica, ma c'è in lui anche una certa licenza creativa. Hai dato al tuo film un ritmo e una struttura da film di genere Vorrei che la storia del processo di Francoforte che io, come molti tedeschi di oggi, non conoscevo, arrivasse al pubblico più vasto. La parola suona male, ma vorrei che fosse un film commerciale. In Germania ha funzionato, ha avuto buoni incassi e una stampa positiva, che ha dedicato spazio anche alla ricostruzione del processo di Francoforte. Molti tedeschi vorrebbero dire basta ai film che ricordano l’Olocausto, ma le istituzioni ci hanno sostenuto, durante le riprese a Francoforte, ci hanno offerto ospitalità. Ed è un segno forte il fatto di averci selezionato per l’Oscar. Lo scopo primario era fare un bel film da vedere, emozionale. Io vengo dal teatro: se chiedo tempo alla gente, voglio anche offrirgli un'esperienza intensa. Poi sì, volevamo raccontare questa storia sconosciuta nel mondo, in Germania come in America, una storia che merita un film. E poi raccontare anche quant'è difficile per un popolo affrontare il proprio passato. Nel miracolo economico in Germania tutti guardavano avanti, tutti negavano, non ne volevano parlare. Inoltre volevamo sottolineare la forza dell'individuo, rappresentata da questi giovani procuratori di Fritz Bauer che hanno detto: 'Basta, noi non possiamo non affrontare, dobbiamo farlo per essere una democrazia stabile; per ricostruire la Germania dobbiamo affrontare cos'è successo'. Questo è un atteggiamento molto morale e coraggioso che trovo bello da raccontare. Il film, in maniera opportuna ed emozionante, non indugia su immagini già tristemente note, di sadismo e morte nei campi di concentramento. Si sofferma piuttosto sulle facce sconvolte di chi ascolta i ricordi, sui movimenti delle mani di chi racconta. È una precisa scelta stilistica? Sì, è un rischo che ci siamo presi. Le immagini dei campi di concentramento sono note e sono già tanto nel pubblico. Il pubblico di oggi è sofisticato e credo che non voglia più vedere scene ricreate ad Auschwitz: si distaccherebbe dalla storia, sa che è finzione e guardebbe alla ricostruzione chiedendosi 'vediamo come la fa lui adesso'. Noi non facciamo un film sull'Olocausto ma sulla Germania degli anni '50, però abbiamo bisogno dell'orrore dell'Olocausto. Abbiamo scelto di far sì che in quei punti il film quasi si ritirasse, lasciando vivere la fantasia e la memoria del pubblico. Il risultato mi rallegra perché sembra che funzioni: è più emozionale così, credo che funzioni meglio di flashback o qualcosa del genere, che sarebbe stato anche manipolativo. Negli anni '70 c'era una serie televisiva, Olocausto, con Meryl Streep: era molto importante perché erano le prime immagini di fiction su Auschwitz. Oggi ormai ci sono tantissimi film. Se uno va là deve avere un'idea speciale, come La vita è bella di Benigni e come - credo - Il figlio di Saul, che non ho ancora visto. Per il mio film non avrei trovato giusto fare alcune scene ad Auschwitz. Come mai hai scelto proprio questa vicenda? Si poteva fare un film solo sul processo, o su una vittima in particolare dell'Olocausto, ma la storia del giovane avvocato deciso a svelare i crimini di guerra dei nazisti nella Germania postbellica è interessante ancora oggi: se non fosse stato per il protagonista di questo film quei 'conti' non si sarebbero fatti. Tutto quello che mostro nel film è vero, storicamente documentato. Il film è una riflessione sulla responsabilità ma sembra non voler essere troppo giudicante verso il passato. Il personaggio centrale, infatti, a un certo punto dice: 'Non so cosa avrei fatto io'. E questa è la massima umiltà. Un film non può mettersi su un piedistallo a giudicare. Siamo tutti umani e dobbiamo avere l'umiltà di capire che l'essere umano è capace del bello ma anche del cattivo. Non si può giudicare gente dalla poltrona, quando non si sa come ci si sarebbe comportati in una data situazione. Volevo raccontare contemporaneamente due cose: da una parte l'ampiezza della colpa che esiste in Germania, perché non sono stati solo pochi nazisti, è stato tutto un popolo a sbagliare, anche non resistere è stata una forma di collaborazione; dall'altra parte però non volevo giudicare. Ognuno di noi nella propria vita deve fare delle scelte giuste. Il tuo film ha un respiro universale, parla della necessità di non dimenticare In molti mi hanno avvicinato per dimostrarmi gioia e commozione, per condividere i propri ricordi… Argentini, spagnoli, tedeschi, inglesi, turchi, testimonianze da paesi nei quali c'è stato troppo silenzio, anche da parte delle vittime e anche dopo aver superato i momenti più duri. Non hai avuto timore di trattare per la sua prima regia e da italo-tedesco una storia così delicata per la Germania? Volevo fare questo balzo dietro la macchina da presa e ho cercato una storia abbastanza forte. Ho avuto un approccio iniziale un po' naïf, non mi sono fatto tanti problemi. Ho scritto la sceneggiatura con Elisabeth Bartel: quando scrivi realizzi un lavoro di fantasia, non è reale, si spera di farne un film. Poi quando la sceneggiatura è diventata solida e forte abbiamo trovato un finanziamento. A questo punto mi è venuto non il panico ma la paura sì: già fare un film per la prima volta è un grande compito, lo è ancor di più con una storia così importante, dove il tono del film deve essere giusto e non ci si può permettere tanti sbagli. Ma la forza della storia - non solo della sceneggiatura, ma della storia reale - ha preso il sopravvento e mi sono sottomesso ad essa. Mi sono detto: 'Farò del mio meglio'. Per andare avanti devi vivere ogni giorno come un giorno da conquistare ma con un atteggiamento professionale e sereno: non si può tenere in mente sempre la gravità e il peso del tema affrontato. Lo stesso è valso per tutti i collaboratori, per gli attori, per il team: la storia ci ha aiutato, era là, era forte, sapeva sempre cosa voleva e noi abbiamo fatto cosa voleva la storia. Un tema comunque delicato per il pubblico tedesco, lo accetteranno da un italiano? O lei si sente ormai del tutto tedesco? Con un padre italiano non sei mai tedesco… in Germania poi sei sempre un bagnino o un gelataio. Mio padre è ingegnere, ma resta un 'pizzaiolo'. E non mi piace questa idea che continuano ad avere alcuni tedeschi, anche se mi piace continuare ad essere percepito come italiano. Per me l'Italia è un Paese bellissimo, con una cultura profonda. Io stesso in Germania sono l'italiano, mentre in Italia per i miei cugini sono "il tedesco". Anche lavorativamente si percepisce questo doppio registro? Il film l'ho fatto con i soldi tedeschi e con un team tedesco, per cui è tedesco. Ma in realtà sin da quando ho realizzato i primi cortometraggi mi sono reso conto che anche il mio modo di fare film non è del tutto tedesco, diciamo al 50%. C'è una certa capacità di emozionarsi, un calore, che devo lottare per riuscire a far emergere. Ci sono delle battute che ho voluto inserire e che in Germania non sarebbero state pronunciate… Se si vede il cinema tedesco spesso è più distante e secco, più analitico che emozionale. Hai mai pensato o avuto occasione di lavorare in Italia? Questo è il mio primo film da regista, tutte le esperienze precedenti sono sempre state come attore. Adesso mi sono pentito, sarei dovuto andare in Italia a vent'anni per poter migliorare il mio italiano e poter recitare anche lì, ma lavorando tanto in Germania non avevo ragione di farlo, di lasciare tutto per un anno o più per trasferirmi. Gli ultimi due, tre anni sono stati dedicati completamente al film da regista, era un passo che volevo fare da un po' di tempo. E' stato un tunnel che non mi ha lasciato il tempo di scrivere altro. Speriamo che il prossimo venga più facile. Hai già qualcosa in cantiere? Magari sull'Italia o in Italia? Ho alcune cose in via di sviluppo, ma niente a breve scadenza. Mi piacerebbe però. Una delle idee è di sviluppare un tema molto discusso in Italia, quello dei lavoratori stranieri immigrati. Un tema che era anche in Solino di Fatih Akin, dove due attori tedeschi (Barnaby Metschurat e Moritz Bleibtreu) interpretavano i figli di un italiano emigrato negli anni '70, o in Pane e cioccolata con Nino Manfredi. Pensi sia possibile lavorare da noi? Dipende. Non lo so. Non credo che il cinema italiano aspetti Giulio Ricciarelli. Il cinema oggi è una torta che diventa sempre più piccola, e tutti vogliono mangiare una fetta. Ogni ora passata su facebook, ogni ora spesa a guardare in streaming sono sottratte al cinema. Ma l'Italia ha una grandissima e bellissima tradizione cinematografica. Mi piacerebbe molto lavorare in Italia, sarebbe un sogno A proposito di sogni, te lo saresti mai aspettato di entrare nella shortlist dei nove titoli in corsa per l'Oscar al film straniero? Non me l'aspettavo, sono molto onorato. È molto bello, sono nervoso naturalmente. Vediamo come andrà ma già sono molto contento che il film giri il mondo: è stato in Brasile, in Cina, in Giappone, Australia, America. Siamo riusciti a fare un film che è un po' universale, che tocca la gente. La corsa all'Oscar è un gioco, bellissimo: sono molto emozionato e se mi scelgono per la cinquina finale farò un salto e un urlo, sennò sarò depresso per tre giorni, ma è sempre un gioco. Recensioni Natalia Aspesi. Repubblica Si può dimenticare l’Olocausto? Non solo i negazionisti, ma una intera nazione, quella responsabile? La Germania lo fece per quasi un ventennio, come se il processo di Norimberga, del 1945-46, con la condanna a morte dei grandi responsabili del nazismo (ma quelli condannati alla detenzione furono graziati negli anni 50), avesse chiuso per sempre quel capitolo mostruoso, cancellandolo come se non fosse mai avvenuto. Quello storico processo poi era in mano agli alleati, ai vincitori, non ai vinti, ai tedeschi, piegati dalla sconfitta, dalla miseria, dalla distruzione. Bisognava ricominciare, riprendersi la vita e il benessere, lasciarsi vincere dall’amnesia... Il processo contro Eichmann con la sua condanna a morte avvenne a Gerusalemme nel 1961, ma solo nel 1963 ci fu un grande processo istruito dalla giustizia tedesca contro i crimini di guerra perpetrati dai tedeschi: fu celebrato a Francoforte, nel 1963, in piena ripresa economica e voglia di divertirsi, costò 5 anni di ricerche, durò 20 mesi, imputati 22 ufficiali SS, 183 udienze, 17 condannati, 6 all’ergastolo. Si riconosceva finalmente che tante brave persone tedesche, tornate alle loro belle famigliole e al loro lavoro, panettieri (era panettiere il secondo direttore del campo, Joseph Bauer), guardiacaccia, medici, avvocati, contadini, erano state spietate SS che avevano torturato, gasato, ucciso milioni di persone, uomini, donne, vecchi, bambini ad Auschwitz- Birkenau, in Polonia, inferno dove avevano prestato servizio 8000 delle 600mila SS. (...) Il labirinto del silenzio, candidato all’Oscar come film straniero, in sala dal 14 gennaio, è una grande storia indimenticabile, carica di serena passione, tesa nel ritmo ansioso del thriller dove il giustiziere deve muoversi tra mille ostacoli ma li vince tutti. Lo ha girato Giulio Ricciarelli, padre italiano, madre tedesca, cinquantenne al suo primo film, scritto con Elisabeth Bartel; senza una scena, una foto dell’Olocausto; solo qualche straziata parola strappata ai sopravvissuti (...); solo quelle facce qualsiasi di uomini di mezza età, gli ex aguzzini, tornati cittadini esemplari, che, muti, perdono ogni bonomia in un attimo di consapevolezza della loro ferocia dimenticata. Il giovane magistrato Radmann (...) non conosce il passato recente del suo paese. È il 1958, e lui come quelli della sua generazione non ha mai sentito nominare Auschwitz. (…) Al palazzo di giustizia la cosa non interessa (...) tranne che al procuratore generale, Fritz Bauer, il meraviglioso, dolente Gert Voss, che gli consente di indagare ma lo avverte: «Non penserà che dopo la morte di Hitler i nazisti siano scomparsi? Sono dappertutto, ad ogni livello, hanno dimenticato e fatto dimenticare ». Un altro magistrato che lo prende in giro chiamandolo sceriffo gli grida «Non vorrà che tutti i figli chiedano al padre se era nazista?». Sì, Radmann lo vuole, «voglio la fine della menzogna e del silenzio». (...) Per Radmann Mengele diventa un’ossessione, sa che va e viene dal Sudamerica, indisturbato, sotto falso nome. Ma è troppo protetto ovunque, nessuno vuole che venga preso, morirà libero in Brasile, nel 1979. Marzia Gandolfi. Mymovies.it (…) Francoforte, 1958. Johann Radmann è un giovane procuratore deciso a fare sempre ‘quello che è giusto’. Un principio, il suo, autografato sulla foto del genitore, scomparso alla fine della Seconda Guerra Mondiale e di cui conserva un ricordo eroico. Ma i padri della nazione, quella precipitata all’inferno da Hitler, a guardarli bene sono più mostri che eroi e Johann dovrà presto affrontarli. (…) Schiacciato tra il silenzio di chi vorrebbe dimenticare e di chi non potrà mai dimenticare, il procuratore chiede consiglio e aiuto a Fritz Bauer, procuratore generale, che gli darà carta bianca e il coraggio di perseverare. Testimonianza dopo testimonianza, Johann Radmann prende coscienza dell’orrore, ricostruisce il passato prossimo della Germania e avvia il ‘secondo processo di Auschwitz’. La Shoah ha marcato il secolo scorso con un’impronta unica e tragica, influenzando in maniera decisiva i nostri modelli di rappresentazione e particolarmente il cinema. Questa ‘influenza’ continua a interrogare autori, critici ed esperti e a produrre opere che aiutano a convivere col passato, un passato che non può e non deve passare. E di passato e della sua rielaborazione dice (molto bene) Il labirinto del silenzio di Giulio Ricciarelli, regista italiano naturalizzato tedesco, che assume il cinema come metodo d’investigazione e approccia il soggetto con l’eloquio lento del ‘diritto’. Con Il labirinto del silenzio assistiamo precisamente a uno slittamento dal piano della visione a quello dell’ascolto, dalla potenza delle immagini a quella delle parole. Al centro del film un giovane e biondo procuratore che sessant’anni dopo la liberazione dei campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau guida il proprio Paese come Arianna fuori dal dedalo e dal silenzio. Se la Germania dichiara oggi a voce alta la propria responsabilità eterna per la Shoah, non è stato sempre così. Dopo la guerra i tedeschi non avevano alcuna voglia di risvegliare i fantasmi del passato e troppa forse di tirarci una linea sopra, rimuovendone il peso. Nel 1949 dunque il cancelliere Konrad Adenauer appoggiava la reintegrazione massiva, soprattutto nella funzione pubblica, dei cittadini rimossi dai loro incarichi perché coinvolti con il regime nazista. Promotore della resurrezione materiale della Germania, sottolineata da Ricciarelli con champagne, nuovi edifici e nuovo stile di abbigliamento, Adenauer interpretava il desiderio della sua gente che voleva soltanto dimenticare, che non voleva sapere. Tutto cambierà però a partire dal 1958 e per l’intervento di una commissione incaricata di indagare sui crimini di guerra e sui criminali nazisti. Mescolando personaggi reali (il giornalista Thomas Gnielka e il procuratore Fritz Bauer, a cui il film rende omaggio) e di finzione (il protagonista ‘composto’ da tre procuratori esistiti), l’autore realizza un dramma giuridico e personale storicamente irreprensibile. Film-dossier sobrio ed efficace, Il labirinto del silenzio scorre una pagina rilevante della storia in fondo alla quale il male avrà finalmente “un nome, un viso, un’età, un indirizzo”. Divorato dall’interno e ‘aggredito’ dall’omertà dominante, il protagonista ostinato di Alexander Fehling si fa carico del passato della nazione. Convinto di vivere nel paese migliore del mondo, come cantano i bambini nel cortile della scuola, Radmann non riesce davvero a immaginare cosa siano stati i campi di sterminio spacciati per ‘campi di detenzione preventiva’. Ma l’enormità della menzogna non tarda a travolgere il protagonista convinto di indagare su un omicidio e smentito dalla realtà che emerge lo sterminio di massa. Due anni dopo il processo Eichmann a Gerusalemme e vent’anni dopo il processo di Norimberga, ventidue criminali nazisti (soltanto sei saranno condannati all’ergastolo) compariranno davanti al tribunale di Francoforte. Momento capitale nella storia recente della Germania, il ‘secondo processo di Auschwitz’ apre una fase volta alla sensibilizzazione della magistratura e dell’opinione pubblica sul tema delle colpe e delle responsabilità della Germania durante la guerra. Assumere il proprio passato divenne da allora un dovere morale per tutto il Paese. Teso e appassionante come un polar, Il labirinto del silenzio svolge una partitura inquisitoria che bracca i cattivi, confronta superiori, gerarchi e subordinati e interroga il silenzio degli aguzzini e quello delle vittime, barricate dietro il loro dolore. Perché il film, attraverso il personaggio di Simon, tratta (anche) l’isolamento dei sopravvissuti, la difficile integrazione in Germania come in Israele, l’impossibilità di dire a chi ignorava l’ampiezza dello sterminio. Ma il film trova le parole, quelle della legge e quelle del Kaddish che Radmann e Gnielka reciteranno per i bambini di Simon lungo il perimetro spinato di Auschwitz. Il silenzio è rotto. Fulvia Caprara. La Stampa Alzare il velo su un passato prossimo frettolosamente archiviato, scoprire la verità, sottoporre i criminali al giudizio che meritano. Tutto questo in contrasto con l’aria del tempo, nella Germania del 1958, dove nessuno desidera ripensare ai giorni del regime Nazionalsocialista, all’Olocausto, alla guerra e alle sue terribili conseguenze. Diretto da Giulio Ricciarelli, di nascita milanese (classe 1965) e di formazione tedesca, Il labirinto del silenzio ricostruisce l’avventura coraggiosa del giovane Pubblico ministero Johann Radmann (Alexander Fehling) che, sfidando colpe sopite e realtà insabbiate, decide di indagare su ciò che era veramente accaduto nei lager e sulle responsabilità di chi li aveva guidati, aprendo le porte del fondamentale processo di Francoforte: «Dopo la fine della seconda Guerra Mondiale - spiega il regista - si è tralasciato per molti anni di discuterne in modo esauriente, non si parlava né dei colpevoli né delle vittime, ovviamente c’erano persone che sapevano di Auschwitz, ma la maggior parte dei tedeschi ne ignorava l’esistenza». Per questo, secondo lo storico e giornalista Paolo Mieli, Il labirinto del silenzio è un film «importantissimo», non semplicemente sull’Olocausto, «ma sulla rimozione, un processo da cui nessun Paese è estraneo». Scelta dalla Germania per partecipare alla corsa agli Oscar 2016, nei cinema dal 14 con Good Films (nello stesso giorno, dall’America, arriveranno i nomi dei cinque candidati al miglior film in lingua straniera), l’opera di Ricciarelli affronta, prosegue Mieli, un vero e proprio «tabù storiografico». Con l’entrata dei russi ad Auschwitz nel ‘45 «il mondo si rese conto di quello che era successo e iniziò ufficialmente il dopoguerra». Ma gli anni che vennero subito dopo non furono meno tragici dei precedenti. Nel rimodellamento dell’Europa post-bellica succedeva che i confini venissero spostati, che «i tedeschi rimasti nei Paesi che avevano occupato fossero cacciati, che, durante le marce, morissero come mosche, oppure che si ritrovassero nei campi di concentramento, vittime di un terribile contrappasso». Sulla Germania in ginocchio le due potenze Usa e Urss, «decisero, in modi diversi, di chiudere un occhio. Il processo di Norimberga finì nel ‘46, in tanti la fecero franca e molti dei condannati vennero messi in libertà alla spicciolata. Era iniziata la Guerra Fredda e l’intero Occidente era convinto che una Terza Guerra Mondiale potesse essere imminente». In questo scenario, lo stesso in cui «tanti ebrei continuavano a tacere, per pudore, per dolore, e anche per la vergogna legata agli episodi di forzato collaborazionismo», si apre la storia del film. La Germania è un Paese proteso verso il vitalismo della ricostruzione e del miracolo economico, popolato da ventenni ignari, che non immaginavano, oppure si rifiutavano di accettare la verità dei fatti: «In genere sapevano solo che i padri avevano fatto la guerra e l’avevano persa... L’adesione al nazismo era stata del 100%, eppure tutti dichiaravano di aver preso parte ai riti, ma di non avere colpe... per un ventennio l’intera Germania aveva compiuto un percorso di auto-assoluzione». Opporsi a tutto questo fu impresa titanica. Il film, sceneggiato dal regista insieme a Elisabeth Bartel, descrive la solitudine angosciosa del magistrato protagonista, i segreti devastanti nascosti nella sua stessa famiglia, la scoperta che in una normale scuola elementare poteva normalmente insegnare un’ex-guardia di Auschwitz, l’insanabile ferita dell’ex-deportato, padre di due bimbe gemelle, finite nelle mani dell’orco Mengele «il peggior criminale del nazismo che la Germania non riuscì mai a prendere». Al fianco di Radmann si muovono, sullo schermo, le figure della fidanzata, dei colleghi che, sulle prime, lo sbeffeggiano, delle vittime che accettano di testimoniare, una dopo l’altra, svelando sofferenze atroci, della segretaria, all’inizio critica e riluttante, poi anche lei travolta dalla forza della verità: «Il suo personaggio - osserva Mieli - rappresenta bene il popolo tedesco. Prima diffidente e poi, una volta convinto che le indagini sugli exnazisti non erano il frutto di una manovra dell’altra Germania, quella dell’Est, deciso ad andare avanti, senza cedimenti morali». Da allora in poi i processi «furono accompagnati dal più pieno consenso». Nel ruolo cruciale del Pubblico ministero Generale Fritz Bauer recita il grande attore teatrale Gert Voss: «Solo davanti alle prove documentali, Bauer si convince completamente. Se il giovane collega avesse messo in piedi un processo ideologico, fatto di chiacchiere, lui lo avrebbe immediatamente chiuso». Arrivare, nel 1963, al giudizio di Francoforte, a due anni di distanza dal processo Eichmann che si era svolto a Gerusalemme, fu evento storico basilare, non solo per le pene inflitte, ma per quelle alleviate, dei sopravvissuti: «Per chi aveva subito quei patimenti, non vederli riconosciuti era un dramma aggiuntivo». Tanti erano morti, ma, per chi era rimasto in vita, verificare che ci si comportasse come se le sofferenze subite non fossero mai esistite, era un nuovo, insopportabile affondo. Rimuovere vuol dire proprio questo, allontanare dalla propria coscienza eventi intollerabili: «Rimozioni simili - ricorda Mieli - hanno coinvolto tanti altri Paesi, compreso il nostro. Basta pensare alla lotta al brigantaggio nel Sud o all’argomento foibe, mai affrontato per un cinquantennio». In questo senso «Il labirinto del silenzio» «è più valido di tanti altri film», dove il tema Shoah, pur provocando la commozione del pubblico, non è stato messo esattamente a fuoco. Carola Proto. Comingsoon.it Nella Germania hitleriana, il procuratore baby-face Johann Radmann sarebbe stato molto probabilmente un bravo ragazzo ariano, il candidato ideale - perché alto, biondo e dal portamento eretto - per diventare un ufficiale al servizio delle SS. Nell’anno 1958 in cui è ambientato Il labirinto del silenzio, però, la patria di Goethe è un paese diverso dalla terra che ha ospitato il Terzo Reich, è una nazione in ripresa, baciata dal sole e dal chiarore della birra, dove si può o gioire delle sottogonne e del rock’n roll oppure risvegliarsi dall’amnesia collettiva post-bellica per riaprire le porte delle stanze degli orrori. Così, ecco che nel film tedesco scelto per gli Oscar, il Pubblico Ministero in cui Giulio Ricciarelli ha riunito i tre procuratori che lavorarono al processo di Auschwitz prende le distanze dai padri per sposare le ragioni di quella disgraziata gente uccisa con il gas o marchiata di infamia e di stella di David sulle divise da prigioniero. Ora, Radmann non è la prima persona, o il primo personaggio a cui questa bella cosa succede, ma la sua vicenda doveva (secondo noi) essere raccontata, perché se è vero che le macchine da presa di un’infinità di registi si sono inoltrate, nel tempo, fra i dormitori e i cortili dei campi di sterminio nazisti, i film sul dopo-Olocausto non sono ancora abbastanza e soprattutto quasi nessuno immagina che, nei dieci anni immediatamente successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ben poco si sapesse a proposito dell’inferno in Polonia in cui morirono più di un milione di ebrei. A dire la verità, nemmeno Ricciarelli ne era al corrente, e quando lo ha scoperto, ha avvertito quel sentimento che in un film è spesso garanzia di onestà e di rigore: l’urgenza. Con un’ansia di un testimone con un’importante dichiarazione da rilasciare e un’umiltà sconosciuta a tanti esordienti, il regista si è lasciato prendere per mano dalla storia e ha assecondato il suo calmo fluire con un ritmo giusto - né troppo lento né forsennato - lasciando il non detto e il non visto fuori campo e creando un’interessante corrispondenza fra l’esattezza dei fatti riportati e la precisione di un montaggio decisamente classico. E’ venuto fuori un film limpido, forse ingenuo come il suo protagonista (che a un certo punto spera di catturare il “dottor morte” Josef Mengele), ma semplice e perciò incisivo. (…) Il labirinto del silenzio non è un film per spettatori cervellotici, ma per chi desidera semplicemente imparare qualcosa, meglio se attraverso un processo di identificazione con un eroe che, proprio come uno degli X-Men, dubita ed entra in crisi, precipitando temporaneamente nel gorgo della rinuncia. Eichmann e la banalità del male Ricciarelli li lascia ad altri, così come i giudizi sulla follia da svastiche. In fondo, il romanzo di formazione di Radmann coincide anche con il suo apprendistato di regista e per entrambi, di nuovo, contano in primo luogo i fatti.
Scaricare