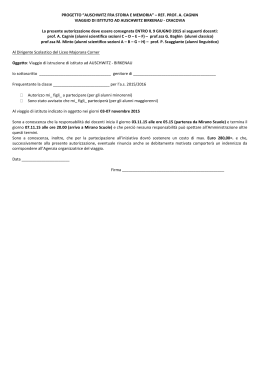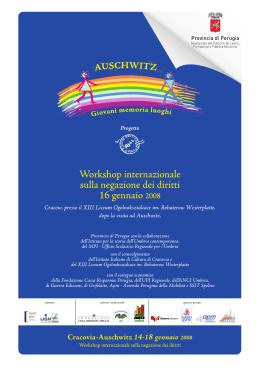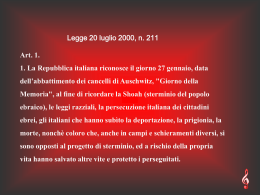IL LABIRINTO DEL SILENZIO (Im Labyrinth des Schweigens) di Giulio Ricciarelli. Con Alexander Fehling, André Szymanski, Friederike Becht, Johannes Krisch, Hansi Jochmann (Germania, 2014) 124' Il labirinto del silenzio: intervista a Giulio Ricciarelli, l'italo-tedesco da Oscar Dietro alla macchina da presa c'è un tocco italiano: alla sua prima regia, c'è l'attore italo-tedesco Giulio Ricciarelli, nato in Italia ma trasferitosi presto in Germania. Sullo sfondo di eventi realmente accaduti, ordisce una riflessione personale su un periodo storico in cui gli individui guardavano avanti e alla ripresa con occhi fiduciosi; nell'era delle sottogonne e del rock'n'roll, il passato nazista era un malloppo da dimenticare. Il labirinto del silenzio ci restituisce lo spaccato poco noto di una Germania di fine anni '50 tutt'altro che consapevole delle sue colpe e del massacro nazista. Com'è possibile? Che ricerche storiche ha fatto? "È questo il paradosso del film. È incredibile in effetti e anche io non lo credevo, ma quello che raccontiamo è vero. Abbiamo lavorato strettamente con molti storici, in particolare con Werner Renz dell'Istituto Fritz Bauer dell'Università di Francoforte. Abbiamo avuto la collaborazione anche di Gerhard Wiese, uno dei tre giovani procuratori che avevano lavorato al primo processo di Auschwitz, e gli abbiamo chiesto: 'Signor Wiese, lei come ha saputo di Auschwitz?'. Ebbene, Wiese a 17 anni è stato soldato, negli ultimi mesi della guerra, ed è stato catturato dai russi: nel campo di prigionia c'era affisso un articolo con tutti i campi di concentramento tedeschi; i prigionieri tedeschi hanno però pensato che non fosse vero e che si trattasse di propaganda. Da allora Wiese si è dimenticato tutto, è poi rientrato in Germania nel '48, ha studiato legge, è diventato un procuratore e nel '62 il pubblico ministero generale Fritz Bauer lo fatto assistente di questo processo. Gli altri due procuratori già operativi gli hanno dato un libretto su Rudolf Höß, un comandante di Auschwitz catturato dai polacchi. Gli hanno detto: 'Leggi cos'è successo in questo posto'. Non sapeva, eppure era un avvocato, un uomo educato. Si deve inoltre considerare che all'epoca c'era una generazione nuova: chi aveva 5 anni quando la guerra è finita, è cresciuto in un'atmosfera in cui nessuno parlava mai del passato. C'era un misto di negare, non sapere, sapere un po', si dovrebbe sapere ma non si vuole sapere: ci sono tutti i colori in questo quadro e questo è quello che "Il labirinto del silenzio" tenta di raccontare". La figura centrale del giovane procuratore idealista Johann Radmann a chi si ispira? "Ai giovani procuratori della realtà. Siccome con questo personaggio ci siamo presi una certa libertà emozionale, gli abbiamo attribuito un nome inventato. Volevo essere molto esatto con la storia. Uno dei giovani procuratori, Kügler, con cui abbiamo parlato scrivendo la sceneggiatura (è morto prima che girassimo il film), era davvero deluso dalla giustizia tedesca. Ha smesso di fare il procuratore, è diventato avvocato penale e anche difeso alcuni criminali di guerra. Questo aspetto, ad esempio, l'abbiamo messo nel personaggio di Johann. Johann si ispira molto alla verità storica, ma c'è in lui anche una certa licenza creativa". Il film, in maniera opportuna ed emozionante, non indugia su immagini già tristemente note, di sadismo e morte nei campi di concentramento. Si sofferma piuttosto sulle facce sconvolte di chi ascolta i ricordi, sui movimenti delle mani di chi racconta. È una precisa scelta stilistica? "Sì, è un rischio che ci siamo presi. Le immagini dei campi di concentramento sono note e sono già tanto nel pubblico. Il pubblico di oggi è sofisticato e credo che non voglia più vedere scene ricreate ad Auschwitz: si distaccherebbe dalla storia, sa che è finzione e guarderebbe alla ricostruzione chiedendosi 'vediamo come la fa lui adesso'. Noi non facciamo un film sull'Olocausto ma sulla Germania degli anni '50, però abbiamo bisogno dell'orrore dell'Olocausto. Abbiamo scelto di far sì che in quei punti il film quasi si ritirasse, lasciando vivere la fantasia e la memoria del pubblico. Il risultato mi rallegra perché sembra che funzioni: è più emozionale così, credo che funzioni meglio di flashback o qualcosa del genere, che sarebbe stato anche manipolativo. Negli anni '70 c'era una serie televisiva, Olocausto, con Meryl Streep: era molto importante perché erano le prime immagini di fiction su Auschwitz. Oggi ormai ci sono tantissimi film. Se uno va là deve avere un'idea speciale, come "La vita è bella di Benigni" e come – credo – "Il figlio di Saul", che non ho ancora visto. Per il mio film non avrei trovato giusto fare alcune scene ad Auschwitz". Lo scopo del film è far conoscere i processi di Auschwitz, meno noti di quelli di Norimberga? "Lo scopo primario era fare un bel film da vedere, emozionale. Io vengo dal teatro: se chiedo tempo alla gente, voglio anche offrirgli un'esperienza intensa. Poi sì, volevamo raccontare questa storia sconosciuta nel mondo, in Germania come in America, una storia che merita un film. E poi raccontare anche quant'è difficile per un popolo affrontare il proprio passato. Nel miracolo economico in Germania tutti guardavano 1 avanti, tutti negavano, non ne volevano parlare. Inoltre volevamo sottolineare la forza dell'individuo, rappresentata da questi giovani procuratori di Fritz Bauer che hanno detto: 'Basta, noi non possiamo non affrontare, dobbiamo farlo per essere una democrazia stabile; per ricostruire la Germania dobbiamo affrontare cos'è successo'. Questo è un atteggiamento molto morale e coraggioso che trovo bello da raccontare". Il film è una riflessione sulla responsabilità ma sembra non voler essere troppo giudicante verso il passato. "Il personaggio centrale, infatti, a un certo punto dice: 'Non so cosa avrei fatto io'. E questa è la massima umiltà. Un film non può mettersi su un piedistallo a giudicare. Siamo tutti umani e dobbiamo avere l'umiltà di capire che l'essere umano è capace del bello ma anche del cattivo. Non si può giudicare gente dalla poltrona, quando non si sa come ci si sarebbe comportati in una data situazione. Volevo raccontare contemporaneamente due cose: da una parte l'ampiezza della colpa che esiste in Germania, perché non sono stati solo pochi nazisti, è stato tutto un popolo a sbagliare, anche non resistere è stata una forma di collaborazione; dall'altra parte però non volevo giudicare. Ognuno di noi nella propria vita deve fare delle scelte giuste". da Simona Santoni – Panorama Farsi guidare dal filo della memoria Soggetto di Elisabeth Bartel; sceneggiatura del regista (italiano naturalizzato tedesco, attore esordiente nella regia) con Amelie Syberberg ed Elisabeth Bartel. Selezionato per l'Oscar 2016. Ambientato a Francoforte sul Meno a partire dal 1958, ricostruisce l'istruttoria del cosiddetto secondo processo di Auschwitz (20 dicembre 1963 – 20 agosto 1965), successivo ai processi di Norimberga (20 novembre 1945 – 1º ottobre 1946) e a quello di Adolf Eichmann a Gerusalemme (1963). A Francoforte furono incriminati ventidue criminali nazisti, sei dei quali furono condannati all’ergastolo; iniziò così la sensibilizzazione della magistratura e dell’opinione pubblica verso le colpe dei Nazisti e la responsabilità della Germania durante la guerra. Corrispondono alla realtà i personaggi del giornalista Thomas Gnielka e del procuratore Fritz Bauer, cui il film rende omaggio; il protagonista Johann Radmann racchiude in sé le figure di tre procuratori. Il racconto perde a tratti la sua incisività soffermandosi su scene superflue e di maniera; ma è convincente nel sostenere con forza l'urgenza di riconoscere la verità, per non essere complici dei criminali e non replicare l'ingiustizia verso le vittime. E' ben evidenziato infatti il coraggioso percorso di pochi "Giusti" nel labirinto del silenzio e delle menzogne, verso la presa di coscienza collettiva dei crimini nazisti: ancora in quegli anni i nomi come Auschwitz e la tragedia dello sterminio erano ignorati, o coperti dall'indifferenza, o addirittura negati, non solo dai singoli, ma addirittura dalle autorità politiche. L'indagine rivela insomma una specie di ombra demoniaca che ha ottenebrato la mente di molte persone insospettabili, anche fra i dichiarati oppositori del Nazismo. Sono significative sia la scena onirica in cui Johann vede il suo stimato padre nei panni di Josef Mengele,1 sia il comportamento dell'insospettabile insegnante, ex-nazista addetto allo smistamento degli internati ad Auschwitz, mentre maltratta un allievo che confonde destra e sinistra. In realtà il procuratore scopre che anche suo padre e quello della sua ragazza sono stati nazisti, o almeno complici del regime con la loro indifferenza.2 Questa triste verità riguarda non solo la Germania, ma anche il resto del mondo sedicente democratico: è eloquente l'atteggiamento altezzoso dell'ufficiale americano che si proclama del tutto estraneo ai trascorsi politici della Germania, preoccupato solo dei nuovi nemici comunisti. La verità storica, contraddittoria e scomoda, dev'essere riconosciuta da ciascuno: è probabile altrimenti che risorga quell'ideologia della superiorità, di un popolo o di un gruppo, che autorizza la prevaricazione sugli altri e sopprime la stessa comunità umana. In questo senso la questione emersa dai processi è purtroppo sempre attuale. Pierluigi Voi 1 Riguardo a Josef Rudolf Mengele (1911-1979), il cosiddetto Todes Engel (Angelo della Morte) di Auschwitz-Birkenau, è particolarmente interessante "The German Doctor – Wakolda" di Lucía Puenzo (2013). 2 Sul tema della "banalità del male" è istruttivo "Hannah Arendt" di Margarethe von Trotta (2012). 2
Scaricare