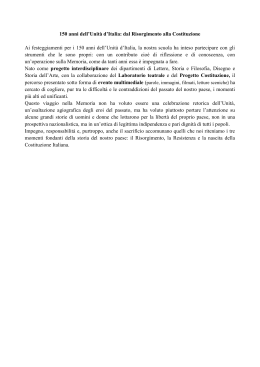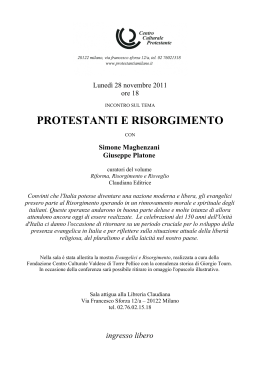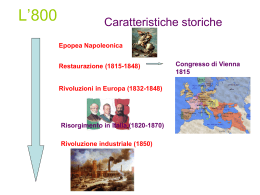SCUOLA 2010 DI LIBERALISMO DI ROMA CI SENTIVAMO UNA NAZIONE, DIVENIMMO UNO STATO COSA RIMANE OGGI DEL RISORGIMENTO LIBERALE Considerazioni e prospettive a 150 anni dall’Unità d’Italia SARO FRENI Introduzione “Principe, ma è proprio sul serio che lei si rifiuta di fare il possibile per alleviare, per tentare di rimediare allo stato di povertà materiale, di cieca miseria morale nelle quali giace questo che è il suo stesso popolo? Il clima si vince, il ricordo dei cattivi governi si cancella, i Siciliani vorranno migliorare; se gli uomini onesti si ritirano, la strada rimarrà libera alla gente senza scrupoli, ai Sedàra; e tutto sarà di nuovo come prima, per altri secoli. Ascolti la sua coscienza, principe, e non le orgogliose verità che ha detto. Collabori.”1 Chevalley pensava: “Questo stato di cose non durerà; la nostra amministrazione, nuova, agile, moderna cambierà tutto.” Il Principe era depresso: “Tutto questo” pensava “non dovrebbe poter durare; però durerà, sempre; il sempre umano, beninteso, un secolo, due secoli; e dopo sarà diverso, ma peggiore”2 No, il Principe di Salina non collaborò. E, forse, i Sedàra l'hanno avuta vinta. Facili a riconoscersi, sono le pagine del Gattopardo. Perché abbiamo iniziato con una citazione così sconsolante? Per cinismo, per fornire argomenti ai neoborbonici, ai revisionisti, ai sanfedisti, ai nostalgici di tutte le Vandee? Ovviamente, no. Non è questo il senso del libro di Tomasi di Lampedusa. Il Gattopardo è, prima che un libro politico, una riflessione sull'uomo e sulla sua miserabile condizione terrena. E' la perenne 1 G. Tomasi di Lampedusa – Il Gattopardo, Istituto geografico De Agostini, 1985 (edizione originale Feltrinelli, 1958), pag. 238 2 Ibid. pag. 242 1 allusione alla precarietà dell'esistenza, continuamente insidiata dalla preveggenza della morte. Ma certamente è una grande opera anche politica (non banalmente politicante, non il Libretto Rosso degli autonomisti) paradossalmente proprio quando mostra i limiti della politica, la sua ingenua pretesa di risolvere l'irrisolvibile, le sue generosità vane, le sue soperchierie e le sue bassezze. Certo, ogni capolavoro, anche il più antico, dialoga col presente. Pone quesiti sull'oggi. Interroga il lettore, lo fa riflettere. Anche sull'attualità: sull'arrivismo dei Sedàra, di tutti i Sedàra d'Italia, sulle speranze tradite, sulle virtù offese. Ma Il Gattopardo non è riducibile al gattopardismo. Non ho scelto di iniziare così, con l'emissario Chevalley e col Principe di Salina, per poter dire che tutto cambia perché nulla cambi, per ammiccare all'indignazione, alla polemica facile sui gaglioffi del trasformismo e del malaffare. Né tanto meno per sostenere che, a conti fatti, si stava meglio prima. La ragione è un'altra. Ed è che Il Gattopardo rivela l'altra faccia del Risorgimento. Non perché sia un romanzo “dalla parte dei vinti”, giacché vinti e vincitori si mescolano e si confondono, ma perché rappresenta l'ombra perenne di scetticismo e di disincanto – di cinismo o di secolare saggezza – che aleggia sul Risorgimento italiano e su tutti i “risorgimenti” dell'umanità, cioè su tutti i tentativi di redimere l'uomo attraverso uno slancio collettivo: inutili anche quando questo slancio è nobile e disinteressato, anche quando è sorretto da una grande tensione ideale. Quel parlare iperbolico e paradossale del Principe spiazza il povero emissario del Regno, garbato, naif, ottimista e razionale. E questo, per una ragione molto semplice. Chevalley vede nel Risorgimento la grande possibilità di riscatto delle miserabili 2 plebi meridionali. Il Principe di Salina scorge solo uno dei tanti tentativi di svegliare la Sicilia dal suo torpore secolare. E ne preconizza il fallimento. Ma il Risorgimento è davvero fallito o no? Le speranze di Chevalley erano, tutto sommato, ben riposte? Ha prodotto, il Risorgimento, un'etica civile condivisa? Ha dato vita ad un mito forte, fondante, creduto e rispettato? Che cosa è rimasto di quell'eredità oggi, a pochi mesi dal suo centocinquantesimo anniversario? Le pagine che seguono non pretendono di offrire risposte a quesiti così impegnativi. Contengono soltanto, molto più modestamente, qualche riflessione. 3 Festeggiare? In fin dei conti, non sarebbe meglio ignorare tutto quanto e lasciar perdere? Non è preferibile far finta di niente, dimenticarsene, come si fa con i compleanni indesiderati, quelli che è meglio non festeggiare perché ricordano l'età, gli acciacchi, la giovinezza perduta? E' un paradosso, si capisce. Una nazione, anche la più scalcagnata, ricorda con orgoglio la sua nascita. Deve farlo. Se vogliamo, le conviene: la classe politica al potere, in ogni luogo e in ogni tempo, sfrutta le ricorrenze per pronunciare discorsi ispirati, tagliare nastri, inaugurare monumenti; in definitiva, per darsi lustro, suggerendo una continuità tra il passato – glorioso – e il presente. Si dà fondo a tutta la retorica di cui si dispone, perché in fondo è una retorica facile, a costo zero. E' una festa. E il garbo impone che, durante le feste, non si facciano le pulci al festeggiato, neanche al più mascalzone. In condizioni normali, dicevo, avviene questo. Oggi, in Italia, no. La festa si è trasformata in un processo. E' come festeggiare l'anniversario di matrimonio nello studio dall'avvocato divorzista. E il tema del divorzio, della secessione di fatto, tra una parte e l'altra dell'Italia è il leitmotiv di questi giorni. Ora, beninteso, non bisogna fare della retorica patriottarda. Altre nazioni hanno vissuto, e vivono, conflitti ben più sanguinosi e coltivano nel loro seno forme di separatismo ben più pericolose di quelle di Umberto Bossi e Raffaele Lombardo. Quindi – senza sentimentalismi posticci, senza invocare la Patria ferita – tanto vale sfruttare questo 4 centocinquantenario per rifletterci su. Dovrebbero farlo tutti, politici e intellettuali, attraverso il sano esercizio critico della ragione e con l'ausilio della buona storiografia. Anche della storiografia revisionista? Certo, anche. Ogni solida storiografia è revisionista. Ogni nuova ricerca mette in discussione le tesi precedenti: le conferma, le integra, le supera o le confuta. Altrimenti non è storiografia: è dogma, verità rivelata, atto di fede. Ogni interpretazione del Risorgimento, come di tutti gli eventi, è ben accetta, purché supportata da argomenti razionali e verificabili. Ma non sembra accadere nemmeno questo. Per i politici, è una grana come le altre. Si bussa a quattrini, per soddisfare qualche clientela nel nome, si capisce, di Mazzini e Cavour. Gli intellettuali latitano. Anche perché il Risorgimento non è più nei loro orizzonti. Una volta ne parlavano, anche solo per contestarlo, come Gramsci. Ora non più. Nel tempo della globalizzazione, viene considerato un evento un po' provinciale, da vecchie zie, un piccolo altarino privato. Qualcuno, tra i dotti, ha segnato un'eccezione. Soprattutto sulle pagine del Corriere della Sera, rifugio di liberali che custodiscono le antiche memorie in modo intelligente e non stantio. Ne parleremo dopo. Per adesso, basta notare che mai come adesso il Risorgimento è messo in discussione, contestato, svillaneggiato. Si dirà: i nemici del Risorgimento ci sono sempre stati, si può dire che l'anti-Risorgimento nasca col Risorgimento. Questo è vero, ed è più che comprensibile: ogni fenomeno storico genera degli sconfitti e quindi dei contestatori, dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese. Ogni tesi genera un'antitesi. 5 Ma oggi, qui sta la novità, il Risorgimento è contestato da una buona parte della classe politica di governo. La sua eredità viene apertamente rifiutata o semplicemente ignorata nei fatti. Nel passato, il Risorgimento veniva onorato anche da quella parte di establishment che non ci credeva troppo. Persino i democristiani dovettero assumerlo nella loro cultura politica, volenti o nolenti. Tutti, nel passato, dovevano fare i conti col Risorgimento, con la sua eredità, anche con i suoi limiti. Era un riferimento obbligato. Per molti anni, la cultura italiana non poté prescindere dalla riflessione sul Risorgimento. Da Gobetti a Gramsci, da Gentile a Rosario Romeo, vi fu chi ne mise in luce le manchevolezze e le pose a base dell'arretratezza italiana, giacché l'Unità aveva lasciato le masse fuori dalla porta e non aveva offerto una soluzione alla questione sociale; e chi, al contrario, pur non negando alcune ombre, lo ritenne un mito a cui abbeverarsi, da vivificare e rinnovare. Per molto tempo, anche in ambito accademico, la storia contemporanea fu, soprattutto, storia del Risorgimento. E, a livello popolare, non si poteva “parlar male di Garibaldi”. Adesso, di Garibaldi, alcuni parlano male, ma i più non ne parlano affatto. Prevale – almeno, così pare – l'indifferenza. Forse non è un caso se i preparativi per la celebrazione sembrano ancora in alto mare. Tra il Comitato per i festeggiamenti e il governo stanno volando i piatti. Il primo lamenta il disinteresse dei politici e dell'opinione pubblica; il secondo assume un atteggiamento rassicurante e fiducioso. Potrebbe trattarsi di due fatti slegati: un conto è la contestazione del Risorgimento in sede politica e storiografica, un altro sono le difficoltà che si incontrano nell'organizzare un evento. 6 Può darsi che tra le due cose non vi sia alcun rapporto, e sarebbe bene che fosse così. Ma è anche possibile che un nesso ci sia. Questa è la tesi di Ernesto Galli della Loggia. E' lui ad aver dato il la al dibattito con un articolo sul Corriere della Sera, il 20 luglio 20093. Il punto drammatico sta nella premessa di tutto ciò. Nel fatto evidente che la classe politica, sia di destra sia di sinistra, messa di fronte a uno snodo decisivo della storia d'Italia e della sua identità, messa di fronte alla necessità di immaginare un modo per ricordarne il senso e il valore – e dunque dovendosi fare un'idea dell'uno e dell'altro, nonché di assumersi la responsabilità di proporre tale idea al mondo, e quindi ancora di riconoscersi in essa – non sa letteralmente che cosa dire, che partito prendere, che idea pensare. E non sa farlo per una ragione altrettanto evidente: perché in realtà essa per prima non sa che cosa significhi, che cosa possa significare, oggi l'Italia, e l'essere italiani. Qualche giorno dopo, Galli della Loggia persiste nella polemica. E mette in luce un una strana verità. Paradossalmente, l'Italia è un dato politico reale esclusivamente per la Lega: ma lo è solo perché oggetto della sua radicale avversione. E' significativo, peraltro, che perfino alle più ripugnanti proposte leghiste, come quella recentissima di imporre agli insegnanti un esame di cultura e lingua locali, i suoi avversari, lungi dal contrapporre l'idea d'Italia e di unità nazionale, si limitino a invocare, come ha invocato il presidente Fini, il “rispetto della Costituzione”. Quasi che dell'Italia non possa pensarsi altra difesa, ormai, che quella riservata a un bene “giuridicamente protetto”. Oggi, insomma, salvo che per la Lega, L'Italia non esiste più per le nostre culture politiche. Non era così nella prima Repubblica, la quale, pur se nata in 3 E. Galli della Loggia, Noi italiani senza memoria. I 150 anni dell'Unità e il vuoto d'idee in “Corriere della Sera”, 20 luglio 2009. A questo articolo ne sono seguiti altri sullo stesso argomento, anche questi pubblicati sul Corriere. L'Italia dimenticata. Le colpe delle classi dirigenti (31 luglio 2007); Una politica senza cultura. Catalogo di idee modeste e casuali (9 agosto 2009); La politica ha perduto il senso del Paese (14 agosto 2009); La Nazione abbandonata. Il dibattito sull'idea di Italia (23 agosto 2009). 7 un momento in cui la coscienza nazional-statale era stata messa a dura prova dalla catastrofe bellica, vide tuttavia la non infeconda dialettica tra culture politiche ognuna in stretto rapporto con la cultura nazionale e con una forte idea d'Italia. Si pensi da un lato alla cultura cattolica e a quella comunista, entrambe legate al dato centrale della nostra storia rappresentato dalla lontananza delle masse popolari rispetto alla costruzione dello stato unitario – e dall'altro alla cultura laico-socialista, viceversa appassionatamente identificata con tale costruzione.4 La lunga citazione è giustificata, credo, da un paio di ragioni. La prima è che le opinioni espresse dal professore sono fondate e ragionevoli. La seconda è che queste opinioni, severe e talvolta urticanti, hanno suscitato un discussione pubblica più significativa del solito. Insomma, non le solite chiacchiere da ombrellone5. La serie di articoli citati addebita alla classe dirigente attuale delle gravi pecche culturali. L'accusa più significativa riguarda, mi pare, la totale assenza di consapevolezza storica. E senza un'idea di fondo, una prospettiva, un progetto, la politica si riduce a occupazione del potere. Il potere, in sé, non va criminalizzato. La politica è anche, forse soprattutto, esercizio del potere; nel limite delle leggi. Ma se il potere di cui si dispone, non viene messo al servizio non dico di un ideale – che suona un po' retorico – ma di un almeno uno straccio di idea, allora la politica diventa poco più che clientelismo. La costruzione del consenso non è più uno strumento funzionale a un progetto, ma il progetto stesso: quello, poco nobile, di occupare le poltrone. Il partito non è più un 4 E. Galli della Loggia, L'Italia dimenticata, in “Corriere della Sera”, 31 luglio 2009 5 Qualche estate fa, in mancanza di meglio, i giornali si posero il fondamentale quesito se Vasco Rossi fosse di destra o di sinistra. Cfr. G. G. Vecchi, “Vasco e Ligabue non sono con voi”. Duello tra il Secolo d'Italia e l'Unità in “Corriere della Sera”, 20 luglio 2005. Le prove a carico di Ligabue, peraltro, erano piuttosto deboli. Si era limitato a concedere, bontà sua, che “ci sono degli intelligenti a destra”. Tanto è bastato per metterlo in mezzo. Questo, giusto per dire che Galli della Loggia ha, se non altro, elevato il livello medio delle discussioni balneari. 8 mezzo, ma un fine, e allora diventa una burocrazia di mestissimi funzionari interessata a perpetuare se stessa, di praticoni della democrazia, di professionisti della chiacchiera. Ernesto Galli della Loggia denuncia da tempo questo stato di cose. La sua tesi si articola, sostanzialmente, in tre punti. Il primo è quello che abbiamo detto poc'anzi: la perdita di senso dell'idea nazionale e le colpe di una classe dirigente inadeguata. Il secondo è la polemica contro la cultura azionista, i suoi eredi, i suoi ripetitori. Il terzo, collegato ai primi due e sviluppato di striscio in uno degli articoli che abbiamo riproposto, è la contestazione dell'approccio sacrale alla costituzione. I tre argomenti sono in stretta relazione tra di loro. La cultura azionista, per molti versi apprezzabile e feconda, ha avuto il limite, secondo Galli della Loggia, di accreditare l'idea che esistessero due Italie: un'Italia virtuosa e perbene e un'altra Italia, cialtrona e maggioritaria, da rieducare. Da qui la tentazione di una pedagogia politica che deve discendere dall'alto. E da qui anche l'idea perfezionistica, rigorista e torinese di cambiare gli italiani6: di farne una cosa diversa da quel gregge anarcoide, superstizioso e privo di senso civico, che sono sempre stati per antica tradizione. Gli azionisti non accettavano l'Italia per quella che era e disegnavano, a loro uso e consumo, una Patria ideale che non era mai esistita. Un'Italia anti-italiana. Ma siccome ogni storia è storia contemporanea, Galli della Loggia non ce l'ha solo con gli azionisti storici, per lo più passati a miglior vita, ma con loro eredi più o meno spuri. E qui veniamo alla costituzione repubblicana, di cui i tardoazionisti sono i più tenaci difensori. Galli della Loggia non nega che la costituzione, in quanto vigente, vada rispettata. Ma 6 Per una ragionata difesa dell'azionismo, cfr. A. Carioti - Maledetti Azionisti, Editori Riuniti, Roma, 2001 9 respinge l'idea che si debba istituire un culto laico attorno ad essa. Per questo, il Nostro ha polemizzato con il ministro Gelmini, quando parve ch'ella volesse inserire un'ora di “costituzione”, che sapeva troppo d'indottrinamento, nei programmi scolastici7. Il patriottismo costituzionale di Fini non basta, dice Galli della Loggia. Bisogna ripensare l'idea di Stato-nazione, un po' troppo frettolosamente buttata via. E riempirla di significato. Riempirla di che? In effetti, se la domanda è facile, la risposta è ardua. Centocinquant'anni sono tanti. Il mondo è cambiato. In che senso ci si può ancora rifare a Mazzini, Cavour, D'Azeglio? Parlare di ideologia risorgimentale, oggi, può sembrare un anacronismo; peggio ancora, un vezzo intellettualistico, buono al massimo per infiocchettare qualche discorso celebrativo, e nulla più. Ma forse non è così. Sergio Romano ha scritto un paio di libri, al riguardo, e un bel po' di articoli. In un volume – Libera Chiesa. Libero Stato? – il cui titolo è l'amaro aggiornamento del motto cavouriano8, l'ex 7 Cfr. E. Galli della Loggia, Ma non è un testo sacro e intoccabile, in “Corriere della Sera”, 25 gennaio 2010 8 Denis Mack Smith, nella sua biografia dedicata allo statista, descrive i rapporti tra Cavour e la Chiesa alla luce della lezione di Machiavelli. «Uno scrittore italiano ammirato da Cavour era Machiavelli, a suo giudizio il massimo filosofo del Cinquecento; e quel che trovava in lui particolarmente memorabile era l'invettiva contro il potere temporale dei papi. Personalmente, abbandonò la credenza dell'infallibilità papale dopo aver letto Guizot e Benjamin Constant. (…) Durante gli anni trascorsi nell'esercito, Cavour usava leggere e meditare la Bibbia; ma gli dispiaceva constatare l'insufficienza degli argomenti razionali in pro della fede, e concluse che per temperamento e forma mentis non avrebbe mai nutrito alcuna credenza profonda. «Cionondimeno, era abbastanza pragmatico e opportunista per accettare l'idea che il cattolicesimo fosse socialmente utile, in specie per quanti, mentalmente più deboli, non erano in grado di pensare con la loro testa, e potevano pertanto trovare appoggio e conforto nell'osservanza dei riti e nell'assoluzione. C'era fors'anche un'utilità nel fingere di credere, sì da offrire un buon esempio alle masse. A quest'atteggiamento si accompagnava un moderato anticlericalismo, che si cristallizzò nella sua mente quando gli accadde d'imbattersi in vistosi esempi di comportamenti immorali tra il clero delle campagne. Ostile per istinto e ragione ad ogni specie di persecuzione, ad opera della Chiesa o contro la Chiesa, l'esperienza lo indusse ad un eguale ostilità verso l'intervento clericale in politica. Attraverso Toqueville e la Westminster Review, come pure attraverso l'osservazione diretta in Svizzera, cominciò a conoscere altre società, dove una libera Chiesa poteva esistere in un libero Stato con vantaggio di entrambi”.» E più oltre, lo storico inglese, delinea il tratto di tolleranza umana che allontanava Cavour dal 10 ambasciatore lamenta l'abbandono della tradizione laica e coglie un'eccessiva condiscendenza verso la Chiesa Cattolica: troppi politici della Seconda Repubblica – è l'idea di Romano – corrono a baciare le pantofole ai preti, credendo di trarne un vantaggio elettorale. Questa deriva clericale fa a pugni, sostiene, con i costumi dell'Italia risorgimentale e post-risorgimentale. La Destra storica, spiega, era contraria alle pretese clericali per ragioni hegeliane, che volevano lo Stato al di sopra delle confessioni 9. La Sinistra, da quella liberale a quella radicale, da quella repubblicana a quella socialista, era schiettamente anticlericale per lunga consuetudine, spesso con punte di asprezza che oggi non oseremmo neppure immaginare. Ma l'Italia di oggi è irriconoscibile anche rispetto alla tanto vituperata Prima fanatismo religioso e dal clericalismo petulante e impiccione. «E' difficile negare ch'egli rimanesse fondamentalmente, seppur moderatamente, anticlericale. Lui stesso si diceva “antipapista”, e alla vigilia delle elezioni scrisse che non scorgeva nessuna possibilità di conciliazione tra Chiesa e Stato: in effetti, era rassegnato al perpetuarsi del “dissidio”. Secondo lui, questo stato di cose offriva anzi dei vantaggi, giacché “non è possibile il conservare la nostra influenza in Italia se veniamo a patti col pontefice”. «Malgrado l'ammonimento di Pio IX che soltanto il cattolicesimo offriva la possibilità della salvezza, Cavour credeva in una politica di tolleranza verso le altre fedi, e tuttora mal sopportava i dogmi di qualsiasi specie. Aveva constatato che un autentico senso religioso era più sviluppato in Inghilterra e in Scozia, paesi caratterizzati dalla libertà e da un indulgente tolleranza, mentre nella cattolica Italia, più che altrove il sentimento religioso languiva. Non gli piaceva il fatto che, laddove lo Statuto del 1848 sanciva la libertà di culto, l'antiquato codice penale invece la negava, e che i magistrati tradizionalisti preferissero conformarsi a quest'ultimo piuttosto che ai princìpi costituzionali.» D. Mack Smith – Cavour. Il grande tessitore dell'Unità d'Italia, edizione speciale per “Il Giornale”, (prima edizione Rcs Libri, 1985), pag. 18-19 e 145 9 Giampiero Carocci, in un volume che riesce ad essere un buon profilo della cultura politica italiana, dal Risorgimento ai giorni nostri, illustra la particolarità del conservatorismo postunitario. «Anche i moderati erano in qualche modo anticlericali, e ciò contribuiva a dare alla loro politica, quanto meno a una loro parte, un fondo radicale. Infatti nel 1882, più con soddisfazione che come lamentela, Silvio Spaventa ravvisava un carattere radicale nel partito moderato che, privo dell'appoggio della Chiesa, aveva, sì, creato il nuovo Stato, ma, non avendo a sua disposizione le forze materiali per conservarlo, cioè la religione, doveva ricorrere a una politica di tipo radicale che si intrecciava con quella di tipo giacobino cui accenneremo più avanti. Ma molti dei moderati più autorevoli, I Ricasoli, i Minghetti, gli Jacini, mentre rifiutavano il potere temporale della Chiesa tenevano, è stato detto, “in altissimo conto il ruolo svolto dai valori e dall'autorità spirituale nel cementare la comunità sociale”. Essi erano un ibrido, una eccezione peculiare dell'Italia nel panorama europeo: erano insieme anticlericali e conservatori. «C'erano due tipi di anticlericalismo: quello di matrice cattolica liberale e quello di matrice laica e razionalista. L'anticlericalismo dei moderati era del primo tipo, ma essi non si limitarono a praticare solo questo. Usarono l'ideologia positivista, laica, patriottica, per fare gli italiani e per educare il popolo delle città, sul quale la Chiesa aveva una presa minore che sui contadini, allo scopo di tenerlo sotto controllo, ma anche nel tentativo di allargare le basi di consenso dello Stato liberale». G. Carocci – Destra e sinistra nella storia d'Italia, Laterza, Bari, 2002, pag. 5 11 Repubblica e persino rispetto al Fascismo, che sottoscrisse sì gli accordi del Laterano, ma con l'intenzione di piegare la Chiesa ad un progetto nazionale. Sergio Romano conclude con parole amare e rassegnate il suo saggio, così pertinenti che non possiamo non citarle per intero. Non posso offrire al lettore né conclusioni né prospettive. Mi limito a constatare che è nata in questi ultimi anni un'Italia molto diversa da quella delle generazioni postunitarie. Non la riconoscerebbero come propria i cattolici liberali, autori di una buona legge (quella delle Guarentigie), forse la migliore fra quelle approvate dalle democrazie europee sui rapporti fra lo Stato e la Chiesa. Non la riconoscerebbe Benito Mussolini, deciso a usare la Chiesa e il cattolicesimo italiano per un progetto nazionale e imperiale. Non la riconoscerebbero Sturzo e De Gasperi, sempre attenti a difendere l'indipendenza civile dei cattolici e le prerogative dello Stato. Non la riconoscerebbe Bettino Craxi, promotore di un Concordato che ebbe il merito di limitare il potere della Chiesa nella società italiana. E non la riconosce come sua, per quel che vale, neppure l'autore di questo libro 10. Cerchiamo di capire un po' più a fondo, seppur nei limiti di una breve tesina, in cosa consistesse – e debba consistere oggi – l'ideologia risorgimentale11. In fondo, a mio parere, la si può riassumere nella seguente triade: nazione, libertà e laicità. Questi tre concetti non sono, ovviamente, degli assoluti. Tutti e tre sono idee storicamente relative. A cominciare dallo Stato-Nazione, che è un'idea, se vogliamo, piuttosto recente. Anche il concetto di libertà pone dei problemi: dobbiamo intendere la libertà degli antichi o quella dei moderni? La laicità nasce con la separazione tra il potere politico e il potere 10 S. Romano, Libera Chiesa. Libero Stato? Il Vaticano e l'Italia da Pio IX a Benedetto XVI, Longanesi e C., 2005, Milano, pp. 145-146. 11 Sull'ideologia risorgimentale vedi ancora Carocci, op. cit., in particolare il terzo capitolo, La “nazionalizzazione delle masse” e lo Stato, pag. 26-35 12 religioso, tra reato e peccato: distinzione a cui, peraltro, tanto per dire della sua relatività, non tutte le civiltà sono giunte, né è detto che vi giungeranno. Ma il fatto che queste tre parole siano inevitabilmente legate ad un contesto storico determinato, non le rende meno attuali. Anche oggi, credo che l'ideologia risorgimentale, nazionale, laica e liberale, abbia un senso. Certamente, va ridefinita. Alle tradizioni politiche bisogna dare continuamente nuova linfa, altrimenti diventano aride e inutilizzabili. E per farlo è necessario anche uno sforzo teorico, atto a comprendere che cosa possano significare, oggi, la nazione, la libertà e la laicità. Quindi, a queste tre parole, ne aggiungerei una quarta: la cultura. La nazione, o meglio l'identificazione di questa con lo Stato, è stata oggetto di molti attacchi. Lo Stato-nazione in generale, è stato giudicato inservibile come spazio giuridico di garanzia rispetto ai poteri extrastatuali, come quelli finanziari. Non solo. Si è cercato di togliergli legittimità culturale, con la valorizzazione delle piccole patrie, dei localismi, delle culture regionali. Non è il caso di affrontare in questa sede un discorso di così vasta portata. Ma si può proporre questa tesi: che tra il troppo grande (i poteri, formali o informali, extrastatuali e sovrastatuali) e il troppo piccolo (il localismo), lo Stato-nazione sia ancora una dimensione significativa della politica, e possa continuare ad esserlo. Poi c'è la Nazione come lingua e cultura, come tradizione e comunità. Questa parte della teoria è la più criticata, forse anche con buone ragioni. Si sostiene che le venerabili tradizioni nazionali siano state spesso il frutto di invenzioni e contraffazioni. I “costumi secolari” erano in realtà di recentissimo conio e vennero spacciati per merce antica allo scopo di conferire 13 ai giovani stati nobiltà e prestigio. Insomma, le tradizioni nazionali sono niente di più di una costruzione umana. Tuttavia, anche accettando quest'idea, e cioè che le nazioni siano nate su di una finzione, ciò non toglie che siano una realtà concreta da secoli, e non se ne possa non tener conto. La bugia, se era tale, è stata creduta ormai per troppo tempo. Per di più, l'Italia nacque prima con i poeti che coi ministri. Esisteva, da un punto di vista culturale, già prima del 1861. Certo, con tante divisioni e differenze. Ma pochi possono ritenere, col principe von Metternich, che fosse solo un'espressione geografica. Quando si parla di nazione, poco dopo si arriva al nazionalismo. E, in effetti, il Risorgimento fu nazionalista. Ma non nel senso che il termine assunse con Corradini, Federzoni e Coppola. Il nazionalismo risorgimentale non fu un nazionalismo imperialista12 . Fu un nazionalismo liberale e/o democratico, rispettoso del principio di autodeterminazione13. La mia idea è che l'idea di nazione debba avere, innanzitutto, due 12 Sergio Romano, nel saggio summenzionato, delinea bene le differenze tra il nazionalismo ottocentesco, liberale, e quello novecentesco, imperialista. «Si cominciano a intravedere così, in occasione della guerra di Libia, le grandi linee di un nazionalismo populista, molto diverso da quello che aveva “fatto l'Italia”. Il vecchio era liberale, borghese, elitario, nutrito di cultura storica e umanistica. Il nuovo aveva una più larga base democratica e una cultura più rozza, enfatica, aggressiva. Il vecchio era cresciuto contro la Chiesa e aveva assunto in alcune circostanze, per le necessità della battaglia, caratteri anticlericali. Il nuovo avrebbe ricercato e ottenuto in molti casi la simpatia e il sostegno della Chiesa. La famiglia nazional-populista italiana è molto grande ed è composta da molti rami. Prevale, in alcuni di essi, la motivazione nazionale, in altri la motivazione popolare; e a seconda della motivazione l'Italia può essere “imperiale” o, con una espressione coniata da Pascoli, “grande proletaria”. Ma vi è quasi sempre, in ogni ramo, una forte componente cattolica. I nazionalisti sono convinti che il cattolicesimo sia l'identità profonda della nazione italiana, e quindi una componente indispensabile del loro programma. Una parte della Chiesa è convinta che le sue radici siano qui, in Italia, e che il controllo delle anime degli italiani sia il suo vero, irrinunciabile “potere temporale”.» S. Romano, Libera Chiesa. Libero Stato? Op. Cit. p. 46 13 Denis Mack Smith, forse per evitare confusioni tra il vecchio e il nuovo nazionalismo, preferisce parlare di Mazzini come un patriota ma respinge la definizione di nazionalista. «Giuseppe Mazzini non era un nazionalista; era un patriota. Diversamente da quanto è stato affermato talvolta, già nel 1836 egli usava il termine “nazionalista in senso peggiorativo; con esso definiva gli sciovinisti, gli xenofobi e gli imperialisti che intendevano usurpare i diritti degli altri popoli, mentre il patriottismo non era una forma dilatata di egoismo né era fine a se stesso, ma era sempre subordinato al rispetto dei diritti, preminenti, dell'umanità.» D. Mack Smith – Mazzini, Rcs Libri, Milano, 2002, pag. 24 14 significati. In un primo senso significa valorizzazione della propria cultura. Non in modo grettamente provinciale. Non facendo le barricate contro i forestierismi, i libri stranieri e gli hamburger. Ma recuperando la consapevolezza di un primato, se non morale e civile, almeno culturale e artistico. Questo impone di non considerare la cultura un orpello, buono solo per far quattrini a spese dei turisti. Vabbé, ma che c'entra col Risorgimento? C'entra. L'Unità Italiana è stata preceduta dalla lingua italiana. I profeti dell'Unità sono stati poeti e romanzieri. La cultura italiana elaborò un mito a cui si abbeverarono i patrioti del Risorgimento e le élites politiche del post-risorgimento. La cultura conta, deve contare. Le classi dirigenti si costruiscono sulla selezione e sull'educazione, politica e intellettuale. Il Risorgimento non aveva le masse, si disse; ma a noi, oggi, mancano le élites. Nazione significa cultura, ma significa anche indipendenza: ed è questo il secondo aspetto che vorrei approfondire. Parlo della sovranità dello stato, da difendere dalle ingerenze vaticane e dalle prepotenze straniere. Durante la Guerra Fredda, l'Italia si era trovata sotto l'ombrello americano, e fu una fortuna. Talvolta, si era presa qualche libertà, concedendosi fugaci giri di valzer, tra furbizie levantine e veementi sussulti d'orgoglio. Ma adesso il ricatto della gratitudine non ha più senso. L'Italia ha le mani libere e deve difendere i suoi interessi, senza egoismi ma anche senza servilismi. L'altro puntello dell'ideologia risorgimentale è la libertà. E la libertà è, prima di tutto, libertà della polis. Libertà dell'Italia da 15 rapporti di dipendenza rispetto alle altre nazioni. L'indipendenza è un'idea risorgimentale a tutto tondo. Anzi, forse, il primo insegnamento del Risorgimento. Ma lo Stato, libero tra gli Stati, non deve diventare oppressore dei suoi cittadini. Questa è l'altra faccia della libertà. La libertà dallo Stato. E' la cosiddetta libertà liberale. La libertà borghese, cosiddetta. Una libertà dagli impedimenti, la garanzia dei diritti fondamentali, quelli di prima generazione. L'Italia del centocinquantenario, e quella degli anni a seguire, dovrà conoscere la differenza tra senso dello Stato e statalismo, accogliere il primo e respingere il secondo. In ultimo, la laicità. Il Risorgimento fu laico e, molto spesso, anticlericale. Le nostre radici nazionali affondano in un conflitto sanguinoso con la Chiesa cattolica. E l'Italia post-risorgimentale fu preda di un furore irreligioso astioso e virulento. Le acque si placarono solo con Giolitti, al principio del secolo. Questi era un maestro di pragmatismo e comprese che i cattolici erano in gran parte dei leali italiani e potevano essere recuperati allo Stato liberale con una politica di apertura e di compromesso. Il vero pericolo veniva da sinistra, dai rossi. Giovanni Spadolini ne parla in un libro antico e piuttosto noto: Giolitti e i cattolici14. Tutto sommato, a giudizio del politico piemontese, si poteva far causa 14 Scrive Spadolini: «A Montecitorio, in quell'alba di secolo, pochi e stanchi riflessi della politica ecclesiastica; nessun dibattito capace di ricordare le gloriose discussioni fra il '60 e il '70; non più quel ritrovarsi tutti, uomini della consorteria cavouriana o del partito d'azione, seguaci di Ricasoli o di Bertani, sulla stessa sponda, solidali nell'avvertire la dialettica fra lo Stato e la Chiesa, nell'identificare la funzione nazionale italiana con l'idea laica, nel contrapporre la Monarchia al Vaticano. Al contrario. […] La morte di Crispi, l'11 agosto 1901, sembrava quasi chiudere un ciclo storico, segnare la fine di un mondo attraverso uno dei suoi massimi rappresentanti, attraverso l'uomo che aveva dominato, bene o male, l'età della “grande peur”, della grande paura di cattolici e socialisti, di neri e rossi marcianti all'assalto del Quirinale, minaccianti le basi dello Stato. […] Scendeva nella tomba l'ultimo eroe del Risorgimento, lo statista caro alla generazione carducciana […] Il Vaticano vedeva scomparire un avversario tenace e risoluto; ma anche il liberalismo giolittiano vedeva tramontare con lui le ultime speranze di una politica di reazione, sia pure giustificata in nome dei supremi ideali del Risorgimento. I cattolici cominciavano a sentirsi cittadini; i cittadini potevano riavvicinarsi al cattolicesimo. […] Lo Stato di Giolitti non avrebbe alzato un dito in difesa del pensiero di Giordano Bruno.» G. Spadolini – Giolitti e i cattolici, Oscar Studio Mondadori, 1974, pag. 1519 16 comune con i cattolici moderati, nel nome dell'ordine sociale. La maggioranza dei cattolici era composta da innocui borghesi, che non nutrivano più nessun rancore nei confronti dello Stato unitario. Le generazioni più giovani non avevano vissuto personalmente quel momento di cesura che fu la lotta tra Stato e Chiesa, si erano ormai integrati nello Stato liberale, e non credevano più nel ritorno del Papa Re. Allo stesso tempo, i nostalgici del potere temporale non avevano più molto seguito: ormai, erano pochi, anziani e irrilevanti. Tra il 1870 e il 1900, invece, non si faceva troppa differenza: rossi e neri erano trattati allo stesso modo. Fu quello il periodo di più acceso anticlericalismo che l'Italia abbia mai vissuto. La sponda di Giolitti erano i cattolici moderati: i Meda, i Tittoni. Un altra corrente era quella dei murriani, i seguaci di Romolo Murri. Murri non era un nostalgico. Il suo movimento – la Democrazia Cristiana (nome che avrà più fortuna qualche decennio dopo) – non aveva nulla da spartire con i vecchi reazionari. Era un movimento politicamente progressista e teologicamente modernista. Ma nacque troppo in anticipo sui tempi e non ebbe l'appoggio della Chiesa, che lo avversò con severità. Maggior successo ebbe Luigi Sturzo, con il suo Partito Popolare, nel 1919. Piccola parentesi. A quel tempo, il cattolicesimo politico italiano non era statalista, proprio perché lo Stato, a quel tempo, era lo Stato liberale. Lo diventerà solo in seguito, nel secondo dopoguerra, quando la Dc diventerà partito-Stato, dopo la morte di De Gasperi e l'ascesa dei “cavalli di razza”, Moro e Fanfani. Ad ogni modo, dicevamo, i rapporti tra Stato e Chiesa si fecero più civili e culminarono nel Patto Gentiloni, in vista delle 17 elezioni del 1913. Ma ognuno doveva stare al suo posto: “Lo Stato e la Chiesa sono due rette parallele che non si incontrano mai”, diceva Giolitti. Si incontrarono, invece, nel 1929, con i Patti Lateranensi. Questo evento venne considerato una grande vittoria per Mussolini, che riconciliò in grande stile l'Italia con la Chiesa cattolica dopo sessant'anni di inimicizia. Ma fu un successo anche per la Chiesa che, al di là dei vantaggi economici che trasse dall'accordo, intravedeva la possibilità di una ritrovata egemonia sulla nostra nazione. Certamente, bisognava aspettare. La Chiesa tentò di influenzare culturalmente il Fascismo, per farne il suo braccio secolare. Ma non ci riuscì. Il Regime, che propugnava una sua religione politica, non accettava concorrenti ideologici sul suo stesso terreno. E l'alleanza con il Nazionalsocialismo paganeggiante segnò la fine del sogno cattolico di imprimere al Fascismo la sua impronta. Ma la Chiesa – che misura la sua opera sul metro dei secoli – seppe attendere il suo turno. Era stata riammessa nel gioco politico italiano. E, dopo la guerra, ebbe campo libero. Libero fino a un certo punto, perché la classe politica repubblicana si mostrò molto ferma rispetto all'invadenza clericale. Da De Gasperi in giù. Ne riparleremo. Quello che ci interessa dire, in questo momento, è che la laicità dello Stato è un principio di libertà e di dignità nazionale. In questi ultimi tempi, per la verità, si è molto discusso intorno al ritorno del sacro e alla nuova dimensione pubblica della religione. Si è citata l'America, che garantisce la neutralità dello Stato rispetto alle confessioni, ma che è impregnata di grande fervore religioso. Va molto di moda la distinzione tra laicità e laicismo. La laicità 18 sarebbe sana e proficua garanzia di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, al di là del loro credo religioso; l'equidistanza dello Stato rispetto a tutte le credenze. E quindi andrebbe bene. Il laicismo sarebbe il volto oscuro e maligno della laicità: un'ideologia livorosa, dogmatica e integralista, che nasconde una concezione intollerante verso la religione e la spiritualità. Tra le altre cose, la laicità consentirebbe a tutti, religiosi e non, di esprimere ciò che pensano. Il laicismo tapperebbe la bocca agli uomini di fede e non consentirebbe loro nemmeno di parlare. La questione è spinosa. Certamente la laicità può essere considerata una condizione oggettiva (la laicità dello Stato), mentre il laicismo è un'idea, una propensione personale, un modo di pensare soggettivo. Del resto, però, anche sulla laicità va fatta qualche distinzione. Per esempio, la laicità dello Stato non è la neutralità. Se lo Stato è laico, vuol dire che ha già scelto una parte. Si risponde che lo Stato decide per tutti, e i credenti possono scegliere di rinunciare a certi diritti che lo Stato concede loro, come quello di divorziare, in nome della loro fede. Certamente, il cittadino credente può decidere di autolimitarsi. Ma il deputato cattolico che deve fare? Deve poter votare seguendo il suo orizzonte di valori o deve votare per forza come voterebbe Eugenio Scalfari? Del resto, anche il deputato agnostico o ateo, socialista o radicale, vota secondo i suoi convincimenti laici. Perché il cattolico non dovrebbe? Detto ciò, ci si può tuttavia chiedere: in una prospettiva liberale, si possono mettere ai voti le libertà fondamentali? In altre parole, si può stabilire, per assurdo, l'istituzione di uno Stato teocratico a maggioranza? Qui si evidenzia il dissidio tra liberalismo e democrazia. Perché, se mettiamo tutto ai voti, allora può vincere anche una maggioranza di fanatici religiosi. Il liberalismo mette 19 un limite, che – nella versione giusnaturalista – sono i diritti naturali. Ma sui diritti naturali si è tutti d'accordo in linea di principio, salvo trovarsi su sponde opposte quando si entra nel concreto. Anche la Chiesa si erge a custode dei diritti naturali, ma – ad esempio – tra i diritti naturali inserisce il diritto del concepito. Un principio potrebbe essere quello che ciascuno è proprietario di se stesso. Quindi, ad esempio, una legislazione laica dovrebbe consentirgli di morire come crede. Ma l'aborto? L'aborto lede il diritto del feto. Il feto possiede diritti? E' un bel problema. Il progresso scientifico, oltretutto, ha posto nuove questioni. Insomma, non voglio infilarmi in un questo ginepraio. Tuttavia, ho fatto questi esempi per dimostrare che la questione della laicità è molto complicata e che non è più riproponibile alla luce dei vecchi schemi. Liberalismo, laicità, laicismo, neutralità, anticlericalismo non hanno lo stesso significato e non è raro che questi concetti facciano a pugni.. L'America ha una storia diversa rispetto all'Europa. L'Europa ha vissuto le guerre di religione. Il sistema europeo è un sistema concordatario, e questo dà vantaggi alla Chiesa, ma allo stesso tempo dovrebbe imporle dei vincoli; soprattutto in Italia, per ragioni geografiche. La laicità risorgimentale da riproporre oggi, per come la intendo io, non è – quindi – una scelta di valori. Ma un modo di essere della classe politica. Che non dovrebbe usare i tanto citati “valori cristiani” per ragioni di bassa cucina elettorale. Non dovrebbe parlare ogni due per tre di “radici”, che ormai sono citate più dai politici che dai giardinieri. Non dovrebbe cercare la legittimazione dei vescovi, salvo poi scaricarli quando affermano 20 cose sgradite. Non dovrebbe mostrarsi più papista del Papa, del resto in modo così falso, stonato e insincero. I Padri della Patria ne sarebbero inorriditi. 21 Che cosa è rimasto del Risorgimento? A voler essere malevoli, si potrebbe pure rispondere: niente. Del Risorgimento non è rimasto nulla. Ma sarebbe solo un giudizio polemico, sprezzante, liquidatorio. Però, quando ci si pone certe domande – “Che cosa è rimasto del Risorgimento?” – significa che, in fondo, ci si aspetta certe risposte. Ma, prima di tutto, diciamo cosa fu il Risorgimento. Esso fu anzitutto un evento storico epocale, fatto di battaglie e di intuizioni politiche, di carne e sangue, di strateghi e visionari, di geni della diplomazia e geni dell'azione. Di ragione cavouriana e sentimento garibaldino (e di mistica mazziniana, ovviamente). E, per dirla con Machiavelli, di virtù e fortuna. Ma fu anche pretesto per fraintendimenti e ipocrisie postume, e – come tutte le vicende storiche – fu presto gravato dalla retorica: tromboni, oleografie, distorsioni opportunistiche e accaparramenti interessati. Il Risorgimento fu questo, insomma: un'umanissima vicenda, contraddittoria come tutte le pagine della nostra storia, e della storia tutta. Piena di ombre, spesso sottaciute per carità di Patria e altrettanto spesso ingigantite da un revisionismo non genuino. Ma anche di gesta memorabili, di uomini probi, non privi di difetti ma nemmeno di grandezze. La storia è, in fondo, storia di uomini. In questo caso di un primo ministro smaliziato e realista, ma abbastanza abile da tramutare persino le disgrazie in opportunità e da fare della follia di un manipolo di patrioti una risorsa politica, a maggior gloria di Casa Savoia, una dinastia che, più per ambizioni espansionistiche che 22 per amore delle libertà politiche, si trovò a guidare una rivoluzione che fu, insieme, liberale e nazionale. E' la storia di un generale col poncho, digiuno di politica, ma armato di coraggio e virtù guerriere: Giuseppe Garibaldi. Ed è la vicenda umana e intellettuale di un profeta della rivoluzione e della repubblica, tormentato apostolo della democrazia politica e della religione patriottica, dei doveri e del sacrificio, come Giuseppe Mazzini. Ma la storia è anche storia di idee. Finora ne abbiamo incontrate un bel po'. Il costituzionalismo e il liberalismo, innanzitutto. Senza di essi, la guerra dei Savoia sarebbe stata una semplice guerra di espansione e di conquista, un capitolo come un altro della politica di potenza di uno stato nemmeno troppo rilevante dello scacchiere europeo. Poi c'è la democrazia, la democrazia mazziniana, tutta permeata di motivi nazionali e insieme popolari, in nome del principio di autodeterminazione. C'è poi l'ingenuo e confuso socialismo di Garibaldi, un socialismo non classista né internazionalista; che poi è la perenne, e in fondo non ideologica, aspirazione alla redenzione dei miserabili e degli oppressi. Senza contare alcuni filoni del pensiero risorgimentale rimasti marginali, ma non per questo privi di spessore, come il cattolicesimo liberale – che cercava di conciliare l'amore per la libertà con la fedeltà ad una Chiesa che si ritenne spogliata dei suoi beni – e il federalismo di Carlo Cattaneo, il cui repubblicanesimo è rimasto per anni all'ombra di quello mazziniano. Storia e pensiero, dunque. Ma non solo. Il Risorgimento è stato anche un'altra cosa, forse più importante: un fatto morale. Nel senso che diede vita ad un mito politico, per dirla con Sorel; a una formula politica, per dirla con Gaetano Mosca. In altri termini, fornì ad un'intera classe dirigente una risorsa di 23 mobilitazione politica per giustificare il suo potere, per dare un senso al suo ruolo. Non è un caso, e lo vedremo in seguito, che quando, durante l'età giolittiana, il mito cominciava a scollarsi troppo dalla realtà e l'entusiasmo era sempre più spento, la crisi del mito di legittimazione portò con sé una condanna, forse ingenerosa, verso il ceto politico liberale che fino ad allora, bene o male, aveva governato l'Italia. E lo screditamento della classe dirigente liberale rese più facile la sostituzione di quella élite con un'altra élite: quella dell'orbace e degli stivaloni. Era una reazione, in parte, naturale. Del resto, avviene quasi sempre così. Il mito va rinnovato, vivificato, reso attuale. Altrimenti deperisce, diventa un guscio vuoto. E così fu per il Risorgimento. La poesia aveva lasciato spazio alla prosa. Le bandiere erano state ammainate. Le grandi idealità riposte nel cassetto. I periodi di pace, e anche di benessere, sono sempre poco eroici. Dopo ogni rivoluzione c'è l'ordinaria amministrazione. Talvolta una buona amministrazione – rigorosa, coscienziosa, attenta – ma inevitabilmente grigia e burocratica. Il simbolo di questa Italia modesta e piccina fu considerato Giolitti, di cui si è già detto qualcosa nelle pagine precedenti. Giolitti aveva tutto per non piacere ad un popolo ammalato di retorica come quello italiano. Intanto non aveva fatto le guerre d'indipendenza: era figlio di madre vedova, ed era rimasto a casa. Ma soprattutto era un uomo pratico, spiccio, non amava parlare troppo per dire nulla. E questo non glielo si poteva proprio perdonare. Aveva fatto carriera nell'amministrazione, era meno colto di Sonnino e meno spericolato di Crispi. Il suo pragmatismo veniva considerato più un vizio che una virtù. Il suo maggior avversario, Gaetano 24 Salvemini, lo chiamò “ministro della malavita”, perché amava il potere, e talvolta ne abusava. Giolitti gli rispose che un sarto, quando confeziona un vestito, deve adattarlo al committente: e se l'Italia aveva la gobba, cioè era fatta maluccio quanto a virtù civili, egli doveva tenerne conto. Salvemini gli rispose che questo era senz'altro vero, ma che il sarto Giolitti aveva lasciato più gobbi di quanti ne avesse trovati. In effetti, lo statista di Dronero, non andava troppo per il sottile. Utilizzava i prefetti per far vincere i canditati governativi, cioè i suoi fedelissimi. Sapeva minacciare e lusingare. Conosceva le debolezze degli uomini e le sfruttava. Era senz'altro un liberale. Un borghese illuminato per Ansaldo, suo biografo simpatizzante15; un progressista per i conservatori. Un Giano bifronte, per la satira: di destra o di sinistra a seconda delle convenienze e delle situazioni. In realtà era un realista: non amava le dottrine, i dogmatismi, le ideologie. La sua ideologia era il potere, da esercitare con senso dello Stato e con sobrietà. Lo Stato era il suo partito. Fu un dittatore parlamentare, si disse; prima di vedere, solo qualche anno dopo, che i veri dittatori, del parlamento sanno fare a meno. Non amava le parole roboanti, gli immancabili destini, le ore della Storia. Quando doveva scaldare un pubblico, lo faceva a malincuore: più per dovere d'ufficio che per convinzione. Come quando, nel 1911, dovette pronunciare un discorso per celebrare il cinquantenario dell'Unità, dinanzi all'Altare della Patria. Si lasciò andare anche lui, gli toccò di essere un po' retorico. Poi, com'è noto, si festeggiò a suon di cannonate, in Libia. Credeva agli ideali del Risorgimento, ma diffidava della loro ostentazione. Il suo liberalismo era empirico, privo di apriorismi, più tattico che strategico. 15 G. Ansaldo – Il Ministro della buona vita, Casa Editrice Le Lettere - Firenze, 2002 25 I critici scambiarono la sua serietà per cinismo. Vilfredo Pareto parlò del suo tempo come di quello delle volpi, a cui avrebbe fatto seguito quello dei leoni. La furbizia avrebbe fatto spazio al coraggio.16 Certo, non tutto l'armamentario del giolittismo fu benefico. Le idealità risorgimentali si immiserirono, la disillusione prese piede. Giolitti non si era mai fatto mai troppe illusioni sugli uomini, e per questo non lo delusero mai. Ma chi aveva creduto, ed erano in tanti, in un'epoca di eroismo, sorretta da una profonda tensione ideale, vide nel giolittismo il contraltare del Risorgimento. Tanto il Risorgimento era avventuroso, quanto il giolittismo era notarile. Così fu che alla decadenza si rispose con uno slancio di volontarismo. E venne il Fascismo. Anche il Fascismo si considerava legittimo erede della tradizione risorgimentale, anzi il suo più credibile interprete. Questa tesi era cara al più noto e autorevole ideologo del Fascismo: Giovanni Gentile. Le idee di Gentile non erano condivise da tutti, all'interno del Fascismo. Anzi 17. Tuttavia, la sua interpretazione è un esempio di come il Risorgimento fu usato come strumento di legittimazione da tutti i regimi politici. Anche da quelli, come il regime di Mussolini, che volevano rappresentare qualcosa di radicalmente nuovo rispetto al passato. Gentile era già un uomo molto noto, quando divenne ministro dell'istruzione. Negli anni precedenti si era speso molto, insieme a Benedetto Croce, nel contrastare l'egemonia del positivismo, e alla fine i due campioni dell'idealismo italiano la ebbero vinta, dando il tono al dibattito culturale del loro tempo. Gentile propugnava una filosofia anti-materialista, per lui il 16 Su Giolitti e i suoi critici, vedi E. Gentile – Le origini dell'Italia contemporanea. L'età giolittiana, Laterza, 2003 17 Sul gentilianesimo e antigentilianesimo, vedi. A.Tarquini – Il Gentile dei fascisti, Il Mulino, 2009 26 positivismo si identificava con tutte le sue bestie nere: l'individualismo, lo scetticismo, la massoneria filantropica, cosmopolita e umanitaria. La corruzione degli ideali risorgimentali era avvenuta dopo l'avvento al potere della Sinistra storica, incarnata in una borghesia traffichina e maneggiona, senza grandezze e senza valori. La storia d'Italia, a suo giudizio, si divideva in epoche di serietà e fede, come il periodo risorgimentale, ed epoche decadenti, magari creative ma di una creatività frivola, da intellettualità salottiera, priva di impegno civile, pronta a ridere di tutto. Ammirava Mazzini, democratico sì, ma con una concezione religiosa della vita e della Patria: Dio e Popolo, sacrificio e dovere. Il suo proposito era di staccare il Risorgimento dalle sue radici rivoluzionarie e individualiste. Gentile era un liberale, si considerava tale e considerava tale il Fascismo. Ma il suo era il liberalismo tipico degli hegeliani di destra: Stato forte, autorevole, superiore alla società e all'individuo. Il suo modello era la Destra storica e pensava che il Fascismo avrebbe apportato quei correttivi autoritari che avrebbero reso alla Nazione la gloria perduta. Non voleva rivoluzioni totalitarie, forse non le immaginava neppure. Si accontentava di un ritorno alla monarchia costituzionale pura, già auspicato in passato da Crispi e Sonnino18. Anche Crispi e Sonnino, pur così diversi tra di loro, si inseriscono nella tradizione risorgimentale. Crispi il Risorgimento l'aveva fatto, da garibaldino. Dopodiché si era convertito ad un autoritarismo d'ispirazione bismarckiana e aveva iniziato a coltivare sogni di grandezza coloniale, miseramente falliti con la disfatta di Adua. Degli ideali di 18 Sulla polemica contro il parlamentarismo e sui tentativi di riforma istituzionale vedi F. Lanchester, La rappresentanza in campo politico, Giuffrè, 2006, pp. 93-115 27 gioventù conservava ancora l'acceso anticlericalismo di stampo massonico, molto in voga nell'Italia umbertina. Sonnino, invece, era un conservatore illuminato. Eterno avversario di Giolitti, gli facevano difetto il pragmatismo e la furbizia dell'uomo di potere. Potere che, in effetti, esercitò poche volte, non tutte con esiti memorabili. Fu il ministro degli esteri del Patto di Londra e delle trattative di pace, in cui la delegazione italiana commise vari errori di giudizio, e fu messa nel sacco. Quando scrisse “Torniamo allo Statuto”, nel 1987 sulla Nuova antologia, aveva in mente i mali dell'assemblearismo, che voleva risolvere ripristinando l'antica monarchia costituzionale, cui era subentrata, di fatto, la monarchia parlamentare. Sidney Sonnino fu senz'altro ispirato da passione risorgimentale. Fu tale nello stile e nella sobrietà del tratto. Ma lo fu soprattutto nella sua avversione per i rossi e i neri, i marxisti e i clericali, che assediavano il fortino dello Stato liberale. Crispi, Sonnino e Gentile furono critici accesi della deriva parlamentare. Certo, ognuno a suo modo e con le sue idee. Gli ultimi due furono animati dall'ambizione di restaurare una mitica età dell'oro, che coincideva con il governo della Destra. Crispi amava, del Risorgimento, il lato populista. Era, se così possiamo dire, un nazionalista di sinistra. Ad ogni modo, il mito risorgimentale attraversò il ventennio. Non lo attraversò indenne: il Risorgimento fu usato, stropicciato, messo al servizio della propaganda. E ai suoi eroi – Garibaldi, Mazzini – fu fatta indossare la camicia nera, che lo volessero o no. Furono tutti considerati precursori del Fascismo. Le distinzioni sfumavano, si prendeva ciò che era utile a inserire l'Italia di Mussolini nel solco del Risorgimento. Ad ogni modo, si tributava un omaggio a dei grandi italiani. Senza troppo 28 preoccuparsi del contesto, senza approfondire. L'Italia era il Fascismo e il Fascismo era l'Italia: i grandi italiani non potevano che essere grandi fascisti. Anche senza saperlo. Si dirà: sono furbizie da regime totalitario. No, sono furbizie di tutti i regimi, anche di quelli democratici. Basti por mente a quanto e come fu mistificato il centenario dell'Unità, nel 1961. Anche allora si stese un velo di omissione su molte cose imbarazzanti. I quattro Padri della Patria venivano ritratti assieme. Si taceva, e non poteva essere altrimenti, sul disprezzo e il malanimo che serpeggiava tra i nostri eroi. Una celebrazione è una celebrazione, non un convegno di studi, certo. Aggiungiamo che la storia presenta pure una sua dimensione simbolica, che non va sporcata con troppe macchie di verità fattuale. Si trattava di educazione civile, di istillare un po' di senso patriottico. Di confermarlo, non di seminare dubbi. E passi. Ma alcuni capovolgimenti, certe giravolte, erano persino ridicole. Come quando si cercò di passare sotto silenzio il conflitto tra Chiesa e Stato. Tutto doveva conciliarsi col clima di ritrovata spiritualità dell'Italia democristiana, tra l'altro in procinto di aprire le porte del governo al Psi. Ma quei festeggiamenti riuscirono bene. Chi vi prese parte, da bambino, ne serba ancora un buon ricordo. Ad ogni modo, torniamo al Fascismo. Il Risorgimento serviva, era una pagina nobile della storia Patria. Nobile e recente, quindi non troppo vaga nelle menti degli italiani. Ma era anche un mito contraddittorio. Ricordava anche un periodo di divisioni, di lacerazioni, di pagine buie. Meglio l'antica Roma. Un mito più unificante. Il Fascismo, che nacque futurista e milanese, divenne presto classico e romano. Le due anime non si elisero mai: coesistettero. Del resto, esisteva anche una Roma laica e mazziniana, a pieno titolo risorgimentale. Il Risorgimento, poi, lo si poteva legare ad un altro evento 29 costitutivo della mitologia fascista: la Grande Guerra, vista come quarta guerra d'indipendenza contro gli eterni appetiti del germanesimo. In questa nostra cavalcata alla buona sul mito del Risorgimento, passiamo al dopoguerra. Già la Resistenza veniva legittimata come un nuovo Risorgimento. Un Risorgimento dalle tenebre oscure della tirannia, che ridonava al paese una nuova dignità civile. Per molto tempo, la Resistenza fu considerata un nuovo mito fondativo dello Stato italiano, alla pari del Risorgimento. Un mito che non conosceva macchie e non poteva subire critiche. Attraverso la lotta partigiana, gli italiani avevano espiato la colpa di aver aderito, in massa, al passato regime. Bisognava far credere di aver, anche noi, vinto la guerra. L'otto settembre non era – come invece si disse poi – la morte della Patria, ma piuttosto la sua rinascita. Ovviamente, il racconto della Resistenza fu parziale e fazioso, come era stato quello del Risorgimento. Ma non si poteva, nel dopoguerra, sottilizzare troppo: i miti vivono anche di questo. Qui è importante dire che gli ideali del Risorgimento, seppur ammaccati, svolsero un loro ruolo nell'Italia repubblicana. Anche i marxisti ne fecero uso. Il 18 aprile 1948 i simpatizzanti del Fronte Popolare dovevano apporre una croce sul rassicurante faccione di Garibaldi (che, secondo la satira anticomunista, se capovolto, rivelava le più truci fattezze del maresciallo Stalin). Il rapporto col Risorgimento rivelava però dei problemi. Un po' perché presupponeva l'accettazione dell'idea di nazione, e il Pci – nonostante la svolta togliattiana del '44 – rimaneva un partito antinazionale. Un po' perché, il partito di maggioranza relativa, la Dc, non poteva farsi interprete della tradizione risorgimentale, che era laica e liberale. Il Psi è un caso a parte. Avrebbe potuto assumere in sé una 30 dimensione nazionale e rivendicare una continuità, per lo meno ideale, con le aspirazioni di dignità sociale che avevano percorso certi filoni del Risorgimento. Ma il socialismo e la nazione facevano fatica a stare assieme. Se vogliamo, il Fascismo nacque per risolvere l'antinomia: fu l'eresia nazionale che si produsse nel seno della dottrina socialista. Non che il socialismo non avesse i suoi eroi patriottici. Vagamente socialista era Garibaldi. Certamente socialista era Cesare Battisti, eroe e martire irredentista, che morì ammazzato dagli austriaci durante quell'appendice di Risorgimento che fu la Grande Guerra. Ma Cesare Battisti veniva fischiato ai comizi. Non dai nazionalisti o dai liberali, ma dai suoi stessi compagni. Il Psi – totalmente sordo al tema nazionale – scelse la strada del neutralismo, nel 1914. Non fece la guerra ma non seppe fare nemmeno la rivoluzione, restando a metà del guado. Battisti, socialista e patriota, fu amico e sodale di Mussolini a Trento, ma lasciò troppi eredi per un solo legato. La sua memoria fu contesa da fascisti e antifascisti: i primi rammentavano la sua militanza irredentista, i secondi sottolineavano la sua fede socialista. Ma anche nel secondo dopoguerra, non era facile, per il Partito socialista, rivalutare il patriota trentino: ricordava troppo la cesura della prima guerra mondiale, il conflitto tra neutralisti e interventisti. Non solo. C'era anche un altro problema. L'alleanza col Pci, che impediva ai socialisti una una strada di autonomia e indipendenza. La scelta frontista fu, per il socialismo italiano, un'altra occasione mancata per riappacificarsi con la Patria. Nel 1956, dopo la brutale repressione di Budapest, il Psi capì che doveva divincolarsi dall'abbraccio mortale con i compagni comunisti, che oltretutto – più organizzati e compatti – stavano stritolando i socialisti, in una competizione a sinistra che vedeva il partito di Nenni sempre più soccombente. L'occasione per 31 smarcarsi definitivamente da tutta la tradizione marxista venne con Craxi. Egli scelse non solo di perseguire una strada di orgogliosa autonomia dal Pci, ma di tagliare, come si disse, la barba a Marx. Recuperò forme di socialismo libertario e non marxista, a cominciare da Pierre-Joseph Proudhon. E si riconciliò col tema della nazione, facendosi portatore di un'idea di indipendenza nazionale tipicamente risorgimentale. Bettino Craxi parlava spesso del Risorgimento, ammirava Garibaldi e citava Mazzini. Come quando, parlando alla Camera, paragonò il patriota genovese ad Arafat. Come Mazzini, disse in sostanza, Arafat combatte con le armi che ha: se è necessario anche con la guerriglia e il terrorismo. Craxi immise con forza due temi risorgimentali nel patrimonio culturale del socialismo: quello della libertà e quello della Patria. Oppose il tema della libertà al dispotismo comunista. E rilanciò, in modo asciutto, non retorico, non passatista, il valore della Nazione, tanto da far parlare di socialismo tricolore. Questo, insieme ad alcune aperture al Msi e alla sua proposta di grande riforma dello Stato in senso presidenziale, gli guadagnò la simpatia di una certa parte della destra intellettuale19. 19 Socialismo tricolore è anche il titolo di un libro del 1983, scritto da Giano Accame, giornalista e intellettuale di destra recentemente scomparso. Nel testo, Accame si occupa della svolta patriottica del craxismo e analizza il rapporto storico tra socialismo e nazione. Nota, fra l'altro, che la vittoria della nazionale ai mondiali di Spagna aveva fatto emergere un nuovo atteggiamento degli italiani verso il tricolore. Solo dieci anni prima non sarebbe stato possibile vedere tutti quelle bandiere per le strade. Evidentemente, l'atmosfera era cambiata e l'impresa degli azzurri era servita a vincere un pudore, un conformismo, che aveva prevalso per tutti gli anni Settanta. Craxi e gli intellettuali a lui vicini colgono il nuovo senso comune e cercano di costruire attorno ad esso un'operazione culturale di recupero dell'idea di Patria, per molto tempo – nel dopoguerra – associata sbrigativamente alla destra e al neo-fascismo. Su “Critica Sociale”, la prestigiosa rivista teorica del riformismo, si dibatteva intorno ad una contraddittoria relazione di odio-amore tra la questione nazionale e la questione sociale. Il 22 ottobre 1980, il periodico dedicava al tema venti pagine di contributi. Nella sintesi introduttiva, si poteva leggere: «Quale origine ha il disagio dei socialisti nell'affrontare la questione nazionale? Eppure socialismo e nazione – nel senso moderno – sono nati contemporaneamente, nella Francia rivoluzionaria. Ma il percorso, da allora, è lungo e accidentato. La nazione è giunta a identificarsi con lo Stato anche nell'Italia unitaria; il socialismo ha oscillato fra una realistica accettazione (che a volte si è trasformata in passiva acquiescenza) e un atteggiamento di rifiuto globale, di negazione aprioristica. Se questo discorso può valere in generale, è tanto più vero se lo si riporta nel contesto delle vicende e della storia del movimento operaio e socialista italiano. Si è tuttavia accresciuta, attraverso le vicende storiche e la pratica politica di 32 Craxi fu forse l'ultimo uomo politico italiano ancorato alla cultura del Risorgimento20. L'ultimo insieme a Giovanni Spadolini, suo predecessore a Palazzo Chigi. Uomo di vastissima erudizione; professore di Storia contemporanea; direttore di importanti giornali nazionali, come il Corriere della Sera; autore di molti volumi di gran pregio storiografico, Spadolini fu un cultore appassionato e consapevole del Risorgimento. Fu segretario di un partito, il Pri, che insieme al Pli era il più accreditato e autorevole custode delle memorie risorgimentali. Entrambi i partiti, infatti, si richiamavano alla tradizione laica e nazionale, seppur da versanti diversi. Il primo valorizzava e si faceva interprete del filone mazziniano, democratico e di democrazia radicale. L'altro esprimeva il côté moderato del Risorgimento, il versante conservatore e liberalborghese21. I due partiti risorgimentali, il Pri e il Pli, erano accomunati, tutti i giorni, una confidenza e una continuità con lo Stato nazionale e le sue istituzioni, almeno per questo ultimo trentennio, che ha aumentato di molto i motivi di incontro e ridotto le ragioni di ostilità fra l'universo morale e sociale [e] politico del socialismo e quello della tradizione storica unitaria. Da queste considerazioni deriva il nuovo interesse nei confronti di questo problema e verso quei tentativi che avvicinino mondi sino a ieri così distanti. […] Il socialismo oggi vuole avere un passato, radici che affondino non solo nella sua storia, ma anche nella storia più generale. Da qui l'ipotesi di un “socialismo tricolore” anche in Italia, un socialismo capace di collegarsi, da sinistra, ai movimenti politici e culturali che derivano dal Risorgimento e che riscoprono oggi affinità col movimento socialista nella sua accezione più tipicamente italiana, quella riformista e democratica». Cit. in G. Accame – Socialismo tricolore, Editoriale Nuova, 1983, pag. 40-41. 20 Queste nostre considerazioni su Craxi prescindono, evidentemente, dalle sue colpe sia giudiziarie che eminentemente politiche. Si tratta di valutazioni che attengono a due piani diversi. 21 I due partiti hanno subito, nella loro storia, numerose oscillazioni sull'asse destra-sinistra. Il Pri nasce come partito anti-istituzionale, in quanto contrario alla monarchia, e ha una collocazione di sinistra, sebbene più moderata rispetto a quella dei socialisti. Nelle campagne del Centro Italia, i repubblicani rappresentano i mezzadri, laddove i socialisti rappresentano i braccianti. Dopo la caduta del Fascismo, si fronteggiarono, all'interno del partito, due tendenze: una era la linea tradizionalista e mazziniana, l'altra proponeva di introdurre il tema della lotta di classe, assumendo i paradigmi dell'analisi marxista. Durante tutta la Prima Repubblica, il Pri si assestò su posizioni di centro e di centro-sinistra moderato. Anche il Partito Liberale oscillò tra conservatorismo borghese e progressismo lib-lab. Si trovò talvolta su posizioni confindustriali e padronali, durante la segreteria Malagodi, e talaltra espresse orientamenti più di sinistra, durante la segreteria Zanone. Tuttavia, il Pli non accettò mai la definizione di partito di destra e si tenne a buona distanza sia dai monarchici sia, soprattutto, dai missini. Questi ultimi, con Michelini, cercarono di inserirsi nel gioco parlamentare cercando sponde tra i liberali, ma il giocò non riuscì. 33 insieme ai socialdemocratici, nella definizione di partiti laici minori. Erano, in effetti, partiti piccoli, ma influenti: sia per la loro posizione centrista – che li rendeva naturali alleati della Dc – sia per la loro influenza culturale. A questo punto, però, ci si potrebbe chiedere: perché il liberalismo italiano, pur così autorevole, espresse percentuali elettorali generalmente basse? La mia tesi è tra il minoritarismo liberale e il declino dell'ideologia risorgimentale ci sia un legame. Croce, Einaudi, De Nicola, Vittorio Emanuele Orlando: al liberalismo italiano dell'immediato dopoguerra non mancavano certo gli uomini, né le idee22. Cito questi nomi anche perché, quando si trattò di scegliere il Presidente della Repubblica, a giocarsela furono loro, insieme al repubblicano Carlo Sforza. De Nicola fu eletto capo provvisorio dello Stato. Einaudi, fu il primo presidente della Repubblica italiana. La domanda è: perché non riuscì a spendere questa autorevolezza a livello elettorale? Perché, insomma, il liberalismo italiano non riuscì a conquistare le masse? Non certo perché quella liberale sia un'ideologia elitaria: in altri paesi, il liberalismo ha conquistato il senso comune ed esprime partiti di una certa consistenza elettorale. Senza contare che, ancora nel 1921 – quando la società di massa era già una realtà, così come il suffragio universale (maschile) – i partiti liberali riportarono un risultato inferiore ai precedenti, ma ancora apprezzabile, se confrontato con ciò che sarebbe avvenuto in età repubblicana. Benedetto Croce cercava di sostenere l'idea che il Fascismo fosse una parentesi e che la storia d'Italia potesse riprendere il suo corso dove l'aveva interrotto. Ma così non fu. Le redini del governo erano, e rimasero, nelle mani della Democrazia cristiana. 22 Forse mancava un “matto”, come come scrisse Mario Ferrara sul “Mondo”. Cfr. Date un matto ai liberali, in “Il Mondo”, 26 maggio 1951. L'articolo è ora contenuto nell'antologia Il “Mondo” . Antologia di una rivista scomoda (a cura di G. Carocci), Editori Riuniti, 1997, Roma, pag. 20-24. 34 La Dc aveva poco a che fare col Risorgimento. Non era espressione di quella storia, e anzi vide nell'affermazione del dopoguerra una rivincita sullo Stato liberale e il risanamento di una ferita. Alla Dc, al suo ceto politico, era generalmente estraneo il principio di laicità dello Stato 23. Si adattò a rappresentare anche la borghesia liberale e non si mise in urto con i suoi valori, ma il ruolo non gli era congeniale. Peraltro, si costituì come partito interclassista, nel quale trovavano spazio le più diverse posizioni: dal conservatorismo alla sinistra solidarista. Ma il mondo viveva la Guerra fredda, e in funzione anticomunista, la borghesia italiana si affidò allo scudo crociato. Che era pur sempre il meno peggio. I partiti risorgimentali esistevano, ma non bastavano. Dopo la caduta del muro di Berlino, verrà un'altra storia. Il Pci cambierà nome. Un paio di anni dopo, l'inchiesta di Mani Pulite sgretolerà i partiti di governo. Si farà strada un partito antiunitario, come la Lega Nord. E la questione risorgimentale si porrà in modo diverso. Ma tutto ciò sarà oggetto del prossimo paragrafo. 23 Oggi, tuttavia, va molto di moda rivalutare De Gasperi, come esempio di laicità e di senso dello Stato. In effetti, l'uomo non era un clericale. Rimase famosa la sua opposizione alla cosiddetta “operazione Sturzo”, patrocinata dal Vaticano. Questo gli costò l'ostracismo di Pio XII, che in seguito gli negherà persino un'udienza. De Gasperi risponderà scrivendo all'ambasciatore italiano presso la Santa Sede una lettera orgogliosa e risentita. 35 Risorgimento e Seconda Repubblica Qualche mese fa, Silvio Berlusconi, parlando ad una festa di partito, consigliò un libro. Leggetelo, disse alla platea. Generalmente, il Presidente del Consiglio non parla di libri, e quindi c'è da credere che il volume in questione lo avesse particolarmente colpito. Che libro era? Si trattava di Risorgimento da riscrivere, di Angela Pellicciari: per farla breve, un libro antirisorgimentale. Intendiamoci. L'onorevole Berlusconi può leggere quello che vuole e caldeggiarne l'acquisto in tutte le sedi. Tra l'altro, la storiografia revisionista – lo abbiamo abbiamo già detto – ci è molto simpatica. Ma ci è sembrato un episodio da segnalare. Il Risorgimento, in questa cosiddetta Seconda Repubblica, non è molto popolare. La Seconda Repubblica viene fatta nascere, convenzionalmente, nel 1994, dopo la crisi di regime dei due anni precedenti. Nasceva sulle ceneri delle ideologie, contro la vecchia politica, la partitocrazia, le antiche appartenenze, le residue fedeltà. Si alimentava di miti nuovi e suggestivi: il pragmatismo e la società civile. La Storia, di per sé, era un ingombro. Anche perché molti dovevano far dimenticare la propria, a destra e a sinistra. La cesura storica avviene nel 1994. Berlusconi scende in campo, all'inizio dell'anno, e pronuncia un discorso diventato famoso. “L'Italia è il paese che amo”, e tutto il resto, compresa la calza sulla telecamera. Dall'altra parte, c'è Occhetto e la sua gioiosa macchina da guerra, che poi si rivelerà 36 un gioioso macinino. Al centro, penalizzati dalla nuova legge elettorale e votati all'irrilevanza, Segni e Martinazzoli. In quattro e quattr'otto, Berlusconi assembla un improvvisatissimo partito e lo battezza Forza Italia. Il nome è patriottico, ma allude più al tifo calcistico che al Risorgimento. Non fa pensare tanto a Cavour e Mazzini, quanto alla nazionale di Sacchi e Baggio, che si appresta a giocare i mondiali negli Stati Uniti. Berlusconi si presenta come l'imprenditore di successo che vuole dare una sterzata al paese, sulla base di un'ideologia efficientista e meritocratica, avversa alla sinistra – da allora, tutta sbrigativamente assimilata al “comunismo” – ma parimenti lontana dall'inconcludenza della vecchia classe politica di governo, spazzata via da Tangentopoli, considerata screditata e corrotta. Berlusconi, che pure si propone di raccogliere i voti del pentapartito, cavalca l'indignazione contro il vecchio ceto politico. Vuole declinare il vecchio moderatismo in forma liberale, e questo gli guadagna la stima e la fiducia di alcuni intellettuali che si rifanno a quella tradizione. Prima o poi, ne rimarranno tutti delusi. Il nuovo ideale è la società civile, che trova seguaci a destra e a sinistra. Tra i progressisti, prende la forma di una rivolta morale degli onesti contro i disonesti: la rivolta morale sublima la rivolta sociale, la lotta alla corruzione prende il posto della lotta di classe. Sul fronte liberal-democratico, la società civile veste i panni dell'Italia laboriosa e fattiva, che si sveglia presto e non si perde in chiacchiere, insofferente verso le lentezze della pubblica amministrazione e della burocrazia, e che crede di dover prendere in mano direttamente le leve del potere. Le classi più attive, il 37 Nord operoso che paga sempre per gli altri, vogliono far piazza pulita dei parassitismi e degli sprechi, senza le mediazioni del ceto politico, considerato una casta di parrucconi e di azzeccagarbugli. Con il crollo del comunismo, veniva meno anche la rendita di posizione della Dc, a cui molti avevano dato il loro voto turandosi il naso. Il malgoverno era pur sempre meglio dei cosacchi in Piazza San Pietro. Ma, adesso, che il pericolo è passato, l'elettorato diventa più esigente e non vuole concedere più cambiali in bianco. Il mito della società civile, che pure era sorretto da un sacco di buone intenzioni, si rivelerà una truffa. Da una parte produrrà il moralismo anti-politico, per il quale vi è una società incorrotta, perennemente sotto il tallone del potere che si mette sempre d'accordo ai suoi danni. Dall'altra alimenterà la follia dell'antielitismo, dell'anti-intellettualismo, del populismo, del disprezzo per ogni forma di mediazione; non concepirà l'esigenza di costruire classi dirigenti e lascerà spazio a un'armata Brancaleone di dilettanti allo sbaraglio. Come dire: se questo era il nuovo, aridatece la Dc. Ma torniamo al '94. Siamo alle elezioni. Il nuovo sistema elettorale rende necessario formare delle coalizioni. Berlusconi imbarca nel suo schieramento la destra missina, che si presenta con una nuova sigla, Alleanza Nazionale (che prelude allo scioglimento del partito, che avverrà al congresso di Fiuggi, nel gennaio 1995), vecchi spezzoni di moderatismo governativo (liberali, democristiani) e la Lega Nord. L'alleanza è complessa: al Nord, An è contro il Polo forzaleghista, al Sud si presenta insieme ai berlusconiani. Berlusconi, com'è noto, vince. Ma l'equilibrio è precario e il governo va a gambe all'aria dopo sette mesi. 38 Così è nata la Seconda Repubblica, che è poi la Repubblica di Berlusconi. Lasciamo perdere se si sia trattato di un esperimento riuscito. Se il partito liberale di massa abbia tenuto fede alle promesse. Se il bipolarismo abbia funzionato. Non è questa la sede per parlarne. Il punto è che quell'anno finiva un mondo. Morivano i vecchi partiti, i quali – bene o male – alludevano ad una storia politica. Il Partito liberale o il Partito repubblicano, pur in un contesto completamente mutato, riannodavano i fili di una tradizione. Usurata, mal compresa, anacronistica, ma presente. Ora non più. Non tutto il male veniva per nuocere, se vogliamo. La tradizione risorgimentale poteva diventare un patrimonio condiviso da tutti gli attori politici; non più rinchiuso dentro gli steccati di uno, due o tre partiti medio-piccoli. Il Risorgimento poteva essere svincolato completamente (in gran parte già lo era) dalla battaglia politica, dall'uso strumentale, dalla zavorra politicante. Se la Seconda Repubblica si fosse limitata a questo, non avrebbe fatto male. La Storia va meditata, non usata a fini di parte. Non si rendeva onore a Garibaldi, quando si utilizzava il suo volto per la propaganda del Fronte Popolare. Si faceva un torto a Mazzini, quando si spendeva il suo nome venerato per ottenere – che so – il ministero delle Poste o la poltrona di qualche municipalizzata. Era giusto restituire il Risorgimento alla Storia. Ma, in realtà, lo si è consegnato all'oblio. 39 La Lega contro l'Unità d'Italia Quando nacque, sembrava un movimento effimero. Una scheggia impazzita di umori protestatari, che sarebbero rientrati subito nei ranghi. Come il Fronte dell'Uomo Qualunque, del quale condivideva la polemica antipartitocratica, l'appello al popolo contro la classe politica, il linguaggio schietto e diretto, non privo di rudezze e volgarità. Adesso, la Lega è al governo, e – come dimostrano le recenti elezioni amministrative – si espande verso regioni che le erano sconosciute. Ma questo già si sa: basta leggere i giornali. Piuttosto, è interessante indagare il rapporto di questo partito con l'Unità d'Italia e il Risorgimento. Un rapporto pessimo, com'è noto. La sua critica si struttura su tre piani. Il primo è quello del dibattito storiografico. Garibaldi è il bersaglio preferito, perché è considerato il maggior colpevole dell'accaduto. Cioè di quella sciagura chiamata Unità d'Italia. I politici leghisti e il suo organo di stampa, la Padania, danno spazio alle tesi della storiografia antiunitaria e si servono di questa polemica per alludere ai problemi dell'Italia odierna. Il secondo piano dell'attacco leghista è legato all'assetto istituzionale scaturito dal Risorgimento: vale a dire, il sistema centralistico, prefettizio, d'ispirazione napoleonica. Così, uno degli argomenti più forti della Lega, quando nacque, fu la messa in discussione della struttura statale e ipotizzò, variamente, la secessione e il federalismo. Il revisionismo storiografico e la richiesta della riforma istituzionale non mettono ancora in questione l'essenza del 40 Risorgimento.24 La ricerca storica è sempre ben accetta, anche e soprattutto quando propone tesi eccentriche e controcorrente. Pertanto, si può continuare ad ritenere il Risorgimento una bella pagina della storia nazionale pur ammettendo che vi furono degli episodi deprecabili e delle scelte sbagliate. Si può ammirare il coraggio o la lungimiranza dei Padri della Patria, anche conoscendo i loro vizi e i loro errori. Per quanto riguarda la struttura dello Stato, il centralismo non è un dogma. Poteva essere necessario in quelle circostanze e può non esserlo adesso. Una diversa distribuzione dei poteri non è certo in contraddizione col Risorgimento. Ma il lato più significativo dell'attacco leghista è il terzo. Quello che riguarda i valori e i simboli. A cominciare dalla bandiera, passando per l'inno nazionale, per finire con la toponomastica. 25 La Lega è un movimento pragmatico, ma ha sempre riservato un certo spazio alla dimensione simbolica della politica. Dall'ampolla del Po in giù. E, dalla sua nascita, ha oltraggiato tutti i valori del Risorgimento. Le critiche tradizionali al Risorgimento intendevano metterne in luce l'incompiutezza, non negavano la bontà del progetto.26 Bossi no. I leghisti, sin dai loro 24 Ovviamente, salvo per la parte che riguarda la secessione, argomento che i leghisti hanno però, al momento, accantonato. 25 La toponomastica è, al giorno d'oggi, l'ultima trincea delle identità politiche. La classe politica, priva di fantasia, s'inventa ogni giorno un nuovo motivo di discussione. L'ultima vivacissima polemica, in ordine di tempo, riguardava la strada da intestare a Bettino Craxi. Così si è innescato un dibattito che mescolava ragioni politiche e ragioni storiche, dichiarazioni roboanti e vendette postume, motivi di opportunità e sospetti di opportunismo, accademici e politicanti, inquisiti e inquisitori, reduci del craxismo e reduci del dipietrismo, nostalgici del garofano e nostalgici delle manette, giustizieri della penna e avvocati d'ufficio. Insomma, un frullato di storia, politica e casellario giudiziario. Si tratta, tutto sommato, di una situazione, in parte, comprensibile. In un'era a bassa intensità ideologica, incapaci di infiammarsi per la politichetta del giorno per giorno, l'unico modo per riaccendere gli entusiasmi sopiti e per riaffermare le identità perdute, sembra essere cambiare i nomi alle strade. Appare gratificante, perché ci si illude di appartenere alla grande storia, in un periodo di rassegnata quiete. Così, il consigliere comunale Tizio si batte contro Bottai (che da morto mise in crisi la giunta Rutelli) e l'assessore Caio si vendica di Lenin. 26 Ad esclusione della critica cattolica anti-moderna e temporalista, che vedeva nel Risorgimento una congiura massonica ai danni della Chiesa. Tuttavia, al di là di questa ed altre posizioni minoritarie, il grosso della cultura politica italiana – almeno dal secondo dopoguerra in poi – accettava l'eredità del Risorgimento, ne ricomponeva le cesure attraverso una sua rivisitazione idilliaca – come la cultura democristiana – o si proponeva di compierne uno nuovo, integrando 41 inizi eversivi e ruspanti, negano che l'Italia sia più di una espressione geografica. Negano che il nostro popolo sia legato da una storia e un destino comuni. Che cosa si è risposto, in questi anni, a questo ribaltamento del mito risorgimentale? All'inizio, la Lega non venne presa molto sul serio. Il folklore delle sue adunate, il linguaggio da osteria, le smargiassate del suo capo erano troppo dissonanti rispetto ai costumi della vecchia politica ed era facile considerare queste stramberie con sufficienza. Tuttavia, quando, in seguito, si dovette fare i conti con il suo innegabile seguito elettorale, si adottarono vari atteggiamenti. La sinistra oscillò tra la deprecazione e l'esaltazione, a seconda delle circostanze. Berlusconi non si mostrò turbato dai presupposti antiunitari di Bossi, e si propose piuttosto di placarli, coinvolgendo i leghisti nel Governo, con alterne vicende. Alleanza Nazionale visse, in principio, con insofferenza l'alleanza con un partito anti-unitario. Nel '94, come ricordato, An e Lega correvano separati, al Nord. Nel '96, dopo un effimero avvicinamento alla sinistra, la Lega si presentò da sola, contro “Roma Polo e Roma Ulivo”. E così fu attaccata da entrambi i lati. L'Italia fu attraversata, per qualche anno, da un impeto di patriottismo, più o meno sincero, contro il partito che voleva dividere l'Italia. Il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, si lasciava andare sovente a discorsi pieni di sentimento e afflato unitario. Fini, nel periodo di maggior consenso del suo partito, furoreggiava a colpi di tricolore. Persino le masse nella società, come la cultura marxista. Il cattolicesimo italiano poteva ancora ospitare, si è già detto, qualche sacca di risentimento, ma più verso l'ideologia liberale che nei riguardi del Risorgimento come fatto storico, dato ormai come acquisito. E, ad occhio e croce, era un sentimento riservato a parte della gerarchia ecclesiastica, meno alla classe politica, quasi per nulla all'uomo della strada. La rottura era stata ricomposta – anche attraverso una lettura di comodo, che smussava le asperità del conflitto. Ad ogni modo, con la Dc saldamente al governo, il cattolicesimo italiano aveva riavuto ciò che, a suo giudizio, gli era stato ingiustamente tolto. L'anti-risorgimento leghista, invece, è un sentimento molto popolare presso l'elettorato delle camicie verdi. 42 gli ex comunisti si riscoprirono patriottici. Tra un richiamo e l'altro all'unità ci fu spazio persino per un ridicolo blitz dimostrativo di un gruppo autonomista, pur non direttamente collegato alla Lega, nel maggio 1997, a Venezia. Pur trattandosi di un episodio da operetta, la cosa fece un certo scalpore, e rinvigorì il patriottismo di ritorno. Quegli anni, quelli in cui la Lega attraversò la sua fase secessionista, videro una compatta reazione della classe politica sul tema dell'Unità nazionale. Con tutta la retorica del caso. La La Lega venne demonizzata, anche oltre il giusto. Negli anni successivi, messi da parte i propositi più forsennati, riuscì tornare al governo, una prima volta nel 2001 e poi nel 2008, comportandosi con meno sconsideratezza della prima volta. Adesso la sua reputazione è migliorata. Non è più il partito antisistema di un tempo. I suoi dirigenti sembrano più posati. La secessione è stata riposta in un cassetto. Ma la contestazione del Risorgimento continua. E l'anno prossimo l'Unità nazionale verrà festeggiata con un partito anti-risorgimentale al governo. E' un dramma? No. Un paradosso, però, sì. Gli altri partiti e la tradizione unitaria Il simbolo del Pdl è attraversato da un tricolore. Quello del Pd è colorato, non per caso, di bianco, rosso e verde. Il maggior partito di governo e il più grande partito d'opposizione mettono ben chiaro che, quanto a italianità, hanno le carte a posto. Il Popolo delle libertà, peraltro, è nato dalla fusione tra due partiti 43 che, già nel nome, alludevano all'Italia: Forza Italia e Alleanza Nazionale: quindi saremmo di fronte al non plus ultra dell'amor di Patria. Ovviamente, non è così semplice. Non si tratta di fare l'esame del sangue ai partiti per testare il loro grado di patriottismo. Anche perché i partiti non sono tutto: di questi tempi, che sono tempi – si dice – di disaffezione verso la politica, i partiti non sembrano rispecchiare fedelmente e completamente l'intero spettro di opinioni che caratterizza una società di massa individualista, pluralista e post-ideologica che pensa con la propria testa. I partiti di oggi non sono i vecchi partiti d'integrazione di massa, i partiti-chiesa. Ma è interessante capire come la classe dirigente interpreta la tradizione nazionale. Poi, eventualmente, si tratta di capire se il popolo la recepisce o la respinge. Galli della Loggia, che abbiamo citato, non ravvisa una grande consapevolezza politico-culturale nel ceto politico attuale. Lo considera un ceto politico schiacciato sul presente, senza una conoscenza del passato né una visione del futuro. Abbiamo assodato, però, che questi partiti ostentano la loro identificazione con l'Italia. Ma l'Italia di cui parlano è l'Italia del Risorgimento? L'Italia del Risorgimento non è un riferimento neutro. Non è l'Italia in generale. E' una tradizione politica, ben identificabile, che ha connotati suoi propri e un suo proprio orizzonte di valori, che abbiamo cercato di abbozzare – con molta approssimazione – nelle pagine precedenti. Vediamo, in pochissime righe, come affrontano questo problema, i due soggetti politici più rilevanti del nostro sistema. A sinistra, ultimamente, si sogna Obama. Prima si celebrava 44 Zapatero e prima ancora Clinton (passando per un fugace amore verso Tony Blair e il New Labour). Passando ai suoi riferimenti italiani, la sinistra è ancorata, principalmente alle vicende della Prima Repubblica, al legame affettivo con i partiti di appartenenza (sia esso il Pci o la Dc) e alla lezione dell'ultimo Bobbio. Del Risorgimento non c'è traccia. A destra, lo sforzo d'interpretazione più generoso si è avuto dalle parti di An, con la “Svolta di Fiuggi”. L'esigenza era quella di ricomporre la frattura Fascismo/Antifascismo, e lo si fece cercando di leggere la storia nazionale attraverso il paradigma dell'italianità. L'idea era: siamo figli della cultura italiana, al di là delle divisioni. Ispiratore della svolta, com'è noto, fu il professor Domenico Fisichella. Ma più o meno sulla stessa linea si trovava anche Marcello Veneziani, altro intellettuale d'area, che ne La rivoluzione conservatrice in Italia sosteneva l'esistenza di un'ideologia italiana, che si è declinata nel tempo in varie forme ma che conserva un filo conduttore comune, una sua peculiarità, un suo tratto specifico.27 An, partito della Nazione, doveva identificarsi in questa ideologia e darle una rappresentanza. Ovviamente, chiedo scusa per le semplificazioni a cui sono stato costretto. La mia tesi è che i riferimenti politico-culturali dei due partiti più votati nel Paese siano, in larga parte, estranei al Risorgimento. Se la sinistra privilegia un ancoraggio rassicurante al progressismo mondiale, un progressismo dei diritti civili e dell'emancipazione, la destra è divisa tra la dimensione anti-ideologica, aziendalista e populista del berlusconismo, estranea ad una vera e propria riflessione culturale e più legata all'istinto pre-politico e antipolitico del suo leader, e quella più consapevole del conservatorismo nazionale finiano, che ha sempre coltivato una 27 M. Veneziani – La rivoluzione conservatrice in Italia, Sugarco Edizioni, 1994 45 ostentata passione patriottica, adesso declinata attraverso le forme del patriottismo costituzionale e di una cittadinanza fondata sulla scelta e non sui legami di sangue. Rispetto a questo tentativo meta-politico, su cui di questi tempi si è molto scritto, vale la pena di dire due parole. La destra di Fini non può richiamarsi direttamente alla Destra risorgimentale, saltando a piè pari il resto. Le sue origini affondano altrove, e con questo altrove – che poi sono l'esperienza fascista e la testimonianza neo-fascista – ha provato a fare i conti a Fiuggi. A Fiuggi, come detto, si è deciso di prendere l'Italia tutta intera, rivendicando una continuità col suo passato e con la sua tradizione culturale al di là delle lacerazioni. Tuttavia, per molto tempo, il richiamo alla Patria è stato poco più di un espediente retorico da comizio. Mentre il Risorgimento liberale non è un'idea generica di Patria, ma una ben precisa scelta di valori. Pur nella necessaria elasticità, che si impone nel definire un'eredità politica, c'è un confine oltre il quale non si può andare, senza tradire la verità storica. Il tradizionale clericalismo della destra italiana – pur celato dietro perentorie affermazioni ghibelline – non può andare d'accordo col Risorgimento liberale. Le pulsioni autoritarie e anti-pluralistiche nemmeno. Le politiche servili e sostanzialmente anti-nazionali, neppure. L'ultima versione della camaleontica destra finiana sembra riscoprire la laicità ma la collega ad un vago libertarismo similpannelliano e ad una nebulosa rivendicazione di diritti civili, piuttosto che alla vigorosa tradizione laica della Destra risorgimentale. L'idea della cittadinanza come scelta, invece, si richiama – implicitamente – ad una interpretazione mazziniana della comunità nazionale che aveva influenzato pure certe frange del Fascismo, il quale – prima di far proprio il razzismo biologico – 46 vedeva nella Nazione una comunità di destino, non definito etnicamente ma spiritualmente e culturalmente. Tuttavia, il Risorgimento liberale non è tra i primi riferimenti della destra nuova finiana, che invece ha i suoi modelli altrove, nella rupture di Sarkozy (rivisitazione pop e sbarazzina della vecchia passione gollista, emersa anche a Fiuggi) e nel popolarismo europeo. Tra i partiti che più valorizzano, al giorno d'oggi, la tradizione del Risorgimento possiamo annoverare i Radicali. Debitori, già nel nome, alla tradizione democratica e anticlericale del radicalismo storico, si ergono a pugnaci paladini della laicità contro le interferenze vaticane. Il partito di Pannella ha preso, nel corso degli anni, varie strade ed ha inseguito i più diversi obiettivi, dalla lotta antipartitocratica a quella contro la fame nel mondo, fino al liberismo spinto degli anni Novanta, che lo vide convergere con il primo Berlusconi nel nome della tanto agognata rivoluzione liberale. Al di là delle tattiche contingenti, però, non ha mai abbandonato l'anticlericalismo come fattore identitario e di riconoscibilità politica. Si tratta di un anticlericalismo di marca antica, talvolta un po' di maniera, ma vivace e coerente. Storicamente, nella retorica pannelliana, hanno trovato più spazio i richiami novecenteschi all'anti-totalitarismo che quelli al Risorgimento, sebbene questi ultimi non manchino, specialmente quando c'è da celebrare la tradizione laica e i suoi momenti simbolici, come la Breccia di Porta Pia. Tuttavia, nella presa di posizione anti-totalitaria che ha caratterizzato il profilo ideologico del radicalismo italiano si intravede senz'altro un nucleo di principi per nulla estranei ad un 47 orizzonte di pensiero che si vuole erede del Risorgimento liberale. Soffermiamoci un momento su questo aspetto. Il termine anti-totalitarismo è stato considerato per molti anni un'eresia, dal momento che metteva su uno stesso piano di condanna morale il comunismo e il fascismo. Gli eroi della cultura radicale sono sempre stati quegli intellettuali e scrittori che si ribellarono a entrambe le dittature e che scelsero la democrazia: da Ignazio Silone a Ernesto Rossi. Nel dopoguerra, questa terza via venne perseguita dal gruppo del Mondo, guidato da Mario Pannunzio, che è stato magna pars del progetto di rinascita radicale, nel 1955, quando l'ala sinistra del Partito liberale fece le valige, in polemica contro il conservatorismo della nuova segreteria. Il movimento, però, ebbe vita breve, messo in crisi dal cosiddetto caso Piccardi, ma soprattutto privo di una base di massa. Negli anni '70, il Partito radicale venne rilanciato dalla genialità e dall'estro politico di Marco Pannella, che abbandonò lo snobismo un po' salottiero e l'allure britannica della fase precedente, rivoluzionandone la strategia e la comunicazione. Fece largo uso di una propaganda irriverente e originale e usò l'arma del referendum per scardinare il potere partitocratico. Il leader radicale amava presentare se stesso e il suo movimento come i veri interpreti dell'antifascismo, tradito – a suo dire – dai partiti di governo e di opposizione, uniti nell'abbraccio consociativo. Il nuovo Fascismo era, insomma, la partitocrazia. 48 La presidenza Ciampi: un nuovo patriottismo Molti ricorderanno la polemica sui calciatori della nazionale che non conoscevano le parole del nostro inno e accompagnavano le sue note con un imbarazzante silenzio o masticando chewing gum. Anche quella volta (come nel già citato caso del 1982, di cui parlava Accame), un fatto della cultura popolare si legò alle riflessioni, più serie, sull'identità italiana. Alfiere di questo nuovo patriottismo fu l'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Ciampi sembrava, a prima vista, il meno adatto per un'operazione del genere. Era un tecnocrate in grisaglia, un ex Governatore della Banca d'Italia, autorevole, sì, ma di un'autorevolezza burocratica che alludeva più alla dimensione legale-razionale che a quella carismatica – per dirla con Weber. Tuttavia, nonostante qualche inevitabile cedimento alla retorica, il tentativo di Ciampi ebbe successo e contribuì a ridare un valore non di parte ai simboli nazionali. Vennero riscoperti il tricolore e l'inno, la Patria e il Risorgimento. Fu una scelta meritoria, che consentì al Presidente della Repubblica – che veniva da una cultura laico-azionista – di suscitare consensi sia a destra che a sinistra. E, tra le altre cose, i calciatori presero a cantare Fratelli d'Italia, pur con molte stonature. 49 Conclusioni All'anniversario dell'anno prossimo, l'ideologia risorgimentale arriva dunque un po' ammaccata, priva di fascino e di capacità mitopoietica. I leghisti la deridono, quando va bene, come una fissazione di vecchi barbagianni. Gli altri, la cosiddetta sinistra e la sedicente destra, ne parlano poco, perché hanno poco da dire. In un periodo in cui tutti si riempono la bocca di valori, i valori del Risorgimento sono fuori moda. Anche perché, coloro che credevano in quei valori li praticarono, e non si limitarono a strombazzarli. Talvolta commisero degli errori, ma li pagarono di persona. Forse il tempo edulcora il passato, ma coloro che fecero l'Italia del Risorgimento appaiono migliori di quelli di oggi, che la vogliono distruggere. Gli uomini del Risorgimento ci hanno lasciato un'eredità politica, che è l'Italia unita, bella o brutta che sia. Ma ci hanno lasciato soprattutto un costume morale di serietà, di pulizia morale, di senso dello Stato e di spirito di servizio. In ultimo, lasciamo la parola a un uomo del Risorgimento nato nel secolo sbagliato, Indro Montanelli. Montanelli, che in gioventù era stato prima un fascista convinto e poi uno scettico frondista, nel dopoguerra – forse per reazione – scelse la via del disincanto e, talvolta, del cinismo. Si prese gioco di tutte le illusioni, compresa quella in camicia nera che lo aveva visto protagonista. E non risparmiò nemmeno il Risorgimento. Ma davanti ai revanscismi neoguelfi, scattava in lui la molla 50 dell'orgoglio. Così, ad esempio, difendeva i Padri della Patria di fronte alle acrimoniose accuse di parte clericale. Ed è con le parole del grande giornalista, che concludiamo questo testo. Non prima di aver fatto alla nostra Nazione gli auguri di buon compleanno. Se non furono degli eroi (anche su questo conveniamo), vorremmo sapere quali furono gli eroi dell'antirisorgimento e delle masse popolari: forse i sicofanti che con le loro delazioni mandavano i patrioti – se questa parola ha ancora un senso – sulle forche, o i briganti sanfedisti di Calabria di Calabria e Lucania, che perfino gli spodestati Borboni finirono per ripudiare? “I padri della patria” […] forse non furono grandi padri, ma comunque lo furono di una patria che – oggi lo vediamo – non ne meritava e non poteva fornirne di migliori. […] Era fatale che, una volta allentatesi le maglie della Dc, l'integralismo di un certo mondo cattolico lo avrebbe portato a confluire sulle posizioni delle leghe. Le ispirazioni sono diverse, ma il nemico è comune: lo Stato unitario e laico. E questo l'infame da schiacciare in nome di un'Italia populista e invertebrata, un'Italia di parrocchie, anzi di “fochi”, di carrocci e di gonfaloni: l'Italia insomma del “Francia o Spagna – basta che se magna”, quale fu quella del prerisorgimento. Dileguatosi, o in via di dileguarsi il pericolo comunista, e caduto quello di Berlino, è questo il Muro che ci dividerà nel prossimo futuro. Da che parte, nel nostro piccolo stiamo noi, mi sembra superfluo dirlo. Ci stiamo, sia chiaro, con la piena consapevolezza dei nostri errori passati e presenti e della nostra intrinseca debolezza. Ma anche con la coscienza che se con noi non c'è tutto il meglio, contro di noi c'è sicuramente tutto il peggio. 28 28 Si tratta di una replica ad alcune tesi espresse durante meeting di Comunione e liberazione I. Montanelli – Se questa è storia, in “Il Giornale”, 1 settembre 1990. Citato anche nell'antologia di articoli montanelliani La stecca nel coro.1974-1994: una battaglia contro il mio tempo, Rizzoli, 2000, pag. 40-41. Sul rapporto tra Montanelli e l'ideologia risorgimentale, vedi anche S. Gerbi e R. Liucci – Montanelli l'anarchico borghese, Einaudi, 2009. Così si esprimono i due autori “Sin dall'89, anno in cui il leghismo comincia ad acquistare visibilità sulla stampa, non si contano i sarcasmi di Montanelli su Bossi e la sua scarsa frequentazione del sapone, della grammatica e dei manuali di galateo. Certo, ammette Indro, le Leghe sono il sintomo di malattie profonde e radicate: lo sperpero di risorse nel Mezzogiorno, la furia lottizzatrice dei partiti, il parassitismo di certa burocrazia romana, il degrado figlio dell'immigrazione incontrollata dal Sud del mondo. E tuttavia il rimedio proposto – lo smembramento dello Stato è più nefasto dei mali da sanare”. p. 175-176 51 BIBLIOGRAFIA In ordine di citazione G. Tomasi di Lampedusa – Il Gattopardo, Istituto geografico De Agostini, 1985 (edizione originale Feltrinelli, 1958) A. Carioti - Maledetti Azionisti, Editori Riuniti, Roma, 2001 D. Mack Smith – Cavour. Il grande tessitore dell'Unità d'Italia, edizione speciale per “Il Giornale” (prima edizione Rcs Libri, 1985) G. Carocci – Destra e sinistra nella storia d'Italia, Laterza, Bari, 2002 S. Romano, Libera Chiesa. Libero Stato? Il Vaticano e l'Italia da Pio IX a Benedetto XVI, Longanesi e C., Milano, 2005 D. Mack Smith – Mazzini, Rcs Libri, Milano, 2002 G. Spadolini – Giolitti e i cattolici, Oscar Studio Mondadori, 1974 G. Ansaldo – Il Ministro della buona vita, Casa Editrice Le Lettere Firenze, 2002 E. Gentile – Le origini dell'Italia contemporanea. L'età giolittiana, Laterza, 2003 A.Tarquini – Il Gentile dei fascisti, Il Mulino, 2009 F. Lanchester, La rappresentanza in campo politico, Giuffrè, 2006 52 G. Accame – Socialismo tricolore, Editoriale Nuova, 1983 A.A. V.V. Antologia di una rivista scomoda (a cura di G. Carocci), Editori Riuniti, 1997, Roma M. Veneziani – La rivoluzione conservatrice in Italia, Sugarco Edizioni, 1994 I. Montanelli – La stecca nel coro. 1974-1994: una battaglia contro il mio tempo, Rizzoli, 2000 S. Gerbi e R. Liucci – Montanelli l'anarchico borghese, Einaudi, 2009 53 Curriculum del concorrente DATI ANAGRAFICI Nome: Saro Cognome: Freni Residenza: Via 27 luglio, 76 - Messina Domicilio: Via Arturo Danusso, 23 - Roma Luogo e data di nascita: Messina, 26 Marzo 1985 FORMAZIONE • Diploma di maturità presso il Liceo scientifico statale “Archimede” di Messina nel corso sperimentale linguistico Brocca, con la votazione di 100/100 con menzione • Diploma di spagnolo conseguito presso l'“Istituto Cervantes”, livello iniziale, nella sessione di aprile 2003, con la votazione di 95,64/100 • Laurea triennale in Scienze politiche, conseguita presso l'”Università degli Studi di Messina” con la votazione di 100/100 • Iscritto alla facoltà di Scienze politiche presso l'Università “La Sapienza” di Roma, corso di laurea magistrale • Ha frequentato le scuole estive di Eurolab-Laboratorio d'Europa nel 2007, in Romania, e nel 2008, a Messina LINGUE CONOSCIUTE • Inglese • Francese • Spagnolo 54 INDICE Introduzione...........................................................................................1 Festeggiare?...........................................................................................4 Che cosa è rimasto del Risorgimento?.................................................22 Risorgimento e Seconda Repubblica...........................................36 La Lega contro l'Unità d'Italia....................................................40 Gli altri partiti e la tradizione unitaria.......................................43 La presidenza Ciampi: un nuovo patriottismo............................49 Conclusioni..........................................................................................50 Bibliografia..........................................................................................52 Curriculum del concorrente.................................................................54 55
Scaricare