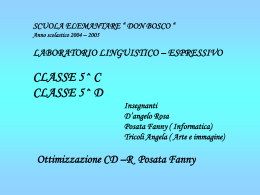Presentazione È un inverno che non dà scampo quello che avvolge nel gelo e nella neve il piccolo paese di St. Andrew, nel Maine, a pochi chilometri dal confine canadese. È notte e la foresta ghiacciata pare sussurrare nell’oscurità. Luke, giovane medico di turno al pronto soccorso, si ritrova davanti una ragazza dall’apparente età di diciannove anni e dalla bellezza eterea e struggente. È atterrita e chiusa nel silenzio, ma i suoi occhi sembrano gridare. Ha appena ucciso un uomo, abbandonandone il cadavere nel bosco. Si chiama Lanny e, con voce appena udibile, sostiene di aver ucciso quell’uomo perché era stato lui a chiederglielo. Prega Luke di aiutarla a scappare. Quando il dottore rifiuta, Lanny afferra un bisturi e si squarcia il petto nudo. Quello che succede dopo cambierà le loro vite per sempre. Luke, sconvolto, accetta di aiutarla a scappare oltre confine. E durante la fuga, lei gli rivela il proprio passato. Lanny è immortale e ha più di duecento anni. Il suo è il racconto di una donna travolta da un amore torbido, appassionato e mai ricambiato abbastanza. È il racconto di un uomo ossessionato dalla bellezza e dal bisogno oscuro di possederla, un uomo che trasforma la passione fisica in uno strumento di dominio. È il racconto del terribile prezzo da pagare in cambio della vita eterna. ALMA KATSU è nata in Alaska, ma è cresciuta in un piccolo paese del Massachusetts. Il suo lavoro di profiler della CIA la ispira nell’indagine dei meandri, a volte oscuri, dell’animo umano. Immortal è il suo primo romanzo. Immortal Agartha 269 Nota dell’Autrice Immortal è un’opera di fantasia, perciò non credo che i lettori vi si accostino attendendosi accuratezza storica. Tuttavia, vale la pena di segnalare almeno una delle libertà che mi sono presa. Non esiste una città chiamata St. Andrew nello Stato del Maine, ma se un lettore cercasse di localizzarla basandosi sugli indizi disseminati nel libro, scoprirebbe che se fosse reale sarebbe più o meno in corrispondenza del luogo in cui, al giorno d’oggi, si trova la città di Allagash. E secondo le testimonianze storiche, non vi fu alcun insediamento abitativo in quella zona fino al 1860 circa. Tuttavia, la città acadiana di Madawaska, non molto lontana, fu fondata nel 1785: ecco perché ho ritenuto di non discostarmi troppo dalla realtà immaginando che Charles St. Andrew avesse fondato la sua città in quegli anni. Parte I 1 Maledetto gelo. Il fiato di Luke Findley rimane sospeso nell’aria, quasi solidificato, come un nido di vespe congelato, privato di tutto l’ossigeno. Le mani stringono con forza il volante; è ancora insonnolito, si è svegliato appena in tempo per correre all’ospedale a fare il turno di notte. Intorno a lui, i campi coperti di neve sembrano fantasmi dai riflessi bluastri sotto la luce della luna, blu come labbra insensibili per l’ipotermia. La neve è così alta che copre ogni traccia dei ceppi e dei rovi che solitamente infestano i campi fino a soffocarli. Sembra tutto in pace, pieno di quiete, ma è soltanto un’impressione ingannevole. Spesso Luke si è chiesto perché i suoi compaesani si ostinino a rimanere in quella punta estrema a nord del Maine. È un posto desolato, gelido, dove è quasi impossibile coltivare la terra. L’inverno regna per metà dell’anno, la neve si accumula e arriva fino ai davanzali delle finestre, e un vento gelido sferza i campi di patate abbandonati. Di tanto in tanto, capita che qualcuno muoia assiderato e siccome Luke è uno dei pochi dottori della zona ne ha già visti parecchi, di casi di congelamento. Un ubriaco (e a St. Andrew non ne mancano) si addormenta accasciato contro un cumulo di neve e la mattina dopo è diventato un ghiacciolo umano. Un ragazzo che pattina sul fiume Allagash incappa in una zona in cui il ghiaccio è troppo sottile per sostenere il suo peso. A volte, il corpo viene ritrovato a metà strada verso il Canada, alla confluenza fra l’Allagash e il St. John. Un cacciatore viene accecato dalla neve e non riesce più a trovare il sentiero che lo porti fuori dai grandi boschi a nord e il suo corpo viene ritrovato seduto contro un tronco, il fucile abbandonato in grembo. Non è stato un incidente, aveva detto disgustato a Luke lo sceriffo, Joe Duchesne, quando il corpo del cacciatore era stato portato in ospedale. Il vecchio Ollie Ostergaard voleva morire. È stato soltanto il suo modo di suicidarsi. Luke sospetta che se fosse stato vero, Ostergaard si sarebbe semplicemente sparato in testa. Morire per ipotermia è un processo lento: c’è tutto il tempo per ripensarci. Luke parcheggia il suo furgoncino in un posto libero di fronte all’ospedale, spegne il motore e intanto si ripromette, per l’ennesima volta, di andarsene via da St. Andrew. Non deve far altro che vendere la fattoria dei suoi genitori e poi sarà pronto per trasferirsi. Anche se non ha ancora idea di dove. Luke sospira, come d’abitudine, estrae le chiavi dal blocchetto di accensione e si dirige verso l’entrata del pronto soccorso. «Ciao, Luke» lo saluta l’infermiera di turno. Lui le passa davanti, sfilandosi i guanti. Appende il parka nell’angusta sala dello staff medico e ritorna all’accettazione. Judy lo blocca. «Ha chiamato Joe. Sta portando qui un prigioniero, vuole che tu gli dia un’occhiata. Dovrebbe arrivare da un momento all’altro.» «Un camionista?» Quando capita qualche guaio, di solito c’è di mezzo uno dei camionisti delle ditte di trasporto tronchi. Ogni due per tre vanno al Blue Moon, si ubriacano e poi scoppia la rissa. «No.» Judy è distratta, sta facendo chissà che davanti al computer. La luce del monitor si riflette sulle sue lenti bifocali. Luke si schiarisce la voce per richiamare la sua attenzione. «Di che si tratta allora? Qualcuno di qui?» Luke è stufo marcio di ricucire e rammendare i suoi compaesani. Sembra quasi che solo gli ubriachi, i rissosi e i disadattati riescano a sopportare di vivere in quella città dimenticata da Dio. Judy finalmente alza lo sguardo dal monitor, puntandosi i pugni contro i fianchi. «No, stavolta è una donna. E non è di qui.» Strano. Capita molto raramente che la polizia porti in ospedale delle donne, e di solito quando succede vuol dire che sono le vittime. Una moglie dopo una litigata col marito. O, d’estate, una turista che si ficca in qualche guaio al Blue Moon. Ma in quel periodo dell’anno è impossibile che si tratti di una turista. Per lo meno è qualcosa di diverso: la notte sembra più promettente, così. Luke prende una cartellina. «Va bene. Che altro abbiamo?» Ascolta distrattamente Judy che fa il riepilogo di quanto è successo durante il turno precedente. È stata una serata indaffarata, ma in quel momento, alle dieci di sera, tutto è quieto. Piuttosto che ascoltare l’ennesimo aggiornamento sui preparativi del matrimonio della figlia di Judy, Luke torna nella saletta ad aspettare da solo lo sceriffo. Non ne può più di lezioni sul costo dei vestiti da sposa, del catering, dei fioristi. Dille di scappare, aveva suggerito Luke a Judy, una volta, e lei l’aveva squadrato come se lui avesse confessato di essere un terrorista. Per una ragazza, il matrimonio è il giorno più importante della vita, aveva sbottato Judy. Tu non sai neanche che cosa voglia dire romanticismo, vero? Non mi sorprende che Tricia ti abbia chiesto il divorzio. Lui aveva smesso di precisare ogni volta che non era stata lei a chiedere il divorzio, ma lui. Tanto nessuno lo ascoltava. Luke sprofonda nel malconcio divanetto e cerca di svagarsi con un Sudoku. Ma non può fare a meno di ripensare al tragitto appena compiuto per arrivare in ospedale: le case affacciate sulle strade deserte, qualche luce solitaria che brilla nella notte. Ma cosa fa quella gente chiusa in casa nelle lunghe ore d’inverno? Siccome è il medico del paese, non ci sono segreti per Luke. Conosce ogni vizio: sa chi picchia la moglie e chi ha la mano pesante coi figli. Chi beve troppo e finisce col camioncino contro un banco di neve. Chi ha una depressione cronica, sfinito dall’ennesima annata senza raccolto, privo di prospettive future. I boschi attorno a St. Andrew sono fitti di misteri oscuri. E ricordano a Luke perché voglia così disperatamente andarsene da quel posto. È stufo marcio di conoscere tutti quei segreti. E non sopporta più che tutti sappiano il suo. E poi c’è quell’altra cosa, quella a cui ultimamente pensa ogni volta che entra in ospedale. Non è passato molto tempo dalla morte di sua madre e ricorda ancora perfettamente la notte in cui la trasferirono nel reparto che, con un eufemismo evidente, chiamavano «l’ospizio»: stanze piene di pazienti ormai troppo vicini alla fine per poterli trasferire senza rischi al centro di riabilitazione di Fort Kent. Le funzioni cardiache erano scese sotto il dieci per cento e ogni respiro le costava uno sforzo immane, anche con la maschera d’ossigeno. Era rimasto seduto accanto a lei tutta la notte, da solo perché ormai tutti gli altri visitatori se n’erano andati a casa. Quando lei aveva avuto l’ultimo arresto cardiaco, lui le stava stringendo la mano. Era ormai sfinita e si era irrigidita per un solo brevissimo istante, poi la sua stretta si era allentata ed era scivolata via in silenzio, come il tramonto diventa notte. L’allarme si era attivato subito: l’infermiera di turno era entrata, ma Luke l’aveva allontanata con un cenno dalle apparecchiature e le aveva spente, quasi sovrappensiero. Poi, con lo stetoscopio che teneva al collo, le aveva controllato battiti e respirazione. Se n’era andata. L’infermiera gli aveva chiesto se desiderasse rimanere un po’ da solo e lui aveva detto di sì. Era da una settimana che rimaneva nel reparto di terapia intensiva con sua madre, giorno e notte, e ora gli sembrava impossibile, ingiusto, andarsene e lasciarla lì. Così, rimase seduto accanto al suo letto con lo sguardo perso nel nulla, o comunque lontano dal corpo nel letto, e intanto cercò di pensare alle prime cose da fare. Doveva avvertire i parenti: erano tutti agricoltori che vivevano nella parte meridionale del paese... Chiamare padre Lymon alla chiesa cattolica, la chiesa che lui non riusciva più a frequentare... Scegliere una bara... Troppi dettagli che richiedevano la sua attenzione. Sapeva benissimo che cosa avrebbe dovuto fare nei giorni seguenti perché ci era già passato appena sette mesi prima, quando era morto suo padre. Ma il pensiero di dover riaffrontare tutto da capo lo sfiniva. Era in momenti come quello che sentiva di più la mancanza della sua ex moglie. Tricia era un’infermiera ed era sempre stata un sostegno per lui nei momenti difficili. Era una persona stabile e concreta, non perdeva mai la testa neanche di fronte agli eventi più dolorosi. Ma ormai era inutile desiderare che le cose stessero in maniera diversa. Ormai era da solo e avrebbe dovuto risolvere tutto così: da solo. Arrossì per la vergogna ripensando a sua madre, a come lei avrebbe tanto voluto che lui e Tricia rimanessero insieme, a come l’aveva rimproverato per averla lasciata andare. Lanciò uno sguardo colpevole alla madre morta di fianco a lui. Aveva gli occhi aperti. Ma solo un minuto prima erano chiusi. Luke sentì una stretta al cuore, un brivido di speranza anche se sapeva benissimo che non significava nulla. Si trattava soltanto di un impulso elettrico che aveva attraversato i nervi a mano a mano che le sue sinapsi avevano smesso di funzionare, come una macchina che scoppietta dal tubo di scappamento mentre le ultime gocce di benzina alimentano il motore. Allungò la mano e glieli chiuse. Si riaprirono una seconda volta, naturalmente, come se sua madre si stesse svegliando. Luke fu sul punto di balzare in piedi, terrorizzato, ma riuscì a reprimere l’impulso. In realtà, non era terrore, ma sorpresa. Riprese lo stetoscopio, si chinò su di lei e le poggiò la membrana sul petto. Silenzio. Nessun rumore di sangue che scorre nelle vene, nessuna eco di respiro. Le prese il polso. Non c’era battito. Controllò l’orologio: erano passati quindici minuti da quando aveva dichiarato morta sua madre. Lasciò andare la mano, riappoggiandogliela sulle lenzuola, e intanto continuò a fissarle gli occhi aperti. Aveva la distinta impressione che lei ricambiasse il suo sguardo, che i suoi occhi fossero puntati su di lui. E poi, di colpo, la mano di sua madre si alzò dal lenzuolo e lo cercò. Si aprì verso di lui, col palmo rivolto verso l’alto, invitandolo a stringergliela. E lui lo fece, chiamandola per nome, ma subito dopo averla afferrata la lasciò andare. Era fredda e senza vita. Luke si allontanò dal letto, strofinandosi la fronte, chiedendosi se avesse le allucinazioni. Quando si voltò a guardarla, lei era immobile, gli occhi chiusi. Luke aveva il cuore in gola, il respiro mozzato. Ci vollero tre giorni prima che si decidesse a parlare con un altro dottore di quello che era successo. Scelse il vecchio John Mueller, un medico generico dall’atteggiamento molto pragmatico, noto perché aiutava a far nascere i vitelli del vicino. Mueller gli lanciò uno sguardo scettico, come se sospettasse che Luke avesse bevuto un po’ troppo. Dita dei piedi o delle mani che hanno spasmi, sì, può succedere, disse, ma quindici minuti dopo la morte? Movimenti muscolo-scheletrici completi? Mueller squadrò ancora una volta Luke: era come se ci fosse da vergognarsi soltanto a parlarne, di cose come quelle. Credi di averlo visto perché volevi vederlo. Non volevi che lei fosse davvero morta. Luke sapeva che non era così. Ma decise di non sollevare mai più la questione, non con altri dottori almeno. E comunque, aveva insistito Mueller, che differenza farebbe? Il corpo si è mosso un po’, e quindi? Credi che lei stesse cercando di dirti qualcosa? Credi davvero in tutte quelle sciocchezze della vita dopo la morte? Ripensarci ora, quattro mesi dopo, provoca a Luke ancora dei brividi che gli scorrono gelidi lungo le braccia. Riappoggia il libro dei Sudoku sul tavolino e si massaggia il cranio con la punta delle dita, cercando di schiarirsi le idee. La porta dello studiolo si apre, una sottile fessura da cui spunta la voce di Judy: «Joe sta parcheggiando qui davanti». Luke esce senza il parka, così che il freddo lo svegli del tutto. Osserva Duchesne avvicinarsi al cordone del marciapiede con il suo SUV bianco e nero, lo stemma della polizia di Stato del Maine stampato sulle portiere anteriori e una minuscola sirena lampeggiante fissata sul tettuccio. Luke conosce Duchesne sin dai tempi della scuola. Non erano nella stessa classe, ma i loro percorsi si erano incrociati a lungo, tanto che Luke si era ritrovato davanti il volto magro da furetto con gli occhi piccoli e lucenti e il naso aguzzo di Duchesne per più di vent’anni. Tenendosi le mani sotto le ascelle per riscaldarle, Luke osserva Duchesne aprire la portiera posteriore e afferrare il prigioniero per un braccio. È curioso di vedere chi abbiano ammanettato stavolta. Si aspetta di trovarsi di fronte una motociclista massiccia e mascolina, col volto arrossato e un labbro spaccato, e lo sorprende invece vedere che si tratta di una ragazza piuttosto minuta. Forse addirittura un’adolescente. Esile come un ragazzino, ma con dei lineamenti molto aggraziati e una capigliatura folta e riccia come quella di un cherubino. Guardando la donna (o ragazza?) Luke prova uno strano formicolio, un mormorio dietro gli occhi. Il battito accelera quasi come se la... riconoscesse? Ti conosco, pensa. Non sa il suo nome, forse, ma la conosce a un livello molto più fondamentale, intimo. Che cosa sta succedendo? Luke strizza gli occhi, osservandola più attentamente. L’ho già vista da qualche parte? No. Si sta sbagliando. Mentre Duchesne la sospinge per un braccio, allacciato all’altro da un paio di manette di plastica, sopraggiunge una seconda auto della polizia, e un altro agente, Clay Henderson, scende e prende in consegna la prigioniera, accompagnandola dentro il pronto soccorso. Quando gli passano davanti, Luke nota che la camicia della prigioniera è inzuppata da un liquido nero che emana un odore per lui familiare, un odore salato e ferrigno. Sangue. Duchesne si avvicina a Luke, indicando l’altra coppia con un cenno del mento. «L’abbiamo trovata che camminava sul bordo della strada camionabile, verso Fort Kent.» «Era vestita così? Andava in giro senza cappotto, con questo freddo? Non poteva essere fuori da tanto tempo, allora.» «Direi di no. Senti, Luke, devi dirmi se è ferita e ha bisogno di cure. In caso contrario, la porto in centrale e finisce in cella.» Rispetto alla media dei poliziotti, Luke ha sempre pensato che Duchesne avesse la mano troppo pesante: ne ha visti di ubriachi portati dentro da lui in pessime condizioni, con evidenti lividi sul volto o bernoccoli in testa. Ma questa ragazza è poco più che un’adolescente, insomma. Che cosa poteva aver mai fatto di così terribile? «Perché l’avete fermata? La accusate di non portare il cappotto con questo freddo?» Duchesne lancia uno sguardo gelido a Luke. Non gli piace quando lo prendono in giro. «La ragazza è un’assassina. Ci ha confessato di aver pugnalato a morte un uomo e di aver abbandonato il suo corpo nei boschi.» Luke segue alla lettera la procedura, ma riesce a malapena a pensare a quello che sta facendo. La testa gli pulsa in modo insopportabile. Punta una luce negli occhi della prigioniera – sono dell’azzurro più chiaro che lui abbia mai visto, come due schegge di ghiaccio – per controllare la dilatazione delle pupille. La pelle della ragazza è appiccicosa al tatto, il battito è rallentato e respira con fatica. «È molto pallida» riferisce Luke a Duchesne, mentre si allontanano dalla barella cui la prigioniera è stata assicurata con dei lacci ai polsi. «Sembra cianotica, forse sta per entrare in stato di shock.» «Vuol dire che è ferita?» chiede Duchesne, scettico. «Non è detto. Potrebbe trattarsi di un trauma psicologico, forse dovuto a una colluttazione. Magari proprio con l’uomo che dice di aver ucciso. Come fai a essere sicuro che non si sia trattato di legittima difesa?» Duchesne insacca i pugni sui fianchi e fissa la prigioniera sulla barella, come se potesse strapparle la verità con la sola forza del suo sguardo. Sposta il peso da un piede all’altro. «Non sappiamo un bel niente... Non è che abbia detto molto. Non puoi semplicemente controllare se ha qualche ferita? Perché se è illesa viene con me in centrale...» «Devo toglierle quella camicia e lavarle via tutto il sangue...» «Datti da fare, allora. Non posso star qui tutta la notte. Ho lasciato Boucher da solo nei boschi a cercare quel corpo.» Anche con la luce della luna piena, i boschi sono vasti e oscuri, e Luke sa bene che l’agente Boucher ha ben poche speranze di trovare quel cadavere da solo. Luke pizzica l’orlo del guanto di lattice che indossa per farlo aderire bene. «Allora vai a dare una mano a Boucher, così intanto io faccio gli esami del caso...» «Non posso lasciar qua da sola la prigioniera.» «Santo Dio, ma guardala» sbotta Luke, indicando con il capo la ragazza. «Non credo proprio che sia in grado di sopraffarmi e scappare. Se è questo che ti preoccupa, lascia qui Henderson.» Entrambi lanciano uno sguardo dubbioso verso Henderson. Il corpulento agente è appoggiato al bancone, sfoglia un vecchio numero di Sports Illustrated abbandonato nella sala d’aspetto, tenendo fra le mani una tazzina di caffè preso alla macchinetta. Ha la fisionomia di un orso dei cartoni animati e, allo stesso modo, ne ha l’identica indolenza amichevole. «Non ti sarebbe di molto aiuto nei boschi... Tranquillo, non succederà niente» dice Luke con impazienza, allontanandosi dallo sceriffo come se la decisione ormai fosse presa. Avverte lo sguardo di Duchesne perforargli la schiena, indeciso se mettersi a discutere con lui. Ma alla fine lo sceriffo si ritira in buon ordine, dirigendosi verso le doppie porte scorrevoli. «Tu resta qui con la prigioniera!» urla a Henderson, calcandosi il pesante cappello di pelliccia sul cranio. «Io torno ad aiutare Boucher. Quell’idiota non riuscirebbe a trovarsi il culo nemmeno con una mappa.» Luke e l’infermiera si dedicano alla donna sulla barella. Lui soppesa un paio di forbici. «Dovrò tagliarle la camicia per togliergliela» la avvisa. «Faccia pure. Ormai è rovinata» mormora lei, con un accento che Luke non riconosce. La camicia è evidentemente costosa, il tipo di capo d’abbigliamento che si vede sulle riviste di moda. Nessuno lo indosserebbe lì a St. Andrew. «Lei non è di queste parti, vero?» osserva Luke, cercando di ammorbidirla con qualche chiacchiera generica. Lei gli osserva il volto ancora una volta, come per valutare se può davvero fidarsi di lui – o almeno, questa è l’impressione che ne ha Luke. «A dire il vero, sono nata qui. Ma è successo molto tempo fa.» Luke sorride. «Molto tempo per lei, forse. Se fosse davvero nata qui, la conoscerei. Ho vissuto da queste parti per quasi tutta la mia vita. Come si chiama?» Lei non ci casca. «Non può conoscermi» si limita a rispondere, in tono piatto. Per qualche minuto l’unico suono che si sente è quello della stoffa bagnata che viene tagliata, con fatica, le punte acuminate delle forbici che si fanno strada lentamente attraverso il tessuto inzuppato. Una volta eseguito il taglio, Luke indietreggia per permettere a Judy di ripulire la ragazza con della garza bagnata d’acqua calda. Le strisce di sangue rosso si dissolvono, rivelando un petto magro e pallido. E senza nemmeno un graffio. L’infermiera appoggia il forcipe con la garza su un vassoio metallico, rumorosamente, e poi esce con sussiego dalla stanza, come se avesse sempre saputo che non avrebbero trovato niente e che Luke, ancora una volta, avrebbe fatto la figura dell’incompetente. Luke distoglie lo sguardo e porge alla ragazza un asciugamano di carta con cui coprirsi il petto. «Gliel’avrei detto che non ero ferita. Bastava chiedermelo» sussurra lei a Luke. «Allo sceriffo non l’ha detto, però» risponde Luke, prendendo uno sgabello. «No. Ma l’avrei detto a te.» Fa un cenno verso il dottore. «Hai una sigaretta? Muoio dalla voglia di fumare.» «Mi dispiace, non ne ho, non fumo» replica Luke. La ragazza lo guarda, i suoi occhi azzurri gli esplorano il volto. «Hai smesso tempo fa, ma hai ricominciato. Non che te ne faccia una colpa, visto tutto quello che hai passato di recente. Ma se non sbaglio hai un paio di sigarette nella tasca del camice.» Per pura reazione istintiva, Luke infila la mano nella tasca e le sente, sono proprio dove le aveva lasciate. Aveva soltanto tirato a indovinare ed era stata fortunata o gliele aveva viste in tasca? E che cosa intendeva con quel visto tutto quello che hai passato di recente? Sta soltanto facendo finta di leggergli i pensieri, sta soltanto cercando il modo di manipolarlo, come farebbe qualsiasi ragazza intelligente che si fosse cacciata in un bel guaio. E d’altronde, è assolutamente vero che la preoccupazione gli si legge in faccia, negli ultimi tempi. Non riesce a trovare un modo di raddrizzare la sua vita, tutto qui; i suoi problemi sono troppo legati l’uno all’altro, come ammucchiati. Per risolverne uno, dovrebbe risolverli tutti. «Qui è vietato fumare e, nel caso non se ne fosse accorta, lei è legata alla barella.» Luke fa scattare la punta della sua penna e prende una cartella. «Siamo un po’ a corto di personale stasera, quindi avrei bisogno che lei mi fornisse qualche dato per l’archivio dell’ospedale. Nome?» Lei fissa la cartella con circospezione. «Non mi va di dirlo.» «Perché? È scappata di casa? Per questo non me lo vuole dire?» Luke la osserva: è tesa, in guardia, ma perfettamente padrona di sé. Gli è già capitato di assistere pazienti coinvolti in morti accidentali e di solito sono in preda a crisi isteriche: piangono, tremano, gridano. Ma questa ragazza trema solo leggermente per il freddo, coperta com’è soltanto da un asciugamano di carta, e l’unico segno di nervosismo sono le gambe che ogni tanto hanno qualche scatto. Eppure basta guardarla in volto per capire che è sotto shock. E Luke avverte anche che se la sta prendendo a cuore; o forse qualcosa di più, qualcosa di alchemico fra di loro, come se lei lo stesse inducendo a chiederle di raccontargli le cose terribili che sono successe nel bosco. «Le va di dirmi cos’è successo stanotte?» le domanda alla fine, avvicinandosi alla barella. «Stava facendo l’autostop? Forse l’ha tirata su un uomo, quello nel bosco... e l’ha aggredita? E lei si è difesa?» Lei sospira e abbandona la testa sul cuscino della barella. «Niente del genere. Ci conoscevamo. Siamo venuti in città insieme. Lui...» Si blocca, come se le parole la strozzassero. «Lui mi ha chiesto di aiutarlo a morire.» «Eutanasia? Era un malato terminale? Cancro?» Luke è scettico. Chi vuole uccidersi di solito sceglie un metodo tranquillo e sicuro: veleno, pillole, il motore della macchina acceso e una canna da giardinaggio infilata nel tubo di scappamento. Non chiede a qualcuno di pugnalarlo a morte. Se il suo amico voleva davvero morire, gli sarebbe bastato rimanere sotto le stelle tutta la notte, fino all’assideramento. Luke lancia uno sguardo verso la donna: sta tremando, coperta soltanto dal velo di carta ospedaliera. «Aspetti, vado a prenderle un camice e una coperta. Sta morendo dal freddo.» «Grazie» dice lei, abbassando finalmente lo sguardo. Poco dopo, lui torna con una consunta gonna di flanella dall’orlo rosa e una coperta di pile azzurro bambino. Sono colori tipici del reparto maternità. Le osserva le mani, legate alla lettiga con lacci di nylon. «Va bene, slegherò una mano alla volta» dice, liberandole la mano più vicina al vassoio degli strumenti, dove giacciono un forcipe, delle forbici insanguinate e un bisturi. Veloce come una lepre, lei afferra il bisturi con la mano magra e affusolata. Lo punta verso di lui, lo sguardo folle, le narici arrossate e dilatate. «Ehi, vacci piano!» esclama Luke, allontanandosi quanto basta per uscire dal raggio d’azione del bisturi. «C’è un agente in fondo al corridoio. Se lo chiamo per te è finita, lo capisci? Siamo in due, non puoi farcela con un bisturi. Adesso calmati e mettilo giù...» «Non chiamarlo» dice lei, col braccio ancora teso. «Non farlo. Ho bisogno che tu mi ascolti.» «Ti ascolto.» La lettiga si trova tra Luke e la porta. Lei potrebbe tagliare il nylon e liberarsi l’altra mano nel tempo che gli ci vorrebbe per aggirarla e uscire. «Ho bisogno del tuo aiuto. Non posso finire in cella. Devi aiutarmi a scappare.» «Scappare?» Di colpo, Luke smette di preoccuparsi che la donna lo ferisca col bisturi. Prova soltanto un forte imbarazzo per aver abbassato la guardia, mettendosi in quella situazione. «Sei pazza? Non ho alcuna intenzione di aiutarti a scappare!» «Ascoltami, ti prego...» «Hai ucciso un uomo stanotte. L’hai confessato tu stessa. Non posso aiutarti a scappare.» «Non è stato un omicidio. Voleva morire, te l’ho detto.» «Ed è venuto qui a farsi ammazzare perché anche lui è cresciuto qui?» «Sì» dice lei, un po’ sollevata. «Allora dimmi chi è, magari lo conosco.» Lei scuote la testa. «Te l’ho detto, non ci conosci. Nessuno qui ci conosce.» «E tu come fai a saperlo? Forse conosciamo qualcuno dei tuoi parenti...» «La mia famiglia non vive a St. Andrew da molto, molto tempo.» Sembra esausta. Ma d’improvviso scatta. «Credi di sapere tutto, eh? Va bene. Mi chiamo McIlvrae. Conosci qualcuno con questo cognome? E l’uomo nella foresta si chiama St. Andrew.» «St. Andrew come il paese?» «Esattamente, come il paese» risponde lei con aria di sfida. Luke avverte una strana sensazione dietro agli occhi, come un sobbollire di qualcosa che sta venendo a galla. Non è un ricordo, non ancora... Dove l’ha visto quel cognome, McIlvrae? È certo di averlo già sentito o visto da qualche parte, ma non riesce ad afferrare il ricordo. «Non c’è nessuno di nome St. Andrew qui da, oh, almeno cent’anni» precisa Luke, infastidito dall’aria saccente di quella ragazza che insiste ad affermare di essere nata lì, ostinandosi in una menzogna che non può certo aiutarla in quella situazione. «Dai tempi della guerra civile, a quanto mi hanno detto.» Lei agita il bisturi verso di lui per attirare la sua attenzione. «Ascolta, non sono certo pericolosa. Se mi aiuti a scappare, non farò del male a nessuno.» Gli parla come a un bambino che non intenda sentire ragioni. «Voglio mostrarti una cosa.» Poi, senza preavviso, punta il bisturi verso di sé. E si incide un profondo taglio nel petto. Un lungo taglio che parte dal seno sinistro e le arriva al costato, sotto il seno destro. Per un attimo, Luke resta impietrito. Il taglio si riempie di rosso, il sangue comincia a sgorgare, i tessuti carnosi iniziano a fuoriuscire dalla ferita. «Oddio.» Cosa diavolo c’è che non va in quella ragazza? Ma è pazza? O è solo istinto suicida? Luke si riscuote dallo stupore e si avvicina alla lettiga. «Indietro! Stai indietro» sbotta lei, agitandogli contro il bisturi. «Devi soltanto guardare. Voglio che guardi.» Lei sporge il petto, allargando le braccia come per offrirgli una vista migliore, ma Luke vede benissimo. Solo che non riesce a credere ai propri occhi. I margini della ferita si stanno avvicinando, come viticci, ricongiungendosi, riallacciandosi. Il taglio ha cessato di sanguinare e si sta rimarginando. La ragazza respira affannosamente ma a parte questo non mostra alcun segno di sofferenza. Luke non è più sicuro di essere sveglio, in piedi sul pavimento. Quello che sta osservando è impossibile. Impossibile! Cosa dovrebbe pensare? Sta impazzendo o sta sognando, addormentato sul divanetto nella sala dei dottori? Qualsiasi cosa stia succedendo, la sua mente rifiuta di accettarlo e inizia a chiudersi in se stessa. «Che cosa...» mormora appena percettibilmente. Ricomincia a respirare, il petto che si gonfia e si sgonfia freneticamente, il volto arrossato. Avverte un conato di vomito. «Non chiamare il poliziotto. Ti spiegherò tutto, te lo giuro, ma non chiamare aiuto. Okay?» Luke barcolla. D’un tratto, il silenzio del pronto soccorso lo avvolge. Non è nemmeno più certo che ci sia ancora qualcuno da chiamare. Dov’è Judy, dov’è il poliziotto? È come se la fata della bella addormentata fosse entrata di soppiatto in quell’ala dell’ospedale e avesse lanciato un incantesimo facendo scivolare tutti quanti nel sonno più profondo. Oltre la porta della saletta c’è il buio, le luci vengono abbassate durante il turno di notte. I rumori sempre presenti – l’eco delle risate di un programma televisivo, il ticchettio metallico del distributore di bevande – sono scomparsi. Non si sente il ronzio della lucidatrice che lentamente percorre i corridoi deserti. Ci sono soltanto Luke e la sua paziente e il suono attutito del vento che sferza le pareti e le vetrate dell’ospedale, cercando di aprirsi una strada. «Che cos’è stato? Come hai fatto?» le chiede Luke, incapace di nascondere l’orrore nella propria voce. Si rimette sullo sgabello per non accasciarsi sul pavimento. «Che cosa sei tu?» Quell’ultima domanda sembra colpirla come un pugno allo sterno. Lei china il capo e i riccioli biondi le nascondono il viso. «Questa... Questa è l’unica cosa che non so spiegarti. Non so più che cosa sono. Non ne ho idea.» È impossibile. Cose come quella che ha appena visto semplicemente non succedono. Non c’è nessuna spiegazione plausibile. Si tratta di una mutante? È fatta di un materiale sintetico autoriparante? È forse una specie di... mostro? Eppure sembra normale, pensa il dottore, e il cuore prende di nuovo ad accelerare e il battito gli rimbomba nelle orecchie. Il pavimento di linoleum comincia a ondeggiare sotto i suoi piedi. «Io e lui siamo tornati qui perché questo posto ci mancava. Sapevamo che tutto sarebbe stato diverso, che non avremmo visto nessuno di quelli che conoscevamo perché se ne sono andati tutti, ma sentivamo la mancanza di quello che avevamo una volta» spiega la donna con tono malinconico, lo sguardo perso oltre il dottore, come se parlasse da sola. La sensazione che lui aveva provato quando l’aveva vista per la prima volta quella sera – il formicolio, il mormorio dietro gli occhi – li unisce ancora, facendo vibrare l’aria di una sottile corrente elettrica. Vuole sapere. «Va bene» dice con voce tremante, le mani strette alle ginocchia. «È una follia, ma... Vai avanti. Ti ascolto.» Lei trae un profondo respiro e chiude gli occhi per un momento, come se stesse per tuffarsi sott’acqua. E poi inizia. 2 Territorio del Maine, 1809 L’inizio è l’unica cosa che ha senso, per me, quindi è dall’inizio che partirò. Lo conservo scolpito nella memoria, per paura che vada perduto nel corso del mio viaggio, nell’infinito svolgersi del tempo. Il mio primo ricordo chiaro e distinto di Jonathan St. Andrew risale a un’assolata domenica mattina. Eravamo in chiesa. Lui era seduto in fondo al banco riservato alla sua famiglia, nelle prime file. A quel tempo aveva solo dodici anni, ma era già alto come gli uomini del villaggio. Alto quasi come suo padre, Charles, l’uomo che aveva fondato il nostro piccolo insediamento. Mi avevano raccontato che, un tempo, Charles St. Andrew era stato un ardito capitano dell’esercito, ma ora era un uomo di mezz’età con un ventre prominente, da benestante. Jonathan non seguiva con particolare attenzione la funzione, ma del resto molto probabilmente ben pochi di noi la seguivano. La messa domenicale durava almeno quattro ore, e arrivava a otto se il prete si sentiva particolarmente ispirato ed eloquente, quindi nessuno avrebbe potuto affermare in tutta onestà di aver ascoltato con devozione ogni parola del sacerdote. Nessuno, tranne forse la madre di Jonathan, Ruth, seduta al suo fianco sulla panca grezza dallo schienale rigido. Ruth veniva da una famiglia di teologi di Boston e avrebbe rimproverato a dovere il pastore Gilbert se il suo sermone non fosse stato sufficientemente rigoroso. Per lei, tutte le anime erano a rischio, e senza alcun dubbio le anime di quella cittadina sperduta nelle terre selvagge, lontane dall’influenza benefica della civiltà, correvano rischi ancor maggiori. In ogni caso, Gilbert non era un fanatico e di solito il suo limite erano quattro ore, quindi sapevamo tutti che presto saremmo stati congedati e saremmo potuti uscire a goderci il sole di quel meraviglioso pomeriggio. Osservare Jonathan con adorazione: era questo il passatempo preferito dalle ragazze del villaggio. Ma quella particolare domenica era lui a guardare: non faceva niente per nascondere i suoi sguardi verso Tenebraes Poirier. Non le staccava gli occhi di dosso da almeno dieci minuti: i suoi occhi castani e ferini erano puntati sul viso grazioso di Tenebraes e sul suo collo da cigno, ma soprattutto sul suo seno, che a ogni respiro andava a gonfiare lo stretto calicò del suo corpetto. Evidentemente non lo turbava per nulla il fatto che Tenebraes avesse diversi anni in più di lui e che fosse stata promessa a Matthew Comstock sin da quando ne aveva soltanto sei. Sarà amore? Me lo chiesi guardandolo dall’alto della balconata, dove io e mio padre sedevamo insieme alle altre famiglie povere. Quella domenica eravamo solo io e mio padre; il resto della mia famiglia era alla chiesa cattolica dall’altra parte del villaggio, a praticare la fede di mia madre, che proveniva da una colonia acadiana su a nordest. La guancia appoggiata all’avambraccio, tenevo gli occhi incollati su Jonathan, con la devozione che solo una ragazzina perdutamente innamorata sa mostrare. A un certo punto, mi parve perfino che Jonathan non si sentisse bene, poiché deglutiva con difficoltà. Finalmente staccò lo sguardo da Tenebraes, che sembrava essere ignara dell’effetto che aveva sul figlio prediletto del villaggio. Se Jonathan era davvero innamorato di Tenebraes, allora tanto valeva che mi gettassi dalla balconata, davanti a tutti i miei compaesani. Perché anche se avevo soltanto dodici anni sapevo con certezza assoluta di amare Jonathan con tutto il mio cuore; sapevo che se non avessi potuto trascorrere tutta la mia vita con lui, tanto valeva rinunciare alla vita stessa. Aspettai la fine della messa, seduta tranquilla a fianco di mio padre, con il cuore che mi martellava il petto, le lacrime che mi riempivano gli occhi, continuando a ripetermi che ero una mammoletta, che non dovevo preoccuparmi per qualcosa che probabilmente non significava niente. Quando la messa finì, mio padre, Kieran, mi prese per mano e mi accompagnò giù dalle scale per raggiungere i nostri vicini sul prato. Era una sorta di ricompensa per aver sopportato tutta quanta la messa: l’opportunità di parlare con i vicini, di avere un po’ di svago dopo sei giorni di lavoro duro e monotono. Per alcuni, era l’unica occasione di contatto umano, a parte la famiglia, in tutta la settimana, l’unica occasione per sentire le ultime novità e per spettegolare. Io rimasi dietro mio padre, che chiacchierava con un paio di vicini, e sbirciai da dietro le sue gambe per vedere se individuavo Jonathan, sperando in cuor mio di non vederlo con Tenebraes. Era vicino ai suoi genitori, da solo, lo sguardo impietrito e fisso sulle loro nuche. Era chiaro che non vedeva l’ora di andarsene, ma tanto valeva sperare che nevicasse a luglio: le chiacchiere dopo la messa duravano di solito minimo un’ora, anche più se il tempo era clemente come quel giorno, e i più coriacei avrebbero dovuto essere praticamente trascinati via con la forza. In più, suo padre era doppiamente gravato dall’impegno perché molti degli uomini del villaggio aspettavano proprio la domenica per parlare con l’uomo che era proprietario delle loro case, o che comunque era in posizione tale da poter migliorare in qualche modo la loro sorte, se lo avesse voluto. Povero Charles St. Andrew, soltanto molti anni dopo avrei capito il peso che gli toccava portare. Dove trovai il coraggio di fare quello che feci in quel momento? Forse fu la disperazione, la determinazione a non lasciare Jonathan a Tenebraes, che mi spinse ad allontanarmi silenziosamente da mio padre. Quando mi fui assicurata che non avesse notato la mia assenza, mi affrettai ad attraversare il prato per raggiungere Jonathan, sgusciando fra i crocchi di adulti in chiacchiera. Ero minuta a quell’età, e bastavano le voluminose gonne delle mie compaesane per nascondermi alla vista di mio padre. Finalmente, arrivai al cospetto di Jonathan. «Jonathan. Jonathan St. Andrew» lo chiamai, ma le mie parole suonarono orrendamente stridule. I suoi meravigliosi occhi scuri si posarono su di me, su di me soltanto, per la prima volta, e il mio cuore perse un battito. «Sì? Che cosa vuoi?» Che cosa volevo? Ora che finalmente avevo ottenuto la sua attenzione, non sapevo proprio cosa dirgli. «Sei una McIlvrae, vero?» disse Jonathan, con diffidenza. «Nevin è tuo fratello.» Arrossii ricordando l’accaduto. Perché non ci avevo pensato prima di avvicinarmi a lui? La primavera precedente, Nevin aveva teso un agguato a Jonathan davanti al droghiere e gli aveva fatto sanguinare il naso prima che alcuni adulti li separassero. Nevin nutriva un odio imperituro verso Jonathan, per ragioni che lui soltanto conosceva. Mio padre si era formalmente scusato con Charles St. Andrew per quella che era vista come una banale scaramuccia fra ragazzi, senza nulla di particolarmente inquietante. Quello che nessuno dei due padri sapeva era che Nevin avrebbe sicuramente ucciso Jonathan a mani nude se ne avesse avuto la possibilità. «Che cosa vuoi? È una delle trovate di Nevin, questa?» Sbattei le palpebre. «Io... Io volevo chiederti una cosa.» Ma non riuscivo a parlare in presenza di tutti quegli adulti. Era solo una questione di tempo, prima o poi i genitori di Jonathan si sarebbero accorti che c’era una ragazzina in mezzo a loro e si sarebbero chiesti che diavolo volesse da loro la figlia di Kieran McIlvrae e se i fratelli McIlvrae nutrissero davvero strane intenzioni nei confronti del loro Jonathan. Gli presi la mano con le mie. «Vieni con me.» Lo condussi attraverso la folla fin dentro al vestibolo vuoto della chiesa e, per ragioni che non saprò mai, lui mi seguì. Stranamente, nessuno notò che ce n’eravamo andati, nessuno ci urlò di fermarci impedendoci di andar via insieme. Nessun adulto ci seguì per farci da chaperon. Era come se anche il destino avesse cospirato affinché io e Jonathan potessimo vivere il nostro primo momento insieme da soli. Entrammo nel vestibolo, camminando sull’ardesia gelida, immergendoci nell’atmosfera appartata e tenebrosa di quel posto. Le voci di fuori sembravano lontanissime, ci giungevano solo mormorii e frammenti di conversazioni. Jonathan si agitò, confuso. «Allora, cos’è che vuoi dirmi?» mi chiese con una punta di impazienza. La mia intenzione era di chiedergli di Tenebraes. Volevo chiedergli di tutte le ragazze del villaggio, volevo sapere quali gli piacessero e se era stato promesso a una di loro. Ma non ci riuscii; le domande mi rimasero incastrate in gola e mi salirono le lacrime agli occhi. E così, per pura disperazione, mi avvicinai a lui e posai le mie labbra sulle sue. Capii la sua sorpresa dal modo in cui si tirò leggermente indietro, prima di riprendere il controllo della situazione. E a quel punto, fece qualcosa di totalmente inaspettato: ricambiò il mio bacio. Si chinò verso di me, afferrandomi le labbra con la sua bocca, inebriandomi del suo respiro. Fu un bacio violento, famelico, goffo. Fu migliore di quanto avessi mai sognato. Prima che avessi il tempo di spaventarmi, mi spinse contro il muro, la sua bocca sempre sulla mia, e si addossò a me finché non sentii qualcosa, tra le allacciature delle sue bretelle, sotto l’orlo della sua giacca. Emise un lamento, il primo lamento di piacere che sentii provenire da un’altra persona. Senza dirmi una parola, mi prese la mano e la portò in basso e lo sentii rabbrividire mentre emetteva un altro lamento. Ritirai di scatto la mano. Mi formicolava tutta. Lo sentivo ancora nel mio palmo. Stava ansimando, cercando di riprendere il controllo, non capiva perché mi fossi sottratta a lui. «Non era questo che volevi?» mi chiese osservandomi con preoccupazione in volto. «Mi hai baciato tu.» «Io...» Parlavo a scatti. «Io volevo solo chiederti... di Tenebraes...» «Tenebraes?» Indietreggiò, sistemandosi i vestiti. «Che cosa c’entra Tenebraes? Che differenza...» Si interruppe, forse perché aveva capito di essere stato osservato in chiesa. Scosse il capo, come per allontanare da sé la nozione dell’esistenza stessa di Tenebraes Poirier. «E tu come ti chiami? Che sorella McIlvrae sei?» Non potevo fargli una colpa della sua incertezza: ce n’erano tre. «Lanore» gli risposi. «Non è proprio un nome bellissimo, vero?» disse, senza rendersi conto che bastano poche parole per ferire a morte il cuore di un’adolescente. «Ti chiamerò Lanny, se non ti dispiace. Lanny, sei proprio un bel guaio di ragazza.» Il tono era scherzoso, per farmi capire che non era arrabbiato con me. «Non te l’ha detto nessuno che non sta bene provocare un ragazzo in questo modo? Specialmente uno che non conosci?» «Ma io ti conosco. Tutti ti conoscono» ribattei, allarmata che potesse ritenermi frivola. Lui era il figlio maggiore della famiglia più ricca e importante del villaggio, proprietaria della falegnameria che dava lavoro a tutti... Era ovvio che tutti lo conoscevano. «E poi, so di amarti. Sarò tua moglie, un giorno.» Jonathan alzò un sopracciglio, scettico. «Un conto è sapere come mi chiamo, ma come puoi essere certa di amarmi? Come puoi aver scelto proprio me? Non mi conosci per niente, Lanny, eppure vuoi essere mia.» Si lisciò la giacca un’altra volta. «Dovremmo tornar fuori prima che qualcuno venga a cercarci. E sarebbe meglio se non ci vedessero insieme, non credi? Vai tu per prima.» Per un secondo, rimasi immobile, sconvolta, in preda alla confusione. Sentivo addosso le tracce del suo desiderio di poco prima, il suo bacio, la mia mano stretta attorno a lui. E comunque, aveva frainteso totalmente: non avevo mai detto di voler essere sua. Gli avevo semplicemente comunicato che lui era mio. «Va bene» dissi, e la mia delusione doveva essere palese perché Jonathan mi rivolse il suo sorriso più smagliante. «Non preoccuparti, Lanny. Aspetta domenica prossima. Ci vedremo dopo la messa, te lo prometto. Forse riuscirò a convincerti a darmi un altro bacio.» A questo punto credo che dovrei raccontarti di Jonathan, del mio Jonathan. Solo così potrai capire perché ero così sicura della mia devozione. Era il primogenito di Charles e Ruth St. Andrew. I due furono così contenti di avere un figlio maschio che gli diedero subito un nome e lo battezzarono entro il primo mese, senza alcun timore, in un tempo in cui la maggior parte dei genitori non ci pensava nemmeno a dare un nome a un bambino prima che dimostrasse di avere qualche possibilità di sopravvivenza. Sua madre era ancora in convalescenza a letto quando suo padre organizzò una grande festa: vennero tutti gli abitanti del villaggio a bere punch al rum e tè zuccherato, e a mangiare torte e biscotti alla melassa; il padre ingaggiò un violinista acadiano, ci furono risate e musica. La festa fu organizzata talmente a ridosso della nascita del bambino che tutti pensarono che Charles stesse sfidando il diavolo: provaci a venire a prendere mio figlio! Provaci soltanto, e vedrai che cosa ti aspetta! E fu subito manifesto, fin dai primissimi giorni, che Jonathan era un bambino fuori dal comune. Eccezionalmente intelligente, eccezionalmente forte, eccezionalmente sano e, soprattutto, eccezionalmente bello. Le donne sedevano rapite accanto alla culla, si accapigliavano per tenere in braccio a turno quel perfetto fagottino di carne con tutti quei sottili e folti riccioli neri, fingendo che fosse loro. Anche gli uomini, fino al più duro e rude dei taglialegna che lavoravano alla falegnameria di St. Andrew, giungevano a una commozione insolita se si trovavano in presenza del bambino. Quando Jonathan raggiunse i dodici anni non c’era modo di negare che ci fosse qualcosa di soprannaturale in lui, e sembrava altrettanto immediato attribuire questa qualità soprannaturale alla sua bellezza. Era una meraviglia. Era la perfezione incarnata. Non c’erano molti di cui si potesse dirlo, a quel tempo, in quell’epoca; la gente finiva spesso sfigurata per le cause più diverse: il vaiolo, o un incidente, o un’ustione davanti al camino; oppure erano secchi secchi per la malnutrizione, sdentati a trent’anni, sgraziati per via di un osso rotto che non era stato steccato a dovere, con cicatrici, paralitici, scabbiosi per la scarsa igiene e, nella terra di boschi in cui vivevamo noi, privi di qualche arto per via del congelamento. Ma non c’era un solo segno a sfigurare Jonathan. Era diventato alto, dritto come un fuso, con le spalle ampie, maestoso come gli alberi sulla sua proprietà. La sua pelle era immacolata come panna appena montata. Aveva capelli neri lisci e dritti, lucenti come le ali di un corvo, e i suoi occhi erano scuri e profondi come gli abissi del fiume Allagash. Era una meraviglia per gli occhi. Ma è davvero una benedizione avere un ragazzo come Jonathan che vive nel tuo villaggio? Povere noi ragazze; prova a immaginare l’effetto che può avere un ragazzo come Jonathan sulle ragazze di un piccolo villaggio, in una conventicola di anime così ristretta che c’erano ben pochi altri svaghi ed era impossibile evitare di avere un qualsiasi contatto con lui. Era una tentazione onnipresente e impossibile da sfuggire. C’era sempre la possibilità di incrociarlo, mentre usciva dal droghiere o mentre attraversava un campo apparentemente per fare un’innocua commissione, ma in realtà messo sulla nostra strada dal diavolo in persona per fiaccare la nostra resistenza alle tentazioni. Non aveva nemmeno bisogno di essere presente per impossessarsi dei nostri pensieri: quando sedevamo a chiacchierare con le nostre sorelle o le nostre amiche, ricamando, prima o poi una raccontava a voce bassa dell’ultima volta in cui aveva posato lo sguardo su Jonathan. A quel punto lui era l’unico argomento di cui avremmo parlato. Forse eravamo in parte colpevoli noi stesse del sortilegio che ci attanagliava, perché nessuna di noi ragazze riusciva a smettere di essere ossessionata da lui, che fosse per un incontro casuale («Ti ha rivolto la parola? Cosa ti ha detto?» chiedevano le altre ragazze) o semplicemente per averlo intravisto in giro per il villaggio, così che anche un dettaglio insignificante come il colore del suo panciotto veniva discusso per ore infinite. Ma quello a cui in realtà pensavamo, tutte noi, era il modo in cui ti scrutava da capo a piedi con quell’impertinenza tutta sua, il modo in cui gli angoli delle sue labbra si incurvavano all’insù quando era assorto, e quanto ciascuna di noi avrebbe dato la vita pur di essere stretta fra le sue braccia almeno una volta, soltanto una. E non erano soltanto le ragazzine a subirne il fascino. Specialmente quando raggiunse l’adolescenza, a quindici, sedici anni, faceva sembrare gli altri uomini del villaggio tutti consunti, grezzi, troppo grassi o troppo secchi, e anche le mogli più irreprensibili cominciarono a guardarlo con occhi diversi. Si capiva dal modo in cui lo fissavano estasiate, lo sguardo famelico, le guance arrossate, le labbra mordicchiate, il suono eterno della speranza racchiuso in un sospiro improvviso. Lui aveva anche un’aura di indefinibile pericolosità che metteva addosso una voglia incontrollabile di toccarlo, come quando una vocina ti sussurra in testa di afferrare un ferro rovente. Sai che non potrai che uscirne ferita, ma non riesci a resistere. Devi provarlo sulla tua pelle. Non ti importa quello che succederà dopo, l’insopportabile dolore della carne lacerata, il morso implacabile del fuoco che ti assale ogni volta che sfiori la ferita. Quella cicatrice, che porterai per il resto della tua vita, marchierà a fuoco il tuo cuore. Assuefatta all’amore, non commetterai mai più la stessa imprudenza nello stesso modo. Sotto questo aspetto, io ero invidiata e insieme presa in giro: invidiata per tutto il tempo che trascorrevo insieme a Jonathan, presa in giro perché avevo chiarito a tutti che non c’era niente di sentimentale o romantico fra di noi. Questo non faceva che confermare alle altre ragazze che io non avevo abbastanza virtù femminili per suscitare l’interesse di un uomo. Ma io non ero diversa da loro. Sapevo benissimo che Jonathan aveva la capacità di darmi alle fiamme con un solo istante della sua attenzione, come carta avvicinata al fuoco. Una ragazza poteva essere annichilita in un istante di amore divino. La vera domanda era: ne valeva la pena? Potresti chiedermi se amavo Jonathan per la sua bellezza, e ti risponderei: è una domanda priva di senso, perché la sua grande, straordinaria bellezza era una parte inseparabile dal tutto. Gli conferiva la calma sicurezza di sé – che qualcuno avrebbe potuto ritenere sprezzante arroganza – e i modi naturali e disarmanti con il gentil sesso. E se fu la sua bellezza ad attirare il mio sguardo per la prima volta, non mi scuserò mai per questo, né mi scuserò per il mio desiderio di farlo mio per sempre. Ammirare una tale bellezza equivale istantaneamente a desiderare di possederla; è lo stesso desiderio che anima ogni collezionista. E io non ero certo l’unica. Quasi tutte le persone che facevano la conoscenza di Jonathan cercavano di possederlo. Era la sua maledizione, ma anche quella di chi lo amava. Perché era come essere innamorate del sole: splendente e inebriante quando gli stavi vicino, ma altrettanto impossibile da possedere in via esclusiva. Amarlo era impossibile, ma anche non amarlo. Così, caddi nella maledizione di Jonathan, intrappolata in quella rete di seduzione. E bastò questo per causarci un destino di sofferenza. 3 Durante l’adolescenza, io e Jonathan diventammo amici. Ci incontravamo la domenica dopo la messa e agli eventi sociali come i matrimoni o perfino i funerali, quando rimanevamo in disparte rispetto alle persone in lutto e ci scambiavamo sussurri e pensieri, oppure decidevamo di non curarci delle apparenze e scappavamo nei boschi, così da poterci concentrare l’uno sull’altra. Gli adulti scuotevano la testa in segno di disapprovazione e senza dubbio qualcuno iniziò a spettegolare su di noi, ma le nostre famiglie non fecero niente per interrompere la nostra amicizia. O quantomeno, se lo fecero, noi non ne venimmo mai a conoscenza. Fu in quel periodo che, lentamente, mi resi conto che Jonathan era più solo di quanto avessi immaginato. Gli altri ragazzi cercavano la sua compagnia molto meno di quanto io avessi dato per scontato, e Jonathan, da parte sua, quando veniva avvicinato da qualcuno in pubblico, spesso faceva di tutto per evitarlo. Mi ricordo che un giorno di primavera, mentre andavamo a una adunanza in chiesa, Jonathan vide che stavamo per incrociare un gruppo di ragazzi suoi coetanei e mi fece cambiare strada. Non sapevo come interpretare la cosa e, dopo averci pensato un po’ con ansia, decisi di chiederglielo. «Perché hai voluto che prendessimo questa strada?» gli domandai. «È perché ti vergogni di farti vedere con me?» Lui esplose in una risata di scherno. «Non essere stupida, Lanny. Anche adesso mi vedono con te. Tutti ci vedono camminare insieme.» Era vero, a ben pensarci, e ne fui sollevata. Ma non riuscii a lasciar perdere la questione. «Allora è perché non ti piacciono loro, quei ragazzi?» «Non è che non mi piacciono...» mi rispose, stizzito. «Allora perché...» Mi interruppe. «Perché mi fai tutte queste domande? Senti, fidati di me: è diverso per noi ragazzi, Lanny. Tutto qui.» Iniziò ad accelerare il passo, e dovetti alzarmi la gonna di qualche centimetro per stargli dietro. Non mi aveva spiegato che cosa intendeva, non mi aveva detto esattamente cosa fosse diverso per i ragazzi. Era tutto diverso, per quel che ne sapevo io. Tanto per cominciare, i maschi potevano andare a scuola, sempre che le loro famiglie potessero permettersi di pagare il compenso del tutore, mentre le ragazze potevano aspirare al massimo all’istruzione che le loro madri decidevano di impartire di persona: i mestieri domestici, e cioè il cucito, le pulizie, la cucina, forse leggere qualcosa dalla Bibbia. I ragazzi potevano azzuffarsi, correre e giocare a chiapparello senza l’impedimento delle gonne lunghe, andare a cavallo. Certo, dovevano anche farsi le ossa – una volta, mi raccontò Jonathan, suo padre gli aveva fatto riparare le fondamenta della loro ghiacciaia, di pietra e malta, così che imparasse anche a fare il muratore – ma comunque, dal mio punto di vista, la vita dei ragazzi era più spensierata. «Vorrei tanto essere nata maschio» borbottai, quasi senza fiato per lo sforzo di stare al suo passo. «No che non vuoi» mi rispose senza voltarsi. «Non vedo proprio cosa...» A quel punto si voltò di scatto verso di me. «E cosa mi dici di tuo fratello Nevin allora? Io non gli piaccio molto, vero?» Mi arrestai, colpita. No, Nevin non vedeva certo di buon occhio Jonathan, da sempre, per quanto mi ricordavo. Mi tornò alla mente la volta in cui aveva litigato con Jonathan, quando era tornato a casa con delle macchie di sangue secco in volto e mio padre, benché rimanesse in silenzio, era stato evidentemente orgoglioso di lui. «Perché credi che tuo fratello mi odi?» mi chiese. «Non ne ho idea.» «Non gli ho mai fatto niente, ma mi odia lo stesso» continuò Jonathan, sforzandosi di nascondere il tono ferito della sua voce. «Ed è così con tutti i ragazzi. Mi odiano. E anche qualcuno degli adulti. Lo so, lo sento. Ecco perché li evito, Lanny.» La confessione sembrava averlo spossato, era come svuotato. «Ecco, adesso lo sai» concluse e poi scappò via, lasciandomi sbalordita a osservarlo scomparire. Per tutta la settimana ripensai a quello che mi aveva detto. Avrei potuto chiedere a Nevin da dove gli fosse nato tutto quell’odio verso Jonathan, ma farlo avrebbe significato riattizzare un vecchio motivo di litigio fra noi. Naturalmente, lui non sopportava il fatto che io fossi diventata amica di Jonathan e ormai avevo capito che era meglio non azzardarmi a chiedergli niente. Probabilmente mio fratello pensava che Jonathan fosse altezzoso e arrogante, che ostentasse la sua ricchezza e che si aspettasse, ricevendole peraltro, delle attenzioni speciali. A parte la sua famiglia, io conoscevo Jonathan meglio di chiunque altro – anzi, forse meglio dei suoi stessi familiari – quindi sapevo perfettamente che erano tutte falsità... tranne l’ultima, ma non era certo colpa di Jonathan se gli altri lo trattavano in modo diverso. E anche se Nevin non l’avrebbe mai ammesso, nel suo sguardo d’odio vedevo chiaramente il desiderio di sfigurare Jonathan, di rovinare per sempre la bellezza del suo volto, di far crollare dal suo piedistallo il figlio prediletto del villaggio. A suo modo, Nevin voleva sfidare Dio, sconfiggerlo, porre rimedio a quella che secondo lui era un’ingiustizia che Dio in persona aveva commesso deliberatamente per umiliarlo, costringendolo a vivere sotto ogni punto di vista all’ombra di Jonathan. Ecco perché Jonathan era scappato via mentre andavamo in chiesa, perché era stato costretto a condividere con me la sua vergogna, e forse credeva che una volta venuta a conoscenza del suo segreto lo avrei abbandonato. Quanto ci aggrappiamo alle nostre paure, quando siamo bambini! Come se ci fosse stata una qualsiasi forza in cielo o in terra che avrebbe potuto impedirmi di amare Jonathan. Al contrario, questa sua paura mi fece capire che anche lui aveva dei nemici e dei detrattori, che anche lui era costantemente sottoposto al giudizio degli altri e che aveva bisogno di me. Io ero la sola amica con cui avrebbe potuto sentirsi libero di essere se stesso. E non era una libertà a senso unico: per dirla in parole semplici, Jonathan era l’unica persona che mi trattava come se io fossi importante. E avere l’attenzione del ragazzo più desiderato del villaggio non è cosa da poco per una ragazza praticamente invisibile tra i suoi coetanei. Come poteva tutto questo non farmelo amare ancora di più? E fu proprio questo che gli confessai la domenica seguente, quando mi avvicinai a lui e lo presi sottobraccio mentre camminava lungo i confini del prato, da solo. «Mio fratello è uno stupido» mi limitai a dirgli, e continuammo a camminare senza bisogno di dirci altro. L’unica cosa su cui non cambiai idea rispetto a quella nostra conversazione era che avrei preferito esser nata maschio. Ci credevo pienamente. Mi era stata inculcata dal comportamento dei miei genitori, dalle usanze che regolavano le nostre vite, in base alle quali le ragazze non valevano quanto i maschi e le nostre vite erano destinate a essere molto meno importanti. Per esempio, Nevin avrebbe ereditato la fattoria da mio padre, ma se non avesse avuto l’inclinazione o la forza di allevare bestiame, avrebbe potuto andare a fare l’apprendista dal fabbro o lavorare come taglialegna per i St. Andrew. Anche se limitate, almeno lui aveva delle scelte. In quanto donna, le mie opzioni erano molte, molte meno: sposarmi e avere una casa e una famiglia tutte mie, rimanere a casa e assistere i miei genitori nella loro vecchiaia, o andare a fare la serva a casa di qualcun altro. Se per qualche ragione Nevin avesse rifiutato di ereditare la fattoria, presumibilmente i miei genitori l’avrebbero lasciata al marito di una delle loro figlie, ma anche quello dipendeva dalla volontà del marito in questione. Un buon marito avrebbe tenuto conto dei desideri della moglie, ma non tutti lo facevano. Un’altra ragione, la più importante a mio modo di vedere, era che se fossi stata un maschio sarebbe stato molto più facile essere amica di Jonathan. Quante cose avremmo potuto fare insieme se io non fossi stata una ragazza! Avremmo potuto andare a cavallo verso l’avventura senza un adulto che ci sorvegliasse. Avremmo potuto passare insieme tutto il tempo che volevamo senza che nessuno si insospettisse o lo ritenesse un fatto su cui spendersi in opinioni non richieste. La nostra amicizia sarebbe stata naturale, innocente, talmente ordinaria che nessuno si sarebbe preso la briga di giudicarla. Avrebbe potuto crescere spontaneamente. Guardandomi indietro, ora capisco che fu un periodo molto difficile per me, che ero ancora intrappolata nell’adolescenza pur muovendo i primi incerti passi nell’età adulta. C’erano cose che volevo da Jonathan, ma ancora non sapevo nominarle e per districarmi avevo soltanto le mie goffaggini da bambina. Gli ero vicina ma volevo esserlo ancora di più, in un modo per me inafferrabile. Quando vedevo come guardava le ragazze più grandi, comportandosi con loro in modo diverso che con me, credevo ogni volta di morire per la gelosia. In parte, era dovuto all’intensità delle attenzioni di Jonathan, al suo grande fascino. Riusciva a farti sentire il centro del suo mondo. I suoi occhi, quegli abissi scuri e insondabili, si posavano sul tuo volto ed era come se lui esistesse per te, per te soltanto. Forse era un’illusione, dovuta soltanto alla gioia di averlo così vicino. Comunque fosse, il risultato era sempre lo stesso: quando Jonathan distoglieva la sua attenzione da te, era come se il sole fosse scomparso improvvisamente dietro una nuvola e un vento freddo e tagliente ti colpisse alla schiena. Non riuscivi a desiderare altro che il suo ritorno, per essere di nuovo illuminata dalle sue cure. E lui cambiava di anno in anno. Quando si lasciava andare, rivelava aspetti che non avevo mai visto prima, o che forse non avevo notato. Poteva diventare rozzo, specialmente se pensava di non avere addosso gli occhi di una donna. Si comportava con la stessa volgarità dei taglialegna che lavoravano per suo padre, parlava in modo sboccato come se avesse avuto esperienza di tutte le intimità che possono esistere tra un uomo e una donna. Tempo dopo avrei scoperto che a sedici anni era stato sedotto e aveva cominciato a sedurre, prendendo così parte (in maniera relativamente precoce, vista l’epoca in cui vivevamo) al grande ballo segreto degli amanti che animava St. Andrew, un mondo nascosto agli occhi di chi non sapeva dove guardare per scoprirlo. Ma erano segreti che non riusciva a condividere con me. Io sapevo soltanto che la mia fame di Jonathan cresceva e a volte sembrava oltre la mia possibilità di controllo. Sapevo soltanto che c’era qualcosa nel suo sguardo ardente, nel suo mezzo sorriso, nel modo sapiente in cui carezzava la gonna di seta di una donna quando pensava che gli altri non se ne accorgessero, che mi faceva desiderare che guardasse e carezzasse me nello stesso modo. E quando ripensavo alle cose rudi che gli avevo sentito dire, volevo che fosse rude anche con me. In realtà ero soltanto una ragazzina sola e confusa che desiderava disperatamente un’intimità carnale (anche se quel tipo di passione era ancora un mistero per me) e – lo capisco soltanto adesso – la mia ignoranza mi avrebbe condotto alla rovina. Avevo una fretta disperata di essere amata. Non posso dare tutta la colpa soltanto a Jonathan. Spesso siamo noi stessi a causare la nostra caduta. 4 Ospedale della contea di Aroostook, oggi Il fumo si avviluppa attorno alle luci accese dentro la stanza. I polsi della prigioniera sono liberi e lei è seduta sulla lettiga, con lo schienale rialzato. Una sigaretta si consuma fra le sue dita. Due mozziconi, consunti fino al filtro, giacciono accartocciati sul fondo di una padella sulla lettiga che li separa. Luke si abbandona sullo schienale della sedia e tossisce, la gola riarsa dal fumo. La mente è ottenebrata, come se avesse preso narcotici per tutta la notte, precipitando in un sogno alimentato dai farmaci, e si stesse risvegliando soltanto ora dalla trance. Un rintocco di nocche sulla porta lo fa alzare in piedi più veloce di uno scoiattolo che risale un albero. Sa che è il caratteristico bussare delle infermiere subito prima di entrare nelle stanze, senza aspettare il permesso. Blocca la porta con il suo corpo, in modo che si apra soltanto di pochi centimetri. Lo sguardo gelido di Judy, deformato dalle lenti dei suoi occhiali, lo percorre da capo a piedi. «Ha chiamato l’obitorio. È appena arrivato il corpo. Joe vuole che chiami il medico legale.» «È troppo tardi ormai. Di’ a Joe che non c’è motivo di chiamare il medico legale proprio adesso. Può benissimo aspettare fino a domattina.» L’infermiera incrocia le braccia. «Mi ha detto anche di chiederti notizie della prigioniera. È pronta ad andare o no?» Luke si rende conto del trabocchetto. Si è sempre ritenuto una persona onesta, eppure non riesce ad affidare la prigioniera alle braccia della giustizia, non ora. «No, non è ancora pronta. Non può prenderla in consegna ora.» Judy lo fissa così intensamente che sembra vedergli nell’anima. «E perché no? Non ha neanche un graffio.» La menzogna gli affiora alle labbra con facilità inattesa. «È sotto shock, ha avuto delle convulsioni. Ho dovuto sedarla. Devo assicurarmi che non abbia una reazione allergica ai sedativi.» L’infermiera sospira rumorosamente, come se sapesse – non sospettasse, ma sapesse per certo – che lui sta facendo qualcosa di disgustoso al corpo della ragazza, approfittando della sua incoscienza. «Lasciami lavorare, Judy, okay? Chiama Joe e digli che mi farò sentire quando sarà stabilizzata.» Le sbatte la porta in faccia. Lanny sposta la cenere delle sigarette con il mozzicone acceso, evitando volontariamente di incrociare il suo sguardo. «Jonathan è qui. Ora non hai più bisogno di credermi sulla parola» dice, posando la cenere nella padella e indicando la porta con un cenno del capo. «Vai. Vai in obitorio e guarda tu stesso.» Luke si agita sullo sgabello. «Anche se c’è un cadavere nell’obitorio, l’unica cosa che prova è che tu hai davvero ucciso qualcuno stanotte.» «Non capisci. C’è molto di più. Lascia che te lo mostri» dice, scostando la manica a campana del camice ospedaliero per rivelare un fine disegno al tratto inciso sulla pelle bianchissima del suo tricipite. Lui si avvicina per osservare più da vicino e capisce che si tratta di un tatuaggio piuttosto rudimentale, in inchiostro nero. È la sagoma di un animale, un rettile, inscritto in uno stemma nobiliare. «Lo troverai nello stesso punto sul corpo di Jonathan...» «Un tatuaggio identico?» «No» commenta lei, sfiorandosi il tatuaggio col pollice. «Ma è delle stesse dimensioni ed è stato fatto dalla stessa persona. Riconoscerai la somiglianza. Sembra fatto con spilli intinti nell’inchiostro... ed è stato fatto proprio così. Il suo assomiglia a due comete che si rincorrono, con le code un po’ allungate.» «Che cosa significano le comete?» le domanda Luke. «Che io sia maledetta se lo so» replica, risistemandosi il camice. «Vai, ora. Vai a guardare Jonathan e poi torna e dimmi se non mi credi.» Luke Findley la lega nuovamente alla lettiga – in modo un po’ improvvisato, del resto non usa quasi mai quei legacci per pazienti riottosi – e poi si alza dallo sgabello. Si insinua attraverso le porte scorrevoli, dopo aver controllato che nessuno lo noti uscire. L’ospedale è ancora al buio, tranquillo, ci sono solo flebili echi di movimenti nelle chiazze di luce che illuminano la postazione delle infermiere in fondo al corridoio. Le sue scarpe scricchiolano sul lindo pavimento di linoleum. Si affretta a scendere le scale, dirigendosi verso nord attraverso un corridoio al pianterreno che conduce all’obitorio. Per tutto il tempo la tensione lo attanaglia. Se qualcuno dovesse fermarlo e chiedergli che cosa ci fa lontano dal pronto soccorso, gli direbbe semplicemente che... Non ha idea di che cosa direbbe. Luke non è mai stato bravo a mentire. Si ritiene una persona fondamentalmente onesta e sincera, anche se non gli è servito a molto nella vita. Nonostante la sua innata onestà e la paura di essere colto sul fatto, però, ha acconsentito alla folle idea della prigioniera soltanto perché è curioso di vedere se davvero il morto è l’uomo più bello mai apparso su questo pianeta. Vuole vedere com’è fatto. Apre le pesanti porte dell’obitorio. Luke sente della musica – è l’assistente che fa il turno di notte all’obitorio, un ragazzo di nome Marcus; gli piace tenere la radio sempre accesa – ma non vede nessuno. Sulla scrivania si notano tracce di lavoro recente (la lampada è accesa, ci sono fogli e documenti sparsi, la carta di una gomma da masticare, una penna senza tappo), ma non c’è traccia di Marcus. L’obitorio è piccolo, in consonanza con le scarse necessità della cittadina. Sul retro c’è una camera refrigerata, ma i cadaveri vengono conservati in quattro nicchie incassate nel muro subito dopo la porta d’ingresso. Luke trattiene il respiro e afferra la maniglia di uno dei cassettoni, massiccia e pesante come le chiusure dei vecchi furgoni di surgelati. Nella prima nicchia trova il corpo di un’anziana; non la riconosce, probabilmente proviene da una delle città più remote della contea. Il corpo tarchiato della donna e i suoi capelli bianchi gli fanno tornare in mente sua madre, e per un attimo rievoca l’ultima conversazione lucida che avevano avuto. Lui era seduto accanto al letto, nel reparto di terapia intensiva, e lei con occhi velati aveva cercato di incrociare il suo sguardo, poi con la mano aveva afferrato la sua in cerca di conforto. «Mi dispiace così tanto che tu sia stato costretto a tornare a casa per prenderti cura di noi» gli aveva detto. Sua madre non aveva mai chiesto scusa di niente, a nessuno, per una semplice ragione: si era imposta di non fare mai nulla per cui poi doversi scusare. «Forse siamo rimasti alla fattoria troppo a lungo... Ma tuo padre si ostinava, non voleva arrendersi...» A quel punto si era fermata, incapace di mostrare slealtà nei confronti del marito, un uomo così testardo che, anche il giorno in cui era morto, la mattina era uscito con gambe tremanti per mungere le vacche. «Mi dispiace che la tua famiglia ne abbia pagato le conseguenze...» Luke ricorda di aver cercato di spiegarle che il suo matrimonio stava già finendo, ben prima che si ritrasferissero a St. Andrew, ma sua madre non aveva voluto sentire ragioni. «Non hai mai voluto rimanere a St. Andrew, sin da quando eri piccolo. So che non sei felice di essere qui ora. Una volta che me ne sarò andata, Luke, non farti scrupoli. Vai. Fatti una nuova vita.» Aveva cominciato a piangere stringendogli convulsamente la mano. Poche ore dopo, era piombata nell’incoscienza e non ne era più riemersa. Luke impiega un minuto buono a rendersi conto di aver lasciato aperta la nicchia, rimanendo in piedi lì davanti, immobile, tanto a lungo che il petto gli si è quasi congelato. È come se sentisse la voce di sua madre. Un brivido lo percorre. Fa rientrare il carrello scorrevole dentro la cella, poi chiude lo sportello. Gli ci vuole un altro minuto buono per ricordarsi cosa ci fa in quel luogo. Nella seconda cella trova una sacca per cadaveri, nera, e con un certo sforzo riesce a estrarre il carrello. Le cerniere si separano con un suono gracchiante, come quando si apre il velcro. Luke scosta i lembi della sacca e rimane paralizzato. Ha visto molti cadaveri, negli anni, e sa bene che la morte non rende certo più belli. I corpi sono più o meno sfigurati a seconda delle modalità del decesso. A volte ci sono lividi e chiazze scolorite, altre volte i corpi sono affetti da un pallore bluastro. C’è solo una costante: i lineamenti sono privi di espressione, spenti. Il volto dell’uomo che ha davanti è quasi bianco, punteggiato da tracce di foglie scure e umide. I capelli neri sono appiccicati alla fronte, gli occhi sono chiusi. Ma non ha alcuna importanza. Luke si rende conto che potrebbe stare a osservarlo per tutta la notte. È magnifico, anche da morto. La sua bellezza toglie dolorosamente il fiato. Proprio quando sta per spingere il carrello nella cella incassata nella parete, Luke si ricorda del tatuaggio. Lancia uno sguardo alle sue spalle nel caso Marcus sia tornato alla scrivania senza che lui l’abbia sentito, poi si affretta ad aprire ulteriormente la sacca, spostando i vestiti, per scoprire il braccio dell’uomo. E, proprio come aveva detto Lanny, scorge due sfere intrecciate con le code che svettano in direzioni opposte. Il tratto è identico, per dimensioni e per le linee esitanti, fatte manualmente, a quello del tatuaggio della ragazza. Dopo aver rimesso tutto a posto, Luke riattraversa l’ospedale vuoto e rientra nel pronto soccorso. Per tutto il tempo, la sua mente si affolla di dubbi e domande. È come materia e antimateria, due verità che non possono coesistere, se non annullandosi a vicenda. Sa di aver visto ciò che ha visto nella stanza, quando Lanny si è tagliata: è successo davvero. Eppure, è impossibile. Ha toccato con la propria mano il punto esatto della ferita sul petto di Lanny, prima e dopo il taglio. Sa che non c’è nessun trucco. Ma quello che ha visto con i propri occhi non può essere successo davvero. A meno che lei non dica la verità. E poi, quell’uomo bellissimo nell’obitorio, i tatuaggi... Tutto questo gli dà la sensazione che, per una volta, dovrebbe lasciarsi andare. Ascoltare. Ma lui resiste: è un uomo di scienza, non è pronto ad abbandonare di schianto tutto ciò che ha imparato. Però è anche curioso. Vuole saperne di più. Poco dopo Luke irrompe attraverso la porta della stanza nel pronto soccorso in penombra – l’agitazione gli pervade di energia il petto, come farfalle chiuse in un vaso – e trova la prigioniera rannicchiata sulla lettiga, illuminata dal taglio discendente della luce e ancora avvolta in spire di fumo. Sembra un angelo caduto, pensa Luke, con le ali recise. Lanny lo osserva con ansia. «Allora l’hai visto? Non è esattamente come ti avevo detto?» Luke annuisce. Una bellezza come quella è una droga di tutt’altra specie rispetto a quelle conosciute. Si strofina il volto, respira a fondo. «Adesso capisci» dice Lanny con solennità. «E se mi credi, Luke, aiutami. Slegami» dice, inarcando la schiena e porgendogli i polsi legati, col viso delizioso rivolto verso di lui. «Devi aiutarmi a scappare.» 5 St. Andrew, 1811 Forse il nostro destino sarebbe stato diverso, migliore, per me e Jonathan, se io fossi nata maschio. Avrei preferito che la nostra rimanesse sempre e soltanto un’amicizia. Avremmo passato tutta la vita entro i confini del nostro piccolo villaggio; non sarei mai incappata nelle sventure che mi accaddero in seguito, non avremmo mai dovuto sopportare il peso del terribile destino che ci è stato imposto. Le nostre sarebbero state vite piccole, forse, ma piene, gratificanti, complete, e io sarei stata felice. Ma non ero un maschio, ero una femmina e, per quanto lo volessi, non c’era modo di cambiare questo fatto. Di fronte a me c’era la misteriosa transizione da ragazza a donna, per me insondabile quanto il trucco di un prestigiatore. Chi avrei dovuto prendere a esempio? Mia madre, Theresa, non era in grado di offrirmi la guida di cui avevo disperatamente bisogno. Era troppo modesta e sottomessa per i miei gusti. Non mi andava di fare quella vita. Volevo di più. Tanto per cominciare, volevo sposare Jonathan, e non pareva proprio che mia madre potesse aiutarmi a diventare il tipo di donna che poteva conquistare uno come Jonathan. C’erano segreti che non tutte le donne conoscevano. Per fortuna, al villaggio, abitava una donna che quei segreti li conosceva tutti. Una donna sul cui conto circolavano diverse voci, il cui nome suscitava un sorriso enigmatico sui volti degli uomini (purché pronunciato quando le loro mogli non erano presenti). Una donna diversa da tutte le altre. Dovevo trovare il modo di far sì che condividesse i suoi segreti con me. Lungo un sentiero ben tracciato, nascosto all’ombra della forgia del fabbro, c’era un piccolo cottage. Era quasi invisibile, ma chi fosse riuscito a notarlo avrebbe pensato a un capanno degli attrezzi o a un deposito in cui conservare il ferro grezzo. Era troppo malmesso e angusto per essere una dimora, eppure non sembrava abbandonato, e la stradina che conduceva all’ingresso mostrava ogni giorno di più segni di passaggio. Di sicuro non poteva abitarci più di una persona, e la legge che vietava di vivere da soli era ancora prevalente, all’alba del diciannovesimo secolo, in quello squallido avamposto puritano in cui abitavamo (perché eravamo senza dubbio dei puritani; i padri fondatori del villaggio erano cresciuti nel Massachusetts ed eravamo abituati a mescolare religione e legge). In ogni caso, nell’estrema punta settentrionale di quello che sarebbe diventato lo Stato del Maine, l’unica ragione a sostegno dell’editto contro chi viveva da solo era la pura necessità: era impensabile che una persona da sola riuscisse a sopravvivere in un ambiente così ostile. All’opposto, in una città più rigidamente puritana, a nessuno era consentito vivere da solo perché, nella solitudine, si rischiava di cedere alle tentazioni. Commettere atti impuri. L’editto contro la vita solitaria dava il diritto di controllare i propri vicini, ma gli abitanti di St. Andrew tenevano fieramente alla propria indipendenza e a quella che oggi chiamate privacy. E in effetti in quel piccolo cottage qualcuno viveva da solo. Una donna, giunta quasi al limite dell’età feconda, ancora bella ma di una bellezza che stava appassendo. Raramente si faceva vedere in paese, ma quando si avventurava per le strade in pieno giorno, gli abitanti le giravano alla larga. Gli uomini facevano di tutto per non incrociare il suo sguardo, mentre le donne facevano frusciare le loro lunghe gonne e cambiavano strada. Alcune la fissavano con aperta ostilità. Ma di notte era tutto diverso. Coperti dalle tenebre, erano in molti a farle visita regolarmente. Uomini – uno alla volta, solo di rado due insieme – sgattaiolavano lungo il sentiero e bussavano sommessamente alla sua porta. Se nessuno rispondeva, il visitatore sapeva di doversi sedere sul gradino e aspettare, con le spalle alla porta, facendo finta di non sentire i suoni che provenivano dall’interno. Dopo un po’, i suoni lasciavano il posto a mormorii di conversazione e poi al silenzio; un minuto dopo la porta si apriva e il nuovo visitatore poteva entrare. Quelli che sapevano della sua esistenza la chiamavano Magdalena. Era il nome che lei stessa si era data quando era arrivata al villaggio, sette anni prima. Nessuno aveva messo in dubbio quel nome inusuale, all’epoca. Era giunta insieme a un piccolo gruppo di viaggiatori provenienti dai territori del Canada francese. Quando gli altri se n’erano andati, lei era rimasta. Aveva detto di essere una vedova e di aver deciso di trasferirsi in un posto dal clima più mite, sempre se i cittadini di St. Andrew le avessero accordato il permesso di stabilirsi fra loro. E fu così che il fabbro si offrì di riattare il suo vecchio capanno, trasformandolo in una piccola ma accogliente casetta. Le buone donne del paese la aiutarono a sistemarsi, portandole tutto ciò di cui non avevano più bisogno: uno sgabello traballante, del tè avanzato, una vecchia coperta. I mariti le portarono ramoscelli e legna da ardere. Quando le chiesero che cosa avrebbe fatto per mantenersi – ricamo, tessitura... o forse era una levatrice e sapeva anche come curare e guarire? – lei si limitò a sorridere con modestia e abbassò la testa, come a dire: «Io? Che abilità potrei mai avere? Mio marito mi trattava come fossi una preziosa bambola di porcellana. Come potrebbe farsi strada nel mondo una povera vedova inetta come me?» Le buone donne si allontanarono perplesse, scuotendo la testa, senza sapere che cosa pensare se non che Dio provvedeva per tutti i suoi figli, inclusa una donna innocente che sembrava contare sulla generosità infinita della gente di quella cittadina solitaria e ostile. Ma alla fine Magdalena non dovette dipendere a lungo dalla carità degli altri. Misteriosamente, provviste iniziarono a comparire sull’uscio, non richieste. Una ciotola di burro, uno staio di patate, una caraffa di latte. La legna da ardere si ammucchiava davanti all’ingresso posteriore. E poi, i soldi: era una delle pochissime persone del villaggio a possedere del denaro vero, delle monete che depositava, contandole ad alta voce, sul bancone del droghiere quando ordinava le provviste. E che ordinazioni insolite: bottiglie di gin, tabacco. I vicini notarono che le lanterne, da lei, rimanevano accese fino a tardi, illuminando l’unica minuscola finestra del cottage: stava sveglia tutta la notte a fumare tabacco e a bere gin, forse? Alla fine, furono i taglialegna a portarla allo scoperto, i boscaioli che lavoravano per Charles St. Andrew facendo una sola annata. Un anno intero in cui erano lontani dalle loro mogli. Uomini come loro sapevano fiutare la presenza di donne come Magdalena dalla parte opposta del villaggio, anche all’altro capo della valle se il vento era favorevole. Prima uno, poi un altro, e poi ciascuno di loro, a turno, dopo il calar del sole si avventurava fino all’uscio di Magdalena. Non che i taglialegna fossero i suoi unici clienti: loro però pagavano in contanti, non con uova o pancetta. Ma per via delle lingue lunghe dei taglialegna, la voce si sparse per tutto il paese, come acqua sporca rovesciata da un barile rimasto sotto la pioggia, e più di una buona moglie levò le sue ire. Magdalena non reagì. Non di giorno, almeno. Nemmeno quando una moglie indignata la insultò apertamente, faccia a faccia. Le mogli, dopo aver reclutato il pastore, organizzarono una protesta per farla espellere dal villaggio. La sua presenza era un segnale: il peccato delle grandi metropoli stava contagiando anche il piccolo avamposto di St. Andrew. Era proprio il genere di cose da cui i coloni avevano cercato di allontanarsi. Il pastore Gilbert si recò in visita presso Charles St. Andrew, poiché era il datore di lavoro dei taglialegna, gli unici clienti di Magdalena di cui ci si potesse lamentare pubblicamente. Per quanto comprendesse le ragioni del pastore e simpatizzasse per la sua causa, Charles fece presente che c’era un altro lato della questione, un fatto che riguardava i servizi offerti da Magdalena e che i cittadini benpensanti stavano trascurando. I taglialegna agivano spinti da un istinto assolutamente naturale – e, sebbene malvolentieri, il pastore non poté che concordare – e per di più erano lontani miglia e miglia, giorni e giorni, dalle loro spose. Senza Magdalena, come avrebbero potuto comportarsi quegli uomini per soddisfare i loro istinti? Forse la presenza di Magdalena era una salvezza, per tutte le mogli e le figlie del paese. Avvenne così che fu stabilita una sorta di diffidente tregua tra la prostituta e le donne virtuose, una tregua che durava ormai da sette lunghi anni. In tempi di crisi, lei si rendeva utile, che alle altre piacesse o meno. Faceva la sua parte curando i malati e i morenti, dava da mangiare ai viaggiatori depredati, metteva qualche moneta nella cassetta della carità della chiesa quando nessuno la vedeva entrare. Non potevo impedirmi di pensare che doveva mancarle la compagnia di un’altra donna, anche se lei rispettosamente si teneva sulle sue e non intratteneva alcuna conversazione con i suoi concittadini. La vera natura della situazione di Magdalena era un mistero per molti bambini e ragazzi. Vedevamo che le nostre madri evitavano quella donna enigmatica. Per lo più i bambini credevano che fosse una strega o una creatura soprannaturale di qualche tipo. Ricordo le loro grida di scherno, ricordo che di tanto in tanto qualcuno le lanciava addosso una manciata di ciottoli. Non io: anche da piccola, avvertivo qualcosa di magnetico in lei. Stando alle convenzioni, io non avrei mai dovuto aver niente a che fare con lei. Mia madre non era particolarmente rigida, ma donne come lei non diventavano amiche delle prostitute, men che meno le loro figlie. Eppure, è esattamente ciò che feci. Accadde una domenica, durante un sermone particolarmente lungo. Mi scusai e sgusciai fuori per andare in bagno. Ma invece di affrettarmi a tornare sulla balconata di fianco a mio padre, indugiai a godermi il calore di quella prima giornata di sole dell’estate. Vagai fino al fienile di Tinky Talbot per vedere la nuova nidiata di maialini, rosa con macchie nere, ricoperti di peluria riccia e ruvida. Accarezzai i loro musi curiosi, ascoltai i loro flebili grugniti. Poi guardai di lato, lungo il sentiero – era la prima volta che mi trovavo così vicina al misterioso cottage – e notai Magdalena su una sedia, dietro alla piccola fioriera della veranda, con una pipa lunga e annerita fra le labbra. Anche lei si stava godendo il sole, avvolta in una coperta, i capelli scandalosamente sciolti sulle spalle. Le parti di lei non avvolte nella coperta erano magre e delicate, le ossa della clavicola, leggere come quelle di un uccello, si intravedevano sotto una pelle che sembrava carta velina. Niente cipria in volto, solo una traccia di nerofumo agli angoli degli occhi e un’ombra di colore sulle labbra. Era diversa da tutte le altre donne del villaggio. Bastava il suo atteggiamento a dimostrarlo: seduta da sola, sotto il sole, contenta di sé e senza vergognarsi di oziare. In fondo, non veniva a messa; quello era il suo modo di godersi la domenica, mentre tutti gli altri erano chiusi in chiesa o nella sala della congregazione. Alzò la mano a schermarsi gli occhi dal sole. «E tu chi sei?» In quel momento, presi la mia decisione. Avrei potuto tornare in chiesa di corsa, e invece mossi qualche timido passo verso di lei. «Non mi conoscete, signora. Mi chiamo Lanore McIlvrae.» «McIlvrae.» Soppesò il cognome, concludendo che, no, non lo conosceva, il che voleva dire che mio padre non era fra i suoi clienti. «No, mia cara, credo proprio di non aver avuto il piacere di fare la tua conoscenza.» Le feci un inchino e lei sorrise. «Mi chiamo Magdalena, anche se credo che tu lo sappia già, questo, vero? Chiamami pure Magda.» Vista da vicino, era molto bella. Si alzò, sistemandosi la coperta, e notai che sotto aveva ancora il corsetto da notte e un velo di lino bianco fermato sul seno da un nastro rosa. A casa nostra dominava la praticità, la concretezza: mia madre non aveva un capo di abbigliamento femminile neanche lontanamente simile alla delicata sottoveste di Magda. L’insieme della sua bellezza e di quell’abbigliamento mi folgorò. Era la prima volta che provavo quel misto di bramosia e invidia verso un’altra persona. Si accorse che fissavo la sua sottoveste e un sorriso complice le spuntò in volto. «Aspetta qui soltanto un minuto» mi disse, poi scomparve dentro la casa. Quando riapparve, mi tese un nastro di velluto rosa. Tu non puoi capire che tesoro prezioso mi stesse regalando; tessuti lavorati come quello erano merce rarissima nella nostra arida cittadina, e fronzoli come un nastro di velluto erano ancora più rari. Era la stoffa più morbida che avessi mai toccato e la cullai fra le mie mani come se fosse un coniglietto. «Non posso accettare un dono di questo valore» le dissi, anche se era evidente il mio desiderio di poterlo fare. «Sciocchezze» disse lei, ridendo. «È solo un pezzo di nastro di un vecchio vestito. Che cosa vuoi che me ne faccia io?» mentì. Mi osservò accarezzare il velluto con palese gioia. «Tienilo. Insisto.» «Ma i miei genitori mi chiederanno dove l’ho preso e...» «Tu risponderai che l’hai trovato per caso» mi suggerì, anche se entrambe sapevamo che non potevo farlo. La bugia sarebbe stata troppo implausibile. Eppure, non riuscivo a convincermi a restituire a Magda il nastro. Fu contenta quando strinsi le dita attorno al suo dono e sorrise, ma non di trionfo: di solidarietà. «Siete molto generosa, madamigella Magda» dissi, rivolgendole un nuovo inchino. «Ora devo tornare a messa, o mio padre crederà che mi sia successo qualcosa.» Lei alzò il mento e puntò il naso sottile verso la congregazione. «Ma certo, cara. Hai ragione. Non devi far preoccupare i tuoi genitori. Spero però che tornerai a farmi visita, signorina McIlvrae.» «Lo farò. Prometto.» «Bene. Adesso vai, su.» Trottai lungo il sentiero, alzando la gonna per evitare le pozzanghere. Prima di svoltare l’angolo, lanciai uno sguardo indietro: Magda era tornata a sedersi e dondolava contenta, lo sguardo perso nei boschi. Riuscii a malapena ad attendere la domenica seguente per sgattaiolare via durante la messa e tornare a far visita a Magda. Avevo nascosto il nastro nella tasca della mia seconda sottogonna, dove potevo infilare la mano per accarezzare di nascosto il velluto. Il nastro mi ricordava Magda; la ammiravo proprio perché era così diversa da mia madre e dalle altre donne del villaggio. C’era soprattutto una cosa in lei che meritava la mia ammirazione, anche se non la capivo veramente: il fatto che non avesse un uomo. Non c’era nemmeno una donna del villaggio che vivesse senza un uomo a fianco, ed era sempre l’uomo il capofamiglia. Magda era l’unica donna di St. Andrew che rappresentava se stessa, anche se da quello che avevo visto lo faceva raramente. Dubitavo che partecipasse alle assemblee cittadine. Eppure continuava a vivere secondo la sua sola volontà e alle sue condizioni. E sembrava farlo con successo. E questo mi pareva una cosa meritevole di molta ammirazione. La domenica seguente riuscii a trovare una scusa per allontanarmi ancora dalla messa (anche se mio padre mi scoccò un’occhiataccia) e corsi fino al cottage di Magda. La trovai sul patio, stavolta. Non era più vestita in modo semplice. Indossava una bellissima camicetta a righe e una giacchetta di lana viola, un colore insolito. L’insieme era di un’eleganza deliziosa, come se volesse fare una buona impressione su qualcuno. Su di me. Ero lusingata. «Buongiorno, madamigella Magda» la salutai correndole incontro, leggermente affannata. «Buona domenica a te, signorina McIlvrae.» I suoi occhi verdi scintillavano. Chiacchierammo per un po’ e lei mi chiese della mia famiglia; le indicai la nostra fattoria. Proprio quando stavo pensando che avrei dovuto tornare a messa, lei mi disse, timidamente: «Ti chiederei di entrare in casa, ma suppongo che i tuoi genitori non approverebbero. Visto chi sono io. Non sarebbe... appropriato». Sapeva che morivo dalla curiosità di vedere l’interno del suo cottage. Casa sua, la testimonianza della sua fiera indipendenza! La mia coscienza mi richiamò all’ordine, intimandomi di tornare in chiesa da mio padre... Ma come potevo rinunciare a quell’opportunità? «Ho soltanto un minuto...» dissi seguendola su per i gradini e attraverso la porta di ingresso. Ai miei occhi apparve come l’interno di un cofanetto di gioielli, ma, in realtà, doveva essere abbastanza cadente e sciatta. La piccola camera da letto era dominata da un letto stretto, su cui era posata una magnifica coperta ricamata in giallo e rosso. Sul davanzale dell’unica finestra erano messe in fila delle bottiglie di vetro, che proiettavano riflessi verdi e marroni sul pavimento. Sparuti gioielli erano posati dentro una ciotola di ceramica ornata di piccole rose rosa. I suoi vestiti erano appesi a ganci sulla porta posteriore: era un assortimento di gonne di vari colori, lunghe fusciacche, sottogonne con le balze. Non una, ma due paia di delicati stivaletti da donna erano allineati a lato della porta. La mia unica delusione fu che la camera era soffocante, l’aria impregnata di un profumo muschiato che ancora non riconoscevo. «Quanto mi piacerebbe vivere in un posto così» osservai, facendola ridere. «Ho vissuto in posti migliori, a dire il vero, ma questo può andare» disse, sedendosi. Prima che la lasciassi, Magda mi diede due consigli da donna a donna. Il primo era che una donna dovrebbe sempre mettere via dei soldi per sé. «Il denaro è molto importante» mi disse, mostrandomi il posto in cui conservava un borsellino pieno di monete. «I soldi sono l’unica strada per avere il controllo della propria vita, per una donna.» Il secondo era che una donna non dovrebbe mai tradire un’altra donna per via di un uomo. «Succede continuamente» mi spiegò con tono triste. «E si può capirlo, visto che sembra che, a questo mondo, solo gli uomini siano importanti. Ci fanno credere che l’unico valore di una donna risieda nell’uomo che ha al suo fianco, ma non è così. E comunque, le donne devono appoggiarsi l’un l’altra, perché dipendere da un uomo è una follia. Gli uomini non sanno far altro che deludere.» Chinò il capo, ma potrei giurare di aver visto delle lacrime nei suoi occhi. Stavo per alzarmi dal pavimento e uscire quando qualcuno bussò alla porta. Un uomo corpulento entrò prima che Magda gliene desse il permesso e io lo riconobbi: era uno dei taglialegna di St. Andrew. «Ciao, Magda, credevo fossi da sola e volessi compagnia, visto che tutti sono a messa stamattina... Chi è questa?» Si bloccò quando mi vide e un ghigno si allargò sul suo volto segnato dalle intemperie. «Hai una nuova ragazza, Magda? Un’apprendista?» Mi prese per il braccio come se non fossi una persona ma un oggetto da possedere. Magda si frammise tra me e lui e manovrandomi abilmente mi condusse all’uscita posteriore. «È una mia amica, Lars Holstrom, e non sono affari che ti riguardano. Vedi di tenere le tue manacce lontane da lei. Tu vai, ora» disse poi rivolta a me, spingendomi oltre la soglia. «Forse ci rivedremo la settimana prossima.» E prima di rendermene conto mi ritrovai in mezzo a una pila di foglie secche, con rami caduti che scricchiolavano sotto i miei piedi. La porta di legno mi si chiuse in faccia e Magda si dedicò ai suoi affari, il prezzo della sua indipendenza. Mi affrettai attraverso il sottobosco fino al sentiero, poi corsi per tornare alla sala della congregazione. Giunsi proprio mentre i parrocchiani spuntavano alla luce del sole. Mio padre me l’avrebbe fatta pagare cara, stavolta, ma ne era valsa la pena. Magda era la custode di tutti i misteri della vita e sentivo che qualunque prezzo avessi dovuto pagare per continuare a imparare da lei, ne sarebbe valsa la pena. 6 Un pomeriggio d’estate, quando avevo quindici anni, l’intera cittadinanza si radunò nel pascolo dei McDougal per ascoltare un predicatore itinerante. Vedo ancora i miei concittadini incamminarsi verso il campo dorato, l’erba alta splendere al sole, sbuffi di polvere che si sollevano dietro i loro passi. A piedi, a cavallo o in carrozza, quasi tutti gli abitanti di St. Andrew si recarono al campo dei McDougal quel giorno, anche se potrei giurare che non era semplicemente per un rigurgito di zelo religioso. Anche i predicatori itineranti erano una rarità nelle nostre zone: una delle pochissime occasioni di svago che ci aiutasse a riempire la tristezza di un interminabile giorno d’estate in quel posto desolato. Quel predicatore, in particolare, sembrava apparso dal nulla e in pochi anni aveva radunato un folto seguito, costruendosi la reputazione di oratore fiero e ribelle. C’erano voci secondo le quali aveva causato uno scisma nei fedeli della città più vicina – Fort Kent, a un giorno di cavallo verso nord – mettendo i congregazionalisti più conservatori contro una nuova fazione di riformisti. Come se non bastasse, circolavano già da tempo voci sulla prossima costituzione in Stato autonomo del Maine, che si sarebbe così separato dal Massachusetts, quindi c’era un’atmosfera di tensione – religiosa e politica – che sembrava preludere a una rivolta contro la religione che i coloni avevano portato con sé dal Massachusetts. Fu mia madre a convincere mio padre ad andare, pur non avendo alcuna intenzione di convertirlo: voleva soltanto stare lontana dalla cucina almeno per un pomeriggio. Dopo che ebbe steso una coperta sul prato, attendemmo che il sermone cominciasse. Mio padre si accomodò di fianco a lei, con aria diffidente, guardandosi attorno per vedere chi c’era e chi no. Le mie sorelle rimasero vicine a mia madre, rimboccandosi pudicamente le gonne sotto le gambe; Nevin si era allontanato non appena la carrozza si era fermata, andando in cerca degli altri ragazzi che vivevano nelle fattorie vicine alla nostra. Io rimasi in piedi a osservare la folla, con una mano a proteggermi gli occhi dai forti raggi del sole. C’erano tutti, alcuni con delle coperte come mia madre, altri con del cibo nei cestini. Stavo cercando Jonathan, come al solito, ma non mi sembrò che fosse presente. La sua assenza non era certo una sorpresa: sua madre era probabilmente la più ardente congregazionalista del villaggio, e la famiglia di Ruth Bennet St. Andrew non avrebbe mai voluto aver niente a che fare con quella follia riformista. Poi però scorsi una sagoma scura nascosta nell’ombra degli alberi... Sì, era Jonathan, che si teneva ai margini della radura a cavallo del suo inconfondibile stallone. Non fui l’unica a notarlo; ci fu un percepibile sommovimento in alcune parti della folla. Chissà come ci si deve sentire a rendersi conto che decine di persone ti fissano rapite, con gli sguardi che seguono i contorni delle tue lunghe gambe ai fianchi del cavallo, le tue forti mani che afferrano le redini. C’era così tanto desiderio incandescente nei petti di molte donne presenti sulla radura, quel giorno, che è un miracolo che l’erba secca non abbia preso fuoco. Lui guidò il cavallo verso di me e, liberatosi delle staffe con un calcio, smontò dalla sella. Odorava di cuoio e di terra arsa dal sole e io avrei voluto poterlo toccare, anche solo sfiorargli la manica bagnata del suo sudore. «Che cosa sta succedendo?» mi chiese, levandosi il cappello e passandosi la manica sulla fronte. «Non lo sai? C’è un predicatore itinerante in città. Non sei qui per ascoltarlo?» Jonathan alzò lo sguardo oltre di me per osservare la folla. «No. Ero fuori per controllare il prossimo lotto da disboscare. Il vecchio Charles non si fida del nuovo agrimensore. Secondo lui, beve troppo.» Strizzò gli occhi per vedere ancora meglio quali ragazze lo stessero osservando. «La mia famiglia è qui?» «No, e non credo che tua madre approverebbe la tua presenza qui. Il predicatore ha una tremenda reputazione. Potresti finire all’inferno soltanto per averlo ascoltato.» Jonathan mi sorrise. «È per questo che sei qui? Non riesci a reprimere il desiderio di finire all’inferno? Se proprio vuoi la dannazione eterna, ci sono modi molto più piacevoli per raggiungerla che non ascoltare un predicatore ingannevole.» C’era un messaggio nello scintillio dei suoi profondi occhi castani, ma non sapevo interpretarlo. Prima che potessi chiedergli spiegazioni, lui rise e disse: «Pare che ci sia qui tutta la città. È un vero peccato che non possa trattenermi, ma hai ragione, mia madre me la farebbe pagare molto cara se lo venisse a sapere». Inforcò la staffa e rimontò agilmente sulla sella. Poi si chinò verso di me con fare protettivo. «Ma tu cosa ci fai qui, Lanny? Non ti sono mai piaciuti i sermoni. Sei qui perché speravi di incontrare qualcuno? C’è qualche giovanotto che ha attirato la tua attenzione?» Fu una sorpresa assoluta per me. Il suo tono malizioso, lo sguardo indagatore. Non mi aveva mai lasciato intendere che gli interessasse sapere se mi piaceva un altro ragazzo. «No» risposi, ma ero senza fiato, a malapena capace di proferire una parola. Lentamente, afferrò le redini e le alzò, quasi soppesandole come stava soppesando le parole da dirmi. «So che arriverà il giorno in cui ti vedrò con un altro ragazzo; la mia Lanny con un altro ragazzo... E non mi piacerà. Ma è giusto così.» Non ebbi il tempo di riprendermi dallo shock e dirgli che poteva impedirlo, lo sapeva benissimo, sapeva come... Lui voltò il cavallo e si dileguò fra gli alberi, lasciandomi confusa a osservare la sua ombra scomparire. Era un enigma, per me. Mi trattava per lo più come la sua migliore amica, non mi toccava mai in modo inappropriato, ma poi c’erano volte in cui il suo sguardo sembrava esprimere un invito, o la sua frenesia nascondere un’ombra di desiderio. Potevo sperare che fosse così? Ormai se n’era andato e non potevo indugiare oltre in quei pensieri o sarei ammattita. Mi appoggiai a un albero e vidi il predicatore farsi largo tra la folla finché non giunse in un piccolo spiazzo libero, davanti a tutti. Era più giovane di quanto pensassi – Gilbert era l’unico prete che conoscevo e quando era arrivato a St. Andrew aveva già i capelli bianchi e l’aria perennemente corrucciata – e camminava con la schiena dritta, sicuro che Dio e la giustizia fossero dalla sua parte. Era bello in modo inatteso e perfino sconveniente per un prete, e le donne sedute più vicino a lui pigolarono come uccellini quando lui le gratificò con un sorriso candido e ampio. Eppure, guardandolo osservare la folla, mentre si preparava a cominciare (con una sicurezza che sembrava indicare che tutti già gli appartenevano), provai un brivido oscuro, come se stesse per succedere qualcosa di orribile. Iniziò a parlare. La sua voce era forte e chiara. Raccontò i suoi pellegrinaggi attraverso tutto il territorio del Maine, descrivendo ciò che aveva visto. Il nostro territorio stava diventando una copia del Massachusetts, con i suoi costumi elitari. Un manipolo di uomini ricchi controllava il destino di tutti gli abitanti. E questo che vantaggi aveva mai portato all’uomo comune? Erano tempi difficili. Uomini semplici, grandi lavoratori, costretti a indebitarsi sempre più. Uomini onesti, padri e mariti, messi in prigione e le loro terre vendute senza lasciar nulla alle loro mogli e ai loro figli. Fui sorpresa di vedere teste annuire fra la folla. Quello che la gente voleva, quello che i veri americani volevano, specificò con enfasi agitando la sua Bibbia nell’aria, era la libertà. Non avevamo combattuto e sconfitto i britannici solo perché altri padroni prendessero il posto del re. I proprietari terrieri di Boston e i mercanti che vendevano la loro merce ai coloni non erano altro che ladri e usurai esosi, e la legge era piegata al loro servizio. I suoi occhi scintillarono mentre osservava gli astanti, incoraggiato dai loro mormorii di assenso, e intanto camminava lungo la macchia di erba schiacciata. Non ero abituata a sentire parole di dissenso pronunciate così apertamente in pubblico e il successo che quel predicatore sembrava avere in quel momento mi fece sentire una punta di allarme. Improvvisamente mi resi conto che Nevin era vicino a me, osservava i volti dei nostri concittadini. «Ma guardali, tutti a bocca aperta...» disse, deridendoli. Non c’era alcun dubbio che avesse ereditato il temperamento critico di nostro padre. Incrociò le braccia sul petto e sbuffò. «Sembrano molto interessati a quello che sta dicendo» osservai. «Ma tu non sai nemmeno cosa sta dicendo!» Nevin socchiuse gli occhi e mi fissò. «Non capisci niente, vero? Ma certo che no, sei solo una stupida ragazzina. Ovvio che non capisci nulla.» Corrugai la fronte e mi portai i pugni ai fianchi, ma non replicai perché su una cosa Nevin aveva ragione: non sapevo di che cosa stesse veramente parlando quell’uomo. Non avevo la minima idea di quel che stesse succedendo nel mondo al di là dei confini del nostro villaggio. Nevin indicò un gruppetto di uomini che se ne stavano in disparte rispetto alla folla. «Li vedi quelli là?» mi domandò. Erano Tobey Ostergaard, Daniel Daughtery e Olaf Olmstrom. Erano tre degli uomini più poveri del villaggio, anche se qualcuno meno caritatevole avrebbe potuto osservare che erano anche i tre più incapaci. «Stanno meditando qualche guaio, quelli là» mi spiegò Nevin. «Sai cosa vuol dire ’indiani pallidi’?» Anche la ragazza più ignorante del villaggio avrebbe saputo dire a che cosa si riferisse quell’espressione. Tempo prima era arrivata la notizia di una rivolta a Fairfax: dei cittadini vestiti da indiani avevano impedito al messo comunale di portare un’ingiunzione a un contadino in arretrato coi pagamenti. «Sta per succedere lo stesso qui» aggiunse Nevin, annuendo. «Ho sentito Olmstrom e Daughtery e altri che ne parlavano a nostro padre. Si lamentavano perché i Watford facevano pagare troppo...» I dettagli sfuggivano alla capacità di comprensione di Nevin; nessuno si prendeva la briga di spiegare a dei ragazzi che cosa significassero i conti e i ricarichi del droghiere. «Secondo Daughtery è una congiura contro la gente comune» recitò a memoria Nevin, con un tono che lasciava intendere che secondo lui forse Daughtery era nel giusto. «Quindi? Che mi importa se Daughtery non paga i suoi debiti ai Watford?» sbottai, fingendo che non mi interessasse. In realtà, dentro di me ero sconvolta dal pensiero di qualcuno che volontariamente non onorasse i suoi debiti, dato che mio padre ci aveva insegnato che un simile comportamento sarebbe stato riprovevole e che solo una persona priva di dignità l’avrebbe fatto. «Potrebbe avere delle pericolose conseguenze per il tuo bello, Jonathan» disse Nevin con tono canzonatorio, ben felice di avere l’occasione per prendermi in giro su Jonathan. «Non sono mica soltanto i Watford che andranno incontro a dei guai se le cose vanno storte. Il capitano è proprietario delle loro case... Che cosa succederebbe se loro rifiutassero di pagare l’affitto? Quegli uomini hanno combattuto per ben tre giorni a Fairfax. Ho sentito che hanno spogliato il poliziotto e l’hanno picchiato con dei bastoni, e poi l’hanno fatto tornare a casa a piedi nudo come un verme.» «Ma noi a St. Andrew non abbiamo nemmeno il messo comunale» dissi, preoccupata dal racconto di mio fratello. «Probabilmente il capitano radunerà i suoi taglialegna più grossi e forti e li manderà da Daughtery a farsi dare i soldi.» C’era un’aria di soggezione nelle parole di Nevin; il suo rispetto per l’autorità e il desiderio di vedere la giustizia prevalere – tratti ereditati da mio padre, senza ombra di dubbio – sembravano più forti del suo desiderio di vedere Jonathan cadere in disgrazia. Daughtery e Olmstrom... Il capitano e Jonathan... perfino la compassata signora Watford e il suo altrettanto altezzoso fratello... mi sentii umiliata dalla mia ignoranza e provai un invidioso rispetto per la capacità di mio fratello di percepire il mondo in tutta la sua complessità. Mi domandai che cos’altro non sapessi, non capissi. «Credi che nostro padre si unirà a loro? Lo arresteranno?» sussurrai, terrorizzata. «Il capitano non è proprietario di casa nostra» mi informò Nevin con disdegno, visto che non lo sapevo. «Nostro padre è il proprietario. Ma credo che sia d’accordo con quello che sta dicendo quel tipo.» Indicò col mento il predicatore. «Nostro padre è venuto in questi territori, come tutti gli altri, pensando che qui sarebbe stato libero. Ma le cose non sono andate esattamente così. Molti faticano a tirare avanti, e intanto i St. Andrew sono sempre più pieni di soldi. Lo ripeto» aggiunse, scalciando il terreno e sollevando una piccola nube di polvere secca, «il tuo bello rischia di andare incontro a dei guai.» «Non è il mio bello» replicai stizzita. «Oh, ma tu lo vorresti eccome, che fosse il tuo ragazzo» mi aizzò lui. «E Dio solo sa perché, poi. Mi sa che c’è qualcosa che non va in te, Lanore, se sei così infatuata di quel bastardo.» «Sei solo geloso, ecco perché lo odi.» «Geloso io?» biascicò Nevin. «Di quel bellimbusto?» Fece una risata sarcastica e preferì andarsene piuttosto che ammettere che avevo ragione. Circa una trentina di nostri concittadini seguì il predicatore a casa dei Dales dall’altra parte del promontorio; lì, disse lui, avrebbe continuato a parlare con quelli che fossero davvero interessati. I Dales avevano una casa piuttosto grande, ma ci stavamo comunque stretti. Tutti, però, accettavamo la scomodità di buon grado pur di ascoltare altre parole di quell’oratore così affascinante. La signora Dales accese un fuoco nell’ampio camino della cucina, perché anche se eravamo in estate la sera faceva comunque freddo. Fuori il cielo era diventato scuro, color pervinca con una fascia rosa brillante all’orizzonte. Nevin era furioso con me. Avevo implorato i miei genitori di consentirmi di ascoltare il predicatore e mio padre aveva acconsentito a patto che ci fosse un adulto con me. Quindi aveva ordinato a Nevin di accompagnarmi. Mio fratello era diventato rosso in viso e fumante di rabbia, ma non poteva rifiutare niente a mio padre, quindi si era rassegnato a seguirmi con passo infuriato fino dai Dales. Nonostante tutto il suo attaccamento alla tradizione, tuttavia, Nevin aveva un tratto ribelle e non potevo fare a meno di pensare che fosse segretamente contento di avere una scusa per ascoltare il resto del discorso. Il predicatore si mise in piedi accanto al camino della cucina e ci studiò uno per uno. Aveva un ghigno selvaggio in volto. Da vicino, notai che sembrava ancor meno un uomo di Chiesa di quanto avessi pensato vedendolo da lontano, nel campo. Riempiva la stanza della sua presenza, tanto che l’aria sembrava rarefatta e opprimente, come in cima alle montagne. Iniziò ringraziandoci per essere rimasti con lui. Perché aveva serbato un grande segreto per noi, per quelli che seguendolo avevano dimostrato di voler conoscere la verità. E la verità era che la Chiesa – qualunque fosse la singola confessione, che nelle nostre terre era per la maggior parte il congregazionalismo – era il problema più grande, l’istituzione più elitaria, e serviva soltanto a mantenere lo status quo. La sua affermazione suscitò una smorfia di disapprovazione e di rimprovero da parte di Nevin, che si vantava di andare alla messa cattolica con nostra madre, invece che a chiacchierare coi padri fondatori del villaggio e le famiglie più abbienti nella sala della congregazione. Dobbiamo liberarci dei precetti della Chiesa, proseguì il predicatore, lo sguardo sempre scintillante e ferino, uno sguardo che visto da vicino appariva molto meno pacifico. Dobbiamo affidarci a nuovi precetti, più in sintonia con i bisogni dell’uomo comune. E il primo precetto di cui sbarazzarci, il più antico, è l’istituto del matrimonio, disse. In quel momento, dentro quella piccola stanza con trenta persone accalcate, c’era un silenzio di tomba. Il predicatore assediava la cerchia degli astanti come un lupo. Ci assicurò di non essere contro l’amore fra uomo e donna, un amore del tutto naturale. No, lui si ribellava ai limiti legali del matrimonio, al legame indissolubile. Era una cosa contro natura, sostenne, acquistando sicurezza di parola in parola visto che nessuno ancora gli aveva urlato di stare zitto. È nella nostra natura esprimere i nostri sentimenti verso le persone che sentiamo affini a noi stessi. Come figli di Dio, avremmo dovuto praticare un «matrimonio spirituale», insistette: scegliere compagni o compagne con cui sentiamo un legame spirituale. Compagni?, chiese una donna, alzando la mano. Più di un marito? O di una moglie? Gli occhi del predicatore si illuminarono. Sì, avevamo sentito bene: compagni e compagne, perché un uomo aveva diritto ad avere tante mogli quante spiritualmente ne voleva, e lo stesso per una donna. Lui stesso aveva due mogli, spiegò, ma aveva incontrato mogli spirituali in ogni città che aveva visitato. Il gruppo fu attraversato da un risolino nervoso e l’atmosfera della stanza vibrò di desiderio trattenuto. Lui si infilò i pollici sotto i risvolti del soprabito. Non si aspettava certo che le menti illuminate di St. Andrew fossero convinte facilmente dal matrimonio spirituale, sulla sola base della sua parola. No, si aspettava che riflettessimo su quell’idea, che ragionassimo sul modo in cui consentivamo alla legge di regolare in tutto e per tutto le nostre vite. Solo guardandoci dentro avremmo capito se quello che ci stava dicendo era la verità. Poi batté una volta le mani e il suo volto smise di essere serio, e quando sorrise sembrò un’altra persona. Ora però basta con questi discorsi, disse. Lo avevamo ascoltato tutto il pomeriggio, era giunto il momento di divertirci un po’. Cantiamo qualche inno dei più allegri, alziamoci in piedi e balliamo! Quella sì che era una rivoluzione rispetto ai soliti sermoni – inni allegri? Danze? La sola idea era eretica. Eppure, dopo soltanto un momento di esitazione, parecchie persone si alzarono e cominciarono a tenere il tempo battendo le mani e a cantare qualcosa di più simile a una canzone da marinai che a un inno. Diedi di gomito a mio fratello. «Portami a casa, Nevin.» «Hai sentito abbastanza, vero?» disse lui, tirandosi su in piedi. «Sì, anch’io. Sono stufo marcio di ascoltare le sciocchezze di quell’uomo. Aspettami qui, vado a chiedere una lanterna ai Dales. La strada sarà tutta al buio, ormai.» Rimasi in bella evidenza accanto alla porta, augurandomi che Nevin facesse in fretta. Eppure, le parole del predicatore mi rimbombavano ancora nelle orecchie. Avevo visto gli sguardi delle donne, tra il pubblico, quando lui le guardava. Il sorriso le illuminava tutte. Si immaginavano insieme a lui, o forse con un altro uomo del villaggio con cui sentivano un legame spirituale... E non potevano fare a meno di sperare che in qualche modo quei desideri si realizzassero. Il predicatore aveva espresso l’idea più folle mai concepita, un abominio morale. Eppure era un uomo di Chiesa, un predicatore. Aveva parlato in alcune delle chiese più importanti delle città costiere, a quanto dicevano le voci che l’avevano preceduto. Questo non gli conferiva forse una qualche autorità? Sotto i miei vestiti, mi sentii avvampare di calore e di vergogna, perché a dire la verità anche a me sarebbe piaciuto godere della libertà di condividere le mie passioni con qualsiasi uomo desiderassi. Naturalmente, in quel momento l’unico uomo che desideravo era Jonathan, ma come potevo escludere che prima o poi ne avrei incrociato un altro? Forse qualcuno altrettanto affascinante e attraente del predicatore? Capivo bene perché le donne lo trovassero intrigante; quante mogli spirituali aveva incontrato il predicatore nei suoi viaggi? mi chiesi. Mentre stavo sulla porta, persa nei miei pensieri, osservando i miei vicini danzare un reel (era la mia immaginazione o gli uomini e le donne continuavano a lanciarsi sguardi di desiderio mentre passavano gli uni accanto alle altre sulla pista da ballo improvvisata?), mi accorsi all’improvviso della presenza del predicatore accanto a me. Con il suo sguardo penetrante e i lineamenti marcati, era molto attraente e sembrava perfettamente consapevole del suo potere seduttivo. Sorrise, mostrandomi gli incisivi bianchissimi e affilati. «Vi ringrazio per esservi unita a me e ai vostri concittadini questa sera» disse, chinando il capo. «Ne deduco che anche voi siete una ricercatrice spirituale desiderosa di un’illuminazione superiore, signorina...?» «McIlvrae» risposi, indietreggiando di mezzo passo. «Lanore.» «Reverendo Judah Van der Meer.» Mi prese la mano e strinse leggermente la punta delle mie dita. «Che cosa ne pensate del mio sermone, signorina McIlvrae? Mi auguro che non vi abbia turbato troppo» disse, e i suoi occhi ebbero nuovamente un guizzo, come se si divertisse a provocarmi. «E che la franchezza con cui espongo le mie convinzioni non sia stata eccessiva.» «Turbata da cosa, reverendo?» risposi con voce soffocata. «Dal concetto di matrimonio spirituale. Sono certo che una giovane donna come voi possa trovarsi d’accordo con il principio a fondamento di questo concetto, e cioè rendere giustizia alle proprie passioni. E se non erro, voi mi parete una donna animata da passioni grandi e profonde.» Mentre parlava il suo sguardo diventava sempre più veemente – questo sono sicura di non essermelo immaginato – percorrendo il mio corpo da capo a piedi con la medesima sicurezza che avrebbe avuto se avesse usato le mani. «E ditemi, signorina Lanore, voi mi sembrate dell’età giusta per prendere marito. La vostra famiglia vi ha già costretta alla schiavitù del fidanzamento? Sarebbe un vero peccato se una giovane donna bella come voi dovesse passare il resto della vita in un letto matrimoniale con un uomo per il quale non prova attrazione. È un vero peccato trascorrere tutta la propria vita senza sapere che cosa vuol dire l’autentica passione fisica», e i suoi occhi scintillarono ancora, come se fosse sul punto di avventarsi su una preda, «perché tale passione non è nient’altro che il dono più grande di Dio ai suoi figli.» Il cuore mi stava per esplodere nel petto e mi sentivo come un coniglio intrappolato da un lupo. Poi però d’un tratto lui rise, mi poggiò una mano sul braccio – provocandomi un brivido che mi salì fino alla nuca – e mi si fece vicino, abbastanza da sentire il suo respiro sul mio volto e uno dei suoi riccioli sfiorarmi la guancia. «Oh, mi sembrate sul punto di svenire! Credo che abbiate bisogno di un po’ d’aria fresca... Vi va di venire fuori con me?» Mi teneva già per il braccio e non attese la mia risposta, ma mi condusse in fretta sul patio. L’aria notturna era molto più frizzante e fredda di quella pesante dentro la casa e respirai a fondo più volte finché il mio corsetto non mi impedì di inspirarne di più. «Vi sentite meglio ora?» Dopo che ebbi annuito, continuò: «Devo dirvi, signorina McIlvrae, che mi ha reso felice vedere che vi univate a noi in questo contesto più intimo. Ho sperato che lo faceste. Vi ho notata nel campo, questo pomeriggio, e ho capito subito che dovevo conoscervi. Ho avvertito un immediato legame con voi. L’avete percepito anche voi, vero?» Prima che potessi replicare, mi prese la mano fra le sue. «Ho trascorso quasi tutta la mia vita viaggiando per il mondo, spinto dal bisogno di conoscere persone diverse. E di tanto in tanto mi è capitato di incontrare persone straordinarie. Persone la cui eccezionalità è visibile anche da una parte all’altra di un campo pieno di gente. Persone come voi.» Aveva uno sguardo febbrile e selvaggio, come di chi insegue un pensiero senza riuscire a metterlo a fuoco, e io iniziai a provare paura. Perché aveva scelto me? O forse non ero stata scelta, forse lo diceva a tutte le ragazze sufficientemente impressionabili da prendere in considerazione la sua idea di matrimonio spirituale. Si addossò a me in modo troppo familiare, oltre i confini della decenza, e sembrava godesse del mio imbarazzo. «Eccezionale? Reverendo, voi non mi conoscete affatto.» Lo spinsi da parte, ma lui continuò ostinato a rimanermi di fronte. «Non c’è niente di straordinario in me.» «Oh, sì che c’è, invece. Riesco a sentirlo. E anche voi lo sentite. Avete una sensibilità speciale, un’indole particolarmente primordiale. Lo vedo nel vostro viso così grazioso e delicato.» La sua mano mi sfiorò la guancia, come se provasse un impulso irresistibile a toccarmi. «Voi traboccate di desiderio, Lanore. Una creatura sensuale. Voi bruciate di ardore, di desiderio di conoscere il legame fisico tra uomo e donna... È la prima cosa in cima ai vostri pensieri. La vostra fame è evidente. Forse c’è un uomo in particolare che...?» Certo che c’era, era Jonathan, ma pensai che il reverendo intendesse scoprire se desideravo lui. «Questi non sono discorsi appropriati, reverendo.» Feci un passo di lato e cercai di aggirarlo. «Ora credo che dovrei tornare dentro...» Lui mi afferrò nuovamente il braccio. «Non volevo mettervi a disagio e se l’ho fatto me ne scuso. Non ne parlerò più... Ma vi prego, ascoltatemi ancora un minuto. Devo farvi una domanda, Lanore. Quando sono arrivato sul campo oggi pomeriggio e vi ho vista, ho notato che stavate parlando con un giovane a cavallo. Un ragazzo di straordinaria bellezza.» «Jonathan.» «Sì, è quello il nome che mi hanno riferito. Jonathan.» Il reverendo si passò la lingua sulle labbra. «I vostri concittadini mi hanno detto che questo giovanotto potrebbe simpatizzare con le mie vedute filosofiche. Vorrei che voi me lo presentaste.» Avvertii un formicolio alla nuca. «Perché volete conoscere Jonathan?» Lui fece una risata nervosa. «Be’, come vi ho spiegato, da quanto mi hanno detto sembra un discepolo perfetto per me, il tipo d’uomo che può davvero apprezzare la verità delle mie parole. Potrebbe sposare la mia causa e forse diffondere la mia dottrina qui, in queste terre selvagge.» Lo guardai negli occhi e per la prima volta notai la sua perversione: quell’uomo amava il caos e la distruzione. Voleva seminare quella stessa perversione dentro Jonathan, così come cercava di seminarla in ogni città che visitava. Come aveva sperato di seminarla in me. «I miei concittadini si stanno divertendo alle vostre spalle, temo. Voi non conoscete Jonathan, ma io sì, meglio di chiunque altro. Non credo che gli interesserebbero molto le vostre teorie.» Non so perché provai il bisogno di proteggere Jonathan da quell’uomo. Ma c’era qualcosa di minaccioso nel suo interesse per lui. Il reverendo non gradì la mia risposta. Forse sapeva che stavo mentendo, o forse non accettava di essere ostacolato nei suoi piani. Mi fissò a lungo, cercando di intimorirmi, mentre pensava a quale mossa attuare per ottenere quello che voleva. E per la prima volta pensai di essere veramente in pericolo: quell’uomo sembrava capace di qualsiasi cosa. Proprio in quel momento, Nevin apparve di fronte a noi con una torcia accesa in mano, e per una volta fui contenta di vederlo. «Lanore! Ti stavo cercando. Sono pronto, andiamo, dai!» urlò. «Buona notte» dissi, allontanandomi dal reverendo, con la speranza di non incontrarlo mai più. Sentii il suo sguardo feroce sul mio collo mentre io e Nevin ce ne andavamo. «Contenta della tua piccola gitarella culturale?» mi abbaiò Nevin mentre ci dirigevamo verso la strada principale. «Non è stato come mi aspettavo.» «Lo credo bene. Quell’uomo è un pazzo, probabilmente per via delle malattie che si porta dietro» disse Nevin, alludendo alla sifilide. «Eppure, ho sentito che ha un sacco di seguaci a Saco. Mi chiedo come mai si sia spinto così a nord.» A Nevin non venne in mente che quell’uomo poteva essere stato costretto all’esilio dalle autorità. Forse nella sua follia aveva concepito visioni e grandiose predizioni e aveva messo strane e pericolose idee in testa a ragazzine suggestionabili, minacciando persone che non erano così disposte a fare quello che lui voleva. Mi avvolsi più stretta nello scialle. «Apprezzerei molto se tu non riferissi a nostro padre quello che ha detto il predicatore...» Nevin fece una risata maligna. «Non credo proprio che lo farò. Riesco a malapena a ricordarmi le blasfemie di quell’uomo, figuriamoci ripeterlo a nostro padre. Poligamia, figuriamoci! ’Matrimonio spirituale’! Non so che cosa farebbe nostro padre, probabilmente riempirebbe me di frustate e chiuderebbe te nel granaio finché non compi ventun anni soltanto per aver ascoltato i discorsi di quell’eretico.» Scosse il capo. «Ti dirò una cosa, però. Di certo gli insegnamenti di quel predicatore si adatterebbero bene al tuo Jonathan. Ha già preso come mogli spirituali metà delle ragazze del villaggio.» «Basta parlare di Jonathan» dissi, tenendo per me lo strano interesse del reverendo per Jonathan, in modo da non dare ulteriori conferme alla pessima opinione di Nevin su di lui. «Lasciamo perdere tutta questa storia.» Rimanemmo in silenzio per tutto il resto della lunga camminata verso casa. Nonostante il freddo notturno, mi sentivo ancora avvampare per lo sguardo lascivo del predicatore, ripensando al momento in cui avevo intuito la sua vera natura. Non sapevo come interpretare il suo interesse verso Jonathan o la sua affermazione circa la mia «sensibilità speciale». Era così palese il mio desiderio di sperimentare l’unione fra uomo e donna? Eppure quel mistero costituiva l’essenza stessa dell’esperienza umana; era poi così contro natura o immorale che una ragazza fosse così curiosa di sperimentarlo? I miei genitori e il pastore Gilbert probabilmente la pensavano così. Camminai lungo la strada deserta sentendomi agitata, eccitata da tutti quei discorsi sul desiderio. Il pensiero di conoscere Jonathan, o altri uomini del villaggio, in quel modo, il modo in cui Magda conosceva gli uomini, mi faceva sentire calda e umida dentro. Quella sera si era risvegliata la mia vera natura, anche se ero troppo ingenua per rendermene conto, troppo innocente per capire che avrei dovuto sentirmi allarmata dalla facilità con cui il desiderio poteva accendersi dentro di me. Avrei dovuto combatterlo con più fierezza, ma forse non sarebbe servito a niente. La nostra vera natura alla fine vince sempre. 7 Gli anni passarono, in apparenza indistinguibili l’uno dall’altro. Ma c’erano sottili eppur evidenti differenze: io ero sempre meno incline a seguire le regole stabilite dai miei genitori e agognavo una mia indipendenza; crescendo, avevo sviluppato una forte insofferenza verso l’atteggiamento sentenzioso dei miei concittadini. Quel carismatico predicatore fu arrestato a Saco, condotto in giudizio e imprigionato, ma riuscì a scappare e scomparve misteriosamente. Tuttavia, la sua uscita di scena non bastò a calmare le acque, che in realtà appena sotto la superficie continuavano a ribollire. C’era una corrente di rivolta nell’aria, palpabile anche in una cittadina isolata come St. Andrew. Si parlava sempre più insistentemente di indipendenza dal Massachusetts, di fondazione di uno Stato autonomo. Se i proprietari terrieri come Charles St. Andrew si preoccupavano delle possibili conseguenze negative sui loro affari, lo nascondevano bene e non lo mostravano a nessuno. Il mio interesse verso faccende importanti come queste crebbe col tempo, anche se avevo ben poche occasioni per soddisfare la mia curiosità. Gli unici argomenti di conversazione adatti a una giovane donna, a quanto pareva, erano confinati all’ambiente domestico: come preparare una morbida pagnotta alla melassa o mungere una vacca non più giovane, come cucire alla perfezione, quale fosse il modo migliore per curare la febbre a un bambino. Tutte prove per stabilire il nostro valore come future spose, immagino, ma a me interessavano ben poco competizioni di quel tipo. C’era soltanto un uomo che volevo come marito e a quell’uomo non interessava per niente quanto fosse morbida una fetta di pane. Tra le varie incombenze domestiche, quella che detestavo di più era fare il bucato. Per i carichi leggeri di vestiti, bastava andare al ruscello ed era semplice lavarli, strizzarli e farli asciugare. Ma diverse volte all’anno dovevamo fare un lavaggio completo e totale, il che voleva dire preparare un fuoco nel cortile, metterci sopra un grosso calderone e poi far bollire, lavare e asciugare indumenti per tutto il santo giorno. Era una fatica disperata: infilare le braccia nell’acqua bollente con la liscivia, strizzare pesanti indumenti di lana, stenderli ad asciugare sui cespugli o appesi ai rami degli alberi. Bisognava scegliere con cura il giorno del bucato, perché doveva esserci bel tempo e non ci dovevano essere altre faccende urgenti da sbrigare. Mi ricordo uno di quei giorni, era l’inizio dell’autunno del mio ventesimo anno. Mia madre, insolitamente, aveva detto a Glynnis e Maeve di aiutare mio padre nel raccolto del fieno e di fronte alle proteste aveva insistito che io e lei ce la saremmo cavate benissimo a fare il bucato da sole. Quella mattina era particolarmente silenziosa e tranquilla, il che non era da lei. Mentre aspettavamo che l’acqua bollisse, armeggiò con l’attrezzatura per il bucato: la sacca di liscivia, la lavanda essiccata, i bastoni che usavamo per muovere i vestiti a bagno nel calderone. «È venuto il tempo che io e te facciamo un discorso serio e importante» disse infine mia madre, mentre eravamo accanto al calderone a osservare le bolle salire in superficie. «È tempo di cominciare a pensare a una vita tutta tua, Lanore. Non sei più una bambina. Ormai hai abbondantemente l’età per sposarti...» A dire il vero, la stavo quasi per superare, quell’età, e da tempo mi chiedevo che intenzioni avessero i miei genitori in proposito. Non avevano organizzato un fidanzamento per nessuno dei loro figli. «... perciò dobbiamo parlare di come fare col signorino St. Andrew.» Trattenne il fiato e mi osservò, sbattendo le ciglia. Alle sue parole, il mio cuore mancò un battito. Che ragione aveva di fare il nome di Jonathan in quel contesto se non perché lei e mio padre avevano intenzione di organizzarmi un fidanzamento con lui? Rimasi senza fiato per la gioia e la sorpresa – quest’ultima per via del fatto che sapevo che mio padre non stimava i St. Andrew, non più. Erano cambiate molte cose da quando tante famiglie avevano seguito Charles St. Andrew a nord. I suoi rapporti con la cittadinanza – con gli uomini che si erano affidati a lui – ormai erano molto tesi. Mia madre mi guardò con franchezza. «Ti parlo da madre che ti vuole bene, Lanore: devi interrompere la tua amicizia con il signorino Jonathan. Voi due non siete più bambini. Continuare in questo modo non può che danneggiarti.» Non sentii più gli schizzi di acqua bollente sulle mie braccia, né il calore del calderone arrossarmi il volto. Ricambiai il suo sguardo, sconvolta. Lei si affrettò a riempire quel silenzio colmo di orrore. «Lanore, devi capire... Quale altro ragazzo potrebbe volerti quando è talmente chiaro che tu sei innamorata di Jonathan?» «Non sono innamorata di Jonathan. Siamo soltanto amici» borbottai. Lei fece una risatina gentile, che però mi ferì ugualmente il cuore. «Non puoi negare il tuo amore per Jonathan. È evidente, mia cara, così come è evidente che lui non prova lo stesso per te.» «Non c’è niente che lui dovrebbe provare, mamma. Siamo soltanto amici, te lo giuro» protestai. «Lo sanno tutti delle sue relazioni...» Mi passai una mano sulla fronte imperlata di sudore. «So tutto. Lui mi dice ogni cosa...» «Ascoltami, Lanore» mi implorò, voltandosi verso di me anche se io cercavo di distogliere lo sguardo. «È facile innamorarsi di un uomo così bello come Jonathan, o così ricco, ma devi resistere. Tra te e Jonathan non è destino.» «E tu come puoi dirlo?» La protesta mi uscì dalle labbra anche se non avevo intenzione di dire niente del genere. «Non puoi sapere quale sarà il futuro mio e di Jonathan.» «Oh, povera ragazza, non dirmi che ormai vedi soltanto lui.» Mi afferrò le spalle e mi scosse. «Non hai alcuna speranza di sposare il figlio del capitano. La famiglia di Jonathan non lo permetterebbe mai, mai. E nemmeno tuo padre lo accetterebbe. Mi spiace da morire che tocchi a me dirti la dura verità, ma...» Non c’era bisogno che me lo dicesse. Naturalmente, mi rendevo perfettamente conto che le nostre rispettive famiglie erano di diverso status sociale, e sapevo che la madre di Jonathan nutriva grandi ambizioni per lui per quanto riguardava il suo matrimonio. Ma è quasi impossibile uccidere i sogni di una ragazza e io cullavo quel sogno da tutta la mia vita. A volte mi pareva di essere nata col desiderio di Jonathan dentro di me. Avevo sempre segretamente creduto che un amore così potente e sincero come il mio alla fine sarebbe stato premiato, e ora venivo costretta ad accettare l’amara verità. Mia madre prese il lungo bastone per rimescolare gli abiti nel calderone e si rimise al lavoro. «Tuo padre ha intenzione di iniziare a cercarti un fidanzato, quindi capisci bene che devi porre termine alla tua amicizia con Jonathan. Dobbiamo sistemare te prima di poter sistemare le tue sorelle» continuò, «quindi comprendi l’importanza di quello che ti sto dicendo, vero, Lanore? Non vuoi che le tue sorelle rimangano per sempre da sole, vero?» «No, madre» risposi, disperata. Le voltavo ancora le spalle, lo sguardo perso in lontananza, cercando di trattenere le lacrime, quando notai del movimento nella foresta oltre la nostra casa. Poteva essere qualunque cosa, benigna o malevola: mio padre e le mie sorelle che rientravano dal raccolto, qualcuno che si spostava da una fattoria all’altra, cervi che brucavano. Seguii con lo sguardo la figura finché non riuscii a distinguerla chiaramente, grande e scura e lucente. Non era un orso. Era un cavallo, con un cavaliere. C’era soltanto un cavallo nero nel villaggio e apparteneva a Jonathan. Perché mai Jonathan cavalcava verso di noi se non per vedermi? Ma oltrepassò casa nostra, dirigendosi verso i nostri vicini, Jeremiah e Sophia Jacobs, che si erano appena sposati. Non c’era alcuna ragione per Jonathan di fare visita a Jeremiah, non che io sapessi. Alzai la mano per sistemarmi dei ciuffi ribelli sotto la cuffietta. «Mamma, sbaglio o mi avevi detto che Jeremiah Jacobs non sarebbe stato a casa questa settimana? Non è andato via?» «Sì che è andato» mi rispose distratta, continuando a mescolare l’acqua. «È a Fort Kent a esaminare un paio di cavalli da tiro; ha detto a tuo padre che sarebbe tornato la settimana prossima.» «E ha lasciato Sophia da sola, quindi?» La figura evanescente era scomparsa dal mio campo visivo, persa nell’oscurità della foresta. Mia madre mormorò un assenso. «Sì, ma lui sa che non c’è ragione di preoccuparsi. Sophia è al sicuro, per una settimana sola.» Col bastone, sollevò dal calderone un indumento fradicio e fumante di vapore. Lo presi e lo portai sotto un albero, dove appendevamo tutti gli indumenti di lana insieme. «Promettimi che lascerai perdere Jonathan e che non cercherai più la sua compagnia» fu l’ultima cosa che mi disse sull’argomento. Ma io stavo pensando alla piccola casetta a due piani della nostra vicina, con il cavallo di Jonathan che attendeva impaziente al di fuori. «Prometto» dissi a mia madre, mentendo con disinvoltura, come se si trattasse di una faccenda da nulla. 8 Mentre l’autunno avanzava e le foglie diventavano color ruggine e dorate, la relazione fra Jonathan e Sophia Jacobs non accennava a cessare. In quei mesi, i miei incontri con Jonathan furono più rari che mai, e dolorosamente brevi. Non era certo colpa di Sophia – Jonathan e io avevamo diversi impegni che ci avrebbero tenuti comunque lontani – ma io le davo la colpa di tutto. Che diritto aveva di appropriarsi in quel modo delle sue attenzioni? Per come la vedevo io, lei non meritava di stare con lui. Il suo peccato principale era che era sposata, e proseguendo in quella relazione stava costringendo Jonathan a uscire dal solco della morale cristiana. Stava condannando all’inferno anche lui, oltre che se stessa. Ma non era solo questa la ragione per cui lei non meritava Jonathan. Sophia non era certo la ragazza più bella del paese; stimavo che ce ne fossero almeno altre venti, di età più o meno uguale, che erano più belle di lei, anche escludendo me stessa per pura modestia. In più, non aveva né la posizione sociale né la ricchezza per ambire a essere una compagna adeguata per un uomo dello status di Jonathan. Le sue abilità domestiche non erano certo brillanti: sapeva cucire abbastanza bene, ma le torte che faceva e portava in chiesa erano farinose e mal cotte. Sophia era intelligente, senza dubbio, ma se qualcuno avesse cercato le donne più intelligenti del villaggio il suo nome non sarebbe stato certo fra i primi a venire in mente. Perciò su che basi aveva il coraggio di prendersi Jonathan, che meritava soltanto il meglio? Io rimasi a tessere l’ultimo lino dell’estate, arrovellandomi nel frattempo sugli strani sviluppi di quella faccenda, maledicendo Jonathan per la sua incostanza. Dopo tutto, quel giorno nel campo dei McDougal non aveva forse detto che sarebbe stato geloso se io mi fossi messa insieme a un altro ragazzo del villaggio? Eppure, era lui a corteggiare segretamente Sophia Jacobs. Una ragazza meno malata d’amore di me avrebbe potuto trarre delle conclusioni ben precise da tutto questo, ma io non ci riuscivo. Preferivo credere che Jonathan avrebbe comunque scelto me, se solo avesse saputo dei miei veri sentimenti. La domenica, dopo la messa, vagavo da sola, lanciando sguardi non ricambiati verso Jonathan, sperando di potergli un giorno dire quanto ardentemente lo desiderassi. Mi incamminavo sui sentieri che conducevano verso la residenza dei St. Andrew chiedendomi cosa stesse facendo Jonathan in quel momento, e nei miei sogni a occhi aperti cercavo di immaginarmi le sue mani sul mio corpo, il suo corpo nudo sul mio, i suoi baci. Adesso arrossisco a pensare al modo ingenuo in cui allora vedevo l’amore! Ero una vergine con un’idea dell’amore ancora casta e cortese. Senza Jonathan, ero profondamente sola. Ed era un’anticipazione di come sarebbe stata la mia vita una volta che Jonathan si fosse sposato e avesse ereditato l’azienda di famiglia e io fossi toccata in moglie a un altro uomo. Ciascuno di noi due sarebbe stato sempre più assorbito dalla sua vita e i nostri cammini non si sarebbero mai più incrociati. Ma quel giorno non era ancora arrivato, e Sophia Jacobs non era sua moglie. Era soltanto un’intrusa che pretendeva di reclamare il suo amore. Fu solo dopo la prima gelata che Jonathan un giorno venne a cercarmi. Com’era cambiato. Sembrava invecchiato di anni. O forse aveva perduto la spensieratezza che lo aveva sempre animato: ora era serio. Adulto. Mi venne a cercare nel campo; ero lì con le mie sorelle, a raccogliere l’ultimo fieno lasciato a essiccare al sole estivo per portarlo nel granaio, dove conservavamo l’erba medica che avrebbe nutrito le vacche durante il lungo inverno. «Lasciate che vi aiuti» disse, saltando giù da cavallo. Le mie sorelle, vestite come me con abiti logori e con fazzoletti annodati sul capo per tenere a bada i capelli, lo guardarono di traverso e ridacchiarono. «Non essere ridicolo» gli dissi, prendendo il suo bel cappotto di lana e le brache di pelle di daino. Raccogliere il fieno era un lavoro faticoso ed estenuante. E comunque, mi bruciava ancora il suo abbandono e mi ripetei che non volevo accettare niente da lui. «Dimmi perché sei qui e basta» gli comunicai secca. «Temo che le mie parole siano per te soltanto. Non potremmo fare almeno due passi insieme?» mi chiese, sorridendo alle mie sorelle per mostrare che non intendeva certo mancar loro di rispetto. Gettai a terra il mio forcone, mi sfilai i guanti e mi incamminai in direzione degli alberi. Lui si affrettò a seguirmi, conducendo il suo cavallo al seguito per una redine. «È parecchio tempo che non ci vediamo, vero?» esordì in modo poco convincente. «Non ho tempo per i convenevoli» gli risposi. «Come hai visto, ho del lavoro da fare.» Lui abbandonò subito ogni finzione. «Ah, Lanny. Non sono mai stato capace di nasconderti niente. Mi sei mancata, ma non è per questo che sono qui oggi. Ho bisogno di un tuo consiglio. Non sono mai stato bravo a giudicare i miei problemi mentre tu sembri sempre capace di vedere le cose con chiarezza e trovare una soluzione, non importa quale sia la natura del problema.» «Puoi anche smetterla di lusingarmi» dissi, asciugandomi il sudore con una manica lurida. «Non sono certo il re Salomone. Ci sono persone ben più sagge in questo villaggio cui potresti rivolgerti, quindi il fatto che tu sia venuto da me significa che ti sei ficcato in qualche guaio di cui non osi parlare a nessun altro. Forza, sputa il rospo. Che cos’hai combinato stavolta?» «Hai ragione. Non c’è nessuno cui possa rivolgermi, tranne te.» Jonathan distolse il suo bellissimo volto dal mio sguardo, imbarazzato. «Si tratta di Sophia, so che l’hai capito, e so che il suo è l’ultimo nome che vorresti sentire...» «Non ti immagini nemmeno quanto» borbottai, rimboccando un angolo della gonna alla vita per allontanare l’orlo dal terreno. «In questi mesi siamo stati abbastanza felici insieme, Lanny. Non l’avrei mai creduto possibile. Siamo così diversi, eppure... La sua compagnia mi è immensamente gradita. Ha un carattere indipendente, e non ha timore alcuno di far valere le sue opinioni.» Continuò a parlare, senza accorgersi che io invece mi ero bloccata, a bocca aperta. Perché, io invece non avevo il coraggio delle mie opinioni? Certo, forse non gli avevo detto come la pensavo su tutti gli argomenti, ma non avevamo parlato da amici, da pari? Il fatto che ritenesse il comportamento di Sophia così peculiare, così unico, mi faceva impazzire. «Ed è ancora più straordinaria considerando la famiglia da cui proviene» proseguì lui. «Mi racconta certe cose su suo padre... È un ubriacone, un giocatore d’azzardo, e picchia regolarmente la moglie e le figlie.» «Tobey Ostergaard» dissi. Mi sorprendeva che Jonathan non sapesse nulla della pessima reputazione di Tobey, ma questo dimostrava ancora una volta quanto fosse isolato dal resto della comunità. Tutti sapevano dei problemi di Ostergaard. Nessuno lo riteneva un buon padre, né un buon capofamiglia. Incapace di lavorare la terra o allevare bestiame, Tobey si era ridotto a scavare tombe nel fine settimana per guadagnare qualcosina, che poi di solito spendeva per ubriacarsi. «Il fratello di Sophia è scappato di casa un anno fa» dissi a Jonathan. «Ha litigato col padre e Tobey l’ha colpito al volto con la vanga del cimitero.» Jonathan sembrò sinceramente impressionato. «La sua infanzia difficile ha indurito il temperamento di Sophia, eppure non è diventata cinica e amara, nemmeno dopo il suo disgraziato matrimonio. Si pente amaramente di aver acconsentito all’unione, specialmente ora che...» Le sue parole si spensero nel nulla. «Ora che... cosa, Jonathan?» insistei, con la paura alla gola. «Mi ha detto che è incinta» sbottò Jonathan, voltandosi finalmente verso di me. «Giura che il bambino è mio. Non so cosa fare, sono disperato.» Aveva il terrore dipinto in volto e, sì, anche il timore per avermi confessato la verità. L’avrei preso a schiaffi se non fosse stato così evidente che non era sua intenzione ferirmi. Eppure, avrei voluto rimproverarlo aspramente: era da mesi che andava avanti con quella donna sposata, che cosa si aspettava? Era già strano che non fosse successo prima. «Che cosa pensi di fare?» gli chiesi. «Sophia ha intenzioni chiarissime: vuole che ci sposiamo e che cresciamo il bambino insieme.» Mi sfuggì una risata sarcastica. «Dev’essere impazzita. La tua famiglia non lo permetterebbe mai.» Mi lanciò uno sguardo fuggevole ma così carico di rabbia da farmi pentire della mia osservazione. «Dimmi» proseguii in tono più conciliante, «cosa vorresti fare tu?» Jonathan scosse il capo. «Te l’ho detto, Lanny, non riesco a prendere una decisione su questa faccenda.» Non sapevo se credergli, comunque. C’era una nota di esitazione nelle sue parole, come se ci fossero pensieri cui non osava dare voce. Sembrava molto cambiato rispetto al Jonathan che conoscevo, il mascalzone che aveva intenzione di rimanere libero da legami il più a lungo possibile. Se solo avesse saputo il conflitto interiore che il suo dilemma mi suscitava. Da un lato, sembrava così disperato e disarmato, incapace di vedere una via d’uscita, che non potevo che provare pietà per lui. Dall’altro, il mio orgoglio era ferito come pelle appena squarciata da un taglio. Mi mossi attorno a lui, mordendomi una nocca. «Be’, cerchiamo di vedere le cose in modo chiaro e spassionato. Sai benissimo come lo so io che ci sono rimedi precisi per faccende come questa. Deve andare dalla levatrice e...» Pensai a Magda: di certo lei avrebbe saputo come cavarsela in situazioni come quella, visto il lavoro che faceva. «Ho sentito che basta bere una pozione fatta con certe erbe per risolvere il problema.» Rosso in volto, Jonathan scosse ancora il capo. «Non vuole. Vuole tenere il bambino.» «Ma non può! Sarebbe una follia esporre così il suo tradimento!» «Se un comportamento come questo equivale a follia, allora, sì, è pazza.» «Ma... e tuo padre? Hai preso in considerazione l’idea di rivolgerti a lui per un consiglio?» Il suggerimento non era del tutto campato in aria: Charles St. Andrew era noto per andare a caccia di servette e probabilmente si era già trovato almeno un paio di volte nella situazione di Jonathan. Ma Jonathan sbuffò come un cavallo ritroso. «Credo che dovrò confidarlo al vecchio Charles, ma non ne sono certo impaziente. Lui saprebbe cosa dire a Sophia, ma ho paura delle conseguenze.» Il che voleva dire, immaginai, che Charles St. Andrew avrebbe costretto suo figlio a interrompere ogni relazione con Sophia e, bambino o meno, non si sarebbero più visti. O peggio, avrebbe potuto insistere perché Jeremiah sapesse la verità, e Jeremiah avrebbe potuto chiedere il divorzio alla moglie adultera e fare causa a Jonathan. Oppure avrebbe potuto estorcere denaro ai St. Andrew in cambio del suo silenzio e crescere il bambino come suo, ma pagato da loro. Era difficile prevedere come sarebbero andate le cose se fosse intervenuto il vecchio St. Andrew. «Mio caro Jonathan» mormorai, cercando freneticamente il consiglio giusto da dargli. «Sono addolorata per questo tuo... incidente. Ma prima di andare da tuo padre, lasciami riflettere per un giorno. Forse mi verrà in mente una soluzione.» «Mia adorata Lanny» rispose, lanciando uno sguardo indietro verso le mie sorelle, che ora ci erano nascoste da un cumulo di balle di fieno. «Come sempre, sei la mia salvezza.» Prima che potessi rendermi conto di quello che stava succedendo, mi prese per le spalle e mi attirò a sé, facendomi alzare sulle punte dei piedi per baciarmi. Ma non fu un bacio amichevole: la forza del suo bacio mi ricordò che poteva evocare il mio desiderio a suo piacimento. Io ero sua. Mi tenne stretta eppure tremava. Eravamo entrambi senza fiato quando mi lasciò. «Sei il mio angelo» mi sussurrò con voce roca all’orecchio. «Senza di te sarei perduto.» Si rendeva conto dell’effetto delle sue parole su una persona disperatamente innamorata di lui? Mi chiesi se non l’avesse fatto per convincermi a risolvere il guaio in cui si era ficcato, o se fosse venuto da me semplicemente per cercare rassicurazioni dall’unica ragazza che sapeva per certo che l’avrebbe sempre amato, a prescindere da quello che combinava. Mi piaceva pensare che una parte di lui mi amasse e che fosse dispiaciuto di avermi delusa. Non posso però affermare di conoscere con certezza quali fossero le sue intenzioni in quel momento; credo che non lo sapesse nemmeno lui. In fondo, era soltanto un ragazzo e si era messo in seri pasticci per la prima volta in vita sua; forse Jonathan era così ingenuo da credere che se Dio gli avesse perdonato quell’imprudenza, lui si sarebbe messo sulla retta via e si sarebbe accontentato dell’unica ragazza che l’avrebbe amato senza riserve. Rimontò sulla sella e rivolse un educato cenno di saluto alle mie sorelle, poi diresse il cavallo verso casa sua. E prima ancora che lui giungesse al limitare del campo e sparisse dalla mia vista, io elaborai un piano. Ero una ragazza intelligente, ma soprattutto non c’era niente che potesse fermarmi quando si trattava di Jonathan. Decisi di fare visita a Sophia e di parlarle in privato. Aspettai di aver chiuso le nostre galline nel pollaio per la notte, così che la mia assenza non venisse notata, prima di dirigermi verso la fattoria dei Jacobs. La loro proprietà era molto più tranquilla della nostra, forse perché avevano meno bestiame e perché c’erano soltanto marito e moglie a prendersi cura di tutto. Mi intrufolai nel granaio, sperando di evitare Jeremiah e di trovare Sophia da sola, e fu così. Stava chiudendo le loro tre cenciose pecore dentro la stalla per la notte. «Lanore!» Ebbe un moto di sorpresa e si portò le mani sul cuore. Era vestita troppo leggera per stare all’aperto, con soltanto uno scialle di lana sulle spalle invece che un mantello per tenere a bada il gelo. Sophia doveva sapere della mia amicizia con Jonathan e solo Dio sa che cosa lui le avesse detto di me (o forse era stupido credere che lui rivolgesse anche un solo pensiero a me quando era in sua compagnia). Mi guardò con il gelo negli occhi, senza dubbio preoccupata del motivo per cui ero andata da lei. Dovetti sembrarle ancora una bambina, anche se avevo soltanto pochi anni in meno di lei; ma non ero ancora sposata e vivevo a casa dei miei genitori. «Perdonami per essere venuta da te senza preavviso, ma dovevo parlarti da sola» le dissi, guardandomi attorno per accertarmi che suo marito non fosse nei paraggi. «Parlerò chiaro, non c’è tempo per le smancerie. Credo tu sappia perché sono venuta qui a parlare con te. Jonathan mi ha detto...» Lei incrociò le braccia e il suo sguardo si fece d’acciaio. «Te l’ha detto, vero? Doveva proprio vantarsi con qualcuno di avermi messa incinta?» «Niente del genere! Se credi che sia contento che tu stia per avere un figlio...» «Non un figlio. Suo figlio» mi corresse. «E so benissimo che non è contento.» Vidi un’occasione. Mi ero chiesta che cosa avrei detto a Sophia sin dal momento in cui Jonathan se n’era andato a cavallo il giorno prima. Jonathan era venuto da me perché gli serviva qualcuno che non avesse paura di affrontare Sophia al posto suo. Qualcuno che le facesse capire la debolezza della sua posizione. Sophia si sarebbe resa conto che io capivo perfettamente quello che avrebbe dovuto affrontare; ci sarebbe stato meno spazio per congetture e ricatti sentimentali. Non lo facevo perché odiavo Sophia, mi ripetei, né perché non sopportavo che lei avesse usurpato il mio posto a fianco di Jonathan. No, io avevo capito perfettamente la natura di Sophia. E stavo salvando Jonathan dalla trappola di quella astuta megera. «Con tutto il rispetto, posso chiederti quali prove hai che il bambino sia veramente di Jonathan? Abbiamo soltanto la tua parola e...» Lasciai sospesa la frase, così che fosse lei stessa a coglierne le implicazioni. «E tu chi sei, l’avvocato di Jonathan?» Non raccolsi la sua provocazione e lei avvampò di vergogna. «Sì, hai ragione, potrebbe essere anche di Jeremiah, ma io so che è di Jonathan. Lo so.» Si portò le mani al ventre, anche se ancora non mostrava alcun segno di gravidanza. «E ti aspetti che Jonathan si rovini la vita solo perché tu sei convinta che...» «Rovinare la sua vita?» urlò. «E la mia allora?» «Giusto, la tua» dissi, raddrizzando la schiena più che potevo. «Hai pensato a che cosa succederebbe se tu accusassi pubblicamente Jonathan di essere il padre di tuo figlio? Otterresti soltanto di far sapere a tutti che sei una donna facile...» Sophia sbuffò, voltandosi di scatto e allontanandosi da me, come se non volesse sentire una sola parola di più. «... e lui negherà tutto. Negherà di essere il padre del tuo bambino. E chi ti crederà, Sophia? Chi potrebbe mai credere che Jonathan St. Andrew abbia scelto di andare con te quando avrebbe potuto avere qualsiasi donna del villaggio?» «Jonathan mi rinnegherà?» mi domandò incredula. «Non sprecare il fiato, Lanore. Non mi convincerai mai che il mio Jonathan possa rinnegarmi.» Il mio Jonathan, aveva detto. Le guance mi si infiammarono, il cuore prese a martellarmi. Non so dove trovai la forza di dire a Sophia le cose orrende che le dissi in quel momento. Fu come se un’altra persona fosse rimasta nascosta dentro di me, una persona con capacità che non avevo mai sognato di possedere, e questa persona fosse stata evocata con la stessa facilità con cui si evoca un genio della lampada. Fui accecata dalla rabbia; sapevo soltanto che Sophia stava minacciando Jonathan, minacciava di rovinargli la vita, e non avrei permesso a nessuno al mondo di recargli danno. Non era il suo Jonathan, era il mio. Lo avevo reclamato anni prima, nel vestibolo della chiesa, e per quanto potesse sembrare stupido, sentii la possessività crescermi dentro, feroce e primordiale. «Non farai altro che renderti ridicola. La donna più sciatta di St. Andrew che sostiene che lo scapolo più desiderato del villaggio è il padre del suo bambino, non quel rozzo di suo marito. Quell’allocco che lei disprezza.» «Ma è davvero figlio di Jonathan» mi rispose con aria di sfida. «E lui lo sa. Non si preoccupa delle sorti del sangue del suo sangue?» Quello mi fermò; avvertii una punta di senso di colpa. «Fai una bella cosa, Sophia, e dimentica questo folle piano. Hai già un marito, digli che il bambino è suo. Sarà contento della notizia. Sono sicura che Jeremiah vuole dei bambini.» «Sì che li vuole, ma li vuole suoi» sibilò. «Non posso mentire a Jeremiah su una cosa come questa.» «E perché no? Gli hai già mentito sulla tua fedeltà, no?» osservai sprezzante. Il suo odio verso di me in quel momento era così tangibile che pensai mi avrebbe assalito come un serpente. Era giunto il momento dell’affondo decisivo, quello al cuore. La guardai dalla testa ai piedi con occhi socchiusi. «Sai bene che la punizione per un’adultera è la morte. È ancora questa la posizione della Chiesa al riguardo. Se vuoi proprio ostinarti nella tua decisione, pensaci bene. Segnerai il tuo destino.» Era una minaccia vuota: nessuna donna sarebbe stata messa a morte per adulterio a St. Andrew, né in alcuna città di frontiera, dove le donne in età fertile erano scarse. La punizione di Jonathan, nel caso remoto in cui i cittadini avessero deciso che era colpevole, sarebbe stata di pagare la tassa sui figli illegittimi e forse di essere ostracizzato dai benpensanti del villaggio per qualche tempo. Sarebbe stata senza dubbio Sophia a sopportare il fardello maggiore. Sophia si aggirò in cerchio in preda all’agitazione, come se stesse dando la caccia a degli aguzzini invisibili. «Jonathan!» urlò, anche se a voce non sufficientemente alta perché il marito potesse sentirla. «Come puoi trattarmi così? Ti credevo un uomo d’onore... Credevo che fossi l’uomo giusto... Invece, mandi da me questa vipera» disse, guardandomi con occhi assassini pieni di lacrime, «perché faccia il lavoro sporco al posto tuo. E tu non credere che non sappia perché lo fai» sibilò, puntandomi un dito addosso. «Tutti sanno che sei innamorata di lui e che lui non ti vuole. La tua è soltanto gelosia. Jonathan non ti avrebbe mai mandata qui a trattarmi così.» Mi ero preparata, sapevo di dover restare calma. Arretrai di qualche passo, allontanandomi da lei come se fosse pazza e pericolosa. «Ma certo che mi ha detto di venire da te, altrimenti come potrei sapere che sei incinta? Ha perso ogni speranza di condurti alla ragione e ha chiesto a me di parlarti, da donna a donna. E da donna ti dico: so che cos’hai in mente. Stai facendo di tutto per migliorare la tua posizione, per scambiare tuo marito con un uomo più ricco. Forse non c’è nemmeno un bambino in arrivo. Mi sembri uguale a prima. E per quanto riguarda il mio rapporto con Jonathan, la nostra è un’amicizia speciale, pura e casta e più forte del legame tra fratello e sorella, anche se non mi aspetto certo che una come te lo capisca» aggiunsi in tono altezzoso. «Non sembri nemmeno capace di immaginare una relazione con un uomo che non comporti alzare le gonne. Pensaci bene, Sophia Jacobs. Hai creato tu questo guaio e la soluzione è in mano tua. Scegli la via più facile. Dai un figlio a Jeremiah. E non avvicinarti mai più a Jonathan: non vuole avere più niente a che fare con te» conclusi con decisione, poi me ne andai. Sulla via verso casa, tremai di freddo e di trionfo, i nervi incendiati nonostante il gelo della notte. Avevo fatto ricorso a tutto il mio coraggio per difendere Jonathan e l’avevo fatto con una determinazione che non credevo di possedere. Raramente avevo alzato la voce in vita mia, e non avevo mai imposto il mio modo di vedere con tanta forza a nessuno. Rendermi conto di avere un tale potere dentro di me mi spaventava, ma era anche una scoperta eccitante. Attraversai i boschi verso casa alleggerita e accalorata, sicura che qualsiasi cosa fosse in mio potere. 9 Fu il rumore improvviso a svegliarmi la mattina seguente. Un tiro di schioppo, un pallettone, polvere da sparo. A quell’ora del mattino, uno sparo poteva voler dire soltanto una cosa: guai. Un incendio nella casa di un vicino, una battuta di caccia, un terribile incidente. Quello sparo proveniva dalla fattoria dei Jacobs. Lo capii appena lo udii. Mi tirai la coperta sul volto, fingendo di essere ancora addormentata, ascoltando i mormorii che provenivano dalla camera da letto dei miei genitori al piano di sotto. Udii mio padre alzarsi, vestirsi e uscire. Mia madre lo seguì, probabilmente avvolgendosi in una coperta mentre iniziava le faccende mattutine, accendendo il fuoco e mettendo una pentola d’acqua a bollire. Mi rialzai a sedere sul letto, riluttante ad appoggiare i piedi sul pavimento gelido e iniziare una giornata che si annunciava strana e sfortunata. Mio padre rientrò con un’espressione scura in volto. «Vestiti, Nevin. Devi venire con me» disse rivolto al corpo raggomitolato sotto le coperte al piano terra. Nevin rispose grugnendo. «Devo proprio?» lo sentii chiedere con voce assonnata. «Devo dar da mangiare al bestiame...» «Verrò io con te, padre» dissi dal pianerottolo, vestendomi in fretta. Il mio cuore batteva così forte che sarebbe stato impossibile rimanere a casa ad aspettare notizie su quello che era successo. Dovevo andare con mio padre e vedere di persona. Durante la notte era caduta la neve, la prima nevicata della stagione, e cercai di schiarirmi la mente mentre camminavo dietro a mio padre, concentrandomi soltanto sul seguire le orme che lasciava nella neve fresca. Il mio fiato si condensava nell’aria frizzante e una goccia di muco mi colò dalla narice fin sulla punta del naso. Nell’avvallamento di fronte a noi c’era la fattoria dei Jacobs, una scatoletta marrone al centro di una vasta distesa bianca. La gente aveva iniziato a raggrupparsi lì, ne vedevo le sagome scure stagliarsi contro la neve, e altri arrivavano da tutte le direzioni, a piedi o a cavallo. A quella vista, il mio cuore accelerò ulteriormente i battiti. «Stiamo andando dai Jacobs?» chiesi a mio padre, che mi dava le spalle. «Sì, Lanore» mi rispose seccamente, anche se non per maleducazione: mio padre era un uomo di poche parole. Io riuscivo a malapena a trattenere la preoccupazione. «Che cosa credi che sia successo?» «Lo scopriremo presto» mi rispose pazientemente. C’era un rappresentante di ogni famiglia della comunità, tranne i St. Andrew, ma loro vivevano dall’altra parte del villaggio e non potevano aver sentito lo sparo. Tutti erano vestiti a casaccio: vestaglie, orli di camicie da notte che spuntavano da sotto il cappotto, capelli spettinati. Seguii mio padre attraverso la piccola folla finché non riuscimmo a farci largo sino alla porta d’ingresso, dove trovammo Jeremiah inginocchiato nella neve fresca e fangosa. Si era vestito di fretta, le bretelle male agganciate, gli stivali slacciati, una coperta sulle spalle. Il suo vecchio fucile, l’arma che aveva provocato l’allarme, giaceva appoggiato al sostegno della palizzata. Il suo volto massiccio e sgraziato era contorto dal dolore, gli occhi arrossati, le labbra screpolate e sanguinanti. Di solito era un uomo così impassibile: fu sconvolgente vederlo ridotto così. Il pastore Gilbert si fece largo fino alla prima fila di spettatori, poi si accucciò e parlò quietamente all’orecchio di Jeremiah. «Che cosa succede, Jeremiah? Perché hai lanciato l’allarme?» «Non riesco a trovarla, padre...» «Chi?» «Sophia. Se n’è andata.» Il tono sommesso della sua voce provocò un’ondata di mormorii nella folla, ognuno che sussurrava qualcosa all’orecchio del vicino, tranne me e mio padre. «Andata?» Gilbert posò le mani sulle guance di Jeremiah, cullandogli il volto. «Cosa vuol dire che se n’è andata?» «Se n’è andata, oppure qualcuno l’ha presa. Quando mi sono svegliato, non l’ho trovata in casa. Né nel cortile, né nel granaio. Il suo mantello non c’è, ma tutte le altre sue cose sì.» Sentire che Sophia, nonostante fosse infuriata e non avesse niente da perdere, non aveva detto niente della mia visita a Jeremiah mi tolse un peso dal petto che non mi ero accorta di avere. In quel momento, Dio mi perdoni, non ero preoccupata per una donna che vagava nei boschi, ma per il mio ruolo in quello che era accaduto. Gilbert scosse il capo canuto. «Jeremiah, sicuramente si è soltanto allontanata per qualche minuto, forse per fare una passeggiata. Presto tornerà a casa e le dispiacerà tantissimo aver dato a suo marito una preoccupazione.» Ma mentre lo ascoltavamo sapevamo tutti che si sbagliava. Nessuno si sarebbe sognato di alzarsi la mattina presto e fare una passeggiata con quel freddo. «Calmati, Jeremiah. Lascia che ti portiamo dentro, al caldo, prima che il gelo ti uccida. Resta qui con la signora Gilbert e la signora Hibbins, si prenderanno cura di te mentre noi andiamo in cerca di Sophia, non è vero, cari vicini?» disse Gilbert con convinzione forzata, aiutando l’uomo a rialzarsi e rivolgendosi a tutti noi. Il pettegolezzo cominciava a passare di bocca in bocca, da marito a moglie, da vicino a vicino: allora la sposina ha lasciato il marito? Ma nessuno ebbe il coraggio di fare qualcosa che non fosse accogliere il suggerimento del pastore. Le due donne accompagnarono Jeremiah, barcollante e confuso, dentro la casa, e noi ci dividemmo in gruppi. Cercammo impronte nella neve che partissero dalla casa, sperando che le tracce di Sophia non fossero state cancellate dalla folla che aveva risposto allo sparo di allarme di Jeremiah. Mio padre trovò una fila di piccole impronte che potevano essere di Sophia e io e lui iniziammo a seguirle. Con lo sguardo fisso sulla neve, i miei pensieri vorticavano. Che cosa aveva indotto Sophia a lasciare la sua casa quella mattina? Forse aveva riflettuto sulle mie parole tutta la notte e quella mattina aveva deciso di affrontare Jonathan. Come poteva la sua scomparsa non essere legata alla nostra discussione? Il cuore mi batteva forte. Seguimmo le impronte che io temevo conducessero a casa dei St. Andrew, ma a un tratto la neve scomparve sotto il fitto degli alberi, e con essa le tracce di Sophia. Io e mio padre proseguimmo comunque, senza una direzione precisa; il sottobosco era spoglio e duro, con qualche foglia caduta e qualche sprazzo di neve qua e là. Non sapevo se mio padre stesse seguendo indizi del passaggio di Sophia – rami spezzati, foglie calpestate – o se stesse proseguendo per puro senso del dovere. Camminavamo paralleli al fiume Allagasi, che riecheggiava alla nostra sinistra. Di solito trovavo rilassante il rumore dell’acqua sulle rocce, ma non quel giorno. Sophia doveva aver avuto una forte motivazione per avventurarsi tutta sola nei boschi. Solo i più temerari degli abitanti osavano addentrarsi nella foresta da soli, perché era facile perdersi in quel panorama tutto uguale, senza punti di riferimento. Ettaro dopo ettaro di foresta selvaggia, un ripetersi di betulle e abeti e pini, intervallati regolarmente da massi che spuntavano dal terreno, coperti di muschi variopinti o screziati di licheni verde pallido. Forse avrei dovuto dire qualcosa a mio padre, fargli capire che il suo gesto di buon vicinato era inutile perché con ogni probabilità Sophia era andata a incontrare un uomo, un uomo con cui non aveva il diritto di vedersi. Magari in quel momento era al sicuro e al caldo in una camera da letto con quell’uomo, mentre noi stavamo al freddo e al gelo a cercarla. Mi immaginai Sophia affrettarsi lungo il sentiero, allontanandosi dall’infelicità di casa sua per congiungersi col suo amante, Jonathan. Jonathan, buono di cuore e confuso, che l’avrebbe sicuramente accolta. Il mio stomaco si contorse al pensiero di lei accoccolata sul letto di Jonathan, al pensiero che aveva vinto lei e io avevo perso e ormai Jonathan era suo. A un certo punto svoltammo verso il fiume e procedemmo seguendone la riva. Mio padre si fermò un secondo, aprendo un piccolo foro nel ghiaccio per dissetarsi. Tra un sorso e l’altro, mi osservò, non senza curiosità. «Non so quanto ancora dovremo cercare. Forse è meglio se vai a casa, Lanore. Non sono posti per ragazze, questi. Stai congelando.» «No, no, padre, voglio provare a continuare ancora un po’...» Sarebbe stato impossibile rimanere a casa ad attendere le notizie. Sarei impazzita o avrei abbandonato ogni decenza per precipitarmi a casa di Jonathan e affrontare Sophia. Me la immaginavo, fiera e trionfante. In quel momento, non avevo mai odiato nessuno quanto odiavo lei. Fu mio padre a vederla per primo. Perlustrava con gli occhi la strada davanti a noi, mentre io riuscivo soltanto a tenere lo sguardo sul terreno abbacinante. Trovò il corpo congelato intrappolato in un gorgo alle radici di un albero, seminascosta in un groviglio di canne e viti selvatiche. Galleggiava prona, incastrata in un ammasso di tife congelate, il suo delicato corpo disteso, le pieghe della sua gonna e i suoi capelli che affioravano sulla superficie dell’acqua. Il suo mantello giaceva abbandonato sulla riva del fiume, ripiegato con cura. «Non guardare, figlia» disse mio padre, afferrandomi per le spalle per farmi voltare. Non riuscivo a staccarle lo sguardo di dosso. Mio padre lanciò l’allarme. Io rimasi come un automa a fissare il cadavere. Altri uomini impegnati nella ricerca arrivarono attraverso i boschi, seguendo il richiamo di mio padre. Due di loro si addentrarono nell’acqua gelida per strappare il corpo dall’abbraccio dell’erba ghiacciata e dal sottile velo di ghiaccio che aveva iniziato a reclamare i suoi resti. Allargammo il mantello sul terreno e vi adagiammo il corpo. La stoffa bagnata aderì alle sue gambe e al busto. La sua pelle era tutta blu e grazie al cielo aveva gli occhi chiusi. Gli uomini la avvolsero nel mantello e a turno lo presero per gli angoli e lo usarono come una slitta per riportare il corpo di Sophia a casa. Io camminavo qualche passo indietro. Mi battevano i denti e mio padre si avvicinò e mi strofinò le braccia tentando di darmi un po’ di calore, ma era inutile perché tremavo dal terrore, non dal freddo. Mi tenevo le braccia strette attorno allo stomaco, temendo di sentirmi male di fronte a mio padre. La mia presenza attenuò la discussione fra gli uomini, che si trattennero dal chiedersi perché Sophia si fosse tolta la vita. Furono tutti d’accordo, comunque, sul fatto che al pastore Gilbert non bisognava dire niente del mantello ripiegato sulla riva. Non avrebbe mai saputo che si trattava di suicidio. Quando io e mio padre arrivammo a casa, corsi al camino e mi ci addossai tanto che il fuoco minacciò di scottarmi il volto, ma nemmeno quel calore riusciva a farmi smettere di tremare. «Non così vicina» mi rimproverò mia madre aiutandomi a togliere il mantello, temendo che potesse prendere fuoco per una scintilla. Ne sarei stata felice. Meritavo di morire arsa viva come una strega, dopo quello che avevo fatto. Poche ore dopo, mia madre venne da me, si fece coraggio e mi disse: «Vado dai Gilbert per aiutarli a... preparare Sophia. Credo che dovresti venire con me. È ora che inizi a prendere il tuo posto fra le donne di questo villaggio e impari alcuni dei doveri che ci si aspetta da te». Mi ero cambiata, indossando una pesante vestaglia da notte, e giacevo accoccolata accanto al camino dopo aver bevuto una tazza di sidro caldo allungato col rum. L’alcol aveva contribuito a rendermi insensibile, a smorzare il bisogno di urlare e confessare le mie colpe, ma sapevo che sarei crollata se fossi stata costretta ad affrontare il corpo di Sophia, anche in presenza di altre donne del paese. Mi rialzai dal pavimento poggiandomi sul gomito. «Non posso... Non sto bene... sto ancora congelando...» Mia madre mi toccò la fronte con la punta delle dita, poi la gola. «Casomai, direi che stai bruciando di febbre...» Mi studiò con attenzione, scettica, poi si rialzò e si mise il mantello sulle spalle. «Va bene, per stavolta, visto quello che hai passato...» Lasciò cadere la frase. Mi guardò ancora una volta, in un modo che non riuscii a interpretare, poi uscì. In seguito mi raccontò quello che era successo a casa del pastore, come le donne avevano preparato il corpo di Sophia per la sepoltura. Prima l’avevano deposto accanto al fuoco per farlo scongelare, poi avevano asciugato l’acqua del fiume dal suo volto e le avevano delicatamente pettinato i capelli. Mia madre mi descrisse il bianco della sua pelle dopo tutto quel tempo nell’acqua del fiume, le piccole ferite rosse dovute alle rocce che l’avevano escoriata quando il suo corpo era stato trascinato dalla corrente. La vestirono col suo abito migliore, di un giallo così pallido da sembrare avorio, impreziosito da ricami che lei stessa aveva fatto e adattato alla sua figura magra con degli spilli. Non fece menzione del corpo di Sophia, niente di anormale, nessun segno di rigonfiamento dell’addome. Se qualcuno aveva notato qualcosa in tal senso, era stato attribuito all’acqua che la povera ragazza aveva ingoiato mentre affogava. E poi un sudario di lino era stato adagiato all’interno di una semplice bara di legno. Due uomini, rimasti lì in attesa intanto che le donne completavano il lavoro, avevano quindi preso la bara, l’avevano messa su un carro e l’avevano scortata fino a casa di Jeremiah, dove sarebbe rimasta in attesa del funerale. Mentre mia madre, con tranquillità surreale, mi descriveva le condizioni del corpo di Sophia, ebbi la sensazione che dei chiodi mi si conficcassero in tutto il corpo, invitandomi a confessare la mia malvagità. Ma riuscii a mantenere il controllo, anche se a malapena, e piansi apertamente mentre mia madre parlava, nascondendomi gli occhi con una mano. Mia madre mi accarezzò la schiena come se fossi tornata bambina. «Che succede, Lanore, tesoro mio? Perché sei così sconvolta per Sophia? È una cosa terribile e poi lei era una nostra vicina di casa, certo, ma non credevo che la conoscessi così bene...» Mi mandò sul soppalco con una borsa d’acqua calda e poi rimproverò mio padre per avermi portata nel bosco. Io mi sdraiai, con la borsa calda sulla pancia, anche se non mi dava alcun sollievo. Rimasi sveglia tutta la notte ad ascoltare i suoni del buio: il vento, gli alberi, le braci che si spegnevano... sussurravano un nome: Sophia. Come era successo per il suo matrimonio, il funerale di Sophia fu una cerimonia in sordina, a cui parteciparono soltanto sua madre e qualche suo parente, suo marito e pochi altri. Era una giornata gelida e coperta, con un presagio di neve nell’aria. Aveva nevicato ogni giorno da quando Sophia si era suicidata. Io e Jonathan osservammo la scena dalla collina che dava sul cimitero. Guardammo i partecipanti in lutto raccogliersi attorno alla fossa profonda e scura. In qualche modo erano riusciti a scavare anche se il terreno era ghiacciato, e non potei fare a meno di chiedermi se era stato suo padre, Tobey, a scavarle la fossa. I presenti, figure nere che si stagliavano contro un campo innevato sullo sfondo, si agitavano senza posa, mentre Gilbert pronunciava la preghiera d’addio. Il mio volto era teso e gonfio dopo giorni di pianto ininterrotto, ma in quel momento, in presenza di Jonathan, non mi scendeva alcuna lacrima. Mi sembrava assurdo spiare il funerale di Sophia, io che avrei dovuto inginocchiarmi di fronte a Jeremiah chiedendo il suo perdono, io che ero responsabile della morte di sua moglie, come se l’avessi spinta io stessa nel fiume. Di fianco a me, Jonathan era chiuso nel silenzio. Alla fine iniziò a nevicare, come se una tensione a lungo trattenuta finalmente esplodesse. Piccoli fiocchi che danzavano nell’aria gelida per poi posarsi sul cappotto di lana nera di Jonathan e sui suoi capelli. «Non riesco a credere che non c’è più» disse, per la ventesima volta quella mattina. «Non riesco a credere che si sia tolta la vita.» Le parole mi si strozzarono in gola e tacqui. Qualsiasi cosa avessi detto sarebbe stata inutile, di nessuna consolazione e, soprattutto, falsa. «È tutta colpa mia» disse infine lui, con voce spezzata, portandosi una mano al volto. «Non puoi fartene una colpa se è successo.» Cercai di consolarlo ripetendogli le stesse parole che avevo ripetuto a me stessa incessantemente per tutti quei giorni, mentre giacevo a letto, in preda alla febbre e al senso di colpa. «Sai bene che la sua vita è stata sfortunata, sin da quando era piccola. Chi può sapere quali afflizioni la tormentassero, e da quanto tempo? Alla fine hanno avuto la meglio. Non può certo essere colpa tua.» Fece due passi avanti, come se non desiderasse altro che essere lì con lei nella sua fossa. «Non posso credere che covasse pensieri suicidi, Lanny. Era felice con me. Mi sembra impossibile che la Sophia che ho conosciuto per tutto quel tempo stesse combattendo contro il desiderio di uccidersi.» «Non si può mai sapere. Forse aveva litigato con Jeremiah... Forse è successo dopo l’ultima volta che l’hai vista...» Lui serrò gli occhi con forza. «Se c’era qualcosa che la preoccupava, era la mia reazione quando mi ha detto del bambino. Non ci sono dubbi. Ecco perché mi incolpo, Lanny, per il modo sconsiderato in cui ho reagito alla notizia. Tu mi avevi detto» disse poi alzando il volto all’improvviso e guardandomi negli occhi, «mi avevi detto che avresti pensato a un modo per dissuaderla dal tenere il bambino. Ti prego, Lanny, dimmi che non sei andata da Sophia con quelle intenzioni...» Colta di sorpresa, indietreggiai. Nei giorni precedenti avevo pensato più volte di dirgli tutto, tormentata com’ero da un senso di colpa che mi avvelenava come la peggiore delle malattie. Dovevo raccontarlo a qualcuno, non era il genere di segreti che un’anima può trattenere senza recare un danno irreparabile al corpo, e se c’era qualcuno al mondo con cui potevo parlare, quello era Jonathan. L’avevo fatto per lui, in fondo. Era venuto da me in cerca di aiuto e io avevo fatto quello che andava fatto. E ora avevo un disperato bisogno di assoluzione. E lui me la doveva, quell’assoluzione. Ma quando prese a scrutarmi con quei suoi occhi scuri e caparbi, capii di non poterglielo dire. Non ora, non quando soffriva così aspramente, quando sarebbe stato preda delle sue emozioni. Non avrebbe compreso. «Cosa? No, non mi è venuto in mente nessun piano. Perché mai avrei dovuto affrontare Sophia da sola, comunque?» mentii. Non era mia intenzione mentire a Jonathan, ma mi aveva colto di sorpresa, la sua domanda era stata come una freccia puntata al mio cuore con precisione soprannaturale. Un giorno gliel’avrei detto, decisi, ma non in quel momento. Jonathan tormentò il suo cappello a tricorno fra le mani. «Credi che... Pensi che dovrei dire la verità a Jeremiah?» Afferrai Jonathan per le spalle e lo scossi vigorosamente. «Sarebbe una cosa orribile, per te così come per la povera Sophia. E che bene farebbe mai a Jeremiah, ora? Servirebbe soltanto a placare la tua coscienza. Otterresti soltanto di rovinare l’immagine che Jeremiah ha di lei. Lascia che seppellisca Sophia ritenendola una brava moglie che gli è stata fedele.» Lui guardò le mie piccole mani che lo tenevano per le spalle. Era insolito per noi avere un contatto fisico come quello, ora che non eravamo più bambini, poi mi guardò negli occhi con un’espressione tanto addolorata che non riuscii a trattenermi. Mi accasciai sul suo petto e lo trassi a me, pensando soltanto che aveva bisogno di conforto, in quel momento, il conforto di una donna, anche se non ero Sophia. Mentirei se dicessi di non aver trovato conforto anch’io stretta nel suo caldo abbraccio, sebbene non ne avessi alcun diritto. Mi bastò toccarlo per sentire un pianto di felicità nascermi dentro. Tenendo il suo corpo stretto al mio, immaginavo che mi avesse perdonato per il tremendo peccato che avevo compiuto ai danni di Sophia, anche se naturalmente lui non ne sapeva niente. Avrei continuato per sempre a tenere la guancia appoggiata al suo petto, ascoltando i battiti del suo cuore attraverso gli strati di lana e lino, inspirando il suo odore. Non avrei mai voluto staccarmi dal mio Jonathan, ma mi accorsi che aveva abbassato gli occhi su di me e quindi alzai il mento e ricambiai il suo sguardo, pronta a sentirlo dire ancora che amava Sophia. E in quel momento decisi che se avesse ancora una volta pronunciato il suo nome, avrei confessato la mia colpa. Ma lui non lo fece. Invece, avvicinò la sua bocca alla mia e la tenne sospesa per un istante, prima di baciarmi. Il momento che avevo tanto atteso passò in un lampo. Ci insinuammo sotto gli alberi, a qualche passo di distanza. Ricordo il meraviglioso calore della sua bocca sulla mia, la sua fame, la sua forza. Ricordo le sue mani che slacciavano il nastro che chiudeva la mia camicetta sul petto. Mi spinse contro un albero e mi morse il collo mentre si affaccendava a slacciarsi le brache. Mi alzai le gonne così che potesse afferrarmi con le mani sui fianchi. Se ho un rimpianto, è quello di non aver nemmeno potuto intravedere il suo membro a causa di tutti i vestiti che ci ingombravano, il cappotto e il mantello, la gonna e la sottoveste. Ma d’un tratto lo sentii dentro di me, un calore che si spingeva a fondo, sempre più a fondo. Si chinò su di me, sfregandomi contro la corteccia dell’albero. E alla fine, il suo lamento di piacere nelle mie orecchie mi suscitò un brivido, perché voleva dire che gli era piaciuto, e non mi ero mai sentita così felice e temevo che non lo sarei stata più come in quel momento. Attraversammo la foresta insieme sul suo cavallo, io ero dietro di lui e lo tenevo stretto in vita, come quando eravamo bambini. Scegliemmo i sentieri meno frequentati per non essere visti insieme senza un accompagnatore. Non ci dicemmo nemmeno una parola e per tutto il tempo io tenni il volto arrossato contro il suo cappotto, cercando di dare un senso a quello che era appena accaduto. Sapevo di tantissime altre ragazze del villaggio che si erano date a un uomo prima del matrimonio – e spesso quell’uomo era proprio Jonathan – e le avevo sempre disprezzate. Ora ero diventata come loro. Una parte di me sentiva che avevo disonorato me stessa. Ma un’altra parte sapeva che non avevo avuto scelta: avrebbe potuto essere la mia unica possibilità di conquistare il cuore di Jonathan e dimostrare che eravamo fatti l’uno per l’altra. Non potevo lasciarmela sfuggire. A un certo punto fermò il cavallo, io smontai dalla sella, gli carezzai la mano e poi mi incamminai lungo il breve tratto che conduceva a casa mia. Tuttavia, mentre camminavo, fui assalita dai dubbi. Che cosa aveva significato per lui quello che avevamo fatto? Era solito andare a letto con tante ragazze senza preoccuparsi delle conseguenze; perché credevo che con me sarebbe stato diverso? E i suoi sentimenti per Sophia? O, per quanto mi riguardava, il mio debito morale nei confronti della donna che avevo spinto al suicidio? Era come se l’avessi uccisa io stessa e ora eccomi a fornicare con il suo amante. Non poteva esistere un animo più corrotto del mio. Mi fermai qualche minuto prima di entrare in casa, per riprendere il controllo, inspirando profondamente l’aria fredda. Non potevo permettermi di crollare di fronte alla mia famiglia. Non c’era nessuno con cui potessi parlare di quello che era accaduto. Avrei dovuto tenere tutto nascosto finché non mi fossi calmata a sufficienza per rifletterci sopra razionalmente. Celare dentro di me la colpa, la vergogna, l’odio verso me stessa. Eppure, allo stesso tempo mi sentivo colma di un’eccitazione vibrante perché, anche se non lo meritavo, avevo ottenuto quello che avevo tanto desiderato. Sospirai, scrollai la neve dal mantello, mi raddrizzai e con passo deciso mi avviai verso il cottage della mia famiglia. 10 Ospedale della contea di Aroostook, oggi Suoni nel corridoio. Luke controlla il suo orologio: le quattro di mattina. Non ci vorrà molto prima che l’ospedale si riempia. Le mattine sono sempre frenetiche, per via degli incidenti sul lavoro così frequenti alle fattorie: una costola frantumata dal calcio di una mucca durante la mungitura, una scivolata su una pozzanghera ghiacciata durante la sistemazione di una balla di fieno. E poi alle sei c’era il cambio di turno. La ragazza lo guarda come un cagnolino guarderebbe un padrone di cui non si fida. «Allora mi aiuterai? O lascerai che quello sceriffo mi porti alla stazione di polizia?» «E cos’altro potrei fare?» Il volto della ragazza si colora. «Non puoi lasciarmi andare. Chiudi gli occhi, io sparirò. Nessuno ti potrà dare la colpa. Potrai dir loro che sei andato al laboratorio, che mi hai lasciato da sola non più di qualche secondo, ma quando sei tornato io ero scomparsa.» Joe dice che è un’assassina, pensa Luke. Posso lasciar libera un’assassina? Lanny gli prende la mano. «Sei mai stato così profondamente innamorato di qualcuno che avresti fatto qualsiasi cosa ti avesse chiesto? Che più di ogni altra cosa vuoi la sua felicità?» Luke è sollevato che lei non possa leggergli dentro perché non è mai stato così altruista. È stato fedele, certo, ma non è mai stato capace di dare senza avvertire una punta di risentimento, e non sa dire come si senta per questo. «Non sono una minaccia per nessuno. Ti ho spiegato perché ho... fatto quello che ho fatto a Jonathan.» Luke fissa quegli occhi azzurri come il ghiaccio e li vede riempirsi di lacrime. Viene percorso da un brivido che parte dalla nuca e gli arriva dentro, al ventre. Il dolore della perdita si impossessa di lui con estrema velocità, gli succede sempre da quando sono morti i suoi genitori. Sa che lei sta provando la sua stessa tristezza e per un momento sente che sono insieme in quel pozzo di dolore senza fondo. E lui è stanco di essere prigioniero del dolore – la perdita dei suoi genitori, la fine del suo matrimonio, la sua intera vita – così stanco che sa di dover fare qualcosa per liberarsene, e di doverlo fare ora o mai più. Non sa perché sta per fare quello che sta per fare, ma sa di non poterci pensare troppo, altrimenti non farà mai niente. «Aspettami qui. Torno subito.» Luke percorre di soppiatto il corridoio fino allo spogliatoio dei medici. Dentro il suo armadietto grigio e malconcio trova un paio di camici, messi lì alla rinfusa e dimenticati da chissà quanto tempo. Fruga in un altro paio di armadietti e trova un camice da laboratorio bianco, una cuffia chirurgica e, nell’armadietto della pediatra, un paio di scarpe da tennis da donna così vecchie che hanno le punte incurvate. Luke prende tutto e lo porta nella saletta. «Ecco, mettiti su questa roba.» Prendono la via più breve verso il retro dell’ospedale, attraversando corridoi di servizio fino ad arrivare all’area di carico e scarico del magazzino. Un infermiere in arrivo per il turno di giorno li saluta con un cenno mentre attraversano il parcheggio, ma quando Luke ricambia il saluto sente il braccio appesantito dalla tensione. Solo quando sono nel parcheggio di fianco al suo pickup Luke si ricorda di aver lasciato le chiavi nel suo parka, dentro la sala dei dottori. «Maledizione. Devo tornare indietro, non ho le chiavi. Nasconditi fra gli alberi, torno subito.» Lanny annuisce in silenzio, tremante di freddo e stretta nel leggero camice di cotone. Il percorso dal parcheggio all’entrata delle ambulanze è il più lungo della sua vita. Luke si affretta per via del freddo ma anche dei nervi a fior di pelle. Judy o Clay potrebbero essersi già accorti che se n’è andato. E se Clay è ancora addormentato nella sua branda, Luke potrebbe svegliarlo quando entra a prendere le chiavi e allora lo coglierebbero sul fatto. Ogni passo diventa sempre più difficile finché non si sente come uno sciatore sull’acqua trascinato a fondo perché qualcosa si è rotto all’altro capo della fune. Spinge le pesanti porte a vetro, così teso che tiene le spalle incassate. Judy, alla postazione delle infermiere, ha un’espressione corrucciata e non alza nemmeno gli occhi dallo schermo del computer quando gli dice: «Dove sei stato?» «A fumarmi una sigaretta.» Ora Judy gli dedica la sua attenzione. Lo fissa con occhi a spillo come quelli di un corvo. «E da quando hai ricominciato a fumare?» Luke si sente come se avesse fumato due pacchetti in una notte, quindi quello che ha detto a Judy non gli sembra nemmeno una bugia. Decide di ignorarla. «Clay è già sveglio?» «Non l’ho visto. La porta della saletta è ancora chiusa. Forse dovresti svegliarlo, non può mica dormire qui tutto il giorno. Sua moglie si starà chiedendo che cosa gli sia successo.» Luke si blocca. Vorrebbe fare una battuta, agire come se fosse tutto nella norma di fronte a Judy, ma del resto Luke non ha mai fatto battute a Judy in passato e non sembrerebbe affatto nella norma se ne facesse una ora. La sua incapacità di mentire e di coprire le sue tracce lo rende ancora più nervoso. Si sente come se fosse caduto dentro il sottile velo di ghiaccio sopra il lago e stesse affogando, riempiendosi i polmoni di acqua gelida, ma Judy non nota niente. «Ho bisogno di un caffè» borbotta Luke e poi si allontana. La porta della sala è a pochi passi di distanza. Nota immediatamente che è socchiusa e che dentro è tutto al buio. La apre ancora un po’ e distingue chiaramente la branda vuota dove dovrebbe trovarsi il poliziotto. Il sangue gli affluisce alle orecchie, le ghiandole della gola gli si gonfiano fino a quattro volte la grandezza normale e non riesce più a respirare. È peggio che affogare: gli sembra che lo stiano strangolando. Il suo parka è appeso alla sua destra, alla parete. Non deve far altro che infilare la mano dentro la tasca. Il suono tintinnante gli conferma che le chiavi sono proprio dove devono essere. Torna indietro con passo deciso. A testa bassa, le mani sprofondate nelle tasche del suo camice da laboratorio, decide di non passare dal corridoio di servizio, che gli farebbe allungare la strada, e invece si dirige verso l’ingresso delle ambulanze. La testa di Judy scatta in su quando Luke le passa di fianco. «Pensavo fossi andato a farti un caffè.» «Ho dimenticato il portafoglio in macchina» le dice lui senza voltarsi. È quasi giunto alla porta d’ingresso. «Hai svegliato Clay?» «È già sveglio» le risponde Luke, aprendo la porta con la schiena. Dall’altra parte della hall c’è il poliziotto, che sembra essersi materializzato non appena è stato fatto il suo nome. Anche lui vede Luke e alza un braccio come per chiamare un taxi. Clay vuole parlare con lui e inizia ad andargli incontro, facendogli ampi cenni... Fermati, Luke. Ma Luke non si ferma. Spingendo con tutto il suo peso sull’anca, richiude di schianto la porta. Il freddo gli sferza il volto quando sbuca all’aperto, riemergendo alla sua vera vita. Ma che cosa sto facendo? Questo è l’ospedale in cui lavoro. Conosco ogni sedia di plastica, ogni lettiga, come se fossero casa mia. Che cosa sto facendo? Sto davvero mandando a gambe all’aria la mia vita per aiutare una sospetta omicida a scappare? Sto impazzendo? Eppure continua, spinto da un irresistibile formicolio nelle vene che lo attraversa tutto come una pallina da flipper, costringendolo a proseguire. Si affretta attraverso il parcheggio, frenetico ed esitante, come se cercasse di rimanere in piedi scendendo a perdifiato lungo un declivio, consapevole di sembrare un pazzo. Luke scruta con ansia il suo pickup più avanti, ma non la vede, è scomparsa, non c’è nemmeno l’ombra del verde ospedaliero del suo camice a dargli un segno. Sulle prime lo prende il panico: come ha potuto essere così stupido da lasciarla da sola là fuori? Eppure, un piccolo barlume di speranza gli si accende in petto quando si rende conto che se la prigioniera è scomparsa sono scomparsi anche i suoi guai. Un attimo dopo lei è li davanti a lui, esile, eterea, un angelo vestito in camice ospedaliero... E il suo cuore sobbalza nel vederla. Luke infila la chiave nel blocchetto di accensione mentre Lanny si accuccia sul sedile, cercando di non guardare il dottore per non innervosirlo ulteriormente. Finalmente il motore si accende e il pickup si allontana dal parcheggio, lanciandosi sulla strada. La passeggera tiene lo sguardo fisso davanti a sé, come se concentrandosi potesse impedire che li scoprano. «Sono alloggiata al capanno dei Dunratty, sai dov’è?» Luke non crede alle sue orecchie. «E pensi che sia saggio andarci? Credo proprio che ormai la polizia abbia scoperto dove stavi. Non è che in giro ci siano molti turisti in questo periodo dell’anno.» «Per favore, proviamo a passare di là. Se qualcosa ci insospettisce proseguiremo, ma io ho lì tutte le mie cose. Il passaporto, i soldi, i vestiti. Scommetto che non hai niente in casa che possa andarmi bene.» È più minuta di Tricia ma più grande delle ragazze. «Vinceresti la scommessa» ammette. «Passaporto hai detto?» «Vengo dalla Francia, è lì che vivo ora.» Si raggomitola sul sedile come un gatto che cerca di conservare il calore. Di colpo, Luke sente le proprie mani sul volante enormi, goffe, gonfie. Sta perdendo il controllo per via dello stress e deve concentrarsi per non abbandonare il volante e finire in un fosso. «Dovresti vedere la mia casa a Parigi. È come un museo, piena delle cose che ho collezionato in questi lunghi, lunghi anni. Vuoi che ci andiamo insieme?» La sua voce è dolce e calda come liquore e quell’invito è intrigante. Luke si chiede se stia dicendo la verità. A chi non piacerebbe andare a Parigi a vivere in una casa piena di ricordi magici? Luke avverte la tensione sciogliersi, la spina dorsale e il collo cominciano a rilassarsi. In quella zona della foresta ci sono capanni da caccia come quello dei Dunratty dovunque. Luke non ha mai dormito in un capanno del genere, ma si ricorda di averne visto l’interno in un paio di occasioni quando era bambino, per qualche ragione che non riesce a ricordare. Sono vecchi capanni che risalgono agli anni Cinquanta, messi in piedi con assi e chiodi, arredati con mobili di recupero e linoleum, pieni di feci di topi. La ragazza indirizza Luke verso l’ultimo cottage sul vialetto ghiaioso dei Dunratty. Le finestre sono scure, le luci spente. «Dammi una carta di credito, così apro quella porta.» Appena entrati tirano le tende e Lanny accende la luce. Ogni superficie che toccano è ghiacciata. I suoi effetti personali sono sparsi ovunque, come se gli abitanti fossero stati costretti a scappare via nel cuore della notte. Ci sono due letti, ma solo uno è sfatto, le coperte e le lenzuola in disordine e il cuscino spiegazzato sembrano prove di colpevolezza. Su un tavolino traballante, che un tempo doveva far parte di un set da cucina, c’è una fotocamera digitale collegata da un cavo a un computer portatile. Sul comodino ci sono bottiglie di vino aperte e bicchieri coperti di impronte e tracce di rossetto. Sul pavimento due valigie aperte. Lanny si accuccia vicino a una di esse e inizia a riempirla, mettendo dentro anche il computer e la macchina fotografica. Luke agita le chiavi dell’auto, nervoso e impaziente. La ragazza chiude la cerniera della valigia, si rialza e poi si dedica alla seconda valigia. Tira fuori un maglione da uomo e se lo porta al volto, annusandone profondamente l’odore. «Va bene, ora posso andare.» Quando ripercorrono il vialetto di ghiaia e passano davanti alla reception (sicuramente chiusa a quell’ora, il giovane Dunratty ancora di sopra a dormire), Luke crede di vedere la tendina rossa di percalle muoversi, come se qualcuno li stesse osservando. Si immagina Dunratty in accappatoio, con una tazza di caffè in mano, che sente per la seconda volta un rumore di ruote sulla ghiaia e si affaccia per vedere chi stia passando di là. Riconoscerà il mio pickup?, si chiede Luke. Ma no, non era niente, soltanto un gatto sul davanzale. Non serve a nulla immaginare guai ancora peggiori di quello in cui si trova. Luke è a disagio quando la ragazza si cambia i vestiti in auto, mentre lui guida, ma poi ricorda che tanto l’ha già vista nuda. Lei si infila dei jeans e un maglione di cashmere più bello di qualsiasi capo abbia mai indossato sua moglie. Getta sul tappetino dell’auto il camice ospedaliero. «Tu ce l’hai il passaporto?» chiede poi a Luke. «Certo. A casa.» «Andiamo a prenderlo.» «Come? Vuoi che partiamo per Parigi così all’improvviso, come se niente fosse?» «E perché no? Ci penso io ai biglietti, pagherò tutto io. I soldi sono l’ultimo dei problemi.» «Credo che dovrei farti arrivare in Canada, subito, prima che la polizia spicchi un mandato di arresto. Siamo a un quarto d’ora dal confine, non di più.» «Ma tu hai bisogno del passaporto per passare il confine? Hanno cambiato le regole, no?» chiede la ragazza, con una nota di panico nella voce. Luke stringe le mani sul volante. «Non saprei... È da un po’ che non passo il confine... Oh, va bene, andiamo a casa mia. Ma soltanto per un minuto.» La fattoria si trova nel mezzo di un campo, come un bambino troppo stupido per rientrare al caldo. Il pickup si inerpica ondeggiando lungo la strada fangosa, ora congelata e piena di spigoli, come ghiaccioli. Passano dalla porta posteriore ed entrano in una cucina triste, sciatta, che non è cambiata di una virgola negli ultimi quindici anni. Luke accende la luce ma nota che non fa differenza nell’illuminazione della stanza. Tazze da caffè sporche giacciono sul tavolino della colazione, briciole scricchiolano sotto i piedi. Tutto quel disordine lo mette enormemente in imbarazzo. «Questa era la casa dei miei genitori. Vivo qui da quando sono morti» spiega. «Non mi piaceva l’idea di vendere la fattoria a uno sconosciuto, ma non riesco a tenerla come facevano loro. Ho venduto il bestiame un mese fa. Ho trovato qualcuno che seminerà i campi la prossima primavera. Mi sembra un peccato lasciare che tutto vada in rovina.» Lanny si aggira per la cucina, passando un dito sul bancone di formica, sullo schienale di vinile di una sedia. Si ferma davanti a un disegno appeso al frigo con una calamita, fatto da una delle sue figlie quando era all’asilo. Una principessa su un pony; il pony si riconosce solo perché somiglia vagamente a un cavallo, ma la principessa è irriconoscibile: un mucchietto di capelli biondi, due macchie di blu per gli occhi, una gonna rosa. Se non fosse per la gonna, potrebbe essere Lanny. «Chi l’ha disegnato? Ci sono bambini in casa?» «Non più.» «Sono andati via con tua moglie?» tira a indovinare. «Non c’è nessuno che si prenda cura di questa casa?» Lui fa spallucce. «Non hai alcun motivo di rimanere qui» dice lei, affermando l’ovvio. «Ho ancora dei doveri» risponde lui, perché è così che è abituato a pensare alla propria vita. Non riuscirebbe a vendere la fattoria, non in quel momento di mercato in crisi. Ha il suo mestiere, anche se non gli rimangono che anziani di cui prendersi cura, ora che i figli e i nipoti si trasferiscono tutti altrove. Il numero di pazienti diminuisce di mese in mese. Luke sale al piano superiore, entra in camera da letto e prende il suo passaporto dentro il cassetto di un comodino. Quando sua moglie l’ha lasciato, si è trasferito nella camera da letto dei suoi genitori: la sua stanza di quando era bambino è stata anche la camera da letto sua e di sua moglie, e non vuole più avere niente a che fare con quella parte della sua vita. Apre il passaporto. Non l’ha mai usato. Non ha mai avuto il tempo di viaggiare, non da quando aveva fatto il tirocinio, e in ogni caso non è mai uscito dagli Stati Uniti in vita sua. Non è mai stato in uno di quei posti lontani che sognava durante l’adolescenza, quando passava lunghe ore sul trattore facendo castelli in aria. Quel passaporto intonso lo fa sentire in imbarazzo di fronte a una persona che invece è stata in tutti quei posti esotici. La sua vita avrebbe dovuto essere diversa. Trova Lanny in sala da pranzo a osservare le foto di famiglia, poggiate in basso sul ripiano di una libreria. Sua madre aveva tenuto sempre lì le foto, esposte, e lui non aveva avuto il coraggio di metterle via, ma solo sua madre conosceva le persone ritratte in quelle foto e i loro legami di parentela con lui. Vecchie foto in bianco e nero, che ritraevano austeri scandinavi morti da un pezzo, ormai, sconosciuti l’uno all’altro. C’è soltanto una foto a colori, in una cornice di legno, che ritrae una donna con due figlie. È in mezzo alle altre foto, come se il suo posto fosse proprio quello. Luke spegne le luci e regola il termostato molto basso, quanto basta per impedire alle tubature di ghiacciare. Controlla le serrature, anche se non sa perché si prenda la briga di farlo. Ha intenzione di tornare a casa subito dopo aver accompagnato quella ragazza oltre il confine, ma quando tocca l’interruttore con la mano sente un groppo in gola. Sembra un addio – e spera che un giorno lo sia, è da tanto tempo che lo pianifica e se lo immagina nei momenti in cui recupera il senno, e spera di farlo un giorno, forse quella primavera, quando sarà in grado di pensare più chiaramente – ma in quel momento sta soltanto aiutando una ragazza nei guai, una ragazza che non ha nessun altro cui rivolgersi. Oggi non partirà, oggi tornerà indietro. «Sei pronta?» le chiede, agitando ancora una volta le chiavi della macchina. Ma Lanny allunga una mano e prende un libricino, tanto piccolo da starle nel palmo. La sovraccoperta non c’è più e la copertina è consunta agli angoli, tanto che il cartone sottostante è visibile, come un bocciolo che spunta dal tessuto giallo. Luke ci mette un minuto buono a riconoscere il libro: era il suo preferito quando era piccolo e sua madre deve averlo conservato per tutti quegli anni. La pagoda di giada, un classico della letteratura per l’infanzia, come Kipling ma non Kipling, storia ambientata in un paese esotico, con tanto di principessa cinese e principessa europea, o comunque occidentale, con illustrazioni a penna e inchiostro fatte dall’autore stesso. Lanny scorre le pagine. «Conosci quel libro?» le chiede. «Da piccolo lo adoravo, si vede da come è consumato. La rilegatura è quasi a pezzi. Non credo che sia ancora ristampato.» Lei glielo porge aperto, indicando una delle illustrazioni. È lei. Indossa vestiti dell’epoca e ha i capelli raccolti sulla nuca, ma la forma a cuore del volto è inconfondibile, così come i suoi occhi, il suo sguardo vagamente arrogante e divertito. «Ho conosciuto Oliver, l’autore, quando entrambi vivevamo a Hong Kong. All’epoca era soltanto un funzionario inglese, noto per essere un ubriacone che chiedeva a tutte le mogli degli ufficiali di posare per il suo piccolo ’progetto’, come lo chiamava. Ma io ero l’unica che aveva acconsentito; pensavano tutte che fosse scandaloso e che si trattasse semplicemente di un suo stratagemma, soltanto una scusa per portarci da sole nel suo appartamento.» Lui sente il respiro mozzarglisi in gola e il cuore perdere un battito, poi un altro. La ragazza nell’illustrazione è la stessa che si trova davanti, ora, in carne e ossa, ed è come un incantesimo per lui stare di fronte a qualcuno che fino a quel momento ha visto soltanto in un disegno su un libro. Come un fantasma che di colpo prende corpo. Per un momento, teme di essere sul punto di svenire. In un attimo lei gli si avvicina e lo spinge verso la porta. «Sono pronta. Andiamo.» 11 St. Andrew, 1816 Avevo realizzato un desiderio profondo del mio cuore: che Jonathan mi vedesse come una donna, come un’amante. Ma niente più di questo. Vivevo in uno stato di incertezza perché da quell’emozionante e sconvolgente pomeriggio non ero più riuscita a mettermi in contatto con lui. Perché era sopraggiunto l’inverno. Gli inverni non vanno mai sottovalutati nella parte del Maine in cui vivevamo. Venivamo assaliti da bufera dopo bufera, e la neve ci metteva al massimo un paio di giorni per arrivare fino alla vita, impedendo ogni spostamento. Ogni attenzione, ogni energia veniva dedicata a mantenersi caldi, a sfamarsi e a prendersi cura del bestiame. Per sbrigare le faccende all’aperto bisognava sempre farsi largo nella neve, ed era una fatica immane. Non si faceva in tempo a spalare un percorso fino al granaio e al pascolo, o a spaccare il ghiaccio sul fiume quanto bastava per raccogliere l’acqua da dare al bestiame o da usare in casa, illudendosi che si potesse tornare alla normalità (o quantomeno a una routine accettabile) che una nuova tempesta di neve si abbatteva sulla vallata. Io rimanevo seduta per ore davanti alla finestra a osservare la strada carrozzabile, coperta da neve intonsa alta più di mezzo metro. E pregavo, pregavo con ardore che la neve si depositasse e si compattasse abbastanza perché potessimo camminarci sopra, così avremmo potuto ricominciare ad andare a messa la domenica. Era la mia unica opportunità di vedere Jonathan. Avevo bisogno che lui acquietasse le mie paure, volevo sentirgli dire che non aveva fatto l’amore con me solo perché non poteva più avere Sophia, ma perché mi desiderava. Forse perché mi amava. E finalmente, dopo diverse settimane di prigionia in casa, la neve si consolidò alla profondità giusta e mio padre mi disse che la domenica seguente saremmo andati al villaggio. Mentre in qualsiasi altro periodo dell’anno quella notizia sarebbe passata quasi inosservata, stavolta sembrava che nostro padre ci avesse detto che saremmo tutti andati a un grande ballo. Io, Maeve e Glynnis trascorremmo i giorni in un turbinio di eccitazione a decidere che cosa avremmo indossato, come togliere una macchia dalla camicetta preferita, chi di noi avrebbe sistemato i capelli all’altra. Perfino Nevin sembrava impaziente che arrivasse domenica per poter uscire dalla nostra piccola casa. Io e mio padre lasciammo le mie sorelle, mio fratello e mia madre alla chiesa cattolica e poi con il calesse raggiungemmo la sala della congregazione. Mio padre sapeva perfettamente il vero motivo per cui andavo a messa con lui e non con mia madre e gli altri, perciò doveva avere più di un sospetto sul motivo per cui ero più agitata del solito mentre ci avvicinavamo al salone. E dopo la messa, siccome la neve sul prato era troppo profonda per fermarsi a chiacchierare, la gente rimase all’interno della sala, affollando le navate, i corridoi e perfino le scale. L’aria vibrava del chiacchiericcio di tutta la gente che, rimasta troppo a lungo al chiuso con la propria famiglia, non vedeva l’ora di poter parlare con qualcun altro. Mi insinuai tra la folla, cercando Jonathan. Captai frammenti di conversazione dei miei vicini – che squallore, che noia infinita, quanto erano tutti stufi marci di mangiare piselli essiccati e melassa e carne sotto sale – ma mi rimbalzavano addosso come granelli di nevischio. Attraverso una stretta finestra intravidi il cimitero e la tomba di Sophia. Il terreno smosso si era ormai adagiato e la neve caduta sulla fossa giaceva più in basso di qualche centimetro rispetto al manto, marcando un’irregolarità nel paesaggio. Finalmente vidi Jonathan. Anche lui si stava districando fra la folla, come se a sua volta mi stesse cercando. Ci incontrammo ai piedi della scala che portava alla balconata, circondati dai vicini, consapevoli di non poter parlare liberamente. Qualcuno avrebbe origliato. «Come sei affascinante oggi, Lanny» osservò Jonathan con cortesia. Una frase innocente, alle orecchie di un ascoltatore casuale, ma il Jonathan che conoscevo sin dall’infanzia non mi aveva mai fatto un complimento, sarebbe stato come fare un complimento a un altro ragazzo. Non riuscii a ricambiare la sua cortesia; riuscii soltanto ad arrossire. Si chinò verso di me e mi mormorò all’orecchio: «Queste ultime tre settimane sono state insopportabili. Stasera, un’ora prima del tramonto, vai al tuo granaio, farò in modo di incontrarti lì». Naturalmente, date le circostanze, non riuscii a chiedergli niente, né tanto meno a ottenere le rassicurazioni di cui il mio fragile cuore aveva tanto bisogno. E, a essere sincera, non credo che qualsiasi cosa mi avesse detto mi avrebbe impedito di incontrarlo. Ardevo dal desiderio di stare con lui. Quel pomeriggio, le mie paure furono placate. Per un’ora mi sentii al centro dell’universo. Era tutto quello che avevo sempre desiderato. Tutto quello che era Jonathan, anima e corpo, era presente in ogni suo tocco, dal modo in cui armeggiò con i nastri e i legacci che chiudevano i miei vestiti, alle sue dita che delicatamente mi passavano tra i capelli, ai suoi baci sulle mie spalle, che mi davano i brividi. Dopo, rimanemmo accoccolati a riprendere possesso dei nostri corpi, ed era meraviglioso essere chiusa nel suo abbraccio, sentirlo addosso a me, come se anche lui volesse impedire a qualsiasi cosa di intromettersi fra di noi. Non c’è felicità uguale a quella di ottenere ciò che hai tanto desiderato, per cui hai tanto pregato. Ero esattamente dove avevo sempre voluto essere, ma ero anche dolorosamente consapevole di ogni secondo che passava. La mia famiglia si sarebbe chiesta che fine avevo fatto. Con estrema riluttanza, allontanai le sue braccia dalla mia vita. «Non posso rimanere, devo tornare a casa... Anche se a volte vorrei che ci fosse un posto tutto mio in cui rifugiarmi, un posto diverso da casa mia.» Volevo soltanto dire che non avrei mai voluto lasciare il suo dolce abbraccio, ma mi uscì una verità diversa, qualcosa che da tempo tenevo dentro di me. Me ne vergognavo, era una paura segreta che non avrei mai dovuto ammettere, ma ormai le parole mi erano scappate di bocca e non c’era modo di rimangiarsele. Jonathan mi guardò interrogativo. «Perché dici così, Lanny?» «A volte... A volte mi sembra di non appartenere alla mia famiglia.» Mi sentii stupida a doverlo spiegare a Jonathan, forse l’unica persona del nostro villaggio cui l’amore non era mai mancato, l’unico che non si era mai sentito immeritevole di felicità. «Nevin è l’unico figlio maschio, quindi i miei genitori lo venerano. E un giorno erediterà la fattoria. Poi ci sono le mie sorelle... sono così carine; tutti al villaggio le ammirano per questo. Le loro prospettive sono buone. Ma io...» Non riuscivo a confessare nemmeno a Jonathan la vera radice della mia paura: che a nessuno interessasse davvero la mia felicità, che io non stavo a cuore a nessuno, nemmeno ai miei genitori. Mi tirò giù accanto a lui, nel fieno, e mi strinse fra le braccia, trattenendomi quando cercai di sfuggirgli, o piuttosto non sfuggire da lui ma dalla mia stessa vergogna. «Non sopporto di sentirti dire queste cose, Lanny... Io ho scelto te, no? A quanto pare sei l’unica con cui sto bene, l’unica con cui posso essere davvero me stesso. Se potessi, passerei tutta la vita con te. Mio padre, mia madre, i taglialegna, i capisquadra... Rinuncerei a tutto, a tutti loro, per poter stare con te, solo io e te, insieme, per sempre.» Naturalmente, divorai le sue parole. Oltrepassarono la mia vergogna e mi si conficcarono in testa, come un sorso di whisky particolarmente forte. Non voglio essere fraintesa: in quel momento era davvero convinto di amarmi con tutto il cuore e io ero certa della sua sincerità. Ma adesso, con la saggezza che ho conquistato a caro prezzo, capisco quanto eravamo stupidi a dirci cose così pericolose. Eravamo arroganti, ingenui, credevamo che ciò che provavamo in quel momento fosse vero amore. Ripensandoci ora, capisco che stavamo soltanto riempiendo l’uno i vuoti dell’altra, così come la marea spinge la sabbia dentro le fenditure di uno scoglio. Entrambi – o forse ero soltanto io? – curavamo le nostre ferite con quello che proclamavamo amore vero. Ma, alla fine, la marea riprende sempre quello che ha sospinto a riva. Jonathan non avrebbe mai potuto darmi quello che aveva dichiarato di desiderare. Non poteva ripudiare la sua famiglia e rinunciare alle sue responsabilità. E non c’era bisogno che mi dicesse che i suoi genitori non mi avrebbero mai accettata come sua moglie. Ma quel tardo pomeriggio, al freddo nel granaio, avevo tutto l’amore di Jonathan solo per me e a quel punto ero pronta a fare di tutto per tenermelo stretto. Mi aveva dichiarato il suo amore, io ero sicura di amarlo: era la prova che eravamo fatti per stare insieme e che, fra tutte le anime dell’universo creato da Dio, noi eravamo legati l’uno all’altra. Legati dall’amore. Nei due mesi che seguirono, ci potemmo incontrare in quel modo soltanto altre due volte, molto poco per due amanti. In entrambe le occasioni, parlammo poco (lui solo per dirmi quanto gli fossi mancata); facevamo subito l’amore, con fretta dettata dalla paura di essere scoperti ma dovuta anche al freddo. Ci spogliavamo quanto osavamo e usavamo le mani e le bocche per massaggiare, accarezzare e baciare. Ogni volta, ci univamo come se fosse l’ultima per ciascuno di noi. Forse presentivamo il futuro di infelicità che ci stava per assalire alle spalle, un conto alla rovescia di secondo in secondo prima che ci avvolgesse nel suo abbraccio mortale. Entrambe le volte, ci separammo in tutta fretta, quando ancora sentivo il suo odore sotto i miei vestiti, un calore al ventre e le guance arrossate, tanto che speravo che i miei genitori mi credessero ammalata per il freddo. Ogni volta che ci separavamo, comunque, i dubbi tornavano a logorarmi. Avevo l’amore di Jonathan, per il momento, ma che importanza aveva? Se c’era qualcuno che conosceva i precedenti di Jonathan, ero io. Aveva amato anche Sophia, eppure io ero riuscita a fargliela dimenticare, a quanto sembrava. Potevo illudermi che mi sarebbe sempre stato fedele, potevo scegliere di chiudere gli occhi e buttarmi, come fanno molte donne, e sperare che col tempo tutto si sarebbe sistemato. La mia fiducia cieca era animata anche dall’ostinata convinzione che fosse Dio stesso a sancire i legami d’amore, a prescindere da quanto potessero essere sconvenienti, improbabili o dolorosi, e l’uomo non poteva opporvisi. Dovevo avere fede nel mio amore, credere che mi avrebbe permesso di superare qualsiasi imperfezione dell’amore che Jonathan provava per me. E l’amore, in fondo, altro non è che fede, e ogni fede viene messa alla prova prima o poi. Adesso so che solo gli stupidi cercano rassicurazioni nell’amore. L’amore ci chiede così tanto che, in cambio, cerchiamo di avere la garanzia che durerà per sempre. Chiediamo l’eternità, ma chi può prometterla davvero? Avrei dovuto accontentarmi dell’amore solido e fraterno che Jonathan aveva provato per me quando eravamo ragazzini. Quello sì che era un amore eterno. E invece tentai di trasformare i suoi sentimenti per me in quello che non erano e così facendo rovinai l’unica cosa eterna e meravigliosa che avevo. A volte gli eventi peggiori accadono sotto forma di un’assenza. Un amico che non viene a trovarci quando è solito farlo, e che poco dopo rinnega la sua amicizia. Una lettera tanto attesa che non arriva, seguita poco tempo dopo dalla notizia di una morte prematura. E, nel mio caso, quell’inverno, la cessazione del mio ciclo mestruale. Prima un mese. Poi, un secondo mese. Pregai che ci potesse essere un’altra causa. Maledissi lo spirito di Sophia, sicura che fosse la sua vendetta. Ma una volta evocato, comunque, lo spirito di Sophia non fu così facile da contenere. Sophia iniziò ad apparire nei miei sogni. A volte intravedevo semplicemente il suo volto stridente tra la folla, pieno di accusa, poi spariva. In un sogno ricorrente, ero con Jonathan e a un certo punto d’improvviso lui mi abbandonava, distogliendo lo sguardo come in risposta a un comando invisibile, ignorando le mie preghiere perché rimanesse. Poi ricompariva in compagnia di Sophia, camminavano mano nella mano e io li vedevo da lontano e capivo che per Jonathan non esistevo più. Da quei sogni mi svegliavo sentendomi ferita e abbandonata. Il sogno peggiore mi faceva svegliare di soprassalto, come se un cavallo mi scalciasse, e dovevo soffocare le urla per non destare le mie sorelle. Gli altri sogni probabilmente erano frutto dei miei sensi di colpa, ma quello non poteva essere altro che un messaggio dall’oltretomba di Sophia in persona. In quel sogno, camminavo lungo il viale principale di un villaggio deserto, col vento alle spalle. Non c’era nessuno in vista, nessuna voce, nessun segno di vita, nessuno che tagliava la legna, nessun rumore di ferro battuto dalla bottega del fabbro. E di colpo mi ritrovavo nei boschi innevati, seguendo la riva dell’Allagash. Mi fermavo in una rientranza del fiume e vedevo Sophia in piedi sulla riva opposta. Si è appena suicidata: la pelle è blu, i capelli sono stopposi e ghiacciati, i vestiti inzuppati le pesano addosso. È l’amante dimenticata, che si decompone nella tomba, ed è a sue spese che io ho trovato la felicità. Il suo sguardo cadaverico si posa su di me e poi lei indica le acque. Non dice una parola, ma so che cosa mi vuole dire: buttati nell’acqua, poni fine alla tua vita e alla vita del tuo bambino. Non osavo parlare della mia condizione a nessuno della mia famiglia, nemmeno alle mie sorelle con le quali solitamente mi confidavo. Mia madre osservò in un paio di occasioni che sembravo sempre preoccupata e intrattabile, anche se poi ci scherzava sopra e diceva che a giudicare dal mio comportamento dovevo soffrire parecchio per via delle mestruazioni. Se solo avessi potuto parlarle della mia situazione... Ma dovevo la mia lealtà a Jonathan. Non potevo rivelare la nostra relazione ai miei genitori senza prima consultarmi con lui. Aspettavo il momento in cui avrei rivisto Jonathan alla messa della domenica, ma la natura intervenne ancora una volta. Passarono diverse settimane prima che la strada per il villaggio fosse nuovamente praticabile. E, a quel punto, sentivo il mio tempo scadere: se fossi stata costretta ad aspettare ancora per molto, non sarei stata più in grado di nascondere il mio segreto. Pregavo ogni secondo perché Dio mi concedesse la grazia di poter parlare con Jonathan ancora una volta e presto. E il Signore udì le mie preghiere perché finalmente spuntò il primo sole d’inverno e splendette per giorni e giorni di fila, tanto che molta della neve caduta di recente si sciolse. E finalmente, una domenica, riuscimmo a sellare il cavallo e a montarlo. Ci avvolgemmo in mantelli, sciarpe, guanti e coperte e ci ammassammo sul fondo del calesse, stretti stretti, per andare al villaggio. Nella sala della congregazione, ebbi l’impressione che tutti mi guardassero. Dio sapeva della mia condizione, naturalmente, ma mi parve che tutti al villaggio ne fossero a conoscenza. Temevo che il mio addome mostrasse i primi segni di rigonfiamento e che gli occhi di tutti fossero puntati sull’inusuale gonfiore sotto la mia gonna. Ma era troppo presto perché si vedesse, e comunque era improbabile che qualcuno potesse notare qualcosa di strano sotto tutti i vestiti invernali che indossavo. Rimasi vicina a mio padre e per tutta la messa mi nascosi dietro una colonna, augurandomi di essere invisibile. Attendevo soltanto il momento in cui avrei finalmente potuto parlare con Jonathan da sola, dopo la messa. Non appena il pastore Gilbert ci congedò, mi affrettai giù dalle scale senza aspettare mio padre. Mi fermai sull’ultimo gradino, cercando Jonathan. E alla fine spuntò e si fece largo verso di me. Senza dire una parola, gli afferrai la mano e lo trascinai dietro la scalinata, dove potevamo parlare più tranquillamente. Quella mossa inattesa lo rese nervoso, e si guardò alle spalle per controllare che nessuno avesse notato che ci eravamo appartati senza un accompagnatore. «Buon Dio, Lanny, se credi che possa baciarti qui...» «Ascoltami. Sono incinta» gli confessai di schianto. Lui lasciò cadere la mia mano e il suo bellissimo volto fu attraversato da una serie di espressioni diverse: shock, sorpresa e poi un’incalzante comprensione che lo fece impallidire. Anche se non mi ero certo aspettata che la mia notizia lo rendesse felice, il suo silenzio mi terrorizzò. «Jonathan, ti prego, dimmi qualcosa. Non so cosa fare.» Lo presi per il braccio. Lui mi guardò di sottecchi, poi si schiarì la voce. «Mia cara Lanny, non so che cosa dire...» «Non è questo che una ragazza nelle mie condizioni si vuole sentir dire!» Mi spuntarono le lacrime agli occhi. «Dimmi che non sono da sola, dimmi che non mi abbandonerai. Dimmi che mi aiuterai a capire che cosa fare.» Lui continuò a guardarmi stralunato e poi con palese riluttanza e tensione mi disse: «Non sei da sola». «Non puoi immaginare quanta paura ho avuto per tutto questo tempo, costretta a tenermi questo segreto, a casa, incapace di parlarne con qualcuno. Sapevo che dovevo dirlo a te per primo, Jonathan, te lo dovevo.» Parla, parlami, lo implorai con lo sguardo. Dimmi che confesserai il tuo ruolo nel mio disonore ai nostri genitori e che mi renderai giustizia. Dimmi che mi ami ancora. Dimmi che mi sposerai. Trattenni il fiato, le lacrime che mi scendevano copiose sulle guance, sul punto di svenire per il desiderio di sentirgli pronunciare quelle parole. Ma Jonathan non riusciva nemmeno a guardarmi in faccia. Abbassò lo sguardo sul pavimento. «Lanny, devo dirti una cosa, ma, credimi, preferirei morire piuttosto che darti questa notizia proprio ora.» Mi sentii mancare la terra sotto i piedi e un impeto di terrore mi assalì, facendomi ricoprire di sudori freddi. «Che cosa ci può essere di più importante di quello che ti ho appena detto?» «Sono stato fidanzato ufficialmente. L’accordo è stato chiuso questa settimana. Mio padre è nella hall a dare l’annuncio proprio in questo momento, ma dovevo trovarti e dirtelo io stesso, prima. Non volevo che lo sentissi da qualcun altro...» Le parole gli morirono in gola quando si rese conto di quanto poco contasse la sua cortesia per me in quel momento. Quando eravamo ragazzini scherzavamo spesso sul fatto che Jonathan non fosse ancora stato fidanzato ufficialmente. Quella faccenda dei matrimoni combinati era difficile da gestire in un piccolo villaggio come St. Andrew. I migliori potenziali mariti e mogli venivano assegnati molto in fretta, i loro matrimoni venivano combinati quando ancora erano bambini di sei anni, perciò se una famiglia non agiva prontamente rischiava di non trovare più nessun candidato papabile. Si sarebbe potuto pensare che un ragazzo ricco e altolocato come Jonathan sarebbe stato un candidato perfetto per qualsiasi famiglia del villaggio con figlie da maritare. E lo era, eppure non era mai stato combinato un matrimonio, nemmeno per le sue sorelle. Jonathan sosteneva che fosse per via delle ambizioni sociali di sua madre: non reputava nessuna delle famiglie del villaggio all’altezza dei suoi figli. Avrebbero sicuramente trovato di meglio fra i soci del marito o attraverso i legami della sua famiglia a Boston. Negli anni c’erano state ripetute indagini in tal senso, alcune sembravano più fruttuose di altre, ma alla fine erano sfumate tutte le opportunità e Jonathan era arrivato a vent’anni senza una promessa sposa. Mi sentivo come se mi avessero aperto il ventre con un coltello da macellaio. «E chi è lei?» Lui scosse il capo. «Non è questo il momento di parlarne. Dovremmo parlare della tua condizione, ora, e...» «Chi è lei? Esigo di saperlo!» gridai. Il suo sguardo ebbe un momento di esitazione. «È una delle McDougal. Evangeline.» Anche se le mie sorelle erano amiche delle figlie dei McDougal, non riuscivo a ricordarmi quale fosse Evangeline, perché erano tante. I McDougal avevano sette figlie, una vera e propria tribù, tutte molto graziose in un modo un po’ severo che faceva trasparire la loro ascendenza scozzese, alte e robuste, con capelli rossi e ricci selvaggi, pelle lentigginosa che scintillava come rame al sole d’estate. Conoscevo anche la signora McDougal: una donna pratica e sempre di buon umore, con lo sguardo scaltro, forse più in gamba del marito, che se la cavava con la sua fattoria, sebbene tutti sapessero che era stata lei a far girare gli affari e ad aver innalzato il livello sociale della famiglia. Cercai di immaginarmi Jonathan insieme a una donna come la signora McDougal, e mi venne la tentazione di gettarmi ai suoi piedi. «E hai intenzione di accettare il fidanzamento?» gli chiesi. «Lanny, non so cosa dire... Non credo di potermi rifiutare...» Mi prese per mano e cercò di trascinarmi indietro verso un angolo più in ombra. «Il contratto con i McDougal è già stato firmato, gli annunci sono stati fatti. Non so come potrebbero reagire i miei genitori rispetto alla nostra... situazione.» Avrei potuto discutere con lui, anche furiosamente, ma sapevo che sarebbe stato tutto inutile. Il matrimonio era un contratto d’affari a tutti gli effetti, sottoscritto per incrementare le possibilità finanziarie delle famiglie coinvolte. Un’opportunità come quella, unire le proprie sorti a quelle della famiglia St. Andrew, non sarebbe stata gettata al vento con facilità, di certo non per un peccatuccio così comune come una gravidanza extramatrimoniale. «Mi addolora dirtelo, ma incontreremmo forti obiezioni al nostro matrimonio» mi spiegò Jonathan, il più gentilmente possibile. Io scossi la testa, affranta: non c’era bisogno che me lo dicesse. Mio padre era rispettato al villaggio per la sua indole quieta e per il suo giudizio, ma noi McIlvrae non avevamo molto altro a nostro favore come promesse spose, eravamo povere e poi metà della nostra famiglia era cattolica. Dopo un po’, gli chiesi con voce roca: «E questa Evangeline... è quella dopo Maureen?» «È la più giovane» mi rispose Jonathan. Poi, dopo un secondo di esitazione, aggiunse: «Ha quattordici anni». La più giovane. Mi ricordavo della bambinetta che le sue sorelle si portavano dietro quando venivano a casa nostra per lavorare al punto croce con Maeve e Glynnis. Era una bambolina tutta rosa, con sottili capelli dorati e una malaugurata inclinazione a piangere a ogni piè sospinto. «Quindi il fidanzamento è ufficiale ma la data delle nozze, se lei ha solo quattordici anni, dev’essere ancora lontana...» Jonathan scosse il capo. «Il vecchio Charles vuole che ci sposiamo il prossimo autunno, se possibile. E comunque entro la fine dell’anno.» Io rimarcai l’ovvio. «Vuole disperatamente che tu abbia un erede che porti avanti il nome di famiglia.» Jonathan mi abbracciò le spalle, tenendomi stretta, e io avrei tanto voluto rimanere aggrappata a quel calore e a quella forza per sempre. «Dimmi, Lanny, cosa vorresti che facessimo? Dimmelo e farò del mio meglio per soddisfare il tuo desiderio. Vuoi che dica tutto ai miei genitori e chieda loro di rompere il contratto di fidanzamento e liberarmi?» Mi avvolse una gelida tristezza. Aveva detto quello che volevo sentirmi dire, ma si vedeva benissimo che aveva paura della mia risposta. Anche se non aveva alcun desiderio di sposare Evangeline, ora che l’inevitabile contratto era stato siglato si era rassegnato a onorarlo. Non voleva che prendessi sul serio la sua offerta. E con ogni probabilità sarebbe stato comunque inutile: per la sua famiglia io ero inaccettabile. Suo padre voleva un erede, certo, ma sua madre avrebbe insistito per avere un erede concepito nel matrimonio, un bambino libero da ogni scandalo. I genitori di Jonathan avrebbero insistito perché lui sposasse comunque Evangeline McDougal, e una volta che si fosse sparsa la voce della mia gravidanza, io sarei stata rovinata. Ma c’era un’altra via d’uscita. Non avevo detto la stessa cosa a Sophia pochi mesi prima? Strinsi la mano di Jonathan. «Potrei andare dalla levatrice.» Un’espressione di gratitudine gli si dipinse in volto per un attimo. «Se è quello che vuoi.» «Cercherò... cercherò di andarci il prima possibile.» «Posso aiutarti con le spese» mi disse, rovistando nelle sue tasche. Tirò fuori una pesante moneta e me la mise in mano. Fui nauseata, per un istante, e resistetti all’impulso di schiaffeggiarlo. Sapevo che ero soltanto arrabbiata. Osservai la moneta per qualche attimo, poi la infilai nel guanto. «Mi dispiace tanto, Lanny» mormorò, baciandomi sulla fronte. Lo stavano cercando, il suo nome riecheggiava dalla sala della congregazione. Sgusciò via per rispondere al richiamo prima che ci scoprissero insieme, e io mi trascinai di nuovo su per le scale fino alla balconata, per vedere che cosa stesse accadendo. La famiglia di Jonathan era radunata nella navata davanti al loro banco, quello più vicino al pulpito, la piazza d’onore. Charles St. Andrew era in cima alla navata, le braccia rialzate. Stava facendo un annuncio e sembrava più piccato del solito. Era ridotto così dall’autunno precedente, diceva che era per la troppa stanchezza o forse per il troppo vino (casomai, era una combinazione di troppo vino e troppe servette). Ma era come se da un giorno all’altro fosse diventato vecchio, grigio, con la pelle afflosciata. Si stancava facilmente, si addormentava durante la messa non appena il pastore Gilbert apriva la Bibbia. Ben presto non si diede nemmeno più la briga di partecipare ai consigli cittadini e iniziò a mandare Jonathan al suo posto. Nessuno di noi, a quel tempo, poteva immaginare che stesse morendo. Aveva costruito lui quel villaggio, in fin dei conti, e con le sue stesse mani. Era indistruttibile, un colono coraggioso, un uomo d’affari di straordinarie capacità. Ripensandoci, probabilmente era quello il motivo per cui aveva insistito perché Jonathan si sposasse in fretta e avesse dei figli: Charles St. Andrew aveva capito che il suo tempo su questa terra stava per scadere. I McDougal percorsero a grandi falcate la navata per unirsi a lui nell’annuncio formale. Il signore e la signora McDougal sembravano due oche seguite dalle loro ochette, tutte in fila e più o meno in ordine d’età. Sette ragazze, alcune tutte in ghingheri, altre più disordinate, con lacci e nastri che sfuggivano ribelli dai loro corpetti. E ultima della fila la più piccola della famiglia, Evangeline. Mi salì un groppo in gola quando la vidi: era bellissima. Non era certo una robusta ragazza di campagna; Evangeline era nell’età incerta in cui si è ancora una ragazzina, ma sul punto di diventare una donna. Era aggraziata e slanciata, con piccoli seni e fianchi appena arrotondati, e labbra da cherubino. I capelli erano rimasti dorati e le cadevano sulle spalle e sulla schiena in lunghi boccoli. Era evidente perché la madre di Jonathan avesse scelto Evangeline: era un angelo mandato in terra, una creatura celestiale degna delle attenzioni del suo figlio maggiore. Fui sul punto di scoppiare a piangere, lì in chiesa davanti a tutti, invece, mi morsi il labbro e la osservai avvicinarsi a Jonathan, rivolgergli un lieve cenno di saluto, lanciandogli un timido sguardo da sotto il suo cappellino. E lui, pallido in volto come non mai, ricambiò il saluto. L’intera congregazione notò quel breve scambio e capì che cosa si erano comunicati in un battito di ciglia. «Era ora che gli trovassero una moglie» borbottò qualcuno dietro di me. «Adesso magari la smetterà di andar dietro a tutte le ragazze che gli capitano a tiro come un cane in calore.» «Ma è uno scandalo! Quella è poco più di una bambina e...» «Stai zitta, su. Hanno soltanto sei anni di differenza, e ci sono in giro mariti ben più vecchi delle loro mogli...» «È vero, tra pochi anni non farà differenza, quando lei ne avrà diciotto o venti. Ma adesso ne ha quattordici! Pensa se fosse tua figlia, Sarabeth! Vorresti vederla sposata al figlio di St. Andrew?» «Santo Dio, no di certo!» Sotto, le altre figlie dei McDougal si erano disposte a semicerchi attorno a Jonathan e ai loro genitori, mentre Evangeline era rimasta educatamente un passo indietro a suo padre. Non è il momento di essere timida, pensai in quel frangente, sporgendomi come se potessi sentire quello che si dicevano laggiù. Sei la futura sposa. Quel bellissimo uomo sarà tuo marito, l’uomo che ti porterà a letto con sé ogni sera. È un uomo difficile da amare, devi dimostrare di essere all’altezza del compito. Vai al suo fianco. E alla fine, dopo diverse insistenze dei genitori, lei fece qualche timido passo, spostandosi dall’ombra del padre, come un puledro appena nato, ancora instabile sulle gambe. Fu solo quando furono fianco a fianco che me ne resi conto appieno: era davvero soltanto una bambina. Me li immaginai a letto insieme, e lui sembrava schiacciarla col suo peso. Era così minuta e tremava come una foglia non appena qualcuno le rivolgeva la parola. Lui le prese la mano e le si avvicinò. C’era qualcosa di galante nei suoi gesti, un senso di protezione. Ma poi Jonathan si chinò su di lei e la baciò. Non era uno dei suoi tipici baci, quelli così impressi nella mia memoria, così intensi che li avvertivi in tutto il corpo, fino alle punte dei piedi. Aveva dimostrato di accettare il contratto di matrimonio baciandola davanti alle loro famiglie e a tutta la congregazione. E davanti a me. Fu in quel momento che capii il messaggio di Sophia nei miei sogni. Non mi stava invitando a uccidermi per contrappasso a quello che avevo fatto a lei. Mi stava dicendo che se continuavo ad amare Jonathan, come aveva fatto lei, mi attendeva una vita di delusioni e sofferenze. Un amore troppo intenso può diventare velenoso e causare grande infelicità. Ma quale può mai esserne la cura? È possibile rinnegare il proprio desiderio? È possibile smettere di amare qualcuno? È più facile annegarsi, sembrava volermi dire Sophia; più facile scegliere un suicidio d’amore. Tutto questo mi passò per la mente mentre li guardavo dalla balconata, con le lacrime agli occhi e le unghie affondate nel tenero legno di pino del pilastro cui ero appoggiata. Ero molto in alto rispetto alla sala della congregazione, abbastanza in alto per gettarmi. Ma non lo feci. Anche in quel momento di disperazione, ero consapevole della nuova vita che portavo dentro di me. Così, mi voltai, corsi giù dalle scale e fuggii da quella scena straziante. 12 Tornai a casa sul calesse, con mio padre, chiusa nel silenzio. Lui continuava a osservarmi di sottecchi, ma io ero tutta avvolta nel mantello e nella sciarpa e tremavo al punto di battere i denti nonostante il sole d’inverno splendesse e ci irradiasse. Lui non disse niente, probabilmente attribuendo il mio malumore e il mio malessere alla notizia del fidanzamento di Jonathan. Ci fermammo alla cadente chiesa cattolica e trovammo mia madre, le mie sorelle e Nevin che ci attendevano in piedi nella neve, con le labbra blu e pieni di rimproveri per averli fatti aspettare così tanto. «Ora basta. Il nostro ritardo è dovuto a buone ragioni» disse mio padre in un tono che non ammetteva repliche. «Oggi, dopo la messa, è stato annunciato il fidanzamento di Jonathan.» Fortunatamente, furono tanto accorti da non esultare per la notizia in mia presenza. Le mie sorelle mi lanciarono sguardi fuggevoli, mentre mio fratello si limitò a commentare: «Povera ragazza, chiunque sia». Quando arrivammo alla fattoria, Nevin sciolse le briglie al cavallo mentre mio padre andò a controllare il bestiame, e le mie sorelle approfittarono del bel tempo per occuparsi delle galline e delle pecore. Io seguii mia madre dentro casa. Lei si affaccendò in cucina, iniziando a preparare la cena, mentre io, ancora avvolta nel mantello, mi abbandonai su una sedia davanti alla finestra. Mia madre non era una stupida. «Vuoi una tazza di tè, Lanore?» mi chiese, davanti al camino. «Non fa niente, lascia stare» le risposi, cercando in tutti i modi di nascondere il groviglio di tristezza che mi imprigionava. Dandole la schiena, udii il clangore della grossa pentola appesa a un gancio sopra il fuoco e il rumore dell’acqua versata dal secchio di acqua fresca. «So che sei sconvolta, Lanore. Ma sapevi che questo giorno prima o poi sarebbe arrivato» mi disse poi, decisa ma gentile allo stesso tempo. «Sapevi che un giorno o l’altro il signorino Jonathan si sarebbe sposato, così come un giorno ti sposerai tu. Te l’avevamo detto che non era opportuno legarti a lui con un’amicizia così forte. Adesso capisci perché.» Mi concessi una lacrima, dato che lei non poteva vedermi in volto. Mi sentivo sfinita, come se uno dei tori nel campo mi avesse calpestato e colpito per un giorno intero. Dovevo farmi aiutare da qualcuno; in quel momento, seduta lì, capii che sarei morta se avessi continuato a tenere tutto dentro. Ma la vera domanda era: di chi potevo fidarmi nella mia famiglia? Mia madre era sempre stata amorevole con noi, difendendoci quando l’indole rigida di mio padre prendeva il sopravvento e i suoi rimproveri diventavano troppo pesanti. Era lei stessa una donna e aveva avuto sei gravidanze, e aveva seppellito due bambini nel cimitero. Se c’era qualcuno che poteva capire come mi sentivo e proteggermi, era lei. «Mamma, ti devo confessare una cosa, ma ho paura di come potreste reagire tu e mio padre. Ti prego, promettimi che mi vorrai ancora bene dopo che ti avrò detto quello che devo dirti» la implorai con voce tremante. Le sfuggì un grido soffocato, seguito dal rumore del cucchiaio che cadeva sul pavimento, e capii che non c’era bisogno che dicessi altro. Nonostante tutti i consigli, nonostante le suppliche e i rimbrotti, le sue peggiori paure si erano avverate. Ordinarono a Nevin di attaccare nuovamente il cavallo al calesse e di andare con le mie sorelle dai Dales, dall’altra parte della vallata, e rimanere lì finché non sarebbe venuto mio padre a prenderli. Io rimasi da sola con i miei genitori, in casa, al buio del tramonto, seduta su uno sgabello al centro della stanza, mentre mia madre piangeva sommessamente vicino al fuoco e mio padre mi girava intorno con passi furiosi. Non avevo mai visto mio padre così arrabbiato. Era paonazzo in volto, le mani strette a pugno tanto da sbiancare. Credo che l’unica cosa che lo trattenne dal picchiarmi furono le lacrime che mi scendevano copiose. «Come hai potuto farlo?» mi urlò addosso. «Come hai potuto concederti al figlio dei St. Andrew? Sei davvero pari alle puttane di strada? Ma che cosa ti è preso?» «Lui mi ama davvero, padre...» Quelle parole furono una provocazione di troppo per mio padre; si lanciò in avanti e mi schiaffeggiò in volto. Perfino mia madre trattenne il fiato per la sorpresa. Il dolore mi indolenzì il mento, ma fu la forza della sua rabbia a sconvolgermi. «È questo che ti ha detto? E tu sei così stupida da credergli, Lanny?» «Ti sbagli. Mi ama davvero...» Tirò indietro il braccio per colpirmi una seconda volta, ma si fermò. «Ma non credi che abbia detto la stessa cosa a qualsiasi ragazza pur di farla cedere ai suoi desideri? Se i suoi sentimenti per te sono autentici, come mai si è fidanzato con la figlia dei McDougal?» «Non lo so» singhiozzai, asciugandomi le lacrime dalle guance. «Kieran» intervenne mia madre, secca, «non essere crudele.» «È una dura lezione» le rispose mio padre, guardandola da sopra una spalla. «I McDougal mi fanno pena, ed è una vera vergogna per la piccola Evangeline, ma io non vorrò mai e poi mai un St. Andrew come genero.» «Jonathan non è cattivo» protestai. «Ma ascoltati! Stai difendendo l’uomo che ti ha messa incinta e non ha nemmeno la decenza di essere qui, di fianco a te, a dare la notizia alla tua famiglia!» sbraitò mio padre. «Immagino che quel bastardo sappia della tua condizione...» «Sì, lo sa.» «E il capitano? Credi che abbia avuto il coraggio di dirlo a suo padre?» «Io... non lo so.» «Ne dubito» disse, ricominciando a camminarmi attorno, i tacchi che risuonavano minacciosi sul pavimento di pino. «Ed è meglio così. Non voglio avere niente a che fare con quella famiglia. Mi hai capito bene? Niente a che fare. Ho preso la mia decisione, Lanore: ti manderemo a partorire lontano. Molto lontano.» Alzò gli occhi e non mi sfiorò nemmeno con lo sguardo mentre parlava. «Tra qualche settimana ti manderemo a Boston, non appena le strade saranno praticabili, in un posto dove potrai partorire. Un convento.» Guardò mia madre, che annuì, con lo sguardo abbassato in grembo. «Le suore gli troveranno una casa, una casa di bravi cattolici, così tua madre si metterà il cuore in pace.» «Volete togliermi il mio bambino?» Feci per alzarmi dallo sgabello, ma mio padre mi spinse giù a sedere. «È naturale. Non puoi tornare a St. Andrew con il frutto della tua vergogna. Non sopporterò mai che i nostri concittadini ti vedano come un’altra delle tante conquiste del giovane St. Andrew.» Ricominciai a piangere disperata. Il bambino sarebbe stata l’unica cosa di Jonathan che mi sarebbe rimasta, come potevo abbandonarlo? Mia madre mi si avvicinò e mi prese la mano. «Devi pensare alla tua famiglia, Lanore. Pensa alle tue sorelle. Pensa alla vergogna se al villaggio si venisse a sapere. Chi mai vorrebbe che suo figlio sposasse una delle tue sorelle dopo che tu ci hai disonorati tutti?» «Non vedo perché le mie colpe dovrebbero ricadere sulle mie sorelle» risposi con voce roca, ma dentro di me sapevo che era la verità. I benpensanti del nostro villaggio avrebbero fatto soffrire tremendamente le mie sorelle, e i miei genitori, per i miei errori. Alzai la testa. «Quindi... Non direte al capitano che sono incinta?» Mio padre smise di camminare e si voltò a guardarmi. «Non darò mai al vecchio bastardo la soddisfazione di sapere che mia figlia non è riuscita a resistere a suo figlio.» Scosse il capo. «Puoi pensare il peggio di me, Lanore. Io prego soltanto di fare la cosa giusta per te. So soltanto che devo cercare di salvarti dalla rovina completa.» Ma io non provai alcuna gratitudine. Non volevo essere mandata via. Egoista come sono, il mio primo pensiero non andò alla mia famiglia e al loro dolore ma a Jonathan. Sarei stata costretta a lasciare la mia casa e non avrei mai più visto Jonathan. Il solo pensiero mi lacerava il cuore come una lama. «Devo proprio andarmene?» domandai, con voce rotta dalla disperazione. «Perché non posso andare dalla levatrice? Così potrei rimanere. Nessuno lo saprebbe.» Lo sguardo gelido di mio padre a quel punto mi ferì più profondamente di un altro schiaffo. «Io lo saprei, Lanore. Io lo saprei e tua madre lo saprebbe. Altre famiglie potrebbero perdonarlo, ma... Noi non possiamo lasciartelo fare. Sarebbe un peccato gravissimo, peggiore perfino di quello che hai già commesso.» Quindi non soltanto ero una pessima figlia e un burattino inerme nelle mani di Jonathan, ma nel mio cuore albergava anche un istinto di assassina miscredente. In quel momento avrei voluto morire, ma la vergogna non basta a uccidere. «Capisco» dissi, asciugandomi le lacrime ormai fredde dal volto, decisa a non piangere più di fronte a mio padre. Oh, quanta vergogna, quanta paura provai quella notte. Oggi, ripensandoci, mi sembra così ridicola quella vergogna, quel terrore. Ma in quel tempo, ero soltanto un’altra vittima, alla mercé della religione e del buon costume, tutta tremante e piangente nella casa dei miei genitori, schiacciata dai precetti di mio padre. Ero una piccola anima inerme sul punto di essere mandata in esilio nel mondo scuro e crudele. Mi ci sarebbero voluti anni per perdonare me stessa. Quella notte, invece, pensai che la mia vita era finita. Mio padre mi riteneva una puttana e un mostro, e mi stava allontanando per sempre dall’unica cosa che contasse per me. Non credevo di poter continuare a vivere. Il periodo più duro dell’inverno alla fine passò. Le giornate brevi e buie iniziarono ad allungarsi e i cieli perennemente coperti, del colore della flanella consunta, iniziarono a schiarirsi. Mi chiesi se anch’io cambiavo a poco a poco come il bambino dentro di me o se i miei cambiamenti corporei erano soltanto frutto della mia immaginazione. In fin dei conti, ero sempre stata magra e nella situazione in cui mi trovavo avevo perso ogni appetito. I miei vestiti non mi stavano stretti come mi ero aspettata, ma forse era soltanto il mio senso di colpa che mi faceva immaginare tutto. In certi momenti mi chiedevo se Jonathan stesse pensando a me, se sapesse che mi avrebbero cacciata via e se fosse addolorato per avermi abbandonata. Forse dava per scontato che avessi fatto quello che gli avevo detto, che fossi andata dalla levatrice e avessi abortito. Forse era distratto dal suo imminente matrimonio. Non avevo modo di saperlo; non mi era più permesso andare alla messa della domenica, né con mia madre né con mio padre, e quindi mi era stata sottratta l’unica possibilità di vedere Jonathan. I giorni passarono con terrificante monotonia. Mio padre mi tenne occupata ogni minuto, da quando ci svegliavamo nella penombra del nuovo giorno fino a quando poggiavo la testa sul cuscino la sera. Le notti non mi davano sollievo, perché sognavo sempre più spesso Sophia: si rialzava dalle gelide acque dell’Allagash, si levava per aria come fumo dalla sua tomba nel cimitero, si aggirava intorno alla mia casa nel buio come un fantasma tormentato. E forse il suo fantasma trovava un leggero conforto nella mia disperazione. Ogni sera prima di andare a dormire mi inginocchiavo di fianco al letto e mi chiedevo se sarebbe stato blasfemo chiedere a Dio di sollevarmi da quella pena. Se l’esilio era la punizione per i miei orrendi peccati, non avrei dovuto accettare la mia croce invece di osare chiedere perdono a Dio? A mano a mano che l’inverno svaniva e il giorno del mio allontanamento si avvicinava, le mie sorelle diventavano sempre più tristi. Trascorrevano più tempo possibile con me e non parlavano mai della mia partenza, ma si sedevano al mio fianco, mi abbracciavano, poggiavano la loro fronte sulla mia. Lavoravano alacremente con mia madre per rammendarmi i vestiti, perché non volevano mandarmi via con l’aspetto della rozza contadina, e mi avevano fatto perfino un nuovo mantello utilizzando la lana della primavera precedente. Non c’era modo di rimandare per sempre l’inevitabile e una notte, quando il disgelo era definitivamente iniziato nella vallata, mio padre mi disse che era tutto pronto e organizzato. Sarei partita la domenica seguente sul carro del droghiere, scortata dal maestro cittadino, Titus Abercrombie. Da Presque Isle avremmo preso la carrozza fino a Camden, poi la nave fino a Boston. L’unico baule che possedevamo fu riempito con le mie cose e lasciato davanti alla porta di casa, e un foglio con su scritti i nomi di tutti quelli che avrei dovuto contattare (il capitano della nave, la madre superiora del convento) fu cucito alla fodera di una sottoveste. Mi diedero anche tutte le monete che riuscirono a racimolare. Le mie sorelle passarono l’ultima notte accoccolate al mio fianco nel nostro grande letto, non volevano lasciarmi andare. «Non capisco perché nostro padre voglia mandarti via.» «Non ha voluto ascoltarci, l’abbiamo pregato in ginocchio, ma non ha voluto.» «Ma ti rivedremo? Verrai ai nostri matrimoni? Sarai al nostro fianco quando ci sarà il battesimo dei nostri figli?» Le loro domande mi fecero salire le lacrime agli occhi. Le baciai delicatamente sulla fronte e le strinsi a me. «Ma certo che ci rivedremo. Starò via soltanto per poco tempo. Adesso non piangete più, eh? Succederanno talmente tante cose mentre sarò via che non vi accorgerete nemmeno della mia assenza.» Loro piansero ancora di più e negarono, giurando che avrebbero pensato a me ogni giorno. Lasciai che piangessero fino allo sfinimento e che si addormentassero, mentre io rimasi sveglia per tutta la notte, cercando di trovare un po’ di pace prima dell’alba. Quando, all’alba, arrivammo, i cocchieri stavano assicurando i cavalli ai carri, vuoti perché avevano scaricato tutta la merce – farina, pezze di tessuti diversi, aghi, tè – al negozio dei Watford il giorno precedente. C’erano tre grossi carri e sei uomini muscolosi che sistemarono gli ultimi finimenti ai cavalli, osservando timidamente la mia famiglia radunata attorno a me. Le mie sorelle erano strette a mia madre, e tutte piangevano. Mio padre e Nevin rimasero in piedi in disparte, rigidi e freddi. Uno dei cocchieri tossì, riluttante a intromettersi ma ansioso di partire in orario. «È ora di andare» disse mio padre. «Voi salite in carrozza, ragazze.» Attese che mia madre mi abbracciasse un’ultima volta, mentre Nevin aiutava il cocchiere a caricare il mio pesante baule sul pianale del carro vuoto. Mio padre si rivolse a me. «Questa è la tua opportunità di redimerti, Lanore. Dio ha scelto di darti un’altra possibilità, ma vedi di non sprecare la sua generosità. Io e tua madre pregheremo che tu partorisca senza problemi, ma non pensare nemmeno di rifiutare l’aiuto delle suore a trovare un posto per il tuo bambino presso un’altra famiglia. Ti ordino di non tenere il bambino, e se tu invece riterrai di non obbedire ai miei ordini, tanto vale che tu non rimetta mai più piede a St. Andrew. Se non diventerai una cristiana timorata di Dio, non voglio più avere niente a che fare con te.» Sconvolta, mi avvicinai al carro, dove c’era Titus ad attendermi. Con dignità e cortesia, mi aiutò a salire sul pianale al suo fianco. «Mia cara, è un piacere scortarti fino a Camden» disse in tono rigido e formale, ma amichevole, lo stesso tono che Jonathan prendeva sempre in giro. Non conoscevo bene Titus perché non avevo mai frequentato le sue lezioni; potevo giudicarlo soltanto in base a quello che Jonathan mi aveva raccontato di lui. Era un vecchio gentiluomo, piuttosto fragile, con il fisico dello studioso: braccia e gambe storte, lo stomaco che nel corso degli anni era diventato prominente. Aveva perso ormai quasi tutti i capelli e quelli rimasti erano grigi, e formavano dei ciuffi attorno al cranio pelato simili a quelli di Benjamin Franklin. Era uno dei pochi uomini del villaggio a portare gli occhiali, con una montatura sottile di fil di ferro, che facevano apparire i suoi occhi ancora più piccoli e umidicci. Titus trascorreva le estati a Camden a insegnare latino ai figli di suo cugino in cambio di ospitalità, poiché tutti gli studenti di St. Andrew lavoravano nelle fattorie di famiglia fino all’inizio della scuola, in autunno. C’era un altro passeggero, uno dei taglialegna di St. Andrew che si era ferito e stava tornando a Camden per trascorrere la convalescenza in compagnia della sua famiglia. Aveva la mano avvolta in bende di stracci puliti. Quando il carro si mise in moto, iniziai a piangere furiosamente, ricambiando i frenetici gesti di saluto di mia madre e delle mie sorelle. A mano a mano che il carro arrancava e sferragliava allontanandosi dal villaggio, il dolore nella gola e al cuore diventò sempre più intenso, mentre guardavo l’unico posto al mondo che conoscevo rimpicciolire nella distanza e dicevo addio all’unico uomo che avessi mai amato. 13 Fort Kent Road, oggi Il confine non è poi così lontano. Anche se sono trascorsi anni dall’ultima volta che ci è venuto, da quando ci aveva portato malvolentieri la sua famiglia per una vacanza, Luke è sicuro di riuscire a trovare la strada senza l’aiuto della mappa. Prende stradine secondarie, che sono più lente e allungano il percorso, ma ritiene che in questo modo le probabilità di incrociare una pattuglia della polizia di Stato siano minori. Siccome gli agenti sono pochi, non vengono mandati a sorvegliare anche le strade secondarie o a piantonare le città più piccole. Invece le autostrade sono le più problematiche: eccessi di velocità, TIR sovraccarichi oltre i limiti di legge, tutte contravvenzioni che permettono di spiccare multe e far guadagnare lo Stato, anche se non molto. Afferra il volante esattamente al centro e guida con una sola mano. La sua passeggera ha lo sguardo ostinatamente incollato alla strada e si mordicchia il labbro inferiore. Quando fa così, sembra ancora di più un’adolescente che nasconde la preoccupazione sotto un velo di impazienza. «Senti» dice lui, cercando di alleggerire la tensione, «ti dispiace se ti faccio un paio di domande?» «Fai pure.» «Be’... dimmi, come ci si sente a essere... quello che sei?» «Non è niente di speciale.» «Davvero?» Lei si appoggia allo schienale e posa il gomito sul bracciolo. «Non mi sento diversa, o almeno, non per quanto mi ricordi. Non ho notato alcun cambiamento, non di giorno in giorno, almeno, non in modi significativi. Non è come avere dei superpoteri o cose simili. Non sono un personaggio di un fumetto.» Sorride per fargli capire che non ritiene stupida la sua domanda. «E quello scherzetto che mi hai fatto al pronto soccorso, quando ti sei tagliata... Ti ha fatto male?» «Non molto. Il dolore quasi non c’è, è più che altro un torpore, forse come se ti facessero un intervento chirurgico con poca anestesia. Solo la persona che ti rende così può farti del male, può davvero farti provare del dolore. Ma è passato tanto di quel tempo che quasi non ricordo più che cosa sia il dolore... quasi.» «È stata una persona a renderti così?» le domanda Luke, incredulo. «E com’è successo?» «Ci arriverò» gli risponde ancora sorridendo. «Abbi pazienza.» La rivelazione che quel miracolo è opera dell’uomo dà a Luke le vertigini, come se vedesse il panorama da una prospettiva completamente diversa e inedita. Rende tutto ancora più implausibile, impossibile, e quindi ancor più probabile che si tratti di un inganno da parte di una ragazza manipolatrice. «E comunque» prosegue lei, «sono praticamente la stessa di prima, a parte il fatto che... non mi stanco mai. Il mio fisico non si stanca più. Ma la stanchezza emotiva, quella la provo ancora.» «Depressione?» «Sì, probabilmente è così. Ci sono un sacco di ragioni, suppongo. Più che altro, di tanto in tanto mi assale l’inutilità della mia vita, la vita di chi non ha altra scelta se non continuare a vivere, giorno dopo giorno. Che senso c’è a sopportare tutto questo da soli, mi chiedo, se non per farmi soffrire, per costringermi a ricordare tutte le cose orrende che ho fatto o il modo in cui ho trattato le altre persone? Non è che possa farci molto, ormai. Non posso tornare indietro nel tempo e annullare i miei errori.» Non è la risposta che Luke si attendeva. Rimette la mano sul volante e lo sente vibrare quando passano su un tratto di asfalto rovinato. «Vuoi che ti prescriva qualche medicina?» Lei ride. «Antidepressivi, intendi? Non credo che servirebbero a molto.» «Le medicine non ti fanno più effetto?» «Diciamo che nel tempo ho sviluppato una forte resistenza.» Si allontana da lui e guarda fuori dal finestrino. «L’unico modo per sfuggire alla propria mente, a volte, è l’annullamento della coscienza.» «Annullamento? Intendi alcol o droghe?» «Possiamo smetterla di parlare di queste cose?» dice, con voce tremula. «Certo. Hai fame? Probabilmente è da un bel po’ che non mangi... vuoi che ci fermiamo a farci un boccone? Vicino a Fort Kent c’è un posto dove fanno delle ciambelle deliziose...» Lei scuote il capo indifferente. «Non ho mai fame. Non più. Posso stare settimane intere senza nemmeno pensare a mangiare. O a bere.» «E dormire? Vuoi fare un sonnellino?» «Non dormo nemmeno. Me ne dimentico. Dopo tutto, la cosa più bella del dormire è avere a fianco qualcuno, no? Un corpo caldo, un peso sul materasso accanto a te. Dà molto conforto, non credi? Sentire i respiri all’unisono, sincronizzati. È il paradiso.» Intendeva forse dire che non c’era un uomo nel suo letto da tanto tempo?, si chiese Luke. E allora, quell’uomo morto all’obitorio, il letto sfatto al capanno che cosa significavano? Forse si stava soltanto prendendo gioco di lui, mascherando la sua vera natura. «Ti manca tua moglie a letto con te?» gli chiese dopo un po’, sondandolo. Certo che gli mancava, anche se sua moglie si agitava molto nel sonno e spesso lo svegliava quando si spostava o gesticolava mentre sognava. Per le stesse ragioni, lui adorava vederla addormentata a letto quando tornava tardi dopo un turno lungo in ospedale, e osservava il suo corpo snello ed elegante drappeggiato dalle coperte che ne disegnavano le curve. I capelli biondi sparsi attorno alla testa, la bocca socchiusa; c’era qualcosa, nel guardarla senza che lei se ne accorgesse, che gliela faceva sembrare meravigliosa, e il ricordo di quei momenti di intimità gli fece salire un groppo in gola. È troppo da confidare a una sconosciuta, la sua solitudine, i suoi rimpianti, così decide di tacere. «Da quanto tempo ti ha lasciato tua moglie?» gli chiede Lanny. «Quasi un anno, ormai. Sta per sposare l’amore della sua adolescenza. È tornata nel Michigan. E si è presa le nostre due bambine.» «È... è terribile. Mi dispiace.» «Non sprecare la tua pietà con me. A quanto pare, tu devi affrontare molto di peggio.» Lui ha di nuovo quella strana sensazione, la stessa che ha provato fuori dall’obitorio, disorientato dal conflitto tra il racconto di quella donna e il mondo come l’ha sempre conosciuto. Com’è possibile che dica la verità? Proprio in quel momento, gli sembra di intravedere le strisce bianche e nere di un’auto della polizia nel retrovisore e svolta a destra. Da quanto tempo li stava seguendo senza che lui se ne accorgesse? La polizia è già sulle loro tracce? Quel pensiero è particolarmente inquietante per un uomo come lui che non ha mai avuto guai con la legge. «Che succede?» gli chiede Lanny, raddrizzandosi. «Sta succedendo qualcosa, lo capisco dalla tua espressione.» Luke continua a guardare dal retrovisore. «Stai tranquilla. Non voglio che ti allarmi, ma penso che ci stiano seguendo.» Parte II 14 Boston, 1817 Il viaggio verso sud a bordo del carro del droghiere richiese due settimane. Sfiorammo il limitare orientale delle Great North Woods e passammo sufficientemente lontani dal monte Katahdin da non vederne la cima innevata, poi seguimmo il fiume Kennebec giù fino a Camden. Fu un viaggio solitario attraverso quella parte dello Stato che, se oggi è ancora poco popolata, all’epoca era praticamente deserta. Incontrammo giusto qualche cacciatore e a volte ci accampammo con loro la notte, con i cocchieri che non vedevano l’ora di bere un po’ di whisky con qualcuno. I cacciatori che incrociammo erano più che altro del Canada francofono e spesso erano tipi riservati, duri, e quel mestiere si adattava alla perfezione alla loro indole di eremiti o comunque di uomini gelosi della propria indipendenza. Alcuni di loro mi sembrarono mezzi pazzi; parlavano da soli borbottando cose strane in modo inquietante mentre pulivano e oliavano i loro attrezzi prima di mettersi a lavorare sulla selvaggina che avevano catturato. Mettevano gli animali morti congelati accanto al fuoco dell’accampamento fino a quando non si riscaldavano a sufficienza, poi estraevano i loro coltelli a lama stretta e iniziavano a scuoiarli. Guardarli mentre aprivano e scuoiavano gli animali fino a scoprire la carne rossa e umida mi fece venire la nausea. Non mi andava per nulla di sedermi accanto a loro, così sgattaiolavo fino ai carri con Titus e lasciavo i cocchieri a bersi il whisky con i cacciatori, riscaldati dall’abbraccio del falò. Anche se ero affranta dal mio esilio, avevo sempre voluto vedere il mondo al di là del mio villaggio. St. Andrew non era certo una cittadina raffinata, ma l’avevo sempre ritenuta civile a confronto di molte altre zone del nostro territorio, che erano in buona parte prive di insediamenti umani. A eccezione dei cacciatori, incontrammo ben poche altre persone nel viaggio fino a Camden. Gli indiani nativi di quella zona si erano trasferiti anni prima, anche se ne erano rimasti alcuni a vivere negli insediamenti dei bianchi o a lavorare coi cacciatori. Giravano voci di coloni che avevano deciso di vivere come gli indiani, abbandonando le loro città per vivere in accampamenti, a imitazione dei nativi, ma erano pochi e di solito si arrendevano al primo inverno. Il viaggio attraverso le Great North Woods minacciava di essere oscuro e misterioso. Il pastore Gilbert ci aveva messi in guardia dagli spiriti maligni che li infestavano in attesa dei viaggiatori. I taglialegna giuravano di aver visto troll e goblin. C’era da aspettarselo, visto che per la maggior parte provenivano dai paesi scandinavi, dove quelle credenze popolari erano comuni. Le Great North Woods rappresentavano la natura selvaggia, la parte di quella terra che aveva resistito all’invadenza dell’uomo. Addentrarsi lì voleva dire rischiare di esserne fagocitati, di tornare a essere l’uomo primitivo che ciascuno di noi ancora portava dentro di sé. Per lo più, quando erano in pubblico gli abitanti di St. Andrew mostravano di non dar peso a queste dicerie; eppure, nessuno osava avventurarsi nei boschi di notte. Alcuni dei cocchieri si divertivano a spaventare gli altri raccontando storie attorno al falò, racconti di fantasmi nei cimiteri o di demoni incontrati su un certo sentiero attraverso la foresta. Quando facevano così cercavo di girare alla larga, ma spesso non era possibile perché c’era soltanto un fuoco e tutti gli altri volevano divertirsi un po’. A giudicare dalle loro storie, o quei cocchieri erano molto coraggiosi oppure erano dei bugiardi terribili, perché nonostante le loro storie di fantasmi vagabondi e spiriti urlanti e cose simili, facevano ancora quel mestiere, guidando un carro per lunghe, interminabili strade solitarie e selvagge. Quei racconti parlavano soprattutto di fantasmi, e ascoltandoli mi colpì il fatto che tutti gli spettri sembravano avere una sola cosa in comune: perseguitavano i vivi perché c’era qualcosa di irrisolto che si erano lasciati indietro nella vita terrena. Che fossero stati uccisi o si fossero suicidati, i fantasmi si rifiutavano di passare oltre la vita perché sentivano ancora di appartenere a questo mondo, non all’altro. Che fosse perché volevano vendicarsi della persona responsabile della loro morte, o perché non riuscivano a separarsi dalla persona amata, i fantasmi rimanevano vicini alle persone che avevano avuto accanto nei loro ultimi giorni. E naturalmente, non potei fare a meno di pensare a Sophia. Se c’era qualcuno che aveva tutti i diritti di tornare indietro come fantasma, era lei. Si sarebbe arrabbiata quando, diventata fantasma, si fosse accorta che la persona responsabile del suo suicidio aveva lasciato il villaggio? O mi avrebbe seguita? Forse mi aveva maledetta dall’oltretomba ed era lei la responsabile della mia tragica situazione. Ascoltare le storie di quei cocchieri non fece altro che rinforzarmi nella convinzione di essere condannata alla dannazione per la mia malvagità. Perciò fui sollevata e rallegrata quando iniziammo a incontrare piccoli insediamenti con più frequenza: voleva dire che ci stavamo avvicinando alla parte più popolata, a sud, e non sarei stata ancora a lungo in balia di quei cocchieri. E in effetti, pochi giorni dopo aver trovato il fiume Kennebec, arrivammo a Camden, una grande città sul mare. Era la prima volta che vedevo l’oceano. Il carro lasciò me e Titus al porto, poiché quelli erano gli accordi con mio padre, e io corsi fino all’estremità del molo più lungo e rimasi a fissare le vaste acque verdi per parecchio tempo. L’odore era peculiare, era il profumo dell’oceano, salato, denso e aspro. Il vento era molto freddo e forte, così forte che mi era quasi impossibile prender fiato. Mi sferzava il volto e mi annodava i capelli, come se volesse sfidarmi. Allo stesso tempo, l’oceano era completamente diverso da qualsiasi cosa avessi visto fino a quel momento. Conoscevo le acque, certo, ma soltanto quelle del fiume Allagash. E anche nei punti in cui era più ampio, si riuscivano sempre a vedere la riva opposta e gli alberi oltre di essa. Al confronto, con il suo orizzonte infinito, la distesa di acqua dell’oceano sembrava la fine del mondo. «Sai, i primi esploratori che arrivarono in America erano convinti che sarebbero caduti oltre il bordo della Terra» mi disse Titus, ricordandomi che c’era lui al mio fianco ora. La marea verdastra e immensa mi terrorizzava ma allo stesso tempo mi ipnotizzava, e non riuscii ad allontanarmene fino a quando il gelo non mi penetrò nelle ossa. Il maestro mi accompagnò fino all’ufficio della capitaneria di porto, dove trovammo un vecchio dalla pelle paurosamente incartapecorita. Ci indicò la piccola nave che mi avrebbe portata fino a Boston, ma mi avvisò che la partenza era prevista a mezzanotte, quando la marea sarebbe scesa. Non mi avrebbero fatto salire a bordo se non pochi minuti prima di levare le ancore. Mi suggerì di aspettare in una taverna, dove avrei potuto mangiare qualcosa e forse sarei anche riuscita a convincere il padrone a lasciarmi appisolare su un letto libero fino all’ora della partenza. Impietosito dal fatto che riuscivo a malapena a farmi capire, credo, non soltanto perché in fondo ero una rozza contadina ma anche perché ero ammutolita dal terrore, mi diede perfino indicazioni per raggiungere una taverna vicina al porto. Se già Camden era così grande e terrificante, come potevo sperare di cavarmela a Boston? «Signorina McIlvrae, devo protestare. Lei non può rimanere priva di una scorta in una taverna, né posso lasciarla da sola per le strade di Camden la notte» disse Titus. «Purtroppo però sono atteso a casa di mio cugino e non posso rimanere con lei per il resto del giorno.» «Ho forse altra scelta?» gli domandai. «Se può alleggerirle la coscienza, mi accompagni fino alla taverna e controlli di persona se è un posto rispettabile. Poi potrà fare ciò che la coscienza le detta. In questo modo, non sentirà di esser venuto meno alle sue promesse a mio padre.» L’unica taverna che avevo visto fino a quel momento era il piccolo cottage dei Daughtery a St. Andrew. Quella taverna era gigantesca al confronto: c’erano due cameriere, lunghi tavoli con panche e cibo caldo. Anche la birra era molto più saporita, e capii con una fitta di dolore di quante cose la gente del mio villaggio fosse priva. Quell’ingiustizia mi colpì, anche se non mi sentivo affatto privilegiata per la mia scoperta, in quella situazione. Mi sentivo affranta e avvertivo la nostalgia di casa, ma nascosi tutto questo a Titus che, impaziente di avviarsi per la sua strada, concordò sul fatto che non sembrava un posto di malaffare e mi lasciò alle cure dell’oste. Dopo aver mangiato, subendo le occhiatacce dei forestieri che entravano nel pub, accettai l’invito dell’oste e mi sdraiai su una branda nel magazzino in attesa dell’ora della partenza. A quanto pareva, accadeva di frequente che i passeggeri delle navi attendessero la partenza proprio in quel pub e l’oste era abituato a offrire loro un letto su cui dormire. Mi promise che mi avrebbe svegliata dopo il tramonto, perfettamente in tempo per arrivare al porto. Mi sdraiai sulla branda, nel magazzino che non aveva nemmeno una finestra, e non mi rimase altro da fare che pensare alla mia situazione. Fu solo in quel momento, rannicchiata al buio, con le braccia strette al petto, che capii di essere sola al mondo. Ero cresciuta in un luogo in cui tutti mi conoscevano e non c’era alcun dubbio su quale fosse il mio posto o su chi si sarebbe preso cura di me. Afflitta, piansi grosse lacrime che mi striarono le guance. In quel momento pensai che mio padre non poteva trovare una punizione peggiore per me. Mi svegliai nell’oscurità al suono delle nocche dell’oste che battevano sulla porta. «È ora di svegliarsi» mi disse dall’altro lato della porta. «Altrimenti la vostra nave partirà senza di voi.» Lo pagai con qualche moneta che prelevai dalla fodera del cappotto, accettai la sua offerta di accompagnarmi fino alla capitaneria di porto e rifeci all’indietro il percorso dal lungomare al molo. La sera era calata repentinamente, così come la temperatura, e la foschia aveva iniziato a sopraggiungere dall’oceano. C’erano poche persone per le strade e quelli che erano ancora in giro si stavano affrettando a tornare alle loro case per ripararsi dal freddo e dalla nebbia. L’effetto di insieme era inquietante, come se stessi camminando attraverso una città di morti. L’oste fu cortese con me nonostante fosse così tardi, e seguii con lui l’eco della marea fino al porto. Attraverso la nebbia intravidi la nave che mi avrebbe portata fino a Boston. Il ponte era punteggiato di lanterne che illuminavano i preparativi per il levate l’ancora: marinai che si arrampicavano sugli alberi e aprivano alcune delle vele; botti che venivano fatte rotolare lungo una plancia per essere immagazzinate nella stiva, con la nave che ondeggiava leggermente a ogni spostamento di peso. Ora mi rendo conto che si trattava di un cargo piuttosto insignificante e anche piccolo, ma all’epoca mi sembrò maestoso quanto una nave di linea inglese o un baghlah arabo, non avendo mai visto prima altri vascelli. La paura e l’eccitazione mi salirono alla gola, e da quel momento in poi mi avrebbero sempre accompagnata, la paura dell’ignoto e un insopprimibile desiderio di avventura, mentre salivo lungo la plancia sul ponte della nave, un passo dopo l’altro, allontanandomi sempre più da tutto ciò che avevo conosciuto e amato, e avvicinandomi sempre più alla mia misteriosa nuova vita. 15 Diversi giorni dopo la nave si avvicinò al porto di Boston. Quel pomeriggio attraccammo, ma io attesi il tramonto per sgattaiolare sul ponte. Era tutto quieto ormai: gli altri passeggeri erano sbarcati non appena la nave era stata ormeggiata e il carico, a quanto sembrava, era già stato tutto trasportato a terra. L’equipaggio, o almeno quelli che riconoscevo, non si vedeva da nessuna parte, probabilmente erano tutti a terra a godersi i benefici della civiltà in una delle taverne affacciate sul porto. A giudicare dal loro numero sulla strada, le taverne erano parte integrante di tutto il giro d’affari della navigazione, ancor più importanti del legname o delle tele da vela. Avevamo attraccato molto in anticipo rispetto all’orario previsto grazie ai venti favorevoli, ma era solo questione di tempo prima che il convento venisse avvisato e mandasse qualcuno a prendermi. E, in effetti, il capitano mi aveva lanciato un paio di occhiate curiose mentre mi aggiravo sottocoperta, chiedendosi evidentemente perché non fossi ancora scesa, e giunse perfino a offrirmi un passaggio per condurmi a destinazione, nel caso non fossi sicura della strada. Non volevo andare al convento. Nella mia mente lo immaginavo come un posto a metà fra una casa di correzione e una prigione. Doveva essere la mia punizione, un luogo il cui scopo era «correggermi» con ogni mezzo possibile, guarirmi dal mio amore per Jonathan. Mi avrebbero tolto il mio bambino, il mio unico e ultimo legame con l’uomo che amavo. Come potevo lasciare che succedesse? Dall’altra parte, però, ero terrorizzata all’idea di scappare e cavarmela da sola. Le incertezze che avevo affrontato a Camden erano centinaia di volte peggiori a Boston, che mi sembrava una città enorme e brulicante di vita. Come avrei fatto a orientarmi? A chi avrei mai potuto rivolgermi per avere aiuto, per trovare un posto in cui stare, soprattutto vista la mia condizione? Improvvisamente mi sentii la contadina ignorante che ero, completamente fuori posto. La codardia e l’indecisione mi avevano impedito di scappare subito dalla nave, ma alla fine fu il pensiero di perdere il mio bambino che mi fece decidere di fuggire. Avrei preferito dormire in vicoli sudici e guadagnarmi da vivere pulendo pavimenti piuttosto che lasciare che mi portassero via il mio bambino. Frenetica e impaurita, mi addentrai per le vie di Boston con soltanto la mia piccola cartella, lasciando il mio baule alla capitaneria di porto. Speravo di poterlo recuperare in seguito, quando avessi trovato un posto in cui stare. A meno che il convento non lo confiscasse a mio nome dopo aver scoperto che ero fuggita. Anche se avevo atteso il tramonto per allontanarmi di soppiatto dalla nave, fui sorpresa e spaventata dalla quantità di attività ancora in corso. C’era gente a fiotti che usciva dai pub e si riversava per le strade, affollando i marciapiedi o accalcandosi sulle carrozze. Carri carichi di botti e di scatole grandi quanto bare correvano per le strade affollate. Io arrancai su per una via e giù per un’altra, scansando altri pedoni, evitando i carri, incapace di memorizzare le strade in modo utile a orientarmi, incapace di dire dopo un quarto d’ora di cammino da che parte fosse il porto. Iniziai a ritenere Boston una città dura e triste: centinaia di persone mi erano passate accanto quella notte, ma nessuna di loro si era accorta della mia espressione terrorizzata, dello sguardo perso, del mio vagabondare senza meta. Nessuno mi aveva chiesto se avevo bisogno di aiuto. Il tramonto lasciò il posto all’oscurità della notte. Accesero i lampioni. Il traffico iniziò a scemare a mano a mano che la gente tornava a casa per cena, e i negozianti tiravano giù le tende e chiudevano le porte. Il panico mi assalì nuovamente al cuore: dove avrei dormito quella notte? E la notte seguente, e quella dopo ancora? No, mi dissi, non devo pensare troppo al futuro o cadrò nella disperazione. Era già abbastanza preoccupante pensare a come cavarmela quella prima notte. Dovevo escogitare un piano altrimenti avrei cominciato a rimpiangere di non essermi arresa all’idea del convento. La risposta era un pub o una locanda. Il più economico possibile, pensai, accarezzando le poche monete che mi erano rimaste. Il quartiere in cui ero finita sembrava residenziale e mi sforzai di ricordare dove avevo visto l’ultima taverna. Era vicino al porto? Probabilmente sì, eppure esitavo a tornare indietro, convinta che sarebbe stata la dimostrazione che non sapevo quello che stavo facendo e che mi ero cacciata in un guaio al di là delle mie possibilità. Non ero affatto sicura della direzione da cui ero venuta, comunque. Psicologicamente, era meglio continuare a muoversi in un nuovo territorio. Ero così sfinita che rimasi in mezzo alla strada a pensare alla mia prossima mossa, incurante del traffico che in una zona più affollata della città mi avrebbe travolto. Assorta nelle mie preoccupazioni, mi ci volle più di un minuto per rendermi conto che una carrozza si era fermata vicino a me e c’era qualcuno che mi stava chiamando a gran voce. «Signorina! Dico a voi, signorina!» disse una voce dall’interno della carrozza. Ed era una lussuosa carrozza, infinitamente più elegante dei rozzi calessi cui ero abituata in campagna. Il legno scuro riluceva lucido e tutte le rifiniture erano estremamente delicate e scolpite con maestria. Era tirata da una coppia di possenti cavalli bai, addobbati riccamente come cavalli da circo, ma equipaggiati con finimenti neri come un corteo funebre. «Dico, forse non parlate inglese?» Un uomo si sporse dal finestrino della carrozza. Indossava un vistoso cappello tricorno sormontato da piume color borgogna. Era chiaro di carnagione e biondo, con un volto allungato e aristocratico, ma la bocca sembrava avvizzita e corrucciata, come a esprimere un costante malcontento. Lo guardai, sorpresa che uno sconosciuto così elegante si stesse rivolgendo proprio a me. «Oh, lascia che ci provi io» disse una donna dall’interno della carrozza. L’uomo col cappello si ritirò dal finestrino e una donna prese il suo posto. Se l’uomo era pallido, lei era ancora più pallida, con la pelle color della neve. Indossava un vestito marrone molto scuro, di taffettà moiré, ed era forse quello che conferiva al suo incarnato quell’aria esangue. Era una donna stupenda ma in qualche modo inquietante, con denti appuntiti velati da labbra tese in un sorriso forzato. I suoi occhi erano di un blu così chiaro che sembravano di lavanda. E da quel che riuscivo a vedere, i suoi capelli – parzialmente nascosti da un cappello particolarmente elaborato, appeso sulla sommità del capo a un’angolatura impossibile – erano del color dei ranuncoli, raccolti strettissimi intorno al capo. «Non aver paura» mi disse, prima ancora che mi rendessi conto di avere davvero paura, un po’. Arretrai e lei aprì la portiera della carrozza e scese in strada, in un fruscio di stoffa inamidata e gonne voluminose e vaporose. Il suo abito era il più elegante che avessi mai visto, adorno di gale e minuscoli fiocchi, attillato sul suo vitino da vespa. Indossava guanti neri e sporse una mano verso di me, lentamente, come se avesse paura di spaventare un cagnolino impaurito. L’uomo col cappello fu raggiunto da un altro uomo, che prese il posto della donna al finestrino della carrozza. «Stai bene? Io e i miei amici non abbiamo potuto fare a meno di notare, passando, che sembri totalmente smarrita.» Il suo sorriso si riscaldò leggermente. «Io... Be’, è solo che...» balbettai, imbarazzata dal fatto che qualcuno mi avesse scoperto, e allo stesso tempo ansiosa di trovare qualcuno che mi aiutasse, che mi mostrasse un’ombra di calore umano. «Sei appena arrivata a Boston?» disse il secondo uomo nella carrozza, sporgendosi dal finestrino. Sembrava infinitamente più gentile del primo, con i suoi capelli scuri e gli occhi altrettanto scuri ma gentili, che invitavano a fidarsi. Annuii. «Hai un posto in cui stare? Perdonami, ma hai proprio l’aria di un’orfana. Senza casa, senza amici?» Mentre lui mi faceva queste domande, la donna mi accarezzò il braccio. «Vi ringrazio per la vostra preoccupazione» dissi. «Forse potreste indicarmi il pub più vicino...» proseguii, spostando nervosamente il peso della cartella che tenevo in mano. A quel punto, l’uomo alto e arrogante era sceso dalla carrozza. Mi prese la borsa. «Faremo di meglio. Ti daremo noi un posto in cui stare. Per stanotte.» La donna mi prese per il braccio e mi guidò verso la carrozza. «Stiamo andando a una festa. A te piacciono le feste, vero?» «Io... io non so...» balbettai, allarmata. Come era possibile che tre persone evidentemente ricche spuntassero dal nulla a salvarmi? Mi sembrò naturale, perfino prudente, essere scettica. «Non dire assurdità. Come fai a non sapere se ti piacciono le feste o no? A tutti piacciono le feste. Ci sarà da mangiare e da bere, soprattutto da bere. E ci divertiremo. E alla fine, ci sarà un bel letto caldo ad attenderti.» L’uomo arrogante lanciò la mia cartella sul pianale della carrozza. «E poi hai forse offerte migliori? Preferisci dormire per strada? Non credo proprio.» Aveva ragione e, se soffocavo il mio istinto che mi lanciava allarmi, dovevo ammettere che non avevo altra scelta. Arrivai perfino al punto di convincermi che quell’incontro fortuito era un segno della sorte. Le mie preghiere erano state ascoltate, almeno per il momento. Indossavano vestiti costosi e sembravano facoltosi: era decisamente improbabile che intendessero derubarmi. Né mi sembravano assassini. Il motivo per cui fossero così desiderosi di portare una sconosciuta raccattata per strada a una festa era un completo mistero, in ogni caso, ma mi sembrava azzardato dubitare troppo della mia buona sorte. Per parecchi minuti rimanemmo in un silenzio teso, mentre percorrevamo le strade di Boston. Ero seduta fra la donna e l’uomo dall’aria gentile coi capelli scuri, e cercai di non mostrare che avevo notato lo sguardo inquisitore dell’uomo biondo. Quando non riuscii più a trattenere la mia curiosità, chiesi: «Scusatemi, ma per quale motivo esattamente richiedete la mia partecipazione a questa festa? Non sarà infastidito il padrone di casa all’arrivo di un’ospite non invitata?» La donna e l’uomo arrogante sghignazzarono come se avessi fatto una battuta. «Oh, non devi preoccuparti. Il padrone di casa è un nostro amico, vedi, e si dà il caso che sappiamo con certezza assoluta che adora intrattenersi con ragazze carine come te» disse il biondo, poi rise di nuovo. La donna gli picchiò il dorso della mano col ventaglio. «Non far caso a questi due» disse l’uomo coi capelli scuri. «Si stanno prendendo gioco di te. Hai la mia parola che sarai più che benvenuta. Hai detto tu stessa che hai bisogno di un posto in cui passare la notte e, se i miei sospetti sono veritieri, hai anche bisogno di dimenticare i tuoi dispiaceri per una notte. E forse, là dove stiamo andando, troverai anche qualcos’altro di cui hai bisogno» disse, e i suoi modi erano così gentili che mi sentii rassicurata. C’erano molte cose di cui avevo bisogno, ma più di ogni altra cosa in quel momento volevo fidarmi di lui. Volevo credere che lui sapesse meglio di me ciò di cui avevo bisogno, poiché io non ne avevo idea. Sferragliammo su e giù per le vie nella carrozza nera. Io continuai a guardare attenta dal finestrino, cercando di memorizzare il percorso, come un bambino in una favola che ha bisogno di ritrovare la strada di casa. Fu una perdita di tempo; non avevo alcuna speranza di ricordarmi il tragitto, non nelle condizioni in cui mi trovavo. Alla fine la carrozza si fermò davanti a un edificio di mattoni e pietra, tutto illuminato a festa, così imponente da lasciarmi senza fiato. Ma a quanto sembrava la festa non era ancora iniziata; non c’era attività alcuna, niente uomini e donne vestiti da sera, nessun’altra carrozza che risaliva il vialetto. Dei servitori aprirono le porte della magione e la donna ci precedette, come se fosse la padrona di casa, sfilandosi i guanti un dito alla volta. «Dov’è lui?» chiese bruscamente a un maggiordomo in livrea. I suoi occhi puntarono brevemente verso l’alto. «Al piano di sopra, signora.» Mentre salivamo le scale, mi sentii sempre più imbarazzata e a disagio. Ero lì vestita con una specie di tonaca, sciatta e fatta in casa. Avevo addosso tutti gli odori della nave e del mare e i miei capelli erano arruffati e impiastricciati di salsedine. Abbassai lo sguardo e vidi ai miei piedi le scarpe rozze e semplici incrostate del fango delle strade, con le punte consumate. Sfiorai il braccio della donna. «Io non dovrei essere qui. Non sono in condizioni di presentarmi a una festa elegante. Non sarei nemmeno degna di fare la sguattera in una casa elegante come questa. Credo sia meglio se me ne vado e...» «Rimarrai finché non ti verrà dato il permesso di andartene.» Si voltò di scatto e mi conficcò le unghie nell’avambraccio, facendomi sussultare dal dolore. «Adesso smettila di piagnucolare e seguimi. Ti garantisco che stanotte ti divertirai.» Il suo tono mi rese chiaro che il mio divertimento era l’ultima cosa che le interessasse. Tutti e quattro irrompemmo contemporaneamente in una camera da letto, enorme, grande quanto tutta la casa della mia famiglia a St. Andrew. La donna ci guidò dritti fino al guardaroba, dove trovammo un uomo in piedi, le spalle rivolte a noi. Era evidentemente il padrone di casa, e c’era un servitore al suo fianco. Il padrone indossava calzoni alla zuava di velluto blu e ai piedi aveva delle eleganti babbucce. Non aveva ancora indossato il cappotto, quindi ebbi la possibilità di vedere il suo reale aspetto senza che lo paludasse un vestito sartoriale su misura. Non era alto e atletico come Jonathan – che era ancora la misura del mio ideale di uomo – ma aveva comunque un fisico magnifico. Una schiena ampia e spalle possenti spuntavano da una vita relativamente sottile. Doveva essere incredibilmente forte, a giudicare dalle sue spalle, come alcuni dei taglialegna di St. Andrew, solidi e forti. Poi si voltò e io cercai di trattenere un’esclamazione di sorpresa. Era molto più giovane di quanto mi aspettassi, poco più di vent’anni, poco più grande di me. Ed era bello in modo non convenzionale, quasi selvaggio. Aveva una carnagione olivastra, che non avevo mai visto nei nostri villaggi di scozzesi e scandinavi. La sua barba e i suoi baffi neri ornavano una mascella squadrata ed erano leggeri, come se si fosse rasato da pochi giorni. Ma la cosa più sorprendente erano i suoi occhi, verdi e screziati di grigio e oro. Erano belli come due gioielli, eppure il suo sguardo era feroce e ipnotico. «Abbiamo portato un’altra attrazione per la tua festa» annunciò la donna. Il suo sguardo mi percorse come un paio di mani ruvide. Dopo una sola occhiata, mi sentii come se non avessi più alcun segreto di fronte a lui. La bocca mi si seccò e le ginocchia mi cedettero. «Questo è il nostro ospite» disse la donna da dietro le mie spalle. «Inchinati, sempliciotta. Sei in presenza di un nobile. Questo è il conte cel Rau.» «Mi chiamo Adair.» Mi porse la mano, come per impedirmi di inchinarmi. «Siamo in America, Tilde. So che gli americani non vogliono aristocratici nel loro paese e quindi non si inchinano di fronte a nessuno. Non possiamo aspettarci che gli americani si inchinino di fronte a noi.» «Siete appena arrivato in America?» Chissà come, trovai il coraggio di rivolgermi a lui. «Due settimane fa.» Lasciò andare la mia mano e si rivolse al suo servitore. «Dalla Romania» aggiunse l’uomo basso e scuro. «Sai dove si trova?» Cercai invano una risposta. «No, temo di no.» Sentii altre risate provenire da dietro di me. «Non è importante» disse Adair, il padrone di casa, rimproverando i suoi servitori. «Non possiamo certo aspettarci che qualcuno qui conosca la nostra patria. La nostra casa è ben più lontana delle sole miglia di terra e mare che ci siamo lasciati alle spalle. È in un altro mondo rispetto a questa terra. Ecco perché sono venuto qui, perché è un altro mondo.» Fece un gesto verso di me. «Tu. Hai un nome?» «Lanore.» «Sei di qui?» «Di Boston? No, sono arrivata oggi. La mia famiglia...» Un groppo in gola mi bloccò per un istante. «La mia famiglia vive nel territorio del Maine, su al Nord. Ne ha sentito parlare?» «No» mi rispose. «Allora siamo pari.» Non so dove trovai il coraggio di scherzare così con lui. «Sì, forse lo siamo.» Lasciò che il servitore gli sistemasse la cravatta, osservandomi con curiosità prima di rivolgersi al trio. «Non statevene lì impalati» disse. «Preparatela per la festa.» Mi condussero in un’altra stanza, colma di bauli ammassati su altri bauli. Aprirono i coperchi, frugando finché non trovarono dei vestiti adatti a me: un bell’abito di cotone rosso e un paio di babbucce di raso. L’abbinamento non era dei migliori, ma comunque sia si trattava di indumenti molto più eleganti di qualsiasi altra cosa avessi mai indossato. Ordinarono a un servitore di preparare velocemente un bagno e mi ingiunsero di ripulirmi bene ma in fretta. «Questi li bruciamo» disse il biondo, indicando con un cenno i miei vestiti, che giacevano abbandonati sul pavimento. Prima di lasciarmi a fare il bagno, la donna bionda, che continuava a incutermi timore, mi mise in mano un calice colmo di vino rosso. «Bevilo» mi disse, «devi essere assetata.» Lo svuotai in due sorsi. Quando uscii dal bagno, avevo già capito che il vino era stato drogato. Mi sembrava che i pavimenti e le pareti si muovessero e dovetti concentrarmi al massimo per riuscire a scendere le scale fino al salone. A quel punto molti ospiti erano già arrivati, per lo più uomini vestiti a puntino con parrucche e maschere che ne occultavano i lineamenti. Il trio era scomparso e io ero rimasta sola. Nel mio confuso stupore, passai di stanza in stanza, cercando di capire che cosa stesse succedendo, mentre il vociare della festa mi circondava da ogni parte. Mi ricordo di aver visto qualcuno giocare a carte in un ampio salone, uomini seduti a gruppi di quattro o cinque ai tavoli tra risate e imprecazioni a mano a mano che le monete venivano depositate sul tappeto verde. Continuai a vagare a caso, uscendo ed entrando in stanza dopo stanza. Barcollando, passavo per un corridoio e uno sconosciuto cercava di prendermi per mano, ma io strattonavo e mi allontanavo più velocemente che potevo, dato il mio disorientamento. C’erano giovani uomini e donne dall’aria confusa, senza maschere, tutti molto belli, che gli invitati prendevano e portavano via da qualche parte. Iniziai ad avere le allucinazioni. Mi convinsi che stavo sognando e che nel sogno ero finita in un labirinto. Non riuscivo nemmeno a parlare: le parole mi uscivano in fiotti incoerenti e comunque nessuno sembrava intenzionato a darmi ascolto. Non pareva esserci via d’uscita da quella festa infernale, nessun modo di tornare per le strade, che in confronto mi sembravano più sicure. Proprio in quel momento, sentii una mano leggera sul mio gomito e svenni. Quando mi svegliai, giacevo di schiena su un letto e c’era un uomo sopra di me, mi stava quasi soffocando. Il suo volto era innaturalmente vicino al mio, il suo alito caldo mi sferzava il volto. Rabbrividii sotto il suo peso e udii un lamento di dolore sfuggirmi dalle labbra, ma il dolore era distante, attutito dalla droga. Capii istintivamente che in seguito mi sarei ricordata tutto. Cercai di chiamare aiuto, ma una mano sudaticcia mi serrò la bocca, le dita salate infilate fra le mie labbra. «Stai buona, bambina» grugnì l’uomo sopra di me, con gli occhi mezzi chiusi. Sopra la sua spalla, vidi qualcuno che ci osservava. C’erano uomini mascherati seduti su sedie ai piedi del letto, con dei calici in mano, che ridevano e incitavano l’uomo ad andare avanti. Seduto in mezzo a quel gruppo, a gambe accavallate, c’era il padrone di casa. Il conte. Adair. Mi svegliai di soprassalto. Mi trovavo in un letto enorme in una camera oscura e silenziosa. Il minimo movimento che facevo svegliandomi era sufficiente a scatenare scosse di dolore lancinante in tutto il mio corpo. Mi sentivo rigirata come un calzino, tesa e indolenzita, insensibile dalla vita in giù. Il mio stomaco era agitato da una marea di bile. Avevo il volto gonfio e anche la bocca, con labbra tirate e screpolate. Sapevo quello che mi era successo la notte precedente, e il dolore che mi attanagliava ne era la prova. Ora avevo bisogno soltanto di sopravvivere. Poi lo vidi, sdraiato a letto al mio fianco. Adair. Quando dormiva, il suo volto assumeva un’espressione di beatitudine. Da quanto riuscivo a vedere, era nudo, anche se coperto dalle lenzuola dalla vita in giù. La sua schiena mi era visibile e mi parve percorsa da vecchie cicatrici, tracce di una selvaggia punizione tempo addietro. Mi sporsi oltre il bordo del letto e, aggrappandomi al materasso, vomitai sul pavimento. I miei conati svegliarono il padrone di casa. Si lamentò per il doposbronza, o così pensai, e si portò una mano alla tempia. I suoi occhi verdeoro si aprirono incerti. «Buon Dio, sei ancora qui» mi disse. Lo assalii, furiosa, alzando un pugno per colpirlo, ma mi scansò facilmente, quasi con indolenza, con un movimento del braccio possente. «Non fare la stupida» mi avvertì, «o ti spezzo in due come un fiammifero.» Ripensai agli altri uomini e donne che avevo visto la sera prima. «Dove sono tutti gli altri?» domandai. «Hanno preso i loro soldi e se ne sono andati, suppongo» borbottò Adair, passandosi una mano tra i capelli arruffati. Arricciò il naso avvertendo l’odore acre del mio vomito. «Fai venire qualcuno a pulire» mi ordinò alzandosi. «Non sono la tua serva. E non sono nemmeno una...» Mi sforzai di trovare una parola che nemmeno sapevo esistesse. «Non sei una puttana?» Tolse una coperta dal letto e se l’avvolse attorno. «Be’, non sei nemmeno una vergine.» «Questo non vuol dire che volessi essere drogata e abusata da un gruppo di uomini.» Adair non disse niente. Strinse la coperta attorno alla vita, fece qualche passo fino alla porta e chiese urlando un servitore. Poi si voltò ad affrontarmi. «Quindi credi che ti abbia trattato male? E che cosa pensi di farci? Potresti raccontare la tua storia alla polizia e ti rinchiuderebbero in galera con l’accusa di prostituzione. Ti suggerisco di ritirare i tuoi soldi e farti dare qualcosa da mangiare giù nelle cucine prima di sparire.» Poi inclinò il capo, osservandomi per la seconda volta. «Tu sei quella che Tilde ha trovato per strada, quella che non aveva un posto in cui andare. Be’... non sia mai detto che non sono un uomo generoso. Puoi stare qui per qualche giorno, con noi. Riposati e cerca di riprenderti, se vuoi.» «E cosa devo fare per avere qualcosa da mangiare, lo stesso della notte scorsa?» gli chiesi acida. «Sei impertinente a rispondermi così, te ne rendi conto? Sei sola al mondo, nessuno sa che sei qui. Potrei mangiarti in un sol boccone, come un coniglietto, un piccolo delizioso coniglietto arrosto. Non ti spaventa neanche un po’?» Mi derise, ma colsi una scintilla di approvazione nel suo sguardo. «Vedremo che cosa ci viene in mente.» Si abbandonò su un divano, avvolgendosi nella coperta. Per essere un aristocratico, aveva i modi di un ruffiano. Feci per alzarmi a cercare i miei vestiti, ma non appena ci provai mi sentii mancare e la stanza iniziò a girarmi intorno. Ricaddi sul letto proprio mentre entrava un servitore con degli stracci e un secchio. Non fece nemmeno caso a me, si chinò e pulì la chiazza del mio vomito. Fu solo in quel momento che sentii le fitte al ventre, una sensazione sperduta in un oceano di dolore. Ero coperta da capo a piedi di graffi, scorticature e lividi. Il dolore interiore era stato causato senza dubbio da ciò che mi aveva causato le ferite esteriori: le mani di un bruto. Ero intenzionata a scappare da quella casa a ogni costo, fossi anche stata costretta a strisciare sulle ginocchia. Ma non riuscii ad andare oltre i piedi del letto. Collassai, sfinita e dolorante. Sarebbero passati mesi e mesi prima che riuscissi a lasciare quella casa. 16 Contea di Aroostook, oggi In questo periodo dell’anno, l’alba possiede una cromia tutta sua, un giallo-grigio impolverato simile alla patina del tuorlo di un uovo sodo. Luke è convinto che aleggi sulla terra come una nebbia venefica, come la maledizione di un fantasma, ma sa che probabilmente non è nient’altro che un’illusione creata dalle molecole d’acqua sospese nell’aria del mattino. Che sia un fenomeno di rifrazione o un’antica maledizione, conferisce alla mattina un aspetto del tutto particolare: il cielo giallastro sembra una volta di nuvole basse avvolte in ombre gravide di presagi oscuri, uno sfondo sul quale gli alberi spogli si stagliano in toni di grigio e marrone. Dopo aver notato la macchina della polizia nello specchietto retrovisore, Luke ha deciso che non è prudente proseguire il viaggio verso il confine canadese a bordo del suo pickup. È troppo riconoscibile, con la targa personalizzata da medico e gli adesivi della vecchia scuola di Jolene che riportano come la figlia del guidatore sia un’allieva meritevole della scuola elementare Allagash River. (E da quando, si era chiesto Luke, mentre Patricia insisteva perché applicassero gli adesivi sul paraurti del suo pickup, c’erano albi d’onore nelle scuole elementari?) Quindi hanno trascorso l’ultima mezz’ora a rientrare a St. Andrew, sfrecciando su strade a senso unico per raggiungere la casa di qualcuno di cui lui pensa di potersi fidare. Inizialmente Luke ha chiamato col suo cellulare per chiedere se era possibile prendere in prestito una macchina, ma più che altro per capire se la polizia era andata in giro a chiedere di lui. Si ferma davanti a una grande fattoria ristrutturata appena fuori dai confini di St. Andrew. La casa è splendida, una delle più ampie e meglio tenute, con particolari di rilievo come i salici che decorano il portico e le lanterne solari disposte lungo il vialetto d’accesso. La casa appartiene a un dottore arrivato in ospedale non molto tempo prima, un anestesista di nome Peter, che si è trasferito dalla città per crescere i figli in campagna, convinto che lì non ci sia criminalità né droghe. È un ingenuo patologico, il prototipo del bravo ragazzo, anche per Luke che, ancora scosso e suscettibile per i recenti problemi, si era allontanato da tutti negli ultimi mesi. Quando Luke bussa alla porta d’ingresso, Peter gli apre avvolto in un accappatoio e in pantofole, con un’espressione preoccupata. Sembra essere stato svegliato di soprassalto dalla telefonata di Luke, e per questo Luke prova un forte imbarazzo. Pete posa una mano sul braccio di Luke, fermandolo all’ingresso. «Va tutto bene?» «Scusa, so che la mia è una richiesta strana» dice Luke, spostando il peso da un piede all’altro, a testa china. Si è esercitato mentalmente a pronunciare questa menzogna negli ultimi dieci minuti. «È solo che... La figlia di mia cugina è venuta a stare da me per qualche giorno e io ho promesso a sua madre che l’avrei riportata a casa in tempo per farle prendere il pullman della gita scolastica. Solo che il mio pickup fa dei rumori strani e temo di non riuscire a portarla fin lassù e poi tornare...» La voce di Luke trasmette la giusta quantità di inettitudine e di rimorso per aver arrecato disturbo a un amico, dimostrando così una sorta di innocente svagatezza benevola che solo un orco respingerebbe al mittente. Peter alza lo sguardo oltre la spalla di Luke e osserva il pickup parcheggiato in fondo al lungo vialetto d’accesso, dove – Luke lo sa benissimo – vedrà Lanny in piedi accanto alla portiera, la valigia ai suoi piedi. È troppo lontana perché Peter riesca a vederla bene, nel caso in cui la polizia più tardi venga a interrogarlo. Lei fa un piccolo cenno di saluto a Peter. «Non hai appena finito il turno?» Peter torna a scrutare Luke, così intensamente che sembra lo stia esaminando per vedere se ha i pidocchi. «Non sei stanco?» «No, sto bene. È stata una notte tranquilla e sono riuscito a dormire un po»’ mente. «Starò attento.» Peter estrae le chiavi da una tasca e le lascia cadere nella mano aperta di Luke. Quando Luke cerca di dargli in cambio le chiavi del suo pickup, Peter si impunta. «Non c’è bisogno che mi lasci le chiavi, tanto non starai via a lungo, vero?» Luke scrolla le spalle, cercando di apparire indifferente. «Meglio che te le lasci, nel caso tu abbia bisogno di spostarlo o qualcosa del genere. Non si sa mai.» Il portone del garage a tre posti si alza lentamente e Luke controlla il portachiavi, scoprendo così che Peter gli sta affidando un SUV nuovo fiammante, grigio acciaio. Sedili in pelle riscaldati e un lettore DVD con schermi sul retro dei sedili anteriori, per intrattenere i bambini nei lunghi viaggi. Si ricorda di come i colleghi, all’ospedale, avevano preso in giro Peter il primo giorno che era arrivato a bordo di quel SUV, perché era un mezzo così inusuale in quella zona. Entro il terzo inverno, la sua carrozzeria grigia lucente sarebbe stata corrosa dal sale sparso sulle strade. Luke fa retromarcia, esce dal garage e si ferma in fondo al vialetto, facendo salire Lanny. «Bella auto» osserva lei, allacciandosi la cintura di sicurezza. «Tu sì che sai come fare affari, vero?» Lei canticchia qualcosa sottovoce mentre Luke conduce l’auto lungo la strada, dirigendosi ancora una volta verso la dogana al confine canadese – stavolta riparato dietro vetri oscurati. Non saprebbe dirne il motivo, ma sente che non tornerà indietro appena passato il confine, è quello il motivo per cui ha lasciato le chiavi del suo pickup ammaccato all’amico. Non che Peter abbia bisogno di quel catorcio: ha altre macchine a disposizione se deve andare da qualche parte. Eppure, questo fa sentir meglio Luke, come se avesse lasciato un deposito o avesse fatto un dono in buona fede, perché sa che ben presto Peter cambierà opinione su di lui e sulla loro amicizia. Lanny incontra lo sguardo di Luke mentre si immettono in un incrocio deserto. «Grazie» gli dice, la voce colma di gratitudine. «Sembri il tipo d’uomo che detesta chiedere favori, perciò... Voglio che tu sappia che apprezzo ciò che stai facendo per me.» Luke si limita ad annuire, chiedendosi fino a che punto arriverà e quanto gli costerà aiutarla a scappare. 17 Boston, 1817 Mi svegliai in un letto diverso, in una camera diversa. Seduto accanto al letto c’era l’uomo dai capelli neri che avevo visto nella carrozza; aveva tra le mani una ciotola piena d’acqua e una pezza bagnata da premere sulla mia fronte. «Bentornata fra i vivi» disse quando aprii gli occhi. Sollevò la pezza dalla mia fronte e la inzuppò d’acqua nella ciotola. Una luce fredda spuntava dalla finestra dietro di lui, perciò capii che era giorno, ma che giorno? Alzai il lenzuolo per osservarmi e vidi che indossavo una semplice vestaglia da notte. Mi avevano dato una piccola camera tutta per me, chiaramente destinata a un membro anziano della servitù. «Perché sono ancora qui?» chiesi con voce roca. Lui ignorò la mia domanda. «Come ti senti?» Il dolore mi assaliva a ondate sorde e aspre, incendiandomi il ventre. «Come se mi avessero pugnalato con una lama arrugginita.» Lui corrucciò leggermente la fronte, poi prese una tazza di brodo dal pavimento. «La cosa migliore per te è che tu stia a completo riposo. È probabile che tu abbia una perforazione lì dentro da qualche parte» indicò vagamente il mio stomaco, «e devi guarire il prima possibile, altrimenti ti verrà un’infezione. L’ho visto succedere già altre volte. È pericoloso.» Il mio bambino. Mi alzai a sedere. «Voglio vedere un medico. O una levatrice.» Lui infilò un cucchiaio nel brodo chiaro, facendo tintinnare il metallo contro la porcellana. «È troppo presto per questo. Aspettiamo un po’ per vedere se per caso peggiora.» Mentre mi tamponava con la pezza bagnata e mi faceva bere il brodo, rispose alle mie domande. Innanzi tutto, mi raccontò di sé. Si chiamava Alejandro ed era il figlio più giovane di una nobile famiglia spagnola di Toledo. Essendo il figlio minore, non aveva alcuna speranza di ereditare le proprietà della famiglia. Il secondogenito era entrato nelle forze armate ed era diventato capitano di un magnifico galeone spagnolo. Il terzogenito era a servizio del re di Spagna e presto sarebbe stato mandato come ambasciatore in una terra straniera. In questo modo, la famiglia aveva obbedito ai doveri che la tradizione imponeva nei confronti della propria nazione e del re; Alejandro era libero di trovare la sua strada e, dopo vari incidenti di percorso e coincidenze del destino, si era trovato con Adair. Adair, spiegò, era un vero e proprio aristocratico del vecchio mondo, ricco come un principe di un piccolo Stato, poiché era riuscito a mantenere la proprietà dei beni e delle terre che erano appartenuti alla sua famiglia per secoli. Stanco del vecchio mondo, era venuto a Boston a caccia di novità, perché aveva sentito tanti racconti sul nuovo mondo e ora voleva conoscerlo di persona. Alejandro e gli altri due che erano nella carrozza – Tilde, la donna, e Donatello, il biondo – erano cortigiani di Adair. «Ogni altezza reale ha una corte» disse Alejandro, con il primo dei molti ragionamenti circolari che avrebbe espresso nel tempo. «Dev’essere circondato da persone beneducate, di alto lignaggio, che facciano in modo che i suoi bisogni siano soddisfatti. Noi siamo il filtro fra lui e il mondo là fuori.» Donatello, spiegò, veniva dall’Italia, dove era stato assistente e musa di un grande artista il cui nome io non avevo mai sentito prima. E Tilde... Il suo passato era un mistero, confessò Alejandro. L’unica cosa che sapeva di lei era che proveniva da una terra a nord, fredda e nevosa come la mia. Tilde era già con Adair quando Alejandro si era unito alla corte. «Lui ascolta praticamente soltanto lei. E Tilde ha un carattere feroce e imprevedibile, quindi bisogna stare sempre attenti con lei» mi ammonì, intingendo il cucchiaio nel brodo. «Non credo proprio che rimarrò qui un minuto di più del necessario» dissi, aprendo la bocca verso il cucchiaio. «Me ne andrò non appena starò meglio.» Alejandro non commentò, apparentemente concentrato nell’infilarmi il cucchiaio di brodo in bocca. «C’è un altro membro della corte di Adair» disse poi, affrettandosi ad aggiungere: «Ma probabilmente non la incontrerai mai. Lei è... solitaria. Non sorprenderti se credi di vedere un fantasma». «Un fantasma?» Mi si drizzarono i capelli sulla nuca, al ricordo dei racconti di fantasmi dei cocchieri, quei morti tormentati in cerca dei loro amori perduti. «Non è veramente un fantasma» mi rimbrottò. «Anche se potrebbe sembrarlo. Sta sempre sulle sue, e l’unico modo di vederla è incontrarla per caso, come quando si vede un cervo nella foresta. Non parla e non ti darà retta se cercherai di parlare con lei. Il suo nome è Uzra.» Nonostante fossi grata ad Alejandro per avermi rivelato quanto sapeva, quelle informazioni mi fecero sentire a disagio, perché dimostravano sempre più quanto io fossi ignorante, cresciuta com’ero in un villaggio sperduto. Nessuno mi aveva mai parlato di quelle terre lontane e non avrei saputo nominare nemmeno un grande artista. La cosa più inquietante era quella Uzra. Non avevo alcuna voglia di conoscere una persona che si comportava in tutto e per tutto da fantasma. E che cosa le aveva fatto Adair per indurla a non parlare più? Le aveva forse mozzato la lingua? Non avevo alcun dubbio che lui sapesse raggiungere tali vette di crudeltà. «Non capisco perché ti sei dato il disturbo di raccontarmi tutto questo» dissi. «Tanto non rimarrò qui.» Alejandro mi osservò col sorriso innocente di un chierichetto e lo sguardo scintillante. «Oh, soltanto un modo per passare il tempo. Vuoi altro brodo?» Quella notte, comunque, quando udii Adair e i suoi tirapiedi procedere maestosamente lungo il corridoio, pronti a uscire la sera, strisciai fuori dal letto e mi fermai sul pianerottolo a osservarli. Erano bellissimi, avvolti in velluto e broccati, incipriati e pettinati da servitori che avevano impiegato ore a prepararli con cura. Tilde, con brillanti appuntati nei suoi folti capelli biondi e le labbra dipinte di rosso; Dona, con una cravatta bianca immacolata annodata fin sotto il mento, ad accentuare il collo aristocratico e il mento appuntito; Alejandro, con il lungo vestito nero e l’aria perennemente addolorata. Si scambiavano battute con perfidia e arguzia, pavoneggiandosi come uccelli dal piumaggio sontuoso. Ma soprattutto osservai Adair, perché era magnetico. Un selvaggio agghindato con un vestito da gentiluomo. Fu in quel momento che lo capii: era un lupo travestito da agnello, che usciva a caccia col suo branco di sciacalli per attirare una preda nella sua trappola. Cacciavano per puro divertimento, così come erano andati a caccia di me. Lui era il lupo, io la lepre con il collo tenero e soffice facilmente spezzabile dal suo morso feroce. Dopo che un valletto gli ebbe poggiato il mantello sulle spalle, Adair si voltò per uscire, alzando lo sguardo su di me, come se avesse sempre saputo che ero lì a guardarlo. Mi rivolse un sorriso che mi fece arretrare di colpo, barcollante. Avrei dovuto aver paura di lui – avevo paura di lui – eppure ero impietrita, folgorata. Una parte di me desiderava essere una di loro, voleva essere al braccio di Adair mentre lui e i suoi adoratori uscivano per divertirsi, per essere oggetto dell’ammirazione altrui come era giusto che fosse. Quella notte, fui svegliata dal loro rientro e non mi sorpresi quando Adair entrò nella mia camera, mi tirò su e mi portò a letto con lui. Nonostante la mia malattia, quella notte mi prese e io lasciai che lo facesse, arrendendomi all’eccitazione del suo corpo sopra il mio, di lui dentro di me, della sua bocca sulla mia pelle. Mentre mi possedeva mi sussurrava nell’orecchio, più lamenti che parole, e riuscii a capire soltanto «non puoi negarti a me» e «mia», come se quella notte mi stesse reclamando come sua proprietà. Dopo, giacqui accanto a lui, rabbrividendo mentre un senso di soggezione mi percorreva tutta. La mattina seguente, quando mi svegliai nel silenzio della mia piccola stanza, mi accorsi che il dolore al ventre era notevolmente peggiorato. Cercai di alzarmi e camminare, ma ogni passo era accompagnato da una fitta all’addome e perdevo sangue e feci; non riuscivo a immaginare di arrivare alla porta d’ingresso, figuriamoci trovare qualcuno che mi accogliesse, là fuori. Ora di sera, la febbre mi era salita vertiginosamente e nei giorni seguenti entrai e uscii da un sonno tormentato, ogni volta svegliandomi più indebolita di prima. La mia pelle diventò pallida e sensibile, i miei occhi cerchiati di viola. Se i tagli e le ferite mi stavano guarendo, succedeva molto più lentamente di quanto fosse percepibile. Alejandro, l’unico che veniva al mio capezzale, mi disse la sua diagnosi scuotendo il capo. «Hai le interiora perforate.» «Ma guarirò facilmente, vero?» gli chiesi, colma di speranza. «Non se subentra una setticemia.» Ignorante com’ero delle complessità dell’anatomia, sapevo comunque che se il dolore era indicativo della serietà del problema, allora il mio bambino era in pericolo. «Un medico» lo implorai, stringendogli la mano. «Ne parlerò con Adair» mi promise lui. Poche ore dopo, Adair irruppe nella mia camera. Non notai nemmeno un barlume di riconoscimento dei piaceri che avevamo condiviso la notte precedente. Prese uno sgabello, lo avvicinò al bordo del letto e iniziò a esaminarmi, premendo le dita sulla mia fronte e sulle guance per sentire la temperatura. «Alejandro dice che le tue condizioni non migliorano.» «Ti prego, chiama un dottore. Ti ripagherò un giorno, non appena riuscirò a...» Schioccò la lingua come a dire che il costo non era importante. Sollevò una delle mie palpebre, poi saggiò i rigonfiamenti sotto la mascella. Quando finì, si alzò dallo sgabello. «Torno fra un momento» disse e lasciò la camera. Mi riappisolai e mi svegliai quando tornò con in mano un vecchio boccale scheggiato. Mi aiutò a sedermi e mi porse il boccale. Il contenuto puzzava di marcio e di erbacce bollite e sembrava liquido di palude. «Bevi» mi ordinò. «Che cos’è?» «Ti farà stare meglio.» «Sei un dottore?» Adair mi guardò con un vago disprezzo. «Non sono quello che tu considereresti un dottore, no. Diciamo che ho studiato la medicina tradizionale. Se fosse rimasto a bollire un po’ più a lungo, sarebbe stato più bevibile, ma non c’era tempo» aggiunse, come se non volesse che io sminuissi le sue abilità solo perché il gusto di quell’intruglio non era all’altezza. «Vuoi dire che sei una levatrice?» Inutile dire che le levatrici – anche se spesso erano le uniche persone con qualche competenza medica nei villaggi – non avevano compiuto alcuno studio, perché alle donne non era consentito di frequentare lezioni di medicina all’università. Le donne che diventavano levatrici imparavano come far nascere i bambini e come preparare medicine con le erbe e le bacche attraverso un apprendistato, spesso dalle loro madri o da una parente. «Non proprio» mi rispose piccato, evidentemente non prendeva le levatrici più seriamente dei dottori. «Adesso bevi.» Feci come mi aveva ordinato, pensando che non avrebbe acconsentito a farmi visitare da un dottore se era arrabbiato con me per non aver provato prima il suo rimedio. Fui sul punto di vomitarglielo tutto addosso; l’intruglio era untuoso e amaro, così aspro che sembrò incrostarmi i denti. «Adesso riposati un altro po’, e tra qualche ora vedremo come stai» mi disse, allungando una mano per prendere il boccale. Gli afferrai il polso. «Adair, dimmi...» Ma di colpo persi il coraggio di proseguire. «Che cosa devo dirti?» «Non capisco il tuo comportamento con me... L’altra notte...» Arricciò la sua bellissima bocca in un sorriso crudele. «È così difficile da capire?» Mi aiutò a sdraiarmi di nuovo sul cuscino e poi mi rimboccò la coperta fin sotto il mento. Distese delicatamente la coperta sul mio petto e mi sfiorò i capelli. La sua espressione di derisione si addolcì e per un momento tutto ciò che vidi fu il suo volto da ragazzino e un’ombra di gentilezza nei suoi occhi verdi. «Non capisci che mi sono affezionato a te, Lanore? Ti sei rivelata sorprendente, per certi versi. Di sicuro non la stracciona che Tilde ha raccolto per strada. Sento qualcosa in te... In qualche modo, tu sei uno spirito affine, anche se non ho ancora capito che cosa ci sia in te che me lo fa pensare. Ma lo capirò, prima o poi. Ora però devi pensare a guarire. Vediamo se l’elisir funziona. Cerca di riposarti. Qualcuno più tardi verrà a controllare come stai.» La sua rivelazione mi sorprese. A giudicare da quella notte insieme, tra di noi c’era una reciproca attrazione. Desiderio fisico, semplicemente. Da un lato, mi faceva sentire onorata che un nobiluomo, un uomo ricco e con un titolo aristocratico, fosse interessato a me; dall’altro, però, era pur sempre un sadico e un egocentrico. Nonostante ci fossero tutti i motivi di allarmarsi, accettai l’affetto di Adair, anche se non era nient’altro che un sostituto di ciò che veramente avevo desiderato, da un altro uomo. Il mio stomaco si acquietò, il retrogusto amaro dell’elisir scomparve. Avevo un nuovo interrogativo che mi agitava, ora. La mia curiosità non riuscì a combattere la pozione di Adair, comunque, e ben presto caddi in un sonno pacifico. Trascorsero un’altra notte e un altro giorno, ma nessun dottore venne a visitarmi e iniziai a chiedermi a che gioco stesse giocando Adair. Da quando aveva confessato il suo interesse per me, non era più tornato a trovarmi; inviava servitori nella mia camera con ulteriori dosi dell’elisir, ma nessun dottore comparve alla mia porta. Trascorse trentasei ore, iniziai a dubitare nuovamente delle sue intenzioni. Dovevo andarmene da quella casa. Se fossi rimasta, sarei morta in quel letto, e il mio bambino sarebbe morto con me. Dovevo trovare un dottore, o qualcuno che fosse capace di rimettermi in sesto, o quanto meno di tenermi viva fino al parto. Quel bambino era l’unica prova dell’amore di Jonathan per me e io ero determinata a far sì che quella prova sopravvivesse alla mia morte. Mi trascinai giù dal letto per recuperare la mia cartella, ma mentre cercavo a tentoni sotto il letto e in un armadio, mi accorsi che la mia sottoveste era bagnata, gelida e appiccicaticcia sulle mie gambe. Mi avevano tolto la biancheria e mi avevano avvolto in un manto, per raccogliere le mie feci e i miei umori. La stoffa era fradicia e puzzolente; non potevo certo avventurarmi in strada in quelle condizioni senza esser presa per pazza e portata in manicomio. Dovevo trovare dei vestiti, il mio mantello, ma mi avevano portato via tutto. Naturalmente, sapevo dove avrei potuto trovare qualcosa da indossare. La stanza piena di bauli, dove mi avevano portata quella prima, fatidica notte. Fuori dalla mia stanza c’era silenzio, si sentiva soltanto il mormorio della conversazione fra due servitori che aleggiava sulle scale. Il corridoio era vuoto. Barcollai fino alle scale, ma ero così debole, febbricitante e tremante che dovetti trascinarmi sulle mani e sulle ginocchia per giungere al piano superiore. Una volta arrivata, mi appoggiai al muro per riprendere fiato e orientarmi. Qual era il corridoio che conduceva alla stanza dei bauli? I corridoi mi sembravano tutti uguali e c’erano così tante porte... Non avevo né il tempo né le forze per provare ad aprirle tutte... Mentre ero bloccata lì, prossima alle lacrime per la frustrazione e il dolore, cercando di aggrapparmi alla mia decisione di scappare, la vidi. Vidi il fantasma. Scorsi un movimento con la coda dell’occhio. Diedi per scontato che si trattasse di una sguattera che ritornava nell’ala della servitù, nella parte superiore dell’attico, ma la figura che si stagliava davanti a me sul pianerottolo non era certo una sguattera. Era minuta ed eterea. Se non fosse stato per il suo seno pieno e i suoi fianchi arrotondati, si sarebbe potuto scambiarla per una bambina. Le sue forme da donna erano avvolte in un costume esotico fatto di seta finissima, pantaloni arcuati e una tunica smanicata troppo piccola per coprirle adeguatamente il petto. E i suoi seni erano meravigliosi, perfettamente rotondi, sodi e alti. Bastava guardarli per capire quanto dovessero essere pesanti fra le mani, il tipo di seni capace di suscitare il desiderio di qualsiasi uomo. Oltre alle sue forme lussuriose, era bellissima in volto. I suoi occhi a mandorla erano esaltati da un cerchio di kohl. I suoi capelli erano un’infinita varietà di rame, avorio e oro, acconciati in boccoli indomiti fino in fondo alla schiena. Alejandro mi aveva descritto perfettamente il colore della sua pelle: cannella, screziata di mica che la rendeva brillante, come se fosse fatta di una pietra preziosa sconosciuta. Mi ricordo adesso ogni dettaglio perché in seguito a quell’episodio la vidi molte altre volte, e sapendo perfettamente che era fatta di carne e ossa, ma in quel momento avrei potuto giurare che si trattava di un’apparizione evocata dalla mente di un uomo per incarnare la perfetta fantasia sessuale. Era una vista che sconvolgeva al punto da mozzare il fiato. Ebbi paura che, se mi fossi mossa, sarebbe scomparsa improvvisamente. Invece, mi guardò con la stessa cautela con cui la osservavo io. «Ti prego, non andartene. Ho bisogno del tuo aiuto.» Esausta, mi appoggiai al corrimano. Lei arretrò di un passo, i suoi piedi nudi non facevano alcun rumore sul tappeto. «No, no, ti prego, non lasciarmi. Sto male e devo andar via da questo posto. Per favore, ho bisogno che mi aiuti, altrimenti non ne uscirò viva. Ti chiami Uzra, vero?» Sentendo il suo nome, indietreggiò ancora, muovendosi come se danzasse, si voltò e scomparve nell’oscurità in cima alle scale dell’attico. Non so se le forze mi abbandonarono in quel momento o se fu la mia determinazione a scemare mentre lei si allontanava da me, ma scivolai a terra. Il soffitto ondeggiava sopra di me, come una lanterna che ruota libera appesa a una corda arrotolata, prima in una direzione, poi in quella opposta. Allora calò il buio. Sentii un mormorio, dita che mi toccavano. «Che cosa ci fa fuori dalla sua stanza?» Era la voce di Adair, aspra e bassa. «Hai detto che non sarebbe stata in grado di alzarsi dal letto.» «A quanto pare è più forte di quel che sembra» borbottò Alejandro. Qualcuno mi sollevò e io mi sentii priva di peso, sospesa. «Riportala lì dentro e stavolta chiudi a chiave la porta. Non deve lasciare questa casa.» La voce di Adair iniziò ad allontanarsi. «Morirà?» «E come diavolo faccio a saperlo?» borbottò Alejandro, poi a voce più alta, così che stavolta Adair potesse sentirlo, disse: «Suppongo che dipenda da te». Dipende da lui? mi chiesi mentre scivolavo di nuovo nell’incoscienza. E come poteva essere che dipendesse da lui la mia sopravvivenza? Non ebbi il tempo di interrogarmi oltre su quella strana conversazione, perché caddi di nuovo in un oblio di leggerezza e silenzio. 18 «Sta morendo. Non passerà la giornata.» Era la voce di Alejandro, anche se le sue parole non erano intese perché io le udissi. Battei le ciglia. Lo intravidi in piedi accanto a Adair, al mio capezzale. Entrambi erano a braccia conserte, sembravano rassegnati ed erano scuri in volto. Eccola, dunque: era la fine, senza appello. E ancora non avevo alcuna idea di che cosa avessero intenzione di fare con me, non sapevo perché Adair si fosse preso la briga di ingannarmi sul suo affetto per me, o riempirmi con strane pozioni rifiutandomi l’assistenza di un dottore. Ma a quel punto, il suo strano comportamento non faceva più alcuna differenza per me: stavo per morire. Se era il mio corpo che volevano – per dissezionarlo, per fare qualche esperimento, per usarlo in un rituale satanico – nessuno avrebbe potuto fermarli. In fondo, che cos’ero se non una vagabonda senza un soldo e senza nessuno al mondo? Non ero nemmeno una loro serva; valevo ancor di meno, ero una donna che aveva permesso che degli estranei facessero con lei quello che volevano in cambio di un tetto sopra la testa e del cibo. Avrei voluto piangere di autocommiserazione, ma la febbre mi aveva lasciato asciutta, senza più lacrime. Non potevo che concordare con la previsione di Alejandro: dovevo essere in punto di morte. Un corpo non poteva provare tanto dolore e sopravvivere. Mi sentivo un fuoco dentro, ogni singolo muscolo bruciava. Ero sfinita dalle fitte. Ogni respiro mi faceva scricchiolare le costole come un soffietto arrugginito. Se non fossi stata così atterrita all’idea di lasciare che il figlio di Jonathan morisse con me e così impaurita all’idea dei gravi peccati che avevo commesso e per i quali sarei stata giudicata, avrei pregato Dio di concedermi la grazia di morire. Avevo un solo rimpianto, ed era che non avrei mai più rivisto Jonathan. Avevo creduto così fermamente che fossimo destinati a stare insieme che mi sembrava inconcepibile l’idea di essere separata per sempre da lui, di morire senza poter allungare la mano e toccare il suo volto, di non averlo al mio fianco a stringermi la mano mentre esalavo l’ultimo respiro. La gravità della mia situazione divenne reale per me solo in quel momento: la mia fine stava per arrivare, non c’era niente che potessi fare, nessun patto con Dio che potesse cambiare il mio destino. E ciò che volevo sopra ogni cosa era rivedere Jonathan. «È una tua decisione, a questo punto» disse Alejandro a Adair, che non aveva ancora proferito una parola. «Se lei ti piace. Dona e Tilde hanno già chiarito la loro posizione in proposito e...» «Non è questione da mettere ai voti» ringhiò. «Nessuno di voi ha il diritto di dire alcunché su chi può unirsi a noi o meno. Voi continuate a esistere solo perché a me piace così.» Avevo udito correttamente? Credetti di no; le sue parole erano confuse e mi rimbombavano in testa. «E continuate a servirmi solo per mia volontà.» Adair si avvicinò a me e mi passò una mano sulla fronte imperlata di sudore. «La vedi la sua espressione, Alejandro? Sa che sta morendo e sta combattendo. Ho visto la stessa espressione sul tuo volto, su quello di Tilde... È sempre la stessa.» Mi posò le mani sulle guance. «Ascoltami, Lanore. Sto per farti un raro dono. Capisci? Se non intervengo, morirai. Quindi, ecco il nostro patto. Sono pronto ad afferrarti quando morirai e a riportare la tua anima in questo mondo. Ma questo significa che apparterrai a me interamente, non soltanto con il tuo corpo. Possedere il tuo corpo è questione da poco, posso farlo quando voglio. Voglio di più da te; voglio la tua anima, la tua fiera anima. Sei pronta ad accettarlo?» mi chiese, scrutandomi negli occhi in cerca di una risposta. «Preparati» mi disse poi. Non capivo assolutamente di che cosa stesse parlando. Si fece ancora più vicino, come un prete pronto a raccogliere una confessione. Aveva in mano una fiala di argento, sottile come il becco di un usignolo, ed estrasse il tappo, più simile a un ago che a un tappo. «Apri la bocca» mi ordinò, ma io ero raggelata dal terrore. «Apri quella maledetta bocca» ripeté, «o ti spezzo la mascella.» Nella mia confusione, pensai che mi stesse offrendo l’estrema unzione – in fondo, provenivo da una famiglia cattolica – e io desideravo ardentemente un’assoluzione per i miei peccati. Perciò aprii la bocca e chiusi gli occhi, rimanendo in attesa. Lui strusciò il tappo sulla mia lingua. Quasi non me ne accorsi, tanto era sottile quello strumento, ma la mia lingua perse immediatamente ogni sensibilità e in bocca avvertii un sapore orrendo. Mi venne un conato di bava e iniziai ad avere le convulsioni; lui mi strinse la bocca, costringendomi a tenerla chiusa. Mi bloccò con forza sul letto, contenendo le mie convulsioni. Il sangue mi riempì la bocca, reso amaro e aspro dalla pozione che mi aveva depositato sulla lingua. Mi aveva forse avvelenato per accelerare la mia morte? Ero persa nel mio stesso sangue e non riuscivo a sentire nient’altro. Una parte di me udì Adair mormorare parole che per me non avevano alcun senso. Ma ero invasa dal panico, e mi era impossibile ragionare. Non mi importava che cosa stesse dicendo o cosa mi stesse facendo, ero completamente sotto shock. Il mio petto si contrasse, il dolore e il panico erano strazianti. I miei polmoni non funzionavano più. Pompa, soffietto arrugginito, per l’amor di Dio! Non riuscivo a respirare. Adesso so che il mio cuore si stava fermando ed era incapace di far funzionare i miei polmoni. Istintivamente portai le mani sul ventre, attorno al piccolo rigonfiamento che aveva appena iniziato a farsi notare. Adair si immobilizzò di colpo, con l’espressione di chi ha finalmente colto la verità. «Mio Dio, è incinta! Nessuno di voi se n’era accorto?» ruggì, voltandosi e agitando il braccio verso Alejandro, dietro di lui. Il mio corpo stava cessando ogni funzione, pezzo dopo pezzo, e la mia anima era in preda al terrore, in cerca di un posto in cui rifugiarsi. E poi di colpo tutto finì. Mi svegliai. Naturalmente, la prima cosa che pensai fu che quell’episodio terribile era stato tutto un sogno o che forse avevo superato la fase acuta della malattia e ora stavo guarendo. Trovai un conforto momentaneo in quelle spiegazioni, ma dentro di me non potevo negare che mi era successo qualcosa di tremendo, di irreparabile. Se mi sforzavo di concentrarmi, mi venivano in mente visioni offuscate di qualcuno che mi teneva giù sul materasso, qualcun altro che portava via una grande bacinella di rame piena di sangue denso e maleodorante. Mi risvegliai nel mio povero letto nella piccola stanza. Ora però la camera era gelida, il fuoco era spento da chissà quanto tempo. Le tende dell’unica finestra erano tirate, ma si intravedeva una lama di cielo coperto. Il cielo aveva quella tinta grigiastra tipica degli autunni del New England, ma anche i piccoli sprazzi di luce erano sottili e polverosi, eppure mi facevano male gli occhi a guardarli. La gola mi bruciava come se fossi stata costretta a bere acido. Decisi di alzarmi a cercare un po’ d’acqua, ma quando mi misi a sedere, ricaddi immediatamente sulla schiena, con la stanza che mi vorticava attorno. La luce, il mio equilibrio, tutto mi provocava attacchi di nausea, come un invalido fiaccato da una lunga malattia. A parte la mia gola e il mal di testa, il resto del mio corpo pareva fresco. I muscoli non mi bruciavano più per la febbre. I miei movimenti erano rallentati, come se mi avessero lasciata a galla in acque gelide per giorni e giorni. Una cosa molto importante era cambiata in me e non c’era bisogno che nessuno mi dicesse di cosa si trattava: il mio bambino non era più con me. Era morto. Impiegai quasi mezz’ora a uscire dalla stanza, abituandomi pian piano a stare in piedi e poi a camminare. Mentre muovevo piccoli passi lungo il corridoio, verso le camere da letto dei cortigiani, udii distintamente i rumori della quotidianità attorno a me con una precisione quasi animalesca: parole sussurrate tra amanti a letto; il russare del maggiordomo che dormiva nel guardaroba della biancheria; il suono dell’acqua che veniva prelevata dal calderone, forse per preparare il bagno a qualcuno. Mi fermai davanti alla porta di Alejandro, barcollante, cercando di trovare il coraggio di entrare e pretendere che mi spiegasse che cos’era successo a me e al mio bambino mai nato. Alzai la mano per bussare, ma mi bloccai. Qualsiasi cosa mi fosse accaduta, era seria e irrevocabile. Sapevo benissimo chi aveva tutte le risposte e decisi di andare direttamente alla fonte: dall’uomo che aveva messo il veleno sulla mia lingua, che aveva sussurrato incantesimi nelle mie orecchie e che aveva provocato tutto quel cambiamento in me. L’uomo che, con ogni probabilità, mi aveva tolto il mio bambino. E in nome del mio figlio mai nato, dovevo essere forte. Mi voltai e andai fino in fondo al corridoio. Alzai ancora una volta la mano per bussare e poi ci ripensai. Non sarei entrata da Adair come un servitore, chiedendo il permesso di rivolgergli la parola. Le porte si aprirono con una sola spinta. Conoscevo quella stanza e le abitudini dei suoi occupanti, e andai direttamente verso il cumulo di cuscini dove solitamente dormiva Adair. Giaceva sotto una coperta di zibellino, immobile come un cadavere, gli occhi aperti e lo sguardo fisso sul soffitto. «Sei tornata fra noi, vedo» disse, più una dichiarazione che un’osservazione. «Sei tornata fra i vivi.» Ero terrorizzata da lui. Non sapevo spiegarmi che cosa mi avesse fatto, o perché non fossi scappata quando Tilde mi aveva invitato a salire sulla carrozza, o come mai avevo permesso che tutto ciò accadesse. Ma era giunto il momento di affrontarlo. «Che cosa mi hai fatto? E cos’è successo al mio bambino?» Il suo sguardo si spostò, posandosi su di me, feroce come quello di un lupo. «Stavi morendo per un’infezione e io ho deciso che non volevo lasciarti andare, non ancora. E tu non volevi morire. L’ho visto nei tuoi occhi. Una volta che ti ho dato la pozione, non c’era modo di salvare tuo figlio.» I miei occhi si riempirono di lacrime. Dopo tutto quello che era accaduto – l’esilio da St. Andrew, essere sopravvissuta a quella tremenda infezione – il mio bambino mi era stato tolto, senza troppi pensieri. «Che cosa hai fatto... Come hai fatto a impedirmi di morire? Hai detto di non essere un dottore...» Si alzò dal letto e indossò una vestaglia di seta. Mi afferrò il polso e prima che potessi rendermi conto di ciò che stava accadendo, mi trascinò fuori dalla sua camera e giù per le scale. «Quello che ti è accaduto non può essere spiegato. Può soltanto essere mostrato.» Mi portò nelle stanze comuni sul retro della casa. Quando incontrammo Dona nel salone, Adair schioccò le dita verso di lui e disse: «Vieni con noi». Mi portò nella stanza dietro la cucina dove c’erano i pentoloni giganteschi utilizzati per preparare le pietanze ai tanti ospiti e altre attrezzature da cucina inconsuete: griglie per il pesce a forma di vergine di ferro; teglie per i dolci e formine; e un barile di acqua presa dalla cisterna e tenuta lì per gli usi domestici. L’acqua scintillava, nera e lucente, nel barile. Adair mi spinse fra le braccia di Dona e indicò il barile con un cenno del capo. Dona alzò gli occhi al cielo mentre si tirava su la manica destra e poi, fulmineo come una massaia che afferra il pollo da ammazzare per la cena, mi prese per il collo e mi spinse la testa nell’acqua. Non ebbi tempo di prepararmi e i miei polmoni si riempirono d’acqua immediatamente. Dalla forza della sua stretta, capii che non aveva alcuna intenzione di lasciarmi andare. Non potei far altro che divincolarmi e agitarmi sperando di riuscire a rovesciare il barile, o di indurlo ad avere pietà di me. Perché Adair mi aveva salvato dall’infezione e dalla febbre se ora voleva vedermi affogare? Mi urlò qualcosa; sentii la sua voce attraverso lo sciacquio, ma non riuscii a capire le sue parole. Un tempo infinito sembrò passare, ma sapevo che doveva essere un’illusione. Si diceva che quando uno sta morendo sperimenta ognuno dei suoi ultimi secondi di vita con estrema chiarezza e distinzione. Ma ormai l’aria nei miei polmoni era finita e la morte sarebbe sopraggiunta da un momento all’altro. Ero appesa alla mano di Dona che mi teneva sott’acqua, intirizzita dal freddo e terrorizzata, in attesa della fine. E non desideravo altro che riunirmi al mio bambino perduto, altro che, dopo tutto quello che mi era accaduto, arrendermi. Trovare finalmente la pace. Dona tirò su la mia testa dal barile e l’acqua mi scorse lungo i capelli, bagnando tutto il pavimento. Mi costrinse a stare dritta. «Allora? Che cosa ne pensi?» mi chiese Adair. «Hai appena cercato di uccidermi!» «Però non sei affogata, giusto?» Porse a Dona un asciugamano, che lui usò per asciugare il braccio bagnato, stizzito. «Dona ti ha tenuto sott’acqua per cinque minuti buoni, eppure tu sei qui ancora viva. L’acqua non ti ha ucciso. Come credi che sia accaduto?» Sbattendo le palpebre per togliermi l’acqua gelida dagli occhi, mormorai: «Non... non lo so». Il suo sorriso sembrava quello di un teschio. «È perché ora sei immortale. Non puoi più morire.» Mi accovacciai accanto al camino acceso nella camera da letto di Adair, che mi porse un bicchiere e una bottiglia di brandy e si sdraiò a letto, lasciandomi a fissare le fiamme. Lui non bevve. Non volevo credergli e non volevo niente da lui. Se non potevo ucciderlo per avermi tolto il mio bambino, allora non avevo altra scelta che scappare il più lontano possibile da lui e da quella casa. Ma ancora una volta, non riuscivo a muovermi né a pensare chiaramente tanta era la paura, e gli ultimi sprazzi di buon senso mi convinsero a non fuggire. Dovevo ascoltare quello che aveva da dirmi. Accanto al letto c’era uno strano apparecchio fatto di ottone e di vetro, con tubature e contenitori – ora so che era un narghilé, ma in quel momento era solo un affare esotico che emetteva volute di fumo. Adair succhiò la pipa ed esalò una lunga e sottile spira di fumo che salì fino al soffitto. Il suo sguardo si fece vacuo e le sue membra si rilassarono. «Adesso capisci?» mi domandò. «Non sei più mortale. Sei oltre la vita e oltre la morte. Non puoi morire.» Mi porse la pipa del narghilé, poi la riprese quando io non accettai. «Non c’è modo in cui qualcuno ti possa uccidere: né con un pugnale, né con un fucile, o un coltello, o un veleno, né con l’acqua né col fuoco. Nemmeno seppellendoti sotto un cumulo di terra. Nemmeno la malattia e la fame possono farti morire.» «Ma come può essere?» Fece un altro lungo tiro dalla pipa, trattenendo il fumo dentro di sé per un momento prima di lasciarlo sfuggire via in una densa nuvoletta. «Come abbia avuto origine tutto questo non saprei dirtelo. Ci ho pensato e ripensato, ho pregato, ho cercato di sognare la soluzione utilizzando qualsiasi tipo di droga. Non ho mai trovato una risposta. Non so come spiegarlo e alla fine ho smesso di cercare una spiegazione.» «Mi stai dicendo che nemmeno tu puoi morire?» «Ti sto dicendo che sono vivo da centinaia di anni.» «Ma chi mai può essere immortale nel Creato di Nostro Signore?» mi chiesi. «Gli angeli sono immortali.» Adair sbuffò. «Sempre gli angeli, sempre Dio. Com’è possibile che quando qualcuno sente una voce parlargli, è sempre convinto che sia la voce di Dio?» «Intendi dire che è opera di Satana?» Si grattò il ventre piatto. «Intendo dire che ho cercato una soluzione e nessuna voce me l’ha data. Né Dio né Satana si è preso il disturbo di spiegarmi come questo... questo prodigio possa far parte dei loro piani. Nessuno di loro mi ha ordinato di fare come comandavano. Da tutto ciò posso soltanto dedurre che io non sono il servitore di nessuno. Non ho nessun padrone. Siamo tutti immortali: Alejandro, Uzra e gli altri. E sono stato io a rendervi tutti così, è chiaro?» Trasse un’altra lunga boccata dalla pipa, si sentì un gorgoglio d’acqua e la sua voce possente si abbassò fin quasi a un sussurro. «Hai trasceso la morte.» «Ti prego, smetti di ripeterlo. Mi stai spaventando.» «Ti ci abituerai, e molto presto non avrai mai più paura di niente. Non ci sarà più niente di cui aver paura. C’è soltanto una regola che devi seguire, una sola persona cui devi obbedire, e quella persona sono io. Perché io ora possiedo la tua anima, Lanore. La tua anima e la tua vita.» «Adesso ti devo obbedire? Questo vorrebbe dire che tu sei Dio?» sbottai, osando essere sfrontata con lui. «Il Dio che ti hanno abituato a adorare ti ha abbandonata. Ricordi cosa ti ho detto prima che tu ricevessi il dono? Ora sei in mio possesso e lo sarai per sempre. Io sono il tuo Dio e se non credi in me e hai il coraggio di sfidarmi, di mettere alla prova quello che ti sto rivelando, ti invito a farlo. Prova a sconfiggermi.» A quel punto, avevo lasciato che mi conducesse a letto e non protestai quando si sdraiò al mio fianco. Mi passò il bocchino del narghilé e accarezzò i miei capelli umidi mentre io inalavo il fumo denso. La droga mi avvolse nei suoi effetti, cullandomi, e le mie paure crollarono come un bambino esausto. Adesso che ero assonnata e sfinita, Adair si comportò in modo quasi gentile. «Non ho alcuna spiegazione da darti, Lanore, ma c’è una storia. Ti racconterò questa storia, la mia storia. Ti dirò come sono diventato quello che sono e forse a quel punto capirai.» 19 Ungheria, 1349 Non appena Adair vide lo sconosciuto, capì con un infallibile brivido di precognizione che il vecchio era lì per lui. Per i lavoratori nomadi con cui viaggiava la famiglia di Adair, il tramonto segnava l’inizio dei festeggiamenti. Quando calava la sera, allestivano giganteschi falò per godersi l’unico momento della giornata in cui erano liberi. Le lunghe ore trascorse a lavorare nei campi erano passate e quindi si radunavano per dividere il cibo e le bevande e per intrattenersi l’un l’altro. Suo zio non era ancora ubriaco e suonava brani popolari con il suo violino da quattro soldi, accompagnando il canto della madre di Adair e delle altre donne. Qualcuno portava un tamburello, qualcun altro una balalaika. Adair sedeva insieme a tutta la sua famiglia, i suoi cinque fratelli e le due sorelle, insieme alle mogli del fratello maggiore. La sua felicità, quella sera, fu ancora più profonda quando vide, oltre il fuoco scoppiettante, che Katarina si stava avvicinando alla cerchia, insieme alla sua famiglia. Lui e la sua famiglia erano nomadi, così come la famiglia di Katarina e tutti gli altri della carovana. Un tempo erano stati servi di un nobile magiaro, ma lui li aveva abbandonati e traditi, lasciandoli preda dei banditi. Erano scappati dai villaggi a bordo dei loro carrozzoni e da quel momento non avevano mai smesso di vagare, lavorando come braccianti in ogni luogo in cui fosse tempo di raccolto, scavando fossati, occupandosi dei campi, afferrando al volo qualsiasi opportunità di lavoro si presentasse. In quel periodo, il regno magiaro e quello rumeno erano in guerra e i nobili magiari sparsi nelle campagne erano troppo pochi per proteggere i nomadi, ammesso che ne avessero l’intenzione. Non era passato così tanto tempo da quando erano stati costretti a scappare dalle loro case perché Adair non si ricordasse più com’era dormire in una casa, la notte, avere per lo meno quella piccola barriera di sicurezza. I suoi fratelli Istvan e Radu erano neonati quando la sua famiglia era stata costretta a fuggire e non avevano alcun ricordo della vita precedente, più felice. Adair si dispiaceva che i suoi fratellini non avessero sperimentato i bei tempi, ma a guardarli sembravano a loro modo più felici del resto della sua famiglia e la malinconia che attanagliava i loro genitori e fratelli li lasciava perplessi. Lo sconosciuto era apparso all’improvviso, quella sera, ai margini del loro accampamento. La prima cosa che Adair notò di lui fu che era molto vecchio, praticamente un corpo consunto sorretto a malapena dal bastone, e quando si avvicinò vide che sembrava ancor più vecchio. La sua pelle era avvizzita e sottile, come la buccia di un’albicocca marcia, tutta coperta di macchioline di vecchiaia. I suoi occhi erano velati da una filigrana lattiginosa eppure erano stranamente acuti, penetranti. Aveva una folta capigliatura bianca, tanto lunga da cadergli sulla schiena in una treccia. Ma a colpirlo più di ogni altra cosa furono i vestiti, che erano di taglio rumeno e fatti di stoffa pregiata. Chiunque fosse, era ricco e, anche se molto anziano, non dimostrò alcun timore nell’introdursi in un accampamento di zingari da solo e di notte. Si fece largo fra la gente e si posizionò al centro della cerchia, accanto al falò. Perlustrò con lo sguardo tutta la folla e Adair sentì il sangue raggelarglisi nelle vene. Adair non era diverso da tutti gli altri ragazzi dell’accampamento: ignorante, sporco, denutrito. Sapeva che non c’era ragione per cui il vecchio scegliesse lui, ma il suo presentimento era così intenso che si sarebbe alzato e sarebbe scappato via se il suo stupido orgoglio infantile non gliel’avesse impedito. Non aveva fatto niente a quel vecchio, quindi perché avrebbe dovuto scappare da lui? Dopo aver scrutato in silenzio uno a uno i volti illuminati dalla tremula luce del falò, il vecchio sfoderò un sorriso sgradevole, alzò una mano e indicò direttamente Adair. Poi guardò il gruppo degli anziani. A quel punto, ogni attività era già interrotta, la musica e le risate erano sfumate nel silenzio. Tutti gli occhi erano puntati sullo sconosciuto e poi su Adair. Fu suo padre a rompere il silenzio. Si fece largo fra i fratelli e le sorelle di Adair e afferrò quest’ultimo per il braccio, quasi staccandoglielo dalla spalla. «Che cos’hai combinato stavolta?» sibilò tra i denti radi. «Alzati, forza! Vieni con me!» Costrinse il figlio ad alzarsi in piedi. «E voi che cosa state a guardare? Tornate ai vostri stupidi racconti e alle vostre stupide canzoni!» Poi trascinò via Adair, seguito dagli sguardi attoniti di Katarina e della famiglia di Adair. I due si recarono all’ombra del fogliame di un albero, seguiti dallo sconosciuto, lontani dalle orecchie indiscrete dell’accampamento. Adair cercò di scongiurare il guaio che gli si era abbattuto addosso, qualsiasi esso fosse. «Chiunque tu stia cercando, giuro che non sono io. Mi confondi con un altro.» Suo padre gli tirò un ceffone. «Cos’hai combinato? Hai rubato una gallina? Hai preso patate o cipolle dai campi?» «Te lo giuro, non lo conosco» farfugliò Adair portandosi una mano alla guancia colpita e indicando l’anziano con l’altra. «Non lasciare che la tua colpevole immaginazione prenda il sopravvento. Non sono qui per accusare il ragazzo di alcun crimine» disse il vecchio al padre di Adair. Osservò sia Adair sia suo padre con disprezzo, come se fossero mendicanti o ladruncoli. «Ho scelto tuo figlio, voglio che venga a lavorare con me.» A suo credito, il padre di Adair accolse con sospetto quell’offerta. «E a che cosa ti potrebbe mai servire? Non ha nessuna abilità. Sa soltanto lavorare i campi.» «Ho bisogno di un servitore. Un ragazzo con la schiena forte e le gambe resistenti.» Adair di colpo vide la sua vita prendere una piega imprevista e indesiderata. «Non sono mai stato un servitore in una casa. Non saprei nemmeno...» Un secondo schiaffo di suo padre fermò le parole di Adair. «Cerca di non far capire quanto poco vali» lo rimproverò il padre. «Puoi sempre imparare, anche se non è che tu sia molto bravo ad apprendere.» «Andrà bene, lo sento.» Lo sconosciuto girò lentamente attorno a Adair, esaminandolo come se fosse un cavallo in vendita al mercato nero. Lasciava una scia di profumo dietro di sé, un odore secco e affumicato, come incenso. «Non mi serve qualcuno svelto di mente, solo uno in grado di aiutare un fragile vecchio ad affrontare le necessità quotidiane. Ma...» A quel punto, il suo sguardo si fece più severo e il suo contegno divenne nuovamente altezzoso. «Vivo lontano da qui e non ho intenzione di ripetere questo viaggio. Se tuo figlio vuole cogliere quest’opportunità, deve partire con me stanotte stessa.» «Stanotte?» Adair sentì un groppo in gola. «Sono pronto a ripagarti la perdita del contributo di tuo figlio al bilancio familiare» disse lo sconosciuto al padre di Adair. E a quelle parole, Adair capì di essere perduto, perché suo padre non avrebbe mai rifiutato dei soldi. A quel punto, sua madre si avvicinò a loro, mantenendosi all’ombra dell’albero, tormentandosi la gonna con i pugni stretti. Attese con Adair mentre il padre e lo straniero contrattavano il prezzo. Una volta che ebbero raggiunto l’accordo sulla somma da pagare e il vecchio si fu allontanato per preparare il suo cavallo, la madre di Adair si scagliò sul marito. «Che cosa stai facendo?» urlò, pur sapendo benissimo che suo marito non avrebbe mai cambiato idea. Non serviva a niente litigare con lui. Ma Adair aveva motivi più forti per combattere e non aveva niente da perdere, perciò aggredì il padre. «Perché mi fai questo? Arriva uno sconosciuto al campo e tu gli vendi uno dei tuoi figli come se niente fosse? Che cosa sai di lui?» «Come osi mettere in dubbio le mie decisioni?» rispose l’uomo, dandogli uno schiaffo tanto violento da spedirlo a terra. Il resto della famiglia si era allontanato dal falò e stava a guardare, appena fuori dalla portata del padre. Non c’era nulla di nuovo per loro nel vedere il padre picchiare uno dei fratelli, ma era comunque sconvolgente. «Sei così stupido che non riconosceresti una buona opportunità nemmeno se ci sbattessi contro. Quest’uomo è evidentemente molto ricco. Sarai il servitore di un uomo ricco. Vivrai in una casa, non in un carrozzone, e non dovrai più lavorare nei campi. Se pensassi che il vecchio accetterebbe, gli chiederei di prendere anche un altro dei miei figli. Forse Radu non è così cieco da non vedere la buona sorte quando si presenta, lui.» Adair si alzò lentamente da terra, rosso di vergogna. Suo padre gli mollò uno scappellotto sulla nuca, tanto per chiarire ulteriormente. «Adesso prepara le tue cose e di’ addio a tutti. Non fare aspettare quell’uomo.» Sua madre fissò il marito in volto. «Ferenc, cosa sai dell’uomo a cui stai affidando nostro figlio? Che cosa ti ha detto di sé?» «So quanto basta. È il medico di corte di un conte. Vive in una casa nella tenuta del conte stesso. Adair dovrà servirlo per sette anni. Passati i sette anni, Adair potrà scegliere se andarsene o rimanere al suo servizio.» Adair fece i calcoli a mente: passati sette anni ne avrebbe avuti ventuno, metà della sua vita. In quel momento, stava entrando nell’età giusta per sposarsi ed era impaziente di seguire le orme dei fratelli maggiori, avere una moglie, dei figli, essere accettato come uomo. Come servitore, non avrebbe potuto sposarsi né gli sarebbe stato concesso di avere dei figli; la sua vita sarebbe stata come sospesa, proprio nel periodo cruciale. E, una volta liberato, sarebbe stato troppo vecchio. Quale donna l’avrebbe mai desiderato a quel punto? E la sua famiglia? Dove sarebbero stati in capo a sette anni tutti loro? Erano nomadi, si spostavano in cerca di lavoro, di un rifugio, per sfuggire al cattivo tempo. Nessuno di loro sapeva leggere o scrivere. Non sarebbe mai stato capace di ritrovarli. E perdere la sua famiglia era impensabile. Erano l’ultima feccia della società, tenuti alla larga da tutti. Ma una volta partito al servizio di quello sconosciuto, come avrebbe potuto sopravvivere senza di loro? Sua madre scoppiò a piangere. Sapeva altrettanto bene di Adair che cosa comportava quella faccenda. Ma suo padre non arretrò di un passo. «È la cosa migliore! Lo sapete benissimo. Ma guardiamoci, riusciamo a malapena a guadagnare abbastanza per nutrire i nostri figli. È meglio che Adair impari a prendersi cura di se stesso.» «Quindi siamo tutti un peso per te!» sbottò Radu. Aveva due anni meno di Adair ed era il più sensibile della famiglia. Corse da Adair e avvolse le braccia sottili attorno alla vita del fratello, bagnando con le sue lacrime la camicia consunta di Adair. «Adair è un uomo ora e deve trovare la sua strada a questo mondo» disse il padre a Radu, e poi, rivolgendosi a tutti, disse: «Adesso basta con questi piagnistei! Adair deve preparare le sue cose». Adair viaggiò tutta la notte, a cavallo con lo sconosciuto, come gli era stato ordinato. Lo sorprese scoprire che il vecchio possedeva un cavallo magnifico, degno di appartenere a un cavaliere, tanto possente da far vibrare il terreno al suo passo. Adair capì che erano diretti a occidente, addentrandosi nel territorio rumeno. Verso l’alba, oltrepassarono il castello del conte a servizio del quale era il medico. Non aveva niente di poetico. Era costruito per resistere agli assedi, squadrato e solido, circondato da abitazioni sparse e recinti di pecore e bovini. Campi coltivati si estendevano in tutte le direzioni. I due cavalcarono per altri venti minuti attraversando una fitta foresta finché non giunsero di fronte a un piccolo torrione di pietra, seminascosto fra gli alberi. Il torrione sembrava umido, coperto di muschio che cresceva selvaggiamente senza i raggi del sole a tenerlo a bada. A Adair il torrione sembrò più una prigione che una casa, apparentemente senza nemmeno una porta ricavata nella sua terrificante facciata. Il vecchio smontò da cavallo e diede ordine a Adair di prendersi cura dell’animale prima di raggiungerlo all’interno. Adair si trattenne più che poté con l’imponente cavallo, togliendo la sella e le redini, portandogli dell’acqua, strofinando la sua schiena sudata con della paglia secca. Quando non poté più evitarlo, raccolse la sella ed entrò nel torrione. All’interno l’aria era quasi troppo fumosa per vederci chiaramente; c’erano un piccolo fuoco acceso nel camino e solo una sottile finestra simile a una feritoia per far uscire il fumo. Guardandosi attorno, Adair vide che il torrione era un’unica e ampia stanza circolare. Per terra, accanto alla porta, c’era una donna che dormiva su un mucchio di paglia. Aveva almeno dieci anni più di Adair e un aspetto matronale, con mani ampie e grassocce e lineamenti quasi asessuati. Dormiva circondata dagli attrezzi tipici del suo sesso: ciotole e cucchiai di legno ritorti, pentole e secchi; un’asse di legno a fare da tavolo, tutta unta e consumata; pile di scodelle di legno che fungevano da piatti; orci di vino e birra. Trecce di peperoncini e aglio erano appese a ganci nel muro di pietra, accanto a salsicce e a un filone di pane di segale raffermo. Dalla parte opposta c’era un tavolo coperto di barattoli e bottiglie, fogli di carta, un calamaio di inchiostro con diverse penne e delle cose strane su cui Adair non aveva mai posato gli occhi prima: dei libri, rilegati con una copertina di legno. Dietro al tavolo si trovavano cestini colmi di strani artefatti provenienti dalla foresta: radici secche e impolverate, pigne, manciate di ortiche, grovigli di erbacce. Sullo sfondo, Adair notò una scalinata che conduceva di sotto, probabilmente a un gelido sotterraneo. All’improvviso Adair si ritrovò di fianco il vecchio che lo scrutava. «Immagino che tu voglia sapere come mi chiamo. Sono Ivor cel Rau, ma puoi chiamarmi ’padrone’.» Mentre si toglieva dalle spalle il pesante mantello e si riscaldava le mani davanti al focolare, il medico gli spiegò che proveniva da una famiglia di nobili proprietari terrieri rumeni ed era l’ultimo maschio della sua famiglia. Anche se un giorno avrebbe ereditato il castello di famiglia e la terra che lo circondava, da giovane aveva deciso di intraprendere una carriera diversa ed era andato a Venezia a studiare medicina. Nei decenni trascorsi come medico di corte era stato a servizio di diversi conti e perfino re. Adesso era giunto al termine di una lunga carriera, al servizio del conte cel Batrin, il nobile rumeno che possedeva il castello che avevano visto prima. Il medico spiegò a Adair di non averlo preso con sé per insegnargli le arti mediche, ma perché voleva che lo assistesse, raccogliendo erbe e altri ingredienti per unguenti e pozioni, oltre a svolgere le mansioni di casa e aiutare la governante, Marguerite. Il vecchio frugò in un baule aperto fino a trovare una vecchia e malconcia coperta di lana grezza. «Preparati un letto di paglia vicino al fuoco. Quando Marguerite si sveglierà ti darà da mangiare e ti riferirà i tuoi ordini per la giornata. Cerca di riposarti, perché voglio che tu sia pronto per stanotte quando mi sveglierò. Oh, e non sorprenderti se Marguerite non ti ascolta né ti rivolge la parola: è sordomuta dalla nascita.» Poi il vecchio prese una candela, che era stata accesa e posata sul tavolo, pronta per il suo ritorno, e zoppicò fino alla scalinata in penombra. Adair eseguì i suoi ordini e si accoccolò accanto al fuoco, addormentandosi ancor prima che il bagliore della candela svanisse nel fondo delle scale. Furono i movimenti della governante a svegliarlo. Interruppe quello che stava facendo per guardare apertamente Adair mentre si alzava da terra. Adair la trovò ancor più brutta di quanto aveva intuito mentre lei dormiva: era sgraziata, con un volto mascolino e la fisionomia massiccia di un bracciante. Lei porse a Adair una ciotola di brodaglia fredda e dell’acqua e, quando lui finì di mangiare, lo condusse al pozzo e gli porse un secchiello, mimandogli le istruzioni. Sempre in quel modo, gli fece prendere l’acqua per la cucina e per il bestiame e tagliare la legna per il falò. Poi, quando lei andò a lavare i panni in una grande tinozza di legno, Adair cercò di appisolarsi un po’, ricordando le ammonizioni del padrone. Furono le mani di Marguerite a svegliarlo di colpo; lo scuoteva per le spalle, indicando le scale. Era giunta la sera e, là sotto, il vecchio si stava alzando. La governante si aggirò accendendo candele nella stanza principale e poco dopo il vecchio salì lentamente e silenziosamente dalle scale, stringendo la stessa candela tozza di quella mattina. «Ti sei svegliato. Bene» disse il medico trascinandosi fino a Adair. Si mise alla scrivania e sfogliò alcune pagine ricoperte di scritte indecifrabili. «Accendi il fuoco» ordinò, «e prendi un calderone. Devo preparare una pozione, stanotte, e tu mi aiuterai.» Ignorando il suo nuovo servitore, il medico iniziò a frugare tra le file di barattoli, ognuno coperto da un telo cerato e chiuso da un laccio, portandoli uno a uno alla luce del camino per leggerne l’etichetta, scartandone alcuni per tenerne altri. Quando il calderone fu appeso e scaldato dalle fiamme, Adair aiutò il vecchio a portare i barattoli in prossimità del fuoco. Seduto lì accanto, osservò il medico misurare manciate di ingredienti nella mano avvizzita per poi buttarle nel pentolone. Adair riconobbe alcune piante ed erbe, ormai secche e ridotte in polvere, ma altri ingredienti gli erano del tutto sconosciuti. Artiglio di pipistrello? O forse di ratto? La cresta di un gallo? Tre piume nere, ma di che uccello? Da un barattolo serrato con forza, il medico versò un liquido denso e scuro che emetteva un odore putrescente non appena esposto all’aria. Da ultimo, aggiunse una brocca d’acqua, poi si voltò verso Adair. «Tienilo d’occhio con attenzione. Falla bollire, poi spegni il fuoco e fai in modo che la pozione non si raggrumi troppo. Dev’essere densa come catrame, hai capito?» Adair annuì. «Posso chiedere a cosa serve questa pozione?» «No, non puoi chiederlo» rispose, poi parve ripensarci. «Col tempo apprenderai, quando sarai abbastanza saggio. Adesso io esco. Bada alla pozione secondo le mie istruzioni. Non allontanarti dal torrione e non addormentarti.» Adair osservò il vecchio prendere il mantello da un gancio e scivolare fuori nella notte. Fece come gli era stato ordinato, seduto tanto vicino al fuoco da non poter fare a meno di inalare le fetide esalazioni del liquido che ribolliva. Il torrione era avvolto nel silenzio, a parte Marguerite che russava, e Adair la osservò per un po’, notando l’ampio ventre che si alzava e si abbassava, la paglia che crepitava quando lei si girava nel sonno. Quando si stancò di quel misero intrattenimento, andò alla scrivania del medico e studiò le pagine scritte a mano, desiderando di possedere la capacità di leggerle. Pensò di provare a convincere il vecchio a insegnargli a leggere; di certo il medico avrebbe ritenuto utile che il suo servitore avesse quella capacità. Di tanto in tanto, Adair saggiava il contenuto del pentolone con un cucchiaio di legno, valutandone la densità, e quando gli parve corretta, prese l’attizzatoio e lo usò per spostare i legni in fiamme ai lati del camino, lasciando sotto il calderone soltanto le braci ardenti. A quel punto, ritenne di potersi rilassare, perciò si avvolse nella coperta logora e si appoggiò al muro. Il sonno lo tormentava, come una birra deliziosa che aveva appena assaggiato e che avrebbe voluto bere ancora, pur non potendolo fare. Le pensò tutte per riuscire a stare sveglio: camminò in cerchio sul pavimento, bevve acqua gelida, fece flessioni. Dopo un’ora di simili trucchetti era ancora più esausto di prima e sul punto di accasciarsi sul pavimento, svenuto, quando di colpo la porta si aprì e il vecchio entrò. Sembrava rinvigorito dalla sua escursione, i suoi occhi appannati parevano quasi scintillare. Controllò dentro il calderone. «Molto bene. La pozione mi sembra pronta. Togli il calderone dal sostegno e lascialo a raffreddarsi nel focolare. Domattina dovrai versare la pozione in quel vaso e coprirla con un foglio di carta. Adesso riposati, è quasi l’alba.» Passarono così parecchie settimane. Adair era contento che si fosse stabilita una routine, perché lo aiutava a non pensare alla perdita della sua famiglia e della sua amata Katarina. Di mattina aiutava Marguerite e di pomeriggio riposava. La sera la trascorreva preparando pozioni o unguenti, oppure ad ascoltare il vecchio che gli insegnava a riconoscere e a raccogliere gli ingredienti. Conduceva Adair nel bosco per cercare una certa pianta o un certo seme al chiar di luna. Altre sere, invece, Adair le trascorreva ad arrotolare ritagli di pelle e ad appenderli alle travi vicino al focolare. Quasi ogni notte il medico spariva per qualche ora e tornava sempre prima dell’alba, andandosi a ritirare nella sua camera, sottoterra. Passati un paio di mesi, il medico prese a mandare Adair al villaggio che circondava le mura del castello per barattare un orcio di unguento con cibo, abiti, attrezzi di ferro o stoviglie. Adair era arrivato al punto di desiderare ardentemente la compagnia di altre persone, se non altro per risentire la propria voce. Ma gli abitanti del villaggio si allontanavano sempre quando capivano che lui lavorava per il medico. Se anche capivano che Adair era solo come un cane e che avrebbe fatto di tutto per parlare con qualcuno, non si muovevano a compassione e facevano in modo che il baratto fosse rapido e senza fronzoli. All’incirca in quel periodo, qualcosa cambiò nel rapporto tra Marguerite e Adair, con estrema vergogna di quest’ultimo. Un pomeriggio, quando si era appena svegliato e si stava rivestendo, lei si era avvicinata al suo letto e aveva iniziato a toccarlo. Senza attendere incoraggiamenti, lo aveva spinto di nuovo sulla paglia, palpandogli il petto sotto la tunica, poi gli aveva infilato le mani nei pantaloni. Dopo avergli provocato un’erezione, si era sollevata le gonne impolverate e si era accucciata su di lui. Non c’era alcuna delicatezza nei suoi movimenti, né in quelli di Adair. Nessuna pretesa che fosse altro che uno sfogo meramente fisico per entrambi. Mentre stringeva la sua carne fra le mani, Adair cercava di immaginare che Marguerite fosse la sua Katarina, ma non c’era modo di ingannarsi fino a quel punto: quella donna era grossa quanto un orso, Katarina invece era esile e delicata, e aveva occhi scuri e incantevoli. Quando tutto finì, Marguerite emise un suono gutturale allontanandosi da Adair, si abbassò le gonne e riprese le sue solite faccende. Lui rimase sul letto di paglia, lo sguardo perso nel soffitto, chiedendosi se il medico li avesse sentiti e, in caso affermativo, quale sarebbe stata la sua reazione. Forse anche lui sfogava i suoi appetiti con Marguerite... No, era impossibile. Adair immaginò che il vecchio si rivolgesse a qualche giovane sprovveduta del villaggio per soddisfare i suoi pruriti, durante le sue escursioni notturne. Forse nel tempo anche lui avrebbe potuto fare lo stesso. Per il momento, a quanto pareva quello doveva essere il suo strano stile di vita; per lo meno, non era estenuante come il lavoro nei campi e poi c’erano le promesse di un miglioramento della sua situazione, se fosse riuscito a convincere il vecchio a insegnargli le arti mediche. Anche se Adair sentiva ancora terribilmente la mancanza della sua famiglia, trovava un conforto nella routine e nella promessa di un futuro migliore. Decise perciò di rimanere ancora lì per un po’, a vedere che cosa il destino avesse in serbo per lui. 20 Dopo aver passato mesi al servizio del medico senza avere alcun contatto con altre persone a parte il vecchio e Marguerite, giunse finalmente la notte in cui Adair avrebbe fatto la sua prima visita al castello. Non che Adair ci tenesse particolarmente a entrare nella fortezza di un nobile rumeno. Provava soltanto odio nei confronti di quei maledetti che avevano razziato i villaggi magiari, distrutto le case della sua gente ed espropriato le loro terre. Tuttavia, non poteva fare a meno di provare una certa curiosità; Adair non era mai stato nell’abitazione di un uomo ricco, non era mai entrato dentro le mura di un castello, aveva sempre e solo lavorato nei campi. Pensò di poterlo sopportare se fosse riuscito a immaginarsi che il proprietario del castello fosse magiaro, non rumeno. Allora avrebbe potuto ammirare le stanze sontuose e gli orpelli lussuosi. Il suo incarico quella notte era trasportare un grosso barattolo contenente una pozione che avevano preparato la sera precedente. Come al solito, lo scopo della pozione gli era stato tenuto segreto. Adair attese vicino alla porta mentre il medico si affaccendava a cercare la veste migliore. Alla fine scelse una tunica ricamata con fili d’oro e trapuntata di gemme colorate, a testimonianza del fatto che si trattava di un’occasione speciale. Il medico cavalcò il suo destriero e Adair arrancò dietro di lui, tenendo l’urna sulla schiena come se fosse una donna anziana che non riusciva più a camminare dritta. Il minaccioso ponte levatoio sopra il fossato fu abbassato per consentire il loro passaggio, e furono scortati fin dentro un ampio salone da una squadra di soldati del conte. C’erano guardie allineate lungo le pareti. Era in corso una festa nel salone. Il medico raggiunse il conte a capotavola e Adair si accucciò in fondo alla stanza, contro una parete, ancora abbracciato all’urna. Riconobbe alcuni degli emblemi sugli scudi appesi alle pareti; appartenevano alle tenute per cui aveva lavorato in passato. Il dialetto del conte gli era familiare, ma Adair non riusciva a capire di che cosa stessero parlando perché usavano troppe parole rumene. Anche un sempliciotto come Adair comprese che cosa significava quella combinazione di fatti: il conte era originariamente un magiaro, ma si era alleato con gli oppressori rumeni per salvare la propria vita e le proprie ricchezze. Ecco perché gli abitanti del villaggio evitavano lo stesso Adair: probabilmente credevano che anche lui fosse un traditore, un simpatizzante rumeno. Aveva appena raggiunto questa conclusione quando il vecchio gli chiese di avvicinarsi con l’urna. Adair gliela portò. Poi, allontanato con un cenno della mano da parte del medico, tornò nell’angolo. Il medico sollevò il panno cerato affinché il conte potesse esaminare il contenuto dell’urna. Il nobile chiuse gli occhi e inspirò profondamente, come se quelle esalazioni pestilenziali fossero dolci come un campo di fiori selvatici. I cortigiani del conte presero a ridere e gioire, come se sapessero che stava per succedere qualcosa di eccitante. Adair trattenne il fiato alla prospettiva di poter finalmente capire lo scopo di almeno una delle pozioni misteriose. Di colpo, lo sguardo del vecchio lo trafisse. «Credo che il ragazzo non debba stare qui; questo posto non fa per lui» disse a una delle guardie. «Forse potete trovare un modo migliore di impiegare il suo tempo, insegnandogli un paio di cose sull’arte militare. Potrebbe trovarsi a dover difendere questo castello, un giorno, o quantomeno a salvare la mia vecchia e inutile pelle.» Adair fu condotto via in mezzo a risate di scherno e portato in un cortile dove alcune guardie oziavano. Non erano né cavalieri né soldati professionisti, ma semplici guardie. Comunque, erano molto più esperti di Adair nell’uso della spada e della lancia. Con la scusa di fargli fare pratica, per due ore si divertirono un mondo a massacrarlo, mentre lui cercava di difendersi con quelle armi poco familiari. Quando gli fu consentito di rientrare nel salone del conte, le braccia gli dolevano per tutti gli affondi con la spada spuntata, la più pesante che le guardie avessero trovato, ed era pieno di lividi e graffi. La scena nel grande salone non era quella che si era atteso. Il conte e i suoi vassalli sembravano semplicemente ubriachi, ondeggiavano sulle sedie o erano caduti a terra, con gli occhi chiusi e un sorriso istupidito sul volto, i corpi abbandonati, rilassati. Notarono a malapena il congedo del medico, che condusse Adair attraverso il cortile. Nell’alba grigia, attraversarono da soli il ponte levatoio e si inoltrarono nella foresta. Adair arrancò dietro il cavallo del vecchio ed era così stanco da essere grato di non doversi riportare in spalla l’urna. Il mistero delle arti del medico a poco a poco iniziò a occupare i pensieri di Adair. Da un lato, Adair era grato di avere un posto asciutto e caldo in cui dormire e non dover più lavorare fino allo sfinimento e, un giorno, alla morte precoce nei campi. A differenza di tutta la sua famiglia, aveva tre pasti al giorno e mangiava tutto quello che poteva: stufato, uova, di tanto in tanto carne alla brace. Aveva una compagna di letto, perciò non c’era rischio che l’astinenza forzata lo facesse impazzire. Dall’altra parte, però, Adair non poteva fare a meno di vedere tutto questo come un patto col diavolo, anche se era stato stretto contro la sua volontà: c’era un prezzo da pagare per una vita relativamente agiata come quella che stava facendo. E Adair sentiva che presto gli sarebbe stato presentato il conto. Una sera, ricevette il primo segnale del pagamento dovuto. Il medico condusse Adair e Marguerite nei boschi. Camminarono a lungo, e siccome non avevano nient’altro da fare se non mettere un piede davanti all’altro, Adair ne approfittò per rivolgere qualche domanda al vecchio. «Posso chiedervi, padrone, perché lavorate sempre e solo di notte?» domandò, assicurandosi di sembrare il più timido e ingenuo possibile. Sulle prime il vecchio grugnì e basta, come se non la ritenesse una domanda degna di risposta. Ma dopo qualche attimo – perché in fondo chi non ama parlare di sé, per quanto possa essere stupida la domanda? – si schiarì la voce per rispondere. «È una questione di abitudine, immagino... Questo è il tipo di lavoro che è meglio svolgere lontano dagli occhi indiscreti delle altre persone.» Il medico respirava con più affanno, ora, perché stavano percorrendo un leggero pendio; riprese a parlare solo quando arrivarono in cima. «Il fatto è, Adair, che questo è un lavoro che si deve fare di notte perché la notte è potente, capisci? È dall’oscurità che queste pozioni traggono la loro forza.» Lo disse con estrema noncuranza, come se fosse un fatto noto a tutti, e Adair capì che avrebbe soltanto dimostrato la propria ignoranza se avesse chiesto ulteriori spiegazioni, quindi si azzittì nuovamente. Alla fine giunsero in un posto così selvaggio e fitto di vegetazione che pareva che nessun essere umano ci avesse mai posato gli occhi. Attorno alle radici dei pioppi e dei larici proliferava una strana pianta con larghe foglie a forma di ventaglio appese a steli nodosi che svettavano nell’erba, come a rivolgere un saluto al trio di visitatori di quella notte. Il medico indicò a Marguerite di seguirlo. La condusse vicino a una delle piante, le fece mettere le mani attorno a una di esse e le segnalò di attenderlo lì immobile. Poi si allontanò da lei, chiamando Adair e dicendogli di seguirlo. Si allontanarono fino a quando la governante non fu quasi scomparsa nell’oscurità; soltanto il suo grembiule bianco splendeva alla luce della luna. «Copriti bene le orecchie e stai attento, altrimenti ne pagherai le conseguenze» spiegò a Adair. Poi indicò a gesti a Marguerite di tirare forte, e lei eseguì, facendo leva con tutto il suo peso in un unico movimento. Nonostante avesse le mani premute sulle orecchie, Adair ebbe la netta impressione di sentire un lamento sfuggire dalla pianta quando le sue radici furono strappate dal terreno. A quel punto Adair guardò il medico e abbassò le mani, sentendosi in imbarazzo. Marguerite trotterellò come un cane al seguito del padrone e li raggiunse, portando con sé la pianta. Il medico gliela tolse dalle mani e spazzò via il terriccio dalle radici sottili. «Sai di che cosa si tratta?» chiese a Adair mentre ispezionava la spessa protuberanza a cinque punte, più grande del palmo di una mano di un uomo adulto. «È una radice di mandragola. Vedi che è a forma di essere umano? Queste sono le gambe, queste le braccia e questa qui è la testa. Hai sentito il suo urlo quando lei l’ha strappata dalla terra, vero? È un suono che può uccidere chi lo sente.» Il medico agitò la radice verso Adair. In effetti sembrava un uomo tozzo e un po’ deforme. «Ecco cosa devi fare quando ti tocca raccogliere radici di mandragola: ricordatelo bene per quando ti manderò a prenderne. Alcuni medici si servono di un cane nero per tirar su le radici, ma quando sentono l’urlo i cani muoiono, proprio come gli esseri umani. Per fortuna non dobbiamo preoccuparci dei cani, visto che abbiamo Marguerite, giusto?» Adair non gradì che il medico lo coinvolgesse in quel discorso canzonatorio su Marguerite. Si chiese, rosso di vergogna, se il vecchio sapesse di loro due e se avesse scelto di lasciare che Adair si comportasse così con lei. In effetti, il medico avrebbe potuto fare paragoni con il modo brusco in cui lui stesso trattava la governante, sfruttandola come un bue per tirar fuori una radice dal terreno e, anche se era sordomuta, era chiaro che lui aveva così poco riguardo per la vita altrui da non curarsi per niente se lei moriva o meno estraendo le radici. Certo, era anche possibile che l’urlo della mandragola non potesse davvero ucciderla e che lui avesse raccontato quella storia a Adair soltanto per spaventarlo. Ma Adair archiviò quello scampolo di informazione sulla mandragola nella sua memoria, insieme agli altri frammenti di saggezza che il medico aveva condiviso con lui. Forse un giorno gli sarebbe tornato tutto utile. Quel poco di emozione che Adair aveva inizialmente provato per la sua nuova vita iniziò a evaporare a mano a mano che la sua routine quotidiana fatta di silenzio e solitudine cominciò a renderlo sempre più infelice. Ispezionò attentamente le bottiglie e i barattoli nello studio del medico, poi esaminò tutto ciò che c’era nella stanza più grande, fino a conoscere a menadito ogni angolo del piano superiore del torrione. Aveva però conservato sufficiente buon senso da non osare avventurarsi nel sotterraneo. Senza chiedere il permesso del medico, però, Adair prese a salire a cavallo il pomeriggio per osservare la campagna circostante. Si diceva che era per il bene del cavallo, per mantenerlo in forma dato che il medico lo cavalcava di rado. Ma a volte, quando metteva diverse miglia fra sé e la sua piccola prigione, sentiva una voce che lo induceva in tentazione, suggerendogli di fuggire, di continuare a cavalcare senza mai voltarsi indietro. In fondo, come avrebbe fatto il vecchio a rincorrerlo senza un cavallo? A ogni modo, Adair sapeva anche che con tutto il tempo che era passato da quando era arrivato al torrione, non sarebbe stato in grado di rintracciare la sua famiglia, e senza una famiglia da cui fare ritorno non aveva alcun senso fuggire. Lì aveva cibo e un tetto sopra la testa. Se fosse scappato, non avrebbe avuto niente e, per tutto il tempo che ancora doveva al medico, sarebbe stato un fuggitivo. Dopo interminabili momenti passati a osservare tutte le strade che conducevano lontano dalla sua piccola prigione, sebbene con riluttanza faceva voltare il cavallo e tornava al torrione. Tuttavia, col tempo, Adair iniziò a pensare che il medico lo stesse prendendo a cuore. La notte, quando lavoravano a una pozione, sorprendeva il medico a guardarlo meno duramente del solito. Il medico iniziò a spiegare a Adair qualcosa in più sui contenuti dei barattoli, mentre sbriciolava semi essiccati o divideva le erbe da conservare. Rivelava i nomi delle piante più strane e le loro proprietà. Era imminente una seconda visita al castello, un appuntamento che sembrava interessare particolarmente al medico, che si strofinava contento le mani mentre camminava nervosamente per la stanza. «Abbiamo un nuovo ordinativo dal conte, e dobbiamo iniziare i preparativi stanotte stessa» spiegò smanioso mentre Adair appendeva il mantello del vecchio a un gancio sulla porta. «Iniziare cosa, padrone?» chiese Adair. «È una richiesta speciale da parte del conte. Si tratta di un compito molto difficile, ma ho già fatto qualcosa di simile in passato.» Percorreva a grandi falcate le assi del pavimento, raccogliendo barattoli di ingredienti per posarli sul tavolo da lavoro. «Prendi il calderone più grande e ravviva il fuoco, si sta spegnendo.» Adair osservava dal focolare. Come prima cosa, il medico selezionò un foglio in particolare fra le sue ricette scritte a mano e lo rilesse velocemente, poi lo appoggiò a un barattolo per poterlo consultare agevolmente. Mentre misurava gli ingredienti e li gettava nel calderone che si stava riscaldando, di tanto in tanto lanciava occhiate di controllo al foglio con la formula. Tirò giù dagli scaffali ingredienti che non aveva mai usato prima. Strani pezzi di animali: musi avvizziti, lembi di pelle incartapecorita, grumi di carne mummificata. Polveri, cristalli scintillanti bianchi come l’avorio o gialli come il rame. Misurò una precisa quantità d’acqua e la versò, poi chiese a Adair di appendere il pesante calderone allo spiedo sopra il fuoco. Quando l’acqua iniziò a bollire, il medico prese una manciata di polvere gialla da una fiala e la gettò sul fuoco: si infiammò in una vampata di fumo, emettendo l’inconfondibile odore di zolfo. «È la prima volta che vedo questa pozione, vero, padrone?» chiese Adair. «Esatto.» Fece una pausa. «È una pozione che rende invisibile chiunque la beva.» Studiò il volto di Adair in cerca di una reazione. «Che cosa ne pensi, ragazzo? Pensi che una cosa simile sia possibile?» «Non ho mai sentito niente del genere.» Ormai aveva imparato che era meglio non contraddire esplicitamente il vecchio. «Forse potrai constatarlo con i tuoi occhi. Il conte ha intenzione di far bere questa pozione ai suoi uomini migliori, che diventeranno invisibili per una notte. Riesci a immaginare che cosa possa portare a compimento un esercito che non può essere visto da nessuno?» «Sì, padrone» rispose Adair e da quel momento in poi iniziò a guardare le pozioni e gli incantesimi del medico sotto una luce diversa. «Bene. Adesso vedi di tener d’occhio il calderone e lascia che evapori tutta l’acqua, come hai già fatto altre volte. Quando sarà evaporata, devi togliere il calderone dal fuoco e lasciarlo raffreddare. A quel punto potrai andare a dormire, non prima. Questi ingredienti sono rari e di alcuni erano le ultime porzioni rimaste, perciò non ci possiamo permettere di rovinare tutto, è chiaro? Controlla ogni cosa con attenzione» disse voltandosi per scendere le scale. «Vedrò se hai fatto tutto bene al tramonto.» Adair non ebbe alcun problema a rimanere sveglio quella notte. Rimase seduto a schiena dritta contro la dura pietra del muro, alle prese con la consapevolezza che il vecchio aveva preso in giro sia lui sia suo padre. Non era un medico, ma un alchimista, forse un negromante. Non c’era da meravigliarsi che gli abitanti del villaggio gli stessero alla larga. Non era soltanto perché era al servizio di un traditore come il conte. Avevano tutti paura del vecchio, e con buone ragioni: probabilmente era in combutta col diavolo. Dio solo sapeva che cosa sospettassero sul conto di Adair. La pozione non era come tutte le altre e impiegò tantissimo a rassodarsi. Solo verso l’alba l’acqua era sufficientemente evaporata. Ma nelle ultime ore della notte, osservando un tenue filo di vapore sollevarsi dal calderone, lo sguardo di Adair continuò a tornare sulla risma di fogli scritti a mano sulla scrivania. Di certo in quella pila c’erano formule molto più interessanti – e profittevoli – di quella per ottenere l’invisibilità per una notte. Il vecchio probabilmente sapeva come preparare filtri amorosi infallibili e amuleti capaci di procurare ricchezza e potere a chi li possedesse. E di certo qualsiasi alchimista sapeva come trasformare il ferro in oro. Anche se Adair non sapeva leggere le formule, non dubitava di poter scovare qualcuno che lo sapesse fare in cambio di una percentuale dei ricavi. Più ci pensava più si infervorava. Avrebbe potuto nascondere i fogli nella manica della sua veste e sgusciare oltre Marguerite, che da un momento all’altro si sarebbe alzata. Poi avrebbe camminato tutto il giorno, allontanandosi più che poteva dal torrione. Considerò brevemente l’idea di prendersi il cavallo, ma lì il suo coraggio si fermò. Rubare un bene prezioso come un cavallo era un reato capitale. Il vecchio avrebbe potuto reclamare legalmente la vita di Adair. Ma le formule... Anche se il vecchio fosse riuscito a rintracciare il suo servitore, probabilmente non avrebbe mai osato condurlo a giudizio davanti al conte. Il medico non avrebbe mai voluto che gli abitanti del villaggio venissero a sapere quanto in realtà fosse potente, o che il suo sapere esoterico era scritto su fogli che potevano essere rubati o distrutti. Adair sentì il cuore martellargli il petto, in un crescendo, finché non divenne impossibile ignorare la tentazione. Fu quasi un sollievo cedere. Adair arrotolò stretti tutti i fogli che osò prendere e se li infilò su per la manica. Proprio in quel momento Marguerite iniziò ad agitarsi. Prima di uscire, tolse il calderone dallo spiedo e lo lasciò a raffreddarsi sul focolare spento. Una volta fuori, scelse un percorso che conosceva bene, che l’avrebbe condotto in territorio ungherese, a una fortezza che i rumeni avrebbero esitato parecchio ad assaltare. Camminò per ore, maledicendo la propria impetuosità, perché non aveva pensato a portarsi dietro delle provviste. Quando avvertì i primi sintomi di debolezza, e il sole iniziava a levarsi in cielo, decise di aver camminato abbastanza e si rifugiò in un granaio nel mezzo di un campo. Era un posto desolato, immerso nel nulla, non c’era nemmeno bestiame in vista. Adair ritenne di essere giunto a distanza di sicurezza, nessuno sarebbe venuto a cercarlo lì. Si addormentò nel fieno da uomo libero. Fu svegliato da una mano stretta alla gola, che lo costrinse ad alzarsi in piedi e poi, inspiegabilmente, lo sollevò da terra. All’inizio Adair non vide chi fosse l’aggressore perché era notte fonda, ma quando i suoi occhi misero a fuoco, la sua mente si rifiutò di credere a ciò che vedeva. L’uomo che lo stava tenendo era magro... avvizzito... ma in meno di un minuto Adair capì che era il vecchio. Lo capì dal suo odore, un misto di zolfo e putrescenza. «Ladro! È così che ricambi la mia ospitalità? È così che ricambi la mia fiducia?» urlò il medico con voce rabbiosa, poi scagliò Adair a terra con tale forza che lo spedì sul fondo del granaio. Prima che quest’ultimo riuscisse a riprendere fiato, il vecchio gli era di nuovo addosso. Lo afferrò per le spalle e, ancora una volta, lo sollevò da terra come se niente fosse. Adair era in preda al dolore e alla confusione: il medico era un anziano; come poteva un vecchio debole come lui sollevarlo da terra con tanta facilità? Doveva essere un’illusione, un’allucinazione indotta dal colpo alla testa. Adair ebbe un solo minuto per pensarci prima che il vecchio lo scagliasse di nuovo a terra per poi iniziare a colpirlo e scalciarlo. I colpi erano tremendamente pesanti. La testa di Adair rimbombò di fitte di dolore e per un attimo il ragazzo ebbe la certezza di essere sul punto di svenire. Sentì che il vecchio lo sollevava e lo trasportava sulle spalle, avvertì l’aria sibilare tutto attorno a sé. Stavano viaggiando a una velocità impressionante, a cavallo, ma gli sembrava impossibile che il vecchio destriero fosse capace di raggiungere tali velocità. Doveva essere tutta un’illusione, si disse, prodotta da qualche elisir che il vecchio lo aveva costretto a bere mentre era svenuto. Era una cosa troppo diabolica, troppo spaventosa per essere reale. Ancora intontito, Adair sentì l’aria rallentare e i loro corpi riprendere il proprio peso. Poi lo assalirono gli odori: l’umidità muschiosa del torrione, i residui di erbe bruciate e di zolfo che ancora permeavano l’aria. Un terrore cieco si impadronì di lui. Cadendo per terra, dischiuse appena gli occhi e sprofondò nella disperazione quando vide che, sì, era davvero tornato nel torrione, era davvero tornato nella sua prigione. Il vecchio gli si avvicinò. Ma era diverso: forse era un’illusione ottica, dovuta alla sua posizione, ma gli sembrò più alto e più minaccioso, per nulla simile al vecchio medico che conosceva. La mano dell’uomo scattò ad afferrare l’attizzatoio. Poi si allungò per prendere la coperta malconcia dal letto di paglia di Adair. Lentamente, deliberatamente, il vecchio avvolse la coperta attorno all’attizzatoio e poi si avvicinò ancora di più a Adair. Adair vide il braccio alzarsi, ma distolse lo sguardo quando l’attizzatoio calò su di lui. La coperta attutì il colpo, impedendo al ferro di spezzare le ossa al ragazzo. Ma quei colpi erano di una violenza che Adair non aveva mai provato prima, ben diversi dai pugni e dagli schiaffi che aveva preso da suo padre, tutt’altra cosa rispetto alle nerbate o le cinghiate. La sbarra di ferro schiacciò i muscoli, frollandogli la carne fino a entrare in contatto con le ossa. Si abbatté su di lui ancora, e ancora, e ancora, sulla schiena, sulle spalle, sulla spina dorsale. Adair rotolò cercando di sfuggire ai colpi, ma l’attizzatoio lo raggiunse comunque sul costato, sullo stomaco, sulle gambe. Presto il ragazzo non sentì neppure più il dolore, incapacitato a muoversi, persino a rabbrividire mentre i colpi continuavano a piovergli addosso. Respirare era straziante, perché vampate di dolore incandescente gli aggredivano le costole a ogni respiro, e gli organi gli sembrarono liquefarsi come per la forza di un incendio. Stava morendo, ne era sicuro. Il vecchio l’avrebbe picchiato a morte. «Potrei tagliarti una mano, sai? È così che si puniscono i ladri. Ma a che cosa mi serviresti poi con una mano sola?» Il medico rimase in piedi, rigido, gettando finalmente da parte l’attizzatoio. «Forse ti mozzerò la mano quando avrai finito di servirmi, così che tutti sappiano che razza di ladro sei. O forse non ti libererò quando saranno trascorsi i sette anni che mi devi. Forse ti terrò per altri sette, come punizione per il tuo crimine. Come hai potuto pensare di sfuggirmi e di potermi portar via ciò che mi appartiene?» Le sue parole non fecero alcuna differenza. Il vecchio si illudeva, pensò Adair, a pensare che il suo servo sarebbe sopravvissuto. Non sarebbe arrivato vivo all’alba, figuriamoci altri sette anni. Un fiotto liquido gli percorse gli intestini e gli organi interni, risalendogli su per la gola, nella bocca. Il sangue gli sgorgò dalle labbra, finendo sul pavimento di legno per poi strisciare verso i piedi del vecchio in un rivolo denso e scuro. Gli usciva sangue da ogni orifizio. Adair sbatté gli occhi. Il vecchio aveva smesso di parlare e lo stava fissando con quello sguardo penetrante che gli era proprio. Si chinò, strisciando sul pavimento verso il ragazzo, come una lucertola o un serpente, attaccato a terra, finché non fu addosso a Adair, con la bocca aperta, la lingua in fuori che ondeggiava, esplorava. Intinse un dito lungo e ossuto nel rivolo di sangue che usciva dalla bocca di Adair. Un lungo filamento rosso colò dalla punta del dito mentre se lo portava alla bocca e lo leccava. Si passò la lingua sui denti e un leggero sospiro di piacere gli sfuggì dalle labbra. A quel punto Adair perse i sensi e fu grato per questo. Ma l’ultima cosa che vide, mentre perdeva conoscenza per quella che, ne era sicuro, sarebbe stata l’ultima volta, furono le dita del vecchio che gli carezzavano il volto e si infilavano nei suoi capelli intrisi di sudore e di sangue. 21 Quella mattina, Marguerite trovò Adair in condizioni orribili. Il corpo del ragazzo si era preparato a morire, quella notte: le sue viscere si erano svuotate, il sangue aveva inzuppato i suoi vestiti ed era colato sul pavimento, tanto che la schiena si era attaccata a terra e la governante dovette impiegare numerosi stracci imbevuti di acqua calda per riuscire a liberarlo. Giacque sul pagliericcio privo di conoscenza per parecchi giorni e quando si svegliò scoprì di essere cosparso di macchie nere e violacee, gialle e verdognole ai bordi, e che la pelle gli faceva male soltanto a sfiorarla. Ma in qualche modo Marguerite lo aveva ripulito da tutto il sangue ed era riuscita a mettergli addosso una vestaglia pulita. Adair continuò a riprendere conoscenza per poi perderla, con pensieri incoerenti che gli danzavano in mente. Ci fu anche un momento orribile in cui gli parve di sentire che qualcuno lo stava toccando, che delle dita gli stavano sfiorando il volto, le labbra. Un’altra volta gli sembrò che qualcuno lo facesse girare a pancia in giù e gli alzasse la vestaglia sulla schiena. Forse era Marguerite che lo puliva delicatamente, perché era impossibilitato ad alzarsi per usare il pitale. Non riusciva a muoversi e a fare resistenza, non poté far altro che accettare quella violazione della sua intimità, vera o immaginata che fosse. L’olfatto fu il primo senso a ricominciare a funzionare e Adair iniziò a riconoscere gli odori nell’aria, filtrati dal sapore metallico che sentiva sulla lingua, dovuto al sangue, e dal sapore gelatinoso del sego bovino. Quando aprì gli occhi, e ci volle qualche secondo prima che riuscisse a mettere a fuoco, prima di avere la certezza di non essere diventato cieco, ciò che lo circondava divenne reale e il dolore lo assalì nuovamente. Le costole gli dolevano, il ventre sembrava ridotto in poltiglia e le viscere liquefatte, e ogni respiro gli provocava fitte lancinanti. Ritrovò la voce solo perché non riuscì a impedirsi di urlare per la sofferenza. Scostò le coperte, cercando inutilmente di alzarsi. Marguerite si affrettò al suo capezzale e gli mise la mano sulla fronte, poi gli mosse i piedi e le mani, per capire se i movimenti gli provocavano fitte di dolore, segno di qualche frattura, e se quindi era ancora in grado di muoversi o aveva degli arti paralizzati. In fondo, a che cosa sarebbe servito se non fosse stato più in grado di muovere una gamba o un braccio? Gli portò del brodo e poi lo ignorò per il resto del pomeriggio mentre svolgeva le solite faccende. A lui non rimase che giacere lì a guardare il soffitto, misurando il trascorrere del tempo dallo spostamento di un riquadro di luce dal soffitto giù su una parete, contando alla rovescia le ore che lo separavano dal tramonto e dal risveglio del vecchio. Adair trascorse quel tempo in preda al terrore dell’attesa: sarebbe stato meglio morire la notte precedente, pensò, piuttosto che svegliarsi in un corpo così devastato. Quanto ci sarebbe voluto per riprendersi? si chiese. Sarebbe stato ancora in grado di muoversi bene, una volta guarite le sue ossa? Si sarebbero ricomposte bene le fratture o sarebbe stato zoppo o gobbo per il resto della sua vita? Per lo meno il suo volto sembrava essere stato risparmiato, non era sfigurato da cicatrici. Nella sua furia, il vecchio non l’aveva mai colpito alla testa; se l’avesse preso lì con l’attizzatoio, gli avrebbe spaccato il cranio in due. Quando il rettangolo di luce svanì, segnalando l’arrivo del tramonto, Adair capì che il suo tempo era scaduto. Decise di fingere di essere addormentato. Perfino Marguerite capì che stava per succedere qualcosa e si affrettò a preparare il giaciglio mentre il vecchio saliva le scale, ma il medico la interruppe, prendendola per il braccio e indicando Adair, per chiederle come stesse. La donna aveva visto Adair chiudere gli occhi e ricadere nel sonno, per cui si limitò a scuotere il capo e se ne andò a letto, tirandosi la coperta sulle spalle. Il vecchio si avvicinò al letto di Adair e si accovacciò. Adair cercò di mantenere il respiro regolare e calmo e di controllare il tremito, in attesa di capire che cosa avrebbe fatto il vecchio. Non dovette aspettare molto: la mano ossuta e gelida gli toccò le guance, poi il pomo d’Adamo, per poi scivolargli sul petto, velocemente, e fermarsi sul ventre piatto. Non fece altro che sfiorare i suoi lividi, eppure Adair riuscì a stento a non raggomitolarsi per il dolore. La mano però non si fermò; passò sull’addome e poi ancora più in basso, e Adair fu quasi sul punto di urlare dal male. In qualche modo, però, riuscì a rimanere stoicamente immobile quando le dita del vecchio trovarono quello che stavano cercando e iniziarono a carezzare, a massaggiare, a muoversi con decisione. Ma prima che il membro di Adair rispondesse agli stimoli, le dita si ritirarono e, senza degnarlo di uno sguardo, il vecchio aprì la porta del torrione e uscì nella notte. Il panico che assalì Adair fu quasi sufficiente a indurlo ad alzarsi dal letto, nonostante le sue condizioni. Fu assalito dall’impellenza di fuggire ma non poteva, non riusciva a controllare le braccia e le gambe non gli rispondevano nemmeno. Il vecchio era molto più forte di quel che sembrava; Adair era inerme al suo cospetto già quando era in piena salute; in quelle condizioni sarebbe stata impossibile qualsiasi resistenza. Umiliato e disperato, Adair si rese conto che non c’era niente che potesse fare per salvarsi, non in quel momento. Non poteva far altro che sopportare qualsiasi cosa il medico decidesse di infliggergli. Trascorse i giorni seguenti ripensando al lavoro che aveva svolto per il medico, agli elisir e agli unguenti che aveva preparato, chiedendosi se per caso fra di essi ci fosse qualcosa che avrebbe potuto impiegare per difendersi. Erano progetti senza speranza, anche se servirono per aiutarlo a memorizzare gli ingredienti di quei potenti elisir: le dosi, quale odore avessero, la consistenza. Ma non sapeva a che cosa servissero tutte quelle misture. Tranne una. Quella dell’invisibilità. Riuscì a fingere incoscienza per altri due giorni, poi il medico scoprì il suo gioco. Gli saggiò gli arti e le giunture esattamente come aveva fatto Marguerite, poi preparò una pozione e gliela fece colare in bocca. Fu quell’elisir a scoprire il gioco di Adair, perché era amara e bollente e gli provocò le convulsioni. «Mi auguro che tu abbia imparato la lezione, così che dal tuo inganno almeno ne venga fuori qualcosa di buono» ringhiò il medico avvicinandosi alla scrivania. «E la lezione è questa: non riuscirai mai a scappare da me. Ti troverò ovunque andrai. Non potrai mai allontanarti abbastanza, non c’è posto al mondo in cui tu possa nasconderti da me. La prossima volta che cercherai di sfuggirmi con l’inganno e di sottrarmi un servizio per il quale ho pagato o di rubare ciò che è mio e solo mio, questo piccolo episodio, al confronto, ti parrà una punizione leggera. Se solo avverto che sei sleale con me, ti incateno al muro di questo torrione e tu non vedrai mai più la luce del giorno. Sono stato chiaro?» Il vecchio non sembrava minimamente disturbato dallo sguardo d’odio puro di Adair. Dopo qualche settimana, Adair riuscì ad alzarsi dal letto e zoppicare per la stanza con l’aiuto di un bastone. Siccome le costole gli scricchiolavano ogni volta che tentava di alzare un braccio, il ragazzo non poteva aiutare Marguerite nei suoi mestieri, ma riusciva ad assistere il medico la sera. Comunque, ogni conversazione fra di loro cessò: il vecchio abbaiava i suoi ordini e Adair faceva in modo di uscire dal suo campo visivo non appena li aveva eseguiti. Dopo un paio di mesi, con dosi regolari della pozione ustionante, Adair era guarito prodigiosamente, al punto tale che riusciva a prendere l’acqua dal pozzo e a tagliare la legna. Poteva correre, anche se non per molto, ed era sicuro di poter di nuovo cavalcare, se si fosse presentata l’opportunità. A volte, mentre raccoglieva erbe nella foresta e si spingeva fino al limitare della collina, guardava l’ampia vallata verde e gli balenava in testa la tentazione di riprovare a scappare. Non desiderava altro che essere libero dalle grinfie del vecchio, eppure... La nausea lo assaliva alla sola idea di essere punito di nuovo e, pervaso da pensieri suicidi, tornava al torrione. «Domani devi andare al villaggio e trovare una ragazza molto giovane. Dev’essere vergine. Non devi chiedere informazioni a nessuno, e fai in modo di non attirare l’attenzione. Limitati a individuare la ragazza, poi torna e dimmi dove abita.» Il panico lo prese alla gola. «Come faccio a sapere se una ragazza è vergine? Devo forse esaminarle...» «Ovviamente devi trovarne una molto, molto giovane. Ma, come per ogni esame, sarò io a farlo» disse con tono raggelante. Il vecchio non gli diede altre spiegazioni e, ormai, Adair non ne aveva bisogno. Sapeva per certo che ogni ordine del medico era animato dal male più assoluto, ma non poteva certo opporsi. Di solito, recarsi al villaggio era una rara distrazione: poteva cogliere scampoli di vita familiare, anche se non della sua famiglia... Ma quel viaggio evocava soltanto cattivi presagi. Giunto al villaggio, Adair indugiò vicino alle case cercando di non farsi notare, per spiare gli abitanti. Ma era un piccolo villaggio e loro lo conoscevano. Non appena individuava dei bambini che giocavano o svolgevano qualche incombenza domestica, i genitori li portavano via o gli rivolgevano occhiate minacciose. Temendo la reazione del medico al suo fallimento, Adair prese un sentiero che non conosceva per tornare indietro al torrione, sperando che gli portasse fortuna. La strada lo condusse a una radura in cui, con sua somma sorpresa, si trovavano alcuni carrozzoni non molto diversi da quello in cui aveva vissuto con la sua famiglia. Un gruppo di zingari era giunto al villaggio e il cuore di Adair si gonfiò di speranza; forse la sua famiglia era venuta a cercarlo. Ma aggirandosi fra i braccianti, si accorse di non conoscerne nessuno. C’erano bambini di tutte le età, comunque, maschietti con le guance rosee e femminucce dal viso grazioso. E poiché lui era della stessa razza, poteva mescolarsi liberamente a loro, anche se nessuno lo conosceva. Sarebbe davvero riuscito a compiere un atto così diabolico? si chiese, col cuore che gli rimbombava nelle orecchie, scrutando i volti che lo circondavano. Stava per darsi alla fuga, sopraffatto dalla ripugnanza verso se stesso – come poteva scegliere la vittima da consegnare nelle mani di quel mostro? – quando andò a sbattere contro una bambina, una ragazzina che gli ricordò tantissimo la sua Katarina, la prima volta che l’aveva incontrata. La stessa pelle bianca come il latte, gli stessi occhi scuri e penetranti, lo stesso sorriso attraente. Fu come se fosse stato il fato a prendere la decisione, non lui. L’istinto di sopravvivenza prevalse. Il medico si rallegrò alla notizia e diede ordine a Adair di tornare all’accampamento degli zingari quella sera, quando tutti dormivano, prendere la ragazza e portargliela. «È un segno del destino, no?» lo derise il vecchio, pensando che forse Adair avrebbe così accettato meglio quello che stava per fare. «La tua gente ti ha venduto, ti ha cacciato via senza un attimo di esitazione. Adesso hai l’occasione di vendicarti.» Ma invece di convincere Adair che era suo pieno diritto rapire la ragazza, quel ragionamento non fece altro che farlo infuriare. «Perché vi serve quella ragazza, padrone? Che cosa ne farete di lei?» «Non hai alcun diritto di pensare. Devi soltanto obbedire» ringhiò il vecchio in risposta. «Hai appena cominciato a guarire, giusto? Sarebbe un peccato romperti di nuovo le ossa.» Il ragazzo pensò di pregare Dio perché intervenisse, ma in quel momento le preghiere erano inutili. Adair aveva tutte le ragioni di credere che lui e la ragazza fossero condannati dal fato e che niente avrebbe potuto salvarli. Perciò attese la sera e tornò all’accampamento. Passò di carrozzone in carrozzone, spiando dalle finestre o dal riquadro di vetro delle porte finché non individuò la ragazza, che dormiva accoccolata come un gattino su una coperta. Trattenendo il fiato, aprì la porta, entrò e prese la ragazza, quasi sperando che urlasse e svegliasse i genitori, anche se ciò avrebbe voluto dire che sarebbe stato colto sul fatto. Ma la ragazzina continuò a dormire fra le sue braccia, come in preda a un sortilegio. Adair corse via. Dall’accampamento non provenne alcun rumore: nessun passo, nessun suono di alcun tipo dall’interno del carrozzone dei genitori, nessun allarme dall’accampamento. La ragazza iniziò ad agitarsi fra le sue braccia e Adair non trovò di meglio da fare per acquietarla che stringerla ancora più stretta al cuore che sembrava scoppiargli in petto, sperando così di calmarla. Rimpiangendo di non avere il coraggio di disobbedire agli ordini demoniaci del vecchio, Adair attraversò di corsa i boschi, piangendo per tutto il tempo. Eppure, quando fu in vista del torrione, un coraggio nato dalla disperazione si impossessò di lui. Non poteva portare a compimento quell’ordine, non gli importava come avrebbe pagato la sua disobbedienza. I piedi rallentarono l’andatura, quasi di volontà propria, e in pochi passi aveva fatto dietrofront. Quando raggiunse il limitare della radura, la ragazza si era svegliata, anche se restava in silenzio, con una strana espressione di fiducia in volto. Adair la calò gentilmente a terra e si inginocchiò di fianco a lei. «Torna dai tuoi genitori. Di’ loro che devono andar via subito, immediatamente, da quel villaggio. C’è un male oscuro all’opera qui, e una disgrazia si abbatterà su di voi se non seguite il mio avvertimento» le disse. Lei alzò una mano e gli sfiorò le lacrime sulle guance. «A nome di chi devo portar loro questo messaggio?» «Il mio nome non è importante» rispose lui, ben sapendo che se anche gli zingari avessero conosciuto il suo nome e fossero tornati a cercarlo, con l’intenzione di punirlo per essersi introdotto di nascosto nel loro accampamento per rapire una bambina, non l’avrebbero certo trovato. A quel punto, sarebbe già stato ucciso. Adair rimase inginocchiato nell’erba e guardò la ragazzina correre indietro, verso il suo carrozzone. Avrebbe voluto correre anche lui, correre verso la foresta e continuare a correre, ma sapeva che non sarebbe servito a niente. Tanto valeva tornare al torrione e accettare la sua punizione. Quando Adair aprì la porta del torrione, trovò il vecchio seduto alla sua scrivania. L’aspettativa dipinta sul volto del medico lasciò subito il posto alla solita espressione di disprezzo e delusione quando si rese conto che Adair era da solo. Il medico si alzò e all’improvviso sembrò più alto e imponente, come una quercia. «Mi hai deluso, a quanto pare. Non posso dire di essere sorpreso.» «Sarò anche il vostro schiavo, ma non sarò mai un assassino. Non lo farò mai!» «Sei ancora debole, molto debole. Sei un codardo. Ho bisogno che tu sia più forte di così. Se fossi convinto che non potrai mai esserlo, ti ucciderei stanotte stessa. Ma non ne sono convinto. Non ancora, almeno... Perciò, stanotte non ti ucciderò, no. Mi limiterò a punirti.» Il medico colpì il suo servitore con tanta forza che Adair cadde a terra e svenne. Quando tornò in sé, si rese conto che il vecchio gli teneva sollevato il capo e gli puntava un calice alla bocca. «Bevilo.» «Cos’è, veleno? È così che mi ucciderete?» «Ti ho già detto che non ti ucciderò stanotte. Questo non vuol dire che io non abbia altri piani in mente. Bevilo!» ripeté con forza, guardandolo con occhi di brace mentre Adair sbirciava dentro la tazza. «Bevilo e non sentirai dolore.» Adair avrebbe bevuto volentieri del veleno, a quel punto, perciò inghiottì il liquido che il medico gli versò in bocca. Una strana sensazione lo pervase rapidamente, non troppo diversa dallo stordimento che gli avevano provocato le pozioni curative del vecchio. Iniziò con un formicolio agli arti, poi in tutto il corpo. Impossibilitato a controllare i propri muscoli, Adair si abbandonò a terra, le palpebre pesanti come se fosse in preda alla paralisi, il respiro affannato. Quando il formicolio giunse alla nuca, un ronzio assordante gli fece capire che stava per accadere qualcosa di soprannaturale. Il vecchio rimase in piedi davanti al suo servitore, valutando la situazione con occhi gelidi, inquietanti. Poi Adair sentì che veniva sollevato e portato via, avvertì il proprio corpo rimbalzare a ogni passo. Giù, giù dalle scale, nel sotterraneo in cui non era mai stato prima, nella camera del vecchio, e quando si rese conto di dov’era Adair fu avvolto da un terrore cieco. Era un posto freddo, l’aria era stantia. Una vera e propria prigione, immonda. I vermi si aggrovigliavano negli angoli. Il vecchio adagiò il giovane su un giaciglio, un vecchio materasso maleodorante e ammuffito. Adair avrebbe voluto strisciare via, ma era intrappolato in un corpo che non rispondeva ai suoi comandi. Per nulla imbarazzato, il vecchio salì sul letto e iniziò a spogliare il suo prigioniero, alzandogli la veste sopra la testa, slacciandogli la cintura. «Stanotte hai oltrepassato il limite. Da stanotte, non ci sarà niente che non farai per me. Ti darai a me, completamente, e non ti farai più stupide illusioni.» Abbassò le brache del giovane e afferrò la biancheria che gli copriva l’addome. Adair chiuse ancora una volta gli occhi. Il vecchio frugò con le dita fra i suoi peli pubici. Adair si sforzò di combattere l’erezione mentre il vecchio gli manipolava il pene. Dopo quello che gli parve un lunghissimo tempo, il vecchio mollò la presa e portò le mani al volto di Adair. Gli premette le guance, poi la pelle sotto gli occhi. Il giovane cercò di opporsi come poteva, narcotizzato com’era, a quell’orrenda violazione. «Adesso, caro il mio stupido ragazzo... Se non mi obbedirai, ti soffocherò. Devi pur respirare, dico bene?» Serrò una mano sul naso di Adair, togliendogli l’aria. Adair trattenne il fiato più che poté, chiedendosi nel suo stordimento se sarebbe soltanto svenuto o forse morto... Ma, alla fine, i riflessi presero il sopravvento e aprì la bocca in cerca d’aria. Quando la aprì, il vecchio la violò. Grazie al cielo, la droga iniziò a rendere incoerente l’orrore che gli stava accadendo e l’ultima cosa che avrebbe ricordato in seguito sarebbe stata il vecchio che gli diceva di sapere tutto dei suoi rapporti con Marguerite e che sarebbero terminati. Non avrebbe più permesso che Adair sprecasse la sua energia e il suo seme con un’altra persona. 22 La mattina dopo Adair si svegliò al piano superiore, sul suo solito giaciglio di paglia, con i vestiti arruffati. La nausea lo assalì subito, anche per via della droga che era stato costretto ad assumere. Ricordava gli avvertimenti del vecchio, ma non aveva alcuna idea delle libertà che si fosse preso in seguito. Ebbe la tentazione di correre giù e di pugnalare a morte il vecchio nel suo letto: l’idea gli balenò in mente per non più di un secondo. Sapeva che era all’opera qualcosa di soprannaturale, di arcano: i poteri del vecchio andavano oltre ogni ragionevole aspettativa e quindi non sarebbe stato certo possibile ucciderlo così. Trascorse il giorno tentando di trovare il coraggio di scappare. Ma un terrore ormai familiare lo teneva incatenato a quel luogo. Un dolore freddo e sordo alle ossa gli rammentava il prezzo della disobbedienza. Perciò, quando il sole ebbe percorso l’arco del cielo e iniziò a calare l’oscurità, Adair si accucciò in un angolo, lo sguardo puntato verso la scalinata. Il vecchio non fu sorpreso di trovare il suo servitore ancora lì. Un ghigno feroce gli comparve in volto, ma non si avvicinò a Adair. Si occupò delle sue faccende come al solito e poi prese il mantello dal gancio. «Andrò al castello stanotte, per un incarico speciale. Se sai cos’è meglio per te, se davvero l’hai capito, al mio ritorno ti troverò qui.» Quando uscì, Adair si accasciò accanto al focolare, rimpiangendo come non mai di non avere il coraggio di gettarsi fra le fiamme. La vita proseguì a quel modo per mesi e mesi. Le punizioni corporali divennero una routine, anche se il vecchio non usò più l’attizzatoio. Adair capì ben presto che i pestaggi non erano legati a specifiche ragioni; era così sottomesso che non ve n’era alcun motivo. Servivano soltanto per mantenerlo al suo posto e perciò non sarebbero mai terminati. Anche le molestie proseguirono, sporadicamente. Il medico faceva in modo che Marguerite mettesse la droga nel cibo di Adair o nell’acqua per agevolare la cosa, ma un giorno il giovane se ne accorse e iniziò a rifiutare il cibo. A quel punto il vecchio lo picchiò e lo costrinse a bere la pozione narcotizzante, fino a ridurlo all’impotenza. Poi anche la perversione del medico accelerò. Forse aveva rotto qualche argine invisibile: ora che si abbandonava ad atti così immorali ed empi, non c’era modo di fermarlo. O forse il vecchio era sempre stato così. Adair si domandava se non avesse ucciso il suo precedente servitore e non fosse andato a cercare lui perché ne prendesse il posto. Il conte iniziò a mandare una servetta al vecchio, di tanto in tanto, perché lui ne abusasse. Qualche sfortunata ragazzina, catturata dagli uomini del conte durante le loro razzie in territorio ungherese. La ragazza di turno veniva condotta nel sotterraneo del medico e incatenata al letto. Le sue urla salivano per tutto il giorno al piano superiore, tormentando Adair, punendolo perché non scendeva nella tana del medico a liberarla. A volte, dopo che il vecchio era uscito per i suoi vagabondaggi notturni, Marguerite mandava Adair di sotto con del cibo per la povera prigioniera. La prima volta che accadde non se la sarebbe dimenticata per il resto della sua vita. Riluttante, si era introdotto quasi strisciando nella camera e aveva visto la poveretta, nuda sotto le lenzuola, tremante di terrore e incapace di rendersi conto della sua presenza. Non chiese al giovane di liberarla. Paralizzata dalla paura, non si avvicinò nemmeno al cibo. Adair si vergognò di scoprirsi eccitato, lo sguardo impossibilitato ad allontanarsi dalle forme femminili affusolate che si intuivano sotto le coperte, il ventre piatto che si gonfiava e sgonfiava a ogni respiro intriso di terrore. Nonostante la compassione per le sue disgrazie e gli orribili ricordi di quanto era accaduto a lui stesso in quel letto, non riuscì a impedirsi di provare desiderio. Lussuria. Non osò violentarla solo perché era di proprietà del vecchio, perciò, pur tremante di desiderio, non la sfiorò neppure e tornò di sopra. Le ragazze di solito morivano entro tre giorni e il vecchio lasciava che fosse Adair a occuparsi del cadavere. Toccava a lui sollevare le membra fredde dal letto e trasportarle nella foresta. Giacevano a terra come statue cadute mentre lui scavava la fossa, quindi le interrava, le copriva di calce viva e poi di terra scura. La morte della prima ragazza lo riempì di vergogna, di odio per se stesso e di disperazione, tanto che non la guardò nemmeno mentre le scavava la fossa. Ma dopo la seconda, e poi la terza, la quarta, Adair scoprì che qualcosa in lui era cambiato e che il suo desiderio – che riconosceva essere abominevole – aveva ormai superato la paura di commettere qualcosa di profano. Con mani tremanti, si arrese al desiderio di toccare quei seni o passare la mano sui loro corpi. Ogni volta che doveva prenderne in braccio una per seppellirla, il petto del cadavere lo toccava e con un brivido lui avvertiva la reazione del proprio corpo. Ma non si spinse mai oltre, non commise mai quell’atto che ancora trovava più repellente che affascinante, perciò a quei corpi furono risparmiate ulteriori molestie. Trascorsero diversi anni a questo modo. I pestaggi e gli stupri si diradarono, forse perché Adair era diventato più forte e più muscoloso negli anni e questo dava meno coraggio al vecchio. O forse la ragione era che ormai non era più un ragazzino e il medico non era più attratto da lui. Dopo un inverno particolarmente freddo e rigido, il vecchio annunciò che si sarebbero recati in Romania in visita alle sue proprietà. Fu mandato un messaggio al suo vassallo, quello che amministrava in sua vece le sue terre, affinché preparasse i conti e sistemasse tutto per l’arrivo del medico e per la sua ispezione. Il conte accordò il permesso di partire, e fu acquistato un secondo cavallo, così che Adair potesse montarlo per il lungo viaggio. Quando giunse il momento di partire, si portarono poche provviste, qualche vestito e due piccoli bauli chiusi a chiave. Si misero in cammino dopo il tramonto, dirigendosi a oriente nel cuore della notte. Dopo sette notti di viaggio, erano nel cuore del territorio rumeno. Avevano attraversato un passo alle pendici dei Carpazi per giungere alla tenuta del vecchio. «Il nostro viaggio è terminato» annunciò il medico a Adair, indicando con un cenno il tenue bagliore che proveniva da un castello poco distante. Il castello era munito di alte torrette agli angoli di un quadrato di mura. Il profilo minaccioso era nitidamente visibile alla luce della luna. L’ultimo tratto di cammino li condusse attraverso campi fertili, vigneti aggrappati ai fianchi delle montagne, bestiame addormentato nelle radure. Gli imponenti cancelli si aprirono all’arrivo dei due; una consorteria di servitori li attendeva nel cortile, con le torce sollevate sopra il capo. Alla testa del gruppetto c’era un uomo più anziano, con una pelliccia che avvolse attorno alle spalle del vecchio non appena scese da cavallo. «Il signore ha fatto buon viaggio, mi auguro» disse con la solerzia di un prete, seguendo il medico su per gli ampi gradini di pietra. «Sono qui, ora, no?» rispose bruscamente il vecchio. Adair colse ogni dettaglio della proprietà mentre entravano. Il castello era imponente, molto vecchio ma ben tenuto. Adair notò che tutti i servitori avevano negli occhi lo stesso sguardo di terrore che era convinto di avere anche lui. Un servitore lo prese per un braccio e lo condusse alle cucine, dove gli diede una portata di carne alla brace e di pollame; poi lo portarono in una piccola camera. Quella notte, per la prima volta da tanto tempo, dormì su un vero e proprio materasso di piuma, sotto coperte orlate di pelliccia. Adair arrivò ad amare quel periodo lontano dal torrione. Viveva nello sfarzo, più di quanto avesse immaginato per chiunque, figuriamoci per un contadinotto come lui. Libero dal regime di schiavitù che aveva subito nel torrione, trascorreva la maggior parte dei giorni a vagare per il castello, mentre il medico era impegnato nell’amministrazione della proprietà e pareva aver perso ogni interesse per lui. Il custode, Lactu, se lo prese a cuore. Era un uomo gentile e sembrava aver riconosciuto il fardello inespresso che il servitore del medico portava. Dato che Lactu parlava anche ungherese, Adair, per la prima volta da quando era stato ceduto al vecchio, poté fare una vera conversazione. Lactu discendeva da una stirpe di servitori che da generazioni lavoravano per il medico. Gli spiegò di non ritenere strano che il medico fosse lontano per la maggior parte del tempo: i signori di quella proprietà erano padroni assenti da generazioni; per tradizione, andavano a servizio del re di Romania. Nell’esperienza di Lactu, il medico tornava all’incirca ogni sette anni per prendersi carico delle faccende più importanti. Tramite il custode, Adair ebbe accesso a tutte le camere «speciali» del castello. Poté così vedere la stanza in cui erano conservati gli abiti da cerimonia del vecchio, ammassati in varie casse, e la dispensa, con file e file di damigiane contenenti vino fatto proprio in quella tenuta. Quella che lo riempì di meraviglia, tuttavia, fu la camera del tesoro, in cui erano raccolti tutti i beni accumulati dalla dinastia dei cel Rau in anni di conquista: corone e scettri, gioielli con pietre preziose incastonate, monete di ogni tipo. Alla vista di tutti quei tesori e quelle ricchezze, Adair ripensò alle formule alchemiche scritte dal vecchio... Quell’enorme castello così lontano era uno spreco. Era un crimine possedere un tesoro così vasto e non farne uso. Passarono settimane in cui Adair incontrò raramente il medico. Ma una notte, il vecchio convocò Adair perché assistesse a una cerimonia nel salone centrale. Il giovane lo osservò firmare editti che avrebbero vincolato chiunque vivesse nella sua tenuta. Accanto alla sua mano destra c’era un pesante sigillo: Lactu prendeva ciascun proclama, lo leggeva ad alta voce e poi posava il foglio davanti al medico, perché apponesse la sua firma. Poi il custode faceva colare della cera scarlatta sotto la firma, e il vecchio imprimeva il sigillo con lo stemma familiare: un dragone che brandiva una spada. In seguito Lactu spiegò a Adair che era quel sigillo a tramandare il dominio dei cel Rau: siccome i signori spesso morivano lontano dalla loro tenuta e senza aver nominato i propri eredi davanti alle autorità rumene, o anche solo con la testimonianza del custode, la firma da sola non aveva alcun valore. Chiunque fosse in possesso del sigillo veniva riconosciuto come proprietario della tenuta. Le settimane diventarono mesi. E Adair sarebbe stato ben contento di non tornare in Ungheria. Si godeva un duplice beneficio: essere trattato come un figlio prediletto e non dover più subire le attenzioni del medico. Durante il giorno, se non aveva altre incombenze, si esercitava nella scherma con le guardie, o faceva cavalcate nei borghi circostanti per osservarne i costumi. Discuteva con Lactu di ciò che aveva visto, approfondendo così la sua conoscenza della tenuta e dei suoi molti aspetti, come la coltivazione delle terre, la produzione del vino, l’allevamento del bestiame. Adair sapeva che il custode aveva per lui un occhio di riguardo, eppure non osò mai confessargli i dettagli della sua vita al torrione. Ricambiava l’affetto dell’uomo, ma ne temeva il giudizio, qualora fosse venuto a conoscenza dei tormenti che aveva sopportato, o se avesse scoperto che aveva assistito il vecchio nella pratica delle arti oscure. Avrebbe tanto voluto svelare a Lactu la natura malvagia del loro padrone, ma non riusciva a trovare un modo di farlo senza parlare di sé, e non voleva perdere l’affetto di Lactu. Una notte, a stagione inoltrata, Adair fu svegliato da una presenza nella sua camera. Mentre accendeva una candela sapeva di non essere da solo, ma fu comunque spaventato quando vide il medico ai piedi del suo letto. Il cuore gli batté forte al ricordo degli orrori di cui era capace il vecchio. «Padrone, mi avete colto di sorpresa. Avete bisogno dei miei servigi?» «È da tanto che non ti vedo, Adair. Volevo guardarti... Ma giuro che quasi non ti riconosco più» disse, con il solito tono di voce simile a un basso ringhio. «Vivere qui ti fa bene. Sei cresciuto. Sei più alto e più forte.» Nel suo sguardo balenò un’eco delle antiche tentazioni, uno sguardo che Adair non avrebbe più voluto vedere. «Ho imparato molto durante questo soggiorno» disse Adair, volendo dimostrare al medico che non aveva approfittato del tempo libero per oziare. «La vostra tenuta è magnifica. Non riesco a capire come facciate a starne lontano.» «La vita qui è troppo tranquilla per i miei gusti. Credo che, col tempo, anche tu arriveresti a pensarla così. Ma sono venuto da te stanotte per dirti che non rimarremo qui ancora a lungo. L’estate si sta avvicinando rapidamente e in Ungheria hanno bisogno di me.» Le parole del vecchio allarmarono Adair. Aveva sempre saputo che il tempo lì sarebbe finito prima o poi, ma si era concesso di sognare che sarebbe durato per sempre. Adair cercò di non mostrare il panico mantenendo un’espressione ferma. Nel frattempo, il vecchio si avvicinò al letto per scrutarlo da vicino. Afferrò le coperte e le sfilò, rivelando il petto e l’addome di Adair. Adair si irrigidì, attendendo l’orrendo tocco del vecchio, che però non giunse. Invece, il vecchio si limitò a osservarlo, famelico. Si accontentò di guardarlo, perlustrando però con gli occhi ogni centimetro del suo giovane corpo. Forse si fermò perché vide che Adair era molto cresciuto. In ogni caso, dopo un minuto si voltò e uscì dalla stanza, in silenzio. 23 Tornati al torrione del vecchio, Adair si aspettava che la vita sarebbe andata avanti come prima, ma questo si rivelò subito impossibile. Troppe cose gli erano accadute. Lo possedeva un’idea che non riusciva a scacciare dalla testa, specialmente durante il giorno quando il medico non era lì a dominare i suoi pensieri. Adair non riusciva a dimenticare quello che aveva visto alla tenuta del padrone: il massiccio castello, i campi rigogliosi, il tesoro, i servitori, i servi della gleba... Mancava soltanto un signore che governasse il tutto, e sulla sua strada c’erano soltanto due cose: il sigillo, nascosto da qualche parte nel torrione, e la morte del vecchio. Il sigillo poteva trovarlo, se avesse cercato bene. Ma uccidere il vecchio era tutt’altra faccenda. Adair ci aveva pensato più volte nei suoi anni di prigionia, aveva esaminato qualunque ipotesi in ogni dettaglio, ma aveva sempre rinunciato. Era un’impresa disperata. Ogni volta che il vecchio gli aveva messo le mani addosso, per rabbia o per desiderio, il servitore aveva represso la vergogna e l’umiliazione giurando a se stesso che un giorno gliel’avrebbe fatta pagare. Ma era il ricordo del brutale pestaggio con l’attizzatoio e dei mesi di agonia che ne erano seguiti a trattenerlo. Tuttavia erano passati anni da quell’episodio e Adair era cresciuto molto. Il medico ora esitava prima di picchiarlo e, anche se continuava a guardarlo con desiderio, i suoi approcci erano più rari e più calcolati. Adair odiava quell’uomo da lungo tempo, ormai; un odio che era diventato parte di lui, come il respirare. I suoi pensieri diventarono sempre più ossessivi, il bisogno di vendicarsi sempre più feroce e impossibile da trattenere. Non si era reso conto di quanto fosse cambiato finché, una sera, non si trovò a dover seppellire un’altra giovanetta morta. Guardò il suo corpo delizioso e si rese conto che anche l’ultimo tabù era crollato. Avrebbe potuto facilmente accanirsi contro quel cadavere, ma quello che desiderava veramente era accanirsi contro il corpo senza vita del medico prima di seppellirlo nel terreno umido. E, soprattutto, avrebbe gioito nel farlo. Non avrebbe provato alcuna paura, alcuna repulsione. Aveva perso l’ultimo briciolo di umanità che gli era rimasto. Ogni resistenza era scomparsa, strappata via uno strato alla volta, come per un animale scuoiato da un cacciatore esperto. Era pronto a scontrarsi con il vecchio, e quel pensiero gli fece provare il primo empito di felicità dopo anni e anni. Per prima cosa decise di non agire da solo. Adair aveva bisogno di trovare l’appoggio degli abitanti del villaggio che già odiavano il medico, alleato dell’oppressore rumeno. Sarebbe bastato individuare quelli che odiavano maggiormente il loro padrone e indirizzarli a scatenare la loro furia sul vecchio, un bersaglio più facile del conte. Se fosse riuscito a dimostrare che il medico aveva commesso dei crimini contro gli abitanti del villaggio, crimini che il conte non avrebbe potuto giustificare, a quel punto il conte stesso sarebbe stato costretto a farsi da parte, anche nel caso in cui la vendetta avesse assunto la forma dell’esecuzione. Si trattava di trovare le persone giuste, scegliere il crimine giusto, e trovare le prove necessarie per incastrare il vecchio. Un giorno, Adair andò nel villaggio in cerca delle autorità religiose. Gli sembrava l’approccio migliore. Nel monastero trovò un giovane monaco che, risparmiato dai lavori nei campi, aveva ancora la pelle rosea come quella di un neonato. L’uomo sembrò sorpreso di trovarsi di fronte il servo del maledetto medico, ma quando Adair si gettò ai suoi piedi, implorando il suo aiuto, il giovane monaco non poté rifiutare. Si sedettero uno accanto all’altro, soli nel monastero, e il monaco ascoltò Adair confessargli i suoi rimorsi poiché era il servitore dell’oppressore del villaggio. Adair spiegò di essere stato costretto a servirlo, contro la propria volontà. Poi, senza indugiare sui dettagli, espresse tutta la sua disperazione per essere costretto a eseguire gli ordini di un despota così empio e malvagio. Quando il monaco iniziò a rassicurarlo – con esitazione, sulle prime, ma poi con parole sempre più convinte – Adair capì di aver trovato l’alleato di cui aveva bisogno. Come tocco finale, allora accennò agli oscuri peccati che il medico e il conte avevano commesso. Il monaco gli disse che poteva tornare quando voleva, ogni volta che avesse avuto bisogno di sgravarsi la coscienza. E così fece Adair. La seconda volta che andò dal monaco, gli raccontò di come il medico lo avesse costretto a rapire una bambina. Il monaco impallidì paurosamente e indietreggiò orripilato, come se avesse di fronte una vipera. Adair descrisse il punto in cui si erano accampati gli zingari e il monaco confermò che un giorno erano spariti di colpo, senza alcuna spiegazione. «Sono convinto che intendesse usare la bambina per una delle sue pozioni infernali, ma a che scopo e per quale motivo non saprei dirlo. Dev’esserci lo zampino del diavolo in persona, perché sia necessario un sacrificio umano, vero?» domandò Adair in tono incredulo, cercando di sembrare il più innocente e ingenuo possibile. A quel punto, il monaco lo implorò di fermarsi. Si rifiutava di credere a quel racconto. «Giuro che è tutto vero» disse Adair, inginocchiandosi. «Posso portare delle prove. Posso portare le pergamene su cui sono scritti gli incantesimi. Basterebbero come prova?» Il monaco, sconvolto, riuscì soltanto ad annuire. Adair sapeva che sarebbe stato abbastanza semplice trafugare le formule dal torrione durante il giorno, mentre il medico dormiva, ma l’indomani, quando si preparò a raccogliere le prove, scoprì che gli tremavano le mani. Non essere stupido, si rimproverò. Sono passati anni. Sei un uomo o soltanto un ragazzino spaventato? Stufo di essere tormentato dalla paura e dall’umiliazione, afferrò i fogli con decisione, li arrotolò stretti e se li infilò su per la manica. Senza dire una parola a Marguerite, si diresse verso il monastero. Gli occhi del giovane monaco si illuminarono quando lesse le parole sbiadite sulla pergamena. Si scusò con Adair per aver dubitato delle sue parole e gli restituì i fogli, consigliandogli di riportarli rapidamente al torrione e di avvertirlo nel caso in cui il medico iniziasse a pianificare un altro orrendo crimine. In ogni caso, aveva bisogno di tempo. Bisognava elaborare un piano per catturare l’eretico che, dopotutto, era un alleato del loro signore. Adair protestò: il medico era alleato del diavolo in persona e non meritava un solo altro giorno di libertà. Ma la risoluzione del monaco era vacillante; evidentemente faticava a trovare il coraggio di compiere una mossa così azzardata contro il conte. Per rinsaldare la sua decisione, Adair gli promise di tornare con altre prove di stregoneria. Quella sera, rimanere accanto al medico fu un’agonia. Adair sussultava ogni volta che il vecchio gli lanciava un’occhiata, sicuro che si sarebbe accorto che lui aveva toccato le sue preziose pergamene. Mentre il vecchio frugava tra i fogli in cerca della formula di cui aveva bisogno, Adair tremava, certo che il vecchio avrebbe trovato qualcosa fuori posto: un angolo piegato, una macchia, l’odore di lavanda e di incenso del monastero. Ma il vecchio proseguì tranquillamente con il suo lavoro. Poco dopo mezzanotte, il vecchio alzò lo sguardo dal tavolo di lavoro. «Vuoi ancora imparare a leggere, ragazzo?» chiese in tono gentile. Adair trovò sospetto che il vecchio tirasse fuori quell’argomento, così all’improvviso. Eppure, se Adair avesse risposto diversamente, il vecchio si sarebbe accorto che qualcosa non andava. Perciò disse: «Certamente, padrone». «Tanto vale cominciare stanotte. Vieni qui, ti insegnerò alcune delle lettere su questa pagina.» Il vecchio gli fece segno con l’indice. Con un senso di costrizione in petto, Adair si alzò dal pavimento e si avvicinò a lui. Il medico guardò lo spazio che li separava. «Più vicino, ragazzo, da lì non vedi niente.» Indicò un punto sul pavimento, vicino a lui. Adair si accostò, con la fronte imperlata di sudore. Non appena si accomodò chinandosi sul foglio, il vecchio allungò una mano e gli strinse la gola in una morsa d’acciaio. Non riusciva a respirare. Le dita gli serravano la trachea. «Stanotte sarà una notte molto importante per te, Adair, ragazzo mio. Molto importante» aggiunse in tono suadente. Poi all’improvviso si alzò dalla sedia e sollevò Adair da terra tenendolo per la gola. «Non credevo che ti avrei tenuto al mio servizio così a lungo. Avevo pianificato di ucciderti molto prima. Ma nonostante il tuo primo grave tradimento, mi sono affezionato a te. Hai sempre avuto una certa bellezza selvaggia e sei stato più leale di quanto ritenevo possibile. Sì, ti sei rivelato migliore di quel che pensavo la prima volta che ti ho visto. Perciò ho deciso di tenerti con me come servitore. Per sempre.» Schiantò Adair contro il muro di pietra come se fosse una bambola di pezza, e la testa del giovane cozzò contro la parete. Le forze lo abbandonarono. Il vecchio lo sollevò e lo portò di nuovo giù dalle scale, nel segreto del suo sotterraneo. Adair perse e riprese conoscenza più volte mentre giaceva sul letto, avvertendo la mano del vecchio sul suo volto. «Ho un dono prezioso per te, mio ribelle contadinotto. Credevi che non riuscissi a leggere il tuo sguardo, vero? Ma ovviamente potevo...» Adair fu assalito dal panico alle parole del vecchio. Iniziò a temere che riuscisse a leggergli i pensieri e che scoprisse il patto con il monaco. «Ma una volta ricevuto questo dono, non potrai mai più rifiutarmi niente, per il resto della tua vita. Questo dono ci unirà per sempre, vedrai...» Il vecchio si avvicinò ancora di più, osservando il suo servo con occhi infuocati. Fu a quel punto che Adair notò un amuleto che pendeva al collo del medico, appeso a un laccio di cuoio. Il vecchio lo afferrò con la mano raggrinzita e strappò il cordino, nascondendo poi l’amuleto alla vista di Adair con entrambe le mani. Ma Adair era riuscito a vederlo alla fioca luce della candela e aveva scorto un lungo ago che fungeva da tappo per una fiala sottile. Sulla punta dell’ago era aggrappata una spessa goccia di liquido viscoso color rame. «Apri la tua maledetta bocca indegna» gli ordinò il medico, con l’ago sospeso sopra le labbra di Adair. «Stai per ricevere il più prezioso dei doni. Molti uomini ucciderebbero o darebbero tutte le loro ricchezze per averlo. E io invece sto per sprecarlo con una nullità come te! Fai come ti ordino, cane ingrato, prima che cambi idea!» Non aveva bisogno di insistere: l’ago era talmente sottile che si insinuò facilmente tra le labbra di Adair, per quanto fossero serrate, e il vecchio lo spinse fino a pungergli la lingua. Fu lo shock, più che il dolore, a spingere Adair a ribellarsi al medico, lo shock dello strano torpore che gli pervase il corpo. Ma fu gelato dal terrore. Istantaneamente si rese conto di esser posseduto da qualcosa di satanico. Poi la pressione calò inesorabilmente e il suo cuore prese a battere sempre più forte, cercando disperatamente di irrorare di sangue le membra intorpidite e il cervello. Per tutto il tempo, il vecchio lo schiacciò a terra, pesante come un macigno, mormorando parole inintelligibili, nella lingua del demonio, mentre combinava qualcos’altro, stavolta con un ago e dell’inchiostro. Adair cercò di scrollarsi di dosso il vecchio ma non riuscì a scansarlo e in capo a un minuto non ebbe più nemmeno la forza di provarci. I suoi polmoni erano al collasso, non riusciva nemmeno a respirare. In preda alle convulsioni, iniziò a tossire e soffocare, agitandosi sul suo letto di morte, sopraffatto dal gelo che lo attanagliava improvvisamente... Adair si sentiva come se lo stessero seppellendo vivo, imprigionato in un corpo che cadeva giù, sempre più giù, abbandonandolo. Ma una strenua volontà, dentro di lui, si oppose alla morte. Se fosse morto, il vecchio non sarebbe mai stato punito e, più di ogni altra cosa, Adair voleva assicurarsi che lo fosse. Il medico studiò il volto di Adair nelle convulsioni della morte. «Sei così forte. Hai una grande volontà di sopravvivere, e questo è un bene. Che sia l’odio per me ad alimentarti. È ciò che mi aspetto, Adair. Il tuo corpo sta per attraversare le ultime fasi della morte; questo ti terrà occupato per un po’. Resta immobile.» Quando il corpo di Adair non riuscì più a combattere, iniziò a morire. Si irrigidì, intrappolando la mente di Adair al suo interno. Mentre giaceva lì, il medico iniziò a raccontare di come aveva iniziato a praticare l’alchimia. Non si aspettava certo che Adair, un semplice contadino, capisse il potere seduttivo della scienza. Ma la sua formazione di medico aveva soltanto aperto una porta. Il vecchio era andato oltre l’alchimia. Si era unito ai pochi, ai più astuti e coraggiosi, che avevano osato spingersi oltre i segreti del mondo naturale per esplorare quelli del mondo soprannaturale. Trasmutare il ferro in oro era soltanto un’allegoria, non lo capiva Adair? Gli autentici visionari non cercavano il modo di trasformare gli elementi terrestri in qualcosa di più prezioso, ma di trasformare la natura stessa dell’uomo! Attraverso la purificazione mentale e la dedizione totale alla conoscenza dell’alchimia, il medico era assurto ai ranghi degli uomini più potenti e sapienti del pianeta. «Posso comandare l’acqua, il fuoco, la terra e il vento. Hai potuto vederlo con i tuoi stessi occhi, sai che è vero» si vantò. «Posso rendere un uomo invisibile. Ho le stesse forze che avevo da giovane, e questo ti ha sorpreso, vero? In verità, sono più forte di quanto ero una volta. Posso arrivare ad avere la forza di venti uomini! E ho sottomesso il tempo stesso. Il dono che ti ho dato» il suo volto assunse di colpo un’espressione odiosa di superiorità e di soddisfazione «è l’immortalità. Tu, mio quasi perfetto servitore, sarai sempre al mio servizio. Non mi deluderai mai. Non morirai mai.» Adair ascoltò quelle parole e sperò di averle fraintese. Servirlo per sempre! Desiderò che la morte lo portasse via. Sopraffatto dal panico, non udì la fine del discorso, ma non importava. Prima che l’oscurità lo intrappolasse, riuscì però a cogliere un ultimo frammento. Il medico stava dicendo che c’era soltanto un modo per sfuggire all’eternità. Per trovare la morte, bisognava che a ucciderlo fosse la stessa persona che lo aveva trasformato. Il suo creatore. Il medico. 24 Quando Adair si svegliò, scoprì di essere ancora nel letto del medico. Il vecchio giaceva accanto a lui, in un sonno simile alla morte. Adair si alzò, in preda a una sensazione completamente nuova. Era come se tutto fosse cambiato mentre dormiva, ma non sapeva come e quanto. Alcuni cambiamenti gli furono subito evidenti: la vista, per esempio. Riusciva a vedere perfettamente al buio. Scorgeva i ratti che si agitavano agli angoli della camera, scavalcandosi l’un l’altro mentre correvano lungo le pareti. Sentiva ogni suono come se si trovasse a pochi centimetri dalla fonte, e ogni rumore era separato e distinto. Ma l’olfatto era potenziato più di tutti gli altri sensi: ogni odore reclamava con forza la sua attenzione, e soprattutto uno, dolce e speziato, con un sentore di rame, che pervadeva l’aria. Non riusciva a identificarlo, nonostante lo tormentasse. Qualche minuto dopo, il medico si agitò e poi scattò a sedere. Notò lo stupore di Adair e rise. «È parte del dono, capisci. Meraviglioso, vero? Hai i sensi ipersviluppati degli animali, ora.» «Cos’è questo odore? Lo sento dappertutto.» Adair guardò le proprie mani, poi il letto. «È il sangue. I ratti ne sono pieni, e come vedi ce n’è dappertutto. Poi c’è Marguerite, che dorme di sopra. Ma puoi anche sentire l’odore dei singoli minerali nelle rocce, nei muri che ti circondano. La terra dolce, l’acqua trasparente, tutto è più chiaro, più nitido. È il dono. Ti eleva al di sopra degli uomini comuni.» Adair si accasciò, inginocchiandosi sul pavimento. «E tu? Tu sei come me? È così che hai ottenuto i tuoi poteri? Puoi vedere tutto?» Il vecchio fece un sorriso enigmatico. «Sono come te, mi chiedi? No, Adair, io non mi sono sottoposto alla tua stessa trasformazione.» «E perché no? Non vuoi vivere per sempre?» Scosse il capo, come se avesse a che fare con uno stupido. «Non è così semplice come esaudire un desiderio. Potrebbe andare al di là della tua comprensione. A ogni modo, io sono un vecchio e porto addosso tutti i segni dell’anzianità. Non vorrei mai vivere tutta l’eternità in questa condizione.» «Se è così, allora come pensi di riuscire a trattenermi, vecchio? Adesso che mi hai reso più forte che mai, non potrai più picchiarmi. E Dio sa che non mi molesterai mai più! Come puoi sperare di riuscire a tenermi legato a te?» Il vecchio si avvicinò alle scale, lanciandogli uno sguardo dietro le spalle. «Non è cambiato nulla fra di noi, Adair. Credi veramente che ti avrei fatto un simile dono solo per darti il potere di liberarti di me? Sono ancora più forte di te. Posso spegnere la tua vita esattamente come se fosse la debole fiammella di una candela. E sono il solo al mondo che può ucciderti, ricordatelo.» Il medico scomparve nell’oscurità. Adair rimase sulle ginocchia, tremante, senza sapere in quel momento se credere alle parole del vecchio e anche allo strano potere che sentiva scorrergli nelle vene e in tutto il corpo. Guardò il punto, sul suo braccio, in cui aveva visto all’opera il vecchio con ago e inchiostro, pensando che potesse trattarsi di un’illusione. Ma no, non lo era. C’era uno strano tatuaggio ora, due cerchi che danzavano uno attorno all’altro. Quel disegno gli era stranamente familiare, ma non riusciva a ricordare dove l’avesse visto in precedenza. Forse il medico aveva ragione. Forse Adair era troppo stupido per comprendere qualcosa di così difficile. Ma la vita eterna era l’ultima cosa che gli interessava in quel momento. Non gli importava di vivere o morire. Non voleva altro che riuscire a convincere il monaco a portare a compimento il suo piano e non gli interessava se, in cambio, ci avrebbe rimesso la vita. Adair trovò il monaco nella cappella, a pregare alla luce di una candela. Rimanendo per un attimo nell’ingresso, si chiese se la sua trasformazione recente in qualcosa di soprannaturale non gli impedisse l’ingresso in un luogo sacro. Se avesse cercato di superare la soglia sarebbe stato scagliato indietro da una schiera di angeli che gli avrebbero negato il permesso di entrare? Dopo un profondo respiro, fece un passo. Non accadde niente. A quanto sembrava, Dio non aveva alcun potere su una creatura come quella che lui ora era diventato. Il monaco vide Adair e corse da lui, conducendolo in un angolo in penombra. «Allontanati dall’ingresso, ci potrebbero vedere» disse. «Che cos’hai? Sembri sconvolto.» «Lo sono. Ho scoperto qualcosa di ancor più terrificante di quanto vi ho raccontato finora, padre. Qualcosa sul conto del medico che non sapevo fino alla scorsa notte.» Adair si chiese se non stesse scherzando col fuoco. Eppure, era convinto di essere sufficientemente astuto da riuscire a intrappolare il medico senza essere travolto anche lui. «Peggio dell’essere un adoratore di Satana?» «Lui... Lui non è umano. Ora è una delle creature di Satana. Si è rivelato a me nel pieno del suo potere maligno. Voi siete stato istruito dalla Chiesa, sapete che esistono cose che non appartengono a questo mondo, creature demoniache che tormentano i poveri mortali per garantire un divertimento a Satana. Qual è la cosa peggiore che potete immaginare, padre?» Con sollievo, Adair vide che sul volto del monaco non compariva scetticismo, né incredulità. Il monaco era diventato bianco come un cadavere e tratteneva il fiato, terrorizzato, ricordando forse le terribili storie che aveva udito nel corso degli anni, le morti inspiegabili, i bambini scomparsi nel nulla. «Si è trasformato in un demone, padre. Non potete immaginare cosa significhi vivere accanto a una tale malvagità, che ti prende alla gola, con il puzzo dell’inferno nel suo alito. E la forza di Lucifero nelle sue mani.» Il monaco alzò un dito, chiedendogli di tacere. «Un demone! Ho sentito parlare di demoni che camminano fra gli uomini, che prendono diverse forme. Ma mai, mai nessuno ne ha affrontato uno ed è sopravvissuto.» Gli occhi del monaco schizzarono dalle orbite e si allontanò da Adair. «Eppure tu sei qui, di fronte a me, vivo. Per quale miracolo?» «Mi ha detto di non essere pronto a prendere anche la mia vita, che aveva ancora bisogno dei miei servigi, così come di quelli di Marguerite. Mi ha ammonito di non scappare, ha detto che avrei subito le peggiori torture se avessi tentato di fuggire, ora che so...» Adair non dovette fingere di rabbrividire. «Che demonio!» «Sì. Padre, credo che possa essere il diavolo in persona.» «Dobbiamo portar via te e Marguerite da quella casa maledetta all’istante. Le vostre anime sono in pericolo, per non parlare delle vostre vite.» «Ma non possiamo correre un simile rischio, non prima di aver elaborato un piano. Marguerite è al sicuro. Non l’ho mai visto alzare le mani su di lei. E per quanto riguarda me... C’è ben poco che mi possa fare che non mi abbia già fatto.» Il monaco sospirò. «Figliolo, può sempre toglierti la vita.» «La mia sarebbe soltanto una delle moltissime vite che ha spezzato.» «Sei disposto a rischiare la tua vita pur di liberare questo villaggio dalla sua immonda presenza?» gli domandò. Adair arrossì di odio. «Mille e mille volte.» Gli occhi del monaco si riempirono di lacrime. «Molto bene, figliolo, allora procederemo. Parlerò con i miei compaesani – con discrezione, te lo assicuro – e vedremo su chi potremo contare per dare addosso al medico.» Si alzò e accompagnò Adair alla porta. «Tieni d’occhio questo edificio. Quando saremo pronti ad agire, appenderò un telo bianco alla lanterna. Abbi pazienza fino a quel momento e sii forte.» Passò una settimana, poi una seconda. A volte Adair si chiedeva se il monaco non avesse perso il coraggio e fosse scappato dal villaggio, troppo codardo per affrontare il conte. Adair approfittò di ogni occasione per ispezionare il torrione in cerca del sigillo che il vecchio aveva adoperato per autorizzare i proclami, durante il soggiorno nei suoi domini. Ma dopo la cerimonia al castello, il sigillo sembrava svanito nel nulla, anche se Adair sapeva bene che il medico non avrebbe corso il rischio di nasconderlo in un posto che non sarebbe stato in grado di raggiungere quando ne avesse avuto il bisogno. Di notte, una volta che Marguerite si era addormentata e il vecchio era uscito dal torrione, Adair apriva ogni scatola, ogni cesta e ogni baule, ma non trovò mai il pesante timbro d’oro appeso al cordino sottile. Proprio quando Adair fu sul punto di non riuscire più a contenere la sua impazienza, giunse la notte in cui un panno bianco sventolò dalla lanterna della chiesa. Il monaco era all’ingresso del monastero, aggrappato a un alto candelabro come se fosse un’arma. Sembrava cambiato rispetto all’ultima volta in cui Adair l’aveva visto, il suo incarnato non era più quello di un bambino. Le sue guance, un tempo piene come quelle di uno scoiattolo, ora erano scavate. I suoi occhi, un tempo limpidi e innocenti, ora erano scuri e sofferti, per via di ciò che sapeva. «Ho parlato con gli uomini del villaggio e sono con noi» disse, prendendo Adair per il braccio con fare cospiratorio e trascinandolo nell’ombra del vestibolo. Adair cercò di contenere la propria gioia. «Qual è il vostro piano?» «Ci raduneremo domani a mezzanotte e marceremo sul torrione.» «No, no, non a mezzanotte» lo interruppe Adair, posando una mano sul braccio del monaco. «Per coglierlo di sorpresa, è meglio agire a mezzogiorno. Come ogni creatura del male, il medico di notte è attivo, mentre di giorno dorme. Avrete più possibilità se agite di giorno.» Il monaco annuì, anche se il suggerimento sembrò turbarlo. «Sì, capisco. Ma come possiamo fare con le truppe del conte? Non rischiamo di essere scoperti da loro se agiamo di giorno?» «Le guardie non si avvicinano nemmeno al torrione, mai. A meno che qualcuno non lanci l’allarme, non avete niente da temere dagli uomini del conte.» Questo non era del tutto vero. Era capitato parecchie volte che le guardie si recassero al torrione durante il giorno, ma soltanto per una ragione: consegnare una giovanetta al vecchio. Ma quelle consegne non erano comunque frequenti. Vero, era da parecchio tempo che il conte non mandava una servetta, quindi le probabilità erano a sfavore, tuttavia... Adair calcolò che comunque valesse la pena di rischiare, perciò decise di non menzionare nemmeno questo rischio al monaco, che avrebbe potuto utilizzarlo come scusa per rinunciare. «Certo, certo...» Il monaco annuì, gli occhi sbarrati. Mi sta sfuggendo, pensò Adair. «E che intenzioni avete con il vecchio, una volta che l’avrete catturato?» Il monaco sembrò colpito. «Non spetta a me determinare la sorte di quell’uomo...» «Invece sì, padre. È vostro dovere, come uomo di Dio. Ricordate quello che dice il Signore a proposito delle streghe: ’Non permetterete loro di vivere’.» Strinse forte il braccio dell’uomo mentre parlava, come per instillargli coraggio nelle vene. Dopo un lungo momento, il monaco abbassò lo sguardo. «La folla... non posso garantire che sarò in grado di controllare la rabbia della gente. Dopo tutto, c’è molto odio verso il medico...» spiegò, con voce piena di rassegnazione. «Questo è vero» disse Adair, in tono conciliatorio. «Non potete essere soltanto voi responsabile di ciò che succederà, padre. È la volontà di Dio.» Dovette reprimere la risata folle che gli sorgeva dentro. L’odiato vecchio finalmente avrebbe avuto quel che meritava! Forse Adair da solo non aveva il potere sufficiente per sconfiggere un alleato del diavolo, ma di certo il medico non sarebbe stato in grado di opporre resistenza a metà villaggio. «Avrò bisogno di un altro giorno per avvertire gli uomini del cambiamento dei piani, per spiegare che è meglio compiere l’assalto durante il giorno» aggiunse il monaco. Adair annuì. «Dopodomani, dunque, a mezzogiorno.» Il monaco ebbe un singulto di terrore e si fece il segno della croce. Un giorno. Adair aveva a disposizione soltanto un giorno per trovare il sigillo, altrimenti avrebbe corso il rischio che a trovarlo e ad appropriarsene fosse qualcuno del villaggio. Ritornò al torrione, cercando di allontanare il panico. Dove poteva trovarsi quel maledetto oggetto? Adair aveva cercato dappertutto, aveva esaminato perfino gli abiti del vecchio ed era arrivato al punto di tirar fuori uno a uno i tessuti conservati nei bauli per assicurarsi che non fosse nascosto là in mezzo. Quel pensiero aumentò la sua disperazione, vide tutti i suoi piani crollare, uno dopo l’altro. Non sarebbe mai riuscito a sfuggire dalle grinfie del medico, non sarebbe mai andato a vivere in quel castello lontano, non avrebbe mai rivisto la sua famiglia o l’amata Katarina. Tanto valeva morire, pensò. Lo sconforto era tale che avrebbe chiesto al vecchio di avere pietà di lui e ucciderlo, ma il suo odio ancora superava quella disperazione, per quanto abissale. Il vecchio era alla scrivania quando Adair tornò dal suo appuntamento segreto. Alzò velocemente lo sguardo su di lui quando entrò. «Dovrò recarmi al villaggio domani; devo procurarmi la biada per i cavalli» disse Adair al vecchio, e un secondo dopo un pensiero, una possibilità, gli venne in mente. Il vecchio picchiettò le dita sul tavolo. «Dovrai attendere un giorno. Preparerò un cataplasma che porterai con te, per barattarlo con il borgomastro in cambio di qualche buon taglio di quercia...» «Chiedo perdono, ma per colpa della mia disattenzione le riserve di biada sono finite. Non c’è cibo da diversi giorni e l’erba è troppo rada per saziare i cavalli ancora a lungo. Non posso attendere. Con il vostro permesso, ne comprerò soltanto una piccola quantità, quanto basta per sfamare i cavalli questa settimana, e andrò dal borgomastro la settimana seguente, quando il cataplasma sarà pronto.» Adair trattenne il fiato, attendendo la reazione del vecchio, perché se si fosse opposto sarebbe stato difficile trovare in poco tempo un’altra scusa per indurlo a rivelare dove conservasse il denaro e i preziosi. Il vecchio scosse il capo di fronte all’incompetenza del suo servitore, poi si alzò e scese dalle scale. Adair sapeva che non era prudente seguirlo, perciò si limitò ad ascoltare, con l’attenzione di un segugio, ogni suono, ogni indizio. Nonostante lo spesso pavimento di travi, sentì che scavava e poi spostava qualcosa di voluminoso. Il suono metallico di monete. Poi di nuovo qualcosa che veniva spostato. Alla fine, il vecchio ricomparve dalle scale e gettò una piccola sacca di pelle sul tavolo. «Questo ti basterà per la settimana. Assicurati di fare un buon affare» ringhiò. Quando, poco dopo, il vecchio uscì per la notte, Adair si affrettò a scendere nel sotterraneo. Il pavimento lurido non recava tracce di alcun tipo e fu solo dopo un’attenta ricerca che Adair individuò il punto in cui il vecchio si era messo all’opera, lungo il muro, un punto umido e ammuffito coperto di escrementi di topo. Lo sporco era stato grattato via da una delle pietre. Adair si inginocchiò e afferrò gli angoli della pietra con la punta delle dita, estraendola dalla parete. In un piccolo anfratto riuscì a intravedere un fagotto di tela ruvida, che estrasse e srotolò. Dentro c’era una sacca piena di monete e, avvolto in un fazzoletto di velluto, il sigillo del regno dei suoi sogni. Adair prese tutto e rimise la pietra al suo posto. Inginocchiato nel lordume, lasciò che l’entusiasmo del successo lo pervadesse, felice di aver trovato il sigillo e di aver ottenuto una vittoria contro il suo oppressore dopo tutte le ingiustizie che aveva subito. Allora gli venne in mente suo padre, e pensò che avrebbe dovuto ucciderlo, invece di lasciare che picchiasse sua madre e i suoi fratelli. E che non avrebbe dovuto lasciare che lo vendessero come uno schiavo. Avrebbe dovuto approfittare di ogni occasione per cercare di scappare, senza mai arrendersi, senza mai smettere di provarci. Avrebbe dovuto uccidere il maledetto conte. Non meritava di vivere, era un nemico dei magiari e un eretico, alleato di un emissario di Satana. Avrebbe dovuto aiutare Marguerite a scappare, condurla presso una famiglia benevolente o in un convento, trovare qualcuno che si prendesse cura di lei. Riguardo al sigillo, Adair pensò che non stava commettendo un furto. Il medico era in debito verso di lui. Quel regno sarebbe stato il giusto tributo. E il medico gliel’avrebbe dato. Oppure sarebbe morto. Nel giorno designato, Adair studiò i movimenti del sole nel cielo con la stessa attenzione di un falco che sorveglia un topo in un campo. Il monaco e la folla sarebbero arrivati al torrione in capo a un’ora o due. Aveva un unico dubbio: doveva stare lì a godersi la fine del medico? Era una tentazione folle. Quanto avrebbe voluto vedere i paesani trascinare a forza il vecchio fuori dal suo letto immondo e condurlo sotto la luce del sole, guardare il suo volto contorto dalla sorpresa e dal terrore. Ascoltare le sue urla mentre lo sbattevano a terra, lo prendevano a bastonate, lo tagliavano a fettine con le falci. Quanto avrebbe voluto incitare la folla a fare razzia del torrione, a sfondare i bauli, spaccare le bottiglie, mandare in mille pezzi i vasi con tutti i preziosi ingredienti e schiacciare tutto sotto i piedi, e poi dar fuoco a quel posto maledetto. Anche se era in possesso del sigillo, Adair non poteva certo andare al castello del vecchio senza sincerarsi che questi non l’avrebbe inseguito. Ma c’era una buona ragione per scomparire prima che la folla giungesse: e se in qualche modo il vecchio fosse scampato alla morte? E se la folla avesse perso il coraggio di agire o se il vecchio avesse bevuto anche lui la pozione dell’immortalità? Dopo tutto, non aveva mai detto apertamente di non averla presa. Se fosse rimasto lì, Adair avrebbe corso il rischio di essere implicato nella faccenda. Non ci sarebbe stato modo di negare il proprio coinvolgimento nella congiura se il medico fosse sopravvissuto e l’avesse scoperto. Era più prudente allontanarsi e conservare un minimo di possibilità di negare tutto. Andò da Marguerite, che stava pelando le patate in un secchio d’acqua, le tolse le patate dalle mani e cercò di condurla verso la porta. Lei oppose resistenza, da quell’anima innocente che era, ma Adair la costrinse e la obbligò ad aspettare mentre sellava il vecchio destriero del medico. Era sua intenzione portare Marguerite al sicuro, al villaggio. In quel modo, lei non sarebbe stata presente durante la rivolta. Era meglio così. Sarebbe tornato lui solo a controllare l’esito della vicenda. Il sole stava tramontando quando Adair si avviò di nuovo verso il torrione. Procedette lentamente, lasciando che il destriero assumesse un’andatura lenta lungo un sentiero tra gli alberi poco battuto. Non aveva intenzione di incappare negli abitanti del villaggio di ritorno dalla spedizione, ancora eccitati e assetati di sangue. A quel punto notò un pennacchio di fumo nero all’orizzonte, ma ora che giunse al torrione era diventato una nebbia scura. Incitò il cavallo, attraversando nubi di fumo, finché non arrivò alla familiare radura davanti al torrione di pietra. La porta era stata divelta dai cardini e il terreno davanti all’ingresso era stato ripetutamente calpestato. Il recinto del bestiame era stato abbattuto e l’altro cavallo era scomparso. Adair scese dal destriero e con cautela si avvicinò alla porta aperta, nera e minacciosa come un teschio. All’interno, strisce di fuliggine si arrampicavano sulle pareti come in cerca di una scappatoia. La devastazione era come se l’era immaginata: frammenti di coccio e di vetro ovunque sul pavimento; calderoni, secchi e pentole capovolti; la scrivania fatta a pezzi. E tutte le formule erano sparite, insieme ai resti del vecchio. A meno che... Il sangue gli si raggelò nelle vene al pensiero che forse la folla aveva davvero perso il coraggio. Iniziò a setacciare fra le macerie, rovesciò mobili, frugò sul pavimento tra i cenci e i pochi beni sopravvissuti al saccheggio dei bauli. Ma non trovò niente del vecchio, nemmeno un orecchio. Dovevano esserci dei resti – un frammento d’osso, un teschio spaccato – se davvero gli abitanti del villaggio erano riusciti a farlo a pezzi. Ma altre e più terribili alternative gli vennero alla mente: forse il medico era riuscito a scappare nella foresta o a nascondersi da qualche parte all’interno del torrione. Dopo tutto, se aveva costruito una nicchia nascosta dietro una pietra, chi poteva dire che non avesse creato una camera segreta? O forse, ancora peggio, si era allontanato con un incantesimo, o era stato risparmiato dal diavolo in persona, mosso a compassione verso un servitore così fedele. Con il panico che gli attanagliava la gola, Adair scese di corsa le scale fino al sotterraneo. La scena, lì sotto, era ancora più spaventosa che sopra. L’aria era piena di fumo nero. A quanto sembrava, era da lì che era partito l’incendio. La stanza era completamente vuota, a parte un letto di cenere dove prima c’erano il materasso e le coperte. Ma Adair sentiva l’odore della morte nascosto nel fumo e si avvicinò alle ceneri, si accovacciò e iniziò a setacciare i resti. Trovò frammenti di ossa, brandelli di pelle e grumi di carne, ancora bollenti. E finalmente individuò un pezzo di teschio, con un frammento di pelle ancora attaccato e una ciocca di capelli. Alzatosi in piedi, si tolse la cenere dalle mani come meglio riuscì. Si prese del tempo prima di lasciare per sempre il torrione, osservando il posto in cui aveva trascorso cinque anni di tormenti. Era un peccato che le mura di pietra non potessero essere abbattute con il fuoco. Non prese niente, tenne soltanto i vestiti che indossava e, naturalmente, il sigillo e la sacca di denaro che aveva in tasca. Alla fine, uscì dall’ingresso sventrato, afferrò le redini del destriero, montò in sella e si diresse a est, verso la Romania. Adair visse nella tenuta del medico per molti anni, anche se la proprietà non passò direttamente nelle sue mani come aveva sperato. Quando giunse al castello da solo, senza il medico, il giovane si presentò al cospetto del custode, Lactu, e gli disse che il medico era morto. Aveva mentito quando aveva detto di avere una moglie e un figlio, spiegò: una copertura atta a mascherare le sue reali tendenze sessuali. Privo di eredi, dunque, il medico aveva lasciato tutto al suo fedele servitore nonché compagno per tutti quegli anni, spiegò Adair, e mostrò il sigillo. Lactu assunse subito un’espressione dubbiosa. Disse che la sua richiesta avrebbe dovuto essere esaminata dal re di Romania in persona. Se Adair non era discendente di sangue del medico, il re aveva il diritto di decidere come disporre della sua proprietà. La decisione del re impiegò anni ad arrivare e non fu a favore di Adair. Gli fu consentito di rimanere nella tenuta e di prendere il nome della dinastia, ma il re gli tolse la proprietà delle terre. Giunse così il giorno in cui Adair non fu più in grado di rimanere. Lactu e tutti gli altri erano invecchiati, mentre lui era rimasto uguale al giorno in cui era tornato al castello senza il vecchio. Perciò, per non destare sospetti, era giunto il momento di sparire per qualche tempo, evitare di attirare l’attenzione e forse tornare dopo qualche decennio, spacciandosi per il proprio figlio, munito del sigillo d’oro. Decise di andare in Ungheria, di seguire il cuore e di rintracciare la sua famiglia. Adair desiderava ardentemente rivederli, a parte suo padre, certo, che odiava, secondo solo al medico. Ormai sua madre doveva essere vecchia e probabilmente viveva col figlio maggiore, Petu. Gli altri dovevano essere adulti, con figli. Moriva dal desiderio di rivederli e di scoprire che cosa fosse successo loro. Impiegò due anni a rintracciare la sua famiglia. Iniziò le ricerche partendo dal luogo in cui era stato venduto e con estrema fatica ricostruì i loro spostamenti, basandosi sulle poche informazioni che otteneva da persone presso cui avevano lavorato o dai vicini. Alla fine, mentre sopraggiungeva il secondo inverno da quando si era messo in cerca, si fermò vicino al lago Balaton ed entrò a cavallo in un villaggio, in cerca di volti simili al suo. Trovò un accampamento di tende ai confini del paese e provò una sensazione strana. Finalmente gli sembrava di essere vicino a qualcuno che conosceva. Scese da cavallo, si insinuò nella notte fino ad arrivare nei pressi dell’accampamento e prese a sbirciare in giro. Avvicinando un occhio a una fessura di un capanno, intravide volti familiari. Anche se erano cambiati nel tempo, erano diventati più pieni e rotondi, e avevano delle rughe, riconobbe quei volti. I suoi fratelli erano raccolti attorno al fuoco, a bere vino e a suonare il violino e la balalaika. Con loro c’erano delle donne che Adair non riconobbe, probabilmente le loro mogli, ma non c’era traccia di sua madre. Finalmente, intravide Radu. Quant’era cresciuto. Alto, col petto largo... Come avrebbe voluto irrompere nel capanno, prendere il fratello tra le braccia e ringraziare Dio che fosse ancora vivo, che gli fosse stato risparmiato il tormento infernale che lui invece aveva sofferto. Poi Adair si avvide che Radu sembrava più vecchio di lui, che tutti i suoi fratelli lo sembravano. E poi vide una donna avvicinarsi sorridente a Radu, che le cinse la vita e la trasse a sé. Era Katarina, ormai donna, bellissima e innamorata di Radu, il fratello che assomigliava di più a Adair. Solo che ora era più vecchio. In piedi al buio e al freddo, Adair ancora bruciava dal desiderio di abbracciare i suoi familiari, di far loro sapere che non era morto per mano del medico... Poi la terribile verità lo assalì di colpo. Come avrebbe potuto spiegar loro tutto quello che gli era successo e ciò che ancora lo attendeva? Il fatto che non sarebbe mai invecchiato. Che non era più un mortale, come loro. Che era diventato qualcosa che non sapeva nemmeno spiegare. Adair girò attorno al capanno, si avvicinò all’ingresso e depositò un sacchetto di monete davanti alla porta. Era denaro sufficiente a permetter loro di cambiare vita. Ci sarebbe voluto tempo, ma avrebbero saputo accettare la loro buona sorte e ringraziare Dio per la sua generosità e la sua compassione. E a quel punto Adair sarebbe già stato a diversi giorni di distanza, a nord, fra la gente di Buda e di Szentendre, a cercare di venire a patti col proprio destino. Alla fine del racconto, mi ero ritratta dall’abbraccio di Adair. Gli effetti del narcotico iniziavano a scemare. Non sapevo che cosa provare per lui, se un profondo rispetto o un cieco terrore. «Perché mi hai raccontato tutto questo?» gli chiesi, sfuggendo al suo tocco. «Consideralo un avvertimento» rispose enigmaticamente. 25 Confine del Maine, oggi Luke esce dall’autostrada e percorre una strada dall’asfalto sconnesso e impolverato, con il motore del SUV che, a regimi bassi, spinge il veicolo su per la strada piena di solchi. Giunti a una curva, parcheggia accanto al vialetto d’accesso ma lascia il motore acceso. Il panorama è perfettamente visibile perché d’inverno gli alberi sono spogli; lui e la sua passeggera riescono a vedere con chiarezza il confine tra Stati Uniti e Canada poco lontano. Sembra un cantiere giocattolo: un’enorme distesa di gabbiotti e di aree di sosta affollate di camion e automobili, l’aria satura di gas di scarico. «È lì che dobbiamo andare» dice, indicando oltre il parabrezza. «È gigantesco» risponde la ragazza. «Pensavo che saremmo passati da un confine meno attrezzato, con due guardie e un cane a ispezionare le auto con una torcia.» «Sei sicura di voler andare fino in fondo? Ci sono altri modi per arrivare in Canada» osserva Luke, anche se non è affatto sicuro che sia giusto incoraggiarla a infrangere altre leggi. Ma lo sguardo che lei gli rivolge gli arriva dritto al cuore, come quello di un bambino che cerca sicurezza dai genitori. «No, mi hai portato fin qui e ho fiducia in te. So che riuscirai a farmi attraversare il confine.» Avvicinandosi al checkpoint, Luke inizia a mostrare segni di nervosismo. C’è poco traffico oggi ma, comunque, la prospettiva di rimaner seduti in coda per un’ora lo atterrisce. Ormai la polizia deve aver diramato un bollettino su di loro; una sospetta di omicidio in fuga e il dottore suo complice... Per un momento è sul punto di uscire dalla coda, ma si ferma all’ultimo secondo, le mani strette e tremanti sul volante. La ragazza lo guarda, anche lei nervosamente. «Tutto bene?» «Ci stanno mettendo troppo...» borbotta Luke, tutto sudato nonostante l’aria fredda dell’inverno. «Va tutto bene» lo rassicura lei. D’improvviso, una luce verde si accende davanti alla fila accanto alla loro e Luke, reagendo con sorprendente rapidità, sterza e accelera, indirizzando la macchina verso il confine, con gli agenti doganali che smistano il traffico. Taglia la strada a un’altra macchina che era in attesa due posizioni davanti a loro e si insinua. La donna al volante dell’altro veicolo gli mostra il dito medio, ma Luke non ci fa caso. Frena di colpo di fronte all’agente doganale. «Andiamo di fretta, eh?» dice il poliziotto, mascherando il suo interesse con un atteggiamento noncurante mentre prende dalle mani del dottore la sua carta d’identità. «Di solito diamo la precedenza alla prima della fila quando apriamo un’altra corsia.» «Mi scusi, agente» dice brusco Luke. «Non sapevo che...» «La prossima volta se ne ricordi, okay?» risponde l’altro in tono amichevole, senza nemmeno alzare lo sguardo mentre esamina la sua patente e poi il passaporto di Lanny. È un uomo di mezz’età, con un’uniforme blu scuro e una casacca con le tasche piene: un walkie-talkie, penne a non finire e altri ammennicoli. In mano tiene una cartellina e un aggeggio elettronico che pare una specie di scanner. La sua collega, una donna più giovane di lui, fa il giro attorno alla macchina con un’asta in cima alla quale c’è uno specchietto, come se si aspettasse di individuare una bomba a tempo agganciata al fondo del SUV. Luke ne segue i movimenti nello specchietto retrovisore, con i nervi a fior di pelle senza alcuna particolare ragione. Poi ci arriva, di colpo: se gli chiedono i documenti della macchina, saranno guai. Perché non è registrata a suo nome. Non è lei il proprietario del veicolo? gli chiederà l’agente. Ma capita ogni giorno che qualcuno prenda in prestito una macchina da qualcun altro, si dice Luke, cercando di rassicurarsi. Non è mica contro la legge. Va bene, lasci soltanto che controlli nel registro per verificare che non sia rubata... Luke pensa: Non chiedermi il libretto di circolazione, non chiedermelo, non chiedermelo, ti prego... Come se rivolgendo quel mantra silenzioso all’agente potesse impedirgli di farsi venire quell’idea. Se il nome di Luke è registrato nel database della polizia in qualche modo – ricercato, fermarlo per interrogatorio – le loro possibilità di fuga si estingueranno definitivamente. Quel difetto nel piano che aveva elaborato rende Luke ancora più nervoso perché lui non ha mai avuto guai con la giustizia, mai, nemmeno da ragazzo, e non è capace di ingannare le autorità. Ha paura di arrossire, e di sudare, e di apparire troppo nervoso e... «Lei è un medico, dunque?» gli domanda l’agente accanto al finestrino, facendo sussultare Luke e attirando la sua attenzione. «Sì, sono un chirurgo.» Stupido, si rimprovera subito. Non gliene frega niente di sapere in che cosa sei specializzato. È la sua vanità di medico a saltar fuori, come un bambino viziato che richiede attenzioni. «Per quale ragione vi state recando in Canada?» Prima che Luke possa trovare una risposta, Lanny si sporge per farsi vedere dal poliziotto. «A dire il vero mi sta facendo un favore. Sono stata sua ospite per un po’ e adesso è giunta l’ora che vada a sfruttare qualche altro lontano parente. E piuttosto che scaricarmi su un autobus, è stato così generoso da insistere per portarmi lui stesso.» «Ah. E dove abita suo cugino?» chiede l’agente con un tono inquisitivo ben mascherato dall’apparente gentilezza. «Lac-Benne» risponde la ragazza con scioltezza. «Cioè, dobbiamo incontrarci a Lac-Benne. Ma lui abita vicino a Québec.» Conosceva il nome di un paesino vicino: a Luke sembra un miracolo. Inizia a rilassarsi un po’. L’agente rientra nel gabbiotto e, attraverso il vetro di plexiglass tutto graffiato, Luke lo osserva. L’uomo si china davanti a un monitor, probabilmente per inserire i loro dati. A stento Luke resiste alla tentazione di schiacciare l’acceleratore e scappare. Non c’è niente che potrebbe fermarlo, nessuna sbarra automatica, nessuna griglia dentata sull’asfalto che possa bucargli le gomme e fermare la loro fuga. Improvvisamente, l’agente è di nuovo accanto al suo finestrino. Gli porge il passaporto e la patente. «Ecco fatto... Buon soggiorno in Canada, allora» dice, facendo loro cenno di proseguire, con lo sguardo già rivolto alla macchina in fila dietro di loro. Luke trattiene il fiato fino a quando l’immagine della stazione di frontiera non scompare dallo specchietto retrovisore. «Perché eri così preoccupato?» Lanny ride, guardandolo di sbieco. «Non siamo mica terroristi o contrabbandieri che cercano di portare sigarette oltre confine. Siamo soltanto due bravi cittadini americani che vanno a farsi un pranzetto in Canada.» «No che non lo siamo» risponde Luke, ma anche lui sta ridendo, sollevato. «Mi dispiace, non sono abituato a sotterfugi come questi.» «No, scusami tu, non volevo ridere di te. So che non ci sei abituato. Te la sei cavata alla grande, comunque.» Gli stringe la mano. Si fermano in un motel anonimo, che non fa parte di una catena, alla periferia di Lac-Benne. Luke aspetta in macchina mentre Lanny si reca alla reception. La osserva parlare con il vecchio alla cassa, che si muove lentamente, approfittando più che può di quella che probabilmente sarà l’unica occasione della mattina di parlare con una bella e giovane ragazza. Poi, Lanny esce e sale sul SUV. Fanno il giro e parcheggiano davanti a una camera sul retro che dà su un filare d’alberi e su un campo da baseball. La loro è l’unica macchina nel parcheggio. Una volta entrati nella camera, Lanny si dà da fare frenetica: svuota la valigia, controlla il bagno, si lamenta della qualità degli asciugamani. Luke si siede sul letto, di colpo è troppo stanco per stare in piedi. Si sdraia sul copriletto di poliestere e fissa lo sguardo sul soffitto. La stanza gli gira attorno come una giostra di carnevale. «Che succede?» Lanny si siede accanto a lui sul bordo del letto, posandogli la mano sulla fronte. «Semplice stanchezza, credo. Quando faccio il turno di notte, di solito vado a letto non appena arrivo a casa.» «Allora, dai, cerca di dormire un po’.» Gli sfila le scarpe da ospedale senza slacciarle. «No, dovrei tornare indietro. È solo mezz’ora di viaggio» cerca di opporsi lui, ma non si muove. «Devo riportare la macchina...» «Stupidate. E poi, alla frontiera potrebbero insospettirsi se tu tornassi subito a casa così.» Gli mette addosso una coperta, poi fruga nella sua valigia ed estrae un sacchettino di plastica contenente la marijuana più profumata che Luke abbia mai sentito. In pochi minuti, lei prepara una voluminosa canna con estrema destrezza, la accende e fuma con avidità. Lascia uscire il fumo lentamente, con gli occhi chiusi, e il suo volto si rilassa, soddisfatto. Luke pensa che un giorno gli piacerebbe suscitarle quella stessa espressione. Lanny gli porge la canna. Dopo un attimo di esitazione Luke la prende e se la porta alle labbra. Aspira e trattiene il fumo, lo sente diffondersi nei lobi cerebrali, avverte le orecchie tapparsi. Gesù, questa roba è forte. Molto. Tossendo, restituisce la canna a Lanny. «È un bel po’ di tempo che non ne fumo una. Dove l’hai presa questa roba?» «In paese. A St. Andrew.» La sua risposta lo inquieta e allo stesso tempo lo sorprende, gli ricorda che ci sono mondi invisibili proprio sotto il suo naso. Ma è contento di non aver saputo che lei aveva della droga con sé quando hanno attraversato il confine, altrimenti sarebbe stato ancora più nervoso. «Lo fai spesso?» le chiede indicando la canna. «Non riuscirei a sopravvivere senza. Non hai idea di quanti ricordi mi affollino la mente... Vita dopo vita, rimorso dopo rimorso... Cose che ho visto altre persone fare. Cose che non riuscirei a dimenticare senza questa roba.» Osserva la canna fra le sue dita. «Ci sono state volte in cui avrei voluto stordirmi con questa roba e rimanere svenuta per, non so, decenni. Dormire e basta. Fermare tutto. Ma non c’è modo di eliminare i brutti ricordi. Non è fare le cose che è difficile, è difficile convivere con quello che hai fatto.» «Come l’uomo nell’obitorio...» Lei poggia l’indice sulle labbra di Luke per impedirgli di andare avanti con quel discorso. Ci sarà tempo dopo, per parlarne, pensa Luke. E in effetti, lei ha tutto il tempo che vuole davanti a sé per venire a patti con l’irreversibilità di quanto ha fatto all’amore della sua vita, e il pensiero la tormenterà ogni minuto di ogni giorno. Non c’è abbastanza marijuana al mondo per sollevarla da quel peso. Sarà l’inferno. Quello che ha fatto lui sembra ben poca cosa al confronto. Eppure, allunga la mano e chiede la canna. «Tornerò a casa» dice, come se volesse convincere lei. «Faccio soltanto un pisolino. Non voglio guidare con questo sonno. Ma devo tornare... ho cose da fare, scadenze... la macchina di Peter...» «Certo» dice lei. Quando il dottore si sveglia, la camera del motel è permeata di una luce grigiastra. Il sole sta tramontando ma i lampioni non si sono ancora accesi. Luke rimane immobile, non si alza a sedere, cerca di riprendere contatto con la realtà. Per parecchi minuti, si sente intontito e non riesce a ricordare dove si trovi e perché tutto gli appaia così estraneo. È accaldato e sudato, sotto la coperta, e si sente come la vittima di un rapimento, trascinata fuori da un’auto, bendata e scaraventata in una camera d’albergo, senza alcuna idea di dove si trovi. Piano piano, mette a fuoco la camera. La sconosciuta è seduta a un tavolino e guarda fuori dalla finestra. È assolutamente immobile. «Ehi» dice Luke, per farle sapere che è sveglio. Lei si volta, con un leggero sorriso sulle labbra. «Ti senti meglio? Ti prendo un bicchiere d’acqua.» Si alza e va nel cucinotto. «C’è soltanto acqua del rubinetto. Ne ho messa un po’ nel frigo per farla raffreddare.» «Quanto tempo ho dormito?» Luke prende il bicchiere; è piacevolmente freddo e vorrebbe posarselo sulla fronte. Si sente febbricitante. «Quattro, cinque ore.» «Oh, Cristo, farei meglio a mettermi in strada. Presto mi cercheranno, se non lo stanno già facendo.» «Che fretta c’è? Hai detto che non c’è nessuno a casa ad aspettarti» gli risponde la ragazza. «E poi non hai un bell’aspetto. Forse quella roba era troppo forte per te. Forse è meglio se rimani sdraiato e se riposi un altro po’.» Lanny prende il suo computer portatile dal piano della cassettiera ricoperta di formica tutta sbrecciata e si avvicina a lui. «Ho scaricato queste foto dalla macchina fotografica mentre dormivi. Ho pensato che ti avrebbe fatto piacere vederlo. Cioè, so che l’hai già visto, hai visto il suo corpo, ma forse ti interessano comunque...» Luke sussulta a quel discorso un po’ macabro, non gli fa piacere ricordare il cadavere all’obitorio e il suo rapporto con Lanny, ma quando lei gli porge il computer lo prende. Nella penombra del tramonto, le immagini sono splendenti e coloratissime sullo schermo. È l’uomo che ha visto sul tavolo dell’obitorio ma non c’è paragone. In quelle foto è vivo, intero, magnifico. Gli occhi e il volto risplendono di vitalità. Ed è incredibilmente bello. Tanto che a vederlo Luke avverte una strana tristezza. La prima foto dev’essere stata scattata all’interno di un’automobile, con il finestrino abbassato. I suoi lunghi capelli neri svolazzano attorno al volto e ha gli occhi socchiusi perché sta sorridendo alla donna che ha scattato la foto, ride per qualcosa che Lanny ha detto o fatto. Nella foto seguente è a letto, il letto che devono aver condiviso nell’alloggio dei Dunratty, la testa su un cuscino bianco, e ancora i capelli sul volto, ciglia così lunghe da sfiorargli le guance, la carnagione perfetta, gli zigomi alti. Uno scorcio di collo e di clavicola si intravede sotto un lenzuolo bianco crema. Dopo un minuto trascorso a guardare una foto dopo l’altra, Luke capisce che la cosa più bella dell’uomo nella foto non è il suo volto perfetto. Non è la sua bellezza. È qualcosa nella sua espressione, una magica interazione fra lo sguardo luminoso e il sorriso. È che è felice di trovarsi con la persona che gli sta scattando le foto. Luke sente un groppo in gola e restituisce il computer a Lanny, brusco. Non vuole più guardare quelle foto. «Lo so» dice la ragazza, con voce strozzata, dando sfogo alle lacrime. «Muoio al pensiero che non c’è più. Per sempre. La sua assenza è come una cavità nel mio cuore. Un sentimento che albergava dentro di me da duecento anni mi è stato strappato via. Non so come fare ad andare avanti. Ecco perché ti chiedo... ti prego, resta con me un altro po’. Non riesco a rimanere da sola. Diventerei pazza.» Appoggia il computer sul pavimento, poi prende la mano di Luke. Lui la sente piccola e calda nella sua. Il palmo è umido, ma Luke non capisce se sia lui o lei a sudare. «Non so come ringraziarti per quello che hai fatto per me» gli dice guardandolo negli occhi, fino in fondo all’anima, come se riuscisse a vedere ciò che si agita dentro di lui, nel profondo. «Io non... non ho mai... Insomma, nessuno è mai stato così gentile con me. Nessuno ha mai corso un rischio simile per me.» D’improvviso, la bocca di Lanny è sulla sua. Lui chiude gli occhi e sprofonda con tutto il suo essere nella bocca calda e umida di lei. Ricade sul letto da cui si è appena alzato, con il peso quasi impercettibile di lei sul suo petto e sente una parte di sé spezzarsi in due. Ciò che sta facendo in qualche modo lo disgusta, eppure non ha desiderato altro che questo dal momento in cui l’ha vista. Non tornerà a St. Andrew, non adesso almeno. La seguirà. Come potrebbe abbandonarla proprio ora? Lei ha bisogno di lui, e quel bisogno lo ha agganciato come un uncino al cuore, e ora lo sta trascinando con sé senza sforzo ed è impossibile resistere. Si sta gettando da una rupe in acque nere e profonde. Non riesce a vedere sul fondo, non sa che cosa lo aspetti, ma sa che niente al mondo potrebbe fermarlo. 26 Boston, 1817 Dopo aver ascoltato la storia di Adair, mi ritirai nella mia camera, terrorizzata e affranta. Mi arrampicai sul letto e mi raccolsi in posizione fetale. Ero atterrita dal ricordo di quello che mi aveva raccontato e cercai di dimenticarmene. Alejandro bussò e quando non ebbe risposta spinse la porta con un gomito ed entrò portando un vassoio con tè e biscotti. Accese alcune candele – «Non puoi star chiusa al buio, Lanore, è da fantasmi» – e poi mi posò una tazzina e un piattino accanto al braccio, ma io non volevo saperne delle sue cortesie. Finsi di avere lo sguardo perso fuori dalla finestra, su un tranquillo vicolo di Boston, ma in verità non vedevo assolutamente niente. Ero ancora accecata dalla rabbia e dalla disperazione. «Su, mia cara, non essere così triste. Lo so che fa paura. Anche io ero terrorizzato quando è successo a me perché era... sconosciuto. Un mistero, un buco nero e profondo.» «Ma, Alej... Che cosa siamo diventati?» gli chiesi, stringendo il cuscino al petto. «Tu sei te stessa, Lanore. Non sei diventata parte di un mondo magico. Non puoi attraversare i muri come un fantasma o far visita a Dio in cielo. Dormiamo e ci svegliamo, facciamo tutto quello che fa un normale essere umano. L’unica differenza è che un mortale si chiede, di tanto in tanto, quale sarà il suo ultimo giorno su questa terra. Ma io e te... I nostri giorni non finiranno mai. Continuiamo e continueremo per sempre a essere testimoni di quello che succede attorno a noi.» Disse tutto questo con impassibilità, come se l’interminabile scorrere dei giorni lo avesse privato di qualsiasi emozione. «Quando Adair mi spiegò quello che mi aveva fatto, volevo uccidermi. Volevo fuggire da questa terribile incognita, anche se ciò comportava porre fine alla mia vita con le mie stesse mani. Ma era l’unica cosa che non potevo fare. «Ma perdere anche il tuo bambino, come conseguenza... Non riesco nemmeno a immaginare quanto ti possa far soffrire. Povera Lanore. La tristezza un giorno passerà, davvero» proseguì con il suo inglese cantilenante, ancora marcato dall’accento spagnolo. Bevve un sorso di tè e poi mi osservò attraverso il vapore che saliva dalla tazza. «Ogni giorno che passa allontana sempre più il tuo passato e la vita con Adair diventa sempre più familiare. Sei parte della nostra famiglia. Poi, un giorno, ti verrà in mente qualcosa della tua vecchia vita – un fratello, una sorella, la casa in cui vivevi, un giocattolo che adoravi – e ti accorgerai di non provare più rimpianto. Sarà semplicemente qualcosa che ti è successo tanto tempo prima, tanto che non sembrerà nemmeno appartenerti. E a quel punto capirai che il cambiamento è completo.» Gli lanciai uno sguardo da sopra la spalla. «Quanto tempo ci vuole perché la sofferenza cessi?» Alejandro sollevò una zolletta di zucchero con un paio di pinzette sottili e la lasciò cadere nella tazza. «Dipende da quanto sei incline al sentimentalismo. Io ho un cuore tenero. Adoravo la mia famiglia e ne ho sentito la mancanza per anni e anni dopo la mia trasformazione. Ma Dona, per esempio, con ogni probabilità non si è mai guardato indietro. Non ha lasciato niente di prezioso dietro di sé. La sua famiglia l’aveva abbandonato quando era soltanto un ragazzo, perché era un sodomita» disse Alejandro, abbassando la voce a un sussurro su quelle ultime parole, anche se in quella casa eravamo tutti sodomiti, se non peggio. «La sua vita era povera e incerta. Linciaggi. Fame. Prigione. No, non credo proprio che abbia rimpianti.» «Io non penso che la mia sofferenza passerà mai. Mio figlio non c’è più! Rivoglio mio figlio. Rivoglio la mia vita.» «Non potrai mai riavere tuo figlio, lo sai» disse con gentilezza, avvicinandosi a me per accarezzarmi il braccio. «Ma perché mai rivorresti la tua vita, piccola? Da quanto mi hai detto, non hai niente e nessuno da cui tornare. La tua famiglia ti ha cacciato di casa. Ti hanno abbandonato quando più avevi bisogno di loro. Non vedo niente che tu possa rimpiangere.» Alejandro mi fissò coi suoi occhi neri e gentili, come se potesse evocare la risposta dalle profondità del mio cuore. «Quando ci troviamo nei guai, spesso ci manca la nostra famiglia. Ma anche questo passerà.» «A dire il vero, c’è una cosa...» mormorai. Si sporse verso di me, ansioso di ascoltare la mia confessione. «Un amico. C’è un amico di cui sento particolarmente la mancanza.» Alejandro era, come lui stesso aveva detto, un animo gentile e malinconico. Chiuse gli occhi, come un gatto addormentato su un davanzale al sole, invitandomi silenziosamente a raccontargli la mia storia. «Sono sempre quelli di cui si sente di più la mancanza. Parlami di questo amico speciale.» Da quando avevo lasciato St. Andrew, avevo cercato in tutti i modi di non pensare a Jonathan. Era oltre le mie possibilità riuscire a non pensare mai a lui, perciò mi permettevo qualche breve indulgenza, per esempio qualche minuto prima di addormentarmi, e ricordavo il calore della sua guancia arrossata appoggiata alla mia, il modo in cui la mia schiena veniva percorsa da un brivido quando lui mi stringeva in vita e mi reclamava a sé. Era già abbastanza difficile controllare le mie emozioni quando Jonathan era soltanto un’apparizione evanescente ai confini dei miei ricordi. Ma rievocarlo di proposito, volontariamente, era più di quanto potessi sopportare. «Non posso. Non ci riesco. Mi manca troppo» dissi ad Alejandro. Lui si appoggiò allo schienale della sedia. «Questo amico è tutto per te, vero? È l’amore della tua vita. È il padre del tuo bambino.» «Sì» dissi. «L’amore della mia vita.» Alejandro attese che proseguissi, il suo silenzio era come una redine che mi tirava per il collo, così andai avanti. «Si chiama Jonathan. Sono innamorata di lui da quando eravamo bambini. Tutti dicevano che era troppo bello per mettersi con me. La sua famiglia possiede l’intero villaggio. Non è un posto grande, né ricco, ma tutti quelli che ci abitano dipendono dalla famiglia di Jonathan per sopravvivere. E poi, è un uomo bellissimo...» Arrossii. «Penserai che io sia una persona così superficiale...» «Per niente!» disse in tono amichevole. «Nessuno è immune alla seduzione della bellezza. Ma in sincerità, Lanore, come poteva quell’uomo essere così bello come dici? Pensa a Dona, per esempio. È così bello che è riuscito a conquistare uno dei più grandi artisti che l’Italia abbia mai conosciuto. Il tuo Jonathan è forse più bello di Dona?» «Se lo vedessi capiresti. Al suo confronto Dona sembrerebbe uno gnomo.» Questo strappò una risatina ad Alejandro; a nessuno di noi piaceva molto Dona, così vanitoso e insopportabile. «Cerca di non farti mai sentire da Dona a dire queste cose! Bene, ma... che cosa mi dici di Adair? È o non è un bellissimo uomo? Hai mai visto occhi come i suoi? Sono come quelli di un lupo...» «Adair ha un certo fascino.» Un fascino animale, pensai, senza dirlo ad alta voce. «Ma non c’è paragone, Alej. Credimi. Comunque non ha alcuna importanza. Non rivedrò mai più Jonathan.» Alejandro mi accarezzò la mano. «Non dire così. Non si sa mai. Forse accadrà.» «No, non riesco a immaginare di tornare a casa, non adesso. Non è come mi ha raccontato Adair? Come potrei mai spiegar loro quello che mi è successo?» Feci una risata di scherno. «Ci sono dei modi... Non potresti più vivere con loro. No, quello sarebbe fuori discussione. Ma una breve visita... Se tu rimanessi soltanto per poco tempo...» Si mordicchiò il labbro inferiore, con fare assorto. «Non darmi delle false speranze. È crudele da parte tua.» Le lacrime mi salirono agli occhi. «Per favore, Alejandro. Devo riposare. Ho un mal di testa terribile.» Mi posò per un attimo le dita sulla fronte. «No, non hai la febbre... Dimmi, questo mal di testa... È come un continuo prurito alla base del cervello?» Annuii. «Sì? Be’, mia cara, è meglio che ti ci abitui. Non è mal di testa: è parte del dono. Sei connessa a Adair adesso.» «Connessa a Adair?» ripetei. «C’è un legame fra voi due, e quel prurito è lì per ricordartelo.» Mi si avvicinò con fare cospiratorio. «Ricordi quando ti ho detto che sei cambiata soltanto per un aspetto, che non sei una creatura magica? Be’, invece siamo un po’ tutti magici, giusto un pochino. A volte penso che siamo come animali, sai? Devi aver notato che adesso tutto sembra più nitido, che riesci a sentire il più piccolo rumore, che ogni odore ti assale l’olfatto. Tutto questo è parte del dono. La trasformazione ci rende migliori. Siamo potenziati. Riuscirai a sentire una voce provenire da lontano e capire così chi sta arrivando a farti visita. Riuscirai a sentire l’odore della ceralacca e a capire che quella persona ti sta portando una lettera. Col tempo, smetterai di far caso a questi poteri, ma agli altri sembrerà che tu sappia leggere nel pensiero, che sia capace di magie! «La seconda cosa che devi sapere è che non sentirai mai più dolore. Ha a che fare con l’immortalità, credo. Non avrai mai più l’impulso della fame o della sete. Certo, ci vuole tempo prima che la sensazione di dover mangiare o bere scompaia... Ma potresti stare a digiuno per settimane senza sentire il morso allo stomaco, e senza svenire o sentirti debole. Potrebbe passarti sopra un cavallo e non avvertiresti altro che un leggero disturbo dove ti si è rotto un osso, ma la sensazione passerà in un secondo, il tempo che l’osso guarisca da solo. Adesso è come se tu fossi fatta di terra e di vento e potessi ripararti da sola.» Le sue parole mi fecero rabbrividire: dentro di me sapevo già che era così. «E la connessione con Adair, il prurito alla mente, è un memento del tuo potere perché soltanto lui può renderti di nuovo mortale. Solo per mano sua tu potrai sentire dolore. Ma ogni danno che dovesse infliggerti sarebbe temporaneo, a meno che non sia lui stesso a scegliere diversamente. Può importi qualsiasi cosa con la sola volontà, dolore, ferite, perfino la morte. Per mia mano, per mia volontà. Sono queste le parole che usa nel suo incantesimo. Sono queste le parole che ti legano a lui per sempre.» Mi portai una mano sulla pancia; aveva ragione a proposito del dolore. Il muto pulsare che avevo avvertito nel mio ventre svuotato era scomparso del tutto. «Sono sicuro che te l’ha detto. E devi credergli: adesso, lui è il tuo Dio. Vivi o muori solo per suo capriccio. E...» Per un momento la sua espressione si addolcì, come se stesse abbassando ogni difesa. «E dovresti stare attenta con Adair. Ti ha dato quello che ogni mortale vuole, ma solo finché tu gli sarai sottomessa. Se lo farai infuriare, non esiterà un secondo a toglierti tutto. Non scordarlo mai.» Ben presto capii che, lo volessi o meno, ormai facevo parte di quella strana famiglia e avrei fatto meglio a individuare al più presto il mio posto in essa. La mia vita era cambiata irrevocabilmente e dovevo trovare un modo per tirare avanti. Adair, da parte sua, aveva centinaia d’anni di esperienza. Gli altri che aveva scelto erano rimasti tutti con lui, probabilmente per una buona ragione. Mi ripromisi anche di dimenticare Jonathan. Ero convinta che non l’avrei mai più rivisto, nonostante quello che aveva detto Alejandro. La mia vecchia vita era finita in tutti i sensi: Boston era diversa da St. Andrew quanto la crema lo è dall’acqua, e non ero più una povera sprovveduta di campagna con una vita di stenti e delusioni davanti a sé. Avevo perso il bambino, l’ultima cosa che mi legava a Jonathan. Tanto valeva lasciarmi tutto alle spalle in un sol colpo. In pochi giorni mi accorsi che i ritmi di quella casa erano diversi da tutto ciò che avevo sperimentato nella mia piccola e laboriosa cittadina puritana. Tanto per cominciare, nessuno in quella casa, a parte la servitù, si svegliava prima di mezzogiorno. E in ogni caso, ognuno dei cortigiani di Adair rimaneva nella sua camera fino alle due, le tre, anche se si sentivano dei suoni dietro le loro porte: mormorii, risate improvvise, una sedia che strisciava sul pavimento. Alejandro mi spiegò che in Europa si faceva così: la sera, la parte più importante della giornata, era dedicata agli eventi sociali – cene, balli, giochi da tavola – e il giorno veniva trascorso a prepararsi con cura, a vestirsi a puntino, a pettinarsi e a scegliere il vestito più adatto alla serata. Si erano portati dietro dall’Europa alcuni servitori selezionati, quelli esperti nelle acconciature e nel mantenere un guardaroba alla moda. Lo ritenevo uno stile di vita decadente, ma Alejandro mi assicurò che la pensavo così solo perché ingannata dalla mia educazione americana e puritana. C’era una ragione, dopotutto, se i puritani erano scappati dall’Inghilterra in cerca di un nuovo mondo, mi fece notare. Il che mi porta al secondo aspetto strano della casa di Adair: nessuno sembrava avere uno scopo nella vita. Non c’erano affari di cui occuparsi e nessuno mai discusse di soldi in mia presenza. Nessuno parlava del vecchio continente, nessuno ricordava le vite passate (come mi disse Alejandro, «Lasciamo riposare i morti»). Non arrivava nessuna lettera, solo inviti da membri dell’alta società di Boston, curiosi di incontrare un nobile europeo. Il vassoio all’ingresso traboccava di inviti a feste, salotti e tè pomeridiani. L’unico argomento che interessava Adair e il suo entourage, il solo impegno che affrontavano con una certa serietà, la preoccupazione che riempiva le loro giornate, era il sesso. Ogni membro della conventicola aveva un compagno di giochi, per una sera o per una settimana. Poteva essere uno snob incontrato a un ricevimento o un lacchè noleggiato per la notte. C’era un flusso costante di donne che affollava la casa, volgari prostitute o rampolle di buona famiglia particolarmente licenziose. Nessuno, in quella casa, andava mai a letto da solo. Ma né Alejandro né Donatello sembravano interessati a me. Quando chiesi ad Alejandro se mi trovasse attraente, rise e mi disse di non fare l’ingenua. La famiglia era interamente dedita unicamente alla ricerca e alla sperimentazione del piacere. Tutto ciò che mi circondava era l’antitesi dell’educazione che avevo ricevuto da parte dei miei genitori, immigrati di discendenza scozzese e scandinava, in un luogo aspro e ostile. Alla lunga, il loro lassismo mi avrebbe disgustato, ma sulle prime tutto quel lusso, che nemmeno immaginavo esistesse, riuscì a sedurmi. St. Andrew era un villaggio di biancheria fatta a mano e di mobili di pino grezzo. Ora vivevo circondata da raffinatezze, e ogni nuova tentazione era migliore della precedente. Mangiavo e bevevo cibi di cui non avevo mai sentito parlare, indossavo abiti e gonne fatti di tessuti esotici provenienti dall’Europa e realizzati su misura da un sarto. Imparai a ballare e a giocare a carte. E mi diedero da leggere dei romanzi che mi aprirono a ulteriori nuovi mondi. Adair adorava le feste e siccome la sua presenza era ancora la novità del momento, a Boston, ce n’era una a cui andare quasi ogni sera. Lui portava ovunque con sé tutto l’entourage e lasciava che Alejandro, Dona e Tilde seducessero i bostoniani con i loro modi da vecchio mondo, i vistosi abiti all’ultima moda parigina, viennese e londinese, e i racconti sull’aristocrazia decadente dell’Europa. A lasciare davvero stupefatti tutti quegli snob, comunque, era Uzra, quando Adair la costringeva a venire con noi. Lei si avventurava all’aperto avvolta in un velo di tessuto bordeaux che la copriva dalla testa ai piedi. Una volta arrivati alla festa, il drappo cadeva a terra svelando Uzra in uno dei suoi costumi, con un corpetto aderente di organza e un gonnellino di veli, gli occhi cerchiati di kohl, catenelle di ottone attorno alla vita nuda, ai polsi e alle caviglie. I veli di seta erano di colori vistosi ma leggerissimi e lei era praticamente nuda a confronto con le altre donne, bardate con strati e strati di sottogonne, corsetti e calze. Uzra tintinnava dolcemente mentre camminava, lo sguardo basso, consapevole di essere ammirata da sguardi lascivi, come una bestia esotica. Le donne coprivano con una mano la loro bocca spalancata per la sorpresa, e gli uomini... L’atmosfera inevitabilmente si riempiva dell’odore muschiato del desiderio e tutti si davano da fare per risistemarsi i vestiti, cercando con estrema goffaggine di nascondere la propria erezione. In seguito, Adair spesso ci raccontava, ridendo, delle assurde proposte che riceveva: uomini che offrivano imponenti somme di denaro pur di passare un’ora da soli con l’odalisca. Avrebbero dato anche l’anima se lui gliel’avesse chiesto, commentava Adair quando eravamo tornati a casa dopo la festa e ci radunavamo attorno al tavolo in cucina, accanto al camino ancora tiepido, a bere una bottiglia di vino. «Tu potresti avere lo stesso effetto» mi disse in privato una sera Adair, la voce come una carezza di velluto, mentre salivamo le scale per ritirarci nelle nostre camere. «Il desiderio maschile è un’arma potente. Può annichilire anche il più forte degli uomini. Quando un uomo vede una donna che lo conquista col suo fascino, è pronto a rinunciare a tutto per averla. Ricordatelo bene, Lanore: a tutto.» «Rinunciare a tutto per me? Sei pazzo. Nessuno ha mai rinunciato a qualcosa pur di avermi» risposi seccata, ripensando a come Jonathan non era stato capace di opporsi alla sua famiglia per stare con me. Nel mio empito di autocommiserazione, non fui equa con lui, lo sapevo, ma ero stata ferita dal mio amato infedele e ne soffrivo ancora. Adair mi guardò con occhi intensi e appassionati e disse una cosa che non avevo mai preso in considerazione. «È triste sentire queste parole a proposito di qualsiasi donna, ma è ancora più triste se si tratta di te. Forse è perché non hai mai chiesto niente in cambio delle tue attenzioni. Tu non ti rendi conto del tuo valore, Lanore.» «Il mio valore? Lo conosco fin troppo bene: sono una sempliciotta ignorante che proviene da una famiglia di poveri.» Mi prese sottobraccio. «Non sei affatto una sempliciotta. E hai un fascino irresistibile per certi uomini, uomini che preferiscono la freschezza e la discrezione alla volgare messa in mostra delle proprie grazie. Troppo seno che spunta da un corpetto, un petto troppo prominente, troppo voluttuoso, mi capisci?» Non lo seguivo; in base alla mia esperienza, gli uomini rimanevano ipnotizzati proprio da quegli attributi, e il fatto che io non li possedessi in eguali proporzioni mi era sempre sembrato una mancanza da parte mia. «La tua descrizione di grazie femminili ’volgari’ mi fa pensare a Uzra, e non c’è volta in cui lei non faccia sbavare tutti gli uomini che la vedono. Eppure io e lei siamo agli antipodi» dissi per punzecchiarlo. «Non c’è un’unica misura della bellezza, Lanore. A tutti piacciono le rose rosse, ma è una bellezza comune. Tu sei come una rosa dorata, rara ma non per questo meno bella» mi rispose, intendendo farmi un complimento, ma io non riuscii a trattenere una risata. Ero magra come un ragazzino e col petto quasi altrettanto piatto. I miei capelli biondi erano ricci e ribelli come un cardo. Non potevo fare a meno di pensare che mi stesse lusingando per qualche suo oscuro scopo, eppure le sue parole dolci ebbero comunque un effetto. «Devi soltanto fidarti di me. Lascia che io ti guidi... Ti insegnerò come ridurre ai tuoi piedi qualsiasi uomo. Come ho fatto con Tilde, Alej e Dona» proseguì, accarezzandomi la mano. Forse era proprio quello il loro scopo; forse era quella la loro attività principale. In effetti, sembravano abilissimi nel portare le persone – specialmente gli uomini perché erano quelli con più potere – a fare ciò che volevano. Riuscivano a controllarli. Ed era un’abilità preziosa, senza dubbio. «Non è sufficiente conquistare il nemico; per controllarlo, devi riuscire a sedurlo.» «Considerami la tua allieva, allora» dissi, lasciando che Adair mi conducesse dentro la sua camera da letto. «Non te ne pentirai» mi assicurò. 27 Fu così che iniziò il mio apprendistato nelle arti della seduzione. Cominciò con le notti trascorse a letto con Adair. Dopo quella sera, in cui Adair mi aprì gli occhi su questo nuovo modo di vedere le cose, capii che era deciso a dimostrarmi che ero degna delle attenzioni di un uomo: lui. Continuammo ad andare alle feste, continuò a sedurre i bostoniani, ma quando tornavamo a casa c’ero sempre io al suo braccio. Mi portava a letto con sé ogni sera. Mi viziava e mi dava tutto ciò che chiedevo. Mi fece preparare della biancheria intima meravigliosa e dei magnifici corpetti (anche se ne avevo scarso bisogno, tanto era modesto il mio seno), nonché dei corpetti di seta colorata, orlata di nastri. Giarrettiere decorate di roselline di seta. Adair si incantava a vederle quando mi sfilava i vestiti. Mi dedicai interamente a diventare la sua rosa dorata. Mentirei se dicessi che non pensai mai a Jonathan in quel periodo. In fondo, era il mio primo amore. In ogni modo, mi sforzai di reprimere il sentimento che ancora provavo per lui, ricordandomi tutti i momenti peggiori fra di noi, le volte che mi aveva ferito senza nemmeno farci caso. Le voci che dicevano che aveva fatto un’altra conquista. Il momento in cui ero rimasta in piedi accanto a lui sulla collina a guardare il funerale di Sophia, sapendo che stava pensando a lei. Quando aveva baciato Evangeline davanti a tutta la congregazione pochi attimi dopo che gli avevo dato la notizia della mia gravidanza. Cercai di vedere il mio amore per Jonathan come una malattia, una febbre che mi consumava il cuore e la mente, e quei ricordi strazianti erano la cura. E le attenzioni del mio nuovo amante sarebbero state il mio ricostituente. Paragonando le mie esperienze con i due uomini, mi sembrava che far l’amore con Jonathan mi avesse riempito di felicità al punto di credere di essere in punto di morte. In quei momenti, ero a malapena consapevole del mio corpo, mi sembrava di levitare fino al soffitto tra le sue braccia. Era sublime. Invece con Adair era tutto concentrato nelle sensazioni corporee, era una fame di carne, muscoli, pelle, era la sensazione di potere che mi dava quando mi saziava. In quel periodo, la scoperta di quella fame che Adair mi suscitava non mi spaventò. Me ne deliziavo, all’opposto, e Adair, invece di reputarmi viziosa e ninfomane, sembrava compiaciuto di riuscire a provocarmi quelle sensazioni. Fu lui stesso a confermarmelo, una sera nel suo letto, mentre accendeva il narghilé dopo che avevamo fatto l’amore con particolare frenesia. «Ritengo che tu abbia una predisposizione naturale per il piacere» osservò con un sorriso lascivo. «Mi spingo a dire che tu adori stare fra le lenzuola. Fai tutto quello che ti chiedo, no? E non c’è niente di quello che ti ho fatto che ti ha spaventata, vero?» Quando confermai con un leggero cenno della testa, proseguì: «Allora è giunto il momento di espandere le tue esperienze, perché le arti del piacere funzionano così: più sono esperti gli amanti che si hanno, più esperti si diventa. Mi capisci?» Accolsi quell’affermazione corrucciando la fronte, con la sensazione che mancasse qualcosa. Si era già stancato di me? Il legame che si era creato fra di noi era soltanto un’illusione, dunque? «Non preoccuparti» mi disse, passandomi il fumo da bocca a bocca in un bacio. «Adesso ti ho fatto ingelosire, vero? Devi combattere sentimenti come la gelosia, Lanore. Non sono degni di te, ormai. Adesso hai una nuova vita davanti a te, una vita piena di nuove esperienze, se non ti fai prendere dalla paura.» In quel momento non volle spiegarmi altro, ma non dovetti aspettare molto. La notte seguente, Dona ci seguì a letto. E Tilde la notte dopo. Quando obiettai, spiegando che ero troppo imbarazzata per lasciarmi andare davanti agli altri, mi bendarono. La mattina seguente, quando lanciai uno sguardo pieno di vergogna a Tilde incrociandola sulle scale, ancora intorpidita dal piacere che era stata capace di darmi a letto, lei ringhiò: «È stata soltanto una performance, stupida puttanella» e si allontanò, dissipando ogni dubbio che si fosse trattato di qualcosa di più. Credo di essere stata ingenua, ma i piaceri della carne erano nuovi per me e le sensazioni che mi davano mi sopraffacevano. Nel tempo sarei diventata insensibile anche a quello che facevano alla mia anima. In breve tempo. Fu non molto dopo che accadde qualcosa di particolarmente significativo, anche se al momento non ne colsi l’importanza. Iniziò tutto con una lezione sull’astronomia e le arti della navigazione cui prendemmo parte all’Università di Harvard. La scienza era un po’ una mania in quel periodo e a volte le università tenevano lezioni pubbliche. Erano posti in cui farsi vedere, così come le feste, un modo di dimostrare che anche se eravamo persone mondane, non per questo eravamo prive di cervello. Perciò Adair ci impose di andare. La lezione di quel giorno era di ben poco interesse per me. Mi sedetti accanto a Adair e gli chiesi in prestito il suo binocolo da opera per scrutare il pubblico. C’erano molti volti che avevo già visto in precedenza, ma non ricordavo i nomi, e proprio quando iniziavo a pensare che era tutto uno spreco di tempo, notai Tilde che parlava con un uomo dall’altra parte dell’auditorium. Intravedevo soltanto parte del profilo dell’uomo, ne vedevo più che altro la schiena, ma era evidente che aveva un corpo magnifico. Passai gli occhialini da opera a Adair. «A quanto pare Tilde ha trovato un nuovo uomo» sussurrai indicandogliela. «Mmm credo proprio che tu abbia ragione» disse, osservandola. «È una cacciatrice nata, Tilde.» Di solito dopo le lezioni ci si incontrava con altri dell’alta società in una taverna. Ma quel pomeriggio Adair non aveva voglia di sopportare chiacchiere davanti a un caffè e una birra. Lo capivo da come sbirciava continuamente la porta. Poco tempo dopo Tilde entrò, a braccetto con un ragazzo che avevamo visto all’università. Era piuttosto appariscente, con un volto bellissimo (un pelo effeminato), un nasino piccolo e appuntito, una fossetta sul mento e meravigliosi riccioli biondi. Sembrava ancora più imberbe in compagnia di una donna sofisticata come Tilde, e anche se certamente lei non poteva essere scambiata per sua madre, la loro differenza d’età era ben visibile. Si unirono al nostro tavolo e Adair passò tutto il tempo a riempirlo di domande. Era studente ad Harvard? (Sì.) La sua famiglia era di Boston? (No, veniva da Philadelphia e non aveva alcun parente nella zona.) Quanti anni aveva? (Venti.) A quest’ultima risposta, Adair aggrottò la fronte, come se non gli fosse piaciuta. Una reazione strana. Poi Adair invitò il ragazzo a cena da noi quella sera. Sarò diretta: il cuoco preparò dell’agnello quella sera, ma era evidente che la portata principale era proprio il giovane dai capelli biondo chiaro. Adair continuò a fargli ogni tipo di domanda personale (aveva amici all’università? Una fidanzata?), e quando il ragazzo iniziò a mostrarsi perplesso, Alejandro intervenne nella discussione distraendoci con aneddoti e barzellette. Circolò più vino del consueto, e in particolare il bicchiere del ragazzo pareva sempre pieno, poi dopo cena agli uomini furono dati dei bicchierini di cognac e ci recammo tutti nella sala da gioco. Dopo una serata trascorsa a giocare a faraone Adair dichiarò che non sarebbe stato cortese rimandare il ragazzo nella sua stanza al college in quelle condizioni – poteva subire sanzioni per la sua ubriachezza se fosse stato sorpreso dagli istitutori – e insistette perché rimanesse con noi quella notte. A quel punto il giovane studente era tanto ubriaco da non riuscire a stare in piedi senza che qualcuno lo sorreggesse, perciò non era proprio nella posizione di rifiutare l’offerta. Adair ordinò a un servitore di aiutarlo a salire le scale. Noi ci radunammo davanti alla camera da letto di Adair come sciacalli ansiosi di dividersi la preda. Alla fine, Adair decise che saremmo stati io e lui a godere della compagnia del ragazzo e congedò gli altri. Ubriaco com’era, il giovane iniziò a spogliarsi senza obiezioni quando Adair glielo ordinò e mi seguì docilmente a letto. A quel punto accadde qualcosa di curioso. Mentre il ragazzo si spogliava, Adair lo studiò attentamente, non con piacere (come mi aspettavo) ma con occhio clinico. Fu solo in quel momento che scoprimmo che il ragazzo aveva un difetto a un piede; non era particolarmente deforme e indossava una scarpa speciale che gli consentiva di camminare in modo quasi normale. Ma era comunque una deformità e Adair, notandola, sembrò visibilmente deluso. Adair si accomodò su una sedia e rimase a osservare mentre il ragazzo mi possedeva. Da sopra la sua spalla notai la delusione sul volto di Adair. Era come se combattesse il ribrezzo verso il nostro ospite. Alla fine, Adair si tolse i vestiti e ci raggiunse, sorprendendo il ragazzo con le sue attenzioni, che furono comunque accettate (non oppose alcuna resistenza, anche se si lasciò scappare qualche lamento quando Adair fu particolarmente rude con lui). Poi dormimmo insieme, noi tre, con l’ospite relegato ai piedi del letto, stordito dagli effetti dell’alcol e insonnolito come sempre accade agli uomini dopo le effusioni amorose. La mattina seguente, dopo aver spedito via il giovane a bordo di una carrozza, Adair e Tilde ebbero una conversazione infuocata dietro una porta chiusa. Io e Alejandro rimanemmo a far colazione ascoltandoli – o piuttosto, cercando di non sentire le loro urla – mentre bevevamo il tè. «Che cosa sta succedendo?» domandai, indicando col mento la porta da cui proveniva la litigata attutita. «Adair ci ha dato ordini chiari e precisi. Dobbiamo andare in cerca di uomini attraenti, solo i più attraenti. Cosa vuoi che ti dica, Adair predilige i volti perfetti. In effetti gli interessa soltanto la perfezione, non l’avevi notato? E da quanto ho capito, il ragazzo che Tilde gli ha portato non era propriamente perfetto...» «Aveva un piede deforme.» Non capivo come quel dettaglio potesse fare la differenza; aveva un volto squisito. Alejandro scrollò le spalle. «Ah, ecco qual era il problema.» Si affaccendò a imburrare il pane e non disse altro, lasciandomi a mescolare il tè e a chiedermi perché Adair avesse quell’ossessione strana. Il fatto era che aveva preso quel ragazzo con particolare brutalità, come se avesse voluto punirlo per averlo deluso in qualche modo. Ripensarci mi faceva sentire a disagio. Allungai il braccio sul tavolo e afferrai la mano di Alejandro. «Ti ricordi la conversazione che abbiamo avuto qualche tempo fa, sul mio amico? Il mio bellissimo amico? Alejandro, promettimi che non racconterai mai di lui a Adair.» «Come puoi pensare che ti farei questo?» mi rispose, offeso. Adesso so che era tutta una recita. Ed era davvero un bravo attore, Alejandro. Dovevamo tutti esserlo quando avevamo a che fare con Adair, ma quello in particolare era il ruolo di Alejandro nel nostro strano ménage familiare. Era lui a cullare chi soffriva, a rassicurare chi aveva delle incertezze, a placare la vittima così che non scorgesse il colpo che le stava per essere inferto. Credevo che lui fosse buono, mentre Tilde e Dona mi sembravano cattivi, perfidi, falsi. Ma adesso capisco che ognuno di loro aveva un ruolo preciso da recitare. In quel momento, però, credetti alle parole di Alejandro. 28 Iniziai a diventare più curiosa nei riguardi dei miei coinquilini. Avevo appena cominciato a vederli come un branco che si muoveva insieme, ognuno con compiti specifici, recitando la propria parte con la facilità di chi aveva svolto quel lavoro ormai innumerevoli volte. Individuare la preda, distrarla, schiacciare la sfortunata vittima sotto i piedi, che si trattasse di un ragazzo con un piede deforme o un avversario sul tavolo da gioco. I tre erano come segugi al guinzaglio; Adair non doveva far altro che liberarli e si scagliavano sull’obiettivo, con sicurezza quasi soprannaturale. Io ero il quarto segugio, il cucciolo del branco, e ancora non avevo capito quale fosse il mio ruolo. E siccome erano un trio perfettamente accordato, si mostravano riluttanti a lasciare che un quarto strumento si inserisse mettendo a repentaglio la loro armonia, sicuri che sarei stata loro d’impaccio o comunque avrei rovinato la fredda grazia e l’efficienza con cui agivano. E a me andava benissimo così: non avevo alcun desiderio di unirmi al branco. Mi aspettavo il loro risentimento e la loro gelosia, viste tutte le attenzioni che Adair aveva per me, ma mi sorpresero. Sembrava non gli importasse. Eppure, dovevo aver spodestato uno di loro dal ruolo di prediletto e confidente di Adair. Ma nessuno sembrava arrabbiato per questo. Non c’era nemmeno una scintilla di gelosia fra di noi. A dire il vero, a parte Alejandro, non avevamo molte occasioni di contatto. Adesso tutti e tre mi sorridevano apertamente, ma senza malizia. Evitavano sia me sia Adair per quanto potevano, a parte quando andavamo e tornavamo dalle feste, e in quei brevi tratti insieme sembrava esserci un’allegria forzata sospesa fra di noi, come un odore di chiuso. Quando io e Tilde incrociavamo gli sguardi, per esempio, a volte notavo la piega torva della sua bocca e una leggera ruga sulla sua fronte, ma non sembrava gelosia. Quei tre vagavano per la casa come fantasmi, tormentati e impotenti. Una notte decisi di chiedere a Adair perché fosse così. In fondo, era più probabile che fosse lui a dirmi la verità che non quei tre. Attesi che Adair recuperasse una bottiglia di brandy e dei bicchieri da portare in camera da letto, mentre i servitori mi aiutarono a togliermi la gonna e il corpetto e mi sciolsero i capelli. Quando Adair versò il brandy nei bicchieri gli dissi: «C’è una cosa a cui penso molto e vorrei affrontare l’argomento con te...» Bevve un sorso abbondante prima di porgermi il bicchiere. «Lo sospettavo. Negli ultimi tempi mi sei parsa distratta.» «Riguarda... riguarda gli altri» iniziai, incerta su come proseguire. «Non chiedermi di mandarli via. Non lo farò. So che vorresti passare tutto il tempo da sola con me, ma non posso lasciarli girovagare da soli. E poi, è importante che rimaniamo insieme. Non possiamo sapere quando potrebbe capitarci di avere bisogno dell’aiuto di qualcuno, qualcuno che capisca, che sappia come stanno le cose. Un giorno te ne renderai conto» si affrettò a dirmi. «Ma io non desidero affatto che tu li mandi via. È solo che mi chiedo chi di loro abbia il cuore spezzato ora che tu passi tutto il tempo con me. Chi di loro soffre maggiormente la perdita delle tue attenzioni? Li osservo e mi dispiace per... Perché ridi di me? Non prendermi in giro, sto parlando sul serio.» Credevo che la mia ingenua sensibilità l’avesse intenerito e che mi avrebbe rassicurata dicendomi che nessuno provava risentimento nei miei confronti, che gli altri avevano avuto ciascuno il proprio turno per entrare nelle sue grazie ma sapevano che quel privilegio non sarebbe durato per sempre, che ciascuno aveva il suo posto nella nostra famiglia. Ma non fu quella la reazione che ottenni da Adair. La sua risata non era per sdrammatizzare. Era pura derisione. «La perdita delle mie attenzioni? Credi veramente che se ne stiano di sopra a piangere ogni sera prima di dormire ora che non sono più la luce dei miei occhi? Lascia che ti dica qualcosa a proposito delle persone con cui dividiamo questa casa. Hai tutti i diritti di saperlo, visto che sarai legata a loro per l’eternità. È meglio che tu stia sempre in guardia con loro, mia cara. Non avranno mai a cuore i tuoi interessi, mai. Non hai capito niente di loro, vero?» «Alej mi ha raccontato qualcosa» mormorai, abbassando lo sguardo. «Sono pronto a giurare che non ti ha raccontato niente di importante e di certo niente che possa indurti a diffidare di lui. Che cosa ti ha detto di sé?» Iniziai a pentirmi di aver affrontato l’argomento. «Solo che proviene da una famiglia altolocata della Spagna...» «Una famiglia importante, sì. I Calderón. Una grande dinastia, perfino, ma oggi non troveresti nessuna traccia di loro a Toledo. E sai perché? Hai mai sentito parlare dell’Inquisizione? Alejandro e la sua famiglia furono catturati dall’Inquisizione, dal più grande inquisitore in persona, Tomás de Torquemada. La madre di Alejandro, suo padre, sua nonna, la sua sorellina: li misero tutti in prigione. Avevano una sola scelta: o confessavano i loro peccati e si convertivano al cattolicesimo oppure sarebbero rimasti in prigione fino alla morte.» «E perché non si è convertito?» urlai. «Per salvarsi la vita, mi sembra un prezzo accettabile.» «Ma lui lo fece.» Adair si versò altro brandy e poi si mise davanti al focolare, il volto illuminato dalla fiamma scoppiettante. «Lui fece esattamente quello che gli avevano chiesto. Sarebbe stato uno stupido a rifiutare, date le circostanze. L’Inquisizione era molto orgogliosa della propria abilità nel fiaccare le persone: ne facevano una scienza. Lo tennero in una cella così piccola che dovette rannicchiarsi in posizione fetale per starci, costretto ad ascoltare le urla e le preghiere degli altri prigionieri per tutta la notte. Chi al posto suo non sarebbe impazzito? Chi non avrebbe fatto qualsiasi cosa gli chiedessero per salvarsi la pelle?» Per un momento, l’unico rumore nella stanza fu lo scoppiettio del fuoco e, dentro di me, sperai che Adair non proseguisse quel racconto. Volevo continuare a pensare all’Alejandro che conoscevo, dolce e ragionevole, non volevo sapere di quali atti di puro egoismo fosse capace. Adair ingollò l’ultimo sorso di brandy e fissò lo sguardo sul fuoco. «Lui consegnò sua sorella all’Inquisizione. Loro volevano una vittima esemplare, la dimostrazione vivente che il maligno era in mezzo a loro. Una ragione per liberare il paese dagli ebrei. Così, lui disse che sua sorella era una strega, una creatura del diavolo. In cambio della vita di sua sorella, che aveva soltanto quattordici anni, gli inquisitori lo lasciarono libero. E fu in quel momento che lo trovai, farfugliante come un folle per quello che aveva fatto.» «È orribile.» Rabbrividendo, mi avvolsi la coperta di zibellino attorno alle spalle. «Dona, invece, consegnò il suo maestro alle autorità quando lo arrestarono per sodomia. L’uomo che lo aveva tolto dalla strada, lo aveva sfamato, gli aveva dato una casa, dei vestiti. L’uomo che l’aveva ritratto sui muri di Firenze. Un uomo che lo adorava, lo amava con tutto il cuore. E Dona lo consegnò senza un attimo di esitazione, lo tradì. Sarei uno stupido se mi aspettassi qualcosa di diverso da lui. «E poi c’è Tilde. Lei è la più pericolosa di tutti loro. Viene da un luogo nel profondo Nord dell’Europa, dove d’inverno ci sono giorni in cui il sole appare soltanto per poche ore. Incontrai Tilde una di quelle gelide e lunghe notti, per strada. Era stata immersa nell’acqua e poi lasciata fuori al freddo dalla sua stessa gente. Vedi, si era innamorata dell’uomo più ricco del villaggio vicino. C’era soltanto un ostacolo sulla sua strada: lei era già sposata. E come decise di risolvere il problema? Uccise suo marito e i suoi due figli. Li avvelenò, convinta che nessuno l’avrebbe mai scoperta. Ma i suoi compaesani ci riuscirono e la condannarono a morte. Volevano che morisse per assideramento e quando la trovai era già mezzo congelata. I suoi capelli erano di ghiaccio, le sue ciglia e la sua pelle erano coperte di cristalli di ghiaccio. Stava morendo, eppure riuscì a guardarmi con un’espressione di odio puro.» «Basta, ti prego» piagnucolai, rintanandomi sotto la pesante coperta di pelliccia. «Non voglio sentire altro.» «La vera misura di un uomo si capisce soltanto quando sta affrontando la morte.» C’era un sogghigno malevolo nella sua voce. «Non è giusto. Ognuno ha il diritto di fare tutto quello che può per sopravvivere.» «Tutto?» inarcò un sopracciglio e sogghignò. «Comunque sia, credo sia giusto che tu abbia il diritto di sapere che sprechi il tuo tempo se provi compassione per loro. Sotto quell’apparenza incantevole e raffinata, sono dei mostri. C’è una ragione se li ho scelti. Occupano un posto preciso nei miei piani... Ma nessuno di loro è capace di amare qualcuno, a parte se stesso. Non ci penserebbero due volte a tradirti se potessero guadagnarci qualcosa. Arriverebbero anche a tradire me se pensassero di potersela cavare.» Si infilò a letto accanto a me e mi fece accoccolare su di lui, e mi sembrò di avvertire uno strano bisogno nelle sue carezze. «È proprio questo che trovo affascinante in te, Lanore. Hai un grande bisogno di amore e una grande capacità di dare amore. Hai la disperata necessità di dare il tuo cuore a qualcuno, e quando lo fai, lo fai con tutta te stessa, con incrollabile lealtà. Credo che faresti di tutto per l’uomo che ami. E sarà un uomo molto fortunato quello che un giorno conquisterà il tuo cuore. Mi piace pensare che potrei essere io quell’uomo fortunato.» Mi accarezzò i capelli per un po’ prima di addormentarsi, lasciandomi sveglia a chiedermi quanto sapesse di Jonathan, con quanta accuratezza avesse letto i miei pensieri. Tutti quei discorsi mi avevano dato i brividi; non riuscivo a capire lo scopo per cui aveva scelto di dare la vita eterna a qualcuno così immeritevole, di circondarsi di codardi e assassini, specialmente se quello di cui aveva bisogno era lealtà. I suoi piani, perché non dubitavo che avesse piani ben precisi, mi sfuggivano. E la cosa peggiore, la cosa che non riuscivo ad affrontare, era che non capivo perché mi avesse scelta, perché avesse deciso di aggiungere proprio me a quella perversa famiglia. Forse aveva visto in me qualcosa che gli aveva fatto capire che ero come gli altri; forse era riuscito a scrutare nella mia anima e aveva concluso che ero tanto egoista da spingere un’altra donna al suicidio pur di rubarle l’uomo che amava. Quanto al suo invito ad amare lui, non avrei mai creduto che un uomo come Adair avesse bisogno di essere amato... o che io fossi il tipo di donna capace di innamorarsi di un mostro. Giacqui tremante fra le braccia di Adair mentre lui dormiva profondamente. E Uzra? Non ci voleva un’intuizione soprannaturale per capire che lei non rispettava i canoni degli appartenenti alla famiglia di Adair. Lei era come una presenza sospesa sopra tutti gli altri. Non che gli altri si dimenticassero di lei, semplicemente nessuno ne parlava. Nessuno si aspettava che si unisse a noi quando ci radunavamo per chiacchierare e per bere fino a tardi la sera o, quando tornavamo da una festa, lei non si sedeva mai attorno al tavolo nella sala da pranzo per mangiare qualcosa. Ma di tanto in tanto sentivamo l’eco dei suoi passi sul soffitto o nei muri, come il rumore di un topo che si arrampica sulle pareti. Di tanto in tanto, Adair la convocava nella sua camera da letto e lei si univa a noi, le labbra strette e lo sguardo basso, arrendendosi senza vera partecipazione. Dopo però, quando ero da sola, veniva a cercarmi e lasciava che le pettinassi i capelli o le leggessi qualcosa, e io lo interpretavo come il suo modo di farmi sapere che non mi riteneva responsabile di quanto accadeva a letto con Adair o, quanto meno, perdonava la mia sottomissione a lui. Una volta, rimasi seduta immobile così che potesse truccarmi il volto come era usanza nel suo paese d’origine, con spessi cerchi di kohl attorno agli occhi da cui partiva una linea che mi percorreva le tempie. Poi mi avvolse in uno dei suoi abiti ampi e voluminosi tanto che alla fine solo i miei occhi furono visibili. E devo dire che il tutto mi conferiva un’aura molto esotica. A volte mi guardava in modo strano, come se cercasse di parlare direttamente alla mia anima, per trasmettere un muto messaggio. Un avvertimento. Non credevo di aver bisogno di avvertimenti da parte sua; sapevo che Adair era un uomo pericoloso e che rischiavo di compromettere la mia salute mentale, oltre che corrompere la mia anima, standogli troppo vicino. Pensavo di sapere dove fosse il confine e che sarei stata in grado di fermarmi prima. Quanto ero stupida. A volte, Uzra veniva in camera mia e mi abbracciava come se volesse confortarmi. Capitò anche che mi trascinasse fuori dal letto, insistendo perché la seguissi in uno dei posti in cui si nascondeva. Adesso mi rendo conto che lo faceva per farmi capire dove avrei potuto rifugiarmi quando fosse arrivato il giorno in cui avrei avuto bisogno di nascondermi da Adair. Tilde, d’altro canto, non mi diede alcun segno di avvertimento quando un pomeriggio mi prese per mano con un sospiro irritato e, ignorando le mie domande, mi condusse con decisione in una camera dove non andavamo quasi mai. Lì, su un tavolino vicino al camino, c’erano una bottiglietta di inchiostro, una serie di aghi disposti a ventaglio e un vecchio fazzoletto macchiato. Tilde si mise su una sedia, sistemandosi i riccioli ribelli dietro le orecchie, senza degnarmi di uno sguardo. «Togliti il corpetto e sfilati le maniche» mi disse seccamente. «Perché? Che intenzioni hai?» le chiesi. «Non te lo sto domandando, stupida puttanella» rispose, togliendo il tappo dalla bottiglietta di inchiostro e ripulendosi le macchie dalle dita. «È un ordine di Adair. Porgimi il braccio nudo.» Digrignando i denti, feci come mi diceva, sapendo che Tilde si divertiva a comandarmi, e poi mi accomodai sullo sgabello davanti a lei. Mi afferrò il polso destro e trasse a sé il mio braccio, torcendolo così che il tricipite le fosse accessibile, poi bloccò il mio braccio sotto il suo, un po’ come un fabbro che serra tra le ginocchia lo zoccolo di un cavallo per ferrarlo. La osservai con sospetto mentre sceglieva un ago, lo immergeva nell’inchiostro e poi lo infilava nella pelle bianca e delicata del mio braccio. Sussultai anche se non avvertii niente più della pressione del contatto. «Che cosa stai facendo?» «Te l’ho detto, è per ordine di Adair» grugnì. «Ti sto marchiando. Si chiamano tatuaggi. Immagino che tu non ne abbia mai visto uno.» Guardai le macchie sulla mia pelle, tre, poi quattro. Tilde lavorava velocemente. Sembravano nei di bellezza, che si formavano a mano a mano che l’inchiostro si spandeva sotto pelle. Dopo circa un’ora, Tilde aveva completato il contorno di un elmo grande quanto una moneta e aveva iniziato a tratteggiare uno strano animale, serpentiforme e irreale. Impiegai un minuto ancora a capire che stava disegnando un dragone. Fu in quel momento che Adair entrò nella stanza. Inclinò il capo per osservare il lavoro di Tilde. Strofinò un pollice sulla mia pelle, sporca di inchiostro nero e sangue rosso, per vedere meglio. «Sai che cos’è?» mi disse con orgoglio. Scossi il capo. «È l’emblema della mia famiglia. O meglio, lo stemma della mia dinastia adottiva» si corresse. «È l’emblema presente sul sigillo di cui ti ho parlato.» «Perché me lo stai tatuando addosso? Che cosa significa?» gli chiesi. Prese il fazzoletto e pulì il tatuaggio, per ammirarlo meglio. «Che cosa credi che significhi? Ti sto marchiando. Sei una mia proprietà, ora.» «È davvero necessario?» gli chiesi cercando di divincolare il braccio, il che non servì ad altro che a procurarmi uno schiaffetto da parte di Tilde. «Immagino che tu lo faccia a tutte le tue creature. Il tuo dov’è, Tilde? Me lo fai vedere? Così saprò come verrà quando l’avrai...» «Io non ce l’ho» disse lei secca, senza nemmeno rialzare lo sguardo dal suo lavoro. «Tu no?» Guardai Adair negli occhi. «Perché io sì, allora?» «È qualcosa di speciale che ho deciso di dare a te. Significa che sei mia per sempre.» Non mi piacque il suo sguardo di possesso. «Ci sono altri modi di trasmettere questo impegno a una ragazza, sai? Un anello, una collana, un simbolo della tua devozione, credo che sia questo il metodo tradizionale» dissi provocandolo. Il mio broncio parve divertirlo. «Quelli sono soltanto orpelli, volgari e passeggeri. Un anello te lo puoi togliere. Ma non potrai fare lo stesso con questo.» Fissai l’opera di Tilde. «Cosa vuoi dire? Intendi che la mia pelle sarà segnata per sempre?» Adair mi rispose con il sorriso crudele che avevo imparato a riconoscere. Lo usava sempre quando stava per fare qualcosa di spiacevole. Strappò il mio braccio dalla presa di Tilde e lo bloccò sotto il suo, inspirò a fondo, afferrò un ago e, dopo aver preso la mira, lo conficcò esattamente nel centro del disegno. Una fitta improvvisa e lancinante mi percorse il braccio e all’improvviso avvertii tutto il dolore delle punture che mi aveva fatto Tilde. «Per mia mano, per mia volontà» proclamò ad alta voce, in tono solenne, e a quel punto la ferita mi bruciò come se vi fosse stato cosparso del sale. Mi diede un’altra storta al braccio, brusca, per osservare ancora il tatuaggio, e io avvampai di dolore. Poi mi lasciò andare. «Lanore, mi sorprendi» disse Adair, in modo ostentato e altisonante. «Credevo che ti avrebbe fatto piacere sapere che ti ho in tale considerazione da volerti con me per l’eternità.» Il fatto era che aveva ragione; la parte più corrotta di me era lusingata dal fatto che un uomo mi desiderasse al punto da marchiare la mia pelle col suo nome. Ma non ero così ingenua da non esserne anche allarmata. Mi aveva trattato come un capo di bestiame. Trascorsero così diverse settimane. Per la maggior parte del tempo ero contenta di come mi trattava Adair: era abbastanza attento, generoso, gentile. Facevamo l’amore spesso e con frenesia. Ma c’erano volte in cui si comportava con crudeltà senza alcuna ragione, se non il proprio divertimento. Quelle volte, Alejandro, Dona, Tilde e io stessa diventavamo giullari di corte che cercavano di compiacere un sovrano dispotico e vendicativo, sforzandosi di sollevargli l’umore o, quanto meno, di evitare di essere il bersaglio della sua crudeltà. In quelle occasioni mi sembrava di essere intrappolata in un manicomio e non desideravo altro che scappare; solo che ero convinta di non poterlo fare. Gli altri erano rimasti con Adair, anche dopo aver subito quel trattamento per lunghissimo tempo. Mi avevano riferito che Uzra aveva cercato infinite volte di scappar via da lui. Di certo, se ci fosse stato un modo di fuggire, a quel punto lo avrebbero trovato. Inoltre, nonostante la mia preoccupazione per i modi di Adair, iniziò a tornarmi in mente Jonathan, sempre di più ogni giorno che passava. All’inizio fu soltanto il mio senso di colpa, perché ora c’era un altro uomo nella mia vita, come se avessi avuto scelta! Eppure, nonostante mi sforzassi di far prevalere la logica, nonostante cercassi di concentrarmi sul modo orrendo ed egoista in cui mi aveva trattato, Jonathan mi mancava e mi sembrava di tradirlo. Non contava il fatto che fosse stato promesso a un’altra donna e che avesse rinunciato a me: andare a letto con un uomo amandone un altro mi sembrava comunque sbagliato. E amavo ancora Jonathan. Se guardavo nel profondo del mio cuore, la verità era innegabile. Per quanto fossi lusingata dalle attenzioni di Adair, compiaciuta del fatto che un uomo che aveva girato il mondo trovasse me, proprio me, irresistibile, sapevo che se Jonathan fosse venuto a Boston il giorno dopo, avrei abbandonato Adair senza nemmeno salutarlo. Stavo semplicemente sopravvivendo. L’unica speranza che mandava avanti i miei giorni era quella di rivedere Jonathan, prima o poi. 29 Il tempo trascorse senza che riuscissi a misurarlo. Da quanto tempo ero con Adair? Sei mesi, sei anni? Avevo perso il conto e mi ero convinta che non avesse alcuna importanza; ormai non avrei mai più avuto bisogno di tener conto del tempo. Il tempo, in tutta la sua infinità, era aperto per me, ora, come l’oceano la prima volta in cui l’avevo visto. Troppo vasto per contemplarlo. Un tardo pomeriggio d’estate, un pomeriggio di cielo blu e oro, qualcuno bussò al portone. Poiché passavo di là e non c’era nessun servitore nelle vicinanze (avrei potuto scommettere che erano tutti a smaltire una sbronza di bordeaux trafugato in dispensa), aprii io, pensando che fosse un venditore ambulante o qualcuno venuto a far visita a Adair. Invece, in piedi sulla gradinata d’ingresso, con una sacca sulle spalle, trovai il predicatore di Saco dallo sguardo selvaggio. La sua bocca si aprì per lo stupore di vedermi e il suo volto ferino si illuminò di piacere. «Io vi conosco, signorina, vero? Riconosco il vostro bel volto, un viso così è impossibile da dimenticare» disse, avanzando nell’atrio senza attendere il permesso. Mi sfiorò col mantello impolverato e si tolse il cappello a tricorno. «Anch’io vi conosco» risposi, orripilata, ritraendomi, incapace di comprendere che cosa mai al mondo l’avesse condotto proprio lì. «Bene, allora non tenetemi in sospeso. Come vi chiamate e come ci siamo conosciuti?» mi chiese, ancora sorridendo ma in un modo che nascondeva l’opera delle sue meningi, mentre si sforzava di ricordare dove ci eravamo incontrati e in quali circostanze. Invece di rispondergli, gli chiesi: «Perché siete qui? Conoscete Adair?» La mia diffidenza parve divertirlo. «Ma certo che lo conosco, perché altrimenti sarei qui? Lo conosco allo stesso modo in cui lo conosci tu, scommetto» disse, abbandonando ogni finzione di cortesia. Allora era vero, adesso io e lui eravamo simili. Entrambi creature di Adair. E poi rammentò e il suo volto assunse un’espressione di gioia lasciva. «Oh, adesso sì che ricordo. Quel piccolo villaggio del Maine non lontano dall’insediamento acadiano. È lì che ti ho incontrata. Senza quella specie di sacco marrone che usate voi per vestirvi... Sei praticamente irriconoscibile con addosso tutta quella seta blu e quei pizzi francesi. È una trasformazione eccezionale, te lo posso giurare. Ti sei lasciata alle spalle i puritani senza alcun rimpianto, vedo. Non è così? Sono sempre i più tranquilli ad avere gli istinti più selvaggi» concluse, stringendo gli occhi a fessura e guardandomi maliziosamente, probabilmente calcolando le probabilità che finissimo a letto insieme e trovandole soddisfacenti. Non doveva far altro che chiederlo a Adair, era improbabile che non acconsentisse. In quel momento fummo interrotti dalla voce di Adair che rimbombò dal pianerottolo sopra di noi. «Guarda un po’ chi si fa vivo alla mia porta! Jude, sei qui per riposarti un po’ dai tuoi pellegrinaggi? Entra, entra, è passato troppo tempo dall’ultima volta che ci siamo visti» disse, scendendo a balzi le scale. Dopo aver abbracciato Jude con affetto, si accorse che quest’ultimo mi stava fissando con un chiaro desiderio e gli chiese: «Che succede? Vi conoscete già voi due?» «A dire il vero, sì, è così» rispose Jude, girandomi attorno, facendo aperta mostra della sua ammirazione. «Qualche tempo fa ti ho scritto per parlarti proprio di questa ragazza. Non ricordi una lettera in cui ti descrivevo una bellezza vergine e molto promettente con una vena animalesca?» Mi raddrizzai sulla schiena e sporsi il mento in fuori con aria di sfida. «E con questo cosa vorresti dire?» Ma Adair ridacchiò e mi accarezzò la guancia per placare la mia indignazione. «Su, mia cara. Mi pare che le sue intenzioni siano abbastanza evidenti, e tu non saresti al mio fianco se lui si fosse sbagliato.» Quell’ospite indesiderato mi scrutò da capo a piedi, come una massaia che saggia la consistenza e la maturazione di un frutto. «Be’, immagino che la sua bellezza non sia più vergine, vero? Quindi, hai preso questa ragazzina sfrontata come tua compagna spirituale, vedo. È così?» chiese Jude a Adair in tono scherzoso, poi si rivolse a me. «Dev’essere stato il tuo destino a volerlo, mia cara, non credi? Il fatto che sei qui lo dimostra. E tu sei fortunato, Adair, perché non sei stato costretto a spingerti fin lassù per averla. Credimi, è un viaggio che non augurerei a nessuno. E lei mi ha anche provocato qualche guaio quando ero lassù. Si è rifiutata di presentarmi al ragazzo di cui ti avevo scritto.» Si riferiva a Jonathan. Tenni la bocca chiusa. «Vorrei che ti tenessi per te tutte quelle fandonie sui ’matrimoni spirituali’, almeno in mia presenza. Non ne voglio saper niente di tutte quelle ciarlatanerie religiose» disse Adair, mettendo un braccio sulle spalle di Jude e conducendolo nel salotto. Il visitatore si diresse subito al mobile dei liquori. «Ma di chi stavi parlando? Chi sarebbe l’uomo di cui mi avevi scritto?» Il predicatore si versò un bicchiere di vino, fino all’orlo, e lo svuotò prima di rispondere, come se il viaggio lo avesse lasciato particolarmente assetato. «Ma non hai letto le mie lettere? Perché mi hai chiesto di spedirti dei rapporti scritti se poi non ti prendi nemmeno la briga di leggerli? Era tutto scritto nella lettera che ti ho spedito. Ti parlavo del villaggio dimenticato da Dio che ho scovato su nella parte più settentrionale del Maine. Questa ragazza, la tua ultima conquista» disse indicandomi con un cenno del capo mentre bevevo un altro bicchiere di vino, «mi ha impedito di conoscere un giovanotto molto promettente. Lo proteggeva con molta gelosia, a quanto ho potuto vedere. E doveva trattarsi proprio dell’uomo giusto, se quello che mi hanno raccontato di lui è vero.» Mi si accapponò la pelle; c’era sotto qualcosa di tremendo, lo sentivo. Rimasi in piedi paralizzata dall’ansia. Adair si versò del vino, senza offrirmelo. «È tutto vero, Lanore?» Non sapevo come rispondere e, in ogni caso, improvvisamente la mia prontezza di spirito mi aveva abbandonato. «Dal tuo silenzio capisco che è tutto vero. Quando avevi intenzione di parlarmi di lui?» mi chiese. «La tua spia non ha capito niente. Quell’uomo non è degno delle tue attenzioni» dissi, pronunciando parole che non credevo avrei mai detto a proposito di Jonathan. «È solo un mio amico, uno del mio villaggio.» «Oh, tutt’altro che indegno di attenzione. Stiamo parlando di Jonathan, lo stesso di cui hai spifferato tutto ad Alej? Su, non sorprenderti, è ovvio che Alejandro mi ha raccontato tutto. Dovevi aspettartelo. Sa bene che non deve tenermi nascosto niente. Dunque, parliamoci chiaro: questo Jonathan, questo esemplare di rara bellezza, è l’uomo che ami? Sono deluso, Lanore, deluso di vedere che ti lasci incantare da un bel visino e...» «E tu chi sei per dirlo?» sbottai infuriata. «Chi è quello che si circonda di bellezze come se collezionasse dipinti? Se l’amore per la bellezza è pura vacuità, allora tu sei ben più colpevole di me e...» «Oh, dai, non offenderti così facilmente. Ti sto soltanto provocando. Il fatto che questo Jonathan sia l’uomo che credi di amare è ragione sufficiente per me per volerlo incontrare, non capisci?» Jude inarcò le sopracciglia. «Se non fossi certo del contrario, Adair, sarei pronto a giurare che sei geloso.» In un disperato tentativo di far cambiare idea a Adair, lo implorai: «Risparmia Jonathan, ti prego. Ha una famiglia che dipende da lui. Non voglio trascinarlo in tutto questo. Quanto all’amore che provo per lui... Hai ragione, ma lui non fa più parte della mia vita. Lo amavo, un tempo, sì, ma ora non più». Adair inclinò il capo, scrutandomi. «Avanti mia cara, stai mentendo e si vede. Avresti rinunciato a lui da tempo se fosse così. Ma lo ami ancora. Lo sento, lo sento qui dentro» disse toccandomi il seno, sopra il cuore. I suoi occhi scintillanti, venati di tristezza, mi scavarono l’anima. «Portalo da me. Voglio incontrare l’uomo di straordinaria bellezza che è riuscito a conquistare la nostra Lanore.» «Se le tue intenzioni sono di portartelo a letto, non ci riuscirai. Non è... Non è come Alejandro o Dona.» Jude esplose in una fragorosa risata, poi si coprì velocemente la bocca e per un istante parve che Adair, ribollente di furia, fosse sul punto di schiaffeggiarmi. «Credi mi interessi soltanto per portarmelo a letto? Credi che sia l’unica cosa che potrei fare a un uomo come quel tuo Jonathan? No, Lanore, io voglio conoscerlo. Voglio vedere perché è così meritevole del tuo amore. Forse siamo simili, io e lui. Mi piacerebbe avere un nuovo compagno, un amico. Sono stufo di essere circondato di leccapiedi servili. Siete tutti dei servi o poco più: ingannevoli, astuti, traditori. Sono stufo di tutti quanti voi.» Adair si allontanò e sbatté il bicchiere vuoto sulla credenza. «E poi, che cos’hai da lamentarti della tua vita qui? Trascorri i giorni nel piacere e nel lusso. Ti ho dato tutto quello che potevi desiderare, ti ho trattato come una principessa. Ti ho aperto gli occhi sul mondo, no? Ho liberato la tua mente dalle costrizioni imposte da quei preti ignoranti e ti ho svelato segreti che gli uomini più saggi passano vite intere a cercare. E tutto questo te l’ho dato senza chiedere nulla in cambio, mia cara, non è così? Sinceramente, la tua ingratitudine mi offende.» Mi morsi la lingua, sapendo che non sarebbe servito a niente rinfacciargli tutto quello che avevo sofferto per colpa sua. Non potei far altro che chinare il capo e mormorare: «Ti chiedo perdono, Adair». Lui serrò ripetutamente la mascella e strinse il pugno sul tavolo fino a sbiancare le nocche, usando il silenzio per farmi capire che stava cercando di superare la rabbia. «Se questo Jonathan fosse davvero tuo amico, sarebbe naturale voler condividere la tua fortuna con lui.» Se quello era il modo in cui Adair vedeva la mia vita con lui, era un povero illuso. La verità era molto più complicata; per quanto gli fossi grata, avevo anche paura di lui e mi sentivo imprigionata in casa sua. Ero stata trasformata in una prostituta e non volevo che Jonathan mi vedesse così, tanto meno intendevo trascinarlo con me nella stessa situazione. Uscendo dalla stanza, Adair mi minacciò senza nemmeno voltarsi: «Non pensare nemmeno per un istante di potermi ingannare, Lanore. Ti opponi, ma nel tuo cuore è esattamente questo che vuoi». Non potevo permettere che Jonathan toccasse il mio stesso destino, né ora né mai. «Jude non esagera; Jonathan vive molto lontano da qui» proseguii, ignorando la sua provocazione. «Dovresti viaggiare per tre settimane su una barca e poi su un carro e ancora non vedresti nient’altro che foreste, campi e contadini.» Adair si voltò e mi osservò attentamente. «Molto bene. Non farò questo viaggio, se è così noioso come dici. Lo farai tu per me. Andrai là, prenderai quell’uomo e lo porterai da me. Come prova della tua lealtà.» Mi sentii morire. Durante la sua permanenza nella casa, Jude venne con noi alle feste, ma al termine di una notte di vizi, mentre salivamo le scale per andare nelle nostre camere, Adair impedì a Jude di seguirci fin dentro la camera, bloccando la porta con la spalla con un sorriso gelido e un ostentato augurio di buona notte. Jude non rimase molto. Trascorse un intero pomeriggio insieme a Adair, nello studio, a porte chiuse. Quando uscì, lo vidi riempirsi la sacca di monete: era chiaro che Adair lo stava ricompensando per qualcosa. Il giorno in cui doveva partire, Jude venne a cercarmi. Ero seduta a cucire nella sala della colazione, approfittando della mattinata chiara e tersa. Si inchinò davanti a me come se io fossi la padrona di casa, tenendo il cappello fra le mani. «Ti metti a cucire? Mi sorprende che tu abbia ancora voglia di prendere in mano ago e filo, Lanore. Di certo avete della servitù che può occuparsi di queste cose» disse. «Anche se credo sia una buona idea fare allenamento. Sai, la vita con Adair non sarà sempre così, grandi case, servitori a non finire, ricchezze da spendere. Ci saranno tempi peggiori, tempi in cui dovrai prenderti cura di te stessa, se la mia esperienza non mente» proseguì, con un mesto sorriso. «Ti ringrazio per il tuo prezioso consiglio» gli risposi in tono gelido, mostrandogli apertamente di non sopportare la sua presenza. «Ma come vedi sono occupata. C’è una ragione per cui sei venuto qui a parlarmi?» «Non approfitterò oltre della tua benevolenza, signorina Lanore» disse in tono quasi mite. «Partirò oggi stesso.» «La mia benevolenza? I miei sentimenti non hanno niente a che fare col fatto che sei il benvenuto in questa casa. È soltanto la volontà di Adair che conta.» Il predicatore ridacchiò, sbattendo il cappello sulla gamba. «Lanore, di certo sai benissimo che Adair tiene in considerazione i tuoi desideri in molte cose. È parecchio preso da te. Credo che tu sia davvero speciale per lui. Non credo di sbagliare se dico che non l’ho mai visto comportarsi così prima... Non l’ho mai visto così infervorato per una donna, potrei giurarlo.» Devo ammettere di esser stata lusingata dalle sue parole, anche se continuai a tenere il capo chino sul mio ricamo per non mostrare la mia soddisfazione. Jude a quel punto fissò il suo folle sguardo su di me. «Ma sono venuto anche per darti un avvertimento. Stai giocando un gioco pericoloso. C’è una ragione se tutti noi altri manteniamo le distanze da Adair. È una lezione che abbiamo imparato nel peggiore dei modi. Tu gli hai mostrato l’amore e questo gli ha messo in testa di meritarlo. Non hai mai pensato che l’unica cosa che tiene a freno il diavolo è che sa che tutti lo odiano? Anche Satana in persona ha bisogno di amore di tanto in tanto, ma amare il diavolo non fa altro che rafforzare le fiamme dell’inferno. Il tuo amore lo renderà ancora più spregiudicato e un giorno te ne pentirai.» Il suo ammonimento mi scosse e mi sorprese; non me lo aspettavo da lui. Ma non dissi niente, attesi che continuasse. «Ho una domanda da farti e spero che tu mi risponda sinceramente. Che cosa ci vede una ragazza come te in Adair? Ho guardato nel tuo cuore e ho visto che è selvaggio, avventuriero. Lui ti ha introdotto nel mondo dei piaceri della carne e tu l’hai abbracciato come soltanto una ragazza allevata secondo i principi puritani farebbe; e con sommo piacere di Adair, aggiungo. Forse non sei passionale ma soltanto stupida, Lanore, ci hai mai pensato? Concedi pure il tuo splendido corpo a Adair, se è quello che desideri, ma perché dare anche il tuo cuore a un uomo che ne farebbe scempio? Non merita la tua lealtà, né il tuo amore. Ti stai comportando in modo irresponsabile verso i tuoi stessi sentimenti, Lanore. Credo che tu sia un po’ troppo ingenua per stare con uno come lui. Perdonami se ti parlo così, ma è per il tuo stesso bene.» Ero sbalordita dalle sue parole. Chi si credeva di essere per darmi della stupida? Ero intrappolata come tutti gli altri, costretta a compiacere un tiranno per sopravvivere. No, in quel momento credevo di star facendo tutto quello che mi era possibile in una situazione orrenda come quella. Naturalmente, adesso vedo le cose in modo molto diverso. So di essere stata avventata, di aver mentito a me stessa. Avrei dovuto esser grata che Jude avesse corso il rischio enorme di mettermi in guardia su Adair nella sua casa, ma ero troppo sospettosa per fidarmi di lui e invece cercai di ingannarlo, di convincerlo che sapevo quello che stavo facendo. «Credo di doverti ringraziare per i tuoi consigli, ma perdonami se dico che sono io a decidere che cosa è meglio per me, non tu.» «Oh, ma non è più soltanto per te stessa, vero?» mi chiese. «Stai per coinvolgere anche il tuo Jonathan in tutto questo, l’uomo verso il quale dici di provare tanto amore. La prontezza con cui hai acconsentito alla richiesta di Adair mi fa pensare che forse, dopotutto, ha ragione lui. Tu vuoi fare quello che Adair ti ha ordinato, vero? Tu vuoi che l’uomo che dici di amare cada nella trappola di Adair, perché questo vorrebbe dire che sarebbe intrappolato insieme a te.» «Sai cosa penso?» dissi, quasi urlando, sbarazzandomi del tessuto che stavo cucendo e alzandomi. «Penso che tu non sia affatto intenzionato a darmi dei consigli. Penso che tu sia geloso. Volevi essere tu stesso a condurre Jonathan da Adair ma non ci sei riuscito. Io invece riuscirò dove tu hai fallito...» Nonostante la mia impetuosità, non sapevo che cosa stessi dicendo. Sicuramente avrei avuto più influenza io di Jude su Jonathan, ma a quale scopo? Jude lo sapeva, ma io no. Lui scosse il capo e indietreggiò di un passo. «Io mi accerto che tutti quelli che porto da Adair ne siano meritevoli, a loro modo. E vanno da lui spontaneamente. Cosa ancor più importante, non gli consegnerei mai una persona che amo. Mai.» Avrei dovuto chiedergli che cosa intendesse; ma come molti giovani, ritenni fosse meglio ingannarlo piuttosto che rivelargli che non sapevo quello che stavo facendo. E non mi fidavo di Jude; mi stava mostrando un volto completamente differente e non sapevo come prendere la cosa. Stava cercando di farmi cadere in trappola? Voleva che mi mostrassi sleale nei confronti di Adair, un padrone che aveva servito per molto più tempo di me? Forse era quello il suo ruolo nel branco di Adair, quello dell’informatore, dell’infiltrato. Della spia. Mi costrinsi ad assumere un’espressione ferma e decisa, ma tremavo, sconvolta. Jude mi aveva spinto ai limiti. «Ho sentito abbastanza. Adesso vattene prima che vada da Adair a riferirgli i tuoi inganni.» Lui si ritirò, sorpreso, ma solo per un momento, poi chinò le spalle. Si inchinò nuovamente, in un gesto esagerato di rispetto, poi si avviò fuori dalla stanza. «Credo di essermi completamente sbagliato su di te, Lanore. Sei tutt’altro che irresponsabile verso i tuoi sentimenti. Sai esattamente quello che stai facendo, vero? Spero che tu possa ottenere il perdono di Dio per quello che farai.» Cercai di rallentare il respiro e il battito del mio cuore, di convincermi che nessuna delle sue parole corrispondeva a verità. «Vai via» ripetei, avvicinandomi a lui come se potessi scacciarlo io stessa da quella casa. «Spero di non vederti mai più!» «Non credo che sia questo il nostro destino. Temo di no. Il mondo è un posto piccolo per chi ha a disposizione l’eternità. Te ne accorgerai. Indipendentemente dai nostri desideri, i nostri cammini si incroceranno ancora» disse, uscendo dalla stanza. 30 I preparativi del viaggio iniziarono immediatamente. Fu prenotato un passaggio a bordo di un cargo che sarebbe partito da Camden quattro giorni dopo. Dona, ben felice di vedermi partire, mi aiutò a scegliere un paio di robusti bauli da viaggio tra le decine e decine che erano giunti insieme a loro dall’Europa. In uno mettemmo i miei vestiti migliori e nell’altro i regali per la mia famiglia: un rotolo di seta proveniente dalla Cina; un set di colletti e polsini di pizzo belga, pronti per essere cuciti su un vestito; una collana d’oro con opali rosa incastonati. Adair insistette perché portassi dei doni che lusingassero Jonathan, per mostrargli quali piaceri offrisse il mondo al di là delle Great North Woods. Gli spiegai che il mio amico aveva soltanto una debolezza, le donne, perciò Dona frugò in un baule e trovò un mazzo di carte con illustrazioni molto esplicite al posto dei consueti fanti, regine e re. La regina di cuori era ritratta in una posa molto audace e scandalosa. Poi aggiunse un libro di versetti pornografici (anche se Jonathan non aveva mai mostrato interesse per la letteratura, se c’era un libro che poteva farlo appassionare era proprio quello); una piccola scultura di giada, che mi dissero di aver acquistato nell’Estremo Oriente, e che ritraeva tre persone nell’atto di fare sesso. E infine, un rotolo di velluto che invece di contenere braccialetti o anelli racchiudeva un set di falli, uno di legno, uno d’avorio e uno d’ebano. Davanti a quell’ultimo dono corrugai la fronte. «Non sono affatto sicura che questi siano di suo gusto» dissi, prendendo quello d’ebano, il più grosso dei tre, per studiarne i dettagli finemente incisi. «Non è perché lo usi lui» disse Dona, togliendomelo dalle mani e arrotolandolo insieme agli altri nel panno di velluto. «Hai già chiarito abbastanza le sue inclinazioni. Ma questi potrebbero essere utilizzati per, diciamo così, intrattenere le sue amanti, qualcosa di nuovo per stimolare le loro voglie e indurle a maggior licenziosità. Vuoi che ti mostri come usarli?» mi chiese, poi mi guardò di sbieco, sdegnato dalla mia mancanza di raffinatezza in materia di sesso. Forse non ero all’altezza del mio compito, secondo lui. Mentre Dona frugava nei bauli, cercando lo specifico gingillo che aveva in mente, anch’io mi divertii a frugare dentro i bauli, aprendo misteriosi involti di tessuto e meravigliandomi di fronte ai tesori che contenevano (un carillon tempestato di pietre preziose a forma di uovo, un uccellino meccanico che sbatteva le ali e cantava una melodia tintinnante). Finché, dentro un baule impolverato infilato sotto una mensola nell’angolo della stanza, trovai un oggetto che mi fece venire la pelle d’oca. Un pesante sigillo dorato (ma fatto sicuramente d’ottone; un sigillo così grande e pesante, se fosse stato fatto tutto d’oro, sarebbe valso una fortuna), avvolto nel velluto e chiuso dentro un borsello di pelle di daino. Era il sigillo del medico, morto da centinaia d’anni, di cui Adair mi aveva parlato? L’aveva conservato come ricordo? «Ecco qui.» La voce di Dona mi riscosse e io chiusi in fretta il baule e lo spinsi al suo posto. Dona aveva avvolto i regali per Jonathan in un fazzoletto di seta rossa e l’aveva chiuso con un nastro dorato. I regali per la mia famiglia invece li aveva infilati in un sacchettino di stoffa blu chiuso da un nastro rosso. «Cerca di non confonderli.» Forse furono tutti i preparativi a indurmi in uno stato di tranquilla compiacenza. Adair era stato così gentile con i regali e mi aveva organizzato un viaggio nel lusso e nella comodità. Iniziai a chiedermi se non ci fosse una possibilità in tutto questo, una chance di sfuggire alla sua presa ferrea. Forse avrei dovuto trattenermi dal considerare quelle opportunità di ammutinamento in presenza di Adair, a letto accanto a lui, ma a centinaia di miglia da lui sarei stata al sicuro. Di certo la distanza avrebbe indebolito il nostro legame. Quel pensiero mi confortò, forse mi conferì perfino un eccesso di sicurezza. Cominciai a vedere in quel viaggio la mia opportunità di fuga; forse sarei perfino riuscita a convincere Jonathan a lasciare la sua famiglia e scappare con me. Tutto questo, fino al pomeriggio seguente. Io e Tilde stavamo tornando dalla modista dove lei aveva comprato un cappello nuovo quando vedemmo la ragazza. Era in un vicolo e osservava il traffico per le strade. Da quanto riuscimmo a vedere di lei, era magra e grigia, un piccolo topino vestito di stracci. Tilde si avviò verso di lei e la ragazza spaventata fuggì nel vicolo. Mentre mi chiedevo perché mai Tilde si fosse lanciata dietro la ragazza e se inseguirla o meno, le vidi sbucare insieme dal vicolo. Alla luce velata dalle nuvole di quel pomeriggio, constatai in che pessime condizioni si trovasse la giovane. Sembrava uno straccio appallottolato e gettato via. La consapevolezza di essere un rifiuto che non interessava a nessuno permeava il suo sguardo. «Lei è Patience» disse Tilde, tenendo stretta la piccola mano della ragazza nella sua. «Ha bisogno di un posto in cui stare, così ho pensato che potremmo portarla a casa con noi. Darle qualcosa da mangiare e un tetto sotto cui dormire per qualche notte. Credi che a Adair darà fastidio? No, vero?» Il suo sorriso era ferino e trionfante, e mi ricordò immediatamente di quando lei e gli altri mi avevano trovato per strada, qualche mese prima. Ed era proprio quello l’effetto che voleva ottenere. Vedendo la mia espressione allarmata, mi diede uno sguardo di avvertimento e capii che avrei dovuto starmene zitta. Tilde chiamò una carrozza e fece salire la ragazza prima di noi. La piccola si sedette sul bordo della panca, lo sguardo perso fuori dal finestrino, gli occhi spalancati a guardare Boston scorrere via. Anch’io ero stata così? Anch’io ero stata tanto indifesa, nient’altro che una preda per un predatore, che praticamente implorava di essere divorata? «Da dove vieni, Patience?» le domandai. Lei mi guardò con cautela. «Sono scappata.» «Da casa?» Scosse il capo ma non diede altre spiegazioni. «Quanti anni hai?» «Quattordici.» Sembrava non averne più di dodici e ne pareva consapevole. Distolse gli occhi dal mio sguardo curioso. Tilde la portò al piano di sopra non appena arrivammo alla casa. «Manderò un servitore con dell’acqua calda, così ti potrai dare una ripulita» disse, e la ragazza imbarazzata si portò una mano sulla guancia lercia. «Ti farò avere anche del cibo. Adesso vado a cercarti qualcosa di più caldo da metterti addosso. Lanore, perché non vieni con me ad aiutarmi?» Andò dritta nella mia camera e iniziò a frugare tra i miei vestiti senza nemmeno chiedermi il permesso. «Abbiamo dato a te tutti i vestiti più piccoli, se non sbaglio... Sono sicura che hai qualcosa che possa andar bene a quella ragazzina...» «Non capisco...» Mi piazzai di fronte a Tilde e chiusi l’anta dell’armadio. «Perché l’hai portata qui? Che intenzioni hai con lei?» Tilde sogghignò. «Non far finta di essere ingenua, Lanore. Tu più di ogni altro dovresti sapere...» «È ancora una bambina! Non puoi consegnarla a Adair come se fosse un giocattolo.» Nonostante avessi visto di persona Adair commettere atti di qualsiasi genere, non l’avevo mai visto molestare una bambina. Non credevo che avrei potuto sopportarlo. Tilde aprì un baule. «Forse è un po’ troppo giovane, ma non è certo un’innocente. Mi ha detto di essere scappata da una casa di correzione dove era stata mandata per partorire. Quattordici anni e incinta. Avanti, lo sai anche tu che le stiamo facendo un favore» disse, scegliendo un completo intimo aderente, con un corpetto che aveva dei laccetti di cotone nei punti strategici. Mi accasciai sul letto. «Dalle questo e dille di lavarsi bene.» Tilde mi gettò il vestito. «Io intanto vedo di procurarle qualcosa da mangiare.» Quando tornai nella sua stanza, trovai Patience davanti alla finestra a guardare giù in strada. Si scostò un ciuffo sporco dagli occhi e guardò con bramosia il vestito che tenevo in mano. Glielo porsi. «Avanti, indossalo.» Le voltai le spalle mentre si spogliava. «Tilde mi ha detto che vieni da una casa di correzione...» «Sì, signora.» «... dove hai partorito. Dimmi, che ne è stato del tuo bambino?» Il cuore mi balzò in gola; di certo non era scappata lasciandolo lì. «Me l’hanno tolto» mi spiegò difendendosi. «Non l’ho mai visto, nemmeno quando è nato.» «Mi dispiace.» «Ormai non c’è più niente da fare. Vorrei soltanto...» Si bloccò, forse pensando che non era opportuno confessare tutto a delle donne così misteriose e sospette, che l’avevano tolta dalla strada senza alcun motivo. «L’altra signora mi ha detto che potrei ottenere un lavoro qui, forse come sguattera in cucina?» «Ti piacerebbe farlo?» «Ma dice che prima devo conoscere il padrone di casa e vedere se mi approva.» Mi scrutò in volto per constatare se anch’io le davo la stessa versione, per sincerarsi che non le stessimo giocando un brutto tiro. Tilde si era sbagliata; quella ragazzina era ancora un’innocente. Che io lo volessi o meno, non riuscii a impedirmi di ripensare alle parole di Jude: era troppo innocente per frequentare uno come Adair. Non potevo permettere che le accadesse quello che era successo a me. La presi per mano. «Vieni con me. Non dire una parola, non fare rumore.» Corremmo giù dalle scale di servizio, che Tilde non usava mai, e attraverso la cucina giungemmo all’ingresso posteriore. C’era una manciata di monete sul tagliere, in attesa sicuramente di un fornitore. Le presi e le misi in mano a Patience. «Vai. Prendi questi soldi e tieniti il vestito, ma vai via subito.» Mi guardò come se fossi impazzita. «Ma dove posso andare? Mi puniranno di certo se torno alla casa di correzione e non posso tornare dalla mia famiglia...» «Allora accetta la punizione, oppure chiedi perdono alla tua famiglia. Per quanta malvagità e perversione tu abbia già visto, ce n’è molta di cui non sospetti nemmeno l’esistenza, Patience. Vai! È per il tuo bene» le dissi, spingendola fuori dalla porta, poi la richiusi con forza. La sguattera entrò proprio in quel momento e mi guardò allibita, e io risalii le scale e mi rifugiai nella mia camera. Presi a camminare nervosamente avanti e indietro. Se avevo cacciato quella ragazza per il suo bene, che cosa ci facevo ancora lì io? Sapevo benissimo che quello che stavo facendo con Adair era sbagliato, sapevo che quella casa era un posto maledetto, eppure... era stata la paura a tenermi lì. E fu nuovamente la paura ad assalirmi. Entro pochi minuti, Tilde avrebbe scoperto che la sua preda era stata liberata, e a quel punto lei e Adair si sarebbero avventati su di me come due leoni. Presi a ficcare dei vestiti in una sacca; ogni fibra del mio essere mi diceva che dovevo scappare. Altrimenti avrei affrontato una furia terribile. Mi ritrovai per strada e poi su una carrozza senza quasi pensarci, contando il denaro nella mia borsetta. Non era molto ma sarebbe bastato a farmi allontanare da Boston. La carrozza mi lasciò davanti a una stazione di diligenze e acquistai un biglietto per la prima in partenza, diretta a New York. «La diligenza partirà fra un’ora» mi disse l’impiegato alla cassa. «C’è un pub dall’altra parte della strada dove vanno di solito i viaggiatori ad attendere l’ora della partenza» mi indicò. Mi accomodai a un tavolo, con una tazza di tè davanti a me, la sacca ai miei piedi. Era il primo momento in cui potevo respirare e riflettere da quando ero scappata in fretta e furia. Anche se il terrore mi attanagliava il cuore, mi sentivo stranamente ottimista. Stavo abbandonando la casa di Adair. Quante volte ci avevo pensato senza averne il coraggio? Adesso lo avevo fatto d’impulso e non c’erano segni che fossi stata scoperta. Di certo non sarebbe riuscito a trovarmi in quell’ora, e a quel punto sarei stata in viaggio e sarebbe stato impossibile rintracciarmi. Chiusi le mani a coppa attorno alla tazzina di ceramica per riscaldarmi e mi concessi un piccolo sospiro di sollievo. Forse la casa di Adair era stata un’illusione, un brutto sogno che era sembrato reale soltanto finché ci ero dentro. Forse non aveva alcun potere su di me là fuori. Forse, trovare il coraggio di scappare era l’unica prova da affrontare. La domanda adesso, ovviamente, era dove andare e che cosa farne della mia vita. Poi, di colpo, mi accorsi della presenza di alcune persone accanto a me. Adair, Alejandro e Tilde. Adair si chinò su di me e mi sussurrò all’orecchio: «Vieni con me subito, Lanore, e non pensarci nemmeno a fare una scenata. Ci sono dei gioielli nella tua borsa, scommetto, e se chiedi aiuto dirò alla polizia che me li hai rubati. Gli altri testimonieranno in mio favore». La sua mano stava per spezzarmi il gomito. Mi sollevò dalla sedia. Sentivo la sua furia irradiare come il calore di un focolare acceso. Non riuscii a guardare nessuno di loro, sulla carrozza che mi riportava alla casa. Rimasi rattrappita, con la bocca secca per il terrore. Non appena entrati, Adair allungò un braccio e mi diede uno schiaffo, scagliandomi a terra. Alejandro e Tilde mi girarono attorno e scomparvero, come uccelli che si levano in volo da un campo con una tempesta in arrivo. Dalla furia nello sguardo di Adair, pareva che volesse farmi a pezzi. «Che cosa credevi di fare? Dove credevi di andare?» Non riuscii a parlare, ma fu subito evidente che lui non voleva risposte. Voleva soltanto colpirmi, e colpirmi ancora, perso in un attacco di rabbia, finché non giacqui ai suoi piedi ridotta a un mucchietto di ossa rotte. Lo guardai con gli occhi gonfi e iniettati di sangue. L’attacco di rabbia non gli era passato. Si medicò le nocche camminando furiosamente davanti a me. «È così che ricambi la mia generosità, la mia fiducia?» ruggì. «Ti ho accolto nella mia casa, nella mia famiglia, ti ho dato dei vestiti, mi sono preso cura di te... In un certo senso, per me siete come bambini. Perciò puoi ben capire la mia delusione. Ti avevo avvertita: tu sei mia, che tu lo voglia o meno. Non mi lascerai mai, mai, a meno che non sia io a volerlo.» A quel punto mi sollevò e mi portò sul retro della casa, dove c’erano la cucina e le camere della servitù, anche se sembravano scomparsi tutti come topi in fuga. Mi trasportò giù per una rampa di scale nella cantina, oltrepassando casse di vino, sacchi di farina e mobili inutilizzati coperti da drappi. Poi entrammo in uno stretto corridoio dai muri umidi e coperti di muffa, in fondo al quale c’era una porta di legno tutta segnata. Dentro quella stanza c’era pochissima luce. Dona, in piedi accanto alla porta con indosso una vestaglia stretta in vita, si piegò come se stesse per vomitare. Stava per succedere qualcosa di davvero terribile se Dona – che di solito gioiva delle disgrazie altrui – era così terrorizzato. In mano teneva una specie di bardatura per cavalli, sembrava una ragnatela di cuoio ed era diversa da qualsiasi altra avessi mai visto. Adair mi abbandonò per terra. «Preparala» disse a Dona, che iniziò a togliermi i vestiti inzuppati di sangue e sudore. Dietro di lui, Adair si spogliò. Quando fui completamente nuda, Dona mi sistemò addosso la bardatura. Era un incubo: costrinse il mio corpo in una posizione innaturale, aperta a ogni oltraggio possibile. I lacci mi fissavano le braccia dietro la schiena e mi tiravano la testa fin quasi al punto di staccarmela dal collo. Dona si lasciò sfuggire un mugolio mentre stringeva i legacci, ma non per questo li allentò. Adair torreggiava su di me, con fare minaccioso. Le sue intenzioni erano decisamente chiare. «È giunto il momento di insegnarti un po’ di obbedienza. Avevo sperato, per il tuo stesso bene, che non sarebbe stato necessario. Mi eri parsa destinata a qualcosa di diverso...» Si fermò, riprendendosi. «Ma tutti devono essere puniti almeno una volta, così che sappiano che cosa succederà se ci riprovano. Ti avevo avvertita, ti avevo detto di non lasciarmi mai, eppure ci hai provato lo stesso. Ma è stata la prima e ultima volta.» Adair infilò le dita tra i miei capelli e avvicinò il volto a pochi millimetri dal mio. «E ricordatene quando sarai di nuovo al tuo villaggio, con la tua famiglia e con il tuo Jonathan. Ricorda: non c’è posto al mondo in cui tu possa nasconderti da me. Ti troverò sempre. Non puoi scappare.» «La ragazza...» cercai di dire aprendo le labbra incrostate di sangue. «Questo non c’entra niente con quella ragazza, Lanore. Dovresti imparare ad accettare quello che succede in casa mia. E non soltanto lo accetterai, ne farai anche parte. Ma questo non c’entra. Hai voltato le spalle a me, hai rifiutato me. Non lo permetterò. Specialmente tu, non mi sarei mai aspettato che proprio tu...» Si interruppe, pensando che fosse meglio non esporsi, ma sapevo che cosa intendeva dire. Non voleva pentirsi di avermi dato un pezzo del suo cuore. Non ti racconterò quello che mi hanno fatto in quella stanza. Concedimi almeno questo brandello di riservatezza. Non voglio entrare nei dettagli della mia umiliazione. Sia sufficiente dire che fu la tortura peggiore che io abbia mai sofferto. Non fu soltanto Adair ad accanirsi su di me: arruolò anche Dona, sebbene l’italiano fosse riluttante. Era il fuoco dell’inferno contro cui mi aveva messo in guardia Jude, era la dimostrazione che risvegliare l’amore nel diavolo in persona era un rischio tremendo. Un amore come quello, ammesso che si possa chiamarlo così, non è mai dolce. E prima o poi lo si sperimenta per quello che veramente è: vetriolo, veleno, acido versato in gola. Ero a stento cosciente quando posero fine alle torture. Aprii gli occhi di una fessura e vidi Adair raccogliere i vestiti da terra. Era madido di sudore e i capelli gli stavano appiccicati al collo in riccioli umidi. Anche Dona si era rimesso i vestiti e stava strisciando sul pavimento, pallido e tremante, come se fosse sul punto di vomitare persino l’anima. Adair si passò le mani tra i capelli bagnati, poi si voltò verso Dona. «Portala su e ordina a qualcuno di pulirla» disse. Poi uscì. Dona mi sciolse dai legacci. Ogni movimento mi faceva soffrire. I legacci erano penetrati nella pelle, lasciandomi addosso decine di tagli e le ferite si riaprirono quando Dona li strappò dal sangue incrostato. Mollò a terra quell’orribile attrezzatura, che si accasciò come una sorta di vuota forma umana, e mi prese in braccio. Era il gesto più gentile che Dona mi avesse rivolto fino a quel momento, e da quel momento in poi. Mi portò nella stanza in cui c’era la vasca da bagno di rame. C’era Alejandro ad aspettarmi, con diversi secchielli d’acqua calda. Alejandro mi lavò con cura, ripulendomi dal sangue e dagli altri fluidi, ma nonostante la sua delicatezza, ogni volta che mi sfiorava provavo dolore. Non riuscivo a smettere di piangere. «Questo è l’inferno, Alejandro. Non posso più andare avanti così.» Mi prese una mano e la tamponò con un asciugamano bagnato. «Non hai scelta. Se ti può essere d’aiuto, sappi che ci siamo passati tutti. Tutti, nessuno escluso. Non ti devi vergognare per quello che ti è successo, non con noi almeno.» Mentre mi lavava, le mie ferite guarivano, i tagli più piccoli scomparivano sotto i miei occhi, i lividi si schiarivano. Mi asciugò e mi avvolse in un camicione pulito, poi mi portò a letto e si sdraiò accanto a me. Mi abbracciò, impedendomi di ritrarmi da lui. «Adesso cosa succederà?» gli domandai, le mani intrecciate alle sue. «Niente. Tornerà tutto come prima. Devi cercare di dimenticare quello che ti è stato fatto oggi, ma non dimenticare mai la lezione. Non dimenticarla mai.» La notte precedente alla mia partenza da Boston fu terribile. Volevo essere lasciata da sola con le mie angosce, ma Adair insistette per portarmi in camera sua. Ormai ero terrorizzata da lui, inutile a dirsi, ma Adair non sembrò cogliere questo mutamento. Forse ci era abituato perché tutti i suoi leccapiedi facevano così e si aspettava che, nel tempo, mi sarei ripresa. O forse non gli importava nulla di aver distrutto ogni brandello di fiducia che potevo aver nutrito in lui. Mi ricordai l’avvertimento di Alejandro e mi sforzai di agire come se non fosse successo niente, di dare le consuete attenzioni a Adair. Aveva bevuto molto, forse per dimenticare quello che mi aveva fatto, suscitando il mio terrore, e fumò il narghilé finché la camera non fu invasa da nuvolette di fumo narcotico. Quella notte a letto fui una compagna distratta e assente: non riuscivo a pensare ad altro che a ciò che avrei dovuto fare a Jonathan. Stavo per condannarlo a trascorrere l’eternità in compagnia di un folle. Jonathan non aveva fatto niente per meritarsi un simile destino. E nemmeno io. Inoltre, non avevo ancora deciso cosa dire alla mia famiglia quando sarei tornata a St. Andrew. In fin dei conti, ero scomparsa dalle loro vite quando ero fuggita dal porto, un anno prima. Sicuramente avevano chiesto di me al convento e alla capitaneria di porto, ottenendo come unica risposta che ero giunta a Boston, sì, ma per scomparire subito dopo. Forse speravano che fossi ancora viva e che fossi scappata per la vergogna e per tenere il mio bambino. O forse erano rimasti in contatto con la polizia di Boston, insistendo perché non cessassero le ricerche fino a che non fossero stati sicuri che ero stata uccisa. Mi domandai se mi avessero fatto il funerale a St. Andrew... no, mio padre non avrebbe consentito che si lasciassero trasportare dall’emozione. Probabilmente, mia madre e le mie sorelle portavano il lutto come un macigno sul cuore, cucito sotto la pelle. E Jonathan? Cosa credeva che mi fosse accaduto? Forse mi riteneva morta, ammesso che mi pensasse. Improvvisamente mi ritrovai gli occhi pieni di lacrime: certo che pensava a me di tanto in tanto, io ero la donna che più amava al mondo! Ma dovevo affrontare il fatto che per tutti, a St. Andrew, ero morta. Alla fine, quelli che sopravvivono riescono ad accettare la morte dei loro cari. Soffrono per qualche tempo, settimane, mesi, ma alla fine i ricordi entrano a far parte del passato, come un giocattolo che da piccoli si adora e che si ritrova per caso in soffitta: prima lo si accarezza, poi lo si rimette a posto. Mi svegliai alle prime luci dell’alba, sudata e scarmigliata da una notte di sonno inquieto. La nave sarebbe partita con la marea del mattino e dovevo arrivare al porto prima che il sole si fosse sollevato del tutto all’orizzonte. Chinandomi per recuperare i miei indumenti ai piedi del letto, vidi Adair, con la testa appoggiata al cuscino. Immagino sia vero che anche i diavoli sembrano angeli quando dormono, quando sono immobili e in pace con se stessi. I suoi occhi erano chiusi e le sue lunghe ciglia sfioravano le guance. I capelli gli cadevano sulle spalle in riccioli folti e lucenti; e la rada peluria sulle guance lo faceva apparire un adolescente. Non un adulto capace di crudeltà disumane. Tutto il fumo narcotico che avevo respirato quella notte mi aveva provocato un forte mal di testa. Se io mi sentivo così male, Adair doveva essere praticamente incosciente. Gli sollevai la mano e la lasciai andare: cadde a peso morto. Non fece nemmeno un borbottio, nemmeno una mossa sotto le coperte. In quel momento mi venne un’idea perversa. Mi ricordai della fiala d’argento che conteneva l’elisir dell’immortalità, le gocce di liquido satanico, magico, che mi avevano trasmutata per sempre in quello che ero ora. Prendilo, disse una voce dentro di me. Quella fiala contiene l’origine del potere di Adair. È la tua occasione di vendicarti di lui. Ruba il suo potere e portatelo dietro con te a St. Andrew. Con quella pozione, avrei avuto la possibilità di legare Jonathan a me, così come io ero legata a Adair. Quel pensiero mi attraversò la mente, provocandomi però una stretta allo stomaco. Non avrei mai potuto usarlo davvero... Non potevo trasformare un innocente in quello... in quello che ero ora, qualsiasi cosa fossi. Prendilo per vendicarti di Adair. È la radice di tutta la sua magia. Pensa a come sarà in preda al panico quando scoprirà che è scomparso! E io la volevo, la vendetta. Volevo vendetta per quello che mi aveva fatto nello scantinato. Lo odiavo per avermi costretta a compiere quella missione, per avermi forzata a condannare l’uomo che amavo a un’eternità insieme a un mostro come lui. Ma più di ogni altra cosa, volevo ripagarlo con la stessa moneta. Mi piace pensare che fu un potere più forte della mia ragione a indurmi a scivolare con cautela fuori dal letto, poggiando silenziosamente i piedi nudi sul pavimento. Mentre indossavo una delle vesti di Adair, esaminai la stanza. Dove avrei nascosto la fiala al posto suo? L’avevo vista soltanto quel giorno, né prima né in seguito. Andai nel guardaroba. Era forse sul carrellino in mezzo agli aghi per cucire? O nel portagioie insieme agli anelli e alle spille? Forse nel tallone di una babbuccia utilizzata di rado? Mi inginocchiai a frugare in mezzo alle sue scarpe, poi mi resi conto che Adair non avrebbe mai custodito un oggetto così prezioso dove il suo cameriere personale avrebbe potuto trovarlo e rubarlo. O se lo teneva sempre addosso – ma l’avevo visto nudo in diverse occasioni e non c’era traccia della fiala – oppure l’avrebbe nascosto in un posto in cui nessuno avrebbe mai pensato di cercarlo. Dove nessuno avrebbe osato cercarlo. Con una candela accesa in mano, uscii dalla stanza e scesi dalle scale della servitù fino allo scantinato, percorsi i corridoi sotterranei umidi e ammuffiti, strusciando una mano sulle pareti di pietra. Rallentai avvicinandomi alla stanza in cui nessuno entrava, quella che tutti temevano. Spinsi la porta tutta rovinata e mossi qualche passo sul pavimento lercio dove io stessa, poco tempo prima, ero rimasta accasciata a sanguinare. Trattenendo il fiato, mi avvicinai in punta di piedi all’unico baule che c’era, in un angolo. Lo aprii. All’interno trovai quell’attrezzatura odiosa, quella bardatura da incubo, ancora piegata secondo la forma del mio corpo, con i legacci di cuoio ancora umidi del mio sudore e del mio sangue. Quando la vidi fui sul punto di lasciare la presa sul coperchio, ma mi fermai quando scorsi un minuscolo fagottino nell’angolo del baule. Infilai dentro una mano e lo afferrai. Era un fazzoletto da uomo, piegato a formare un cuscinetto. Sollevai un angolo e vidi... la fiala. Alla luce della candela, l’argento brillò come una decorazione su un albero di Natale, con gli stessi riflessi vagamente offuscati. La luce sembrava pulsare minacciosa, quasi a segnalare il pericolo. Ma ormai ero giunta fin lì e non avevo intenzione di tornare indietro. La fiala era mia. La chiusi nel pugno, me la portai al cuore e la rubai da quella prigione. 31 Provincia di Québec, oggi Oltre la finestra della camera del motel, il cielo è diventato di un nero bluastro, il colore dell’inchiostro di una biro. Hanno lasciato aperta la tenda mentre si gettavano a letto insieme, e ora che la frenesia di scoprire il corpo dell’altro è passata, Lanny e Luke giacciono fianco a fianco, a guardare fuori dalla finestra le stelle del Nord. Lui le sfiora il braccio nudo con la punta delle dita, stupendosi della luminosità della sua pelle, della sua perfezione. Color crema, costellata di lentiggini d’oro chiaro. Il corpo di Lanny è un susseguirsi di curve morbide, tenui. Vorrebbe accarezzarla tutta, e poi ricominciare, come se facendo così potesse assorbirne una parte e tenersela tutta per sé. Si chiede se sia stato l’incantesimo a renderla più bella, a esaltare il suo aspetto naturale. Non riesce a credere di aver avuto la fortuna di poter fare l’amore con lei. Si sente vagamente come un vecchio pervertito mentre le esplora il corpo, come se non avesse tenuto una donna così stretta a sé da ben prima del suo matrimonio. Di certo non da quando aveva vent’anni, almeno, ma anche all’epoca non ricorda che il sesso fosse mai stato così incredibile, forse perché lui e la sua partner erano troppo imbarazzati. Sa bene che cosa direbbero la sua ex moglie o i suoi amici se lo vedessero con Lanny; lo riterrebbero nel bel mezzo di una crisi di mezz’età di proporzioni gigantesche, ridotto ad aiutare una ragazza appena maggiorenne a scappare dalla polizia in cambio di sesso. Lei lo guarda con un sorriso che le illumina il bellissimo volto, e lui non può fare a meno di chiedersi che cosa abbia di così attraente per lei. Ha sempre pensato a se stesso come un uomo qualunque: statura nella norma, abbastanza magro ma non certo in una forma tale da meritare ammirazione; capelli arruffati e mossi di un colore indefinito, tra il castano e il biondo. I suoi pazienti gli hanno più volte lasciato intendere di ritenerlo un po’ hippie, come quegli autostoppisti che calano in massa su St. Andrew d’estate, ma Luke è convinto che lo vedano così perché tende a essere parecchio disordinato quando non ha attorno nessuno che si prenda cura di lui. Che cosa ci vede una donna come lei in uno come me? pensa. Prima di poterglielo chiedere, comunque, qualcosa li distrae, qualcosa oltre il vetro. Vedono delle ombre e capiscono che c’è del movimento sul vialetto d’accesso. Luke ha giusto il tempo di alzarsi a sedere che qualcuno inizia a bussare violentemente alla porta. Si sente una voce maschile: «Aprite! Aprite, polizia!» Luke trattiene il fiato, incapace di pensare, di reagire, di fare qualcosa, ma Lanny balza fuori dal letto, con un lenzuolo avvolto attorno al corpo, e atterra sul pavimento senza fare alcun rumore, come una gatta. Si porta un dito alle labbra a indicargli di tacere e scivola oltre l’angolo, entrando nel cucinotto e poi nel bagno. Lui aspetta che si nasconda, poi scende dal letto, si mette una coperta in vita e apre la porta. Le sagome di due agenti di polizia riempiono il vano della porta ma Luke non riesce a vederli bene perché gli stanno puntando una torcia in volto. «C’è stata una chiamata, dicono che c’è un uomo che fa sesso con una minorenne... le dispiace accendere la luce, signore?» gli chiede uno degli agenti, in tono esasperato, come se non vedesse l’ora di sbattere Luke al muro e mettergli lo sfollagente alla gola. Entrambi fissano il petto nudo di Luke e la coperta allacciata in vita. Luke trova l’interruttore più vicino e accende la luce, illuminando la stanza. «Dov’è la ragazza che ha preso questa stanza?» «Quale ragazza?» riesce a dire Luke, con la gola secca e rovente come se fosse piena di sabbia del deserto. «Ci dev’essere un errore, questa è la mia stanza.» «Quindi è stato lei a registrarsi per questa stanza?» Luke annuisce. «Non credo proprio. Il tipo alla reception ci ha detto che è l’unica stanza occupata in questa parte del motel. A nome di una ragazza. Lei ha detto alla reception che la stanza era per lei e per suo padre.» I poliziotti si fanno avanti di un passo. «Una vicina ha detto di aver sentito della gente fare sesso qui dentro, e siccome il receptionist ha detto che qui c’erano un padre e sua figlia...» Il panico assale Luke, si sforza di trovare una via d’uscita dalla sua bugia. «Ah, sì, esatto. La ragazza, sì, siamo insieme, ecco perché ho detto che era la mia stanza, intendevo questo, ma non è mia figlia. Non vedo proprio come possa aver detto una cosa del genere.» «Certo, come no.» Sembrano tutt’altro che convinti. «Le dispiace farci entrare a dare un’occhiata? Vorremmo anche parlare con la ragazza. È qui?» Luke si blocca e ascolta. Non sente niente, il che lo fa pensare che lei sia riuscita a uscire senza farsi vedere. Negli sguardi dei poliziotti, Luke vede indignazione a malapena sotto controllo. Probabilmente non chiederebbero di meglio che buttarlo a terra e prenderlo a calci, fargliela pagare per tutte le ragazzine abusate che hanno visto nel corso degli anni. Luke sta giusto per balbettare una scusa quando nota che i poliziotti stanno fissando qualcosa dietro di lui. Si volta, facendo arrotolare la coperta malconcia color pesca attorno alle gambe. Lanny è lì, in piedi, con il lenzuolo avvolto attorno al corpo nudo. Ha in mano un bicchiere di plastica rosso tutto segnato, da cui sta bevendo dell’acqua. «Oh! Mi era sembrato di sentire qualcuno bussare. Buonasera, agenti. C’è qualcosa che non va?» I due poliziotti la squadrano dalla testa ai piedi nudi prima di rispondere. «È stata lei a prenotare questa stanza, signorina?» Lei annuisce. «E quest’uomo è suo padre?» Lei arrossisce. «Oddio, no. No... non so perché ho detto così a quel tizio alla reception. Probabilmente temevo che non ci avrebbe dato la stanza, visto che non siamo sposati. Sembrava, non so, il tipo che sputa sentenze, ecco. Ho solo pensato che non fossero affari suoi.» «Ah. Ah. Be’, dovremmo vedere la sua carta d’identità.» Si stanno sforzando di rimanere impassibili, di dissipare la loro sacrosanta furia ora che non c’è nessun pervertito da portare di fronte alla giustizia. «Non avete alcun diritto di controllarci. È tutto consensuale» dice Luke mettendo un braccio attorno a Lanny e attirandola al suo fianco. Adesso vuole che se ne vadano. Subito. Vuole lasciarsi alle spalle quest’esperienza imbarazzante e fastidiosa. «Dobbiamo soltanto accertarci che lei non sia un... Lo sa» dice il più giovane dei due agenti, abbassando il capo e facendo un gesto spazientito con la torcia. Non c’è alternativa, Luke deve dare agli agenti la patente e far vedere anche il passaporto di Lanny, sperando che non sia stato diramato un bollettino da St. Andrew o quanto meno che non sia arrivato fino in Canada. Ma Luke si accorge subito che non avrebbe dovuto preoccuparsi: i due agenti sono talmente agitati e delusi che si limitano a dare uno sguardo frettoloso ai loro documenti, probabilmente senza nemmeno leggere i loro nomi, poi indietreggiano ed escono mormorando scuse appena udibili per il disturbo. Non appena se ne sono andati, Luke chiude la tenda che dà sul vialetto. «Oh, mio Dio» dice Lanny prima di lasciarsi cadere sul letto. «Dovremmo andarcene. Dovrei portarti in una città.» «No, non posso chiederti di correre altri rischi per me...» «Non posso certo lasciarti qui, no?» Si veste mentre Lanny è in bagno. Sente l’acqua che scorre. Si passa una mano sul mento e sente la barba ispida, rendendosi conto che sono passate ventiquattro ore da quando si è rasato l’ultima volta, poi decide di controllare se il parcheggio è libero. Infila un dito a uncino dietro una tenda e sbircia fuori: l’auto della polizia è parcheggiata accanto al SUV. Lascia ricadere la tenda. «Maledizione. Sono ancora là fuori.» Lanny alza lo sguardo dalla valigia. «Come?» «I due poliziotti, sono ancora là fuori. Staranno controllando la targa.» «Dici?» «Forse stanno vedendo se abbiamo dei precedenti.» Si strofina il labbro inferiore, pensoso. Probabilmente non possono avere risposte immediate sulle targhe o le patenti emesse negli Stati Uniti. Probabilmente devono attendere il responso dal computer, previa autorizzazione dei loro colleghi americani però. Forse lui e Lanny hanno un po’ di tempo prima che... Luke prende Lanny per un braccio. «Dobbiamo andare. Ora.» «Ma non cercheranno di fermarci?» «Lascia qui la tua valigia, dai. Vestiti e basta.» Escono dal motel mano nella mano. Si incamminano verso il loro veicolo quando un finestrino dell’auto della polizia si abbassa. «Ehi» dice il poliziotto seduto dal lato del passeggero, «non potete ancora andarvene.» Luke lascia la mano di Lanny così che lei possa rimanere indietro mentre si avvicina alla macchina di pattuglia. «Perché non possiamo andarcene? Non abbiamo fatto niente di male. Vi abbiamo già mostrato i nostri documenti. Non avete alcuna ragione di continuare a tormentarci. Tutto questo comincia a sembrare un caso di molestia.» I due agenti sono turbati, incerti, non gradiscono il suono della parola «molestia». «Ascoltate» prosegue Luke, aprendo le mani per mostrare che sono vuote. «Stiamo soltanto andando a cena. Vi sembra che vogliamo scappare? Abbiamo lasciato i bagagli nella stanza, abbiamo già pagato la notte. Se dopo i controlli di routine vi venisse in mente qualche altra domanda, potreste sempre tornare più tardi. Ma se non avete intenzione di arrestarmi, non credo proprio che possiate trattenermi.» Luke parla in tono calmo e ragionevole, le braccia aperte, come se cercasse di dissuadere dei ladri dal rapinarlo. Intanto, Lanny sale sul SUV, lanciando agli agenti uno sguardo vagamente ostile. Lui la segue, accende il motore ed esce lentamente dal parcheggio, controllando nello specchietto retrovisore che la pattuglia non gli stia alle costole. Solo quando hanno percorso un bel tratto di strada Lanny estrae il computer portatile da sotto il maglione e se lo poggia in grembo. «Non potevo lasciarlo lì. C’è roba che scotta qui dentro, cose tra me e Jonathan che potrebbero essere usate per incriminarmi» gli spiega, come se si sentisse colpevole per aver corso il rischio di portarselo via. Un secondo dopo, estrae il sacchettino di marijuana dalla tasca, come se stesse sollevando un coniglio dal cappello di un prestigiatore. Luke sente il cuore in gola. «Anche la marijuana?» «Quando avranno capito che non torneremo indietro perquisiranno la stanza... Questa roba avrebbe dato loro una ragione per arrestarci...» Rimette il sacchetto nella tasca del suo giaccone, sospirando esausta. «Credi che siamo al sicuro ora?» Luke controlla nuovamente lo specchietto. «Non so... Adesso hanno il numero di targa. Se si ricordano i nostri nomi, il mio nome...» Dovranno abbandonare il SUV da qualche parte. Luke si sente tremendamente in colpa per aver preso in prestito la macchina di Peter. No, non deve pensarci. «Non voglio pensarci adesso. Raccontami un altro po’ della tua storia.» Parte III 32 L’autostrada che conduce alla città di Québec ha due corsie per direzione ed è buia come una pista d’atterraggio abbandonata. Gli alberi spogli e il paesaggio anonimo che la attorniano ricordano a Luke Marquette, la cittadina solitaria a nord del Michigan in cui la sua ex moglie risiede. Luke ci è andato, una volta sola, per vedere le sue figlie, poco dopo che Tricia si era trasferita lì con il suo fidanzatino. Le due bambine di Tricia e Luke adesso vivono nella casa del ragazzo di lei, in un bosco di ciliegi, e due giorni alla settimana ospitano anche il figlio e la figlia di lui. Durante quella visita, vedendo Tricia col suo fidanzatino, Luke non l’ha trovata più felice di quando stava con lui; ma, forse, era soltanto imbarazzata che il suo ex marito la vedesse in quella casa quasi in rovina con una Camaro vecchia di dodici anni parcheggiata nel vialetto. Non che la casa di Luke a St. Andrew fosse messa meglio. Le bambine, Wynona e Jolene, erano infelici, ma c’era da aspettarselo; si erano appena trasferite e non conoscevano nessuno. A Luke si spezzava il cuore a stare lì, a mangiare nella pizzeria in cui le aveva portate per il pranzo. Se n’erano state zitte zitte tutto il tempo, troppo piccole per capire con chi prendersela, a chi dare la colpa. Avevano tenuto il muso nonostante tutti i suoi tentativi di alleggerire l’atmosfera, e lui non sopportava l’idea di doverle riportare alla madre e di salutarle, vedendole così ferite e chiuse. Ma sapeva anche di non poterci fare niente: non poteva sperare di risolvere tutti i loro problemi in un fine settimana. Ma al momento di ripartire, mentre diceva loro addio sui gradini di cemento davanti alla porta d’ingresso della casa di Tricia, le cose tra lui e le ragazze erano migliorate. La loro paura si era acquietata, era come se avessero ritrovato un po’ di terreno sotto i loro piccoli piedi. Piansero entrambe quando Luke le abbracciò per salutarle e agitarono le mani mentre lui risaliva a bordo dell’auto a noleggio e ripartiva. Eppure, quei piccoli passi avanti non bastarono a farlo sentire meglio. «Ho due figlie» dice Luke all’improvviso, sopraffatto dal bisogno di condividere qualcosa della sua vita con lei. Lanny lo osserva dal sedile del passeggero. «Erano loro nella foto a casa tua? Quanti anni hanno?» «Una cinque e l’altra sei.» Avverte una punta d’orgoglio, è tutto ciò che gli rimane del senso di paternità. «Vivono con la madre. E con l’uomo che lei vuole sposare.» Qualcun altro si sta prendendo cura delle sue figlie, ora. Lanny si volta per guardarlo in faccia. «Per quanto tempo siete stati sposati?» «Sei anni. Adesso siamo divorziati» aggiunge, poi si rende conto che probabilmente è inutile. «È stato un errore sposarci, ora lo capisco. Avevo appena terminato la mia specializzazione a Detroit. I miei genitori avevano iniziato ad avere problemi di salute e sapevo che sarei dovuto rientrare a St. Andrew... Probabilmente non mi andava di tornare da solo. E non riuscivo a immaginare che avrei potuto trovare qualcuno lì. Conoscevo tutti, ero cresciuto lì. Credo di... Credo di aver visto in Tricia la mia ultima possibilità.» Lanny stringe le spalle e una ruga di imbarazzo le si forma sulla fronte. Troppa onestà la imbarazza, pensa Luke, che sia lei o qualcun altro a essere onesto. «E tu? Tu ti sei mai sposata?» le chiede e per tutta risposta lei si mette a ridere. «Non mi sono nascosta per tutto questo tempo, se è quello che pensi. No, alla fine me ne sono fatta una ragione. Capii che Jonathan non si sarebbe mai legato a me in quel modo. Non era nelle sue corde.» Luke ripensa all’uomo all’obitorio. Qualsiasi donna sarebbe caduta ai piedi di un uomo come quello. Infinite seduzioni, infinite proposte, infinito desiderio, infinite tentazioni. Come ci si poteva aspettare che un uomo così si dedicasse anima e corpo a una sola donna? Era naturale che Lanny desiderasse che Jonathan amasse soltanto lei e le fosse fedele, ma come condannarlo per averla tradita? «Quindi hai trovato un altro uomo e ti sei innamorata?» Luke cerca di tenere la speranza fuori dalle sue parole. Lei ride nuovamente. «Per essere uno che si è sposato per disperazione e che ora è divorziato, mi sembri un romanticone senza speranza. Mi sono sposata, te l’ho detto, ma chi ha parlato di innamoramento?» Lei gli volta di nuovo le spalle. «No, non è del tutto vero. Ho amato tutti loro, tutti gli uomini che ho sposato, ma non come amavo Jonathan.» «Tutti loro? Quante volte ti sei sposata?» Luke sente di nuovo la strana, fastidiosa sensazione che ha provato la prima volta nel capanno dei Dunratty, quando ha visto il letto sfatto. «Quattro volte. Una ragazza si sente sola ogni cinquant’anni, più o meno» risponde Lanny, sogghignando con autoironia. «A loro modo, erano tutti brave persone. Si sono presi cura di me. Mi hanno accettata per quello che sono, per quello che potevo condividere con loro.» Questi scorci del suo passato gli fanno desiderare di saperne di più. «E quanto hai condiviso con loro del tuo passato? Hai raccontato loro di Jonathan?» domanda Luke. Lanny scuote il capo e i suoi capelli danzano attorno alla sua testa. Ancora non si volta per guardarlo. «Non ho mai detto a nessuno la verità su di me prima d’ora, Luke. Mai. Tu sei l’unico.» Lo sta dicendo soltanto a mio beneficio? si chiede Luke. Lei ha imparato a dire ciò che le persone vogliono sentirsi dire. È un’abilità fondamentale da acquisire se si vuole sopravvivere per centinaia di anni senza essere scoperti. La sottile arte di far entrare delle persone nella tua vita, legarle a te, fare in modo di conquistarle, perfino farle innamorare. Luke vuole sentire la sua storia, sapere tutto di lei. Ma dirà la verità? O lo sta soltanto manipolando finché non sarà al sicuro dalla polizia? Mentre Lanny torna a chiudersi in un silenzio pensieroso, Luke continua a guidare, chiedendosi cosa succederà quando arriveranno a Québec, se lei sparirà all’improvviso lasciandogli soltanto un frammento della sua storia. 33 Boston, 1819 Avevo svolto i preparativi per il mio viaggio di ritorno a St. Andrew con lo stesso entusiasmo che avrei impiegato per un funerale. Usando i soldi che Adair mi aveva dato quando ero partita, avevo prenotato un passaggio su un cargo che partiva da Boston per andare a Camden, e da Camden in poi avrei viaggiato a bordo di una carrozza noleggiata esclusivamente per me, con un cocchiere. L’unico mezzo di trasporto da e per St. Andrew era sempre stato il carro del droghiere, che due volte l’anno trasportava merce al negozio dei Watford. Avevo in programma di arrivare in pompa magna, facendo la mia comparsa in scena a bordo di una carrozza lussuosa con cuscini sulle dure panche di legno e tendine ai finestrini. Volevo che capissero tutti e subito che non ero la stessa donna che era fuggita da lì tempo prima. Era appena iniziato l’autunno e, mentre Boston era soltanto fredda e umida, i passi di montagna che conducevano alla parte settentrionale della contea di Aroostook probabilmente erano già innevati. Mi sorprese la nostalgia della neve di St. Andrew: un mantello bianco e intatto che copriva avvallamenti e colline, le punte coniche dei pini che spuntavano da cumuli di neve. Dappertutto, dolci dune bianche. Da bambina, passavo ore a guardare fuori dalla finestra ghiacciata del cottage dei miei genitori. Osservavo il vento spruzzare la neve con folate quasi orizzontali, neve fine come polvere, ed ero contenta di potermene stare dentro al calduccio, col fuoco acceso e cinque altri corpi attorno a me che mi riscaldavano. Perciò quella mattina andai al porto di Boston e aspettai di salire sulla nave che mi avrebbe riportata a Camden e, intanto, pensai a com’erano diverse le circostanze rispetto a quando ero arrivata. Con me c’erano due bauli pieni di vestiti meravigliosi e di regali, una borsa con più denaro di quanto l’intero villaggio vedeva in cinque anni, e avrei viaggiato nel lusso. Quando avevo lasciato St. Andrew ero una ragazza in disgrazia senza alcuna prospettiva. Ora tornavo come una raffinata lady che aveva avuto la fortuna di diventare ricca incappando in una sorte favorevole. Ovviamente, dovevo tutto a Adair. Ma questo non mi impediva di essere triste per quello che stavo per fare. Finché fummo in mare, mi nascosi nella mia cabina, ancora sopraffatta dal senso di colpa. In un tentativo di attenuare le mie emozioni, mi attaccai a una bottiglia di brandy e, sorso dopo sorso, cercai di convincermi che non stavo per tradire il mio primo amore. Stavo per fare un’offerta a Jonathan per conto di Adair, stavo per offrirgli un sogno: la vita eterna. Era un dono che qualsiasi uomo avrebbe accettato. Anzi, chiunque sarebbe stato disposto a pagare qualsiasi cosa per poterlo avere. Jonathan era stato scelto per entrare a far parte di un mondo invisibile. Avrebbe scoperto che la vita non era soltanto quella che conosceva. Non avrebbe certo potuto lamentarsi di quello che gli avrei proposto. Eppure io sapevo che quella nuova esistenza aveva un prezzo. Solo che ancora non sapevo quale sarebbe stato il prezzo per lui. Non mi credevo superiore ai mortali, non mi ritenevo una divinità. Anzi, sentivo di aver abbandonato la sfera umana e di essere entrata in un regno fatto di orrendi segreti e di rimorsi, un regno sotterraneo e oscuro, un luogo di punizione. Ma confidavo che ci fosse sempre una possibilità di ravvedimento, un modo di rimediare ai propri peccati. Nel tempo che impiegai ad arrivare a Camden, noleggiare la carrozza e iniziare il lungo viaggio solitario verso nord, l’idea di ribellarmi a Adair ricominciò a tormentarmi. Dopo tutto, quella terra era talmente diversa da Boston, Adair sembrava così lontano da me... Ma ricordavo fin troppo bene la punizione che lui mi aveva inflitto per aver tentato di scappare, e il pensiero di disobbedirgli ancora mi riempiva di terrore. Giunsi a un patto con me stessa: se, arrivata a St. Andrew, avessi constatato che Jonathan era felice della sua vita, tra la sua ingombrante famiglia e la sua sposa bambina, lo avrei risparmiato. Avrei pagato io le conseguenze: sarei fuggita e avrei cercato di rifarmi una vita, perché di certo non potevo tornare a Boston senza Jonathan. Paradossalmente, era stato Adair stesso a fornirmi i mezzi per fuggire: soldi, vestiti. Avevo quanto mi bastava, per cominciare. Quelle fantasie durarono ben poco. Non potevo certo scordare l’avvertimento di Adair, eseguire i suoi ordini oppure soffrire indicibilmente per mano sua. Adair non avrebbe mai permesso che lo abbandonassi. Con quello stato d’animo angosciato, mi preparai a giungere a St. Andrew in quel pomeriggio d’ottobre, ad affrontare la sorpresa della mia famiglia e di quelli che mi conoscevano nel rivedermi viva, e cogliere la loro delusione appena avessero scoperto come mi ero ridotta. Giunsi una domenica, col cielo coperto. Ero stata fortunata, la stagione non era ancora rigida e fredda e i tratti innevati lungo la strada erano stati comunque percorribili. Gli alberi spogli spiccavano su un cielo grigio come la flanella e le ultime foglie aggrappate ai rami avevano un colore spento, erano tutte raggrinzite e accartocciate, come pipistrelli appesi a testa in giù. La messa era appena terminata e la gente stava uscendo dalle ampie porte della congregazione per radunarsi sullo spiazzo. I parrocchiani erano rimasti in gruppetti a chiacchierare, nonostante il vento freddo, riluttanti come sempre ad abbandonare la compagnia degli altri per tornare nell’isolamento delle loro case. Non c’era traccia di mio padre; forse, ora che non c’era più nessuno che lo accompagnasse a messa, aveva preso ad andare alla chiesa cattolica. Ma i miei occhi individuarono immediatamente Jonathan e il mio cuore si sollevò nel vederlo. Era sul limitare dello spiazzo dove erano legati i cavalli e le carrozze e stava salendo a bordo del calesse della sua famiglia, con le sue sorelle e suo fratello in fila dietro di lui. Dov’erano sua madre e il capitano? La loro assenza mi preoccupò. Al suo braccio c’era una ragazza minuta, pallida di fatica. Jonathan la aiutò a salire sulla parte anteriore del calesse. C’era un fagottino fra le sue braccia. Un bambino. La sposa bambina aveva dato a Jonathan qualcosa che io non potevo più dargli. Alla vista del bambino, fui sul punto di perdere il coraggio e di ordinare al cocchiere di fare dietrofront. Ma non lo feci. La mia carrozza irruppe sulla scena e immediatamente attirò la curiosità di tutti i presenti. A un mio segnale, il cocchiere fermò i cavalli e io, col cuore in gola, saltai giù dalla carrozza ritrovandomi in mezzo alla gente che si era subito radunata attorno al veicolo. Mi accolsero con più calore di quanto mi fossi aspettata. Mi riconobbero, nonostante i vestiti nuovi e i capelli acconciati e la carrozza a nolo. Ero circondata da persone che avevo sempre ritenuto non si curassero di me: i Watford, il fabbro Tinky Talbot con i figli, tutti macchiati di fuliggine, Jeremiah Jacobs con la sua nuova moglie, della quale mi ricordavo il volto ma non il nome. Il pastore Gilbert si precipitò dai gradini della congregazione, con la tonaca mossa dal vento, mentre i miei vecchi vicini mormoravano attorno a me. «Lanore McIlvrae, che io sia dannato, è proprio lei!» «Ma guardatela, tutta imbellettata!» Mani si protesero dalla folla per stringere le mie, anche se con la coda dell’occhio vedevo le espressioni di disprezzo e le teste che si scuotevano. Poi la folla si divise in due per far passare il pastore Gilbert, che arrivò col volto arrossato per la corsa. «Signore nostro, sei davvero tu, Lanore?» mi chiese, ma lo udii a malapena tanto ero sconvolta dal suo aspetto. Com’era invecchiato! Era dimagrito e la sua pancia era quasi scomparsa, il suo vecchio volto era pieno di rughe come una mela dimenticata in una cantina fredda. Gli occhi erano appannati e arrossati. Mi strinse la mano con un misto di affetto e trepidazione. «La tua famiglia sarà così contenta di vederti! Credevamo tutti che fossi...» Si fermò, arrossendo, come se fosse stato sul punto di lasciarsi sfuggire una parola sbagliata. «Che ti fossi perduta. E invece sei tornata da noi, e ovviamente stai benissimo!» Quando nominò la mia famiglia, le espressioni dei presenti cambiarono, anche se nessuno disse una parola. Santo Dio, che cosa era successo alla mia famiglia? E perché tutti sembravano così invecchiati? La signora Watford aveva i capelli diversi da come me li ricordavo, erano grigi. I fratelli Ostergaard erano cresciuti e riempivano abbondantemente i loro vestiti, i polsi che spuntavano dalle maniche troppo corte. La folla si divise ancora, stava arrivando qualcuno. Era Jonathan. Oh, com’era cambiato. Aveva perso ogni traccia del ragazzo di un tempo; la scintilla da scavezzacollo che aveva sempre avuto nello sguardo era scomparsa, così come la sua baldanza da bellimbusto. Era ancora bellissimo, ma aveva un’aria più sobria ora. Mi guardò da capo a piedi, constatando com’ero cambiata anch’io e questo sembrò rattristarlo. Avrei voluto ridere e abbracciarlo per ravvivargli l’umore, ma non lo feci. Mi prese le mani fra le sue. «Lanny. Credevo che non ti avrei mai più rivista!» Perché continuavano tutti a dirmi la stessa cosa? «Ma, a quanto pare, Boston ti ha fatto bene!» «Sì» risposi, senza aggiungere niente. Volevo solleticare la sua curiosità. A quel punto, la ragazza col bambino si fece largo tra la folla e raggiunse Jonathan, piazzandoglisi accanto. Lui la prese e la spinse a farsi avanti. «Lanny, ti ricordi di Evangeline McDougal, vero? Ci siamo sposati poco dopo che te ne sei andata. Be’, è passato abbastanza tempo da quando sei partita perché avessimo il nostro primo figlio, a quanto vedi!» Fece una risata nervosa. «Una bambina, avresti mai detto che il mio primo figlio sarebbe stato una femmina? Non sono stato fortunato, forse, ma la prossima volta andrà meglio, vero?» disse a Evangeline, che arrossì. Era logico. Avrei dovuto aspettarmi che Jonathan si fosse sposato ed era del tutto probabile che avesse anche un figlio, ormai. Ma vederlo con sua moglie e sua figlia fu più difficile di quanto avessi immaginato. Mi sentii mancare il fiato, mi sentii intorpidita, incapace di congratularmi con loro. Come potevano tante cose essere cambiate così velocemente? In fondo, ero stata via soltanto qualche mese. «So che sembra tutto affrettato, la paternità e tutto il resto» disse Jonathan, togliendosi il cappello e abbassando lo sguardo, «ma il vecchio Charles voleva a tutti i costi vedermi sistemato prima di morire.» Sentii un groppo alla gola. «Tuo padre è morto?» «Sì, certo. Oh, scusa, tu magari non lo sai. È successo poco prima del mio matrimonio. Sono passati due anni, ormai.» Aveva gli occhi asciutti ed era molto calmo. «Si è ammalato poco dopo che tu te ne sei andata.» Erano passati più di due anni da quando ero partita? Ma come poteva essere? Era irreale, erano cose che succedevano soltanto nelle favole. Ero forse stata preda di un incantesimo? Avevo forse dormito per tutto quel tempo mentre il mondo andava avanti senza di me? Non riuscivo a parlare. Jonathan mi strinse la mano, scuotendomi dalla mia trance. «Non dovremmo trattenerti, devi andare dalla tua famiglia. Però devi venire a casa mia a cena, presto. Voglio sapere quali avventure ti hanno impedito di tornare da noi. Fino a ora, intendo.» Mi riscossi dal mio stupore. «Sì, certo.» La mia mente era altrove: se tutti quei cambiamenti si erano abbattuti sulla famiglia di Jonathan, che cos’era successo alla mia? Quali disgrazie l’avevano colpita? A giudicare da quello che aveva detto Jonathan, era passato tutto quel tempo da quando avevo lasciato il villaggio, ma questo non aveva senso. Il tempo si muoveva più velocemente qui? O era più lento a Boston, nel vortice delle feste notturne e nel languore della camera da letto di Adair? Chiesi al cocchiere di fermarsi in cima alla strada che portava a casa dei miei genitori. Il cottage era cambiato, impossibile negarlo. Già era modesto in partenza, ora era quasi in rovina. Mio padre l’aveva costruito con le sue mani, come gli altri primi coloni (l’unica eccezione era il capitano, che si era portato dietro dei muratori da Camden per farsi costruire la sua villa). Mio padre aveva costruito una casa a una sola stanza, fatta di legno, con l’intenzione di allargarla in seguito. E l’aveva fatto: un recesso dietro la stanza principale era la camera da letto di Nevin; per noi ragazze era stato approntato un soppalco, dove per molti anni avevamo dormito l’una accanto all’altra, come bambole su una mensola. La casa sembrava accasciata, come un buon cavallo che invecchia. La malta fra le travi si era scrostata, lasciando delle fessure. Al tetto mancavano diverse tegole. I detriti si erano accumulati sullo stretto portico e i mattoni del forno erano sconnessi. Vidi chiazze rosse tra gli alberi dietro la casa, il che voleva dire che c’era ancora bestiame al pascolo. La mia famiglia era riuscita a tenere almeno una parte del bestiame, ma a giudicare dalle condizioni della casa, era successo qualcosa di grave che aveva portato a una drastica riduzione dei loro guadagni. Erano evidentemente sulla soglia della povertà. Osservai la casa. La mia famiglia era tornata dalla chiesa – il carro era vuoto accanto al granaio e vedevo il vecchio baio castrato che pascolava nel recinto – ma non c’erano segni di attività, soltanto un sottile pennacchio di fumo che usciva dal camino. Un misero fuocherello in un giorno così freddo. Lanciai uno sguardo alla pila di legname. Sembrava abbandonata. I ciocchi di legno erano di sole tre file e l’inverno stava per arrivare. Dopo un po’, chiesi al cocchiere di arrivare fin sulla soglia. Attesi invano di vedere qualche segno di vita, allora mi armai di tutto il mio coraggio, scesi dalla carrozza e mi avvicinai alla porta. Bussai e fu Maeve ad aprire. Spalancò la nocca per la sorpresa e mi squadrò da capo a piedi, poi lanciò un urlo e mi gettò le braccia al collo. Danzammo abbracciate sulla soglia e poi, sempre danzando, entrammo in casa. Le sue grida di gioia mi assordarono. «Signore nostro, sei viva! Cara Lanore, credevamo che non ti avremmo più rivista!» Maeve si asciugò le lacrime di gioia dalle guance con un lembo del grembiule. «Quando non abbiamo più avuto notizie di te... Le suore hanno scritto alla mamma e al papà per dire che probabilmente eri... ti eri persa.» Maeve sbatté più volte le palpebre. «Persa?» «Morta. Uccisa.» Maeve mi guardò e aveva gli occhi asciutti. «Ci hanno detto che succedeva di continuo a Boston. Dei forestieri arrivano in città e i briganti li rapiscono, li derubano e li uccidono.» Il suo sguardo era rapito. «Ma se non ti eri... persa, se eri viva, che cosa è successo? Dove sei stata? Sono passati quasi tre anni!» Quasi tre anni. Ancora una volta, tutto quel tempo svanito nel nulla mi sconvolse. Al di fuori del tempo che avevo trascorso insieme a Adair, il resto del mondo era stato come un treno che rispetta i suoi orari, di certo non aveva rallentato per attendermi. Fui salvata dal dover dare una spiegazione così su due piedi quando mia madre salì dalla cantina, il grembiule teso per tenere qualche patata. Lasciò cadere tutto quando mi vide, impallidendo come un lenzuolo. «Non può essere!» Il mio cuore si fermò. «È così, madre. Sono tua figlia.» «Sei tornata dal regno dei morti!» «Non sono un fantasma» dissi, serrando le mascelle, cercando di trattenere le lacrime mentre la abbracciavo, avvertendo tutta la diffidenza nella tensione dei suoi muscoli vecchi e sottili sciogliersi lentamente. Mi abbracciò con tutta la forza che le rimaneva, che era molta meno di quanto ricordavo. Mentre parlavamo, anche lei pianse e si asciugò le lacrime dagli occhi. Alzò lo sguardo su mia sorella e le disse: «Vai a chiamare Nevin». Ebbi una stretta allo stomaco. «Devi proprio? Così presto?» Mia madre annuì. «Sì, dobbiamo. Adesso è lui l’uomo di casa. Mi dispiace dovertelo dire, ma tuo padre è morto, Lanore.» È impossibile prevedere le proprie reazioni di fronte a notizie come quella. Per quanto fossi stata furiosa con mio padre e per quanto avessi iniziato a sospettare che fosse successo qualcosa di terribile, l’annuncio di mia madre mi tolse il fiato. Caddi su una sedia. Mia madre e mia sorella si strinsero la mano. «È successo un anno fa» disse mia madre con compostezza. «È stato uno dei tori. Un calcio alla testa. È stato tutto così improvviso che non ha sofferto.» Loro, invece, avevano sofferto ogni giorno da quando era accaduto. Era evidente dai loro volti segnati, dai vestiti malandati, dalle condizioni della casa. Mia madre colse il mio sguardo sperduto con discrezione. «È stato un duro colpo per Nevin. Si è fatto carico di mandare avanti la fattoria e tu sai bene che è un lavoro durissimo per un uomo solo.» La bocca un tempo gentile di mia madre si era indurita in un’espressione grave. Era una reazione a quelle circostanze difficili. «Ma perché non avete preso qualcuno che vi aiutasse, qualche ragazzo delle altre fattorie? Oppure potevate affittare il terreno. Sono certa che c’è qualcuno al villaggio che vuole espandere la sua proprietà» dissi. «Tuo fratello non ne vuole sentir nemmeno parlare, perciò vedi di non toccare l’argomento con lui. Sai quant’è orgoglioso» rispose, voltandosi così che non potessi vedere l’amarezza sul suo volto. L’orgoglio di Nevin era stato la loro disgrazia. Dovevo cambiare argomento. «Dov’è Glynnis?» Maeve arrossì. «Adesso lavora dai Watford. Oggi sta riempiendo gli scaffali.» «Di domenica?» Inarcai un sopracciglio. «Lavora per ripagare i nostri debiti, a dire la verità» spiegò mia madre, e la sua confessione terminò in un sospiro di irritazione mentre puliva le patate. Il denaro che mi aveva dato Adair mi pesava nella borsa. Non c’erano dubbi: avrei dato a loro quei soldi e mi sarei preoccupata solo dopo delle conseguenze. La porta si aprì e Nevin entrò nella penombra della casa, una massiccia sagoma in ombra contro il cielo annuvolato. Ci volle qualche secondo prima che i miei occhi si abituassero e riuscissi a vederlo bene. Era dimagrito ed era diventato asciutto e muscoloso. Si era tagliato i capelli così corti che sembrava si fosse rasato, e il suo volto era sporco e pieno di cicatrici, così come le sue mani. Aveva lo stesso sguardo di disprezzo per me che aveva il giorno in cui ero partita, un disprezzo alimentato dal suo vittimismo e dalle disgrazie che si erano abbattute su di loro in mia assenza. Quando mi vide, emise una specie di grugnito e passò oltre. Raggiunse il catino con l’acqua per lavarsi e vi immerse le mani. Mi alzai in piedi. «Ciao, Nevin.» Lui grugnì ancora e si asciugò le mani con uno straccio prima di togliersi il cappotto malandato. Puzzava di bestiame, sterco e sudore. «Vorrei parlare con Lanore da solo» disse. Mia madre e mia sorella si scambiarono uno sguardo, poi iniziarono a muoversi verso la porta. «No, aspettate» le richiamai. «Usciamo io e Nevin. Voi rimanete qui, che c’è caldo.» Mia madre scosse il capo. «No, ci sono cose che dobbiamo fare prima di cena. Voi parlate pure.» Spinse mia sorella davanti a lei. La verità era che avevo paura a rimanere da sola con Nevin. Il suo disprezzo nei miei confronti era come una parete di roccia liscia e impervia. Non mi diede neanche un appiglio. Avrei fatto meglio ad andarmene, sembrava dirmi il suo sguardo di sfida, piuttosto che cercare la sua compassione o la sua comprensione. «Quindi sei tornata» disse, inarcando un sopracciglio. «Ma non rimarrai.» «No.» Non aveva senso mentirgli. «La mia casa è a Boston, ora.» Mi guardò con fare altezzoso. «Posso ben immaginare come ti mantieni, visto come sei vestita. Credi davvero che io o tua madre vogliamo sapere il modo vergognoso in cui ti sei ridotta? Perché sei tornata?» Era la domanda che più temevo. «Volevo rivedervi tutti» dissi, in tono implorante. «Volevo farvi sapere che non ero morta.» «Potevi darci questa notizia anche con una lettera. È passato tanto tempo e tu non ci hai mai fatto sapere niente.» «Non posso che scusarmi per questo.» «Sei stata in prigione? È per questo che non ci hai scritto?» mi chiese, con voce piena di sarcasmo. «Non ho scritto perché non ero sicura che avreste ricevuto volentieri mie notizie.» E cosa avrei mai potuto scrivere, comunque? Ero convinta che sarebbe stato meglio non far sapere più niente di me, meglio per loro, anche Alejandro mi aveva consigliato in tal senso. È una convinzione, o un’illusione, tipica dei giovani quella di credere di poter cancellare il proprio passato, senza che quel passato prima o poi venga a cercarli. Lui capì che era soltanto una scusa e sbuffò. «Non hai mai pensato all’effetto che il tuo silenzio poteva avere su nostra madre e nostro padre? Hai quasi ucciso la mamma. Ed è per questo che nostro padre è morto.» «Ma la mamma ha detto che è stato un toro...» «È così che è morto, certo. Con il cranio aperto in due da un toro, il sangue che colava nel fango e niente che potessimo fare per fermarlo. Ma hai mai visto nostro padre abbassare la guardia col bestiame? No. È successo perché era morto dentro. Dopo aver ricevuto la lettera dalle suore, non è più stato lo stesso. Si dava la colpa per averti mandata via. E pensare che sarebbe ancora con noi se tu gli avessi fatto sapere che eri viva!» Picchiò un pugno sul tavolo. «Ti ho già detto che mi dispiace. C’erano circostanze ben precise che mi hanno impedito di...» «Non voglio ascoltare le tue scuse. Hai detto che non sei stata in prigione. Torni con l’aspetto della puttana più ricca di Boston. Certo, riesco bene a immaginare quanto siano stati difficili per te gli ultimi tre anni. Basta, non voglio sentire altro.» Si allontanò da me, carezzandosi le nocche insanguinate. «Ho dimenticato di chiederti: dov’è il bambino? L’hai lasciato a casa col tuo protettore?» Le mie guance arrossirono come braci. «Sarai felice di sapere che il bambino è morto prima di nascere. Un aborto.» «Ah. La volontà di Dio, si dice così, no? La giusta punizione per la tua perversione, per esserti concessa a quel demonio di St. Andrew nella sua bella casa.» Nevin mi guardò in cagnesco, felice della notizia, felice di poter sputare sentenze. «Non ho mai capito come mai una ragazza intelligente come te fosse tanto accecata da quel bastardo di St. Andrew. Perché non mi hai mai dato ascolto? Io sono un uomo, proprio come lui, so come ragiona un uomo...» Lasciò cadere il discorso, esasperato. Avrei voluto togliergli quel sorrisetto soddisfatto dalla bocca, ma non potevo. Forse aveva ragione lui. Forse riusciva davvero a vedere dentro Jonathan e a capirlo meglio di me, e in tutti quegli anni aveva cercato di impedirmi di cadere in tentazione. Il mio fallimento era anche il suo. Si pulì nuovamente le nocche. «Allora, quanto pensi di rimanere?» «Non lo so. Qualche settimana.» «Nostra madre sa che non sei tornata per sempre? Che ci abbandonerai un’altra volta?» mi chiese Nevin aspro, ma con una nota di compiacimento nella voce, perché sapeva che avrei spezzato il cuore a mia madre un’altra volta. Scossi il capo. «Non puoi rimanere tanto» mi ammonì, «altrimenti la neve ti bloccherà qui fino a primavera.» Quanto tempo mi ci sarebbe voluto per convincere Jonathan a venire a Boston con me? Avrei potuto sopportare un intero inverno imprigionata a St. Andrew? Mi dava la claustrofobia soltanto il pensiero dei lunghi giorni bui dell’inverno, costretta dalla neve a stare rinchiusa in casa con mio fratello. Nevin infilò il pugno insanguinato nel catino, lavando la ferita che si era procurato da solo. «Puoi stare qui con noi finché sarai qui in visita. Se fosse per me ti sbatterei fuori, ma non voglio dare ai nostri vicini niente su cui spettegolare. Però devi comportarti bene per tutto il tempo, altrimenti ti caccio.» «È chiaro.» Mi passai nervosamente una mano sulla gonna di seta. «E non portare qui quel bastardo di St. Andrew. Ti ordinerei di non vederlo finché starai sotto il mio tetto, ma so che lo vedresti comunque e mi mentiresti.» Aveva ragione, naturalmente. Per il momento, però, finsi di essere contrita. «Tutto quello che vuoi, fratello mio. Grazie.» 34 Quella prima notte a casa fu difficile. Da un lato, non avrei potuto chiedere una cena più festosa. Quando Glynnis tornò a casa dal lavoro presso i Watford, ci fu un altro ricongiungimento che rallegrò tutti i nostri cuori (a parte quello di Nevin, che non mi avrebbe mai perdonato). Mentre i biscotti cuocevano, tirai fuori i regali per loro dal baule, porgendoli come se fossi Babbo Natale. Maeve e Glynnis danzarono tutt’attorno al tavolo con la seta cinese avvolta al petto, immaginandosi i vestiti eleganti che ne avrebbero ricavato, mentre mia madre quasi pianse di gioia quando vide lo scialle. La loro contentezza rese ancora più arrabbiato Nevin; grazie al cielo non avevo portato niente per lui (sapendo che probabilmente lo avrebbe gettato nel fuoco), altrimenti mi avrebbe preso per le orecchie e mi avrebbe scaraventata fuori di casa su due piedi. Rimanemmo seduti attorno al tavolo dopo aver mangiato e le candele si consumarono, mentre mia madre e le mie sorelle mi raccontavano tutto quello che era successo al villaggio durante la mia assenza: raccolti andati male, malattie, un paio di nuovi arrivi. E, naturalmente, nascite, morti e matrimoni. Si soffermarono a lungo sul matrimonio di Jonathan, immaginando che io volessi sapere ogni dettaglio: il cibo delizioso che avevano servito agli ospiti (non potevano sapere che avevo mangiato e bevuto cose più esotiche di quanto potessero mai immaginare); i soci d’affari dei St. Andrew che avevano affrontato il duro viaggio tra fiumi e foreste pur di partecipare all’evento. «È così triste che il capitano non sia riuscito a vivere abbastanza per vederlo» disse mia madre. E la bambina! Da come ne parlavano mia madre e le mie sorelle, sembrava che fosse stata partorita collettivamente da tutto il villaggio. Tutti – a parte Nevin – parevano avere un interesse speciale per quella neonata. «Come l’ha chiamata Jonathan?» domandai, spalmando l’ultima crosta di pane con un rimasuglio di lardo. «Ruth, come sua madre» rispose Glynnis inarcando le sopracciglia. «È un bel nome cristiano» precisò mia madre. «Sono sicura che volessero un nome tratto dalla Bibbia.» Alzai l’indice in segno di disaccordo. «Non Jonathan, e nemmeno Evangeline, non credo proprio. È stata tutta opera della madre di Jonathan, potrei giurarlo.» «Forse l’idea di avere un figlio il prima possibile... Forse anche quella è stata un’idea della signora St. Andrew.» Maeve trattenne il fiato per un momento, guardando sua sorella in cerca di appoggio, poi proseguì: «È stato un parto molto difficile, Lanore. Evangeline stava quasi per morire. È così minuta...» «E così giovane...» Tutti annuirono. «Così giovane, sì» sospirò Maeve. «Ho sentito dire che la levatrice le aveva detto di aspettare un po’ prima di avere dei bambini.» «È vero» aggiunse Glynnis. «Adesso basta!» Nevin conficcò il coltello nel tavolo, facendoci sussultare. «Possibile che un uomo non possa mangiare in pace senza dover ascoltare pettegolezzi sul bellimbusto del villaggio?» «Nevin...» cercò di intervenire mia madre, ma lui la interruppe. «Non voglio più sentire nemmeno una parola sull’argomento, chiaro? È tutta colpa sua, è lui che ha voluto sposarla così giovane. È uno scandalo, ma da uno come lui non ci si poteva aspettare altro» ringhiò Nevin. Per un brevissimo momento, fui tentata di pensare che avesse rimproverato mia madre e le mie sorelle per risparmiarmi ulteriori discorsi sulla bambina, temendo che potessero ferirmi. Si allontanò bruscamente da tavola e si andò a sedere sulla seggiola accanto al fuoco, quella dove si metteva sempre nostro padre dopo cena. Fu strano vederlo lì, con la pipa di mio padre in bocca. A giudicare dalla posizione della luna in cielo, era quasi mezzanotte quando scesi dal soppalco. Non riuscivo a dormire. Le braci nel camino mandavano riflessi tremuli sulle pareti. Ero irrequieta, non riuscivo a rimanere chiusa nel cottage. Avevo bisogno di compagnia. Di solito, a quell’ora, mi preparavo a trascorrere la notte nel letto di Adair, e scoprii, seduta sul divanetto, di avere bisogno – anzi, di essere affamata – di conforto fisico. Mi vestii e scivolai fuori più silenziosamente che potevo. Il mio cocchiere dormiva nel granaio, al calduccio sotto una montagna di coperte e riscaldato da una decina di mucche accalcate attorno a lui sotto lo stesso tetto. Non mi andava di sellare il baio castrato della mia famiglia, risvegliando il povero vecchio animale dal suo meritato riposo, così mi incamminai a piedi verso l’unica meta che mi venne in mente: il villaggio. Per chiunque altro, anche un viaggio così breve sarebbe stato un suicidio. La temperatura era largamente sotto lo zero e il vento soffiava gelido, ma il clima non aveva più alcun effetto su di me e potevo camminare velocemente senza nemmeno affaticarmi. In pochissimo tempo raggiunsi le prime abitazioni. Ma dove andare? St. Andrew non era certo una grande città. Poche luci erano accese dietro le finestre dei cottage. Il villaggio dormiva, ma la locanda di Daniel Daughtery era ancora aperta e l’unica finestra di cui disponeva era illuminata. Indugiai davanti alla porta, chiedendomi se fosse opportuno farmi vedere a quell’ora. Poche donne frequentavano quel posto, e nessuna sarebbe mai entrata da sola. Avrei dato adito a voci che presto sarebbero giunte all’orecchio di Nevin, alimentando la sua convinzione che io fossi una poco di buono. Tuttavia la presenza di quei corpi caldi al suo interno, il mormorio delle voci, le risate occasionali erano un forte richiamo per me. Mi tolsi il fango dalle scarpe ed entrai. C’erano soltanto pochi clienti, e per fortuna, visto lo spazio ristretto. Un paio di taglialegna alle dipendenze di Jonathan e Tobey Ostergaard, il povero e rozzo padre di Sophia. Sembrava un cadavere a sua volta, la sua pelle era grigia e il suo sguardo vacuo era perso sulla parete posteriore. Si voltarono tutti verso di me quando entrai, e Daughtery mi rivolse uno sguardo particolarmente lascivo. «Una birra» ordinai, tanto per prendere qualcosa: c’era soltanto quella sul menu. La locanda un tempo era parte della casa di Daughtery, ricavata (nonostante le proteste di sua moglie) per farci stare un bancone, un piccolo tavolo e qualche sgabello costruito mettendo insieme del legname di scarto, tutti quanti, nessuno escluso, con una gamba più corta delle altre due. Per la maggior parte, i clienti non si fermavano lì a bere: prendevano una botte di birra da portarsi a casa mentre mangiavano, perché fare la birra era molto difficile e secondo tutti quanti quella di Daughtery era la migliore del villaggio. «Avevo sentito dire che eri tornata» disse Daughtery prendendo i miei soldi. «A quanto pare, Boston ti ha trattata bene.» Esaminò i miei vestiti da capo a piedi, senza imbarazzo. «Come ha fatto una contadinotta come te a comprarsi vestiti del genere?» Come mio fratello, e probabilmente come tutti gli altri, Daughtery era convinto di sapere che cosa avessi fatto per diventare ricca. Ma nessuno aveva il coraggio di dirmelo apertamente in faccia e le insinuazioni di Daughtery mi fecero infuriare. Ma cosa potevo farci, date le circostanze? Gli rivolsi un sorriso enigmatico avvicinando il boccale alle labbra. «Ho fatto quello che infinite altre donne hanno fatto per migliorare la loro situazione: mi sono accompagnata a gente ricca, signor Daughtery.» Uno dei taglialegna se ne andò poco dopo il mio arrivo, ma l’altro mi chiese di andare al tavolo con lui. Aveva sentito Daughtery nominare Boston e non vedeva l’ora di parlare con qualcuno che c’era stato di recente. Era giovane, sui vent’anni, di indole buona e di aspetto pulito, diversamente dalla maggior parte dei manovali di St. Andrew. Mi disse di provenire da una famiglia umile che viveva poco fuori Boston. La paga era buona ma la solitudine e l’isolamento lo stavano uccidendo lentamente. Gli mancavano la varietà della città, mi raccontò, e i suoi intrattenimenti. Gli vennero le lacrime agli occhi quando gli descrissi i giardini pubblici nei sabati di sole e la superficie nera e lucente del fiume Charles nelle notti di luna piena. «Speravo di riuscire a tornare prima della brutta stagione» disse, lo sguardo basso sul boccale. «Ma ho sentito che i St. Andrew hanno bisogno di qualcuno che rimanga qui a lavorare durante l’inverno e che la paga è molto buona. Quelli che hanno già fatto un inverno qua, però, mi dicono che è ancora più solitario.» «Credo sia una questione di prospettiva» dissi. Daughtery sbatté un boccale sul bancone di acero, facendoci sussultare entrambi. «Su, finite. È ora di andare ciascuno nel proprio letto.» Ci ritrovammo fuori dalla porta chiusa della locanda, rannicchiati l’uno contro l’altra per ripararci dal vento. Lo sconosciuto avvicinò la bocca al mio orecchio, tanto che il calore del suo fiato mi fece drizzare i capelli sulla nuca, come fiori che si orientano verso il sole. Mi confidò che era da tanto tempo che non stava con una donna. Mi disse anche di avere pochi soldi, ma mi chiese se sarei stata comunque disponibile. «Spero di non aver sbagliato a immaginare la tua professione» aggiunse con un sorriso teso. «Ma quando ti ho visto entrare da Daughtery tutta sola...» Non potevo dargli torto. Ci intrufolammo nel granaio dei Daughtery: gli animali erano talmente abituati ai clienti del bar che non fecero una mossa. Il giovane taglialegna si aprì i vestiti, si sbottonò le brache e mi mise il suo pene in mano. Si sciolse, letteralmente, al mio tocco e ben presto si perse in una fitta nuvola di piacere. Dovevano essere stati il ritorno a St. Andrew e l’incontro con Jonathan a rendere il mio corpo pieno di desiderio. Erano le mani di un taglialegna ad accarezzarmi, ma era a Jonathan che pensavo. Fu un rischio, concedermi di pensare così a Jonathan, ma quella notte, la combinazione di carne e ricordi mi diede un assaggio di ciò che avrebbe potuto essere e mi fece desiderare di avere di più, ancora di più. Perciò attirai il ragazzo a me e posai un piede su una balla di fieno, per offrirgli un migliore accesso alla mia sottogonna. Il giovane taglialegna mi prese, con i suoi muscoli sodi e il tocco gentile, e io cercai di immaginare che si trattasse di Jonathan. Ma non riuscii a mantenere a lungo quell’illusione. Forse Adair aveva ragione, avrei potuto guadagnarci anch’io se avessi reso Jonathan uguale a noi. Una fame insaziabile mi assalì e capii che avrei dovuto provarci, o sarei rimasta insoddisfatta per il resto della mia vita. Cioè, nel mio caso, per l’eternità. Il taglialegna tremò e sospirò quando venne, poi prese un fazzoletto dalla tasca e me lo porse. «Perdonami la volgarità» mi sussurrò accalorato all’orecchio, «ma è stata la miglior scopata della mia vita. Devi essere la prostituta più brava di tutta Boston!» «Cortigiana» lo corressi gentilmente. «E non posso certo fingere di poterti ricompensare come è tua abitudine...» disse, frugando in un borsellino per prendere i soldi, ma io gli poggiai una mano sul braccio e lo fermai. «Non importa. Tieniti i tuoi soldi. Mi basta che tu prometta di non parlarne a nessuno» dissi. «Oh, no, certo che no. Anche se me ne ricorderò per il resto della mia vita!» «Anch’io» dissi, anche se il suo volto da ragazzino sarebbe stato soltanto uno dei molti. O forse l’ultimo, perché sarebbe stato rimpiazzato da quello di Jonathan, soltanto Jonathan, se avessi avuto fortuna. Osservai il giovane taglialegna barcollare all’aperto e incamminarsi verso la strada che conduceva alla tenuta dei St. Andrew. Poi mi avvolsi stretta nel cappotto e mi mossi nella direzione opposta. Il suo liquido caldo mi scivolò lungo le cosce e io avvertii una sensazione familiare e piacevole al petto, la soddisfazione che provavo ogni volta che riuscivo a dominare un uomo, a renderlo inerme tramite il piacere del sesso. Non vedevo l’ora di provare quella sensazione con Jonathan, di sorprenderlo con le abilità che avevo acquisito. La strada mi condusse alla bottega del fabbro e, per forza d’abitudine, guardai lungo il sentiero che conduceva al cottage di Magda. C’era una fievole luce dietro lo scialle che solitamente appendeva alla finestra, così capii che era sveglia. Com’era strana la vita: un tempo le avevo invidiato il suo cottage, ma forse glielo invidiavo ancora, perché avvertii un piccolo mancamento al cuore quando lo vidi, ricordandomi i modesti lussi che mi avevano tanto colpito quando ero piccola. La casa di Adair era lussuosa, certo, ma una volta entrati si rinunciava per sempre alla propria libertà. Magda era padrona in casa propria e nessuno poteva toglierle quella libertà. Mentre ero all’inizio del sentiero, la porta d’ingresso si aprì e ne uscì un taglialegna (grazie al cielo, perché mi avrebbe mortificato vedere uno dei miei vicini fare i suoi comodi con Magda). La vecchia ragazza in questione lo seguì fuori e per un momento furono entrambi illuminati dalla luce che proveniva dalla porta aperta. Ridevano e Magda si avvolse un mantello sulle spalle mentre accompagnava il suo cliente giù dai gradini e lo salutava con un cenno della mano. Io mi spostai nell’ombra per risparmiare al taglialegna l’imbarazzo di essere visto, ma Magda fece in tempo a notarmi. «Chi c’è là?» disse ad alta voce. «Non vogliamo guai qui!» Uscii dall’ombra. «Nessun guaio, signorina Magda.» «Lanore? Sei davvero tu?» Allungò il collo. Io sfilai accanto al taglialegna che lentamente si allontanava, salii le scale e abbracciai Magda. Le sue braccia sembravano più fragili che mai. «Santo cielo, ragazza, mi avevano detto che ti avevamo persa per sempre» disse conducendomi all’interno. Faceva caldo, per via del fuoco acceso nel piccolo camino e dei due corpi che avevano appena finito di muoversi là dentro (l’odore muschiato si avvertiva ancora nell’aria; quei taglialegna non prestavano molta attenzione all’igiene personale), perciò mi tolsi il mantello. Magda mi prese per le spalle e mi fece voltare e rivoltare, ammirando il mio bel vestito. «Be’, signorina McIlvrae, a quanto pare te la sei cavata più che bene.» «Non posso certo dire di esserne orgogliosa» dissi. Magda mi rimproverò con lo sguardo. «Devo pensare dunque che hai fatto fortuna nel solito modo delle ragazze come noi?» Quando non risposi, si levò di scatto il mantello. «Be’, conosci la mia opinione sull’argomento. Non è certo un crimine intraprendere l’unica strada possibile e avere successo. Se Dio non avesse voluto che ci guadagnassimo da vivere facendo le puttane, ci avrebbe dato altri mezzi per mantenerci. Ma non l’ha fatto.» «Non sono esattamente una prostituta» precisai, senza sapere perché ne avvertissi il bisogno. «C’è un uomo che mi mantiene e...» «Siete sposati?» Scossi il capo. «Allora sei la sua amante.» Il suo non era un giudizio, ma una constatazione, come se mi stesse informando sulla posizione che occupavo. Versò del gin in due bicchierini, appannati dall’età e dall’uso, e io le raccontai della mia vita a Boston e di Adair. Fu un sollievo poter finalmente parlare a qualcuno di lui, in una versione edulcorata, naturalmente, omettendo le parti di lui che avrei voluto cambiare: i suoi attacchi di rabbia e di violenza, i suoi repentini cambiamenti di umore, gli uomini che di tanto in tanto si portava a letto. Le dissi che era ricco, bello e innamorato di me. «Buon per te, Lanore. Ma assicurati di mettere da parte un po’ del suo denaro.» Alla luce della candela, vidi più chiaramente il volto di Magda. Gli anni in cui ero stata via avevano lasciato il segno su di lei. La sua pelle così delicata aveva iniziato a formare delle pieghe attorno alla bocca e sulla gola, e i suoi capelli neri ora avevano striature di bianco ben evidenti. I suoi corpetti un tempo sontuosi ora erano sfilacciati e grigi. Anche se era l’unica prostituta del villaggio, non sarebbe stata in grado di continuare quel lavoro per molto tempo ancora. I taglialegna più giovani avrebbero presto smesso di frequentarla e i più maturi, che sarebbero ancora andati da lei per ottenere i suoi servigi, probabilmente avrebbero iniziato a trattarla in modo sempre più rude. Presto sarebbe diventata una vecchia senza amici in un villaggio in cui la vita era dura e aspra. Avevo appuntato al mio corpetto una minuscola spilla con una perla, un regalo di Adair. La mia famiglia non sapeva niente di gioielli, così l’avevo indossata ostentatamente in loro presenza, ma Magda sapeva di certo che valeva una piccola fortuna. All’inizio avevo pensato di darla alla mia famiglia, avevano più diritto loro di averla che non quella donna, benché fosse la mia unica amica. Ma poi avevo deciso di lasciar loro dei soldi, e non erano pochi. Perciò, sganciai la spilla dal mio vestito e gliela porsi. Magda inclinò la testa. «Oh, no, Lanore, non devi farlo. Non ho bisogno dei tuoi soldi.» «Vorrei che l’avessi tu e...» Lei allontanò la mia mano tesa. «So che cosa stai pensando. Ma ho intenzione di ritirarmi presto. Ho messo da parte un bel po’ di denaro durante la mia permanenza qui. Il vecchio Charles St. Andrew avrebbe dovuto mandare direttamente a me le paghe dei suoi uomini, visto tutto il tempo che hanno passato in questo cottage, risparmiando loro la fatica di portarsi i soldi in tasca per un giorno o due al massimo» disse, ridendo. «No, preferisco che la tenga tu. Puoi non credermi, adesso, perché sei ancora giovane e bella e hai un uomo che apprezza la tua compagnia, ma un giorno tutto ciò finirà e potresti aver bisogno del denaro che quella spilla vale.» Naturalmente non potevo dirle che quel giorno non sarebbe mai arrivato per me. Feci un sorrisetto forzato e mi riappuntai la spilla sul vestito. «Ho intenzione di trasferirmi a sud questa primavera. Da qualche parte vicino alla costa» proseguì. Si guardò intorno, come se stesse decidendo in quel momento che cosa portarsi dietro e che cosa, invece, lasciare lì. «Forse troverò un vedovo gentile e solitario e mi sistemerò.» «Sono sicura che la sorte ti arriderà, Magda, qualsiasi cosa tu decida di fare, perché hai un cuore generoso» dissi e mi alzai in piedi. «Adesso è meglio che ti lasci riposare, e poi devo tornare dalla mia famiglia. È stato bello rivederti, Magda.» Ci abbracciammo ancora e lei strofinò con calore la mano sulla mia schiena. «Prenditi cura di te, Lanore. E stai attenta. Soprattutto, non innamorarti di quell’uomo. Noi donne prendiamo sempre le decisioni sbagliate quando siamo innamorate.» Mi scortò alla porta e mi fece uscire, salutandomi con la mano. C’era del vero, nel suo consiglio, una verità che mi strinse il cuore, e mi avviai verso il bosco molto meno sicura di prima. Il cammino verso casa mi rese ancora più agitata di quanto lo fossi prima di uscire e, pensandoci, capii che era perché avevo mentito a Magda su Adair. Non era soltanto il fatto che le avevo nascosto il suo segreto, anzi, il nostro segreto. Su quello non avevo scelta. E se c’era qualcuno a St. Andrew che avrebbe perdonato le perversioni di Adair, era proprio Magda. Eppure avevo scelto di mentirle su di lui e sulla mia relazione con lui. Più di ogni altra cosa, una donna vuole essere orgogliosa dell’uomo della sua vita, e ovviamente io non lo ero. Come potevo essere orgogliosa di ciò che Adair aveva suscitato in me – ciò che aveva capito immediatamente non appena aveva posato il suo sguardo su di me – e cioè che anche in me albergavano i suoi stessi oscuri desideri? Per quanto fossi terrorizzata da lui, non potevo negare di esserne attratta. Avevo accolto ogni sfida sessuale che mi aveva lanciato. Aveva risvegliato qualcosa in me che non potevo più negare, ma di cui non ero certo fiera. Forse non era di Adair che mi vergognavo. Forse mi vergognavo di me stessa. Quei pensieri funesti mi occuparono la mente per tutto il cammino, mentre mi stringevo addosso il mantello per ripararmi dal vento e correvo sul sentiero che conduceva alla casa della mia famiglia. Non riuscivo a smettere di ripensare alle cose terribili che avevo fatto, e al piacere che avevo provato nel farle. Non c’è da meravigliarsi che mi fossi ridotta a domandarmi se ormai non fossi oltre ogni possibilità di redenzione. 35 Quando mi svegliai il giorno dopo, sentii mia madre e Maeve parlottare in cucina a bassa voce per non svegliarmi. Ai loro occhi, probabilmente, apparivo come una perdigiorno fannullona, nascosta sotto strati di coperte, una che spreca il momento più produttivo della giornata dormendo fino all’ora di pranzo, anche se a dire il vero non mi alzavo così presto da un sacco di tempo. «Guarda un po’ chi si è appena svegliata» disse mia madre dal camino quando mi sentì sbadigliare da lassù. «Immagino che Nevin si sia lamentato» risposi scendendo dalla scala. «Siamo a malapena riuscite a impedirgli di prenderti per i piedi e trascinarti giù» disse Maeve, porgendomi i vestiti, che avevano steso vicino al fuoco per riscaldarli. «Sì, be’, non riuscivo a dormire stanotte, così ho fatto due passi fino al villaggio» confessai. «Lanore!» esclamò mia madre, quasi lasciando cadere il coltello. «Ma sei diventata pazza? Potevi morire congelata! Se non peggio» disse, scambiando uno sguardo d’intesa con mia sorella: entrambe sapevano che non avevo più molte virtù da proteggere. Il suo tono di voce si tranquillizzò. «Avevo dimenticato quanto fa freddo la notte così a nord» mentii. «E dove sei andata?» «Di certo non in chiesa, scommetto» disse Maeve ridendo. «No, non in chiesa. Sono andata da Daughtery.» «Lanore...» «Volevo solo un po’ di compagnia, tutto qui. Non sono più abituata a tutto questo silenzio, ad andare a letto così presto. La mia vita è molto diversa a Boston. Abbiate pazienza con me.» Strinsi la cintura della gonna attorno alla vita e poi mi avvicinai a mia madre e la baciai sulla fronte. «Ma adesso non sei a Boston, figlia mia» mi rimproverò lei. «Non preoccupartene troppo» disse Maeve. «Non è che Nevin non si faccia vedere da Daughtery di tanto in tanto. Se gli uomini possono farlo, non vedo perché tu non possa, almeno una volta.» E qui lanciò uno sguardo a nostra madre, per vedere se avrebbe reagito: «Noi ci abitueremo». Quindi Nevin frequentava la locanda dei Daughtery. Avrei dovuto stare più attenta. Se avesse scoperto dei miei flirt notturni, le cose si sarebbero messe male per me. In quel momento qualcuno ci interruppe bussando alla porta. Uno dei servitori dei St. Andrew ci consegnò una busta color avorio con sopra il mio nome. Dentro c’era un biglietto scritto con la calligrafia meticolosa della madre di Jonathan: era un invito a cena per me e la mia famiglia quella sera. Il servitore rimase sull’uscio ad attendere la nostra risposta. «Che cosa devo rispondere?» chiesi, anche se era abbastanza facile intuire la loro risposta. Maeve e mia madre si misero a saltare e ballare come se fossero Cenerentola invitata al gran ballo del principe. «E Nevin? Lui rifiuterà di venire» osservai. «Di certo, e per principio» disse Maeve. «Vorrei che tuo fratello fosse più portato per gli affari» borbottò mia madre. «Potrebbe approfittare dell’occasione per convincere Jonathan ad acquistare più merce da noi. Metà del villaggio sopravvive grazie a quella famiglia. Chi altri comprerà la nostra carne? Loro hanno tutti quei taglialegna da sfamare...» Probabilmente pensava male dei St. Andrew perché sfamavano la loro forza lavoro con cacciagione della tenuta. Tornai alla porta e mi rivolsi al servitore. «Vi prego, dite alla signora St. Andrew che siamo lieti di accettare l’invito e che saremo in quattro.» La cena di quella sera fu surreale per me. Ero circondata dalla mia famiglia e dalla sua. Non era mai accaduto in tutto il tempo in cui io e Jonathan eravamo amici da piccoli, e sarei stata ben felice se a cena fossimo stati soltanto noi due a un tavolino davanti al fuoco nel suo studio. Ma non sarebbe stato appropriato, visto che Jonathan aveva una moglie e una figlia ora. Le sue sorelle erano già diventate delle zitelle precoci e sembravano dei gufi. Guardavano le mie sorelle, ben più vivaci di loro, come se fossero delle scimmiette lasciate libere in casa loro. Il povero Benjamin, un po’ ritardato, era seduto accanto a sua madre, lo sguardo fisso nel piatto, le labbra strette, sforzandosi di stare immobile. Di tanto in tanto, sua madre gli prendeva la mano e gliela accarezzava, il che sembrava avere un effetto tranquillizzante sul poveretto. Alla sinistra di Jonathan c’era Evangeline. Pareva una bambina alla quale era stato accordato il permesso di sedersi al tavolo dei grandi. Le sue piccole dita rosa sfioravano ogni posata come se non fosse abituata al servizio completo con cui era apparecchiata la tavola. E a tratti il suo sguardo si alzava e si fissava sul volto del marito, come un cagnolino che controlla se il suo padrone è ancora presente. Vedere Jonathan circondato da quelle persone, dalla famiglia che sarebbe sempre dipesa da lui, mi fece sentire dispiaciuta e stanca. Dopo la cena – un carré di capriolo e una decina di quaglie arrosto, così che alla fine rimasero piatti pieni di scheletri: costole di cervo e piccole ossa d’uccello letteralmente spolpate – Jonathan guardò i presenti, quasi tutte donne, e mi invitò a seguirlo nel vecchio studio del padre, che ora era il suo. Quando sua madre aprì la bocca per protestare, disse: «Non c’è neanche un uomo qui che possa fumare la pipa con me, e se permettete vorrei parlare con Lanore da solo. E poi sono sicuro che altrimenti si annoierebbe a morte». Ruth inarcò le sopracciglia, mentre le sue sorelle sembrarono offendersi. Forse lui voleva soltanto che non si sentissero a disagio in mia compagnia; sono certa che anche loro fossero convinte che mi prostituissi, e probabilmente Jonathan aveva dovuto superare le loro proteste per riuscire a invitare me e la mia famiglia. Una volta chiusa la porta, versò del whisky per entrambi e riempì due pipe di tabacco, poi ci accomodammo su due sedie vicino al fuoco. All’inizio, volle sapere come era accaduto che fossi scomparsa a Boston. Gli raccontai una versione più dettagliata della storia che avevo raccontato alla mia famiglia: ero alle dipendenze di un ricco europeo, mi pagava per fargli da mediatrice con gli americani. Jonathan mi ascoltò con aria scettica, mi parve, indeciso se mettere in dubbio il mio racconto oppure semplicemente goderselo. «Dovresti prendere in considerazione l’idea di venire a Boston a vivere. La vita lì è più semplice» gli dissi, avvicinando un fiammifero alla pipa. «Sei un uomo ricco. Se vivessi in una grande città, potresti godere di tutti i piaceri della vita.» Scosse il capo. «Non possiamo abbandonare St. Andrew. C’è il legname da raccogliere, è la nostra sostanza vitale. Chi manderebbe avanti la falegnameria?» «Il signor Sweet, come già accade adesso. O un altro sovrintendente. È così che i ricchi con molti investimenti gestiscono le loro proprietà. Non c’è motivo per cui tu e la tua famiglia dobbiate sopportare la rigidità degli inverni in questo posto.» Jonathan fissò il camino, fumando la pipa. «Forse pensi che mia madre abbia il desiderio di ricongiungersi alla sua famiglia, ma non riusciremmo mai a portarla via da St. Andrew. Non lo ammetterà mai, ma si è abituata ad avere una certa posizione sociale, qui. A Boston non sarebbe altro che una delle tante vedove ricche. Potrebbe perfino risentirne, a livello sociale, per aver trascorso così tanto tempo ’tra i selvaggi’. E poi, Lanny, non hai pensato a che cosa succederebbe al villaggio se ce ne andassimo?» «La tua impresa andrebbe comunque avanti. Dovresti sempre pagare gli abitanti di St. Andrew per fare tutto quello per cui già li paghi. L’unica differenza sarebbe che tu e la tua famiglia avreste finalmente lo stile di vita che vi meritate. Ci sarebbero dei dottori per Benjamin. E tu potresti vedere altre persone del tuo livello, la domenica, o andare alle feste e a giocare a carte ogni sera, come appartenente all’élite della città.» Jonathan mi rivolse uno sguardo incredulo, tanto pieno di dubbi da farmi pensare che quello che aveva detto di sua madre fosse soltanto una scusa. Forse era lui ad aver paura di lasciare St. Andrew, di abbandonare l’unico luogo che conosceva, e diventare un pesce piccolo in uno stagno molto affollato. Mi sporsi verso di lui. «Non credi di meritartelo, Jonathan? Hai lavorato con tuo padre per costruire la fortuna della tua famiglia. Non hai idea di che cosa ti aspetti fuori da questi boschi, queste foreste impenetrabili come le mura di una prigione.» Lui sembrò offeso. «Non è che io non abbia mai lasciato St. Andrew. Sono stato a Fredericton.» I St. Andrew avevano dei soci d’affari a Fredericton, come parte del commercio di legname. I tronchi venivano imbarcati sul fiume Allagash e portati al fiume St. John, poi lavorati a Fredericton, tagliati in assi o trasformati in carbonella. Charles aveva portato il figlio con sé a fare quel viaggio quando Jonathan era ancora adolescente, ma lui non me ne aveva mai parlato molto. Ora che ci pensavo, Jonathan non sembrava avere alcuna curiosità per il mondo al di fuori della nostra piccola cittadina. «Fredericton non è certo Boston» lo rimbeccai. «E poi, se verrai a Boston potrai conoscere il mio datore di lavoro. È un nobile europeo, praticamente un principe. Ma soprattutto, è un vero esperto dei piaceri della vita. Un uomo capace di arrivare dritto al cuore.» Cercai di sorridere maliziosamente. «Ti posso garantire che lui cambierebbe per sempre la tua vita.» Lui mi squadrò. «Un ’esperto dei piaceri della vita’, hai detto? E tu come fai a saperlo, Lanny? Pensavo che fossi la sua intermediaria o qualcosa del genere.» «Si può fare da intermediari in parecchi campi.» «Mi hai incuriosito, lo devo ammettere» disse, eppure il suo tono di voce era pieno di indulgenza. Una parte di me era dispiaciuta nel vedere Jonathan così schiacciato dalle responsabilità da non avere alcuna curiosità verso le tentazioni che gli offrivo. Ma ero sicura che il vecchio Jonathan fosse ancora lì dentro, da qualche parte. Non dovevo fare altro che risvegliarlo. Io e Jonathan trascorremmo molte altre sere insieme, dopo quella. Presto mi resi conto che non si era fatto nuovi amici. Non ne capivo bene il motivo. Sicuramente non scarseggiavano gli uomini che avrebbero desiderato guadagnare la posizione sociale e i benefici finanziari che l’amicizia con Jonathan avrebbe garantito. Ma Jonathan era tutt’altro che stupido. Quelli erano gli stessi uomini che, da ragazzini, avevano invidiato il suo bell’aspetto, la sua posizione, la sua ricchezza. Che covavano un forte risentimento nel vedere i loro padri legati mani e piedi al capitano per sopravvivere. «Mi mancherai quando te ne andrai» mi disse Jonathan in una di quelle sere trascorse chiusi dentro lo studio a fumare tabacco di prima qualità. «Non credi che potresti rimanere? Non devi per forza tornare a Boston, non se il problema sono i soldi. Potrei darti io un lavoro, così potresti anche aiutare la tua famiglia ora che tuo padre non c’è più.» Mi chiesi se Jonathan avesse pianificato quella proposta o se gli fosse venuta spontanea in quel momento. Anche se fosse riuscito a inventarsi un lavoro da farmi fare, sua madre si sarebbe fermamente opposta all’idea di avere alle proprie dipendenze una donna caduta in disgrazia come me. Aveva ragione su una cosa: era l’occasione di farmi perdonare dalla mia famiglia, e mi si strinse il cuore all’idea. Ma ero più terrorizzata all’idea di disobbedire agli ordini di Adair. «Non posso lasciare la vita della città, non ora che l’ho sperimentata. Anche tu la penseresti così al mio posto.» «Ma ti ho già spiegato che...» «Non devi certo decidere su due piedi. Dopotutto, trasferire tutta la tua famiglia a Boston non è cosa da poco. Torna con me e visitala almeno una volta, prima di decidere. Puoi dire alla tua famiglia che si tratta di un viaggio di lavoro. Così vedrai se la città incontra i tuoi gusti.» Avevo pulito il cannello della pipa con un pezzo di fil di ferro – un’abilità appresa grazie al narghilé di Adair – e picchiettai il fornello contro un vassoietto per liberarlo dalla cenere. «Potrebbe anche avvantaggiarti negli affari, tra l’altro. Adair ti porterà con sé, ti presenterà ad altri uomini, i proprietari delle fabbriche di legname lavorato e cose del genere. Ti presenterà all’alta società. Non c’è cultura, qui a St. Andrew! Non hai idea di cosa ti stai perdendo: il teatro, i concerti. Ma soprattutto» dissi, avvicinando le labbra alle sue orecchie per garantire il massimo della segretezza, «ciò che sono sicura che troveresti irresistibile è il fatto che tu e Adair siete molto simili quando si tratta del piacere di un uomo.» «Dici?» La sua espressione mi implorava di proseguire. «Le donne si gettano ai suoi piedi. Tutti i tipi di donna. Donne ricche, donne povere e, quando si stanca di loro, ci sono sempre quelle del mestiere.» «Cioè...» «Le prostitute. Boston è piena di prostitute di tutti i tipi. Ci sono bordelli di lusso e donne di strada. Ci sono attrici e cantanti che si accompagnano volentieri a un uomo in cambio di una bella stanza d’albergo e qualche soldo da spendere.» «Stai dicendo che dovrei pagare un’attrice o una cantante per trovare una donna che voglia stare con me?» mi chiese, poi abbassò lo sguardo. «Vuoi dire che tutti gli uomini a Boston pagano le donne per stare con loro?» «Solo se uno vuole avere l’esclusiva, per così dire» risposi, riguadagnando a poco a poco terreno. «Quelle donne spesso sono più esperte delle arti amorose di chiunque altro» aggiunsi, sperando di incuriosirlo ancor di più. Era giunto il momento di dargli uno dei regali di Adair. «Ecco, questo è da parte del mio datore di lavoro» dissi porgendogli un pacchettino avvolto in un drappo di seta rossa. Era il mazzo di carte pornografiche. «Da un gentiluomo a un altro.» «Affascinante» disse, esaminando attentamente una carta dopo l’altra. «Ho visto un mazzo simile a questo quando sono andato a Fredericton, ma non era così... creativo.» Quando sollevò il drappo di seta per riavvolgerci il mazzo di carte, cadde fuori un secondo regalo. Uno che mi ero dimenticata di avere. Jonathan inspirò di scatto. «Santo Dio, Lanny, chi è questa?» Teneva in mano un piccolo ritratto di Uzra e lo fissava con sguardo incantato. «È un fantasma? È la creazione di un pittore?» Non mi piacque affatto il suo tono di voce – nessun gentiluomo avrebbe parlato in quel modo davanti a una donna cui diceva di tenere molto – ma cosa potevo farci? Quel ritratto doveva servire a indurlo in tentazione, e chiaramente aveva funzionato. «Oh, no, esiste davvero in carne e ossa, te lo posso giurare. È una concubina del mio padrone, un’odalisca che ha preso con sé quando ha percorso la via della seta in Oriente.» «Il tuo padrone ha un ménage familiare piuttosto curioso, a quanto pare. Una concubina a Boston? Non credevo che fosse permesso.» Jonathan guardò dal ritratto a me e di nuovo il ritratto, con le sopracciglia aggrottate. «Ma non capisco... Perché mai il tuo padrone ha mandato dei regali proprio a me? Perché gli interesso? Che cosa diavolo gli hai detto di me?» «Sta cercando un compagno d’avventure, diciamo così, e ha la sensazione che tu sia uno spirito affine.» Reagì con sospetto, forse perché temeva che tutto quell’interesse da parte di un uomo che non conosceva fosse non tanto per lui quanto per le sue ricchezze. «A dirti il vero, credo che la gente di Boston l’abbia deluso. Sono tutti così seriosi. Non è ancora riuscito a trovare un bostoniano che abbia le sue stesse inclinazioni, che sia disposto a indulgere in qualsiasi fantasia lo intrighi...» Ma Jonathan non sembrò prestare attenzione a quello che gli avevo detto. Mi fissò così da vicino che temetti di averlo inavvertitamente offeso. «Che cos’hai?» gli chiesi. «È solo che sei così... Così cambiata» sussurrò infine. «Non posso certo negarlo. Sono cambiata completamente. Ma la domanda è: sei deluso dal mio cambiamento?» Sbatté le palpebre e un’ombra di dolore gli velò il volto. «Mi dispiace dirtelo, ma... Sì, un po’ sì. Non so come dirtelo senza urtare i tuoi sentimenti, ma non sei più la stessa ragazza di quando sei partita. Sei così mondana... Sei l’amante di quell’uomo, vero?» mi chiese esitante. «Non esattamente.» Mi sovvenne un’espressione che avevo udito anni prima. «Per lui sono una moglie spirituale.» «Moglie spirituale?» «Lo siamo tutte. L’odalisca del ritratto, Tilde, io stessa...» Pensai che fosse meglio lasciar fuori Alejandro e Dona, non sapendo come avrebbe reagito Jonathan a quella situazione. «Ha tre mogli sotto lo stesso tetto?» «Per non parlare delle altre donne con cui si intrattiene...» «E a te non dà alcun fastidio?» «Ha il diritto di dare le sue attenzioni a chi desidera, così come lo abbiamo noi. Quello che c’è fra di noi è diverso da qualsiasi altra cosa tu abbia mai sentito, ma... Sì, devo ammettere che a me va benissimo così.» «Santo cielo, Lanny, non riesco a credere che tu sia la stessa ragazza che ho baciato nel vestibolo della chiesa tanti anni fa.» Mi guardò, timido, quasi non sapesse bene come comportarsi. «Visto che parli di libertà di concedere le proprie attenzioni a chi si desidera, suppongo che non sia sconveniente chiederti... Un altro bacio? Soltanto per sincerarmi che tu sia davvero la Lanny che conoscevo una volta, tornata da me?» Era la breccia che avevo atteso. Si alzò dalla sedia e si chinò su di me, mi prese il volto fra le mani, ma il suo bacio si fece attendere. Quell’esitazione quasi mi spezzò il cuore. «Devi sapere che ho temuto che non ti avrei mai più rivisto, Jonathan, tanto meno sentire di nuovo le tue labbra sulle mie. Ho creduto di morire per quanto sentivo la tua mancanza.» Mentre i miei occhi percorrevano il suo volto, capii che era stata la speranza di rivedere Jonathan l’unica cosa che mi aveva impedito di impazzire. Ora eravamo insieme e non avrei permesso a niente e nessuno di frapporsi. Mi alzai a mia volta e mi appoggiai a lui, con tutto il corpo. Dopo un secondo di esitazione, finalmente mi abbracciò. Ero contenta di avvertire di nuovo il suo desiderio, ma era così cambiato dall’ultima volta che eravamo stati insieme, era cambiato persino il profumo dei suoi capelli e della sua pelle. L’esitazione delle sue mani quando mi cinse in vita. Il suo sapore quando ci baciammo. Era tutto cambiato. Era più lento, più dolce, più triste. Il suo modo di fare l’amore, per quanto sempre tenero e dolce, non era più famelico come un tempo. Forse era per via del fatto che eravamo nella casa della sua famiglia, perché sua moglie e sua madre erano separate da noi soltanto da una porta chiusa a chiave. O forse era soltanto il senso di colpa perché stava tradendo Evangeline. Dopo che Jonathan fu venuto, rimanemmo sul divanetto insieme, il suo capo tra i miei seni avvolti nella seta impreziosita da nastri e pizzi. Era ancora fra le mie gambe, accasciato su un cuscino di gonne e sottogonne rialzate fino alla mia vita. Gli carezzai i capelli mentre il mio cuore si riempiva di beatitudine. E sì, sentivo anche una segreta sensazione di possesso perché ero riuscita a farlo cedere al desiderio. Quanto alla moglie fedele in attesa oltre quella porta... Be’, non era stata forse lei a rubarmi l’uomo che amavo? E il vincolo del matrimonio significava ben poco se lui ancora desiderava me, se il suo cuore ancora mi apparteneva. E il mio corpo vibrava ancora, a riprova del suo desiderio. Nonostante quello che era accaduto a entrambi negli anni che ci avevano visti lontani, ero convinta più che mai che il legame fra di noi fosse indissolubile. 36 Québec, oggi Luke si ferma davanti a un autogrill vicino all’uscita dell’autostrada. Ha bisogno di una sosta, di interrompere la monotonia del nastro grigio della strada. Parcheggia e poi chiede a Lanny di prestargli il computer portatile: vuole vedere le ultime notizie, controllare la sua casella e-mail. Oltre alla solita sfilata di messaggi dell’amministrazione ospedaliera («Si ricorda a tutti i dipendenti di non parcheggiare nell’ala est del parcheggio, perché l’area è destinata allo scarico della neve spalata»), nessuno gli ha scritto. Nessuno sembra aver notato la sua assenza. Luke fa scorrere il mouse senza meta sul desktop, distratto; non c’è niente da ricontrollare. Sta per spegnere il computer quando sente un segnale: qualcuno gli ha appena mandato un’e-mail. Si aspetta che sia spam, o un altro invito tanto gentile quanto impersonale da parte della sua banca perché apra un nuovo conto corrente o qualcosa di altrettanto inutile, invece proviene da Peter. Luke si sente a disagio; sa di aver approfittato dell’indole generosa del suo collega. Peter è più un conoscente che un vero e proprio amico, ma siccome ci sono pochi anestesisti da quelle parti e Luke è un medico del pronto soccorso, hanno avuto modo di conoscersi meglio rispetto ad altri colleghi. Per via della recente serie di disgrazie, Luke è stato un po’ meno amichevole del solito, ma Peter è uno dei pochi dottori che ancora gli parla. «Dove sei?» recita l’e-mail. «Non credevo che avresti tenuto la mia macchina così a lungo. Ho cercato di chiamarti ma non rispondi al cellulare. Va tutto bene? Hai avuto un incidente? Ti sei fatto male? Sono preoccupato per te. CHIAMAMI.» In coda all’e-mail Peter ha aggiunto i suoi numeri di telefono e quello del cellulare della moglie. Luke chiude l’email di Peter, serrando le mascelle. Ha paura che io stia impazzendo, pensa. È consapevole di avere un comportamento strano, per usare un eufemismo, e che i suoi concittadini lo considerano una specie di soggetto a rischio e che evitano accuratamente di menzionare Tricia, il suo divorzio o la morte dei suoi genitori. Nessuno crede di poter gestire tutta la sua infelicità. È solo in quel momento che Luke si rende conto che andar via dalla sua città con quella donna lo ha distratto dalle sue miserie. È da mesi che non gli capitava di non pensare a quanto sta male. È la prima volta che è riuscito a parlare delle sue figlie senza mettersi a piangere. Luke inspira a fondo e lascia uscire il fiato lentamente. Non saltare alle conclusioni, si ripete. Peter è stato gentile e paziente, in quella e-mail. Non ha minacciato di rivolgersi alla polizia. È la persona più decente che Luke abbia frequentato negli ultimi tempi, ma probabilmente si deve al fatto che Peter è appena arrivato a St. Andrew. Il giovane dottore non è stato ancora infettato dall’innata stranezza di quella cittadina, dalla sua freddezza scostante, dal suo vizio tutto puritano di giudicare sempre. Per un momento, Luke ha la tentazione di telefonare a Peter. È l’ultimo legame che gli rimane col mondo normale, quel mondo che esisteva prima che aiutasse Lanny a scappare dalla polizia, prima che ascoltasse tutta quella storia incredibile, prima che lui andasse a letto con una paziente. Peter sarebbe capace, forse, di convincerlo a tirarsi indietro. Luke fa un altro profondo respiro; la domanda è: vuole lasciarsi convincere? Riapre l’e-mail di Peter e clicca su Rispondi: «Mi dispiace per la tua macchina» digita. «Presto la lascerò da qualche parte e la polizia la troverà e te la restituirà.» Rilegge quello che ha scritto e capisce che il vero significato è che non tornerà mai indietro. Prova un enorme sollievo. Prima di cliccare su Invia aggiunge: «Tieniti il mio pickup, è tuo ora». Luke fa un salto in bagno e poi risale sul SUV: Lanny è già sul sedile del passeggero, lo sguardo fisso avanti con un sorriso serio. «Che succede?» le chiede girando la chiave nel blocchetto d’accensione. «Niente...» Lei abbassa lo sguardo. «Quando sono andata a pagare alla cassa, mentre tu eri in bagno, ho visto che sotto il bancone avevano delle bottiglie di liquore. Così ne ho chiesta una di Glenfiddich. Ma la ragazza non ha voluto vendermelo. Ha detto che dovevo aspettare che mio padre uscisse dal bagno e che la comprasse lui.» Luke apre la portiera e fa per scendere. «Vado subito io, se vuoi...» «No, lascia stare. Non è per il whisky; è solo che... Mi succede di continuo. Non ne posso più, ecco tutto. Mi scambiano sempre per un’adolescente, mi trattano come una ragazzina. Avrò l’aspetto di una ragazzina ma non penso come una ragazzina e a volte non riesco a sopportare che mi trattino così. So benissimo che quest’aspetto mi è utile, ma, santo Dio...» Si prende il capo fra le mani, scuotendolo, poi rialza le spalle. «Facciamole vedere un bello spettacolo. Facciamola andare fuori di testa, dai.» Prima che Luke riesca a dire qualcosa, Lanny lo afferra per il colletto della giacca e lo attira a sé. Preme la bocca sulla sua e gli dà un lungo bacio, strusciandosi su di lui. Il bacio continua e continua, finché a lui non vengono le vertigini. Oltre la spalla di Lanny, vede una donna impietrita dietro la cassa, la bocca atteggiata a una O di stupore e gli occhi strabuzzati. Lanny lo lascia andare, ridendo. Picchia una mano sul cruscotto. «Forza, papà, troviamoci un motel così ti scopo fino a farti impazzire.» Luke non si unisce alla risata. Senza pensarci, si ripulisce la bocca. «Non farlo più. Non mi piace essere scambiato per tuo padre. Mi fa sentire...» Mi fa sentire orribile, e non lo sono, pensa, ma non lo dice ad alta voce. Lei si tranquillizza all’istante, rossa di vergogna, e guarda smarrita le proprie mani. «Hai ragione. Scusa, non volevo imbarazzarti» dice. «Non succederà più.» 37 St. Andrew, 1819 Quel meraviglioso momento insieme sul divanetto non sarebbe stato l’ultimo. Facemmo in modo di incontrarci più spesso possibile, anche se le circostanze erano quanto meno sconvenienti: un capanno ai margini del pascolo, colmo di erba medica secca (e poi dovevamo stare attenti a pulirci accuratamente togliendo ogni traccia di semi e steli), o la stalla dei cavalli accanto alla casa dei St. Andrew; lì ci chiudevamo nella stanza dove conservavano i finimenti e le attrezzature e ci strofinavamo l’uno contro l’altra silenziosamente fra redini e briglie appese. Durante quegli incontri con Jonathan, mentre il suo respiro entrava in me e gocce del suo sudore mi cadevano sul volto, mi sorpresi più volte a pensare a Adair. Mi sorpresi a provare un senso di colpa, come se lo stessi tradendo, perché in fondo, a nostro modo, eravamo amanti. C’era anche una corrente sotterranea di terrore puro per la punizione che Adair mi avrebbe inferto non tanto per essere andata a letto con un altro uomo, ma per essere innamorata di un altro uomo. Ma perché avrei dovuto sentirmi in colpa, perché avrei dovuto avere paura, visto che stavo facendo quello che mi aveva ordinato? Forse perché dentro di me sapevo di amare Jonathan, soltanto Jonathan. Lui avrebbe vinto, sempre e comunque e su chiunque. «Lanny» sussurrò Jonathan durante uno dei nostri appuntamenti, baciandomi la mano mentre giaceva sdraiato sul fieno a recuperare fiato. «Tu meriti di meglio.» «Ti incontrerei in una foresta, in una caverna, in un campo» gli risposi, «se fosse l’unico modo di vederti. Non mi importa dove siamo. L’unica cosa che mi importa è che siamo insieme.» Belle parole, quelle degli innamorati. Ma mentre eravamo lì, sdraiati sul fieno, e gli accarezzavo la guancia, la mia mente non poté fare a meno di vagare. E vagò per luoghi pericolosi, insinuandosi in faccende che era meglio non rivangare, come le circostanze che mi avevano costretta a lasciare St. Andrew anni prima, delle quali Jonathan non aveva mai parlato. Da quando ero tornata in città non mi aveva chiesto nemmeno una volta del nostro bambino. Lui voleva chiedermelo; lo percepivo ogni volta che c’era una pausa di silenzio fra di noi, lo sorprendevo a guardarmi di sottecchi con mesta serietà. Quando sei partita da St. Andrew... ma le parole gli morivano in gola. Probabilmente pensava che avessi abortito, come gli avevo preannunciato quel giorno in chiesa. Ma io volevo che sapesse la verità. «Jonathan» dissi dolcemente, arrotolandomi i suoi ricci neri tra le dita e poi lasciandoli andare, «non ti sei mai chiesto perché mio padre mi abbia mandato via dal villaggio?» Lo sentii irrigidirsi e trattenere il fiato. Dopo un po’, rispose: «Quando ho scoperto che te n’eri andata, era ormai troppo tardi... Ho sbagliato a non cercarti prima, avrei dovuto controllare che non fossi nei guai o che non ti fosse successo qualcosa di brutto...» Iniziò a giocherellare con il pizzo del mio corpetto. «Che scusa ha usato la mia famiglia per spiegarti come mai mi avevano mandata via?» «Hanno detto di averti mandata a prenderti cura di un parente ammalato. Erano molto chiusi dopo la tua partenza, se ne stavano sulle loro. Una volta ho incontrato una delle tue sorelle al villaggio e le ho chiesto se avessero ricevuto tue notizie, se mi poteva dare un indirizzo a cui scriverti, ma lei è scappata via senza rispondermi.» Alzò il capo dal mio petto. «Non era così? Non stavi accudendo qualcuno?» Volevo ridere della sua ingenuità. «L’unica persona che aveva bisogno di cure ero io stessa. Mi hanno mandata via perché partorissi il bambino altrove. Non volevano che nessuno lo sapesse.» «Lanny!» Mi posò una mano sul volto, ma io la scacciai. «E hai...» «Non c’è nessun bambino. Ho avuto un aborto.» Non c’era alcuna emozione nelle mie parole, ora; non mi tremò la voce, non mi salì un nodo alla gola. «Mi dispiace così tanto di tutto quello che ti è successo, di quello che hai dovuto affrontare da sola...» Si mise a sedere, incapace di distogliere lo sguardo da me, ora. «C’entra qualcosa col fatto che sei finita a stare con quell’uomo? Quell’Adair?» Sono sicura che il mio volto a quel punto si scurì. «Non voglio parlarne.» «Quali prove hai dovuto affrontare, povera, coraggiosa Lanny? Avresti dovuto scrivermi, informarmi della tua situazione. Avrei fatto qualsiasi cosa per te, tutto quello che era in mio potere...» Cercò di abbracciarmi – e il mio corpo l’avrebbe desiderato con ogni fibra – poi sembrò ripensarci e si tirò indietro. «Ma sto impazzendo? Che cosa... che cosa stiamo facendo? Non ti ho già fatto abbastanza male? Che diritto ho di ricominciare con te, come se si trattasse semplicemente di un gioco?» Jonathan si prese la testa fra le mani. «Devi perdonare il mio egoismo, la mia stupidità...» «Non mi hai costretta» dissi, cercando di tranquillizzarlo. «Anch’io lo volevo.» Se solo avessi potuto ritrattare le mie parole... Era stato un errore parlare del bambino, ormai era morto e sepolto. Mi maledissi per aver ceduto alla mia indole meschina. Volevo che Jonathan sapesse quanto avevo sofferto e che riconoscesse la sua parte di colpa nel triste destino che mi aveva afflitto, ma tutto mi si era rivoltato contro. «Non possiamo andare avanti così. Questo è proprio l’ultimo dei problemi di cui ho bisogno ora.» Jonathan si allontanò da me e si alzò in piedi. Quando vide la mia espressione scossa e ferita continuò: «Perdona la franchezza, cara Lanny. Ma sai benissimo che ho una famiglia, una moglie, una figlia appena nata, obblighi e responsabilità che non posso tralasciare. Non posso mettere a repentaglio la loro serenità per rubare pochi momenti di piacere con te... e non c’è futuro per noi, non ci può essere. Sarebbe doloroso e ingiusto per te continuare così». Non mi ama abbastanza da scegliere me. La verità mi si conficcò improvvisamente nel cuore, come una lama lunga e affilata. Cercai di respirare. Sentii la rabbia incendiarmi. Possibile che se ne rendesse conto soltanto ora, dopo aver iniziato ancora una volta una relazione con me? Oppure a ferirmi di più era il fatto che per una seconda volta stava scegliendo Evangeline? Devo ammettere che il primo pensiero che mi venne in mente, mentre ero lì seduta in preda a un’emozione violenta, fu la vendetta. Ora mi è facile vedere con quanta facilità le donne rifiutate stringano un patto col diavolo; in quei momenti il bisogno di vendicarsi è troppo inferiore alla possibilità di farlo. Se Satana in persona mi fosse apparso davanti in quell’istante, promettendo di darmi i mezzi perché Jonathan soffrisse le pene eterne dell’inferno, io gli avrei dato la mia anima in cambio senza nemmeno pensarci su. Avrei stretto un patto col demonio per vendicarmi del mio amante infedele. Ma forse non c’era alcun bisogno di evocare il diavolo, di scrivere quel patto efferato e firmarlo col mio sangue. Forse lo avevo già fatto. A quel punto non avevo idea di come realizzare il piano di Adair, e l’idea di fallire mi riempì di terrore. Avevo creduto di riuscire a sedurre Jonathan, di convincerlo a seguirmi a Boston con le armi dell’amore e del sesso, ma avevo fallito. I rimorsi e il senso di colpa fecero allontanare da me il mio amante, anche se promise che sarebbe stato per sempre mio amico e, se ne avessi avuto bisogno, il mio benefattore. Rimasi in attesa, sperando che cambiasse idea e tornasse da me, ma a mano a mano che i giorni passavano fu sempre più chiaro che non sarebbe successo. Una visita, lo implorai. Vieni a Boston almeno a fare una visita. Ma Jonathan resistette. Un giorno addusse la scusa di non potersi fidare della madre, che avrebbe mandato a rotoli gli affari di famiglia in sua assenza; un altro giorno disse invece che aveva un problema di lavoro che richiedeva la sua presenza. Alla fine, comunque, era sempre sua figlia che gli impediva di partire. «Evangeline non mi perdonerebbe mai se la lasciassi da sola con la mia famiglia per un periodo così lungo, e non può certo affrontare tutto il viaggio con me, avendo la bambina» mi disse, come se fosse veramente legato mani e piedi a sua moglie e alla neonata: come a dirmi che non avrebbe mai messo i suoi desideri avanti a quelli della sua famiglia, perché era un marito e un padre coscienzioso. Scuse plausibili per un altro uomo, non per il Jonathan che conoscevo. Le nevicate in arrivo avvicinavano sempre più il giorno della mia partenza. Sentivo che se fossi rimasta a St. Andrew tutto l’inverno sarebbe accaduto qualcosa di terribile. Adair, infuriato perché avevo osato sfidarlo, avrebbe potuto radunare il suo branco infernale e abbattersi sul villaggio come una furia. Chissà che cosa avrebbero potuto fare quelle creature infernali dal cuore nero ai poveri innocenti di St. Andrew, segregati dalla neve e isolati dal resto del mondo. Pensai a quanto Alejandro e Dona mi avevano raccontato del passato barbaro di Adair, di come aveva guidato razzie di villaggi e sterminato tutti quelli che si opponevano. Pensai alle povere ragazze innocenti che aveva violentato, al modo in cui mi aveva drogato per poi abusare di me. Finché era nell’alta società di Boston, era costretto a tenere sotto controllo la sua natura brutale; non c’era modo di prevedere però come si sarebbe comportato in un villaggio isolato. E io sarei stata l’unica responsabile, colpevole di aver attirato quella piaga sui miei concittadini. Una sera, ero da Daughtery a riflettere sulla mia situazione, sperando di incontrare il giovane taglialegna che avevo visto quando ero arrivata, quando entrò Jonathan. Avevo già visto quell’espressione sul suo volto in precedenza: non era a caccia di compagnia perché si sentiva solo. Era appagato. Si era appena portato a letto qualcuno. Si sorprese nel trovarmi lì, ma ora che mi aveva vista non poteva certo andarsene senza parlarmi. Si accomodò su uno sgabello di fronte a me, la schiena verso il camino acceso. «Lanny, che cosa ci fai qui? Non è certo il posto giusto per una ragazza da sola.» «Oh, ma non sono certo una ragazza innocente, vero?» dissi, piccata, pentendomi immediatamente della mia acrimonia. «E dove altro posso andare? Non è che posso bere in compagnia di mia madre e di mio fratello: non riuscirei a sopportare i loro sguardi di disapprovazione. Tu almeno puoi sempre tornare nella tua grande casa e chiuderti nello studio per stare un po’ da solo. E avresti qualcosa di meglio da bere di quello che servono qui, comunque. A proposito, non dovresti essere a casa, a quest’ora? Con tua moglie? Hai combinato qualcosa, stasera. Te ne sento l’odore addosso.» «Considerata la tua posizione, non mi aspettavo che fossi così pronta a giudicarmi» disse. «Va bene, visto che me lo chiedi ti dirò la verità. Sono stato con un’altra donna. Una che vedevo prima che tu tornassi così inaspettatamente. Anch’io ho un’amante. È Anna Kolsted.» «Anna Kolsted è una donna sposata.» Lui fece spallucce. Tremavo di rabbia. «Perciò con lei non hai interrotto la relazione, nonostante tutte le belle parole che hai detto a me l’altro giorno, vero?» «Io... io non potevo lasciarla così bruscamente senza dirle quello che era successo.» «E le hai spiegato bene di aver avuto un improvviso rigurgito di coscienza? Le hai detto che hai deciso di non vederla più?» gli chiesi, come se ne avessi il diritto. Lui rimase in silenzio. «Ma non impari mai, Jonathan? Non può finire bene» dissi gelida. Jonathan strinse le labbra e serrò la mascella, distogliendo lo sguardo, mentre il suo risentimento saliva sempre di più. «Non sai dirmi altro, a quanto pare, vero?» Il nome di Sophia rimase sospeso fra di noi, senza essere pronunciato. «Finirà allo stesso modo. Si innamorerà di te e ti vorrà tutto per sé.» Mi ritornò la stessa paura, lo stesso rimorso che avevo provato quando avevamo trovato Sophia morta nel fiume. Non credevo che, dopo tutto quello che avevo passato, il suo fantasma avesse ancora il potere di tormentarmi. Forse era perché a volte mi chiedevo se non avrei fatto meglio a seguire il suo esempio. «È inevitabile, Jonathan. Tutti quelli che ti conoscono prima o poi vogliono possederti.» «Parli per esperienza, vero?» La sua risposta tagliente mi azzittì per un secondo. Ovviamente ce l’aveva con me per qualcosa, anche se non sapevo cosa. Con tono sarcastico dissi: «Quelli che ti hanno per sé tendono a sfidare la sorte. Forse dovresti chiedere un parere a tua moglie. Non hai mai pensato a quanto ne soffrirebbe la povera Evangeline se scoprisse la tua relazione con la signora Kolsted?» Jonathan fu sopraffatto dalla furia in un attimo, come una tempesta. Controllò dietro di sé per verificare che Daughtery fosse impegnato e che nessuno stesse ascoltando, poi mi afferrò per il braccio e mi tirò a sé. «Cristo santo, Lanny, abbi pietà di me. Sono sposato con una bambina. Aveva soltanto quattordici anni quando ci siamo sposati. Quando l’ho portata a letto la prima volta, dopo ha pianto. Ha pianto. Ha paura di mia madre e le mie sorelle la intimidiscono. Io non ho bisogno di una bambina, Lanny. Io ho bisogno di una vera donna.» Strappai il braccio dalla sua presa. «Credi che non lo sappia?» «Quanto vorrei non aver mai ceduto alle pressioni di mio padre. Non dovevo sposarla. Ma lui voleva un erede, era l’unica cosa che gli interessava. Ha visto una ragazzina con tanti anni fertili davanti a sé e ha concluso l’affare con il vecchio McDougal, come se lei fosse una giumenta.» Si passò una mano fra i capelli. «Non hai idea della vita che sono costretto a fare ora, Lanny. Non c’è nessuno che possa mandare avanti gli affari al posto mio. Benjamin ha l’intelligenza di un bambino di quattro anni. Le mie sorelle sono delle sempliciotte. E quando mio padre è morto, be’... Tutte le sue responsabilità mi sono piombate addosso. L’intero villaggio dipende dalle sorti della mia famiglia. Hai idea di quanti siano i coloni che acquistano i terreni con i soldi prestati da mio padre? Basta un inverno particolarmente rigido, o basta che non siano bravi a coltivare la terra, e rimangono indietro coi pagamenti. Potrei appropriarmi dei loro terreni, ma che cosa me ne farei di un’altra fattoria in fallimento? Perciò perdonami, per favore, se ho un’amante e mi concedo qualche distrazione da tutte le mie responsabilità.» Abbassai lo sguardo sull’avanzo di birra nel bicchiere. Lui proseguì in tono sempre più infervorato. «Non puoi immaginare quanto mi abbiano tentato le tue offerte. Darei qualsiasi cosa per liberarmi dai miei obblighi! Ma non posso, e credo che tu possa ben capirne il motivo. Non sarebbe soltanto la mia famiglia a pagarne il prezzo, sarebbe tutto il villaggio. Vite rovinate. Forse mi hai preso in un momento di debolezza quando sei tornata, Lanny, ma gli ultimi anni mi hanno insegnato una lezione, una dura lezione. Non posso essere così egoista.» Aveva dimenticato di avermi detto, una volta, che voleva lasciarsi tutto alle spalle, la sua famiglia, la sua ricchezza, per stare con me? Che un tempo sperava che al mondo ci fossimo soltanto noi due? Una donna più equilibrata sarebbe stata contenta di vedere che Jonathan era cresciuto e aveva imparato ad accettare le proprie responsabilità, sarebbe stata orgogliosa di vederlo reggere obblighi che avrebbero spezzato un uomo più debole. Ma io non posso dire di essermi sentita né felice né orgogliosa. Lo capivo, però. Amavo quel villaggio, a mio modo, e non desideravo affatto vederlo in rovina. Anche se la mia famiglia era in difficoltà, anche se i miei concittadini mi avevano trattata con disprezzo e non facevano altro che spettegolare su di me alle mie spalle, non potevo sottrarre loro il pilastro della comunità, era evidente. Rimasi davanti a Jonathan, rattristata e commossa dal tormento che mi aveva appena confessato. Eppure dentro di me il panico mi percorreva dalla testa ai piedi. La mia missione era fallita, avrei deluso Adair. Che cosa potevo fare? Finimmo la birra, tristi e sconsolati. Sembrava chiaro che avrei dovuto rinunciare a Jonathan. Dovevo concentrarmi sulla mia situazione: che cosa avrei fatto ora? Dove potevo rifugiarmi in modo che Adair non fosse in grado di rintracciarmi? Non avevo alcuna intenzione di subire le stesse orrende torture che mi erano già state inflitte una volta. Pagammo il conto e uscimmo sul sentiero, in silenzio, gravati dal peso delle nostre rispettive preoccupazioni. La notte era fredda, il cielo terso e illuminato dalla luna e dalle stelle, con nuvole leggere che ombreggiavano la luce argentea. Jonathan mi prese per il braccio. «Perdona il mio sfogo e dimentica i miei problemi. Hai tutti i diritti di detestarmi per quello che ti ho appena detto. L’ultima cosa che voglio è che tu ti faccia carico delle mie preoccupazioni. Il mio cavallo è nel granaio dei Daughtery, lascia che ti accompagni a casa.» Ma prima che riuscissi a dirgli che non era necessario e che preferivo essere lasciata da sola con i miei pensieri, fummo interrotti dal rumore di passi sul sentiero. Era tardi e si gelava, era improbabile che ci fosse ancora qualcuno in giro. «Chi è là?» urlai verso una figura nell’ombra. Edward Kolsted comparve alla luce della luna con un fucile in mano. «Andatevene per la vostra strada, signorina McIlvrae. Non ho niente contro di voi.» Kolsted era un uomo duro, apparteneva a una delle famiglie più povere del villaggio e non era certo in grado di competere con Jonathan per il cuore di nessuno. Magro, il volto sottile sfigurato dal vaiolo, come tanti altri giovani. Nonostante fosse ancora un ragazzo, i capelli castani gli si stavano assottigliando e i denti gli stavano già cadendo. Puntò il fucile al petto di Jonathan. «Non essere stupido, Edward. Ci sono dei testimoni: Lanny e gli uomini dentro da Daughtery... A meno che tu non voglia uccidere tutti quanti» gli disse Jonathan. «Non mi importa. Hai rovinato la mia Anna, mi hai reso lo zimbello del villaggio. Sarei orgoglioso di guadagnarmi la fama di quello che finalmente te l’ha fatta pagare.» Alzò ancora il fucile. Io ero paralizzata dal terrore. «Ma guardati, razza di bellimbusto» lo schernì Edward mirando con il fucile. A suo credito, Jonathan non si mosse di un millimetro. «Credi che qui piangeranno la tua morte? Per niente. Ti detestiamo tutti, tutti gli uomini del villaggio ti odiano. Credi che non sappiamo quello che vai in giro a fare, che fai perdere la testa alle nostre mogli con la tua stregoneria? Hai voluto divertirti con la mia Anna e nel farlo mi hai tolto la cosa più preziosa che avevo. Sei il demonio in persona, tu, e questo posto sarebbe migliore senza di te!» Edward aveva alzato la voce, ma nonostante le sue parole ero sicura che non avrebbe portato a compimento la sua minaccia. Voleva soltanto spaventare Jonathan, umiliarlo e costringerlo a chiedergli perdono, e questo gli avrebbe restituito un po’ di dignità. Ma non era abbastanza coraggioso da uccidere davvero il suo rivale. «È questo che vuoi da me, che sia il demonio? Certo, ti farebbe comodo, ti toglierebbe ogni colpa.» Jonathan abbassò le braccia. «Ma la verità è che tua moglie è una donna infelice e questo ha ben poco a che fare con me e molto a che fare con te.» «Bugiardo!» urlò Kolsted. Jonathan fece un passo verso il suo assalitore e io sentii una stretta allo stomaco, non capivo se Jonathan volesse trovare la morte o se volesse costringere Kolsted ad affrontare la verità. Forse sentiva di doverlo alla sua amante. Forse la nostra discussione da Daughtery lo aveva indotto a prendere una decisione. Ma il suo atteggiamento risoluto poteva essere travisato e Kolsted avrebbe potuto dedurne che Jonathan si comportava così perché amava Anna. «Se tua moglie fosse stata felice, non avrebbe cercato la mia compagnia. Lei...» Il vecchio fucile di Kolsted sparò, intravidi una fiammata azzurrognola uscire dalla canna. Fu tutto troppo veloce: uno scoppio come quello di un tuono, un lampo di luce, e all’improvviso Jonathan barcollò indietro, poi si accasciò al suolo. Il volto di Kolsted si contorse, illuminato da una lama di luce lunare per un istante. «Gli ho sparato» mormorò, come per rassicurarsi. «Ho sparato a Jonathan St. Andrew.» Caddi sulle ginocchia nel fango semicongelato, portandomi Jonathan in grembo. I suoi vestiti erano già inzuppati di sangue e anche il suo cappotto. Era una ferita profonda e grave. Avvolsi le braccia attorno al petto di Jonathan e guardai furiosa Kolsted. «Se avessi un fucile ti sparerei su due piedi. Sparisci subito.» «È morto?» Kolsted allungò il collo ma non riuscì a trovare il coraggio di avvicinarsi all’uomo cui aveva appena sparato. «Saranno tutti qui in un attimo e se ti trovano col fucile in mano ti sbatteranno subito in galera» sibilai minacciandolo. Volevo che se ne andasse: qualcuno dentro la locanda poteva sentirci e in ogni caso lo sparo avrebbe presto attirato gente. Dovevo nascondere Jonathan prima che ci scoprissero. Non dovetti ripeterlo due volte a Kolsted. Che fosse per paura o per improvviso rimorso, o forse perché non voleva essere imprigionato, l’attentatore di Jonathan indietreggiò come un cavallo imbizzarrito e corse via. Con le braccia strette al suo petto, trascinai Jonathan dentro il granaio dei Daughtery. Gli aprii il cappotto, poi la giacca, finché non scoprii la ferita al petto. Gli usciva sangue a fiotti da un foro proprio sopra il cuore. «Lanny» disse, cercando la mia mano. «Sono qui. Stai fermo.» Lui sospirò ancora e poi tossì. Non c’era nessuno che potesse aiutarci: gli aveva sparato a bruciapelo, colpendolo in un punto vitale. Riconobbi l’espressione sul suo volto: era la maschera di sofferenza di chi sta per morire. Perse conoscenza, abbandonandosi tra le mie braccia. Udii delle voci oltre le assi bucherellate dai tarli: alcuni uomini erano usciti dalla locanda dei Daughtery e ora erano sul sentiero. Il mio cuore accelerò i battiti, pervaso dal panico. Non trovando nessuno, si allontanarono. Abbassai lo sguardo sul meraviglioso volto di Jonathan. Il suo corpo, ancora caldo, mi pesava sul grembo. Devi farlo vivere. Devi tenerlo con te, a tutti i costi. Lo strinsi ancora più forte. C’era soltanto un modo per salvarlo. Feci scivolare il suo corpo a terra, gli aprii del tutto il cappotto e la giacca. Grazie a Dio era svenuto. Se non fossi stata così spaventata, non sarei mai riuscita a fare quell’incantesimo maledetto. Ma avrebbe funzionato? Forse mi ricordavo male o forse c’erano parole speciali che dovevo recitare per far funzionare una magia così potente. Comunque, non avevo tempo per i ripensamenti. Frugai nel corpetto, cercando la fiala d’argento. Quando a tentoni la scovai, strappai la stoffa e la estrassi dal suo nascondiglio. Con mani tremanti, tolsi il tappo e aprii le labbra di Jonathan. C’era soltanto una goccia avanzata, più piccola di una gocciolina di sudore. Pregai che bastasse. «Non lasciarmi, Jonathan. Non posso vivere senza di te» sussurrai nel suo orecchio; era l’unica cosa che mi era venuta in mente. Ma poi mi ricordai delle parole di Alejandro, di quello che mi aveva detto il giorno in cui ero stata trasformata. Pregai che non fosse troppo tardi. «Per mia mano, per mia volontà» dissi, sentendomi un po’ stupida perché sapevo di non avere potere su niente, né in terra né in cielo né all’inferno. Mi inginocchiai nel fieno, con Jonathan in grembo, e gli tolsi i capelli dalla fronte. Rimasi in attesa di un segno, di qualcosa. Di quello che era successo a me ricordavo soltanto la sensazione di cadere sempre più giù e la febbre che mi incendiava il corpo, e poi di essermi svegliata, molto tempo dopo, nell’oscurità. Strinsi ancora una volta Jonathan a me. Aveva smesso di respirare e stava diventando sempre più freddo. Gli richiusi il cappotto addosso, chiedendomi se sarei riuscita a portarlo fino alla fattoria della mia famiglia senza farmi notare. Sembrava improbabile, ma non c’era altro luogo in cui potessi portarlo, e prima o poi qualcuno sarebbe venuto a cercare nel granaio dei Daughtery. Sellai il cavallo di Jonathan, sorpresa di non essere più intimorita da quel fiero stallone. Con una forza che non sapevo di possedere, nata dalla situazione di estrema necessità, gettai Jonathan sul garrese del cavallo, montai sulla sella e uscii dal granaio, attraversando in fretta e furia il villaggio. Più di un abitante in seguito avrebbe dichiarato di aver visto Jonathan St. Andrew uscire dal villaggio a cavallo quella notte, alimentando le più disparate teorie sulle ragioni della sua scomparsa. Quando arrivammo alla fattoria della mia famiglia, sollevai il corpo di Jonathan, lo portai nel granaio e svegliai il mio cocchiere. Dovevamo andar via da St. Andrew quella notte stessa, non potevo correre il rischio di aspettare fino alla mattina, quando la famiglia di Jonathan sarebbe venuta a cercarlo. Dissi al cocchiere di sellare immediatamente i cavalli, saremmo partiti subito. Quando protestò che era troppo buio per viaggiare, gli dissi che la luna era piena e poi aggiunsi: «Sono io a pagarvi, quindi ascoltatemi bene. Avete quindici minuti per preparare i cavalli, non uno di più». Per quanto riguardava il baule con i miei vestiti e le altre cose, avrei abbandonato tutto. Non volevo svegliare i miei familiari. Il mio unico pensiero in quel momento era di portar via Jonathan dal villaggio. Mentre la carrozza sferragliava sulle strade innevate, lanciai uno sguardo oltre la tendina del finestrino per vedere se qualcuno in casa ci avesse sentito, ma non notai nessun movimento. Immaginai il momento in cui si sarebbero svegliati e si sarebbero accorti che ero scomparsa, chiedendosi – col cuore spezzato – perché avessi deciso di partire in quel modo, così misterioso come i miei anni di silenzio. Stavo commettendo una grande ingiustizia ai danni dei cuori generosi di mia madre e delle mie sorelle, e mi addolorava moltissimo, ma la verità era che era più facile deludere loro che perdere Jonathan per sempre. O disobbedire a Adair. Jonathan giaceva sulla panca di fronte a me, avvolto nel cappotto e in una coperta di pelliccia, col mio cappotto arrotolato a fargli da cuscino (io non ne avevo bisogno, il freddo non mi faceva alcun effetto). La testa era inclinata in modo strano. Non si muoveva, il petto non gli si alzava e abbassava per il respiro, non c’era alcun segno. Niente. La sua pelle era bianca come il ghiaccio alla luce della luna. Fissai lo sguardo sul suo volto, attendendo un segno di vita, ma era così immobile che iniziai a chiedermi se non avessi fallito. 38 Nelle ore che precedettero l’alba riuscimmo a percorrere parecchie miglia, allontanandoci dal villaggio, con la carrozza che sferragliava lungo il sentiero impervio e solitario che attraversava la foresta. Per tutto il tempo rimasi in silenzio a vegliare Jonathan. Sembrava un carro funebre, con me nella parte della vedova che accompagnava il cadavere del marito nell’ultimo viaggio, verso il luogo dell’eterno riposo. Il sole si era levato da un po’ quando Jonathan si mosse. Ormai ero quasi giunta alla conclusione che non sarebbe tornato indietro; ero rimasta per ore seduta immobile, tremante, sul punto di vomitare, piena di odio verso me stessa. Il primo segno di vita fu una contrazione sulla guancia destra. Poi sbatté le ciglia. Siccome era ancora bianco come un cadavere, per un attimo pensai che fosse un’illusione ottica, poi udii un basso lamento, vidi le sue labbra aprirsi e poi entrambi gli occhi spalancarsi. «Dove siamo?» mi domandò in un sussurro appena percepibile. «In una carrozza. Resta sdraiato. Tra poco ti sentirai meglio.» «Una carrozza? E dove stiamo andando?» «A Boston.» Non sapevo che cos’altro dirgli. «A Boston? Ma che cosa è successo? Io...» Probabilmente gli si era affacciata alla mente l’ultima cosa che ricordava, noi due nella locanda di Daughtery. «Ho forse perso una scommessa? Ero forse ubriaco e ho accettato di andare con te...» «Non c’è stato alcun accordo» dissi, inginocchiandomi accanto a lui per avvolgergli meglio il cappotto addosso. «Ci stiamo andando perché dobbiamo. Non puoi più rimanere a St. Andrew.» «Di che cosa stai parlando, Lanny?» Jonathan ora era arrabbiato con me e cercò di spingermi via, anche se era così debole che non riuscì nemmeno a spostarmi. Sentii qualcosa di duro sotto il ginocchio, come un sassolino appuntito; abbassai la mano e trovai un proiettile. Il proiettile sparato dal fucile di Kolsted. Lo sollevai davanti agli occhi di Jonathan. «Lo riconosci questo?» Cercò di mettere a fuoco il piccolo oggetto scuro che avevo in mano. Lo osservai e vidi che i ricordi gli tornavano alla mente: il litigio sul sentiero, lo sparo accecante che aveva posto fine alla sua vita mortale. «Mi ha sparato» disse, col petto che mostrava i segni dell’affanno. Si portò una mano sopra il cuore, sotto il cappotto e la camicia strappata e intrisa di sangue secco. Si tastò la pelle sotto i vestiti, ma non c’era più alcun segno. «Non sono ferito» disse Jonathan, sollevato. «Kolsted deve avermi mancato.» «Come potrebbe essere? L’hai visto il sangue? E i vestiti strappati? Kolsted non ti ha mancato, Jonathan. Ti ha preso al cuore e ti ha ucciso.» Lui serrò gli occhi. «Quello che dici non ha senso. Non capisco.» «Non è una cosa che possa essere capita» gli risposi, prendendogli la mano. «È un prodigio.» Cercai di spiegargli tutto, anche se, Dio mi è testimone, sapevo pochissimo io per prima. Gli raccontai la mia storia e quella di Adair. Gli mostrai la piccola fiala d’argento, ora vuota, e gli feci annusare gli ultimi vapori che ne uscivano. Mi ascoltò, guardandomi tutto il tempo come se fossi pazza. «Ordina al cocchiere di fermare la carrozza» mi disse infine. «Voglio tornare subito a St. Andrew, dovessi anche farmela tutta a piedi.» «Non posso lasciarti uscire.» «Ferma questa carrozza!» urlò, alzandosi in piedi e iniziando a picchiare i pugni sul tetto. Cercai di spingerlo a sedere, ma ormai il cocchiere aveva sentito e aveva arrestato i cavalli. Jonathan aprì la portiera e si scaraventò fuori, nella neve intonsa e alta fino alle ginocchia. Il cocchiere si voltò, guardandoci con sospetto dall’alto del suo scranno, i baffi incrostati di brina del suo stesso respiro. I cavalli ansavano, esausti dopo tutta quella strada percorsa nella neve. «Torniamo subito. Fate sciogliere della neve per abbeverare i cavalli, nel frattempo» dissi al cocchiere, nell’intento di distrarlo. Corsi dietro Jonathan, con le gonne che mi ostacolavano nella neve, lo raggiunsi e lo afferrai per un braccio. «Devi ascoltarmi. Non puoi tornare a St. Andrew. Sei cambiato, ora.» Mi respinse con forza. «Non so che cosa ti sia successo mentre eri via, ma... Non posso far altro che pensare che tu sia impazzita...» Mi aggrappai alla sua manica, come se ciò potesse impedirgli di scappare. «Posso provarti tutto. Se ti darò una prova, prometti che verrai via con me?» Si fermò e mi guardò come se si aspettasse qualche strano trucco da parte mia. «Non ti prometto un bel niente.» Alzai la mano, lasciando la presa sulla sua manica, indicandogli di aspettare. Con l’altra mano, presi un piccolo ma affilato pugnale dalla tasca del mio soprabito. Mi aprii il corpetto, esponendo il bustino all’aria gelida, e poi, afferrando l’impugnatura del pugnale con entrambe le mani, me lo conficcai nel petto fino all’elsa, senza nemmeno lasciarmi sfuggire un sospiro. Jonathan sembrò accasciarsi di schianto e sporse le mani verso di me. «Santo Dio! Tu sei davvero pazza! In nome del cielo, che cos’hai fatto...» Il mio sangue iniziò a spillare attorno all’elsa, finché una rosa rossa non si disegnò sulla seta, dallo sterno alla pancia. Estrassi la lama, poi gli afferrai la mano e premetti le sue dita sulla ferita. Cercò di tirar via la mano, ma io la bloccai lì dov’era. «Toccala. Voglio che tu senta quello che sta accadendo. Poi dimmi ancora che non mi credi.» Sapevo che cosa sarebbe successo. Era un trucchetto che Dona faceva spesso per intrattenerci quando ci riunivamo in cucina per rilassarci dopo una serata in città. Si sedeva davanti al camino acceso, poggiava il cappotto sulla spalliera della sedia, si tirava su le maniche e poi si incideva gli avambracci con il coltello, in profondità. Io, Alejandro e Tilde guardavamo i due lembi rossi della ferita strisciare l’uno verso l’altro, come due amanti in preda a una forza di attrazione superiore, per poi ritrovarsi in un abbraccio che li rendeva indistinti. Una cosa impossibile, che però accadeva davanti ai nostri occhi infinite volte. Dona rideva amaramente mentre guardava la sua carne guarire come per miracolo, ma quando avevo provato io a fare la stessa cosa avevo scoperto che si avvertiva una sensazione del tutto particolare. Quello che volevamo provare era il dolore, ma non riuscivamo a sentirlo, non esattamente. Eravamo giunti al punto di desiderare qualcosa di simile al suicidio, e inseguendolo potevamo concederci il momentaneo piacere di fare del male a noi stessi, ma anche quello ci era negato. Quanto odiavamo noi stessi, ognuno a suo modo! Il volto di Jonathan impallidì quando sentì la carne viva muoversi, tremare e infine richiudersi. «Che cosa...» mormorò, orripilato. «Qui c’è lo zampino del diavolo, non c’è altra spiegazione.» «Non saprei dirtelo. Non ho spiegazioni. Ma quello che è fatto è fatto e non c’è modo di tornare indietro. Non sarai mai più lo stesso di prima e il tuo posto non è più a St. Andrew. Adesso vieni con me» dissi. Sotto shock, pallido e inerme, non oppose resistenza quando lo presi per il braccio e lo trascinai verso la carrozza. Jonathan rimase catatonico per tutto il viaggio. Il suo silenzio e il suo sguardo vuoto mi riempirono di angoscia: volevo sapere se avrei riavuto o meno il mio amico. Il mio amante. Di noi due, era stato sempre Jonathan quello sicuro di sé e mi sentivo a disagio a ruoli invertiti. Ma sarebbe stato stupido aspettarmi qualcosa di diverso; in fondo, io stessa avevo sfiorato il baratro della depressione per tanto tempo, a casa di Adair, ritirandomi in me stessa e rifiutando di credere a quello che mi era successo. Durante la traversata in nave per Boston, Jonathan rimase tutto il tempo chiuso nella piccola cabina. Non salì sul ponte nemmeno una volta. Questo non fece altro che aumentare la curiosità dell’equipaggio e degli altri passeggeri, perciò anche se il mare era calmo come l’acqua di un pozzo, io dissi a tutti che non stava bene, che aveva il mal di mare e che non se la sentiva di alzarsi. Gli portai della zuppa e della birra, anche se ormai il suo corpo non aveva più bisogno di cibo e la fame era scomparsa. Jonathan avrebbe presto imparato che quando mangiavamo lo facevamo per abitudine, per puro conforto, per far finta di essere gli stessi di sempre. Quando la nave attraccò nel porto di Boston, Jonathan era ridotto a una creatura dallo strano aspetto emaciato, per via di tutte le ore trascorse nella penombra della cabina. Pallido e nervoso, con gli occhi cerchiati per la mancanza di sonno, emerse dalla sua cabina indossando i cenci che avevamo comprato a Camden in un negozietto che vendeva roba di seconda mano. Rimase in piedi sul ponte, circondato dagli sguardi attoniti degli altri passeggeri che, senza dubbio, per tutto il viaggio si erano chiesti se il passeggero invisibile non fosse in realtà morto nella sua cabina. Osservò l’attività sul molo mentre la nave veniva ancorata, fissando con gli occhi spalancati la quantità di gente a terra. Sembrava un po’ spaventato. La sua incredibile bellezza era stata attenuata dalle prove cui era stato sottoposto e per un momento desiderai che Adair non lo vedesse per la prima volta ridotto in quello stato. Volevo che Adair vedesse che Jonathan era esattamente come lo avevo descritto: che stupida vanità! Sbarcammo e non facemmo in tempo a percorrere qualche metro che scorsi Dona che ci aspettava insieme a un paio di servitori. Indossava un vistoso abito da funerale, con piume di struzzo nere appuntate sul cappello, era avvolto in un ampio mantello nero e si appoggiava su un bastone, torreggiando sulla gente comune come se fosse la morte in persona. Un sorriso maligno si fece strada sul suo volto quando ci vide. «Come facevi a sapere che sarei tornata oggi? Su questa nave?» pretesi di sapere. «Non ho mandato una lettera per avvisarvi dei miei programmi.» «Oh, Lanore, la tua ingenuità è ridicola. Adair sa sempre queste cose. Ha percepito la tua presenza all’orizzonte e mi ha mandato ad accoglierti» mi disse, scansandomi. Dedicò tutte le sue attenzioni a Jonathan, senza mascherare il fatto che lo stava esaminando da capo a piedi e viceversa. «Cosa aspetti? Presentami al tuo amico.» «Jonathan, lui è Donatello» dissi secca. Jonathan non si mosse, non sembrò nemmeno accorgersi della presenza dell’altro. Non riuscii a capire se fosse perché non gli era piaciuto il modo in cui Dona l’aveva esaminato o perché fosse ancora sconvolto. «Non sa parlare? Che razza di educazione ha ricevuto?» disse Dona. Quando Jonathan non raccolse la provocazione, Dona liquidò l’affronto rivolgendosi di nuovo a me. «Dove sono i tuoi bagagli? I servitori...» «Saremmo vestiti così se avessimo avuto altro da indossare, secondo te? Ho dovuto lasciare tutto indietro. Avevo a malapena i soldi per pagarmi il viaggio di ritorno.» Nella mia mente, visualizzai il baule che avevo abbandonato a casa di mia madre, anonimo e relegato in un angolo. Quando l’avrebbero aperto – quando, cioè, la curiosità avrebbe preso il sopravvento sulla riservatezza, pur sapendo che non sarei mai tornata da loro – avrebbero trovato il borsellino di camoscio pieno di monete d’oro e d’argento. Ero felice di aver lasciato lì il borsellino coi soldi; sentivo di dovere alla mia famiglia almeno quello. Era denaro di Adair, denaro sporco di sangue, il denaro che avrebbe ripagato la mia famiglia per avermi persa per sempre, proprio come lui stesso aveva acquietato il suo senso di colpa lasciando dei soldi per la sua famiglia secoli prima. «Come sei coerente. La prima volta sei venuta da noi senza niente. Ora porti il tuo amico con te, ed entrambi non avete niente di niente.» Dona alzò le mani esasperato, come a dire che ero incorreggibile, ma sapevo che era tutta una recita per non farsi vedere stizzito; anche ridotto com’era in quel momento, Jonathan era evidentemente un uomo eccezionale. Sarebbe diventato la luce degli occhi di Adair, l’amico e il compagno col quale Dona non avrebbe potuto competere. Dona sarebbe caduto in disgrazia e non c’era niente che potesse fare per impedirlo. E tutto questo fu chiaro a Dona fin dal primo momento in cui posò lo sguardo su Jonathan. Se solo Dona avesse saputo la verità, non avrebbe sprecato la sua invidia. Il nostro ignobile arrivo, quel giorno, fu l’inizio della fine per tutti noi. Jonathan riprese un po’ di vita sulla carrozza, durante il tragitto verso la casa di Adair. In fondo, quello era il suo primo viaggio in una città così grande, varia e piena di meraviglie come Boston e, attraverso i suoi occhi, io rivissi il mio arrivo di anni prima: la massa imponente di gente per le strade polverose; la quantità strabiliante di negozi e locande; le case imponenti fatte di mattoni, alte parecchi piani; il numero enorme di carrozze per strada, tirate da cavalli splendidi; le donne vestite all’ultima moda, che concedevano ampie vedute sul loro seno e sul collo bianco e affusolato. Dopo un po’, Jonathan dovette distogliere lo sguardo dal finestrino e chiudere gli occhi. E poi, naturalmente, c’era la casa di Adair, imponente quanto un castello. Ma a quel punto Jonathan era diventato insensibile alla magnificenza. Mi permise di condurlo su per la scalinata e dentro la casa, attraverso il foyer con il lampadario che ondeggiava appeso al soffitto e gli uscieri in livrea che si inchinarono tanto da poter ispezionare da vicino le scarpe incrostate di fango di Jonathan. Attraversammo il salone da pranzo con il tavolo apparecchiato per diciotto persone e giungemmo alla doppia scalinata che portava alle camere da letto al piano superiore. «Dov’è Adair?» chiesi a uno dei maggiordomi, ansiosa di chiudere la faccenda il prima possibile. «Proprio qui.» La sua voce si levò dietro di me e mi voltai, vedendolo entrare. Si era vestito con cura, con una studiata semplicità, i capelli legati sulla nuca da un nastro, alla moda europea. Come Dona, anche lui esaminò il mio Jonathan come se dovesse attribuirgli il giusto prezzo al mercato, strofinando le dita della mano destra. Per parte sua, Jonathan cercò di rimanere indifferente; lanciò un’occhiata a Adair e distolse subito lo sguardo. Ma io avvertii distintamente un cambiamento nell’atmosfera e colsi uno sguardo di riconoscimento passare tra di loro. Forse era ciò che intendevano i mistici quando parlavano di un legame tra anime destinate ad attraversare il tempo insieme in una forma o nell’altra. O forse era una danza di guerra tra capibranco selvaggi, mentre si chiedevano chi sarebbe stato il vincitore e quanto sarebbe stato sanguinario il combattimento. Oppure, era semplicemente il fatto che finalmente Jonathan aveva di fronte l’uomo che mi aveva conquistata. «Perciò sarebbe questo l’amico di cui ci hai parlato» disse Adair, fingendo che fosse tutto semplice, tanto semplice quanto ospitare un amico. «Maestà, ho l’onore di presentarvi Jonathan St. Andrew» dissi, cercando di imitare al meglio il tono di un usciere, ma nessuno dei due sembrò divertirsi. «E voi siete...» Jonathan cercò il termine migliore per descrivere Adair in base ai miei racconti, e in effetti con che appellativo era possibile definirlo? Mostro? Orco? Demone? «Lanny mi ha... mi ha raccontato di voi.» Adair inarcò un sopracciglio. «Davvero? Mi auguro che Lanny non abbia esagerato troppo di fantasia, infarcendo il racconto di idee strane che soltanto lei pare possedere. Un giorno dovrete raccontarmi che cosa vi ha detto.» Schioccò le dita all’indirizzo di Dona. «Mostra al nostro ospite la sua stanza. Dev’essere esausto.» «Posso accompagnarlo io» provai a dire, ma Adair mi interruppe. «No, Lanore, resta con me. Vorrei parlarti un momento da solo.» Fu in quel momento che capii di essere nei guai: vibrava di rabbia trattenuta, che nascondeva soltanto a beneficio del nuovo ospite. Guardammo Dona condurre un Jonathan catatonico su per le scale, finché non scomparvero dalla vista. Poi Adair si voltò di scatto verso di me e mi schiaffeggiò con forza in volto. Scaraventata per terra, mi portai una mano alla guancia e lo fissai in cagnesco. «Perché l’hai fatto?» «L’hai trasformato, vero? Mi hai rubato l’elisir e l’hai trasformato tu. Credevi davvero che non avrei scoperto quello che hai fatto?» Adair torreggiò su di me, sbuffando come un cane inferocito, con le spalle tremanti. «Non ho avuto scelta! Gli hanno sparato... sarebbe morto...» «Credi che sia stupido? Mi hai rubato l’elisir perché era questo che avevi in mente fin dall’inizio, trasformarlo! Legarlo per sempre a te!» Adair si chinò, mi prese per il braccio, mi costrinse ad alzarmi e mi sbatté contro il muro. Fui assalita dal panico e dai ricordi: lo scantinato, quella diabolica attrezzatura di cuoio e legacci, e io totalmente indifesa di fronte alla sua violenza. Poi mi colpì ancora, un manrovescio che mi scaraventò a terra un’altra volta. Mi portai ancora la mano alla guancia e sentii del sangue. Mi aveva squarciato la pelle e anche se la ferita aveva già iniziato a rimarginarsi, il dolore mi si irradiò in tutto il cranio. «Se avessi avuto intenzione di portartelo via, sarei tornata con lui?» Ancora sul pavimento, strisciai indietro come un gambero per allontanarmi dalla sua portata, inciampando sull’orlo della gonna. «No, sarei scappata portandolo con me. È esattamente come ti ho detto... Ho preso la fiala, sì, ma per precauzione. Avevo un presentimento, sentivo che sarebbe successo qualcosa di terribile. Ma sono tornata da te, Adair. Io ti sono fedele» dissi, anche se nel mo cuore avrei voluto ucciderlo, vendicarmi della sua violenza, furiosa per l’impossibilità di difendermi. Adair mi fulminò con lo sguardo, cercando di capire se credere alle mie parole. Ma non mi colpì più. Si voltò e se ne andò, e pronunciò il suo avvertimento in modo che riecheggiasse in tutta la casa. «Vedremo se la fedeltà che giuri di avere per me sarà tale. Non credere che finisca qui, Lanore. Distruggerò ciò che c’è tra te e quell’uomo, lo farò in pezzi così piccoli che il legame tra di voi sarà meno di niente. Puoi rubare le mie cose, puoi fare piani alle mie spalle, ma non otterrai mai nulla. Sei mia, Lanore, e se credi che io non possa disfare quello che tu hai fatto sei in errore. Anche Jonathan sarà mio.» Rimasi accasciata sul pavimento, con la mano sulla guancia, cercando di soffocare il panico che mi avevano suscitato le sue parole. Non potevo permettergli di togliermi Jonathan. Non potevo lasciare che distruggesse il mio legame con l’unica persona al mondo cui tenessi veramente. Se avessi perduto Jonathan, la vita non avrebbe avuto senso... e, purtroppo, non mi sarebbe rimasto altro che la vita. 39 Québec, oggi È quasi mezzanotte quando arrivano a Québec. Lanny conduce Luke in quello che pare essere il miglior albergo della città vecchia, un edificio alto simile a una fortezza, con un parapetto dal quale sporgono bandiere che garriscono al vento gelido della notte. Ben contento di essere alla guida di un SUV nuovo di zecca invece che del suo vecchio pickup, Luke porge al parcheggiatore le chiavi e poi lui e Lanny entrano nella lobby, senza bagagli. La camera d’albergo è senza dubbio il posto più lussuoso in cui sia mai entrato; al confronto, l’albergo in cui è stato durante il viaggio di nozze impallidisce. Il letto è enorme, con materassi di piuma, una decina di cuscini e lenzuola Frette, e mentre si lascia cadere tra le sue braccia vellutate, punta un telecomando verso il televisore a schermo piatto. Il telegiornale locale dovrebbe andare in onda entro pochi minuti ed è ansioso di scoprire se parleranno della scomparsa di una sospetta omicida da un ospedale del Maine. Luke spera che St. Andrew sia troppo lontana e insignificante perché la storia arrivi fino in Québec. Gli cadono gli occhi sul computer portatile di Lanny, ai piedi del letto. Potrebbe controllare se c’è qualcosa su internet, ma di colpo è assalito da una paura del tutto irrazionale: se cerca notizie su di loro in rete, in qualche modo lascerà una traccia, e le autorità saranno in grado di risalire a loro tramite la connessione internet e l’uso di parole chiave sospette. Il battito accelera, anche se sa che non è possibile. La sua paranoia sta raggiungendo il culmine anche se sa benissimo che non ce n’è alcuna ragione. Lanny esce dal bagno avvolta da una nuvola di vapore. L’accappatoio dell’albergo le sta larghissimo, pende sul suo corpo minuto, e ha un asciugamano avvolto a turbante in testa, con alcuni ricci umidi che le cadono sugli occhi. Estrae un pacchetto di sigarette dalla tasca della giacca. Prima di accenderne una, offre il pacchetto a Luke, ma lui fa un cenno di rifiuto. «La doccia è paradisiaca» dice, sbuffando un rivolo di fumo verso l’impianto antincendio sapientemente occultato nel soffitto. «Dovresti approfittarne anche tu.» «Tra un minuto» risponde lui. «Che cosa c’è in televisione? Stai controllando se parlano di noi?» Lui annuisce, agitando il piede verso lo schermo. Compare il logo del notiziario e poi un uomo di mezz’età dall’aspetto serio inizia ad annunciare i titoli di testa mentre il suo co-conduttore annuisce. Lanny rimane seduta con le spalle rivolte allo schermo, asciugandosi i capelli. Al settimo minuto del notiziario, lo schermo si riempie con una foto di Luke. È lo scatto del tesserino dell’ospedale, quello che appare ogni volta che il suo nome viene menzionato nella newsletter ospedaliera. «... è scomparso ieri sera dopo aver curato una donna sospettata di omicidio all’ospedale della contea di Aroostook, e le autorità temono che possa essergli accaduto qualcosa di grave. La polizia chiede a chiunque sappia dove si trovi attualmente il dottore di chiamare il numero in sovrimpressione...» Il servizio dura meno di un minuto, ma lo sconvolge vedere il proprio volto in televisione, al punto che non riesce a prestare ascolto alle parole del giornalista. Lanny gli prende il telecomando dalle mani e spegne il televisore. «A quanto pare ti stanno cercando» dice, e la sua voce lo risveglia dalla momentanea paralisi. «Ma non dovrebbero attendere quarantott’ore prima di considerarlo ufficialmente un caso di persona scomparsa?» chiede lui, leggermente indignato, come se avesse subito un’ingiustizia. «Non hanno aspettato perché ti considerano in pericolo.» E lo sono? si chiede. Non è che lo sceriffo Joe Duchesne sa qualcosa che io non so? «Hanno fatto il mio nome in diretta. L’hotel...» «Non c’è motivo di preoccuparsi. La stanza l’abbiamo presa a mio nome, ricordi? La polizia di St. Andrew non sa come mi chiamo. Nessuno può fare due più due, in questo caso.» La ragazza si volta ed esala un altro sbuffo di fumo. «Andrà tutto bene. Fidati di me. Sono un’esperta della fuga.» Luke sente il cervello premere contro le pareti interne del cranio, come se volesse schizzare fuori. L’enormità di ciò che ha fatto lo assale: Duchesne vorrà parlare con lui. Peter, senza dubbio, avrà detto alla polizia del SUV e dell’e-mail, perciò lui e Lanny non possono certo continuare a usare quel veicolo. Per poter tornare a casa, dovrà mentire in modo estremamente convincente allo sceriffo e ripetere la stessa menzogna a tutti quanti, a St. Andrew, forse per il resto della sua vita. Chiude gli occhi, respira e cerca di riflettere con calma. È stato il suo istinto a spingerlo ad aiutare Lanny. Perciò, se solo riuscisse ad arginare il panico che gli ottunde i pensieri, il suo istinto gli potrebbe rivelare ciò che veramente vuole, perché è fuggito in quel modo dalla sua vita, perché si è lanciato in fuga con quella sconosciuta, facendo terra bruciata dietro di sé. «Significa che non potrò mai tornare indietro?» chiede. «Se è quello che vuoi, perché no?» risponde lei, con cautela. «Ti faranno un sacco di domande, ma niente che tu non possa gestire. Ma tu vuoi davvero tornare a St. Andrew? Vuoi tornare alla fattoria dei tuoi genitori, a quella casa piena dei loro ricordi ma senza le tue figlie? Vuoi tornare all’ospedale a prenderti cura dei tuoi ingrati concittadini?» Luke si sente ancora più a disagio. «Non voglio parlarne.» «Luke, ascoltami. So cosa stai pensando.» Scivola sul letto e si siede accanto a lui, vicina, così che lui non possa voltarsi. Lui sente un leggero profumo di sapone che, spinto dal calore della pelle, si leva da sotto l’accappatoio. «Vuoi tornare lì solo perché lì c’è tutto quello che conosci. Tutto quello che ti rimane. L’uomo che ho visto entrare nel pronto soccorso mi è sembrato esausto, sfinito. Hai dovuto affrontare la perdita dei tuoi genitori, di tua moglie, delle tue figlie... Ormai non c’è più niente per te, là. È una prigione. Se ora torni a St. Andrew, ci rimarrai per il resto della tua vita. Invecchierai circondato da persone che non si interessano minimamente a te. So che cosa stai provando. Sei da solo e hai paura di rimanere da solo per il resto della tua vita, a vagare in una grande casa senza nessuno con cui parlare. Nessuno che sia al tuo fianco nelle piccole cose della vita quotidiana – nessuno con cui cenare, nessuno che ti ascolti raccontare com’è andata la giornata. Hai paura della vecchiaia – chi ci sarà con te? Chi si prenderà cura di te come tu ti sei preso cura dei tuoi genitori, chi ti terrà per mano quando sarai in punto di morte?» Luke sa che quelle parole sono tanto brutali quanto vere, e non riesce a sopportarlo. Lei gli avvolge un braccio attorno alle spalle e quando lui non la respinge lei lo attira a sé e preme il volto sul suo braccio. «Hai tutti i motivi di aver paura di morire. La morte si è presa tutti quelli che conoscevo. Li ho tenuti fra le mie braccia, nel momento della fine, li ho confortati, ho pianto quando se ne sono andati. La solitudine è una cosa terribile.» Sono parole assurde, dette da una ragazza così giovane, ma la sua tristezza è profonda e palpabile. «Posso stare per sempre con te, Luke. Non me ne andrò. Starò con te per il resto della tua vita, se vorrai.» Luke non si allontana da lei, ma pensa alle sue parole. Non gli sta proponendo amore, giusto? No, Luke lo sa bene, non è uno stupido. Ma non è nemmeno amicizia, non esattamente. Non si illude che lui e Lanny si siano trovati, che siano anime gemelle: si conoscono da meno di trentasei ore. Perciò, crede di capire bene che cosa esattamente gli stia offrendo quella ragazza. Lei ha bisogno di un compagno. Luke ha seguito un istinto che non credeva albergasse dentro di lui e l’ha aiutata. Perciò, lei crede che possa funzionare. In cambio, lui può lasciarsi alle spalle le complicazioni della sua vecchia vita senza dover far niente, senza nemmeno dover chiudere il contratto dell’elettricità. E non sarà mai più solo. Rimane fra le braccia di Lanny, lascia che lei gli accarezzi la schiena, godendo della sensazione della sua mano sulla pelle. Lentamente gli si schiariscono le idee e Luke si sente in pace per la prima volta da quando lo sceriffo l’ha portata nel pronto soccorso. Sa che, se ci pensa troppo, la sua mente tornerà ad annebbiarsi. Gli sembra di essere un personaggio di una fiaba, ma se si sofferma troppo a riflettere su quanto sta accadendo, se rifiuta il richiamo della storia di Lanny, la confusione tornerà. Avverte la tentazione di non mettere in dubbio il mondo invisibile di Lanny. Se accetta che quello che lei gli ha raccontato è vero, dovrà ammettere che ciò che ha sempre pensato della morte è falso. Ma Luke è un medico, ha visto più volte la morte, ha visto più volte la vita abbandonare un paziente. Ha imparato ad accettare la morte come uno dei pochi assoluti esistenti, e ora lei gli sta dicendo che non è così. Ci sono alcuni destini che sono stati iscritti nel codice della vita in inchiostro invisibile. Se la morte non è un assoluto, allora quali altri fatti, quali altre convinzioni che ha appreso nella vita sono bugie? Ammesso che la storia di quella ragazza sia vera. Anche se finora l’ha seguita in una sorta di stupore annebbiato, Luke non riesce ancora a scrollarsi di dosso il dubbio di essere vittima di un inganno. È evidente che lei è molto brava a manipolare le persone, come molti psicopatici. Ma ora non riesce a pensare a tutto questo. Lei ha ragione su una cosa, almeno: è stanco, sfinito, e ha paura di giungere alla conclusione errata, di prendere la decisione sbagliata. Si lascia andare sul cuscino, dal leggero profumo di lavanda, e si accuccia contro il corpo caldo di Lanny. «Non ti preoccupare. Non andrò da nessuna parte, ora. Anche perché non mi hai raccontato il resto della tua storia. Voglio sapere cos’è successo dopo.» 40 Boston, 1819 Quella sera, la prima sera di Jonathan a Boston, uscimmo. L’evento era una cosa piuttosto tranquilla – un concerto tenuto da un pianista e un cantante sconosciuto – ma io non credevo comunque che fosse una buona idea portarlo fuori, era ancora in stato confusionale, la sua mente era in subbuglio. La parola d’ordine di Adair era sempre stata la segretezza. Aveva raccontato a tutti noi le occasioni in cui era stato sospettato di stregoneria ed era riuscito a malapena a scappare da folle inferocite, fuggendo a cavallo nelle notti di luna, lasciandosi alle spalle fortune che aveva impiegato decenni ad accumulare. E Dio solo sapeva che cosa poteva lasciarsi sfuggire Jonathan visto lo stato in cui era ridotto. Ma Adair non si lasciò dissuadere, ci mandò a cercare nei bauli un completo da sera che andasse bene a Jonathan. Alla fine, però, impose a Dona di cedere a Jonathan il suo meraviglioso completo francese (Jonathan era alto come Dona, aveva solo le spalle più larghe) e ordinò a una servetta di fare le necessarie modifiche, mentre noi ci truccavamo, ci profumavamo e ci vestivamo. Avremmo introdotto Jonathan nel bel mondo cittadino; ma non poteva certo dichiarare il suo vero nome. «Devi ricordarti di presentarti con un altro nome» gli spiegò Adair, mentre i servitori ci aiutavano a indossare i mantelli e i cappelli alla luce del candelabro nell’ingresso. «Non possiamo permettere che giunga voce al tuo villaggetto sperduto che Jonathan St. Andrew è stato visto a Boston.» La ragione era ovvia: la famiglia di Jonathan l’avrebbe cercato in lungo e in largo. Ruth St. Andrew non si sarebbe mai arresa al mistero della scomparsa di suo figlio. Avrebbe organizzato ricerche in tutto il circondario, e poi nei boschi e nelle foreste. Quando la neve si fosse sciolta a primavera senza il rinvenimento del corpo, avrebbe dedotto che Jonathan se n’era andato di sua volontà e avrebbe allargato ulteriormente le maglie della ricerca, nel disperato tentativo di trovarlo. Non potevamo permetterci di lasciare tracce che avrebbero potuto condurre qualcuno fino a noi. «Perché ci tieni tanto a portarlo fuori già stasera? Perché non lasci che si riprenda con calma?» domandai stizzita a Adair mentre salivamo sulla carrozza. Mi guardò come se fossi un’idiota, una bambina fastidiosa e stupida. «Perché non voglio che si chiuda nella sua stanza, al buio, a ripensare a ciò che si è lasciato alle spalle. Voglio che veda ciò che il mondo ha da offrirgli.» Sorrise a Jonathan, anche se Jonathan aveva lo sguardo scuro e perso fuori dal finestrino della carrozza, indifferente perfino alla mano di Tilde che gli carezzava provocatoriamente il ginocchio. C’era qualcosa nella risposta di Adair che non mi convinceva, e avevo imparato a fidarmi del mio istinto quando mi diceva che Adair stava mentendo. Adair voleva che Jonathan fosse visto in pubblico, ma il motivo mi sfuggiva. La carrozza ci condusse a un edificio alto e imponente non molto lontano dal parco di Boston. Era la casa di un consigliere municipale e avvocato, la cui moglie era impazzita per Adair. O meglio, era impazzita per ciò che Adair incarnava: l’aristocrazia europea e l’eleganza più raffinata. Se solo avesse saputo che, in verità, stava intrattenendo il figlio di uno zingaro, un contadino con le mani lorde di fango e di sangue... Il marito si recava sempre nella fattoria di famiglia, ai confini della città, quando sua moglie dava una delle sue feste ed era meglio così, perché avrebbe avuto un colpo apoplettico se avesse visto che cosa accadeva in quelle occasioni e come sua moglie spendeva i suoi soldi. Oltre ad aggrapparsi al braccio di Adair per la maggior parte della serata, la moglie del consigliere cercava sempre di farlo interessare alle sue figlie. Nonostante l’America avesse da poco conquistato la propria indipendenza e avesse scelto la democrazia invece della monarchia, c’erano ancora molte persone innamorate dell’idea di una dinastia reale, e la moglie del consigliere probabilmente sognava di far sposare una delle sue figlie a un nobile. Mi aspettavo che, al nostro arrivo, si sarebbe abbattuta su Adair come una tempesta di gonne di taffettà e di inchini, conducendo nella sua scia le figlie e spingendole sempre più vicine al conte, così che lui potesse agevolmente sbirciare nel loro décolleté. Ma quando Jonathan fece il suo ingresso nel salone da ballo, tutti si azzittirono per un momento e poi cominciarono a serpeggiare dei mormorii. Non è esagerato dire che tutti, nessuno escluso, gli puntarono gli occhi addosso. Tilde lo prese sottobraccio e lo condusse dove si trovava Adair in conversazione con l’ospite. «Permettetemi di presentarvi» disse Adair e poi fornì alla moglie del consigliere un nome con cui ricordare Jonathan, Jacob Moore, un nome molto comune. Lei alzò lo sguardo e rimase senza fiato. «È un mio cugino ed è americano, pensate un po’.» Adair posò un braccio sulle spalle di Jonathan. «La famiglia di sua madre è inglese, così come quella della mia, e siamo lontani parenti...» Adair smise di parlare quando si accorse che nessuno – per la prima volta da quando era arrivato in America – lo stava ad ascoltare. «Siete appena arrivato a Boston?» chiese la donna a Jonathan, senza staccare gli occhi dal suo volto. «Perché di certo mi ricorderei di voi se vi avessi visto prima.» Io ero accanto al tavolino del punch con Alejandro, a guardare Jonathan che abbozzava una spiegazione, con Adair che cercava di soccorrerlo. «Credo proprio che non rimarremo qui molto, stasera» osservai. «Non sarà così facile come crede Adair.» Alejandro sollevò il calice nella loro direzione. «È impossibile nascondere un volto come quello. Si spargerà la voce, e potrebbe arrivare perfino al tuo villaggetto dimenticato da Dio.» C’erano preoccupazioni più urgenti, comunque, pensai osservando Jonathan e Adair insieme. Le donne si raccoglievano in branco non attorno all’aristocratico europeo ma davanti allo sconosciuto alto e bello. Lo fissavano da dietro i ventagli aperti. Si mettevano in fila, rosse in volto, in attesa di essere presentate. Avevo già visto quelle espressioni in passato, e in quel momento capii che la cosa non sarebbe mai cambiata. Ovunque Jonathan fosse andato, le donne avrebbero cercato di possederlo. Anche se lui non faceva niente per incoraggiarle, avrebbero sempre tentato di conquistarlo. La competizione era stata già difficile in un posto piccolo come St. Andrew, ma a Boston... Capii che da quel momento in poi Jonathan non sarebbe mai più stato mio, mio e basta, avrei sempre dovuto condividerlo con qualcuno. Quella sera, Adair sembrò soddisfatto di cedere la scena a Jonathan; e, in effetti, sembrava prestare particolare attenzione alle reazioni delle altre persone. Ma non potevo fare a meno di chiedermi quanto sarebbe durato. Adair non mi sembrava il tipo capace di vivere all’ombra di un’altra persona; fino a quel momento lui era sempre stato il polo d’attrazione, e così voleva che andassero le cose, inevitabilmente. Anche Jonathan non avrebbe avuto altra scelta. «Sento che presto ci saranno guai grossi» mormorai ad Alejandro. «Quando c’è di mezzo Adair, ci sono sempre guai. Si tratta soltanto di vedere quanto grossi.» Rimanemmo più a lungo di quanto pensavo. La notte stava per arrendersi allo sbocciare purpureo dell’alba quando rientrammo verso casa, stanchi e silenziosi. Notai che Jonathan aveva iniziato a uscire dal suo guscio. Forse perché aveva bevuto troppo, aveva le guance arrossate e sembrava decisamente meno nervoso. Salimmo le scale in silenzio e il rintocco dei nostri tacchi sul pavimento di marmo riecheggiò per tutta la casa, vuota. Tilde prese Jonathan per mano, cercando di portarselo in camera, ma lui si sottrasse alla presa, scuotendo il capo. Uno a uno, i cortigiani scomparvero dietro le porte dorate delle loro camere finché non rimanemmo che io, Adair e Jonathan. Stavo per riaccompagnare Jonathan nella sua camera, per dirgli qualche parola di rassicurazione e, con un po’ di fortuna, essere invitata a riscaldarlo sotto le coperte, quando fui fermata da un braccio attorno alla vita. Adair mi fece voltare e mi strinse a sé. Davanti a Jonathan, mi infilò una mano sotto il corpetto e mi palpò il sedere. Con un calcio, aprì la porta della sua camera. «Vuoi unirti a noi stanotte?» disse a Jonathan strizzando l’occhio. «Sarà una notte indimenticabile, per celebrare il tuo arrivo. Lanore è perfettamente in grado di dare piacere a entrambi, l’ha già fatto parecchie volte. Dovresti vedere tu stesso: è particolarmente portata per compiacere due uomini contemporaneamente.» Jonathan impallidì e indietreggiò. «No? Allora sarà per un’altra volta. Forse quando sarai più riposato. Buona notte» disse Adair e mi trascinò dietro di sé. Era impossibile fraintendere il suo messaggio: io non ero altro che una puttana qualunque. Era così che Adair voleva uccidere qualsiasi amore Jonathan provasse per me, e in quell’istante capii che ero stata stupida a dubitare che Adair potesse portare a compimento la sua minaccia. Riuscii a malapena a guardare il volto di Jonathan – sconvolto, ferito – prima che la porta si richiudesse. La mattina seguente, raccolsi i miei vestiti e, in sottoveste e a piedi nudi, andai davanti alla camera da letto di Jonathan, in attesa di udire qualcosa che mi facesse capire che era sveglio. Impazzivo nell’attesa di sentire i rumori del risveglio – il fruscio delle lenzuola, l’acqua nella bacinella – perché mi avrebbero lasciato intendere che tutto era normale. Non sapevo se ce l’avrei fatta ad affrontarlo. Volevo vederlo per avere le stesse rassicurazioni che i bambini cercano sul volto dei genitori dopo essere stati puniti, ma mi mancava il coraggio di bussare. In ogni caso dentro era tutto silenzioso e immobile, e vista la lunga e tormentata giornata che Jonathan aveva trascorso, dovevo aspettarmelo che dormisse per un giorno filato. Così tornai nella mia camera, mi lavai e indossai vestiti puliti, poi mi avviai al piano di sotto sperando che, nonostante fosse così presto, i servitori avessero già preparato il caffè. Con mia sorpresa, c’era Jonathan seduto nella sala da pranzo piccola, con una tazza di latte caldo fumante e del pane davanti a sé, sul tavolo. Sollevò lo sguardo su di me. «Ti sei svegliato» dissi, stupidamente constatando l’ovvio. Lui si alzò e spostò indietro la sedia di fronte alla sua. «È tutta la vita che seguo gli orari dei contadini. Sono sicuro che ti ricordi ancora com’era a St. Andrew. Se dormivi oltre le sei di mattina, entro mezzogiorno tutto il villaggio avrebbe sparlato di te. L’unico caso in cui era ammesso era se ti trovavi sul letto di morte» disse ironicamente. Un giovane servitore assonnato portò una tazza e un piattino, rovesciando goffamente un po’ di caffè oltre il bordo della tazza, poi la posò accanto al mio braccio sinistro, annuì e se ne andò. Anche se la sera prima non avevo fatto altro che pensare a come spiegare la mia situazione a Jonathan, in quel momento mi trovai senza parole. Non avevo idea di come cominciare, quindi mi ritrovai a giocherellare nervosamente con la delicata maniglia della tazza. «Quello che hai visto la notte scorsa...» Jonathan alzò una mano, con il volto contratto, come se non avesse alcuna voglia di affrontare quel discorso pur sapendo di doverlo fare. «Non so perché ho reagito in quel modo ieri sera... Mi avevi spiegato con sufficiente chiarezza la tua situazione quando ancora eravamo a St. Andrew. Se ti sono sembrato sconvolto è perché, come dire, non mi aspettavo che Adair mi facesse quella proposta.» Jonathan si schiarì la voce. «Sei sempre stata la mia più cara amica, Lanny...» «Questo non è cambiato, Jonathan.» «... ma non ti direi la verità se negassi che le sue parole mi hanno sconvolto. Non sembra il tipo d’uomo che una donna dovrebbe permettersi di amare.» Sembrava particolarmente afflitto da quello che mi stava dicendo. Abbassò lo sguardo sul tavolo. «Tu lo ami?» Come poteva pensare che io amassi qualcun altro che non fosse lui? Ma non sembrava geloso, soltanto preoccupato. «L’amore non c’entra niente» risposi tetra. «Devi capirlo.» La sua espressione cambiò di colpo, come se gli fosse venuto in mente qualcosa. «Non dirmi che ti... che ti costringe a fare quelle cose?» Arrossii. «Non esattamente.» «Quindi tu vuoi stare con lui?» «Non più, ora che ci sei tu qui» risposi, e lui sembrò imbarazzato, ma non seppi dire perché. In quel momento, non volevo altro che avvisare Jonathan delle intenzioni di Adair nei suoi riguardi. «Ascolta, c’è una cosa che ti devo dire su Adair, anche se ormai probabilmente l’hai intuita avendo conosciuto Dona e Alejandro. Loro sono...» Esitai, incerta su quanto altro potesse sopportare Jonathan dopo tutto quello che aveva passato nelle ultime ventiquattr’ore. «Sono sodomiti» disse lui con semplicità, portandosi la tazza di caffè alle labbra. «Uno non passa un’intera vita in mezzo ai taglialegna, che non hanno altra compagnia se non quella maschile, senza intuire qualcosa al riguardo.» «Loro vanno a letto con Adair. Vedi, Adair ha un’indole piuttosto peculiare» dissi. «È un fanatico del sesso, in qualsiasi forma. Ma non c’è traccia di amore o di tenerezza in quello che fa.» Mi fermai prima di dire che Adair usava il sesso come forma di punizione, per esercitare il suo potere su di noi, per costringerci a obbedirgli. Non dissi niente perché avevo paura, proprio come Alejandro non mi aveva detto nulla per paura che la verità mi sconvolgesse. Jonathan mi guardò negli occhi, con la bocca serrata. «In che cosa mi hai trascinato, Lanny?» Gli presi la mano. «Mi dispiace, Jonathan, davvero. Devi credermi. Ma... Anche se non vuoi sentirmelo dire, per me è di immenso conforto averti qui. Sono stata così sola. Avevo bisogno di te.» Lui ricambiò la stretta alla mano, anche se con una certa riluttanza. «E poi» continuai, «cos’altro potevo fare? Kolsted ti aveva sparato. Stavi sanguinando, stavi morendo fra le mie braccia. Se non avessi agito subito, saresti...» «Morto, lo so. È solo che... Spero di non trovarmi mai a sperare di esserlo.» Quella mattina, Adair convocò il sarto. Jonathan aveva bisogno di un guardaroba nuovo, decretò. Non poteva permettere che il suo nuovo ospite fosse visto in pubblico con vestiti inadeguati e di misura sbagliata. Visto che tutti gli altri membri della nostra conventicola erano fanatici di vestiti e avevano arricchito il sarto, il signor Drake accorse ancor prima che la tavola della colazione fosse sparecchiata, accompagnato da uno stuolo di assistenti che trasportavano enormi rotoli di stoffa. Lane e velluti, sete e broccati provenienti dalle case di moda europee. Cofanetti colmi di costosissimi bottoni di madreperla e di osso, fibbie in peltro per le scarpe. Sentivo che Jonathan non approvava e non voleva indebitarsi con Adair per avere un guardaroba di lusso, ma non disse niente. Io rimasi seduta su uno sgabello ai margini dell’attività frenetica in corso, guardando con desiderio quelle stoffe meravigliose, sperando di ottenere a mia volta un paio di vestiti. «Sai, anche a me servirebbero un po’ di cose nuove» dissi a Adair, avvicinando uno scampolo di satin rosa alla guancia per vedere se si abbinava bene al mio incarnato. «Ho dovuto lasciare tutto il mio guardaroba a St. Andrew quando siamo scappati e ho dovuto anche vendere l’ultimo gioiello che avevo per pagare la nave fino a Boston.» «Non ricordarmelo» mi rispose seccamente. Il signor Drake fece salire Jonathan su uno sgabello davanti allo specchio più grande della casa e iniziò a prendere le misure con un nastro, impressionato dalle proporzioni del corpo di Jonathan. «Santo cielo, quanto siete alto» commentò, muovendo le mani sulla schiena di Jonathan, poi sui fianchi e infine – provocandomi un mancamento – lungo l’interno delle cosce per prendere le misure del cavallo. «Il signore calza a sinistra» mormorò Drake, con tono incantato, rivolto a un assistente che annotava le misure. L’ordinativo per il sarto era lungo e articolato: tre redingote e una decina di paia di pantaloni, incluso un paio fatto di squisita pelle di daino per andare a cavallo; una decina di camicie, inclusa una ornata di pizzo per le serate di gala; quattro gilet; almeno una decina di cravatte. Un paio di stivali nuovi. Calze e reggicalze di lana e di seta, tre paia ciascuno. E questo per le necessità più immediate. Altri ordini sarebbero arrivati quando fosse giunto un nuovo carico di stoffe da Londra e Parigi. Il signor Drake stava ancora annotando gli ordini quando Adair posò un grosso rubino sul tavolo, davanti al sarto. Non fu scambiata una parola ma, dal sorriso che spuntò sul volto di Drake, era chiaro che la ricompensa gli andava più che bene. Quello che non sapeva era che il gioiello era soltanto una bagatella, presa da una scatola che ne conteneva moltissime altre, una scatola fra tante. Adair aveva tesori che risalivano al sacco di Vienna. Una gemma di quelle dimensioni era come un fiorellino di campo per Adair. «Voglio anche un cappotto per il mio amico, e che sia ben foderato di raso pesante» aggiunse Adair, facendo girare il rubino sul tavolo come una trottola. Il rubino aveva attirato lo sguardo di tutti i presenti e, per una frazione di secondo, fui soltanto io a vedere lo sguardo di approvazione che Adair rivolse a Jonathan, dal collo alla schiena, ai glutei sodi. Era uno sguardo così apertamente voglioso, così carico di desiderio che il mio cuore si raggelò di terrore al pensiero di quello che attendeva il mio Jonathan. Mentre il sarto rimetteva via la sua attrezzatura, giunse uno sconosciuto a far visita a Adair. Un gentiluomo dall’aria tetra, con due libri contabili e il necessario per scrivere – inchiostro, pennini – sotto il braccio. I due andarono immediatamente nello studio senza dire niente a nessuno. «Sai chi sia quell’uomo?» chiesi ad Alejandro guardando la porta dello studio chiudersi. «Un notaio. Adair ha assunto un notaio mentre tu eri via. Lo capisco: adesso che siamo in questa nazione, ci sono da risolvere faccende legali che riguardano le sue proprietà in Europa. Di tanto in tanto succede. È un fatto senza importanza» rispose, come se fosse la cosa più noiosa del mondo. Perciò in quel momento non ci badai. «È una stupidaggine» disse Jonathan quando Adair gli comunicò che stava arrivando un pittore per fare i bozzetti di un suo ritratto a olio. «Sarebbe un delitto non affidare all’eternità di una tela dei lineamenti come i tuoi» controbatté Adair. «Ci sono uomini molto più comuni che si sono fatti immortalare per i posteri, che hanno imbrattato i muri delle loro case con i loro brutti ceffi. E questa casa non fa eccezione» disse Adair, indicando le pareti coperte di ritratti, affittati insieme alla casa per avere un pedigree bell’e pronto. «E poi, la signora Warner mi ha parlato di questo pittore di talento e voglio vedere se si merita le lodi che gli stanno piovendo addosso da tutte le parti. E dovrebbe essere grato agli dei di poter avere un modello come te, te lo assicuro. Il tuo volto potrebbe segnare una svolta nella sua carriera.» «Non mi interessa proprio niente della sua carriera» ribatté Jonathan, ma sapeva che era una battaglia persa. Accettò di posare per il pittore, ma non fu per niente collaborativo: si accasciò su una sedia, la guancia appoggiata a una mano, un’espressione scocciata, come uno scolaretto costretto a rimanere in classe per punizione. Io stetti su una sedia accanto alla finestra per tutta la seduta, fissando Jonathan, rapita, vedendo la sua bellezza con occhi nuovi, quelli dell’artista che lo ritraeva in rapidi bozzetti a carboncino. Il pittore sembrava più che soddisfatto di aver avuto la fortuna di poter lavorare su un soggetto così rimarchevole e guadagnarci pure. Dona, che un tempo era stato la musa di un pittore famoso, rimase accanto a me tutto il pomeriggio, con la scusa di osservare la tecnica del pittore. Ma notai che guardava più Jonathan che i bozzetti. «Diventerà il prediletto, vero?» disse Dona a un certo punto. «Basta questa faccenda del ritratto per capirlo. Adair fa ritrarre soltanto i suoi favoriti. L’odalisca, per esempio.» «Ma cosa comporta essere il suo favorito?» Mi guardò in tralice. «Su, non fare l’ingenua con me. Anche tu per qualche tempo sei stata la favorita di Adair. E in un certo senso lo sei ancora. Perciò sai benissimo che ha un certo peso. Lui vuole le tue attenzioni a ogni momento. È molto esigente e si annoia in fretta, specialmente quando si tratta di sesso» disse Dona, inarcando le spalle come a dire che era ben contento di non essere più sotto pressione, di non dover essere lui a inventarsi sempre nuovi modi per portare Adair all’orgasmo. Lo osservai attentamente, studiando i suoi lineamenti mentre parlava. Anche lui era un bell’uomo, sebbene la sua bellezza fosse stata rovinata per sempre dall’infelicità che aveva dentro. Una malignità segreta gli velava lo sguardo e gli piegava la bocca in un ghigno. «Quindi Adair ha fatto fare ritratti soltanto di loro due?» chiesi, riprendendo la conversazione. «Soltanto di Uzra e ora di Jonathan?» «Oh, ce ne sono stati altri. Soltanto quelli di bellezza immensa. Ha lasciato i loro ritratti in un magazzino nel vecchio continente, volti d’angelo rinchiusi in una cripta. Sono quelli caduti in disgrazia. Forse un giorno li vedrai.» Inclinò la testa, osservando Jonathan con occhio critico. «I ritratti, intendo.» «I ritratti...» ripetei. «Ma i caduti? A loro che cosa è successo?» «Be’, alcuni se ne sono andati. Con la benedizione di Adair, naturalmente. Nessuno se ne può andare, altrimenti. Si sono dispersi come foglie al vento... Raramente ci capita di rivederli.» Fece una pausa. «Tu hai conosciuto Jude, però, ora che ci penso. La sua partenza non è stata certo una perdita. Che idea diabolica, quella di farsi credere un prete. Un peccatore nell’abito di un santo.» Dona rise, come se fosse la cosa più divertente che poteva immaginare: uno dei dannati mascherato da predicatore. «Hai detto che soltanto alcuni se ne sono andati. E gli altri? Qualcuno se n’è andato senza il permesso di Adair?» Dona mi rivolse un sorriso tirato e malevolo. «Non far finta di essere stupida. Se fosse possibile lasciare Adair senza il suo permesso, secondo te Uzra sarebbe ancora qui? Frequenti Adair da abbastanza tempo per sapere che non è né incauto né sentimentale. O te ne vai con la sua benedizione oppure, be’... Non lascerebbe mai in giro qualcuno che volesse vendicarsi di lui rivelando la sua esistenza alle persone sbagliate, non credi?» E queste furono le ultime parole che Dona era disposto a dire sul nostro misterioso padrone. Abbassò lo sguardo su di me e, pensando che fosse meglio non rivelare altro, uscì dalla stanza, lasciandomi a riflettere su tutto quello che mi aveva detto. Fu in quel momento che Jonathan si alzò di scatto dalla sedia, irritato. «Ne ho abbastanza di questa stupidaggine. Non ne posso più» disse, seguendo Dona fuori dalla stanza. Il pittore, deluso, vide la sua fortuna uscire dalla porta con lui. Alla fine, non ci fu alcun ritratto di Jonathan. Adair fu costretto ad accontentarsi di uno schizzo a carboncino che fece incorniciare sotto vetro e appendere nello studio. Quello che Adair non sapeva era che Jonathan sarebbe stato l’ultimo dei suoi favoriti a essere immortalato in un ritratto. Perché tutti i suoi piani, tutte le sue intenzioni, erano sul punto di essere sovvertiti per sempre. 41 Dopo il successo della prima notte, Adair cominciò a portare Jonathan con sé ovunque. Oltre alle solite serate di gala, iniziò a trovare occasioni per loro due soltanto, lasciando noi altri abbandonati a noi stessi. Adair e Jonathan andavano alle corse di cavalli in campagna, a cene e dibattiti nei club per gentiluomini, a lezioni alla Harvard. Venni a sapere che Adair portava Jonathan nei bordelli più esclusivi della città, dove pagava sei o sette ragazze che si prendessero cura di entrambi. L’orgia sembrava una sorta di rituale inteso a rafforzare il legame fra loro due, come un patto di sangue. Adair faceva conoscere a Jonathan tutte le cose che apprezzava della vita: impilava romanzi sul comodino di Jonathan (gli stessi che aveva fatto leggere a me quando mi aveva preso sotto la sua ala), faceva preparare dei manicaretti apposta per lui. Si parlò perfino di tornare nel vecchio continente, così che Jonathan potesse visitarne le grandi città. Era come se Adair avesse deciso di creare una storia che i due potessero condividere. Avrebbe fatto vivere a Jonathan la sua stessa vita. Era uno spettacolo agghiacciante, ma riusciva a distrarre Jonathan. Non mi aveva più parlato dei suoi timori per la sua famiglia e per le sorti del villaggio da quando eravamo partiti, anche se ero sicura che ci pensasse di tanto in tanto. Forse non ne parlava per riguardo nei miei confronti, dato che non c’era niente che potessimo fare per cambiare la situazione. Fu dopo qualche tempo che le cose andavano avanti così, con i due uomini che passavano quasi tutto il tempo in compagnia esclusiva, che Adair mi prese da parte. Gli altri oziavano nel solarium, insegnando a Jonathan a giocare a faraone, mentre io e Adair li guardavamo dal divano, come due genitori che osservano i loro figli giocare in armonia. «Adesso che ho potuto frequentare il tuo Jonathan, mi sono fatto un’opinione su di lui... Vuoi sapere che cosa ne penso?» mi disse Adair a voce bassa per non farsi sentire. Mentre parlava, il suo sguardo non abbandonò mai Jonathan. «Non è l’uomo che credi che sia.» «E tu che cosa ne sai di cosa penso di lui?» Cercai di sembrare sicura di me ma non riuscii a trattenere un tremito nella voce. «So che sei convinta che un giorno capirà e si darà anima e corpo soltanto a te» disse con sarcasmo, come a dire che gli importava ben poco quello che pensavo. Dimenticare tutte le altre... Già una volta Jonathan aveva fatto questo voto a una donna, e non era servito a molto. Probabilmente era rimasto fedele a Evangeline per un mese al massimo dopo averla sposata. Atteggiai la bocca a un sorriso disinvolto. Non volevo dare a Adair la soddisfazione di fargli capire che mi aveva ferita. Adair si sistemò meglio sul divano, accavallando le gambe. «Non dovresti prendertela così a cuore per la sua natura incostante. Non è capace di un simile amore, per nessuna donna al mondo. Non è capace di nessuna emozione che prevalga sulla sua percezione di sé, su ciò che vuole e che desidera. Per esempio, mi ha detto di essere dispiaciuto di provocarti tanta infelicità...» Mi conficcai le unghie nel dorso della mano, ma non ne seguì alcun dolore che potesse distrarmi. «... ma non sa cosa farci. Per qualsiasi uomo la soluzione sarebbe ovvia: o darti quello che vuoi oppure rompere ogni rapporto con te. Ma lui ha ancora bisogno della tua compagnia, perciò non riesce a staccarsi da te.» Sospirò con fare teatrale. «Ma non disperare. Non hai perso tutte le speranze. Forse arriverà il giorno in cui sarà capace di amare una sola persona e c’è una possibilità, per quanto tenue, che quella persona sia tu.» E poi rise. Quanto avrei voluto schiaffeggiarlo. Gettarmi su di lui, stringergli le mani attorno al collo e soffocarlo. «Sei furiosa con me, lo sento.» Perfino la mia rabbia impotente sembrava divertirlo. «Sei arrabbiata perché sai che ti ho detto la verità.» «Sono furiosa con te» risposi, «perché mi stai mentendo. Stai cercando di fare a pezzi i miei sentimenti per Jonathan.» «Sono riuscito a sconvolgerti, però, no? Certo, ammetto che di solito riesci a capire quando sto mentendo – e sei l’unica ad avere questa capacità, a quanto pare, mia cara – ma stavolta non ti ho detto alcuna menzogna. Quanto vorrei aver mentito. Almeno non saresti così ferita, giusto?» Era troppo. Non potevo sopportare che mi mostrasse pietà nel momento stesso in cui cercava di mettermi contro Jonathan. Guardai Jonathan giocare a faraone, assorto nella partita. Avevo iniziato a pensare alla presenza di Jonathan come a un grande conforto, come un mormorio quieto che risuonava dentro la mia anima. Di recente, però, avevo notato una corrente sotterranea di malinconia provenire da Jonathan. Credevo fosse tristezza, per aver dovuto abbandonare Evangeline e sua figlia. Ma se ciò che aveva detto Adair era vero, forse la malinconia era dovuta al fatto che sapeva di rendermi infelice. Per la prima volta, mi chiesi se a ostacolare il nostro amore, a essere tarato, fosse lui e non io. Mi sembrava disumano essere incapace di darsi pienamente a una sola persona. Un trillo di risata femminile interruppe i miei pensieri. Tilde gettò le carte sul tavolo, vittoriosa. Jonathan le lanciò uno sguardo e da quello sguardo capii che era stato a letto con lei. Era andato a letto con Tilde anche se non la trovava particolarmente attraente, anche se sapeva di dover stare attento a lei, anche se sapeva che se l’avessi scoperto mi avrebbe spezzato il cuore. La disperazione mi assalì, come un pezzo di carta avvicinato alla fiamma. C’erano cose che non potevo cambiare. «Che spreco.» Adair si avvicinò istantaneamente al mio orecchio, come il serpente nel giardino dell’Eden. «Tu, Lanore, sei capace di provare un amore perfetto, un amore come io non ne ho mai visti. Eppure, scegli di sprecarlo per qualcuno di così immeritevole come Jonathan...» Il suo sussurro era come un profumo in una notte cristallina. «Che cosa intendi dire? Che tu saresti un uomo ben più meritevole del mio amore?» gli chiesi, cercando la risposta nei suoi occhi ferini. «Quanto vorrei che tu potessi amarmi, Lanore. Ma se soltanto tu mi conoscessi veramente, capiresti quanto anch’io non sia degno del tuo amore. Ma un giorno, forse, mi vedrai come ora vedi Jonathan, con lo stesso favore. Sembra impossibile, vista la tua devozione assoluta per lui, ma chi può mai dirlo? Ho visto l’impossibile accadere, di quando in quando nella mia lunga vita» rispose astutamente, ma quando provai a chiedergli di spiegarsi meglio, si limitò ad arricciare il naso e a ridere. Poi si alzò dal divano e chiese di partecipare alla prossima partita di faraone. Abbandonata a me stessa, me ne andai nello studio per cercare un libro con cui distrarmi. Mentre passavo accanto alla scrivania di Adair, la luce della mia candela illuminò un fascio di fogli lasciati sul tampone di carta assorbente e, come se fosse stato il destino a volerlo, l’occhio mi cadde sul nome di Jonathan, scritto con la calligrafia di Adair. Ma perché mai Adair aveva scritto qualcosa su Jonathan? Era una lettera a un amico? No, dubitavo che avesse un amico al mondo. Presi i fogli e li avvicinai alla luce della candela. Istruzioni per Pinnerly (avevo appreso che era il nome del notaio). Apertura di un conto a nome di Jacob Moore (era il nome falso di Jonathan) presso la Bank of England per la somma di ottomila sterline (era una fortuna) da trasferirsi dal conto di (seguiva un nome che non riconobbi). Le istruzioni proseguivano, dando ordine di aprire diversi altri conti sotto il nome falso di Jonathan ad Amsterdam, Parigi e San Pietroburgo. Le rilessi due volte, ma non riuscii comunque a capirne il senso, perciò le riappoggiai sul tavolo, esattamente come le avevo trovate. A quanto sembrava, Adair era così preso da Jonathan che si stava organizzando per garantirgli una vita agiata. Era come se lo stesse adottando. Ammetto di aver provato una punta di gelosia e di essermi chiesta se avesse stabilito un fondo anche per me, da qualche parte. Ma che senso avrebbe avuto, visto che Adair non me ne aveva mai parlato? Ogni volta dovevo lusingarlo e implorarlo di darmi dei soldi da spendere, e lo stesso facevano gli altri. Mi parve un ulteriore segno del fatto che Adair nutriva un interesse del tutto speciale per Jonathan. Jonathan sembrava accettare la sua nuova vita. Quanto meno, non si oppose a condividere i vizi e le libertà di Adair, e non parlò più di St. Andrew. C’era solo un vizio che Adair non aveva compartito col suo nuovo favorito, uno che Jonathan avrebbe sicuramente accolto se gli fosse stato offerto. Quel vizio era Uzra. Jonathan viveva da noi da tre settimane quando gli fu presentata. Adair chiese a Jonathan di attenderlo nel salotto – con me ingelosita al suo fianco – e poi fece entrare Uzra con un gesto tronfio. L’odalisca era agghindata nel consueto fascio di seta avvolgente. Quando le lasciò la mano, la stoffa cadde al suolo, rivelando Uzra in tutta la sua bellezza. Adair la fece perfino danzare davanti a Jonathan e lei ondeggiò i fianchi e intrecciò le braccia mentre Adair cantava un motivetto improvvisato. In seguito, fece portare il narghilé e ci sdraiammo sui cuscini del pavimento, facendo a turno a succhiare il bocchino di avorio intagliato. «È adorabile, vero? Così adorabile che non riesco a separarmene. Non che lei non mi abbia causato problemi: è un demonio. Si butta dalle finestre o giù dai tetti. Non le importa di farmi impazzire ogni volta. È ancora piena di odio verso di me.» Le accarezzò il naso con la punta dell’indice, nonostante lei avesse l’aria di volergli staccare a morsi quel dito appena ne avesse avuto l’opportunità. «Credo sia stato proprio questo a tener desto il mio interesse in tutti questi anni. Lasciate che vi racconti come Uzra si è unita a me.» Sentendo menzionare il proprio nome, Uzra diventò improvvisamente tesa come una corda di violino. «Ho incontrato Uzra durante un viaggio nei paesi arabi» prese a raccontare Adair, incurante del disagio evidente di Uzra. «Ero in compagnia di un nobile che stava negoziando la liberazione del fratello, il quale aveva stupidamente cercato di rubare il tesoro di uno dei capi. A quel tempo mi ero ormai costruito una buona reputazione di guerriero mercenario. Avevo cinquant’anni di esperienza con la spada, e non erano certo pochi. Fatto sta che quel nobile mi aveva assoldato per aiutarlo, e la paga era sontuosa. Fu così che capitai in quei luoghi e conobbi, per puro caso, Uzra. «Accadde nel mercato di una grande città; lei seguiva passo passo suo padre, vestita come comandavano le tradizioni. Non riuscivo a vederle altro che gli occhi, ma fu abbastanza: capii di dover vedere di più. Perciò li seguii al loro accampamento ai margini della città. Parlando con alcuni uomini che si occupavano dei cammelli, appresi che il padre era il capo di una tribù di nomadi e che la famiglia era giunta in città per darla in sposa a un sultano, un principe fannullone, perché in cambio fosse risparmiata la vita del padre.» La povera Uzra a quel punto era completamente immobile. Aveva perfino smesso di fumare il narghilé. Adair si avvolse un ricciolo dei suoi capelli attorno a un dito e tirò leggermente, come per rimproverarla per la sua indifferenza, poi lo lasciò cadere. «Individuai la sua tenda e vidi che c’erano una decina di schiave che si prendevano cura di lei. Le avevano formato un cerchio attorno e, credendo che fosse protetta dagli sguardi indiscreti, la aiutarono a togliersi le vesti, sfilandole il tessuto dalla pelle color cannella, poi le sciolsero i capelli. Le loro mani le percorrevano tutto il corpo come farfalle... quando irruppi nella tenda scoppiò il caos» disse Adair con una fiera risata. «Le donne urlarono e scapparono, inciampando e cadendo una sull’altra nel tentativo di proteggersi da me. Come potevano pensare che io mi sarei accontentato di una di loro quando davanti a me c’era quell’incantevole jinn tutta nuda? E Uzra aveva capito che ero lì per lei, a giudicare dal suo sguardo. Ebbe appena il tempo di coprirsi con una veste prima che mi avventassi su di lei e la portassi via. «La condussi nel deserto, dove ero certo che nessuno ci avrebbe trovato. Quella notte la presi più volte, senza curarmi delle sue urla» disse, come se non ci fosse niente di cui vergognarsi, come se lei gli spettasse di diritto con la stessa naturalezza con cui l’acqua serviva a dissetarlo. «Solo al sorgere del sole la mia passione iniziò a scemare e mi ritenni sazio della sua bellezza. Tra un momento di piacere e l’altro, le domandai perché la volessero dare al sultano. Era per via di una superstizione della sua tribù, mi disse, secondo la quale una jinn dagli occhi verdi avrebbe portato pestilenze e sofferenze alla sua gente. Erano dei vigliacchi idioti e si erano rivolti al sultano. Il quale ordinò al padre di consegnargliela o di perire egli stesso. Capite? Per impedire che la maledizione si avverasse, doveva morire. «Avevo capito di non essere il primo uomo con cui era giaciuta, così le chiesi chi le avesse preso la verginità. Un fratello? Un parente maschio, senza dubbio: chi altri sarebbe stato in grado di avvicinarsi a lei? Scoprii che era stato proprio suo padre. Riuscite a crederci?» domandò, incredulo, come se fosse la cosa più assurda che aveva sentito. «Era il capo, un patriarca abituato ad avere tutto ciò che desiderava. Ma quando Uzra aveva ormai cinque anni, aveva capito, dal colore della pelle, che lei non era sua figlia naturale. La madre gli era stata infedele e, a giudicare dal colore verde degli occhi, era andata a letto con uno straniero. Lui non disse niente, si limitò ad andare un giorno nel deserto con la madre di Uzra e tornare da solo. Quando Uzra ebbe dodici anni, prese il posto della madre nel letto del padre. Lui le aveva detto che era la figlia di una puttana e non era sangue del suo sangue, perciò non era proibito. Ma lei non doveva dirlo a nessuno. I servitori credevano che fossero ammirevoli la tenerezza e l’affetto di una figlia che non poteva stare senza il suo papà, nemmeno la notte. «Le dissi che niente di tutto questo importava. Non avevo intenzione di consegnarla nelle mani di quel sultano rozzo e ignorante. Né l’avrei rimandata dal padre così che lui potesse ricominciare ad abusare di lei fino al momento di consegnarla, da codardo qual era.» Mentre Adair proseguiva nel racconto, ero riuscita a trovare la mano di Uzra e gliel’avevo stretta, di tanto in tanto, per farle capire che soffrivo con lei, ma nei suoi occhi verdi e vitrei vidi che la sua mente si era allontanata da quella crudeltà. Anche Jonathan sembrava imbarazzato per lei. Ma Adair proseguì, incurante del fatto che soltanto lui trovava divertente quel racconto. «Decisi di salvarle la vita. Proprio come avevo fatto con gli altri. Le dissi che la sua lunga tortura era giunta al termine. Avrebbe iniziato una nuova vita con me e sarebbe rimasta con me per sempre.» Quando l’oppio iniziò a fare effetto su Adair e lui si addormentò, io e Jonathan sgusciammo via silenziosamente. Mi prese per mano e mi condusse fuori da quella stanza. «Santo Dio, Lanny, che cosa dovrei pensare di questa storia? Ti prego, dimmi che voleva soltanto intrattenerci, che stava esagerando...» «È strano... Ha detto che le ha salvato la vita, ’proprio come con gli altri’. Ma lei non è come gli altri, a giudicare dalla storia che ci ha appena raccontato.» «In che senso?» «Mi ha raccontato un po’ di come gli altri sono finiti con lui. Alejandro, Tilde e Dona. Avevano fatto cose orribili prima che Adair li incontrasse.» Entrammo nella camera di Jonathan, che era accanto a quella di Adair ma più piccola, pur avendo un guardaroba molto ampio e una vista sul giardino. E una porta comunicante con quella di Adair. «Credo che sia per questo che li ha scelti, perché erano capaci di commettere le atrocità che lui richiede. Credo che sia questo che cerca nei suoi compagni: una tara, una sorta di difetto.» Ci togliemmo parte dei vestiti per stare più comodi e poi andammo a letto, sdraiandoci fianco a fianco. Jonathan mi cinse un braccio attorno alla vita con fare protettivo. L’oppio stava avendo il suo effetto anche su di noi e io ero sul punto di addormentarmi. «Ma non ha senso... Perché allora ha scelto te?» mi chiese Jonathan con voce assonnata. «Tu non hai mai fatto del male a nessuno in tutta la tua vita.» Se c’era un momento in cui parlargli di Sophia e di come l’avevo spinta al suicidio, era quello. Arrivai perfino al punto di inspirare per prepararmi a parlare, ma... Ancora una volta, non ci riuscii. Jonathan mi credeva innocente, al punto di dubitare dei motivi della mia presenza in quel luogo. Mi credeva incapace di fare il male, e non potevo rovinare tutto. E, cosa ancor più significativa, non si era chiesto perché lui fosse stato scelto, che cosa ci vedesse Adair in lui. Jonathan conosceva se stesso abbastanza bene da credere che in lui albergasse il male, che ci fosse qualcosa dentro di lui che andava punito. E forse lo sapevo anch’io. Eravamo entrambi tarati, a nostro modo, ed eravamo stati scelti per ricevere una punizione che meritavamo. «C’è una cosa che devo dirti» mormorò Jonathan, assonnato, con gli occhi già chiusi. «Presto andrò in viaggio con Adair. Mi ha detto di volermi portare a... Non mi ricordo dove, esattamente, forse a Philadelphia. Anche se, dopo il suo racconto di stasera, devo confessare di non essere entusiasta di partire da solo con lui...» Mentre mi stringevo addosso il suo braccio, notai sotto la stoffa leggera della sua camicia un segno sulla sua pelle. C’era qualcosa di orrendamente familiare in quelle macchie nere velate dalla sua manica, perciò la arrotolai scoprendo così le sottili linee nere incise all’interno del suo tricipite. «Questo dove te lo sei fatto?» gli chiesi, rialzandomi a sedere di scatto, preoccupata. «È stata Tilde, vero? L’ha fatto lei con i suoi aghi?» Jonathan riuscì a malapena ad aprire gli occhi. «Sì, sì... l’altra sera, quando siamo usciti a bere...» Osservai il tatuaggio da vicino; non era lo stemma araldico; erano due sfere, con code lunghe e tese, sovrapposte come due dita intrecciate. Era diverso da quello che avevo io, ma avevo già visto quello stesso tatuaggio. Sulla schiena di Adair. «È lo stesso di Adair» riuscii a dire. «Sì, lo so... ha insistito perché me lo facessi. A indicare che siamo fratelli, o qualcosa di altrettanto stupido. Ho accettato soltanto per farlo stare zitto.» Sfiorando il tatuaggio con il pollice, avvertii una lama di gelo attraversarmi. Il fatto che Adair avesse messo il suo stesso marchio su Jonathan doveva avere un significato, ma non riuscivo a capire quale potesse essere. Volevo implorarlo di non partire con Adair, di disobbedirgli... Ma conoscevo le inevitabili conseguenze di una follia simile. Perciò non dissi niente, rimasi sveglia a lungo ad ascoltare il ritmo stabile e sereno del respiro di Jonathan, senza riuscire a scrollarmi di dosso quel presentimento. Il presentimento che il nostro tempo insieme fosse prossimo alla fine. 42 Québec, oggi Luke si sveglia circondato dal debole suono delle miserie umane. È disorientato, come sempre quando si sveglia dopo un breve riposo. Il suo primo pensiero è che ha dormito troppo e che farà tardi all’ospedale. È solo quando sta per tirare un pugno alla sveglia – benché non stia suonando – e scagliarla giù dal comodino che si ricorda di trovarsi in un hotel. E che c’è una sola persona con lui. E quella persona sta piangendo. La porta del bagno è chiusa. Luke bussa gentilmente e, quando non giunge alcuna risposta, apre la porta. Lanny è seduta nella vasca, completamente vestita. Quando alza lo sguardo su di lui, Luke vede che il trucco le è colato sul volto in striature nere e appuntite come spade, come un clown in un film dell’orrore. «Ehi, che cos’hai?» le chiede, prendendole la mano. «Che cosa ci fai qui dentro?» Lei si lascia sollevare fuori dalla vasca. «Non volevo svegliarti.» «Ma è per questo che sono qui.» La riporta a letto e lei si accoccola fra le sue braccia, come una bambina piccola. «Mi dispiace... È che inizio soltanto ora a... a rendermi conto che...» dice lei, le parole rauche interrotte dai singhiozzi. Luke finisce la frase per lei: «Che lui non c’è più». Lei riprende a piangere. Fino a quel momento Lanny si è concentrata sulla fuga, sull’evitare di essere scoperti. Ora che la fase della fuga è terminata, l’adrenalina sta scemando e il ricordo di ciò che l’ha condotta fino a lì ritorna con prepotenza. Ora è costretta ad affrontare la realtà: la persona più importante della sua vita non c’è più. È l’uomo che ama e non lo vedrà mai più. Luke ripensa alle tante volte che, in ospedale, ha incrociato qualcuno che piangeva, qualcuno che aveva appena ricevuto la notizia della morte di una persona cara. Una donna con il volto fra le mani, un uomo, accanto a lei, immobile, paralizzato dal dolore. Luke non saprebbe contare le volte che gli è capitato di uscire dalla sala operatoria, sfilandosi i guanti e la mascherina, scuotendo il capo. Di avvicinarsi ai parenti in attesa, il volto colmo di speranza di ricevere buone notizie. Ha imparato a erigere un muro, per difendersi dal dolore dei parenti. Non ci si può lasciar trascinare dalla loro sofferenza. Si può annuire, riconoscere il loro dolore, ma soltanto per un momento. Chi cerca di farsi carico del loro peso non dura più di un anno in ospedale. Ma quella ragazza singhiozzante fra le sue braccia... Il suo è un dolore senza fine. La sofferenza di cui è intriso il suo pianto potrebbe spezzare il mondo in due. Cadrà nell’abisso della disperazione e continuerà a cadere a lungo, senza niente cui aggrapparsi. Lui immagina che esista una formula per calcolare quanto tempo impieghi la sofferenza a passare, e ritiene che dipenda tutto dal tempo trascorso insieme alla persona amata. Ha visto vedove, dopo cinquant’anni di matrimonio, avviarsi con un sorriso alla morte perché convinte che si sarebbero così riunite al loro amato. Ma non c’è sollievo per Lanny. Quanto tempo impiegherà Lanny a sopportare giorno dopo giorno l’assenza di Jonathan? Quanto tempo per accettare di essere stata proprio lei a ucciderlo? Ci sono persone al mondo che sono impazzite per molto meno, che sono state annichilite dalla depressione. Non c’è alcuna garanzia che lei riesca a sopravvivere a qualcosa come quello che è successo. Ma lui la aiuterà. Deve farlo. Ritiene di essere l’unico a poterlo fare. Con la sua esperienza («Signora Parker? Abbiamo fatto tutto quello che potevamo per suo figlio, ma purtroppo...») è convinto che la sofferenza di Lanny gli scivolerà addosso come gocce d’acqua su un impermeabile. Lei a poco a poco sta smettendo di piangere. Si strofina gli occhi col dorso delle mani. «Va meglio?» le chiede Luke, sollevandole il mento con un dito. «Vuoi che usciamo a prendere un po’ d’aria?» Lei annuisce. Un quarto d’ora dopo sono fuori, a camminare mano nella mano. Lanny si aggrappa al braccio di Luke proprio come fanno gli innamorati, ma sul suo volto, ora ripulito dalle sbavature di trucco, c’è un sorriso triste e disperato. «Beviamo qualcosa?» le chiede. Entrano in un bar molto elegante e lui ordina scotch liscio per entrambi. «Guarda che non puoi sperare di vincere una gara di bevute con me» lo ammonisce lei con una risata mesta. Brindano come se avessero qualcosa da festeggiare. E proprio come lei aveva detto, a Luke basta un bicchiere per iniziare ad avvertire il calore torpido dell’ubriachezza, mentre lei ne ha già bevuti tre e l’unico segno è il sorriso un po’ più rilassato. «C’è una cosa che vorrei chiederti. Su di... su di lui» dice Luke, come se evitando di pronunciare il nome di Jonathan potesse risparmiarle un po’ di sofferenza. «Dopo tutto quello che ti ha fatto passare, come hai potuto continuare ad amarlo così? Non mi pare che ti meritasse...» Lei solleva il bicchiere vuoto prendendolo per l’orlo, come se fosse un pezzo degli scacchi. «Potrei trovare un sacco di spiegazioni: per esempio, potrei dirti che all’epoca le cose funzionavano così, che ogni moglie sapeva che il marito prima o poi l’avrebbe tradita. O che Jonathan era semplicemente fatto così, e non avevo altra scelta che accettarlo. Ma non è la vera ragione.» Fece una pausa. «Non so come spiegartelo. Ho sempre desiderato che lui mi amasse come io amavo lui. Oh, mi amava, questo lo so. Ma non nel modo in cui volevo io. «E non è poi così diverso da tante altre persone che ho conosciuto nel tempo. Uomini, o donne, che non amano abbastanza il proprio compagno da smettere di bere, o di perdere soldi al gioco, o di tradirlo con altre persone. È sempre così: c’è uno che dà e uno che prende, in una coppia. Quello che dà vorrebbe che l’altro cambiasse.» «Ma chi è nato per prendere non cambia mai» dice Luke, pur chiedendosi se sia sempre vero che le cose stanno così. «A volte, quello che dà dovrebbe imparare a lasciar perdere. Ma non sempre ci si riesce. Non ci si riesce proprio. Io non sono riuscita a lasciar perdere Jonathan. Trovavo sempre un modo di perdonargli tutto.» Luke vede che le stanno tornando le lacrime agli occhi e prova a cambiare argomento. «E Adair? Da quello che mi hai raccontato, lui si era innamorato di te...» «Il suo amore era come l’amore che il fuoco nutre per il legno.» Fa una risata amara. «Per un po’ mi ha tratta in inganno, devo ammetterlo. Un istante era gentile con me e l’istante dopo mi umiliava. Era tutto un gioco, una prova. Credo che... penso che volesse soltanto scoprire se poteva costringermi ad amarlo. Perché credo che nessuno l’abbia mai amato.» Lei si ferma, le mani strette in grembo, e gli occhi tornano a riempirsi di lacrime. «Guarda cos’hai fatto... Adesso mi viene di nuovo da piangere. Non voglio piangere in pubblico. Non voglio imbarazzarti. Torniamo in camera, a fumare un po’ di marijuana.» Il volto di Luke si illumina al ricordo della qualità straordinaria di quell’erba che lei ha con sé. «Sono pronto a fumarmi tutto il sacchettino con te, se è quello che ci vuole per tirarti su il morale» le dice. «Oh, mio eroe» risponde Lanny, prendendolo sottobraccio. Barcollano per strada fino all’hotel, col vento gelido che li sferza in volto. Luke vorrebbe poter somministrare a Lanny una dose di morfina per farla sentire meglio. Se potesse farlo, sarebbe disposto anche a farle un’iniezione di tranquillante al giorno pur di farle trovare un po’ di pace. Scuote la testa per schiarirsi le idee. Sente che farebbe qualsiasi cosa per renderla di nuovo felice, ma non vuole diventare schiavo della sua infelicità. A letto, lei posa le labbra salate sulle sue. «Mi sono fatta migliaia di volte quella domanda, sai? Perché? Perché Jonathan non mi amava?» dice in un sussurro esausto ed ebbro. «Che cos’ho di sbagliato? Dimmelo tu... È così impossibile amarmi?» Luke è colto di sorpresa. «Non saprei dirti perché Jonathan non ricambiava il tuo amore. Ma, per quello che vale, posso dirti che secondo me ha fatto un grosso sbaglio.» Jonathan era un idiota. Soltanto uno stupido avrebbe sprecato una tale devozione. Lei lo guarda scettica, ma sorride comunque. E poi si addormenta di colpo. Lui la stringe a sé, avvolgendo le braccia attorno al suo corpo morbido e invitante, accarezzandole le braccia e le gambe, così eleganti e affusolate. Non ricorda di essersi mai sentito così, tranne forse quel giorno in pizzeria con le sue figlie, quando avrebbe tanto voluto poterle mettere sulla macchina a noleggio e riportarsele in Maine. Sa di aver fatto la scelta giusta, sa che è stato corretto non cedere alla tristezza in quel momento – le ragazze stanno meglio con la madre – ma il ricordo di quando ha preso la macchina e se n’è andato, lasciandole, lo tormenterà per sempre. Solo uno stupido può sprecare un amore come quello. E poi, Lanny. Farebbe qualsiasi cosa per proteggere quella fragile donna, per guarirla. Vorrebbe poterle succhiare via il veleno, come una sanguisuga. Vorrebbe prenderlo lui, se potesse, quel veleno. Ma sa che non può far altro che stare con lei. 43 Boston, 1819 Una sera, mi svegliò una lama di luce polverosa che mi colpì le palpebre. Uzra comparve accanto al mio letto, con una piccola lampada a olio che ondeggiava appesa alla sua mano. Doveva essere notte fonda, perché la casa di Adair era silenziosa come una cripta. Il suo sguardo mi implorava di alzarmi, perciò lo feci. Lei scivolò fuori dalla stanza nel suo solito modo silenzioso, costringendomi a seguirla a tentoni. Indossavo delle pantofole e camminavo su folti tappeti, pertanto il rumore dei miei passi era poco più che un sospiro. Ma in quella casa silenziosa, anche i sospiri riecheggiavano lungo i corridoi. Uzra schermò la lampada mentre oltrepassavamo le altre camere, per fare meno luce possibile, e riuscimmo a raggiungere le scale che conducevano in soffitta senza farci scoprire. La soffitta era divisa in due parti. Una era riservata agli alloggi dei servitori e un’altra, più piccola, veniva utilizzata come magazzino. Era lì che Uzra si nascondeva. Mi condusse attraverso un labirinto di bauli che solitamente le facevano da barriera, proteggendola dal mondo esterno, e poi lungo un corridoio stretto e soffocante che terminava in una minuscola porta. Fummo costrette a chinarci e contorcerci per riuscire a passare da quella porta, per poi sbucare in quello che sembrava il ventre di una balena: travetti in legno al posto delle costole, un camino di mattoni al posto di una trachea. La luce della luna filtrava da finestre prive di tende che davano sul sentiero che portava alla rimessa delle carrozze. Lei aveva scelto di abitare in un posto così cupo pur di stare alla larga da Adair. Era un posto orrendo in cui vivere, caldo d’estate e gelido d’inverno, solitario come un deserto lunare. Vidi quello che immaginai fosse il suo nido, circondato da tendine di organza iridescente, ricavate dai sarong che indossava, appese ai travetti come biancheria stesa ad asciugare. Il letto stesso era costituito da due coperte prese dal salotto e intrecciate a formare un cerchio, non molto diverso dalle tane degli animali selvatici, approssimativo e raffazzonato. Un mucchio di ninnoli era impilato accanto al letto, con diversi gioielli: diamanti grossi come chicchi d’uva, una retina di fili d’oro da indossare con il chador. Ma c’era anche del bric-à-brac, cose che un bambino avrebbe potuto collezionare: una spada corta, lucente ed elegante, un ricordo della sua terra, con una lama che sembrava un serpente in movimento. Uno specchio in bronzo. Mi fece cenno di seguirla e io smisi di fissare il suo misero tugurio, la prova della sua resistenza a Adair. Mi condusse a un muro cieco. Io non ci vedevo niente, ma lei si inginocchiò e rimosse un paio di assi, rivelando uno spazio in cui poter strisciare. Prendendo la lampada a olio, si gettò senza paura in quello spazio oscuro come un ratto abituato a insinuarsi nelle pareti. Io trassi un profondo respiro e la seguii. Dopo aver strisciato sulle mani e sulle ginocchia per circa sei, sette metri, sbucammo in una stanza priva di finestre. Uzra alzò la lampada così che io potessi vedere dove ci trovavamo: era uno spazio angusto e arredato, con un piccolo camino e una porta; faceva parte degli alloggi della servitù. Mi avvicinai e cercai di aprirla, ma qualcosa da fuori la bloccava. La stanza era dominata da un ampio tavolo coperto di bottiglie e barattoli e una varietà di chincaglieria. C’era una madia, anch’essa piena di contenitori di tutte le forme e grandezze, per lo più tappati da stoffa incerata o da tappi di sughero. Sotto il tavolo c’erano ceste piene delle cose più diverse, da pigne a rami secchi fino a misteriosi organi di animali essiccati. Libri antichi e fragili giacevano infilati fra i barattoli. Ai bordi del tavolo c’erano delle candele su piattini d’argento. Inalai profondamente: la stanza era piena di una miriade di odori e profumi, di spezie e di foresta e di polvere e altri odori che non riuscii a identificare. Rimasi al centro e mi guardai intorno, lentamente. Credo di aver capito immediatamente che cosa fosse quella stanza e a cosa servisse, ma non volevo ammetterlo. Presi uno dei libri dallo scaffale. La copertina era di stoffa blu con incise delle scritte a mano e vari simboli intrecciati fra loro. Voltando con cautela le pagine, vidi che nessuna era stampata: erano tutte scritte a mano, con estrema cura, con annotazioni di formule e strane illustrazioni – per esempio, la parte di una pianta da conservare o un’elaborata scena di dissezione del corpo umano – ma era scritto tutto in una lingua che non conoscevo. I disegni erano più esplicativi e riconobbi alcuni dei simboli che avevo visto da giovane e altri che avevo già notato nei volumi della libreria di Adair: pentagrammi, l’occhio della provvidenza, cose simili. Quel libro era un’opera rimarchevole, parlava di anni trascorsi nascondendosi, di segreti e di intrighi, era un libro di quelli che gli uomini comuni passano vite intere a cercare. Ma i suoi contenuti mi erano incomprensibili. C’era un altro libro ancora più vecchio, con una copertina di legno, rilegato con un nastro di pelle. All’interno, le pagine erano libere, non cucite insieme, e dalla varietà di carte impiegate sembrava che il libro fosse una sorta di collezione di appunti piuttosto che un volume unico. La calligrafia sembrava quella di Adair, ma ancora una volta era in una lingua che non conoscevo. Uzra si spostò, inquieta, facendo risuonare le campanelline appese ai suoi fianchi. Non le piaceva stare lì dentro e potevo capirla benissimo. Adair l’aveva chiusa dall’esterno per una precisa ragione: non voleva che qualcuno ci capitasse, anche solo per caso. Ma quando sporsi la mano per rimettere a posto il secondo volume, Uzra si avvicinò e mi afferrò il polso. Alzò la lanterna e la avvicinò al mio braccio e quando vide il tatuaggio – di cui mi ero quasi dimenticata, ormai – si lasciò sfuggire un lamento, come quello di un gatto morente. Alzò il suo braccio e me lo mise davanti agli occhi, col palmo della mano rivolto in su. Aveva lo stesso tatuaggio, nello stesso posto, anche se il suo era un po’ più grande ed eseguito con meno accuratezza, come se la mano del tatuatore non fosse stata precisa come quella di Tilde. Il suo sguardo mi accusava, come se me lo fossi fatta io stessa, ma non c’era modo di fraintendere il suo messaggio. Adair aveva scelto di marchiarci allo stesso modo. Le sue intenzioni nei miei confronti, perciò, non potevano essere tanto diverse da quelle che aveva avuto per Uzra. Alla luce della lanterna, guardai quella stanza ancora una volta. Mi tornò alla mente una descrizione che avevo udito dalle labbra di Adair stesso, quella della stanza nel torrione del medico che era stata la prigione della sua gioventù. C’era soltanto un motivo per cui poteva aver bisogno di una stanza come quella, nascosta nell’angolo più sperduto della casa. D’improvviso capii che cos’era quel posto e perché esisteva, e fui attraversata da un violento brivido di terrore. La storia strappalacrime che Adair mi aveva raccontato, quella della sua cattura e della sottomissione al medico maligno mi tornò tutta in mente. Solo... Solo che a quel punto mi chiesi con quale dei due uomini avessi trascorso tutti quei mesi, chi fosse veramente l’uomo con cui ero andata a letto, quello che ora sembrava così interessato all’altro uomo della mia vita, che io amavo con tutta me stessa. Adair voleva che i suoi seguaci lo credessero un ragazzino zingaro che era riuscito a vendicarsi del suo oppressore, appropriandosi meritatamente delle ricchezze del suo crudele e disumano tiranno. Ma, in effetti, dietro quel volto angelico si nascondeva il mostro del racconto, l’uomo che aveva accumulato poteri oscuri e rovinato vite. Era capace di passare da un corpo all’altro. Non c’era altra spiegazione. Si era lasciato dietro il suo guscio decrepito, sacrificandolo alla furia di quel villaggio. Ma dentro quel corpo c’era il povero ragazzino zingaro. Come dovevano essere stati terrorizzanti i suoi ultimi minuti di vita, costretto a pagare il male fatto dal medico. Era una menzogna perfetta per servire ai suoi mostruosi scopi e sembrava aver funzionato per centinaia d’anni. Ma ora che sapevo la verità, che cosa avrei potuto fare? Avevo dei sospetti sull’inganno di Adair, dunque, ma avevo bisogno di prove: per convincermi io stessa dell’orribile verità, se non altro. Con Uzra che mi tirava per la manica, presi una pagina dal volume e una manciata di erbe da uno dei barattoli impolverati sul tavolo. Rischiavo tremende punizioni se il mio furto fosse stato scoperto – avevo sentito la storia dalle labbra di Adair stesso, no?, quella che finiva con un attizzatoio avvolto in una coperta e un pestaggio interminabile – ma dovevo sapere. Iniziai facendo visita a un professore della Harvard che avevo conosciuto durante una delle feste di Adair. E non a un tè del pomeriggio o in un salotto con intellettuali: no, era stata una festa di tutt’altro tipo. Scovai il suo studio a Wheydon Hall, ma era con uno studente. Quando mi vide aspettare in corridoio, mandò via lo studente e mi venne a prendere, con un sorriso affascinante sul suo volto da vecchio diavolo. Forse pensava che fossi andata lì per ricattarlo, dato che l’ultima volta che l’avevo visto stava montando un ragazzino più giovane dei suoi studenti cantando a squarciagola. O forse sperava che fossi lì per invitarlo a un’altra festa. «Mia cara, cosa vi conduce da queste parti oggi?» disse, dandomi qualche colpetto sulla mano mentre mi conduceva nel suo ufficio. «Sono così rare le visite che ricevo da parte di giovani donne così belle. E come sta il nostro comune amico, il conte? Confido che stia bene, vero?» «Come sempre» dissi, e mai risposta fu più vera. «E a cosa devo dunque la vostra gradita visita? Devo immaginare che presto ci sarà un’altra soirée...?» Il suo sguardo si illuminò di fiero desiderio, alimentato da tutti i pomeriggi trascorsi davanti a una marea di ragazzi tanto giovani quanto intoccabili. «A dire il vero, sono qui per chiedervi un favore» dissi, estraendo dalla borsetta la pagina che avevo rubato. Perfino la carta era diversa da qualsiasi altra avessi mai visto: spessa e ruvida, ingiallita come quella dei macellai, e ora che non aveva più il peso della copertina di legno a schiacciarla si arrotolava da sola. «Mmm» mormorò il professore, sorpreso. Prese il foglio dalle mie mani e l’avvicinò agli occhi, alzando gli occhiali sulla fronte per ispezionarlo. «E dove l’avete trovato, mia cara?» «L’ho trovato da un libraio» mentii. «Un libraio che sostiene di avere trovato una collezione di libri antichi, tutti riguardanti un argomento che so essere particolarmente caro a Adair. Pensavo di acquistarli per fargli un regalo, ma sono scritti in una lingua che non conosco. Ho bisogno dunque di verificare che il libro corrisponda a quanto sostiene il libraio. Non si è mai abbastanza prudenti, in questi casi.» «Certo, avete perfettamente ragione» borbottò continuando a esaminare la pagina. «Dunque, la carta non è certo di manifattura locale. Non è candeggiata. Probabilmente è stata fatta da qualcuno per farne uso proprio. Ma è per la lingua che siete venuta da me, vero?» Sorrise lievemente da sotto gli occhiali. Era un professore di lingue antiche, questo me l’ero ricordato dal nostro breve incontro a quella festa, anche se non sapevo di quali lingue. «È una lingua di matrice prussiana, direi. O qualcosa di simile. È molto strana, probabilmente una forma arcaica. Non l’ho mai vista prima d’ora.» Prelevò da una mensola un libro molto spesso e pesante e iniziò a sfogliarne le pagine sottili. «Sapreste dirmi di che cosa si parla? Che cosa c’è scritto, più o meno?» «Voi di che cosa vi aspettate che parli?» mi chiese, animato dalla curiosità, mentre ancora sfogliava le pagine. Mi schiarii la voce. «Di magia. O qualcosa di simile.» Si bloccò e mi fissò. «Alchimia?» dissi, stavolta con qualche esitazione. «Qualcosa che abbia a che fare con la trasformazione di una cosa in un’altra?» «Oh, mia cara, si tratta quasi sicuramente di qualcosa di magico, forse un sortilegio o un incantesimo di qualche tipo. Ma non saprei dirvi di che cosa si tratti esattamente. Magari se me lo lasciate per qualche giorno...» Fece un timido sorriso. Conoscevo abbastanza bene il mondo accademico per sospettare che cosa avrebbe fatto se avessi lasciato quel foglio in mano sua: avrebbe cercato di costruirci una carriera, usandolo come base di uno studio, di un saggio, e io non l’avrei più riavuto. Oppure, peggio ancora, se Adair avesse scoperto che era scomparso ed era finito in mano a quel lascivo professore nostro amico, allora... dire che per me si sarebbe messa male sarebbe stato un eufemismo. Inarcò un sopracciglio, in attesa, ma io mi allungai sopra la scrivania e gli strappai il foglio dalle mani. «No, mi dispiace, non posso. Ma vi ringrazio per la vostra gentile offerta. Ciò che mi avete detto è sufficiente» dissi, alzandomi dalla sedia e aprendo la porta. «E, vi prego, non fatene parola con Adair se lo vedete. Quando si tratta di regali, è difficile trovare qualcosa che lo accontenti. Voglio che quei libri siano una sorpresa.» Il vecchio professore sembrò sorpreso lui stesso di vedermi scappare così dal suo ufficio. Subito dopo andai in cerca di una levatrice. Stavano iniziando a scarseggiare in città come Boston; i medici avevano preso il loro posto nel far nascere i bambini, almeno per chi poteva permetterselo. In più, non cercavo una levatrice qualunque. Ne volevo una di quelle che si trovano in campagna, una che sapesse tutto su come curare con le piante e le erbe. Una di quelle che, cent’anni prima, in quelle stesse terre venivano definite streghe dai loro stessi vicini e morivano arse vive o impiccate. Alcune prostitute di strada mi dissero dove trovarne una, poiché era l’unica che le prostitute si potessero permettere di pagare per curare la gonorrea o trovare un rimedio in caso di gravidanze indesiderate. Sentii un brivido lungo la schiena quando oltrepassai la soglia della piccola stanza di quella donna: odorava di polvere e di polline e di vecchie cose marcescenti, proprio come la stanza segreta nella soffitta di Adair. «Ho bisogno di sapere di che cosa si tratti. L’avete mai visto prima?» le chiesi, estraendo un fazzoletto dalla mia borsa e aprendolo davanti a lei. La manciata di erbe che avevo rubato si era un po’ rimescolata durante il viaggio e ora c’erano piccoli steli e briciole di foglie marroni. Lei prese una fogliolina rimasta quasi intatta e la guardò da vicino, poi la sbriciolò con le dita e la annusò. «È neem, mia cara. Si usa per curare un certo numero di malattie. Non è molto comune da queste parti, e ancora più rara allo stato naturale come questo. Per lo più si trova in tinture e cose simili, diluita il più possibile per farla durare. Come l’avete trovata?» mi chiese con noncuranza, come se fosse vagamente interessata ad acquistarne un po’ lei stessa. Forse pensava che fosse quello il motivo per cui l’avevo cercata. Si strofinò le mani sopra il fuoco, facendo cadere le briciole nella fiamma. «Temo di non potervelo rivelare» dissi, mettendole una moneta in mano. Lei fece spallucce e accettò il pagamento, infilandosi la moneta in tasca. «Ho una seconda richiesta. Avrei bisogno dei vostri servigi per una faccenda... Ho bisogno che mi prepariate qualcosa che induca un sonno molto profondo. Non necessariamente un sonno tranquillo. Deve essere capace di far addormentare una persona il più velocemente possibile.» La levatrice mi rivolse un lungo sguardo silenzioso, chiedendosi se non avessi in realtà intenzione di avvelenare qualcuno, perché come altro si poteva interpretare la mia richiesta? Alla fine disse: «Non voglio essere rintracciata se le autorità per qualche ragione fossero coinvolte, è chiaro?» «Avete la mia parola.» Le misi in mano altre cinque monete, una piccola fortuna. Lei guardò il denaro e poi me, infine chiuse il pugno attorno all’oro. Sulla carrozza, mentre tornavo alla casa, riaprii il fazzoletto per esaminare la sostanza che la levatrice mi aveva dato. Era un grumo duro e bianco, e anche se all’epoca non lo sapevo, si trattava di fosforo bianco, probabilmente acquistato da un fabbricante di fiammiferi che a sua volta l’aveva rubato sul posto di lavoro. La levatrice l’aveva manipolato con estrema attenzione, come se non si fidasse a lavorarlo; mi aveva detto di sbriciolarlo in un mortaio e mescolarlo con del vino o del liquore, aggiungendo del laudano per favorirne l’ingestione. «È molto importante diluirlo perché abbia effetto. Potreste usare il solo laudano, ma ci vorrebbe parecchio tempo per ottenere un effetto. Il fosforo è più rapido, ma... se qualcuno dovesse ingerire questa quantità di fosforo, gli effetti sarebbero molto gravi» disse, con uno sguardo impossibile da fraintendere. Avevo già un piano, un piano molto pericoloso, ma mentre uscivo da quella piccola stanza non potevo che pensare al vero Adair. Ero piena di pietà per il povero ragazzino zingaro, morto senza nemmeno essere sepolto perché non c’era un corpo da interrare. Le sue belle spoglie mortali ora erano abitate dall’uomo che ne aveva preso possesso attraverso un incantesimo. E per quanto riguardava l’ultima parte del suo racconto, era impossibile capire quanto corrispondesse al vero e quanto no. Forse aveva davvero fatto visita alla famiglia di Adair, lasciando un tributo per espiare la colpa di aver preso il loro figlio, per aver potuto assumere un corpo così perfetto. O forse quella parte del racconto era soltanto una bugia, raccontata per rendere quella storia più credibile, più commovente, per influenzare i sentimenti di chi la ascoltava, per allontanare i sospetti. E la perdita del suo regno? Un rischio calcolato... Ma forse ne valeva la pena, alla fine, pur di guadagnare un nuovo corpo ospite che trasportasse la sua vecchia anima malvagia. Ma se non avessi fermato quell’uomo orribile, avrebbe preso la cosa che mi era più cara al mondo. Avrebbe preso Jonathan. Bello, forte, virile: il corpo del giovane zingaro dovette sembrare un dono degli dei al vecchio medico. Ma lì, nel nuovo mondo, quel corpo mostrava i suoi limiti. O piuttosto, i limiti erano nel volto: era troppo esotico, con l’incarnato olivastro incorniciato da capelli ricci e selvaggi. Lo vedevo nelle espressioni degli esponenti della buona società quando conoscevano Adair, dal modo in cui aggrottavano la fronte, con uno sguardo di istintiva diffidenza. Lì, in mezzo ai discendenti degli inglesi, degli olandesi e dei tedeschi, che non avevano mai visto un turco o un arabo, che avevano visto capelli simili soltanto sui crani degli schiavi, il corpo dello zingaro era un impedimento. Adesso capivo lo sguardo di approvazione di Adair per quel povero studente che Tilde gli aveva scovato, prima che scoprisse che aveva una deformità a un piede. Ora capivo la sua famelica approvazione nei confronti di Jonathan, della sua bellezza priva di difetti. Aveva scatenato i suoi segugi infernali, li aveva mandati a cercare un perfetto corpo ospite. Aveva perfino utilizzato Jude perché setacciasse la campagna alla ricerca del corpo ideale. Ma lì a Boston il tempo stava scadendo per Adair e aveva bisogno di un nuovo corpo, uno che fosse gradito a chi deteneva il potere in quel nuovo ambiente. Voleva Jonathan. Voleva indossare il suo corpo come una maschera. La gente era attratta da Jonathan come le mosche dal miele, nessuno poteva resistergli. Gli uomini volevano essere suoi amici, stargli vicino come pianeti attorno al sole. Le donne si davano a lui anima e corpo: e nessuno lo sapeva meglio di me. Lo avrebbero sempre cercato, si sarebbero sempre aperti con lui, senza accorgersi che l’anima che lo possedeva era il male incarnato, pronto a sfruttarli fino in fondo. E siccome nessuno conosceva il segreto di Adair, nessuno poteva fermarlo. Nessuno a parte me. 44 Quando arrivai alla casa, la trovai in subbuglio. I servitori correvano già dalle scale come acqua dalle cascate, andandosi a nascondere nello scantinato, nelle dispense, ovunque pur di allontanarsi dal frastuono che proveniva dai piani superiori. Pugni che percuotevano porte, ganci che sbattevano. Le voci attutite di Tilde, Dona e Alejandro mi giunsero da sopra. «Adair, cosa succede?» «Facci entrare!» Corsi su per le scale e trovai i tre radunati ai piedi della rampa che portava in soffitta, impotenti, restii a interrompere quello che stava accadendo dietro le porte chiuse, qualsiasi cosa fosse. Dall’interno provenivano rumori terrificanti: Uzra urlava, Adair ruggiva in risposta. Sentimmo il rumore sordo della carne contro la carne. «Che cosa sta succedendo?» chiesi, accorrendo da Alejandro. «So soltanto che Adair ha cercato Uzra dappertutto.» Ripensai alla storia di Adair, alla furia del medico quando gli erano state rubate delle cose dal tavolo. «Dobbiamo salire! La sta massacrando!» Afferrai la maniglia, ma non cedette. Aveva chiuso a chiave. «Prendete un’ascia, un martello, qualsiasi cosa! Dobbiamo spaccare la serratura!» urlai, ma loro si limitarono a guardarmi come se fossi uscita di senno. «Non sapete di cosa sia capace...» Poi i rumori cessarono di colpo. Pochi minuti dopo, la serratura scattò e Adair emerse, pallido come un cencio. Aveva la lama serpentina di Uzra in mano e i polsini erano macchiati di rosso vivo. Lasciò cadere la spada a terra e si fece largo tra di noi, ritirandosi nella sua camera. Fu solo a quel punto che trovammo il corpo. «Tu hai a che fare con tutto questo in qualche modo, vero?» mi disse Tilde. «Ti si legge in volto il senso di colpa.» Non risposi. Abbassai lo sguardo sul corpo di Uzra e mi si rivoltò lo stomaco. L’aveva colpita al petto, le aveva tagliato la gola, e doveva essere stata l’ultima cosa che le aveva fatto perché era caduta a terra con la testa rovesciata indietro, con qualche ciuffo ancora arricciato dove probabilmente lui l’aveva afferrata. Le parole «per mia mano, per mia volontà» mi riecheggiarono in mente, le stesse parole che aveva pronunciato per darle la vita eterna ora erano servite a togliergliela. Ripensarci mi fece rabbrividire, così come vedere il suo tatuaggio sul braccio abbandonato al suo fianco. Alla fine, quel marchio sul suo corpo non aveva alcun significato. Lui poteva ritirare la sua benevolenza quando e come voleva. La lite poteva essere stata scatenata da qualsiasi cosa, non l’avrei mai saputo con certezza, ma la tempistica rendeva improbabile che si trattasse di qualcosa di diverso dalla stanza segreta. In qualche modo, Adair doveva aver scoperto che gli erano stati sottratti degli oggetti e aveva dato la colpa a lei. E lei non aveva negato. O aveva voluto proteggermi, oppure – molto più probabilmente – aveva accolto con gioia la furia di Adair, sperando di trovare così la tanto agognata morte. Avevo preso quelle cose senza sapere quale sarebbe stato il prezzo da pagare. Non credevo che la cosa si sarebbe ritorta contro Uzra. Né pensavo che lui sarebbe mai giunto al punto di uccidere uno di noi, tanto meno Uzra. Era molto più in sintonia col suo carattere somministrare una feroce punizione fisica e tenere in pugno la sua vittima, tremante di terrore. Instillarle la paura che Adair lo facesse di nuovo. Non avrei mai pensato che l’avrebbe uccisa, perché credevo che, a suo modo, lui l’amasse. Mi accasciai per terra accanto a lei, le presi la mano, ma era già diventata fredda. Forse le nostre anime abbandonavano i nostri corpi più in fretta del normale, tanto ambivano la liberazione. La cosa terribile era che avevo pianificato la mia fuga, mia e di Jonathan, ma non mi era nemmeno venuto in mente di portare Uzra con noi. Anche se sapevo quanto disperatamente volesse liberarsi, non mi era balenato nemmeno per un secondo di aiutare quella povera ragazza, che aveva sopportato il peso della folle ossessione di Adair per anni e anni, che era stata così gentile con me e mi aveva aiutato a orientarmi in quella tana di lupi. L’avevo data per scontata e in quel momento, riconoscendo freddamente il mio egoismo, mi chiesi se in fondo io non fossi davvero più simile a Adair di quanto volessi ammettere. Jonathan aveva sentito le urla e ci aveva raggiunto in cima alle scale. Vedendo il corpo di Uzra sul pavimento, decise di andare ad affrontare direttamente Adair e fargliela pagare. A stento io e Dona riuscimmo a trattenerlo. «A che scopo?» urlai a Jonathan. «Tu e Adair potreste duellare fino alla fine dei tempi senza riuscire a risolvere la cosa! Per quanto vogliate uccidere l’altro, nessuno di vuoi due può!» Quanto avrei voluto dirgli la verità, dirgli che Adair non era chi pensavamo che fosse, che era molto più potente e pericoloso e spietato di quanto chiunque di noi immaginasse. Ma sapevo di non poter correre il rischio. Avevo paura che Adair intuisse i miei piani. E poi non potevo rivelare a Jonathan i miei sospetti. Ora sapevo tutto. Quegli sguardi di ammirazione che Adair rivolgeva al mio Jonathan non riguardavano questioni di letto. Il desiderio che nutriva per Jonathan aveva radici molto più profonde. Adair voleva toccare quel corpo, accarezzarlo, esplorarlo in ogni dettaglio non perché voleva fare sesso con Jonathan ma perché voleva possederlo. Possedere quel magnifico corpo, vivere con quel bellissimo volto. Voleva reincarnarsi in un corpo irresistibile. Adair ci diede istruzioni precise: dovevamo pulire il camino in cucina e preparare un catafalco. La sguattera e la cuoca scapparono quando calammo come un’orda sulla cucina. Io, Dona e Alejandro togliemmo le pentole dal focolare dell’ampio camino. Strofinammo le pareti annerite e spazzammo via la cenere. Il catafalco era fatto con due cavalletti di legno appoggiati su larghe assi. Costruimmo una pira nello spazio tra i cavalletti con parrucche e pigne spalmate di sego per facilitare l’accensione, poi paglia e sterpi secchi per alimentare la fiamma. Il corpo, avvolto in un sudario bianco, fu adagiato sulle assi. Fu avvicinata una torcia agli sterpi, che presero subito fuoco. I ceppi impiegarono un po’ ad accendersi e ci volle circa un’ora prima che le fiamme si levassero potenti. Il calore in cucina era insopportabile. Infine, anche il corpo prese fuoco, il sudario bruciò rapidamente con le fiamme che lo lambivano, quasi danzando, mentre fiocchi di cenere nera si levavano con la corrente di calore e scomparivano su per il camino. L’odore, penetrante e spaventoso, rese inquieti tutti gli abitanti della casa. Soltanto Adair riusciva a sopportarlo: si era seduto su una poltrona proprio davanti al camino e osservò il fuoco divorare Uzra poco a poco: prima i suoi capelli, poi i suoi vestiti, poi la pelle delicata delle sue braccia e infine la carne. Giunse il momento in cui il cadavere, imbevuto di unguenti, iniziò ad arrostire e a friggere, e l’odore di carne bruciata pervase la casa. «Questo odore riempirà tutta la strada. Non capisce che i vicini lo sentiranno?» disse Tilde acida, con gli occhi umidi. Ci radunammo nel corridoio davanti alla cucina, a osservare Adair, ma dopo un po’ Tilde e Dona si arresero e tornarono nelle loro camere, borbottando sommessamente. Io e Alejandro rimanemmo davanti alla cucina, seduti a terra, a guardare Adair. Quando il cielo cominciò a schiarirsi, il fuoco si era quasi estinto. La casa era satura di fumo grigio, che rimaneva sospeso nell’aria. Solo quando il fuoco fu completamente spento Adair si alzò. Passandoci accanto, toccò la spalla di Alejandro. «Fai raccogliere le ceneri e falle disperdere nell’acqua» gli ordinò con voce cupa. Alejandro insistette per farlo lui stesso, inginocchiandosi accanto al focolare ancora caldo con uno scopino e una paletta. «C’è troppa cenere» mormorò, come se io non fossi lì con lui. «Forse perché c’era tutto quel legno. Le ceneri di Uzra non possono essere più di una manciata.» In quel momento, lo scopino incontrò qualcosa di solido e lui infilò la mano nel mucchietto di resti. Trovò un piccolo pezzettino d’osso consumato. «Forse dovrei tenerlo. Per Adair. Un giorno potrebbe essere lieto di averlo. Cose come queste costituiscono amuleti potentissimi» si interrogò, rigirandoselo tra le dita come un esemplare rarissimo. Ma poi lo lasciò cadere nella paletta. «O forse no.» Dopo quanto era successo, Adair scelse di stare in disparte. Durante il giorno restava nella sua camera e l’unico visitatore che riceveva era il notaio, il signor Pinnerly, che il giorno seguente accorreva con una strabiliante quantità di documenti che spuntavano dalla cartella ricolma. Emergeva dalla camera un’ora dopo, col volto arrossato come se avesse fatto una corsa campestre. Un giorno lo intercettai vicino alla porta d’ingresso, dichiarandomi preoccupata per il suo rossore affaticato e offrendogli qualcosa di freddo da bere. «Siete molto gentile» disse ingollando un bicchiere di limonata, asciugandosi la fronte con un fazzoletto. «Temo però di non poter rimanere molto. Il vostro padrone nutre aspettative molto alte nei miei confronti, forse più di quanto un semplice uomo di legge come me possa portare a compimento. Non è che posso piegare il tempo al mio volere» borbottò esasperato, poi notò i documenti che minacciavano di fuoriuscire dalla sua cartella e si affannò a rimetterli a posto. «Oh, davvero? Be’, è molto esigente, in effetti, ma ritengo che voi siate sufficientemente abile da accontentarlo e compiere qualsiasi incarico Adair vi affidi» dissi, adulandolo senza ritegno. «Ditemi, che miracoli si aspetta da voi?» «Una serie di trasferimenti di denaro piuttosto complicati, che coinvolgono banche europee, alcune in città di cui nemmeno ho sentito parlare» spiegò, poi parve rendersi conto che non era opportuno ammettere manchevolezze di fronte a un membro della casata di Adair. «Ma non è niente, non fateci caso, ve ne prego. Sono soltanto un po’ affaticato, mia cara. Non è il caso che una signorina della sua bellezza si preoccupi di materie così mondane.» Mi diede qualche colpetto alla mano con fare così paternalistico che avrei voluto schiaffeggiargliela. Ma non avrei ottenuto quello che volevo. «Tutto qui? Si tratta soltanto di far girare dei soldi? Pensavo che un uomo intelligente come lei sarebbe stato capace di fare una cosa del genere con un gesto del mignolo.» Punteggiai le mie parole con un piccolo movimento osceno del mio mignolo e un movimento della bocca, un gesto che avevo visto fare a parecchi ragazzini in vendita per attirare clienti maschi. Funzionava. La discrezione parve fuggirgli dalle orecchie come segatura da un pupazzo rotto e mi fissò con la bocca spalancata. Se già non sospettava che in quella casa vivessero soltanto prostitute e leccaculo, ora lo sapeva con certezza. «Mia cara, per caso avete appena...» «Che cos’altro vi ha chiesto Adair? Niente che possa tenervi occupato fino a notte fonda, immagino. Niente che vi possa impedire di, diciamo, intrattenere un’ospite...» «Biglietti per la diligenza per Philadelphia, domani» rispose in fretta. «Gli ho detto che era praticamente impossibile. Così adesso gli devo noleggiare una carrozza privata...» «Per domani!» esclamai. «Dunque parte così in fretta!» «E non ha intenzione di portarvi con lui, mia cara. No. Siete mai stata a Philadelphia? È una città straordinaria, molto più viva di Boston, e non è certo il posto in cui, per fare un esempio, la signora Pinnerly verrebbe mai. Forse potrei mostrarvela io stesso...» «Aspettate! Come fate a sapere che io non ci andrò? Ve l’ha detto lui?» Il notaio mi sorrise apertamente. «Suvvia, non agitatevi. Non è che abbia intenzione di fuggire con un’altra donna. Andrà con un uomo, il fortunato beneficiario di tutti i maledetti trasferimenti di denaro. Se il vostro padrone volesse un mio consiglio, gli direi che tanto varrebbe adottarlo, quell’uomo, perché alla lunga sarebbe più semplice...» «Jonathan?» gli chiesi. Avrei voluto prenderlo per le spalle e scuoterlo per fermare tutto quel chiacchiericcio e strappargli il nome di bocca come una lumaca dal guscio. «Jacob, volevo dire, Jacob Moore?» «Sì, il nome è quello. Lo conoscete? Diventerà presto un uomo molto ricco, ve lo posso garantire. Se mi consentite di parlare apertamente, forse dovreste prendere in considerazione l’idea di ingraziarvi questo signor Moore, subito, prima che si sparga la voce...» Avendo esplicitato i suoi pregiudizi circa le mie intenzioni, Pinnerly si era messo in un angolo da solo. Mi divertii a vedere come avrebbe cercato di tirarsene fuori. Si schiarì la voce, imbarazzato. «Non che io abbia immaginato anche per un solo momento che voi... e il beneficiario del conte... dovete scusarmi. Credo di aver oltrepassato i confini della mia professione e...» Giunsi le mani in un gesto pudico. «Credo anch’io.» Mi restituì il bicchiere e prese la cartella. «Vi prego, credetemi se dico che ho parlato a sproposito senza volerlo. Confido che non andiate a riferire al conte le mie... cioè, la mia...» «La vostra indiscrezione? No, signor Pinnerly. Sono una donna discreta.» Esitò. «E suppongo che la proposta di una visita notturna...» Scossi il capo. «È fuori questione.» Mi rivolse uno sguardo straziato, a metà tra il rimpianto e il desiderio, e poi scappò dalla casa del suo cliente più strano, ben felice, credo, di lasciarsela alle spalle. A quanto pareva, ingenti somme di denaro venivano trasferite su conti intestati a Jonathan e quel fatidico viaggio a Philadelphia sarebbe avvenuto l’indomani. Adair era pronto a fare la sua mossa, il che voleva dire che il tempo stava per scadere per me. E per Jonathan. Dovevo agire immediatamente, oppure avrei trascorso tutta l’eternità tormentata dal rimorso. Andai da Edgar, il maggiordomo, quello incaricato di sovrintendere alla servitù e di mandare avanti l’amministrazione della casa. Edgar era di indole sospettosa e incline al furto, come tutti quelli che entravano a far parte di quella casa, dal padrone fino all’ultimo dei servi. Il che voleva dire che sapeva fare bene il suo lavoro, ma faceva il minimo necessario. È una caratteristica deplorevole se ci si aspetta da un maggiordomo che una casa venga governata al meglio, ma perfetta per uno che lavorava in un luogo in cui le convenzioni e gli scrupoli erano stati abbandonati da tempo. «Edgar» dissi, intrecciando le mani davanti a me con sussiego, proprio come una brava padrona di casa. «C’è bisogno di fare una riparazione nella cantina e Adair desidera che sia eseguita durante la sua assenza. Per favore, fate chiamare il muratore e ditegli di portare una carriola di pietre e una di mattoni nello scantinato entro oggi pomeriggio. Ditegli che tutto dev’essere pronto per iniziare i lavori non appena il conte sarà partito. Lo pagheremo il doppio purché esegua gli ordini.» Quando Edgar mi rivolse uno sguardo insospettito – la cantina cadeva a pezzi da tempo, perché tutta quella fretta proprio ora? – aggiunsi: «E, mi raccomando, non disturbate Adair con questa faccenda. È occupato a prepararsi per il viaggio. Ha affidato a me la questione perché io la risolva in sua assenza, e mi aspetto che sia così». Potevo permettermi tranquillamente di bistrattare i servitori; Edgar sapeva bene che era meglio non contrariarmi. Mi voltai e mi allontanai con passo altezzoso. Dovevo avviare la fase seguente del mio piano. 45 La mattina seguente, la casa ferveva di preparativi per la partenza di Adair. Lui trascorse diverse ore a scegliere quali abiti portare con sé; poi spedì dei servi a mettere il tutto nei bauli e a caricarli sulla diligenza. Jonathan si era rinchiuso in camera sua, dove avrebbe dovuto preparare i bagagli: ma avevo la sensazione che non riuscisse a convincersi a partire e che fosse in arrivo una lite. Mi nascosi nella dispensa con un mortaio preso dalla cucina e sbriciolai il grumo di fosforo con estrema cura, fino a ridurlo in polvere finissima. In quei momenti, mi sentii più nervosa che mai e ad aggravare il mio stato c’era la preoccupazione che Adair fiutasse l’inghippo intuendo che stavo tramando contro di lui. A dire il vero, non conoscevo la portata dei suoi poteri, ammesso che si potessero definire così. Ma ero arrivata a quel punto, ormai, e non avevo più altra scelta: dovevo andare fino in fondo, pur di salvare la mia vita e quella di Jonathan. La casa era immersa nella quiete e nel silenzio. Forse era soltanto la mia immaginazione, ma quel silenzio mi sembrava carico di emozioni e tensioni inespresse: abbandono, risentimento, rabbia verso Adair per quello che aveva fatto a Uzra, incertezza su quale sarebbe stato il destino di tutti noi. Con un vassoio tra le mani, sul quale avevo posato il vino drogato, superai tutte le porte delle camere da letto fino a giungere davanti a quella di Adair. Da un’ora, da quando cioè i servitori avevano caricato i bauli, non proveniva alcun rumore da lì dentro. Bussai una volta e, senza attendere una risposta, aprii la porta e scivolai all’interno. Adair era seduto in una poltrona che aveva spostato accanto al fuoco. Era una cosa insolita, poiché usualmente si sdraiava su un cumulo di cuscini. Forse era seduto più formalmente perché agghindato come un gentiluomo di quel tempo e non a petto nudo come era suo uso. Sedeva tutto irrigidito, con calzoni alla zuava e stivali, un gilet e una camicia dal colletto alto, con una cravatta di seta. Il suo cappotto era piegato sulla sponda di una poltrona lì accanto. Indossava un completo di lana grigio scuro, con poche decorazioni o ricami, molto più sobrio rispetto a come si vestiva di solito. Non aveva la parrucca, si era pettinato i capelli all’indietro e li aveva legati stretti. Aveva un’espressione triste, come se non facesse quel viaggio per sua volontà ma perché vi era costretto. Alzò una mano e fu solo in quel momento che notai il narghilé accanto a lui. La stanza si stava riempiendo del profumo dell’oppio, e doveva essere una varietà piuttosto forte. Succhiò dal bocchino, incavando le guance, con gli occhi mezzo chiusi. Appoggiai il vassoio su un tavolino accanto alla porta e mi accovacciai per terra vicino a lui. Infilai delicatamente le dita nei riccioli che gli erano caduti sulla fronte e li scostai. «Pensavo che avremmo potuto stare un po’ insieme prima della tua partenza. Ho anche portato da bere.» Aprì lentamente gli occhi. «Sono contento che tu sia venuta. È da un po’ che volevo spiegarti il senso di questo viaggio. Probabilmente ti stai chiedendo perché mi porto Jonathan e non te.» Repressi l’istinto di rivelargli che sapevo tutto e attesi che proseguisse. «So che non riesci a sopportare di stare lontana da Jonathan, ma te lo porterò via soltanto per pochi giorni» disse con aria di scherno. «Jonathan tornerà, mentre io proseguirò il viaggio da solo. Starò via per un po’. Sento il bisogno di stare da solo. È una necessità che mi pervade, di tanto in tanto... Stare da solo con i miei pensieri, con i miei ricordi.» «Ma come puoi lasciarmi così? Non ti mancherò?» gli chiesi, cercando di avere un tono civettuolo. Lui annuì. «Certo che mi mancherai, ma non posso farci niente. È per questo che Jonathan mi accompagnerà per un tratto, così che io possa spiegargli un po’ di cose. Si prenderà cura della casa e di voi mentre io sarò via. Mi ha raccontato di come ha mandato avanti la famiglia e impedito ai debiti dei tuoi concittadini di portare alla rovina un intero villaggio, per cui governare i conti di questa casa non sarà che un gioco per lui. Ho trasferito tutti i miei soldi a suo nome. Sarà lui a comandare, perciò tu e gli altri non avrete altra scelta, dovrete seguire i suoi ordini.» Sembrava quasi convincente e mi chiesi, per un esile istante, se non avessi male interpretato la situazione. Ma conoscevo Adair fin troppo bene per credere davvero che tutto fosse così semplice e pulito come diceva lui. «Lascia che ti versi da bere» dissi, alzandomi. Avevo scelto un brandy particolarmente forte, sufficientemente aromatico da mascherare il gusto del fosforo. Giù nella dispensa, avevo usato un cono di carta per far scivolare la polverina nella bottiglia, avevo aggiunto una discreta quantità di laudano, messo un tappo di sughero e mescolato lentamente e con cura. Mentre lo maneggiavo, il fosforo aveva rilasciato qualche scintilla nell’aria, perciò sperai che non ripetesse lo scherzo, rivelando la propria presenza con un bagliore sul fondo del bicchiere di Adair. Versando la mistura nel bicchiere per lui, notai sulla credenza alcuni oggetti sparsi, probabilmente in vista del viaggio. C’era un rotolo di documenti legato da un nastro, i fogli erano vecchi e ruvidi ed ero certa provenissero dalla risma raccolta nel libro con la copertina di legno, quello della stanza segreta. Accanto a esso c’erano una tabacchiera e un piccolo flacone, simile a quelli utilizzati per i profumi, contenente un’oncia di liquido marrone salmastro. «Ecco» dissi, porgendo un calice pieno a Adair. Me n’ero versato uno anch’io, pur non avendo certo l’intenzione di berlo tutto. Soltanto un sorso, per convincere Adair che non ci fosse niente di anormale. Lui sembrava già pesantemente sotto l’effetto dell’oppio, anche se sapevo che l’oppio da solo non sarebbe bastato a farlo addormentare. Tornai ad accoccolarmi ai suoi piedi e lo guardai con quello che speravo fosse inteso come uno sguardo di preoccupata adorazione. «È da giorni e giorni ormai che sei inquieto. È per quello che è successo con Uzra, vero? No, non protestare: hai tutti i diritti di essere sconvolto da quello che è accaduto dopo averla tenuta con te per centinaia d’anni. So che lei significava qualcosa per te.» Lui sospirò e mi permise di passargli nuovamente il bocchino del narghilé. Era evidente il suo bisogno di obnubilare i pensieri. Sembrava quasi malato: si muoveva lentamente, era gonfio. Forse stava soffrendo per aver ucciso l’odalisca, o forse aveva paura di abbandonare quel corpo per prendere quello di Jonathan: in fondo, era passato molto tempo dall’ultima volta che l’aveva fatto. Poteva essere un processo doloroso. Forse aveva paura delle conseguenze di un ulteriore sortilegio, che sarebbe andato ad aggiungersi alla lista dei peccati che aveva già commesso, una lista per la quale un giorno gli sarebbe stato presentato il conto. Dopo aver fumato ancora un po’, mi guardò con gli occhi socchiusi. «Hai paura di me?» «Perché hai ucciso Uzra? Avevi le tue ragioni. Non spetta a me metterle in dubbio. Le cose stanno così, il padrone sei tu.» Lui chiuse gli occhi e tornò a reclinare il capo sull’alto schienale della poltrona. «Sei sempre stata quella più ragionevole con me, Lanore. Con gli altri è impossibile vivere. Nei loro occhi c’è sempre uno sguardo di accusa. Sono freddi, si nascondono da me. Dovrei sterminarli e ricominciare da capo.» Dal tono della sua voce, capii che non era una vuota minaccia; un tempo, aveva fatto la stessa cosa a un vecchio gruppo di suoi cortigiani. In un attacco di furia, aveva commesso una strage. Nonostante avessimo la capacità di vivere in eterno, a ben vedere la nostra esistenza era sempre appesa a un filo. Dovetti imporre alle mie mani di non tremare mentre gli accarezzavo la fronte. «Che cosa aveva fatto per meritare quella punizione? Ti va di dirmelo?» Lui scostò la mia mano e riprese a succhiare dal bocchino. Presi la bottiglia e gli versai un altro bicchiere. Gli consentii di accarezzarmi goffamente il volto con le sue mani assassine e continuai a blandirgli la coscienza con false rassicurazioni sul fatto che aveva avuto tutti i diritti di uccidere l’odalisca. A un certo punto, tolse la mia mano dalla sua fronte e iniziò ad accarezzarmi il polso, percorrendo le vene con la punta delle dita. «Ti piacerebbe prendere il posto di Uzra?» mi chiese, con una punta di agitazione. La sola idea mi terrorizzava, ma cercai di non mostrarglielo. «Io? Ma io non ti merito... Non sono bella come Uzra. Non potrei mai darti quello che ti dava lei.» «Puoi darmi qualcosa che lei non è mai stata capace di darmi. Lei non si è mai arresa a me, mai. Mi ha odiato e disprezzato ogni singolo giorno che siamo stati insieme. Con te invece sento che... Ci sono stati dei momenti felici tra di noi, vero? Mi piace pensare che in alcuni momenti tu mi abbia perfino amato.» Posò le labbra sul mio polso, sentendo le pulsazioni. «Potrei renderti più facile amarmi, se tu lo volessi. Saresti mia, mia soltanto. Non ti dividerei più con nessuno. Che cosa ne pensi?» Continuò ad accarezzarmi e baciarmi il polso, mentre io mi sforzavo di trovare una risposta che non suonasse immediatamente falsa. Alla fine, fu lui a rispondere per me. «È per via di Jonathan, vero? Lo sento nel tuo cuore. Vuoi essere libera per Jonathan, per il giorno in cui lui verrà da te. Io voglio te, ma tu vuoi Jonathan. Be’... forse c’è un modo perché tutto questo si possa risolvere, Lanore. Forse c’è un modo per far sì che entrambi abbiamo ciò che più desideriamo al mondo.» Sembrava una confessione, una conferma di tutto quello che avevo sospettato, e mi fece gelare il sangue nelle vene. L’abilità quasi soprannaturale di Adair nell’individuare anime corrotte sarebbe stata la ragione della sua fine. Perché mi aveva scelta bene. Mi aveva individuata nella massa, sapendo che ero il tipo di persona che, senza alcuna esitazione, sarebbe stata capace di versare bicchiere drogato dopo bicchiere drogato a un uomo che aveva appena dichiarato di amarla. Chissà, forse se si fosse trattato soltanto di me, se soltanto il mio, di futuro, fosse stato in pericolo, avrei scelto e agito diversamente. Ma Adair aveva coinvolto Jonathan nel suo piano. Forse era convinto di rendermi felice, forse pensava che fossi così superficiale da stare con lui e amarlo purché lui avesse il corpo di Jonathan da farmi ammirare e godere. Ma dentro quel corpo ci sarebbe stata l’anima perversa e omicida di Adair, dietro il volto del mio amato ci sarebbe stata la sua anima maledetta e l’avrei sentita in ogni parola, in ogni carezza. Che cos’altro potevo fare? Lasciò andare il mio braccio e cadere il bocchino del narghilé. I suoi movimenti erano intorpiditi, rallentati come un giocattolo a molla che ha esaurito la carica. Non potevo aspettare ulteriormente. Visto quello che stavo per fargli, dovevo sapere. Dovevo essere assolutamente certa. Avvicinai le labbra al suo orecchio e sussurrai: «Tu sei il medico, vero? Sei tu l’uomo di cui mi hai raccontato, vero?» Parve aver bisogno di un momento per capire il senso delle mie parole, ma poi non reagì con rabbia. Al contrario, un lento sorriso gli si dipinse in volto. «Sei così intelligente, mia Lanore. Sei sempre stata la più intelligente, l’avevo capito dal primo momento. Eri l’unica che capiva quando stavo mentendo... Hai trovato l’elisir. Hai trovato il sigillo... Oh, sì, me ne sono accorto. Ho sentito il tuo profumo sul velluto... In tutto il tempo che ho vissuto, tu sei la prima ad aver svelato il mio enigma, ad aver interpretato correttamente gli indizi. Mi hai scoperto, e sapevo che l’avresti fatto.» Stava perdendo lucidità e a un certo punto non sembrò più accorgersi della mia presenza. Mi sporsi su di lui, afferrandolo per l’orlo del gilet, e dovetti scuoterlo per avere la sua attenzione. «Adair, dimmi: quali sono i tuoi piani con Jonathan? Vuoi prendere possesso del suo corpo, vero? È questo che hai fatto al ragazzino zingaro, il ragazzo che ti ha servito, e ora vuoi Jonathan. È così, vero?» Aprì gli occhi di scatto e il suo sguardo gelido si posò su di me, facendomi quasi perdere il controllo. «Se fosse possibile... Se una cosa simile dovesse succedere veramente... mi odieresti, Lanore, vero? Eppure non sarei diverso dall’uomo che conosci, l’uomo che hai amato. Perché tu mi hai amato, Lanore, lo so.» «È vero» gli dissi, per rassicurarlo. «Avresti me e avresti anche Jonathan. Ma senza la sua eterna indecisione. Senza la sua indifferenza crudele verso i tuoi sentimenti, senza la sua crudeltà, il suo egoismo, i suoi rimpianti. Io ti amerei, Lanore, e tu saresti sicura dei miei sentimenti. È una cosa che non puoi avere da Jonathan. È qualcosa che non otterrai mai da lui.» Le sue parole mi scossero perché sapevo che erano vere. E furono anche parole profetiche; fu come una sorta di maledizione che Adair mi lanciò, condannandomi all’infelicità eterna. «So che è così. Eppure...» mormorai, continuando ad accarezzargli il volto, cercando di capire quanto fosse sul punto di cedere. Mi pareva impossibile che un corpo potesse ingerire così tanta droga e rimanere conscio. «Eppure, è Jonathan che scelgo.» A quelle parole, lo sguardo di Adair si illuminò di una piccola scintilla di comprensione, comprensione di ciò che avevo appena detto. Comprensione del fatto che qualcosa di terribile gli stava accadendo, perché ora non riusciva più a muoversi. Il suo corpo si stava arrendendo alla droga, anche se lui la combatteva. Si contorse sulla poltrona come la vittima di un infarto, con convulsioni e tremori, la bava che gli colava dagli angoli della bocca formando piccole bolle. Mi rialzai in piedi di scatto, evitando le sue mani che afferrarono l’aria invece di me. Si bloccò a mezz’aria. Si afflosciò. Inerte. E di colpo si immobilizzò, rigido come un cadavere e grigio come acqua sporca, e rotolò giù dalla poltrona cadendo sul pavimento. Era tempo di compiere l’ultima mossa. Tutto era già stato predisposto poco tempo prima, ma non potevo fare quell’ultima parte da sola. Avevo bisogno di Jonathan. Corsi fuori dalla stanza e lungo il corridoio fino alla camera da letto di Jonathan, entrando senza bussare. Lui stava camminando nervosamente per la stanza, ma sembrava pronto per uscire, con il cappotto piegato sul braccio e il cappello in mano. «Jonathan» esalai, richiudendo la porta dietro di me e impedendogli così di uscire. «Dove sei stata?» mi chiese, con un tono arrabbiato. «Ti ho cercata ovunque senza trovarti... Ho aspettato, sperando che tu venissi da me, e poi non ce l’ho più fatta. Adesso vado da Adair a dirgli che non voglio partire con lui, non ne ho alcuna intenzione. Gli dirò che non voglio più saperne niente, di lui, e che voglio andarmene.» «Aspetta! Jonathan, ho bisogno di te. Devi aiutarmi.» Per quanto fosse in preda alla rabbia, Jonathan si accorse che ero sconvolta e mise da parte le sue recriminazioni per ascoltarmi. Gli raccontai tutto, sicura di apparirgli una pazza, ma non avevo avuto il tempo di prepararmi il discorso, di trovare un modo per spiegargli tutto senza sembrare folle o paranoica. E dentro di me mi sentii morire, perché sapevo che mi avrebbe vista per quella che ero: un essere malvagio, capace di condannare qualcuno a sofferenze terribili: la stessa che aveva indotto Sophia a suicidarsi, crudele, dura come l’acciaio, anche dopo tutto quello che io stessa avevo sofferto. Ero sicura che Jonathan mi avrebbe denunciata. Ero certa che sarebbe scappato da me, che l’avrei perso per sempre. Quando gli spiegai tutto quanto, di come Adair avesse progettato di uccidere la sua anima e prenderne il posto dentro il suo corpo, trattenni il fiato, aspettando che Jonathan mi scacciasse o mi schiaffeggiasse addirittura, definendomi una povera squinternata. Aspettai di sentire il fruscio del mantello, la porta richiudersi di schianto. Ma non fece niente di tutto questo. Mi prese la mano e in quel momento avvertii un legame fra di noi, un legame che non sentivo da tempo. «Mi hai salvato, Lanny. Un’altra volta» mormorò, con voce rotta dalla commozione. Quando vide Adair accasciato sul pavimento, immobile come un cadavere, Jonathan ebbe un moto di ribrezzo. Ma subito dopo, si diede da fare per aiutarmi. Legammo Adair più stretto che potemmo: le braccia dietro la schiena, le caviglie, una benda appallottolata in bocca. Quando Jonathan iniziò a legare i polsi di Adair alle caviglie, piegando il nostro prigioniero all’indietro in una posizione di totale vulnerabilità, mi ricordai del terribile strumento di tortura in cui ero stata legata. Provai la stessa orrenda sensazione di vulnerabilità e seppi di non poter fare la stessa cosa a Adair, anche se era stato proprio lui a torturarmi in quel modo. Per quanto tempo sarebbe rimasto legato in quella posizione prima che qualcuno lo trovasse e lo liberasse? Sembrava una punizione troppo crudele, perfino per lui. Avvolgemmo Adair nella sua coperta di zibellino preferita, una piccola concessione. Io uscii per prima, così che Jonathan, se avesse incontrato uno degli altri, avrebbe potuto dire che quel fagotto fra le sue braccia ero io. Ci accordammo di incontrarci nel seminterrato per portare a compimento il mio piano. Io corsi avanti, scendendo le scale della servitù per arrivare nel seminterrato. Aspettai Jonathan ai piedi delle scale, appoggiata alla fredda parete di pietra, divorata dalla preoccupazione per lui. Avevo lasciato che fosse lui da solo a correre il rischio di portar via Adair da quella stanza. Anche se gli altri si erano tutti isolati, sconvolti dalla fine di Uzra e confusi dalla partenza di Adair, non c’era alcuna garanzia che Jonathan non incrociasse uno di loro lungo il percorso. Avrebbe potuto essere visto da uno della servitù, e sarebbe bastato quello per mandare a rotoli il nostro piano. Attesi in preda all’ansia finché Jonathan non spuntò sulle scale, con il corpo di Adair accasciato fra le sue braccia. «Ti ha visto qualcuno?» gli chiesi. Lui scosse il capo. Lo precedetti attraverso il contorto labirinto di corridoi, fino a giungere al piano più basso del seminterrato, la cavernosa cantina in cui venivano conservate le casse di vino. In quel punto, sembrava di essere nelle segrete di un castello. Era completamente separato dal resto dell’edificio ed era circondato da uno spesso strato di terreno e di pietre, allo scopo di mantenere costante la temperatura per il vino. In fondo, avevo scovato una piccola nicchia priva di finestre, incavata nelle massicce fondamenta della casa. Sembrava un ampliamento della cantina, iniziato e mai portato a termine: c’erano mattoni e assi di legno sparsi sul terreno. Il giorno prima, come avevo ordinato, erano stati consegnati i mattoni e le pietre, impilati sul pavimento accanto a un secchio di malta, coperto da un panno inumidito che ora era quasi asciutto. Jonathan osservò quei materiali e poi mi guardò negli occhi, intuendo immediatamente a che cosa servissero. Lasciò cadere il corpo inerte di Adair sul terreno freddo e umido. Senza dire una parola, si tolse la giacca e si rimboccò le maniche della camicia. Rimasi a fare compagnia a Jonathan mentre chiudeva l’apertura della piccola nicchia; posò una prima fila di mattoni, poi iniziò a sistemare strati di pietre simili a quelle del muro circostante. Jonathan lavorava in silenzio, posando le pietre una a una con attenzione, sistemandole con un colpo di manico della cazzuola, come aveva imparato a fare da giovane. Io rimasi tutto il tempo a fissare la forma inerte di Adair, sul pavimento, che a poco a poco scompariva nell’ombra. Quando giunse l’ora in cui era prevista la partenza di Adair, salii e mandai via la diligenza, spiegando al cocchiere che i signori avevano cambiato idea, ma volevano comunque che i loro bagagli fossero portati a destinazione, come previsto. Poi accennai casualmente a Edgar che il padrone era già partito, un po’ prima rispetto a quanto previsto per evitare di avere troppa attenzione attorno a sé. Aveva voluto partire in sordina. Il fatto che le camere di Adair e Jonathan fossero vuote confermò la mia versione e Edgar si limitò a fare spallucce e riprese i suoi compiti. Se gli altri gli avessero chiesto qualcosa, avrebbe dato la mia versione dei fatti. Tornai giù. Jonathan continuò a lavorare meticolosamente, fermandosi ogni volta che sentivamo un rumore o un movimento che sembrava nella nostra direzione. Per lo più, là sotto c’era un silenzio tombale e avvertivamo a stento dei rumori provenire dai piani superiori. Del resto, tra la cantina e il primo piano c’era un piano di magazzini pieni. Eppure non riuscivo a tranquillizzarmi, sentivo che gli altri sarebbero venuti a cercarmi. E volevo lasciarmi alle spalle il prima possibile quell’atto tremendo. L’uomo in quella cella è un mostro, continuai a ripetermi per acquietare il mio senso di colpa crescente. Non è l’uomo che credevo. «Fai più in fretta, ti prego» mormorai, appollaiata su una vecchia cassa. «Non posso, Lanny» mi rispose Jonathan senza voltarsi, senza interrompere il ritmo di lavoro. «La tua droga...» «Non è mia. Lo stiamo facendo assieme!» urlai, saltando giù dalla cassa, agitata. «La droga prima o poi esaurirà il suo effetto. I nodi si allenteranno e il bavaglio si scioglierà. Ma questo muro deve reggere. Non posso sbagliare. Dev’essere il più resistente possibile.» «Va bene, ho capito» dissi, tormentandomi le mani mentre andavo avanti e indietro in preda a un’agitazione crescente. Sapevo benissimo che la pozione non poteva ucciderlo, anche se era velenosa, ma speravo che lo facesse dormire per sempre o che gli avesse causato dei danni cerebrali permanenti, così che non si sarebbe mai reso conto di quello che gli era successo. Perché non era certo un essere magico in sé, non era un demone né un angelo. Non poteva far sì che i nodi si sciogliessero da soli, né attraversare i muri come un fantasma. Il che significava che a un certo punto si sarebbe svegliato, al buio, e non sarebbe riuscito a togliersi il bavaglio, né a chiedere aiuto, e chissà per quanto tempo sarebbe rimasto lì, murato vivo. Mi fermai davanti alla cella per vedere se percepivo la presenza di Adair, quella sensazione elettrica alla base della nuca che testimoniava il nostro legame eterno. Non sentii nulla. Forse per via del fatto che Adair era pesantemente sedato. Forse l’avrei avvertito di nuovo quando si fosse svegliato, e sarebbe stata una tortura sentire giorno dopo giorno l’eco della sua agonia nella mia testa senza poterci fare nulla. Infinite notti ho ripensato a quello che ho fatto a Adair, e ci sono state volte in cui sono giunta a pensare che se fosse possibile tornare indietro, non lo rifarei più. Ma in quel momento, non potevo permettermi simili pensieri. Era troppo tardi per avere rimorsi. Troppo tardi per la pietà. Quella sera, Jonathan sgattaiolò fuori mentre gli altri erano via, a una delle solite feste. Ebbi un assaggio dei litigi che mi aspettavano quando Jonathan, una volta uscito, si voltò verso di me e mi chiese: «Adesso possiamo tornare a St. Andrew, giusto?» Io trattenni il fiato. «St. Andrew è l’ultimo posto al mondo in cui possiamo andare. Lì ci scoprirebbero subito per quel che siamo. Non invecchieremo mai, Jonathan. Non ci ammaleremo mai. Tutte le persone da cui vuoi tornare un giorno capiranno e ti guarderanno con orrore. Avranno paura di te. È questo quello che vuoi? Come faremo a spiegare le cose? Non possiamo. E il pastore Gilbert ci accuserà di stregoneria, questo è poco ma sicuro.» La sua espressione si rabbuiò mentre mi ascoltava, ma non disse niente. «Dobbiamo sparire» proseguii. «Dobbiamo andare dove nessuno ci conosce e dobbiamo sempre essere pronti a partire da un momento all’altro. Devi fidarti di me, Jonathan. Devi affidarti a me. Ora possiamo solo contare l’uno sull’altra.» Non protestò. Mi diede un leggero bacio sulla guancia e si recò nella locanda dove avevamo pianificato di incontrarci l’indomani. La mattina seguente, dissi agli altri che partivo per raggiungere Jonathan e Adair a Philadelphia. Quando Tilde inarcò un sopracciglio con aria di sospetto, le rivoltai contro le stesse parole di Adair, dicendole che non sopportava più i loro sguardi di accusa per quello che aveva fatto a Uzra e che forse loro non erano in grado di perdonarlo, ma io sì. Poi andai da Pinnerly e chiesi la lista dei conti intestati a Jonathan. All’inizio il notaio fu piuttosto reticente a consegnarmi i documenti privati di Adair, ma io lo condussi sul retro e mi bastarono pochi minuti sulle ginocchia per convincerlo a cambiare idea. E che cos’erano pochi minuti da puttana in cambio della sicurezza finanziaria di Jonathan per il futuro? Jonathan mi avrebbe perdonata, ne ero sicura e, comunque, non l’avrebbe mai scoperto. Gli altri non dissero niente contro di me, non apertamente almeno, ma erano evidentemente sospettosi e ostili. Si radunavano negli angoli più in ombra della casa e parlottavano a voce bassa. Alla fine, però, si dispersero e ognuno tornò nella sua camera a farsi gli affari suoi, lasciandomi via libera. Entrai nello studio. Io e Jonathan avevamo bisogno di soldi per fuggire, almeno fino a che non fossimo riusciti a mettere le mani sui conti che Adair stesso aveva aperto, per il suo futuro, ovviamente. Con mia sorpresa, trovai Alejandro seduto al tavolo, pareva affranto, con la testa fra le mani. Mi guardò con indifferenza mentre prelevavo dei soldi dal cofanetto di Adair e li mettevo dentro un borsellino. Non c’era niente di strano nel fatto che portassi a Adair altri soldi per il suo viaggio. Ma Alejandro mi osservò con curiosità quando tirai giù dalla parete il ritratto a carboncino di Jonathan. Era l’unica cosa che non potevo lasciarmi dietro. Lo tolsi dalla cornice, lo inserii fra un telo di stoffa e un panno di camoscio, lo arrotolai in uno stretto cilindro e lo legai con un nastro di seta rossa. «Perché ti porti via quel ritratto?» mi chiese. «C’è un pittore a Philadelphia e Adair vuole presentarlo a Jonathan. Jonathan non accetterà mai di farsi fare un altro ritratto, e Adair lo sa, così vuole chiedere a questo pittore di dipingerlo a partire da questo schizzo a carboncino. A me sembra uno sforzo eccessivo, lo so, ma sai bene com’è fatto Adair, una volta che decide una cosa...» dissi con forzata allegria. «Non ha mai fatto niente del genere» rispose Alejandro, rinunciando alle domande con la disperazione di uno che inizia ad accettare l’inevitabile. «È tutto molto... inatteso. E strano. Non so che cosa fare, ora.» «Ogni cosa finisce, prima o poi» osservai, dopodiché con noncuranza uscii dallo studio. Attesi in carrozza mentre i servitori portavano giù i miei bauli e li caricavano. Poi partimmo con uno scossone e mi inserii nel traffico di Boston, scomparendo tra la folla. Parte IV 46 Québec City, oggi Luke e Lanny sono seduti al tavolo della camera d’albergo, davanti a un elegante servizio da tè con tazze di porcellana e un piattino colmo di brioche, intonse. Quattro pacchetti di sigarette, ordinati assieme alla colazione, giacciono in una coppa d’argento. Luke beve un altro sorso di caffè con la panna. La notte precedente è stata piuttosto movimentata, hanno bevuto molto, fumato marijuana, e mentre la fatica è ben visibile sul suo volto, quello di Lanny non lascia trasparire niente: ha sempre una pelle delicata e liscia e l’aria splendente. Ma la sua tristezza è visibile. «Immagino che tu abbia cercato di saperne di più sull’incantesimo» dice Luke dopo qualche attimo di silenzio. La sua domanda suscita un barlume di divertimento sul volto di Lanny. «Naturalmente ci ho provato. Non è facile scovare un alchimista, uno vero. In ogni città in cui sono stata, sono andata a scovare i maestri delle arti oscure, lo sai, quelli con un’inclinazione per la perversione. E ce ne sono in ogni città, alcuni che operano alla luce del sole, altri costretti a nascondersi.» Scuote il capo. «A Zurigo scovai un negozietto in un vicolo a poca distanza dalla via principale. Vendeva manufatti rari, teschi antichi con incisioni fatte nelle ossa, pergamene rilegate in pelle umana e riempite di parole in linguaggi che oggi nessuno più conosce. Pensai che se c’era qualcuno che conosceva le vere arti della negromanzia, dovesse essere il proprietario di quel negozio, che aveva dedicato la sua vita alla ricerca della magia più arcana. Ma la conosceva solo per sentito dire. Non ne venne fuori nulla. «Fu soltanto in questo secolo, circa cinquant’anni fa, che finalmente mi giunse una voce che aveva una parvenza di verità. Accadde a Roma, durante un ricevimento. Conobbi un professore, uno storico. La sua specializzazione era il Rinascimento, ma la sua passione privata era l’alchimia. Quando gli domandai se avesse mai sentito parlare di una pozione in grado di conferire l’immortalità, mi spiegò che un vero alchimista non avrebbe avuto bisogno di una pozione dell’immortalità, perché il vero scopo dell’alchimia era di trasformare l’uomo, portarlo a un livello superiore. Un po’ come la leggenda dei tentativi di trasformare il piombo in oro; mi disse che era una pura allegoria, si trattava invece di trasformare l’uomo in un essere superiore.» Lei china il capo e sposta in là la tazza di qualche centimetro, con il piattino che si sposta a sua volta sulla tovaglia di damasco. «Come puoi immaginare, la sua risposta mi deluse. Ma poi proseguì, dicendomi di aver sentito parlare di una pozione rara con un effetto simile a quello che io gli avevo descritto. Si diceva che fosse in grado di trasformare un oggetto nel... be’, il termine migliore è familiare dell’alchimista, credo, dare vita a un oggetto inanimato, come un golem, perché facesse da servitore all’alchimista. Quella pozione era anche in grado di rianimare i morti, farli tornare alla vita. «Secondo il professore, lo spirito che andava a impossessarsi dell’oggetto o del cadavere proveniva dal mondo demoniaco» dice, con voce rotta dal disprezzo. «Un demone evocato per obbedire agli ordini. Non riuscii ad ascoltare oltre. E da quel momento ho smesso di cercare spiegazioni.» Rimangono seduti in silenzio, a osservare il traffico dieci piani sotto di loro, con le auto che si muovono ordinatamente oltre la griglia della finestra. Il sole dell’alba sta iniziando a farsi strada fra le nuvole, e i suoi riflessi illuminano il servizio d’argento sul tavolo. Tutto sembra bianco e argenteo e vitreo, pulito e lindo, e tutto ciò di cui hanno parlato – oscurità, morte – sembra distante milioni di miglia. Luke prende una sigaretta, ci giocherella con le dita e poi la mette da parte, senza accenderla. «Perciò avete lasciato Adair murato vivo nella sua casa. E non sei mai tornata a controllare che non fosse uscito?» «Mi preoccupavo che fosse riuscito a liberarsi, naturalmente» dice, annuendo quasi impercettibilmente. «La sensazione, il nostro legame, era scomparso, però. Non avevo niente su cui basarmi. Tornai un paio di volte – ero terrorizzata all’idea di cosa avrei trovato, come puoi immaginare – giusto per controllare che la casa ci fosse ancora. Era... Era... Per tantissimo tempo fu utilizzata come abitazione. Mi aggirai attorno all’isolato, cercando di percepire la presenza di Adair. Niente. Poi una volta tornai e scoprii che era diventata un’impresa di pompe funebri. Da non crederci. Il quartiere si era impoverito... mi immaginai le stanze in cui preparavano i cadaveri, nel seminterrato, a pochi passi da dove Adair era murato vivo. L’incertezza era troppa, così...» Lanny spegne la sigaretta, la posa e ne accende immediatamente un’altra. «Perciò chiesi al mio avvocato di contattare le pompe funebri e di fare un’offerta per rilevarle. Come ti dicevo, era tempo di crisi. L’offerta era più di quanto i proprietari avessero mai pensato... La accettarono. «Non appena se ne furono andati, ci entrai di persona. Era difficile immaginare che fosse la casa che conoscevo, era così cambiata. La parte dello scantinato sotto la scala d’ingresso era stata rinnovata. Un pavimento di cemento, una caldaia, un sistema di riscaldamento dell’acqua. Ma la parte sul retro era rimasta intatta, lasciata lì a marcire. Non c’era elettricità. Era tutto buio e umido. «Andai nel punto in cui... In cui avevamo messo Adair. Era impossibile distinguere il vecchio muro dalla parte che Jonathan aveva costruito. Era tutto invecchiato. Eppure, non avvertii alcuna sensazione provenire da dietro quella parete. Nessuna presenza. Non sapevo che cosa pensare. Fui quasi tentata, quasi, di far abbattere il muro. È come quella perversa voce nella tua testa che ti spinge a saltar giù dal balcone quando ti avvicini troppo alla ringhiera.» Sorride mestamente. «Ovviamente non lo feci. Anzi, a dire il vero, feci rinforzare il muro con del cemento armato. Dovettero procedere con cura, non volevo che il muro fosse danneggiato durante i lavori. Ora è sigillato a dovere. E io dormo molto meglio.» Ma non è vero che dorme meglio: Luke se n’è accorto nel poco tempo che sono stati insieme. Deve condurla via dal posto in cui l’ha spinta a recarsi coi ricordi, dalla cella buia e umida in cui ha rinchiuso l’uomo che ha condannato. Luke allunga una mano e prende la sua. «Ma la tua storia... Non è ancora finita, vero? Tu e Jonathan avete lasciato la casa di Adair insieme. E poi che cosa è successo?» Lanny sembra ignorare la domanda per qualche momento, assorta a osservare il mozzicone di sigaretta fra le sue dita. «Siamo rimasti insieme per qualche anno. All’inizio, rimanemmo insieme perché era la cosa migliore da fare. Potevamo prenderci cura l’uno dell’altra, guardarci le spalle a vicenda. Erano tempi difficili e avventurosi. Viaggiammo costantemente perché eravamo costretti a farlo e perché non sapevamo come sopravvivere altrimenti. Imparammo a crearci nuove identità, a vivere nell’ombra, anche se era difficile per Jonathan riuscire a non attirare l’attenzione. La gente era sempre ammaliata dalla sua bellezza. Ma a poco a poco divenne sempre più evidente che se rimanevamo insieme era perché io lo volevo. Era un matrimonio surrogato, privo di intimità. Eravamo come una vecchia coppia unita da un patto di non amore, e io avevo costretto Jonathan a recitare il ruolo del marito donnaiolo.» «Non era costretto a tradirti» obietta Luke. «Era la sua natura. E le donne che si interessavano a lui... non si arrendevano mai.» Sbuffa delicatamente e scrolla la cenere nel piattino che stanno usando come posacenere. «Eravamo entrambi infelici. Arrivammo al punto di non sopportarci più; ci eravamo fatti troppo male a vicenda e detti cose orribili. A volte lo odiavo così tanto da non voler altro che sparisse dalla mia vita. Sapevo che doveva essere lui ad andarsene perché io non avrei mai avuto la forza di lasciarlo. «Poi un giorno mi svegliai e trovai un biglietto sul cuscino accanto.» Sorride ironicamente, come se fosse abituata a osservare le proprie sofferenze da spettatrice indurita. «Mi scrisse: ’Perdonami. È meglio così. Promettimi che non verrai mai a cercarmi. Se cambierò idea, sarò io a trovarti. Ti prego, rispetta i miei desideri. Il tuo affezionato J’.» Lei fa una pausa, schiaccia la sigaretta nel piattino. La sua espressione è rigida ma vagamente divertita. Guarda fuori dalle alte finestre. «Alla fine trovò il coraggio di andarsene. Fu come se mi avesse letto nella mente. Naturalmente, il suo abbandono fu un’agonia per me. Volevo morire, sicura che non l’avrei mai più rivisto. Ma si va avanti, no? E comunque, non avevo altra scelta, anche se è consolatorio in qualche modo pensare che l’avessi.» Luke ricorda come ci si sente a essere sfiniti dalla tensione, ricorda i giorni in cui lui e Tricia non riuscivano a sopportare nemmeno di stare nella stessa stanza. Lui rimaneva seduto al buio e cercava di immaginare come si sarebbe sentito se si fossero separati, come si sarebbe sentito in pace. Non c’era alcun dubbio che sarebbe stata lei ad andarsene – non poteva certo aspettarsi che fosse lui a lasciare le sue figlie o la casa in cui era cresciuto – ma quando la sua famiglia se ne andò lasciandolo da solo alla fattoria, non fu affatto come essere da solo. Fu come se qualcosa gli fosse stato strappato via con violenza, come se una parte del suo corpo fosse stata amputata. Le concede un momento per riprendersi dal dolore dei ricordi. «Ma non è finita così, vero? È ovvio che vi siete incontrati di nuovo.» La sua espressione è imperscrutabile, luminosa e allo stesso tempo oscura. «Sì, è così.» 47 Parigi, un mese prima Era una giornata grigia. Sbirciai oltre le tende e scorsi una striscia di cielo dal terzo piano della mia casa, una vecchia villetta a schiera nel quinto arrondissement. Era l’inizio dell’inverno a Parigi, il che voleva dire che da allora in poi quasi tutti i giorni sarebbero stati grigi. Accesi il mio computer, poi rimasi accanto alla scrivania a mescolare la panna nel caffè mentre il computer si avviava. Trovo che ci sia qualcosa di rassicurante in quella sequenza di suoni e sibili, qualcosa di confortante a livello subliminale, come il cinguettio degli uccelli o un qualsiasi segno di vita esterna alla mia. Adoro la normalità e cerco il massimo della routine che riesco a infilare in una vita altrimenti priva di scopo e di forma. Sorseggiai il caffè. Anche se non ne ho veramente bisogno per svegliarmi, come altre persone, ormai lo bevo per abitudine. Avevo dormito pochissimo, sonnecchiando più che altro. Ero sveglia dalle primissime ore dell’alba, a fare ricerche per il libro che per contratto dovevo scrivere, ma mi annoiava da morire. Poi, stanca, ricominciai a catalogare la mia collezione di ceramiche mentre guardavo qualche replica alla televisione americana. Ero arrivata al punto di pensare che avrei spedito la mia collezione a un’università o a un museo, un posto in cui altri potessero vederla, insomma. Mi ero stufata di essere costantemente circondata da tutta quella roba, che mi tirava a sé come mani dalla tomba. Sentivo il bisogno di liberarmi di un po’ di cose. Il caffè, caldo e aromatico, mi ravvivò quasi miracolosamente quella mattina, facendomi sentire presente a me stessa, al contrario di come mi sentivo di solito, cioè distratta e irrequieta. Era una sensazione così poco familiare che – visto che non avevo alcun calendario in casa – per un secondo non riuscii a ricordare che anno fosse. Le mie e-mail finirono di caricarsi e percorsi velocemente con lo sguardo la lista dei mittenti. Più che altro roba d’affari: il mio avvocato, il mio editore della piccola, scalcagnata casa editrice che aveva pubblicato la mia precedente monografia sulla ceramica cinese antica, un invito a una festa. Mi ero fatta una vita da presunta esperta di ceramiche cinesi. La mia falsa identità di intenditrice era basata su un’inestimabile collezione di ceramiche che il mio datore di lavoro cinese mi aveva consegnato mentre salivo a bordo di una nave inglese durante i saccheggi dei nazionalisti. Un’altra vita fa, un’altra storia che nessuno conosceva. Quella era la persona che avevo scelto di essere in quel periodo, e se non stavo troppo a pensarci poteva anche funzionare. C’era un indirizzo e-mail che non conoscevo. Dallo Zaire – oh, oggi si chiama Repubblica Democratica del Congo. Aggrottai la fronte; conoscevo qualcuno nello Zaire? Forse era una richiesta di beneficenza, o un truffatore che fingeva di essere un principe africano in momentanee difficoltà economiche che chiedeva un aiuto. Stavo per eliminarla senza nemmeno aprirla ma all’ultimo momento cambiai idea. «Cara Lanny» c’era scritto, «un saluto dall’unica persona che pensavi non si sarebbe mai più fatta viva. Prima di tutto, lascia che ti ringrazi per aver onorato la mia ultima richiesta di non cercarmi, non l’hai mai fatto da quando ci siamo lasciati...» Maledette parole innocenti, scritte in pixel fluttuanti sullo schermo. Stampa, ordinai con un clic del mouse. Stampa, maledetta, devo tenere in mano queste parole. «Spero che mi perdonerai per questa irruzione nella tua vita. Per quanto sia comoda, non ho mai superato la convinzione che la corrispondenza via e-mail sia in qualche modo meno educata e corretta di una lettera. Per la stessa ragione, non riesco a usare il telefono. Ma il tempo mi sta addosso, perciò non ho avuto altra scelta che scriverti un’e-mail. Sarò a Parigi fra pochi giorni e mi piacerebbe molto vederti finché sarò lì. Spero che i tuoi impegni te lo consentano. Ti prego, rispondimi e fammi sapere se mi incontrerai... Con affetto, Jonathan.» Mi scaraventai sulla sedia, con le dita sospese sulla tastiera. Che cosa rispondere? Avevo così tante cose imbottigliate dentro di me dopo decenni di silenzio. Voglia di parlare e nessuno con cui poterlo fare. Parole gettate ai muri, al cielo, ai piccioni, ai gargoyle appesi alla cattedrale di Notre-Dame. Grazie a Dio. Credevo che non ti avrei più sentito. Mi dispiace. Mi dispiace. Vuol dire che mi hai perdonato? Ti ho aspettato così a lungo. Non puoi immaginare cosa abbia provato quando ho visto il tuo nome sullo schermo. Mi hai perdonato? Esitai, strinsi entrambe le mani a pugno, le scossi, le riaprii, le scossi ancora. Le tenni sospese sopra la tastiera. Alla fine digitai semplicemente: «Sì». L’attesa di quel giorno fu un tormento unico. Cercai di tenere strettamente a bada le mie aspettative, ma era impossibile non abbandonarsi ai sogni dopo che Jonathan mi aveva contattato così all’improvviso. Sapevo bene che non avevo ragioni di nutrire speranze, ma c’era ancora una parte di me che cullava sogni romantici e selvaggi che riguardavano Jonathan. Era impossibile non sognare a occhi aperti, soltanto per provarne la gioia. Era passato tanto tempo dall’ultima volta in cui avevo avuto qualcosa da aspettare. Nella sua seconda e-mail Jonathan mi raccontò della sua vita. Aveva preso una laurea in medicina, in Germania negli anni Trenta, e l’aveva usata per recarsi in posti lontani e remoti dove praticare la medicina. Viaggiando con documenti sospetti, era più facile aggirare le autorità nelle zone più isolate, dove c’era bisogno di un dottore e gli ufficiali governativi erano più inclini a chiudere un occhio. Aveva lavorato coi lebbrosi nell’Asia Pacifica, con le vittime del vaiolo nel subcontinente indiano. Una febbre emorragica l’aveva condotto nell’Africa centrale ed era rimasto a guidare l’ospedale di campo in una zona di rifugiati vicino al confine con il Ruanda. Non è certo chirurgia a cuore aperto, mi scrisse: si tratta di ferite da sparo, dissenteria e vaccinazioni contro il morbillo. Qualsiasi cosa servisse, lui la faceva. Come potevo rispondere, se non confermandogli il luogo e l’ora in cui incontrarci? Mi emozionava e mi inquietava pensare che Jonathan era un dottore, un angelo per i sofferenti. Ma Jonathan si aspettava che gli dicessi come avevo vissuto da quando ci eravamo lasciati e, seduta davanti a quel computer, non sapevo cosa scrivere. Cosa potevo dirgli che non fosse imbarazzante? La mia vita era stata difficile dopo la nostra separazione. Per gran parte del tempo avevo vagato. La maggior parte delle cose che avevo fatto erano state meschine, stupide, cose che però al tempo credevo necessarie per la mia sopravvivenza. Ora, finalmente, ero in pace, conducevo una vita quasi monacale e non soltanto per scelta. Ma avevo imparato ad accettarla. Jonathan avrebbe notato la mia omissione, ma mi rassicurai dicendomi che mi conosceva bene e non avrebbe certo nutrito illusioni che fossi cambiata durante la nostra separazione, quanto meno non così drasticamente com’era cambiato lui. Perciò, la mia prima e-mail a Jonathan fu piena di frivolezze e smancerie: non vedevo l’ora di vederlo, di raccontarci un po’ di persona le nostre vite, cose così. A mano a mano che il giorno predestinato si avvicinava, cedetti a stupide aspettative, ingenue speranze. Nel caso in cui Jonathan avesse voluto vedere dove abitavo, chiesi alla governante di venire un po’ prima, acquistai un enorme bouquet di fiori, di quelli che non avrebbero stonato a un ricevimento di nozze reali. Riempii il frigorifero di champagne e presi in cantina un vecchio e pregiato cabernet. La notte precedente l’incontro, non riuscii a chiudere occhio. Rimasi alzata a guardarmi allo specchio. Gli sarei sembrata diversa? Esaminai il mio riflesso con la cura di un entomologo. Era pura nevrosi convincermi che ci fossero stati dei cambiamenti, illudermi di essere come le altre donne, quelle che si vedono nelle pubblicità televisive, che si preoccupano delle rughe ai lati della bocca e delle zampe di gallina attorno agli occhi. Sapevo benissimo che non c’erano stati cambiamenti. Avevo ancora l’aspetto di una studentessa universitaria con l’aria perennemente imbronciata. Lo stesso volto morbido e liscio che Jonathan aveva visto il giorno che mi aveva abbandonata. Carina, ma non bellissima: la rovina e allo stesso tempo la fortuna della mia vita, bella abbastanza da essere apprezzata ma non abbastanza da essere adorata. Avevo ancora l’ardore di una ragazza che non ne aveva mai abbastanza, del sesso, anche se al contrario avevo avuto abbastanza sesso da riempire più di una vita. Non volevo apparirgli affamata quando mi avrebbe vista, ma non c’era modo di evitarlo, come capii quando mi guardai allo specchio. Avrei sempre avuto una fame inestinguibile per lui. Sempre guardandomi allo specchio, mi chiesi se sarebbe stato strano, inquietante, rivedersi il giorno seguente esattamente identici, in mezzo a persone che per noi erano come neonati. Guardarci in volto sarebbe stato come fermare il tempo. Quanto tempo era passato da quando Jonathan mi aveva abbandonato? Centosessant’anni? Non riuscivo più nemmeno a ricordare l’anno esatto. Mi sorprese accorgermi di non provare più lo stesso straziante dolore che mi aveva assalito all’epoca. C’erano voluti decenni perché quella sofferenza divenisse una sorta di pulsazione sorda, di gran lunga superata dalla mia voglia di rivederlo. Riappoggiai lo specchio sul tavolino. Era ora di bere qualcosa. Aprii una bottiglia di champagne, freddo al punto giusto. Che senso aveva conservarlo per il giorno dopo, in nome di qualcosa che certamente non sarebbe mai accaduto? Il fatto che Jonathan mi avesse ricontattata dopo un’eternità di separazione era già un motivo più che sufficiente per festeggiare. Decisi di soffocare la mia speranza prima di ritrovarmi a cambiare le lenzuola o ad aggiungere degli asciugamani in bagno. Veniva a farmi visita, niente di più. Vediamoci nella lobby a mezzogiorno, mi aveva detto nella sua ultima e-mail. Io non stavo più nella pelle per l’attesa e presi in considerazione l’idea di accamparmi là fuori all’alba, se non di precipitarmi direttamente nella sua stanza. Ma sarebbe stato un gesto troppo patetico perfino per me. Meglio fingere di avere ancora un po’ di orgoglio e di sapermi controllare. Perciò, rimasi nel mio studio a osservare le lancette dell’orologio strisciare fino a indicare le undici, poi uscii, chiamai un taxi e mi feci portare all’Hôtel Prix St. Germain, con un’aria di distacco che dava una discreta idea di noncuranza. Dal finestrino posteriore del taxi, vidi il caratteristico vicoletto in cui abitavo scivolare via come il fondale di cartone dipinto di un carosello quando comincia la musica. Conoscevo l’Hôtel Prix St. Germain, ma non ci ero mai entrata. Era un vecchio albergo tranquillo, situato in una via poco frequentata sulla Rive Gauche, decisamente adeguato a un medico impegnato in Africa che si voleva trattenere a Parigi solo pochi giorni. L’aria nella lobby era stantia, e se avesse avuto un colore sarebbe stato il marrone. Dietro il bancone principale c’era un addetto dall’aria molto professionale e cupa che non mi perse di vista un attimo. Mi accomodai su una delle poltrone di pelle disposte a gruppetti nella lobby. Erano tutte così le lobby degli alberghi, come una stanza che trattiene il fiato? La poltrona che avevo scelto era di fronte al passaggio che portava dall’ingresso alla reception. Un vecchio orologio a muro appeso sopra la porta d’ingresso diceva: 11.48. Da giovane, Jonathan aveva stabilito la regola di farsi sempre aspettare. Ora che era un medico, immaginai che avesse imparato a essere più puntuale. Un vecchio quotidiano era appoggiato su un tavolino. Non essendo mai stata interessata agli accadimenti mondiali, raramente mi prendevo la briga di comprare un quotidiano in quei tempi. Gli eventi mi confondevano, mi sembravano sempre gli stessi. Quando guardavo i notiziari la sera sprofondavo in un disorientante senso di déjà vu. Un massacro in Africa? Era in Ruanda? No, un momento, quello era successo nel 1994. O nell’ex Zaire? O in Liberia? L’assassinio di un capo di Stato? Il tracollo dei mercati azionari? Un’epidemia di poliomielite, vaiolo, tifo... o era AIDS? Avevo attraversato immune tutti quegli eventi, osservando da spettatrice le piaghe che avevano afflitto l’umanità. Era terribile vedere tutta quella sofferenza, ma non ho mai avuto la capacità di cambiare le cose. Ero come un fantasma sullo sfondo della storia. Ma riuscivo a capire perché Jonathan fosse stato attratto dall’idea di diventare un medico e di imparare a fare qualcosa per porre rimedio, per quanto gli era possibile, ai mali del mondo. Rimboccarsi le maniche e darsi da fare, pur sapendo che era impossibile sconfiggere le malattie, anche in un solo villaggio... Eppure, l’importante era provarci, sempre, senza mai smettere. Senza rendermene conto, avevo tenuto lo sguardo fisso su quel giornale per tutto il tempo, assorta nei miei pensieri. Alzai lo sguardo di colpo, aspettandomi l’arrivo di Jonathan. La porta d’ingresso si aprì e io mi sporsi ansiosamente in avanti intravedendo quella che mi sembrava una fisionomia familiare, ma poi mi rilassai di nuovo. L’uomo indossava dei pantaloni kaki tutti spiegazzati e una giacca di tweed molto consunta. Una sorta di foulard a stampa etnica attorno al collo, occhiali da sole a coprirgli lo sguardo. E una barba lunga di almeno tre, quattro giorni, riccia e irregolare. L’uomo mi si avvicinò, con le mani in tasca. Sorrideva. Solo in quel momento capii. «È questo il tuo benvenuto per me? Non ti ricordi più del mio aspetto? Forse dovevo mandarti una fotografia» disse Jonathan. Uscimmo, dietro suggerimento di Jonathan. Disse che gli pareva che avessi bisogno di aria. Jonathan mi prese per il braccio e me lo tenne stretto, accompagnandomi fuori, sul marciapiede. Trovammo un angolino tranquillo in un parco fatto più che altro di cemento e panchine, con un albero solitario che spuntava da un basamento di pietra. Ma dava comunque l’illusione di trovarsi in mezzo alla natura. «È bello rivederti.» Non riuscii a rispondere, e comunque non era necessaria una mia risposta. Mi sembrava assurdo che fosse mancato dalla mia vita per così tanto tempo e ora, rivedendolo, credevo che nessuna ragione al mondo fosse sufficiente a tenerci distanti. Volevo toccarlo, baciarlo, sentire tutto il suo corpo sotto le mie mani per assicurarmi che fosse davvero lì, davanti a me in carne e ossa. Ma per quanto fossimo intimi, c’era più di un secolo a separarci. E c’era qualcosa nel suo modo di fare che mi fece capire che avrei dovuto procedere con cautela. Una volta che ripresi un po’ di colore in volto, trovammo un caffè e finimmo per rimanerci delle ore di fila. Tra tazze di caffè e calici di Lillet e sigarette (per me; Jonathan il dottore disapprovava), restammo in un angolo a raccontarci le nostre vite. I suoi racconti di quanto accadeva nel bush erano affascinanti e mi stupiva scoprire che lui potesse essere così felice in una terra tanto arida e deserta quanto il Maine era gelido e rigoglioso. O che riuscisse a stare dentro una tenda, come un eremita in meditazione, a riempire siringhe con pazienza infinita, incurante delle zanzare che lo tormentavano. La malaria, l’Uganda, che cosa gli importava di tutto quello? Si era offerto volontario per recarsi in una vallata afflitta da un’epidemia di febbre dengue. Aveva portato con sé antidiarroici e altre medicine, trasportandoli sulla schiena quando la Land Rover si era arenata in mezzo a un fiume. Per quanto ammirassi quello che faceva, tutti quei racconti sui pericoli che aveva corso volontariamente mi mettevano a disagio. «Come hai fatto a trovarmi dopo tutto questo tempo? Potevo essere ovunque nel mondo» gli chiesi alla fine. Da quando si era fatto vivo, morivo dalla voglia di chiederglielo. Lui fece un sorriso enigmatico e bevve un altro sorso del suo aperitivo. «È una storia strana. La risposta breve è: tecnologia. E fortuna. Ho pensato a lungo di cercarti, ma non sapevo come fare. La risposta mi è giunta quando ho visto un libro per bambini in casa di un collega...» «La pagoda di giada» tirai a indovinare. «La pagoda di giada» confermò sorridendo. «Leggendo quella favola al figlio del mio collega, ti ho riconosciuta nei disegni. Ho fatto qualche ricerca e ho scovato il nome della modella del pittore, Beryl Fowles, un’espatriata inglese che viveva a Shanghai...» «Ho sempre amato quel nome, me lo sono inventato io.» «... e così ho ingaggiato qualcuno che mi trovasse tutte le informazioni possibili su questa Beryl. Ma a quel punto, Beryl Fowles era scomparsa da decenni.» «Eppure mi hai scovata.» «Ho assunto un investigatore perché riuscisse a trovare chi aveva ereditato i soldi di Beryl, e così via, seguendo anello dopo anello la catena ereditaria, ma alla fine non venni a capo di nulla.» «Ma non ti sei arreso?» Jonathan sorrise ancora. «È a questo punto che entra in gioco la tecnologia. Conosci quel software di riconoscimento fotografico che oggi trovi su internet, quello che ti permette di rintracciare foto tue o dei tuoi amici nei siti? Be’, l’ho provato con una delle illustrazioni di quel libro e ha funzionato. Non è stato facile, ho dovuto insistere un po’, ma alla fine ho ottenuto un risultato, una piccola fotografia dell’autrice di una monografia sulle ceramiche cinesi antiche, pensa un po’... Non avrei mai immaginato che saresti diventata un’esperta di ceramiche cinesi. Comunque, è stato il tuo editore a dirmi dove potevo contattarti.» Si trattava delle ceramiche cinesi, affidatemi dal mio datore di lavoro a Shanghai, dove mi ero recata in cerca di un impiego dopo aver fatto da modella per quel libro per bambini. Perciò, era stata la mia ultima grande avventura in Cina a condurre Jonathan di nuovo da me. Fu nel tardo pomeriggio che finimmo a casa mia, dove bevemmo lo champagne e tre quarti del cabernet, accompagnato da pane tostato con foie gras. Su sua insistenza, mostrai la casa a Jonathan, con crescente imbarazzo a ogni stanza. Mi scoprii sorpresa io stessa dalla quantità di cose che avevo accumulato nel corso degli anni, ammassate a fare da barriera all’incedere impietoso ed eterno degli anni. Jonathan mi disse parole carine, lodò la mia previdenza nel conservare cose rare e preziose per le generazioni future, ma sapevo bene che stava soltanto cercando di mitigare il mio senso di colpa. Un medico missionario non viaggiava certo con un carico di chincaglierie come quello. Non c’erano magazzini o souvenir da nessuna parte ad attendere il ritorno di Jonathan. Mi capitò sott’occhio una scatola che non notavo da più di vent’anni ormai, piena di gioielli preziosi donatimi dai miei ammiratori: un anello con un rubino grande quanto un chicco d’uva, un fermacravatta impreziosito da uno stemma araldico con incastonato un diamante blu. La vista di tutto quel lusso mi diede la nausea e riposi la scatola nella libreria dimenticata dov’era rimasta a marcire per tanto tempo. Trovammo cose ben peggiori: c’era un vero e proprio bottino di guerra, cose che avevo portato via da luoghi lontani durante i miei anni errabondi e frenetici. Di certo Jonathan li riconobbe per quello che erano: statuette di Buddha squisitamente lavorate, tappeti fatti a mano con fili di venti colori diversi, armature cerimoniali. Tesori che avevo ottenuto in cambio di fucili o preso io stessa a mano armata o – in alcuni casi – sottratto a cadaveri. Me ne sarei liberata, giurai a me stessa in quel momento, richiudendo le porte di quelle stanze. Ogni oggetto e ogni statua sarebbero stati spediti a qualche museo o restituiti alle nazioni cui appartenevano. Come avevo potuto vivere così a lungo con quelle cose in casa mia, senza nemmeno pensarci? L’ultima stanza che visitammo fu la mia camera da letto all’ultimo piano. Aveva l’aria mesta di una stanza che da tempo non era più impiegata per il suo vero scopo. C’erano una testiera svedese e un letto di legno accanto a una serie di finestre alte e strette; sia le finestre sia il letto erano velati da teli di cotone bianco, mentre sul materasso era posato un copriletto di seta blu. Uno scrittoio francese del diciottesimo secolo serviva da tavolino per il computer, con le sue gambe storte; di fronte, una sedia Biedermeier. Il tavolo era coperto di fogli e soprammobili, mentre una vestaglia di seta grigia era poggiata sullo schienale della sedia. L’insieme dava l’impressione di una stanza in cui solo di recente erano stati tolti i teli per proteggere dalla polvere, come se tutto fosse rimasto sospeso nel tempo, in attesa. Jonathan si fermò davanti al dipinto appeso di fronte al letto. Il nome dell’artista si era perduto da tempo, ma ricordavo benissimo il giorno in cui era stato fatto lo schizzo. Jonathan non aveva voluto posare, ma Adair aveva insistito, così era ritratto come se si fosse accasciato controvoglia sulla sedia, scuro in volto e arrabbiato, ma di una bellezza mozzafiato. Era convinto che così avrebbe rovinato il ritratto ma in realtà l’aveva reso unico. Rimanemmo entrambi di fronte al quadro, eseguito quasi duecento anni prima. «Dopo tutti i tesori che hai ammassato in questa casa... Non riesco a credere che tu abbia tenuto anche questa stupidaggine» mormorò Jonathan. Quando vide lo sguardo ferito sul mio volto, si raddolcì e mi prese la mano. «Ma capisco perché l’hai fatto... e ne sono felice.» Gli lanciammo un ultimo sguardo prima di uscire da quella stanza. Venne la notte e trovò Jonathan sdraiato su un divano in salotto mentre io ero sul pavimento, appoggiata con la schiera al bracciolo di una poltrona. Per ore ci eravamo raccontati le nostre storie. Io mi ero arresa e gli avevo raccontato cose del mio passato di cui mi vergognavo, come le folli avventure che avevo inseguito insieme al pazzo che aveva preso il posto di Jonathan. Si chiamava Savva ed era uno di noi, uno dei primi compagni di Adair, l’unico degli altri che io abbia mai incontrato. Savva aveva avuto la sfortuna, molto tempo prima, di incontrare Adair dalle parti di San Pietroburgo, mentre era perso in una tempesta di neve. Savva non volle mai entrare nei dettagli in merito alla fine del suo legame con Adair, ma io riuscii a intuire qualcosa: Savva era di temperamento irrequieto e non sapeva tenere a freno la lingua. Dato che Savva non riusciva a stare a lungo in nessun posto, avevamo girovagato per i continenti, come esuli in fuga. Per essere un uomo nato tra la neve e i ghiacci, Savva era inspiegabilmente attratto dal calore e dal sole, per cui trascorremmo la maggior parte del nostro tempo nel Nordafrica e nell’Asia centrale. Viaggiammo con i nomadi attraverso il deserto, trasportando armi oltre il passo Khyber. Insegnammo ai beduini a sparare coi fucili e poi rimanemmo perfino a vivere con i mongoli per qualche tempo (erano rimasti particolarmente colpiti dalle abilità equestri di Savva). Rimanemmo insieme fino alla fine del diciannovesimo secolo, quando ci trovammo intrappolati dentro un hotel del Cairo a causa di una tempesta di sabbia. Non fu un diverbio a separarci. Non si trattò di uno spiacevole incidente che condusse a una lite alimentata da rancori seppelliti per anni. Semplicemente, ci rendemmo conto che non avevamo più niente da dirci. Probabilmente avremmo dovuto separarci decenni prima, ma era così facile e confortante stare con qualcuno che non aveva bisogno di spiegazioni. Ci sentivamo ancora ogni vent’anni o giù di lì, con una cartolina, una telefonata ubriaca, durante le vacanze magari, proprio come una vecchia coppia di divorziati. «E tu.» Colsi l’occasione per cambiare argomento, esausta dopo aver rievocato tutti quei ricordi. «Tu di certo non sei rimasto da solo per tutto questo tempo. Ti sei mai risposato?» Lui fece una smorfia, ma non disse niente. «Non dirmi che sei stato solo soletto tutti questi anni? Sarebbe troppo triste.» «No, non direi solo. È difficile essere da soli quando uno fa il medico in quei villaggi, dove tutti hanno un bisogno disperato delle tue attenzioni e sono così contenti che tu sia lì... Mi invitavano sempre a mangiare con loro, a partecipare alle loro cerimonie. A diventare parte della loro vita.» I suoi occhi si chiudevano sempre più spesso e il suo volto si rilassava sempre di più. Presi una copertina e gliela posai addosso, rimboccandogliela sulle spalle. Riaprì gli occhi per un istante. «Tornerò nel Maine. Voglio vederlo un’altra volta. È per questo che ti ho cercata, Lanny. Voglio che tu venga con me. Ci verrai?» Dovetti ricacciare indietro le lacrime. «Certo che verrò con te.» 48 Prendemmo uno di quegli aerei giganteschi per i voli intercontinentali per tornare in America. L’aereo non fece nemmeno in tempo a decollare da Orly che Jonathan si addormentò. Da New York prendemmo una coincidenza e con un volo interno giungemmo a Bangor, poi noleggiammo un’auto sportiva per salire verso nord. Era da due secoli che non vedevo quelle terre e, per quanto possa sembrare impossibile, c’erano lunghi tratti che mi sembrarono immutati. Per il resto, c’erano strade asfaltate, fattorie vittoriane, immensi campi di grano coltivati con straordinaria precisione geometrica, con le tubature di irrigazione che incombevano all’orizzonte, come giganteschi bruchi. Osservando quello spettacolo da dietro il parabrezza di quell’auto lussuosa, era facile illudermi di non essere mai stata lì. Poi la strada piegava attraverso le coltivazioni inoltrandosi nelle Great North Woods. Ci introducemmo nella penombra fredda della foresta, su una strada fiancheggiata da file e file di tronchi massicci, con il cielo nascosto da una coperta di foglie. La macchina procedeva a scossoni sulla strada irregolare, inerpicandosi e aggirando massi che sembravano spuntati a forza dal terreno, coperti di muschio. Quella parte sì che me la ricordavo. Mi bastò vedere quegli alberi per tornare indietro di duecento anni, sommersa dai ricordi della mia prima vita, la mia vera vita, quella che mi era stata tolta. Doveva essere lo stesso per Jonathan. Sentivamo entrambi che ci stavamo avvicinando a casa. Il viaggio era così veloce, fatto in automobile. L’ultima volta che l’avevamo fatto avevamo trascorso settimane intere su una carrozza, con Jonathan catatonico dopo quello che gli avevo fatto, a malapena capace di parlarmi. Ci avvicinammo al nostro villaggio di un tempo senza dirci una parola. Com’era cambiato tutto quanto. Non eravamo nemmeno sicuri che quella strada, la via principale che attraversava la città, fosse la stessa via polverosa che duecento anni prima conduceva le carrozze e i calessi a St. Andrew. Dov’era la chiesa? Dov’era il cimitero? E non avremmo dovuto poter vedere la sala congregazionale da lì? Guidai la macchina il più lentamente possibile, così che potessimo sovrapporre con la mente il villaggio che ricordavamo alla città che avevamo davanti. Per lo meno St. Andrew non era ancora diventata come tutte le altre città dell’America, dove ogni negozio, ristorante e albergo è parte di una catena multinazionale, uguale in tutto il mondo. Per lo meno St. Andrew aveva conservato un po’ di originalità, anche se aveva perduto lo scopo originario della sua fondazione. Non era più una cittadina così industriosa. Le fattorie che un tempo erano sparse qua e là erano scomparse e non avevamo visto alcun segno del commercio di legname per miglia e miglia. Al suo posto, sembrava aver preso piede l’industria turistica. Negozi di attrezzatura da escursione si allineavano lungo entrambi i lati della strada: uomini bianchi, lindi e puliti ma vestiti da campagnoli che radunavano altri uomini e donne e li guidavano in tour nelle foreste o in canoa sul fiume Allagash. Oppure li portavano nel bel mezzo del fiume armati soltanto di salvagenti, lasciandoli a pescare per tutto il giorno fino a tirar su un bel pesce che avrebbero ammirato per poi rigettarlo in acqua. C’erano negozi di artigianato e locande là dove un tempo c’erano fattorie e granai, dove c’erano la forgia di Tinky Talbot e la drogheria dei Watford. Rimanemmo sconvolti quando alla fine capimmo che la sala della congregazione era stata demolita e il centro città ora era occupato da un ferramenta, una gelateria e un ufficio postale. Per lo meno il cimitero l’avevano risparmiato. La nuova generazione di abitanti di sicuro riteneva quel posto molto piacevole, e se non avessi saputo com’era stato due secoli prima, non avrei avuto nulla da obiettare. Ma ora la città sopravviveva accontentando i capricci dei turisti e mi sembrava degradata. Era come tornare e scoprire che la casa della tua infanzia era stata trasformata in un bordello, o peggio, un supermercato. St. Andrew aveva venduto l’anima in cambio di una vita più semplice, ma chi ero io per giudicare? Prendemmo una stanza in un capanno da caccia fuori città; quello dei Dunratty era un vecchio motel, scalcagnato e palesemente segnato dall’incuria, che accoglieva i cacciatori e i pescatori che venivano lì a fare la stagione. Era un posto da uomini, perciò c’era da attendersi una certa austerità. C’erano circa dieci camere una in fila all’altra, dietro alla reception. Chiedemmo un capanno, possibilmente quello più vicino alla foresta. Il custode non disse niente, si accertò con discrezione che non avessimo fucili o canne da pesca e, non vedendone, tornò indietro, rassegnato, alle sue faccende. Ci chiese se eravamo sposati, come se si preoccupasse veramente che uno dei suoi scalcagnati capanni potesse essere usato come nido d’amore. Ci disse che c’eravamo soltanto noi, tutte le altre stanze erano vuote. Sarebbe stato tutto molto tranquillo. Lui era disponibile se avevamo bisogno di qualcosa, bastava chiamarlo a casa – e indicò vagamente in una direzione imprecisata – ma per il resto eravamo da soli. Era un posto triste, quattro pareti coperte di miseri pannelli e il soffitto con una semplice copertura di compensato. La camera era quasi interamente occupata da due letti – poco più larghi di un singolo, ma più piccoli di un matrimoniale, con testiere in ferro battuto risalenti alla Grande Depressione – divisi da una minuscola credenza al posto di un comodino, con sopra una lampada in ceramica. Due sedie di metallo senza cuscini erano posate di fronte a un televisore che aveva almeno trent’anni. Da un lato c’era un piccolo tavolo contornato da tre sedie da cucina in legno, senza braccioli. Oltre una porta trovai un cucinotto piuttosto funzionale, e dietro un’altra porta c’era un bagno che odorava leggermente di muffa. Quando Jonathan buttò le valigie sul letto scoppiai a ridere. «Non vorrai veramente fermarti qui?» gli chiesi incredula. «Ci dev’essere un posto più carino. Forse in città...» Jonathan non disse niente. Si mise in piedi davanti a una porta scorrevole che dava su un patio di legno grezzo. Oltre, c’era soltanto la foresta: tronchi imponenti, larghi, che torreggiavano su di noi, scricchiolando nel vento. Aprimmo la porta e ci incamminammo nella foresta, e l’aria tersa ci accarezzò. Tornammo subito sul patio e rimanemmo a osservare la foresta infinita per un tempo altrettanto infinito. Quella era casa nostra. Ci aveva trovato. «Rimaniamo qui» disse infine Jonathan. Uscimmo verso le cinque di quel pomeriggio, ansiosi di vedere qualcos’altro prima del tramonto. Tuttavia, era difficile orientarsi: strade che dovevano condurre in una direzione ci portavano inaspettatamente in quella opposta, come se la città fosse stata fatta e rifatta innumerevoli volte nel corso del tempo. La nuova pianta urbana era stata progettata dalle industrie del legname e attraversava miglia e miglia di foresta senza alcuna ragione apparente, portando direttamente a un’autostrada, che a sua volta portava all’incrocio fra l’Allagash e il St. John. Dopo un paio di false partenze, incrociammo una strada che ci ricordava il sentiero che portava alla casa di Jonathan, e fu con un muto cenno di assenso che concordammo di percorrerla fino in fondo. Dopo un tunnel di rami intrecciati uscimmo in uno spiazzo che un tempo era stato il campo di fieno davanti alla magione dei St. Andrew. La strada era stata spostata, non passava più dal canale accanto alla ghiacciaia e poi su fino alla grande casa. Ma riconobbi la forma del terreno. Ora, una strada sterrata per il trasporto del legname passava direttamente sul lato destro della casa, che dava sullo strapiombo. Aumentammo la velocità, ansiosi di rivederla. Ma a mano a mano che ci avvicinavamo, iniziai a rallentare. La casa c’era ancora, ma solo qualcuno che ci aveva vissuto sarebbe stato in grado di riconoscerla. Quella magione un tempo sontuosa era stata abbandonata a marcire. Era come un cadavere lasciato alla furia degli elementi, uno scheletro che ancora conservava quei tratti che appena bastavano a riconoscere la fisionomia di un tempo. Era cadente, scrostata, priva di tegole in diversi punti e di assi sul fronte e sulle pareti. Anche i pini che un tempo servivano per rompere il vento sulla parte anteriore dell’edificio stavano morendo, sembravano vedovi dimenticati, come gli alberi che si trovano nei cimiteri. «È abbandonata» disse Jonathan. «Chi l’avrebbe mai potuto...» iniziai, ma non sapevo bene che cosa dirgli. «Su, dai, Jonathan. Per lo meno l’hanno lasciata dov’era. Hai visto il punto in cui c’era la casa della mia famiglia? Ora c’è un incrocio. Il mondo va avanti, no?» Nonostante i miei tentativi di alleggerire l’atmosfera, Jonathan cadde in un profondo silenzio. Girammo l’auto e tornammo in città. Quella sera cenammo in un piccolo ristorante in centro. L’unico motivo per cui si poteva definire un ristorante era che lì si poteva comprare da mangiare, ma non era certo il tipo di locale che ero solita frequentare. Assomigliava più a una trattoria, con una decina di tavoli di formica circondati ognuno da quattro sedie di metallo tubolare. Le tovaglie erano di carta, così come i tovaglioli. I menu erano coperti di plastica ingiallita e avrei potuto scommettere che erano gli stessi da almeno vent’anni. C’erano cinque clienti, inclusi me e Jonathan. Gli altri tre erano uomini in jeans, camicia di flanella e cappellino da baseball o roba simile, tutti seduti a tavoli separati. La cameriera probabilmente era anche la cuoca. Ci guardò severa porgendoci i menu, come in dubbio se servirci o no. La radio trasmetteva un leggero sottofondo di musica country. Ordinammo cibo che nessuno di noi due mangiava da tempo immemorabile, ammesso che mai l’avessimo mangiato. Filetti di pesce gatto alla griglia, pollo e gnocchi, cibo che ci parve perfino esotico tanto era strano. Prendemmo due bottiglie di birra e parlammo poco, sempre con l’impressione che gli altri origliassero. La cameriera – con i capelli tirati su tipo filo spinato e il volto rincagnato – guardò il cibo sbocconcellato che avevamo lasciato nei piatti prima di chiederci se desiderassimo altro. «La torta è buona» disse secca, come se stesse parlando del clima. «Ti ha deluso tanto rivedere la tua casa?» gli chiesi dopo che la cameriera ci piazzò davanti altre due birre. Jonathan scosse il capo. «Dovevo aspettarmelo. Tuttavia, non ero preparato.» «È tutto così diverso, ma in un certo senso, è tutto uguale. Mi sento fuori luogo, qui. Se non ci fossi tu qui con me, me ne sarei già andata.» Uscimmo dal ristorante e passeggiammo in strada. Era tutto chiuso, a parte un piccolo bar che, a giudicare dalla minuscola insegna al neon a forma di mezzaluna, si chiamava Blue Moon. Sembrava un posto romantico, ma osservando dalla vetrina vidi che era pieno di uomini: camionisti e taglialegna che guardavano una partita alla televisione. Dopo esserci lasciati alle spalle la zona commerciale, giungemmo al cimitero. La luna era abbastanza chiara per farci strada fra le tombe. Era diventato selvatico e pieno di erbacce. Cespugli di more, ortiche e macchie di muffa avevano coperto il muro di cinta e inghiottito alcune delle pietre tombali. Anni di gelo e disgelo avevano frantumato alcune lapidi, mentre altre erano state erose dal tempo o rotte da qualche vandalo. Mi inoltrai velocemente, poiché non volevo rivedere i miei vecchi compaesani in quel modo, ma Jonathan se la prese calma, passando di tomba in tomba cercando di leggere i nomi iscritti e le date, scostando le erbacce che li coprivano. Sembrava così triste e avvilito che dovetti reprimere l’istinto di afferrarlo per un gomito e trascinarlo via di lì a forza. «Guarda, questa è quella di Isaiah Gilbert» mi chiamò. «È morto nel... 1842.» «Un bel po’ di tempo. Ha avuto una vita lunga, allora» commentai dal punto in cui mi trovavo, mentre cercavo di calmare i ricordi e un vago senso di vertigine fumandomi una sigaretta. Jonathan si era avvicinato a un’altra tomba. Si accucciò sui talloni, guardandosi attorno. «Mi chiedo se tutti quelli che conoscevamo siano qui, da qualche parte.» «Qualcuno sarà anche andato via da qui. Hai visto qualche tomba della mia famiglia?» «Ma non dovrebbero essere nel cimitero cattolico dall’altra parte della città?» mi chiese, incamminandosi lungo un corridoio e scrutando tomba dopo tomba. «Dopo se vuoi possiamo andarci.» «No, grazie. Non ho più nessuna curiosità in tal senso.» Capii che Jonathan aveva trovato qualcosa di significativo quando lo vidi inginocchiarsi accanto a una lapide doppia. Era di pietra grezza, segnata dal tempo, e da dove mi trovavo non potevo leggere l’iscrizione. «Di chi è?» gli chiesi avvicinandomi. «Di mio fratello.» Le sue dita sfiorarono le iscrizioni. «Benjamin.» «Ed Evangeline» aggiunsi, sfiorando l’altra lapide. Evangeline St. Andrew. Moglie adorata. Madre di Ruth. «Così si sono sposati, alla fine.» «Per mantenere l’onore della famiglia?» gli chiesi, strofinando le lettere con le dita. «A quanto pare, lei non è vissuta a lungo.» «E Benjamin è stato seppellito accanto a lei. Quindi non si è mai risposato.» Nell’ora seguente rintracciammo quasi tutta la famiglia di Jonathan. Prima sua madre e poi, alla fine, anche sua figlia, Ruth. L’ultima St. Andrew della città. Le sorelle di Jonathan non c’erano, però, il che lo indusse a sperare che si fossero sposate e fossero andate via di lì, che avessero avuto famiglie felici e ricche da qualche altra parte e che ora giacessero nel terreno accanto ai loro mariti in un posto più allegro di quello. Forse erano riuscite a scappare dalla malinconica St. Andrew. Ricondussi Jonathan nel capanno. Mi ero portata dietro due bottiglie di squisito cabernet dalla Francia, nascoste nella valigia. Ne stappammo una e la lasciammo respirare sul tavolo, intanto che ci sdraiavamo insieme sul letto. Tenni Jonathan stretto a me finché il suo corpo smise di essere gelido e poi lo spogliai. Ci infilammo sotto le vecchie lenzuola di cotone, sorseggiando il cabernet e chiacchierando della nostra infanzia, dei nostri fratelli e sorelle e amici e nemici. Di tutte le persone che giacevano a decomporsi mentre noi, inspiegabilmente, eravamo ancora vivi. Ancora non riuscivo a sopportare l’idea di confessargli la verità su Sophia. Invece, parlammo di tutte le persone cui avevamo voluto bene finché Jonathan, cullato dal vino e dalle parole, non si addormentò. Fu solo in quel momento che piansi, per la prima ma non ultima volta. 49 Non c’erano più posti dove andare per rivivere il passato: nessun cimitero da visitare, nessun sentiero un tempo familiare ma ora evanescente e inutilizzato da ripercorrere. Camminando lungo l’Allagash, avvistando di tanto in tanto dei cervi e dei daini, ammirando la luce del sole che splendeva sul Maine in quella stagione. Ammirammo quello che c’era, invece di abbandonarci ai ricordi di quello che c’era stato, in quel punto o in un altro. Trascorremmo il resto del tempo godendo della compagnia reciproca. Il tempo passato insieme però stava diventando come una droga di cui mi stavo intossicando, non riuscivo ad averne abbastanza e iniziai a pensare che forse ci potevamo perdere qui, dove tutto era iniziato. Forse Jonathan sarebbe stato felice di rimanere in un posto che conosceva. Non eravamo costretti a vivere per forza a St. Andrew; dato che la città era così cambiata, sarebbe stato spiazzante abitarci. Ma potevamo comprare del terreno nella foresta e costruirci un capanno, dove avremmo vissuto lontani da tutto e tutti. Senza giornali, senza orologi, senza il ticchettio insistente del tempo che ci picchietta sulle spalle, risuonandoci nelle orecchie. Senza dover scappare dopo sessant’anni in un posto per riemergere con un altro nome in un altro posto, oppure fingere di essere una nuova persona, proprio come un pulcino appena uscito dall’uovo, ma con dentro il peso della persona che sapevo di essere e della quale non avrei mai potuto liberarmi. Una notte eravamo sul patio dietro quel malconcio capanno, stretti nei cappotti, su due sedie pieghevoli, a bere vino e a guardare la luna piena. Jonathan diresse la conversazione sul nostro passato e la cosa mi inquietò. Si chiedeva se Evangeline avesse avuto una vita dura e infelice dopo la sua scomparsa e se fosse stato lui la causa della morte precoce della madre. Gli ripetei infinite volte che mi dispiaceva, ma Jonathan non voleva sentire le mie scuse, scuoteva la testa e diceva che, no, era stata colpa sua, si era comportato in modo orribile con me, aveva approfittato dell’amore che provavo per lui, che era così evidente. Scossi il capo a mia volta, posandogli una mano sul braccio. «Ma io ti volevo così tanto, non capisci? Non è stata tutta colpa tua.» «Torniamo ancora in quel posto, Lanny» disse Jonathan. «Quel posto fra gli alberi dove ci incontravamo di solito, sotto la volta di alberelli di betulla. Ci ho pensato spesso, sai? È il posto più bello del mondo, per me. Credi che sia ancora così? Non lo sopporterei se li avessero tagliati.» Un po’ malfermi e riscaldati dal vino che avevamo bevuto, salimmo sul SUV, anche se dovetti tornare nel capanno per prendere una coperta e una torcia. Tenni la bottiglia di vino aperta stretta al petto mentre Jonathan guidava tra gli alberi. A un certo punto fummo costretti a parcheggiare e a proseguire per circa un chilometro a piedi. Trovammo la radura, ma era cambiata. Le betulle erano cresciute, ma soltanto fino a un certo punto, poi si erano fermate. I loro rami più in alto ora si intrecciavano, a formare una tenda che ombreggiava i rametti che avevano cercato di seguire il loro esempio. Mi ricordavo quella radura, dove ci incontravamo da bambini per ridere e raccontarci storie che allietassero le nostre vite solitarie, ma il tempo passato aveva portato via con sé la bellezza unica di quei momenti. La radura non era più un luogo segreto e magico: era soltanto un altro pezzo di foresta, niente di più e niente di meno. Stesi la coperta sul terreno e ci sdraiammo sulla schiena, cercando di sbirciare tra le foglie e i rami per vedere il cielo notturno, ma c’erano soltanto pochi spiragli da cui spuntavano le stelle. Provammo a fingere che fosse proprio quello il posto in cui venivamo da piccoli, ma sapevamo entrambi che forse era cinque metri più in là, o cento metri più in giù. In poche parole, era un posto come un altro in quella foresta in cui sdraiarsi a guardare le stelle. Ripensare alle nostre infanzie mi portò alla mente il peso che mi ero tenuta dentro per tutto quel tempo. Era giunto il momento di dire a Jonathan la verità su Sophia. Un segreto più è vecchio e più è potente, tuttavia ero terrorizzata dalla reazione che Jonathan avrebbe potuto avere. Ci eravamo ritrovati, eppure quel segreto svelato avrebbe potuto separarci di nuovo, quella notte stessa, e forse, stavolta, sarebbe stato per sempre. Quelle paure mi indussero quasi a cambiare nuovamente idea, ma non potevo continuare a portare quella spada di Damocle. Dovevo confessare la verità. «Jonathan. C’è una cosa che ti devo dire da tempo. Si tratta di Sophia.» «Mmm?» Si irrigidì un poco. «È stata colpa mia se si è uccisa. Solo colpa mia. Quando mi hai chiesto se ero andata da lei a parlarle, ti ho mentito. Sono andata da lei e l’ho minacciata. Le ho detto che sarebbe stata la sua rovina se avesse tenuto il bambino. Le ho detto che tu non l’avresti mai sposata, che non volevi più avere niente a che fare con lei.» Avevo sempre creduto che sarei scoppiata a piangere, confessandogli la mia colpa, ma non lo feci. I miei denti iniziarono a battere. Lui si voltò verso di me, ma al buio non riuscivo a distinguere la sua espressione. «E hai aspettato tutto questo tempo per dirmelo?» «Ti prego, perdonami. Ti prego, ti prego...» «Va tutto bene. Davvero. Va tutto bene. Ci ho pensato a lungo nel corso degli anni. È strano come il tempo ti porti a vedere le cose diversamente. All’epoca, non avrei mai creduto che i miei genitori avrebbero acconsentito a farmi sposare Sophia. Ma come avrebbero potuto fermarmi? Se li avessi minacciati di lasciare la famiglia per stare con Sophia e il bambino, non avrebbero certo potuto ripudiarmi. Si sarebbero arresi: c’ero soltanto io che potevo mandare avanti gli affari di famiglia e prendermi cura di Benjamin e delle mie sorelle, dopo la morte dei miei. Solo che in quel momento non riuscivo a vedere che le cose stavano così. Non sapevo cosa fare, e sono venuto da te. Ed è stato ingiusto, ora lo capisco. Perciò... È anche colpa mia se Sophia si è uccisa.» «Ma tu l’avresti sposata?» «Non so. Forse sì, per il bene del bambino.» «La amavi?» «È successo tanto tempo fa. Non ricordo cosa provavo esattamente.» Forse diceva la verità, ma non capì che quella risposta mi fece letteralmente impazzire. Ero certa che vedesse le donne della sua vita in una sorta di classifica e volevo sapere che posizione occupavo, chi c’era davanti a me e chi dietro. Volevo che la nostra relazione, così complicata, diventasse più semplice: di certo gli anni che passano aiutano a chiarire le cose, no? E a quel punto Jonathan doveva aver capito una volta per tutte quello che provava per me. Rimasi seduta, senza nemmeno sfiorarlo, il che mi rese nervosa. Avevo bisogno di una carezza rassicurante, per avere la certezza che non mi odiasse. Anche se non mi incolpava per la morte di Sophia, forse le cose terribili che avevo fatto lo disgustavano. «Hai freddo?» gli dissi. «Un po’. E tu?» «No. Ma posso stare vicina a te lo stesso?» Mi tolsi il giubbotto e lo stesi su di noi. I nostri respiri si univano sopra di noi formando nuvolette bianche, come uno spettro nella notte scura. «Hai le mani gelide.» Gli presi una mano e soffiai fiato caldo sulle sue dita prima di baciarle una a una. Gli misi una mano sulla guancia. «Anche il tuo volto è gelido.» Non si oppose. Strofinai il mio viso sulla sua barba rada, sul suo bellissimo naso sottile, sulle sue palpebre delicate. Non mi fermò. Gli aprii i vestiti fino a scoprirgli il petto e il ventre. Poi mi spogliai e mi misi sopra di lui, con la fodera di flanella del mio giubbotto che mi carezzava le natiche. Facemmo l’amore su quella coperta sotto le stelle. I movimenti del sesso erano gli stessi, ma c’era qualcosa di diverso. Fu tutto più lento e tenero, quasi cerimoniale, ma come potevo lamentarmi? L’impeto della nostra passione giovanile era scomparso, rimpiazzato da qualcosa di simile all’amore. Che però mi lasciò triste, comunque. Era come se ci stessimo dicendo addio. Quando finì, con me a cavalcioni su di lui, Jonathan sospirò nel mio orecchio e si tirò su i pantaloni fino in vita. Io presi una sigaretta. Esalai un tenue filo di fumo nell’aria fredda, mentre i polmoni mi si riempivano di calore, calmandomi il respiro. Continuai a fumare, mentre Jonathan mi accarezzava i capelli. Mi ero chiesta che cosa sarebbe accaduto alla fine del nostro viaggio. Jonathan non mi aveva detto niente e io non ero sicura di quando dovesse terminare. I biglietti aerei erano open e Jonathan non mi aveva detto entro quando sarebbe dovuto tornare al campo profughi. Ma una cosa era certa, quel viaggio non poteva durare ancora molto: non era stato altro che una serie di delusioni, inframmezzate da sogni a occhi aperti stile «e vissero felici e contenti». Non aveva fatto altro che ricordarci tutto quello che avevamo perduto. Solo gli alberi e quel magnifico cielo ci avevano accolto con familiarità. E non riuscivo a scacciare il sottile dubbio di essere proprio io la causa della malinconia di Jonathan. Forse ero io ad averlo deluso. O forse era lui che non era riuscito a perdonarmi. Non avevamo ancora parlato del motivo per cui mi aveva abbandonato, anni prima, e immaginavo di saperne la ragione: dopo anni di frustrazioni e di recriminazioni, era stufo di continuare a deludermi. Ma stavolta non si trattava di rimanere insieme per sempre; stavolta c’era in sospeso qualcosa di diverso, fra di noi. Qualcosa di irrisolto, ma non riuscivo a intuire cosa. Jonathan voleva stare con me, questo era evidente, altrimenti non mi avrebbe chiesto di fare quel viaggio con lui. Se fosse stato ancora arrabbiato non mi avrebbe mai contattato, non mi avrebbe mai scritto quell’e-mail, non avremmo bevuto champagne, non avrebbe baciato il mio volto, non mi avrebbe consentito di cullarlo a letto. Al suo fianco perdevo ogni sicurezza, come era sempre stato; il mio amore era come un macigno appeso al collo. «Che cosa facciamo domani?» gli domandai, con aria casuale, spegnendo la sigaretta per terra. Jonathan inarcò il mento verso le stelle e chiuse gli occhi. «Be’, allora» proseguii quando vidi che non aveva intenzione di rispondermi, «quanto vorresti trattenerti ancora? Non voglio metterti fretta, sia chiaro. Rimaniamo quanto vuoi.» Lui fece un lento sorriso, ma ancora non rispose. Mi misi sul fianco, accanto a lui, appoggiando la testa a una mano. «Hai pensato a cosa faremo dopo? A... A noi?» Finalmente aprì gli occhi, sbattendo le palpebre. «Lanny, c’è una ragione se ti ho chiesto di venire qui con me. Non hai ancora capito quale?» Scossi il capo. Lui afferrò la bottiglia di vino, si rialzò appoggiandosi a un gomito e bevve, poi me la passò. Ne era rimasto pochissimo. «Sai perché ho voluto che tornassimo proprio qui?» Scossi ancora il capo, muta. «L’ho fatto per te.» «Per me?» «Speravo ti rendesse felice tornare qui con me, che in un certo senso avrebbe compensato almeno in parte il modo in cui ti ho abbandonato. Questo viaggio non è stato per me: per me è stato un inferno, tornare. E me lo aspettavo. Ho sempre sperato di poter rimediare a quello che avevo fatto alla mia famiglia, a mia madre, a mia moglie, a mia figlia. Morte pensando che le avessi abbandonate. Darei qualsiasi cosa per tornare indietro.» Come poteva cambiare così rapidamente? Come poteva essere così cattivo con me? Sentii come se una gelida barriera invisibile fosse calata fra di noi. «Non è stata colpa tua» dissi, come se non sapessimo entrambi di chi era la colpa. Non me la sentivo di bere altro vino, perciò gli passai la bottiglia. «Ma a che cosa serve riparlarne adesso, Jonathan? Non c’è niente che io o te possiamo fare per tornare indietro. Il passato è passato.» «Il passato è passato, già...» ripeté prima di scolare a fondo la bottiglia. Il suo sguardo si perse nell’oscurità e capii che faceva apposta a non guardarmi. «Sono così stanco di tutto questo, Lanny. Non riesco più a continuare in questo modo, non sopporto più l’infinita successione dei giorni, uno dopo l’altro in un nastro senza fine... Ho cercato in ogni modo possibile di trovare un senso, qualcosa che mi facesse tirare avanti.» «Ti prego, Jonathan. Non dire così, ora sei ubriaco e stanco...» La bottiglia di vino affondò nel terreno molle quando Jonathan vi si appoggiò sopra. «So benissimo quello che dico. È per questo che ti ho chiesto di venire qui con me. Sei l’unica che può aiutarmi.» Sapevo dove stavamo andando a parare. La vita è un cerchio e anche le parti peggiori ritornano, prima o poi, a tormentarti. Avevamo avuto quella discussione ogni notte per mesi di fila – o forse anni? – prima del suo abbandono. Mi aveva tormentata, implorata, minacciata. Era quella la vera ragione per cui era partito, non perché non sopportasse più di deludermi, ma perché mi rifiutavo di dargli l’unica cosa che voleva con tutto se stesso. Quel suo unico desiderio rimaneva sospeso fra di noi. Era l’unico modo in cui poteva fuggire da tutto quello che voleva dimenticare per sempre: le responsabilità tradite, un figlio mai nato e una figlia abbandonata, il tradimento della persona che più lo amava. C’era un solo modo per far scomparire tutto quel gravame dalla sua coscienza. «Non puoi chiedermi di farlo. Abbiamo entrambi convenuto che si tratta di una cosa troppo orribile da chiedermi. Non puoi lasciarmi da sola con...» «Ma non credi che io meriti di essere liberato, Lanny? Mi devi aiutare.» «No. Non posso.» «Vuoi che ti dica che me lo devi?» Quelle parole mi ferirono perché non me le aveva mai dette prima, mai, nemmeno una volta. In qualche modo era riuscito a non gettarmele addosso, pur essendo parole che mi meritavo pienamente. Me lo devi perché sei stata tu a farmi questo. È la tua maledizione quella che pende sul mio capo. «Come puoi dire così?» urlai angosciata, pronta a ritorcergliele contro, pronta a ferirlo e a farlo sentire orribile così come lui aveva fatto sentire orribile me. «Come puoi dire così proprio tu, che mi hai abbandonata e mi hai lasciata a tormentarmi tutti questi anni?» «Ma tu non eri sola. In qualche modo, io sono sempre stato con te. Dovunque ti trovassi, dentro di te sapevi che io ero da qualche parte, nel mondo, ma c’ero.» Jonathan si rialzò da terra con qualche sforzo. Sembrava esausto, il capo gli ciondolava a ogni respiro. «Le cose sono cambiate per me. C’è una cosa che ti devo dire, Lanny. Non avrei voluto. Non vorrei mai farti soffrire, ma ho bisogno che tu capisca perché sono tornato a chiedertelo. Perché adesso per me è così importante.» Fece un profondo respiro. «Mi sono innamorato.» Si fermò, aspettandosi che reagissi male alla notizia della cosa più bella che gli era accaduta in tutta la sua vita. Aprii la bocca per congratularmi ma, naturalmente, non uscì niente. «Una donna ceca, un’infermiera. Ci siamo conosciuti in un campo profughi. Lei lavorava per un’altra organizzazione non profit. Un giorno l’hanno convocata a Nairobi all’ufficio centrale per una riunione. Mentre ero nel bush, ho sentito la notizia alla radio. C’era stato un incidente automobilistico in città. Era morta. Impiegai un giorno a trovare un elicottero che mi conducesse a recuperare il suo corpo. Eravamo insieme da pochi anni. Non riuscivo a credere all’ingiustizia che avevo subito. Mi ci era voluta una vita, più vite anzi, per trovare la persona fatta per me ed ero riuscito ad averla soltanto per così poco tempo.» Parlò sommessamente, senza troppo dolore, forse per riguardo nei miei confronti. Ma comunque, mentre lo ascoltavo mi si contorsero le budella, sempre di più. «Adesso capisci? Capisci perché non posso continuare così?» Scossi il capo, determinata a essere decisa, dura, nonostante la sua sofferenza. «Non voglio ferirti» disse. «E so che comprendi benissimo la mia sofferenza. Vuoi che ti racconti di quant’era meravigliosa? Di come non potevo fare altro che amarla con tutto me stesso? Di come sia impossibile continuare a vivere senza di lei?» «Succede ogni giorno» riuscii a dire. «Il tempo passa, uno dimentica. È facile.» «Non ci provare. Non con me, non funziona. Io lo so come stanno le cose veramente. E anche tu.» Forse in quel momento mi stava davvero odiando un po’. «Non posso più andare avanti così. Non riesco a sopportare di averla persa, non riesco ad accettare che non ci sia niente, niente che io possa fare per smettere di soffrire così atrocemente. Impazzirò, impazzirò intrappolato per sempre dentro questo corpo. Non puoi condannarmi a questo destino. Ho resistito finché ho potuto perché lo so, lo so, che è una cosa tremenda da chiederti. Non avrei voluto parlarti di lei in modo così... brusco. Ma mi hai forzato la mano, e ora che te l’ho detto... Non posso tornare indietro. Ecco, adesso sai cosa voglio da te. Devi aiutarmi.» Prese la bottiglia di vino e la schiantò contro una roccia. I frammenti di vetro caddero a terra in una litania di note alte e aspre, che si librarono attorno a noi. Afferrò la bottiglia rotta per il collo; nel suo pugno stretto sembrava un bouquet di fiori di vetro verde. Era l’unica arma a disposizione. Era uno strumento rude e violento, e voleva che lo usassi su di lui. Voleva che lo facessi sanguinare a morte. Non puoi lasciarmi sola, sola senza di te. Avrei voluto dirgli così, ma non potevo. Mi aveva opposto l’unica argomentazione che avesse il potere di convincermi: aveva perso il suo amore e non poteva andare avanti a vivere. Era giunto il momento di lasciarlo andare, alla fine. Non riuscivo a parlare. Capii che stavo piangendo solo perché le lacrime che mi scendevano sulle guance si ghiacciavano al vento freddo, incendiandomi la pelle. Lui alzò una mano e con un dito raccolse le mie lacrime. «Perdonami, Lanny. Perdonami se siamo arrivati a questo punto. Mi addolora non essere mai riuscito a darti quello che volevi. Ci ho provato. Non hai idea di quanto avrei voluto farti felice, ma non ci riuscivo. E tu meriti di essere amata dell’amore che hai sempre sperato di avere. Spero e prego che prima o poi tu riesca a trovare quell’amore.» Lentamente, presi la bottiglia rotta dalle sue mani. Jonathan si tolse la camicia e si offrì a me, e io guardai prima la mia mano, poi il suo petto pallido, dai riflessi blu sotto la luce della luna. Il nostro doveva essere l’amore di una vita. Ci inginocchiammo uno davanti all’altra, tremando non per il freddo ma perché eravamo giunti all’inevitabile. Non riuscii nemmeno a guardarlo: mi spinsi addosso a lui, sapendo che il bordo tagliente della bottiglia avrebbe fatto il resto. Gli spigoli verdi taglienti si insinuarono nella sua carne, disegnando un morso perfettamente circolare, morbido e cedevole. La bottiglia affondò con facilità e mi ritrovai le mani coperte dal sangue di Jonathan. Si lasciò sfuggire un flebile sospiro e nulla più. E poi colpii forte con la mano e comparvero tre linee rosse sul biancore della sua pelle. Le ferite, profonde, si aprirono ancora di più e ancor più sangue fluì. Jonathan si accasciò, cadendo sul petto e poi rotolando sulla schiena, le mani posate mollemente sulle ferite, con il sangue che gli zampillava fra le dita. La cosa che mi colpì di più fu che la sua carne aveva ceduto così facilmente. Continuai ad aspettarmi che i margini della ferita si avvicinassero, ma non accadde. Così tanto sangue. Svegliati, mi sentii dire, ma come a miglia e miglia di distanza. Devi svegliarti. E poi mi svegliai nel folto della foresta, mentre l’uomo che amavo si contorceva al mio fianco, in preda alle convulsioni, rotolando nel fango, tossendo, soffocando. Ma sempre sorridendo. Il suo petto si alzava e si abbassava con quello che sembrava uno sforzo disumano, e mi resi conto che avevo già visto quella scena, nel granaio dei Daughtery, dopo che gli avevano sparato. In un lampo fui su di lui. Gli premetti la camicia sulle ferite, cercando stupidamente di arrestare l’ultima fuoriuscita di sangue. Jonathan scosse il capo e cercò di levarmi la camicia dalle mani. Alla fine, non mi rimase altro da fare che stringerlo a me. Fu in quel momento che compresi quello che avevo perso. Jonathan era stato sempre dentro di me, anche per tutti gli anni in cui eravamo stati lontani, era sempre in un angolino della mia mente, e quella sensazione mi dava sicurezza e conforto. Ora non mi rimaneva che un enorme vuoto che risucchiava tutto. Avevo perso l’unica cosa importante della mia vita. Non avevo più niente, ero sola, a sopportare il peso del mondo, di quella vita, senza nessuno che mi aiutasse. Avevo commesso un errore. Rivolevo Jonathan. Era meglio essere egoisti. Era meglio che mi odiasse fino alla fine dei tempi piuttosto che sentirmi per sempre così vuota. Sentirmi così e non poter far niente per riaggiustare le cose o per smettere di soffrire. Mi aggrappai al suo corpo per un tempo lunghissimo, finché il sangue raggrumato non congelò e mi ritrovai coperta dalla testa ai piedi di sangue umido e viscido. Non ricordo il momento in cui ho lasciato andare il corpo di Jonathan. Non ricordo di essermi alzata e di essermi messa a correre nella foresta, urlando a Dio di avere pietà di me e di lasciarmi morire. Che finisse anche per me, quel tormento. Non potevo continuare a vivere senza di lui. Non ricordo come sono finita sull’autostrada, zoppicante sull’asfalto. Non ricordo il momento in cui lo sceriffo e l’agente di polizia mi hanno trovata. Fu soltanto quando mi ritrovai dentro la macchina della polizia, sul sedile posteriore, con le mani ammanettate dietro la schiena, che mi tornò tutto in mente, fu in quel momento che capii di non desiderare altro che tornare nella foresta. Tornare da lui e morire con lui, così che potessimo vivere per sempre insieme. 50 Parigi, oggi Il corridoio d’ingresso è stretto e pieno di casse di legno giovane e scheggiato. Un martello, dei chiodi e un paio di guanti da lavoro sono poggiati su un tavolino a piedistallo accanto a una pigna di posta non aperta. Luke trasporta giù dalle scale un busto di marmo e ha il volto rosso per lo sforzo. Il busto è il secondo di una coppia che finirà al Bargello, a Firenze – uno dei tanti musei italiani, preferito agli Uffizi perché ha una maggiore collezione di scultura rinascimentale. Il primo busto è già chiuso nella sua cassa. Sulla parete, a osservare tutta quell’attività, c’è l’unico oggetto d’arte che non lascerà quella casa, il ritratto a carboncino di Jonathan che Lanny ha rubato dalla casa di Adair. Il ritratto è stato spostato dal suo posto originale – davanti al letto di Lanny – e messo nell’ingresso, anche se Luke non aveva particolari obiezioni a lasciarlo dov’era. Non è capace di essere geloso dell’uomo in quel ritratto, non più di quanto sia capace di odiare l’alba dorata o la cattedrale di Notre-Dame. Lanny esce dallo studio con una busta chiusa in mano. Dentro quella busta c’è una lettera di scuse per aver sottratto quelle opere d’arte ai legittimi proprietari, chiunque siano dopo tutto quel tempo. La lettera – una copia della quale ha accompagnato ogni pezzo spedito fino a quel momento – ha un tono dispiaciuto ma vago, ed è priva di riferimenti a come e quando il mittente si sia appropriato di quell’opera. Lanny ci ha lavorato per giorni, leggendo a voce alta le varie versioni a Luke finché non hanno concordato su quella finale. Lavorano indossando guanti di lattice, per non lasciare impronte. Lanny ha organizzato il trasferimento delle opere e la loro spedizione anonima tramite il suo avvocato parigino, che è stato scelto per la sua particolare dedizione verso i clienti e per l’approccio flessibile al codice. Perciò non crede che le spedizioni possano essere ricondotte a lei, per quanto accurate siano le indagini dei musei e degli altri destinatari. Quanto a Luke, un po’ gli dispiace veder scomparire tutte quelle meraviglie così poco tempo dopo il suo arrivo. Vorrebbe avere più tempo per apprezzare quella che dev’essere la più completa collezione privata di opere d’arte e manufatti antichi al mondo. Lanny non aveva esagerato quando gli aveva detto che la sua casa era più stupefacente di qualsiasi museo. I piani superiori erano pieni di tesori, ammassati senza nemmeno un ordine. Ogni volta che sposta un oggetto per spedirlo, ne scopre altri dieci o più. E non si tratta soltanto di quadri o di sculture. Ci sono montagne di libri, fra i quali senz’altro sono presenti diverse prime edizioni. Tappeti orientali fatti di seta così fine da poter passare attraverso un braccialetto da donna. Kimono giapponesi e caffetani turchi di seta ricamata. E ogni genere di spade e di armi da fuoco. Vasi greci, samovar russi, coppe di giada, d’oro, scolpite nella pietra. Parecchi bauli pieni di sacchettini di seta e di velluto, ognuno contenente un gioiello con pietra preziosa. Poi ci sono cose che lo spiazzano completamente: per esempio, dentro la custodia di un ventaglio ha trovato un biglietto scritto a mano per Lanny e firmato da lord Byron. Luke stenta a leggere tutte le parole, ma riesce a individuare il nome di Jonathan tra gli scarabocchi. Lanny sostiene di non ricordare di che cosa parlasse quella lettera, ma com’è possibile scordare un biglietto scritto da uno dei poeti più famosi del mondo? Quella è la casa di un collezionista pazzo, che cerca di compensare un vuoto confuso e inarticolato della sua vita diventando schiavo dell’impulso incontrollabile di ammassare oggetti di pura bellezza. Eppure, lei ha generosamente tenuto da parte alcuni pezzi perché vadano a costituire un fondo fiduciario per le figlie di Luke, sufficiente a pagare la retta di una buona università quando saranno cresciute. Luke scopre che, a parte la collezione di antiche ceramiche cinesi, nessuno ha mai tentato di fare un elenco, perciò convince Lanny a catalogare ogni pezzo a mano a mano che vengono spediti: una breve descrizione, un’ipotesi di dove l’ha acquistato, il nome della persona o dell’istituzione che lo riceverà. È convinto che un giorno le sarà di conforto, quell’elenco. Le darà la possibilità di ricordare le sue vecchie avventure senza il peso di essere circondata da tutti quegli oggetti. È un bene per lei liberarsi di quelle cose, ritiene. La aiuta a non pensare a Jonathan, non sempre almeno. Luke ha sorpreso Lanny più volte a piangere in bagno oppure in cucina, mentre aspettava che l’acqua del tè bollisse. Eppure, recentemente le crisi di pianto hanno iniziato a diradarsi e il progetto di cui si stanno occupando, la spedizione di tutti gli oggetti della sua casa, l’ha resa visibilmente più serena. Lei dice di sentirsi più in pace con se stessa, che è un modo di compensare tutto il male che ha fatto. Una volta è giunta perfino a dire che, pentendosi e cercando di porre rimedio, sperava di poter essere perdonata. Sperava che l’incantesimo si rompesse. Così avrebbe potuto invecchiare con Luke e abbandonare questa vita mortale più o meno contemporaneamente a lui. Così non avrebbe più sofferto quella profonda, insopportabile solitudine. Quei discorsi – quell’affidare le proprie speranze a una sorta di intervento magico – mettono a disagio Luke. Date le circostanze, però, ha imparato a non dubitare (non del tutto, almeno) che possano accadere eventi quanto meno improbabili. Lanny infila la lettera sotto il coperchio e Luke lo inchioda. Il corriere arriverà alle due precise per il ritiro di quel giorno e Luke è riuscito a metter via soltanto i due busti. Deve darsi da fare. Quando posa il martello per asciugarsi la fronte dal sudore, nota la pila di posta inevasa. In cima c’è una spessa busta che proviene dall’America e, per riflesso, sbircia l’indirizzo del mittente. È quello di un avvocato di Boston, colui che si occupa della casa di Adair, o meglio, della cripta di Adair. Luke sfoglia velocemente le altre buste: ci sono sette lettere che provengono dallo stesso avvocato, la più vecchia di un anno prima. Apre la bocca per dire qualcosa in proposito a Lanny ma proprio in quel momento lei gli passa accanto veloce, con la borsetta a tracolla, cercando distrattamente le chiavi di casa. «Ho un appuntamento dal parrucchiere, ma dovrei riuscire a tornare prima che venga il corriere. Vuoi che prenda qualcosa da mangiare già che sono fuori? Che cosa vorresti?» «Fammi una sorpresa» le risponde. Luke è contento di vederla immersa in una routine – è un segnale del fatto che non è paralizzata dalla depressione – e, in particolare, gli dà gioia vedere quanto velocemente lui sia entrato a far parte di quella routine. Adora il fatto che stanno così bene insieme. Lei ha smesso di fumare perché lui gliel’ha chiesto, perché non riesce a sopportarlo anche se sa che non può farle alcun male. Lei condivide tutto con lui: la sua panetteria preferita, la sua passeggiata pomeridiana preferita, gli anziani con cui ama chiacchierare nel parco. È felice di fare commissioni per lei, di prendersi cura di lei, e lei in cambio è grata per ogni suo gesto gentile. Questo significa che lui la ama? È scettico, profondamente scettico sul fatto che ci si possa innamorare così velocemente, soprattutto visto chi è lei e quello che gli ha raccontato, ma allo stesso tempo c’è una strana sensazione, una specie di vibrazione emotiva che si è impossessata di lui, una sensazione che non provava dal giorno in cui sono nate le sue figlie. Dopo che Lanny è uscita, lui torna di sopra a cercare il prossimo oggetto da rimpatriare. Più tardi ha un appuntamento, deve ricordarsi di lasciare Lanny a seguire il corriere, perché lui deve incontrarsi col direttore dei volontari al Mercy International, un’organizzazione che invia medici nelle zone di guerra e nei campi di rifugiati, così come nelle cliniche per i senzatetto. Era l’ultima organizzazione per cui aveva lavorato Jonathan, e qualcuno aveva contattato Lanny poco dopo che lei e Luke erano rientrati dal Québec. Cercavano Jonathan e lei, per un momento, era rimasta senza parole, poi si era ripresa e aveva detto di conoscere un altro dottore che voleva rendersi disponibile, purché potesse praticare a Parigi. Luke è contento del colloquio, è felice che Lanny abbia capito che lui non può essere sereno se non svolge il suo mestiere di medico, e spera che il suo francese arrugginito sia abbastanza comprensibile per curare gli immigrati da Haiti e dal Marocco. Luke sceglie il prossimo oggetto da spedire, un largo arazzo che finirà in un museo tessile a Bruxelles. L’arazzo è stato arrotolato come un tappeto ed è infilato accanto a una grossa libreria da studio legale piena di ogni sorta di bric-à-brac. Metà delle vetrine della libreria sono aperte e quando Luke cerca di sollevare l’arazzo qualcosa cade da uno dei ripiani. Lui si china e lo raccoglie. È una piccola palla di camoscio, e dal modo in cui il tessuto è chiuso – è il solito modo raffazzonato in cui Lanny conserva le cose – capisce che c’è dentro qualcosa. Lo apre con cautela – forse c’è dentro qualcosa di fragile – e trova un piccolo oggetto di metallo. Una fiala, per la precisione, più o meno grande quanto il mignolo di un bambino. Anche se è ossidata e scurita dal tempo, si capisce benissimo che è lavorata e incisa con cura, come un gioiello. Con mani tremanti, prende il tappo e lo toglie. È secco. Annusa la fiala vuota. E la sua mente si mette in moto: forse è secca ma ci sono modi di analizzare i residui. Potrebbe mandarli a un laboratorio e scoprire così gli ingredienti dell’elisir, le proporzioni. Potrebbero cercare di riprodurlo e probabilmente, dopo qualche tentativo a vuoto, riuscirebbero. Ricreare la pozione significherebbe per lui poter rimanere con Lanny per sempre. Lei non sarebbe più sola. E, ovviamente, altre persone sarebbero interessate all’immortalità. Potrebbero venderla a prezzi astronomici, facendola gocciolare sulle lingue dei clienti come se si trattasse di fare la comunione. Oppure potrebbero essere dei veri benefattori: in fondo, che cosa farsene di troppo denaro? Potrebbero darla a grandi scienziati per farla studiare. Chi può immaginare che impatto avrebbe quell’elisir sulla scienza e sulla medicina? Un elisir che rigenera i tessuti potrebbe rivoluzionare le cure delle ferite e delle malattie. Potrebbe cambiare tutto. Così come rivelare al mondo la condizione di Lanny. Eppure... Luke ha il sospetto che l’analisi del residuo non rivelerebbe un bel niente. Ci sono cose al mondo che resistono a qualsiasi indagine, che non possono essere esaminate alla luce del sole. Una piccola frazione di una piccola percentuale di un fattore che non può essere spiegato né riprodotto. Quando era uno studente di medicina, ne aveva sentito parlare, di fenomeni simili, raccontati da un vecchio e saggio professore al termine di una lezione. L’aveva sussurrato agli studenti mentre uscivano dalla sala operatoria dopo una dissezione. Ci sono alcuni medici e alcuni ricercatori che rifiuterebbero questa verità e sosterrebbero che la vita è meccanica, che il corpo non è altro che un sistema di sistemi, come una casa. Che si vive finché si mangia quello o si beve quell’altro, finché si seguono quelle regole, come se ci fosse una ricetta della vita. Basta riparare il sistema idrico o aggiustare la struttura quando si danneggia, perché il corpo è soltanto un vascello che trasporta la coscienza. Ma Luke sa che le cose non sono così semplici. Anche se un chirurgo dissezionasse Lanny – e sarebbe un incubo, con il corpo che cerca di ripararsi da solo mentre mani e bisturi lo scavano – non riuscirebbe a individuare la parte di lei che è cambiata e che l’ha resa immortale. Né servirebbero analisi del sangue o biopsie o qualsiasi tipo di radiografia. Quindi, si potrebbe anche analizzare la pozione, darne dei campioni a migliaia di chimici per farla riprodurre, ma Luke è convinto che nessuno sarebbe capace di ottenere lo stesso risultato. C’è una forza superiore dentro Lanny, riesce a sentirla, anche se non ha idea se si tratti di una forza spirituale, di magia, di chimica o di un tipo di energia sconosciuto. Sa soltanto che il miracolo dell’esistenza di Lanny, come la fede e la preghiera, funziona meglio in solitudine, protetto dallo scetticismo e dalla forza bruta della ragione. E sa che, in effetti, se le sue condizioni fossero rese pubbliche, lei si disintegrerebbe o evaporerebbe come brina al sole. Probabilmente è per questo stesso motivo che nessuno degli altri – gli altri di cui Lanny gli ha raccontato, Alejandro, Dona e la diabolica Tilde – si sono mai esposti al pubblico. Strofina la fiala tra le dita come una sigaretta e poi, d’impulso, la getta a terra e la schiaccia col tacco, con tutto il suo peso. Si appiattisce facilmente, come se fosse fatta di carta. Luke va alla finestra, la apre e scaglia fuori il pezzettino di metallo, più lontano che può, oltre i tetti dei vicini, e distoglie appositamente lo sguardo per non vederne la traiettoria. Immediatamente, si sente sollevato. Forse avrebbe dovuto parlarne a Lanny prima di distruggere la fiala. invece no. Sa benissimo che cosa avrebbe detto lei. E poi, ormai è fatta. Ringraziamenti Immortal è evidentemente un’opera di finzione, ma è anche il frutto di alcune ricerche, specialmente per quanto riguarda la storia dello Stato del Maine. Ho consultato due volumi in particolare: Maine in the Early Republic, a cura di Charles E. Clark, James S. Leamon e Karen Bowden (University Press of New England, 1988), e Liberty Men and Great Proprietors: The Revolutionary Settlement on the Maine Frontier 1760-1820, di Alan Taylor (University of North Carolina Press, 1990). Eventuali errori e imprecisioni si devono soltanto a me. Spesso si dice che quello dello scrittore è un mestiere solitario, e in parte è vero, ma sarebbe impossibile riuscire a pubblicare un libro senza l’aiuto e la benevolenza di molte persone nel lungo percorso che conduce alla pubblicazione stessa. Vorrei ringraziare tutti coloro i quali hanno letto le prime versioni del romanzo, tra cui Dolores, Lisa, Randy, Linda, Jill, Kelley e Kevin; i miei professori alla Johns Hopkins, Tim Wendel, Richard Peabody, Elly Williams e Mark Furrington; Elise Cheney e Jeff Kleinman per avermi incoraggiato da subito; e i magnifici organizzatori della Squaw Valley Community of Writers. Un enorme ringraziamento è dovuto a Tricia Boczowski, la mia editor presso la Gallery Books, per aver intravisto qualcosa di promettente nel mio romanzo, per la sua guida editoriale e per l’ottimismo e l’allegria con cui ha portato questo romanzo alla pubblicazione. Ringrazio anche la Gallery Books per essersi così adoperata per il mio libro. Infiniti ringraziamenti anche a Nicky Kennedy, Sam Edenborough e Katherine West, gli agenti per la vendita dei diritti all’estero della Intercontinental Literary Agency, e agli editori di Immortal negli altri paesi, per aver dimostrato grande fiducia in un romanzo d’esordio: Giuseppe Strazzeri e Fabrizio Cocco presso la Longanesi; Cristina Arminana presso la Mondadori Spagna; Katarzyna Rudzka presso la Proszynski Media in Polonia e la ESKMO Publishing in Russia. I miei più sentiti ringraziamenti vanno a Peter Steinberg, il mio agente, non soltanto per aver creduto nel mio lavoro ma per averlo curato con dedizione, trasformando una storia forse anche un po’ traballante nel romanzo che avete appena finito di leggere. Grazie alla mia famiglia per aver sopportato il mio pessimo temperamento da scrittrice sin da quando ero una bambina seriosa. E, naturalmente, tutto il mio amore va a Bruce, che con infinita pazienza ha sopportato che dedicassi ore e ore a questo libro e mi ha permesso di realizzare tutti i miei sogni.
Scaricare