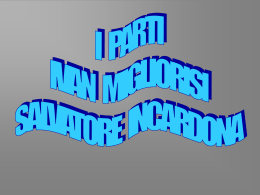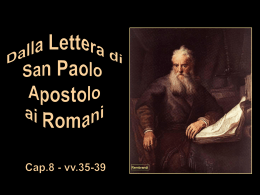S studio del mese S al u te e m alat t i a R i le t t u ra s u l f i l o d e l la te s t i m o n i a n z a Il dolore e la salvezza Soprattutto nella sua dimensione popolare e devozionale, ma anche in quella magisteriale, il cattolicesimo deve ancora fare i conti con la malattia e in generale con la sofferenza. Sono ancora molto diffusi modi di pensare e di pregare improntati a un certo «dolorismo», angelismo e spiritualismo imperanti in tutta l’età moderna e profondamente inadatti a entrare in contatto con il mondo contemporaneo, nel quale il corpo – con le sue esigenze e il suo desiderio di vita, di salute, di relazione – assume sempre maggiore centralità. Gesù riacquista e dona la vita proprio perché l’ha persa e l’ha offerta: tornare al nucleo del messaggio evangelico, che vede al centro una vita incarnata senza mai idolatrarla o considerarla un bene «oggettivo e indisponibile», consente una morale della relazione e della responsabilità. Essa non si basa su un astratto universalismo, ma su una presa di coscienza che il valore della vita va misurato con vari parametri, il primo dei quali potrebbe essere il rapporto con gli altri, e con Dio. Il Regno - 391-400_doss-CR.indd 391 attualItà 12/2013 391 02/07/13 16.50 tudio del mese S 392 S ono in autobus e sto percorrendo una strada della mia città, Trento. Per fortuna i mezzi pubblici sono attrezzati per ospitare pure le carrozzine. Perché io sono disabile. Quando mi muovo ho bisogno di un accompagnatore che non solo mi aiuta negli spostamenti, ma a volte è costretto a rispondere al mio posto, in quanto molte persone, soprattutto anziani, ritengono i portatori di handicap incapaci d’intendere e di volere, di parlare e di poter avere una vita normale. Eterni bambini, i disabili possono essere accarezzati. Di norma a loro non viene rivolta neppure la parola. Ci sono abituato ormai. Così quella volta sull’autobus mi viene incontro una signora che, come mi aspettavo, si rivolge esclusivamente alla mia assistente, chiamata da lei «badante», con domande sul mio conto abbastanza personali, finché tira fuori dalla borsetta l’immagine di un Sacro Cuore di Gesù; gliela consegna con l’esortazione di leggermi ogni giorno la preghiera scritta sul retro. Silenziosamente penso che poteva andarmi peggio, almeno sono sfuggito alle carezze. Poi è sempre bello trovare qualcuno che invita a pregare! A casa leggo la preghiera. Recita così: «Gesù, il tuo sangue / puro e sano / circoli nel mio organismo malato, / e il tuo corpo / puro e sano / trasformi il mio corpo malato / e pulsi in me una vita / sana e forte, / se è la tua santa volontà». Firmato: Alleanza Dives in misericordia di Rinnovamento carismatico cattolico. Qualche giorno dopo pubblico un articolo sul settimanale diocesano Vita trentina, nel quale scrivo tra l’altro: «Mi chiedo però se quella preghiera sia conforme alla fede che anch’io dico di professare. Perché da quelle invocazioni si deduce che nel mio corpo malato non circola il sangue di Cristo (non si sa il motivo, forse per qualche peccato; ritorniamo così alle domande dei farisei sul cieco nato e alla visione religiosa contrastata da Gesù); e soprattutto si capisce che la volontà di Cristo è quella che non pulsi in me una vita sana e forte, poiché non mi fa guarire. Poi però mi chiedo: che cosa è guarigione, che cosa sono salute e malattia?». La riflessione di queste pagine scaturisce in parte da queste esperienze personali. Esse dimostrano chiaramente come il cattolicesimo – nella sua dimensione popolare e devozionale e, come vedremo, pure in quella magisteriale – debba fare ancora i conti con la malattia e in generale con la sofferenza. Da qui scaturisce una grande difficoltà a entrare in contatto con il mondo contemporaneo, in cui il corpo occupa sempre maggiore centralità. La dimensione della corporeità ha trovato, in quest’ultimo secolo, uno spazio crescente nella riflessione filosofica e nel comune sentire delle persone. Il corpo conta perché in esso e attraverso esso esistiamo, incontriamo gli altri e percepiamo il mondo. In una prospettiva cristiana poi la «carne» è al centro dell’inaudito annuncio della rivelazione: anche Dio assume un corpo che soffre, muore e risorge a vita nuova. Tutto questo è l’opposto dello spiritualismo e dell’angelismo imperanti in tutta l’età moderna e messi in discussione soltanto negli scorsi decenni. Mentre le conquiste scientifiche e soprattutto tecniche cambiavano la nostra visione del mondo, la Chiesa cattolica in particolare ha cercato di affrontare le ripercussioni Il Regno - 391-400_doss-CR.indd 392 attualItà etiche della modificazione della mentalità (e quindi dei nuovi costumi, valori e stili di vita) proponendo un richiamo allo sfuggente concetto di «legge naturale» a cui bisognerebbe, razionalmente e oggettivamente, fare riferimento. Questa impostazione però risulta essere perdente, fragile di fronte al vaglio della critica filosofica, ambigua dal punto di vista logico e sconfitta dall’inevitabile pluralismo di pensiero e di comportamento. E lontana dalla proposta cristiana. L’alternativa è tornare al nucleo del messaggio evangelico, che vede sicuramente al centro la vita senza mai idolatrarla o considerarla un bene «oggettivo e indisponibile»: Gesù riacquista e dona la vita proprio perché l’ha persa e l’ha offerta. Di qui nasce una morale della relazione e della responsabilità che non si basa su un astratto universalismo, ma su una presa di coscienza che il valore della vita va misurato con vari parametri, il primo dei quali potrebbe essere il rapporto con gli altri (e con Dio). In questo articolo cercherò di affrontare tale complesso quadro teorico ed esistenziale – che coinvolge filosofia, teologia, etica e politica – attraverso le particolari lenti della salute e della malattia. La medicina infatti è l’ambito in cui con più evidenza si può cogliere il discorso fatto in precedenza: infatti è sul versante della salute che si gioca l’intreccio tra tecnica e corporeità, tra libera scelta individuale e orizzonti valoriali condivisi, tra visione religiosa e prospettiva laica. Riflettere sul concetto di malattia risulta poi decisivo per ripensare l’approccio della teologia e della pastorale cattolica, soprattutto per quanto riguarda il corpo, la sessualità, l’esistenza stessa. Ci soffermeremo dunque sulla difficoltà di definizione di salute e di malattia e sulla differenza sostanziale tra malattia e disabilità. Di qui si passerà a delineare proprio il rapporto tra il magistero pontificio e i malati, con il passaggio dalle tendenze «doloriste» a quelle di una maggiore inclusione attiva di malati e disabili nella vita della Chiesa. Tutto però, infine, viene ricondotto al cuore del mistero cristiano, ossia al significato e alla funzione del sacrificio redentivo di Cristo. La tesi di fondo sostenuta in queste pagine riguarda la necessità di superare definitivamente il rapporto tra sofferenza di Cristo e malattia (Gesù è stato condannato a morte, non è deceduto per un male incurabile!), e di connetterlo invece con il desiderio di vita, di bene e di liberazione connesso a tutta la visione della Bibbia. Il rimando alla definitiva vittoria escatologica sul male dà nello stesso tempo una nuova energia esistenziale nell’affrontare la sofferenza e una potente chiave di lettura per dirimere i dilemmi etici a cui non ci possiamo sottrarre. Difficile definizione La salute e la malattia sono condizioni esistenziali di cui tutti abbiamo fatto esperienza. La salute rimanda alla pienezza di vita, mentre la malattia è sempre un’anticipazione della morte. Siamo dunque di fronte a ciò che caratterizza principalmente la nostra essenza di esseri umani. Queste due condizioni – o situazioni – fondamentali, benché di primo acchito risultino di immediata ed evidente comprensione, sono in realtà di difficile definizione, da qualsiasi punto di vista esse si approccino. A livello 12/2013 02/07/13 16.50 biologico e medico salute e malattia sono connesse a disfunzioni organiche di vario tipo, da cui nella maggior parte dei casi si può guarire ritornando così alla «normalità», cioè all’efficienza dei meccanismi che sostengono e regolano il nostro corpo. Riacquistiamo in questo modo la «salute». I due elementi in discussione sono dunque connessi alla corporeità, ma sappiamo quanto salute e malattia incidano in profondità sul nostro modo di percepire noi stessi e il mondo coinvolgendo le varie dimensioni del nostro essere. Dare una definizione filosofica di salute e malattia è un’impresa ardua, anche perché questa strada è stata poco battuta nella storia del pensiero. Facciamo qui soltanto alcune considerazioni generali, senza la pretesa di utilizzare un linguaggio preciso ed esaustivo, cercando però di dare alcune coordinate fenomenologiche di fondo. A mio avviso occorre guardarsi dal rinchiudere il discorso sulla salute e sulla malattia in un recinto troppo specialistico, che rischia di non dare ragione delle componenti emotive e immediate che tanta parte hanno nella nostra auto-rappresentazione. Non c’è forse qualcosa di più soggettivo della percezione del proprio stato di salute; d’altra parte la differenza tra una condizione sana e una malata è quasi oggettiva, universalmente condivisa, perché rimanda alla comune struttura della biologia e della cultura umane. Nel prosieguo del discorso si dovrà sempre tenere presente questa compresenza di soggettività e oggettività. Una grande differenza tra i concetti di salute e malattia risiede nel fatto che la prima, la salute, può essere declinata soltanto al singolare, mentre la seconda, la malattia, presenta in sé un’enorme pluralità di sfumature, quasi che fossimo davanti a fenomeni diversificati, difficilmente componibili in un’unica sintesi. Certamente ciascuno di noi darà una valutazione del tutto personale di che cosa significhi essere in salute, nel pieno delle forze o, come si dice, di cosa voglia dire «essere in forma». Tuttavia, pur a fronte di varie modalità di sopportazione del dolore o dell’evidenza o meno di sintomi correlati a una determinata patologia, e pur davanti a interpretazioni opposte della stessa corporeità umana (si pensi alla differenza sostanziale tra la medicina occidentale e quella cinese), a ogni latitudine subito ci accorgiamo se una persona è sana o malata, insomma se ha qualche problema fisico. Stabilire un netto e univoco confine tra salute e malattia è invece molto problematico, e può interessare piuttosto concreti risvolti sanitari rispetto a riflessioni filosofiche. La salute è dunque un concetto abbastanza univoco. Così non si può dire per la malattia. Qui non stiamo parlando del praticamente illimitato elenco nosologico delle patologie, a sua volta differenziato secondo l’eziologia (malattie di origine genetica, batterica, virale…) oppure secondo le funzioni e gli organi colpiti, ma nel diversificarsi del «valore» oggettivo ed esistenziale che assume la malattia. L’osservazione pratica aiuta a capire meglio questo discorso. Insita nel concetto di malattia sta la possibilità della guarigione, del ritorno cioè alla condizione precedente all’insorgenza del male. In teoria il malato spera sempre nella guarigione, ma in realtà non è ovviamente così. E allora bisogna aggettivare la parola malattia rendendola «cronica», «incurabile» o «terminale». In questo modo però si altera completamente l’idea stessa di malattia. La condizione del malato terminale non può essere comparata con quella di chi, almeno nell’auspicio o nella speranza, può guarire. Di qui scaturisce la differenza tra malato e disabile. La disabilità può essere causata sicuramente da una patologia, ma pure da eventi esterni come un incidente stradale o un infortunio sul lavoro. Quasi sempre dalla disabilità non si può guarire perché essa, più che avere le caratteristiche di una malattia, rimanda a ulteriori categorie e a ulteriori risvolti esistenziali. Il disabile non è un malato, è una persona normale, ma con più o meno gravi deficit fisici o intellettivi. Io stesso ho vissuto la differenza tra malattia e disabilità. Quando la patologia neuromuscolare di cui sono affetto ha esaurito il suo decorso, portandomi alla quasi completa immobilità, ecco che paradossalmente non sono più malato (non c’è una cura per guarire o per recuperare le mie funzioni muscolari), ma sono disabile. Assicuro il lettore che sono due situazioni molto diverse. Parlare di «malati» in senso general-generico è un’omologazione inutile e sbagliata, un incasellamento tipico con cui la società esclude i diversi, inglobandoli nella stessa categoria. Vedremo come questa generalizzazione sia presente nella cultura cattolica. Quando il corpo dev’essere «interpretato» Un’altra differenza fondamentale tra salute e malattia sta nel fatto che quest’ultima ci pone domande scomode che vanno al centro della nostra umanità. «Quando il corpo sta bene, non ha bisogno di essere interpretato».1 Con questo illuminante aforisma il card. Martini sintetizza in pieno un aspetto centrale del nostro ragionamento, quello secondo cui è la condizione di malattia a interpellare la nostra individualità. La salute, vissuta come una situazione «normale» e che quindi non richiede una particolare decifrazione, non rimanda ad altro: in un certo senso basta a se stessa, non necessita di ulteriori spiegazioni, non spinge a più approfonditi livelli di analisi. La malattia invece richiede un’interpretazione del corpo, inteso ovviamente nel senso generale di «corporeità». Tuttavia – come ci insegnano consolidate ricerche filosofiche – questa ermeneutica non può che essere plurale, nutrendosi di volta in volta delle convinzioni personali e dei contesti sociali, dell’apporto sedimentato nei secoli come per esempio con le tradizioni religiose oppure, viceversa, delle mode effimere del momento. Non si potrà mai giungere a una descrizione del corpo univoca e universalmente valida. Mutuando un’espressione dal contesto dell’esegesi biblica, soprattutto ebraica, potremmo parlare di una «interpretazione infinita» del corpo, che dobbiamo mettere in campo necessariamente per affacciarci alla vita almeno con un po’ di consapevolezza. La malattia non può poi non rimandare alla sofferenza. Scrive Silvano Zucal in un articolo dedicato al tema del dolore: «Indubbiamente il dolore è un fatto emotivo e segnatamente di emotività negativa, può innescare dinamiche psichiche latenti, può essere un luogo soteriologico Il Regno - 391-400_doss-CR.indd 393 attualItà 12/2013 393 02/07/13 16.50 S tudio del mese Da sinistra a destra: P. Cattani, P. Stefani, A. Casati e O. Piccolo a una presentazione del libro di P. Cattani Cara Valeria. Lettere sulla fede, Il Margine, Trento 2008. – per chi crede o segue il teologo –, o comunque un luogo ove la domanda radicale di senso e quindi anche la domanda religiosa si pone –per chi è in ricerca o è agnostico –, ma è soprattutto, per tutti, il luogo proprio di autointerrogazione dell’uomo, di un interrogarsi dell’uomo su di sé. Infatti il dolore, a tutti i livelli, dal puro e semplice livello somatico a quello psicologico fino a quello esistenziale, non è altro e sempre che lo scontro, traumatico, dell’uomo che tende a una pienezza di vita fisica, psichica ed esistenziale con i limiti evidenti di tale vita».2 Nell’attuale temperie un altro punto fondamentale è senza dubbio il rapporto tra il corpo e la tecnica. Innumerevoli sono ormai gli studi che trattano dell’argomento, declinato secondo varie angolature e quindi anche secondo la visuale di cui stiamo parlando. La medicina diventa la frontiera più avanzata del cambiamento di mentalità contemporaneo. La relazione tra corpo e tecnica infatti non è più esclusivamente l’ambito per disquisizioni dotte o astratte (o ancora peggio terreno di scontro ideologico e politico), ma diventa il luogo concreto in cui s’incontrano e si scontrano istanze etiche differenti, in cui si devono prendere decisioni spesso tragiche, in cui la sofferenza è un fattore dirimente. Questi sono problemi che interessano soprattutto le società ricche dove è possibile applicare cure molto costose e sofisticate, mentre la stragrande maggioranza della popolazione mondiale non ha accesso neppure ai farmaci più elementari, per i quali non ci sono certo dilemmi etici di sorta. Tuttavia sarebbe sbagliato limitarsi a pensare che questo inedito rapporto tra la tecnica e l’interpretazione del corpo, proprio e altrui, sia solamente appannaggio dell’Occidente; se guardiamo bene, la tendenza a una progressiva «artificializzazione» della salute fisica è una traiettoria ben precisa su cui si è incamminata l’umanità. In fondo religioni, culture, modi di percepire il mondo, stili di vita anche molto diversi tra di loro possono pure incontrarsi (e non solo contrapporsi) proprio sul terreno della salute e della malattia: non è un caso che l’Organizzazione mondiale della sanità sia uno degli organismi internazionali più trasversali e più capillarmente diffusi, capaci di unire persone di tutti gli angoli del pianeta. Si tratta ovviamente di un approccio laicizzato alla salute, basato su standard scientifici universalmente accettati e passibili di aggiustamenti, controlli e revisioni, che lasciano volentieri sullo sfondo istanze etiche e, in misura maggiore, religiose. Come scrive Gilberto Corbellini: «L’uomo dell’età secolare è portato a vivere la sua malattia in modo sempre meno religioso. Nel suo compito di rendere abitabile il mondo è inclusa anche la lotta a fondo contro tutti i condizionamenti negativi, tra i quali la malattia tiene il posto principale».3 Un diverso concetto di corporeità In questo contesto, in cui la salute e la malattia sono per così dire sempre di più medicalizzate, e in generale sottoposte a quella che pure a sproposito viene chiamata «scienza», allo stesso tempo assistiamo a processi paralleli o inversi, segnati quasi dalla nostalgia di una visione diversa. Con la secolarizzazione si è rotto un approccio unitario alla realtà e con la specializzazione del sapere si 394 Il Regno - 391-400_doss-CR.indd 394 attualItà è parcellizzato anche lo studio dell’uomo, il cui corpo, almeno dall’età moderna in poi, è considerato alla stregua di una macchina e contrapposto all’anima (quando essa viene postulata). La religione è quindi assolutamente bandita da questo modo di intendere la cura dell’uomo, anzi viene vissuta come un vetusto retaggio di superstizione, come appannaggio di persone ignoranti oppure come ultimo appiglio quando non si sa più «a quale santo votarsi». Di converso però assistiamo al desiderio, confuso e contradditorio ma crescente, di cambiare modello. La medicina cinese od orientale, gli approcci olistici, l’omeopatia, i rimedi naturali, l’interpretazione del corpo sempre in relazione con il mondo (il rapporto microcosmo/ macrocosmo) sono solo alcuni esempi che finiscono per cozzare contro gli assiomi della medicina occidentale. Secondo questa visione la malattia non è tanto causata dalla disfunzione di qualche organo, quanto dalla mancanza complessiva di equilibrio che va recuperato attraverso un insieme di azioni che potremmo definire, grossolanamente, psico-fisiche. La salute viene vista come armonia e benessere completo dell’individuo con se stesso e con l’ambiente circostante. La possibilità di accedere a una conoscenza medica minima da parte del grande pubblico (basta avere un collegamento Internet) ha poi creato una sorta di «medicina fai da te» che assomma un po’ di tutto, comunque rompendo con schemi consolidati. Per quanto riguarda le malattie – dal semplice mal di testa alle forme di tumore più gravi – emerge la spinta a una «liberalizzazione» delle cure e a una richiesta di personalizzare gli standard generali sui farmaci e sui protocolli medici. Tutto questo per lasciare spazio non solo ai (presunti miracolosi) nuovi trattamenti ma pure, come detto, a una rivisitazione del concetto di corporeità e quindi di malattia, ora completamente in pugno della biologia, della chimica e in ultimo della genetica. È evidente il ritorno più o meno nostalgico o esotico a religioni antiche e lontane, a riti sciamanici secolarizzati che segnalano il bisogno di una visione diversa dell’uomo e della vita, ora ingabbiati in meccanismi forse razionali e «scientifici», comunque massificanti e spersonalizzanti. Questo è un fenomeno che si può cogliere in molteplici forme, dalla riorganizzazione degli ospedali per cercare di renderli meno burocratici e più umani alla scelta sempre più diffusa di tornare a vivere «in campagna», in contatto con la natura, nella speranza di condurre un’esistenza più sana e quindi di garantirsi la salute, lontano dalle città ormai dominate dal traffico e dall’inquinamento. Alla ricerca di una nuova spiritualità si finisce quasi sempre per approdare in Oriente, sia per il fascino di civiltà millenarie e ancora sconosciute, sia perché sembra che l’Occidente abbia esaurito le sue risorse interiori. L’etica laica, ma pure quella di derivazione religiosa, sono relegate ai margini e le esperienze di assistenza «spirituale» ai malati secondo forme nuove danno risultati non soddisfacenti. Ma il problema è molto più profondo perché riguarda lo stesso linguaggio utilizzato. Questo è evidentissimo per l’etica cattolica, le cui istanze paradossalmente dominano il discorso pubblico 12/2013 02/07/13 16.50 (almeno in Italia) senza essere minimamente tenute in considerazione non dico dall’interezza della popolazione, ma neppure dagli stessi fedeli. Sembra quasi che la religione cristiana non abbia più niente da offrire e che i dettami della Chiesa cattolica – quando si conoscono – siano considerati alla stregua di divieti retrogradi da combattere oppure di insignificanti proclami, lontanissimi dalle difficoltà e dai dolori di ogni giorno. Allora si preferisce uscire dalla nostra tradizione per rifugiarsi in Oriente. Da che cosa deriva tutto ciò? Dal laicismo e dal relativismo? Dal progressivo allontanamento dalla fede? Può essere ma non è motivazione sufficiente. Parlando di salute e di malattia dobbiamo affermare che la visione cattolica degli ultimi secoli non è stata adeguata e al passo con i tempi. Una disamina puntuale ci aiuterà a capire meglio questo discorso e a evidenziare quali siano le questioni aperte di oggi. La sofferenza nella visione cristiana Il rapporto con la malattia e quindi con la sofferenza ha visto nella teologia, nella morale e, in generale, nella pietà popolare cattoliche un grande cambiamento di prospettiva, avvenuto negli ultimi 150 anni. Tale mutamento va di pari passo con una nuova visione complessiva del valore salvifico della redenzione, che non pone più al centro il dolore in quanto tale patito da Cristo, alla stregua di un inevitabile prezzo da pagare per la salvezza, ma si concentra sull’abbassamento di Dio nell’esistenza umana che prevede ovviamente la sofferenza e la morte. Per lungo tempo ci si è scordati che la croce di Cristo non è stata da lui voluta e non è stata causata da circostanze per così dire «naturali». La condanna alla crocifissione di Gesù di Nazaret deriva direttamente da una chiara scelta che oggi definiremmo politica, religiosa e giudiziaria: bisognava togliere di mezzo un pericoloso sovvertitore dell’ordine stabilito, un riformatore visionario che metteva a repentaglio la fede dei padri. La sofferenza di Cristo è prima di tutto la conseguenza di un episodio di malagiustizia: essa incarna la condizione di tutte la vittime della storia che non hanno cercato la morte, ma che l’hanno accettata per non tradire i propri ideali di pace, giustizia e libertà. Cristo è la vittima per eccellenza e in lui si possono riconoscere tutti i miserabili della terra: poveri, affamati, emarginati, profughi, condannati e appunto anche malati. Con una precisazione: benché in concreto molto simile, la sofferenza inflitta e patita dall’uomo per propria responsabilità è differente da quella derivante dalla malattia. Infatti, come abbiamo detto in precedenza, la malattia è un evento che colpisce dal di fuori, a prescindere dalla qualità morale dell’individuo. Certo moltissimi fattori controllabili e gestibili (dalla tutela dell’igiene all’accessibilità dei farmaci, dalle campagne di vaccinazione agli esami preventivi) causano il diffondersi o meno delle patologie: quando però esse si abbattono concretamente sulla persona, la domanda sulla sofferenza appare in tutta la sua drammaticità. Nella concezione tradizionale veniva poi messa tra parentesi la visione, così tipica delle prime comunità cristiane, che appellava Cristo come «medico» dell’anima ma, sicuramente, anche del corpo: ci si ricollegava all’attività pubblica di Gesù, contrassegnata da azioni tipiche di un guaritore e di un taumaturgo, e poi alle capacità che avrebbero avuto anche i discepoli di far recuperare, più o meno miracolosamente, la salute agli ammalati. Innumerevoli sono i passi neotestamentari in tal senso, e non mancano le citazioni dei padri della Chiesa, come del resto le rappresentazioni iconografiche connesse. Scrive Antonio Autiero: «Cristo è definibile come medico, perché con il cristianesimo si profila chiaramente una possibilità di aggancio della tematica della ricerca di salute con la ricerca di salvezza. Una concezione di questo genere, che nella Chiesa primitiva ha subito cominciato a suscitare interesse per la cura dei malati, ha ispirato una historia caritatis, il cui studio è di primaria importanza per cogliere le movenze di un atteggiamento di dedizione verso i malati, fortemente innervato di tensione etica».4 Dolorismo Nella storia della Chiesa incontriamo tuttavia un’oscillazione tra «annuncio dell’attività terapeutica di Gesù e sanzione disciplinare del divieto di praticare la medicina; tra cura della corporeità e rifiuto di essa».5 Nel corso del tempo, similmente a quanto accaduto con altri simboli e raffigurazioni legati a Cristo (il pesce, l’àncora, il buon pastore con l’agnello sulle spalle…), si fece strada, soprattutto in Occidente, una concezione che metteva al centro la sofferenza della croce piuttosto che la luce della risurrezione. Una visione dalle tinte forti ma oscure, che appunto privilegiava quello che poi, in età contemporanea, sarebbe stato chiamato «dolorismo». La teologia tradizionale finì così per ignorare la differenza tra la sofferenza inflitta a causa dell’ingiustizia degli uomini e quella, per così dire, «naturale»; dimenticandosi Il Regno - 391-400_doss-CR.indd 395 attualItà 12/2013 395 02/07/13 16.50 tudio del mese S Sofferenza e guarigione nei Vangeli La relazione che risana è un episodio che risale a circa una decennio fa. Davanti alla camera di correzione – in pratica di tortura – di una prigione del Camerun era appeso un cartello con scritto: «La sofferenza conduce alla saggezza». Parole, in quel contesto, irridenti e blasfeme. Il direttore della prigione neppure sapeva dell’esistenza della scritta. Informatone da una giovane volontaria italiana, l’ha tolta, continuando però ad affermare la validità del suo contenuto. Fermo restando che, assunta in quella forma crudele, la sofferenza conduce al massimo a un’avvilita sottomissione, ci si può chiedere se, in condizioni più umane, il nesso tra sofferenza e saggezza possa rivendicare una qualche validità. Nell’esistenza di tutti si esperimenta su di sé e si osserva negli altri che ci sono dolori che fanno maturare le persone; tuttavia non è infrequente essere costretti a tirare anche la conclusione opposta: esistono sofferenze che minano in modo brutale il fisico e rimpiccioliscono e rendono gretto l’animo. La sofferenza è una sfida, non una scuola. Come in tutti i «corpo a corpo», se ne può uscire sconfitti o vincitori. Nulla è assicurato in partenza. Al riguardo non si può mai indicare un’unica, universale strategia. Di fronte al dolore la sopportazione, la rassegnazione, la resistenza, la lotta attiva, la ribellione impotente, l’offerta, il disprezzo, l’accettazione serena, l’imprecazione violenta, la speranza, la disperazione, lo sfinimento e altri stati d’animo ancora, hanno tutti voce in capitolo. Ognuno di essi, secondo i tempi e le circostanze, può essere opportuno o improprio. L’aver compresso l’arco di questo ventaglio è stata una delle più gravi responsabilità di una certa spiritualità cristiana. Essa, avendo indicato una via monocorde come l’unica consona alla fede, troppo spesso ha aggiunto un artificiale senso di colpa all’animo di chi non sa rassegnarsi allo scandalo del male. Nei Vangeli la morte di Gesù è raccontata in diversi modi. Matteo e Marco mettono sulle labbra del crocifisso il grido «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Mt 27,46; Mc 15,34; Sal 22,2); Luca parla di un sereno affidamento del proprio spirito al Padre (cf. Lc 23,46; Sal 36,1); Giovanni presenta Gesù soggetto attivo del proprio morire facendolo congedare dal mondo con l’espressione tipica di chi ha portato a termine la propria missione: «È compiuto!» (Gv 19,30). Neppure guardando all’esempio massimo costituito dalla morte del loro Signore i credenti hanno un’unica risposta. La fede davvero degna di questo nome non si sovrappone all’umano, lo vive. Non vi è alcuna risposta precostituita all’atto di vivere nella fede. Anche per il credente gli interrogativi e forse le risposte nascono entro il crogiuolo dell’esistenza. Le guarigioni e il Regno Nei Vangeli si riscontra però una costante: un loro fondamento si trova nel fatto che per i malati e i sofferenti l’incontro con Gesù è stato sempre risanante. Nel primo secolo alcune comunità cristiane hanno scelto, non senza audacia, di rendere il genere biografico «vangelo» via privilegiata per confermare e far maturare la propria fede. Da allora la vita umana del Signore Gesù è parte costitutiva del credere. Ciò fa sì che le relazioni instaurate da Gesù con le persone sofferenti rientrino nella nostra intelligenza della fede. Da esse si ricava un dato certo: la guarigione non prescinde mai dal ristabilimento di relazioni. 396 Il Regno - 391-400_doss-CR.indd 396 attualItà Per la tradizione biblica era pura evidenza che la malattia grave fosse, in senso letterale, una specie di morte in vita. Essa, infatti, riduce già ora quelle relazioni con Dio e con le altre persone che sarebbero state del tutto recise nello sheol (il luogo sotterraneo in cui si svolgeva l’umbratile vita residuale dei morti). Tra i vari luoghi biblici che lo affermano vi è il canto di ringraziamento di Ezechia, il quale, risanato grazie all’intervento di Isaia, esclama: «“A metà dei miei giorni me ne vado, sono trattenuto alle porte degli inferi (sheol) per il resto dei miei anni”. Dicevo: “Non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi, non guarderò più nessuno fra gli abitanti del mondo”» (Is 38,10-11). Questi versi, ispiratori dell’incipit della Commedia dantesca, celebrano l’avvenuta guarigione mediante un lungo squarcio autobiografico trasformato in lode al Signore. L’Antico Testamento, che contiene il più desolato canto del malato grave (cf. Sal 88), ci trasmette parimenti il più ampio e argomentato inno legato a un’avvenuta guarigione (cf. Is 38,10-20). In esso Ezechia offre a Dio il proprio risanamento, non la propria sofferenza. Nei Vangeli non c’è nulla di paragonabile. Il risanato non racconta mai il suo «prima» e il suo «dopo». L’egemonia assunta dall’incontro con Gesù è indiscussa, tutto si concentra lì. Ogni cosa si risolve nello scambio tra i protagonisti. Il modo di narrare tipico dei Vangeli stabilisce la centralità dell’hic et nunc. Non potrebbe essere altrimenti, visto che le guarigioni sono segni di un Regno tanto prossimo da essere visto in qualche modo già operante. Non è un caso che i racconti di guarigione si addensino nella prima parte dei Vangeli e si diradino drasticamente quando si incrementano i preannunci della passione. La via della croce non è la prima imboccata da Gesù nel suo cammino. Il primato dell’incontro è indiscusso; ed è anche per questo che a risanare non è solo e tanto Gesù, quanto la fede stessa di chi si incontra con lui (cf. Mc 5,33). Tuttavia molteplici sono le modalità in cui questo avviene. Ciò si giustifica per il fatto che diverse sono le condizioni dei malati: c’è chi è in grado di chiedere (cf. Mc 1,40-45), chi di osare (Mc 5,25-33), c’è chi è nelle condizioni solo di confidare nell’aiuto di altri per essere posto di fronte a Gesù (cf. Mc 2,1-12; 7,31-37), c’è chi è talmente segregato da se stesso da far sì che dal suo interno la voce sia solo quella dell’«avversario» (cf. Mc 1,21-27; 5,1-20), c’è chi non incontra direttamente Gesù ma è guarito per l’insistenza di qualcuno che domanda in vece sua (Mc 8,24-30; 9,14-28), c’è infine qualche rara occasione in cui è Gesù stesso che prende per primo l’iniziativa (cf. Mc 3,1-6). Molti sono gli atteggiamenti assunti da chi è nella sofferenza. In modo corrispondente varia è anche la mappa degli incontri risananti avvenuti con Gesù. Essa indica, allusivamente, la complessità delle relazioni da instaurare, anche oggi, con chi è nella malattia o con chi è tanto prossimo alla persona sofferente da condividerne in prima persona la condizione. Rileggere sotto questa angolatura le storie di guarigioni contenute nei Vangeli, per quanto esuli dal loro significato originario, non è affatto improprio. Piero Stefani 12/2013 02/07/13 16.50 poi che Gesù era venuto per salvare l’uomo tutto intero, quindi pure per riportare la salute fisica. La sofferenza di Cristo sulla croce era direttamente collegata alla salvezza e tutti i sofferenti, in quanto tali, potevano partecipare in un certo modo all’opera redentiva che, stando al celebre passo paolino, deve ancora essere completata. Anzi, poiché si sottacevano le istanze di giustizia sociale, così presenti invece nel dibattito odierno, proprio i malati, vittime innocenti per antonomasia, venivano assurti a prototipo dei sofferenti cristiani, pazienti per la redenzione dell’uomo. Questa visione ha avuto – e per certi versi continua ad avere – esiti paradossali e parossistici, favorendo la diffusione dell’idea che Dio «avesse bisogno» di procurarsi vittime, che il dolore in se stesso fosse una cosa buona, che i malati dovessero accettare in silenzio la propria situazione in quanto essa era la via privilegiata per manifestare la propria fede. E per raggiungere la salvezza eterna (ovviamente dell’anima). Una citazione ottocentesca – scandalosa e inaccettabile per la nostra sensibilità – vale di più di molti discorsi e testimonia una mentalità diffusissima dentro la Chiesa e fuori. È tratta da un libretto del francese Jean Lyonnard, pubblicato nel 1865, e divenuto un classico della devozione del Sacro Cuore di Gesù e di Maria, intitolato significativamente I patimenti continui del cuore agonizzante di Gesù e del cuore compassivo di Maria: «Dio, per fini a lui solo noti, si sceglie in tutti i ranghi della società cristiana delle vittime speciali, e comunica loro, per la salvezza dei loro fratelli, una più larga partecipazione alle sofferenze del suo divin Figlio, e per conseguenza al suo titolo e alla sua funzione di vittima».6 Quasi 100 anni dopo, il più alto magistero ecclesiale, quello del papa, pur cercando di proporre accenti diversi in realtà avallava la visione tradizionale del malato come «individuo privilegiato» perché più vicino alla sofferenza di Cristo. Così Pio XII esortava i malati: «La passione di Gesù – quindi la redenzione – deve essere completata (cf. Col 1,24) dalla nostra sofferenza. Voi dunque non siete inutili. Col vostro dolore soprannaturale offerto, voi potete conservare tante innocenze, richiamare sul retto cammino tanti traviati, illuminare tanti dubbiosi, ridare serenità a tanti angosciati».7 La valenza soprannaturale della sofferenza, vista come mezzo di espiazione anche per quanti sono lontani dalla fede, sta alla base della dottrina cattolica, determinando poi quelle indicazioni di natura morale specifiche dei malati. In un discorso coevo alla citazione precedente, il pontefice si rivolgeva così ai pazienti di un ospizio: «Fate la volontà di Dio. Chi più di voi può compierla tutta e con la massima semplicità? A voi, infatti, non si domanda di agire; a voi si chiede di accettare; serenamente sempre, gioiosamente, se possibile. In questa accettazione del vostro stato è il compimento della volontà di Dio in voi».8 In queste righe si coglie l’atteggiamento fondamentale di certa mentalità cattolica – diffusissima e indiscussa fino a qualche decennio fa, e oggi ancora ampiamente accettata – per cui il malato, per essere pio fedele, non dovrebbe in primo luogo lamentarsi e neppure cercare la guarigione, ma sarebbe chiamato a sopportare serenamente la pro- pria condizione, vissuta e percepita come volontà di Dio, e a dire «l’Amen della pazienza e della rassegnazione», secondo una formula molto di moda per un certo tempo. Il malato è passivo, non è più un soggetto autonomo, non deve mirare a recuperare la salute, ma la sua funzione è quella di essere un modello di sopportazione e di virtù. Questo paradigma, più simile allo stoicismo classico rispetto alla mentalità biblica ebraica e cristiana, fa da sottofondo a quel «paternalismo», così presente in ambiente sanitario, secondo il quale deve essere il medico e soltanto il medico a decidere per il paziente, mentre l’autonomia individuale viene necessariamente sacrificata. Di qui le difficoltà odierne per introdurre nella legislazione italiana provvedimenti in merito al testamento biologico, alla possibilità di sospendere i trattamenti per i malati terminali o alla stessa tutela della libertà individuale nella scelta o nel rifiuto delle cure. L’evoluzione del magistero cattolico Sul finire degli anni Cinquanta qualcosa stava cambiando con il sorgere negli Stati Uniti del movimento per l’emancipazione razziale, che poi contagiò in maniera inarrestabile tutto il campo di quelli che saranno chiamati i diritti civili. La tutela delle minoranze divenne un punto fondamentale per la crescita democratica. L’individuo possiede diritti inalienabili, a prescindere dalla propria condizione di vita: anche nel linguaggio, anche nel gergo di tutti i giorni, occorreva fare attenzione ai termini utilizzati, per esempio riguardo ai neri o agli omosessuali. Paradossalmente questo valeva (e vale) anche per i malati, benché non esista condizione più comune della malattia; tuttavia piano piano cominciò a venire meno la sovrapposizione, quasi la coincidenza tra la persona e la sua particolare condizione patologica. Questo riguarda soprattutto la disabilità: riscontriamo un’evoluzione terminologica, mutuata dal mondo anglosassone e variamente tradotta in italiano, da «handicappato» a «persona con handicap», da «disabile» a «diversamente abile» fino a giungere a perifrasi del tipo «persona che vive l’esperienza della disabilità». Questo spostamento lessicale, a volte arzigogolato e poco coerente, rappresenta però la volontà di rompere la stretta identificazione tra la persona e il malato. Questa rottura stenta a verificarsi nella mentalità comune e ovviamente si verifica ancora meno nel magistero ecclesiale, così lento a fare propria qualsiasi istanza di cambiamento. Chi è malato, e in particolare chi è disabile, sicuramente sarà almeno una volta incappato in «bravi cristiani» sempre pronti all’aiuto e sempre pronti a ricordare che il malato è diverso dagli altri. Purtroppo questi atteggiamenti fuori luogo, forse dettati da buona fede ma non per questo meno stolti e arretrati, sono molto più appannaggio delle persone religiose rispetto a quanti si dicono laici, non frequentano la Chiesa e sono pure anticlericali. Nella mia esperienza personale ho trovato molta più comprensione in queste persone rispetto ai credenti: negli ambienti laici che frequento vengo trattato normalmente, con i miei pregi e i miei difetti. Non sono un eroe, non sono un bambino. Non sono un esempio. E soprattutto la mia condizione non è connessa in nessun modo – e non può essere altrimenti – a Dio e alla religione. Altrimenti ritorniamo ai Il Regno - 391-400_doss-CR.indd 397 attualItà 12/2013 397 02/07/13 16.50 tudio del mese S 398 commenti dei discepoli che dicono, alla vista del cieco nato guarito da Gesù: ha peccato lui o i suoi genitori? Ancora oggi però la Chiesa tende a considerare i malati come una categoria univoca e soprattutto a parte, come angeli in terra privi di sostanza concreta, senza corpo, senza desideri, senza voglia di vivere. Involontariamente si costringono i malati a essere malati per sempre, contraddicendo in maniera stridente l’antico e sapiente adagio «non dire gobbo al gobbo». Così Lochet sintetizzava questa consuetudine nel 1962: «Non abbiamo bisogno di una farmacia spirituale, ma di un buon nutrimento comune. Ciò che i malati chiedono non è una cappella di infermeria, ma la Chiesa. Abbiamo bisogno semplicemente di una spiritualità. Non domandiamo che si apra per noi una nuova scuola di spiritualità, dove tutto sia visto attraverso un’ottica di malati e in odore di ospedale. Che non ci si parli continuamente “in quanto malati”, come se non si volesse sapere altro da noi; prima di essere malati siamo uomini e figli di Dio».9 Una riflessione anche oggi validissima. Mentre cresceva nella società l’importanza della salute, trasformatasi ben presto in salutismo, ossia nel bisogno, se non di essere, almeno di apparire fisicamente in forma e di mascherare il trascorrere del tempo, si assisteva, pure nel mondo cattolico, a una riproposizione – almeno nelle riflessioni più consapevoli – di una lettura più positiva e più vicina alla realtà concreta, se così si può dire, della salvezza annunciata dal Vangelo. La salvezza di Cristo non può essere completamente disgiunta dalla salute del corpo o per lo meno non può essere contrapposta a essa, quasi che il malato in lotta per la sua guarigione fosse percepito con sospetto invece di essere incoraggiato nel suo cammino. Alcune citazioni papali degli anni Sessanta, estratte da pronunciamenti piuttosto estemporanei, senza pretesa di solennità e di ufficialità, testimoniano questo cambio di paradigma. Giovanni XXIII, che pure manteneva sostanzialmente l’impostazione dei suoi predecessori, grazie alla sua spiccata capacità intuitiva e «profetica» riuscì prima di altri a entrare in sintonia con il mondo che cambiava. I malati diventano improvvisamente non soltanto soggetti attivi, ma possono concretizzare le virtù cristiane in un senso mai preso in considerazione fino ad allora: il superamento con vari espedienti delle difficoltà legate al corpo è un esempio di forza e di determinazione valido per tutti. Qui però non ci si riferisce a quell’atteggiamento, in fin dei conti pietoso e paternalistico, con cui sono trattati soprattutto i disabili, considerati come detto in precedenza eroi per antonomasia poiché «sopportano» la loro condizione (spesso a torto ritenuta dall’esterno insostenibile), ma all’idea che essi siano in grado di offrire qualcosa agli altri. Giovanni XXIII, in un discorso del 1960 ai paraplegici sportivi, connette invece direttamente questa visione a un particolare passo evangelico che parla di «violenza», intesa come sforzo deciso in direzione del raggiungimento di una meta, anzi della Meta, il regno di Dio: «Voi avete mostrato ciò che può realizzare un’anima energica, malgrado gli ostacoli – in apparenza insormontabili – che il corpo le oppone. Lungi dal lasciarvi abbattere dalla prova, voi la dominate, e con un sereno ottimismo voi affrontate delle prove apparentemente riservate ai soli uomini validi. Cari figli, Il Regno - 391-400_doss-CR.indd 398 attualItà voi siete una dimostrazione vivente delle meraviglie che può operare la virtù dell’energia. Perché l’energia è una virtù, una virtù necessaria all’uomo, più necessaria ancora al cristiano, secondo l’insegnamento stesso di Cristo: il Regno dei cieli soffre violenza, sono i violenti che se ne impadroniscono» (cf. Mt 11,12).10 Sulla stessa linea, nel 1963, Paolo VI: «Ciascuno voglia ognor meglio temprarsi e diventar maestro di energia umana e cristiana, che affronta la vita con disinvoltura e con la vittoriosa attitudine, promanante dallo spirito. Siano coraggiosi, coltivino inalterata fiducia, facciano quanto possono per abilitare la vita all’attività a cui deve essere destinata e non abbiano timore di essere delle esistenze mancate o inutili».11 La parola «energia» risuona in questi discorsi come una grande novità, che però negli anni successivi non sembra sia stata raccolta in maniera adeguata. Evidentemente si tratta soltanto di spunti, che illuminano passaggi d’epoca alla cui comprensione sarebbe necessario dedicare molto spazio. Eppure può ancora essere ripresa come una felice intuizione capace di schiudere orizzonti inediti, in grado poi di affrontare le odierne sfide. Anche i malati sono attivi, possono avere voce in capitolo non solo sulle scelte che li riguardano direttamente e, dal punto di vista cristiano, contribuiscono alla comunità e si avvicinano a Dio non tanto attraverso l’accettazione passiva del loro stato, quanto per il loro esempio di lotta contro il male. Tra natura e tecnica, tra accettazione e lotta Negli anni seguenti, a livello di magistero pontificio, i gesti simbolici hanno assunto un’importanza decisiva: la nettissima divaricazione nell’approccio alla salute e alla malattia da parte di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI (e soprattutto nell’impatto emotivo e mediatico che tale differenza ha avuto nell’opinione pubblica) dimostra meglio di molti altri discorsi il mutamento di prospettiva. La mistica della sofferenza, così presente nel papa polacco, poteva essere interpretata infine come un titanismo eroico tipico di una visione dolorista della croce; l’umile gesto di papa Ratzinger, che si dimette perché le sue forze fisiche non gli consentono più di guidare la Chiesa, rompe con questo tipo di mistica, condividendo invece le difficoltà quotidiane che qualsiasi anziano o malato deve affrontare. Piero Stefani, in un articolo per Il Regno pubblicato subito dopo la morte di Karol Wojtyla,12 rifletteva ampiamente sulla visione del dolore da parte di un papa che aveva scritto tra l’altro un’enciclica, la Salvifici doloris, sicuramente ascrivibile a una visione tradizionale della sofferenza. Scrive Stefani: «La profondità abissale del mistero sta nell’affermare che non solo la redenzione avvenne tramite la sofferenza di Gesù Cristo, ma che in lui la sofferenza stessa è redenta. Per quanto non ci si precluda qualche allusione alla dimensione “soddisfattoria” della croce di Cristo, il discorso di Giovanni Paolo II non è volto né a presentare in modo strumentale il dolore, né a dare precisi contenuti ultraterreni alla redenzione. Il suo scopo più autentico è altro: mostrare come “in un certo senso” (inciso molto frequente nella lettera apostolica) la pienezza della redenzione compiutasi in Gesù Cristo debba completarsi in noi e che quindi il suo soffrire si congiunga con il nostro. 12/2013 02/07/13 16.50 In altre parole il dolore è redento là dove si presenta come redentore: “La sofferenza di Cristo ha creato il bene della redenzione del mondo. Questo bene in se stesso è inesauribile e infinito. Nessun uomo può aggiungervi qualcosa. Allo stesso tempo, però, nel mistero della Chiesa come suo corpo, Cristo in un certo senso ha aperto la propria sofferenza redentiva a ogni sofferenza dell’uomo. In quanto l’uomo diventa partecipe delle sofferenze di Cristo – in qualsiasi luogo del mondo e tempo della storia –, in tanto egli completa a suo modo quella sofferenza, mediante la quale Cristo ha operato la redenzione del mondo. Questo vuol dire, forse, che la redenzione compiuta da Cristo non è completa? No. Questo significa solo che la redenzione, operata in forza dell’amore soddisfattorio, rimane costantemente aperta a ogni amore che si esprime nell’umana sofferenza. In questa dimensione – nella dimensione dell’amore – la redenzione già compiuta fino in fondo, si compie, in un certo senso, costantemente. Cristo ha operato la redenzione completamente e sino alla fine; al tempo stesso, però, non l’ha chiusa: in questa sofferenza redentiva, mediante la quale si è operata la redenzione del mondo, Cristo si è aperto sin dall’inizio, e costantemente si apre, a ogni umana sofferenza. Sì, sembra far parte dell’essenza stessa della sofferenza redentiva di Cristo il fatto che essa richieda di essere incessantemente completata” (n. 24)». È chiaro che per Giovanni Paolo II la sofferenza in quanto tale, espressa in maniera concreta nella malattia (che colpisce i buoni e i cattivi, provocando quasi sempre «vittime innocenti») sia la dimensione che più avvicina al sacrificio redentivo di Cristo. Bisogna assolvere alla propria missione fino alla fine, così come fece Wojtyla. Chi non ce la fa più in un certo senso rinuncia alla sua vocazione. «Non si scende dalla croce»: così il card. Dziwisz ha sprezzantemente commentato le dimissioni di Benedetto XVI, banalizzando in tal modo la visione del pontefice di cui era stato a lungo segretario. Ci vorrà molto tempo per chiarire se il gesto di Benedetto XVI avrà conseguenze anche nell’ambito della visione magisteriale della malattia, oppure se tutto verrà archiviato in breve tempo come un incidente di percorso da dimenticare presto. Certo è che papa Ratzinger – a torto o a ragione indicato per anni come il più rigido custode dell’ortodossia e come fautore di una svolta tradizionalista – imprime una sterzata improvvisa proprio su un tema (quello della vecchiaia e quindi della malattia e della morte) che viene annoverato tra quelli «sensibili», oggetto di dispute bioetiche e politiche. Ci sono momenti in cui le forze del corpo non consentono più di svolgere pure il compito più alto – e ammantato di sacralità – nella Chiesa; ci sono «zone grigie» in cui ogni persona può dire «non ce la faccio più». Si apre allora uno spiraglio di dialogo per immaginare un nuovo rapporto tra natura e tecnica, tra volontà positiva del paziente e accettazione della fine, tra testamento biologico e accanimento terapeutico, tra volontà di Dio e libertà dell’uomo. Comprendere la croce Abbiamo volutamente messo sullo stesso piano ambiti molto diversi tra di loro ma che non possono essere chiariti se non si valutano nella loro radice comune: per un cristiano questa radice si trova appunto nell’interpretazione della croce di Cristo, da cui poi discende tutto. Ritorniamo così al punto centrale. Un aspetto che riguarda il cuore della fede e non un’interpretazione antropologica, frettolosamente definita come oggettiva, che si poggia sul concetto per lo meno ambiguo di «legge naturale». Tutto l’impianto dell’etica cattolica, relativa a salute e malattia, di questi ultimi anni si è basato su un pilastro così riassumibile in un linguaggio non filosofico: esiste una norma inscritta nella natura, compresa pienamente da una retta ragione e comunque perfettamente interpretata dalla sola Chiesa cattolica. Conformarsi a essa non è un atto di fede ma di ragione, cosicché chi non la ottempera è irrazionale, nichilista e addirittura «contro natura». Questa legge per esempio impone all’uomo di preservare la vita «dal concepimento fino alla morte naturale», secondo uno slogan ripetuto allo sfinimento dalla Chiesa, ma in realtà privo di concrete applicazioni pratiche. Quelli di natura, ragione, essenza, universalità delle norme morali sono concetti filosofici di difficile comprensione, per addetti ai lavori, completamente inservibili per la gente comune e comunque lontanissimi da un orizzonte cristiano. Così la posizione razionalista di un Gian Enrico Rusconi, che ha buon gioco nell’affermare: «Quando ad esempio nel dibattito sulle biotecnologie si discute dell’inizio biologico della vita umana o meglio della persona umana… i parlamentari cattolici … dichiarano di argomentare in termini razionali etico-naturali o addirittura scientifici, contemporaneamente però gli uomini di Chiesa nei loro interventi pubblici non esitano a richiamarsi direttamente all’imperativo della creazione divina… Il laico può osservare in silenzio queste incongruenze».13 Nel contesto pluralistico odierno risulta dunque molto debole la posizione cattolica quando pretende di essere l’unica depositaria della verità oggettiva («naturale») sull’uomo e di avere in mano l’unico modello razionale di riferimento per la persona umana. Il discorso pubblico e democratico implica invece una grande differenza valoriale, che deve essere accettata non solo dal punto di vista politico ma pure filosofico e forse teologico. La navigazione che abbiamo intrapreso può allora giungere a un punto di approdo; un porto sicuro che ci fa tornare indietro ai fondamenti della visione biblica della vita e della morte fortemente contrapposte l’una all’altra. Da qui scaturisce un ripensamento delle basi stesse della fede cristiana e in particolare della funzione redentiva della sofferenza. È evidente quanto su questo terreno si giochi gran parte di quell’approfondimento teologico avvenuto nell’ultimo secolo, volto a presentare in una luce nuova il messaggio evangelico, per troppo tempo declinato attraverso le categorie del peccato, del dolore e della paura. L’attesa di una salvezza concreta, inaugurata dalla risurrezione di Cristo, era stata sostituita dal timore per la sempre possibile dannazione dell’anima e dall’imminente giudizio divino: la sofferenza era comunque vista come una purificazione dalla colpa, quasi mai come un segno della caducità del mondo e dell’uomo da cui un giorno, secondo la promessa, dovremo essere liberati. Bisognava dunque, come detto in precedenza, accettare, tacere e rassegnarsi. Il Regno - 391-400_doss-CR.indd 399 attualItà 12/2013 399 02/07/13 16.50 tudio del mese S Una tale impostazione non poteva, un giorno, che essere rigettata: sembra possibile stabilire almeno in parte un parallelo tra la progressiva secolarizzazione delle masse e la rappresentazione di un cristianesimo oscuro e così lontano dalla sete di vita delle persone. Oggi assistiamo invece al tentativo di rileggere la passione di Cristo con una sensibilità più adeguata alla convinzione diffusa (e forse più naturale) secondo cui la sofferenza è sempre qualcosa di negativo da combattere o da rifiutare. Per una certa tradizione tutto ciò può creare problema, perché mette in discussione un’interpretazione consolidata – ma ora giudicata inaccettabile sia dal punto di vista esegetico sia da quello teologico – del sacrificio espiatorio di Cristo basato essenzialmente sulla morte cruenta. Visione sintetizzata da questo passo del 1954, tratto dalla prestigiosa Enciclopedia cattolica: «Il dolore sopportato con amore e con rassegnazione aumenta il merito delle azioni e unisce più intimamente a Dio, rendendo il sofferente più simile al divino Salvatore che volle attraverso al dolore e alla croce redimere l’umano genere dalla colpa».14 Da ciò deriva una serie di fraintendimenti e di approcci sbagliati alla salute e alla malattia che hanno finito per aumentare sempre di più il divario tra l’etica cattolica e il comune sentire della gente. Dal Novecento in poi – ci riferiamo soltanto al campo della medicina – è stato tutto un inseguimento da parte del magistero cattolico, incapace di rapportarsi con le nuove conquiste tecniche e scientifiche e con la nuova mentalità che si stava diffondendo: dai trapianti agli anticoncezionali, dalle cure palliative all’accanimento terapeutico, dalle cellule staminali alla fecondazione assistita, la frontiera di quella che genericamente viene chiamata bioetica è stata mano a mano sempre più fortificata, rendendo molto problematico il rapporto tra la Chiesa e il mondo. In questo ambito l’apertura alla contemporaneità, inaugurata dal Vaticano II, sembra quasi non essere mai avvenuta. Così non stupisce che uno dei primi santi canonizzati da papa Francesco, l’11 maggio scorso, sia mons. Luigi Novarese, fondatore del Centro volontari della sofferenza e dei Silenziosi operai della croce. Anche se il papa ha detto che «l’apostolo dei malati» «ha saputo rinnovare la pastorale dei malati rendendoli soggetti attivi nella Chiesa», le parole, lo stile e le stesse meritevoli opere di carità sorte grazie all’impegno di Novarese ricalcano una mistica della sofferenza di altri tempi. Ed ecco l’esaltazione della malattia, che più invalidante e visibile si presenta meglio è, così da realizzare una vicinanza ai malati quasi morbosa. Un altro episodio, al limite del ridicolo, è stato quello del presunto esorcismo effettuato dal papa in piazza San Pietro nei riguardi di un disabile: la notizia, smentita poi dall’ineffabile Dino Boffo che pare l’abbia inventata di sana pianta, dimostra come tutti però hanno preso per buona l’implicita e possibile connessione tra disabilità e possessione diabolica. Pochissimi si sono scandalizzati per questa eventualità. La Chiesa deve dunque compiere ancora molto cammino. L’attesa della salvezza e della liberazione Un nuovo approccio al dolore e quindi alla malattia riuscirebbe forse a riavvicinare l’etica cristiana e la sensibilità 400 Il Regno - 391-400_doss-CR.indd 400 attualItà comune. Sintetizza il grande teologo protestante Karl Barth: «Come l’esilio e la schiavitù, la malattia appare così come la realtà provvisoria la cui liberazione sarà il segno dei tempi nuovi. Non è paradossale il considerarla, da questo punto di vista, come la realtà che deve essere abolita e la cui presenza è precisamente destinata a mettere in luce la grande e concreta verità della salvezza».15 Esilio, provvisorietà, realtà presente a cui si contrappongono liberazione, salvezza, tempi nuovi: sono questi i due poli dentro i quali si può collocare una visione adeguata della malattia e generalmente del male del mondo, la cui definitiva abolizione diventa il segno concreto dei tempi escatologici. Ed è questo un altro punto ineludibile, ma praticamente rimosso fino a un passato recentissimo: il rapporto di tensione tra il difficile presente di sofferenza e la promessa futura di liberazione che sempre anima il messaggio della Bibbia. Una tensione che non si potrà mai risolvere ma che nello stesso tempo dà la forza per resistere al male, in tutte le forme con cui esso deturpa e avvilisce la nostra esistenza. Certamente da parte cattolica si tende sempre a smussare gli angoli, privilegiando la logica dell’et et piuttosto che quella dell’aut aut. Un atteggiamento completamente agonico nei confronti della malattia confligge non solo con la tradizione ma pure, oserei dire, con una visione generale delle cose. Riferito al nostro tema Sandro Spinsanti, autore di un libretto che abbiamo citato più volte, conclude la sua riflessione con queste parole: «Il dilemma della lotta e dell’accettazione non si risolve negando uno dei termini – magari in tempi successivi – ma approfondendolo e facendo dei due termini due dimensioni coesistenti nell’unico atteggiamento cristiano di fronte alla malattia».16 Piergiorgio Cattani 1 C.M. MaRtInI, Le ragioni del credere, Mondadori, Milano 2011, 1176. Per un’ulteriore bibliografia sul tema salute/malattia cf. A. autIeRo, «Contributo della teologia morale per l’etica della medicina», in L. loRenzettI, Teologia e bioetica laica, EDB, Bologna 1994; F. CaRetta, M. PetRInI, Ai confini del dolore. Salute e malattia nelle culture religiose, Città Nuova, Roma 1999; G. CoRbellInI, Breve storia delle idee di salute e malattia, Carocci, Roma 2004; A. MatuRo, Sociologia della malattia: un’introduzione, Franco Angeli, Milano 2007; L. PaReyson, Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza, Einaudi, Torino 1995; G.E. RusConI, Quel che resta dell’Occidente, Laterza, Bari 2012; C.F. sInoPolI, Salute, malattia e sofferenza: tra valori ed etica, Messaggero, Padova 2008; S. sPInsantI, L’etica cristiana della malattia, Paoline, Roma 1971. 2 S. zuCal, «Società analgesica e domanda filosofica sul dolore», in Per la filosofia 13(1996) 36,15-21, qui 15. 3 G. CoRbellInI, Breve storia delle idee di salute e malattia, Carocci, Roma 2004, 17. 4 autIeRo, «Contributo della teologia morale per l’etica della medicina», 56. 5 Ivi, 66. 6 Citato in sPInsantI, L’etica cristiana della malattia, 45. 7 Ivi, 54. 8 Ivi. 9 Ivi, 75. 10 Ivi, 63. 11 Ivi, 69. 12 P. stefanI, «Il magistero della sofferenza», in Non temete. Giovanni Paolo II memoria ed eredità della Chiesa, numero monografico di Regnodoc. 7,2005,17-20. 13 G.E. RusConI, Quel che resta dell’Occidente, Laterza, Bari 2012, 169. 14 Citato in sPInsantI, L’etica cristiana della malattia, 69. 15 Ivi, 175. 16 Ivi, 123. 12/2013 02/07/13 16.50
Scarica