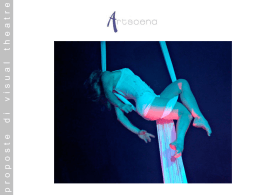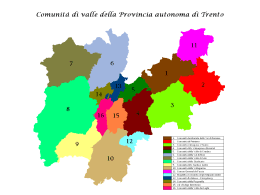Carmela Bernasconi Semini Siamo nati per la vita Storia romanzata degli anni trascorsi da un medico condotto in un circondario di montagna, tra il 1905 ed il 1925, nel ricordo della figlia. Pubblicata a Mendrisio nel 1974 (Questo testo è a libera disposizione dei lettori, ma solo per una personale privata lettura.) PRESENTAZIONE Carmela Bernasconi-Semini ha raccolto in questo volumetto, cedendo alla cordiale insistenza di parenti e amici, una serie di racconti, o piuttosto di capitoli, già usciti in un settimanale di Mendrisio. Attraverso l'affettuoso memorare dell'autrice, riviviamo gli anni della sua fanciullezza, trascorsa con la famiglia in valle Onsernone, dove il padre era medico condotto. Anche alla nostra memoria tornano i facili versi del Fusinato, che l'autrice ci ricorda... «Arte più misera, arte più rotta Non c'è del medico che va in condotta», con un'altrettanto nota, e certo per maggiori titoli, pagina del Fucini, poiché il libro è innanzitutto, attraverso la rievocazione di una cara immagine di padre, che è facile immaginare ragionevolmente severo e trepidante di ferma sollecitudine per figli e pazienti, un generoso devoto omaggio all'opera svolta con profonda umanità, spesso con rara abnegazione, dai medici condotti del nostro Paese. Medici che, nelle eccezionali condizioni in cui erano chiamati a operare, nelle valli del Sopraceneri soprattutto, dovevano essere chirurghi, certo, ma anche ginecologi, dentisti e perfino veterinari. «L'Onsernone è valle aspra, disagiata e povera, la tremenda fame che la travagliò nel 1816-17 passò in proverbio come cosa estrema».., dice il Bianconi in un suo recente libretto. Il padre dell'autrice era medico condotto in Onsernone, abbiamo detto, e non è certo difficile immaginare quanto disagiata fosse la valle ancora cento anni dopo che il proverbio ne aveva fatto, per la storia locale, «la valle della fame» (definizione che in casa nostra, con rabbia campanilista, era stata voltata in «valle della fama»). Nelle memorie della Bemasconi Semini, che naturalmente vive con gli altri "dutturitt" (i figli del medico) la vita del villaggio capoluogo, ritroviamo notizie delle fatiche, dei disagi grandi, degli estenuanti disperati litigi per un «termine», di tutte le sventure, insomma, dei poveri abitanti della Valle, di montanari, che credo siano veramente stati i contadini più poveri del mondo (i rimasti, quelli che non avevano avuto il coraggio di fare il fagotto dell'emigrante), dai duri lavori fissati per l'eternità dall'alternarsi delle stagioni; brevi le pause, per le poche povere feste, che del resto finivano per comportare, spesso, qualche fatica supplementare per abbellire la chiesa con pizzi e fiori di carta, ripulire case e strade, prepararsi alla confessione e alle devozioni. Di «ricchi», solo uno ne compare in queste pagine ed è lo stesso che, ancora parecchi anni dopo, veniva indicato a noi, ormai adolescenti, come l'unico «sciur» della valle. L'autrice ci traccia qualche altro ritratto di adulto, ma ha naturalmente cari nel ricordo soprattutto i coetanei, come ha sempre più nell' occhio il quadro naturale e il paesaggio, la strada giornalmente percorsa dal medico in diligenza o, d'inverno, in slitta, i prati con la breve esplosione dei fiori prima della fienagione, gli alpi, il bellissimo laghetto dei Salei, sopra Comologno, la «nitida pupilla» di un bel verso del Tarabori. Piacevole sorpresa incontrare, nel libretto, persone, fatti, avvenimenti, che hanno, più tardi, eccitato anche la nostra fantasia di adolescenti, avvenimenti che anche a noi erano sembrati addirittura fiabeschi, come l'arrivo in valle, e l'insediamento, nientedimeno che di una colonia di Olandesi. Tanto che ancora parecchi anni dopo, ci spingevamo fin nei tornanti sotto Vergeletto, a piedi o con un vecchio biciclettone prestato, a spiare le finestre della «villa», nella speranza di chissà quale fantastica apparizione. Su quei tornanti si arrampicava giornalmente il medico condotto. E gli anziani lo ricordano ancora oggi (così come la figlia ce lo descrive in tenuta invernale, alto, col passamontagna e la pellegrina, accompagnato dal fido postiglione Morgantini («ul Murgant») lungo quella strada ancora oggi così tortuosa e disagevole da tenere lontana la gran massa dei turisti (ma forse è questo il primo segno di un cielo finalmente benigno agli Onsernonesi). E così l'affettuosa rievocazione degli incanti di una fanciullezza trascorsa in una casa per molti aspetti certamente invidiabile, in un'oasi di serenità dove perfino c'era spazio per l'invenzione di un gustoso lessico familiare (le pagine dedicate ai «telami delli ragni» sono certamente tra le più felici della raccolta), diventa anche un omaggio alla valle che l'autrice ha tanto amata e che con tanta nostalgia ricorda. Un omaggio per il quale ogni Onsernonese le sarà certamente grato. Bixio Candolfi UNA CONDOTTA DI VALLE Una valle longitudinale, severa dentro i suoi numerosi e lunghi avvallamenti. Aprica e sassosa, era a tratti anche avara di verde nei primi anni del novecento, quando il medico dava inizio alla sua missione. Una dozzina di paesi abbarbicati sul pendio o riposanti in qualche breve conca del monte. Al centro della valle il capoluogo, residenza obbligatoria del medico: nella sua abitazione a tipo di chalet c'era la moglie e mezza dozzina di figlioli, tre bambine e tre maschietti. Lì dentro, nell'angolo della casa ombreggiata da un annoso castagno, c'era il suo studio letteralmente tappezzato di libri, tra i quali emergeva l'armamentario dei «ferri del mestiere» in solido acciaio cromato, lucidissimi e sempre pronti per l'uso. Valle e casa erano tutto il suo regno, tutto un mondo per la sua tenace energia e per la sua missione, il respiro della sua vita. ACCANTO A LUI I due robusti cavalli della vecchia diligenza federale fermi sotto la tettoia diedero segni di impazienza appena udirono il fischio del treno che sostava davanti alla stazioncina di Pontebrolla. E scesero i viaggiatori che dovevano proseguire verso le Centovalli e l'Onsernone. Il postiglione Morgantini, notissima e tipica figura, tanto da non poter immaginare la vecchia diligenza senza di lui, si diresse verso il trenino con il suo passo pesante e cadenzato, ad incontrare qualcuno. Era scesa in quell'istante una gentile figuretta di donna ancor giovane e fresca nella sua maturità, che portava sul braccio un bimbetto e per mano un altro frugolo di poco più grande. Qualche passo più avanti la figliola maggiore dall'aria consapevolmente giudiziosa teneva d'occhio una monelluccia saltellante che poteva avere si e no sei anni. Il postiglione nella sua austera uniforme federale si presentò alla madre e senza preamboli le chiese: «siete voi la duttura? Venite con me». La giovane donna nel suo «tailleur noisette» da cui faceva spicco la camicetta in «seta cruda» con un cappellino leggermente rialzato sulla nuca da una bella crocchia di capelli corvini, alle parole del postiglione ebbe un leggero sussulto e le rosee guance s'imporporarono tenuemente. Mai nessuno l'aveva chiamata con quell'appellativo; però lo stupore si mutò subito in una vaga sensazione di sicurezza di fronte a quella maschia figura tanto sbrigativa. Seguì l'ordine impartitole e con le sue quattro creature si trovò al lato nord della piccola stazione, accanto ad una troneggiante diligenza gialla, con le grandissime ruote dalla robusta raggiera pure gialla. Pochi minuti dopo i cavalli al cenno del postiglione su a cassetta, s'erano mossi di scatto, quasi leggeri, in un trotto ritmato dal bubbolio metallico delle sonagliere a traverso i tre paesi delle terre di Pedemonte, tra il frastornante rumore delle ruote sull'acciottolato. Dentro la diligenza "al completo,, c'era gran silenzio, rotto soltanto dall'irrequieto muoversi della frugoletta incuriosita d'ogni piccola cosa del traballante veicolo. La madre spingeva lo sguardo al di là dei finestrini, intanto che i due piccoli si erano addormentati: l'uno serrato al suo petto, l'altro con la testolina ricciuta sulle sue ginocchia. Tre lunghissime ore dovevano trascorrere così, prima di giungere alla meta a riabbracciare lo «sposo», pensava la donna e stupita mirava il paesaggio, lo sfondo dei monti che pareva si elevassero sempre più alti, severi, accavallati gli uni sugli altri, sopra vallette e valloni sempre più profondi, scoscesi, misteriosi!... Non sapeva rendersene conto la giovane madre, anche se aveva più volte puntato l'indice sulla cartina geografica e ammirato le cartoline che il marito, già in Valle, le aveva inviato regolarmente. Osservava, pensava, scrutava, quasi volesse vedere in una sol volta, dove e come il «suo dottore» avrebbe percorso quei sentieri, superati quei tornanti e quelle giogaie; lei che ignorava l'austera struttura delle nostre valli, e che aveva l'occhio abituato soltanto al dolce scemare delle colline, verso il sereno piano dell'amata Campagnadorna!... E la strada saliva erta, ostinatamente ripida, tagliata a nastro dentro il robusto fianco della montagna, con il fondo ricoperto di grossa ghiaia a ciottoli aguzzi, silicei, che le ruote della diligenza spostavano, in un gioco di rumore stridulo e cigolante: era la salita dei «Sabbioni». A questo punto il postiglione scendeva dal suo seggio, buttava le redini sul largo dorso dei cavalli, e lui — il Morgantini — il fedelissimo, il forte postiglione, muoveva i passi sul ciglio della strada, a lato della pariglia, della quale ripeteva con il movimento delle spalle, il cadenzato e faticoso andare. Né si sapeva se così facesse per alleggerire il peso alle sue bestie, o per rassicurare tacitamente i passeggeri che sull'orlo dello stretto percorso, al di sopra del burrone, c'era lui, a garantire l'incolumità. Poi quando il groppone della carrozzabile si spianava, con una mossa rapida il postiglione era di nuovo a cassetta, con le briglie tra le grosse dita nodose. Mentre i cavalli riprendevano il trotto lungo i parecchi ponti gettati arditamente a traverso altrettanti giogaie, impazienti di raggiungere i primi paesi della Valle. Ma la giovane moglie non sembrava rasserenarsi gran che. Né si stancava d'interrogare il paesaggio e di meditare in cuor suo, quasi volesse presagire il futuro della nuova vita che la attendeva a lato del consorte, votato per vocazione all'arduo, appassionante e generoso compito di medico di condotta. Ed ora chiediamoci: quante di queste giovani donne — ombre fedelissime dei nostri medici di condotta — hanno vissuto l'analoga segreta vicenda del loro primo accedere in una condotta di Valle?... Tante sono, tutte oscure e tanto silenziose quanto cariche di meriti; nessuna storia ce le ricorda. Noi pure passiamo oltre, premendo pero in cuore uno slancio di femmineo orgoglio all'indirizzo di queste creature dolci e forti, come la donna biblica in quella stupenda pagina. IL TURNO DELLE VISITE II turno delle visite mediche nei singoli paesi veniva regolarmente ripartito lungo l'arco della settimana. La vecchia e gialla diligenza postale, a due robusti cavalli, era la fedele collaboratrice. Per una simpatica usanza, la cui origine forse si perde nel tempo, il medico sceso dalla «posta» infilava la gradinata verso il sagrato e giungeva alla porticina del campanile. Sapeva dove il sagrestano riponeva la grossa chiave arrugginita e pochi istanti dopo ecco il diffondersi nel silenzio di quell'aria cristallina «la campana del dottore». Un brivido sembrava percorrere le pareti di quelle case grigie strette l'una all'altra in atto di cordiale convivenza. Era un brivido di vita che faceva spalancare le porte delle case, nell'attesa settimanale del medico. Quasi come nella bella favola di «Astro fanciullo», il giovane principe atteso nella sua città che, finalmente entratovi, vede spalancarsi ai suoi occhi tutte le porte, grandi e piccole. Ma la realtà, fantasticamente vicina alla favola, si ripeteva ogni giorno a turno sempre, in ognuno dei dodici paesi della condotta di valle. Uscito sul sagrato, mentre il rintocco della campana si affievoliva, il medico s'imbatteva in qualche arzillo e asciutto vecchietto che, si era mosso incontro al dottore, per dirgli che la sua artrosi cervicale gli dava quasi pace, o che la sinovite del suo ginocchio aveva diminuito le fitte più dolorose. Una sosta in piedi a scrivere la ripetizione della ricetta per il prodigioso farmaco e poi via con l'abituale svelto passo sulle pietre dei viottoli e delle vetuste e sconnesse scalinate. Infilava la prima porta spalancata dove dentro c'era un bimbo di poche settimane, con la giovane madre che soffriva di mastite. Seduto sul gradino dell'altra porta c'era quel monelluccio dai grandi occhi azzurri che impaziente attendeva il dottore; il quale gli aveva promesso di levargli i punti di una larga ferita che s'era fatto alla pianta del piede, correndo scalzo dietro il suo cerchio di ferro. Nella cunetta della strada polverosa inavvertitamente s'era appoggiato di peso su un grosso coccio di bottiglia. Quel giorno, buono buono, si era lasciato cucire il profondo strappo nelle carni del piedino, ma aveva strillavato ribelle davanti all'ago ipodermico dell'iniezione antitetanica che il dottore gli doveva necessariamente fare. All'angolo della salita in fondo ad un cortiletto rallegrato dai gerani, il medico sapeva che al di là di quella porta spalancata al sole, avrebbe dovuto entrare più per una ragione di rimprovero che per una visita propriamente detta. La madre d'una nidiata di figlioli aveva avuto qualche mese innanzi un attacco influenzale piuttosto grave che le aveva lasciato un'infiltrazione polmonare con un residuo subfebbrile. Era poi entrata in convalescenza, ma assai stremata di forze. E la sua casa era pesante con un sovraccarico di lavori svariati da compiersi giornalmente, senza eccezioni. Come in molte famiglie della valle, alle donne di casa incombeva anche l'allevamento del bestiame, compreso quello delle numerose capre, le quali, quantunque libere nei boschi del patriziato, dovevano però essere mattina e sera richiamate, riunite sul posto per la mungitura e la somministrazione a ciascuna di esse d'una manciata di crusca e sale. Alle sole donne era riservato tutto il disimpegno pastorizio perché gli uomini, emigranti stagionali nella Svizzera francese, rimanevano assenti da casa durante tutta la buona stagione. Gli anziani e gli adolescenti s'impegnavano a dare una mano, quando a maggio la famiglia iniziava quel periodo di vita nomade sui monti alti sovrastanti il paese con tutta la carovana del bestiame. Vita beata fatta di libertà e di frugalissimo cibo, di tanto sole e verde smagliante, ma anche di molte dure fatiche. La donna in attesa del controllo medico, sentiva che le esigenze della famiglia reclamavano il suo posto di lavoro, capiva che la sua inerzia era quasi un assurdo, perciò sembrava sorda alla voce autorevole e suadente del medico che la avvertiva di non esporsi ad una ricaduta. Ma chi può far desistere una madre dal suo compito? Sarebbe come dire al fiume, libero e fecondo, di non tendere alla sua foce, o all'uccello in volo di non recare il moscerino nel becco spalancato dei suoi nati. Per il medico il turno delle visite diventava più gravoso durante il periodo invernale quando, dopo giorni e notti di fitto nevicare, la vecchia diligenza sostava bloccata in rimessa e doveva essere sostituita dalla piccola slitta postale, pur essa gialla, con lo stemma delle Poste federali. Ma quanto provvidenziale il piccolo mezzo, docile al passo del cavallo e alle redini del postiglione, dominatore sicuro in quel deserto bianco! Immancabile passeggero era il medico di condotta nel suo pastrano a pellegrina, con gli scarponi e il passamontagna. II lieto conversare dei due, medico e postiglione, legati da reciproca simpatia, rendeva piacevole quel cadenzato scivolare sulla neve. Prima dello scadere dell'inverno comparivano puntuali le epidemie dell'infanzia: morbillo, parotite, pertosse, scarlattina. Casi dislocati su e giù, un po' in ognuno dei paesi, però mai gravi, perché i ragazzi della Valle erano ricchi di sangue sano. Al medico però, spettava il coscienzioso compito di vigilare sulle possibili complicazioni che a fine del decorso infiammatorio, potevano insorgere. Sconosciuti erano allora gli antibiotici. Il dottore se li teneva cari quei frugoli febbricitanti; conquistava divertito il loro interesse, mostrando la lunga e saltellante lancetta del suo cronometro mentre controllava il battito del polso. I più grandicelli invece li intratteneva, illustrando di aneddoti l'origine e il significato dei loro nomi di battesimo o di quelli meno comuni dei loro genitori. E in Onsernone, di nomi ce n'era tutta una gamma curiosa; si voleva in parecchi di essi scorgere un segno storico o mitologico risalente chi sa, forse ai primi popoli che dal sud vennero ad abitare la valle. Tra i molti spiccano: Quirino, Pompeo, Èrcole, Aurelio, Marco, Melchiorre, Titone, Tobia, Samuele, Evaristo, Lindoro, Gentile, Geremia, Eliseo. I nomi femminili invece recavano un'impronta di chiara spiritualità: Candida, Prudenza, Speranza, Celesta, Pura, Severa, Albina, Diomira, Petronilla, Gioconda, Artemisia, Luduina e persino Panacea, il cui nome rendeva il medico così ilare da esclamare che almeno la «Panacea» non avrebbe dovuto ricorrere mai al soccorso dei farmaci. Altra clientela saltuaria era quella degli emigranti stagionali, colpiti da infortuni sul lavoro e da malanni vari, i quali rincasavano dalla Svizzera interna per ultimare la cura. C'erano poi, tra gli infortuni, quelli dei boscaioli carbonari o borradori che al servizio di una locale impresa per il trasporto dei grossi pali, lavoravano ininterrottamente i giorni e le notti a turno nei fitti boschi «a oviga» cioè sul versante destro della valle privo di paesi. Erano quasi tutti bergamaschi questi forti lavoratori, ben piantati, dalla parlata gutturale impalpabile. Parecchi di essi finivano per accasarsi in valle, dove si trovavano bene tra l'ospitalità e la cortesia degli onsernonesi; però la loro tipica figura bergamasca si manteneva tale anche con il passare degli anni. Per i casi di una certa gravità era ovvio che non potesse bastare il solo turno settimanale delle visite; per cui il medico, oltre che tenerseli sempre vicini con il telefono, riservava loro il pomeriggio della domenica. Prendeva con sé qualcuno dei figlioli più grandicelli i quali erano ben lieti di compiere l'andata in diligenza e il ritorno a piedi, a fianco del genitore che lungo il percorso di quattro o cinque chilometri, aveva così tante e svariate cose da dire e da mostrare. Durante le ore crepuscolari della buona stagione, il nastro tutto svolte della strada tagliata dentro il fianco della montagna, i ponti sopra il fiume che ruggiva trasparente e spumoso contro i piloni, le alte severe ripe dei due versanti che in certi punti sembravano volersi toccare, da lasciar quasi a fatica intravedere l'intensissimo azzurro del cielo, erano tutte immagini suggestive di viva curiosità. A monte della strada, sulle ripide rocce nude, nere e mantenute umide da rigagnoletti che scendevano da chi sa dove, crescevano disseminati con grazia, i lunghi steli a infiorescenza delle bellissime sassifraghe bianche, chine verso terra, sempre cullate dalla brezza. Spesso in una piccola insenatura della nuda roccia, da una crepa sorgeva ardita una giovane betulla dalle mille foglioline a batticuore; ammirandola da sotto in su sembrava fosse lì a testimoniare la sua vittoria per esser nata e cresciuta a picco d'un dirupo, essa tanto esile e gentile. Poi d'un tratto, ad interrompere la selvaggia solitudine della strada, ecco, rivestita di muschi, la costruzione in pietra di una cappellina, che la pietà cristiana degli avi aveva dedicato al dolce sembiante della Vergine con il suo piccolo Gesù sulle ginocchia. Intanto dagli anfratti sopra il letto del fiume salivano le ombre della sera, su su fino ad incontrarsi con il cielo che andava trapuntandosi di stelle. Ancora una svolta nel bianco della strada polverosa, e poi al di là d'una prateria, la punta dell'amico campanile. Le stesse pomeridiane escursioni per ragione medica, si ripetevano anche durante le domeniche fredde e serene del lungo inverno di valle. E non erano da meno delle altre per la ricerca di piacevoli curiosità. Quando il brullo paesaggio era quasi interamente ovattato di neve e più roca la canzone del fiume, a monte della strada, al di sopra della cunetta colma d'acqua gelata, si spiegava in tutta la sua imponente bellezza la palizzata delle pesanti candele di ghiaccio: colonne rovesciate di una cattedrale gotica in miniatura. Di candele di ghiaccio ce n'erano anche appena fuori il paese, formavano l'irresistibile attrattiva degli scolari. Alle compagne si univa logicamente la più monella delle figliolette del medico. Un giorno, nel bel mezzo della battaglia alle candele, toccò proprio ad lei riceverne la pesante punta di ghiaccio dentro le carni, appena sopra il ginocchio. Relativa soddisfazione del padre medico che con due punti metallici poteva, insieme alla buona lezione, infliggere una certa immobilità provvisoria alla sua piccola «disfattista». Chi ha dimestichezza con le bellezze non sempre palesi delle nostre vallate nel periodo invernale, sa cosa vuol dire scoprire un grosso ciuffo di vischio che troneggia verde e vivo su di una scheletrita e robusta quercia. Era la meraviglia che faceva sostare il medico con i suoi figlioli nelle sere di plenilunio, come davanti ad uno scenario lirico. Infatti, lui che la sapeva lunga di musica, che appassionatamente e con competenza si dilettava — nelle ore libere — anche di musica operistica, si infervorava spiegando, appoggiato al muricciolo del parapetto, l'incantevole scenario nel bosco sottostante. E faceva rivivere «nella foresta sacra dei Druidi», il primo atto della «Norma» quando la sacerdotessa cantava alla «casta diva» mentre con la falce d'oro tagliava il fatidico vischio. CHIAMATA NOTTURNA Nel cuor della notte uno strattone vigoroso alla maniglia della corda metallica fa rimbalzare il minuscolo batacchio del campanello dentro la camera da letto e svegliare di soprassalto i familiari. Il medico apre la finestra e dal di sotto una voce robusta scandisce: "signor dottore mi manda la levatrice, la signora Margherita, perché venga d'urgenza a Gresso per il caso che lei sa; io l'aspetto con la vettura giù in piazza". Tramestio di passi concitati, parole misurate, e a scatti precisi; tintinnio di ferri riposti dentro la capace borsa ostetrica insieme ad astucci già pronti per l'uso. Un controllo silenzioso, meditato, di brevi istanti e poi il saluto alla moglie, che resta sulla porta esterna a seguire il rumore dei passi rapidi e secchi sulle pietre della scalinata, che poi si perdono nel buio. I figlioli, svegliati all'improvviso e non in via straordinaria, si erano subito dolcemente riaddormentati. Ma la mamma no, non poteva riprendere sonno: pensiero e fantasia seguivano la vettura al trotto, con quei due lampioncini fumiganti tra le svolte della strada selvaggia e si portavano in quella casa, sotto l'incubo di un'ora fatale, dove la giovane madre, tra gli spasimi dell'attesa, che si succedevano ad intervalli, era perfettamente conscia di prepararsi ad un travagliatissimo parto. Stava per mettere al mondo la sua seconda creatura e forse si sarebbe ripetuta la lunga estenuante pena del primo parto: così la moglie del medico cercava di ricordare: "si, effettivamente, due anni fa il bambino si presentava in posizione anormale con procidenza del cordone ombelicale; ce la farà stavolta?" Conosceva, anzi era sicura che la mano esperta, dalle movenze calcolate, precise ed oculate del "suo dottore" non avrebbe fallito, eppure dubbio e paura l'assalivano; non era più possibile rimanere a letto! Al primo bagliore dell'alba che filtrava dalle tende si alzò. Si trovò al piano di sotto senza saper bene cosa mettersi a fare. La pendola scandiva in silenzio i minuti... e sembravano ore. Di tanto in tanto volgeva furtiva lo sguardo all'apparecchio telefonico dalla grossa sagoma misteriosa, sporgente dalla parete; era in attesa della comunicazione in uso nei casi più gravi. Ma il campanello taceva, imperscrutabile. Quando Dio volle il telefono squillò e la donna fece un sobbalzo. "L'operazione si è svolta normalmente, il bambino è vivo e la madre riposa". In quel momento sembrò che le pareti della stanza si allargassero, che fuori il sole fosse già alto e che lei avesse riacquistato anni di gioventù. Quando il dottore rientrò in casa i figlioli stavano preparandosi per la scuola; incontro festoso, era nato un bimbo. I più piccoli si affrettavano a chiederne il nome, mentre i grandicelli prestavano l'orecchio al conversare dei genitori che era abitualmente aperto, senza sottintesi, intercalato di termini professionali, ma naturalmente nel concetto realistico, così che essi, volta per volta si corredavano d'una certezza semplice e chiara: nel mistero della vita il "partorirai con dolore" coronato di gioia. Era risaputo — allora — dai medici di condotta, che nelle nostre vallate era frequente il parto difficile. Forse stavano in gioco due fattori: la statura della donna valligiana, spesso al di sotto della media, e l'abitudine, dettata dalla necessità, di far portare sulle spalle anche alle adolescenti gerla e "cadula" lungo i pendii dei monti. La donna onsernonese, svelta e agile, noncurante della fatica, seguiva l'inveterata tradizione senza valutare o temere le possibili conseguenze per lo sviluppo armonico del delicato e complesso organismo della giovane, destinato alla procreazione. Oggi che il miracolo della chirurgia ostetrica ci dona stupore e sicurezza, si è voluto, dopo l'istituzione delle cliniche materne sostituire al forcipe il taglio cesareo. Con risultati prodigiosi e insostituibili. Ma, come ogni cosa terrena non reca in sé la perfezione assoluta, vediamo di ragionare un istante sull'argomento. La donna vanta una superiorità biologica sullo uomo, nel senso che ha dimostrato di resistere meglio alle prove più dure dell'esistenza. Citiamo soltanto le logoranti condizioni del tempo di guerra a cui erano costrette moltissime donne. La superiorità naturale della donna non ha bisogno di statistiche; è saggiamente confermata dalla natura che all'organismo della donna impone il più pesante impegno che l'essere umano possa sostenere: il parto. Tuttavia, accanto a questa forza biologica, è connessa una profonda delicata e misteriosa sensibilità psichica. La psiche femminile è una miniera di mirevoli intuizioni, ma sgraziatamente tanto fragili che un niente a volte può rompere il delicato equilibrio. E tra queste cause ci sono i diversi incidenti riguardanti la sfera genitale. Per esempio il taglio cesareo. Non discutiamo sui casi gravi in cui spetta al ginecologo imporre il "taglio" per la vita stessa della creatura e forse anche della madre. E qui non è mai riconosciuto abbastanza il miracolo dell'odierna chirurgia, che vanta inoltre anche l'immenso beneficio di evitare alla donna i dolori del parto. Può essere questo un allettante miraggio per la giovane sposa in procinto d'essere madre; miraggio, però che può occultare delle conseguenze negative e far insorgere dopo anni un'intima sofferenza nevrotica. Man mano che il bimbo cresce e che ovviamente la madre lo vede staccarsi dalle sue materne apprensioni, essa inconsciamente può credere di amar meno quel suo figlio che non ha messo al mondo in una diretta testimonianza di sacrificio. Può essere un caso limite, ma il problema si fa chiaro anche con una semplicistica similitudine che non vuol essere retorica: chi non riconosce la salda gioia della conquista a coloro che, potendolo, si impongono la paziente fatica, lo estenuante sacrificio, di giungere passo dopo passo alla vetta del monte, senza ricorrere ai moderni, facili mezzi di trasporto? Altro problema comune ai medici di condotta d'allora, se pure non frequente, ma arduo nella sua intima e delicata struttura, era quello della ragazza madre e del figlio suo! Non che lo stesso problema sia oggi scomparso dalla società, tutt'altro! E però diminuita la desolante difficoltà finanziaria che ineluttabilmente il caso recava con sé. Non esistevano allora le previdenze sociali e le casse di malattia; sconosciute erano pure le provvidenziali opere private per la maternità e l'infanzia. Si consideri inoltre la cruda sequela di pregiudizi ambientali, mai disgiunti dalla colpa d'onore, e avremo così il quadro penoso della ragazza madre, sola e indifesa a sostenere un peso sproporzionato alle sue forze morali e fisiche. Il medico di condotta avvertiva la sconcertante situazione e tanta più pena provava in cuor suo, quando il caso particolare ostacolava la ricerca della paternità del nascituro. Molto spesso era un selvatico fiore germogliato durante il periodo della caccia alta che richiamava sui monti della valle l'elemento forestiero. Pagina nera questa, da imputare purtroppo alla cinica superiorità dell'uomo maschio che tradisce gli obblighi della sua dignità e si maschera dietro una troppo facile ipocrisia! E la creaturina cresceva, accanto all'amorevole solitudine della madre nubile, la cui florida e sana bellezza di vallerana si scoloriva e intristiva in breve volgere di tempo. Medico e levatrice (vera sage-femme quella signora Margherita!) vegliavano di comune accordo e vigilavano inosservati il crescere e il maturare del figlio di N.N.: consapevoli, ne spianavo prudenti la muta reazione che fatalmente sarebbe sorta dentro di lui, quando, da altri e non dalla madre, gli sarebbe stata duramente svelata la cruda realtà di figlio bastardo! Era ineluttabile e non c'era nulla da fare. Egli avrebbe maturato a poco a poco la ferma risoluzione di emigrare oltre oceano, per confondere, negli sterminati orizzonti della California, il pesante segreto, legato al suo destino. CARO FIUME Onsernone la valle; Isorno il fiume: due nomi dissimili ma che si integrano nell'espressione fonetica; così come l'una, la valle è fatta per l'altro, il fiume. Ha un lungo austero percorso l'Isorno. Generalmente incassato tra i fianchi della montagna, a tratti si stende, si rilassa, quasi volesse giocare e spumeggiare attorno a giganteschi macigni levigati d'uno splendente granito! Poi subito si arresta dentro profonde buche d'un verde cupo, quasi tacito e pensoso; pochi attimi, poi via di corsa sprizzante, trasparente, vigoroso. Mai però irritato quel caro fiume; sempre laborioso e dignitoso come la gente della sua valle. Non fa mai bizze l'Isorno, non ha mire espansionistiche come tanti suoi fratelli che, rompendo d'improvviso gli argini, usurpano la pace altrui. L'Isorno è paziente, è sobrio anche quando di inverno, dopo lunghe nevicate, precipitano le slavine dai canaloni del Ruscada e piombano sulle sue acque, quasi a soffocarlo. Lui non si ribella, non straripa, ma rinvigorisce la sua forza d'erosione e pazientemente scava e scava sotto la massa di neve gelata frammista a pietrami, e vincitore, ritrova il suo corso, il suo eterno andare. Può dirlo chi l'ha contemplato e inconsciamente gli ha voluto bene, perché quelle acque con la loro sommessa canzone, accompagnavano i passi del medico di condotta, quando a piedi percorreva la strada a strapiombo sopra il fiume, tra un paese e l'altro della Valle. Come d'un individuo che lungo l'arco della sua vita s'è fatto per meriti un nome, istintivamente si va alla ricerca dei suoi natali, così parlando d'un fiume non si è paghi se non si risale a scoprirne la sua sorgente. Le carte geografiche insegnano che L'Isorno ha due belle e distinte sorgenti, distanziate l'una dall'altra e con caratteristiche proprie. L'una quasi a rivendicare la razza latina dei suoi valligiani, nasce in territorio italiano, in quel di Craveggia e parecchio cammino nel fondo della valle deve percorrere, prima di scivolare via, noncurante del confine italosvizzero, e giungere a Spruga, lambendo le balze rocciose, giù, giù, sotto l'aprico villaggio, posto in cresta al monte. L'Isorno di Vergeletto detto meglio «Ribo» più vivo e sbarazzino del primo, conquista subito la simpatia di chi, a ritroso, sale verso la sua sorgente, con la curiosità e l'impazienza di giungere a scoprire il perché della sua vivacità; del correre giulivo e irrequieto delle sue acque mutevoli anche nel riflesso delle tinte: dall'immacolato latteo, al trasparente vitreo, dall'azzurro cielo, al verde buio, quando di proposito s'allarga verso il margine per sorvolare sornione un buchetto rivestito da sonnolenti piante acquatiche. Ma la sua sorgente è ancora tanto lontana e tanto in alto, su oltre i 2800 metri, dentro l'arcano avvallamento di Porcareccio, in territorio valmaggese. Lì forse ha rubato le bellezze delle acque della Maggia d'un tempo; da lì è scaturito libero e ciarliero pago di trovarsi tra la beatitudine alpestre d'una valle meravigliosa; la valle del Pian delle cascine; angolo nostrano aperto e ridente, quasi in contrasto con l'austera fisionomia di tutta l'Onsernone. I due fianchi che lo determinano sono mollemente foggiati a terrazzi e declivi, rivestiti di faggi, betulle, carpini, ontani, pini e abeti che vivono meravigliosamente associati, offrendo alla nostra ammirazione la varietà delle loro robuste forme e la ricchezza delle loro svariate tinte, dentro il gioco dei raggi d'oro d'un sole tutto onsernonese. Nel sottobosco, tra i soffici tappeti di muschio, la costellazione dei fiori, dolcemente aggregati alle fragole e ai mirtilli. Sul piano della valle il fiume, a saltelli come un fanciullino, allarga a poco a poco i suoi margini e s'adagia in un letto di ciottoli levigati, bianchi o striati di gneiss, tra la sabbia finissima, scintillante di quarzo e mica. Al margine, sul lato sinistro, la strada segue parallela gli svolti e i dolci meandri. Se c'imbattiamo sul finire di giugno, nei giorni in cui si caricano le mandrie agli alpi di Casone e Porcareccio, allora è gioia grande partecipare alla bucolica scena, tender l'orecchio alla canzone dei grossi campani e ripensare estatici al «ranz des vaches» dei pastori d'oltre Gottardo. Mentre ci scostiamo per lasciare il passo ai docili quadrupedi, non è raro il caso che qualche giovenca, attratta dal ciangottare vivace dell'acqua, rompa la fila per affondare le unghie delle zampe anteriori e poi tutto il muso, per ristorarsi in quelle fresche e chiare acque. E perché non imitare la giovenca?... L'invito è troppo lusinghiero: chini sulla riva raccogliamo l'acqua nel cavo della mano e avidamente vi porgiamo le labbra; è acqua purissima quella, non ancora contaminata dall'uomo, acqua ebbra di sole, gonfia d'ossigeno. Le due belle sponde del fiume, ad intervalli vengono collegate tra loro da primordiali ponti costruiti semplicemente con due robusti pali di conifere, tenuti insieme da un assito sconnesso che passandovi sopra, vi capita talvolta di scorgere tra le fessure qualche grassa trotella punteggiata d'argento, saltellante tra la spuma bianca. Sono pregiate le trote dell'Isorno di Vergeletto! Lo sa l'uomo del pesce conosciuto in quasi tutti i paesi della Valle: «ul Martin di pess». Chi l'incontra per la prima volta ci resta un po' male, e forse se ne scosta con un istintivo senso di paura: ma è soltanto un falso allarme, suggerito dall'aspetto di quell'uomo, scamiciato, con il petto irsuto, un paio di pantaloni indefinibili per stoffa e colore che, sbrindellati scendono sui piedi scalzi avvezzi a camminare sulle pietre, se li giudichiamo dalla scorza scura dei calcagni; cammina dinoccolato e svelto, con a tracolla una vecchia borsa di paglia, e appoggiata alla spalla, una primordiale lunga canna da pesca. Ha i capelli radi e lunghi fin sulle spalle, la barba incolta; vi guarda noncurante con la bocca atteggiata ad un riso indefinibile, mentre articola qualche parola mozza. Se siete donna si sofferma a mirarvi un istante e butta fuori il suo ritornello gutturale: «na bela femna», e se ne va. Povero Martino: non è un selvaggio come lo si crederebbe a prima vista; non fa paura: è soltanto un minorato, una di quelle povere esistenze maltrattate dalla natura fin dalla nascita, uno di quegli individui che dalla società di allora furono sempre abbandonati alla loro sorte, come uomini non recuperabili. Vive solo, «ul Martin di pess» in una vecchia cascina, ch'era dei suoi genitori, morti innanzi tempo; alleva una capra e poche galline e si fa tutto da sé. Non vuol nessuno, perché nessuno deve sapere dove nasconde i soldi che ricava dalla vendita delle sue trote. Un giorno — chi sa come — nel bosco si fece una profonda ferita lacerocontusa al braccio, molto sanguinante. Non voleva essere curato; ma qualcuno, mosso a pietà chiamò d'urgenza il medico che pazientemente e con studiata perizia riuscì ad accattivarselo e finalmente a mettergli in sesto la fasciatura. In seguito, quando gli capitava d'incontrare il dottore, gli mostrava con l'indice il suo braccio cicatrizzato... e se la dava a gambe! Lo sciabordio del vivacissimo Isorno di Vergeletto, ci richiama alle sue sponde, rammentandoci le vicende del suo percorso: episodi, memorie, leggende, fantasia e realtà. Il Pian delle Cascine, centro maliardo di questa regione alpestre sta inserendo sul passato dei germogli nuovi che possono essere forieri di un promettente avvenire turistico. E la «Pro Onsernone» che se ne prende la responsabilità, elabora i progetti, studia le prime possibili iniziative. La «Pro Onsernone», con alla testa un Comitato intraprendente, legato alla causa da intelligente amor di paese, è nata proprio a Vergeletto nel lontano 1903, quando in tutto il Cantone erano quasi inesistenti le «Pro». Se dopo i primi anni felici conobbe qualche stasi (e quale società ne va esente?) da qualche tempo ha ripreso vigore e attività. Ogni anno, alla fine di luglio la Pro Onsernone, forte di molti soci e simpatizzanti, tiene la sua Assemblea in un caratteristico contorno festoso al Pian delle Cascine, dove attinge linfa fecondatrice da quelle aure imbalsamate, dal sole che gioca tra l'ombra della ricca boscaglia e dalla gioconda canzone delle trasparenti irrequiete acque del Ribo. L'attuale comoda rotabile a lato del fiume, vuol essere il primo e allettante richiamo per trasformare gli esistenti casolari vuoti in altrettante casette di vacanza, da parte dei moltissimi onsernonesi domiciliati fuori della Valle, che sempre ogni anno, nel giorno della festa sociale, ritemprano il loro invitto attaccamento alla terra degli avi. Vergeletto è una di quelle località montane che viste una volta non te le scordi più; un paesino di meraviglie. Alla minuscola piazza fa da sfondo l'antica chiesetta con il suo piccolo sagrato semicircolare: un lindo bavaglino sotto il musino pulito d'un bimbo. Al suo lato s'apre stretto un viottolo sassoso che svolta in su; subito accanto, un vecchio mulino con finestrelle e logge sconnesse. All'angolo destro irrompe invadente e vaporosa una cascata che flagella le pale della ruota di legno e le fa ostinatamente girare, dentro il fragore d'una canzone avvincente. Appena qualche metro dal tonfo dell'acqua ecco in veste signorile l'«hotel des neiges» grazioso albergo trapuntato di finestrelle e terrazzini che sa offrire, con la pace serena, anche un'ottima cucina. Per parecchi anni la sorella più giovane del Dottore, maestra di scuola a Mendrisio, lì trascorreva le sue vacanze, scegliendosi la cameretta proprio prospiciente la cascata del mulino, perché — diceva — quella voce ritmata dell'acqua che cade, concilia il sonno, lo popola e lo arricchisce di sogni fantastici: sono a volte gli accordi sognanti della musica di Grieg dentro i fiordi norvegesi o lo scrosciante applauso nel chiuso d'una oscura sterminata platea; oppure di colpo la fluente schiuma bianca colpisce gli occhi sotto le palpebre, ma che non è se non il sole già alto che filtra dalle tendine e ti ridà la reale visione delle cose. Ma non è tutto: un'altra meraviglia ci chiama oltre il viottolo, dietro il mulino; di subito intravedi, da una rupe guarnita di betulle, una massa d'acqua immacolata che scende a getto continuo; sembra leggerissima spuma ed è invece la cascata della «Camana», e la sua eterna canzone ci vuole là sotto, ad ammirare il raro spettacolo e irrorarci con l'aspersione della sua acqua benedetta. L'acqua delle due cascate si riunisce proprio sotto il selciato della piazzetta che fa da ponte, poi raggiunge il fiume che scorre via. Ora L'Isorno si è fatto adulto, ma canta ancora più sonoro e più deciso a scendere verso la bassa valle; nel suo letto selvaggio aggira i macigni che vorrebbero impedirgli il corso, urta e leviga i sassi meno grossi tra balze e schiume rabbiose. Intanto i due fianchi delle montagne diventano sempre più robusti e minacciosi, si stringono a soffocarlo in una delle più orride strozzature dell'alta valle. Costretto da quella morsa paurosa, il fiume con una brusca gomitata cambia direzione e si porta tutto a sinistra. La strada sorvola il baratro con un ardito ponte che pianta i suoi piloni nella viva roccia. A transitare da quel ponte, da dove a stento scorgi un lembo d'azzurro su tra le altissime severe cime, un brivido ti corre per la pelle. Il medico quando talvolta rincasava a piedi con a lato uno o due figlioli, si soffermava nel mezzo del ponte perché anche loro imparassero a contemplare il grandioso spettacolo della natura, anche a traverso l'orrido. Ma di sera no! Essi si stringevano forte al braccio del padre e chiudevano le palpebre fino allo svolto dopo il ponte, perché non volevano vedere il tremolio di ombre che la fioca luce della lanterna appesa all'occhiello del pastrano del padre proiettava ingrandite sulla roccia sporgente. Forse in quegli istanti la loro fantasia era più che altro soggiogata da un fatto realmente accaduto qualche anno prima proprio sullo stesso ponte. Stavano per calare le ombre serali di una notte lunare d'autunno; transitava sul ponte un «char-à-banc» tirato da un robusto cavallo, le cui redini erano nelle mani di un giovanotto avvezzo a quella strada, pratico di quegli antri. Rincasava al suo domicilio nel capoluogo della Valle, dove teneva con l'aiuto della madre un avviato negozio di ogni genere, e recava la merce — all'ingrosso — anche ai negozietti di altri paesi; in più, con il fratello gestiva un albergo con «buvette». I due fratelli erano anche soci di una impresa per il taglio delle «borre», ricercate a quei tempi per i pali del telegrafo e del telefono. Era un uomo accorto e navigato, laborioso, con una personalità volta verso un certo materialismo della vita. Quella sera, strano caso, il cavallo forse adombrato dal gioco di luci proiettate da un lunone che spuntava dietro la cresta d'una oscura abetaia — non s'è mai saputo come — diede uno strattone tale che il timone si spaccò netto e il cavallo, sorvolando il parapetto cadde dritto nel profondo pozzo verde del fiume. Il carro per l'urto asportò il muricciolo e andò a pezzi sul breve spiazzo di un macigno appena al di sotto della strada, trascinando seco l'uomo che, chissà come, restò lì quasi vi fosse stato comodamente adagiato. A casa, la madre turbata per il ritardo del figlio, mandò alla ricerca due inservienti che attaccarono l'altro cavallo ad una vecchia carrozza. A stento, con cautela e fedeltà, lo caricarono e lo riportarono a casa salvo; solo immobilizzato ad una spalla e al gomito, ambedue rotti. Per liberarlo dagli indumenti dovettero adoperare le forbici; la madre si prese fra le mani la giacca squartata, e con un gesto scenico levò dal di sotto della fodera qualcosa che mostrò agli astanti: «ecco chi ha salvato dalla morte mio figlio: la Madonna di Re». Essa, all'insaputa del figliolo, cuciva sotto la fodera delle giacche l'immagine sacra di quel Santuario tanto caro agli Onsernonesi. A quelle parole il ferito girò lo sguardo sorpreso verso la madre, ma non proferì verbo. Appena rimessosi in sesto, manco a dirlo, il giovanotto riprese in pieno il lavoro, gli affari e l'andirivieni sulle strade della Valle con un «char-à-bancs» nuovo fiammante. Qualcuno asseriva — ma assai a bassa voce — che quando transitava su quel ponte si facesse svelto il segno della croce. Non che il giovanotto si vantasse anticlericale (parola di moda in quegli anni) però era chiaro che i comandamenti di Dio gli erano poco congeniali o meglio, certuni gli riuscivano scomodi. Gli amici lo canzonavano, ma in complesso godeva ovunque simpatia e benevolenza dai suoi dipendenti che gli riconoscevano valida rettitudine nei loro confronti. L'episodio dello scampato pericolo lo rese ancor più popolare: tutti lo interrogavano incuriositi, ma lui si limitava a dire che solo sua madre sapeva perché era scampato dalla morte. Era del resto un individuo complesso e superdotato di vitalità. Qualche anno prima dell'incidente, con quale entusiasmo aveva aderito al progetto lanciato dalla città di Lugano per la costruzione di un crematorio cantonale! Ne parlava come di una scoperta luminosa. Il giorno in cui gli aderenti erano stati convocati a Lugano per la posa della prima pietra, egli vi si era recato con il simbolico mattone di una ben nutrita banconota. Di ritorno, ebbe particolari interessantissimi da raccontare a tutti, e da quel raduno euforico gli rimase sempre nel suo dire una frase famosa che intercalava con studiata opportunità: «le fiamme purificatrici, il fuoco purificatore». In Valle, come del resto in tutto il cantone, erano anni di un certo mal celato fermento politico e i «maggiori» dell'uno e dell'altro partito cercavano di foggiare le coscienze dei cittadini più per spirito di lotta che per convinzione. Così nascevano e prendevano corpo certe ideologie già bacate sul nascere. Gli Onsernonesi per loro natura aperti e dignitosi, non succubi — e ne fanno fede i fatti storici dei secoli scorsi nel testo di Lindoro Regolatti — se in quegli anni non avessero avuto pressioni di parte piuttosto accese, avrebbero superato con minor difficoltà e con esiti più positivi certe inevitabili crisi che intaccavano le finanze, l'economia, la pastorizia, l'emigrazione. Un altro ponte sovrasta ardito le acque dell'Isorno e solo a qualche chilometro da quello di cui ci siamo testé occupati. Esso ha un nome coronato da celebrità, anche se nessun cavallo è stato inghiottito nei gorghi delle sue oscure acque: è il «Ponte Oscuro». Però è un nome grammaticalmente improprio perché il Ponte Oscuro non è uno solo con una sola arcata, come ne vediamo a centinaia nelle nostre valli; esso è l'incrocio ad angolo retto di due solidissimi ponti che vantano ben tre arcate ciascuno, imponentissime e robuste, dentro cui l'occhio si perde con un senso di tenebrosa soggezione. Ma è un attimo solo; qualcosa ti distoglie dalla paurosa contemplazione e ti fa sorridere Sul crocicchio delle tre strade (la prima che viene da Vergeletto, l'altra che prosegue per Spruga e la terza a pochi minuti da Russo) mentre al centro dei due ponti ammiri il gioco curioso che fanno le giogaie dei monti accavallantesi dentro il profondo cuneo, vedi ergersi ardita, leggera, in bianca veste, una betulla altissima al di sopra delle arcate, e sembra lì a vigilare e a rassicurare i tuoi passi. Anche il medico con i figlioli faceva la fermata d'obbligo al Ponte Oscuro, giungendovi nelle belle ore diurne; c'era un gaio esperimento da compiere con una certa accortezza che divertiva e abbreviava la fatica del camminare. Nella cunetta della strada polverosa, i due figlioli raccattavano ciascuno un sasso, uno di grossa mole e l'altro assai piccolo che venivano allineati sul piano del parapetto, proprio nel punto sovrastante perpendicolarmente al centro del profondo pozzo verde che si scorgeva giù, nel letto selvaggio del fiume. Il padre, che pareva lui pure divertito, già teneva in mano il cronometro pronto a far scattare la lancetta appena iniziava la caduta dei sassi: erano pochi secondi di profondo silenzio, d'intensa concentrazione su quei due corpi di peso diverso, che abbandonati nel vuoto scomparivano insieme dentro il gorgo delle acque. Riprendendo il cammino la conversazione si imperniava su certune parole difficili, alle quali il padre si sforzava di dar un senso: la gravità, la resistenza, il moto uniformemente accelerato. Ma ai figlioli interessava assai più il fatterello di Galileo che dall'alto della torre di Pisa, aveva fatto precisamente ciò che essi facevano spesso al Ponte Oscuro gettando i due sassi dal peso diverso. Mentre la strada che dal Ponte Oscuro conduce a Russo è stagliata sul fianco sassoso del lato sinistro, il fiume si scosta sempre più a destra, e sprofondando più in basso corre ad incontrare il fratello suo, l'Isorno dell'altra sorgente; sotto le bolle di Crana avviene la confluenza. Da qui un solo Isorno con un volume d'acqua più imponente, più severo e più oscuro, eppure assai meno rombante perché le falde del Ruscada imprigionandolo, gli attutiscono il rumore. Il fiume scompare dalla nostra vista, privandoci della sua irruente e pur familiare compagnia, quasi fosse diventato un fiume sotterraneo. Ma non diamoci per vinti; dobbiamo affrettarci a ritrovare il suo corso, ad ammirare molto da vicino le sue acque, per carpire dentro le sue onde un arcano segreto, il mistero delicato ed avvincente d'una leggenda, nata proprio dentro i suoi flutti. É necessario portarci fino a Mosogno e scendere a saltelli ancor più in basso di una sua piccola frazione, per una ripida scalinata tutta pietre e ciuffi d'erba. Laggiù il nostro Isorno è attraversato da un antichissimo, solido ponte a schiena di mulo, di ridotte dimensioni; un ponticello costruito da chissà quali rustiche mani che, pietra su pietra, hanno fortemente allacciato le due sponde del fiume e lo hanno chiamato «ponte della Neveria». Di là, su un civettuolo spiazzo verde sorge la chiesina dello stesso nome, di epoca medioevale, ornata da un minuscolo campaniletto, la cui unica campanella squilla a perdifiato una sol volta all'anno, il mattino del 16 luglio per festeggiare la Madonna del Carmine, a cui è dedicata quella «casuccia del buon Dio». Corre a un lato della chiesina un sentiero ben battuto nell'erba che prosegue e si addentra, seguendo il fiume, nella fitta boscaglia di faggi. Quella è regione riservata ai «carbunatt», taglialegna specialisti nel ricavare dalle «biche» la carbonella, pregiato utilissimo combustibile del passato. Ma anche di un passato assai remoto, se vogliamo dar fede alla strana leggenda di quel preciso luogo. E qui ci vorrebbe la grazia del poeta per trascrivere intatto nella sua fine cesellatura il racconto, reso vivo dalla voce e dalla fede delle vallerane. Quel mattino di festa c'era brulichio di fedeli e di vivaci ragazzini dentro e fuori la chiesa; stava per iniziare la Messa. La campanella inondava l'aria di gioia e i tocchi argentini echeggiavano dolci fin dentro il bosco dove ferveva il lavoro dei «carbunatt». Uno tra essi, un bergamasco alto e ben piantato, fece ai compagni una scommessa, scandita in parole povere ma decise, che li fece tutti allibire. E non fecero nemmeno in tempo a farlo desistere dal suo incredibile sacrilego proposito perché sull'istante, voltate le spalle si incamminò sicuro verso l'oratorio in festa. Che cosa avrebbe fatto? Ritto e confuso tra gli altri, fissava la celebrazione eucaristica e dopo «l'Agnus Dei» si portò anche lui all'altare per comunicarsi. Poi subito uscì dalla porticina laterale, levò dalla bocca la sacra particola e l'adagiò tra i rami di una fascina che affidò alle onde del fiume, il quale, cullandola come una gondola, se la portò lontana. Il taglialegna rivoltosi poi ai compagni esclamò: «ce l'ho fatta!» II dì seguente, in una di quelle bellissime albe rosate di luglio, improvvisamente i tocchi affrettati e frenetici della campanella ruppero il silenzio dell'ora mattutina. Le case della frazione si destarono, s'udì un vocio confuso e un ticchettio di passi correre giù verso il ponte, mentre la voce irritata del custode della chiesina esclamava: ma chi è entrato in chiesa senza la chiave? E intanto la campanella sembrava impazzire: suonava e chiamava, suonava e chiamava!... Gli accorsi, diretti all'oratorio, furono fermati di botto sulla schiena del ponte, con le teste chine verso l'acqua del fiume: alla base del più grosso macigno si era incagliata una fascina e sopra, sul piano levigato e biancastro, era comparsa una strana cosa. Al centro di grandi semicerchi iridati dai più vivi e luminosi colori, sorgeva nella sua bianchezza immacolata, il cerchio perfetto di una piccola ostia! Venne anche il curato in camice ed aspersorio; tra un silenzio di mistero, scandì in latino l'oremus degli esorcismi di allora... e benedisse! L'ostia parve ancora più nitida su quel tabernacolo al centro del fiume. Tutti entrarono nella chiesuola e incominciò la Messa: la campanella si tacque. I taglialegna che in disparte e ammutoliti avevano seguito la scena a capo chino, disparvero entro la boscaglia. Cercarono, chiamarono il compagno, oppressi da un incubo. Non c'era più. Nella baita erano sparite anche le sue poche robe. Era sparito il taglialegna e nemmeno era giunto a casa sua, giù nel Bergamasco. Solo molto tempo dopo, si sparse la voce che un taglialegna s'era messo al servizio d'uno di quei signori feudali della terra lombarda; e che poi si era arruolato cavaliere con l'armatura di ferro, gli sproni, la spada, l'elmo, la visiera, e sul petto la Croce di Cristo. Da quanti secoli è nata la leggenda? Nessuno lo sa. Però tutti possiamo oggi ancora sporgerci sul ponte della Neveria e ammirare il mistero di quei cerchi iridati, difesa e protezione della piccola Ostia bianca. Ma il nostro fiume, correndo verso la foce, qualcosa ha ancora da svelarci: forse è un monito di saggezza per i suoi valligiani.Giunto alle falde del bel monte di Calascio da un lato, e gli avvallamenti di Auressio dall'altro, con un ultimo brusco dislivello di oltre duecento metri, l'Isorno si adagia sul piano delle terre di Pedemonte, incontra il fiume Melezza che scende dalle Centovalli: vi si getta e... perde il suo nome! Anche se oggi la confluenza dei duecorsi d'acqua avviene in condizioni mutate da quelle che furono sempre lungo l'arco dei secoli, da chi sa quale lontanissima epoca. Isorno e Melezza, da sempre due fiumi fratelli, entrambi liberi e selvaggi, recanti ognuno un quasi egual volume d'acqua viva, spumeggiante e fiera. E quel loro incontro nei pressi di Intragna poteva essere l'immagine d'una vita operosa, il coronamento vittorioso d'un lungo avventuroso e selvaggio cammino per entrambi. Presa dell'Isorno a Mosogno (foto OFIMA) Ma oggi che è successo al Melezza? Lo scorgiamo affacciarsi sul piano senza vita,umiliato nel suo ancestrale superbo incedere, defraudato nel dovizioso suo volume d'acqua. Si aggira pigramente attorno ai macigni e ai ciottoli asciutti del suo grande letto, come se avesse smarrito la strada! Il genio e la tecnica dell'uomo gli hanno interrotto il corso, lo hanno costretto a fermarsi, proprio sul punto più pittoresco d'un suo meandro, contro una superba sporgenza rupestre rivestita d'abeti. Per chi sale la strada sul lato opposto della valle, sbucando da una svolta, ha l'illusione di trovarsi davanti ad uno dei meravigliosi laghetti alpini. Ma non è che una illusione. Subito ci si accorge di trovarci di fronte ad una paurosa prigione di cemento armato. Allora un brivido ci percorre le membra, una visione apocalittica ci sfiora lo sguardo: e se un giorno quella massa d'acqua, in un impeto di rabbiosa vendetta, rompesse le sbarre per evadere in una scatenata libertà? Sarebbe — come più di una triste esperienza ci ha ammonito — la giusta sconfessione della tecnica di fronte alla superiorità della Natura. L'Isorno nell'abbraccio con il fratello Melezza, avverte lo strano mutamento e si prepara a scoprire, qualche chilometro più avanti, una seconda ugualmente squallida scena; l'incontro con il fiume Maggia, nei pressi di Ponte Brolla. Il fiume Maggia! Altro meraviglioso fiume dal lungo, ricco corso, dentro un'altra bellissima valle. Le generazioni passate ne andavano fiere, scrittori e poeti ne cantarono le bellezze.Cos'è oggi il Maggia? L'immagine di una devastazione, la realtà di una ricchezza perduta, senza speranza di ricupero! Se provassimo a sfogliare qualche vecchio manuale scolastico di geografia, stupiti, increduli, vi leggeremmo press'a poco così: «Il Maggia, con l'apporto delle acque dell'Isorno e del Melezza, forma un lungo, marcatissimo delta alla foce nel lago Maggiore, la cui lingua di sabbia finissima si prolunga ogni anno di più verso il centro del lago. Le generazioni future vedranno il lago di Locarno tagliato in due parti dalla strozzatura che il delta gli imporrà contro la montagna del Gambarogno». Ma oggi — tutti lo sanno, il delta della Maggia ha pure esso perduto la sua vitalità. Nemmeno l'Isorno non gli reca più il suo volume d'acqua; la sua canzone è diventata triste: avviciniamolo nella fantasia, cediamogli la parola, perché esso ha qualcosa di molto serio da dire ai suoi valligiani che stanno lassù, trai cari monti d'Onsernone. Ascoltiamolo; la sua voce è sincera. «Chi meglio di me sa tutto di voi, cari abitatori della mia Valle? Ho visto nascere i vostri antenati, venuti dal sud, all'epoca preromana, a dissodare le ricchezze delle foreste, attorno alle mie acque. Ho seguito tutte le evoluzioni della vostra storia, chiara, semplice; ho ammirato la vostra tenacia nella durissima lotta per l'esistenza, ho apprezzato l'attaccamento al vostro angolo di terra, la vostra solidarietà, lo spiccato spirito d'indipendenza duro e dignitoso. Io conosco tutte le vostre alterne vicende della buona ed avversa fortuna, il periodo fiorente dell'industria della paglia, la lavorazione redditizia del legname al tempo dei borradori; poi a causa della concorrenza, il decadimento delle due industrie e quindi la miseria, anche la fame, sopportata con una fierezza ed una dignità senza pari. Poi il rifiorire del vostro ricco Patriziato, la costruzione della strada carrozzabile, a tronchi, con sacrifici immensi; la creazione delle prime scuole, per voi che, prima e meglio di altri vallerani, avete apprezzato l'istruzione popolare al punto d'eliminare l'analfabetismo con un risultato d'avanguardia rispetto alle altre regioni del Cantone. Neppure scorderò i vostri sacrifici durante la prima guerra mondiale, il tesseramento, il dilagarsi della tremenda epidemia gripposa, durante la quale il vostro medico di quel tempo ha conosciuto e partecipato a tutte le dolorose conseguenze; e l'emigrazione stagionale e quella nelle remote terre d'oltre oceano. E la seconda guerra mondiale con gli sconvolgimenti sociali, tecnici, industriali, morali; e infine l'attuale dolente nota che colpisce in generale le valli: lo spopolamento, la fuga dai nostri amati villaggi montani delle migliori giovani energie, delle più belle, promettenti intelligenze. Io, vostro unico corso d'acqua, giunto quaggiù alla foce, ormai esausto in sì povero e squallido letto, vado riandando il mio e vostro passato, il nostro comune presente, e mi rattristo: le mie acque non sanno più cantare, hanno perduto la loro cristallina purezza... Vogliate, o cari miei vallerani, tendere l'orecchio, anche se la mia voce vi giungesse roca e fessa. A volte sono preso da un segreto senso di terrore: come utilizzano le mie acque, imprigionate a mezzo il corso in una conduttura forzata e costrette a passare al di là della mia montagna, dentro il buio d'una galleria? Con quale reddito per tutta la mia valle? E qui la voce dell'Isorno che più su ci esortò ad ascoltarlo, si tacque un istante. Poi riprese: «... da questa mia desolata foce, prima ch'io mi perda dentro le acque del lago, lasciate ch'io riveda un'ultima volta, tra la maestà selvaggia, sul margine di un burrone, serrato tra nere montagne, una piccola rude sagoma di un'antica Cappella: — la Madonna delle due sponde. Sorge ai piedi di Auressio, proprio di fronte al campanile di Loco, occhieggiante tra i castagni, al di là della selvaggia sponda e par voler sussurrare: «Rinuncia a percorrere l'interminabile avvallamento, spicca un breve ardito volo dal tetto della mia cappellina, ed ecco evitato l'inutile lungo percorso...». E' ancora la voce fantastica del fiume che vuole, in un ultimo anelito nostalgico, esortare i suoi vallerani a gettare arditi ponti sopra gli avvallamenti, perché, avvicinati i paesi, rifiorisca l'antica proverbiale ospitalità onsernonese, e viva e fattiva offra ai visitatori, con il sole, l'aria pura e le fresche acque, la serena e tranquilla convivenza umana. «I TELAMI...» Già era l'ora dell'ambulanza e nessuno aspettava il medico: così che i familiari si attardavano attorno al desco in uno di quei rari momenti di serena distensione che la cura. della condotta sapeva a volte generosamente elargire. Ma ecco dalla terrazza qualcuno s'intravvede, bussa e cautamente spinge l'uscio biascicando con evidente confusione qualche parola di scusa; fissa l'occhio sulla persona del medico e prorompe con voce d'angoscia: «Signor dottore... non ne posso più...». E' uno del paese che ha la sua casa su, su, in cima alla «gana» proprio a ridosso del monte, quasi seminascosta da annosi e fronzuti castagni. Giovane d'anni, ma d'aspetto più che maturo, come spesso sono i vallerani che trascorrono i giorni in una monotona ininterrotta solitudine laboriosa, in quel momento appariva sofferente oltre l'usato. Con uno scatto mette sotto l'occhio del medico il pollice della mano destra gonfio a dismisura, tumefatto, irriconoscibile nella sua forma e nel colore della pelle. Allora, nel silenzio del locale, tuonò la voce severa del medico: «Giovanotto, cosa avete messo su questo dito?» ... «ho messo (e la parola stentava ad uscire dalla gola) ...ho messo (e intanto col naso in su fissava l'angolo del soffitto) ...ho messo ...i telami delli ragni!...». Seguì un attimo di silenzio, di sospensione incerta. Il medico non afferrò in pieno il significato, al che la moglie osò suggerire: «le ragnatele». Poco mancò che in quel momento si udisse il malcelato scoppiettio d'una risatina, subito spenta da un'occhiata di fuoco della madre al più sbarazzino dei maschietti. La nidiata rimasta sola al rinchiudersi delle due porte che separavano dallo studio, diede libero sfogo all'ilarità; dall'inconscio di ognuno stava sprigionandosi quel godimento crudele che a volte s'impossessa della psiche infantile e si traduce in gioconda espressione chiassosa. Che gusto puntare il dito verso l'angolo del soffitto e ripetere divertiti: «i telami delli ragni!». Era così nata all'improvviso una delle frasi più espressive, proprie ad un lessico familiare che, una volta entrate dentro, vi si abbarbicano per un lungo volger di anni, con un significato puramente intelligibile dentro le pareti domestiche: «sei proprio un telami»... capitava di sentire la voce irata del fratello buttata in faccia all'altro, se in quel preciso momento non capiva una spiegazione, o non se la sbrigava in un qualsiasi impegno. E l'epiteto — anche passati gli anni — conservava tutta la sua ironia, quando con cognizione di causa si dicevano tra loro i fratelli: «ce ne sono di telami a questo mondo!». Ma in famiglia ormai nessuno ci faceva caso, e gli altri, parenti o estranei, nemmeno sapevano avvicinarsi al significato vero del curioso vocabolo. Quel giorno però, al di là delle due porte, l'episodio del patereccio di Ercole, non era certo cosa da poco. Intanto che la moglie (infermiera occasionale) preparava l'iniezione antitetanica e dall'armamentario levava l'occorrente per l'operazione e la medicazione, il medico dava inizio alle prime disinfezioni del dito e allestiva il termocauterio per la bruciatura. Per una ormai lunga esperienza psicologica il dottore sapeva che bisognava distrarre l'attenzione del paziente, stendere il suo spirito turbato dalla febbre, i suoi nervi doloranti; perciò con studiata impercettibile procedura gli poneva le domande del caso, l'aiutava a rispondere con esattezza e a cucire con nesso logico, l'istoriato dell'accaduto e la vera ragione di quei «telami» assurti a sicuro medicamento. Al momento di accomodare con un capace fazzoletto la mano fasciata al collo del paziente, il dottore con visibile soddisfazione, gli raccomandava che a casa si mettesse subito a letto, tranquillo; e aggiunse: «domattina verrò io a misurarvi la temperatura; dalla farmacia riceverete per posta domattina un depurativo da prendersi, un cucchiaino tre volte al giorno. Avete corso un brutto rischio giovanotto! Perciò ricordatevi un'altra volta che le ragnatele sono un ricettacolo di polvere e di microbi, specie quelle della stalla!». Infatti l'uomo aveva a poco a poco confessato al medico che non una, ma parecchie volte si era recato nella stalla a prendere «i telami» d'apporre sul dito terribilmente dolorante. E c'era la ragione, però con un non ben definito motivo. Il bisnonno del giovane, che già era nato in quella stessa vecchia casa in cima alla «gana», aveva in paese la fama di saper guarire le infezioni delle ferite, dei paterecci e dei foruncoli purulenti. Doveva essere stato uno di quei guaritori che s'incontrano in ogni regione più o meno grande, ai monti e al piano. E di solito i guaritori sono anche erboristi competentissimi. Non vogliamo qui alludere a quell'altra caterva di presunti guaritori che, spacciandosi per tali, ornano il loro verbalismo di formule e superstizioni inspiegabili. I primi, dotati di una naturale intuizione, di una particolarissima inclinazione ad avvicinarsi alla natura, studiandola traverso l'alterno gioco delle stagioni, sono corredati di memoria e senso di raziocinio superiore alla media. Generalmente sono individui introspettivi, di poche parole e con un certo sguardo profondo. Individui dotati d'intelligenza e su di essa non si discute; è un dono, meglio, una scintilla di grazia elargita all'uomo dal Creatore. E chi non ci dice che questi individui dotati, se avessero potuto corredarsi di studi, conseguire una laurea scientifica, non sarebbero stati in grado di dare innanzi tempo all'umanità qualche prodigiosa scoperta del nostro tempo? La confessione che il medico aveva saputo strappare al suo paziente era culminata con un particolare di un certo interesse, oscuro a capirsi. Il bisnonno, lui, le ragnatele non le cercava dentro le stalle! Bensì dentro quei piccoli antri che i massi erratici, precipitati dall'alto in chissà quali epoche geologiche, sovrapponendosi l'un l'altro, avevano originato; cavità al riparo dal sole, dall'aria, e dalla polvere. Con un nome generico si dicono «caverne» ma gli onsernonesi nel loro dialetto le chiamano: «i baalm». Orbene, dentro le pareti di questi antri, l'inconscio naturalista raccoglieva probabilmente insieme alle ragnatele, dei frammenti di «muffe», di licheni, che, sparsi con una certa sapienza sulla pagina superiore di speciali foglie, venivano applicate delicatamente sui gonfiori purulenti. E lentamente le fitte dolorose diminuivano, rossore e gonfiore si attenuavano, il paziente adagino ritrovava la calma. Casi simili, ricercati un po' ovunque tra la gente rurale, possono accertare analoghe esperienze. Parecchi anni corsero via dopo il curioso episodio del patereccio. E chi ancora lo ricorda?... Nel frattempo anche la famiglia del medico aveva subito una di quelle svolte che logicamente e inevitabilmente mutano la fisionomia di un nucleo familiare: figli che si accasano, altri che per ragioni di lavoro o di studio si allontanano dal tetto paterno. E la nidiata, un tempo compatta, chiassosa e scanzonata, si era ridotta alla metà. Quel giorno il padre venne a sedersi a tavola con l'aria di chi ha qualcosa di nuovo da comunicare. Teneva fra le mani una delle sue riviste professionali aperta ad una pagina con l'articolo già segnato a matita rossa: «Le monde medical» un mensile da Parigi. Le riviste del medico di condotta; amici sinceri, consiglieri silenziosi e altrettanto preziosi, anche nei particolari casi di diagnostica. Dalla vicina Italia la posta recava pure due quindicinali di gran pregio: «II policlinico» e «La ginecologia moderna». Figlioli, disse, prima ancora di portare alla bocca il cucchiaio della minestra fumante — chi di voi ricorda la storiella di quel guaritore che si diceva cercasse dentro le pareti dei «baalm» i suoi rimedi per le ferite purulenti?» Ma ci volle la madre a rendere edotti i tre figli e richiamare il ricordo lontano. Allora la conversazione si rianimò fino alle allegre allusioni. Il padre che intanto si era ammutolito, riprese tra le mani l'articolo della rivista e con una certa solennità lesse che da un recente congresso di medici e scienziati alla «Sorbona» veniva lanciata al mondo una grande scoperta: «Un medico inglese, A. Fleming, aveva accidentalmente estratto dalle culture di una muffa una sostanza antibiotica detta «Penicillium notatum» che iniettata nell'organismo combatte con efficacia le infezioni. E l'articolo faceva seguire il commento sugli immensi benefici che la scoperta avrebbe ben presto recato all'umanità. Infatti, circa un ventennio dopo, Fleming era proclamato «Premio Nobel» per la medicina (1945). Ma il medico di condotta non c'era più; da qualche anno aveva chiuso la sua non breve giornata terrena. La notizia del premio Nobel a Fleming fece rievocare ai figli le parole pronunciate da Lui quel giorno a tavola mentre teneva fra le mani il suo «Monde medical». «Chi mi vieta di pensare che quell'ignaro oscuro guaritore della "Gana" potrebbe essere stato inconsapevolmente un precursore del grande Fleming?». DENTARIA Quando al cadere dell'inverno subentra quel periodo insignificante di transizione, di muta attesa, anche le valli assumono un aspetto scialbo, anonimo. Scomparsa la neve, il brullo dei prati spenti fa il paio con gli alberi ischeletriti quasi gementi sotto le raffiche di un vento spietato. Come ogni anno nella natura, così ogni fine inverno nelle case! Con una puntualità esacerbante tornano i vari malanni, le solite febbri influenzali, le inevitabili epidemie infantili, i reumatismi, lo «stridor di denti». Si direbbe una comune oscura intesa di sofferenza della natura con l'uomo: il trionfo del vento e l'attentato al sistema nervoso. Il lavoro del medico di condotta in quel periodo si accentua, le chiamate telefoniche si intensificano, il pomeriggio dell'ambulanza è al suo completo. Fra chi attende c'è spesso anche qualche ragazzino dell'età scolastica, l'età della seconda dentizione. Bello è mirare questo ometto quando, finita l'operazione, esce dallo studio tenendo stretto nel cavo della sua piccola mano un batuffolo di cotone idrofilo, dentro cui sta nascosta la corona annerita d'un suo molare, causa di tanti strilli dolorosi. Egli trionfante porterà a casa quel brutto dente per gettarlo sulla fiamma crepitante del camino e compiere con serietà metodica e giocosa un rito: così ha fatto suo padre, suo nonno, recitando con cantilena l'antico distico ritmato e ben accentuato nel dialetto di valle. Quel fuoco che distruggendo il dente vecchio deve ridare al bambino il nuovo robusto dente, non potrebbe identificarsi con l'immagine di quei fuochi di primavera che accesi sulle prode e sui cigli dei prati devono far rispuntare più vigorosa la nuova vegetazione? Forse è questa arcana corrispondenza tra il creato e la creatura che ha fatto germogliare lungo i secoli le belle leggende e i saporiti proverbi delle nostre terre! ... Se il piccolo episodio dell'ilare ragazzino ci ha distolti dal nostro intento, non ci ha fatto però scordare che ad attendere il medico in ambulanza ci stanno spesso anche gli adulti, sotto l'incubo tormentoso del mal di denti. E l'ansia appassionata di farla finita con tanto stridore infernale fa loro superare la paura del dolore che l'estrazione vera e propria del dente deve necessariamente provocare. Ma essi sono anche sorretti da una fiducia particolare nel loro medico dentista che si è acquistato la fama di saper cavare i denti con grande rapidità, perché — asseriscono — ha il polso franco. Dal canto suo però il medico di condotta — dentista obbligato — sa cosa voglia dire spolpare le radici dei grossi molari, a volte piantate a sghimbescio dentro gli alveoli, o strappare a forza la radice lunga a fittone dei canini. Ci vuol perizia e una certa chiaroveggenza. Non sempre esiste un rapporto diretto tra un individuo ben piantato fisicamente e una dentatura parimenti robusta; può succedere un rapporto di antitesi per una lieve anomalia dello sviluppo scheletrico. Perciò il dottore prima di agire deve premunirsi e rendersi diagnosticante conto, caso per caso. E non dimentichiamo che allora era sconosciuta nell'odontotecnica la pratica della radiografia dentaria. Per di più i medici di condotta non facevano uso degli agenti anestetici iniettati sotto le gengive. L'unica forma di leggera anestesia gengivale esterna, era data dalla spruzzata di etere. Ogni medico poi usava i propri accorgimenti. Perché il paziente non perdesse il coraggio al momento buono, gli si occultavano le bacinelle con le diverse tenaglie, le pinze sottili e grosse, quella di particolarissima forma e struttura, a cui si attaccavano certi uncini destinati a smuovere le radici negli alveoli, prima di procedere all'estrazione finale. E l'ultima avvertenza che forse aveva in sé un occulto beneficio fisiopsichico era l'ordine perentorio che il medico dava al suo paziente: ...... su un fiato lungo con la bocca spalancata!». E prima che la faticosa frase fosse terminata, la tenaglia gi à aveva ghermito il dente fino al colletto. L'attimo di silenzio era seguito da un urlo selvaggio cavernoso, rotto al suo nascere: e il dente sanguinante, dentro la piccola morsa della tenaglia, veniva presentato al suo padrone ....! Lo spasimo cessava all'istante e tra paziente e medico si stabiliva in quel preciso momento un'arcana commossa corrispondenza di sentimenti: entrambi erano vittoriosi..... In un pomeriggio di domenica scialbo e triste per i sibili ventosi che premevano contro le fessure delle porte, uno strano episodio di dentaria lasciò il suo strascico di ricordo nella casa del medico. A passi concitati, con il cappello calcato sulla fronte, con una grossa sciarpa di lana attorno al collo, lasciando liberi al viso soltanto gli occhi, entrò in casa un individuo dall'aspetto giovanile, energico, ma visibilmente sofferente e nervoso. Così imbacuccato sembrava, di primo acchito, irriconoscibile. Si trattava invece della notissima e cara figura del docente di disegno nella scuola maggiore consortile in paese. Brevissimi i convenevoli: urgeva dar presto un sollievo al poveretto dall'evidente sofferenza. Nello studio, il dottore — coadiuvato dalla moglie — faceva i preparativi necessari all'estrazione del dente. Intanto cercava di distrarre il paziente, che non stava molto calmo sulla sedia. Al di qua delle due porte i figlioli occupati in svariati modi, si attendevano, nella logica abituale, quel grido di dolore di un solo istante ma che penosamente feriva sempre gli orecchi. Invece, di colpo si apre la porta... è lui! Afferra il cappello e a passi concitati raggiunge la terrazza e scompare sulla strada, sfidando a testa china il vento... Pronti alla risata crudele... i figlioli incontrarono lo sguardo del padre che con una deludente scrollatina di spalle esclamò: «ecco un'altra conferma del poco coraggio maschile in faccia al dolore fisico: una donna si sarebbe comportata diversamente! Ma tornerà». Infatti l'indomani, sul tardo pomeriggio, lui, il professor Ulisse, si ripresentò al suo dottore - dentista più calmo, dignitoso e sicuro di sé. La notte insonne, lo stridore del dente guasto e le fitte crudeli che dal mascellare superiore vibravano dentro il cervello, gli diedero la coraggiosa decisione. E fu cosa breve: dopo l'inevitabile urlo, fu la liberazione, il trionfo! La madre entrò nel soggiorno e disse ai figlioli « è stato bravissimo: verrà qui a bere il caffè: siate cortesi». E venne, accolto dalla nidiata con uno scattante battimani e con esclamazioni gioiose. Quel noto viso, dagli occhi ancora cerchiati per la sofferenza patita, si illuminò del più splendente sorriso di gratitudine. Ulisse conosciuto più tardi con lo pseudonimo di «Glauco» poeta dialettale, appena conseguito il diploma di docente di disegno, venne nominato insegnante alla scuola maggiore consortile in Valle. Due, a quei tempi, erano in Valle le scuole maggiori, non obbligatorie, che erano frequentate assai volentieri, anche per l'annessa scuola di disegno che allettava i maschi. Il professor Ulisse, di carattere riservato e riflessivo, era stimato dalla popolazione e benvoluto dai suoi allievi. Gli piacevano le lunghe escursioni sui monti della Valle, e forse, tra i prati verdi tempestati di fiori dalle vivacissime tinte e tra i fitti boschi rallegrati dagli uccelli, egli ritraeva gli intensi colori per i suoi acquerelli e le inspirazioni per la sua poesia dialettale. In classe, durante le ore di lezione, egli era intransigente; il programma di disegno era allora strettamente legato alle svariatissime applicazioni geometriche all'acquerello. Ne risultavano graziosi quadretti colorati, dentro cui spiccavano le più svariate forme di bellissime stelle geometriche. E i ragazzi vi si appassionavano al punto di creare loro stessi combinazioni diverse dal modello. Ma le ragazze, che a fatica avevano imparato a far girare con destrezza la punta del compasso, tenendo l'altra fissa al centro, assai male se la sbrigavano con i colori all'acquerello. Allora il professore, che spesso parlava a scatti, invitava i ragazzi ad aiutare le più pasticcione, e alzando la voce, ammoniva: «Nemmeno sapete vedere la bellezza di queste tinte! Sono il verde dei vostri prati, il giallo dei botton d'oro sui vostri sentieri, sono il colore vivo dei rododendri in fiore!» Per diversi anni il professore si fermò in Valle; poi attratto dal desiderio di un logico avanzamento, chiese ed ottenne il trasloco sulle rive del suo Ceresio, dove insegnò sempre al Ginnasio di Lugano. E intanto comparivano sulla stampa le sue poesie dialettali di schietto e sano sapore paesano. Un giorno al medico di condotta, la Posta recò in cara sorpresa, un simpatico opuscolo, rilegato con cura, la cui copertina recava: Glauco — «E Tilip e Tilep» Come dedica vi si leggeva: «A la santa memoria di me pori Vegitt». Una delle belle poesie del libretto merita il richiamo di alcuni versi. Eccola: «Tempural in montagna» Che nocc d'inferno, fioeui! Saett e tron vün adré l'altro, senza mai requià. La fin dal fagott?... mond? l'ora da fa 'l Ma slonghi giò long e tiraa, vo sott, fo per quarciam e... anima buzarona quel diavoleri l'è bel e balcad: güzzi i orecc... piü 'n cipp, e tiri'l fiaa; salti giò impressa dal paion insci a l'orba ma con la pagüra cerchi a taston; verdi foeu l'anta scura slonghi 'l copin; ga dò n'oeugiada al ciel e vedi ca l'è tütt sternii da stell! Forse in quel temporale notturno di spaventosa paura, finito rapidamente in una splendida serenata, chi sa che non ci sia il richiamo a quell'altra terribile paura del dente da cavare, finita pur essa rapidamente, in una serena calma, simile invero, a quella d'un cielo trapunto di stelle! VETERINARIA Chi era quel medico di condotta che nelle Valli non veniva interpellato nei molteplici casi di malanni o infortuni degli animali di stalla o di casa? A quel tempo la veterinaria era esercitata da uno strettissimo numero di professionisti, ed era quasi inesistente nelle lontane nostre vallate. Il medico, che sapeva di doversi trovare una volta o l'altra di fronte a casi — anche impellenti — di veterinaria, non trascurava, per un certo principio di solidarietà, di tenersi al corrente e di aggiornarsi su quei problemi che facevano parte della vita stessa dei valligiani. Proprio in quegli anni erano stati dati alla stampa due validissimi testi: « L'allevamento bovino» e « La capra delle nostre Valli». Il primo, un grosso volume ben rilegato in rosso, corredato da moltissime illustrazioni, lo si doveva all'iniziativa e alla penna dell'infaticabile e apprezzatissimo professor Alderige Fantuzzi, saggio e sapiente pioniere per la divulgazione dell'agraria e dell'allevamento razionale del bestiame nel nostro Ticino. Ambedue i libri esercitavano un vivo interesse anche ai figlioli del medico, che se li sfogliavano assai spesso, non foss'altro che per contemplare le tante belle illustrazioni, delle quali alcune così nuove nel loro genere ardito, che imponevano domande curiose al padre, a cui egli rispondeva sempre con precisione e naturalezza. Gli episodi nei quali il medico di condotta dovette fare il veterinario improvvisato, sono diversi. Accennerò soltanto a due fra i più curiosi. Un giorno di domenica, sul tardo pomeriggio di una di quelle meravigliose giornate di ottobre, così carezzevoli nella luce d'un tramonto di valle, spuntò dal fondo della gradinata, su verso la casa del medico, un gruppetto serrato di ragazzi al seguito di un cacciatore, recante sulle braccia protese a fatica, un bellissimo cane da caccia: un pointer. Dopo lunghe ore di affannose ricerche e di rincorse appassionate sul pendio boschivo del monte, il cane nell'attraversare uno di quegli ammassi di grosse pietre, tutto buche e trabocchetti (le gane) chi sa come, vi restò impigliato con una zampa anteriore e nello sforzo per liberarsela, se la fratturò in due punti. Il cacciatore, un locarnese, appena fu alla presenza del dottore, gli parlò con tale supplichevole angoscia, enumerando le virtù e le prodezze del suo cane, da commuovere gli astanti. Ma il medico rimase come impietrito alcuni istanti, poi disse semplicemente: «Io vi assicuro il buon esito dell'operazione, se metterete la museruola al cane». Soltanto i familiari potevano capire tutto il profondo significato di un ordine così laconico. Il medico aveva paura dei cani, una grande paura! E la ragione c'era. Da studente a Pavia, un caro suo amico, studente di medicina pure lui, era stato morsicato brutalmente da un cane idrofobo; e la guarigione era stata lunga e penosa. Subito dopo che i ragazzetti ebbero trovato in paese una museruola, il dottore cominciò i preparativi per l'operazione, con la sua abituale serena dedizione. E quasi avesse a che fare con un.... paziente umano, gli chiese un po' scherzoso: «Sei davvero un bel cane; come ti chiami?» «Fram» rispose pronto il padrone. Il medico, divertito, aggiunse subito: «E hai anche un nome celebre. Fram era la nave norvegese usata da Nansen e poi da Amundsen per le esplorazioni polari: si conserva ancora ad Oslo». Il lavoro d'ingessatura non fu breve; il bravo cane, a parte qualche improvviso guaito proprio .... canino, si mostrò remissivo e paziente. A fine operazione il celebre cane, liberato dalla museruola diede una leccata alla sua zampa grossa e bianchissima di garza, tra l'esilarante risata dei ragazzetti, ai quali il dottore aveva dato lo specialissimo permesso di rimanere in qualità di... assistenti. Ma il cane quella sera non poteva rincasare «per nessun conto» aveva sentenziato il medico: sarebbe stata un'imprudenza. Venne così sistemato su di una coperta, nel breve corridoio, con la zampa appoggiata e assicurata su di un grosso cuscino, mentre lui, buono buono, non s'accorse neppure della partenza del suo padrone: aveva occhiate languide e quasi... beate, verso tutti quei visetti, più beati di lui! All'indomani fu un andirivieni di scolari e scolaretti nella casa del medico a vedere il «celebre cane». E... celebre per davvero, se si pensa che ebbe gli onori della «stampa» sui quaderni degli scolari, in quei giorni: dai grandicelli ai più piccini, i quali tra inevitabili sgorbi e incallite sgrammaticature scrissero: «Io mi piace Fram: io vorrei tenerlo per me». «Io mi faceva compassione, povero Fram». In un'altra occasione l'intervento fu su di una capra; si chiamava «Nana» e faceva parte di un gruppetto di altre cornute, quasi tutte «buone di latte». Ma la Nana le superava tutte, diceva la sua padrona. Viveva sola la donna, e quelle bestie erano il suo sostentamento e la sua soddisfazione. Un giorno la Nana mancò al quotidiano appuntamento per la mungitura, sul limitare del bosco patriziale. La donna la chiamò a lungo con quelle strane inflessioni di voci così caratteristiche nelle vallerane, quando chiamano le capre; la cercò per due giorni. Finalmente la rinvenne accucciata all'entrata di una di quelle caverne naturali fra masso e masso. La povera bestiola aveva un capezzolo della mammella sanguinante, stranamente e profondamente lacerato. Siccome la donna non voleva sacrificare la capra più buona di latte, ricorse al medico di condotta. Egli studiò il da farsi. Escludere il pericolo di una latente infezione, non era possibile. Allora decise di amputare metà della mammella. Fu una faticaccia! Un'operare stentatamente e con difficoltà enorme. Nonostante le previsioni incerte del dottore circa la guarigione, la capra, dopo un periodo di cure e di permanenza nella stalla, un giorno, vispa al pari delle altre sue compagne, riprese la sua vita selvaggia nei boschi del patriziato, sempre puntuale alla mungitura; con il solo suo capezzolo sempre sodo, sempre ugualmente generoso di latte aromatico. ERA NATO PER VIVERE... Fu quella una lunga estate di siccità: lunga a non finire, come non mai; giorno dopo giorno dall'alba al tramonto, il cielo nella sua smagliante bellezza restava implacabilmente azzurro. La siccità prolungata sulle montagne riesce più dannosa che altrove: come al piano lo è la pioggia torrenziale. Tanto e vero che i brianzoli acuti e spicci nella loro parlata, sputano con rabbia: «la miseria arriva in barca». Totalmente rovesciata è la situazione su nelle alte cime dove lo strato di humus del terreno è ridotto al minimo: l'insolazione violenta e continua sulle rocce surriscalda la temperatura, tanto da far lentamente scomparire l'incomparabile armonia dei colori alpestri. Smunto sembra l'oscuro delle pinete, scolorito il verde manto dei prati, con macchie rasate qua e là, come per incipiente calvizie; e le pietraie solitamente ornate di licheni e sassifraghe a guisa di monili, prendono un aspetto ferrigno e crudo che par si vogliano vendicare. Si era sul finire d'agosto e la siccità durava da oltre due mesi. Un colubro lungo e pigro strisciava a fatica tra i sassi del sentiero. Le donne intente quel pomeriggio ad ammucchiare l'ultimo scarso fieno, lo videro e quasi insieme esclamarono: «segna acqua lo scorsone». In quella si udì lontano dietro le più alte cime un mugugnare di tuoni, e poi rapidissimo passò un lampo a cielo scoperto: «marca male»... disse la più anziana «e poi quando i primi tuoni vengono da ponente, portano tempesta: affrettiamoci a portare a casa questa miseria di fieno». Detto così, appoggiò il manico del rastrello al suo petto, fissò lo sguardo su, su, verso il limitare del grande pascolo e foggiando le mani a imbuto ai lati della bocca gridò: «bardess» c'è qua il temporale; entrate con le bestie dentro la stalla. Infatti appena più sotto la pineta si scorgeva una vecchia stalla quasi a ridosso di un masso sporgente dal prato: di pietra scura era il masso, come le levigate piode del tetto e le mura a secco della cascina. Subito raccolta la voce della nonna i due pastorelli (alto e ben piantato il maggiore, minuscolo l'altro e ancor bambino) non durarono fatica a infilare dentro la porta, una dietro l'altra le due giovenche e la vecchia bovina, impazienti di adagiarsi sullo strame. Il fratello maggiore, con l'abituale perizia, legò le bestie alla mangiatoia, lasciando penzolare la catena dai grossi anelli di ferro. Poco discosto venne a sedersi il piccolino, intento — già com'era sul prato — a scortecciare con un piccolo coltello arrugginito un segmento regolare di un ramo. E vi lavorava di gusto, perché nelle mani del nonno quel pezzetto di frassino sarebbe diventato uno zufolo, anzi un flauto quasi, da cui ricavare i motivi delle belle cantilene montane. Dentro la stalla il silenzio era alto, rotto soltanto dal cadenzato ruminare delle bestie sdraiate e sonnolente. Intanto fuori, il brontolio dei tuoni lontani si faceva via via più frequente e poi a tratti le raffiche di vento sollevavano in alto gli sterponcelli e gli aghetti secchi della pineta. Poi le prime gocce d'acqua picchiarono grosse e pesanti sul tetto: una giovenca s'alzò di colpo e buttò fuori un lungo muggito. Dal breve pertugio in alto sulla parete, s'intravedevano gli sprazzi di luce taglienti dei lampi; a colpi fragorosi i tuoni, come fossero grosse pietre rotolanti sopra il tetto, si susseguivano rintronando, e la pioggia sferzava, grondante, furibonda: un diluvio, un finimondo! Poi uno schianto terribile: il fulmine si abbatteva con forza indemoniata sul masso di pietra dietro la cascina, rimbalzava, s'infilava furioso dentro un buco del muro e stramazzava come esausto, proprio sugli anelli di ferro della catena, lasciando entrambi esanimi e anneriti dal contatto della corrente, il piccolino e la bestia. Subito tutte le porte dei casolari sparsi nel vasto pascolo si spalancarono e le esclamazioni disperate, le parole incredule, le voci d'angoscia dei montanari, rinforzarono, incrudelito, lo scrosciare della pioggia; ognuno con il cuore in gola raggiunse la porta della cascina: la spalancarono... e ammutolirono! Il fulmine aveva risparmiato il fratello maggiore che giaceva però a terra tramortito e quasi incapace di spiegarsi a parole. Senza perdere tempo un paio di quei montanari decise di scendere subito in paese per il da farsi in simili tristi casi, c'era da avvertire l'autorità e con i dovuti modi la madre che di rado poteva raggiungere i figlioli ai monti, perché impegnata con un negozietto e una «buvette». Il temporale lentamente svaniva al di là delle opposte cime, donde era venuto; la pioggia continuava cheta, quasi lagrimevole; intanto il cielo pareva schiarirsi sul tramonto di quel povero giorno. L'accaduto recò in paese la costernazione dentro ogni quieto focolare. Senza indugio decisero di partire alla volta di Quiello, per le constatazioni legali e pietose, il sindaco, il medico e il parroco don Giuseppe, seguiti da diversi compaesani. Lungo il sentiero d'una faggeta odorante di terra bagnata, il passo di quei pietosi era affrettato, nonché pesante; pareva seguire il ritmo delle parole piene di mistero che, staccate e reticenti, formavano il loro discorrere. «Per me — asseriva il sindaco che la sapeva lunga e conosceva palmo a palmo il suo pezzo di montagna — per me la ragione di quel fulmine violento, mai caduto prima sui prati di Quiello, bisogna ricercarla dentro quel masso sassoso a ridosso della cascina. È vero che, fulmini e valanghe hanno i loro enigmi e riesce sempre difficile scoprirne formazione e causa. Tuttavia sembra venirci in aiuto la straordinaria siccità di questo lungo periodo. È risaputo che le nostre montagne — specie se di natura silicea — possono racchiudere dentro le rocce delle strisce o filoni di metallo allo stato puro. Quel masso abbruciacchiato dal sole, denudato dal suo strato di muschio, licheni e semprevivi, ha favorito il contatto diretto dell'aria, con il presunto filone di metallo, dando così esca all'elettricità di cui erano sovraccariche le nuvole. A formare poi la continuità, a guisa di parafulmine, c'era quella catena di ferro...». E qui si tacque. Si udì poi la voce d'uno del seguito che osò specificare: «... io ho sotto gli occhi il piccolo coltello di quel «poverino» sbalzato lontano dalle sue mani e penso a quell'abitudine che si ha tra noi sui monti quando minaccia un temporale, di correre a coprire di stracci o a nascondere le falci, i falcetti e tutti gli arnesi di ferro acuminati...» Giunti sul luogo dove erano attesi e sbrigato con triste e cosciente responsabilità quel poco che restava da compiere, scesero verso il casolare di nonna Aurelia, dove essa pure li attendeva. Il medico si occupò subito del fratello maggiore, rincantucciato, raggomitolato quasi, nell'angolo di fondo del camino; lo osservò nei minuti particolari, gli ascoltò il cuore, cercò di farlo parlare, distraendolo, e scrisse una ricetta. Intanto la nonna si dava d'attorno a servire il caffè; aveva il volto scavato dall'angoscia, senza esserne abbattuta; era una donna forte, l'Aurelia, già provata da sofferte crude esperienze. In paese era additata come quercia robusta che, colpita dalla folgore, dritta e sicura continua a vegetare e ricoprire di fronde la parte rimasta intatta. Dopo alcuni istanti di silenzio pesante, la donna sfogò il suo dolore, imprimendogli con la fierezza della sua indole, un'aperta ribellione. «... no! non è giusto! mai il fulmine cadde su questo nostro pascolo; tante altre volte siamo rimasti in quella stalla ad aspettare che il temporale passasse...! E perché oggi questa disgrazia? No, non è proprio giusto che venisse colpito un innocente, il mio caro povero «angerin». Molti anni fa ero una giovane sposa; la difterite mi portò via in pochi giorni il mio primo nato; ho sofferto sì, ma poi chinai il capo; anche per tutte le altre batoste che ho avuto... e tante. Ma stavolta no: sento di non poter rassegnarmi, è troppo ingiusto». Allora intervenne don Giuseppe: «Aurelia, siete sempre stata una donna esemplare: perché proprio stavolta non volete riconoscere i misteri della vita? Cercate qualche pensiero che possa aiutarvi a sopportare questa dura prova; per esempio immaginate di vedere il vostro «angerin» tra gli angeli del cielo a modulare contento il suo flauto...» A questo punto intervenne il dottore: «... a proposito — don Giuseppe — domani per il funerale, dia ordine al sagrestano che non si suonino le "campane di allegria" secondo la vecchia e assurda abitudine; siamo nati per la vita, non per la morte precoce! Io mi chiedo perplesso il perché di quel suono a festa durante il funerale d'un bimbo. Voi dite: è un angioletto che si unisce all'infinita schiera della gerarchia celeste, per cantare le lodi a Dio! Ma si rifletta: il Creatore non ha bisogno di altri angeli, Lui che dispone la venuta al mondo di tante creaturine, non per la morte, ma perché vivano, si facciano adulti e servano Dio il più a lungo possibile. Questa è fede, e non deve essere annebbiata o storpiata con il suono a festa delle campane quando disgraziatamente un bimbo muore!». Il nostro parroco può confermarlo. «Infatti — aggiunse don Giuseppe — è falso asserire che Dio voglia la morte dei nostri bambini; è quasi eresia il pensarlo. Egli potrà semplicemente permetterla a traverso le infinite fatalità della vita umana, o per le stesse nostre imprudenze.» E il medico concluse insistendo: «E' quindi un assurdo sfrontato riempire l'aria di melodie festose, durante il funerale di un bimbo! Questa antica usanza poi è perfettamente in contrasto e fa a pugni con l'altra di cui gli onsernonesi sono degnamente fieri: quello di suonare le campane a festa (il cosiddetto concerto d'allegria) durante tutta la cerimonia del battesimo di un bambino. E' una cosa che riempie l'animo di allegrezza, commuove e inorgoglisce. A questa aggiungete l'altra simbolica ed eloquente usanza di distribuire sul sagrato a tutti i ragazzetti del paese una michetta di pane fresca e croccante intanto che il neonato riceve il sale della sapienza e diventa cristiano, tra l'allegro scampanio delle campane!... Ma domani, no. L'allegria delle campane sarebbe un insulto al dolore di chi piange la cruda perdita della propria cara creatura...». E venne l'ora del triste funerale bianco. La campanella più piccola, tra le cinque, da sola, diffondeva lenta, lenta, la sua voce argentina! La piccola bara portata a braccia dai ragazzetti della scuola recava sul coperchio un serto gentile di colchici, che in quei giorni punteggiavano i prati. Qualcuno disse che quel grazioso intreccio di corolle di un delicato azzurrino assomigliava alle alucce degli angeli scesi dal cielo a involare lo spirito di quel bimbo, le cui membra martoriate dovevano scomparire dentro la terra nera del breve camposanto. LA SLAVINA Dall'alto del campanile scese il suono ovattato del «primo segno» della Messa festiva e si sparse smorzato sopra i tetti, i comignoli, le logge, i muri imbacuccati fino all'inverosimile di neve soffice, leggera, candida. Nevicava da oltre tre giorni e tre notti, senza interruzione a fiocchetti piccoli rapidi, nervosi quasi, che poi a tratti si tramutavano in farfalle larghe, leggere e incerte, quasi fossero stanche di cadere in basso a far neve sopra neve, a smussare gli angoli, a riempire i vani tra casa e casa, a far scomparire ogni sagoma di abitato, a comporre e scomporre le mille volte i berretti pendenti sui comignoli, sui piloni dei cancelli, sul pilastro della fontana, sui pali del telefono, e persino sulla croce in vetta allo svelto campanile!... Nevicava, nevicava, in un'atmosfera di silenzio sconfinato, che sembrava non dover finire mai, come un'eternità di mistero bianco. Quel suono di campane che dall'alto cadeva quasi sonnolento, destò un brivido di vita: una dopo l'altra la porta esterna delle case si apriva a fatica segnando un perfetto settore bianco dentro la neve alta. Nei cortili e lungo le discese delle gradinate sepolte sotto il bianco mantello uniforme, sporgevano qua e là gli uomini muniti di robuste e larghe pale di legno piatto, con le quali schiacciavano a forza di braccia la massa invadente della neve asciutta. E tanto alta era, che i viottoli, le stradine, le gradinate era come se si fossero appoggiate su di un alto zoccolo, chi sa per quale prodigio. Così che dalle finestre del pianoterra delle casucce, si vedeva passare soltanto la parte inferiore delle persone: gli scarponi del «birgum» l'ampia gonna a pieghe fitte, rialzata sopra la caviglia della Filomena, i pantaloni di grosso velluto a righe che la Linda aveva preso tra quelli di suo marito, le gambe corte e gracili dentro gli stretti pantaloni di fustagno del «Giuli sacrista» o le ginocchia ben tornite e svelte della vispa «Diomira», di sotto la corta gonnella. Dentro la casa del medico ferveva il consueto tramestio come per ogni risveglio d'un giorno di festa. La madre affaccendata a distribuire a ognuno il cambio settimanale della biancheria e degli abiti della festa, entrando nella camera dei maschietti li trovò ambedue con i visetti appiccicati ai vetri e stranamente mogi mogi a contemplare la neve che cadeva sempre più serrata. «Mamma — dissero appena la videro entrare — nevica ancora, nevica sempre e noi oggi abbiamo fissato il nostro bel gioco sulla neve del sagrato...». «Sono tre giorni e tre notti che cade la neve, figlioli; ce n'è tanta, è alta, molto alta! Da ieri le slitte della Posta sono ferme e il pedone con il sacco postale non ha potuto incontrarsi con l'altro a Mosogno; e il telefono dell'alta Valle non funziona; siamo completamente isolati. Speriamo cessi almeno quest'oggi di nevicare. Svelti figlioli, sta per suonare il secondo «segno di Messa». Ma i due parvero non dar peso alla sollecitazione e aggiunsero: «Sai mamma, è un gioco importante il nostro che vogliamo fare quest'oggi, è una gara, ma non deve nevicare più. Siamo in tanti: c'è il Lindoro, il Fulvio, l'Attilio, il Samuele, il Gusto, l'Ottavio; ed enumerandoli con tanto fervore, pareva mancasse loro il respiro. Si gioca a far l'omino dentro la neve e ad indovinare a chi appartiene la sagoma; quello che fa più errori, per penitenza verrà gettato con forza nella neve, e da solo dovrà sbrigarsela a uscire». La madre, assorta nei suoi timori circa le difficoltà e le ansie che l'insolita nevata poteva creare in caso d'una chiamata urgente fuori del paese, venne colpita dalle ultime frasi dei suoi monelli, le quali sembravano stranamente allacciarsi al filo dei suoi pensieri ansiosi: le strade impraticabili e gli slittamenti di neve sopra i viandanti,... il suo dottore solo in quei pericoli! Allora proruppe di scatto, ebbe un sussulto e con voce nervosa fuori dell'usato, ingiunse: «... no, figlioli, quelli non sono giochi da fare: non voglio! Non vi lascerò uscire di casa, questo pomeriggio!... Il parroco don Giuseppe stava per voltarsi verso i fedeli ad annunciare il suo «ite, missa est» quando si aprì la porta laterale della chiesa ed entrarono decisi due individui non del paese, alti, con dei giacconi imbottiti, dei grossi gambali da neve, e nella mano sinistra il berretto passa montagna. Si diressero verso i banchi degli uomini e fu un attimo: si ruppe il silenzio, fu scomposto l'ordine dei posti e qualcuno a mezza voce, concitatamente, voltato verso le donne, disse: «... è caduta una grossa slavina prima del Ponte Oscuro, e ha portato via una giovane di Comologno...!». In breve il sagrato fu pieno di gente, ansiosa di sapere più precise notizie. Diversi uomini con pale, badili, picconi, corde e una barella, erano sulle mosse per incolonnarsi dentro l'unico passaggio pedonale al centro della strada invasa di neve. Nessuno parlava, e in quell'atmosfera di mistero, sotto la cappa bigia della nuvolaglia, anche i fiocchi di neve, fattisi radi e incerti, parevano coscienti della tristezza che incombeva. Nel silenzio si levò la voce energica del sindaco ad ammonire: «occhio ai ragazzi; si proibisca loro di seguirci». Alcuni momenti dopo, seguirono la comitiva che già svoltava al «campo rotondo» il maestro, il medico e don Giuseppe munito di una robusta pala: sempre così lui! Apostolo della parola e dell'azione fraterna ogni qual volta le necessità lo richiedevano!... Era la mattinata di domenica del 14 febbraio 1915. L'alta Valle da un paio di giorni era totalmente isolata: le slitte ferme, il telefono muto. A Comologno e frazioni la scorta di pane era finita, poiché dal prestino di Russo veniva il quotidiano alimento. Quella domenica sulla mensa non sarebbe comparso il pane per nessuno! Era il primo inverno della prima guerra mondiale, la maggior parte degli uomini dell'«Attiva» erano sotto le armi, al di là del Gottardo. Nei paesi non c'erano abbastanza braccia robuste e resistenti per spalar la neve lungo un percorso di oltre nove chilometri, ossia da Russo a Spruga. Quel mattino di festa di buon'ora, alcuni volonterosi, tra cui diverse ragazze giovanissime ed entusiaste dell'impresa, in colonna per uno, con la gerla sulle spalle e ai piedi gli scarponi, partirono da Comologno salutati dai Compaesani, per la loro lunga marcia cadenzata, vivace, allegra. Giunti a Russo, rifornite le gerle del fresco, croccante pane, ripresero la via del ritorno, svelti, sicuri, trionfanti. Ma ahimè: l'uomo propone e il fato dispone! A mezza strada tra Russo e Ponte Oscuro sotto la roccia nuda che fiancheggia la carrozzabile intagliata dentro di essa, ecco d'un tratto un boato e la scivolata precipitosa di un'enorme massa di neve frammista a rami d'albero e a pietrami. Da dove veniva? chi l'aveva mossa? perché scendere proprio sul passaggio degli uomini? Mistero! domande che restano e resteranno sempre senza risposta. La valanga e il fulmine appartengono agli enigmi secolari della Natura sovrana, alla potenza distruttrice e imbattibile delle forze naturali. Come non si può prevedere la caduta della folgore, tanto meno si può arguire dove, come e quando si stacchi la valanga dalla montagna. Uno dei molto vecchi pregiudizi faceva dire alla gente di pianura che la valanga aveva origine da una prima piccola palla di neve che rotolando ingrossava, ingigantiva. Nulla di più impreciso. Bisogna aver ammirato qualche volta sul fianco opposto della valle, la massa di neve precipitare da una insenatura! D'un tratto si muove dalla cima come spinta da un arcano comando e si avanza come la fiancata di una nave, che, scivolando, spezza e trascina tutto ciò che si presenta davanti al suo pancione e giù giù finché batte vincitrice e strafottente sul fondo della valle!... Si dice che a volte basta un breve soffio d'aria sprigionato da chi sa quale gola di monte a provocare il primo movimento della prima massa di neve! Oppure il ripercuotersi del passo dei viandanti anche lontani... Chi lo sa? Le ore battevano lente giù dal campanile e più lente si smorzavano sui tetti, nella sagoma uniforme d'un paese sotto la neve. C'era silenzio anche dentro le case: vi regnava triste una trepidazione inusitata e uguale per tutti. Suonò anche la campana del mezzogiorno festivo; ma attorno al desco, il posto del padre, del marito o del fratello quel giorno rimase vuoto; gli uomini del paese erano ancora tutti là a scavare perplessi, la massa compatta della valanga. I ragazzi, nella loro incontenibile irrequietezza spiavano dalle logge, dalle finestre delle case lungo la strada, il sopraggiungere di qualcuno. Finalmente gridarono ad una sol voce: «vengono, sono qua...». Erano soltanto due mandatari, l'usciere e un municipale che s'affrettarono a spalancare le porte della sala comunale e sgombrare il grande tavolo, perché il dottore aveva dato ordine che la poveretta venisse stesa lì, dopo aver fatto tutto ciò che poteva per tentare di rianimarla. E s'avanzò finalmente in silenzio la fila dei soccorritori con al centro la barella su cui giaceva la sfortunata diciassettenne. Allora il dottore redasse l'attestato di morte, l'ultimo doveroso gesto, e scrisse «Matilde Marconi, nata il 7 febbraio 1898, deceduta per asfissia da neve il 14 febbraio 1915; consegnò il foglio al sindaco, e in silenzio, triste e stanco, lasciò la sala. Vita e morte: i capisaldi dell'esistenza umana; l'alfa e l'omega di ogni uomo; ma anche due termini contraddittori, sempre in combutta tra loro, per tutti, e in modo particolare per l'uomo della scienza medica. Per vocazione, competenza e passione il medico. lo scienziato, lo studioso ricercatore, votano la loro esistenza per la salute dell'uomo, per il suo benessere fisico e psichico e per il prolungamento della sua vita sulla terra. È naturale che la morte sia la grande nemica del medico, contro cui egli si batte ininterrottamente, con una lotta spietata. «Siamo nati per la vita» era lo slogan, il pertinace assioma che governava ogni azione del nostro medico di condotta. E quando una morte precoce, imprevedibile, colpiva uno dei suoi convallerani, segretamente ne soffriva. Il culto per i trapassati era per lui qualcosa di arcano che doveva scaturire da quell'incommensurabile concetto che assumeva per lui la vita. E diceva ai suoi familiari quando sembrava loro di non volerlo capire: «... che cosa sono mai per un medico i resti di un corpo umano privato del suo spirito?... Corpo e anima sono l'insieme della più grande meraviglia di perfezione tra le create cose...». Quando gli succedeva di essere triste raggiungeva, nelle bellissime sere stellari, l'angolo preferito del loggiato, dove aveva fissato un robusto cannocchiale, e, appassionato com'era di astronomia, gli pareva di veder la ragione dell'esistenza di quella sconfinata miriade di mondi celesti: regno di pace infinita, di supreme immortali bellezze, da cui può essere sensibile «un'arcana celeste corrispondenza d'amorosi sensi» con lo Spirito dei trapassati. All'indomani del triste accaduto la cappa pesante di nuvole scomparve per incanto e in un cielo tersissimo splendeva il più bel sole invernale! Spesso si hanno di questi contrasti. Perciò in quel triste pomeriggio una miriade di stelline di neve luccicanti al sole, faceva ala al mestissimo corteo della povera vittima verso il camposanto di Russo. E noi che percorriamo il tratto di strada verso il Ponte Oscuro, volgiamo lo sguardo al di sopra della nuda roccia, da dove partì la valanga omicida. Proprio su quell'altura, qualche anno appresso, il corpo forestale coadiuvato dalle scolaresche della valle, in un giorno della festa dell'albero, creò la bella pineta che oggi perennemente fa rivivere il nome della giovanissima portatrice di pane!... UNA BAMBOLA PER LA POVERA « VIOLETTA» La chiamarono «Speranza»: venne al mondo dopo anni di una deludente attesa di due sposi non più giovani. Perciò quel dono di bimba sarebbe stata la loro speranza, il respiro della loro vita. Del resto quel nome era allora comunissimo in Valle, caro agli onsernonesi chi sa mai per quale origine. E la bimba crebbe sana, ilare, ciarliera come le rondini sotto la grondaia della sua umile dimora. La sua giovinezza sbocciò esuberante, decisa e aperta a donare la sua gioia di vivere a chi le stava attorno. Il maestro di scuola avrebbe voluto che Speranza proseguisse gli studi; nemmanco a pensarci: mancavano i mezzi. Tuttavia la fanciulla avvertì anche troppo presto che il suo orizzonte era angusto per la sua anima irrequieta, per la sua indole assetata di cose più grandi di lei. E a poco a poco con le sue graziette insistenti persuase i genitori — attoniti e perplessi — di lasciarla scendere in città. E spiegò loro il suo piano di lavoro già stabilito. Sarebbe andata presso una famiglia d'origine onsernonese della quale Speranza conosceva i figlioli che da anni salivano in Valle a passare l'estate, proprio vicino alla sua povera casetta. C'era tanto bisogno d'aiuto in quella famiglia di Locarno, in cui i genitori, impegnatissimi in un avviato e redditizio commercio, poco potevano attendere alle cure della casa. Speranza assunse in pieno il disbrigo domestico, offrendo la destrezza del suo braccio e la generosità del suo cuore. Il maggiore dei figli, suo coetaneo e amico dei giochi d'infanzia, studiava con impegno nella Svizzera interna. La madre aveva affidato a Speranza anche l'intero compito di governare i suoi abiti, la sua biancheria che dentro il cesto postale facevano a intervalli regolari la spola tra lo studente e la sua famiglia. La fanciulla adempiva al delicato incarico con un certo orgoglio misto ad entusiasmo; per cui spesso con il biglietto recante le notiziole della famiglia, essa, con tutta spontaneità, andava via via ricordandogli i giochi dei felici giorni trascorsi in valle. A volte si divertiva a rammentargli le corse folli con i compagni del paese, sui pendii dei prati falciati di fresco, o le piacevoli gare a sgusciare tante più castagne dai ricci pungenti, o ad abbacchiare le noci che uscivano dal mallo fresche e umide, come pulcini dall'uovo. Altre volte erano i nomi di alcuni giovanotti di comune conoscenza che avevano lasciato il paese per emigrare lontano, oltre oceano! Ma era anche la nostalgia del suo idillico angolo di valle, con il pensiero dei suoi genitori soli lassù, a darle quella vena di romanticismo. Non di rado succedeva che Guido cogliesse nel segno quei richiami, e rispondesse, anche se un po' distrattamente, con allusioni di simpatico umorismo, dall'aria goliardica, che tanto piaceva a Speranza. Ma intanto la fanciulla non si rendeva conto che quel grazioso ignaro giochetto andava via via alimentando la sua fervida fantasia e accendendo lentamente in cuore una nascosta fiamma. Così, segretamente, follemente, Speranza si innamorò del suo compagno d'infanzia! Verso la fine di un inverno particolarmente crudo e interminabile la figliola si ammalò di un improvviso e cattivo attacco influenzale con complicazioni polmonari. I genitori la vollero con loro e il medico di condotta, chiamato d'urgenza, si avvide subito che il male assumeva sintomi poco rassicuranti. Dopo alcune settimane di febbre altissima, subentrò — come sempre in casi analoghi — il lungo periodo subfebbrile con tosse ostinata. Ma lei, la speranza fatta persona, non si perdeva d'animo, sempre ugualmente ilare e fiduciosa, nella certezza di tornare al suo compito e al suo segreto sognare!... Un giorno particolarmente luminoso di sole e pieno d'aromi per l'incipiente stagione estiva, la madre incaricò Guido di salire in valle per chiedere precisazioni sulla convalescenza di Speranza, e per recare a piene mani diversi doni agli sconsolati genitori. L'incontro dei due amici riaccese nei meravigliosi occhi di lei tutta la sua fiamma d'amore, rendendola palese e scoperta di colpo! Lui, scosso in quella duplice rivelazione di stupore e di angoscia, sostenne l'intima lotta, mostrando come sempre il suo benevolo e giocondo umorismo. Ma appena la porta della stanzuccia si richiuse dietro le sue spalle, rimase come impietrito e nascose il viso dentro il palmo delle mani. In quel momento saliva le scale il medico per la visita quotidiana alla sua malata: vide la scena, non si stupì e con un gesto affettuoso invitò il giovane a seguirlo, giù nel cortiletto, seduti l'uno accanto all'altro, sulla vecchia panchina di pietra viva. Fu un lungo conversare, una reciproca comprensione, uno scambio intelligente di riflessioni amare, ma anche di previsioni ottimistiche verso l'avvenire della medicina. «... non è purtroppo un fatto nuovo» — proseguiva il medico — il caso di questa cara fanciulla! Partono sani dalla loro valle i giovani, e... dopo un'assenza più o meno lunga, qualcuno ritorna al suo tetto con i polmoni contagiati! Tu lo sai come si è diffuso ultimamente al piano il bacillo TBC e purtroppo in maniera quasi imbattibile. In primo luogo perché servono di cultura al microbo gli ambienti cittadini, l'aria stessa delle basse quote, e purtroppo, anche i preconcetti e le assurde paure della popolazione e degli stessi ammalati, a non voler svelare il loro male. E' una lenta, silenziosa strage imperterrita! E noi, medici di condotta delle valli, mentre siamo orgogliosi dell'integrità polmonare dei nostri vallerani, a volte subiamo il panico per la diffusione del bacillo di Koch... Fortunatamente, e in virtù di questo grande medico tedesco batteriologo (Roberto Koch, premio Nobel 1905) la scienza medica nelle sue odierne ricerche diuturne di laboratorio, ha già esperimentato degli eccellenti farmaci contro la tubercolosi, la così detta lotta contro il bacillo di Koch. Ti citerò soltanto alcuni nomi tra i più pregiati farmaci, che io uso conformemente ai casi: il guaiacolo, la codeina, il creosoto (che va dosato con sapienza) e, tra i modernissimi, i derivati dell'acido paraaminosalicilico. Nelle forme polmonari in cui il focolaio non è completamente aperto, i suddetti farmaci riescono a bloccare l'azione diretta dei bacilli tubercolotici e a costringere l'organismo a lottare con efficacia. E' indispensabile però che l'ammalato venga curato in un ambiente di aria balsamica e con una terapia di riposo controllato. Tuttavia resterà una guarigione lunga e problematica quella della tubercolosi. Ma al punto in cui è giunta oggi la medicina, è consolante guardar con ottimismo l'avvenire, perché la vostra generazione, caro Guido, vedrà finalmente il trionfo della lotta contro il bacillo di Koch». Il giovane che aveva seguito con interesse il dire del medico, e che più volte era intervenuto con diverse obiezioni e domande, all'ultima affermazione si ammutolì. «E' significativo il tuo silenzio a questo punto Guido» — riprese il medico — e poiché siamo giunti alla svolta a cui intendevo arrivare, e già che si è fatto tardi, t'accompagno alla Posta e lungo la strada continueremo il nostro ragionare. Non è l'avvenire della scienza medica che ti possa interessare per ora: ti comprendo, caro figliolo, e sei pienamente giustificato. Tu vuoi sapere da me a che stasi è il male che colpisce la tua piccola amica. Per intanto è temerario dare un giudizio definitivo. Ti dicevo in principio che è stato violento l'attacco broncopolmonare di cui fu vittima Speranza; ambedue i suoi polmoni sono intaccati: uno all'apice e l'altro alla base; ed io avverto con lo stetoscopio il sibilo anormale della sua respirazione. Ma forse possiamo contare su di una convalescenza progressiva, anche se lunga. E qui permettimi figliuolo, che io prosegua svelandoti come possa esistere un'altra causa a complicare e rendere incerta la situazione del malato di tubercolosi». Il giovane lo interruppe dicendo «è ben triste il suo dire, dottore: prosegua, senza reticenze fino in fondo: m'interessa e m'appassiona...». «La tisi è un terribile e strano male, con i suoi alti e bassi di lunghi intervalli, per cui quando la febbre si riduce e la tosse tace, l'individuo non soffre più, si sente rinascere e anela alla vita con palpito struggente. E questo in particolare negli individui giovani con nel cuore la irrequieta fiamma d'amore! Lotta tacita che consuma, come veridicamente la definisce l'espressione dialettale, con quello spietato "al va cunsunt". Se tu pensi che l'uomo è composto di corpo e di spirito, di materia e psiche strettamente congiunti, tu puoi comprendere cosa possa essere la conseguenza di questa inconscia lotta tra sofferenza e amore, tra vita e morte!... E dal momento che io conosco il tuo diletto per la musica operistica, lascia che a mo' di conclusione purtroppo amara, io t'inviti a ripensare un istante a Verdi, e a una delle sue opere: "La Traviata". Tutte le passioni umane ebbero a traverso le stupende melodie di quel genio, le loro espressioni più toccanti: e in quest'opera Verdi non fu soltanto musico, ma medico e psicologo insieme. Ripensa alle ultime scene del quarto atto in cui l'appasionatissima Violetta, non si piega alla gravità del suo male, ma vi si ribella con tutta la forza del suo anelito, e sulle note laceranti dei violini canta: — Cessarono gli spasimi del dolore In me rinasce... m'agita insolito vigore Oh! io ritorno a vivere! E in quell'ultimo duetto, in cui l'orchestra sembra intessere il più meraviglioso inno alla felicità, la poveretta, prima di soccombere all'ultimo insulto del male, canta: «Parigi, o caro, noi lasceremo, la vita uniti trascorreremo, la mia salute rifiorirà. Sospiro e luce tu mi sarai Tutto il futuro ne arriderà» Si udì avvicinarsi il rombo della corsa postale; e i due tacquero. Nell'affettuoso congedo il medico gli disse ancora: «qualunque cosa possa accadere, ritrova Guido, la via della speranza, accanto a quella dell'esperienza. La vita degli uomini sarà sempre più o meno intessuta di contraddizioni di assurdi e soprattutto di misteri imperscrutabili: soltanto il pensiero dell'Infinito può darcene una ragione». Con passo quasi stanco il medico rifece la strada, risalì la lunga gradinata di pietra: stava per cadere l'ombra della sera e le prime lucciole irrequiete punteggiavano l'aria. In casa i familiari l'attendevano per la cena; la moglie notò il suo silenzio, la sua tristezza e lo interrogò soltanto sul finire del frugale pasto. Allora il medico sentì il bisogno di sfogare il suo animo e a lungo parlò di Guido, di Speranza, la cara fanciulla... la povera Violetta di Verdi!... Ognuno dei figlioli ascoltava; ciascuno seconda dell'età e del modo d'intendere il racconto. A un tratto la più piccola delle figliole scivolò giù svelta dalla sedia, si appartò verso l'angolo dei suoi giocattoli e ricomparve tenendosi affettuosamente tra le piccole braccia un suo bamboccio di celluloide, sorridente, nei chiari occhi dipinti, con un gonnellino rosa di lana e un bavaglino ricamato a colori vivaci. Disse: «prendi papà, la mia bambola: è bella; portala domani alla povera Violetta: vedrai come sarà contenta...». Anche quella sera, come tantissime altre, il padre si sedette accanto alla tastiera del piano; teneva fra le mani uno spartito d'opera: ma lo appoggiò chiuso sul leggio. Nel silenzio dell'ora tarda risuonarono alcuni accordi lenti e tristi e... poi sotto le agili dita si sprigionò d'un tratto una cascata di note che sembrava scandire tra i singhiozzi le parole della romanza: «Gran Dio... morir si giovane...» Sarebbe però ingiusto non ricordare che alcuni casi di TBC giungevano a perfetta guarigione, quando i così detti emigranti temporanei rincasavano a farsi curare in tempo per riacquistare il prodigio della salute. Ciò procurava al medico soddisfazioni senza pari, come la conquista d'una radiosa vittoria. Un pomeriggio capitò in casa, proveniente dall'alta valle, una donnina, non più giovane, ben messa nel modesto costume, con in capo il fazzoletto scuro, appoggiato più che annodato sulla nuca, come solo sanno metterselo le valligiane, a guisa di aureola. Aveva l'aria triste senza essere accasciata; una di quelle madri tutto spirito, capaci di guardar in faccia alla realtà. Con ripensamenti tutti personali. Cercava il medico, non per una visita; doveva comunicargli qualche cosa. Ma non c'era quel pomeriggio; una chiamata d'urgenza l'aveva chiamato nella bassa valle. «Non importa» disse «sono contenta lo stesso di raccontare anche a lei "duttura" la mia povera storia». E così dicendo levò da una busta una fotografia di una famigliola: due giovani sposi con il figlioletto sulle ginocchia di lei. E proseguì: «Vede, "duttura" questo è mio figlio, morto alcuni mesi fa a Ginevra; faceva il gessatore e cadde sfracellandosi dall'alto dell'impalcatura di un palazzo. Se le dico il nome, senz'altro lo ricorderà, perché me lo guarì il suo dottore da un male cattivo, che non aveva ancora diciotto anni». E man mano che entrava nel vivo dei particolari le si accendevano le gote e gli occhi luccicavano di lacrime. Infatti la moglie del medico ricordava il caso di un figlio giovinetto dell'alta valle, che era andato presso un suo zio, padrone d'una «Sostra» di scalpellino a Riveo. E dopo qualche anno era rientrato in famiglia malato di silicosi. Aveva la trachea e i grossi bronchi gravemente infiammati, e una tormentosa e lacerante tosse secca, che per lo sforzo, le venoline della gola si screpolavano e la mucosa faceva sangue II medico, com'era logico, se la prese con i genitori che avevano esposto il figlio così giovane ad un sì pericoloso rischio. Ma nel contempo li rianimò e intimò loro che seguissero scrupolosamente i suoi ordini. Dopo un lungo periodo di febbriciattola e di alti e bassi, il giovane entrò in convalescenza. Allora il medico lo spedì per due estati consecutive all'alpe, perché occupandosi gradatamente di leggeri lavori alpestri, facesse lunghe ore di sonno, lente passeggiate, e si nutrisse abbondantemente di latte, panna, formaggio e pane di segale raffermo. Guarì perfettamente e si irrobustì, tanto da diventare abile al servizio militare. Ma poi si lasciò adescare dal miraggio della grande città e... con un paio d'amici, partì per Ginevra. Lentamente si rianimò quella madre e in tono persuasivo concluse: «Io sono venuta per regalare al dottore la fotografia di mio figlio, a lui che seppe strapparlo dal suo crudo destino di morte... che gli allungò la vita, procurandogli la gioia di formarsi una famiglia e di lasciare a me il conforto di un figlioletto che è l'immagine viva di suo padre!...». Ai medici di condotta potevano a volte capitare di questi riconoscimenti, di sapore un poco trascendentale!.. TEMPO LIBERO DI ALLORA Espressione sconosciuta allora: — Tempo libero! — Esisteva, ma era anonimo e godeva della più logica e individuale libertà: poteva essere corto, lungo, aleatorio o ricercato con appassionata voluttà; impiegato secondo le proprie abitudini, le necessità, le scelte personali e poteva creare situazioni serene, senza che a nessuno venisse in mente di attribuirle al «tempo libero». Una cosa era evidente, chiara come la luce: in valle non esistevano uomini o bambini che non sapessero cosa fare; erano sconosciuti i neghittosi, gli sconclusionati, i perditempo. Qualche prova? Le donne che per il loro nomadismo dovevano spostarsi da una cascina all'altra, dalle casa al Patriziato e viceversa, per il governo delle capre, le vedevi quasi sempre con la «cadula» sulle spalle per il trasporto della legna e le mani operose sopra il grembiule rialzato e tenuto stretto in vita dalle cocche. E rigonfio il grembiule era, perché dentro ci stava la treccia di paglia che svelte esse lavoravano con le agili dita, mentre camminavano lungo i sentieri non sempre agevoli. E se ne incontravi qualcuna: «alègar» ti diceva con spontaneità; allora ti sentivi onorato di cederle il passo sul sentiero e sostare... in ammirazione. Il peso sulle spalle e ai piedi i «peduli» confezionati da loro stesse con i ritagli di stoffa resistente e la grossa suola trapunta da solida corda. (Oh! così comodi i peduli e sicuri anche sulle pietre nude e ripide!). Sotto il braccio sinistro un mazzetto di belle, regolari pagliuzze di un paglierino vivace a portata di mano, perché la destra con svelto, abituale gesto potesse sfilarne una dal mazzetto, ogni qualvolta occorreva, nel magico gioco di far la treccia di paglia. E la treccia di paglia onsernonese era di svariati aspetti: sempre allettanti a vedersi quelle grosse balle di treccia gialla, pronte ad essere portate al mercato di Locarno per un paio di centesimi al metro. Una specie di derisione!... C'era la paglia fatta con 4 elementi, piuttosto grossa che dava una treccia comune, buona per impagliare sedie; c'era quella fatta con 5 pagliette, dalla tessitura più graziosa: poi quella di 7 pagliuzze sottili, intrecciata con tale maestria che si faceva ammirare come fosse un pizzo! Anche i ragazzi non sapevano sprecare il tempo, esortati com'erano sempre dalle loro mamme da quell'intercalare persuasivo dentro le flessioni incisive del loro dialetto: o «bardèss» non si può «giubezzare» il tempo!... E ai «bardèss» quell'intimazione era entrata d'istinto nella loro natura, che non avreste mai visto un ragazzo in ozio anche durante i sei lunghissimi mesi di vacanza. Sì, perché per anni il Dipartimento Educazione accordava alle Valli una tale smisurata vacanza, confacente alla vita nomade dei montanari. Inesistente era pure il tempo libero per il medico di condotta; anzi per lui più che per ogni altra persona, per una ragione plausibile. Chi avrebbe sostituito il medico di condotta durante il suo tempo libero?... Ma la cura della condotta non era sempre avara di tempo libero: ti capitava, è vero, quando non te l'aspettavi, o viceversa. Quando il medico sapeva che lo stato di salute generale della valle era buono, ecco subentrare d'improvviso una chiamata urgente, anche grave, specialmente durante l'estate: una caduta da un prato a picco durante la fienagione; una morsicata di vipera (e ce n'erano spesso); un incidente di lavoro ai taglialegna o agli operai addetti al «filo a freno» per il trasporto dei legnami; quando non era la caduta dall'albero di ciliegio di qualche monello audace e distratto. L'inverno invece appariva a volte generoso di ore libere, quando però non c'era lo spauracchio delle polmoniti e complicazioni simili. E il medico ben sapeva mettere a frutto quelle "ore buche", chi sa quante volte desiderate! C'erano i suoi libri, le sue riviste ad attenderlo; la sua musica di pianoforte e di armonium, di cui teneva celata la grande passione. Succedeva talvolta che la casa cambiasse la sua abituale fisionomia, quando il padre si proponeva di far l'accordatura del pianoforte. Dispetto grande per i «tre inseparabili figlioli» se succedeva in giornate di cattivo tempo. Si doveva innanzitutto sgombrare dal piano i libri, le fotografie e quell'insulso di un picchio verde imbalsamato, con il becco eternamente puntato su di un pezzo di tronco, e sempre pieno di polvere! Poi c'era d'aiutare il padre a levare le viti alle diverse coperture di legno pregiato del pianoforte, e lasciarlo lì nudo e squallido come un vecchio scheletro, con tutti quei martelletti ovattati di feltro e di polvere. Quanto era brutto! Così scorticato, veniva sospinto di fronte alle due finestre, in piena luce. Il guaio poi diventava maggiore quando l'accordatura veniva improvvisamente interrotta da qualche chiamata d'urgenza; e quel povero brutto ceffo restava abbandonato a sé, solitario e ingombrante. Quando all'indomani il padre si rimetteva al lavoro, doveva regnare in tutta l'abitazione il più assoluto silenzio; nessun rumore era permesso, nemmeno lo scricchiolio sul pavimento di legno. Più nessuno poteva far sentire la propria voce; nemmeno l'orologio a muro, perché gli si fermava il pendolo. In quella strana atmosfera il padre si tramutava in accordatore attento e accigliato, seduto davanti a quell'indefinibile istrumento quasi macabro, con in una mano il corista e nell'altra, alternativamente, la stecca per separare la vibrazione delle corde multiple, e la chiave a becchetto di acciaio per regolare l'altezza del suono. E nel gran silenzio della casa risonavano staccati e ritmati gli accordi, or acuti or gravi, che le dita dell'accordatore ripetutamente, instancabilmente ritraevano dalla tastiera. Oggi, a distanza di decenni, nell'orecchio si risvegliano d'improvviso quegli accordi atonali, quando avvertiamo qualche particolare di musica contemporanea o dodecafonica. E con stupore ci si chiede: «ma perché questo strano sovrapporsi di sensazioni acustiche?... Fortunatamente la sera di quel lungo stranissimo giorno, stonato nel suo accordo familiare, sapeva elargire con generosità la sua melodiosa ricompensa. Il padre, nell'intento di collaudare la sua fatica di accordatore, sedeva al piano e dava inizio, senza interruzione, ad un particolare repertorio che doveva essere un «pot-pourri» di rimembranze! Dal primo tocco di mani sulla tastiera, ecco sgorgare le note recanti l'eco dei suoi anni di studente italiano: «si scopron le tombe, si levano i morti, i martiri nostri son tutti risorti» a cui seguivano «II carnevale di Venezia» il pezzo più trionfale della «marcia dell'Aida», la Santa Lucia dell'incantevole «Sul mare luccica l'astro d'argento...». Una piccolissima sospensione, poi erano le note cadenzate del «Ranz des vaches» accanto al dolcissimo «La haut sur la montagne» seguito dalla pastorale del Guglielmo Tell, concatenata da un pezzo della «Moldava» la cui tematica è la dolce canzone di un fiume che fugge via nelle sue luci iridescenti. Altro attimo di respiro e poi sgorgava la briosissima, scintillante musica della «Cavalleria rusticana» a cui seguivano vari cenni ai «Valzer viennesi» e la mazurca di quel «Cucù» di cristallina sonorità che — diceva lui — era un trofeo di derisione al più antisociale delle creature alate! E sul finire le nostalgiche «Campane a sera» dolcemente accostate a quel «Più presso a te Signor, venir vogl'io...» che si diceva fosse stato cantato sulla nave «Titanic» mentre lentamente s'inabissava; e la figlia maggiore del medico ne rivestiva le parole con la sua voce bellissima di fanciulla romantica. Ad un'altra incombenza il medico dedicava di tanto in tanto qualche sua ora libera, e si faceva aiutare dai suoi monelli a turno: era lo sviluppo fotografico delle pellicole del suo piccolo apparecchio «Kodac» dentro la «camera oscura». Questa, altro non era che il sottoscala quanto mai angusto, perché stretta e minuscola era la scala di legno che metteva al piano superiore. Era stato adibito quel sottoscala di proposito a camera oscura; ai lati, sulle mensole stavano le bottiglie degli acidi, i misurini per il dosaggio, il recipiente per l'acqua, le bacinelle, le pinze, la lanterna a schermo rosso e i piccoli asciugamani. Al centro un tavolinetto rotondo cui attorno, a mala pena ci stavano i tre sgabelli. Bisognava otturare tutti i più piccoli spiragli di luce, financo il buco della serratura delle due porte. Quando tutto era accuratamente allestito e il padre di buon umore, allora l'operazione in quella «tana» poteva riuscire uno spasso; ma guai a chi diceva una parola inutile e tanto meno se si lasciava dominare dai malcelati scoppiettii di riso! Allora il padre alzava la voce, qualcuno urtava una bacinella e l'acido N. 1 o N. 2... correva sulle gambe! Subito nasceva il dubbio, fatto paura, che la operazione «bagno delle pellicole» non riuscisse a dovere. Guai se il padre non intravedeva, tra il netto contrasto di chiaro e scuro delle negative, le sue cime dei monti, il suo cielo con i bei cumuli, le cascate dalla chioma fluente, il laghetto alpino con i rododendri e le cento attrattive della sua Valle. A operazione ultimata i figlioli uscivano nella luce bianca con un ampio respiro, a guardarsi negli occhi le... pupille dilatate dei gatti. Oggi che in pochi minuti ti consegnano una foto a colori, ci si accorge che sono passati tanti... troppi anni, da quando funzionava quella specie di camera oscura ... Tra i curiosi passatempi uno specialissimo c'era, che si ripeteva ogni due anni durante l'estate. Ed era desideratissimo dai figlioli del medico, così che di tanto in tanto essi chiedevano: «... papà, quando arriva il signor Droz?» Giungeva da Berna, e arrivava a Russo con l'auto postale; era l'ispettore forestale in capo; faceva una sosta in casa del medico che gli era amico e poi proseguiva per Spruga un giorno e per Vergeletto un altro. Il medico lo teneva in grande considerazione; era figlio del consigliere federale Numa Droz (cosa che non voleva dire un... bel niente per i figlioli); poi era redattore della rivista «Il club alpino svizzero», un simpatico quindicinale che recava tra le grosse parole del titolo, una piccola testa di camoscio, dai caratteristici cornetti ricurvi, dentro uno sfondo di un bel «Cervino» in miniatura. Altro giornaletto caro al medico; figuriamoci se non poteva esserlo anche il suo redattore, il quale a sua volta ci teneva che il medico collaborasse al giornale con i suoi articoli. Una piccola rivista, il cui atto di fondazione si trova nientemeno che nel museo nazionale svizzero! Il giorno che il signor Droz doveva giungere in paese, c'era una certa trepidazione tra quei tre folletti! Ma essi solo ne conoscevano la ragione. E il padre — ingenuo — sembrava lusingato di quell'interesse, per cui scendendo insieme verso la posta in attesa dell'auto, amava ripetere ai suoi figlioli i soliti ragguagli intorno al signor Droz. «Arriva la posta, attenzione, suggeriva a bassa voce la monella: si saluta bene e non si ride... d'accordo». All'incontro, dopo i convenevoli, i «due grandi» si avviavano primi verso la salita della gradinata; dietro, la «triade» puntava gli occhi sulla persona del signor Droz e con aria trionfante bisbigliava a bassa voce «si, è proprio lui». Alto (forse raggiungeva i due metri) le spalle robuste, un po' ricurve, come spesso succede alle persone allampanate, con un viso allungato, dal muso sporgente, occhi tondi, un poco velati da un paio di grosse lenti a pinzetta sul naso piccolo; e una testa (oh... quella testa!) con una fitta capigliatura a spazzola, e i capelli, proprio color... pelo di DROmedario! Uno dei tre allora suggeriva a bassa voce: «non vi pare che il signor DROz abbia una testa che assomiglia a quella del bel dromedario che il nonno ci portò dal suo viaggio alle piramidi d'Egitto...? e seguivano gli scoppiettii di riso, mal trattenuto, ma che lasciavano intuire l'impazienza per la scenetta finale. Eccoci finalmente sull'entrata della casa; due erano le porte da oltrepassare... e per ben due volte il signor Droz era obbligato a curvare il dorso e ad abbassare la testa, proprio come avrebbe dovuto fare... un vero dromedario ... Divertiti i «tre», con aria di mistero si chiedevano: «ma perché si chiama soltanto Droz?». L'estate portava anche una serie di giochi uno più avvincente dell'altro; giochi che si facevano in piccole comitive con i compagni di scuola, a cui spesso si univano i ragazzi che in paese venivano a passare le vacanze. C'erano l'Aldo, l'Attilio, il Lindoro, il Fulvio, l'Anna, l'Olga, l'Eliseo, l'Augusto. Durante la fienagione, là sui pendii della «Pezza», ci si dava l'aria di aiutare a stendere il fieno al sole, a fare i bei mucchi con il rastrello; poi si aspettava il momento giusto per piombare di colpo sul mucchio dall'acuto profumo di erbe secche; sprofondarvisi un attimo, e poi di fretta ricomporlo alla bell'e meglio. Quando i diversi «barghiei» erano ricolmi e le donne se ne andavano curve sotto una cupola di fieno alta due volte la loro persona, allora ecco i ragazzi far gli scivoloni sui pendii ancora odoranti di fieno, ruzzolare, riconquistare il punto di partenza più volte e sempre più in fretta, e poi ansanti, buttarsi sul prato a guardar su nel cielo i bei giochi delle nuvole, i candidi cumuli le cui instabili forme alimentavano le più ardite fantasie. Pochi minuti, poi la piccola comitiva era in piedi per rispondere ossequiente ed entusiasta all'invito del «capobanda» che aveva detto: «Andiamo a giocar alla lippa!». Erano vere partite la cui foga assorbiva tutte le energie; e la passione della vincita entrava nel sangue. La «lippa»: un pezzetto di legno duro, assai bene appuntito d'ambo le parti, perché spiccasse degli ampi salti, quando il giocatore di turno la percuoteva con l'apposito bastoncello. E le partite si susseguivano fin verso il tramonto, quando la terra del cortile, così rimossa, sollevava una nuvola di polvere. Allora si rincasava accaldati, sudati, sudici, scapigliati e stanchi; non di rado con le ginocchia sbucciate a sangue. La «triade» rientrando in casa sapeva d'essere accolta male. La madre poi si rivolgeva alla maggiore con un predicozzo a non finire: «che era peggio di un monellaccio e che avrebbe almeno dovuto vergognarsi!»... Dallo studio si affacciava il padre che dava l'ordine di lavarsi faccia, mani, piedi e ginocchia, e nella comune capace tinozza dentro l'acqua del risciacquo veniva poi a mettere il disinfettante: il lysoformium. E i figlioli se la spassavano con l'acqua che faceva schiuma e che sprigionava l'acuto profumo tanto familiare tra le pareti di casa. Ma il guaio era che quel profumo non piaceva ai loro compagni che andavano dicendo quasi schifati: «i duturitt» puzzano di acido fenico!...Allora per correre al riparo si asciugavano alla bell'e meglio e di soppiatto prendevano il barattolo del talco che la mamma usava per l'ultimo nato, e lì si compiva la grande infarinatura, l'inenarrabile sciupìo... La pazienza della madre rasentava il limite; ci voleva ancora il padre a convincerla perché chiudesse un occhio e lasciasse sbizzarrire quei figlioli in vacanza, non li costringesse a reprimere la loro vivacità, la pienezza delle loro energie; sarebbe stato tanto di guadagnato al riaprirsi della scuola. Sì, perché se il padre era tanto generoso a perdonare le piccole follìe delle vacanze, diventava altrettanto intransigente nell'esigere dai figli l'adempimento del loro dovere di scolari. Ma un giorno sul finir dell'anno scolastico, una piccola avventura parve assumere un allarme quasi drammatico!... L'unica scuola elementare era mista, nelle mani di un maestro; perciò il lavoro femminile veniva riservato alle ragazze il giovedì mattina, vacanza per i maschietti. Da qualche tempo, essendo impegnata la titolare, veniva incaricata per il lavoro femminile una sarta anziana del paese. E si sa, già allora dalle supplenti provvisorie, non si dovevano pretendere miracoli! Dietro a quella piccola ribalta rialzata del banco spesso succedevano cosette simpatiche, gustose, specie per le allieve meno chiamate alla vocazione dei lavori muliebri. C'era tra queste, la monella del medico, che aveva per compagna di banco la figlia del maestro; vivacissima pur essa e furba più dell'altra, e più dell'altra tanto brava in lavoro; sapeva cucire con il ditale, non le sudavano le mani, lavorava la calza tenendo il filo sul dito e, ciò che importa, raramente lasciava cascare le maglie a scaletta ... Quel mattino di uno smagliante maggio, lei aveva portato dentro la cartella un bel mazzetto di erba «acetosella» e dentro un cartoccio le «raspe» croccanti, tolte dal paiolo della polenta. Si doveva far finta di preparare una specie di gustoso... pasto; e poi chi sa quali cose interessanti le due avessero da scambiarsi!...La supplente aveva già richiamato or l'una or l'altra delle due, le aveva persino minacciate di "penso". Ad un certo punto ne chiama una al tavolo con la sua calza, la quale aveva ben due maglie a scaletta, scappate giù giù fino ai primi giri della calza. Brontolando, l'insegnante sgusciò di colpo i ferri del lavoro, tese rigirando nervosamente il filo che in pochi istanti si tramutò in un grazioso mucchietto di lana ricciutella! Mancava poco alla fine della lezione; la scolaresca dava segni di stanchezza; le due erano tornate ciarliere e riderelle. A un dato momento la supplente si alzò di scatto dalla sedia e tra un silenzio generale scrisse sulla lavagna: «La C ...... e la A ....... sono le peggie della scuola. 300 volte, firmato». Tutti gli occhi furono addosso alle due infamate. Quando la figliola rientrò in casa mancava poco a mettersi a tavola; si rincantucciò zitta zitta su di uno sgabello, tenendo con i gomiti ben stretta sulle ginocchia la sua cartella. Nessuno le fece caso; quando rientrò il padre di ritorno dalle visite in paese, come sua tenera e tenace abitudine, rigirò lo sguardo per accertarsi che tutta la nidiata fosse al completo. «Ne manca una — disse — dov'è?». La scovarono subito, ma essa rimase immobile a capo chino. Allora il padre le fu vicino, le pose la mano sulla testa dicendo «Cos'hai... la febbre?». Non era ancor finita la frase ch'essa scoppiò in singhiozzi, e, levato un quaderno dalla cartella, lo consegnò aperto al padre. Sulla prima pagina egli lesse ciò che la figlia in nitida grafia aveva ricopiato dalla lavagna. Un istante di silenzio, poi si udì una di quelle buone, brevi risate che il medico sapeva fare in certe occasioni! La piccola protagonista credeva di sognare!...Suo padre la canzonava... invece di ammonirla! Non sapeva rendersene conto, nemmeno quando, fattosi serio, le disse laconicamente: «Appena finito il pranzo e sgombrato il tavolo, tu trascriverai 30 volte, hai inteso, 30 volte il tuo penso in bell'ordine e poi lo passerai a me!». Il padre di fronte a quella grossa sgrammaticatura che ovviamente non poteva correggere e nemmeno voleva far rimarcare all'interessata, scrisse sotto il penso: «Riconosco l'insubordinazione di mia figlia e ritengo che la sua distrazione le abbia fatto scrivere uno zero in più alla cifra del penso!». Una specie di soluzione salomonica, avente anche lo scopo di impedire che la sgrammaticatura — troppe volte ripetuta — entrasse nella testa dell'imputata!... Ma, — guarda un po' — il caso volle che proprio la stessa divertente sgrammaticatura mettesse poi salde radici dentro il lessico familiare. E quel «peggie» restò sempre sinonimo di «lavoro femminile» per tutti i membri della famiglia. UN PAESINO DA « NULLA» Si dice talvolta che per gli occhi! Naturalmente dentro l'anima, dove, visione più cara, stanno veder meglio si devono... chiudere per veder meglio dentro noi stessi, riposti in dolcissima pace, nella i ricordi più vivi. Orbene, portiamoci sui crinali delle belle montagne a rivivere con la gioia dello spirito le escursioni di un tempo lontano. E tra i moltissimi e svariati itinerari vogliamo di proposito sceglierne uno solo, quello che ci ricondurrà nella memoria a scoprire una piccola grande cosa: un paesino da nulla sull'erta di un monte selvaggio, solo e orgoglioso nella luce sconfinata della sua immensa solitudine eloquente. Vi si giunge dai monti della bassa valle, dopo lunghi chilometri, beatamente affondando i piedi nel soffice sottobosco, dove la più svariata e profumata flora alpina ti rende lieve la fatica, ti riempie i polmoni di inebrianti aromi e t'invita a cantare! E quando si è in allegra comitiva il canto corale diventa gioia, energia, entusiasmo. Sono vecchie canzoni popolari che sgorgano spontanee dalle gole canore; e così piene di fresca melodia prorompono in scorrevoli ed ampie tonalità musicali. Il sole accenna al tramonto quando, usciti dai boschi di faggi querce e larici, ti si affaccia allo sguardo lo sfondo della Valle di Vergeletto, nell'ampio giro delle sue giogaie di monti sfolgoranti nell'ultima luce solare. Sotto ai nostri piedi, stanno prati e dossi verdi seminati di cascine; ma di fronte, in alto, sopra una radura, dove spicca la rude sporgenza dei tornanti polverosi di una ardita e angusta carrozzabile, ecco adagiato tra il verde, il miracolo di un pugnello di case: un minuscolo paese da nulla: Gresso. E stai estasiato ad ammirarlo, avvolto in una leggera nebbiolina di fumo evanescente, sfuggito dai comignoli nell'imminenza della parca cena, intanto che nel cielo si accendono le prime stelle. E' un paesino «da nulla» Gresso, così solo, così fuori dal mondo, con le sue casine strette l'una all'altra, divise appena da sassose anguste viuzze, vigilate dalla chiesuola con la sola campanellina sull'esile torretta; con al centro una casa che, unica, vanta il pregio di riunire in se, posta, osteria, prestino e il negozietto «d'ogni genere»: è la casa del signor Gentile. Orbene, mirando quel paesino, qualcosa ti avvince, che non è soltanto la sua sicurezza d'esser solo e di bastare a se stesso sull'erta d'un monte; esso è una limpida immagine della più schietta comunità e della tacita fratellanza che riunisce dentro un pugnello di case, individui e famiglie. Allora non puoi far a meno di ricordare il pensiero poetico del «Rio Bo» del poeta: «Microscopico paese da nulla, però c'è sempre di sopra una stella, ... una stella innamorata. Chi sa se nemmeno ce l'ha una grande città?». Anche il medico di condotta amava soffermarsi al sommo dei tornanti di Gresso, nella tarda ora del tramonto, per contemplare lo scintillio delle stelle palpitanti in quella stupenda conca di cielo. Forse come in nessun'altra parte della valle, il firmamento nella zona di Gresso sa mostrare tanta arcana dovizia! Era lui stesso, il medico ad asserirlo, e voleva che i figlioli lo sapessero. Perciò c'era la fermata d'obbligo in quella specola naturale: egli puntava il suo bastone ferrato verso il cielo e rendeva attenti i figlioli, si estasiava in quel grande silenzio palpitante di vita stellare. A ponente la dolcissima e vivida luce di Venere sopra Vergeletto, tutto a nord il gran carro dell'Orsa maggiore, poco discosto l'Orsa minore con la Stella polare dritta e vigilante sopra Gresso; verso meridione in certi periodi estivi la luce arancione del pianeta Marte, quasi piccolo braciere ardente. E dentro la lunga misteriosa Via Lattea. I figlioli si divertivano un mondo a creare nomi fantasiosi di gruppi stellari; c'era «la carta geografica», una «gabbia con uccellini saltellanti», una «corona di re» un «rosario d'oro», uno «scrigno aperto sfolgorante di diamanti». E il padre compiaciuto non spiegava più; lasciava che la fantasia sbrigliata dei suoi monelli corresse tra terra e cielo rendendo leggero e più veloce il piede lungo la sassosa discesa dei tornanti. Ma ci fu chi seppe vedere e apprezzare quel selvaggio angolo di monte. Vennero dal nord, dal lontano e gelido mare dei Paesi Bassi, già negli anni antecedenti la prima guerra mondiale. Non si sa né come, né perché. Vennero con tutta la loro tenacia, il loro sereno realismo, sostarono ai piedi dei tornanti di Gresso e scelsero un simpatico pianoro riparato dai venti, attorniato da pinete, rallegrato da limpida scorrevole acqua canora, con il sole smagliante di giorno e le stelle sfolgoranti nelle notti senza luna. E fecero sorgere una solida comoda costruzione, capace di accogliere diverse famiglie: e la chiamarono «Villa degli olandesi». Per tutti e sempre fu solo la «Villa degli olandesi», e a tutti sembrò un miracolo di generosa benevolenza verso la valle. La diligenza dapprima, le auto postali poi, che ai piedi della costruzione avevano fissato una nuova fermata, offrivano ai passeggeri lo spettacolo di una gentile visione. La mole ardita, lo stile nordico, le facciate irregolari con le molte finestrelle ornate di pizzo; le graziose scalette del pianoterra; e davanti alla facciata principale un minuscolo leggiadro parco di betulle, quasi fosse l'ondeggiare delle vele sul loro pallido mare. Il tutto destava la curiosità di avvicinare quegli strani robusti abitatori e — perché no — di stringere amicizia con i loro bambini dagli occhi color del mare, dai capelli biondissimi e con quelle curiose calzature a punta come microscopiche barchette. La permanenza degli olandesi in valle si prolungava oltre la stagione estiva; non di rado succedeva che avessero bisogno del medico di condotta. E lui vi andava premuroso come sempre, fiero di prestare la sua opera a fratelli di altra stirpe, conoscere da presso la loro correttezza per un logico scambio di simpatie. Anche per i figlioli del medico era grande festa sostare nel parco dei bambini olandesi a «conversare» tra squillanti risatine. Le loro parlate erano tanto diverse: eppure subito nasceva e vi si stabiliva la più naturale intesa. Molto spesso succede così tra bimbi di idiomi e costumi diversissimi. Che ne sappiamo noi adulti? Forse è nient'altro che la trasparenza delle loro anime infantili, a giocare il simpatico sortilegio. Un giorno che il medico si era attardato più del solito dentro la villa, i piccoli olandesi si diedero un gran da fare a portare fuori sul prato scatole e scatolone colme di giocattoli da mostrare ai nuovi amici. C'erano bambole con le trecciole dorate, barchette a vela e navi di una certa importanza; giuochi di costruzione con l'immancabile mulino a vento; tutta la serie degli animali domestici in legno; e curiosi giardinetti con finti giacinti e tulipani, ritti nel verde come spilli dentro un cuscinetto. La conversazione si animò; le frasi più strane si incrociavano con esclamazioni di gioia, in perfetta letizia. Ad un tratto spiccò il nome di Haarlem e di Giovannino, il piccolo eroe che aveva chiuso con il suo ditino intirizzito dal freddo un buco nella diga, dietro cui il terribile mare sarebbe passato a sommergere la città. (Proprio così raccontava la stupenda novella del libro di lettura) E quando i figlioli del medico in un euforico entusiasmo ripeterono la voce cattiva del mare che sussurrava: «giù, giù: passerò, passerò giù, giù: annegherai, annegherai...» si elevò nell'aria al di sopra delle betulle un coro di voci e l'incrociarsi di due nomi: «Evviva Giovannino di Haarlem». Oggi ancora a distanza di decenni tornano gli olandesi alla loro villa. Sono le generazioni nuove della nostra nuovissima epoca. Tornano sorvolando l'Europa con gli aviogetti; discorrono forse di imprese spaziali, di elettronica, di scienza nucleare; enumerano i grossi problemi sociali e religiosi dell'era presente; esaltano i nomi dei loro eroi sportivi. Sono forse uomini forti e studiosi come i loro antenati che hanno dominato il mare con gigantesche dighe, per cui si dice: «Dio ha creato il mondo e gli olandesi l'Olanda!» Sono forse studiosi e colti, sempre alla ricerca di problemi da risolvere; e sono forse anche uomini ricchi; eppure tornano ancora ai piedi dei poveri tornanti di Gresso — il paesino da nulla — con la semplicità nel cuore di chi è sicuro di ritrovare la serenità nel suggestivo scenario di una natura intatta, non deturpata dalla tecnica. Convinti di cercare la risposta ai misteri dell'Infinito, nel silenzio di una notte stellata, al di là di quello splendido firmamento. LE BELLE ESCURSIONI Da Russo, su per il ripido sentiero a picco del torrente Caurga, eccoci alla Furcola: gigantesco cofanetto verde di velluto erboso. Vi si giunge con il «fiato corto», diceva il medico, che aveva per la comitiva in aspra e pericolosa salita un «occhio clinico»; perciò consigliava a riprese un attimo di distensione per una più calma e profonda respirazione. L'alpestre scena di quel monte, inquadrato nella luce diffusa di un azzurro tersissimo, l'aria imbalsamata di resina, i campani delle pigre vacche pascenti ti inondano di gaiezza. E se appena ti soffermi accanto ad una di quelle casupole di pietra viva, sei certo di incontrare la più festosa abituale ospitalità onsernonese e di sentirti ritemprate le energie da una tazza di caffè: di quel loro caffè che odora di faggio e di resina, ispessito da un cucchiaio di fresca panna, che nel dialetto di valle vien chiamata in perfetta dizione: «la spessura». *.*.* Da Russo ancora, muovendo i passi stavolta verso nordovest dopo una prima ripida salita lungo il sentierino degli ultimi prati, ecco inoltrarci nella fitta faggeta del patriziato: riserva inestinguibile per tutta la legna da ardere dell'intero paese. Il sentiero è in lieve salita, per nulla faticoso, anche per la morbidezza del sottobosco; e il fitto fogliame dei faggi nasconde alla visuale il burrone che più sotto finisce a strapiombo sulla strada del Ponte-oscuro. Si cammina così leggeri, senza sforzo per oltre un'ora, fin che, uscendo dalla boscaglia, posi lo sguardo su di una ampia distesa verde, in faccia al sole, ondulata di terrazzi, pianori e dolci poggi. Il tutto intersecato da molte casupole e cascinali in pietra scura, delimitati da precisi steccati di legno dentro cui, ben coltivato a verdure e fiori, sta l'orto di ogni famiglia: è Quiello, il paesino alpestre per la dimora estiva di Russo. A questo punto non puoi far a meno di sostare in ammirazione, portandoti una mano a schermo sulla fronte per abbracciare con lo sguardo quel pugnello di abitacoli in miniatura dentro la pace infinita di una conca verde. Una sensazione di gaudio fraterno t'inonda l'anima, se non che di colpo un pensiero tenebroso ti assale e ti scuote, come di un sassolino che entrato improvviso nella superficie tranquilla di uno specchio d'acqua, la rompe, l'increspa e la scompiglia in infiniti cerchi misteriosi...Perché mai?... Nel posare l'occhio su di un pezzo di prato poco più grande d'un lenzuolo, tra due casupole, un ricordo di un'arcana paurosa narrazione passata di bocca in bocca dai grandi e raccolta con occhi sbarrati dai piccoli, si è presentato vivo e macrabo alla tua fantasia. Una donna aveva osato nel bel mezzo d'una estiva notte lunare, spostare i termini, di confine per fare un poco più grande il suo pezzo di prato, decurtando lo spazio della vicina. Dopo sorde lunghe querele avvenne che la donna morì e per tante notti di seguito, allo scoccar della mezzanotte, l'anima della poveretta veniva scorta — avvolta nel funereo drappo — percorrere ripetutamente il confine del suo pezzo di prato, preceduta da uno strano alitare di vento, dentro cui si udiva l'eco ritmata di un lugubre singhiozzare. E così ogni notte paurosa, fin che scontato non fu il peccato del maltolto. *.*.* Rechiamoci verso Mosogno con un itinerario ardito: infiliamo sotto il ciglio della carrozzabile un'interminabile gradinata di pietraie a ciuffi d'erba, per scendere giù giù in fondo alla valle. Giunti a scorgere l'Isorno sonoro e spumoso, proprio nel preciso punto dove nei primordi della storia (come annota il prof. Natale Regolati) il traghetto del fiume era fatto con un navicello: da qui il nome di Naveria e poi Neveria dato al ponte costruito più tardi in sasso a schiena di mulo. Attraversato il ponte e recato un saluto a traverso l'inferriata della finestrella alla chiesuola della bella leggenda, si risale subito il lato opposto della valle, riacquistando a forza di polmoni i metri perduti e oltre, in un sottobosco di mirtilli. Dopo un paio d'ore di tutta salita si raggiunge un'altra erbosa e ampia conca verde seminata di cascinali che coronano la suggestiva chiesetta alpina della «Madonna della Segna» in territorio centovallino. Una gustosa sosta e poi si riprende a salire sotto una fitta faggeta, la quale, sul malagevole crinale del Pizzo Ruscada, cede a poco a poco il posto ai larici, ai pini e poi alle conifere di basso fusto. Il sentiero è a tratti raccapricciante, perché si staglia entro i canaloni che a precipizio finiscono dritti nel letto dell'Isorno. Dall'alto di quell'impervia cresta del Ruscada, con l'azzurro del cielo sopra la testa e ai piedi la voragine insidiosa, si prova la strana sensazione di esser diventati piccini, inermi...Allora qualcuno della comitiva per non tradire un senso di arcana paura, intona con la bella pura voce dei suoi vent'anni l'appassionata canzonetta dell'emigrante ticinese a cui risponde il coro argentino e rincuorato di tutti: «Dimmi oi bella che tu vuoi venire che il mio cuore palpita d'amor per te...». Intanto che l'occhio di ognuno spazia sul vasto panorama di due valli sottostanti, l'anima si fa grande e sconfina oltre il creato... Poi finalmente si perde quota e con i piedi più saldi e il respiro più ampio si raggiungono i poggi e i dirupi sassosi sotto Spruga, e si attraversa l'Isorno giovinetto, su di un fragile ponte. La scalata al severo pizzo Ruscada è compiuta con l'orgoglio dell'escursionista, pago per l'aspra sua impresa. *.*.* Comologno riserva agli appassionati un'altra insperata conquista. della montagna Con la tenacia e la regolarità, proprie all'incedere dei montanari avvezzi alle lunghe salite, ci disponiamo ad attraversare, salendo, le svariate regioni montane. Subito al disopra del paese, i pendii dei prati lisci, poi intersecati da ginestre montane, da ciuffi d'erica e macchie di rovi; ai lati del sentiero quasi pianeggiante, compare la felce maschia, rustica testimonianza dell'ultima era quaternaria, che ingombra il terreno ai piedi dei primi faggi e dell'ultimo sorbo. Lentamente il bosco s'infittisce, mentre qua e là spiccano le ultime leggiadre chiome delle cento foglioline pendule delle betulle, che d'un tratto, in una piccola spianata erbosa sembrano salutare con accennati inchini dell'esile e bianco fusto, il sopraggiungere sfrontato dei duri larici, invadenti il pendio pietroso della montagna. Mentre si calca il sentiero a zig-zag per l'ultima ascesa, lo sguardo è perso giù in quella fragile adunata di betulle, che, quasi evanescente, pare la riproduzione viva delle ballerine di Degas. Siamo in cima: davanti a noi la luce di uno sconfinato orizzonte e il sipario aperto sull'alpe di Salei: le mandrie al pascolo, o pigramente adagiate sul fitto tappeto verde, il gregge delle pecore con il muso rasente terra, le cascine, le lunghe stalle, e tra l'erba, sostenuti da zampe di legno, i segmenti dei rustici abbeveratoi ricavati dal tronco scavato dei larici: il tutto sembra messo lì sul muschio per un grande fantastico presepe. Poi in un angolo sopraelevato del grande scenario, il laghetto alpino, il lago dei Salei: stupenda smisurata pietra di zaffiro, incastonata dentro una corona di rododendri in fiore... NELLA DOLCE TERRA DEI NONNI I nonni, tutti e quattro, stavano di casa a Mendrisio. Essi quasi mai compivano il lungo viaggio per recarsi in Valle, che allora era un viaggiare anche un poco disagevole. Uno però c'era fra i quattro che affrontava senza indugi le lunghe ore di treno e di posta: era il nonno paterno a cui piaceva il soggiorno in Valle. E grande festa faceva sempre la nidiata alla sua comparsa. I nonni!... Una miniera di serenità, un fulcro che rinsalda i due estremi dell'arco della vita: alba e tramonto. I primi, i nipoti, inconsciamente si sentono attratti dai secondi; ma questi, i nonni, guai a scordarsi d'esser i generatori di due generazioni, di cui essi vantano la duplice proprietà, l'esclusiva proprietà, tanto che allora era un orgoglio, un dovere anzi per le nonne tener pronto sulle labbra or l'una or l'altra delle tipiche frasi: «sangue del mio sangue, viscere delle mie viscere...» e mai nessuno osava dissentire. Ma poi che il tempo passava e che ineluttabilmente qualche vuoto si faceva tra la bella quaterna dei nonni, i figlioli più grandi della nidiata venivano inviati a turno a Mendrisio a tener compagnia ai nonni rimasti. Era il 1913 di un luminoso e dolce settembre. A Mendrisio si facevano i preparativi per un Congresso eucaristico. E la madre, che premeva in cuore un palpito di nostalgia per la sua terra, asseriva che bisognava mandare una «rappresentanza» laggiù. In famiglia si dispose che il turno toccasse alla seconda figliola, dal momento che la primogenita, già ormai una signorinella, era quasi di casa a Mendrisio, dove stava tutta a suo agio. Il padre preparò con meticolosa chiarezza l'itinerario di un viaggio che non era né breve, né semplice per una ragazzina che per la prima volta si allontanava sola da casa. A Mendrisio giunse in pieno pomeriggio con una gioiosa sensazione d'orgoglio. A riceverla c'era lo zio, sotto la pensilina della stazione assolata e semideserta. E in quel preciso momento essa avvertì l'urto della prima impressione: uno strano senso di solitudine e un sentirsi come rimpicciolita. Mentre percorreva il lungo tratto dritto fiancheggiato da vetrine, a lato di quello zio robusto e silenzioso, girando lo sguardo si avvide di trovarsi dentro un ampio orizzonte luminosissimo. Proprio di fronte ai loro occhi si elevava, facendosi più nitida, una roccia strana nel gioco meraviglioso delle sue luci, d'ombra e di sole; dei suoi chiaroscuri di nudo e di verde, profusi di riflessi d'oro, con un piccolo eremo intarsiato con grazia nella stessa roccia. Non ne aveva mai ammirata un'altra simile! C'era sì, a Russo, dietro la sua casa una roccia irregolarmente nuda, ma quanto diversa! «...zio, che cos'è quel bel monte?» disse rompendo il silenzio. «Come, non lo sai?... l'è ul ciapp dal san Nicolaa, ne vedrai altre di belle cose, se farai con noi una lunga vacanza...». E poi non disse più nulla. La ragazzina pure si tacque, quasi sommersa di pensieri, fin che giunsero sulla porta a vetri dell'albergo della «sciura Teresa» la «mamgranda» come voleva esser chiamata lei; la madre di sua madre che l'aveva messa al mondo proprio lì in quella stretta contrada, dentro un lungo e importante caseggiato da cui era uscita sposa giovanissima, in un candore di veli, come nuvoletta irradiata di sole. La nonna si strinse ben due volte al petto quella figlioletta esclamando con un sospirone: «la tusa da la mia tusa! ...». Una scenetta in pieno contrasto: il trionfo della nonna accanto alla nipotina che per la prima volta provava il disagio della timidezza....... Ma non era la nonna ad incuterle soggezione, bensì quel vasto locale, altissimo ai suoi occhi, curioso a vedersi nel suo arredamento, con quel gigantesco maestoso camino che occupava quasi intera la parete di fondo, al cui angolo destro si apriva una fuga di sale, salette, salottini, e finalmente un lungo luminoso salone chiuso in fondo da un palco. Il tutto un ambiente invitante e austero, solenne, ma freddo, indicibilmente estraneo; e parve il cozzarsi di due nature: lo spirito che emanava da quell'ambiente contro la sensazione nuova della fanciulla. Ora qui nacque per quell'ambiente la sua prima sorda e segreta ostilità, la quale via via che passavano i giorni si acutizzava fino a raggiungere il suo culmine ogni volta che all'ora dei pasti i familiari si raccoglievano ad un'estremità del lungo tavolo, con le spalle al camino e il viso verso la porta a vetri, per esser pronti al saluto di chi entrava in albergo. E la ragazzina inconsciamente si vedeva nei panni di sua madre bambina, crescere, giocare, folleggiare dentro le spire di una sì strana atmosfera ... C'era però una cosa di suo gusto: infilare la porta della cucina che si apriva a sinistra del vasto camino: un locale lungo, alto come il primo, con una vetrata che guardava l'ampio cortile interno; sulla parete opposta un arsenale di casseruole, padelle, coperchioni e coperchietti di lucidissimo rame. Sotto la vetrata una cucina economica che sembrava non finire mai, davanti alla quale in certe ore del giorno ci stava il cuoco ad armeggiare intento, ma sempre ilare e faceto, nella sua bella parlata romana che a volte intercalava canoramente di romanze italiane allora in voga. Dentro le vie del Borgo ferveva quell'animazione insolita e uguale un po' ovunque nei giorni che precedono una festività.Verso il pomeriggio inoltrato intanto che la nonna, seduta al tavolo sotto il porticato che dava sul cortile, sceglieva, mondava, sbaccellava un'enorme quantità di erbaggi esuberanti di freschezza, la ragazzina assaporava un vago senso di libertà. Uscì sulla strada e si portò verso la piazza, sotto le superbe gradinate della chiesa da dove veniva il regolare scampanio festoso. La facciata della chiesa a Mendrisio (vedi «Storia della prepositurale di Mendrisio» di Mario Medici) sorge in vetta ad un minuscolo poggio e mostra con imponenza soffusa di dolcezza tre bellissime arcate, sul cui attico s'innalza la cupola campanaria tarchiata, quasi tozza. Mendrisio nel 1930. Foto Soldini - Chiasso D'un tratto (chi sa come) essa rivide il suo caro campanile lassù in Valle, così alto e snello, e in cuore le punse la nostalgia.... Russo, anni '20, foto Finzi - Lugano Salì, si soffermò sotto le arcate a contemplare il sole che calava tra nuvole d'oro dietro un mirabile anfiteatro di colline. Poi si trovò dentro il grande tempio con le pupille ancora cariche di luce, e l'urto della penombra in quell'immenso vuoto le diede la sensazione di trovarsi in un mondo irreale, come le succedeva nei suoi fantasiosi sogni notturni. Chierichetti e sagrestani formicolavano, intenti ai preparativi per la funzione serale eucaristica. A poco a poco prese fiamma un numero incalcolabile di candele e lampade, e allora tra un luccichio di oro e di argento troneggiò singolarissimo un altare fatto a guglia: la fanciulla non credeva ai suoi occhi che potesse esistere un altare tanto diverso da quelli dentro le chiese della sua valle. Allora si ricordò di tutto quel parlare che il nonno faceva sempre intorno alla sua chiesa di Mendrisio, ... che lui l'aveva vista sorgere pietra su pietra; e che — finita — l'aveva benedetta il prevosto Gaetano Pollini, poi consacrata il vescovo del Ticino Mons. Vincenzo Molo. E ancora, che il Papa Pio IX aveva mandato da Roma il suo messaggio con la benedizione e le indulgenze, felicitandosi con i Mendrisiensi; che in tutto il Cantone non esisteva una chiesa così bella e così grande come quella dei santi Martiri Cosma e Damiano. E che nel Borgo viveva la persona che per la prima aveva ricevuto il battesimo nel tempio, appena consacrato; faceva la fruttivendola: tutti la conoscevano, anche quelli di fuori, e tutti la chiamavano sempre e soltanto "Prima" come se il suo cognome fosse andato perduto. Tutte queste cose la ragazzina ricordava beata. Poi di colpo si sprigionò dall'alto della cantoria un poderoso suono d'organo, che le cupole, i vani, le colonne del tempio fecero echeggiare in soavi cristalline melodie. La fantasia della bimba ebbe un sussulto, essa che non conosceva se non il suono del minuscolo armonium di suo padre, che veniva portato in chiesa per le solennità..... Intanto teneva fisso lo sguardo su quell'altare, perché così alto e finemente intarsiato le sembrava una guglia frastagliata del suo Ghiridone, baciato dal sole. Ma poi si accorse che qualcosa stonava e si chiese: “perché quel tendone rosso dietro l'altare appeso e tenuto stretto da una specie di vecchio e malfermo baldacchino fissato su sotto la cupola?... Com'è brutto, quasi che le belle guglie che si elevano al cielo avessero bisogno di un tendone!... “ A cerimonia terminata, sull'uscita della chiesa, tra la calca dei fedeli, incontrò la nonna che la prese affettuosamente sottobraccio. E la ragazzina, quasi non potesse trattenere le sue impressioni, esclamò: «Nonna, com'è grande la tua chiesa, e com'è bello il suo altare; però non mi piace quel tendone rosso...» — «Sa ta disat, tusa, l'è ul so bel!» — sentenziò la nonna. La figliola restò male e si chiuse nel silenzio; sapeva che la nonna era un po' sempre battagliera e che non ammetteva contraddizioni. All'indomani mattina il postino entrò in albergo, depose sul lungo tavolo un cesto pesante di vimini colorato, con due coperchi tenuti chiusi da fibbiette, e sormontati da due manici rivestiti. Era indirizzato alla nonna e veniva da Russo. Appena aperto si sparse per l'aria l'acuto profumo di funghi: che meraviglia! riposavano tra soffici cespuglietti di muschio; c'era tutta una varietà di allettanti e freschissimi funghi porcini, boleti, prataioli, "chanterelles". La fanciulla contemplandoli rivede i suoi boschi, le faggete, i castagneti e assaporò il profumo selvaggio della sua valle...; poi proruppe in una domanda: «Zio, quando mi accompagni a casa?...» — «Ma come, rispose lui quasi seccato, saresti già stufa di stare con noi?... tua sorella non fa così!». Allora la nipotina trovò il coraggio di ribattere: «Sì, ma mia sorella è andata a scuola a Mendrisio; qui c'è la sua maestra Nemesia, le sue amiche che ricorda sempre: l'Ada, la Lina, la Rita, la Maria: Io invece sono sola!..» Erano i primi attacchi d'un «male oscuro» che lentamente prendeva possesso e non poteva più contenersi in petto: «il mal di paese» e... nessuno se ne avvedeva. Nemmeno la nonna; perché può succedere talvolta che per quel «bene» troppo possessivo, i nonni non sappiano vedere dentro l'anima meravigliosa del bambino. Appena terminato il pranzo e distribuito i vassoi con il caffè ai singoli pensionati, là nelle salette (incarico affidato alla ragazzina) la nonna disse di doversi recare giù verso Cercera per delle incombenze. Nonna e nipotina eccole in strada: l'una orgogliosa e l'altra beata, come sempre capitava di esserlo a quest'ultima, appena poteva uscire dalla porta a vetri e voltare le spalle all'albergo. A metà discesa della strada nuova (la strada di «Meregasc» costruita dall'ingegnere dalla testa grossa...) così spiegava la nonna, svoltarono a destra verso il cimitero. Giunte di fronte ad un'ampia cancellata in ferro battuto, vigilata da due altissimi cipressi, la nonna cavò di tasca un lungo rosario marrone, mentre la fanciulla taceva stupita e pensosa. Essa di colpo rivide dentro gli occhi il piccolo camposanto su in Valle, con un cancello mai chiuso a chiave, ma solo a malapena accostato, al margine della strada, sul limitare di un castagneto, di cui qualche robusto ramo fronzuto sporgeva verso l'interno del muretto di cinta e abbondantemente lasciava cascare in autunno i grossi ricci aperti al sorriso, sui poveri disadorni tumuli. Entrate nel grande camposanto, la ragazzina girò lo sguardo su quella fitta selva ordinata di croci e di figure in marmo, di lapidi lucide con le fotografie. Alla svolta del viale principale venne colpita da una figura maschile in marmo bianco, ritta in piedi, vista di fronte, in modo tale che si trovava in posizione perfettamente opposta e tutte le altre tombe. Le piacque subito, si avvicinò, sfiorò con la mano il bastone ricurvo su cui sembrava appoggiarsi (proprio come faceva suo padre) e lesse su di una lapide: «Dottor Carlo Pasta, i figli gelosamente ne ricordano le virtù, gli ammalati il medico benefico e monumento eterno alla gloriosa sua memoria resta il Generoso». Allora le tornarono un'altra volta alla memoria le parole del nonno, di quel nonno Florindo così ciarliero e così gustoso nel suo dire, e riandò beata la storia di quell'uomo che fu grande e bravo, ma che i suoi Mendrisiensi non seppero comprenderlo in vita. non l'assecondarono nei suoi grandiosi progetti: egli assicurava che il Generoso avrebbe fatto la grandezza di Mendrisio. Sì, proprio così diceva il nonno! Poi alzò lo sguardo, mirò quelle pupille marmoree che sembravano vive, puntate com'erano verso il cielo lontano quasi volessero significare: «ammiro, sì, il mio Generoso, ma il mio anelito è ora finalmente pago nella grandezza di Colui che creò tutte le montagne». Poi quasi di corsa passò oltre la costruzione dei «forni» dicendo alla nonna che non voleva scendere in quegli antri, perché le mettevano degli strani brividi, e si trovò in contemplazione di un monumento di mole imponente, quasi un mausoleo: seduta ai piedi di un busto raffigurante un gagliardo giovane, stava la madre avvolta in un ampio scialle così naturale, per nulla marmoreo, la cui frangia sembrava scomposta dalla brezza; ai piedi un paio di zoccole che veniva voglia di toccarle per accertarsi se davvero non fossero di velluto le «pattine» e di lana il nodo della «frisa». E il caro povero viso di quella madre in un atteggiamento di dolore senza conforto. La ragazzina impressionata riandava solo alcune parole del racconto vivo del nonno, le più terribili: «...le avevano ucciso il figlio per la politica!...». Poi ripresero la discesa, giù giù oltre il sottopassaggio di Cercera; la nonna disse che doveva recarsi alla «Tana» per ordinare della polleria e dei salumi nostrani della «mazza» casalinga. A destra di un bel sentiero scorreva dell'acqua tranquilla, silenziosa, ombreggiata da fitta boscaglia e si muoveva così lenta che appena appena incurvava l'erba dei margini. La fanciulla guardò e chiese: «Nonna, cos'è?» «Ma non vedi?... è un fiume, ul nost Lavecc che vegn da Stabi» « Ma nonna, i fiumi non sono così! questo mi sembra un biscione che striscia nelle foreste vergini; non posso guardarlo! i fiumi veri non sono proprio così!» - «...Ma come sono dunque?». E la bimba presa da entusiasmo parve non smetterla più di parlare; disse che i fiumi della sua valle scorrono in fretta, fanno rumore come cantassero una bella canzone; hanno grossi sassi lucidi dentro il loro letto e della sabbia d'argento; fanno cascate bellissime, bianche come panna montata, spruzzano acqua purissima come se giocassero, e mettono gioia a guardarli... «...Ma chi t'insegna queste cose?» interruppe la nonna. «il mio papà, - rispose sicura - lui sa tutto, è come un vocabolario il mio papà!». La nonna guardò negli occhi la sua nipote e non ebbe nulla da replicare. Sulla via del ritorno il giorno stava scemando, tra le dolci colline del Varesotto calava il sole in una palla infuocata e i suoi riflessi incendiavano la roccia del San Nicolao; in uno spiccato profilo d'argento si delineavano il San Giorgio, il colle di S. Agata e il vasto cielo d'opale era tutto un incanto. La piccola lo mirò a lungo e poi uscì a dire: «nonna com'è bello il cielo di Mendrisio!» E lei di rimando: «Ma se l'è 'inscì bell', perché non vuoi restare con la tua 'mamgranda' che ti vuole tanto bene?». Quella lunga giornata doveva avere il suo epilogo. Come ogni sera la porta a vetri dello albergo si apriva e si richiudeva in continuazione al passaggio dei clienti intenzionati a trascorrere le prime ore notturne al tavolo da gioco, o intorno a quel bellissimo biliardo dal tappeto verde, con quelle palle d'avorio così vive e quasi pensose al tocco dell'elegante stecca di legno lucido. Ad un tratto la nonna chiamò la nipote e le disse: «Vieni a vedere chi c'è; saluta questo signore che conosce i tuoi genitori, si chiama N. T.». Era persona dall'aspetto distinto, vivace e faceto proprio alla maniera dei Mendrisiensi. Ebbe parole allegre per la bimba e poi disse di scatto: «Oh, io la conosco la valle Onsernone: è tutta sassi!». La fanciulla fu come fosse colpita in pieno petto e subito rimbeccò un «non è vero!» deciso, guardando male il signor N.T. il quale riprese: «Adesso ti fermerai a far compagnia alla tua nonna, e vedrai come ti piacerà andar a scuola a Mendrisio». Fu un attimo imprevedibile: la figliola scoppiò in lagrime con certi singhiozzi che sembrava si sprigionassero chi sa da quale profondità; incapace di reprimerli andò ad accovacciarsi in un angolo del grande camino. Rimase assai male il signor N.T. e subito consolò la bimba con parole gentili e le mise nella tasca del grembiulino una bella moneta d'argento dicendole: «ti comprerai un giocattolo da portare ai tuoi fratellini...». Doveva essere il bello scudo che allora recava la regale figura dell'Elvezia seduta accanto allo stemma crociato. E di giorni ne passarono parecchi. Si chiusero anche le cerimonie del Congresso eucaristico: fu un'apoteosi di fede la lunghissima e ordinata processione con le confraternite, le verginelle nei graziosissimi costumi in svariate tinte pastello e quel gigantesco grappolo di uva bianca, portato a spalla da due giovanotti: simbolo biblico della «Terra promessa», ed espressione liturgica dell'Eucarestia. Tra la folla dei curiosi si andava dicendo: «Soltanto Mendrisio sa fare delle belle processioni!». A poco a poco, settembre si adombrava delle sue luci meravigliose; la brezza della sera si faceva fresca e l'autunno incombeva superbo sugli ubertosi vigneti stracarichi di pampini d'uva. Da qualche giorno si andava dicendo che su nel Sopra Ceneri pioveva con un susseguirsi di temporali di rara violenza. I corsi d'acqua rumoreggiavano ingrossati a dismisura convogliando materiale terroso e legnami. E nel Mendrisiotto incombeva un'afa pesante. Fu il pomeriggio sull'imbrunire quando si scatenò tra lampi e tuoni un furiosissimo temporale. In pochi minuti tutti i vigneti della plaga vennero spogliati, spelacchiati, denudati. E i chicchi di grandine grossi come noci e persino come uova, giacevano in terra a mucchi, misti a grappoli pesti e vetri infranti. Scese la notte su di una generale costernazione. All'indomani presto il postino recò un telegramma da Russo che diceva laconicamente: «Non muoversi fino nuovo avviso; ferrovia interrotta Bellinzona - Locamo, piano Magadino inondato». Ma il telegramma aveva taciuto il peggio, che non tardò a sapersi. I primi clienti entrati in albergo dissero che nel bel mezzo del piano di Magadino l'acqua aveva asportato il terrapieno della ferrovia e la locomotiva dell'ultimo treno della sera per Locamo era sprofondata con il suo macchinista. Furono giorni veramente tristi e lunghi a non finire per la ragazzina, che già aveva gioito alla idea del suo ritomo in Valle! Quante volte - non vista - andava ad aprire la bella scatolona con il regalo che la nonna le aveva fatto comperare accompagnandola in fondo a «Corrobiello» in un negozietto tutto di giocattoli, spendendo il bello scudo d'argento del sig. N.T. Era una piccola graziosa locomotiva che trascinava due carrozze verdi in corsa su di un binario circolare di latta bianca. Ma quel giorno, tornando finalmente a casa, accompagnata dallo zio, che tristezza la ciminiera di quella grossa locomotiva che a mala pena sporgeva dalla melma! Sul binario ricostruito a titolo provvisorio il treno passava lento lento a qualche metro appena dal luogo dove il povero macchinista giaceva sepolto vivo al suo posto di lavoro... I passeggeri ai finestrini guardavano ammutoliti e tristi. Quando finalmente, giunti a Ponte-Brolla, e accomodati sulla Posta, correvano verso l'imbocco della Valle Onsernone, alla fanciulla parve di sognare... Se avesse potuto tradurre il palpito del suo piccolo cuore avrebbe esclamato: «Ti rivedo, o mia valle e m'illumino d'immenso». Torno a te, valle severa nei tuoi dirupi, valle di mio padre medico!... » SAGRE E STAGIONI All'ombra dei campanili, sui sagrati delle chiese, hanno vita tutte le sagre della nostra «sacra terra». È il campanile l'elemento principe di una sagra: sono le sue campane a dare il tono più spiccatamente festoso alla sagra, anche quando dall'alto della torretta campanaria è una sola campanella che irrequieta, ciarliera annuncia a perdifiato, già parecchi giorni prima, l'appressarsi della sagra annuale, la festa particolarmente cara a quel dato nostro villaggio. Dolci campanili nostri! Bisognerebbe non aver tra mano e sfogliare la bellissima terza edizione del volume di Piero Bianconi «I campanili del Ticino» per non sentirci «campanilisti» cento volte di più...È lui stesso il nostro scrittore che nella dotta presentazione alle molte nitidissime fotografie, ci parla dei nostri campanili in tono di amorosa filiale sapienza. «L'ombra dei campanili — egli dice — non è che un'esigua striscia sui tetti, ma sentimentalmente copre tutto il villaggio, tutta la città, perché il campanile è il segno di raccolta, è il perno del paesaggio, è una sigla di bellezza nell'emblema della Patria». E più avanti c'è nelle sue parole un fremito di commozione quando, ricordando la funesta valanga del 1951 ad Airolo, scrive: «il vecchio campanile che aveva già visto disastri e valanghe e frane e incendi, neppure quella notte aveva tremato, tanto che portava ancora il suo enorme elmo di neve! Dopo otto secoli era ancora in piedi, vivo, intatto e sempre giovane: però quella notte sembrava chiedesse ansioso alla sua gente smarrita: «Siete ancora vivi, ci siete tutti?...» Che cosa sarebbero mai i nostri paesi, se per un assurdo li immaginassimo senza campanili?... Scrigni senza gioielli, navi senza nocchiere!...È logico dunque che si rivolga al campanile il primo pensiero, discorrendo di sagre. Ma che cos'è una sagra? Quale la sua origine: come... quando... e perché nacque?... Domande che ci stuzzicano la curiosità, e alle quali vorremmo trovare una risposta. Perché una sagra non è cosa da poco: è un minuscolo compendio silenzioso di vita religiosa, sociale, artistica, a volte anche economica, che si inserisce dentro la cronistoria dei diversi nuclei di tutta la nostra gente. E perché — anche se presunzione può sembrare questo pio desiderio — non chiedere ai valenti nostri ricercatori di storia locale, quale dono pregevolissimo, uno studio storico sulle sagre della nostra Terra? Di due disparate e distanziate regioni del nostro Cantone, sono le sagre care al nostro cuore. Le une del Mendrisiotto, le altre dell'Onsernone. È chiaro che le stesse abbiano pochi punti in comune, pur avendo tutte quale solida base, una fede semplice, tradizionale, adorna di gaiezza e di orgoglio paesano. Nella dolcissima plaga mendrisiense, ondulata di piani e colli, si direbbe che i nostri avi avessero fatto un accordo per distribuire tanto magistralmente per date e luoghi, le nostre sagre. E noi sospinti da un vago senso di rimembranze, non possiamo far a meno di elencarle. In novembre alle porte del lungo periodo invernale, dà il via la fiera di San Martino nell'antichissima storica chiesa dell'omonimo piano. Seguita a brevissima distanza da quella della Madonna del Sassello a Obino, in vetta a un poggio, su su verso il calle che conduce al Generoso. In dicembre la sagra di santa Lucia, poco sopra al piano di Stabio di romana memoria. A gennaio inoltrato, quando l'Epifania ha fatto zittire gli echi delle Feste, ecco al centro della Campagnadorna, mettersi in giubilo Genestrerio per la sagra del vecchio Eremita sant'Antonio Abate. A chiudere lo stesso mese c'è il beato Manfredo Settala, attorno al quale è sempre vivo il fantasioso episodio delle sue sacre spoglie che, rivendicate da ben tre paesi, vengono portate di corsa da due giovenchi, dalla vetta del San Giorgio fin giù a Riva San Vitale, dolcemente lambita dal lago. Due le sagre di febbraio: sull'incantevole minuscolo colle di Tremona, stagliata contro il cielo di ponente, spicca la chiesuola della festa di sant'Agata, seguita a pochi giorni dalla sagra di Sant'Apollonia a Coldrerio, la cui antica chiesa già parrocchiale la si direbbe studiatamente appoggiata su di un leggero promontorio, residuo morenico del preistorico ghiacciaio. E finalmente, quando i cuori avvertono l'incipiente primavera, chiude la serie delle sagre la festa di San Giuseppe nella chiesa che adombra il cimitero di Ligornetto, nel bel mezzo della pingue campagna, coltivata oggi ancora con un buon impegno. Anche se apparentemente le nostre Sagre van perdendo quel loro antico fascino che ha per secoli attanagliato i cuori della nostra gente, pensiamo che tutto non andrà perduto. A testimoniare la fede, le tradizioni, i costumi di chi ci ha preceduto, resteranno pur sempre questi nostri Oratori o santuarietti: «Casucce del buon Dio» come sono dette dal nostro Giuseppe Zoppi! E perché dunque non ripescare dentro la memoria certi frammenti di episodi ascoltati dalla viva voce di chi oggi non è più, e narrati con il cuore ilare, tra un alone di fantasia e realtà?... E' un omaggio dovuto in particolare ad una indimenticabile «reggiura» dal fine intuito, dallo schietto attaccamento alle zolle feconde di questa nostra terra mendrisiense che le faceva dire ad ogni occasione, voluta o fortuita, proverbi, detti, distici e constatazioni rimate del nostro dialetto lombardo, così splendido quando è puro, così conciso, da gareggiare in sapienza con la più antica voce latina. Era gioia serena ascoltarla, anche quando, intenta ai suoi lavori d'ago, nei quali era tanto esperta, essa non si avvedeva della nostra ammirazione. La fiera di san Martino, diceva con naturalezza, quasi rievocandola, laggiù in quella piana sotto il magnifico Borgo, era anche il convegno voluto e segretamente atteso dai giovanotti e dalle forosette di tutto il Mendrisiotto: gli uni a gruppetti chiassosi, le altre in fila, ciarliere, braccio sotto braccio, girando e rigirando lo sguardo, con cuore allegro. E, aggiungeva, forse per stornare la nostra attenzione dai suoi più intimi ricordi, «dev'essere sempre stato così fin dai lontani tempi di Renzo e Lucia». "Lui" la «pustava» (la fissava, la sceglieva) e segretamente ne serbava la simpatia, così come da un mazzo di fiori se ne sceglie uno e non se ne scorda il profumo. "Lei", graziosa, nel suo costume dalla lunga gonna a pieghe fitte in autentica «strusa», con la raggiera di spilloni argentei fra le treccie dei capelli bruni, lasciava la fiera con un segreto dolce interrogativo in fondo al cuore. Ma il convegno doveva ripetersi alla susseguente fiera di santa Lucia. La santa patrona degli occhi, doveva condurre i giovani a «lustraa la vista» e far comprendere alla loro bella, a traverso le occhiate vive e accese, d'aver fissata...l'amorosa scelta! E i convegni si susseguivano ad ogni fiera, durante le quali dolcemente doveva maturare l'amore per le coppie fortunate. La vivace memoria della nostra «reggiura» andava infiorando il suo dire di quei detti o distici appropriati alle caratteristiche di ciascuna fiera, che — ahimè! — oggi più non sappiamo ripetere. All'ultima delle fiere — quella di san Giuseppe — quando tra l'erba ancor smunta dei prati occhieggiavano le primule dorate, aperte al più bel sorriso, e l'aria sapeva di primavera, le coppie, tra la folla gioconda e irrequieta del sagrato, timidamente raggianti, entravano in chiesa a chiedere al santo patrono degli sposi, la sua protezione nell'imminenza delle nozze! Sagre onsernonesi! Ci siete pure voi tra i nostri ricordi... Ci siete tutte risplendenti di sole vivido, caldo; guarnite di «porte trionfali» imbottite di rametti di pini e larici, avviluppate di rami d'edera, intramezzate di rododendri in fiore. Lì, sotto quelle improvvisate porte doveva passare la processione, ordinata nella sua semplicità, canora nello stupendo arcano salmodiare latino di inni, sequenze o litanie. Generalmente nelle valli, le sagre sono fissate durante i mesi estivi, dentro la luminosità montana della piena estate. Non perché c'entri qui la ragione del «turismo», no di certo! Esse nacquero quando il turismo, questo moderno despota bifronte, generatore di utili e di danni, non esisteva nemmeno «in mente Dei» se così ci è lecito dire. La ragione è tutt'altra; essa ha radici ambientali prima di tutto e poi umane, di una umanità spirituale, nata dall'istintivo bisogno di fratellanza. Le sagre valligiane, a differenza di quelle del piano, sono in massima parte celebrate nella chiesa parrocchiale dello stesso paese, ad onore e gloria di quel santo patrono. Elenchiamole. Nel mese di luglio a Vergeletto: sant'Anna. In agosto sono diverse e tutte solenni; a Russo, la Assunzione della Vergine, artisticamente figurata in una grande tela del nostro Mola; seguita all'indomani dalla sagra di san Rocco a Berzona, santo che del resto è venerato in moltissime chiese del nostro cantone, invocato a difesa dei contagi del corpo e dell'anima. Così le fervide invocazioni dei nostri avi. E sul finir d'agosto, San Bernardo a Mosogno, il fondatore della abbazia di Chiaravalle, dottore di santa romana Chiesa, per cui Dante in quella sua grande sinfonia poetica del 33.mo canto del Paradiso, mette sulla bocca del santo l'invocazione alla Vergine. A Comologno, in quella massiccia chiesa parrocchiale, chiude l'agosto la sagra della decollazione di san Giovanni, il grande Precursore, cui costò la testa l'intrepido «Tibi non licet» all'infedelissimo Erode. Chiude la serie festosa delle sagre estive Loco, con l'antichissima festività del santo Crocefisso, a metà settembre. In quella chiesa parrocchiale che il sacerdote don Buetti, nelle sue note storichc, definì una semibasilica, per diversi antichi e disparati pregi. La sua costruzione è di epoca assai lontana; già verso il XIII secolo si menzionava la parrocchiale di san Remigio a Loco, negli annali della Diocesi di Como. Tra le molte tele del coro se ne ammira una rappresentante san Remigio che battezza il re Clodoveo. Nella cappella dell'artistico Crocefisso, presso lo altare, si legge scolpita la seguente epigrafe: «anno 1314 in hoc signo vinces». Ma non vogliamo scordarci di un altro pregiato segno per dovizia di tradizione che fa tutt'uno con la sagra del santo Crocefisso a Loco. Durante la processione di quel pomeriggio festoso che, dall'ampio sagrato si muove verso la parte centrale del paese e procede lenta, ordinata, ricca di stendardi in broccati preziosi, tutti i fedeli, dal clero ai laici, dai ragazzetti alle fanciulle, diffondono nell'aria vespertina un canto d'intonazione purissima, dolce e sostenuto ad un tempo in una mistica e rara flessuosità di voci. E' l'antico inno del «Vexilla Regis» che oggi forse soltanto a Loco è cantato con l'autentica purezza della sua lontana origine. Le parole naturalmente sono latine, ma nessuno è preso dal desiderio di scoprire il significato delle stesse, perché l'animo è interamente conquistato da quella solenne e chiara melodia, quasi fosse un diretto e personale dialogare con Dio. Siamo andati alla ricerca di qualche precisazione sull'origine del Vexilla Regis, che pare sia stato composto nel 556 da san Venanzio, vescovo di Poitiers, quando poté avere nella sua città una reliquia della Santa Croce. Lo scrisse in ginocchio, a piè del Crocefisso. L'informazione però non aggiunge se fu lo stesso san Venanzio a rivestire con la melodia, le parole dell'inno. A questo punto ci punge il desiderio di fare una breve digressione. Fino a qualche anno fa nelle nostre chiese in circostanze diverse si cantavano inni e sequenze nelle loro splendide me lodie tradizionali, come «l'Adeste fidelis», l'invito degli Angeli nella notte di Natale; «l'Iste confessor» in onore dei santi non martiri, e quell'incomparabile «Stabat Mater» che fortunatamente si canta ancora a Mendrisio nella chiesa della Madonna Addolorata, durante il suo settenario. «Canta con noi la nostra Addolorata» andavano ripetendo commossi i Mendrisiensi, fino a qualche anno fa, parlando della bellissima statua lignea dei padri Serviti, dal viso dolce, affilato e pallido. Si comprende come possa esser nata nel cuore delle nostre bisnonne quella specie di affettuosa leggendaria espressione, la cui suggestione ci può oggi ancora tacitamente indurre a scorgere un leggerissimo tremito di labbra in quel viso addolorato; mentre la folla che gremisce la chiesa canta lo «Stabat Mater» tra il sonoro accompagnamento dell'antico organo e lo sfavillio di luci di cento candele che riempiono l'altare, ai piedi del simulacro. Giova forse ricordare che le parole dello «Stabat Mater» sono attribuite al poeta laudista Jacopone da Todi (12311306) dottore in legge, gaudente dapprima e poi frate francescano, il quale compose la celebre sequenza in circostanze drammatiche, dopo la morte della moglie, avvenuta per lo sprofondamento d'un palco durante una festa da ballo. Di Palestrina, Pergolesi, Rossini sono i diversi allestimenti musicali dello Stabat Mater. Ora ci si permetta d'aggiungere: l'odierno rinnovamento postconciliare ha operato e sta tuttora operando nella liturgia tante pregevoli riforme, allestite con somma sapienza e circostanziate necessità. Però noi ci chiediamo: tra alcuni decenni che ne sarà dell'immenso patrimonio plurisecolare di quella cultura latina e gregoriana che di tanto lustro impregnò la liturgia della Chiesa? È un interrogativo nostalgicamente triste, se pensiamo che i figli dei nostri figli nemmeno sapranno attingere in quello storico grandioso passato di cultura religiosa. Ci si rimprovera — lo sappiamo — che la nostra Fede oggi ha urgente bisogno di essere sfrondata da quel vecchio alone di sentimentalismi che hanno sempre pervaso la retta e razionale visione dei principi trascendentali! Ed è pure giusto! Però non dimentichiamo che ogni credente porta nel cuore la sua Fede; e la sola ragione umana — limitata nella sua essenza — non riuscirà mai a sfrondare a zero la grandezza incommensurabile del mistero!...Non obblighiamo il credente di media cultura a sentirsi deluso nel bel mezzo di una discussione razionale, intorno ad un principio di delicata natura teologica! Potrebbe succedere ciò che avveniva al bambino di alcuni anni fa, quando, distrutto il suo giocattolo nuovo per vedere com'era fatto, lo abbandonava poi subito a terra così sventrato, perché non vi aveva trovato nulla che appagasse le sue limitate nozioni! Ma lasciamo gli interrogativi e torniamo in Valle a rivivere un istante ancora la nostra lontana fanciullezza serena. Portiamoci proprio al centro della valle, a Russo, dove un pugnello di case sfolgoranti nel sole di mezzo agosto, in un tripudio di verde, vive frenetico l'attesa della sua sagra: l'Assunzione. E' la vigilia! l'alto campanile d'un bellissimo romanico classicheggiante che si eleva nel cielo quasi a gareggiare con la cima del Pizzo Ruscada che gli troneggia di fronte, riempie l'aria dei concenti argentini delle sue cinque campane che suonano, suonano... «d'allegria» motivi di canti religiosi e di canzonette popolari. Frattanto nell'ampio sagrato, sostenuto da una massicciata di muro a secco che lo sopraeleva dalla carrozzabile, ferve il lavoro fuori e dentro la chiesa. Tutti a dare una mano; con don Giuseppe c'è «ul Giuli sacrista» i chierichetti, le fanciulle, i ragazzi e alcune sposine, scesi tutti dai monti in preparazione festosa. C'è l'erba nel sagrato da strappare tra ciottolo e ciottolo, c'è da spazzare, lustrare spolverare pavimento, balaustre, banchi, confessionali. Prelevare dalla sacristia in pompa magna i busti d'argento dei quattro padri della Chiesa: sant'Ambrogio, sant'Agostino, san Crisostomo e san Basilio; due per l'Occidente e due per l'Oriente nei primi secoli della Chiesa; e troneggiarli, quei grossi quattro busti, sull'altar maggiore; ma quanto arcigni quei sembianti! Non godono certo la simpatia dei chierichetti e tanto meno dei fedeli che neppure sanno chi siano e perché si debbano mettere in mostra! C'è da stendere il gran tappeto sul pavimento del Coro; ci sono le grandi sedie imbottite da disporre ai lati dell'altare per i sacerdoti che celebrano la «Messa in terza» e per tutti gli altri parroci della Valle. Finalmente quando ogni cosa splende nell'ordine, ecco sulla porta d'entrata il sagrestano che aiuta il medico a portare in chiesa, dentro la cappella di sant'Antonio, il suo armonium e attorno farsi il gruppetto della corale d'occasione, per l'ultima prova dei canti che all'indomani condecoreranno la grande Messa e le lodi vespertine del pomeriggio. Poi, mentre il sole tende a scemare dietro le creste, s'ode un vocio pieno d'allegria nella piazza sottostante, dove è giunta la corsa postale: sale la scala del sagrato attorniato dai ragazzetti il predicatore, Padre Felicissimo, organista della Madonna del Sasso : notissima e cara figura di francescano che immancabilmente giunge in paese due volte l'anno: in agosto per la sagra e in gennaio per le Quarant'ore. Gli si fa incontro il medico, amico di lunga data, anche per via della musica, per cui l'uno è ammiratore dell'altro; e appena s'incontrano sono ambedue presi dalla loro passione musicale e conversano e discutono a non finire. Ma don Giuseppe, ritto davanti al suo confessionale, richiama padre Felicissimo al suo ministero. E la vigilia della sagra si chiude facendo risplendere di luce anche le anime dei fedeli. Ma la vigilia aveva anche un altro epilogo, un simpatico codicillo di un certo carattere intimo dentro le pareti di casa del medico di condotta. Un segmento di sentiero erboso, fiancheggiato da un vecchissimo muro che sosteneva l'orto di famiglia, separava la casa parrocchiale da quella del medico. Padre Felicissimo aveva imparato subito a percorrere quel sentiero; così che ogni qualvolta veniva in paese era d'obbligo per lui trascorrere il dopo cena tra quei familiari. E quella particolare sera, sbrigata in tutta fretta la cena, la madre dava gli ordini che ogni cosa fosse a posto e l'ambiente pronto ad accogliere i due cari ospiti: il parroco e il francescano. Come d'abitudine essa serviva il caffè e la torta, quella che piaceva a padre Felicissimo, senza uvette, fatta di soli tre elementi: uova, zucchero e farina; servita con panna montata, quella panna che soltanto in valle poteva trovarsi tanto fresca e aromatica. I conversari, va senza dirlo, erano improntati di allegrezza e sincera spigliatezza, secondo la caratteristica del frate: felicissimo sempre, di nome e di spirito. E lo era in particolare quando i due musicisti, davanti alla tastiera, infervorati sino all'inverosimile, sostenevano le classiche polemiche intorno alle fughe di Bach e gli oratori di Händel. Allora don Giuseppe, l'irreprensibile, non perdeva di vista l'orologio: ad un certo punto si alzava da sedere e rivolto al frate gli diceva in tono risoluto: «ricordati che domani mattina l'Ave Maria suona prima dell'alba, e noi dobbiamo essere già in chiesa, per quelle pecorelle che non amano la luce piena!... Pronto Padre Felicissimo, rivolto ai familiari strizzando l'occhio verso don Giuseppe, con fare semiserio e canzonatorio esclamava: «non vi pare figlioli che... quello lì... sia sempre il mio censore ?...». La risata generale e gustosa, preparava i convenevoli del commiato. Era il tardo pomeriggio della terza domenica di settembre: quella dolcissima ora «tra lusco e brusco» per dirla con Pascoli, che sembra sospesa in un incontro di pace tra il dì e la sera. Lungo il nastro serpeggiante della carrozzabile che striscia dentro le svolte della bassa Valle c'era un brulichìo di persone; gruppetti a piedi, alcuni in bicicletta, altri pigiati su le panchine di qualche «char-à-bancs» che sfrecciava traballando, altri che si avviavano alla fermata della corsa postale. Tornavan tutti dalla sagra del Santo Crocifisso di Loco. Anche la nidiata al completo dei figlioli del medico rientrava in casa, accolta dal sorriso della madre. Mutati d'abito e di scarpe in attesa della cena, ognuno assaporava quella dolce distensione che sempre le pareti domestiche sanno elargire al rientro d'una passeggiata, la sera del dì di festa. L'ultimo della mezza dozzina, un bimbetto sui tre anni, vivacissimo sempre, dall'aria decisamente indipendente, quella sera se ne stava quieto in disparte, forse vinto dalla stanchezza. Ad un tratto si avvicina al pianoforte, dà un giro vigoroso alla vite dello sgabello rotondo per sedervici comodo all'altezza della tastiera. Era un suo gesto abituale e nessuno vi faceva caso. Mentre destavano curiosità nei familiari certe sue naturali movenze quando giocava sui tasti, che inconsciamente rispecchiavano quelle di suo padre. E strimpellava la povera tastiera, però sempre per una ragione: per esempio quando i fratelli non lo volevano nei loro giochi, o nei loro lavori di costruzioni; o quando la madre lo obbligava a mangiar la minestra. Allora di scatto sedeva al piano e strimpellando si prendeva le sue rivincite. Altre volte compariva tenendo fra le mani un catalogo di un certo notissimo emporio che puntualmente giungeva da Zurigo due volte l'anno. Lo sfogliava alla ricerca della pagina dei giovanotti nei loro abiti alla moda, appoggiava il catalogo aperto sul leggio e con un'aria giuliva batteva le piccole dita affusolate sui tasti, con agilità e compostezza, senza però ricavarne nessun accordo sensato. «Cosa suoni?» gli chiedevano già maliziosamente consapevoli della risposta. Ed egli pronto rispondeva: «suono il Lilin che mi dà le caramelle». Era costui il fidanzato della sorella maggiore che regolarmente si trovava all'appuntamento sulla strada ombreggiata dai castagni, poco sotto il paese. All'incontro il giovanotto si faceva un dovere di riempire di caramelle le tasche del grembiulino di quel simpatico bimbetto. Chi poteva comprendere che cosa passasse poi nella mente del piccolo goloso quando, seduto al piano, si illudeva di tradurre in suono la gioia di quel dono? ... Forse il ritmo che faceva il fruscio della carta che avvolgeva i dolciumi, o chi sa... il mormorio delle parole che si scambiavano i due innamorati!... Ma quella sera, rientrato dalla gita alla sagra di Loco e sedutosi quieto al piano, ben altri dovevano essere i suoi pensieri! Posando leggermente sui tasti la manina destra, a pause ne ritraeva alcuni suoni legati. Il padre che leggeva seduto al tavolo, si accorse di quelle inusitate lente movenze, quasi studiate, del figlioletto, e lo tenne d'occhio. Intanto le note si susseguivano in un accenno distinto dell'inizio di una spiccata melodia religiosa. Dalla cucina si affacciarono a vedere chi suonava, la madre e la sorella maggiore: quest'ultima tentò a mezza voce di canticchiarne il motivo. Ma subito il padre intervenne con il deciso cenno della mano a farla smettere, e a imporre silenzio anche ai fratelli. Il piccolino, attentissimo e fisso alla tastiera, aveva ultimato l'espressione melodica e riprendeva da capo, tentando con la manina sinistra alcune note di accompagnamento. Nel silenzio del locale parve d'un tratto diffondersi precisa e dolcissima l'eco del «Vexilla Regis»: qualche ora prima la processione della sagra aveva riempito l'aria vespertina di quel bellissimo canto. Poi d'improvviso il piccolo pianista avvertì lo strano silenzio dietro le sue minuscole spalle: di scatto si volse, intuì la scenetta e d'impulso scivolò dallo sgabello e si rannicchiò sotto il tavolo, seminascosto dalla grossa frangia del vecchio tappeto. Perché mai quel gesto?... Forse stupito di se stesso, avvertì in quel preciso momento la vaga sensazione d'aver aperto una breccia alla sua sensibilità musicale, e forse senza comprendere le parole dell'inno, intravide quell'arcano «Vessillo» splendere nel sole!..... NON TI SCORDAR DI LORO Sollecitati da un compito di rimembranza e di gratitudine, vogliamo rivolgere il pensiero ai nostri medici di condotta del passato, i quali hanno indistintamente in comune, il tacito appellativo di oscuri e dimenticati apostoli di una dura quanto alta missione di fratellanza umana. Di Ippocrate, il celebre medico dell'antica Grecia, che tramandò ai posteri i suoi trattati di coscienza, onestà e scienza, a profitto dei malati, restò popolare uno dei suoi aforismi che si traduce a un dipresso così: «La vita è breve, l'arte del medico è lunga e difficile». E, forse da questo pensiero, a traverso le generazioni, è scaturito il vecchio detto che si andava allora ripetendo tra il popolo: «Non c'è arte più misera, arte più rotta, di quella del medico di condotta!» Verità che del resto non ha mai impensierito, né resi titubanti i giovani studenti di medicina di allora, tenacemente legati ai lunghi studi, agli inevitabili sacrifici per conseguire l'ideale di dedicare tutto di se stessi al sollievo dell'umanità sofferente. E non c'è valle o angolo di terra ticinese, anche tra i più impervi o selvaggi, che non siano stati muti testimoni di episodi piccoli o meno piccoli, della diuturna costante dedizione alle personali responsabilità dei nostri medici di condotta. Cos'era allora un medico per la nostra povera gente? Un professionista, sì, ma sotto le vesti di un medico, un consigliere e anche un confessore. Non che il medico ostentasse queste sue prerogative; al contrario: conscio di non poter contare su adeguate pretese finanziarie, all'infuori dello strettissimo necessario, provava la soddisfazione morale in quell'evangelica povertà che fa sentire ricco chi non ha niente... Perciò, senza scostarci dal vero, possiamo asserire che il medico di condotta era allora il servitore della collettività, nel senso più nobile della parola. E la sua esperienza andava via via affinandogli le intuizioni, per cui non di rado il medico di condotta aveva percezioni che si sarebbero dette precorritrici, o del sesto senso. Era perciò logico il sorgere di certe incomprensioni da parte di coloro che, in nome delle loro competenze civili e politiche, non si peritavano di giudicare arbitrariamente l'agire del professionista. Qualche spunto a mo' d'esempio. Il medico di condotta sempre scrupolosamente vigile sulla salute generale dei suoi conterranei, vedeva di malocchio che si obbligassero le adolescenti a portare sulle spalle gerle e simili, con pesi sproporzionati alla loro resistenza fisica. In particolare nelle Valli, dove la quasi totalità del lavoro agricolo veniva sbrigato dalle donne, era cosa comunissima incontrare sui sentieri, spesso ripidi e malagevoli, queste belle figliole nell'incipiente rigoglio della loro giovinezza, sottoposte a fatiche direttamente cagionevoli al normale sviluppo del loro delicato e complesso apparato genitale. Ma a nulla valevano le esortazioni e le parole di convincimento in proposito! La necessità di mutare una tradizione atavica, non poteva essere compresa che in qualche sporadico caso. Allora il medico di condotta che era pure medico scolastico, durante le sue visite nelle classi maggiori coglieva l'occasione per impartire qualche precisa nozione sulla fisiologia sessuale della donna e inculcare il suo punto di vista. Forse dalle stesse allieve si sarebbe gradatamente potuto trovare una pur incerta collaborazione in merito; anche se sulle prime esse provavano qualche confusione alle parole del medico e pudicamente, mentre lui parlava, nascondevano il viso dietro la ribalta del banco... Si sa che i tempi erano ben lungi dall'essere maturi per combattere a viso aperto certi pesanti pregiudizi o tabù, come sono chiamati oggidì. Però qualcosa si sarebbe ottenuto già allora, se tra la delegazione scolastica, da chi dicevasi esperto in merito, per aver girato il mondo in qualità di gessatore, non si fosse gridato allo scandalo!... Altro problema non indifferente della situazione sociale di allora: quasi tutte le parrocchie anche dei piccoli paesi ticinesi, avevano lo fortuna di possedere il proprio parroco, interamente votato con spirito di sacrificio alla sua missione dì apostolo. Ma la situazione finanziaria del parroco era quasi sempre precaria e negletta; la casa parrocchiale troppo vasta e troppo vecchia, priva di ogni comodità, e soprattutto troppo fredda per i lunghi mesi invernali, resi spesso ancor più lunghi e tristi dalla vita solitaria del povero sacerdote di valle. Di queste specifiche cose si impensieriva il medico che non poteva conciliare l'olocausto a Dio nel ministero sacerdotale, a scapito della salute fisica e psichica. *** Intanto correvano i primi decenni del novecento; ovunque nel mondo si avvertivano i sintomi di un'embrionale evoluzione che doveva più tardi sfociare nella tecnica, nelle scienze, nelle industrie. Ma nei grandi stati europei malauguratamente covava silenziosa la brace della prima guerra mondiale. Nel già povero Ticino nostro, fallivano diverse banche, e nelle Valli aumentava l'emigrazione oltre Oceano. E quando ai confini della Patria si udì il fragore della guerra, dai nostri dolci campanili si sparse lugubre la campana a martello per la mobilitazione generale, seguita a breve distanza dal tesseramento e dall'epidemia grippale violenta e paurosa. Un trio che nella storia non si smentisce mai: «... a peste, fame et bello ... ». La vita dei nostri medici di condotta era diventata estenuante, inconcepibile; ma essi compatti ridiedero forza alla loro parola d'ordine : vivificare le energie, raddoppiare i sacrifici, dilatare la generosità del cuore, fino all'oblio di se stessi, per essere ininterrottamente, ad ogni ora del giorno e della notte, fratelli ai fratelli sofferenti. Nel frattempo — come avviene dopo immani vicende belliche — in parecchi stati europei è sentito, per profonde ragioni umanitarie, il bisogno di promuovere importanti iniziative, atte a migliorare le condizioni sociali. Anche dentro i nostri confini nasce così una specie di effervescenza che scuote la volontà e la tenacia di alcuni precursori, ricchi di genio e di cuore. Vogliamo alludere alla creazione delle «Casse malati», diventate però soltanto molti anni più tardi, dopo duri tentativi, vivaci e lunghe discussioni tra polemiche talora acerbe, quel grandioso movimento di solidarietà di cui oggi godiamo i benefici. (Così abbiamo desunto dal pregiato Numero unico «50 anni di vita della Federazione ticinese Casse Malati» 1921-1971). Ma l'attuazione di dette Casse non poté in un primo tempo essere effettuata nei centri cittadini, dove esistevano e funzionavano da lunga data diverse società private di mutuo soccorso, anche se logicamente carenti di una certa fisionomia democratica e di mezzi finanziari. Perciò in via totalmente sperimentale si fanno i primi incerti tentativi per il funzionamento delle casse malati nelle valli, dove vengono rimaneggiate le vecchie condotte mediche. I primi a subire l'urto della grezza riforma sono logicamente i medici, i quali di colpo perdono la loro autonomia, la libertà di prescrizione dei farmaci, e devono adeguarsi ad una certa esigenza burocratica, per cui la mentalità del medico di allora, votato per altruismo al solo interesse dei malati, stenta sulle prime ad adattarsi a quella nuova burocratica forma sociale, che tra l'altro poneva sotto questione il delicato segreto professionale, tanto strenuamente sostenuto e da secoli difeso dalla medicina legale. In quel medesimo periodo postbellico anche la chimica camminava di pari passo con il progresso scientifico e quale prima logica conseguenza, la farmaceutica metteva in luce le sue scoperte di prodotti medicinali e terapeutici che avevano — a quei tempi — qualcosa di mirabolante. Dalle grandi case farmaceutiche della vicina Milano ci vennero — per citarne uno — i famosi fermenti lattici della Bulgaria, offerti in graziose fialette, dentro in altrettante attraenti scatolette, e che i medici accolsero subito come meravigliosi toccasana del fegato e dell'apparato intestinale, contro i tenaci postumi grippali. E noteremo per inciso che i suddetti fermenti lattici si trasformeranno in pratica nei consumatissimi «Joghurt» entrati in commercio con la denominazione di «elisir di lunga vita». E non dimenticheremo le nostre grandi Case svizzere, che consigliavano i medici, con una larghezza senza pari di campioni pubblicitari, a far largo uso dei loro nuovissimi e studiatissimi prodotti; limitiamoci a citare i farmaci a base di salicilati e di zolfo, dai quali ci vennero in seguito gli straordinari odierni miracolosi «sulfamidici». Erano tutti una gamma di moderni prodotti che i medici andavano via via sperimentando con piena soddisfazione e con intimo grato orgoglio verso la scienza. Ma con la creazione delle Casse Malati — limitatissime nelle loro disponibilità finanziarie, ai medici di condotta venne imposta una ristretta farmacopea ufficiale, dalla quale erano esclusi gran parte dei nuovi prodotti. Le difficoltà vertevano sullo stesso piano, ma con chiare finalità opposte : i medici miravano unicamente a una terapia aggiornata e totale in favore degli ammalati; i gerenti delle Casse invece avevano l'occhio vigile unicamente ed intransigentemente al loro bilancio finanziario ! Né si poteva pretendere che comprendessero i progressi della scienza medica !... Perciò la situazione morale della vertenza imponeva spesso ai medici delle incresciose rinunce, per cui si vedevano costretti a riprendere il vecchio sistema delle prescrizioni sui loro lunghi foglietti delle ricette con in testa l'immancabile «Recipe». «Lungo studio e grande amore» esigeva da sempre dal medico di condotta la compilazione delle ricette, per gli svariatissimi elementi in dosi e forme determinate e che dovevano avere specifiche virtù terapeutiche nei riguardi di ciascun paziente a cui erano destinate. Si trattava di decotti, di linimenti antinevralgici o febbrifughi, depurativi o diuretici, digestivi o emetici, tonici o analgesici, per cui ogni ricetta era infiorata di una graziosa dicitura, come ad esempio : la belladonna, la passiflora, la poligala, la segale cornuta, la noce vomica, il viscum album, l'allium sativum, il thymus serpillum, la veronica officinalis, l'alcacyl, l'ipecacuana, lo strofanto, il laudano, lo sciroppo talù e via di questo passo! Tutti nomi che suscitavano divertimento ed ilarità repressa ai figli del medico, i quali forzatamente silenziosi, se li dovevano sorbire, mentre lui, attentissimo e severo, trasmetteva per telefono alla farmacia la lunga ricetta. Tenui ricordi... che spontanei affiorano in dolcissima tirannide dentro l'evanescenza di un commosso turbamento !... Si è così voluto soffermarci con qualche cenno su «croci e delizie» dei nostri medici di condotta, per i quali molto spesso le preoccupazioni professionali superavano i riconoscimenti, a conferma del già citato antico famoso distico dell'arte misera e rotta del povero medico di condotta. Oggi che la tecnica dell'automazione ha raggiunto limiti di una potenza e di una precisione da stupire lo stesso inventore fino a renderlo incredulo, può nascere l'assurda paura per un domani, in cui la fraterna assistenza del dottore verrebbe sostituita dal gelido ticchettio di un cervello elettronico. Ma no ! Una simile impostazione resterà sempre, per fortuna nostra, falsa e inattuabile. Anche se oggi moltissimi congegni elettronici servono meravigliosamente al medico e al chirurgo per diagnosticare con precisione i mali dei pazienti, nulla potrà mai, anche in un avvenire lontano, sostituire le mani del medico. Una volta, e non sono che pochi decenni, i nostri medici di condotta, si servivano semplicemente dello stetoscopio; però, più che all'efficacia di quel piccolo delicato istrumento, essi si affidavano alla sensibilità delle loro mani. Chi, tra i meno giovani, non ricorda d'aver visto il medico auscultare i polmoni d'un paziente, tamburellando, in un curioso magico gioco, gli indici sovrapposti delle due mani in una ritmata, scrupolosa esplorazione ? E lo stesso ticchettio veniva ripetuto sul fegato, sulla milza, sull'addome. Le mani d'un medico! Perché non ci chiediamo cosa furono sempre, e cosa ancora sono oggidì ? A volte, non senza una strana muta commozione, mi succede di ripensare alle mani di mio padre; mani cariche d'una mirabile forza nervosa, mani vive sotto la cui epidermide rosea s'intravedeva un leggero fittissimo tessuto di vasi capillari, come fossero animati da una segreta attività espressiva. Egli aveva quasi un culto per le sue mani, perché, diceva, l'epidermide è un organo che possiede delle impensate arcane doti di sensibilità. Quante volte si spazientiva con noi, perché, secondo lui, le nostre mani non erano mai pulite e tanto meno mai asciugate a dovere. L'umidità dell'epidermide, insisteva, è la prima e più facile cultura di microbi. E se da un lato, per evitare prediche, noi monelli ci presentavamo a lui, nascondendo prudentemente le mani, d'altra parte ci prendeva spesso la curiosità di mirare da vicino quel suo strano ticchettio di dita; perciò gli si diceva : «papà, le nostre bambole sono malate; ascoltale se hanno la polmonite !» E lui sorridente e compiaciuto, tamburellava... ascoltava un torso di pezza imbottito di cruschello... Ma l'argomento «mani» non poteva esaurirsi lì: entrava spessissimo nella sua aneddotica, nei ricordi della sua vita di studente. E certi accenni che solo in parte ferivano la nostra fantasia, con il trascorrere degli anni hanno acquistato, chi sa come, un valore di nostalgica attualità. Per esempio la tipica frase che amava spesso ripeterci : «impariamo a conoscere Dio, anche sull'unghia del nostro dito mignolo»... Chi sa mai in quale contesto di ragionamento lui, nostro padre, ci parlava così?... forse, se ben ricordo, accusando lui stesso una certa filosofia panteistica dei suoi anni universitari. Ma la frase gli era cara perché apparteneva ad uno dei suoi maestri più celebri, il professor Murri, il cui nome ci era tanto familiare anche perché faceva spicco su di un grosso volume sempre a sua portata di mano, tutto postillato ai margini. Pure di un altro suo chiarissimo maestro (il cui nome è andato perduto) amava riandare con grande piacere i particolari di uno strano episodio. Strano e tanto soffuso di mistero, per noi ignari dell'argomento! Era del suo professore di anatomia, filosofo e profondamente credente, malgrado la tendenza di positivismo che imperava allora negli atenei italiani. Prima di dar inizio alla lezione, in quella vasta e squallida sala anatomica, egli esigeva che gli studenti, ritti attorno al tavolo anatomico alla presenza del cadavere, ascoltassero la sua dissertazione, sapientemente inspirata da un soffio di spiritualità, sulla meravigliosa creazione del corpo umano, e in particolare sulla gravità e l'importanza scientifica del lavoro anatomico che le loro mani erano in procinto di compiere. Mani ferme, esploratrici, consapevoli della materia che scrupolosamente dovevano anatomizzare, dissezionare in minutissime parti da mettere con circospezione sotto i vetrini del microscopio. E l'opera si compiva solenne, silenziosa, sorvegliata dalla guida sapiente del maestro; quando d'improvviso (e capitava non di rado) uno degli studenti più non reggeva e sveniva... Allora il maestro, sconsolato, deluso, alzava gli occhi al soffitto ed esclamava: «cupio dissolvi et esse cum Christo». Al che gli studenti in segno di logica contestazione, si facevano attorno al poverino brontolando: «lasciamolo con il suo san Paolo, lui che non sa capire che noi non siamo al par di lui, con i sensi... in Paradiso!». Ricordi o fatti di ieri — si dirà: oggi l'evoluzione vertiginosa del progresso ha rivoluzionato il sistema della ricerca scientifica, anche sul piano medico. Però non scostiamoci dalla realtà di ogni giorno, di ogni minuto, ovunque c'è un individuo da operare e un chirurgo che s'accinge a salvarlo. Soltanto alle mani del chirurgo che non tremano, che hanno la precisa fermezza di movimenti razionalmente sapienti, sono affidati i feriti irriconoscibili, squartati dagli infortuni stradali, dalle abrasioni in seguito alle disgrazie aviatorie, dalle mutilazioni per l'esecrata violenza criminale d'oggidì. Si va dicendo — e con ragionato stupore — che viviamo l'era della cardiochirurgia, delle trapanazioni del cranio, dei trapianti degli organi e anche della loro sostituzione, delle operazioni strepitose di tumori e cancri, in qualunque parte delicata del nostro organismo: tra le viscere di ogni apparato, nelle ghiandole e nelle masse cerebrali. A chi il merito di tanta responsabilità? Alle mani del medico chirurgo: dall'anestesista in un primo tempo, che dosa gli agenti anestetici per la narcosi; del cardiologo che ti introduce le dita nelle valvole del tuo cuore; dell'osteologo che ti mette un perno nel femore spezzato, o ti sostituisce l'anca con un pezzo di plastica; dell' oculista che ti ridona la luce degli occhi, frugando anche tra le delicatissime membrane della retina; del pediatra a cui basta un tocco delle sue dita sul corpicino del bimbo per scoprire la causa del suo dolore; e infine dell ostetrico che promuove il primo vagito a quella creatura che si rifiuta di venire alla luce... Mani di medico: mani di taumaturgo: ieri come oggi, come sempre! A questo punto un'istintiva, segreta invocazione sale silenziosa dal cuore alle labbra: — Signore: i nostri medici sono strumenti nelle Tue mani. Tu hai dato loro l'intelligenza, la costanza nella ricerca scientifica, la vocazione nell'assolvere il loro nobile compito, ovunque nel mondo; tra gli uomini vicini e lontani, nelle baracche delle grandi metropoli, sui monti dispersi, nei paesi sottosviluppati, tuttora in preda a secolari pregiudizi, tra ostinate malattie endemiche, tra gli innocenti che muoiono di fame e di sete! Illumina, Signore, il loro genio, sostieni le loro iniziative, reggi l'abilità delle loro mani, perché, debellate un giorno sulla terra le sofferenze della carne e della psiche, possa il tuo Popolo, o Signore, non importa di che credo e di qual colore della pelle, servirti unito nella pace, in piena disponibilità fisica e spirituale, per raggiungerti al di là del mistero, nella luce perenne, o Dio di Amore!... APPENDICE Abbiamo sentito il bisogno di offrire all'affettuoso ricordo di chi legge questi racconti i nomi dei medici che hanno condiviso con il Nostro le fatiche e le soddisfazioni di una condotta di valle. Forse l'elenco è incompleto: lo abbiamo ottenuto consultando annuari e guide degli anni che vanno dal 1900 al 1930. Abbiamo preso in considerazione soltanto quelle regioni del Ticino che obbligavano il medico condotto ad un certo tipo di vita, determinato dalla natura per un verso (l'inverno di montagna e tutte le difficoltà di comunicazione) e dal costume della gente dall'altro (agricoltura montana e pastorizia con alpeggio estivo). Nelle valli del bacino della Maggia Nel 1907 c'è stata una nuova ripartizione dei circondari medici: per quel che riguarda le valli del bacino della Maggia essi si sono ridotti a cinque da otto che erano (tre in valle Maggia, uno per le Centovalli e il Pedemonte, uno per la valle Onsernone). In quelle regioni erano attive tre levatrici: una in valle Onsernone, la Margherita Sansuvini di Russo, una a Intragna e una sola per tutta la valle Maggia. Ecco i nomi dei medici che abbiamo trovato, alcuni dei quali hanno badato per più anni a due e anche a tre circondari. Dr. Pietro Risi, Intragna Dr. Giuseppe Terribilini, Russo Dr. Giacomo Mazzi, Intragna Dr. Costantino Semini, Russo Dr. Vittorio Spigaglia, Russo Dr. Michele Zanini, Maggia Dr. Pietro Gugliemoni, Cevio Dr. Valente Bernasconi, Cevio Dr. Carlo Terribilini, Cevio Dr. Pietro Respini, Intragna Dr. Corrado Zenna, Russo In val Verzasca La condotta della valle Verzasca restava periodicamente vacante. Dr. Massimino Fonti, Gordola Dr. Valente Bernasconi, Gordola Dr. Pio Cortella, Gordola Dr. Carlo Terribilini, Gordola Nel Gambarogno Dr. Pietro Galletti, Vira Dr. Davide Alesina, Vira Dr. Ausonio Bertoni, Vira Dr. Simeone Wademisow, Vira Dr. Giovanni Varesi, Gerra Dr. Vittorio Montemartini, Gerra Dr. Gaet. Bruno, Gerra Dr. Ottavio Pagani, Gerra In valle di Blenio Nel 1907 i circondari medici sono passati da tre a quattro ma quasi mai si a-vevano quattro medici condotti contemporaneamente in valle. Dr. Pasquale Biotti Malvaglia e poi Ludiano Dr. Simeone Wademisow, Malvaglia Dr. Domenico Fumosoli, Comprovasco Dr. Ferdinando Braga, Olivone Dr. Secondo Ramonetti, Olivone Dr. Remo Panzera, Olivone In Leventina I circondari medici erano cinque, c'erano però anche, segnatamente a Faido, dei medici liberi professionisti e numerose levatrici. La Leventina era divisa in circondari trasversali. E' interessante oggi notare per esempio che Sobrio era unito al circondario di Giornico mentre Anzonico e Cavagnago erano uniti a Lavorgo e Chironico. Dalpe stava con Faido e Prato con Quinto. Dr. Antonio Corecco, Bodio Dr. Attilio Maffi, Quinto Dr. Gabriele Maggini, Faido Dr. Erncsto Lucchini, Lavorgo Dr. Fabrizio Maffi, Quinto Dr. Felice Pagnamenta, Giornico Dr. Mario Peretti, Airolo Dr. Giovanni Gobetto, Ambrì Dr. Angelo Sciolli, Lavorgo Dr. Felice Pozzi, Ambrì Dr. Beniamino Borrani, Faido Dr. Guido Kauffmann, Airolo Nelle valli del Luganese Dr. Angelo Catenazzi, Agno Dr. Alessandro Rossi, Magliaso Dr. Alessandro Torriani, Agno e Maglio di Colla Dr. Angelo Sciolli, Pura e Breno Dr. Luigi Viola Boros, Ponte Tresa Dr. Achille Zanini, Curio Dr. Alessandro Casella, Tesserete Dr. Ulisse Fiori, Bironico Dr. Luigi Maggioni, Colla Dr. Mario Antonini, Rivera e Tesserete Dr. Giuseppe Schwyter, Maglio di Colla Dr. Giuseppe Gorneiski, Bironico Dr. Francesco De Matteis, Madonna del Piano,Breno e AgnoDr. Numa Masina. Curio Dr. Giacomo Gamba, Maglio di Colla Dr. Roberto Farner, Madonna del Piano Dr. Costantino Semini, Maglio di Dr. Domenico Nurisio, Madonna Colla del Piano Dr. Luigi Riva, Maglio di Colla Dr. Francesco Riva, Arogno Dr. Romeo Noseda. Tesserete Dr. Vittorio Massa, Arogno Nel Mendrisiotto (valle di Muggio e Montagna del Sangiorgio). Dr. Felice Prada, Castel San Pietro Dr. A. Cereghetti, Muggio Dr. Evaristo Camponovo, Arzo Dr. Gay des Combes, Cabbio Dr. Pietro Rusconi, Arzo
Scarica