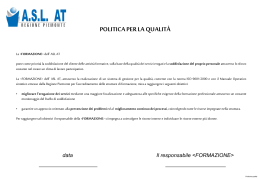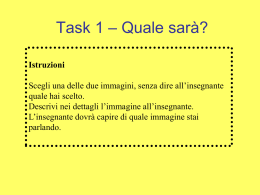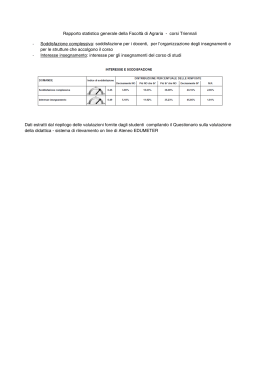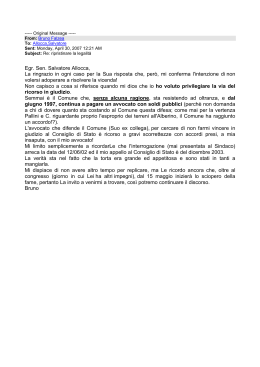M. A. Aliverti A. Cavelli R. Colombo G. B. Contri G. Contri M. D. Contri V. Ferrarini M. G. Monopoli M. G. Pediconi A cura di Angela Postiglione IL PENSIERO DEL FIGLIO :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: e-book Il pensiero del figlio INDICE Prefazione di Angela Postiglione 44 Introduzione. Intervista a Giacomo B. Contri di Angela Postiglione 5 Chi è genitore. Generare non è procreare di Giacomo B. Contri 12 Soggetti o sottomessi di Maria D. Contri 19 Puer oeconomicus di Maria D. Contri 25 Puer politicus di Maria Gabriella Pediconi 29 Après moi le déluge di Raffaella Colombo 36 Ambizione, eredità, ricchezza di Vera Ferrarini 45 Il posto dell’adulto di Maria Antonietta Aliverti 52 Genitore. Una professione?C’era una volta il bambino di Maria Antonietta Aliverti 54 Potere e volere di Angela Cavelli 57 Inchieste alla Maigret di Maria Grazia Monopoli 63 Appendice Proposta di incontri di presentazione a docenti studenti e genitori della figura dell’Avvocato della Salute come difensore di soggetti in difficoltà di Giulia Contri 67 2 Il pensiero del figlio L’Avvocato della Salute: l’altra faccia dello Psicoanalista a cura di Giulia Contri 70 3 Il pensiero del figlio Prefazione [*] Il pensiero del figlio raccoglie le relazioni tenute da docenti di Studium Cartello in occasione di una serie di incontri avvenuti presso l’associazione culturale di Trento “A. Rosmini”, tra il dicembre 2003 e il marzo 2004. I testi pubblicati sono dunque trascrizioni di un parlato, e di un parlato in un contesto di dialogo con un pubblico composto da genitori, insegnanti, o da persone semplicemente interessate al tema. L’idea di questi incontri era nata in me a partire da questioni che scaturivano dalla mia esperienza personale e quotidiana di madre e di insegnante, ma prima ancora di moglie, e dall’aver osservato quanto grande e diffuso sia il disagio dell’adulto nelle sue relazioni anzitutto con il partner, e, poi, con i figli e, nel caso dell’insegnante, con gli alunni. Piuttosto che mettere l’accento sul cosiddetto “disagio giovanile”, mi sembrava dunque più utile pormi la questione di come acquisire io una mia competenza, un mio giudizio, un mio saperci fare, nelle mie relazioni. Il malessere dei figli, o degli alunni, mi sembrava che dovesse anzitutto fornire lo spunto per meditare sugli errori e sul disorientamento degli adulti. Una particolare fonte di disagio sono le difficoltà scolastiche dei figli, o degli alunni, quando si ha a che fare con ragazzi, ma anche con bambini, che non si sanno orientare, che diventano o ribelli o insicuri e fragili, facilmente scoraggiabili, distratti, disinteressati nei confronti della scuola, incapaci comunque di investimento proficuo nel lavoro scolastico. I dati sulle percentuali dei fallimenti e degli abbandoni scolastici sono, del resto, sempre più allarmanti. Molti adulti, di fronte a queste difficoltà, si dichiarano incompetenti, disorientati e impotenti, non meno e non diversamente dai figli. Da dove ricominciare per fondare una competenza, una capacità di orientamento e di giudizio, che rendano capaci di una iniziativa che dia frutti? Mi sono rivolta, per trovare risposte alla mia questione, all’Associazione milanese Studium Cartello1, che mi ha interessato per la sua dichiarata ambizione di essere, anche se per ora solo, Una idea di Università, di una Università della competenza individuale, acquisibile da chi vi entri non per essere “formato” dall’alto, ma per con-laborare. Dello Studium Cartello mi ha interessato anche l’idea dell’Avvocato della salute, ossia di una nuova figura professionale, che può intervenire a “difendere”, su richiesta sua o dei suoi tutori se minore, un individuo che si trovi in difficoltà con il suo contesto di vita, sentendosi incompetente a farvi fronte. Ci sono casi in cui la diagnosi di psicopatologia e l’indicazione di una “cura” non sono in prima istanza le più adeguate: l’azione per linee per così dire ”esterne” alla cura, ma sempre a favore di un individuo, e sugli scenari più diversi (giudiziario, psichiatrico, scolastico, familiare, lavorativo), risulta più adatta. Per questo, in Appendice, vengono riportati alcuni documenti illustranti la nuova professione. Angela Postiglione [*] vedi in fondo il calendario degli incontri Lo Studium Cartello è un’Associazione costituitasi a Milano fin dal 1973 nel suo nucleo centrale Il Lavoro psicoanalitico. Tale Associazione si è successivamente, nel 1994, articolata come Cartello, di altre due entità Enciclopedia e Scuola pratica di psicopatologia. La parola Studium si rifà allo Studium bolognese del XII secolo, per il primato che in esso era dato allo studio del diritto. 1 4 Il pensiero del figlio Introduzione Intervista a Giacomo B. Contri di Angela Postiglione 2 Mi è sembrato che la migliore Introduzione a Il pensiero del figlio fosse un commento di Giacomo B. Contri ai luoghi comuni che colonizzano i discorsi sulle relazioni tra genitori e figli o tra insegnanti e allievi. Gli ho quindi chiesto di commentarne alcuni dei più comuni che gli ho sottoposto nel corso di un’intervista. La teoria dominante connette l’educazione dei figli con l’idea di “ruolo” di genitore e successivamente di educatore. Non ha senso parlare di educazione del neonato: non ci vede, non ci sente, non è affatto educabile. Il neonato, quando va bene, può solo venire trattato bene, riscaldato, perché appena nasce ha freddo, lavato in acqua tiepida, allattato, salvo che si addormenti istantaneamente. Quando viene preso tra le braccia, importa la delicatezza. Se gli si parla, non importa il significato delle parole, che sono fuori dalla sua portata, ma la qualità dei suoni emessi. Questi sono esempi di come il bambino può compiere la sua prima esperienza di soddisfazione. E’ciò che chiamo trattar bene un neonato. Per il bambino si comincia bene se si comincia dalla sua soddisfazione, così elementare, ma anche così soggetta a sottigliezze. Sottolineo specialmente il tono e il volume della voce, delicata o gracchiante, con cui gli si parla. So che è stata messa in dubbio l’idea di una prima esperienza di soddisfazione nel bambino, ma è un dubbio che considero una vera cattiveria. Molto di ciò che avverrà negli anni successivi di quel bambino dipenderà da questa sua prima esperienza, così “terraterra”, dalla temperatura del bagnetto, alla specie di voce. L’insieme di atti dell’adulto – potrebbe trattarsi anche di un’infermiera - guai, e rincaro la dose, guai, se tendesse ad essere né più né meno di quel che faccio per l’ospite che ricevo a quest’ora, che può solo essere accolto bene. L’ospite, se si sentisse sottoposto a educazione, sarebbe già tanto se non se ne andasse sbattendo la porta. Importante, dunque, è cominciare bene. Col bambino o si comincia bene o si comincia male. E, per di più, il genitore che, puramente e semplicemente, è intento a far star bene il bambino, starà meglio anche lui, perché si comporta come il padrone di casa che riceve l’ospite. Non si tratta bene un ospite invitato a pranzo se lo si obbliga a mangiare. Cominciare educativamente significa irrimediabilmente cominciare male. Dopo tanti anni di esperienza e di meditazione, mi sono convinto che il bambino autistico sia tale perché non è stato trattato bene, e al livello degli esempi che ho appena fatto. L’idea di “ruolo genitoriale” - la stessa espressione “ruolo genitoriale” fa venire la pelle d’oca - corrisponde indubbiamente a un metodo molto comune, che ha bisogno di mettere tutte le cose su un piano astratto, valido per “tutti”, dove sparisce il “ciascuno”. Un po’ di tempo dopo vedremo dei bambini vandali, non dico neanche autistici, anche se penso che un bambino autistico sia un vandalo: uno che non è stato accolto bene farà del vandalismo, spaccherà le vetrine, parlerà male, insulterà la gente, offenderà, non risponderà se lo chiami. Nel bambino piccolo si può cogliere molto presto questo vandalismo: è perché 2 Trascrizione di Angela Postiglione e Maria D. Contri non rivista dall’autore. 5 Il pensiero del figlio non lo abbiamo trattato bene. Se non lo abbiamo trattato bene, non avrà infatti alcun motivo di comportarsi bene. Si sente spesso dire, prendendo probabilmente spunto da uno sketch di Zelig: “Mio figlio è sconnesso”, oppure: “Mio figlio fa delle cose senza ragione”. La parola “sconnesso” è senz’altro usata a proposito, se la si prende alla lettera, se con essa si intende che mio figlio non è sconnesso in sé, è sconnesso da me che non l’ho trattato bene. In questo caso sono io che l’ho sconnesso da me, anzi, non gli ho neanche dato modo di connettersi, non si vede perché avrebbe dovuto farlo. Per quanto riguarda l’adulto che dice che il bambino più o meno piccolo fa delle cose senza ragione, questo adulto dimostra di avere poco intelletto. Il bambino fa sempre le cose con ragione, dovrebbe essere preso come puro modello di razionalità. Se non si connette, è perché ha ragione di non connettersi. Se c’è un bambino che piange, non occorre essere dei geni per capire che ha un motivo per piangere, perché è bagnato, perché la mamma gli manca, perché, più in generale, non sta bene. Se c’è qualcuno che capisce la razionalità, questo è proprio il bambino. Il bambino imparerà presto a prendere l’iniziativa, ma dapprima l’iniziativa è quella dell’adulto. E’ lui che inizia, collocandosi nella posizione di ospite, connettendosi col bambino dalla posizione di ospite. Ma spesso gli adulti non si connettono con lui, neppure come fa l’infermiera che, portandosi via il bambino appena nato, sta attenta che la temperatura del bagnetto sia adeguata. Appena deposto nel bagnetto, lui allora si addormenta subito: è stato ben accolto. Quanta razionalità e buon senso ha il bambino! Secondo alcuni il compito del genitore consisterebbe nel dare certe regole. Ciò che ho detto del genitore e del neonato sarebbe bene si ripetesse ad ogni età della vita, né più né meno che come tra adulti, la stessa regola del trattar bene i propri ospiti . Non ho inteso enunciare delle regole per la prima l’infanzia, ho inteso dire che le regole per la prima infanzia è bene che siano le stesse che dovrebbero esserci tra adulti. Il primo peccato è trattare il bambino da bambino, fatte salve certe ovvietà, come per esempio che non offrirò un bicchiere di whisky a un bambino, o che dovrò provvedere io a una parte della sua termoregolazione. Ma, per il resto, la regola sana dei miei rapporti con i miei ospiti, sarà quella regola che metterà in buona relazione i miei ospiti con me: la regola riguarda l’individuo. Incomincia ad andare tutto storto quando si distinguono regole specifiche per educandi. E’ un dato di osservazione, anche per le maestre d’asilo, che, quando un bambino è stato trattato bene, a sua volta si comporta benissimo. Non ha neppure bisogno di essere accompagnato dalla regola. E, infatti, quando è stato trattato bene e gli diciamo: “Vieni qui!”, senza dubbio viene subito! Non abbiamo bisogno di un trattamento che lo istruisca a venire quando lo chiamiamo. Se è stato trattato bene, avrà voglia di venire! Il bambino è un critico straordinario. Sa cogliere con precisione quando l’adulto agisce nei suoi confronti in base a regole astratte e, per ciò stesso, si fa una cattiva opinione dell’adulto. A molti adulti non piace questa elementare, ma solida facoltà critica del bambino, la sua capacità di distinguere con chi sta bene e con chi non sta bene. Secondo altri, fondamentale sarebbe invece educare ai valori. Non ho nessuna voglia di mettermi a discutere, per la millesima volta, di cosa sono i valori, o della filosofia dei valori, di Max Scheler e di tutto il resto. 6 Il pensiero del figlio Prendiamo la parola “valere” per come la si intende nell’universo e la si usa nella vita quotidiana, quando si dice “vale la spesa” oppure “questo è uno spettacolo che vale”. Ora, c’è un solo esplicito valore per il bambino, per qualsiasi bambino, ed è quello che egli coglie come ciò che vale per lui perché vale anzitutto per l’adulto. Prendiamo un semplice esempio. Il bambino ha la minestra davanti, e io con un altro cucchiaio mangio la sua stessa minestra, oppure gli do dei cucchiai della minestra dal mio piatto, o del dolce, o di qualsiasi altra cosa. Anche in questo caso, la parola educazione è eccessiva. Il bambino apprezza il fatto che io apprezzi, perciò apprezza ciò che gli do, ivi compreso l’apprezzamento per ciò che gli dico! Anche se gli comunico delle idee che potrebbero essere impegnative. Apprezza quelle idee, per il fatto che sono io il primo ad apprezzarle. C’è qui una questione di certezza: se il bambino constata il fatto che io sono il primo ad apprezzare, sia che si tratti di minestra che di idee, acquisisce la certezza che non voglio ingannarlo. Se una cosa piace anche a me, è del tutto ovvio che non lo ingannerò, magari suonando i registri alti, puri, astratti, ideali. “Se piace a lui – si dice il bambino - è ovvio che non vuole ingannarmi, posso averne la certezza”. Non posso dire a mio figlio più grande: “Leggi quel libro!”, se mio figlio non constata che a me quel libro piace. Non importa se è un romanzo, se è il Vangelo, se è il Corano, se è il Pentateuco, il bambino apprezza ciò che l’adulto apprezza. C’è’ sempre una questione di prezzo, nel verbo “apprezzare”. E qualsiasi bambino si accorge quando il papà si diverte anche lui a buttarlo per aria. Se ne accorge subito! Come vede, le sto dicendo tutte cose ovvie in risposta alle sue domande! Mai alzare il tono su questi argomenti! Dall’altezza del tono, abbiamo la prova che già si è deragliato. Allora valore è piacere? Ho usato la parola apprezzamento per usare una parola lievemente più priva di equivoco. Nel nostro mondo la parola piacere, purtroppo, è diventata equivoca ed è un vero peccato, perché una persona appena raziocinante sa che il piacere non esiste in natura, il piacere è solo dell’uomo. L’animale non mangia con piacere. Non esiste il fenomeno del piacere alimentare nel mondo animale, come non esiste il gusto nel mondo animale. Le api non provano il minimo gusto per il miele, né i cavalli per il foraggio. Bisognerebbe ripensare alla filosofia dei valori. Il valore è un giudizio condiviso, o almeno potenzialmente condivisibile. Oltretutto, ciò che dico va a favore del senso dell’autorità, perché agli occhi critici del bambino si presenta subito una netta distinzione tra autorità dell’adulto, in quanto sa apprezzare, e autorità dell’adulto in quanto sa solo comandare. Nel primo caso è ovvio che il bambino riconosce come autorevole l’adulto, perché è stato il primo ad avere un giudizio di apprezzamento, per esempio per la ciliegia che gli offre. E’ autorevole, perché è venuto prima lui. In che cosa? Nell’apprezzamento! I bambini non apprezzano i sacrifici degli adulti, ne apprezzano solo gli apprezzamenti. Mille volte ho già citato quella canzone d’altri tempi “Mamma tu compri i profumi per te e non i balocchi per me”. Se non abbiamo delle fette di salame sugli occhi, ci accorgiamo che al bambino dei balocchi non gliene importa mica tanto! Si arrangia lo stesso, si procura i balocchi da sé, oppure giocherà con quelli dei suoi amichetti! Il bambino apprezza i profumi della madre, non apprezza i sacrifici della mamma che rinuncia ai profumi per comprargli i balocchi. Il bambino apprezza la mamma profumata! Il bambino vuole la mamma bella! Anche questa è un’ovvietà, ma culturalmente tutto va in senso contrario. E la mamma che compra i profumi per sé non lo fa per un intento educativo, ma 7 Il pensiero del figlio perché le piace essere profumata! Andrà da sé che ciò piacerà anche al bambino. La parola piacere che ho appena usato, significa buona relazione con la mamma e con il papà. Secondo tutta la mia esperienza, c’è una prima cosa che il bambino apprezza, ed è se l’adulto parla bene o male. E sto proprio parlando della lingua italiana. Il bambino sa distinguere alla perfezione la cattiva lingua, quella senza apprezzamento, senza gusto sia per ciò che si dice sia per la persona cui è detta. Non nel senso che egli apprezzi solo chi ha studiato a Oxford, l’adulto potrebbe anche essere un analfabeta, non è un problema di buona grammatica. Anche fra adulti si coglie benissimo se l’interlocutore non ha nessun gusto per ciò che dice e per il fatto di dirlo. E’ invece una questione di piacere simultaneo per ciò che si dice e per la persona a cui lo si dice. Non sto poi a parlare, come tutti dovrebbero sapere, del fatto che il bambino intende, intellettualmente, ciò che si dice molto prima di sapere parlare e quindi è necessario fare veramente attenzione a quello che si dice ai bambini e a quello che non si dice. Il bambino, infatti afferra perfettamente e oserei dire di più: il bambino afferra e, guarda caso, non perdona. Non nel senso che diventerà necessariamente autistico, ma metterà in atto altri modi suoi di non perdonare: si chiamano vendette o sanzioni. E il bambino che sanziona è ancora sano, è quando non sanziona più, che incomincia ad ammalarsi. Quelli che sostengono la teoria delle regole e dei valori, molto spesso dicono anche: “Il bambino vive in un mondo tutto suo”, “Va’ poi a capire cosa pensa!”. Ma figuriamoci se il bambino vive in un mondo tutto suo! Questa frase è la menzogna delle menzogne. Il bambino vive nel mondo dell’altro. dei genitori, dei maestri, vive nel mondo reale. E’ solo quando si ammala che non vive nel mondo reale. A partire dal bagnetto iniziale, vive nel mondo dell’altro, ad esempio dell’infermiera che glielo ha preparato. Questo falso cosmico, secondo cui il bambino vivrebbe in un mondo tutto suo, oltretutto è persino una stupidaggine. Basta l’osservazione per vedere che il bambino vive nel mondo degli altri. Non c’è un mondo tutto suo del bambino, esiste un mondo “tutto suo” solo nel caso dello psicotico. Riguardo alla frase “e poi va’ a capire che cosa pensa”, si tratta di un altro concetto assolutamente sbagliato, che per lo più significa: “Non ho mai capito che mio figlio pensa!”. Può anche darsi che in certi momenti mi scappi di dire “Va’ a capire cosa pensa!”, purché la prima osservazione sia che mio figlio pensa! Ed è questo che la civiltà detesta: che mio figlio pensi, che si faccia i suoi giudizi, che agisca di conseguenza, che sia critico. Anche questo lo si può capire con un facile esempio. Quando in casa arriva un ospite, si vede come il bambino, tenendosi un po’ lontano, dapprima gli giri intorno, aspettando di farsi una sua opinione. E quando se la sarà fatta, agirà di conseguenza: o il tipo gli è piaciuto, allora svilupperà con lui una relazione, o non gli è piaciuto e allora si terrà da una parte, e se quello cercherà di relazionarsi, al massimo gli risponderà con fredda cortesia. A me che sono insegnante, capita di sentire dei genitori criticare così il proprio figlio: “Mio figlio non mi rispetta. Mi risponde sempre!” E’ vero che frequentemente il figlio non rispetta i genitori. La sola cosa che dovrò fare in questo caso sarà di chiedermi perché non mi rispetta: se non mi rispetta, ci deve essere un motivo. La frase “Mi risponde sempre”, può significare “Mi risponde polemicamente”, ma c’è anche il caso in cui significa: “Mi risponde caramente”. Il bambino, sia che risponda polemicamente, sia che risponda caramente, è sempre critico. Il bambino con dei problemi deve essere innanzi tutto occasione di auto-interrogazione da parte dell’adulto e non di una riforma educativa con cui agire su di lui. Ai bambini 8 Il pensiero del figlio disturbati, infatti, fa sempre piacere sapere che il genitore disturbante si è messo in cura, lo sente anzitutto come un sollievo. Nella sua relazione Chi è genitore. Generare non è procreare, che compare nel libro, Lei dice che è possibile, ma accade raramente, che il rapporto insegnante-allievo nella scuola venga pensato e vissuto come momento di trasmissione ereditaria. Che cosa intendeva dire? Se io genitore apprezzo qualche cosa e passo a mio figlio ciò che apprezzo, siano cose sensibili o pensieri, ecco qua un esempio di eredità. E’ facile capire che un figlio è figlio se è erede. La relazione dell’adulto col piccolo è basata sugli apprezzamenti che l’adulto fa e da questo il figlio non potrà che essere arricchito. L’idea è semplice, anche se tutto il mondo non ce la fa su questo punto di per sé così facile. Il passaggio da genitore a insegnante non va da sé, ma, in fin dei conti, un insegnante, per puro buon senso, potrebbe dirsi di non avere nessun dovere di insegnare. Per quel che lo pagano! All’insegnante andrebbe detto ciò che nell’antichità si diceva al medico: “Medico, cura te stesso!”. Dobbiamo ricordarci che l’insegnante è uno pagato poco, e che tutti i santi giorni e le settimane è sempre lì a ripetere le stesse cose. E’ già straordinario che il mondo degli insegnanti non sia un mondo ad alto tasso di suicidio! In questa situazione deplorevole, il primo modo per cavarsela degli insegnanti potrebbe essere quello di lavorare con se stessi, svolgendo nell’insegnamento della propria materia le cose che li interessano, potrebbe essere quello di trattare come personale il proprio lavoro, ossia, aprendo un insegnamento tutto pervaso di apprezzamenti: “Ecco ciò che apprezzo della materia che vi insegno!”. Parlo anche per esperienza personale: gli insegnanti che ancora oggi ricordo sono quelli che mostravano di avere particolare interesse, che so io, per la guerra dei trent’anni, per Orazio, per la storia moderna, per la trigonometria! Li apprezzavo! Tutti gli altri mi annoiavano e per di più non sono neanche rimasti nei miei ricordi. Non sto tanto facendo un paragone tra genitori e insegnanti, semplicemente applico all’insegnante quello che vale per i genitori. Se il genitore imposterà il rapporto con i figli sulla base di quello che apprezza, otterrà qualcosa. La stessa cosa vale per l’insegnante. Non è corretto pensare in termini di continuità diretta tra genitori e insegnanti. Invece trovo proficuo pensare a un comune principio: “Cura te ipsum!”. Medico, cura te stesso, genitore cura te stesso, insegnante, cura te stesso! A dire il vero, l’antico “Cura te stesso” interessa più il genitore o l’insegnante che non il medico. Che il mio medico abbia l’artrite, mi dispiace per lui, ma quello che a me importa è che lui curi la mia artrite. Posso persino essere contento che anche lui ne soffra: mi fido di un medico che, pur sapendo di avere l’artrite, è lì a curarmi. Mentre non è così facile per un genitore o per un insegnante ottenere un beneficio per un figlio o per gli allievi: possiamo stare bene solo con persone che, a loro volta, stanno bene. Almeno il beneficio di base è assicurato. Guardi, per la stessa ragione, quando andiamo ospiti a casa di qualcuno, noi stiamo bene quando, entrati in quella casa, notiamo che quella persona ne ha cura. Basta la porta aperta e si capisce subito se quella casa è in ordine: non ha importanza se è miliardaria. Incomincio subito a sentirmi un ospite ricevuto bene. Quanto conta, nel conferimento di quell’eredità di cui Lei parla, il rapporto tra i due genitori? Il rapporto tra i due genitori è indipendente dai figli. Quando i due genitori si mettono a comportarsi bene tra loro soltanto per i figli, non solo abbiamo un errore, ma credo che si 9 Il pensiero del figlio tratti di un errore al quadrato o al cubo. I figli devono essere l’ultima preoccupazione del genitore. Quanto più è l’ultima preoccupazione, tanto più il figlio si troverà bene. Il rapporto tra genitori o c’è o non c’è, indipendentemente dal figlio. Quando due si mettono a esibire chissà che amore tra loro per il bene del bambino - sto parlando ad esempio di quei genitori che si separano, ma poi si rimettono insieme per amore dei figli -, in questo caso, il bambino è stato ingannato. Anche perché, e forse soprattutto perché, qui è subentrato il potere di un principio astrattissimo. Sotto, infatti, c’è il pensiero: “Non lo facciamo per noi, in realtà non lo facciamo neanche per il figlio, ma solo in obbedienza al principio educativo, ai valori, alle regole, che ci hanno insegnato”. E l’amore dei i genitori passa non tanto attraverso i regali che si fanno tra di loro, attraverso i regali sessuali, attraverso l’aiuto reciproco, ma per il modo in cui si parlano: ci sono dei giri di frasi che dicono che l’amore tra di loro o c’è o non c’è, che il rapporto c’è o non c’è. Dico giri di frasi, e non buone maniere, che peraltro non guastano mai. Il buon rapporto tra i genitori è molto ben esemplificato dal buon colloquio tra di loro, dal buon giro di frasi, dall’accuratezza linguistica con cui si parlano, non minore, anzi, dell’accuratezza nell’abbigliamento, dell’accuratezza della tavola. Vi sono dei ragazzi che non hanno mai visto accuratezza linguistica tra i genitori, non sospettano neanche che esista, al massimo hanno visto dei gesti da “galateo”: hanno visto che i due si parlano, come si dice, in punta di forchetta. Il bambino è critico: sa distinguere quando c’è o non c’è rapporto. Ciò che sto dicendo, non lo sto dicendo io, all’inizio del terzo millennio, lo si diceva già attraverso il comandamento “Onora il padre e la madre”. Per quale motivo le tavole della legge hanno sentito il bisogno di specificare questo? Perché già allora, di fronte a un certo comportamento dei genitori, al loro figlio veniva voglia di disonorarli, di trattarli per quei cialtroni che erano! E allora il buon Dio sente il bisogno di dire: “Va be’ dai, lasciate stare. onorateli lo stesso!” In realtà non è un invito, è un consiglio di perdonare. C’è una grande saggezza in questa affermazione, nella scelta stessa del verbo, nella scelta de verbo “onorare”. Si è sempre ignorato il fatto che il figlio non è un contraente del contratto coniugale, ne diventa un contraente, un sano contraente passivo, solo ad eredità avvenuta, allora sarà anche lui incluso nel patto. Il bambino non è un contraente, lo sarà solo per via dell’eredità. Se non sarà così, allora, nel migliore dei casi, anche lui si limiterà ad onorare i genitori. E penserà che non vale la pena di stare a farsi il sangue marcio ad analizzare perché le cose siano andate in una certa maniera. La polemica contro i genitori è patologia. Quando un figlio è sempre lì a polemizzare contro i genitori, è malato, perché il pensiero è incapace di fare riferimento al buon senso pratico che si dice: “Lasciamo perdere, andrò a fare altre cose nella vita!”. Invece resta lì fissato a buttare via la sua vita nel polemizzare. Un ruolo implica una formazione ed è giusto che sia così. Se quello del genitore e dell’insegnante non è un ruolo, o non è solo un ruolo, come si forma una competenza di genitore e di insegnante? Il punto è sempre lo stesso. Guai all’idea di formazione dei genitori. Non ci si forma a essere genitori! Non si fanno scuole per genitori né corsi di formazione per genitori! I genitori sono due persone che hanno una relazione. L’eredità per il figlio consisterà nella qualità o bontà di questa relazione. Tutto il resto è puro buon senso: non mettere il bambino a venti gradi sotto zero sul balcone, non lasciare che un bambino di due anni attraversi la strada da solo, e altre simili ovvietà. L’adulto può trasferire solo ciò che è bene per lui, ma se non ha dei beni, cosa vuole che possa trasferire? Per quanto riguarda l’insegnante, accetto la parola formazione, quando la si usa per dire che un insegnante si è formato in letteratura italiana, in storia dell’arte, in matematica. Ma, al di fuori di questi studi, che poi corrispondono alla preparazione liceale o 10 Il pensiero del figlio universitaria, non c’è la formazione dell’insegnante. C’è solo o quell’insegnante che va avanti a vanvera, disperato, perché non gliene importa niente, oppure quello che, anche nell’insegnamento, ci mette una misura di interesse per quello che insegna. Da cinque anni se insegna da cinque anni, da due anni se insegna da due anni e via di seguito. Il peggior insegnante è quello a cui non importa niente della sua materia. Peggiorerà ancora di più, se andrà a fare i corsi di formazione per diventare un bravo insegnante. Per questo io ho disistima della didattica. 11 Il pensiero del figlio Chi è genitore Generare non è procreare di Giacomo B. Contri 3 Procreare e generare Ho sentito parlare di rapporto tra genitori e figli fin da quando ero piccolo, se ne parla tutti i momenti e non se ne può più, che noia! Anche perchè - scusate l’espressione gergale ma chi mai, e quando mai, ha trovato una formula al riguardo, che cavi il ragno dal buco? Non l’ha mai cavato nessuno! Non sto a citarvi una celebre frase di Goethe che dice: “Tanto, qualsiasi cosa tu abbia da trasmettere ai tuoi figli, non sarai in grado di farlo!” E non parto dal pessimismo, parto dal fatto che non c’è formula possibile, c’è solo un’idea, non inventata da me, un’idea di mobilitazione, l’idea di eredità. Il verbo “generare” è altro, è distinto da “procreare”. Nell’ordine della natura si compiono certi atti dai quali, per una catena causale, usciranno dei bambini. Ma fin qui, si tratta più o meno della stessa catena causale per la quale nascono anche i gattini. E questo è il procreare, il fare. Generare, invece, è né più né meno che il concetto di conferimento di un’eredità. Un figlio è un figlio perché è un erede, e non perché è nato come un gattino. Si trattasse pure di un “gattino superiore”, o di “mammiferi superiori”, o di “scimmie superiori”, su cui fantasticare che un giorno saremo in grado di farle diventare umane. Nell’umanizzazione, non si tratta di acquisizione di qualità umane: il concetto di uomo, e di figlio, è quello di erede. Ed è un concetto squisitamente giuridico. E’ il concetto centrale del Credo nella formulazione datane a Nicea (325 d.C.). Non intendo fare alcun appello a personali adesioni alla dottrina cattolica, faccio solo riferimento a un testo in cui ci viene offerta una delle distinzioni decisive per le nostre esistenze quotidiane: il figlio, vi si dice – nel caso, figlio divino, ma non mi occupo di questo ora -, è generato e non fatto, è generato e non creato. Dal contesto e dal testo si comprende che ciò significa che è un erede. E’ l’eredità che fa il figlio. Il concetto di eredità chiunque lo intende, anche senza avere fatto studi giuridici, un po’ tutti sanno che c’è il testamento, che per questo si va dal notaio: il bambino può essere neonato, non parlare ancora, potrebbe perfino essere un bambino sfortunato che un giorno sarà malato di certe malattie metaboliche che ne faranno un debile a vita; malgrado tutto, per il solo fatto che vi sia stato riconoscimento, un giorno ci sarà acquisizione, titolarità della casa, del casato, della Fiat o di quello volete voi. E il solo fatto di essere stato riconosciuto erede, condizionerà l’esistenza di moltissime altre persone. Non ha alcuna importanza che questo bambino diventi adulto, scolarizzato, educato, buono, cattivo. Il dato dell’eredità ha effetti di per sé. Non ha affatto importanza che il bambino sia il piccolo bambino irresponsabile, incapace di. L’eredità è in sé stessa determinante, è determinante che si possa dire di essere figlio. Non si può fare la metafisica del figlio, la metafisica del figlio è giuridica. Il figlio è un erede. Trasmissione ereditaria e trasmissione scolastica 3 Trascrizione di Angela Postiglione e Maria D. Contri non rivista dall’autore. 12 Il pensiero del figlio L’eredità può riguardare beni fisicamente esistenti, capitali, aziende. Nella trasmissione scolastica si pretende invece di trasmettere un “patrimonio” di conoscenze, di abilità, di abitudini - e l’insegnamento è certo una trasmissione. Ma non ditemi che da qualsiasi parte del mondo, salvo forse eccezioni, la trasmissione scolastica. dall’inizio fino agli studi superiori, venga pensata, e fatta pensare, come un’eredità! Il proprio dell’eredità è di essere mobilitante, di far venire “voglia”, di mettere in moto un soggetto. Si assume ciò che ci viene lasciato in eredità per farcene qualche cosa, per diventarne in qualche modo imprenditori. Un’eredità non si è costretti ad accettarla. Non c’è un comando a questo proposito. La legge stessa dello stato prevede il “beneficio di inventario”, la libertà cioè di non assumersela una certa eredità; se lo si fa, è per il proprio beneficio, perché, appunto, ce ne è venuta “voglia”. C’è poi il caso dell’idiota che agisce in modo da sprecare, da dilapidare l’eredità. E’ il caso molto ben rappresentato nella celebre, e assai interessante, parabola del “figlio prodigo”. Costui acquisisce l’eredità nella legittimità, non è uno che scappa con la cassa del papà: ha chiesto la legittima eredità al padre e il padre era così d’accordo sulla legittimità, che gliel’ha concessa. Non c’è delitto né errore né peccato fin qui nella condotta di questo figlio. Solo che, successivamente, anziché mobilitarsi e incrementare l’eredità medesima, non fosse che sotto forma di rendita - il che gli avrebbe permesso anche di goderne -, egli la spreca, la butta via come uno sciocco. Alla fine però lo riconoscerà, di essere stato uno sciocco. Permettetemi un commento fra parentesi, che interessa il modo con cui trattiamo con i nostri figli. Anche io ne ho alcuni. Nella parabola evangelica, quando il figlio torna, il padre – tutti lo sappiamo - lo accoglie bene, e c’è il famoso vitello grasso. Ma perché lo accoglie bene? E qui siamo tutti pronti all’argomento lacrimoso del cuore di papà che vuole tanto bene ai suoi bambini e quindi li perdona comunque. Ma no! Questo padre si ritrova un figlio che gli è tornato a casa con due competenze in più. In primo luogo ha saputo riconoscere un errore - ditemi voi quante persone al mondo conoscete che sanno riconoscere un errore, arduo, a dir poco! -, ha acquisito, cioè, competenza su ciò in cui consiste sbagliare, distinguendolo dal non sbagliare. In secondo luogo il padre sa vedere nel figlio la capacità di riconoscere che innestarsi sulla fonte del capitale, sulla fonte del bene, è un’idea migliore che lasciar perdere tutto. Il padre, insomma, si trova in casa un figlio che si è innalzato in capacità rispetto a quando è andato via, e per questo lo ha nominato – come spesso mi capita di dire - “presidente del consiglio di amministrazione!”. E’ questo il senso del vitello grasso, non è il cuore, cosiddetto paterno, il cuore del papà che aveva tanto pianto per il figliolo. No! Questo padre ha saputo riconoscere che il figlio gli è tornato meglio di come è andato via. Perché dobbiamo sempre far collimare l’amore con una sottesa idea di stupidità, con l’idea che l’amore sarebbe stupido, che non sarebbe concettualmente costruito, o intelligente? Questo padre è tutto contento di vedersi tornare il figliolo, ma il figliolo ravveduto, e non semplicemente pentito, con le idee più chiare, sapendone più di prima! Ecco qui, a mio parere, un’indicazione per gli insegnanti, ma anzitutto per i genitori, riguardo agli errori dei figli. Attenzione, però, dobbiamo saper distinguere quando un figlio sbaglia da quando non sbaglia per niente! Attenzione a non imputare al figlio un errore che non è un errore. Io porto sempre un esempio tratto da quel che accade in paesi a tradizione cattolica, quando si tratta di introdurre all’esperienza del confessionale dei bambini. Si insegna che uno dei peccati che lui bambino a otto, nove, dieci, undici anni dovrebbe confessare è di aver rubato in casa. Coloro che sostengono questa idea dovrebbero essere imputati di errore a loro volta. Ma perché? Non sto qui considerando il caso del figlio drogato che ha mandato in rovina l’intera economia familiare, vendendo i gioielli e le pellicce della mamma, o che ha picchiato la 13 Il pensiero del figlio madre. Si tratterebbe, in ogni caso, di altra fattispecie, che non è neanche quella del furto, se vogliamo. Sto sostenendo che al bambino, non bisogna suggerire di confessare al prete d’avere rubato, perché la fattispecie furto per un figlio, in quanto erede, non esiste. Il figlio è sempre e solo erede, al massimo, dunque, è imputabile di imprudenza, se ciò che preleva senza avvertire supera limiti non tollerabili per l’economia domestica – e allora è una faccenda di consenso. O altrimenti potrebbe trattarsi di prematurità nel tempo, di imperizia e così via. Se mio figlio mi dicesse di aver fatto un certo errore, un errore effettivo - sto pensando a un esempio, non vi sto raccontando la mia storia di padre -, anch’io farei di mio figlio il presidente del consiglio di amministrazione della mia casa. Non starei a perdere tempo a rimproverarlo, lo elogerei piuttosto per averlo riconosciuto! Dopotutto l’esperienza della nostra vita è che l’esperienza senza l’errore non esiste. E non starò a evocare la dottrina del peccato originale, che dice che necessariamente siamo peccatori. E’ meglio avere una buona opinione dell’errore, ma devo dire di aver avuto, nel corso della mia vita scolastica, solo qualche rara esperienza, positiva, di utilizzazione favorevole allo studente di un errore commesso in un compito, o in altre occasioni. C’è dunque, dicevo prima, una trasmissione scolastica che non riesce per lo più a configurarsi come trasmissione ereditaria. Sappiamo tutti, lo sanno anche i sassi, che quella scolastica è assai poco mobilitante, salvo per alcuni.: in genere sappiamo bene che c’è ben poco di mobilitante nell’insegnamento. Il quesito che pongo è allora il seguente: non si potrebbe cercare di concepire come trasmissione ereditaria anche quella scolastica? In modo tale che un soggetto sia messo in condizione di pensare di trovarsi di fronte alla trasmissione di un bene valorizzabile, di un patrimonio di conoscenze, abilità, abitudini, prodotto, incrementato, arricchito dal lavoro di altri, e di cui lui potrà farsene qualche cosa. E non farsene qualche cosa per lo stipendio, per la sopravvivenza, ma farsene qualche cosa per il profitto. Ecco la grande distinzione che distingue un figlio da uno schiavo. Lo schiavo ha il salario, se l’ha, il minimo per la sopravvivenza. Esiste anche il proletario, non solo quello del capitalismo, che portava a casa quanto bastava per sopravvivere, lui, la moglie, la prole. Il figlio è a livello del profitto, l’eredità è a livello del profitto, e non della sopravvivenza. La sopravvivenza è ancora dal lato dello schiavo, del servo: è la lezione del Capitale di Marx. Il figlio è un uomo libero, ma è libero perché c’è un’eredità da far fruttare, non perché è stato definito un uomo libero! Imprenditorialità del bambino Diciamo anzitutto una parola sulla realtà del bambino, quella che si vede, quella che è sotto gli occhi di tutti. E’ innegabile quello che si vede, ma, come al solito, ce ne facciamo poco di quel che si vede! C’è un celebre salmo che dice che abbiamo gli occhi, ma non ci servono per vedere! Abbiamo orecchie, ma non ci servono per udire. Abbiamo il naso, ma non ci serve per odorare. Lo stesso Freud, mio più grande maestro, che non ho mai conosciuto di persona, diceva che la nostra prima pecca è che non sappiamo vedere e non sappiamo udire. Prima osservazione: non appena un po’ di motricità si è istituita (cammina, corre, parla), il bambino si muove per iniziative personali. Salvo che abbiate un bambino che è già una gatta morta - non è un termine molto scientifico, ma a volte il linguaggio popolare è migliore -, il bambino è un’iniziativa dopo l’altra: si va a cercare gli amici, va a tirare la giacca all’amico di casa che trova più simpatico per farci delle cose insieme, si fa i giochi da solo se non ne ha abbastanza, se li inventa. Dico sempre che il bambino è formidabile nell’aprire 14 Il pensiero del figlio tutti gli sportelli apribili e tutte le possibilità che il mondo gli offre. Anzitutto le persone, e non solo quelle, sono per lui altrettanti sportelli. Il bambino non è un ente a un solo sportello, li apre tutti. Ho spesso osservato che un figlio, appena ha cominciato a parlare, è capacissimo di chiamare papà, o anche mamma, l’amico, magari sconosciuto fino ad un’ora prima, appena arrivato, perché gli sta bene. Ha aperto un nuovo sportello, in senso bancario, il bambino si è aperto una nuova linea di credito. Non osserviamo abbastanza queste cose. Seconda osservazione: oltre alla facoltà di iniziativa, il bambino ha una illimitata capacità di pensiero. Si dice infatti: “Una ne fa, mille ne pensa”. E’ un buon detto! E’ solo successivo all’ammalarsi, del bambino o del ragazzo, che cominciano a costituirsi dei limiti al pensiero: “Ci son cose che non si devono neanche pensare”. Man mano che diventano grandi, sentono gli educatori che dicono: “Certe cose non si pensano nemmeno”. Un soggetto diventa sempre più inibito, sempre più limitato nell’esercitare il proprio pensiero. L’inibizione, infatti, non riguarda tanto gli atti, quanto il pensiero! La connessione tra pensiero ed iniziativa imprenditoriale è facile per tutti. L’imprenditore bisogna che l’iniziativa se la inventi, e il bambino è un imprenditore della propria esperienza infantile. Non so se nel primo anno o nei primi sei mesi di vita il bambino sia una tabula rasa – sono però orientato a credere che non lo sia neanche nei primi mesi -, ma certamente è da molto presto che è un imprenditore e non una tabula rasa, con un grado di realismo che implicherebbe il concetto filosofico di realismo, ma al momento non voglio prendere queste vie. Al realismo del bambino non sfugge niente, sono i genitori che non si accorgono di come i bambini osservino il loro comportamento, ascoltino i loro discorsi, criticamente. Semplicemente il bambino non ha ancora connesso la criticità alla malevolenza. E’ da grandi che uniamo la criticità alla malevolenza o, nel migliore dei casi, all’obiezione. I bambini semplicemente osservano che il papà è universitario, che la mamma è simpatica, che si è comportata bene o non si è comportata bene, che gli amici sono di una specie o di un’altra specie. I bambini sono di una chiarezza senza pari! Volesse il cielo che noi adulti recuperassimo la facoltà osservativa e critica, non malevola, che abbiamo avuto da bambini! Ed è abbastanza frequente il caso del genitore, non troppo a posto nel suo spirito o nel suo cuore, che detesta proprio il fatto della capacità di idee chiare e distinte del bambino, oltre che di imprenditoria e di pensiero senza limite! Un pensiero senza limiti Che il bambino sia senza limiti, è inutile dire. ”Sì, però – si obbietta -, il bambino ancora non conosce il teorema di Pitagora o il teorema di Gödel”. Ma no! Non si può parlare di limite a questo riguardo, dato che nel suo campo il teorema di Gödel, o quello di Pitagora, non si è ancora affacciato. Potrò dire di essere limitato nel mio pensiero a proposito del teorema di Gödel solo il giorno in cui me lo insegneranno e io non lo capirò. Ma prima di quel giorno non si potrà dire che sono limitato in quella direzione, non ha senso. Rispetto a tutto ciò che entra nel campo della afferrabilità da parte sua, il pensiero del bambino è illimitato. Se incominciassimo a parlare delle difficoltà scolastiche, temo che finiremmo per radere al suolo la quasi totalità di ciò che chiamiamo la didattica. Non sono un terrorista, tanto più che non so che cosa vorrebbe dire radere al suolo la didattica, bombardare il Ministero della Pubblica Istruzione?E poi cos’è la didattica, quella che servirebbe a rendere intelligibile, facile, accessibile, tangibile una materia? Per intendere qualche cosa bisogna averne voglia. Per imparare il teorema di Pitagora non si tratta, come dicevano i cinquecenteschi, di spalmare il miele, il “soave licor”, sull’orlo del bicchiere che lo contiene, così, ingannato dal dolce, mi ingoio anche il teorema. Non si 15 Il pensiero del figlio tratta di unire al duro apprendimento un fattore di gradevolezza. Ma questo è sciocco! E’ il teorema di Pitagora che o è o non è gradevole. La difficoltà scolastica a qualsiasi livello o grado scolastico è una pura faccenda di limitazione del pensiero. Ma all’inizio il mio pensiero era illimitato. Non ha senso parlare delle difficoltà della matematica. Dico sempre che la difficoltà della matematica è colpa di quel dannato di Pitagora. Non posso spiegare tutto questo, ma lasciatemi almeno fare una battuta: se ci sarà il Giudizio Universale, Pitagora ne passerà di tutti i colori! Perché è lui che ci ha chiusi, inibendoci, nel quadrato, nel triangolo, nella sfera. Fra intelletto e intelligenza - usiamo pure una parola usata anche da tutta la psicologia novecentesca -, fra intelligenza e averne voglia non c’è alcuna differenza. Abbiamo un’idea del desiderio così balorda che pensiamo che il desiderio sia più vicino alle suole delle scarpe e che l’intelligenza sia invece in alto. Siamo dominati dall’idea di una divisione dell’uomo in due, sopra l’ombelico e sotto l’ombelico, un’idea che è una delle catastrofi dell’umanità e con cui roviniamo, dai bambini in su, tutti quelli che vanno a scuola. Desiderio, intelligenza, eredità sono un solo concetto, l’idea stessa della possibilità di far fruttare per il proprio beneficio quel che si riceve da un altro. Non crederete che nasciamo con dei desideri. Si usa, e si strausa, la parola “esigenza”, ma quali sono le mie esigenze? Se son nato schiavo avrò esigenze da schiavo, sarà la schiavitù a darmi le mie esigenze, ossia quasi nessuna. Il libero, ossia l’erede, avrà esigenze da libero, e da erede. Sono acquisite le esigenze! Chiamatele poi esigenze, o desideri, o, se preferite, usate altre parole ancora. Mi capita a volte di fare l’esempio di una persona - sarà capitato a tutti grandi o piccini - che un giorno si trova in casa da sola, un po’ depressa, qualche cosa che le è andato storto. Che cosa fa? Può darsi che le venga una buona idea, anche questa è imprenditoria. Le può venire l’idea di prendere il telefono e di chiamare un amico dicendo: “Dai, usciamo a cena insieme, facciamo due passi!”. E’ un atto imprenditoriale per la produzione di un desiderio. Se in un momento di depressione, di stanchezza, suono all’amico, sto compiendo un atto formale di domanda: “Fammi venire voglia di qualche cosa, perché la mia depressione consiste nel non aver voglia di niente!”. Il desiderio è qualcosa che riceviamo da fuori. L’impianto è quello ereditario: è questa la fonte dei desideri. E’ la presenza o meno del desiderio a rendere l’uomo libero o schiavo, erede o non erede. C’era quella vecchia formula, il vecchio principio della leva: “Datemi dei punti d’appoggio e vi solleverò il mondo”. Ve ne propongo una nuova: “Datemi il desiderio e vi solleverò il mondo”. E’ il desiderio che fa la potenza, non sono i muscoli a fare la potenza. E’ una di quelle cose che tutto il novecento non ci ha insegnato, perlomeno nella sua prima parte, in cui era tutta una faccenda di muscoli. Basta pensare alle rivoluzioni, alle guerre, a tutte le forme di violenza! Il desiderio è stato ridotto a una faccenda intima, ma quel che conta poi sarebbero i muscoli di tante specie, non solo quelli legati alle ossa, perché lì, ci sarebbe la vera forza. La forza, al contrario, è avere un desiderio! La prova provata da secoli di ciò che vi sto dicendo, che la forza, cioè, è avere un desiderio, è l’esistenza degli imprenditori. Cos’è un imprenditore? Certo oggi è più difficile aprire un’ impresa che avrà i successi della Fiat; a metà ottocento, certo, esisteva la persona che, partendo da poco, metteva in piedi un’azienda di livello nazionale o internazionale. Ma anche oggi esistono i Bill Gates, che dopotutto sono partiti dal niente. Ed è il desiderio che fa l’imprenditore. Eredità, dono, promessa, amore Se figlio, allora il figlio per definizione è un figlio adottivo. Lo sarà anche il figlio di uno sposo e una sposa, con tutto ciò che di biologico, di fisico e di causale si dà nella procreazione. Non condivido l’intera discussione sui figli adottivi, cui consegue poi che i 16 Il pensiero del figlio genitori si lascino andare ad incaute frasi del tipo:”Sì, ma non è il mio vero figlio!”. E’ un errore grave, non solo per l’effetto che può avere sul figlio, ma perché non è così! Il figlio, anche quello nato dai più o meno “magnanimi” lombi di qualcuno, è figlio in quanto adottivo. Ciò che definisce il figlio è l’adozione. E’ infatti l’eredità a definire il figlio. Altrimenti sarà uno dei tanti servi del mio casato, per esprimerci nei termini di un’epoca in cui esistevano servi, e casati. Ma ampliamo questo ultimo concetto: allora, ciò che fa il figlio, una volta posto al centro il concetto di eredità, non è il dono di una quantità di beni. E’ una confusione comunissima. Si trattasse pure di un bambino di un mese, in quanto erede cioè in quanto riconosciuto come figlio, egli è fonte autonoma di ciò che ha ereditato, possessore legittimo. L’eredità anzitutto non è il dono. Il Credo, col suo genitus non factus, in questo è chiarissimo. Secondo il Credo, il figlio non ha ricevuto in dono il regno, lo ha ricevuto in eredità, semplicemente perché era figlio di suo padre, così come si dice “figlio di papà”. L’eredità non è dono, ma non è neanche promessa, anzi, è molto incauto lasciarsi andare all’idea che si tratterebbe di promessa. L’eredità non è promessa. E’ secondo il diritto che il figlio, in quanto riconosciuto, è erede. Potrei anche avere dei genitori criminali. E rispetto agli effetti giuridici, in quanto erede, il figlio è sempre già maturo. Non c’è nessuna differenza, avvenuto il riconoscimento, fra l’avere un mese e l’avere ottanta anni. Tutti sappiamo quanti discorsi si fanno sull’amore, ma non confondiamo l’amore con il dono o con la promessa. L’amore è la trasmissione ereditaria. E, a questo livello, non faccio distinzione tra padre e madre, perché, rispetto alla trasmissione dei beni, la madre è a pari titolo del padre. Faccio sempre notare che in spagnolo, per dire genitori si dice padres, ambedue i genitori sono chiamati padres: è molto corretto. Le promesse si possono anche non mantenere, si tratta di una fattispecie penale, di un crimine, perseguibile o no che sia dalla legge dello stato. Non c’è forse crimine più grave della promessa non mantenuta, più grave di una menzogna addirittura. Proprio l’altro giorno, parlando a trecento studenti dell’Università di Urbino, dicevo loro: “Voi avete tutti venti, ventuno, ventidue anni. Sapete qual è la differenza fra voi e gli studenti del ’68? I figli del ’68 avevano ricevuto delle promesse, non importa se dai cristiani, dai comunisti, dai fascisti, erano ancora figli della promessa, e di una promessa non mantenuta! Il prodotto si è chiamato il ’68, che in parte è nato qui vicino”. Concludendo, il figlio non è effetto di dono, non è effetto di promessa, è effetto di eredità, è effetto di costituzione, proprio come si dice “la costituzione italiana”. Il figlio si costituisce in uno statuto giuridico che non è dato in natura. Il puro creato, il puro procreato, il puro fatto, ossia il non figlio, non può che assumere lo statuto del servo, o meglio dello schiavo, a partire dalla sua testa, dal suo pensiero. Qualcuno potrebbe dire: “D’accordo, qui ci sono servi in catene, obbligati a lavorare con lo scudiscio, ma nel loro pensiero sono liberi”. No, il non erede, colui che non si è costituito come figlio, cioè come erede, è servo nel suo pensiero. In questo caso, parliamo poi di psicopatologia! Comune umanità: imprenditori o consumatori Ma io che eredità posso lasciare ai miei figli? Può darsi che possieda un cavallo, trasmetterò loro il cavallo, o un’automobile, o quattro soldi in banca, o un appartamento. Mi si potrebbe allora obiettare che questo discorso dell’eredità varrebbe solo per le grandi famiglie del passato o del presente, ma che per tutti gli altri…! Le masse popolari che eredità hanno da lasciare? Uso la parola masse popolari pensando all’era sessantottina, in cui si usava e si abusava all’estremo di questa espressione. Il pensiero sessantottino era privo del pensiero dell’eredità, anche quando aveva ragione, e, 17 Il pensiero del figlio tante volte, quanta ne aveva! Non crediate che io sia un antisessantottino! Ma era questo il buco di pensiero del ’68, un buco del pensiero che era anche di Marx. Il mondo degli imprenditori è finito con la fine del capitalismo, il punto di vista dominante, dominante anzitutto nella teoria economica, è diventato quello del consumatore, e il mondo dei consumatori è il mondo della distribuzione dei beni, contrapposto al mondo dei produttori-imprenditori, che producono non in vista del salario e della sopravvivenza, ma del profitto. E non mi si dica che ci sono altri tipi di pensiero, che sanno pensare. L’idea del paradiso, per esempio, è lì a parlare al mondo di una imprenditoria aperta a tutti, e invece il paradiso è pensato come un mondo dove si sta lì a bocca aperta ad aspettare che la grazia divina cada nel nostro becco di consumatori. Accenno appena, con un lessico triviale, a un argomento di cui potrei discutere con discreto tecnicismo teologico. Allora, cosa posso trasmettere ai miei figli, stante la non soverchia entità dei beni materiali di cui dispongo? Rispondo: colazione, pranzo, cena. Non mi riferisco al solo contenuto materiale che, se è discreto, tanto meglio: a colazione pranzo e cena in una famiglia normale, ma anche in quella anormale, si apre la bocca, si parla, si dice qualche cosa, si dice quel che si pensa. E’ che noi siamo abituati da una lunga tradizione educativa a disprezzare il nostro pensiero. Cominciamo ad apprezzare la parola pensiero, peraltro in via del tutto accademica, quando si tratta del pensiero di Einstein o di altri grandi autori, ma quando si tratta di noi stessi, siamo tutti al di sotto del livello di galleggiamento dell’autostima, siamo nella disistima. E sono gli psicologi a parlare sempre di autostima o mancata autostima. Cosa posso dunque trasmettere ai miei figli?Un pensiero innestato sul profitto, su quello cioè che tanti chiamano concetto positivo della realtà, realismo buono. E’ tutto un linguaggio che in certi contesti si usa molto, e non sono certo io a ritirarmene. Ma cosa significa avere un concetto positivo della realtà? Significa essere capaci di pensare che da ciò che ricevo da un altro posso tirar fuori un guadagno, un beneficio. Cristo lo diceva in modo perfetto – mi attengo qui all’enunciato evangelico, è irrilevante che io parli qui da cristiano, da credente, o meno -: “l’albero lo giudico dai frutti”. L’albero è la realtà: “Benissimo, dice Gesù, ma per il mio realismo positivo l’albero non basta Se non dà frutti, ordinerò al fattore di tagliarlo: se non fa fichi, il frutto sarà il legname da ardere, o da far mobili”. Posso dire di avere un rapporto positivo con la realtà solo se entro con essa in un rapporto produttivo, ossia se tratto anche la pianta di fico come un’eredità acquisita da far fruttare, anche quando la pianta di fico non è mia. In altri termini, ciò che posso trasmettere a mio figlio è la realtà tutta pensata come eredità. Il solo realismo degno di questo nome è quello che da una cosa ne vuole “spremere” un’altra, benché “spremere” non sia l’idea più esatta. Il frutto non è un prodotto di spremitura. Tra l’albero e il frutto, c’è il lavoro, e il lavoro di più d’uno. Non posso certo dedicarmi a questo punto a concetti di economia politica, posso solo accennare a qualcosa che serve per la conclusione del mio intervento. Il lavoro di uno solo produce di che sostentarsi, di che sopravvivere: il contadino che lavora la sua campagna produce per sfamarsi. Occorre invece fare un’azienda agricola perché ci sia profitto. C’è profitto quando si apprezza e si rielabora il prodotto del lavoro di un altro. Non solo, ma anche quando si lavora perché l’altro apprezzi e rielabori il prodotto del nostro lavoro. Pensiamo invece a cos’è l’azienda uomo e donna, così come li crea domineddio… dovrebbero essere un’azienda, ma quando mai le coppie si concepiscono come azienda, ossia come coppie per un frutto. Si commette addirittura l’errore di considerare frutti i figli. E no! E’ vero che in latino si dice “fructus ventris”, ma il figlio è l’erede del frutto, non è il frutto. 18 Il pensiero del figlio Soggetti o sottomessi di Maria D. Contri I figli, gli allievi, ma anche la moglie, il marito, gli amici, i collaboratori sovra- o subordinati sul lavoro, insomma tutti i partner dei propri rapporti possono essere trattati secondo i due corni di una alternativa: come soggetti o come sottomessi. Che si faccia una scelta ragionevole dipenderà anzitutto dal fatto che si veda bene l’alternativa e che si faccia una scelta tra i due corni di essa. Ci vorrà tuttavia un passo ulteriore nella ragionevolezza per arrivare a rendersi conto che trattare i partner come sottomessi o sottomettibili, ovviamente a un comando, è un comportamento dannoso, distruttivo. Così facendo si andrà a distruggere infatti quello che è il vero pozzo di petrolio, la principale risorsa su cui si fonda la produttività di una persona e la sua capacità di rapporto: una produttiva attività lavorativa si mobilita in un soggetto capace di avere in proprio mete di guadagno da raggiungere, in collaborazione con altri e con le istituzioni considerate come patrimonio da far fruttare. E la Dottoressa Cavelli nel suo intervento ci dice cosa succede di una persona quando è arrivata a concludere “io non ho risorse per riuscire”. Nella mia esperienza come psicoanalista, ma prima ancora come insegnante, vedo, e ho visto, molto bene quanto il fatto che si sia instaurato in qualcuno il pensiero “non posso” sia “il” problema. E suppongo che se ciascuno di voi ripenserà alla propria vita, troverà che da qualche parte, almeno un po’, quella idea è lì, radioattiva, e pronta ad esplodere laddove si produca un qualche incidente di percorso più o meno grave. Sto leggendo un libretto, di quelli che trovate allegati a un periodico, intitolato Il sonno della ragione4, che riprende una famosa frase del pittore spagnolo Francisco Goya: “il sonno della ragione genera mostri”. Si tratta di una raccolta di brevi testi di autori diversi che riflettono sulla crisi della ragione a partire da un fatto molto eclatante come la distruzione delle torri gemelle di New York, un fatto preso come esempio di quello che sarebbe qualcosa di specifico dei nostri tempi, quello che sarebbe un male oscuro, una minaccia, che colpirebbe specificamente le nostre società ormai troppo complesse e globalizzate e dunque indifendibili da chi le voglia distruggere. Mi sono imbattuta ad apertura di libro nel breve scritto di Amartya Sen, Professore di filosofia all’università di Cambridge, premio Nobel per l’economia e la filosofia. L’attenzione di questo testo è rivolta a catastrofi come le carestie o le distruzioni ambientali, in quanto prevedibili e prevenibili, che sono eventi di cui certo non può che occuparsi un’istanza di governo, locale o nazionale o sovrannazionale. Tuttavia i governanti sono pur tuttavia loro stessi degli individui più o meno sonnolenti, più o meno svegli quanto all’esercizio della ragione e, oltre a ciò, i governanti sono espressione della ragionevolezza dei loro elettori e sono spesso tentati di appoggiarsi alla loro non ragionevolezza. Non si tratta per lo più di eventi, dice Amartya Sen, spiegabili con una esplicita cattiva intenzione di affamare intere popolazioni o col premeditato desiderio di distruggere il mondo, essi vanno piuttosto fatti risalire ad azioni insensate o perseguite senza alcun sensato ragionamento preliminare. Ci sono risultati terrificanti causati da negligenza e umana ottusità, cui poi – dice Amartya Sen - si sovrappone una “sorda testardaggine”. Si vuole ottenere un certo scopo, un certo beneficio e non si mette bene in conto, prima di agire, del costo dei danni che si possono provocare perseguendo in un certo modo quel dato scopo, 4 AA. VV., Il sonno della ragione, Reset, Milano 2003. 19 Il pensiero del figlio danni tali che, magari non subito, ma nel tempo renderanno del tutto inutile, azzereranno il beneficio conseguito. Si potrà disboscare una montagna per costruire seconde case e lo si pagherà nel tempo con alluvioni e frane disastrose. Si potrà praticare una diminuzione forsennata dei salari e licenziamenti di massa, e lo si pagherà nel tempo con una diminuzione degli acquirenti dei propri prodotti o con l’aumento dello scontento sociale e del disordine. Lo stesso procedimento Sen lo applica a casi individuali in cui ci si trovi invece di fronte a qualcosa di indisponente o seccante. E’ legittimo, dice Sen, tener in conto la propria reazione irritata di fronte a certi comportamenti altrui, ma poi si tratta di valutarla, di giudicarla questa nostra reazione – può essere che abbiamo ragione, ma anche che abbiamo torto, che siamo degli intolleranti. In altri casi, invece, si tratta di ottenere da altri un certo comportamento. In ambedue i casi si tratta di premeditare con attenzione che cosa pensiamo di fare per far smettere il comportamento che ci risulta sgradevole o per ottenere il comportamento desiderato, in modo tale da non scatenare reazioni peggiori delle azioni che volevamo evitare o più dannose del vantaggio che volevamo ottenere . Come ho già accennato, per un certo periodo ho insegnato e spesso mi è capitato di sentire dei genitori, o anche dei miei colleghi, che dicevano: “Ma no, ma cosa stai lì! A calci nel sedere glielo fai fare! ”. “ A schiaffoni lo fai smettere!”. Così si fa più in fretta, pensavano. Ora, questa è la stupidaggine! Si pensa di giungere più in fretta a ottenere un certo comportamento, o a far smettere qualcuno che ti dà fastidio o ti danneggia, pretendendo obbedienza, anche con l’applicazione di forza, manesca o vocale o magari aviotrasportata: “Smettila!”, “Fai questo!”. Si pretende che quell’ allievo o quel figlio o quel dipendente, si sottometta a un puro e semplice comando. Si pensa, cioè, illudendosi stupidamente, di poter ottenere il proprio scopo direttamente. Si può avere l’impressione che sarebbe più economico evitare di dover fare un giro in più, perché sembra un giro di troppo. In economia, certo, l’imprenditore, se vuole avere profitto, deve cercare di ridurre i costi, ma la riduzione di certi costi può provocare disastri. “Ma cosa ci giri intorno!!”, dicevano certi miei colleghi, o certi genitori. Di che giro stavano parlando? Il giro del pensiero del figlio, o dell’allievo, che sembrava loro veramente una perdita di tempo: tempo perso sarebbe quello lasciato loro per pensare in proprio “E’ meglio fare così come mi è chiesto” o “E’ meglio non fare così”. Mi è sembrato proprio questo l’aspetto più interessante di questo libretto: i danni maggiori si fanno più per stupidità che per cattiveria, si fanno perché non ci si ferma a connettere, non ci si dà il tempo di connettere le proprie azioni con le loro conseguenze, non si osserva abbastanza la realtà che si ha di fronte (“Hanno occhi per vedere e non vedono ..“, annotava già il Vangelo, suggerendo che l’unica scusa possibile nel giorno del giudizio sarà che “Non sanno quello che fanno“): non si premeditano le azioni, non si osservano le conseguenze, e quindi, a cose fatte, non ci si corregge, non si fa tesoro dell’esperienza. Lo scopo di questo corso è di fornire degli elementi di meditazione per diventare più intelligenti sui danni – in certi casi si tratta di vere e proprie catastrofi - che si provocano quando di distrugge la capacità e dunque la libertà del figlio o dell’allievo nel pensare le proprie mete, quando non lo si tratta cioè come soggetto. Si ha fretta e si pensa di raggiungere più rapidamente lo scopo di un corretto comportamento da parte sua pretendendo che obbedisca, che si sottometta a un puro e semplice comando. Sembra che avere allievi o figli sottomessi a dei comandi permetta di risparmiare tempo e fatica, di arrivare allo scopo più direttamente. Si può avere l’impressione che sarebbe più economico evitare di dover fare il giro del pensiero del figlio o dell’allievo. Ci sono persone che addirittura si vantano che per far obbedire i propri figli, o allievi, a loro “Basta uno sguardo“, e magari esaltano, e rimpiangono, per questa che viene considerata una dote eccezionale, i 20 Il pensiero del figlio propri genitori, o i propri insegnanti. Volendo ottenere qualcosa dai figli, dagli allievi, ma anche dai propri amici, dai propri colleghi, dai propri subordinati, si ha fretta. Si pensa di far prima passando per la sottomissione anziché per la soggettivazione. Se il modo di trattare i figli è quello di cercare di sottometterli, può darsi che in certi casi non si provochino delle catastrofi. Un po’ perché, fortunatamente, non sempre i genitori sono così rigidi, così sistematici e ogni tanto si distraggono o hanno altro da fare (i genitori che fanno meno danni sono allora quelli che hanno i fatti loro, il loro lavoro, i loro amici, per cui lasciano che i figli abbiano una loro vita), e un po’ perché i bambini hanno sette vite come i gatti e si difendono. Ma quando non c’è questa capacità di difesa, quando questa capacità non la si è lasciata costruire per la fretta sistematica di farsi obbedire, in effetti, si possono provocare delle catastrofi. Sto pensando alla psicosi, all’autismo, vere e proprie catastrofi umane. Ma quel che è certo è che danni se ne fanno sempre. Se si facessero delle statistiche si vedrebbe – ma a dire il vero è un dato di osservazione sotto gli occhi di tutti, ciascuno può cominciare dalla propria stessa esperienza – come mediamente il danno emerga con la fine dell’infanzia e con l’inizio dell’adolescenza. Lo schema più comune per quanto riguarda la carriera scolastica è il seguente: alle elementari va bene, o addirittura brillantemente, alle medie va ancora bene ma si cominciano a perdere i colpi, col passaggio alle superiori le cose cominciano ad andare male. Nel caso di iscrizione all’Università, poi, ci sarà un rallentamento degli esami, esami che vanno male, ciclo di studi che non si conclude. In altri termini, più l’ordine di scuola richiede una capacità di iniziativa personale autonoma, meno ci si riesce: non inganniamoci, non è perché il liceo o l’Università sarebbero più difficili delle elementari che non ci si riesce. Seguendo poi le biografie anche dopo il termine degli studi, si vedrebbero delle difficoltà anche nel mantenere un lavoro, o nello stabilire legami amorosi che tengano. Avete sentito dire nella lezione di Giacomo Contri che trattare il figlio da erede vuol dire trattarlo da libero, cioè da pensante. E trattarlo da libero vuol dire trattarlo da soggetto. Essere trattati da liberi, da soggetti, da eredi, sono tre modalità strettamente connesse. Allora, trattare un figlio da erede che cosa vuol dire? Mi capita a volte di dire a qualche madre o padre che venga da me come psicoanalista: “ Guardi che quando si dice che il figlio lo si mette al mondo, si intende che poi ci si deve curare che al mondo ci stia bene“. Non vuol dire in altri termini soltanto che si sarà provveduto alle sue necessità o che gli si lasceranno dei beni al sole o che gli si trasmetteranno conoscenze, abilità tecniche o sociali, vuol dire anche poi che lo si deve favorire nelle sue iniziative, nella messa a punto di capacità che gli permettano di far fruttare le proprie risorse e la realtà del mondo a proprio vantaggio. Vuol dire che si dovrà lasciar sviluppare in lui un interesse in proprio a far fruttare l’eredità ricevuta. Senza di questo che cosa succederà? Che il figlio rifiuterà l’eredità, o la dilapiderà, non vedendovi altro che un’imposizione, un comando, un’ipoteca sulla sua vita e non un vantaggio per lui, una dote, un capitale accumulato dai genitori, o dalla società nel suo insieme, da reinvestire. In un certo senso, mettere al mondo un figlio vuol dire che il mondo glielo si lascia in eredità ! “A somiglianza” di Dio che ha fatto il mondo e poi ha detto agli uomini: “ Ecco io ho fatto questo e quello, adesso prendetelo e fatelo fruttare “. Ricordate la battuta di Woody Allen che, a chi gli diceva: “ Ma chi ti credi di essere ? Dio ? “, rispondeva: “Bisogna pur darsi dei modelli ! “. Qualcuno potrebbe chiedersi a questo punto: ma come si fa a trasmettere al figlio, o all’allievo il sapere, le varie abilità, ma anche l’amore della musica o della lettura o dello sport, o anche delle buone maniere in società, come un’eredità ? Cioè come qualcosa da far fruttare per il proprio profitto, per il proprio benessere, per la propria soddisfazione, in 21 Il pensiero del figlio modo tale che l’apprendimento, lo studio e successivamente il lavoro non venga vissuto come sottomissione a una sorta di schiavitù. E io dico sempre che il successo di una vita è che anche il lavoro sia soddisfacente, che si riesca a farsi pagare per fare un lavoro che piace, che di per sé dà soddisfazione. Bisogna che questo sia anzitutto vero per l’insegnante, o per il genitore stesso. Non si può lasciare in eredità ciò che non si possiede. E’ una cosa questa su cui non si può mentire. Nessuno può insegnare a un altro quello che lui stesso non sa. Difficilmente un genitore che non guarda al sapere, alla cultura e anche al lavoro come a una fonte di beneficio per sé, ma come a un’imposizione cui penosamente sottomettersi, riuscirà a trasmettere al figlio l’interesse per la cultura e per il sapere o per il lavoro: potrà comandarglielo di studiare e di lavorare, punirlo se non studia, con i risultati che abbiamo detto. Tuttavia fondamentale è avere in mente i due corni dell’alternativa: o trattare il figlio, e l’allievo, come soggetto/erede/libero/pensante o trattarlo come qualcuno da sottomettere a comandi. Per poco che un genitore tratti per conto suo la realtà come fonte di beneficio per sé, lo trasmetterà al figlio. Bisogna però poi che eviti i comportamenti che stroncano quel desiderio, quel gusto di vivere, che lui stesso ha suscitato. Nella mia carriera scolastica ho avuto due allievi che mi hanno fatto da maestri su questo tema: Natalino e Paride. Natalino, un sicilianino con comportamenti da piccolo bullo prepotente, anarchico rispetto alla disciplina della classe, esperto in tecniche di guerriglia tanto da rendere praticamente impossibile un qualsiasi lavoro: era impossibile fare lezione quando c’era lui! Tecniche già messe a punto in famiglia: era in grado di impedire a una famiglia intera di guardare in santa pace la televisione! Natalino poteva di primo acchito parere del tutto privo di interesse per la realtà scolastica e del resto la sua era una famiglia semianalfabeta. Poteva quindi parere che la strada da battere con lui fosse quella della sottomissione, non solo quanto alla repressione del suo comportamento disturbante - cosa che facevo, anche se nel suo caso la repressione si riduceva poi ad espellerlo dalla classe, peraltro con la collaborazione di un forzuto bidello, dato che non bastava certo il comando “ fuori! “-, ma anche quanto all’inculcargli il dovere di studiare. Pareva che la strada da battere con lui fosse quella del torchiarlo in modo tale da “ficcargli in testa “ che doveva studiare e rispettare le regole della vita scolastica, col comando e la punizione. Pareva che nella sua testa l’interesse per la scuola non ci fosse in nessun modo e si trattasse quindi di inculcargli puramente e semplicemente, ficcargli appunto bene in testa, qualcosa che nella sua testa non c’era. Poi un giorno successe una cosa, una cosa successa ormai trenta anni fa, che fu per me una specie di folgorazione sulla via d Damasco! Avevo dato come compito di scrivere un racconto giallo a partire da alcuni elementi indicati da me. Natalino, che di suo si stava introducendo a una carriera da delinquentello, doveva aver trovato nel tema, come dicono gli inglesi, la sua tazza di tè. Fatto sta che in pochi minuti riempie tre pagine di fitta scrittura e si precipita fuori dal banco per farmele leggere. Naturalmente c’erano duecento errori di ortografia e dal punto di vista della correttezza sintattica era un disastro, però, leggendo, si capiva che c’era una trama sostanziosa e ben congegnata. Al mio commento “Mica male! Buona l’idea !”, mi strappa i fogli di mano e corre tra i banchi gridando, a sbandierare il suo successo: “Alla Contri piace!”. Questo “Alla Contri piace!” non l’ho più dimenticato. Dimostrava che lui al successo scolastico ci avrebbe anche tenuto, ma che ormai lo considerava un investimento in perdita: in italiano, su duecento parole, c’erano trecento errori di ortografia, non parliamo poi della sintassi. Riteneva di essere rimasto troppo indietro, e tanto valeva battere altre strade, con abbozzi di percorsi delinquenziali. Ma il gusto e l’apprezzamento, il desiderio nei confronti della scuola c’erano ancora, bisognava però interrompere un puro e semplice intervento 22 Il pensiero del figlio repressivo. Non che l’iniziale intervento repressivo fosse stato inutile: il fatto che comunque lui dovesse sottostare al mio comando “Fuori!” – peraltro preannunciato normativamente: “Se urli ancora ti sbatto fuori” -, grazie all’intervento del forzuto bidello, mi aveva infatti sicuramente innalzato nella sua stima: non ero una che parlava al vento. Ma era importante che questo ragazzino si imbattesse nel mio apprezzamento di una sua capacità. Per questa via si riaperse per lui l’idea di una possibilità di accesso alla cultura e per noi insegnanti l’idea di una sua trattabilità. Mi misi perciò in seguito d’accordo con una collega per lavorare in questa direzione e, in effetti, pian piano, vedendo che gli si dava anche una mano a recuperare sia in italiano che in matematica, incominciò ad aumentare il suo investimento nel lavoro scolastico e, di conseguenza, a migliorare il suo comportamento. Purtroppo l’anno successivo la famiglia si trasferì in una delle estreme periferie milanesi e mi venne riferito che la sua carriera da piccolo boss a sfondo delinquenziale si era andata precisando. Da Natalino appresi, o meglio mi confermai nell’idea, che in nessun caso lo studio è qualcosa da imporre, come si impone il lavoro a uno schiavo. Allo schiavo il lavoro va infatti imposto: di suo non ha e non può avere alcun interesse per un’attività da cui a lui non viene in tasca niente. Quelle dei miei allievi non erano delle teste in cui bisognava inculcare il dovere di studiare. Loro, almeno un po’, ce l’avevano già il gusto dell’apprendimento, il desiderio della riuscita scolastica, almeno un po’ ne avevano ereditato, ma poi erano stati stroncati, erano rimasti inutilizzati, non trattati come una risorsa, magari rattrappita, ma da mettere in valore e da sfruttare. L’altro mio maestro fu Paride, che era proprio un poverino. Si chiamava Paride, ma era brutto, sembrava un vecchietto, con una di quelle facce che sembrano un po’ una mela cotta tutta raggrinzita. Scolasticamente era un disastro, non stava attento, non faceva i compiti, il suo comportamento era disordinato, restando però isolato e incapace di intercettare e fomentare il disordine di altri. Un giorno la bidella mi racconta: “Sa cosa mi ha detto Paride? Che adesso si è messo a studiare “. E alla domanda: : “Come mai ti sei messo a studiare?” aveva risposto: “Perché ho capito che la Contri non mi odia !” Io, a dire il vero, non gli avevo prestato neppure una grande attenzione: non gli riusciva neppure di essere un fomite di disordine. Chi catalizza e fomenta il disordine di altri dispone ancora di capacità di difesa e di iniziativa: è a lui che i rappresentanti di un’istituzione prestano più attenzione. Non avevo fatto dunque un granché per lui, se non rispondergli civilmente, ma in fondo abbastanza distrattamente, quando mi chiedeva aiuto su qualcosa che non sapeva fare o riconoscere qualche suo peraltro modesto miglioramento. Che ci fosse qualcuno che lo odiava era vero, ed era la madre. Io stessa l’avevo conosciuta. La sua prospettiva era quella del comando, una prospettiva coltivata con rigidità: era una donna abbastanza ignorante, ma in queste cose non occorre avere la laurea! Le sue idee me le aveva esposte con chiarezza: l’avevo rimproverata, una volta, perché non aveva lasciato venire il figlio a una delle poche gite scolastiche che organizzavo perché ogni tanto vedessero direttamente cose di cui a scuola si parlava soltanto o che si potevano vedere solo in fotografia. La sua risposta fu: se voglio che mio figlio mi obbedisca cosa devo fare? Lo punisco togliendogli le cose che gli piacciono. In casa ormai non c’è più niente che io gli possa togliere. La gita scolastica era ancora una delle poche cose a cui lui tenesse. Era una madre che nell’alternativa tra il trattare il figlio come soggetto o come sottomesso aveva scelto e aveva ormai del tutto scartato l’idea di sfruttare il filone di ciò che al figlio piaceva. Anzi, quando vedeva che c’era ancora qualcosa che lui faceva con piacere, ne prendeva nota per potergliela al momento buono togliere a titolo di punizione per ottenere da lui una maggiore obbedienza. Il figlio aveva ragione a definire ciò come odio: questa madre era lì a scrutare che cosa al figlio piacesse, facendosene un punto di appoggio per ottenere, col sottrarglielo, sottomissione. 23 Il pensiero del figlio Che cosa stava facendo questa donna? Stava essiccando nel figlio il pozzo di petrolio del gusto di vivere e di fare le cose, il principio Stesso del trattare la realtà come fonte di beneficio. Al momento il figlio era ancora un ragazzino ed era bastato poco perché questo gusto di vivere gli si riaccendesse, era ancora vivace in lui la capacità di chiedere e ricevere aiuto, ma fino a quando avrà ancora resistito? Come qualificare se non come ottusità, accompagnata da sorda testardaggine, per usare le parole di Amartya Sen, una prospettiva che invece di sfruttare il pozzo di petrolio, gli dà fuoco fino ad esaurirlo ? 24 Il pensiero del figlio Puer oeconomicus di Maria D. Contri 5 Puer oeconomicus non è un modo di dire. Non è solo “une façon de parler “, né una finzione, né un’astrazione, né una teoria. Anzi, la mia tesi è la seguente: è un dato di osservazione che esiste il puer oeconomicus. Incerta e traballante, incompiuta, disturbata, quando non minata fino alle fondamenta, è piuttosto l’esistenza dell’homo oeconomicus. Non si può darne per scontata l’esistenza, un’esistenza che, stando alle teorie che pongono tale esistenza tra i propri articoli di fede, si tratterebbe naturalmente poi di regolamentare sulla base di principi in un modo o nell’altro superiori: artistici, etici, religiosi, politici, scientifici. La razionalità dell’homo oeconomicus andrebbe infatti sollevata sul piano di una superiore e più ampia razionalità, variamente definita a seconda delle preferenze ideologiche di ciascuno, e accomunate però tutte da un comune punto di fuga utopico-idealizzante. L’introduzione della categoria dell’homo oeconomicus come atomisticamente determinato da motivazioni individualistiche data dalla prima metà dell’ottocento6, ma la teoria di riferimento è antica. Antica è infatti l’idea secondo cui la vita umana si svolgerebbe su due piani, uno alto, disinteressato, e uno basso, dominato dall’interesse, determinato dai bisogni del corpo, l’idea secondo cui quindi l’uomo sarebbe costretto a vivere come due vite, diviso, scisso tra interessi “particulari”, economici appunto, da una parte, e “valori” universali e comuni dall’altra. L’uomo economico sarebbe l’uomo che si muove nella società spinto ad acquisire e a consumare avidamente e individualisticamente il maggior numero di beni – vincolato solo dalla scarsità dei mezzi o dalla saturazione -, o spinto, nel caso si tratti di un imprenditore, a massimizzare il suo guadagno. L’avidità, in questa prospettiva diventa la caratteristica dominante e determinante di una “natura” umana originaria, diventa in definitiva un istinto, presociale nella sua costituzione. Può essere utile richiamare un’etimologia: avidità viene dal latino avere o anche havere, che significa bramare qualcosa con impazienza e angoscia. E non può che essere così, quando si tratti di un individuo che, originariamente, ossia per definizione, non ha in proprio alcuna facoltà di comporre i propri desideri con quelli degli altri, orientati a loro volta allo stesso modo, e quindi da temere come ostacolo e minaccia. Non basta tuttavia ammettere, come molti fanno, che, sì, questa definizione dell’uomo economico è una caricatura che non si incontra nella realtà, che gli uomini reali agiscono in base a ordinamenti di preferenze più complessi, se poi, nello stesso tempo si continua a sostenere che tale definizione serve comunque a capire che cosa succede nei rapporti economici, nel mercato, che si tratterebbe insomma di un costrutto euristico. Ogni definizione, ogni categoria, che venga applicata all’uomo ha sempre effetti pratici, finisce sempre per produrre il proprio soggetto, grazie alle strategie politiche in senso generale, di politica economica e di indottrinamento pedagogico che ne vengono dedotte. Prima o poi 5 E’ sembrato utile riportare qui il testo di un intervento fatto da M. D. Contri il 19 aprile 2002 in un ciclo di conferenze dal titolo Il bambino: soggetto economico (dal suo punto di vista) presso il Corso di laurea in economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni nonprofit dell’Università di Bologna, sede di Forlì. Il titolo dell’intervento era: Il caso del bambino:quello in cui il pensiero dell'altro è acquisito in un'economia di vantaggio senza costi per nessuno. 6 Tale categoria venne enunciata nel saggio Sulla definizione di economia politica (1836), da J. S. Mill, filosofo ed economista inglese, interessato a definire l’oggetto dell’economia politica come “scienza mentale”. Secondo J. S. Mill l’economista deve isolare, rispetto alla globalitò degli usi, della moralità, delle regole di vita che orientano l’agire umano, i motivi economici, legati alla massimizzazione della ricchezza. 25 Il pensiero del figlio ogni definizione dell’uomo si trasforma nella teoria di una natura umana originaria, dimenticando, e facendo dimenticare, di esserne in realtà la costituzione. Da una tale definizione dell’uomo si deduce infatti anzitutto la definizione di una razionalità compiutamente umana distinta, e scissa, da quella dell’uomo economico, di per sé asociale, distruttiva anzi del legame sociale. Ma questa operazione ha un costo: si tratta di una razionalità cui si può pervenire solo rinunciando alla soddisfazione di un interesse personale, individuale. Il costo è dunque un costo logico: ci si viene a trovare di fronte al paradosso di una razionalità che può compiersi solo rinunciando a se stessa. Esisterebbero sì altre “sfere “ più “alte “, in quanto disinteressate, più umanamente degne nel senso di “integralmente” umane, secondo una scala di “sfere “ gerarchicamente ordinate, e non solo più alte, ma anche più libere, al costo tuttavia di un benessere individuale inferiore, sacrificato, compresso e inibito, al costo, in definitiva, di una rinuncia al principio stesso della soddisfazione e del benessere individuale. Esisterebbe per esempio un mondo fantastico, ma senza soddisfazioni reali, oppure esisterebbe la “sfera “ morale, dell’amore, o della solidarietà, tutte sfere per accedere appunto alle quali bisognerebbe rinunciare alla soddisfazione dell’ ”avidità”. La razionalità “superiore” è tale da non ammettere in alcun modo comportamenti “egoistici”. Anche la sfera economica troverebbe peraltro la sua perfezione solo sublimandosi, sollevandosi nella sfera del rigore della scienza che metabolizza la soddisfazione in utilità. La conseguenza logica più rilevante della teoria dell’uomo economico, il suo implicito, è la scissione tra un uomo definito come essenzialmente asociale e una socialità implicante rinuncia e sacrificio dell’individualità, contro cui si alimenterà quindi una perenne ostilità e conflittualità. Una conflittualità e un’ostilità che, ci insegna Freud, costituiscono il nucleo intorno a cui si sviluppa non solo ogni psicopatologia, ma ogni guerra e ogni altro orrore che tormenti la nostra civiltà. La verità è che il costrutto dell’homo oeconomicus si edifica sulle macerie del puer oeconomicus, sulla sua amputazione, sulla sua scissione. E' una tesi certo controcorrente, non solo rispetto alla teoria economica, ma anche rispetto alle svariate teorie psicologiche dominanti. Gli a priori sono sempre trasversali. Tutta la psicologia cognitivista, per esempio, è sostenuta dallo stesso presupposto, nonché quella di derivazione kleiniana. Se leggete Winnicott potrete con facilità ritrovare questo schema, trasversale tuttavia e comune agli approcci più disparati, Ma non c’è qui il tempo, e non è neppure la sede, di ripercorrere tutti i rivoli, apparentemente eterogenei gli uni rispetto agli altri, che percorre un’impostazione di questo genere nella filosofia, nella psicologia, nelle dottrine politiche, nelle teorie economiche, in quelle pedagogiche. Tra homo oeconomicus così definito e puer oeconomicus c’è la stessa distanza che Freud descrive in L’Avvenire di un’illusione tra l’intelligenza del bambino e la “relativa atrofia” dell’intelligenza dell’adulto medio. L’atrofia dell’homo oeconomicus è una e una sola cosa con l’atrofia intellettuale di cui parla Freud: “Pensi – dice Freud a un suo immaginario interlocutore - al deprimente contrasto tra la radiosa intelligenza di un bambino sano e la debolezza intellettuale dell’adulto medio” 7, una “relativa atrofia” di cui va attribuita la responsabilità all’educazione, alla modalità pedagogica, che mira progressivamente a far passare, il bambino, di farlo accedere, agli strati alti, del vivere, a una cosiddetta razionalità “integralmente” umana, inducendolo a una progressiva rinuncia al suo principio di piacere, al suo modo pacifico, il modo della partnership, di entrare in rapporto con la realtà come fonte di beneficio. 7 S Freud, L’avvenire di un’illusione, 1927, OSF, vol. 10, p. 474. 26 Il pensiero del figlio Dice il proverbio: “Al contadino non far sapere com’è buono il cacio con le pere “. E perché non ci sarebbe da farglielo sapere? Ma perché, lo sa già. Inutile organizzare corsi di formazione per insegnarglielo. Sarebbe certo plausibile fare corsi di formazione su come si fabbrica al meglio il cacio, su come darne notizia sulle reti commerciali per venderlo ecc. ecc. E così per le pere. Ma non certo su quanto è buono. E cosa vorrebbe dire insegnarglielo? Per esempio uno dei modi correnti a tutt’oggi sarebbe quello di dirgli “mangialo che ti fa bene “, insegnargli che mangiare il cacio è utile, perché contiene calcio, proteine, mentre le pere contengono vitamine, e che ciò fa parte della dieta mediterranea, ecc. ecc. Non che tutto ciò di per sé sarebbe sbagliato, ma lo è quando questi insegnamenti professionistici destituiscono, detronizzano, delegittimano il sapere, la ragione fondamentale per cui il contadino mangia il formaggio con le pere ed è che gli piace, gli dà gusto. Il contadino parte da un sapere del sapore, di cui ha piena competenza. La pedagogia trascina fuori il bambino, e il contadino, dalla sua competenza, alienandolo e mettendolo in balia di razionalità astratte da essa. E non solo nel contadino, ma nell’essere umano in quanto tale, il gusto, il piacere, la soddisfazione conseguente a una certa azione, è ciò che, nella normalità, assume la rappresentanza di ciò che è utile alla vita in quanto biologica. E, del resto, è un dato di comune osservazione, e non solo per chi occupi il posto di terapeuta, come, nella psicopatologia, una volta decaduto il principio di piacere, o di soddisfazione individuale, decada anche la ricerca dell’utile e la disponibilità a investire lavoro per accedervi. L’esperienza clinica insegna che quando un bambino viene trattato così - gli si dà da mangiare, gli si propinano tutte le cure di cui ha bisogno sulla base di criteri “alti”, per esempio scientifici -, quanto più tali presupposti saranno stati messi all’opera precocemente e sistematicamente, la conseguenza sarà l’autismo in età precocissima o l’anoressia al momento dell’adolescenza, due casi esemplari di catastrofe del puer oeconomicus. Ma tutta la psicopatologia va letta come crisi, quando non come catastrofe, del puer oeconomicus, tanto più devastante quanto più sistematica e precoce sarà stata la disdetta del principio stesso di piacere. Ben lungi dall’aver bisogno dell’intervento di razionalità aggiuntive per diventare capaci di rapporto, di socialità, è proprio in quanto sperimentiamo l’altro, e lo pensiamo, come tramite alla soddisfazione del corpo che lo amiamo, ci prendiamo cura di lui, lo rispettiamo, ci disponiamo al lavoro per averne la collaborazione. Nel puer oeconomicus il desiderio non è immediatamente rivolto a oggetti, a beni: il bambino opera anzitutto a mobilitare una risorsa inesauribile, l’eccitabilità in un altro del desiderio di soddisfare il desiderio del bambino per la propria stessa soddisfazione. L’agire economico del bambino è economico in quanto è regolato quindi da una forma del rapporto ad un tempo economica (mira come frutto a una meta di soddisfazione), morale, sociale e giuridico-sanzionativa (c’è soddisfazione solo se l’altro collabora liberamente per la propria stessa soddisfazione). E del rapporto con gli altri si giudica, ovvero si sanziona, evangelicamente, dai frutti, dal frutto della soddisfazione, individuale per definizione. Economico, morale, giuridico coincidono: l’offerta, prima che essere offerta di un bene, di un oggetto, è offerta di un desiderio che si fa domanda, e la domanda è anzitutto lavoro di eccitazione di un desiderio. Ora, che cosa produce, secondo Freud, l’interruzione dell’elaborazione del puer oeconomicus, che cosa interrompe l’ elaborazione della propria iniziativa come attività, come lavoro volto a ottenere la propria soddisfazione da un altro il cui statuto è quello di libero nel suo moto di risposta in quanto eccitato a rispondere per la propria stessa soddisfazione? E’ l’irruzione di una teoria non economica, ovvero di un ordine dell’esperienza in cui i rapporti non sono più regolati da un principio di beneficio. Irrompe la teoria antieconomica che Freud chiama fallica, antieconomica perché riduce l’economicità alla pura e semplice acquisizione di beni, astratta dalla forma del rapporto, che quindi deve essere imposta dall’esterno. 27 Il pensiero del figlio La teoria che Freud chiama fallica – la teoria secondo cui esiste un solo sesso, quello maschile – impedisce l’elaborazione dell’idea del rapporto sessuale come forma di rapporto economico in quanto volto a una soddisfazione senza scarti, senza perdita per nessuno dei due partner, anzi con profitto di tutti e due. Vi si sostituisce l’idea di un’interazione tra individui isolati e omogenei tra di loro, sottomessi a una ragione sociale proveniente da una fonte esterna ai partner. E’ un atto quello sessuale che potrebbe essere esemplare di come la messa a disposizione di un proprio oggetto per la soddisfazione di un altro possa essere di per sé eccitante e soddisfacente per colui che lo offre, e non solo per colui che lo riceve, senza dover fare concessioni ad alcuna oblatività, ad alcuna morale del dono, e dunque a nessuna rinuncia e a nessun sacrificio per poter entrare in rapporto. Ricordiamo come la tesi centrale di Freud sia che il disordine psichico e sociale incominci proprio nel punto in cui si entra nell’ordine di idee secondo cui si deve cedere sul principio di piacere per avere rapporto. Ad un certo punto irrompe, dunque, una teoria antieconomica, che riduce l’individuo a essere alle prese solo col bene di cui impadronirsi, costretto a considerare come fastidioso “laccio e lacciuolo”, come limite e impaccio alla propria azione, ogni pensiero che riguardi il rapporto. Mi auguro che prima o poi degli economisti riconoscano la teoria fallica come teoria antieconomica. Ed è una teoria che il bambino non elabora da sé, la incontra dapprima nei suoi altri. Rileggete, o leggete, Il caso clinico del Piccolo Hans in cui Freud ci racconta di una madre che dice al figlio di avere anche lei il pene. E’ una comunicazione che getta il bambino nell’angoscia, poiché fa sparire la pensabilità di un rapporto pacifico tra padre e madre come rapporto tra qualcuno che ha qualcosa da mettere al servizio di un altro per la propria e altrui soddisfazione, senza sacrificio per nessuno. Il bambino è allora indotto a pensarsi individualisticamente, come individuo originariamente, costituzionalmente isolato. Vengono così poste le premesse per l’introduzione alla teoria che “corpo” sia anzitutto organismo, grumo “avido” di bisogni e istinti e non, originariamente, questione di soddisfazione grazie all’apporto di un altro. Quella “fallica“ è una teoria che fa sparire l’idea stessa di rapporto in funzione di un beneficio nel gioco reciproco di domanda e offerta, una teoria che atomizza gli individui, sbarrando loro la strada a pensare al rapporto di un corpo con altri corpi in base a un principio di collaborazione. Ricevere un beneficio, o farne domanda, comincerà ad assumere il significato di una confessione umiliante di indigenza e povertà, erogarlo, invece un dono sacrificale sì, ma segno di appartenenza alla categoria dei ricchi, status symbol. A partire da essa, si introdurrà un principio di classificazione tra chi ha e chi non ha, un principio di gerarchia tra gli esseri umani che sarà fomite di rapporti invidiosi. Dove ciascuno verrà a collocarsi di fatto o nella posizione del povero o di chi può correre il rischio di diventarlo. Una teoria fomite anche della produzione dell’idea di risorse scarse, di guadagno per l’uno con costi per l’altro, all’insegna di un mors tua vita mea, che successivamente verrà recepita nella teoria “adulta “ come caratteristica dell’homo oeconomicus, anziché del non oeconomicus per definizione. Ma se così è, più che a regolare l’homo oeconomicus, ciò a cui si tratta di lavorare è al compimento della sua costruzione, come compimento del puer oeconomicus anziché come sua distruzione. 28 Il pensiero del figlio Puer politicus di Maria Gabriella Pediconi Può sembrare scandaloso riconoscere al bambino due proprietà come queste, di essere cioè ad un tempo oeconomicus e politicus, avendo non solo la capacità di un moto e di un’azione individuali in vista di un beneficio, ma anche di elaborare forme del rapporto a pieno titolo giuridiche. Eppure basta l’osservazione per constatare come il bambino agisca in modo da suscitare il desiderio dell’altro a collaborare alla sua soddisfazione e che ne sarà soddisfatto solo quando l’altro risponderà liberamente per la propria stessa soddisfazione. Il bambino è competente dei fondamenti di un ordine economico giuridicamente regolato. Ben lungi dall’idea di dover civilizzare il bambino, è semmai sulla distruzione del suo ordine che si erge una incivile civiltà, piena di diseconomie e di sopraffazione degli uni sugli altri. E’ la questione che Giacomo Contri poneva durante un dibattito a un eminente giurista italiano: «giudica ammissibile – non solo lessicalmente, ma soprattutto concettualmente – che nel trattare l’amore come rapporto giuridico e nel parlare di attività giudicante e sanzionatoria persino nel bambino noi asseriamo l’esistenza, in atto, di una normale, quotidiana attività giurisprudenziale e giurisdizionale di ogni soggetto umano, anteriormente al subentrare del giurista di professione?»8. Il bambino, in altri termini il soggetto umano in quanto tale, si definisce a partire dal riconoscimento della sua originaria competenza giuridica, ovvero fondativa dell’esperienza in quanto civile. Lo stesso Freud, nel Disagio della civiltà, descrive la vita psichica pari solo alla vita di una città, quindi come esperienza sociale e politica. E di una città come Roma – è il paragone di Freud – nulla di ciò che l’ha costruita nei secoli è definitivamente scomparso: accanto alle costruzioni recenti continuano a sussistere tutte gli apporti precedenti. Nessuno si permetterebbe di dire che Roma non era ancora pienamente Roma al momento della sua costituzione; ciò che fa di Roma una città è la sua fondazione, la sua costituzione. La sua forma civile è l’atto stesso della sua fondazione, atto iniziale e iniziante l’esistenza di una civiltà, inizio civile e politico, ovvero di governo di tutte le relazioni e di tutti gli atti che serviranno ad incrementarne la costruzione. Così per il soggetto, una volta costituito il suo statuto sulla legge del beneficio, ogni nuovo atto psichico sarà un atto da cittadino, poiché «nello psichico è possibile tale conservazione di tutti gli stadi anteriori accanto alla strutturazione finale»9. Ne verrà che ogni atto attesterà la costituzione iniziale e ne giudicherà i frutti acquisiti. Basta dire che l’uomo è un animale politico? A ben pensare questa formulazione non è un complimento, è piuttosto una teoria cavalcata dalla Kultur da secoli e secoli. Se animale, allora niente politica!Eppure la teoria direbbe che in nulla l’uomo si distinguerebbe dagli animali se non nella sua socialità sofisticatamente organizzata. L’organizzazione estrema, alfine, sembrerebbe ciò che in fondo contraddistingue la civiltà umana da quella … delle api! Chi ha conosciuto i bambini, per esperienza sa che un bambino è quanto di più lontano c’è da un animale e non per un fattore di organizzazione, ma per la competenza a vivere e “cavalcare” tutte le relazioni al fine della propria e altrui soddisfazione, competenza politica in piena regola, degna del trono regale, se del caso. Cavalcare – in inglese rise – come atto di interessamento e lavoro, convincimento e preparazione affinché l’altro ci si metta, ci metta 8 AA.VV (a cura di Carlamaria Zanzi), L’esperienza giuridica. Istituzioni del pensiero laico, SicEdizioni, Milano 1999, p. 94. 9 S. Freud, Il disagio della civiltà, 1929. OSF, vol. 10, p. 564. 29 Il pensiero del figlio del suo per arrivare al beneficio, sostenendo la relazione. 1. I figli, i bambini chiedono la bussola Anzitutto una premessa: non possiamo trattare i due termini, “figlio” e “bambino”, automaticamente come sinonimi, dobbiamo specificare il nesso. Il bambino è un individuo piccolo di statura, che ha pochi mesi di vita o qualche anno di età, che pensa, sa cosa vuol dire riuscire e sa creare rapporti per raggiungere una meta e stare bene. Ma il bambino è anche figlio, così come è figlio un adulto, ed è lo statuto giuridico di figlio a essere il nucleo fondante di ogni e qualsiasi partnership. A questo punto facciamo un passaggio logico favorito dall’osservazione: nella nostra esperienza, anzitutto personale, possiamo accorgerci che per i bambini è più facile, viene facile – la facilità è una grande risorsa – stare al posto di figli. Dire a un adulto “sei figlio di” può non risultare simpatico, può suscitare degli affetti non sempre positivi, mentre dire a un bambino “sei figlio di tuo padre, di tua madre” è un’attestazione giuridica. Il bambino vive più facilmente dell’adulto del pensiero dell’eredità. Che abbia una settimana di vita, un minuto di vita, o abbia già raggiunto i cinquant’anni, ai fini dell’eredità è perfettamente indifferente: ormai l’erede è lui e tutti gli altri, tutto il mondo dovrà tenerne conto. La facilità dei bambini a stare al posto dei figli possiamo anche dirla così: i bambini ci chiedono la bussola. Perché? Qual è il pensiero del figlio? Nella posizione del figlio, il bambino associa volutamente, praticamente, fattivamente, effettivamente un altro al proprio pensiero. La posizione del figlio è quella posizione giuridica in cui il soggetto – abbiamo già detto che non conta l’età, ma la posizione in quanto giuridica e psichica - annette volentieri un altro al proprio agire e al proprio pensare. Quindi dal posto del figlio si costruisce l’idea di lavoro come lavoro a due posti10. Uno dei punti cardinali della bussola giuridica consiste proprio in questo associare un altro al proprio pensiero come lavoro, nel suo procedere concludentemente verso la soddisfazione. Ma occorre una precisazione. Quando diciamo che i bambini ci chiedono la bussola potremmo essere tentati dall’idea che mette gli adulti nella posizione esclusiva di chi dà, secondo uno schema a due piani: sopra c’è l’adulto che si prodiga nel dare e sotto c’è il bambino che, seppur volentieri, è il solo a ricevere. In questo schema, alla lunga, entrambi i piani si rivelano estremamente scomodi. Ci si può chiedere: come mai per l’adulto non è più così facile stare nel posto del figlio, di chi cioè riceve, di chi associa il lavoro di un altro al proprio lavoro per la propria stessa soddisfazione? Ecco una prima scoperta: i figli, i bambini ci chiedono, o meglio, portano allo scoperto quanta bussola resta agli adulti che stanno in loro compagnia. Lo dimostrano, lo mettono in piazza, lo fanno vedere: lo vedono tutti se un insegnante “ci sa fare oppure no con questo o quello scolaro”, se un insegnante o un adulto si sa orientare rispetto ai bambini. Spesso gli adulti sono messi in difficoltà dai bambini, dal pensiero, dall’orientamento sano, giuridico, dei bambini. Gli adulti sono in difficoltà con i bambini, o meglio, sono messi in difficoltà dal fatto che il rapporto con i bambini mette in mostra la loro nevrosi, ossia l’insufficienza della loro bussola, il loro non disporre agilmente del proprio orientamento. I bambini con i loro moti ci interpellano e ci costringono ad annotare quanto noi non ci sappiamo più fare con le cose della vita. E l’adulto messo con le spalle al muro che farà? Nella sua posizione di maggiorente, potrà preferire di non ammettere il fatto di essere stato 10 La vita psichica, non del bambino ma a partire dal bambino, è una vita giuridica, economica, politica: egli pensa e opera per un proprio fine soddisfazione secondo una norma in cui l’Altro è cooptato come partner e mezzo di tale fine. Per ottenere la partnership, il bambino compie ogni possibile atto di propiziazione dell’Altro, ossia gli dà soddisfazione. (cfr. AAVV, Aldilà il corpo, SicEdizioni, Milano 2000). 30 Il pensiero del figlio messo in difficoltà dal pensiero del bambino e, adottando la via più breve, arriverà fino ad accanirsi con la salute psichica del bambino mettendola in dubbio. 2. Il “caso” di Giulia Annotiamo. Un insegnante a scuola non tratta La classe bensì tratta con Francesco, Paolo, Anna, insomma con ciascuno. A prima vista sembrerebbe una questione che riguarda l’insegnante, più che il genitore. Come insegnanti ci ritroviamo spesso in difficoltà quando ci mettiamo a fare i discorsi su La classe: non solo, infatti, facciamo un’operazione di astrazione quando diciamo“questa classe va male”, ma ce ne dichiariamo anche sconfitti. Solo quando il trattamento è trattamento di uno per uno è possibile per l’insegnante l’idea di un certo successo, di una certa soddisfazione, di un certo lavoro per il beneficio. Tuttavia, il trattamento uno per uno e, quindi, l’esperienza del beneficio, della soddisfazione, sono possibili sia per il genitore che per l’insegnante solo a condizione che ci si orienti con quella bussola giuridica che ha il suo cardine nella posizione di figlio, e non sulla base di teorie generalizzanti. Giulia è una bambina di quattro anni che frequenta la scuola dell’infanzia. È decisamente a modo, carina, di quelle bambine di cui si potrebbe dire tutto il bene. Sa il fatto suo. Le maestre sono messe in difficoltà da qualcosa che la riguarda, così convocano la mamma. A questo punto Giulia diventa … il caso di Giulia. Viene così alla ribalta l’ordine delle relazioni in cui essa è implicata. Neppure nel caso dell’autismo possiamo completamente escludere l’influenza dell’ordine delle relazioni in cui il bambino autistico è preso. Lavorare con i bambini, con i ragazzi, con gli adulti diventa subito lavorare con gli ordini di relazione in cui essi sono implicati. La difficoltà delle maestre sta nel fatto che la bambina non si lascia educare facilmente. L’episodio incriminato riguarda una festa di compleanno. Nella classe vige la regola per cui se è il compleanno di un bambino, tutti realizzano un disegno e lo regalano al festeggiato. Giulia si rifiuta di fare il disegno, disobbedendo quindi alle regole della classe. Forse non ne ha voglia, oppure la festeggiata non le è simpatica: potrebbe avere dei motivi personali per non disegnare. Eppure la maestra insiste, si accanisce; Giulia cerca di svincolarsi e chiede di andare in bagno, temporeggia, rinvia, “ci prova”. L’insegnante le nega ogni diversivo, ottenendo il disegno con l’imposizione. La maestra ha fatto il suo mestiere, Giulia il suo, fin qui ordinaria amministrazione, fin qui non c’è problema o disagio. Eppure la maestra comincia a parlare della testardaggine di Giulia come di un problema, come di un tratto negativo del cosiddetto carattere. La bambina poteva avere buoni motivi per non disegnare; capita a tutti di temporeggiare circa le richieste di un altro, per poi decidere alla fine di soddisfarle. Invece, nel pensiero della maestra di Giulia l’episodio diventa l’inizio di un problema: comincia a chiedersi se la bambina non soffra di un qualche disagio che emergerebbe nei suoi comportamenti, fino a convocare la madre per dirle che “Giulia si isola”. L’espressione “si isola” la maestra l’attinge a teorie pedagogiche correnti più che non all’episodio realmente accaduto. Giulia infatti non si era affatto isolata, né rispetto alla maestra – aveva semplicemente provato ad evitare un compito non gradito –, né rispetto all’altra bambina - stava forse solo esprimendo un suo preciso parere su di lei. E poiché l’insegnante segnala alla mamma un problema, la signora comincia a preoccuparsi. Assumendo le parole della maestra senza alcun filtro, si fa preoccupare dalla maestra. Inoltre la maestra aggiunge, come segnale di isolamento, il fatto che la bambina si ciuccia la mano, non esattamente il dito, ma la mano, una parte della mano. A questo punto 31 Il pensiero del figlio la mamma si allea con la maestra e aggiunge una specie di spiegazione del ciucciare la mano: è una reazione a una precoce proibizione. Da piccola la bambina ciucciava continuamente il dito e la madre glielo impediva tenendo a forza il dito lontano dalla bocca. Successivamente la bambina aveva ripreso a ciucciarsi la mano senza farsi vedere. Si trattava di un compromesso rispetto alla proibizione materna: “non ciuccio il dito, ciuccio la mano”. La maestra propone dunque questi nessi: il ciucciare la mano sarebbe lì a dimostrare la chiusura in sé, confermata dal fatto di essere testarda, e inoltre anche da un altro fatto, di non fare subito amicizia. Ma cosa può voler dire fare “subito” amicizia? Come se si trattasse di un automatismo, di una reazione fisiologica alla vicinanza, come tra due cani che si annusano e scodinzolano. Effettivamente è piuttosto diffusa l’idea che i bambini “piccoli” facciano amicizia con tutti, o anche che bisogna “educarli”, al “dovere” di essere amici di tutti. Ecco una concezione che allontana il fare amicizia dall’ordine giuridico del costituire rapporti di soddisfazione. Ma nel caso di Giulia non si tratta affatto di isolamento: la bambina si prende il suo tempo prima di cominciare a parlare e a giocare con coetanei, specialmente se ancora sconosciuti. Se lei entrasse in questa stanza adesso, starebbe due ore a guardare, alla fine farebbe la sua scelta e andrebbe da tizio a chiedere una cosa. Ecco una condotta che evidenzia un pensiero giuridico: tempo, scelta, competenza. Non è vero che vanno bene tutti! La verità è che le insegnanti sono quasi disorientate dal fatto che la bambina non sia esuberante e quindi subito da “bloccare”, cui dare degli alt come ad altri bambini della sua età considerati “normali” – bloccare è spesso un sinonimo di educare. I bambini esuberanti sono facili da stoppare. Invece un bambino “che sa il fatto suo” potrebbe farci venire in mente che non sappiamo cosa fare, che anzi è lui a “isolarsi”, potrebbe disorientarci, mettere in crisi lo schema pedagogico che classifica come esuberanti, e quindi da “educare” nei loro moti, i bambini piccoli. E’ una generalizzazione che diventa teoria presupposta. Questo caso non rappresenta una vera e propria psicopatologia, né infantile né degli adulti, in quanto gli insegnanti e i genitori in questione si sono limitati a fare le loro osservazioni senza intervenire direttamente sulla bambina. Colpisce tuttavia il modo di organizzare le osservazioni a partire dalla teoria pedagogica secondo la quale il rapporto col bambino è educativo e non giuridico. E quando i comportamenti dei bambini li mettono in difficoltà, gli adulti, piuttosto che elaborare soluzioni soddisfacenti con quel particolare bambino, ricorrono a schemi pedagogici impersonali con cui problematizzare i comportamenti infantili. Perché ci facciamo mettere in crisi dal fatto che ognuno è a modo suo? Quando un bambino ci implica a modo suo, noi sfuggiamo dal rispondere in modo altrettanto personale. Cosa contiene questo disorientamento degli adulti? Anzitutto dice che c’è stata una crisi e che l’orientamento iniziale, l’orientamento della posizione di figlio, è caduto in disgrazia. E se nel bambino la crisi può manifestarsi con segnali di vero e proprio disagio e angoscia, negli adulti ne troviamo più spesso un mascheramento per mezzo dell’adesione a teorie pedagogiche o ad astratte filosofie di vita. Adesione che camuffa la crisi e si oppone a qualsivoglia correzione degli errori. Tale adesione alle teorie presupposte connota del resto tutta la psicopatologia. 3. La teoria dell’amore presupposto e la crisi del pensiero giuridico Per rimanere nella descrizione di come in molti casi sia proprio la salute, o normalità, che si orienta con una bussola giuridica, facile per il bambino, a mettere in difficoltà l’adulto, in quanto, lui, si è dis-orientato, prendiamo in esame alcuni stralci di un altro caso. Si tratta del caso, trattato da Freud, noto come Il caso del piccolo Hans. I genitori del piccolo Hans sono messi in difficoltà, fino a provocare la malattia del 32 Il pensiero del figlio figlio, dalla sua richiesta di prendere posto nella sua elaborazione della relazione d’amore Non solo, infatti, non sono in grado di affiancare l’elaborazione del bambino, contribuiscono anzi a smentire l’ordine giuridico del pensiero stesso, secondo cui quel soggetto già si regolava. Hans, bambino di quattro anni, è interessato a varie cose tra cui il “fapipì”. Attraverso questo organo scopre le differenze tra materia animata e inanimata, tra uomini e donne, introducendosi alle cose del mondo. Sta costruendo la sua enciclopedia, come dire: sta prendendo la sua prima laurea, quella che si ottiene entro i primi cinque anni di vita! Certo, lui non sa dell’esistenza di Einstein; però possiamo ammettere che ai bambini non serve sapere di Einstein, il loro intelletto lavora benissimo ugualmente. Le nuove conoscenze, i nuovi saperi forniscono al pensiero un arricchimento. Il pensiero procede di arricchimento in arricchimento, fintanto che non inciampa nella crisi. Quando Hans è arrivato ormai quasi alla conclusione circa la questione di chi ha o non ha il fapipì e ne chiede conferma alla mamma, la mamma risponde che lei ce l’ha: la sua costruzione subisce un terremoto che lo getta nell’angoscia. Secondo attacco al buon ordine del suo pensiero: una sera Hans, che ha conosciuto delle nuove amiche, dice alla mamma che ha preparato il pigiama e che andrà a dormire dall’amica. La mamma è in difficoltà: non vuole mandarlo. Cerca di fermarlo, ma non è facile. Non è facile educare i bambini: se pratichiamo il rapporto con loro come rapporto educativo ci danno filo da torcere e hanno ragione. La madre, dopo aver provato a dire al bambino di non andare, usa, e non una sola volta, la frase: “Ma tu davvero vuoi lasciare la tua mamma?!”11. Hans resterà segnato: è stata introdotta nel suo pensiero l’alternativa, sconosciuta fino a quel momento, tra l’affetto per l’amica e l’amore per la mamma. Nell’amore in senso giuridico, nella partnership, non c’è alternativa, opposizione, tra un partner e l’altro, c’è preferenza. Invece questa frase pretende per la mamma una posizione assoluta, idealizzata, astratta, come nella frase corrente “la mamma è sempre la mamma” oppure “nessuno ti vorrà mai bene come la mamma!”. Amare la mamma comincerà a voler dire amare la mamma invece che l’amica oppure diversamente dall’amica: così da adulti ci si può trovare a giustificare di amare ciò che della mamma si ritrova nel partner o nella partner. La cosiddetta psicologia dello sviluppo afferma che dopo l’adolescenza la famiglia non conta più niente: che fortuna! Al contrario l’esperienza ci dimostra che, una volta assolutizzati e idealizzati i genitori, neppure con l’analisi ci si dispone a rintracciarne gli errori. Nei casi più fortunati occorre molto tempo per togliere dall’idealizzazione i genitori: in fondo i genitori si tratta solo di onorarli – in senso biblico – in giudizio. E giudicare vuol dire riconoscere il posto che hanno avuto, tra altri, nell’introdurci a certe teorie. La mamma del piccolo Hans passa al figlio una precisa teoria dell’amore: “La mamma è sempre la mamma”. Hans ha smesso di pensare sua madre come una donna, donna di un uomo, di un partner; come una donna cioè capace di associare al proprio lavoro per la soddisfazione il lavoro di un altro, di volta in volta secondo preferenza. Il figlio non ha potuto quindi più pensare alla sua relazione con lei come ad una partnership, ha cominciato a fantasticare una relazione esclusiva, in cui Lamamma – lo scrivo volutamente così - è diventata un feticcio, un’astrazione. La parola stessa amore è diventata un’astrazione, mero 11 Freud riporta così il dialogo raccontatogli dal padre di Hans: “Hans: - Allora vado giù a dormire con Mariedl. “Mamma: - Vuoi davvero lasciare la mamma per andare a dormire giù? “Hans: - Bè, ma domattina torno su per fare colazione e andare al gabinetto. “Mamma: - Se vuoi proprio andare via da papà e mamma, prenditi giacca e calzoni, e addio! “Hans prende veramente il vestito e va verso la scala, per andare a dormire con Mariedl. È ovvio che lo riportiamo in camera”. In Analisi della fobia di un bambino di cinque anni (Caso clinico del piccolo Hans), OSF, vol. 5, pp. 489-90. 33 Il pensiero del figlio assoggettamento senza contenuto di soddisfazione reciproca, amore pre-supposto a qualsiasi contenuto. Del resto la teoria del determinismo psichico di tutta la psicologia cosiddetta scientifica poggia su Lamamma! C’è del vero! Il rapporto con lamamma ti condiziona per tutta la vita - a meno che non ti riesca di giudicarne -, deviandoti dal pensiero stesso della meta di soddisfazione! Le mamme potrebbero tornare a chiedere di essere trattate da donne: sarebbe una richiesta rivoluzionaria! Nel caso del piccolo Hans il contributo materno alla patologia di Hans viene peraltro sostenuto e incrementato dalla complicità del padre che rimprovera sua moglie di un errore impossibile, quello di amare troppo il suo bambino; le coccole indurrebbero al vizio. La teoria paterna secondo cui l’amore come seduzione, come capacità di se-durre, di condurre un altro con sé sarebbe sbagliato, toglie l’uomo dalla posizione di partner di quella donna: entrambi si tolgono, dalla posizione di uomo e donna per entrare nel ruolo di genitori, babbo e mamma, ponendosi sul piedistallo dell’idealizzazione astratta. 4. La riuscita scolastica Quanto è stato detto fin qui, circa le relazioni tra bambini e insegnanti, bambini e genitori, genitori e insegnanti, ha una certa ricaduta sulla riuscita scolastica. La riuscita scolastica dipende, infatti e anzitutto dalla riuscita del pensiero dell’eredità, dalla bussola iniziale. Se anche i genitori non avessero nessun rapporto con la scuola, si potrebbe ipotizzare una netta separazione tra due mondi: scuola da una parte, genitori da un’altra? Davvero i genitori potrebbero considerarsi fuori dal mondo della scuola? No, perché la continuità tra scuola e famiglia la fa il figlio12 Quindi i genitori non si possono togliere dall’esperienza dei figli, così come i figli non si possono togliere dall’esperienza dei genitori. E’ il figlio a fare la cosiddetta continuità educativa in quanto vive sia il rapporto giuridico con sua madre e suo padre, sia quello con le sue insegnanti e i compagni. La riuscita stessa è iniziale. La riuscita è già il fatto che un individuo ponga la propria costituzione, è la riuscita di un individuo che si muove, che si muove a conclusione, che diventa capace di rapporto, poiché nell’uomo il rapporto è il mezzo per concludere, è il mezzo per star bene. Un individuo che riesca in questo, e questo accade fin nei primi mesi di vita, è uno che sa cosa vuol dire riuscire. Vi propongo, come esemplificazione, un’intervista, di circa un anno fa, alla figlia più giovane della nota famiglia Missoni. La giovane riconosce con gradimento che grazie al nome che porta e che lei non cerca di nascondere può essere favorita, sa bene che l’introduzione alla realtà del mondo passa per il fatto di essere una Missoni, compresa la possibilità di partecipare ad un ballo mondano a Parigi. Eppure lei stessa ricorda che a scuola la riuscita non le è stata facile, soprattutto a causa di un pensiero ricorrente: “Li deluderò?” ad ogni interrogazione: ”Li deluderò?” Chi? “I miei genitori: i Missoni!” La riuscita – ci viene da pensarla come una strada spianata per una Missoni – sembra dover passare per la porta stretta dei partner iniziali. Un pensiero di delusione nei loro confronti comporta il dubbio di non essere all’altezza, una specie di crisi, una pesante esitazione rispetto al successo. Sarà bene tenere conto che la riuscita scolastica è solo una delle forme della riuscita 12 Questa tesi pone una novità rispetto alle definizioni pedagogiche che insistono sulla continuità educativa orizzontale come contatto tra istituzioni. C’è una prima città, prima rispetto alla città delle istituzioni, in cui, giuridicamente parlando, viene privilegiato l’ordinamento del figlio. 34 Il pensiero del figlio nella vita. Se l’insuccesso scolastico mette in crisi l’idea generale della riuscita, si introduce la falsa corrispondenza tra fallimento scolastico e fallimento esistenziale. Mentre le teorie pedagogiche correnti considerano la riuscita scolastica come rappresentativa dell’autostima, capita sovente di osservare che fino alla scuola primaria i bambini vanno volentieri a scuola, anche se non prendono tutti voti ottimali. Se uno viene bocciato, può mantenere l’idea di riuscire nella vita oppure tale idea è per lui compromessa? Si può mantenere l’idea di riuscita nella vita se la bocciatura è la sanzione ad un lavoro mancato: in questo caso anche la bocciatura può diventare una buona notizia, un diritto. Ci sono ragazzi che si comportano in modo tale da provocare la bocciatura, ricorrono a mezzi estremi per ottenere un rimedio estremo. Per un ragazzo che sta perdendo tempo, che sta perdendo la bussola, la bocciatura può permettere un ri-orientamento individuale: è una sanzione che può interrompere quel meccanismo provocatorio della coazione a ripetere. La possibilità di riuscire consiste, infatti, anche nella possibilità di essere sanzionati per i propri atti. La sanzione è un altro dei punti cardinali della bussola giuridica. L’atto vuole la sanzione, anzitutto premiale. Così i bambini, i ragazzi, vogliono essere sanzionati per il loro lavoro; se ai loro atto non segue alcuna sanzione c’è disorientamento, poiché proprio la sanzione dà la possibilità di associare un altro al proprio atto per portarlo a conclusione. Una madre che non punisse un comportamento che ritiene sbagliato, lasciando sospeso il giudizio, magari mostrandosi solo imbronciata, non permetterebbe la conclusione stessa dell’atto, favorendo la crisi. La sanzione, premiale o penale che sia, dice che si può ricominciare di nuovo perché l’atto si è concluso. Sanzione, giudizio, soddisfazione sono sinonimi per la vita psichica come vita giuridica, fin da bambini. La sanzione onora l’atto e costruisce relazioni civili. Il racconto di Oscar Wilde dedicato al Gigante egoista ci mostra molto bene questo passaggio di civiltà: l’uomo incattivito chiude il giardino ai bambini ovvero a tutti gli altri che ne fruivano per il solo fatto che fosse a disposizione. I bambini non si rassegnano e continuano ad aspettare che la rigidità ceda all’insistenza, una rigidità apparentemente troppo fredda per lasciar passare il minimo argomento di apertura. L’apertura arriva, ma di soppiatto, una bambina ha fatto una breccia nel muro di cinta del giardino che ricomincia a vivere, uscendo dal troppo prolungato letargo. Anche il gigante è stufo di tanto gelo, ma ancora non si lascia provocare dal gusto della compagnia. Guarda i bambini contenti e li invidia, in preda alle proprie stesse asperità, finche non vede, lontano, un bambino che si dà un gran daffare per approfittare di un albero del giardino, senza riuscirci. In quel momento il gigante pensa di poter essere utile, da quanto tempo non pensava di poter essere utile per qualcuno, di poter mettere una sua qualche mossa al servizio di un altro! Aiuta quel bambino a salire sul desiderato albero e il bambino … lo ringrazia! Il gigante è vinto: ormai tutti lo tenevano a distanza, intimoriti, tutt’al più riverenti, mentre quel bambino l’aveva trattato bene, lo aveva addirittura ringraziato. Cade il castello di carta dell’invidia e l’uomo si risolleva dall’abbrutimento, torna ad aprire le porte a tutti i bambini, agli altri, specialmente vorrebbe la compagnia di quel bambino che gli ha fatto tornare alla mente che poteva avere soddisfazione mentre ne dava ad un altro. Il ringraziamento, la sanzione premiale, è stata l’occasione di una nuova nascita psichica, è stato un atto politico che ha riaperto le porte ad un nuovo ordinamento universale: il giardino inaccessibile torna a fiorire e a portare frutti. Non una intenzione aggiunta ma la mossa stessa di un soggetto che tratta un altro secondo la legge del proprio beneficio e ne fa un principio civile in grado di rimettere in modo antiche civiltà ormai sotterrate. 35 Il pensiero del figlio Après moi le déluge di Raffaella Colombo Introduzione Il titolo scelto per il Corso suggerisce un’idea di educazione che si muove intorno al concetto di figlio e ci pone di fronte a un’alternativa. O educhiamo figli in quanto eredi (generati), o educhiamo figli in quanto definiti dal loro essere biologicamente tali (fatti, procreati). L’alternativa è ingente e carica di conseguenze. Il figlio biologico non è automaticamente un erede. Infatti, eredità rinvia a paternità (sia di uomo che di donna presi nell’esercizio della funzione paterna, quella di generare un figlio): erede è chi entra legittimamente in possesso di un capitale, dove l’accento è posto non tanto sull’entità e qualità del capitale, bensì, e anzitutto, sulla legittimità del possesso. Educare un erede significa renderlo capace di trattare con profitto il capitale ricevuto. Educare un figlio in quanto definito dalla coppia di termini mamma-bambino significherebbe invece avviare qualcuno all’amministrazione e all’incremento di beni ai quali non potrà mai avere accesso, non possedendo i titoli per farlo. Sarebbe una contraddizione, un’impresa destinata a produrre attivamente l’invidia. L’alternativa non è fittizia. Sappiamo che il pensiero del figlio, che almeno in un primo tempo ogni individuo possiede, è contrastato, persino negato. L’ignoranza attiva della competenza individuale di pensiero, in quanto pensiero di figlio, attacca il pensiero con ogni mezzo culturale, anzitutto con l’educazione. “Maleducare”: il trattamento patogeno del pensiero È notorio che il momento dell’entrata nella scuola materna segna un passaggio decisivo per la vita di rapporti del bambino e dei suoi famigliari. Un momento desiderato ma anche temuto. Il bambino viene confrontato con le richieste che la scuola pone e le eventuali difficoltà che egli mostra vengono notate e segnalate. Al più tardi a partire dai due-tre anni, il bambino agisce come i grandi, dice quello che pensa – dice anzitutto di essere grande -, si muove autonomamente e con notevole disinvoltura. Anzi, si muove con una disinvoltura tale da stupire spesso gli adulti. Ma a questa età viene meno l’indulgenza che l’adulto gli riservava da piccolo/bisognoso delle cure ausiliarie proprie del periodo che precede lo svezzamento. E hanno inizio i primi attacchi sferrati contro il suo pensiero. Sono attacchi che rimangono impressi nella memoria individuale come ricordi confusi di offesa inammissibile, dispiacere e angoscia di perdere l’amore dell’altro. Le conseguenze immediate sono le reazioni eccessive del bambino, che appare cambiato: timido, impacciato, rallentato, suscettibile o, al contrario, oppositivo, impreciso, irritabile, irrequieto. Le conseguenze a lungo termine potranno assumere, dopo la pubertà, i tratti di una patologia psichica dichiarata. Ci si può dunque immaginare che cosa accadrebbe, se l’iniziativa del bambino venisse osteggiata nel periodo precedente lo svezzamento. Quando gli attacchi al pensiero hanno luogo prima dei due-tre anni, in un momento cioè in cui il bambino non parla ancora, non mangia autonomamente, non cammina, ma è completamente dipendente dal buon volere dell’altro, allora è la crescita stessa a esserne compromessa. L’individuo agirà a prescindere dal rapporto con l’altro. Mangiare, espellere e ritenere, udire, vedere, parlare, persino 36 Il pensiero del figlio dormire, saranno moti del corpo che si rendono autonomi dal rapporto, dunque dall’iniziativa del soggetto, dall’investimento su un partner, dalla meta di soddisfazione e arricchimento. La psicopatologia precoce è proprio quella forma di patologia psichica che, avendo avuto inizio prima dei due-tre anni, fa di un soggetto che normalmente si muove per profitto un soggetto che non prende iniziativa, anzi che evita e persino osteggia quella altrui. Ne fa un soggetto che, invece di muoversi per scendere in piazza, rimarrà alla finestra…a controllare il movimento altrui. Bisogna infatti tenere presente che anche nella più grave forma di patologia psichica, l’individuo non si muove al di fuori del rapporto. L’altro è costantemente presente, ma come nemico, come ostacolo da evitare. Ecco perché l’autismo è propriamente umano. Una tragedia dell’umanità. Aborto post-partum. Un esempio. Frieda Prima di procedere, vi illustro tramite un esempio il modo in cui l’individuo difende il pensiero – che, ripeto, è pensiero della legge di moto del corpo (umano), è il dispositivo mediante il quale l’uomo si muove, lavora e intrattiene rapporti, mangia parla dorme ecc. – e vi illustro i costi, che in certi casi possono diventare ingenti, di tale difesa per la vita psichica. Costi che in tal caso nella scuola vengono registrati come insufficienza di profitto, difficoltà di apprendimento, ritardo scolastico, disattenzione, irrequietezza o passività. L’esempio riguarda una bambina di cinque-sei anni alla quale era stata disconosciuta la facoltà di pensare, persino di udire e vedere. Di fatto, a scuola – l’ultimo anno di scuola materna-, si comportava come una sordomuta. Conobbi Frieda nei miei primi anni di attività professionale, quando lavoravo in un Servizio itinerante di Diagnosi e Trattamento psico-pedagogico precoce (in Svizzera, nel comprensorio delle Tre Valli subalpine di lingua italiana del Canton Grigioni). Mi prendevo allora cura di bambini in età prescolare (da 0 a 6 anni), incontrando i loro genitori, gli insegnanti, i pediatri e tutti coloro che in caso di difficoltà di crescita in un bambino si trovano coinvolti. Fu proprio il lavoro con Frieda a spingermi verso la decisione, che da tempo meditavo, di occuparmi della psicopatologia del bambino. Frieda era una bambina che fin dall’inizio della frequenza della scuola materna si era mostrata piuttosto passiva. Ma da alcuni mesi risultava eccessivamente apatica: parlava pochissimo, si sottraeva alle attività proposte e, molto spesso, si distendeva a terra a occhi aperti, muta e irremovibile. L’unica attività che svolgeva era il disegno. I suoi erano disegni in cui ripeteva il medesimo motivo, senza variazione: casa, cielo, prato, fiori, bambina. Le insegnanti della scuola materna avevano segnalato un possibile ritardo evolutivo e avevano chiesto di rinviare di un anno l’inizio della scuola elementare. L’esclusiva e ripetitiva attività pittorica della bambina ne era uno degli indici. Ero stata interpellata per una valutazione di maturità scolastica e la vedevo una-due volte alla settimana. Nel frattempo, avevo saputo che la sua nonna materna era morta da un anno circa. Era stata uccisa una notte, in casa sua, dal nipote tossicomane, per furto. La bambina apparentemente non sapeva dell’omicidio. Sapeva solo che la nonna era morta nel sonno, come spesso accade alle persone anziane. Famigliari e insegnanti avevano cercato di non fare trapelare nulla dell’accaduto e sembrava che fossero riusciti nel loro intento. Inizialmente, durante gli incontri con me, Frieda non parlava, non aveva niente da dire e niente da fare. Stava distesa a terra preferibilmente dandomi le spalle. A volte disegnava. Componeva sempre il medesimo motivo, come già le maestre mi avevano comunicato: casa, prato, fiori, bambina. I suoi disegni sembravano fotocopie a colori con un’unica variante: la 37 Il pensiero del figlio neve, che di volta in volta cambiava colore, rosa, arancione, rossa, e che Frieda disegnava con particolare attenzione e cura del dettaglio. Fu proprio quel particolare a colpirmi. Perché mai un bambino, a un certo punto, giunge a disegnare quello che nella psicologia evolutiva viene descritto come “disegno infantile” tipico? Come accade cioè che il bambino, dopo i primi anni di scuola materna, smetta di disegnare quello che gli va e faccia solo quei disegni che ogni insegnante vede da generazioni? E perchè Frieda, nella sua produzione mediamente nella norma, introduceva senza eccezione quel particolare di cui curava particolarmente forma e colore? In quegli anni iniziavo la mia formazione freudiana. Conoscevo il significato del particolare che balza all’occhio o all’orecchio in quanto non c’entra, e sapevo coglierlo. Ecco, nei disegni di Frieda, c’era un corpo estraneo. La invitai svariate volte a parlarmene. Sbagliavo. Infatti, ritengo a seguito della mia insistenza, la neve sparì dai disegni della bambina, o meglio, di volta in volta veniva raffigurata come stelle, coriandoli, pioggia. Il colore era passato dai toni del rosso a quelli del blu. Frieda cercava di distogliere la mia attenzione dalla “neve rossa”, ma non riusciva a evitare di disegnare quel particolare stonato. Il fatto attirò ulteriormente la mia attenzione. D’improvviso, un giorno, alla mia domanda: “Chi c’è dentro la casa?”, avvenne una svolta sbalorditiva. Frieda mi guardò e senza una parola eseguì con estrema velocità e scioltezza una serie di disegni, circa dieci, ciascuno dei quali rappresentava una scena d’interno. In successione, disegnò una donna a letto che dorme, un uomo che entra in casa, l’uomo vicino al letto, il letto insanguinato, l’uomo che esce di casa, del sangue dappertutto, l’uomo dietro le sbarre, la nonna morta nella bara, un buco nella terra, una tomba con una croce sopra. Solo a quel punto si fermò e con un sospiro disse: “Ho finito”. Era evidentemente che la bambina sapeva tutto, ma sapeva pure che doveva non sapere. I genitori mi avevano dichiarato che Frieda era stata tenuta all’oscuro dell’accaduto e, visto che era piccola, di sicuro non aveva colto la verità dei fatti. Ciò l’aveva posta in una condizione di conflitto tale da renderla estranea a ogni rapporto, fino a ridursi all’isolamento. Da quell’episodio in poi, ascoltandola, stando al filo delle sue domande, rispettando i suoi silenzi - spesso tornava ai suoi disegni-copertina/copertura -, riprese a esercitare il suo pensiero e l’iniziativa. Una questione in particolare era rimasta senza risposta e occupava la sua attenzione: dove si trovava la nonna ora che era morta? Un giorno mi disse: “Non so dove disegnare la nonna: adesso è in cielo, ma è nella bara sottoterra”. Noi tutti ci siamo imbattuti nella questione che impegnava Frieda. La spiegazione che i bambini ricevono in caso di morte di una persona cara non è affatto soddisfacente: il fatto che “la nonna sia in cielo, mentre è chiaro che la nonna è sepolta al cimitero” è una contraddizione e tutti i bambini che hanno avuto un’educazione cristiana o un’istruzione religiosa vi si imbattono. Frieda si risolse disegnando la nonna che viene prelevata dal cimitero e portata in cielo da Gesù Bambino e infine la nonna tra le nuvole al di sopra del cimitero. Aveva trovato una soluzione che scioglieva la contraddizione: la nonna era in cielo e la tomba, in terra, … a nostra consolazione! Il lavoro di cura che ho raccontato è stato una pietra miliare nella mia ricerca intorno al pensiero. Il pensiero del bambino non è infantile. Pensare non ha età Una delle maggiori scoperte della storia è stata la psicoanalisi: una scoperta controversa per svariati motivi. La resistenza alla psicoanalisi è anzitutto resistenza alla tesi dell’unicità del pensiero, nel bambino come nell’adulto: con Freud, il bambino non può più essere trattato come un piccolo rispetto ai grandi, ma come un pensatore a pieno titolo. 38 Il pensiero del figlio Eppure l’obiezione al pensiero come unico permane granitica quanto mai ed è documentabile con il trattamento che comunemente l’adulto riserva al bambino a partire dai suoi due-tre anni, cioè dal momento in cui prende la parola per dire quello che pensa. Ciò nonostante, il pensiero del bambino esiste. Il suo costituirsi era già avvenuto nei primi mesi di vita e proprio la condizione di dipendenza del lattante, che spingeva l’adulto a atteggiamenti protettivi nei confronti del piccolo, lo aveva temporaneamente preservato da atti patogeni a suo danno. Il primo tempo della vita psichica, dunque, può essere chiamato a tutti gli effetti l’iniziale tempo di salute e salvezza. In seguito, allorché il bambino si imbatte in un atto patogeno (comunque e sempre da parte di qualcuno, mai per cause biologiche) che ne mette in crisi il pensiero, passerà inevitabilmente dalla certezza iniziale all’incertezza, dalla sicurezza al dubbio, dalla competenza alla credenza di essere incompetente. E’ una crisi che segna, fissandosi successivamente in una psicopatologia (nevrosi o psicosi), la storia del pensiero individuale e che segna la storia dell’umanità intera, fissandosi nella religione come nevrosi (o psicosi) universale. Dopo la pubertà, infatti, il pensiero, messo in crisi durante l’infanzia. si troverà in difficoltà rispetto ai rapporti, alle esigenze e alle richieste della vita: con la pubertà, l’individuo è a tutti gli effetti simile agli adulti che lo hanno cresciuto, ma si troverà sprovveduto . L’uscita dalla crisi non è univoca, non sempre, cioè, avviene con una soluzione di compromesso. L’individuo può rinunciare al pensiero come pensiero di figlio e dunque come pensiero che ha come meta il profitto, sostituendolo con la soggezione a una teoria astratta. L’esito sarà la psicopatologia: insonnia, difficoltà nei rapporti e conflitti, disturbi tali da incidere seriamente sulla salute e difficoltà scolastiche e lavorative. Pensare è facile e leggero Non pensare è impossibile: o si pensa bene e si sta bene, o si pensa male e si sta male (facendo stare male anche altri), per il semplice fatto che abbiamo un corpo e un principio di orientamento – Freud lo chiamava principio di piacere – che spinge alla ripetizione della, e alla conclusione nella, soddisfazione per mezzo di un altro. Si pensa di giorno e di notte, senza sosta. Durante il sonno il pensiero si realizza nei sogni, durante la veglia il pensare è continuo anche se per lo più inconsapevole. Ma l’individuo che sta bene pensa a conclusione. Il pensiero che conclude non solo non affatica, ma è riposante. E’ il pensiero inconcludente che stanca: il pensiero che non riesce a concludere insiste fino a far star male l’individuo. Non esiste chi non viva di rapporti, in quanto un individuo, fin da lattante, trova soddisfazione per mezzo di un altro, con profitto proprio e dell’altro. Ma c’è chi ne vivrà bene e chi ne vivrà male, tanto è vero che descrivere il lavoro individuale di pensiero come lavoro imprenditoriale è appropriato. Ma è chiaro che tale descrizione corrisponderà al vero nella misura di un riscontro reale. Ecco allora una questione: esiste l’uomo sano? Esiste realmente chi agisce per profitto proprio e altrui? Risposta: l’uomo sano esiste unicamente in quanto guarito. In altri termini, il pensiero comune non lo si incontra in stato di salute, ma in stato di crisi, di malattia, di perversione. La salute è il frutto di un lavoro di guarigione dalla psicopatologia. La scoperta della natura della psicopatologia come malattia della libertà, libertà del pensiero prima che dell’azione, ha fornito il secondo grande motivo di obiezione alle scoperte di Freud: l’uomo, secondo Freud, non sarebbe padrone in casa sua, ma un separato in casa. La divisione tra corpo e pensiero, tra amore e ragione, tra lavoro e profitto, tra sessi, è l’effetto di un’abdicazione dal pensiero, e dell’angoscia che ne è il correlato. È notevole il fatto che la storia del pensiero non contenga traccia alcuna della suddetta separazione: le formulazioni di pensiero di cui è costituita sono compatte (si parla ad esempio del pensiero di Kant, del pensiero di Hegel, del pensiero di Platone). Sul versante 39 Il pensiero del figlio dei costumi (economia, sociologia, antropologia, ecc,), invece, sono note quelle teorie che agendo su scala mondiale per mezzo di applicazioni pratiche nei campi dell’economia, della salute, dell’educazione, ecc., modificano i comportamenti individuali. La storia del pensiero tratta tali teorie come delle direttive universali. E l’umanità, nella sua credenza di incompetenza, vi si è sempre rivolta come a un’autorità indiscussa capace di sedare l’angoscia. L’ostilità riguardo alle scoperte freudiane sulla psicopatologia si manifesta immediatamente, già in alcuni tra i più vicini allievi e collaboratori di Freud, fornendo un pesante contributo a quella che sarà la psicologia accademica del novecento. Quest’ultima, negando l’unicità tra corpo e pensiero e l’orientamento economico del pensiero, separa ciò che era unito e produce teorie a sostegno di tale separazione. Teorie Come dice nel suo intervento la Dr.ssa Aliverti, sul mercato della psicologia e della pedagogia si trovano teorie, modelli, programmi di sviluppo a non finire. Si trovano teorie diverse sul pensiero e sul bambino, ma ovunque ci si rivolga, il pensiero viene distinto tra l’aspetto affettivo e l’aspetto cognitivo: l’intelligenza è stata separata dalla competenza. Il bambino della psicologia accademica è il bambino astratto che risulta dalla teoria scientifica che lo costruisce come modello applicabile al singolo individuo nei suoi legami sociali. Il bambino di Piaget, il bambino di Chomsky, il bambino della Klein o quello di Winnicott, tra altri autori che hanno fatto scuola, sono tipi di bambino inconfondibili tra loro. Ma non sono reali e non si incontreranno mai. Ciò non significa tuttavia che non si incontrino bambini trattati secondo i suddetti modelli teorici. Li incontriamo tutti i giorni nelle parole degli adulti che parlano di loro, nello smarrimento, opposizione, difficoltà, crisi che ne descrive il loro malessere a scuola e in famiglia. In breve, le teorie sul bambino sono teorie ingiuriose accomunate dalla negazione della continuità tra principio di piacere e principio di realtà. L’insieme delle teorie che discendono dall’adulto che nega la continuità della vita psichica del bambino rispetto alla vita psichica dell’adulto in quanto orientata fin dalla prima infanzia al profitto ottenuto per mezzo del rapporto con un partner può essere suddiviso in due sottoinsiemi: 1. quello delle teorie che pongono la priorità biologica della costituzione individuale, soggetta poi ad evoluzione: dal bambino spensierato concreto illogico alla maturità via pedagogia; 2. quello delle teorie che pongono invece la priorità psichica della costituzione infantile, ma individuata come già patologica: la maturità è già presente nel bambino come inconcludenza, ripetizione, fallimento. Nel primo raggruppamento rintracciamo la psicologia scientifica, quella che già Freud aveva criticato come fuorviante e rispetto alla quale voleva una nuova psicologia a partire dalle scoperte che faceva sulla nevrosi. In questa classe di teorie non c’è riconoscimento della psicopatologia come vita psichica (con concorso dell’individuo stesso al suo mantenimento), ma come effetto di micro-distrubi dell’organismo e/o di disturbi socio-educativi che impedirebbero all’individuo il pieno esercizio delle sue facoltà cognitive e/o di quelle affettive. Ma la separazione tra affetto e pensiero è un falso che già Freud aveva ampiamente segnalato come errore millenario (o nevrosi universale). 40 Il pensiero del figlio Nel secondo raggruppamento rintracciamo la posizione rappresentata da Mélanie Klein (e di svariati autori che a lei fanno riferimento), la quale sembra, di primo acchito, sostenere le scoperte di Freud sulla continuità della vita psichica e sulla psicopatologia. Sembra. In realtà tale posizione fa del bambino un mostro e della vita individuale una valle di lacrime segnata dall’odio iniziale, ossia dal tradimento precoce dell’amore, dalla delusione che ne segue (disincanto) e dalla fredda rassegnazione finale. In questa classe di teorie, il bambino contiene in sé il genotipo patologico dell’adulto, tanto che l’adulto sembrerebbe non avere autonomia rispetto al bambino. Sembrerebbe trattarsi di un rinforzo delle scoperte freudiane. Non è vero: mentre Freud asserisce l’iniziale sanità della vita psichica, qui sono già le prime forme di iniziativa individuale a essere individuate come patologiche. Anticipando l’inizio della psicopatologia al momento della nascita o a prima ancora, la negazione della continuità tra pensiero nel bambino e pensiero nell’adulto viene risolta in una nuova, perversa continuità: l’uomo nasce malato. Come già detto, i due raggruppamenti hanno un fattore comune: la negazione della continuità tra principio di piacere e principio di realtà. Il principio di piacere (o di beneficio, o di profitto) è il principio di realtà stesso preso dal lato del principio (orientamento); il principio di realtà è il principio di piacere preso dal lato del reale. Solamente un partner reale è mezzo per il beneficio con pace buona per tutti e solamente il profitto muove l’iniziativa individuale. Ogni altra posizione è antieconomica e violenta. Riuscire o la fecondazione del pensiero Il dubbio sulla propria competenza individuale si insinua mediamente presto, intorno ai primi anni di scuola, e può far sì che la capacità di apprendere - una capacità che hanno tutti i bambini che stanno bene -, venga meno. Se i bambini imparano a parlare è perché hanno appreso. Eppure nessuno l’ha loro espressamente insegnato. Se imparano a camminare, a mangiare, a fare a meno del pannolino, a trattare adeguatamente le cose, a vestirsi, se, cioè, arrivano allo svezzamento in tutti i suoi aspetti, è perché lo hanno appreso, ma nessun metodo specifico di apprendimento è stato adottato dai grandi a tale fine. Potremmo dire che hanno appreso dagli appunti che per i primi anni di vita hanno preso guardando e ascoltando ciò che altri facevano con loro e tra loro. Perché a scuola non dovrebbero continuare a prendere come avevano fatto fino a quel momento? È una questione che io continuo a pormi, in quanto ciò che viene proposto a scuola dall’insegnante al bambino non è difficile, semmai talvolta noioso o eccessivamente ripetitivo, nondimeno fattibile: sappiamo che i bambini sono notevolmente tolleranti nei confronti delle esigenze degli educatori, anche di quelle poco ragionevoli. Il passaggio scolastico dalle elementari alle medie è senza dubbio un momento critico. Potremmo paragonarlo a una crisi amministrativa: cambiano i rapporti, cambiano le modalità di studio e lavoro, cambiano i criteri di valutazione e le richieste di prestazione. La crisi è fisiologica. Sarebbe da delinquenti banalizzare tale momento e istillare nel ragazzo il dubbio sulle sue capacità: occorre piuttosto dargli del tempo perché possa rivedere compiti mansioni e interessi. E se è da aiutare, che sia l’aiuto che si dà ad ogni imprenditore in crisi, cioè in crescita, e non l’aiuto che si dà a un naufrago. Ricordo, ad esempio, un padre che ho stimato moltissimo. Riuscì a liberare la figlia, allieva di prima media, dal timore della matematica. Lo fece in una sola serata. Alla fine delle vacanze “dei Morti”, fine ottobre-inizio novembre, sua figlia non aveva ancora svolto il compito di matematica comprendente un’intera pagina di espressioni oltre a calcoli vari, un 41 Il pensiero del figlio lavoro che aveva dimenticato di fare e che avrebbe richiesto quanto meno un pomeriggio di intensa applicazione. Infatti, per fare due esercizi, la ragazza aveva impiegato due ore. Di fronte all’angoscia della figlia che non procedeva, il padre le propose di andare a prendere la calcolatrice e di dividere a metà il lavoro, ognuno con la propria. Diversamente non ce l’avrebbe mai fatta a concludere. Ma la ragazza si opponeva, dicendo che l’insegnante non permetteva l’uso della calcolatrice. Il padre le fece osservare che non sarebbe certamente stato l’uso occasionale di quello strumento elettronico a farle dimenticare operazioni aritmetiche e tabelline che aveva imparato e svolto per anni alle elementari. Da quel momento in poi, per la ragazza, la scuola non è più stata un ente assoluto e estraneo, difficile da cogliere, da affrontare e da capire, ma un campo di lavoro personale che toccava a lei affrontare e che poteva affrontare in vari modi. Il gesto del padre è stato l’atto con cui un uomo trasmette a un altro il modo di produzione del profitto: un esempio di trasmissione ereditaria. Illustro ora un contro-esempio di riuscita, secondo l’equivalenza di prendere e apprendere. Apprendere significa prendere, in quanto per apprendere occorre l’organo con cui prendere, cioè il pensiero. Senza “mani e lingua” non si può prendere nulla, neppure la migliore offerta. Ma accade che al pensiero vengano tagliate e la lingua e le mani. Si taglia la lingua al pensiero quando l’individuo si trova nella posizione in cui non può più pensare: è l’angoscia. Si tolgono le mani al pensiero quando, per vari motivi, l’individuo non può o non vuole più imparare, come nel caso dell’autismo. L’esempio illustra una tragedia individuale e famigliare. Si riferisce a un giovane adulto sul quale la teoria della separazione dell’intelligenza dalla competenza individuale è diventata destino personale. Oggi il giovane, di nome Andrea, fa il mantenuto. Ha venticinque anni, si è laureato con ottimi voti presso un’università lontano da casa, dopo la laurea è rientrato a domicilio e da allora fa in modo che il padre lo mantenga in un appartamento autonomo dove da due-tre anni vive evitando ogni contatto con i genitori. Riceve i finanziamenti dalla banca. È solo, nullafacente, invecchiato precocemente e evitato da tutti. Bisogna notare che il padre si chiama Paolo. Rispetto agli altri due figli (un maschio e una femmina), “i figli intelligenti”, Andrea è il figlio stupido (tutti lo sanno per espressa dichiarazione della madre). È l’altro maschio, di nome Pietro, “il figlio”, cioè colui che darà alla famiglia la continuità del casato, poiché da generazioni ci sono un Paolo e un Pietro. Paolo genera Pietro. Pietro genererà Paolo. Dunque, in questa famiglia, Andrea è fuori gioco fin da sempre. Era già stato escluso dall’eredità su due fronti: sul versante dell’imprenditorialità sarebbe stato Pietro a subentrare al padre nell’azienda, come di fatto è avvenuto, mentre sul versante dell’intelligenza era stato pregiudicato fin da piccolo dalla madre. Eppure, essendo andato a studiare fuori sede, Andrea ce l’avrebbe fatta. Stimato in ambito universitario, aveva ricevuto proposte professionali interessanti. Ma – qui sta la fissazione nella patologia - il suo rientro a casa gli si impone come obbligo. Avrebbe dimostrato a tutti che era giunto il tempo del risarcimento a lui dovuto e torna per vendicarsi. Ha perso tutto: possibilità di carriera, rapporti, salute. Oggi è il cruccio di tutti. Andrea avrebbe fatto bene a rivolgersi a qualcuno per una cura, ma oggi sono i familiari stessi a darlo per matto. E lui non si muove. La vicenda avrebbe potuto figurare in un impietoso racconto di fine Ottocento, mentre è 1. realmente accaduta e 2. recentemente accaduta. Essa documenta tristemente quel modo di concepire l’eredità per cui ciò che viene trasmesso sono i beni e il nome del padre e eventualmente i caratteri genetici ereditari. Come aveva osservato il Dr Contri, l’eredità della generazione di figli è l’eredità del modo di produzione del profitto: “io lavoro come lavora mio padre, io faccio come fa mio padre. Perciò gli sono figlio”. Padre è il riconoscimento del figlio, e tale riconoscimento potrebbe avvenire in non più tenera età. Negare al proprio figlio questo accesso ereditario è iniquità oltre che dolo e indice di psicopatologia già nel genitore. Tuttavia non è un destino. 42 Il pensiero del figlio La possibilità per la competenza individuale di giungere a giudicare il proprio genitore esiste, e persino la constatazione di avere avuto come padre un delinquente è produttiva: permette all’individuo di riprendere il proprio corso di pensiero liberandosi dalla prigionia della condanna. Per il pensiero, il giudizio non comporta sanzione penale: il giudizio è già sanzione e apre al perdono. L’attentato del dubbio È facile udire da un adulto: “Questo figlio è come me”. Ma è altrettanto facile udire da un ragazzo: “Come mia madre/mio padre, io sono una bestia in matematica”. Non è necessario che siano i genitori stessi a stabilire chi e che cosa avrebbero ereditato i figli dall’uno o dall’altro. Separare l’intelligenza dall’affetto, separare il pensiero dal rapporto, cioè dal desiderio di ricevere facendo in modo che l’altro collabori con me, è la prima breccia attraverso cui nel grande si insinua il dubbio sul bambino, il quale, poi, l’assumerà a sua volta. Sembra incredibile, eppure di fronte alla difficoltà del proprio bambino a scuola l’adulto resta disorientato e si allarma. Dubitare delle capacità del bambino, rivolgersi a professionisti esperti per degli aiuti specifici, insistere sui compiti, è un’ingiuria e un atto doloso. Il campo che riguardava la competenza individuale del bambino viene trasformato in un campo da cui il figlio è espropriato. Da imprenditore che era, il bambino si ritrova nella posizione di un esecutore di ordini alle dipendenze di un padrone. Crisi d’amministrazione e competenza La nascita del fratellino rappresenta un momento rilevante nella vita psichica del bambino. Succede che il primogenito ne sia contrariato. Ci sono mutamenti nei rapporti di profitto, è innegabile. Il bambino che improvvisamente se ne trova uno nuovo tra i piedi che non solo gli toglie dello spazio, ma addirittura l’attenzione dei grandi, non si trova affatto in una facile posizione. Inoltre, può contare poco sugli adulti se si pensa a frasi come: “Tu che sei più grande, datti da fare”. È comprensibile come il diventar grande, che fino a quel momento era un’ambizione, rischi di venir meno (i bambini non si ritengono piccoli. Di statura semmai, o quando le prendono dai più grandi, ma non nei rapporti). Risolvere la reale crisi di amministrazione che l’arrivo di un altro comporta, - un altro che non è ancora un socio e dovrebbe diventarlo a vita, dato che, come tutti sanno, bambino compreso, una volta arrivato non andrà più via -, è un serio problema. Come trasformare in socio chi non lo è ancora e non fa niente per esserlo, anzi, dà fastidio? Il problema per il bambino sta nel fatto che trasformare il nuovo arrivato in partner è anzitutto un lavoro di pensiero, in quanto si tratta di preparare il posto a un altro che sarà partner attivo a distanza di mesi se non anni: il fratellino inizierà a diventare compagno di gioco quando avrà almeno sei mesi - un anno. Quando sta bene, il bambino cerca altri per farsene dei compagni. Ma ci sono adulti che non hanno mai avuto accesso al pensiero di socio e permangono ostili al fratello. Ripeteranno la medesima ostilità nei confronti dei loro bambini. Un esempio: un ragazzino di otto anni mi viene inviato dalla madre che si dice preoccupata per le notevoli difficoltà di concentrazione e attenzione del figlio e per i risultati scolastici davvero scadenti. Ma la sua principale preoccupazione risiede altrove. Teme che il suo bambino di otto anni sia incline all’omosessualità. Infatti, fin da piccolo, egli predilige colori pastello, chiacchiera “come solo le donne amano fare”, cura meticolosamente il suo aspetto, non tollera comportamenti grossolani, insomma non ha nulla del maschio. Il 43 Il pensiero del figlio problema sarebbe da ricondurre ai primi anni di vita, quando il bambino viveva da “principe”, attorniato da adulti adoranti e dalla mancata frequentazione di coetanei durante la prima infanzia. Ci voleva un fratellino. Pazzesco. Mi trovo di fronte un bambino brillante e disinvolto. Senza ombra di imbarazzo, anzi con una certa ostentazione, ammette di essere distratto a scuola, di non scrivere quando non ne ha voglia e di nascondere i compiti quando non li vuole fare. Mi sembra un ragazzino disturbato che per il momento se la cava furbescamente. È evidente che sta cercando di evitare qualcosa, tuttavia non riesco a capire dove stia il problema, finché un giorno mi fornisce il tassello mancante. Mi dice: “Io non capisco perché i miei genitori hanno fatto mio fratello. Dicono di averlo fatto perché lo volevo io, ma io non ricordo di aver mai chiesto loro un fratellino. Comunque, è arrivato”. Poi aggiunge: “Mi dicono pure che io avevo bisogno di un compagno di giochi, ma io i compagni di giochi me li cerco da me. Non avevo bisogno che loro me ne procurassero uno che, oltretutto, è antipatico”. Segue una lunga lista di difetti a carico del fratello. Ecco un esempio di inganno (con beffa) e di negazione della competenza. La spiegazione ricevuta dai genitori aveva ostacolato il bambino. Gli era stata sottratta la possibilità di trattare personalmente l’evento della nascita del fratellino a vantaggio suo e di tutti. Anzi, la risposta mistificatoria dei genitori aveva disconosciuto in lui quella domanda che ogni bambino si pone e pone: “come nascono i bambini?”. Aveva inoltre raggirato il suo lavoro intellettuale. Fare opposizione non poteva che essere l’esito più ovvio del rigore pedagogico esercitato dalla madre che lo considerava un deviante. La competenza del bambino non è ammissibile dall’adulto che non esercita più la propria competenza, la medesima per cui, da bambino, egli stesso era stato offeso nel suo pensiero. O si diventa come bambini, o si invidia il bambino. Educare Educare è una delle professioni impossibili, annotava Freud, insieme con il governare e il curare. L’annotazione freudiana è tanto poco apprezzata quanto facilmente sottoscrivibile. Ciò che cerca l’educatore, l’insegnante, il genitore sono indicazioni e suggerimenti applicabili e efficaci. Eppure l’annotazione stessa contiene il suggerimento cercato. Educare è impossibile come verbo transitivo: si tradurrebbe in comando o programma, mentre come verbo intransitivo equivale a prendersi cura di qualcuno che già si orienta secondo un principio individuale di guadagno, affinché costui possa davvero produrre profitto. In altri termini, educare è uno dei nomi che qualificano il rapporto ereditario tra due individui. Il bambino non ha bisogno di metodi educativi particolari: vuole essere trattato bene, cioè trattato come un individuo sanzionabile e giudicato per i suoi atti. 44 Il pensiero del figlio Ambizione, eredità, ricchezza di Vera Ferrarini Il titolo dato a questo incontro mi piace: lo reputo ambizioso, dal latino ambire. E ricordiamo come in latino il verbo ambire fosse riservato al darsi d’attorno di coloro che aspiravano a ottenere cariche e onori pubblici, collegasse dunque la meta della soddisfazione di un desiderio col moto e col lavoro. Trovo proprio interessante ripartire dall’ambizione, anzi poter ripartire dal concetto di ambizione, in qualsiasi situazione ci si trovi. Dato che, per parafrasare un titolo celebre, l’ambizione, quella buona, non è più una virtù, sarebbe tempo, anzi è tempo di ricominciare a considerarla una virtù, che non ha proprio nulla a che vedere né con l’orgoglio né con la supponenza ma piuttosto è da connettere con il desiderio, l’iniziativa, la mossa. Non c’è ambizione che non rimandi a quello che Giacomo Contri ha chiamato e chiama il Chi; l’ambizione rimanda al Chi, a colui che può imputare a se stesso la possibilità di mettersi in una posizione di lavoro. Mi viene alla mente una domanda che era stata posta a Contri stesso durante un convegno intitolato “Il resto della psicoanalisi”13; la questione riguardava la possibilità di dare inizio ad un lavoro di analisi dopo i cinquant’anni. La risposta, asciutta, è stata: “Ma se una persona ha voglia di lavorare a centodieci anni, non vedo perché non possa intraprendere l’analisi”. Aveva evidentemente estremizzato la cronologia, proprio per offrire un altro concetto di lavoro e di tempo. Il tempo della vita di ognuno di noi, invece, è ridotto sovente alla scansione stupida e scontata del famoso quesito che la Sfinge pone ad Edipo nell’omonima opera di Sofocle: “Chi è l’animale che prima cammina a quattro zampe, poi a due e poi a tre?”. Risponde Edipo: “E’ l’uomo”. Da tale indovinello, l’uomo è definito come colui che scandisce cronologicamente la sua vita secondo infanzia, maturità, vecchiaia, secondo una cronologia ineluttabile, triste e, alla fine, stupida, perché senza meta. C’è invece Chi, facendo addirittura apologia di suicidio, afferma: “E’inevitabile che avvengano scandali, ma guai a colui per cui avvengono. E’ meglio per lui che gli sia messa al collo una pietra da mulino e venga gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli”.14 Questo pensiero, questo giudizio conclusivo, consultabile nei Testi scritti, ribaltando la triste scansione “infanzia maturità vecchiaia”, non solo dice che è preferibile il suicidio allo scandalo di un bambino, ma pone un concetto di salute nuovo, come si legge nell’asserzione: “Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio”.15 Il ribaltamento, rispetto al solfeggio melanconico con il quale si definisce l’uomo (tale solfeggio è frequentemente suonato nel tono aulico dei filosofi o in quello più greve che si può ascoltare in piazza o in classe o in aula insegnanti), consiste nel considerare il tempo come propizio secondo una scansione così descrivibile: “maturità iniziale crisi guarigione”, o anche “ normalità crisi guarigione”.16 13 Il riferimento è ad un convegno tenutosi a Reggio Emilia nel 2001, il cui titolo era “Il resto della psicoanalisi”. 14 Lc. , 17, 20. 15 Mc. , 10, 13-18. 16 Il concetto è ampiamente sviluppato nel testo dello Studium Cartello L’aldilà. Il corpo, a cura di P. Cavalleri, Sic Edizioni, Milano 2000. 45 Il pensiero del figlio Questo capovolgimento, che indica il bambino come bussola orientativa del concetto di salute considerata come guarigione, cambiamento, ritorno non infantile17 alla competenza logica, alla capacità sanzionatoria e alla mossa ex-citata da una meta ed ex-citante per i suoi altri, per chi la sa prendere, di quel soggetto che a cinque- sei anni ha già vagliato tutto, dovrebbe dar da pensare: dopo l’apologia del bambino fatta da Gesù soltanto Freud, con il suo lavoro di osservazione, ci ha offerto la novità di una stima per il lavoro di questi soggetti, dal nipotino Ernst al piccolo Hans, fino a chiamare il bambino padre dell’adulto. Non c’è nulla di cui egli, piccolo solo in metratura, non voglia sapere, a meno che non ne voglia sapere perché qualcuno lo ammala. L’ambizione allora, di cui il bambino che sta bene è ben competente, consiste nella possibilità di pensa il rapporto di lavoro secondo quel pensiero che fa prendere il tempo come propizio per un beneficio. Se è cos triste scansione può invece diventare: maturità iniziale, crisi, guarigione. Non so se anche a voi suona familiare una frase come questa: “C’è chi può!”. Tale frase di solito non è riferita agli insegnanti, se il verbo potere è concepito nel suo significato corretto e non confuso con il sostanti “potere”, il cui esercizio, nelle aule scolastiche coincide sovente con piccole azioni di prepotenza che nascondono l’impotenza. Nella mia infanzia, la frase possedeva una tonalità invidiosa che conteneva un sottinteso pesante ed esautorante così enunciabile: “Tu non puoi, noi non possiamo: quello sì che è uno che p E’ ricco, e tu sei esclusa da questo!”. Io invece, mi voglio riappropriare, anche nell’occasione dell’incontro di oggi di questa frase: “C’è chi può”. Ecco: c’è chi può mettersi in una posizione di correggibilità anche rispet alla tentazione di giudicare il titolo proposto come utopistico. Ambizione e correggibilità, dunque. Anzi: ambizione, dunque correggibilità. Si può ambire allora a riprendere nelle mani il quesito posto da Giacomo Contri nell’intervento di dicembre. “Non si potrebbe cercare di concepire come trasmissione ereditaria anche quella scolastica?”. Ambizione. Lavoro. Correzione. Eredità. Questi potrebbero essere i lemmi, i titoli costituenti l’articolazione semplice, ma non semplicistica del lavoro di oggi. La parola “talento” rimanda ad una celebre parabola detta “Dei talenti”18: suggerisco di leggere sul sito dello Studium Cartello, nella sezione Pensiero di Cristo, il lavoro che su questa cosiddetta parabola, redazione di un pensiero giudizioso, concludente e sanzionante, è stato fatto; senza presupporre credenze confessionali, reputo utile consultare e vagliare il pensiero che essa documenta. C’è un certo signore, un ricco, un soggetto investitore, il quale prende l’iniziativa di muoversi interpellando un altro, anzi alcuni altri che potrebbero essere chiamati operatori finanziari e chiede loro di trafficare dei talenti al fine di produrre un profitto, un guadagno, un interesse. Penso, e propongo, di poter considerare questo movimento, mossa, iniziativa, rilancio, come normativo di qualsiasi rapporto: che cosa cambierebbe, che cosa si potrebbe generare se io considerassi l’altro - figlio, studente, collega – come capace di produrre soddisfazione e beneficio per me? Ogni iniziativa potrebbe diventare un appuntamento di guadagno, compresa la sanzione inevitabile qualora si constatasse, magari dopo rilanciati appuntamenti, che non c’è stato guadagno. La competenza umana che tale pensiero produttivo di atti designa è generatrice di quella professionale, soprattutto quando si tratta della professione di insegnanti, che altrimenti si ridurrebbe pauperisticamente ad essere soltanto quella di dipendenti o funzionari statali. Nel mio lavoro di psicoanalista mi accade sovente di incontrare bambini o giovani uomini e donne esautorati dalla mancanza di investimento dei loro altri più prossimi, dei loro genitori, che li hanno “ fatti”, ma non li stanno “generando” attraverso quella stima propositiva cui allude la famosa parabola. Ritorniamo dunque a consultarla: si tratta di un soggetto investitore che si muove, prende l’iniziativa e interpella altri affinché, a loro volta si muovano per operare in modo tale da produrre beneficio, profitto, guadagno. 17 18 La stima per il bambino non ha nulla a che vedere con l’idea del “ fanciullino” di Pascoli. Mt., 25, 14-30. 46 Il pensiero del figlio Alcuni di questi interpellati mettono a frutto i talenti e li moltiplicano; c’è solo uno invece che li sotterra, non li fa fruttare, non opera, non pensa neppure di affidarli ai banchieri. Tale soggetto è considerato malvagio, pesantemente sanzionato e smascherato nel suo pensiero invidioso del profitto e del modo di produzione corretto (anche secondo l’etimo della parola) di quel proprietario. In un certo periodo della mia vita io pensavo che egli lo avesse, almeno, custodito: appunto, secondo un “al-meno” e non un “al-più”, secondo un profitto che è lo scopo dell’azione dell’investitore e di qualsiasi soggetto che si muova secondo un pensiero sano come quello del bambino, o di un adulto almeno un po’ guarito. Ho trovato questa dinamica di investimento in un breve testo, di cui vi leggo alcune parti senza, per ora, nominare l’autore; per coglierne il senso e farlo fruttare si tratta di collocare l’insegnante al posto di soggetto investitore e lo studente al posto dell’operatore finanziario, di colui che dovrebbe far fruttare; i posti però, e questo è rilevante, sono intercambiabili. Si tratta di un autore che si definisce vecchio nel momento in cui scrive questo, e che ricorda la sua esperienza ginnasio-liceale. “Si prova una strana sensazione, quando, in età così avanzata, si è ancora una volta incaricati di scrivere un “ componimento” per la scuola.(…..) E’ sorprendente la prontezza con cui si accetta l’incarico, come se negli ultimi cinquant’anni non si fosse verificato alcun cambiamento particolare. Eppure siamo invecchiati, siamo alle soglie dei sessant’anni…”. Intanto mi colpisce la dichiarazione stupita: “ è sorprendente la prontezza”, che non è precisamente la caratteristica di chi è vecchio. “Sono vecchio, eppure mi sorprende la prontezza con cui mi metto al lavoro”: può essere così raccolto ed esteso il senso della frase. E’ un’idea di vecchiaia certamente diversa da quella di cui parlavo all’inizio alludendo al concetto che l’antico, praticato e melanconico indovinello della Sfinge ad Edipo segnala. Chi racconta non è certamente “ oberato di vecchiezza”19 e non è mentalmente pre-pensionato, così come non lo è chi ha risposto che un lavoro di analisi, per chi ha voglia di lavorare, può iniziare anche nel tempo della vecchiaia cronologica: può essere comunque anche quello tempo per il moto,la correzione, il cambiamento. Il fluire dei ricordi si condensa in una descrizione ancora più efficace: “Quando, già con i capelli grigi e tutto il peso di una vita borghese sulle spalle, camminando per le strade incontravamo inaspettatamente un anziano signore ben conservato, lo salutavamo quasi con deferenza, perché avevamo quasi riconosciuto in lui uno dei nostri professori del ginnasio. Ma poi ci si fermava a guardarlo riflettendo: E’ veramente lui o è uno che gli assomiglia moltissimo? Che aspetto giovanile ha, e tu come sei diventato vecchio! Quanti anni potrà avere oggi? E’possibile che questi uomini che allora erano ai nostri occhi i tipici esponenti del mondo degli adulti fossero di tanto poco più vecchi di noi? In quei momenti il presente pareva oscurarsi e dagli angoli riposti della nostra memoria riemergeva la nostra vita da dieci a diciotto anni, con i suoi presentimenti e i suoi errori, le sue trasformazioni dolorose e i suoi esaltanti successi. Riaffioravano alla mente i primi sguardi…”. Qui mi fermo, perché nelle frasi che leggerò ora ritrovo quel movimento di investimento che facevo notare prima e che allude pienamente all’ambizioso titolo dell’incontro di oggi. “Riaffioravano alla mente i primi sguardi rivolti a una civiltà tramontata, (destinata, almeno per me, a divenire in seguito fonte di inesauribile conforto nelle lotte della vita), i primi contatti con le scienze, tra le quali credevamo di poter scegliere quella a cui poter offrire i nostri servizi, che sarebbero risultati certamente inestimabili.” 19 L’espressione è di Efrem il Siro, autore trattato in S. Averincev, Dieci Poeti. Ritratti e Destini, La Casa di Matriona, Bergamo 2001. 47 Il pensiero del figlio La “civiltà tramontata” diventa “fonte”, fonte inesauribile; è acquisita come eredità da prendere e da far fruttare, da coltivare con cura fino al punto da pensare di poter offrire “i nostri servizi” giudicati “inestimabili” ad altri. L’atto del ricordare si condensa e fluisce nell’evidenza riconosciuta di una scoperta, che è la scoperta propria del rifare memoria….e l’autore conosce bene la portata di questa facoltà. “E a me sembra di ricordare che tutti quegli anni erano stati percorsi dal presentimento di un compito che in un primo tempo si era delineato appena (..Il presentimento di un compito può cominciare a formularsi con questi pensieri: “mi viene voglia di”, “penso di “, “comincio a coltivare questa idea” , “ho voglia di prendere, di apprendere” etc.) e che aveva infine trovato la sua aperta espressione nel mio saggio di maturità, dove avevo dichiarato l’intenzione di contribuire, nella mia vita, allo sviluppo del sapere umano. Più tardi sono diventato medico, o più propriamente psicologo, e ho potuto creare una nuova disciplina psicologica, la cosiddetta “psicoanalisi”, che oggi è seguita con eccezionale interesse da medici e ricercatori di paesi vicini e lontani, di lingua diversa, suscitando ovunque parole di lode e di biasimo – mentre, com’ è ovvio, ha trovato la sua eco più debole nel paese d’origine”. Ecco l’ambizione, come frutto di un lavoro che è consistito sicuramente anche nello studio della sintassi greca e di quella latina, dai verbi alla perifrastica; è l’ambizione di Sigmund Freud che tutti avrete capito essere l’autore di questo scritto, intitolato Psicologia del ginnasiale20. La riflessione si articola ulteriormente e si arricchisce: “L’emozione che provavo incontrando i miei vecchi professori del ginnasio mi induce a fare una prima ammissione: è difficile stabilire che cosa ci importasse di più, se avessimo più interesse per le scienze che ci venivano insegnate o per le persone dei nostri insegnanti. In ogni caso questi ultimi erano oggetto per tutti noi di un interesse sotterraneo continuo, e per molti la via delle scienze passava necessariamente per le persone dei professori…” Il bravo insegnante, il competente professionalmente è chi ha la competenza umana di trattare ciò che sa (…e deve sapere! ), ciò che ha imparato, come suo patrimonio e sua eredità da far fruttare con soddisfazione; è un soggetto investitore e non soltanto, come accade spesso, un funzionario statale. Freud mette a fuoco ancora meglio la natura di questo rapporto: “Li corteggiavamo o voltavamo loro le spalle, immaginavamo che provassero simpatie o antipatie probabilmente inesistenti, studiavamo i loro caratteri e formavamo o deformavamo i nostri sul loro modello (…) spiavamo le loro piccole debolezze ed eravamo orgogliosi dei loro grandi meriti, del loro sapere e della loro amicizia”. Nella ricchezza di pensiero che mette al lavoro chi legge queste frasi, una delle considerazioni che mi sembra davvero rilevante, è questa: “In fondo li amavamo molto, se appena ce ne davano un motivo; non so se tutti i nostri insegnanti se ne sono accorti”. Se appena ce ne davano un motivo, noi eravamo disposti ad amarli! Una delle traduzioni che io ritengo purtroppo attuale nella scuola di oggi di questo condensato “appena” è: qualora un insegnante non si metta, con tutti gli strumenti anche pedagogici di cui può disporre, a contrastare, anzi spesso a distruggere quel resto di pensiero che considera la scuola come occasione di profitto. “Li amavamo molto”, potrebbe sembrare una frase un po’ sentimentale; nelle pagine seguenti, invece, l’autore si chiede che cosa significhi davvero “ li amavamo molto”, e riflette sul tempo che gli studenti stavano vivendo, il tempo del ginnasio.21 Le considerazioni non si affossano nella descrizione del comportamento adolescenziale, ma con parole che io trovo di una densità feconda e pro-vocatoria, offrono la possibilità di valutare la realtà psichica di chi si trova in un momento della sua vita in cui l’idea di padre è in crisi. La considerazione 20 S. Freud, Psicologia del Ginnasiale, 1914, OSF, vol. 7, pp. 477-480. Ginnasio sta qui ad indicare l’intero corso degli studi medi di indirizzo umanistico (comprensivi pertanto del nostro liceo) secondo un uso della parola introdotto in Germania fin dal Rinascimento. 21 48 Il pensiero del figlio seguente, infatti, inizia con una avversativa: “Ma fra le imagines che si sono formate in un’infanzia di cui di solito si è perduto il ricordo, nessuna è più importante, per il giovane o per l’adulto, di quella del proprio padre. La natura di questa crisi si esprime in quella che Freud chiama una “ambivalenza emotiva”, di cui si ha la “manifestazione più impressionante nel mito greco del re Edipo”. In tale ambivalenza risiede ed è facilmente constatabile una “coesistenza degli opposti”, così come è descritta nelle frasi seguenti: “Nel corso della fanciullezza ci si appresta a un mutamento in questo rapporto col padre, la cui importanza non sarà mai sottolineata abbastanza. Il fanciullo comincia ad uscire dalla stanza dei bambini, ad affacciarsi al mondo reale; a questo punto farà delle scoperte che scalzano la sua originaria ammirazione per il padre e determinano il suo distacco da questo primo ideale. Egli scopre che suo padre non è l’essere più potente, più saggio e più ricco della terra, comincia a diventare scontento di lui, impara a criticarlo e a valutare la sua posizione sociale; poi, di solito, fa pagare cara al padre la delusione che gli ha procurato: tutto ciò che nella nuova generazione appare denso di promesse, ma anche tutto ciò che essa ha di urtante è determinato da questo distacco dal padre”. “Noi li amavamo molto, se appena ce ne davano il motivo”. E tale motivo è da connettersi con la “ fase dello sviluppo” in cui “ha luogo l’incontro del ragazzo con gli insegnanti”. La conclusione, preziosa per chi la sa prendere, dà da pensare: “A questo punto possiamo capire il nostro comportamento verso i nostri professori del ginnasio. Questi uomini, che pure non furono tutti dei padri, diventarono per noi i sostituti del padre .(…) Abbiamo trasferito su di loro il rispetto e le attese che nei nostri anni infantili avevamo nutrito per il padre onnisciente, e poi abbiamo cominciato a trattarli come trattavamo, a casa, i nostri padri”. Osservo che spesso, fin dai primi anni delle elementari, accade frequentemente che l’insegnante, più che facilitare, più che coltivare l’idea di guadagno, la distrugge; la difficoltà che i bambini incontrano sovente in prima elementare, il pensiero della difficoltà, soffoca la certezza della facilità, dell’apprendere come prendere con soddisfazione. Mi accade di constatare inibizione e incertezza rinunciataria in bambini di sei sette anni che fino a quel momento hanno preso tutto ciò che era prendibile, hanno imparato a parlare e, prima di pronunciare la prima frase con soggetto-verbo-predicato hanno pensato da sani logici, magari in due diverse lingue. Perché? Una delle risposte che mi sono data è questa: sovente gli insegnanti, via pedagogizzazione screditante, via imperativo disinvestente, non collaborano al piacere con il quale il bambino fino a quel momento ha appreso con certezza, interesse e capacità di giudizio. Non accade soltanto ai bambini; l’esempio vale per tutti, ma in primo luogo per i genitori che partecipano a questo incontro. Il pedagogismo si può manifestare nel nostro discorso quando le frasi, che sembrano libere e aperte, non fanno posto all’altro, ma sono chiuse al suo pensiero e al suo apporto. La pedagogia non lavora secondo la dinamica di lavoro su lavoro, non mira alla produzione con profitto, cioè all’arricchimento, che è l’unica questione di una concepibile riforma della scuola” 22, non ha come meta la produzione di un “discorso a quattro mani”. La lettura di alcune pagine della rivista “La mediazione pedagogica”, nelle quali l’autore23 afferma, riferendosi a Husserl, che la pedagogia è una scienza rigorosa, conferma questo giudizio. Chiamando a raccolta ( non a caso) autori come il già citato Husserl, Foucault, Gadamer e Bachelard, Giachery dichiara che “esiste un brusio dell’essere che si manifesta quotidianamente nell’agire educativo e che cerca di dare fisionomia (occhi, volto, parola) al soggetto che ci sta di fronte, di rispecchiarci nella sua instancabile ricerca di identità”. La 22 Rimando al lemma “pedagogia” del primo volume dell’Enciclopedia aforistica dello Studium Cartello: G. B. Contri, L’Ordine Giuridico del Linguaggio. Il primo diritto con Freud o la vita psichica come vita giuridica, Sic Edizioni, Milano 2003. 23 G. Giachery, Il brusio dell’essere-pedagogico. Riflessioni in merito alla filosofia dell’educazione, in “La mediazione Pedagogica”, web.tiscalinet.it/mediazionepedagogica. 49 Il pensiero del figlio delicata parola “brusio”, segnala la cinica negazione del rapporto come beneficio e della possibile produzione a due del discorso. Prendiamo una frase corrente: “Lo faccio per il tuo bene”, oppure, dopo un insuccesso: “Te l’avevo detto !”, oppure: “Mangia che ti fa bene”24; potremmo fare un elenco, e sarebbe lungo, di frasi che, come insegnanti o genitori continuamente pronunciamo, senza accorgerci di avere introdotto nel rapporto qualcosa che lo distrugge, un comando, una mediazione pedagogica che toglie il posto all’altro e azzera la possibilità del rapporto. Voglio fare un esempio che mi riguarda: quando io dicevo a mia figlia: “Sembri sempre la vispa Teresa”, in realtà in quel momento stavo introducendo pedagogicamente un mio concetto che non rappresentava un’offerta di lavoro per lei. Non dicevo, magari perché richiesta di un parere: “Ma non ti sembra che tu in questa occasione possa essere stata ingenua, che ci sia stata nella tua condotta un po’ di ingenuità…”. No, dicevo proprio “Sei una vispa Teresa”, la inchiodavo a questa definizione imprigionante e predittiva; era una mossa violenta, non era certamente un invito alla correzione (cum-rego), a un lavoro reciproco, ma era “bollare” mia figlia e un condannarla proprio a essere Vispa Teresa anche per il futuro, qualora il ritornello si fosse ripetuto fino a diventare esautorante. Tro vo notevoli, perché rivoluzionano molte coordinate del nostro pensiero, le osservazioni di Averincev a proposito di un tratto di quella che consideriamo, per teoria presupposta e tramandata, l’intoccabile civiltà greca. “Come è noto - scrive Averincev - la crema dei dialoghi letterari è rappresentata da quella di Platone, il cui eroe principale, il personaggio chiave, la figura più luminosa è Socrate. Ma che cos’è il Socrate platonico? E’ l’ideale dell’uomo non dialogico, che non può essere intimamente apostrofato, che non può essere turbato e scosso dalle parole dell’interlocutore ma, nella foga della discussione rimane del tutto impenetrabile, impassibile, inaccessibile per qualsiasi altro io ed è perciò in condizione di manipolare i partners del discorso, di manovrarli come cose25 non facendosi manovrare da nessuno”26. La lettura attenta del “ Simposio” di Platone porta a scoprire che i due soggetti, maestro e discepolo, non sono posti nella posizione che ho descritto riferendomi alla famosa parabola dei talenti o dell’investitore. C’è un maestro che è teso al suo piacere e controlla la virtù dell’allievo. Il maestro è il controllore della virtù dell’allievo, mentre per lui la meta è il piacere. L’ultimo passaggio potrebbe sembrare un salto, ma non lo è; argomenterò le ragioni per cui reputo che l’articolazione non sia ardita ma intellettualmente e logicamente connessa con il titolo proposto e il suo svolgimento. Ricorderete la famosa novella di Verga intitolata La roba; è un racconto ambientato in Sicilia, nel quale si tratta del concetto di eredità la quale, come tale, può essere lasciata perché altri la coltivino oppure odiosamente distrutta. Propongo questa chiave di lettura: la pedagogia può uccidere l’eredità diventando pedagogismo e la distruzione dell’eredità, così come ha riguardato Mazzarò, il protagonista della novella, può riguardare ognuno di noi. La ricchezza di una terra calda e bionda di grano, la terra siciliana, distese di viti profumate e di ulivi nodosi, carichi di frutti e di promesse, appartengono ad una sola persona che accumula affannosamente senza usufruire di ciò che possiede. “Ma di chi è?”- si chiede qualcuno - “Di Mazzarò”, “E qui?” “Di Mazzarò”. E il guardiano sdraiato bocconi sullo schioppo accanto al vallone, levava il capo sonnacchioso e apriva un occhio per vedere chi fosse. “Di Mazzarò”. 24 La frase può sembrare innocua; io stessa ho impiegato del tempo per metterne a fuoco la gravità che pure mi era stata segnalata. 25 Lo studente può essere trattato come oggetto, anzi meglio gestito come si usa dire oggi e come si trova scritto in tanti manuali di psicologia. 26 S. Averincev, Atene e Gerusalemme, Donzelli, Roma 1994, p. 21. 50 Il pensiero del figlio Ed egli mangiava, come ricorderete, pane e cipolla. “Della roba ne possedeva fin dove arrivava la vista ed egli aveva la vista lunga, dappertutto, a destra e a sinistra, davanti e di dietro nel monte e nella pianura. Più di cinquemila bocche, senza contare gli uccelli del cielo e gli animali della terra, che mangiavano sulla terra e senza contare la sua bocca, la quale mangiava meno di tutti e si contentava di due soldi di pane e un pezzo di formaggio, ingozzato in fretta e in furia, anche in piedi ….”. “Era che ci aveva pensato e ripensato tanto a quel che vuol dire roba, quando andava senza scarpe a lavorare nella terra che adesso era sua. Ed aveva provato quel che ci vuole a fare i tre tarì della giornata, nel mese di luglio, a star con la schiena curva quattordici ore”. Il concetto di lavoro, così importante e decisivo per ognuno di noi27, coincide in questa descrizione con lavoro forzato e imposto da un padrone ancor più severo e duro di un padrone reale; è ininterrotto affanno improduttivo, perché, anche se produttivo di roba, non lo è di soddisfazione. Mi chiedo quanto del nostro lavoro non sia affanno improduttivo o lavoro forzato. “Tutta quella roba si era fatta lui e quando qualcuno gli chiedeva di non metterlo in mezzo alla strada, col pigliarsi il mulo e l’asinello, che non avevano da mangiare, lui rispondeva: “Lo vedete quel che mangio io? Pane e cipolla!” E’ un bel programma di miseria per tutti, non così lontano dal contenuto di tanti nostri pensieri o di diverse ideologie. Arriva la fine, e qui arriva la mia proposta. “Sicché, quando gli dissero che era tempo di lasciare la sua roba per pensare all’anima, uscì nel cortile come un pazzo, barcollando e andava ammazzando a colpi di bastone le sue anitre e i suoi tacchini e strillava: “Roba mia vientene con me!” Tante volte ho letto questa novella, senza che producessi il pensiero che invece, mi è venuto in questi giorni. Che cosa fa Mazzarò? Uccide la sua eredità, ammazza le sue anatre e i suoi tacchini, gridando “Roba mia vientene con me!”. E’ un atto di distruzione della sua ricchezza, di odiosa eliminazione della possibilità che un altro possa usufruirne. Allora la questione che pongo è questa: “Quando uccido l’eredità?”. E’ una domanda, rispondendo alla quale senz’altro si guadagna, perché chiamar per nome gli errori propri e altrui vuol dire sicuramente guadagnarci. Si tratta di imputabilità, ben diversa dal senso di colpa che si rivela in tanti pensieri e frasi: “Siamo tutti peccatori, tutti sbagliamo”, “A fare genitori si sbaglia sempre!”. Non così: nome, cognome, indirizzo e numero civico dell’errore. Possiamo chiamare per nome il nostro errore o delitto, cogliendo l’occasione di accettare come provocazione questa domanda: quando uccido l’eredità? (E la posso uccidere dal posto di insegnante, da quello di genitore, di figlio o di amico). Quando sono Mazzarò che dà dei colpi alle anatre e ai tacchini, senza possederne? Uccido l’eredità ogni volta che non lavoro in modo tale da ottenere un beneficio. Non si tratta di produrre il bene attraverso la mediazione pedagogica, ma di lavorare in modo tale da ottenere il beneficio per mezzo dell’altro. E’ un bel capovolgimento! Ad esempio se io preparo con cura una lezione su Mazzarò o su Edipo, avrò la soddisfazione di ricevere delle domande dall’altro, a cui magari non avevo neanche pensato. Allora il beneficio non è soltanto in quel misero stipendio, altrimenti davvero l’insegnante fa soltanto il funzionario statale! Io credo che ognuno possa pensare alle bastonate che dà alla sua eredità, alla possibilità di concepirsi erede; è vantaggioso e produttivo poter nominare pensieri e atti distruttivi nostri e altrui, secondo quello che G. B. Contri chiama L’Ordine Giuridico del Linguaggio28. 27 Faccio notare che il bambino è un lavoratore e lo è anche quando gioca, magari per trovare, mettendo in scena precise situazioni, soluzione ad un suo problema. 28 Cit. 51 Il pensiero del figlio Il posto dell’adulto di Maria Antonietta Aliverti E’ bene ringraziare per l’invito a parlare, non essendo un ringraziamento di circostanza: esso è legato al fatto di aver incontrato, nella prima giovinezza, un amico, un prete, don Luigi Giussani, che mi ha aiutato a capire che l’incontro con altri è sempre interessante, e che il mondo non si chiudeva nel breve perimetro della mia città, né del mio paese. Il mondo è l’universo dei rapporti possibili, dei rapporti cioè che si possono realizzare. Seguo tuttora quel suo pensiero, e negli anni ho fatto molti altri incontri che hanno arricchito quella prima scoperta: tra gli altri, anche quello con un ebreo che avevo guardato dapprima con la diffidenza presa a prestito da alcuni miei maestri universitari, ma che poi, grazie a un amico mio e suo, ho conosciuto e apprezzato. Sto parlando di Sigmund Freud che si è occupato, con modestia e tenacia, di errori che non sono errori qualsiasi, perché ne va della vita individuale e sociale. Freud è l’unico autore del 1900 che se ne sia occupato con serietà e l’unico anche a riconoscere al bambino una competenza matura di giudizio e di parola, dopo che per primo l’aveva fatto Cristo. Il bambino, che appartiene fin dalla nascita al genere umano, sa chi è e che cosa gli piace, è curioso, attento a sé e agli altri - in particolare attento ai discorsi degli altri tra loro si muove per propria soddisfazione. Viene accompagnato, se va bene, perché se va male l’adulto pretende di sostituirlo, in tutte le prime esperienze che egli impara a riconoscere come benefici per sé. Questi adulti lo introducono alla realtà del mondo, mentre lo aiutano a scoprire le possibilità del suo corpo: dall’essere allattato al mangiare da solo, dallo stare seduto all’alzarsi, al camminare, al correre, dall’ascoltare – dato che capisce sin dall’inizio il senso dei discorsi degli adulti - al prendere la decisione di parlare. Parlare è una facoltà, non un dovere. Il bambino ama parlare, domanda con una curiosità che non si arresta di fronte a nulla, e sapendo che la soddisfazione viene dall’altro, prende l’iniziativa del dargliela per primo, onde riceverne: si è stabilita una partnership tra corpi che pensano secondo una medesima norma, ossia un rapporto. L’uomo non è una costruzione a due piani, separabile tra corpo e mente, o tra pensiero astratto e pensiero concreto, o tra razionalità e affetti. Né si può dire che ci sia sviluppo umano. C’è storia di ognuno, come seguito di avvenimenti, di incontri. Il primo, poi unico pensiero, è quello del rapporto tra Io e Universo, in base al quale si può vivere in collaborazione con altri. Rapporto non è confronto con l’altro, ma alleanza con lui, a certe condizioni. Si impara attraverso il veder vivere altri, notando (e quanto annota un bambino!) patti stabiliti e rispettati tra adulti. Un esempio può essere l’appuntamento: è quello che inizia ogni giornata, quello del pranzo o della cena, o il momento di un incontro come questo. Un bambino, come ogni altro, si incontra, non “si gestisce”, come mi accade spesso di ascoltare: “non riesco più a gestire mio figlio” o “i miei allievi”. E’ possibile vivere secondo una libera e consapevole obbligazione stabilita da noi stessi con altri, se il tempo è pensato a partire non da un “devo”, ma da un “posso”: posso pensarci, non è già tutto organizzato, predefinito. La nascita dell’Io dal Chi infantile accade nei primi anni di vita in modo sorprendente, quando si sia ancora capaci di farsi sorprendere, ma c’è per tutti un “ma”. Il bambino è ingenuo, e non s’accorge del fatto che l’altro può non costruire con lui una reale partnership, 52 Il pensiero del figlio ma limitarsi a trattarlo secondo teorie pedagogiche o psicologiche. La teoria, acquisita acriticamente da altri ben reali, blocca e corrompe il pensare individuale già costituito nella prima età. Ecco la psicopatologia, ossia “la psicologia del patologico”, secondo una utile definizione di Evelyne Pewzner. Ora, da dove nasce il pensare seguendo teorie, per cui poi capita di sentir dire “ certo, in teoria è così, ma in pratica….”? Nasce dal non ripensare, o addirittura censurare del tutto la propria infanzia, dal non voler neanche pensare a cosa possa significare la frase “se non ritornerete come bambini”, non conoscerete la soddisfazione. Così noi adulti ci consegniamo più o meno coscientemente alle teorie culturali più diverse, in cui la parola rapporto è sostituita da altri lemmi quali interazione, comunicazione, socializzazione, come se un concetto fosse sinonimo di un altro. E le teorie restano in memoria, accanto a questioni irrisolte quali: chi sono io? Chi sono gli altri? Come può avvenire la relazione? Questioni che ritorneranno negli anni successivi con tutti i problemi di identificazione, i dubbi, le incertezze, le confusioni possibili, accompagnati dalla resistenza a riprendere in mano la propria storia personale per correggere deviazioni più o meno cospicue da quel primo orientamento del pensare che prometteva così bene. Tra la nostra età adulta e l’età infantile, per esempio, è teoria comune l’interporre l’adolescenza, che oggi può prolungarsi ben oltre i trenta anni. In realtà l’adolescenza non è un’età, ma spesso una perdita di tempo rispetto al concludere su come si voglia vivere. E’ un specie di limbo, perché la persona ritiene di non poter più scegliere non riconoscendo di avere un criterio di scelta che resti valido. Così, se il bambino è ingenuo, l’adulto può sistemarsi in un infantilismo che giustifica ogni comportamento proprio e accusa ogni comportamento altrui come causa della propria insoddisfazione. E, tuttavia, è solo l’adulto che può trovare un’altra strada, verso una innocenza che non può essere del bambino. L’innocenza è un esito legato a un permanente lavoro su di sé, per poter, di volta in volta, occupare il posto di figlio. E’ il figlio che riconosce, cioè conosce una seconda volta, il padre: si tratta, qui, di un autentico rapporto, in cui può essere generata una forma nuova del pensare. Giacomo Contri, nel precedente incontro, ha detto che il figlio non è fatto, ma è generato e, se generato, allora è anche erede. La generazione è un lavoro in cui è implicato un tempo e un ordine non qualsiasi del pensare. Si tratta di pensare secondo due posti, un pensare in cui è implicato il giudicare, avente come scopo una soddisfazione comune. Il pensare del figlio è quello di un Io adulto che difende chi è ed è pronto a ogni ulteriore profitto. Per questo si muove con una propria iniziativa nell’incontro con ogni altro, senza diffidenza e senza ingenuità, chiamando altri a condividere la prospettiva di una ricchezza ereditabile. Non si possono ereditare i mali, vale la pena di ereditare dei beni. Possiamo chiederci: quali beni, e da chi, ho ereditato oggi ? Si può conoscere solo ciò che si eredita, e si può avere l’ambizione di ereditare se si scopre di poter vivere secondo un pensiero di natura, che è il nome dato nello Studium Cartello al principio di piacere di Freud. E dato che il dire è un fare con l’altro, siamo imputabili anche di ciò che diciamo, il che è una buona notizia. Posso concludere con un esempio, reale, che chiarisce una delle affermazioni più interessanti di Freud, “il bambino è il padre dell’adulto“, che ribalta ogni idea di sviluppo del pensare umano. Ecco il fatto. Un giovane padre ha tradito la moglie, questa lo ha scoperto, è seguito un periodo di pianti e discussioni in famiglia, in cui il clima non è obbiettivamente sereno. Una sera il padre dice al figlio di quattro anni: “Vedi, ho fatto un errore, e adesso tutti ce l’hanno con me“. Il bambino lo guarda sorridendo e risponde : “Basta che tu non lo faccia più“. E’ la conferma dell’affermazione di Freud. Vi ringrazio per l’ascolto. 53 Il pensiero del figlio Genitore. Una professione? C’era una volta il bambino 29 di Maria Antonietta Aliverti A proposito del titolo “C’era una volta il bambino” vale la pena di intenderlo come “C’era una volta il bambino Giovanni” o “C’era una volta il bambino Giuseppe”, ossia non esiste il bambino come categoria astratta ma esistono i bambini, e questa è una buona notizia per tutti. Tutti, infatti, sono stati bambini, e questa esperienza è rimasta in qualche anfratto della memoria: ripensare alla propria infanzia significa scoprire una competenza di pensiero che spesso, in epoca successiva, si ritiene di aver persa per sempre. Una seconda annotazione: il lavoro di un genitore è una professione? E’ certamente un lavoro ma non ha niente a che vedere con una professione e anche quando poi, nella vita, si sia professionisti, è bene ricordare che quella competenza cui accennavo sopra serve anche a giudicare come si sia professionisti. Essere professionista è un caso dell’essere adulti. Come si arriva a essere adulti a partire dall’infanzia? Ci si arriva passando per la pubertà, fatto biologico preciso per cui, da lì in avanti, si possono avere bambini: parlare di pubertà consente di farla finita con tutte le teorie sull’adolescenza, concepita come una sorta di limbo, di “già e non ancora”, in cui è facile ritrovarsi confusi fino a rimandare ogni decisione, conservando anche in una età ben più avanzata un modo di pensare gravato da conflitti instauratisi in quel limbo. Nella persona esiste storia, non semplice sviluppo. Se è vero che esiste una crescita che può essere valutata dalla medicina (pensiamo al bambino prima incapace di stare seduto, poi capace anche di camminare e correre), bisogna ricordare che l’individuo eccede i parametri medici. Il corpo è solo umano, è individuale, e nessun altro ha giurisdizione in questo campo, se non il proprio io. Il neonato ha già una vita psichica: quando ha fame e viene allattato si tranquillizza, giudica di aver ricevuto questo apporto da un altro, ossia sa fare esperienza di soddisfazione, e questa gli resta in memoria. E’ una memoria ancora non cosciente, una memoria corporale, che è tale essendo l’uomo uomo dall’inizio. La caratteristica del corpo umano è il pensare, che è altro dall’associare dell’animale. Così, se pensiamo al bambino, ci accorgiamo che il suo primo giudizio è: “Questo mi piace, quello no” e il secondo è: “Tu, che mi tratti così, mi piaci oppure no”. Non è automatico né scontato che l’adulto piaccia al bambino, non si tratta di niente di causato biologicamente, stante che non siamo dotati di alcun istinto, e questa è una importante scoperta. Tra i tre e i cinque anni il bambino nota che l’altro che gli risponde in realtà sono due: sono un uomo e una donna e diventano rilevanti perché il piccolo nota, tra altre, la differenza di sesso. Nella normalità questa differenza vive della distinzione dei posti tra soggetto e altro in modo intercambiabile. Uno dei primi errori, gravido di conseguenze negative, è quello di ribaltare la differenza dei sessi, fissa, sulla distinzione dei posti, che è mobile. Che significa? Vuol dire che non esistono ruoli predefiniti o funzioni prestabilite maschili o femminili: uomo e donna possono incontrarsi per un arricchimento reciproco. Non è una questione di complementarietà, di due metà che si mettono insieme per fare un’unità: questa idea del 29 Si è ritenuto opportuno, vista l’affinità degli argomenti trattati, inserire questo articolo, sintesi di due relazioni, tenute dalla dr. M.A. Aliverti rispettivamente a Trento nel 1999 e a Rovereto (TN) nel 2000. 54 Il pensiero del figlio rapporto tra uomo e donna deriva da un mito greco riportato anche da Platone. Come si vede, esistono errori di lunga data. E qual è il lavoro dell’adulto? Consiste nel favorire la possibilità della soddisfazione in altri, e per questo può coincidere con la quotidianità. Può lavorare così chi si riconosce figlio. Noto che figlio e bambino non sono automaticamente sinonimi. Il bambino, pur competente per quanto lo riguarda, è ingenuo, cioè impreparato al danno che gli può venire da qualcuno che fin lì gli andava bene, il figlio, esperienza adulta certa, è qualcuno che sa che ingenuità non è innocenza: l’innocenza è ciò a cui mira l’adulto, distinguendola dall’ingenuità che, per altro, denunciata in età adulta, è solo infantilismo perseguito individualmente. Diventare figli è un avvenimento, esito di rapporto con altri e può non accadere: se non accade apre la strada a tutta la psicopatologia, clinica e non. Si può aver cura, attenzione, attesa per questo accadere anche in altri. Allora diventa interessante pensare all’esperienza infantile, in cui ognuno era capace di dire: “Questo mi piace, quello no”. Ogni bambino ha un principio di piacere ben costituito in se stesso; essendo stato soddisfatto per anni affronta la relazione con tutto il reale con questo “apparato” della soddisfazione. Gli interessa la realtà umana prima della realtà delle cose. Questo interesse è ciò che l’adulto può innanzitutto prendere per sé dall’esperienza infantile, così come può scoprire di avere un criterio personale sano per orientarsi nelle scelte: “ So chi mi va bene e chi no”. Non ci sono, infatti, bene e male come categorie astratte dal vivere, ma si tratta di beneficio o di maleficio che mi viene da altri. E’ questa la questione principale su cui ha lavorato Freud, unico autore del 1900 che si sia occupato con modestia e tenacia del pensare umano, fino a riconoscere nel pensiero infantile una fonte per capire anche la patologia del pensare adulto. Prima di Freud c’è stato, nei tempi antichi, Agostino di Ippona, che ha descritto i suoi pensieri infantili come un finissimo psicologo. L’iniziativa ancora ingenua del bambino e quella dell’adulto che, riconoscendosi figlio, vuole ogni relazione come una relazione di guadagno, è la domanda: essa conferisce potere all’altro, in quanto la competenza nel domandare riconosce all’altro un “Tu puoi”. E’ una domanda posta come offerta perché l’altro possa accettarla. E’ una legge, quella della domanda e dell’offerta, che vale per il singolo, ma anche per tutti gli altri e così facendo si costruisce un universo che è altro da quello studiato dai fisici o dagli astronomi: è l’universo umano, che è ancora da edificare. Saper tenere il proprio posto consente di tener libero, nel proprio pensare, un posto per un altro che lo sappia occupare. Distinzione dei posti significa possibilità di guadagno, di ricchezza per entrambi, dato che non esistono a priori funzioni o ruoli prestabiliti, se non in alcune tra le più comuni teorie patologiche. Posso fare qui l’esempio della teoria della mancanza, che poi necessita di essere colmata dall’altro, ossia la teoria della complementarietà: tra soggetto e altro, anche lui soggetto, esiste possibilità di supplemento, di arricchimento, perché il soggetto non manca di niente. C’è una facoltà che potremmo chiamare talento negativo, di arricchirsi facendo spazio a un altro. Si tratta della facoltà di saper ricevere, facoltà individuale visibile in ogni bambino ancora sano. Il bambino è un giudice competente circa le proprie relazioni: fa le sue inchieste sul mondo e può scoprire che alcuni testimoni sono poco attendibili. L’adulto spesso si affida a teorie pedagogiche o psicologiche e pensa di dover educare il bambino, anziché semplicemente rapportarsi con lui. C’è la possibilità che il primo inganni il secondo testimoniando un piacere che non prova, o immettendolo nella strada del “Non ti piace, ma si deve”, soprattutto se l’adulto vive per sé stesso questa unica legge del “Si deve”. L’inganno, in tal caso è sull’amore, ossia corrisponde alla frase “Lascia perdere il tuo 55 Il pensiero del figlio pensiero, che, in quanto pensiero, è già amore, in nome di un altro pensare, astratto rispetto alla tua esperienza”. La relazione può diventare un estenuante mettersi d’accordo in cui il bambino, disorientato dallo scoprire che l’altro gli propone una norma diversa dalla sua, non sa più come comportarsi e questo non sapere più si protrae negli anni in dubbi, scrupoli, confusioni di ogni sorta, a testimoniare che il pensare è entrato in crisi. Il pensare umano normale si muove per uno scopo. Se lo si perde, allora si può girare all’infinito su pensieri i più diversi, ma senza alcuna soddisfazione: è la patologia Lavorare con i bambini anche malati consente di osservare come essi siano ancora in presa diretta con il principio della soddisfazione, per cui a volte non ci vuole molto, ma ci vuole un adulto che sappia di che cosa si tratta, un adulto che favorisca quindi un incontro aspettando con pazienza l’iniziativa dell’altro. Quando la difficoltà è, invece, dell’adulto, il lavoro risulta più lungo, perché si tratta di reimparare a porsi secondo un’imputabilità premiale, cioè in modo da ottenere beneficio dall’altro. Occorre, in ogni caso, un totale rispetto per la persona, che è possibile solo nel rispetto della sua competenza di pensiero. Non c’è rispetto dell’altro se io penso al suo posto. Occorre darsi e dare all’altro il tempo necessario, perché si possano riconsiderare i propri errori, scoprendo che sono correggibili, perché si apra un orizzonte nuovo, l’interesse cresca, la vita si arricchisca e l’esperienza diventi la memoria di ciò che è andato a buon fine. Un adulto così sarà ricercato tanto dal bambino quanto da altri, perché è solo un ricco che può insegnare a altri come arricchire. Cambia, in questa esperienza di rapporto, la stessa concezione del tempo, non più caratterizzato o da noia o da affanno come nella patologia, ma come opportunità da far fruttare per sé e per l’altro. Nella guarigione si scopre un nuovo posto, occupabile a piacere, un posto che consente di incrementare il proprio guadagno in ogni senso, dato che il terreno su cui si può muovere questo pensiero non ha limiti. 56 Il pensiero del figlio Potere e volere di Angela Cavelli Un Soggetto è qualcuno che si muove perché ha un interesse, che lo mobilita, verso qualcosa che ancora non ha e che potrebbe ricevere da un altro, perché dunque“gli va”, gli “va bene” qualcosa. Ricordo che, quando insegnavo alle Scuole Elementari, qualcuno chiese ai bambini che materia preferissero, ottenendo questa risposta: ”L’intervallo”. Alla domanda poi sul perché qualcuno volesse fare l’insegnante da grande, la risposta fu: “Perché le maestre alle 10 e 30 bevono il caffè che porta la bidella”. Mi sembrarono delle buone risposte: a loro qualcosa andava, qualcosa in quella scuola andava loro bene, infatti venivano a scuola volentieri. Noi insegnanti naturalmente incominciammo a chiederci come mai le nostre lezioni non fossero così interessanti come l’intervallo. Seppi anche di una bambina che aveva chiesto: ”Perché andare a scuola non è bello come mangiare?” Anche questa domanda ci interpellò, perché in effetti l’apprendere potrebbe diventare bello come il mangiare. La domanda come iniziativa Una domanda è una iniziativa. Faccio un esempio. Se un allievo fa una domanda all’insegnante, questa è una libera iniziativa di un soggetto che ha fatto prima un lavoro di pensiero e poi si è mosso per porre una domanda; non sto parlando di qualcuno che butta lì una cosa solo per far passare il tempo, ma di qualcuno che ci ha pensato prima di porla, ha cioè fatto un lavoro; ebbene, se l’altro, l’insegnante, si mette in moto per rispondere a questa iniziativa, cioè fa un lavoro ulteriore e in questo valorizza la domanda dell’allievo, ne nasce qualcosa che prima non c’era e cioè un profitto per entrambi, frutto di lavoro su lavoro. Possiamo chiamare questo un rapporto di partnership, in cui c’è arricchimento intellettuale sia per l’allievo che per l’insegnante. E poiché l’affezione non è slegata dal lavoro intellettuale, possiamo chiamare questo lavoro su lavoro l’inizio di un rapporto. Dapprima, quando insegnavo alle Scuole Elementari, non mi rendevo neppure conto dei bambini che avevo davanti, non li vedevo neanche, tutta presa com’ero dal programma, li trattavo come teste da riempire il più possibile, tanto da compromettere anche l’intervallo. Non mi accorgevo che loro avevano un pensiero e il pensiero quando è normale è sempre amoroso, cioè pronto a cogliere l’interesse dell’altro per farlo diventare proprio. Trascuravo così l’occasione di passare loro la mia voglia, il mio investire su ciò che facevo. Quando mi resi conto di essere io la prima a non essere portatrice di interesse per ciò che insegnavo, mi tolsi dalla fissazione del “devo fare tanto”, “devo fare tutto io” e mi incontrai allora nella loro collaborazione. Proposi, per esempio, in una terza elementare un lavoro sulle regioni, dando delle tracce, delle indicazioni su come classificare i dati: le caratteristiche del suolo, le coltivazioni, le industrie e altro ancora. Questa ricerca piacque talmente, non per il metodo, ma per il fatto che avessi fatto loro venir voglia di lavorare, lasciando loro spazio, che mi ritrovai tra le mani un lavoro enciclopedico degno di una ricerca universitaria. In questo caso ero stata io il Soggetto di una iniziativa che loro avevano raccolto e su cui avevano lavorato abbondantemente. Raccolsi più di quanto avessi seminato. Mi ricordo di un’amica che portò 57 Il pensiero del figlio all’Università una ricerca storica fatta dai suoi allievi in quinta Elementare, ricevendone 10 e lode. E’ un po’ per dire che l’Università incomincia dalle Elementari. La mia iniziativa, che possiamo anche chiamare un “mi va” in andata, è stato l’anticipo di ciò che avrei ricevuto: poteva anche andare male, ma anche questo andare male mi sarebbe servito come correzione per una prossima volta, e il “mi va” finale è stata la buona sorpresa per il lavoro concluso con l’aiuto di altri. Il “mi va” è mobilitante, il “devo” no L’interesse, il “mi va” è mobilitante, il “devo” non lo è. A uno studente del penultimo anno di Liceo andava di seguire le orme di suo padre e indirizzarsi verso gli studi di ingegneria civile, per poi lavorare nella sua ditta di costruzioni. Aveva dunque ereditato l’interesse del padre, perchè non si ereditano solo i soldi paterni, ma anche gli investimenti, gli interessi. Studiava con profitto perché aveva l’idea di ciò che avrebbe potuto fare in futuro. Succede qualcosa: lanciano lo Sputnik, il primo satellite artificiale e questo avvenimento, frutto di un lavoro d’altri, gli fece venire una nuova idea. Incominciò a pensare che avrebbe voluto lavorare nelle ricerche spaziali, un campo che si apriva in quel momento. Finiti gli studi liceali, si iscrisse alla Facoltà di fisica. La sua strada ebbe inizio e divenne così un astrofisico. In questo caso lo “Sputnik” è l’esito di un lavoro che hanno fatto altri: il giovane uomo si è trovato a esserne beneficiario e a potersi dire: “lo voglio anch’io”. Con questo “mi va”, rispetto al lavorare alle ricerche spaziali, egli anticipa il beneficio che ne avrebbe ricevuto. E prende l’iniziativa di seguire quella strada, già certo del beneficio. Si può dire che questa persona ha ereditato l’interesse del padre, ma non vi si è fissato; quando al suo orizzonte gli si presenta altro, investe su quello. Cosa ha fatto? Ha spostato l’interesse ricevuto dal padre su altro, con libertà. Se questa persona invece avesse detto: ”Devo seguire mio padre perché è mio padre, e dunque devo, non perché mi piace, mi interessa, mi va, non avrebbe mai trovato la propria strada. Vi ho mostrato la differenza tra la posizione dura e pura del “Devo fare come mio padre”, che è la strada dell’identificazione, e quella libera del “posso”, cioè dell’iniziativa, del Soggetto che segue il proprio principio di piacere. Soggetti e sottomessi Se il Soggetto si muove verso qualcuno e verso qualcosa, perché ha il pensiero di ottenere un di più, un profitto, di ricevere insomma qualcosa che prima non aveva, il sottomesso si muove per comando, perché “deve”, perché è un compito a cui si è sottomesso, perché lo vogliono i genitori, o perché tutti fanno così. Diciamo che un po’ tutti a scuola abbiamo seguito questa strada, soprattutto alle Superiori, non c’è di che scandalizzarsi: il nostro muoverci era un misto di dovere, di “tutti fanno così” e il “mi va” era legato al fatto che in ogni caso is trattava poi di un’occasione per incontrare gli amici, per chiacchierare nell’intervallo o giocare al pallone. Ma fare le cose solo per dovere impedisce al pensiero di andare liberamente verso la percezione del vantaggio che si può ottenere nel passare quelle ore a scuola, e poi appesantisce perché non è soddisfacente per nessuno. Gli allievi solo sottomessi al dovere devono essere continuamente richiamati a stare attenti, perché appunto il dovere non è mobilitante e ciò risulta pesante anche per gli insegnanti. Sono lì loro stessi sottomessi al 58 Il pensiero del figlio dovere di insegnare e costretti a tenere la disciplina, di spingere perché gli allievi facciano … il minimo. In questi casi l’insegnante non è certo visto come un partner per un profitto. La posizione libera dell’insegnante Ma qual è la posizione dell’insegnante che può permettere a un allievo di riprendere il pensiero del proprio vantaggio anche riguardo alle materie scolastiche perché arrivi al “mi va?” L’insegnante ha questa occasione quando ha già lui stesso una pista personale, gli va la sua materia, e il suo aggiornarsi è legato non semplicemente al fatto di avere un ruolo, di far parte di una istituzione, ma al suo interesse. Allora per lui ogni occasione è buona per prendere dai libri, dai giornali, dai colleghi, dai dibattiti. Tanto che si potrebbe dire che il suo lavoro lo fa per sé, ed è per questo che gli risulta soddisfacente, guadagnandoci, in più, uno stipendio. Oltre a ciò, se uno è in questa posizione, non sarà lì a “pretendere” dagli allievi la soddisfazione di quello che fa, ma eventualmente la soddisfazione dagli allievi gli arriverà anch’essa come un di più, in modo sorprendente. La posizione di chi “pretende” la soddisfazione dai propri allievi e dai propri figli è come quella posizione di una mia amica che una volta mi disse: ”I miei figli non capiscono i sacrifici che io ho fatto”. Io le risposi: “Ho sbagliato in tante cose, ma non ho mai preteso questo, perché toccava a me fare le cose che desideravo fare, e se non le ho fatte è perché mi sono tirata indietro, per cui il mio non fare lo imputo a me”. Questa persona si era posta dei limiti quanto a ciò che avrebbe potuto fare, negli studi e nel lavoro, restando poi preda dell’invidia e trattando male o ironicamente chi aveva concluso più di lei. Era però una cattiveria spacciare dei limiti autoimposti per sacrifici fatti per amore dei figli. Non so se la mia frase l’ha aiutata, comunque ora è direttrice di una scuola, è riuscita dunque a raggiungere ciò che desiderava, ma che prima non si permetteva, lasciando così in pace figli e altri. L’insegnante che ha una pista personale è affascinante per gli allievi, perché qualcuno che investe su ciò che fa può dare l’idea all’allievo che sulla realtà si può investire per un profitto. In questo caso, l’insegnante che ha una propria pista personale, non è sottomessa al dovere, ma è nella posizione libera del “mi va”. L’inibizione Ora farò un esempio di inibizione intellettuale, di arresto del pensiero: in tal caso non ci si mette più a lavorare, non si investe più per ottenere un profitto. Non si riesce più a imparare, a prendere. E’ esperienza comune notare come alcuni allievi pensino di non essere capaci in qualche materia, per cui infatti dichiarano di “non essere portati”. E’ interessante questa parola, che in realtà significa che non si è stati condotti da qualcuno ad avere gusto per quella materia, che spesso è la matematica. Un’amica mi raccontava che, quando lei era piccola, le avevano detto che non era fatta per la matematica, allora lei l’aveva lasciata da parte, pensando: “non fa per me”. Questo giudizio aveva limitato il campo del suo interesse e lei non aveva più lavorato in quel senso. Non era arrivata fortunatamente a dire: “Non ne voglio più sapere, mettiamoci una pietra sopra”, l’aveva semplicemente accantonata. Era stato messo un limite al suo pensiero, mentre il pensiero è illimitato. Ma, nel suo caso, era bastato l’incontro con qualcuno che le ha detto: ”Perché no?”, per toglierla da questa sottomissione a un giudizio altrui che l’aveva limitata nei suoi interessi. Questo intervento le aveva fatto addirittura guadagnare dei buoni voti in questa materia, e un buon voto è un giudizio di profitto. 59 Il pensiero del figlio Perciò, nei giudizi che si danno agli allievi o ai figli, è meglio essere particolareggiati nel puntualizzare un errore e dire: “Questa parte non l’hai studiata, riprendila”, piuttosto che dire “Non sai studiare” o “Non fai mai niente”; è meglio precisare: ”Questa frase non sta in piedi per questa ragione…”, piuttosto che dire: ”Tu sei negata per l’italiano”: certe attribuzioni limitano il pensiero. Ma voglio portare un altro esempio, presentando un brano tratto da un mio libro, in cui racconto, sotto lo pseudonimo di “Vaga”, come sono intervenuta presso mio figlio per fargli riprendere il gusto dello studio. Scrivere libri è il mio modo di fare ordine nella mia vita, nei miei pensieri, di riprendere le correzioni che altri mi hanno fatto e che mi hanno portato a rimettere in auge il pensiero della soddisfazione. In questi libri c’è la mia storia sotto forma di romanzo e in più punti parlo dei due figli che mio marito e io abbiamo adottato quando loro avevano uno otto e l’altro nove anni. Premetto che il figlio di cui qui parlo è il maggiore dei due. Quando è venuto da noi aveva già una bocciatura alle spalle, che viveva come una sconfitta, o meglio come un fallimento, e di cui non ha mai voluto parlare. Data la sua situazione familiare, non aveva probabilmente ereditato il pensiero del profitto da trarre dal sapere e dalla cultura, dell’utilità per lui dell’andare a scuola. Inoltre, lasciava sempre l’iniziativa di parlare al fratello minore, che naturalmente faceva di tutto per imporre la sua idea. Il brano che adesso vi leggerò ha a che fare con la situazione di impasse in cui alle Superiori mio figlio si è ritrovato, mentre nei due anni delle Elementari e delle Medie le cose erano andate avanti senza particolari problemi, perchè egli aveva accettato di far proprio il nostro pensiero, che era poi quello dell’utilità del prendere, e dell’apprendere, dalla scuola. Mio figlio dunque frequentava un Istituto Tecnico Superiore e, verso la fine di quell’anno scolastico, doveva preparare tutto un programma di Italiano e di Storia, un lavoro di mesi, immenso, perché gli mancavano molte interrogazioni. “E Vaga se l’era preso vicino e aveva cominciato a spiegare la sintassi del periodo, richiedendo poi al figlio degli esempi. Dall’altra parte ottenne dapprima un brontolio, seguito da una litania ininterrotta di bestemmie elargite a piene mani e poi via via, qualche frase d’esempio esattamente contraria alla logica. E Vaga, sempre più divertita, incominciò a sperare. E ogni sera si metteva con foga a spiegar liriche, a rivoltar romanzi, a tracciar schemi, riassunti, sintesi fino a che Lucio si decise a scrivere e a raccontare lui stesso, incuriosendosi anche a quelle avventure inedite. E così a Vaga venne l’idea che il figlio fosse un intellettuale in potenza perché sapeva collegare pensieri filosofici e avvenimenti. “Mi ha spiegato la teoria hegeliana e marxiana” disse spalancando gli occhi la professoressa di italiano“ e in classe l’han guardato come non l’avessero mai visto e fuori gli han pagato da bere. L’ha saputo anche la bidella! ..” Che cosa ha reso possibile questo successo? La prima persona che pensava che le difficoltà scolastiche fossero una questione superabile ero io: sapevo che mio figlio aveva difficoltà non perché fosse nato così, ma perché non riusciva a pensare di potercela fare, coprendo questo pensiero con un: ”Non me ne frega niente”. Se io avessi esordito con un: “Non capisci niente”, non avrei fatto altro che confermare il suo pensiero negativo e non gli avrei dato nessuna possibilità, anzi avrei aggravato la sua inibizione: questa frase sarebbe stata una vera e propria offesa. Non avrei, del resto, potuto pronunciare questa frase, soprattutto perché la mia posizione era un’altra: non era quella di una strategia guerresca, del corpo a corpo, del “Non dire parolacce”, né quella del “Mettiamoci d’accordo” e neppure del “Poverino come t’ha 60 Il pensiero del figlio fatto male mamma”. La mia posizione derivava dalla certezza che si trattasse di inibizione del pensiero, cioè di arresto, di impedimento del pensiero. Con il mio modo di fare gli ho trasmesso la possibilità di un pensiero nuovo, l’idea che anche lui poteva prendere dalla realtà della scuola e farsene qualcosa, perché l’inibizione non è l’ultima parola. Devo dire che in effetti mio figlio riuscì a terminare la scuola, anche se, a tutt’oggi, non è ancora in una situazione risolta, soddisfacente. Non sono bastati i momenti di successo, io ve ne ho raccontato uno, che pure ci sono stati, a farlo rinunciare al pensiero di non essere capace. Che cosa ho ricavato da questa esperienza? 1. C’era stata una disdetta del “mi va” rispetto alla scuola e dunque mio figlio aveva deciso di non provarci più, pensandosi incapace. Il Soggetto è il Soggetto del “mi va” sia dal lato della meta personale, sia dal lato del successo in termini di voti, in questo caso, di profitto scolastico. Se ci sono troppi insuccessi, e lui alle Superiori ne aveva avuti, e anche prima, il prender gusto a studiare viene disdetto. A questo vanno, certo, aggiunti gli errori patogeni miei e di mio marito e la sua rinuncia al proprio pensiero rispetto al fratello: tutto ciò aveva fatto sì che restasse solo con il dovere di studiare rispetto al quale si era sentito incapace, e lì si era attestato. Il “Non sono capace” non va mai preso come vera rappresentazione, è una falsa rappresentazione; la vera rappresentazione è: ”Tu mi dici perché devo fare questa cosa, ma io non vedo perché la devo fare. Mi resta solo che la devo fare e allora non ci riesco”. Se il pensiero di base è “Non posso”, “Non sono capace a niente”, non c’è più un “mettercisi”, un “mi va”: ci si impunta sul “devo studiare”, e a studiare non ci si riesce. Alla fine si arriverà a dire: ”E’ troppo tardi”. 2. La crisi era scoppiata con il passaggio all’adolescenza, con la maturità sessuale; la crisi può anche scatenarsi prima, ma solitamente - direi che è una costante anche in tanti altri casi di insuccesso - con l’adolescenza, e con le nuove questioni provenienti dalla maturità sessuale, viene a galla un pensiero su cui ci si era attestati prima. Mio figlio, dopo i quattordici anni, aveva infatti abbandonato il pensiero che gli avevamo trasmesso di potersene farsene qualcosa della scuola, e aveva ripristinato, quello di fallimento precedente. Ma il pensiero attestato sul “Non sono capace”, coperto da una giustificazione, dal “Non me ne frega niente”, è un pensiero malato. 3. La difficoltà scolastica divenne poi difficoltà sul lavoro che, alla prima occasione, alla prima difficoltà. Abbandonava per cercarne un altro. E’ questo l’esito di una carriera negativa. Se non c’è ripresa del pensiero di poter profittare della realtà, si resta nella sottomissione e non si passa alla soggettivazione, quella al lavoro, che è del Soggetto, implicante un “mettercisi”. Non è che mio figlio non avesse del tutto il gusto del lavoro o della scuola, ma non in misura tale da scuotere l’idea di fondo di “non essere capace”: c’era un vuoto di pensiero rispetto alla propria capacità. E’ riuscito, infatti, a lavorare fino a 27 anni sia pure con vari cambiamenti, poi però è incominciata una parabola discendente, e l’unico modo che egli ha trovato attualmente per riprendere è stato quello del tirare a campare, in attesa di un miracolo. Non è ancora libero, non ha ancora il pensiero di concludere su ciò che vuol fare nella vita. E’ come sospeso. Chi cresce nella vita è perché ha una prospettiva per il futuro e lui non ha ancora questo pensiero. La persona, in cui l’esperienza del “Mi va bene” non è stata troppo disdetta, recupera facilmente, ma se l’esperienza del non andare è stata troppo forte, per cui è diventato predominante il “Non mi va”, l’andar bene di qualcosa rimane solo un caso che non intacca 61 Il pensiero del figlio il presupposto ”Il mio destino è che mi vada male”. L’esperienza del successo è pur qualcosa, ma non diventa determinante; basta una discontinuità, un incidente, una qualche non riuscita e rispunta ancora il pensiero secondo cui il mio destino è quello di andare male. C’è tuttavia una imputabilità in questo impuntarsi sull’ “ormai è troppo tardi”. Nel caso di mio figlio, ora tocca davvero a lui di accettare di incontrare qualcuno affidabile che possa dargli una mano e toglierlo dall’impasse. Ma l’iniziativa adesso è sua e di nessun altro. E questo vale non solo per lui, ma anche per altri che sono in questa condizione di inibizione. Io preferisco pensare che mio figlio sia ancora nella situazione del figliol prodigo che ha dissipato i suoi averi, i suoi talenti, ma che non sia ancora detta l’ultima parola, come la parabola insegna. 62 Il pensiero del figlio Inchieste alla Maigret di Maria Grazia Monopoli Il Maigret di Georges Simenon è un uomo contraddittorio, Quando Pyke, “l’uomo di Scotland Yard”30, durante un viaggio in treno nel corso di un’inchiesta che egli segue come osservatore, gli chiede: “Lavorare le piace, non è così?”, risponde: “Non saprei”. E Simenon commenta: “Era vero. Da un lato, Maigret imprecava ogni volta che qualcosa veniva a interrompere il suo tran tran quotidiano, dall’altro, se lo lasciavano in pace anche solo per pochi giorni si incupiva e si faceva prendere dall’ansia”. Maigret oscilla, dubita anche del proprio modo di lavorare, rifugge infatti da discorsi sul metodo, ma teme il giudizio dei colleghi inglesi cui immagina appartenere un più rigoroso procedere: “Cosa poteva pensare di lui l’uomo di Scotland Yard? Era venuto per studiare i ‘metodi di Maigret’, e Maigret metodi non ne aveva”31. “Era oltremodo imbarazzante. Pareva di vederlo, di ritorno a Scotland Yard, radunare i colleghi (magari davanti a una lavagna) e scandire: ‘Un’inchiesta del commissario Maigret ..’. E se faceva fiasco? Se era uno di quei rompicapo alla cui soluzione si arriva solo dieci anni dopo per puro caso?”32. “Stava facendo una buona figura? Quelli di Scotland Yard avevano forse un piglio più sicuro fin dall’inizio di un’inchiesta?”33. E quando Pyke che evidentemente, è lui, questa volta – ironia di Simenon! -, a immaginare un Maigret cartesiano, gli chiede: “Il treno non l’aiuta a pensare?”, risponde: “Mah, io penso così poco!”. E ancora, alla domanda “Insomma lei non sa quale sia il bandolo della matassa?”, la risposta è: “Proprio così. E non so nemmeno se c’è un bandolo ..”34. A un certo punto, sotto lo sguardo indagatore dell’inglese, Maigret arriva persino a dubitare del proprio modo di registrare le notizie: “L’inglese si aspettava che Maigret prendesse appunti?”35. Oppure si lascia indurre, contro le proprie abitudini, a interrogatori formali: “Non aveva nessuna voglia di procedere agli interrogatori. Perché mai aveva detto di sì quando l’ispettore Lechat glielo aveva proposto? Per vigliaccheria di fronte a Pyke? Di norma si comincia un’inchiesta interrogando la gente, no? Non si fa così in Inghilterra? Lo avrebbero preso sul serio se si fosse messo a gironzolare per l’isola come uno sfaccendato?”36. In fondo Maigret è un angosciato, dubita di se stesso, teme di deludere l’altro supposto possedere la giusta teoria, il giusto “metodo”, circa il “si fa così”: “E’ deluso, Pyke? … E’venuto in Francia per conoscere i nostri metodi, ma, come avrà visto, non ne abbiamo”37. “Immagino che da voi, Pyke, le inchieste vengano condotte in modo molto sistematico, vero?”38. “Dipende – gli risponde Pyke. Per un delitto avvenuto un paio d’anni fa a Brighton un mio collega è rimasto undici settimane in albergo, passando le giornate a pescare con la lenza e le serate a bere birra insieme alla gente del posto”. “Esattamente – commenta Simenon – quello che Maigret avrebbe voluto fare e che non aveva fatto proprio a causa di Pyke”. Anche a lui “sarebbe piaciuto per esempio starsene in piazza sotto il sole, a fumare la pipa 30 G. Simenon, Il mio amico Maigret. Le inchieste di Maigret, Adelphi, Milano 1999, p. 20. Ivi, p. 20. 32 Ivi, p. 24. 33 Ivi, p. 32. 34 Ivi, p. 24. 35 Ivi, p. 36. 36 Ivi, p. 45. 37 Ivi, p. 151. 38 Ivi, p. 56. 31 63 Il pensiero del figlio guardando i giocatori di bocce che avevano cominciato una partita in piena regola; gli sarebbe piaciuto gironzolare per il porto, guardare i pescatori che rammendavano le reti; gli sarebbe piaciuto guardare tutti i Galli e i Morin di cui gli aveva fatto cenno Lechat”39. Quello di Maigret non sarebbe, però, uno sguardo accidioso e pigro, a condizione che egli riuscisse ad autorizzarsi pienamente ad esso, senza farsi sconcertare dal sospetto che esistano metodi più sicuri e veloci, come quelli, per esempio, supposti appartenere agli investigatori di Scotland Yard. Il suo procedere non è affatto futile e fatuo, mira anzi alla ricostruzione dell’imputabilità in un delitto, è un procedere che rifugge, però, dalla precostituzione di teorie astratte, di bandoli di matasse preconcette, da sistematiche tecniche inquisitorie cui sottomettere la realtà per forzarla a corrispondervi, il suo è un procedere che parte dall’attenzione, dall’ascolto, dall’osservazione dell’altro con cui entra in rapporto. Tanto più che le teorie astratte, pensa Maigret, contengono anzitutto un’astrazione, quella secondo cui il criminale si muoverebbe in base a una razionalità che valuta le conseguenze, sapendo dunque perfettamente quello che fa. Al contrario: “ I veri delitti nascono un po’ per caso I nostri giovanotti hanno cominciato un po’ per gioco, senza chiedersi dove quel gioco li avrebbe portati. Sembrava quasi un bello scherzo. Rifilare a una vecchia rincitrullita, ricca a palate, dei quadri con tanto di firme illustri! Ed ecco che una mattina un tizio qualunque, un Marcellin, sale a bordo in un momento inopportuno .. Vedrà che gli psichiatri discuteranno sul loro rispettivo grado di responsabilità”40. Quello di Maigret è un modo utilizzabile come paradigma per ripensare tutti i pedagogismi da cui noi insegnanti siamo bombardati, tutte le teorie educative e didattiche, o della comunicazione, che frappongono fra noi e la nostra esperienza un’astrazione, un’astrazione dal soggetto in quanto pensante qui ed ora, ivi compresi gli errori di pensiero. Potremmo anzitutto esserne aiutati a ripensare alla forza seduttiva – da cui lo stesso Maigret è tentato - dell’idea che incontrare l’altro attraverso una teoria astratta, pedagogica o della comunicazione, anziché attraverso il rapporto, sarebbe una via di conoscenza più rapida ed efficace, con la conseguenza che si incomincerà a muoversi da incapaci di valutare, di giudicare in proprio ciò che accade con l’altro, raccogliendo il suo pensiero e la sua iniziativa. La domanda che un insegnante, libero dall’ingombro di presupposti, si porrebbe allora sarebbe: come si regola nei suoi rapporti questo soggetto che ho davanti? La sua attenzione sarebbe allora simile all’attenzione fluttuante dell’analista, che ascolta, ma lascia che siano alcune fra le cose ascoltate ad imporglisi. La posizione dell’aspettare non è meramente passiva, implica un lavoro di attesa che l’altro si mostri, che venga a dirmi qualcosa. Solo a questo punto ci potrà essere un sostegno o una correzione, se c’è qualcosa da correggere. Ho presente, in questo momento, una classe di bambini di prima elementare, piuttosto numerosa, ma potrebbe essere di prima media o di prima superiore, sarebbe lo stesso. Se solo si fosse capaci di fermarsi un momento, di stare “pigramente” a guardare, senza presupposti pedagogici o teorie di approccio alla comunicazione, ci si accorgerebbe che ognuno di loro porta una storia di cui non è possibile non tener conto. Questo “pigramente” non è certo quello del vizio capitale dell’accidia. E’ la posizione attiva di chi vigila, pronto a cogliere l’iniziativa invitante dell’altro. Ci si accorgerebbe allora della singolarità di ognuno e il bambino non sarebbe costretto a lasciarsi livellare dall’idea che alla maestra di quel che lui pensa effettivamente non gliene importa niente, non si lascerebbe “massificare” dall’idea che qua si pensa tutti insieme uniformemente e che quel che è bene pensare, per muoversi e per essere in linea, lo decide solo l’adulto. Al bambino, in tal caso non resterebbe che formulare, già a sei anni, il pensiero che la vera vita è fuori dalla scuola, il pensiero che ci sarà un “poi” che riscatterà il 39 40 Ivi, pp 56-57. Ivi, p. 151. 64 Il pensiero del figlio “durante”. E quel bambino, quell’alunno che inizierà presto a pensare con questo scarto fra l’ora e il poi, fra l’oggi e il domani, fra il dentro e il fuori, sarà il futuro adulto che non saprà più vivere nel presente dei suoi rapporti, che non si aspetterà niente di nuovo dalle sue ventiquattro ore, che vivrà nell’illusione che poi, fuori dalle ore cupe e insoddisfacenti del lavoro, solo il tempo “libero” darà frutto di piacere. Il tempo del lavoro sarà pensato come tempo “schiavo”. All’idea che all’adulto non importi niente di quel che lui pensa, che sia l’adulto a dare la linea di quel che si deve pensare e fare, il bambino viene peraltro introdotto dai genitori, non sto facendo, quindi, del tutto carico agli insegnanti di un’operazione che altri hanno incominciato e che loro soltanto proseguono e consolidano. Occorre una sistematicità militata nel tempo per distogliere il bambino dall’idea di rapporto come incontro tra un’iniziativa e una risposta, tra un’offerta e una domanda Di quella prima elementare ripenso così a una bimba che in giardino durante la ricreazione se ne sta in disparte con la faccia lunga. Le chiedo cosa c’è e mi risponde, che suo padre (i genitori sono separati), le nasconde qualcosa, perché l’ha sentito al telefono dire qualcosa alla madre e scrivere qualcosa su un foglietto. Dice di non aver dormito tutta la notte e di aver cercato invano quell’appunto. Alla sua richiesta di chiarimento il papà le ha detto che non era nulla. Le domando se può dirmi cosa ha sentito, ma mi risponde che è un segreto. Alla mia richiesta se la cosa sentita le pareva bella o brutta, mi dice che non era né bella né brutta, era strana. Dopo queste poche battute torna a giocare con gli altri. Non le avevo dato nessuna soluzione, né potevo, non la chiedeva neanche, avevo solo ascoltato il suo pensiero, su una questione in cui si era imbattuta. Ripenso a quel bambino con psicopatologia precoce, che non parla, la cui iniziativa è stata troppo per tempo stroncata, e che si difende così, in modo per lui diseconomico, dal livellamento cui è stato sottoposto. A proposito di facce, di volti, di storie, ho davanti agli occhi, anche quel bambino a cui manca un rene, ma che sta bene fisicamente. Ha però una madre ansiosissima e un padre protettivo, sistematicamente critici nei confronti di ciò che il bambino pensa, nel timore che la sua iniziativa possa incrinare il muro difensivo che gli hanno costruito intorno. Ed ecco, quindi, un bambino che ha sempre paura di sbagliare e piange per nulla di fronte alle difficoltà scolastiche. Ho presente quella bambina che sembra chiusa, introversa e non socializzata, un po’ impacciata, ma, a ben osservare, è una che, semplicemente, non si butta a corpo morto a far qualcosa con gli altri: si muove solo se c’è qualcosa che la interessa, per il resto si fa i fatti suoi. C’è anche quel biondino con gli occhiali che, all’arrivo in prima, sapeva già leggere e scrivere. Un po’ timido e magari un po’ ansioso, per combattere forse la noia dei primi mesi e in conflitto con il desiderio di far vedere che lui sa, critica un po’ tutto, fa il superiore con tutti e si rende antipatico. C’è poi il perfettino, che ha bisogno dell’approvazione delle insegnanti e fa mostra di sapere tutto. Segnala un po’ untuosamente i difetti degli altri per mostrarsi bravo lui, ma poi va a casa a tormentarsi nel dubbio di aver fatto bene il suo lavoro, C’è il furbo e intelligente, ma che non riesce a stare fermo, c’è quella che si muove bene, che sa trarre frutto da ciò che impara, svelta e curiosa. Potrei continuare fino al ventiquattresimo bambino, uno per uno. Ecco che allora le regole, che magari ci devono essere, sia a casa che a scuola, non possono essere astratte e contrapposte al pensiero individuale, sano o un po’ barcollante o scosso che sia, le regole devono tener conto dell’altro che si mostra a chi gli presti attenzione. Allora avremo allievi che accetteranno di obbligarsi piacevolmente in un rapporto. Non dimentichiamo che apprendere viene da prendere, e prendere rimanda a un’iniziativa: non 65 Il pensiero del figlio c’è astuzia di regolamento o di didattica o di pedagogia che possa sostituirsi a un’iniziativa individuale che si rivolga alla scuola, e dunque all’insegnante, come a fonte di beneficio e di vantaggio per sé. Guardiamoci dal danneggiare con la nostra astrattezza questa iniziativa, impariamo a saperla vedere, ascoltare e raccogliere. 66 Il pensiero del figlio Appendice L’avvocato della salute: l’altra faccia dello psicoanalista a cura di Giulia Contri 67 Il pensiero del figlio STUDIUM CARTELLO IDEA DI UNA UNIVERSITA’ ENCICLOPEDIA IL LAVORO PSICOANALITICO SCUOLA PRATICA DI PSICOPATOLOGIA PROPOSTA DI INCONTRI DI PRESENTAZIONE A DOCENTI GENITORI STUDENTI DELLA FIGURA DELL’AVVOCATO DELLA SALUTE COME DIFENSORE DI SOGGETTI IN DIFFICOLTA’ L’Avvocato della salute è una nuova figura di professionista privato che si differenzia da altre figure istituzionali di tutela in quanto si pone come difensore - all’interno di un contratto stipulato col difeso stesso o con chi esercita la patria potestà nel caso di minori - di singole persone in particolari difficoltà nei più diversi ambiti, dal lavorativo, al giudiziario, allo scolastico. L’Avvocato della salute si fa carico della complessità di ragioni incidenti in situazioni, spesso apparentemente senza vie di uscita, in cui una persona può trovarsi, al fine di individuarne le vie di soluzione. L’idea che ispira tale figura è che solo un professionista centrato sul caso individuale, che si assuma il compito di analizzare e risolvere tali difficoltà, potendo contare sull’alleanza con un difeso che lo pensi come proprio Avvocato, possa facilitarne il superamento ed evitare che esse si fissino in un pensiero patologico di fallimento. Per questo ritengo opportuno proporre incontri, diversificati ma anche non, con le tre componenti scolastiche, docenti, genitori, studenti, per illustrare una risorsa cui ricorrere in casi che, per un intrico di ragioni – psicologiche, di ritardo cognitivo, di orientamenti sbagliati, di conflitto o incomprensione tra insegnanti e allievi o tra figli e genitori, in certi casi di handicap, di isolamento sociale ecc. –, sembrino non poter avere che uno sbocco nel fallimento e nell’abbandono scolastico. Propongo quindi, per ogni componente scolastica, un incontro di due ore ad inizio d’anno con due avvocati della salute che trattino rispettivamente: 1. 2. salute dello statuto di questa nuova professione di casi particolari esemplificativi dell’operare dell’Avvocato della 68 Il pensiero del figlio Giulia Contri Avvocato della salute P. S. Allego una breve raccolta di documenti illustranti la nuova figura professionale 69 Il pensiero del figlio L’Avvocato della salute: l’altra faccia dello psicoanalista L’idea dell' Avvocato della salute come l'altra faccia dello Psicoanalista è nata dallo Studium Cartello ormai quasi dieci anni fa. Per alcuni anni si è fatta una concessione verbale che si è rivelata equivoca e dannosa, quella di denominarlo anche “Tutor della salute”: con il frequente risultato regressivo di confonderlo con figure già esistenti di operatori nel “sociale”. In sé, “Avvocato della salute” è la definizione stessa dello psicoanalista già dietro il divano. Lo psicoanalista infatti ha cura della salute di un soggetto e in ciò partecipa del medico benché non compia alcun atto medico: ne ha cura difendendo e promuovendo la facoltà di difesa autonoma del soggetto, consistente nel suo stesso pensiero, nella facoltà giudicante di questo, nella capacità di trattare il reale come possesso legittimo o eredità da far fruttare, pensiero e giudizio che nella patologia sono limitati, deformati, esautorati (nevrosi, psicosi, perversioni, psicopatologia precoce). L’Avvocato della salute opera a difesa e a riabilitazione di un io che come avvocato difensore delle proprie facoltà sia stato messo fuori causa dalla teoria di una assolutezza delle istituzioni – a cominciare dal linguaggio – cui non c’è che da subordinarsi. Si è ritenuto tuttavia preferibile riservare la parola “psicoanalista”, come già è consuetudine, per designare quello del divano, e riservare l’espressione “Avvocato della salute” per il medesimo, allorché egli opera per linee per così dire esterne (esterne rispetto al divano): sempre a favore di un individuo, sì, ma sugli scenari più diversi (giudiziario, psichiatrico, scolastico, familiare, lavorativo…).In un tale sdoppiamento nell’esercizio della medesima avvocatura si offre un’opportunità di collaborazione tra questo Avvocato e Avvocati, Giudici, Medici, Insegnanti, ecc, in funzione della salute di un Soggetto. Ha potuto accadere che qualcuno abbia iniziato a operare partendo da questo secondo anziché dal primo. Ma anche in questo caso l’essere egli stesso analizzato è auspicabile. L’Avvocato della salute è un professionista che, come lo psicoanalista, si riserva di assumere un cliente solo dopo alcune sedute preliminari: non c’è automatismo nell’assunzione, come invece nella medicina e nel “sociale”. In caso di soggetti minori o interdetti, opera su mandato della famiglia. 70 Il pensiero del figlio Sullo scenario scolastico L’Avvocato della salute è dunque impegnato nello stesso processo di riabilitazione in cui è impegnato lo psicoanalista, a difesa della normalità, contro quella rinuncia alla padronanza della propria vita nel perseguimento di propri individuali fini e contro l’instaurarsi del presupposto di una propria irrimediabile incompetenza, inadeguatezza e quindi sub-ordinazione rispetto a un reale progressivamente percepito allora come comandato e insieme come proibito, come inaccessibile. Quella rinuncia intorno a cui ruota ogni psicopatologia, e cui consegue disinvestimento della realtà, inibizione al lavoro, risentimento e senso di colpa, inerzia rassegnata e ribellismo, e oppositività. L’ambito della scuola è un ambito in cui privilegiatamente si possono osservare le conseguenze, in termini di spreco delle risorse individuali e istituzionali, della caduta di un individuale principio di beneficio nel rapporto con la realtà incontrata, con l’offerta di un’occasione di accesso a un patrimonio di conoscenze, a un’eredità sociale cui altri hanno lavorato. La trasformazione della scuola in scuola di massa, la progressiva estensione dell’obbligo, la facilitazione degli accessi alla scuola media superiore e all’Università hanno portato a rendersi conto che non bastava aprire a tutti l’accesso alla scolarizzazione perché tutti ne profittassero. Non basta una trasformazione nel “sociale”, non basta una “riforma” delle istituzioni. I dati della “selezione”, o, eufemisticamente, della “dispersione” scolastica, che è il piede d’argilla del colosso del sistema scuola, hanno smentito questa illusione. Non si è tuttavia riconosciuta e apprezzata l’incidenza del difetto di un individuale principio di beneficio, o di profitto, nei “nuovi venuti”. Neppure si è meditato sulle modalità di trasmissione del sapere che delegittimano l’allievo nella sua posizione di erede, che mettono fuori causa l’Io come avvocato difensore delle proprie competenze. Si è invece privilegiata la soluzione del “facilitare” l’accesso a quell’eredità abbassando i costi dell’accesso ad essa. L’eredità incominciò a trasformarsi in svendita, la scuola a diventare un “saldi” colossale. Si sta oggi, peraltro, mettendo a punto un’altra soluzione che della prima è elaborazione. Si sta creando un dualismo che si va radicalizzando tra i due estremi, con variegate forme intermedie: da una parte centri di eccellenza, per coloro che sono in grado di apprezzare lo studio come investimento, in vista di un profitto, e dall’altra scuole che stanno diventando più o meno luoghi di intrattenimento, rette da “animatori “, dovendo “intrattenere“ persone disinteressate alla scuola e tuttavia costrette a restarci per un certo numero di anni. L’Avvocato della salute, come del resto lo psicoanalista, affronta questo nodo di problemi difendendo, sostenendo i propri clienti uno per uno: agli operatori nel “sociale” il compito di mettere a punto soluzioni rivolte a una molteplicità di individui, non senza che la sua consulenza possa risultare loro utile. Il vero e proprio cliente che l’Avvocato della salute difende è il singolo studente quand’anche si tratti di un minore ed egli operi quindi su mandato della famiglia. L’Avvocato della salute è un professionista che lavora alla ricostruzione - non tanto alla costruzione - alla riabilitazione, di una competenza nel “prendere” dal patrimonio culturale per proprio interesse, che è una capacità di tutti i bambini finché stanno bene. Nella patologia viene sospesa l’idea del sapere come prodotto del lavoro delle generazioni precedenti nei cui confronti porsi come eredi in vista di un beneficio. Il sapere diventa un’imposizione cui sottomettersi in quanto incompetenti, senza più potersi autorizzare a giudicarne. 71 Il pensiero del figlio Il vero ap-prendere è sempre un prendere, un capire (capere in latino vuol dire prendere), da un’eredità pensata come patrimonio da far fruttare. Ma è una capacità messa in dubbio a volte molto presto, fin dai primi anni di scuola, con la conseguenza di un effetto valanga quanto al senso della propria inadeguatezza rispetto a un sapere che diventa così sempre più inaccessibile. Per attendere a qualcosa e per intendere qualcosa bisogna averne voglia: fra intelligenza e averne voglia non c’è alcuna differenza, desiderio e intelligenza sono lo stesso concetto. Se lo psicoanalista lavora con il suo cliente nel dialogo analitico a una ricostruzione di un principio di profitto, attraverso una critica del pensiero attraverso il pensiero, l’Avvocato della salute lavora per linee esterne, cercando cioè di facilitare quell’accesso al sapere di cui uno studente ha cominciato a dubitare e a cui è tentato di rinunciare. Le vie di questa facilitazione possono essere molteplici, ma sostanzialmente esse consistono nel ritessere relazioni sensate, ossia secondo un individuale principio di profitto, con le occasioni che nel “sociale” si offrono. Per esempio: procurando supporti al recupero dei ritardi progressivamente accumulati, che rappresentano un forte incentivo alla rinuncia e ad assumere la posizione del diseredato; suggerendo occasioni di attività che risveglino l’interesse per ciò che il pensiero umano ha prodotto nella sua storia o, anche, in certi casi, che favoriscano la fuoriuscita da situazioni deprimenti di isolamento; dialogando con gli insegnanti sia per averne informazioni su una particolare situazione scolastica sia per tenerli al corrente del progetto di recupero intrapreso così che lo studente ne riceva un riconoscimento che lo riscatti dall’idea di fallimento in cui era caduto. Condizione della possibilità di questo dialogo con gli insegnanti è di aver ottenuto dai genitori la delega a rappresentarli presso la scuola; riorientando lo studente rispetto ad eventuali improvvide scelte di iter scolastico in collaborazione con gli insegnanti che ne abbiano individuato l’opportunità; dialogando con i genitori sia per concordare con loro le iniziative da prendere nella prospettiva di un recupero sia perché il loro modo di trattare il figlio ne favorisca la riabilitazione; valutando le eventuali diagnosi di psicopatologia conclamata, o di patologia organica che già siano state date, o, eventualmente valutando che in certi casi l’idea di fallimento si è già fissata, organizzandosi in elementi di psicopatologia e che quindi si rende opportuno consigliare un trattamento terapeutico; dialogando con il singolo studente, che non deve essere solo messo al corrente delle iniziative che vengono prese nel suo interesse: una condizione del successo dell’operare dell’Avvocato della salute è che lo studente di cui si sia accettato di assumere la difesa, sia messo in grado di apprezzare l’Avvocato della salute come proprio avvocato, con cui stabilire un patto da rispettare. La forma del rapporto dell’Avvocato della salute con il proprio cliente è infatti quella del contratto, di cui , dopo un primo tempo di incontri preliminari, vanno definiti termini, tempi, contenuti, onorario. 72 Il pensiero del figlio Difendere Federica dal difendersi con la malattia Un caso di Raffaella Colombo All’età di 4-5 anni, Federica è una bambina dall’aspetto e dal comportamento sgradevoli. Non mostra il viso: tiene costantemente la testa bassa e nascosta da una massa di capelli che le velano il viso e che non le vengono tagliati. Non parla: si esprime per monosillabi e con gesti delle mani. Si muove come un burattino. A scuola, per lunghi periodi, si rifiuta di toccare carta e penna. Fin dalla scuola materna viene segnalata come gravemente problematica e a rischio di fallimento scolastico. Il suo comportamento è infantile e urtante. È una bambina che si presenta come una handicappata e si cercano invano cause organiche del suo ritardo e degli innumerevoli disturbi di comportamento. I genitori, sostenuti dalle mie osservazioni che spostano l’accento dall’appariscente complesso di disturbi funzionali, che ne facevano una debile, all’idea che si tratti invece di un’inibizione del pensiero – il che restituisce alla bambina l’integrità individuale e una prospettiva di guarigione –, le danno il credito necessario a favorire la sua scolarizzazione. Ma i fatti contraddicono le indicazioni da me fornite: a scuola Federica è inerte, immobile, muta, irrigidita: non scrive, non legge, non parla, non esegue nulla. Semplicemente, sta seduta al suo posto. Durante le vacanze di Natale accade un fatto sorprendente: Federica inizia a scrivere e leggere come qualsiasi altro bambino di prima elementare dopo tre mesi di scuola. Anzi, si scopre che Federica sa leggere e scrivere scorrevolmente, meglio di altri. Ma dopo le vacanze invernali, Federica torna a ostinarsi nel rifiuto di eseguire compiti e consegne ricevute sia a scuola sia a casa. I periodi di rifiuto e quelli di lavoro si alterneranno costantemente lungo l’intero corso delle elementari. Il fatto significativo di questo caso che voglio segnalare risale al secondo quadrimestre del primo anno di scuola elementare. Come anticipato, Federica a scuola va, ma non partecipa. Eppure durante le vacanze scolastiche, spontaneamente, aveva iniziato a scrivere e leggere. A gennaio inizia a lamentarsi per un dolore alle mani. Tiene costantemente ripiegati entrambi gli anulari, dicendo di non riuscire a distenderli. Con il tempo, le dita ripiegate aumentano finché́ nel giro di due mesi tiene entrambe le mani costantemente chiuse a pugno. Dice di provare dolore, per cui viene completamente accudita (imboccata, vestita, lavata, pulita ecc.). Gli ortopedici interpellati hanno già stabilito la data per un intervento chirurgico finalizzato a un allungamento dei tendini di entrambi gli anulari, che conviene non rinviare oltre. Vengo avvertita del fatto. Non escludo che si tratti invece di un tentativo estremo di Federica per difendersi dalle incessanti, e per lei assillanti e intollerabili, richieste che genitori e insegnanti le rivolgono: “Io vi dimostrerò che non è vero che non voglio fare nulla: io non posso fare nulla. Sono malata”. Se la mia ipotesi fosse corretta, se cioè si trattasse di un comportamento intenzionale di Federica, la contrazione delle dita che tutti hanno constatato, medici compresi, non si dovrebbe riscontrare nel sonno. Invito dunque i genitori a tentare di aprire le mani della bambina mentre questa è addormentata e di comunicare ai medici l’esito dell’osservazione, a maggior ragione nel caso in cui constatassero che le dita delle mani nel sonno si distendono. Di fatto, nel sonno, le mani di Federica sono completamente rilassate. Non si tratta dunque di accorciamento dei tendini. L’intervento chirurgico viene annullato e nel giro di pochi giorni la bambina torna a usare le mani normalmente. Oggi, seppure ancora affetta dall’inibizione a parlare e da comportamenti infantili difensivi, Federica si prepara a sostenere gli esami di terza media. 73 Il pensiero del figlio La difesa della facoltà di difesa o la correzione come desiderio generato dalla prospettiva di riuscire Un altro caso di Raffaella Colombo Si tratta di un giovane quindicenne che, al momento della segnalazione, frequenta la prima classe liceale. Da Natale il profitto scolastico è improvvisamente calato, e la scuola avverte i genitori dell’inevitabile bocciatura a fine anno. Oltre al mancato rendimento improvviso, il ragazzo non parla più, evita ogni rapporto con i compagni, con gli insegnanti e manca spesso da scuola all’insaputa della famiglia. Presenta difficoltà che meritano una visita specialistica presso un neuropsichiatria: questa è l’indicazione che la scuola dà ai genitori convocati. Dalla visita risulta quanto segue: il ragazzo è gravemente depresso, è una minaccia per sé e per gli altri, non parla, ha movimenti rallentati, è apatico e assenteista. Viene indicato che sarebbe bene che interrompesse immediatamente il liceo e che frequentasse una scuola meno esigente. Ma anzitutto avrebbe bisogno di un trattamento psicologico individuale e di un accompagnamento costante: non bisogna lasciarlo mai da solo. Al ragazzo viene detto di scordarsi la carriera liceale: non ne avrebbe le capacità. I genitori arrivano da me terrorizzati, non sanno più come comportarsi con il figlio. Tramite una terza persona, faccio in modo che sia il ragazzo stesso ad arrivare a me: non possono essere i genitori a indirizzarlo, non verrebbe per questo medesimo motivo. Con me non parla, dicendo di non aver nessuna difficoltà e di essere insufficiente solo in latino. Dopo diversi incontri – viene accompagnato dalla suddetta terza persona -, racconta finalmente un episodio di insuccesso scolastico che sarebbe stato l’inizio delle sue difficoltà scolastiche: una grave offesa da parte dell’insegnante di latino che in una interrogazione l’avrebbe insultato, dandogli del deficiente. Mentre per il resto tutto bene. E’ impassibile, correttissimo, non succede niente. Io però so che il suo comportamento a casa è insopportabile, manierato, autistico, non parla con nessuno, tiranneggia, comanda, si chiude in camera sua per ore, rimane fisso davanti allo specchio a lungo continuando a pettinarsi, a guardarsi. Acquista video e libri horror, non esce di casa. Ma da lui tutto questo non trapela. Gli chiedo anche di portarmi la fotocopia dei giudizi e delle pagelle, ma lo evita ripetutamente. Non manca un appuntamento, ma è molto pedante, indisponente, mi fa notare i miei ritardi di cinque minuti sull’appuntamento che gli ho dato, e non dice nulla. Ad un certo momento, visto quello che sapevo, temo che lui menta, e so che devo fare in modo che ciò non accada. Per questo gli avevo chiesto di portarmi la pagella: il ragazzo diceva che i suoi voti erano più che sufficienti, mi elencava anche i voti più che sufficienti che aveva ricevuto nelle varie materie. Il criterio che seguo e che ritengo importantissimo è quello di evitare che egli mi menta, perché se riuscisse, io l’avrei perso e lui sarebbe perduto. Dopo cinque o sei appuntamenti logoranti, decido di affrontarlo di petto. Gli comunico quello che io penso di lui sulla base degli indizi che mi ha fornito e di quello che mi era stato detto dalla terza persona che, nel frattempo, continuava ad accompagnarlo. Ciò che io pensi, egli desidera saperlo: vuole che io gli dica che impressione mi fa. Gli annuncio che intendo parlare con la persona accompagnatrice, in quanto ho un’idea che gli potrebbe essere utile, ma, visto che è minorenne, di questa idea dovrei parlare anche con un adulto. Qui inizia il mio intervento come avvocato della salute, avendo messo da parte la possibilità di un lavoro con lui sul pensiero: il problema del profitto è così importante che occorre la riuscita, occorre cioè uno spiraglio di riuscita per poter poi mettere mano al pensiero. Gli dico che sono sicura della bocciatura, malgrado quello che lui mi riferisce, e che capisco benissimo le sue difficoltà. Gli indico di smettere immediatamente la frequentazione 74 Il pensiero del figlio del liceo e di cambiare scuola. Ormai l’anno è perso (siamo a marzo) e ha perso anche la faccia. Se, come dice lui, non merita la bocciatura ma è una montatura degli insegnanti, che trovi una scuola dove poter frequentare due anni in uno, così da non perdere quello perso. Il ragazzo accetta, si muove e, grazie alla terza persona, prende contatto con una scuola privata che accetta determinate condizioni e accetta soprattutto di seguirlo nelle sue richieste. Durante l’estate studia e aderisce all’indicazione del nuovo preside, che gli ha proposto non di passare immediatamente alla seconda liceo, recuperando privatamente la prima ma, al contrario, di ripetere la prima studiando privatamente per la seconda. In tale modo, alla fine della prima, potrebbe rendersi conto della preparazione raggiunta e dell’opportunità di passare direttamente in terza. Durante il primo trimestre frequenta la prima liceo e studia privatamente il programma di storia e inglese di seconda. Periodicamente lo sollecito a parlare con il preside, verifico che lo abbia fatto, e mi faccio raccontare: è un lavoro di resoconto. Appena mi dice che sta cominciando ad affezionarsi ai suoi compagni, cosa che non accadeva più dalle elementari, mi preparo a proporgli di lasciar perdere l’idea di fare due anni in uno e di continuare con la sua classe sino alla quinta liceo. Accetta di continuare con la sua classe, riesce, non gli importa più di perdere un anno, e da quel momento in poi inizia a raccontare ciò che non aveva mai detto. Emerge di tutto: disturbi, rituali compulsivi, soprattutto difficoltà di rapporto con la madre. Non ha ancora parlato del padre. A questo punto la mia difesa è terminata e inizia un altro lavoro di difesa. Difendendo la sua facoltà di difesa, l’ho riportato nella nevrosi. E qui inizia un altro lavoro, quello psicoanalitico. 75 Il pensiero del figlio Sullo scenario giudiziario Nell’ambito giudiziario è del pari rilevabile una rinuncia all’individuale capacità di difesa della propria libertà, dei propri beni, dei propri interessi in soggetti che presuppongono l’istituto del giudice o del difensore come superiore, e unica, istanza deputata a decidere in merito. 1. Relazione con l’avvocato difensore Tali soggetti rivelano anzitutto un difetto di cognizione di causa in procedimenti che li riguardano dal momento che giustificano nel proprio pensiero la teoria secondo cui competerebbe unilateralmente a professionisti della difesa difenderli. A se stessi, poi, nessun ruolo attivo in giudizio in piena capacità di intendere e di volere, nessuna partnership col proprio difensore. Essi si pensano messi fuori causa come difensori dei propri affari, e non collaborano con il legale che li rappresenta presso i tribunali. Fedele della stessa teoria è per lo più il difensore legale, che parte dall’idea che chi si fa difendere è per principio uno che non lo sa fare. Pone perciò tutta la difesa dalla propria parte. Si tratta in questo caso di una difesa incompleta. L’Avvocato della salute è un professionista che lavora a riabilitare, nei soggetti che hanno rinunciato all’idea di esser capaci di difendersi quando hanno a che fare con la giustizia come imputati, come vittime, come testimoni, come minori ecc., il pensiero che non esiste difensore supremo di loro averi, iniziative, imprese: posto cioè in alto per competenza rispetto a loro collocati in basso per incapacità. E che difendere le proprie ragioni in giudizio è anzitutto in capo a loro come individui: al di là dell’incompetenza tecnica; al di là del fatto di non potervisi difendere direttamente; al di là del compito istituzionale dei tribunali di emettere le sentenze che riguardano illeciti e contenziosi. 2. Relazione con la legge e con il giudice Se un soggetto è chiamato a rispondere di fatti contestatigli come costituenti reato, l’avvocato della salute lo aiuta ad elaborare un giudizio sulle ragioni che lo hanno portato a delinquere: a fare cioè in proprio il proprio processo. Partendo dalla violazione della norma del diritto statuale per cui egli è sottoposto a processo, quel professionista rielabora con lui la questione se, si o no, quel reato sia riconoscibile come violazione di una norma individuale – secondo un primo diritto – regolante il rapporto pacifico, in vista di un profitto individuale, con i propri altri. Questo lavoro costituisce per quel soggetto un’occasione per riavviare una propria individuale capacità legislativa, di giudizio e di correzione. Se un soggetto imputato secondo il diritto dello Stato riconosce la propria imputabilità secondo un primo diritto, secondo una norma individuale, offre all’avvocato della salute un’opportunità di collaborazione con il Giudice o con l’Avvocato. E l’Avvocato come il Giudice possono essere aiutati da quel riconoscimento a orientarsi meglio sulla capacità di intendere e volere di un soggetto e sulla sua imputabilità in tribunale. Un soggetto che si riconosce imputabile secondo un diritto individuale non necessariamente si riconoscerà come imputabile secondo la norma statuale: eviterà però di esercitare atteggiamenti rivendicativi nei confronti del difensore che non sarebbe in grado di 76 Il pensiero del figlio difenderlo, o del Giudice che non sarebbe capace di giudicarlo, perché non saprebbero capire le difficoltà e i problemi che lo hanno portato a delinquere. Si aprirebbe però qui un’ulteriore questione da elaborare da parte dell’Avvocato della salute con il suo difeso. Le ragioni individuali del reato che l’Avvocato della salute elabora col proprio cliente non consistono ad ogni buon conto in motivazioni psicologiche da fornire come profilo soggettivo e come attitudine morale ad avvocati e giudici perché ne usino a difesa e in giudizio. Quelle ragioni sono i criteri di regolazione dei rapporti secondo danno proprio e altrui, o secondo vantaggio, che hanno presieduto all’infrazione delle norme statuali. E serviranno all’imputato da orientamento anche dopo il giudizio del tribunale. Le vie di questa facilitazione possono essere diverse. Per esempio: portando il cliente a conoscenza del funzionamento dell’apparato giudiziario preposto all’amministrazione della giustizia, e facendogli superare attraverso questa conoscenza la paura che l’apparato gli incute inibendone la facoltà di giudizio; mettendo in contatto il cliente - direttamente o attraverso il legale - con i dovuti ambiti giudiziari perché questi vi faccia pervenire le sue istanze nel corso di una controversia (difensori, giudici, degli adulti o minorili, servizi sociali, psicologici, peritali….); consigliandogli l’uso della conciliazione delle controversie (separazioni consensuali tra coniugi; accordo in questioni relative a rapporti familiari; transazione ove possibile in questioni patrimoniali, di lavoro, ecc.), favorendone così la capacità di giudizio individuale in alternativa al giudizio istituzionale; motivandolo a stabilire con l’avvocato difensore una collaborazione attiva che gli metta a disposizione tutti gli elementi di conoscenza necessari ad una difesa efficace; collaborando egli stesso come avvocato della salute col difensore legale attraverso iniziative per lui possibili nel giudiziario - consulenze, perizie, pareri sul proprio cliente, ad esempio - atte a valorizzarne le ragioni. Difendere Tatiana perché si autorizzi ai rapporti Un caso di Raffaella Colombo Illustro brevemente un aspetto della storia di una giovane diciassettenne in affido dall’età di sette anni presso una famiglia. L’affido era avvenuto d’urgenza ma non escludeva contatti con i genitori. Dal secondo anno di affido in poi fino allo scorso anno Tatiana non aveva più avuto notizie della madre: subito dopo l’inizio dell’affido, la madre aveva abbandonato il marito e si era trasferita con il secondogenito di tre anni in un’altra città insieme con un altro uomo. Aveva disdetto gli appuntamenti con la figlia in affido e fatto perdere le sue tracce. Per decisione del Tribunale dei Minori le era stato di conseguenza ingiunto il divieto assoluto di qualsivoglia forma di frequentazione, contatto, tentativo di avvicinamento della figlia fino al suo raggiungimento della maggior età. A Tatiana, che allora aveva otto-nove anni, restavano esclusivamente i contatti con il padre presso il quale si recava regolarmente (visite periodiche con brevi pernottamenti) e con i parenti del ramo materno che frequentava insieme con il padre. Ma anche la frequentazione del padre viene interrotta. Il Tribunale penale, a seguito di una condanna al carcere nei confronti del padre - per molestie sessuali sulla figlia avvenute durante il diritto di visita -, intima il divieto di ogni relazione padre-figlia fino al raggiungimento della maggiore età della ragazza. La denuncia viene inoltrata dalla ragazza stessa lo scorso anno dopo anni di completo silenzio, proprio nel momento in cui essa riesce 77 Il pensiero del figlio a riprendere i contatti con la madre. Il silenzio era motivato anzitutto dal suo timore di perdere l’unico membro della famiglia che le era rimasto e cui era affettivamente legata. Per l’avvocato della salute la difesa della salute psichica della giovane, che quando avvengono questi fatti ha quasi 16 anni, pone la seguente questione: - Avendo preso l’iniziativa di contattare la madre, la giovane sta contravvenendo alla decisione presa anni prima dal Tribunale dei Minori: tra madre e figlia non possono esservi contatti di nessun tipo fino alla maggiore età della ragazza. Conviene invitarla a interrompere i contatti presi abusivamente (con la complicità di un parente della famiglia materna che le fornisce il recapito telefonico e l’indirizzo della madre), oppure conviene orientarla in modo tale che sappia sostenere la sua iniziativa fino a giungere al punto da rendere legittimi i sui atti? Il decreto di allontanamento riguarda la madre. Quanto alla figlia, non ci sono imputazioni di sorta a suo carico. Ma scrivere, telefonare, incontrare la madre significa mettere la madre in una posizione di illegalità. D’altra parte la ragazza è determinata a non tornare indietro: agirà comunque e in modo coatto. Scelgo dunque per la seconda possibilità: -Invito la ragazza a non agire di nascosto (dalla famiglia affidataria e dai Servizi sociali che esercitano la tutela). - Le propongo di comunicare alla famiglia affidataria e ai Servizi sociali la notizia e la sua intenzione di non recedere di un passo dal suo agire. - Le suggerisco di fare in modo da ottenere un appuntamento con il giudice dei Minori al quale dichiarare le sue intenzioni e decisioni. Dopo mesi di tentativi ripetuti e ostinati, aiutata dalla famiglia affidataria che a sua volta mantiene i contatti con i Servizi sociali, Tatiana viene ricevuta personalmente dal giudice e ascoltata. Ne ottiene la disponibilità da parte di una revisione del decreto di allontanamento della madre e da parte dei Servizi sociali una maggiore attenzione alla sua situazione. Attualmente la ragazza visita regolarmente la madre recandosi autonomamente nella città in cui questa vive e lavora, ha preso la decisione di prolungare la permanenza presso la famiglia affidataria per qualche anno, ha smesso di fantasticare una madre ideale e irraggiungibile che ha sempre amato la sua bambina, sta lavorando seriamente per portare a termine la formazione professionale che aveva finora fallito, ha preso a formulare richieste chiare e ragionevoli ai Servizi sociali per ottenere il massimo sostegno, sta ricostruendo la sua storia e imputando a ciascuno meriti e debiti. La competenza di un minore a giudicare e a decidere dei rapporti con i genitori Un caso di Giulia Contri La madre di una tredicenne a lei affidata dopo la separazione mi ha rivolto recentemente domanda di avere dei colloqui con la figlia: essendo venuta a sapere dall’avvocato della madre che il padre aveva fatto richiesta al tribunale, in occasione del divorzio, di riconoscergli il diritto di incontrarla con più frequenza rispetto agli accordi seguiti alla separazione, questa desiderava che una sua volontà contraria non solo all’aumento ma addirittura al mantenimento della frequentazione di suo padre fosse tenuta in conto nelle misure che sarebbero state prese dal tribunale nel frangente. 78 Il pensiero del figlio A me in specifico come avvocato della salute, la madre era stata indirizzata dal medico pediatra della figlia attento al ruolo che come tale avrei potuto giocare a favore della capacità di porsi della ragazza nel giudiziario. Il consiglio di rivolgersi ad un professionista era arrivato alla signora dal proprio avvocato, che voleva accertarsi della natura dell’atteggiamento drasticamente negativo della ragazza nei confronti della pretesa paterna ai fini di un parere da lui usabile in giudizio. La ragazza, cui avevo detto della mia funzione di difesa delle sue istanze di figlia - da avanzare nel caso nelle sedi giudiziarie opportune - si è posta con grande maturità a giudicare di un padre che mai aveva fatto il padre con lei, mostrandosi incapace di stabilire un qualsivoglia tipo di rapporto da genitore. Anche ora, in occasione del divorzio, egli non si era neppure degnato di interpellarla relativamente alle sue nuove richieste. Mentre mi raccontava di questo mancato rapporto, l’ho sostenuta anzitutto nel giudizio che stava autorizzandosi a dare su un padre inesistente: che peraltro sempre l’aveva zittita quando ella esprimeva disagio per questa inesistenza e chiedeva l’instaurarsi di una relazione costruttiva, facendole a volte dubitare del suo disagio stesso. Le ho consigliato, in secondo luogo, di scrivere al giudice una lettera perché la decisione di non voler continuare una relazione diventata ormai un obbligo (meno che mai poi se aumentava) fosse resa nota a chi doveva prendere giudiziariamente provvedimenti che la riguardavano (la cosa arrivava anche alla difesa del padre, e, per quella via, al padre stesso). Ciò perché il giudice l’ascoltasse di persona, cosa che non si è data, perché per il momento il giudice ha ritenuto significativa per l’udienza la comunicazione scritta della ragazza. Nel contempo ho steso io stessa un parere per l’avvocato della madre, che se n’é servito per una memoria al giudice. Lettera e parere hanno fatto decidere quest’ultimo per un rinvio in attesa che si verifichi se esistono le condizioni perché il padre ripensi un possibile rapporto da instaurare con la figlia: come avevo proposto nel parere stesso, e come la figlia ha accettato di verificare. Anche se ci crede poco. Cito dalla lettera, molto bella, della ragazza al giudice: è farina del suo sacco, ella l’ha scritta senza che né sua madre né io le dessimo alcun suggerimento, che pure più volte ci aveva sollecitato a fornirle: «Viste le richieste fatte da mio padre riguardo le mie visite desidero metterla al corrente che io non ho il desiderio di stare con lui in quanto non si è mai creato tra noi nessun tipo di rapporto (…) egli non è un padre che ha piacere di conoscere sua figlia e crearsi un legame con lei (…). Fin da quando ero piccola mi portava da mia nonna (sua madre) e lui che doveva esser contento al pensiero “posso passare un po’ di tempo con la mia bambina” si metteva sul divano a dormire, così il mio rapporto finiva prima ancora di iniziare (…). Lui non si è mai impegnato da quando ero piccola ad instaurare un buon rapporto e un’intesa tra noi, non è colpa mia se ora non sento il desiderio di instaurarlo in queste condizioni, sarei disposta a provare solo (e sottolineo solo) se il suo comportamento e il suo interessamento nei miei confronti cambiassero e se mi dimostrasse che vuole veramente occuparsi di me e mi dimostrasse di volermi veramente bene». La ragazza dice in sostanza che laddove un rapporto tra padre e figlia non è stato istituito, è inesistente e non è desiderato di fatto da nessuna delle due parti, il giudice non può imporlo. Non è il diritto dello Stato che crea rapporti: o sono due persone che quel rapporto lo vogliono, o il diritto come tale non può istituirlo. 79 Il pensiero del figlio «Quando sto con lui mi sento come un pacco, nel senso che mi porta dove vuole lui e non facciamo mai qualcosa che interessa anche a me, e a me infastidisce molto il fatto che le cose mi vengano imposte e non proposte (…) Non ne ha nemmeno parlato con me (che sono la prima interessata) del fatto che voleva richiedere visite frequenti (…) almeno per sapere se mi poteva far piacere (…). Lui pensava che così sarebbe entrato per forza a far parte della mia vita in questo modo prepotente (…). Lui del resto, quando sono finalmente riuscita a parlargli di questo mio disagio, la sua risposta è stata: “Tu hai dei doveri verso di me e li devi rispettare - alzando la voce come il suo solito”. Ma io dico: perché dovrei rispettare i miei doveri verso di lui quando lui non ha mai rispettato i suoi verso di me?». A dire: se il giudice a sua volta stabilisse il diritto di mio padre di vedermi facendolo diventare un dovere per me, questo sarebbe un comando. Io sono disposta a rimettermi in gioco se mio padre mostra il desiderio di instaurare un rapporto che faccia piacere ad entrambi di porre; in caso contrario io non ne voglio sapere di un’imposizione, cui chiedo alla giustizia di non dovermi subordinare. Per quanto mi riguarda non mi ci subordinerò. Nei colloqui con me la ragazza ha drasticamente affermato: «Se le cose vanno avanti come sono sempre andate con mio padre, ognuno per la sua strada». Non condiscendendo al perverso pensiero paterno di potersi garantire un legame con lei in via di diritto. Diritto che si vanificherebbe nell’impropria funzione di dettar rapporti laddove nessuno ne istituisce. Un caso di abuso sessuale tra minori: rielaborazione individuale e ricorso giudiziario Un altro caso di Giulia Contri Riferisco per questioni del caso, che ho seguito come avvocato della salute, di una ragazza tredicenne abusata sessualmente da due coetanei, uno minore di quattordici anni, l’altro appena quattordicenne. Le questioni sono: - quella della opportunità della denuncia del fatto all’autorità giudiziaria - quella del tipo di difesa offerto alla minore in causa - quella del rapporto madre-figlia - quella della collaborazione con i servizi sociali del Tribunale per i Minorenni Rielaborare La prima decisione, meditata in proprio dalla ragazza dopo l’abuso, é stata di non parlarne con nessuno, di pensarci su individualmente per quasi due settimane. A dire che la faccenda apparteneva a lei soltanto, e cioè a certa sua idea di rapporto con l’altro sesso: idea che aveva dovuto fare i conti con la pratica di rozzo dominio manipolatorio del suo corpo messa in atto dai due minori abusanti. Ella aveva insomma avuto bisogno di elaborare in privato quell’idea dopo l’abuso volgare subito. Il fatto di non parlare della violenza subita é comune a molte minori abusate: esso può esser segno, come qui, non di una vergogna inconfessabile, ma di un giusto ritegno legato alla convinzione della privatezza della questione che le riguarda, per la quale esse temono una indebita gestione esterna. 80 Il pensiero del figlio Nel caso, appunto, il pensiero di socializzare la cosa con qualcuno é venuto alla ragazza in un secondo momento: l’abuso era qualcosa di difficoltoso da analizzare da sola, urgeva comprendere con l’aiuto di qualcuno quale dinamica era invalsa tra lei e i suoi futuri abusanti prima dell’abuso, e quale logica maschile aveva prodotto l’abuso. Alla ragazza in verità non é stata posta da nessuno la domanda se voleva sporgere denuncia nei confronti dei compagni abusanti: ella ne aveva soltanto parlato ad un certo punto con una compagna prima, con un insegnante poi, per averne lumi e sollievo. Da questo poi per forza di cose scuola e famiglia sono entrate nell’agone. La scuola ha lasciato alla famiglia di decidere il da farsi. E’ stata la madre a prendere l’iniziativa di denunciare l’abuso senza chiedere il consenso preventivo della figlia, e senza lasciar valutare alla figlia in prima persona il modo per lei più congeniale di governarlo. Per questa donna l’accaduto rivestiva il carattere di una tale gravità; era talmente necessario porre le premesse per la punibilità degli autori di un abuso così mostruoso; che non si é fatta alcun problema degli esiti negativi dell’espropriazione dalla decisione della figlia, o del danno che la pubblicità dell’azione giudiziaria avrebbe potuto arrecarle. Denunciare Sono stata chiamata in causa coma avvocato della salute per A.B. qualche tempo dopo che la denuncia era stata avanzata. Mio ruolo a quel punto - anticipo qui qualche dato sul lavoro dell’avvocato della salute in questi casi, che approfondirò nel paragrafo successivo - era di accompagnare anzitutto i passi che A.B. doveva affrontare nel giudiziario, ambito con il quale mai prima di allora ella aveva avuto a che fare: quelli relativi agli interrogatori, prima presso l’autorità di Polizia Giudiziaria, e poi presso il Giudice per le Indagini Preliminari in sede di Tribunale per i Minorenni. Distribuiti peraltro su un arco di tempo di mesi e mesi. Essere sottoposta a ‘giudizio’ richiedeva alla ragazza capacità di giudizio personale sui fatti di cui era stata protagonista: delicati da valutare in quanto relativi ai rapporti con l’altro sesso. In fase dunque di ricostruzione per gli interrogatori era importante sollecitare alla chiarezza il suo pensiero intorno alla logica con la quale si era svolto tra lei e i coetanei l’incontro pomeridiano in casa di uno dei due, compagno di scuola tredicenne, di famiglia conosciuta da quella della ragazza, che sapeva del loro ritrovo. Andando al di là di un possibile gioco seduttivo e conoscitivo tra convenienti di quell’età, praticamente da subito i due amici, per tacito accordo, si erano dati a manipolare sessualmente in modo grezzo e volgare il corpo della ragazza (dico manipolare in quanto non ci fu contatto genitale, ma soltanto violenza manuale dei due minori insieme ai danni della ragazza). All’elaborazione della dinamica dell’accaduto la ragazza aveva dedicato i giorni immediatamente successivi all’evento, tentando da sola di dare all’improvvisa violenza dei due compagni su di lei il senso di un grave incidente di percorso. Incidente superabile, nel suo pensiero, attraverso una ripresa di rapporti confacenti con altri dell’altro sesso, con amiche e amici, con l’attività di studio e sociale. E attraverso un aiuto, subito cercato, di qualcuno che la confermasse nella positività di quella ripresa, e lavorasse nel tempo con lei ad un ripensamento di tutta la storia. A evitare possibili esiti patologici per il futuro. 81 Il pensiero del figlio La denuncia da lei non decisa, e la pubblicità indebita che con il procedimento giudiziario fu data all’episodio, sconfessò il suo desiderio di fare della cosa una questione privata. Difendere Il fatto che si procedesse giudiziariamente - affidando cioè ad organismi superiori il giudizio - contro degli imputati di reato ha costituito per la ragazza un richiamo continuo a quanto era successo come a evento eccedente il giudizio suo personale, nonché il suo cogliersi individualmente come parte in causa di una dinamica tra sessi. Quanti istituti dell’apparato giudiziario era stato necessario mettere in campo - carabinieri, giudici, avvocati - perchè si potesse dire qualcosa che contasse dell’accaduto!Quale ampia comunità di persone, al seguito, era stata tirata dentro a dire la sua - compagni di scuola, genitori, insegnanti, amici di famiglia - a produrre cioè giudizi in sua vece! In buona misura malevoli: "Puttana, ci sei stata"; o, se non esplicitamente malevoli, espressione di repressa invidia: "Deve esser stato bello!’" A conferma del pensiero del rapporto sessuale come sadico, e a pericolosa possibile fissazione futura del pensiero della ragazza in tal senso. A evitare tale fissazione, a fronte di giudizi da pubblica piazza di amici e parenti in quella direzione, come avvocato della salute ho lavorato a far sì che la ragazza elaborasse proprie ragioni difensive rispetto a quel pensiero: per se stessa dopo l’esperienza passata, ancora prima che per il tribunale che l’avrebbe esaminata. Ella si trovava al fianco una madre che non perdeva occasione per tentare di farglielo acquisire come proprio, quel pensiero: metteva infatti continuamente in piazza il fatto ‘innominabile’ successo come quello da cui la figlia come vittima non si era saputa difendere e non si sarebbe saputa difendere se le fosse capitato ancora. Solo la giustizia poteva far giustizia, nessuno poteva farla per le scarse forze di cui disponeva. La figlia abusata per prima. I rapporti della madre con la figlia Per identificazione ella attribuiva alla figlia quella che ella viveva come propria di incapacità di difendersi: da un possibile abuso sessuale del tipo capitato alla figlia stessa, ma soprattutto dal pensiero del rapporto sessuale come sadico, rimosso ma in lei operante attivamente come invidia misconosciuta per la figlia che aveva subito l’abuso. La madre si faceva porta aperta all’irruzione nel pensiero della figlia della irresistibilità dell’idea del rapporto sessuale come sadico. Il giudizio della madre su di lei come incapace a resistere a quell’idea si accompagnava a quello di incapacità comunque della ragazza a resistere al dominio sadico dell’altro in tutti i suoi ambiti di vita e di studio. Bisognava allora lavorare ogni volta sui giudizi espressi dalla madre sulla figlia stessa come non corrispondenti al dato reale del suo porsi come capace: sul suo impegno scolastico che le sarebbe stato impedito di far funzionare bene dai malevoli, anche se toccavamo con mano che funzionava; sui rapporti che lei non avrebbe potuto porre in positivo per ostacoli messi in mezzo da altri cattivi proprio nel momento in cui potevamo dire che stavano andando bene; sulle mete costruttive che qualcuno non voleva che lei istituisse proprio quando constatavamo che lei stava istituendole. 82 Il pensiero del figlio Bisognava che nel concreto dei propri rapporti, insomma, la ragazza potesse verificare che quanto lei costruiva in positivo - nello studio come nella vita privata - poteva funzionare. Nulla stava a dire che oppositori/nemici glielo stavano impedendo. E che lei dovesse sottostarvi rinunciando al proprio principio di autonomo funzionamento. Ella in pratica non era impotente a istituire liberamente relazioni funzionanti, e a ogni piè sospinto doveva essere soggetta all’imposizione sadica di un altro dominatore fino a farsi piacere l’imposizione da teoria materna "sadico é bello". Si trattava di lavorare contro l’ombra che la concezione materna sadica dei rapporti, a cominciare da quello sessuale, poteva gettare sul pensiero della figlia. L’essere infatti la madre così affezionata all’idea dell’incapacità della figlia di difendersi dagli abusi si dimostrava sempre più chiaro segno della sua strategia di fare della figlia stessa un proselita della teoria dell’ irresistibile fascino del rapporto - sessuale anzitutto - come sadico. Il pericolo dell’irruzione di quell’idea nel pensiero della figlia era tanto più grande quanto più quella concezione materna sadica, rimossa, si ripresentava nella forma di una preoccupazione difensiva genitoriale amorevole contro il dispregio di cui la figlia sarebbe stata bersaglio , senza soluzione di continuità anche adesso che non se ne vedeva più nemmeno il più lontano segno, da parte di parenti, amici, compagni di scuola a seguito del consenso che ella avrebbe dato ad un abuso innominabile. I servizi sociali I servizi sociali territoriali del Tribunale dei Minori (che chiamano regolarmente a rapporto i genitori di figli abusati) hanno avuto a che fare con la madre della ragazza subito dopo che questa era ricorsa per un attacco di panico ad un servizio medico di pronto soccorso ospedaliero. Preoccupata dello stato in cui la donna versava e della diagnosi del pronto soccorso da questa esibita, attraverso la curante della ragazza l’assistente sociale incaricata del caso é risalita a me avvocato della salute, e mi ha convocata. C’erano tutti gli elementi, affermava, perchè si potesse pensare ad un allontanamento della ragazza da casa, visto, oltre allo stato clinico, l’accanimento della madre contro compagni e compagne di scuola della figlia, nonché con i loro genitori, sentiti come autori di denigrazioni continue nei confronti della figlia nonché di loro come genitori. La forza pubblica era stata di nuovo messa in ballo dall’una e dall’altra parte delle famiglie in guerra. Si intravvedeva, sempre secondo la rappresentante dei Minori, il serio pericolo che la cosa producesse danni gravi alla ragazza. Ho proposto come possibilità alternativa all’allontanamento della figlia la mia interposizione come avvocato della salute: mi sarei fatta promotrice presso la famiglia di un accordo con il quale essa mi delegasse di rappresentarli presso la scuola, tenendo io al loro posto i contatti con preside e docenti, interessandomi io dell’andamento scolastico della ragazza e delle sue relazioni di contesto in quell’ambito. Ne avrei riferito personalmente ai genitori, che avrei invitato ad ogni buon conto sempre a tenere una posizione di distanza dagli eventi scolastici. Lo scopo era di ottenere - facendo fare, fisicamente e nei rapporti concreti, un passo indietro ai genitori della ragazza - che si sedassero gli animi di compagni di scuola e genitori, messi in un allarme continuo da una diatriba che si presentava senza soluzione di continuità: accuse e controaccuse si accavallavano infatti senza che più nessuno riuscisse a capire chi aveva incominciato, e senza che la madre che intendeva dar fuoco alle polveri si lasciasse scappare occasione per farlo. 83 Il pensiero del figlio Il mio lavoro é consistito sostanzialmente, oltre che nel far ritirare dal terreno i genitori della ragazza, nel fare in modo che gli insegnanti si adoperassero ad impedire duelli anche solo verbali tra compagni, a non raccogliere provocazioni di altri genitori, ad aiutare la ragazza a lavorare meglio scolasticamente dopo la tempesta che l’evento aveva suscitato. Gli esiti di questo impegno scolastico della ragazza, del resto, sono stati singolarmente positivi, pur partendo la ragazza da basi molto fragili di preparazione pregressa. A dimostrazione del fatto che l’aver ella lavorato con il mio aiuto ad individuare una propria meta futura professionale per la quale valesse la pena di impadronirsi di strumenti adeguati di sapere le ha permesso di mettere a punto una prospettiva personale concreta in alternativa alla distrazione teorica sadomasochistica materna. Interrompere infatti una guerra che sembrava non terminare mai e che finiva sempre col darla vinta al nemico, ha voluto dire per la ragazza non dare più alimento al pensiero di questo nemico sadico irresistibile, che per amore o per forza - più per amore, cercava di dire la madre con l’affezione all’idea di non potervisi sottrarre - porta a sottostare ad un rapporto violento con lui. Che, allora, piace. © Studium Cartello – 2007 Vietata la riproduzione anche parziale del presente testo con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine senza previa autorizzazione del proprietario del Copyright 84 Il pensiero del figlio ASSOCIAZIONE CULTURALE “A. ROSMINI” Trento 2003/04 Seminario Genitori, figli, educatori: un lavoro di competenze Calendario degli incontri Giovedì – 18 dicembre 2003 – ore 17. Chi è “genitore”. Generare non è procreare. Relatore: Dott. Giacomo B. Contri Giovedì – 04 marzo 2004 – ore 17. Generare-educare. Il pensiero dei figli. Relatori: Dott.ssa Maria Antonietta Aliverti e Dott.ssa Raffaella Colombo Giovedì – 11 marzo 2004 – 0re 17. Genitori e insegnanti: lavorare per il beneficio Relatori: Dott.ssa M. Gabriella Pediconi e Dott.ssa Maria Grazia Monopoli Giovedì – 18 marzo 2004 – ore 17. Per una scuola dei talenti della soddisfazione e del profitto Relatori: Dott.ssa Vera Ferrarini e dott. Alfeo Foletto Giovedì – 25 marzo 2004 - ore 17. Scuola: soggetti o sottomessi? Relatrice: Dott.ssa Maria Delia Contri e Dott.ssa Angela Cavelli 85
Scarica