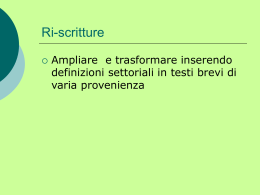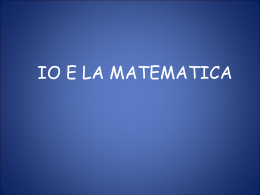racconti fenandel59 10-01-2007 12:36 Pagina 14 «Ho 33 anni, vivo e lavoro a Verona. In realtà mi chiamo Benedetto ma il mio nome non mi è mai piaciuto. Nell'unica mia precedente apparizione letteraria (il racconto Catia nell'antologia Malacarne edita da Aliberti nel 2004) ho usato lo pseudinomo di Elle. In passato ho lavorato davvero in un aeroporto, ma i personaggi e soprattutto le vicende narrate in questo racconto sono per la maggior parte frutto di una rielaborazione affettuosa di esperienze mie e dei miei colleghi di quegli anni, condita – se volete – con un po' di nostalgia». il valzer della patata benny ferraris Arrivano a frotte, le stagionali. A fine autunno e, più numerose, a primavera. Anche se il contratto dura pochi mesi tutto sommato è considerato un buon lavoro. E poi fa sempre una certa impressione quando lo racconti in giro. Ma lavorare in aeroporto, a conti fatti, non è diverso da stare all’ufficio postale. Solo che se sei fortunato per terra trovi un penny invece di cento lire, se invece c’hai sfiga uno ti starnutisce in faccia e sei il primo in Italia a beccarti l’influenza australiana. A selezionarle era Augusto, vecchio marpione e nostro amico fidato. Lo chiamavamo “un bacio e ’na carezza”. Raccontava che ai tempi belli, a Fiumicino, taroccava le liste d’attesa e alla fine, guarda caso, rimaneva a terra proprio la bonazza di turno. Purtroppo signorina non c’è posto, sono desolato ma ho fatto il possibile, posso almeno offrirle la cena? e via così. Dice che non era proprio detto, tante volte si incazzavano per davvero; ogni tanto però ti andava dritta e la benamata compagnia di bandiera non doveva nemmeno sborsare i soldi per il pernottamento della passeggera. Privilegi dei grandi scali: da noi in provincia gli aerei sono pieni solo quando c’è la fiera, e gli sfigati che sul volo non ci stanno sono al massimo rappresentanti dell’edilizia. Altro che cena romantica e serata col botto. Glielo dicevamo ogni volta: Augusto, ci raccomandiamo a te, stavolta pensa solo alla qualità, l’azienda ha bisogno di collaboratrici valide. Ogni tanto riusciva a far passare gnocchette ragguardevoli anche se non sapevano dire mezza frase in inglese; ma erano casi isolati. Di regola aveva le mani legate: facendo i colloqui con le Risorse Umane, il capitolo “bella presenza” aveva una priorità inferiore. 14 Il corso introduttivo durava una settimana: alla fine, giusto prima di buttarle nella mischia, Augusto convocava me e il mio amico Calvados. Capitavamo in aula a fare un sopralluogo, un po’ come i mercanti facoltosi che vedono per primi il bestiame in vendita. Dieci minuti per dare un’occhiata, fare un po’ gli splendidi e farci riconoscere. Era un vantaggio minimo, anche se Calvados è così brutto da assicurare l’effetto rimbalzo e far capire che il pezzo giusto ero io: due battute e poi qualche scommessa, puerile ma divertente. La vera mischia scattava solo dopo, quando le stagionali cominciavano a lavorare. Per le più appetitose cominciava un’esperienza schizofrenica, confrontate coi tempi convulsi del nuovo lavoro in un ambiente dove i pochi colleghi maschi facevano a gara per fare i simpatici e dare una mano, mentre le donne, che erano la maggioranza del personale, non perdevano occasione per far capire che sarebbe stato meglio lasciar perdere. Nonostante la giovane età, le stagionali hanno la scorza dura e, in molti casi, le idee chiare. Subiscono pressioni, dispetti e vere bastardate, ma tengono botta. Al massimo un piantino – ottima occasione per ganci efficacissimi – poi fanno passare la tempesta, creano nuove alleanze e mettono in atto la loro strategia. Devo ammetterlo: sulle prime, giovane e illuso, mi ero invaghito di qualcuna. Ma l’esperienza insegna, e i colleghi esperti pure: oltre alle bastonate nei denti mi erano servite le lezioni del Corazziere, un capoturno che dall’alto del suo metro e mezzo sciorinava imprese degne delle migliori commedie all’italiana, con palleggi di due o tre novelline in contemporanea. Poi concludeva sempre raccomandando: Fai altrettanto, tu che puoi. fenandel59 10-01-2007 12:36 Pagina 15 La sua carriera, quanto a questo, era tramontata mestamente da quando si era accasato con una collega che lo teneva sotto doppio controllo incrociato, a vista e attraverso una rete di colleghe informatrici. Il povero Corazza da allora si limitava a proiettare le sue aspirazioni su di noi, giovani stalloni, sfoggiando solo qualche numero innocente con procaci viaggiatrici in difficoltà. Col tempo ero diventato più accorto, ma i trucchi che adottavo quando arrivavano le nuove stagionali erano grossomodo sempre gli stessi: sorrisetti, ti ricordi di me, al caffè offro io che sono qui da più tempo, se non hai capito chiedimi pure che ti rispiego, e piccoli favori assortiti. Il mio classico era presentarmi come il più bello del check-in, un po’ di spavalderia non guasta. Anche i colleghi, ciascuno aveva il suo stile e il suo repertorio: io ero più tattico, altri come Calvados e il Fiocina più diretti, il Bombarda decisamente sfacciato. Tra noi vigeva un accordo non scritto: se uno puntava una preda con decisione, bastava che lo facesse sapere in giro e per fair play gli altri spostavano il mirino, almeno per un po’. Ma cambiava poco: dopo un mesetto si tirava su la rete e si vedeva cosa avevi preso. Il campo delle operazioni si restringeva settimana dopo settimana. Se con la punta numero uno c’era poco gioco, si rimescolavano le carte e via per un’altra mano. Le migliori, comunque, non passavano mai inosservate. Nell’ambiente le notavano subito tutti, dagli operai della rampa ai baristi fino ai veri ossi duri, cioè i piloti e gli steward, quei maledetti. Non tutti entravano davvero nella competizione. Saverio, ad esempio, il napoletano responsabile del nastro bagagli con la testa eternamente impomatata: lui si limitava a un ruolo di osservazione e, per così dire, progettazione. D’estate mandava moglie e figli per tre mesi in ferie a casa della suocera, «per avere mano libera». Ma a giudicare da quanto si arrapava per ragazzine di vent’anni più giovani, non doveva combinare granché nelle sue serate da single. Quasi tutte le mattine sgattaiolava in silenzio dalla porticina dietro i banchi del check-in e mi spuntava a sorpresa da dietro le spalle. Mi arpionava un braccio e poi partiva con la sua panoramica: in ordine numerico, a partire dal banco 1, numerava in dettaglio posizioni, varianti e orifizi in cui avrebbe posseduto ciascuna delle colleghe presenti. Da vero signore non ne dimenticava nessuna, e con fantasia ammirevole dedicava a ciascuna una piccola perla, un trattamento personalizzato che cambiava giorno dopo giorno. La sua vera passione, però, era la Cavalla, una virago in minigonna perenne che scatenava il suo testosterone in modo incontrollabile. Quando vedeva la Cavalla, Saverio trasaliva, rapito dal desiderio: stringeva fortissimo la morsa sul mio braccio mentre le descrizioni di cosa le avrebbe fatto si facevano sempre più torbide; di solito sul più bello di colpo tornava in sé e concludeva queste performance con un motto di stizza nei miei confronti: «ma perché non te la chiavi, la Cavalla, cazzo!» Come se la cosa dipendesse solo da me. La Cavalla non ci aveva mai degnato di uno sguardo, a me e ai miei compari.A Saverio tanto meno.Volava più alto, lei, puntava dritto ai comandanti, come vengono chiamati nell’ambiente. Alla fine ce l’ha fatta: i bene informati la danno sicura con un pilota tra i più fascinosi. Prima della fine della stagione, però, qualcosa succedeva sempre. Se avevi scommesso e giocato bene il risultato arrivava, soprattutto con le più giovani. Alla peggio, un ripiego. Magari una che veniva fuori in seconda battuta, che a prima vista l’avevi sottovalutata oppure era entrata nelle grazie di qualcun altro. Un classico consisteva nel giocare su più campi, ma in questo bisogna fare molta attenzione: basta una distrazione, la più stupida mossa falsa e il palco cade: il tam tam della solidarietà femminile sputtana a 360 gradi additandoti come un maiale. Sulla definizione, niente da ridire, ma alla fine becchi il doppio due di picche. C’era anche una regola ferrea su cui puntavamo: quelle che arrivando dichiarano ai quattro venti quanto sono innamorate del loro bellissimo fidanzatino, entro fine stagione qualche storiella se la fanno. È sempre stato così, è la “legge del Bombarda”: con la stagionale fidanzata, la chiavata non tarda. Come la ricciolona rossa che diceva che era venuta a lavorare lì per sei mesi perché le servivano i soldi per sposarsi: matrimonio già fissato, lunghe descrizioni dell’abito e altre banalità. Non aveva fatto i conti con il Fiocina, che le ha messo gli occhi addosso prenotandola fin dal primo giorno. Manco una settimana alle nozze e tac, beccati a bombare nella macchina di lui: parcheggio dipendenti, pieno giorno, fine turno. Tanto di cappello. Quello che si fa fatica a capire, in questi casi, è che non necessariamente cedere alla tentazione implica un cambiamento di piani: alcuni giorni dopo la performance automobilistica, la rossa si avviò all’altare, vestita di bianco candore, come previsto. Il Fiocina ne fece una malattia, che durò a lungo e con momenti di profondo sconforto, e fu interrotta solo dall’arrivo della successiva infornata di stagionali. E io? La cantonata colossale è arrivata a sorpresa, quando ormai credevo di avere la pelle spessa come un elefante. Una moretta con gli occhi da zingara. L’avevo notata subito, in aula, durante l’anteprima concessa da Augusto. Misi le cose in chiaro con tutti, quella è mia, guai a 15 fenandel59 10-01-2007 12:36 Pagina 16 chi la tocca, e via con la punta. Le dissi che ogni stagione avevo il diritto di selezionare una che mi facesse da segretaria personale e che se avesse fatto la brava forse il privilegio sarebbe toccato a lei. Sulle prime era stata al gioco, poi un po’ per volta l’avevo persa di vista. Mi raccontavano che stava con un discografico ricco sfondato e m’era giunta anche la voce, non confermata, che combatteva la solitudine delle lunghe tournée del fidanzato fiondando con un belloccio, un collega di Saverio. Poco male, come da procedura avevo cambiato obiettivo in corsa, togliendomi anche qualche soddisfazione. Erano anni in cui andavo via come il pane. Verso fine stagione il Corazza organizzò la solita festa, a cui venivano invitati tutti e regolarmente ne succedeva di ogni. Io sfruttavo queste occasioni per fare notare la mia classe superiore: non mi mischiavo a tutti quegli allupati all’ultima spiaggia e mi astenevo da qualunque gancio, dando meritato spazio all’altra mia grande passione: mi inchiodavo al banco del bar e di solito finivo la serata marcio come un cavallo cantando I will survive al karaoke. Quella volta, proprio mentre cercavo di alzarmi dallo sgabello su cui avevo già costruito una consistente fortuna alcolica, mi si parò davanti la zingara con un fare bellicoso. Io non l’avevo nemmeno vista arrivare alla festa, ma i miei sensi ovattati dall’alcool si ridestarono prontamente. «Non mi offri niente?» «È tutto gratis». «Alla fine l’hai trovata la tua segretaria, eh?» «Ne ho provate diverse, ma le ho licenziate tutte in tronco alla fine del periodo di prova. Non c’è più il personale di una volta». «Il posto è vacante? Mi posso candidare?» Ho sempre pensato che il massimo sia una donna seducente, che nasconde più che svelare, che fa intuire più di quanto ti fa vedere. Ma poi, quelle rare volte che sono così esplicite io perdo la testa. «Facciamo un altro giro di ginlemon e poi ti faccio il colloquio, vediamo se sei all’altezza». Bevuto il drink in un sorso, ci eravamo rifugiati nell’unico bagno della casa. La nostra focosa intimità fu presto guastata da qualcuno che bussava sulla porta in maniera sempre più insistente. Io e la zingara ci guardammo: era inevitabile interrompere l’approccio, e se volevamo mantenere riservata l’informazione sul nostro tête-à-tête occorreva che uno solo uscisse, e l’altro si nascondesse da qualche parte. Pur con gli ettolitri d’alcool che il Corazza forniva ai suoi ospiti e tutta la nostra disinvoltura, uscire insieme dal cesso non poteva non destare sospetti. Eccomi allora, nascosto dietro la tenda della doccia, ubriaco perso e con il nervoso nelle mutande, ad aspettare che la scocciatrice che c’aveva interrotto finisse di vuotare la vescica, canticchiando allegramente una canzone dei Pooh. 16 Nonostante la rompicoglioni, il dado era tratto. Passai la notte con la zingara senza che mi sfiorasse il pensiero del facoltoso discografico o di qualunque altro concorrente al cuore della mia nuova segretaria particolare. Il modo in cui si era proposta e la naturalezza con cui gli eventi si erano svolti mi diedero una certa baldanza: la mattina dopo mi presentai al lavoro con un’ora di sonno, un alito da codice penale, ma incredibilmente tonico. Chi la dura la vince, pensavo. Non ci ero rimasto nemmeno tanto male quando, prima di salutarci, aveva preferito non darmi il suo numero di telefono adducendo motivazioni sfuggenti. Invece avrei dovuto. Nel giro di qualche settimana io e la zingara allacciammo una relazione strana, in cui era sempre e solo lei a decidere tutto, a convocarmi quando voleva vedermi, e io che obbedivo, sbavandole dietro in modo sempre più ignobile. Alla fine dei nostri incontri lei lasciava sempre intendere che, visto quanto le piacevo, le cose tra di noi si sarebbero sistemate in poco tempo. Poi se ne andava e non dava notizie di sé per qualche giorno. Io non desistevo, anzi diventavo sempre più sicuro che prima o poi l’avrei accalappiata e fatta definitivamente mia. A tratti mi sentivo talmente vicino alla meta che pensavo che non appena l’avessi vista cadere ai miei piedi per concedersi finalmente senza più riserve, avrei seguito la strategia che tante volte mi aveva suggerito il Corazza: le avrei detto che non mi interessava più. Sul lavoro facevo del mio meglio per nascondere la nostra liaison, ogni volta che veniva fuori il suo nome cambiavo discorso e smentivo qualunque sospetto nel modo più efficace: continuavo a fare il piacione come sempre. Sfidavo il Fiocina a chi diceva la cazzata più grossa con le colleghe gnocche e per fare lo sborone avevo anche fatto innamorare di me una scorfana di cui si era invaghito Calvados. Affettavo indifferenza anche quando Saverio mi spiegava con la consueta gravità quale trattamento avrebbe riservato alla mia zingarella. L’unica cosa che avevo manifestamente cambiato era il mio atteggiamento professionale: facevo di tutto, ma proprio di tutto, perché il contratto della zingara alla fine della stagione venisse prolungato. Avevo bisogno ancora di un po’ di tempo, solo un po’ di tempo in più, per farla mia: se non fosse stata confermata come avrei fatto? La fregatura, ovvio, era dietro l’angolo. O meglio, davanti ai miei occhi, ma io mica l’avevo vista. Tutti sapevano che la zingara si vedeva con un comandante sardo pluridivorziato, oltre col solito discografico del cazzo e con il collega di Saverio: ecco cosa faceva tutte le altre sere. Non si erano presi la briga di mettermi sul “chi va là” solo perché la mia astuzia aveva dissuaso tutti e nessuno sospettava che tra i tanti ballerini invitati al valzer della patata ci fossi anch’io. Molti anzi si chiedevano: ma se non se la fa, perché fenandel59 10-01-2007 12:36 Pagina 17 insiste tanto a dire che è brava? E si convincevano: forse perché è brava davvero. Alla fine la stronza aveva trionfato. Subito dopo aver firmato l’agognata conferma contrattuale per la prima volta insinuò che il nostro momento non era mica poi così vicino. Un cambiamento di rotta tanto brusco, a dispetto del mio impegno per prolungare la nostra collaborazione, mi incuriosì. Condotto un rapido sondaggio presso le accreditate fonti informative dell’azienda, il risultato fu tanto chiaro quanto sconfortante. Nel frattempo la mia avventura nell’ovattato mondo dell’aviazione civile si stava concludendo. Me ne andai così, dopo un ultimo giro di stagionali di cui, come sempre, io e il Fiocina godemmo l’ebbrezza e Calvados andò in bianco. Non la salutai nemmeno. * L’ho rivista l’altra sera, dopo anni, la zingarella. Stavo passeggiando in centro con Lulù, la stagista diciassettenne che mi ha fatto finalmente mettere la testa Andrea Piva Apocalisse da camera Einaudi, 214 pagine, 13,80 euro Un ottimo esordio e uno dei titoli più azzeccati degli ultimi anni. Ecco cos’è Apocalisse da camera, romanzo del salernitano-barese Andrea Piva, conosciuto soprattutto come sceneggiatore de Lacapagira e Mio cognato, o per Un muro di televisori, racconto incluso ne La qualità dell’aria. Non un capolavoro, sia chiaro, ma un esempio di come ci si possa staccare alla grande dalla stitichezza di molte produzioni nazionali, per stile e organizzazione della storia, oltre che per l’utilizzo di una lingua finalmente non piana, quasi barocca. Ambientato in una Bari che resta sullo sfondo, Apocalisse da camera cresce nella sua miscela di tragedia e di acida ironia a ogni capitolo, permettendo al lettore di ridere, anche se a denti stretti, delle disgrazie del protagonista. Perché, per quanto nel distacco di una narrazione in terza persona, non è difficile leggere nell’implosione di un uomo qualunque, di un bastardo qualunque, il ritratto, seppur distorto, di noi stessi e di una società che è poi quella in cui viviamo. Questo rappresenta la figura del trenta-e-qualcosa Ugo Cenci, assistente senza assegno alla cattedra di Filosofia del diritto, che traccheggia mantenuto dai genitori (loro sì con portafogli, e contenti d’aprirlo per gli sfizi del loro unico figliolo) nei corridoi dell’università, avendo come sole passioni l’alcool, la cocaina e il sesso. Quest’ultimo con studentesse che senza problemi offrono i loro servigi, in cambio del voto sul libretto. Uno come tanti, direbbe Siti, con la coscienza infilata sotto i tacchi. Ma viene un giorno in cui il suo superiore, il professor Frappelle, gli notifica l’esistenza di voci attorno a questi mercimoni. Niente di scandaloso, Frappelle non è né giudice né poliziotto, ma se le voci continuano dovrà prendere provvedimenti: «Che poi significherebbe allontanarti dall’istituto.Tutto qui». La coscienza o qualcosa di simile inizia lentamente a scavare, accendendo il lato paranoico del personaggio e facendolo scivolare inesorabilmente, nell’arco della stessa giornata, dentro il buco nero dell’autodistruzione, da cui non lo salveranno gli innumerevoli pippotti di coca né le massicce dosi di vodka e rum. Non fosse per l’epilogo, Apocalisse da camera sarebbe il degno gemello di Mio cognato: un salto nel nero totale. Ma in questo compendio dell’orrore che Piva costruisce per descrivere la società come oggi la viviamo, il grottesco tanto caro alla migliore e alla peggiore commedia all’italiana ha il sopravvento, rendendo ancora più agghiaccianti le conclusioni che se ne possono trarre. recensioni Andrea Piva a posto, per lo meno nelle ultime cinque settimane. Ci siamo salutati io, lei e Luigi: anche lui ai tempi lavorava in aeroporto e s’era guadagnato l’appellativo di “Culoquadro” per le sue doti fisiche e intellettuali. Ho presunto che oggi sia il suo compagno, o quantomeno il padre dei due gemellini addormentati che portavano nel passeggino. Lei sembrava stanca, un po’ appassita, e d’altronde vivere insieme a due mostri di sei mesi e a Culoquadro, che i suoi anni li ha sempre dimostrati al cubo, non rientra esattamente nella mia idea di vita stimolante e rilassante. Era inevitabile che la situazione generasse un po’ di imbarazzo, soprattutto quando Culoquadro, che non sospettava di nulla, mi ha invitato ad andarli trovare. Manco per il cazzo, pensavo. Andandocene, sentivo un po’ di amaro in bocca. Lulù non ha migliorato la situazione: mi ha chiesto chi fosse «quella vecchia col passeggino» e a me non è venuto da rispondere niente di meglio che «mia cugina». Povera Lulù, chissà che confusione con questa storia delle parentele. Quando incontriamo qualcuno io dico sempre che lei è la mia sorellina minore. Sergio Rotino 17
Scaricare