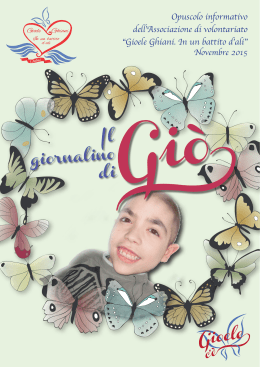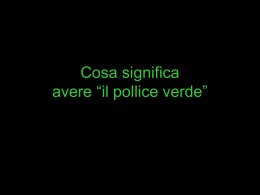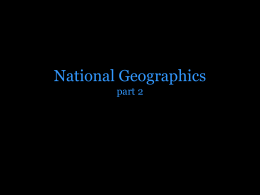Andrea Viscusi SPORE Spore 1. AD 2019 Robert Kerrigan aveva deciso, molto tempo prima, che non sarebbe morto in un ospedale. Entrambi i suoi genitori avevano fatto quella fine, due decenni e mezzo prima, e non era stato piacevole salutarli per l’ultima volta nella cella di un obitorio. Per questo, quando i medici gli avevano spiegato che avrebbe dovuto rimanere lì, e sottoporsi a dialisi quotidiane per sopperire alla sua cronica insufficienza renale, con cortesia ma estrema decisione aveva rifiutato. «Ho già dei piani su come morire» si era giustificato. Suo figlio Stephen lo aveva riportato a casa, senza fargli domande su come era andato quell’ultimo colloquio coi dottori. Le condizioni di Robert erano in costante declino da alcuni anni, ed era ormai chiaro che il suo corpo avrebbe ceduto presto. Rimaneva da appurare quanto presto, ma non era un argomento facile da affrontare. Quella sera, dopo aver cenato con la famiglia di Stephen, Robert era uscito in veranda per godersi l’aria fresca e i suoni della campagna. Stava contemplando il cielo blu rischiarato da migliaia di puntolini luminosi, una vista che nel suo appartamento cittadino era preclusa dalle luci sempre accese di strade ed edifici, quando suo figlio lo raggiunse. Stephen prese una sedia di legno e si sedette accanto a lui, ma non disse nulla. Stava a Robert iniziare il discorso. Decise di partire dal punto più lontano possibile. «Sai cos’è quella?» domandò in tono casuale allungando un braccio verso l’alto, a indicare una parte della volta celeste. «Nel cielo?» chiese conferma Stephen. «Una costellazione, intendi?» «No, dietro alle costellazioni. Quella striscia più chiara, che sembra una spruzzata di vernice. La vedi?» «Sì.» 3 «È la Via Lattea. Lì si trova il centro della Galassia, dove le stelle sono più vicine e concentrate.» Stephen non trovò niente da commentare, così lui proseguì: «Sai, quando ero giovane ero convinto che nel corso della mia vita avrei visto altri mondi, altre stelle. Non avevo ancora trent’anni quando siamo arrivati sulla Luna, ed ero sicuro che, di lì a qualche decennio, saremmo andati tutti nello spazio. Ma non è successo.» «No, non è successo.» «È un vero peccato…» Lasciò la frase in sospeso, perché si era reso conto di essere arrivato al nucleo del discorso. «Ormai è chiaro che non vedrò mai un cielo diverso da questo» aggiunse allora. «Papà, non devi...» «No, aspetta.» Riabbassò lo sguardo e lo portò su suo figlio. Nella semioscurità non riusciva a vederlo bene, ma anche il suo volto tradiva evidenti segni di vecchiaia. E quando i figli iniziano a essere vecchi, i genitori non possono fare altro che morire... come Lana aveva già fatto, sei anni prima. «Sappiamo entrambi che mi rimane poco tempo, Stephen. E quello di non aver raggiunto le stelle sarà forse il mio unico rimpianto. Ma in fondo io amo questo pianeta, e voglio continuare a esserne parte.» «Sarai sempre parte di noi, papà.» La sua voce tentennava. Robert non poté evitare di sorridere. Avrebbe dovuto spiegargli qual era il suo piano per la morte: «Lo so, caro, ma non è questo che intendo. Il fatto è che, quando succederà, e succederà presto, io non voglio finire sigillato in una scatola di legno e metallo, o carbonizzato e stipato in un vaso.» «Va bene, faremo tutto quello...» «Lasciami parlare!» Era straziante interromperlo, ma doveva essere chiaro. 4 «Dopo che è morta tua madre, così all’improvviso, ho capito che io volevo scegliere come morire, e cosa ne sarebbe stato di me, dopo. Per questo ho acquistato un kit di decompicoltura.» «Un... un cosa?» «Si tratta di una tuta nella quale finirà il mio corpo. La troverete nel mio armadio. La tuta è infestata di spore di funghi, organismi che proliferano nutrendosi di sostanze in decomposizione: decompi-coltura. Le spore adesso sono inattive, e possono sopravvivere in questo stato per secoli, ma quando mi infilerete nella tuta la riempirete anche di un mix di minerali e soluzioni attivatrici, che daranno inizio al processo.» «E che cosa... cosa ne sarà di te, papà?» Nonostante la scarsa luce, i riflessi delle lacrime che scivolavano sulle guance di Stephen erano ben distinguibili. «Diventerò quei funghi. Loro si nutriranno di me, e mi reintrodurranno nel ciclo di vita del pianeta. Sarò sempre parte di questo mondo. Non visiterò gli altri, ma...» «Oddio papà, perché? Non avremo nemmeno una tomba su cui piangerti, non potremo portarti dei fiori!» «Sì invece. Nel punto in cui lascerete la mia tuta, crescerà una florida colonia di funghi. Quella sarà la mia tomba, una lapide vivente che vi farà capire che non c’è niente di spaventoso nella morte. La vita prosegue, sempre, solo in forme diverse. Mi capisci, Stephen?» Suo figlio non rispose subito. Non rispose per niente. Gli prese una mano, ed emise alcuni lunghi respiri irregolari. Poi domandò: «Quando sarà?» Stavolta fu lui a inspirare a fondo. «Non più di una settimana.» Sentirsi pronunciare quelle parole lo scosse. Strinse più forte la mano di Stephen, lui gli si fece incontro e lo abbracciò. «Una settimana da uomo» ripeté Robert, bisbigliando nell’orecchio del figlio. «E dopo sarò parte di qualcosa di più grande.» 5 Le spore iniziarono ad attecchire sul suo corpo inerte quattro giorni dopo. 2. AD 2061 Kelvin parcheggiò la bicicletta in veranda, di ritorno dal viaggio verso il Centro di Razionamento. Aveva inoltrato la richiesta per un decompikit la settimana precedente, quando le condizioni di suo padre avevano iniziato ad aggravarsi. Aveva poi dovuto aspettare un giorno in cui il pulviscolo fosse abbastanza rarefatto da permettergli di uscire di casa senza protezioni, e si era recato al Centro a ritirare il kit. Mentre apriva il pacco sul quale era impresso il nome Stephen Kerrigan , non poté fare a meno di fissare lo sguardo sulla macchia di funghi che fin da quando era piccolo copriva una parte del giardino. I funghi non avevano forma definita, erano solo una massa di escrescenze e bulbosità di colore e consistenza variabile. Ma persistevano in quella posizione e si espandevano lentamente, stagione dopo stagione. Quella, gli aveva sempre detto suo padre, era la tomba di nonno Robert. Rientrato in casa, filò verso la camera da letto dove era sistemato Stephen, ma Kate lo intercettò nel corridoio. «L’hai preso?» chiese con il fiato corto, come se lei avesse appena pedalato per otto chilometri all’andata e altrettanti al ritorno. «Sì, era pronto.» Mostrò a sua sorella il pacco che aveva ritirato, contenente la tuta e il mix per la decompicoltura. Kate annuì. «Fai presto. Dobbiamo metterlo dentro.» Solo allora Kelvin capì perché lei appariva così sconvolta. «Oh no. Vuoi dire... papà è... mentre ero via?» Lo sguardo di lei si pietrificò, e fu una risposta sufficiente. Papà è morto , prese a ripetersi Kelvin, cercando di assimilare il vero significato di quella frase. Non gli riusciva di 6 crederci fino in fondo e fu solo quando, guidato da Kate, vide suo padre immobile nel letto che il peso di quel fatto iniziò a opprimergli il petto. «Svelto, apri il kit» gli fece sua sorella, che sembrava affrontare la cosa con più freddezza. «Doppiamo cospargerlo della soluzione micotica per facilitare la coltura, e prima lo facciamo più è efficace. I funghi inizieranno ad assorbire subito il sudore, il sangue ancora in circolo, i fluidi...» «Basta così» la fermò. «Non voglio saperlo.» Kate lo guardò dall’altro lato del letto. I suoi occhi grigi, così simili a quelli di Stephen, lo fissarono con sufficienza. «Non fare l’ottuso. Sai che toccherà anche a te» lo rimproverò. «Certo che lo so. Ma non vuol dire che mi piaccia.» «A nessuno piace morire, Kelvin. Ma è inevitabile. E con il decompikit, in fondo, torniamo a far parte...» «Non raccontarmi la storia del cerchio della vita» la ammonì. «È solo una favola che ci raccontano per farci accettare l’obbligo del decompikit.» Kate abbassò lo sguardo e scosse la testa, come una maestra di fronte a un alunno testardo. Di sei anni più grande di lui, si era sempre sentita in dovere di fargli notare la sua maggiore maturità. Ma adesso erano entrambi adulti, prossimi all’anzianità. Kelvin si riteneva in grado di pensare con la sua testa. China sul corpo di Stephen, Kate iniziò a spogliarlo, con professionale distacco ma anche con estremo riguardo. Estrasse dal kit la soluzione micotica e il pennellino con cui l’avrebbe stemperata sulla pelle del deceduto, come indicavano le istruzioni. Kelvin dovette ricordarsi che non era la prima volta che lo faceva: il suo secondo figlio era morto di fibrosi polmonare, dopo il Tifone Nero del ‘54. «Ti ricordi di nonno Robert?» chiese lei, senza smettere di lavorare sul corpo di Stephen. «Poco. Ero molto piccolo quando è morto. Ricordo quello che ci ha raccontato papà.» 7 «Nonno Robert ci aveva visto lungo» continuò Kate. «Fu uno dei primi a usare il decompikit. Adesso dobbiamo farlo tutti, quindi la cosa non sembra tanto straordinaria, ma all’epoca fu una sua scelta. Anticipò di parecchio i tempi.» «Sì, questo lo so» assentì lui. «Sai perché volle entrare nella decompituta?» Kelvin si fermò a riflettere. In effetti non ci aveva mai pensato. Ora che da quasi quindici anni l’utilizzo del decompikit era obbligatorio, in modo che i preziosi elementi di cui era composto il corpo umano non andassero sprecati ma rientrassero velocemente nell’ecosistema, si dava per scontato che la fine di tutti sarebbe stata quella. Ma il nonno era morto quarant’anni prima, quando ancora il pianeta non era così impoverito dallo sfruttamento umano e devastato dai cambiamenti climatici, e ci si poteva permettere di sprecare le risorse contenute in un cadavere. Perché, allora, aveva voluto diventare terreno di coltura per i funghi? Kate andò in suo aiuto: «Papà mi raccontò della conversazione che ebbe con il nonno, qualche giorno prima della sua morte. Nonno Robert non voleva finire in una cella chiusa, come si usava allora. Voleva continuare a vivere in qualche maniera, in questo mondo che aveva amato. E se guardi in giardino, puoi ancora vedere cosa ne è di lui.» «Sì, ma in realtà il nonno è morto. E anche...» la voce gli si spezzò. «Anche papà.» Non riuscì a trattenere i singhiozzi e chinò la testa, coprendosi il viso con la mano. Quando ebbe superato il momento di improvviso sconforto, sollevò lo sguardo e si trovò Kate proprio di fronte. I suoi occhi lo fissavano ancora intensamente, ma stavolta erano carichi di comprensione. Gli mise le mani sulle spalle. «Sì, papà è morto» ripeté. «E toccherà a tutti noi. Tutti lasceremo qualcosa, qui. Lasceremo soprattutto un vuoto nella vita dei nostri cari. Ma se in qualche modo, anche dopo essercene andati, possiamo essere d’aiuto al pianeta che ci ha 8 sostenuti, e quindi anche a tutte quelle persone che ci hanno amati, allora è nostro dovere farlo. Il nonno lo aveva capito. Voleva smettere di essere un individuo, e far parte di qualcosa di più grande.» Kelvin inspirò e trattenne il fiato per diversi secondi. L’odore di muffa che proveniva dal barattolo aperto della soluzione micotica gli si insinuò nelle narici, inopportunamente fragrante. Era l’odore fresco della vita che sboccia, un’impressione che lo riportava ai primi anni della sua infanzia, quando ancora le tempeste malsane non avevano provocato milioni di vittime, e il pulviscolo non oscurava quasi del tutto il cielo notturno, nascondendo le stelle. «Capisci, Kelvin?» proseguì sua sorella. «Usare il decompikit non è solo un obbligo. Non è nemmeno solo un dovere nei confronti di chi verrà dopo di noi. È un onore.» Stordito per gli sconvolgimenti di quel giorno, ma intimamente convinto, Kelvin annuì. Kate gli tolse le mani dalle spalle, e gli prese le sue. «Vieni, aiutami. Metteremo papà accanto al nonno. I loro funghi cresceranno vicini, si mischieranno. E loro saranno di nuovo insieme.» 3. AD 2128 Sarah si svegliò in preda a un attacco di starnuti. Si ritrovò seduta sul letto, con gli addominali contratti per lo sforzo ripetuto e gli occhi che le lacrimavano. Durò più di due minuti, e alla fine dovette tirare il fiato come dopo una corsa. Disgustata, si guardò le mani con le quali si era coperta naso e bocca, e le trovò cosparse di spruzzi di saliva, grumi di muco trasparente e – notò con ribrezzo – alcuni corpuscoli marroncini. Scese dal letto e corse in bagno. Aprì il rubinetto, ma come nella maggior parte dei casi non uscì nulla: l’antiquato acquedotto ormai era praticamente a pezzi, ed erano rare le occa9 sioni in cui riusciva a far giungere acqua fino alla vecchia casa. Uscì nel giardino. Camminò sul soffice tappeto di funghi che circondava la villetta, sollevando nuvolette di spore a ogni passo, diretta al pozzo artesiano che suo zio aveva installato trent’anni prima, durante la Seconda Siccità. Le precipitazioni non erano un problema in questa stagione, anzi. La forte umidità aveva favorito il proliferare dei funghi, che adesso ricoprivano praticamente tutta la superficie esterna dell’edificio. All’interno alcune pareti stavano perdendo l’intonaco, sostituito dalle propaggini delle ife che trovavano la loro strada attraverso il cemento, assorbendo i minerali di cui avevano bisogno. Pompando la leva, Sarah riempì un catino d’acqua a metà e vi si sciacquò le mani. I piccoli corpuscoli che le erano usciti starnutendo sembravano non volersi staccare dalla pelle, e dovette strusciare con forza per liberarsene. Rimase poi a fissare i minuscoli punti marroni che galleggiavano nell’acqua, cercando di capire che cosa fossero. Si inginocchiò sul terreno, per osservare più da vicino, e in quella mossa schiacciò decine di altri miceli, che si profusero in vaporose esplosioni di spore. Allora capì. Allarmata, corse in casa. Cercò uno straccio, ne strappò un angolo e lo usò per soffiarsi il naso. Non riuscì a spremersi fuori molto, ma i punti marroni erano sempre lì. Che cosa significava? Piegò lo straccio e lo infilò in una tasca. Lo avrebbe mostrato a Mekon, forse lui sarebbe riuscito a darle una risposta. Tornò fuori, ma stavolta prese la via dei campi, dove avrebbe trovato suo marito, occupato a coltivare la terra fin dall’alba. Nonostante fosse ancora prima mattina, il sole batteva forte, e Sarah si dette della stupida per non aver pensato a coprirsi la testa. Camminò con lo sguardo basso, per evitare che la luce solare diretta le danneggiasse gli occhi. Raggiunse Mekon in dieci minuti. Lui indossava una tuta 10 integrale, con un pesante turbante e occhiali da sole a specchio. Solo le mani erano libere, e infatti spuntavano asciutte e abbronzate dalle maniche strette ai polsi. Troppo intento a scavare i nuovi solchi, non si accorse di lei finché non le fu praticamente accanto. «Ehi, che ci fai qui?» chiese con aria preoccupata, la voce ovattata dalla membrana filtrante che aveva sulla bocca. Poi, notando che non aveva protezioni, fu ancora più sconvolto. «È successo qualcosa? Non hai nemmeno gli occhiali!» «No, niente. Cioè, non lo so...» cercò di tranquillizzarlo con scarso successo. Estrasse il fazzoletto e glielo porse. «Guarda.» Mekon prese lo straccio e lo studiò, senza capire. «È sporco...» osservò poco convinto. «È roba che avevo nel naso.» «Sì, allora?» «Non vedi?» «Vedo cosa?» «Sono spore!» sbraitò lei. Mekon rimase fermo a guardarla. Sarah non poteva scorgere la sua espressione dietro la tuta e gli occhiali, ma riuscì a intuirla. Pochi secondi dopo, lui stava ridendo. «Spore? E qual è il problema? Siamo circondati da funghi, è normale che ci siano spore in giro. Non hai visto in che condizioni è casa nostra? Tra un paio d’anni i muri saranno fatti di ife, invece che di mattoni.» Sarah cercò di contenere l’irritazione. «Non hai capito. Queste non erano nell’aria. Mi sono uscite dal naso. Erano dentro di me!» Mekon sembrò considerare quel particolare. Mormorò qualcosa tra sé, continuando a guardare il fazzoletto sporco. «Che cosa significa?» gli chiese infine. «Non lo so, Sarah. Può darsi che tu abbia respirato spore mentre dormivi. Poi le hai cacciate fuori. I funghi sono già estesi su tutte le pareti, per cui...» «No, è diverso» protestò lei. In qualche modo, sapeva che 11 la risposta era più complessa. E in fondo conosceva già la risposta. «Mekon» ricominciò in tono grave, «e se le spore stessero crescendo dentro di me?» «In che senso?» «Pensaci. Da quanto tempo usiamo i funghi per la decompicoltura? Un secolo? Prima era obbligatoria, e venivano forniti i kit per il trattamento dei cadaveri. Adesso i funghi sono così diffusi e specializzati che non ce n’è più bisogno, un corpo viene attaccato dalle spore poche ore dopo la morte.» «Certo, è naturale.» «Questo sì. Ma se i funghi stessero mutando? Se da saprofiti fossero diventati parassiti?» Mekon rimase in silenzio per un po’, poi si tolse gli occhiali e abbassò la guaina che gli copriva il viso. Parlò lentamente, scandendo bene le parole: «Parassiti? Che cosa vorresti dire? Cos’è un parassita?» «Un organismo che prolifera a scapito di un altro, e ne provoca la morte.» Mekon ci pensò su, poi rispose: «Buffo. Non è quello che sto facendo io, proprio in questo orto? Non sto coltivando queste piante per provocarne la morte e proliferare su di essa?» «In un certo senso...» «E non siamo noi tutti parassiti di questo pianeta? Non lo abbiamo quasi portato alla morte?» Sarah cercò di sostenere il suo sguardo, ma iniziava già a sentirsi in colpa per quanto aveva detto. «Forse non ricordi bene le Siccità, e quello che c’è stato prima, e che i nostri genitori hanno dovuto sopportare. Non ti hanno mai raccontato di quando il sole non bruciava la pelle?» «Non dire così» cercò di opporsi. «Sono una Kerrigan. La mia famiglia...» «Sì, conosco la storia. Un tuo antenato è stato il primo a farsi decomporre dai funghi. Nel giardino di casa nostra vive la più antica decompicoltura. Può anche darsi che sia vero. Ma ora anche questo non importa. I funghi ci hanno salvati, Sa12 rah. Quando era troppo tardi per noi, grazie a loro siamo riusciti a sopravvivere, insieme a tutta la Terra. Quindi... parassiti? Forse. Ma lo siamo tutti, in un modo o nell’altro. Se anche tu avessi nel naso una colonia di funghi, cesseresti di essere Sarah?» «No, naturalmente.» «Infatti. E qualunque cosa sia, io continuerò a essere con te.» Sarah sorrise, rincuorata. «Lo so. Grazie.» «Non devi ringraziarmi. Lo faccio perché mi conviene. Anch’io sono un parassita» scherzò lui. Risollevò le protezioni sul viso e infilò gli occhiali. «Torna in casa ora, non puoi stare fuori così scoperta. Io tra un paio d’ore avrò finito, poi mangeremo insieme.» «Va bene» assentì lei. Stava per girarsi, ma poi si sporse verso di lui, e abbassando di nuovo il filtro lo baciò velocemente sulle labbra. Mentre riprendeva la strada di casa avvertì qualcosa sulla lingua. Contrasse le labbra cercando di intrappolare il corpo estraneo, e lo prelevò con le dita. Era un filamento lungo meno di un centimetro, sottile come un capello, con alcune minuscole ramificazioni. Un’ifa. Se ne liberò strusciando le dita sulla camicia, e continuò a camminare. 4. EM 1608 Kemi aveva sete. Non beveva da sei giorni, e per quanto i suoi simbionti potessero sopportare la carenza d’acqua e assorbire l’umidità nell’aria, stava arrivando a un livello critico. I miceli sul suo braccio sinistro iniziavano a seccarsi, e si desquamavano in polverose esplosioni di spore. Finché aveva avuto saliva, aveva leccato i funghi più in difficoltà per tenerli in vita, ma adesso anche le sue ghiandole erano a secco. 13 Se non avesse trovato una fonte d’acqua in breve tempo, sarebbe morto. E senza un rizomorfo che lo reclamasse prima di allora, non avrebbe partecipato alla Micosfera. Nei suoi ultimi vagabondaggi si era imbattuto in pochissimi umani, la maggior parte dei quali fungati solo in minima parte. In effetti anche il tappeto micotico che lì rivestiva il suolo era sottile e fragile: si trattava probabilmente di una zona che era stata scarsamente abitata, nella quale i funghi avevano avuto pochi corpi sui quali attecchire e diffondersi. La Micosfera non aveva ancora raggiunto quella porzione del pianeta. Ecco perché lui si era spinto fin laggiù. Sarebbe stato doloroso, ma avrebbe accelerato il processo di espansione. Esausto, si lasciò cadere al suolo sulla schiena. I miceli sul dorso e sulla nuca attenuarono il colpo, e lo sostennero morbidamente sul terreno prosciugato dal sole. Sollevò il busto e tossì, liberando con ogni spasmo migliaia delle sue spore gastriche. Le guardò librarsi in aria, e sorrise vedendole allontanarsi, augurando loro di trovare un terreno fertile. Poi tornò a sdraiarsi, e chiuse gli occhi. Riprese coscienza quando avvertì il livello di umidità salire rapidamente intorno a lui. No, non era umidità... Acqua! si rese conto. Questa è acqua! Aprì gli occhi, e vide una sagoma incombere su di lui, stagliata contro gli ultimi raggi del tramonto. Quello sconosciuto gli aveva tirato su la testa, e gli stava dando da bere. Kemi avvertì il liquido scorrergli giù per la gola, raggiungere lo stomaco, e subito si sentì rinvigorito. Gli parve di sentire i funghi sul suo corpo gonfiarsi soddisfatti. La sagoma continuò a versargli acqua tra le labbra, poi, quando lui parve sazio, parlò: «Va meglio ora?» Era una voce femminile. Kemi si mise a sedere, scrollando le gambe intorpidite. Portò una mano sulla fronte, per schermarsi dal sole e osservare meglio la sua salvatrice. Era giovane ma graziosa. Carnagione scura, profondi occhi neri e capelli che le scendevano 14 in boccoli fino alla schiena. I miceli che le crescevano sulle spalle e sul collo erano rigogliosi, e le lunghe ife che spuntavano dalle mucose del naso, delle labbra e delle palpebre erano pettinati, tradendo un delizioso tocco di vanità. «Sì» rispose dopo quelle considerazioni, stupendosi lui stesso per la sua voce, che non sentiva da molto tempo. Si alzò in piedi, e guardò la ragazza da pari altezza. «Sto meglio. Grazie.» «Ti ho visto arrivare dalla collina, qualche ora fa. Ho capito subito che eri a secco, così ti sono venuta incontro. Fortunatamente sono arrivata in tempo. Io sono Peac.» Gli tese la mano, e lui la strinse. Avvertì un brivido percependo le spore del suo palmo che si mischiavano alle sue. «Kemi. Kemi Lin Ker-Gan» si presentò. Poi chiese: «Che posto è questo?» «Un posto deserto» confermò lei. «Poca acqua, anche in passato. Pochi funghi.» «La Micosfera non cresce qui?» Peac gli lanciò un’occhiataccia. «La Micosfera cresce ovunque!» «Sì, certo. Ma nessuna appendice in questa zona? Nessun rizomorfo?» «Non nella pianura. Lassù, sulle colline, dove vive la mia famiglia, ci sono molti punti di accesso. Ma qui non sono mai arrivati. Non hanno trovato il modo di attecchire, suppongo.» «Già, lo immaginavo. Per questo mi ero fermato qui.» Lei sgranò gli occhi. Un micelio sull’orecchio destro eiettò le sue spore. «Vuoi dire che...» Kemi annuì, con un ampio sorriso. «Sì. Voglio morire qui, e diventare un nuovo punto d’accesso alla Micosfera.» «Ma se muori qui, da solo, senza un contatto...» «Lo so, non parteciperò. Ma la Micosfera deve espandersi, e qualche sacrificio è necessario.» Commossa, lei gli si gettò addosso e lo abbracciò. 15 «Non credevo che esistessero ancora persone come te!» Sentendo il suo corpo caldo, e le spore che si mescolavano, Kemi fu preso dall’eccitazione. Erano le sue ultime ore di vita, in fin dei conti. E lei lo sapeva. Pochi minuti dopo erano al suolo, avvinghiati l’uno all’altra in un impeto di passione. Fecero l’amore lì, e Kemi la penetrò avvertendo il piacevole contatto dei miceli che crescevano all’interno della sua vagina. Eiaculò sperma e spore, e si augurò di riuscire a fertilizzare sia lei che i suoi simbionti fungini. Era buio quando smisero, e si sdraiarono affiancati, a osservare il cielo blu rischiarato da migliaia di puntolini luminosi. «Dicono che sia come sognare, sognare per sempre» mormorò lei. «Sì, ma non solo» disse Kemi. «La Micosfera non è solo un sogno. È un insieme di sensazioni, di pensieri, di personalità. Tutti gli individui che ne fanno parte, tutti quelli che sono morti e sono stati decomposti dai funghi, esistono ancora lì dentro. Un micelio è immortale, finché riesce a trovare nutrimento, e la Micosfera esiste da... da quanto? Siamo nel 1608 dell’Era Micotica, ma esiste da molto prima. Sempre più grande, sempre più forte. E tutti ne faremo parte.» «Ma tu, Kemi...» Peac girò la testa dalla sua parte, e lui ruotò il collo a sua volta, guardandola con tenerezza. «Tu non sentirai nulla se morirai qui, da solo, lontano dalla Micosfera.» Era vero. Se si fosse decomposto prima di entrare in contatto con un’appendice della Micosfera, la sua identità sarebbe andata perduta. Certo, prima o poi l’enorme macromicelio che si estendeva sopra e sotto la superficie dell’intero pianeta avrebbe raggiunto anche quella zona, e i funghi che erano nati dal suo corpo sarebbero entrati a farne parte... ma lui non lo avrebbe saputo. 16 Ciò nonostante, non gli importava. La Micosfera doveva crescere. Doveva vivere. Per sempre. Ripeté a Peac queste parole, e lei tornò ad abbracciarlo. Fecero l’amore di nuovo, fino all’alba, poi lei lo salutò e tornò alle sue colline. Kemi non si mosse dalla posizione in cui si trovava. Voleva che i suoi funghi attecchissero in fretta, prendendo possesso di quella porzione di terreno. Due giorni dopo, quasi completamente disseccato, vide spuntare dal suolo un rizomorfo, a una ventina di metri sulla sua sinistra. Il filamento di ife intrecciate cresceva a vista d’occhio, allungandosi di cinque centimetri ogni ora. Allora la Micosfera è arrivata fin qui! gioì dentro di sé Kemi. Forse posso entrare a far parte del sogno eterno. Si sporse in direzione del rizomorfo, ma i funghi sulla schiena si erano ancorati al terreno e gli era impossibile spostarsi. Allungò il più possibile il braccio, ma era ancora troppo lontano. «Cresci, cresci in fretta!» pregò il rizomorfo. «Raggiungimi, sono qui!» Lo sforzo prosciugò le sue ultime energie. Capì che la morte era prossima, e che il rizomorfo non lo avrebbe reclamato in tempo. Non avrebbe mai sentito la Micosfera. Ma era felice lo stesso. Peac gli aveva promesso che sarebbe morta in quel punto, e si sarebbe unita a lui. Per allora, la Micosfera avrebbe proliferato anche lì, e così Kemi Lin Ker-Gan sarebbe stato parte di qualcosa di più grande. 5. Data sconosciuta La Micosfera aveva ormai perso il conto delle rivoluzioni che il pianeta aveva compiuto intorno alla sua stella. Era un dato irrilevante per essa. Il pianeta che un tempo, come indicavano i più remoti ricordi dei componenti del micelio, era stato chiamato Terra, 17 adesso si chiamava esso stesso Micosfera. Non c’era distinzione tra il mondo e chi lo occupava. Il macromicelio planetario, costituito da quadriliardi di componenti autonome ma tutte unite in un intreccio di ife che presentava più connessioni di qualsiasi cervello mai sviluppatosi nell’universo, aveva raggiunto il suo livello massimo di espansione. Non c’erano altre risorse da assorbire, non c’erano più distinzioni tra le creature diverse che epoche prima avevano abitato quel mondo. Tutto era Micosfera. E questo, unito al fatto che l’astro intorno a cui la Micosfera ruotava si sarebbe spento presto, rappresentava un problema. Per tempi incalcolabili, in quel suo apice di completezza, la Micosfera aveva analizzato il problema, attingendo ai ricordi, alle nozioni e alle esperienze dei suoi componenti. Infine aveva trovato una soluzione praticabile. Era un’idea semplice, che arrivava da alcune delle più arcaiche propaggini del suo nucleo primevo. La specie mammifera che aveva dato origine al processo di micelizzazione planetaria un tempo aveva sognato di compiere quel passo, ma la fretta e l’immaturità le avevano precluso la possibilità. Adesso, però, la Micosfera disponeva di mezzi ben più efficaci. In un’unica, colossale esplosione, la Micosfera si dissolse nello Spazio, lanciando le sue spore immortali in un viaggio potenzialmente infinito ma destinato al successo, verso altre stelle e altri mondi, per dare vita a qualcosa di ancora più grande. _______________ Il “decompikit” non è un’invenzione, ma un progetto realizzato e diffuso dalla “Infinity Burial Project”, N. d. A. 18 Il giorno più importante Oggi La sveglia parte alle 7:40 come ogni mattina. Ma questo non è un giorno come gli altri. Il braccio di Gioele emerge da sotto il piumone con la circospezione della proboscide di un elefante, e spegne la suoneria. Non perché voglia dormire ancora. In realtà non ha nemmeno bisogno di essere svegliato. Gioele non ha dormito, stanotte. Si tira su dal letto senza troppa energia. I suoi movimenti sono lenti, pesanti, ma dentro freme di ansia ed eccitazione. Il pavimento è freddo sotto i piedi nudi, ma questo non basta a scuoterlo dal suo torpore. Mentre si avvia verso il bagno, passa con lo sguardo sul calendario. Sorride. Perché è il 21 dicembre 2012, ed è il giorno più importante della sua vita. Ieri Quello si stava rivelando uno dei giorni più schifosi della sua vita. «Glielo ripeterò un’altra volta» riprese la vigilessa. «La sua auto è stata immatricolata nel duemilacinque. La prima revisione deve essere effettuata dopo quattro anni dall’immatricolazione. Questo significa che attualmente…» «So fare da solo un’addizione» la interruppe stizzito Gioele. Se c’era una cosa più odiosa dell’essere fermato dalla polizia municipale, era il fatto di venire anche trattato da deficiente. «Allora non mi faccia perdere tempo in discorsi inutili. La sua macchina non può circolare.» 19 «Ma è perfettamente a posto!» insistette lui. «Non è questo il punto. Le revisioni devono essere eseguite regolarmente. Ora, se vuole scendere…» Gioele eseguì il cortese ordine spalancando la portiera di colpo e sbattendola con forza per richiuderla. Lei non parve impressionata dalla dimostrazione di astio. «Mi dia i documenti» disse. Ormai aveva capito l’inutilità delle proteste, per cui si limitò a porgere quanto chiesto. La vigilessa passò le carte al suo collega, che tornò alla volante e cominciò a segnare qualcosa. Ora che poteva vederla per intero, Gioele si accorse che era una bella donna. Giovane, in forma, i capelli neri raccolti dietro la testa e seminascosti dal berretto dell’Arma. Il trucco leggero metteva in risalto gli zigomi con una sfumatura di rosa, e le palpebre con un verde morbido. Forse era colpa dell’uniforme che non prevedeva una versione femminile, ma il seno era a malapena contenuto dai bottoni argentati. Peccato per quelle scarpe basse, ridicole, quasi da infermiera, che lasciavano scoperto il collo del piede. Per quanto fosse attraente, la rabbia che Gioele nutriva nei suoi confronti in quel momento gli impediva di formulare pensieri erotici di qualsiasi tipo. In realtà avrebbe gradito colpirla su quegli zigomi rosati, sporcandosi le nocche di sangue e fondotinta. «Bene» disse lei, «abbiamo finito. Dovrà portare la sua auto a compiere la revisione quanto prima. Fino ad allora non potrà circolare. E ci sono centoquarantotto euro di sanzione amministrativa.» «Non posso circolare? E come vado al lavoro?» «Mi dispiace, non è un problema mio. Ora, prenda questi…» Gioele le strappò i documenti di mano. Rientrò in macchina mormorando tra sé improperi rivolti alla donna e ai suoi parenti più stretti. Lei tornò ad affacciarsi al finestrino. 20 «Mi scusi. Le ho detto che non può circolare.» La fissò basito. «E quindi?» La donna guardò il collega, e annuì nella sua direzione. «Quindi, lui condurrà la macchina a casa sua» spiegò indicando l’altro, che si era tolto il berretto e si stava avvicinando. «E lei verrà con me» aggiunse aprendo di nuovo la portiera. Oggi Gioele richiude lo sportello della specchiera. Nonostante si sia mosso con ostentata calma, più per dimostrare a se stesso di mantenere l’autocontrollo che per ingannare un inesistente pubblico, ha terminato di lavarsi e sbarbarsi prima delle otto. Perde qualche altro minuto osservandosi allo specchio, nel tentativo di convincersi che quello è l’aspetto migliore che può ottenere da se stesso. Passa in cucina, per preparare il caffè che costituirà la sua colazione di quel giorno. Normalmente lo accompagnerebbe con qualcosa di più solido e più dolce, ma questa mattina il suo stomaco pare essersi ritirato alle dimensioni di una prugna. Mentre aspetta che l’acqua salga nella moka, si collega ai soliti feed e podcast mattutini. Come si era aspettato, nessuno può evitare di parlare di quel giorno particolare: la fine del mondo. Almeno secondo il calendario elaborato da un popolo primitivo, estinto ormai da quattro secoli. Non è certo la più affidabile delle previsioni, ma la favola del termine del Grande Ciclo dei Maya ha cominciato a circolare già diversi anni prima della data fatidica, e la cultura popolare ne è ormai assuefatta. Gioele ascolta distrattamente i titoli degli interventi disponibili. Nessuno di questi sembra prendere sul serio la minaccia dell’apocalisse, e non è difficile capire perché: delle 21 immani catastrofi che secondo alcuni, più pazzi o più furbi degli altri, avrebbero dovuto devastare il pianeta, nessuna si è presentata all’appello prima dell’alba di oggi. Se è vero che i terremoti si sono succeduti imprevedibili come sempre e i tornado hanno mantenuto il loro potere distruttivo, è anche da rilevare il fatto che nessun vulcano è emerso dalle viscere della terra e nessun asteroide ha impattato contro la superficie. Niente lascia presagire che la civiltà umana, o la vita stessa, sia in pericolo. Tuttavia, Gioele sa che oggi la sua vita cambierà. Non per l’intervento di divinità o forze cosmiche, ma perché lui lo ha deciso. O meglio, loro lo hanno deciso. Solo nel momento in cui il campanello suona, Gioele si accorge che le otto e mezza sono passate da sei minuti. È già in ritardo. Ieri Non gli avrebbero mai scusato quel ritardo, in ufficio. Aveva perso oltre un’ora e si ritrovava di nuovo a casa, al punto di partenza, e senza un mezzo di trasporto. Il vigile parcheggiò la sua macchina nel posto condominiale riservato. Scese e tornò verso la volante. «Posso andare ora?» domandò Gioele alla poliziotta che lo aveva accompagnato, senza guardarla. «Certo, vada pure» concesse lei. «E mi raccomando, non usi l’auto.» «Non c’è bisogno che lo ripeta ancora. Grazie e buon…» «Senta» disse la vigilessa poggiandogli una mano poco sopra il gomito, «capisco che lei sia infuriato adesso, ma sto solo facendo il mio lavoro. Mi dispiace per l’inconveniente.» Così, si permetteva pure di offrirgli la sua pietà! Se possibile, la cosa faceva ribollire ancora di più l’ira di Gioele. «Ah bene» commentò, «quindi adesso… non so, devo offrirle 22 qualcosa da bere, agente?» «Mi chiamo Petra.» Gioele la guardò senza rispondere. Sembrava quasi che si divertisse, la stronza. «E comunque» continuò lei, «sarà per un’altra volta. Adesso sono in servizio.» «Ottimo. Allora alla prossima occasione le pago un aperitivo, e lei magari mi offre un divieto di sosta.» La vigilessa (Petra, si chiamava Petra) rise. Per quanto trovasse fuori luogo il buonumore, Gioele non riuscì a incazzarsi quanto avrebbe voluto. Uscì velocemente dall’auto per non mostrare alla donna che la rabbia stava sfumando. Il poliziotto prese il suo posto sul sedile del passeggero e lo salutò con un grugnito. Oggi Il saluto di suo fratello consiste in un indice che batte irritato sul quadrante dell’orologio. «Grazia Giova, lo so» risponde Gioele senza fermarsi nell’ingresso. È ancora mezzo svestito, e sì, è in ritardo: alle nove meno un quarto dovrebbero passare a prendere gli altri. Giovanni lo segue in camera da letto. Mentre si sistema la camicia nei pantaloni, Gioele lo vede riflesso nello specchio intento a pulirsi gli occhiali. «Allora, il mondo esiste ancora?» chiede guardando la sua immagine, e stringe la cintura. «Il sole è sempre nel cielo, e non ho visto dischi volanti atterrare da queste parti. Quindi se anche ci siamo allineati col centro galattico e siamo entrati in una porzione di spazio diversa da quella che abbiamo occupato negli ultimi sei milioni di anni, la cosa non sta influenzando altro che gli oroscopi.» Gioele prende la giacca appesa con una gruccia alla maniglia della finestra. È la prima volta che ne indossa una di 23 colore bianco lattiginoso, e non si sente del tutto a suo agio, come se fosse vestito al negativo. Si volta verso il fratello e allarga le braccia per farsi osservare: «Sono a posto?» Lui inforca le lenti. «Manca la cravatta.» «La cravatta la metto in macchina.» «Perfetto. Andiamo.» Giovanni lo precede verso l’ingresso. Gioele chiude la porta con quattro giri e infila le chiavi nella tasca della giacca. Scendono le scale rapidamente, e sono sul pianerottolo del primo piano quando Gioele si blocca. «Cazzo, aspetta!» esclama, e si fionda di nuovo su per i gradini. Dal basso gli arriva la voce scocciata del fratello: «Dai, Giò, muoviti…» Arrivato alla porta, Gioele si tasta alla ricerca delle chiavi, le trova, e le ficca senza delicatezza nella toppa. Non girano. «Merda, oh merda, dai dai dai…» borbotta tentando ancora di far funzionare la serratura, che non ha mai dato problemi prima. Al sesto tentativo, quando il flusso di imprecazioni comincia a farsi blasfemo, si accorge che stava ruotando la chiave nel verso sbagliato. Girando in senso antiorario, la porta si apre. Gioele si precipita dentro e torna in camera da letto, apre il cassetto del comodino e recupera la piccola scatola rivestita di velluto che aveva dimenticato. La stringe forte nel pugno e corre fuori. Giovanni lo aspetta in macchina. Fa rombare il motore in folle quando lo vede comparire dal portone. «Ci siamo» dice Gioele una volta entrato. «Parti!» Ieri «Fermo!» Giovanni eseguì troppo alla lettera l’ordine, ed entrambi subirono il contraccolpo della frenata. 24 «Lascia la macchina qui» suggerì Gioele. «Ma sono in divieto!» «Ci metto giusto due minuti. Quanto ci vorrà per pagare un bollettino?» Giovanni non sembrava convinto, ma spense il motore. «Comunque io non ti porto più in giro…» «E dai, ho la macchina ferma. Faccio in fretta.» I minuti necessari per svolgere la pratica burocratica si rivelarono quasi venti volte quelli previsti da Gioele. Quando fece ritorno alla macchina del fratello, lo trovò impegnato a discutere con un individuo in uniforme. Un individuo che si accorse di conoscere. «Non sono in sosta, sono in fermata!» cercava di difendersi Giovanni. «Motore spento» obiettò lei. Petra. «Ma sto solo aspettando…» «Non insistere Giova» intervenne Gioele, sopraggiunto in quel momento. «Ha ragione lei, sei in divieto di sosta.» La poliziotta si girò verso di lui, e lo sguardo inizialmente acre si stemperò in un bagliore di riconoscimento. «Oh, buongiorno a lei, signor…» «Gioele» completò lui. Petra sorrise. Era truccata con la stessa delicatezza di quando lo aveva fermato, una decina di giorni prima, ma stavolta portava i capelli sciolti sulle spalle, invece che raccolti sotto il berretto. Gioele si ritrovò a pensare che era tutt’altro che detestabile, ora che non era lui a rischiare di essere multato. Non fosse stato per quegli orribili mocassini… «Tutto a posto con la sua auto?» chiese lei. «In effetti non ho ancora preso appuntamento per la revisione. Sono venuto giusto oggi a pagare la sanzione» e sventolò la ricevuta che aveva con sé. «È colpa mia se mio fratello ha lasciato la macchina qui, avevo bisogno di essere accompagnato.» «Capisco…» fece lei, picchiettando con la penna sul blocchetto che teneva in mano. 25 «Facciamo così» propose Gioele, sapendo che quello che stava per dire avrebbe potuto incriminarlo per oltraggio a pubblico ufficiale – sempre che un reato del genere esistesse al di fuori dei telefilm. «Lei rimette la penna in tasca e non scrive niente. Ci offre questo parcheggio in divieto di sosta. In cambio, le offro un aperitivo, come eravamo rimasti d’accordo.» Petra smise di dondolare la penna. «Sono in servizio» ricordò, e sembrava sinceramente triste. «Non lo sarà per tutto il giorno, immagino» fece notare lui. «Voglio dire, anche i semafori si spengono a una certa ora…» Oggi «Anche i semafori funzionano ancora» constata Gioele quando sono costretti a fermarsi per la terza volta. Il ritardo accumulato ammonta a diciotto minuti. Il traffico è lo stesso di ogni mattina. Al pari di loro due, gran parte della gente non sembra curarsi dell’ampiamente anticipato crollo della civiltà. Qua e là, attaccati ai pali o appesi alle finestre dei palazzi, ci sono striscioni che inneggiano in toni più o meno seri al pentimento e alla resa. La fine è vicina, ammonisce uno di questi. Un altro recita: Il mondo finisce domani, dammela oggi. Accanto all’insegna di un ristorante, un cartellone pubblicizza una serata a base di mayale. «Sai, hanno fatto uno studio sui semafori disposti in serie come su questa strada» attacca Giovanni in attesa che scatti il verde. In questo momento Gioele non potrebbe essere meno interessato alle teorie idiote sulla viabilità, ma lascia che il fratello prosegua. «Dicono che se prendi un rosso, li prendi tutti uno dopo l’altro. Perché i tempi e le distanze sono calcolati in modo che ti ritrovi al semaforo sempre nello stesso momento del ciclo verde-rosso-verde. Quindi…» fa 26 una pausa per ripartire. «Quindi…» «Quindi impiegheremo mezz’ora per fare un chilometro, ho capito.» «Più o meno. Mica avevi impegni, oggi?» Giovanni si volta verso di lui sorridendo. «Oh, no, ma essendo l’ultimo giorno della nostra specie pensavo di godermela un po’…» «Non so quello che succederà al resto del pianeta» conclude il fratello, «ma è sicuro che il tuo mondo finirà oggi.» Lui non commenta. Quella battuta l’ha sentita un centinaio di volte, negli ultimi mesi. Si avvicinano al semaforo successivo, e Gioele sta per far notare all’altro che la sua teoria sui semafori si è appena rivelata inesatta, quando Giovanni inchioda. «Giova, che ca…» fa in tempo a dire, prima che il colpo della macchina che li segue lo sbalzi in avanti. La scatola in velluto gli scappa di mano e finisce sul tappetino. Un coro di clacson sottolinea il triplo tamponamento provocato da Giovanni. Gioele fissa suo fratello: «Ma sei rincoglionito? Era verde!» «Scusa, io non… mi sembrava…» Inferocito, Gioele spalanca la portiera ed esce per valutare i danni. Gli occupanti delle altre due auto stanno venendo verso di lui, e le loro espressioni non anticipano una conversazione piacevole. Ma lui non ha tempo da perdere. «Scusate» cerca subito di rabbonirli, «io vado piuttosto di fretta, non potremmo…» In quel momento uno stridio acuto li raggiunge dall’altra parte dell’incrocio. Qualcuno ha inchiodato come Giovanni poco prima. Il fragore metallico che segue copre le bestemmie che Gioele si lascia sfuggire mentre si accuccia e alza le braccia per proteggere la testa. 27 Ieri Gioele alzò la giacca sopra la testa di Petra per proteggerla dall’acqua. Non pioveva quando erano entrati nel ristorante, e nessuno dei due si era preoccupato di portare un ombrello. «Molto galante da parte tua» commentò lei. Quella sera aveva indossato un top e una gonna di un colore troppo simile a quello della divisa con cui lui l’aveva conosciuta. Ma almeno portava un paio di decenti scarpe col tacco. Contrariamente a quanto si era aspettato, Petra era in grado di camminare senza alcuna difficoltà anche con quelle. «Sto solo compiendo il mio dovere civico» rispose lui, mantenendo le braccia sollevate mentre camminavano per tornare alla macchina di lei. «Voi vigilate sull’ordine tutti i giorni, è giusto che anche noi cittadini facciamo la nostra parte.» «E dai, basta!» Petra gli mollò uno schiaffetto a puro scopo dimostrativo. «Basta con le battute sul mio lavoro! Ti rendi conto di quanto sia difficile portare avanti dei rapporti sociali con la mia professione?» «No, proprio non ci arrivo. Ma so che non potrei mai stare insieme a un vigile succhiasangue.» Petra si fermò. Gli rivolse uno sguardo scoraggiato ma luminoso, intenso come il sapore del primo caffè della mattina. Rimase in silenzio per alcuni secondi, che lui si ritrovò a contare nell’attesa che succedesse qualcosa. Poi domandò in un sussurro, appena udibile sotto la pioggia: «Ah no?» Gioele dovette impegnarsi per riuscire a formulare una risposta. In quel momento i suoi pensieri sembravano giocare a nascondino. «Non ne sono del tutto sicuro» disse. «A dire la verità, non ho mai provato.» Un rivolo d’acqua colò da un ciuffo dei capelli e gli finì tra gli occhi, discese sul naso, poi cadde giù. Petra invece era an28 cora asciutta. Nel tendere la giacca sopra la sua testa, le braccia di Gioele le circondavano il viso, in un abbraccio sfalsato di mezzo metro verso l’alto. Lei invece posizionò i polsi all’altezza giusta, incrociandoli dietro la sua nuca. Gioele si aspettava che dicesse qualcos’altro, o forse lui stesso avrebbe voluto parlare prima che accadesse, ma niente sembrava appropriato e comunque ogni proposito evaporò quando la vide avvicinarsi, le labbra profumate di lampone appena dischiuse. Lo scroscio della pioggia intorno e addosso a lui parve cambiare di tonalità, si trasformò in una sinfonia naturale eseguita da un’orchestra celeste. Oggi Se prima i clacson formavano un coro, adesso sono un’intera orchestra. I ripetuti tamponamenti hanno del tutto bloccato l’incrocio, occupato da un pick-up che il proprietario ha abbandonato per lanciarsi a discutere con gli altri automobilisti. Il pulviscolo di vetri infranti in mezzo alla strada brilla come un tappeto di diamanti. Gioele torna verso la macchina e recupera la scatolina che gli era sfuggita di mano per la brusca frenata. Giovanni invece cerca di giustificarsi di fronte ai due tamponatori. «Il semaforo ha cambiato colore, non ho fatto in tempo…» «Cambiato colore un cazzo, era verde.» «Verde pieno!» «Ti sei fermato come un cretino!» «All’improvviso!» «Io non ho avuto il tempo…» «Come facevo?» «E tu vuoi anche…» «E se arrivava qualcuno?» «… che ti dia ragione!» «Un attimo, aspettate» li implora Giovanni col fiato corto. 29 «Vi posso assicurare…» «Non mi frega un cazzo!» interrompe il più aggressivo dei due. «Adesso chiamiamo i vigili così lo vedono loro il casino che hai combinato, imbecille!» L’uomo estrae il cellulare, schiaccia un tasto col pollice, poi si ferma. Un’espressione vacua gli appare sul viso. Torna a guardare Giovanni, stordito, forse spaventato, come se lui fosse la causa della sua incertezza. Gioele si avvicina al fratello e lo prende in disparte. «Ascolta Giova, io non posso rimanere qui.» «Ma la macchina…» «Lo so, infatti. Vado da solo. Prenderò un autobus.» «Ma sei in ritardo.» «Sì, e se rimango qui lo sarò ancora di più. Mi dispiace lasciarti in questa situazione, ma capisci…» «Sì, certo. Me la vedo io, vai.» Gioele gli stringe una spalla con affetto. «Ci vediamo più tardi, il posto lo conosci.» Non ha ancora mosso un passo, quando un motorino che ha evitato tutta la fila slitta e finisce a terra, a pochi metri dalle auto ferme. L’anziana signora a bordo rimane incastrata sotto il peso del mezzo, alcune arance rotolano via dalla busta che era appesa al manubrio. Gioele e Giovanni corrono verso di lei, gli altri due uomini fanno lo stesso. «Tutto bene signora?» «Si è fatta male?» «Riesce ad alzarsi?» In risposta la donna geme debolmente. Le pesanti calze di lana che porta sotto la gonna sono strappate in più punti. C’è del sangue sul viso. «Serve un’ambulanza.» «Tiriamola su…» Gioele cerca ancora lo sguardo di suo fratello. «Io devo andare.» «Va bene, ci penso io.» Giovanni sorride per un istante, poi fa scattare la tastiera del suo cellulare e rimane a fissare il piccolo schermo. Gioele 30 comincia ad allontanarsi, ma il fratello lo ferma: «Aspetta Giò! Com’è il numero per l’ambulanza?» Voltandosi e continuando a muovere piccoli passi all’indietro, Gioele risponde. Crede di rispondere. Sente di sapere quello che deve dire, ma non riesce ad articolarlo, è incapace di pensarlo. «Cen… cento…» balbetta. Si sente stupido. Come se cercasse di aspirare qualcosa da una cannuccia bucata, compie uno sforzo che realizza essere inutile ma non sa come evitare, perché è l’unico modo in cui può farlo. Quella sensazione dura solo un attimo. Poi, con convinzione ed estremo sollievo, esclama: «Centodiciotto!» Suo fratello lo ringrazia e compone il numero. Gioele scorge nei suoi occhi una strana ombra, un’inquietudine remota che, sospetta, qualcuno avrebbe potuto ritrovare anche nei suoi, solo qualche secondo prima. Ma è in ritardo, non può fermarsi a pensare. Ieri Se si fosse fermato a pensare prima di portarla lì, forse Gioele avrebbe cambiato idea. Quanto poteva essere banale una notte sotto le stelle? Ma ormai non poteva cambiare il programma, per cui prese Petra per mano e la condusse nella radura in cui aveva passato giornate intere, da bambino, giocando con suo fratello e con amici da tempo dimenticati, a rincorrersi, ad azzuffarsi, a guardare in su, il cielo e le nuvole. Stese sull’erba il telo da mare che aveva portato apposta, e insieme si sdraiarono. «Non credo sia stata una buona idea» cercò di giustificarsi quando si accorse che lei stava per addormentarsi, accoccolata sul suo petto. 31 Petra si sollevò per guardarlo negli occhi. «No, è un posto splendido. È solo che le stelle, a guardarle, mi mettono tanta tristezza.» «Tristezza?» «Sì» confermò lei, e tornò a sdraiarsi. Indicò la volta scura punteggiata da centinaia di astri, riuniti in configurazioni che nessuno dei due sapeva riconoscere. «Perché mi viene da pensare quanto piccoli e remoti siamo, noi quaggiù, e quanta vita e quanto movimento ci devono essere là, da qualche parte nello spazio.» Gioele restò sorpreso. Petra era intelligente, ma fino ad allora si era sempre mostrata pratica, attenta solo a quello che aveva intorno a sé. Forse per questo le stelle, così lontane, la mettevano in soggezione. «Non preoccuparti» cercò di consolarla, massaggiandole una spalla. «Non c’è niente che possa farci del male, tra quei puntini luminosi.» «Non sto parlando di alieni cattivi, di asteroidi o di supernove. Non sono minacce come queste che mi turbano. Ma… sappiamo così poco, in realtà. Conosciamo solo il nostro piccolo angolino di universo, e crediamo di conoscerlo a fondo, ma basterebbe spostarsi un po’ più in là e tutto questo potrebbe non essere più valido.» «Cioè?» «Cosa sappiamo davvero di tutte le leggi che governano la vita? Le cose potrebbero funzionare diversamente, da altre parti. Un giorno l’uomo potrebbe capitare in una porzione di universo in cui il fuoco non brucia più, le reazioni chimiche non funzionano allo stesso modo, e si espandono come le correnti nell’oceano, che possono essere più calde o più fredde e scorrono in una sola direzione e ci portano a…» «Ehi» la fermò Gioele, sentendo crescere la sua inquietudine. Le pose una mano sulla guancia e la tenne lì, immobile. Guardandola intensamente negli occhi, e parlando in poco più di un sussurro, provò a tranquillizzarla: «Ti ho portata qui per guardare le stelle. In fondo sono belle, no?» 32 «Sì, lo sono.» Petra appoggiò la mano su quella che lui teneva sulla sua guancia. Sorrise. «Sono davvero belle. E stanotte sono davvero tante.» Oggi Gli incidenti quella mattina sono davvero tanti. Sulla strada verso la più vicina fermata dell’autobus, Gioele ne ha contati sei. Più i due all’incrocio. Più la signora caduta. Decide di non soffermarsi a considerare quella stranezza. Deve fare in fretta. Sta correndo sul marciapiede, tenendo stretta in tasca la scatola vellutata perché non scivoli via, quando un cane sbucato da un portone gli si infila tra le gambe e schizza verso l’asfalto. Gioele inciampa, quasi cade, ma riesce a recuperare l’equilibrio. Di nuovo, i freni di un’auto fischiano, si sente un tonfo secco e un guaito, e il cane è finito sotto la macchina. Non vorrebbe farlo, ma Gioele non può evitare di guardare la bestiola riversa sulla strada che ansima, muove a scatti le zampe posteriori, e la scia di sangue blu che fuoriesce dalle narici… No. Rosso. Quello è rosso, non blu. L’insolita sensazione di straniamento lo coglie ancora, solo per un attimo. Quando se ne accorge è già passata. Gioele sente il cuore battere troppo in fretta per essere affaticato solo da quel breve tratto di corsa. Prosegue, adesso camminando piano, verso il palo che contrassegna la fermata dell’autobus. Ci sono altre due persone che aspettano lì, un ragazzino con gli auricolari nelle orecchie e una donna asiatica di mezza età. Gioele si avvicina alla tabella oraria. 8:52 8:58 9:10 9:16 9:25 9:30 9:36 Deve impegnarsi per distinguere bene le cifre, è costretto a coprire con le dita i numeri successivi per riuscire a leggere 33 l’ora nel modo corretto. Sono le nove e undici, secondo il suo orologio. Questo vuol dire che deve aspettare ancora… deve, ancora, prima che… Vuoto. Sta guardando in uno specchio in cui è riflessa la sua immagine in uno specchio. Riesce a pensare solo che deve aspettare ancora, ancora aspettare, ancora, prima che arrivi, aspettare. Non riesce ad andare oltre. È bloccato. «Scusate» chiede ai due in attesa. «È già… è già passato? Quanto manca prima che…?» La donna asiatica dice qualcosa, un cigolio che lui non riesce a intendere. Gioele rivolge uno sguardo interrogativo al ragazzo, sperando che lui possa rispondergli nella sua lingua. Anche il ragazzo dice qualcosa, qualcosa che non cigola ma Gioele non riesce comunque a comprendere. Deglutisce. Fa un cenno e si allontana. Ha deciso che andrà a piedi. Ieri Andare a piedi ormai non era più una scelta per Gioele, ma una necessità. Non si era più curato di effettuare la revisione, e la macchina giaceva ferma nel suo parcheggio condominiale riservato. Aveva anche smesso di pagare l’assicurazione. L’avrebbe venduta, prima o poi. Ma aveva scoperto di potersela cavare benissimo con le sue gambe e le linee di trasporto pubblico. Combinandole, era sempre riuscito ad arrivare ovunque. Casa di Petra, poi, era una delle destinazioni più agevoli: sei fermate di autobus, seguite da meno di un chilometro di camminata. Questione di mezzora. Suonò il campanello. Il cancello era aperto e si permise di entrare prima che lei rispondesse al citofono. Petra apparve sulla soglia in accappatoio, con i capelli ancora bagnati dalla doccia appena terminata. Era scontato che dovesse finire di prepararsi. Le andò incontro e la baciò, insinuando una ma34 no sotto il panno azzurrino per assaggiare la pelle resa profumata dal bagnoschiuma e morbida dall’acqua calda. «Ti amo» bisbigliò lei, insolitamente languida, dopo essersi liberata della sua stretta. «Anch’io» rispose lui, ma si accorse che non era la risposta che lei voleva. «Per sempre?» «Credo di sì.» «Credi?» si lagnò Petra, incrociando le braccia indispettita. «Voglio dire… se diventassi un completo idiota, se perdessi ogni più flebile barlume di ragione, potrei dimenticare di amarti.» «Davvero?» Capì che doveva iniziare a ritrattare: «Dovrei essere completamente pazzo, il mio cervello non dovrebbe funzionare più… in quel caso sarebbe possibile, credo.» «Quindi stai dicendo» riepilogò lei, «che quello che provi per me non è altro che una miscela di reazioni chimiche, di collegamenti tra i tuoi neuroni e che tutto questo potrebbe azzerarsi da un momento all’altro? Che se per qualche motivo non fossi più in grado di ragionare, smetteresti di amarmi?» Gioele sapeva quello che lei voleva sentirsi dire. Si arrese: «No, non potrei mai.» Petra annuì. «Devo vestirmi» disse, e tornò in casa senza invitarlo a entrare. Lui strinse le labbra. Aveva fatto un passo falso. Ma avrebbe rimediato. Sarebbe tornato tutto a posto. Oggi C’è qualcosa fuori posto. Gioele è costretto ad ammettere che qualcosa non va, decisamente non va, quando vede un uomo sdraiato al suolo, le braccia distese lungo il corpo, che 35 si contorce come un lombrico, sembra che cerchi di camminare con le clavicole. Un altro schianto alle sue spalle. Un’auto si è infilata in una vetrina e gli allarmi suonano e il vetro esplode tutto intorno. Qualcuno sta gridando. Sono parole, Gioele può sentire che c’è un ordine in quei suoni, ma non riesce a coglierlo. Lui sa solo che deve arrivare. Arrivare dove? Non lo sa. Sì, lo sa, e ci sta andando. È in ritardo anche se ritardo non è quello che credeva prima perché adesso non importa. Continua a camminare. La direzione è quella giusta, sì, però non è sicuro di quanto manchi ancora. Ci sono dei piccioni. Sono tutti a terra, saltellano. Saltellano e frullano con le ali, come se cercassero di volare e non ci riuscissero. Che cosa può impedire a un piccione di volare, di comportarsi come se fosse un… uno… quello che… un uccello che non vola, che lui conosce, anche se non l’ha mai visto, che è più grosso di un piccione ma non dello stesso colore. Giovanni, anche lui deve arrivare. Lo ha lasciato indietro, ma arriverà anche lui, perché tutti ci devono essere. Questo è il giorno più importante della sua vita, ed è il loro giorno e nessuno deve mancare. C’è un suono che va su e giù, come un fischio che si alza, si abbassa e si ripete, e pensa che in qualche modo quel suono significa che qualcuno sta male ma non capisce perché il suono dovrebbe far stare male, lui lo sente ma non sta male. Gioele ha una scatola in mano, un piccolo cubo dalla superficie morbida quasi calda a toccarla, e ora la sta toccando e sente che è quasi calda e pensa che è calda, ma non del tutto, solo quasi. Apre la scatola. 36 Ieri Gioele chiuse la scatola di colpo. Petra era appena rientrata in casa. Poteva farcela. Cercò di farsi coraggio. Doveva farcela. Trattenne il respiro, non voleva che lei si accorgesse che era lì. Doveva essere una sorpresa, doveva essere perfetto, doveva… La luce si accese. Petra mosse un passo, distrattamente, sfilandosi un orecchino, poi si immobilizzò vedendolo seduto di fronte al suo letto, inginocchiato su una gamba, le mani dietro la schiena. «Cosa…» fu tutto quello che lei riuscì a dire. Gioele si impose di muovere le braccia, spostare in avanti quelle cazzo di braccia che non volevano uscire dal loro nascondiglio. Con le braccia, che si spostavano tremolanti come tralicci sospesi in una giornata ventosa, vennero avanti le sue mani; con le mani, disposte a coppa come un cresimando in attesa dell’ostia, venne avanti la piccola scatola ricoperta di velluto blu; blu come l’uniforme che Petra aveva ancora addosso, rientrata dal turno. «Vuoi…» fu tutto quello che lui riuscì a dire. Ci provò di nuovo: «Vuoi…» Lei gli andò in soccorso. Non disse niente, ma afferrò la scatola e la aprì. Osservò l’anello ornato di un minuscolo diamante sfaccettato che Gioele aveva scelto. Poi tornò a guardare lui. Lo prese per mano e lo fece alzare. Si baciarono, e fu chiaro che non c’era bisogno di suggellare l’accordo in altro modo. Lui cercò di mostrarsi pratico: «Dobbiamo… dovremo fissare il giorno.» «Deve essere perfetto» iniziò a fantasticare lei. «Deve essere il nostro giorno, deve essere speciale.» «Deve essere…» «… la fine del mondo» concluse lei. I suoi occhi brillavano. 37 Oggi e domani e sempre Brilla qualcosa, quella cosa nella scatola quasi calda aperta ora. Lui, che non è solo lui ma ha anche un modo per parlare di sé senza dire che è sé, guarda quella cosa che brilla, che ha una forma come di una cosa che va avanti e ritorna su se stessa e continuando ad andare non ha una fine. Il colore è quello che può vedere intorno, tutti quei pezzettini sparsi che brillano con la luce, e anche se non sa qual è il colore dovrebbe essere lo stesso per tutti. Prende la cosa che brilla e la tiene con due dita, ma gli casca e la prende con altre dita prima che smetta di cascare perché non può cascare di più. Deve arrivare. Deve essere da qualche parte. Da qualcuno. Lo sente, ma un po’ meno. Qualcuno c’era, oltre a qualcosa. E quello che brilla era per qualcuno ma ora qualcuno non serve più perché non c’è quello che prima. Guarda, e vede. Vede altri, tutti qualcuno che forse sono anche loro e come lui. Si chiede se. Chiede ma non. Intorno, qualcuno anche non. Guarda e prova a ma non anche con loro e allora non prova non e sarà più. Mano, in mano brilla percorso non fine avanti e non mano cade brilla in giù e tinc-tinc. Tinc, tinc-ti-ti titititi, tinc. Brilla. Non. Più. 38 Natura morta Forse se il treno non fosse arrivato con quaranta minuti di ritardo e ne avesse accumulati altri venticinque durante il tragitto, per quell’assurdo principio secondo cui un treno già in ritardo deve sacrificarsi affinché gli altri della stessa tratta possano rimanere in orario, Dario non avrebbe nemmeno fatto caso alla frutta nella cesta. Ma era arrivato a casa spossato, nervoso e irritabile, e vedere quelle tre mele avvizzite sul tavolo della cucina gli pareva una ragione sufficiente per avviare una polemica e sfogare così la sua frustrazione. «E che cazzo, Lore!» sbraitò, in modo che il coinquilino potesse sentirlo in qualunque stanza del pur limitato bilocale. «Ma devi per forza farlo marcire qui, questo schifo di frutta?» Il primo cenno di risposta fu lo sciacquone in bagno. Poi Lorenzo Lotti, ventidue anni spesi principalmente a seguire qualunque serie tv americana dagli anni Cinquanta al presente, comparve nel corridoio e gli venne incontro. «Beh, buonasera anche a te» lo salutò con una smorfia, stropicciandosi un occhio dietro le lenti ovali. «Buonasera un cazzo» rincarò la dose. «Non potresti stare attento al cibo che va a male? Preferirei non dover mangiare in mezzo alla putrefazione.» Lorenzo si avvicinò all’oggetto incriminato e osservò le mele grinzose. Dario si sostentava con una dieta quasi esclusivamente carnivora, con concessioni ai prodotti della terra solo nel caso di patate e pomodori; l’unica frutta che gli capitava di assumere era il succo di pera abbinato agli shottini di rum. Perciò le mele nel cesto erano di uso esclusivo dell’altro occupante della casa, che cercò di giustificarsi: «Guarda, le ho comprate giusto ieri sera. Non è normale che siano già in questo stato.» «Sì, okay, se ti fai inculare all’Esselunga e compri la frutta già marcia fai pure, basta che poi non lasci crescere le colo39 nie di muffa, va bene?» Lorenzo annuì, poco turbato dalla rimbeccata. «Ricevuto, capo» confermò, e considerando esaurito l’argomento tornò verso la sua camera, probabilmente per spararsi nel resto della serata altri sette-otto episodi di Doctor Who, la cui serie classica era una delle sue infatuazioni più recenti. Nonostante la sfuriata forse esagerata, Dario sapeva che il coinquilino non se l’era presa. Convivevano (o meglio: “dividevano le spese”, una fraseologia che lasciava meno spazio agli equivoci) da un anno e mezzo, da quando entrambi avevano iniziato l’università, e avevano fatto le elementari insieme, anche se negli anni successivi si erano persi di vista. Il loro rapporto era abbastanza radicato da poter sopportare anche episodi come questo. Prima di pensare alla cena, Dario accese il computer ed entrò su Facebook, per controllare se Lara avesse risposto al suo messaggio di quella mattina, cosa che non era avvenuta. Assimilando quell’ennesima seccatura della giornata, tornò in cucina per prepararsi due Sofficini, ignorando le mele semimarce che continuavano a occupare il cesto alle sue spalle. Aveva dimenticato la questione della frutta finché non rientrò in casa il giorno dopo, a metà pomeriggio grazie all’assenza del professore di economia politica, e vide che adesso erano completamente annerite. Ma non era quello il dettaglio più insolito: un post-it appiccicato su una di esse recava la scritta “Non buttare – esperimento in corso” nella calligrafia spigolosa di Lorenzo. Inoltre adesso le mele erano circondate da un grappolo d’uva, due arance e una banana. Dario prese la prima penna che trovò e aggiunse sul foglietto giallo: “se stai cercando di realizzare una natura morta sei sulla buona strada”. I biglietti lasciati in giro erano uno dei sistemi di comunicazione più in voga tra loro due, visto che spesso avevano orari diversi e capitava che non si incrociassero anche per un 40 paio di giorni. La mattina successiva il bizzarro esperimento di Lorenzo gli fece prendere un colpo quando, mentre si preparava il caffè e scartava un Buondì all’albicocca, vide che anche l’orologio a muro era appoggiato nel cesto della frutta, e segnava le 10:49. Precisamente due ore e quarantasei minuti di ritardo rispetto all’orario del suo treno. Ebbe un attimo di panico, poi pensò di controllare il telefono, che invece segnava le 7:42, il che era più coerente con la sveglia impostata sulle 7:20. Aveva sentito trafficare Lorenzo nella sua stanza, per cui sapeva che era sveglio. «L’orologio è svalvolato!» avvertì, anche se la lancetta dei secondi girava senza la minima esitazione. Il coinquilino emerse alcuni secondi dopo, in boxer e maglietta e senza occhiali, lo sguardo che sembrava perso nei contorni indistinti della sua miopia. «Uh, no, non è l’orologio che non va.» «È avanti di due ore» gli fece notare Dario biascicando il boccone. «No, la questione è un’altra» ripeté lui. «Questo è il mio esperimento.» «E che sarebbe?» chiese scettico. Lorenzo esibì un sorriso da bambinone. «Ecco, mi pareva strano che la frutta fosse marcita così in fretta. Davvero, era fresca quando l’ho presa! Allora mi è venuto un dubbio.» «E ne hai presa dell’altra da far marcire...» «Esatto.» Spostò l’orologio che copriva la visuale, e mostrò che le mele adesso presentavano delle grosse macchie di muffa, la banana era quasi interamente striata di marrone e gli acini d’uva erano diventati flaccidi e opachi. «Wow» commentò Dario. «Mi stai dicendo che il nostro cesto ha il potere di far marcire la frutta?» «Incidentalmente sì, ma non è solo quello.» 41 «Non che mi interessi davvero, ma vai avanti.» «Credo che in questo punto preciso della nostra casa, dove teniamo il cesto della frutta, esista una sorta di anomalia del tessuto spazio-temporale, per cui il tempo scorre più in fretta che nel resto dell’universo. Non si spiega in altro modo il fatto che la frutta marcisca così velocemente.» «Non potrebbe essere semplicemente che qui dentro fa troppo caldo, c’è troppo umido o che so io?» «Nah, la cioccolata nel mobile lì accanto rimane sempre bella soda. E hai visto l’orologio? In effetti è andato avanti.» Dario lasciò che la sua espressione commentasse quella teoria. «Sì, sì, lo so che non mi credi» minimizzò l’altro. «Ma sto studiando altri esperimenti. Vedrai che ti fornirò la prova inconfutabile che è così.» «Dopodiché mangerai queste cazzo di mele?» «Sì, forse» scrollò le spalle. «La perdita delle mele è solo un effetto collaterale.» «Okay, allora nel caso tu scopra come accelerare il tempo, fammi il favore di applicare la formula a Lara, che ogni volta che le scrivo mi fa dannare una giornata intera prima di rispondermi con tre parole in croce.» Lorenzo ridacchiò. «Beh, credo che potrei far invecchiare il suo corpo ma non modificare il suo cerv...» Si interruppe a metà parola, corrucciò la fronte, e dopo alcuni secondi tornò in camera sua. Dario scosse la testa, a metà tra il divertito e il confuso, poi si rese conto che, indipendentemente dalla velocità del tempo, lui iniziava a essere davvero in ritardo. Finì il caffè in una sorsata, prese lo zaino e uscì. Nella settimana seguente, mentre la frutta passava dallo stato “marcio” allo stato “morto”, assumendo la forma di rinsecchiti moncherini neri, tanto che nemmeno i moscerini ne erano attratti, Dario notò che il suo coinquilino usciva ogni matti42 na presto per un quarto d’ora, festivi inclusi, e tornava con un giornale che poi abbandonava sul tavolinetto dell’ingresso. Gli risultava strano che Lorenzo potesse interessarsi a un quotidiano, che peraltro non sembrava leggere mai, ma d’altra parte le sue stranezze peggiori erano ben altre, per cui lasciò correre. Si meravigliò invece il giorno in cui, al posto del cesto della frutta, vide appoggiato sul tavolo un cuscino, e la sedia adiacente imbottita e coperta da un piumone. Lorenzo non era in casa, ma appena rientrò lo intercettò subito: «No, ecco, questa adesso me la spieghi.» Lui ghignò soddisfatto: «Sapevo che saresti venuto tu da me!» «Dai, non fare l’idiota. Che significa quel cuscino? Abbiamo ospiti?» «No. Lì ci dormirò io, stanotte.» «Seduto al tavolo?» «Proprio.» «Ti aspetti che ti chieda perché dovresti farlo?» «Me lo stai chiedendo?» Dario sospirò. In questi casi era insopportabile. «Sì, dai, te lo sto chiedendo.» «Allora. Tu non ti sei più interessato, ma naturalmente avevo ragione. Ho fatto alcune prove con dei cronometri sincronizzati in varie parti della casa, e ho scoperto che in effetti in questa piccola zona il tempo corre. Non sono riuscito a definire i confini precisi dell’anomalia, ma comunque il punto è quello. L’effetto però non è lineare, è cumulativo: un oggetto nella zona anomala accelera sempre di più, quindi all’inizio prende un vantaggio di pochi minuti, poi qualche ora, e dopo circa sette ore arriva a una settimana di anticipo.» «Ma dici sul serio?» chiese conferma Dario. Era una cosa assurda, però il tono dell’altro non era quello di quando raccontava una storiella. Anzi, aveva l’espressione e il linguaggio da esame universitario (Dario aveva assistito al suo orale di tri43 gonometria, che gli era valso un 28 sul libretto), o delle volte in cui riassumeva la trama di qualche telefilm. Lorenzo era serio. «Assolutamente. Non ti sei accorto di nulla perché in questi giorni l’unica cosa a cui pensi è come trovare la strada per le mutande di quella.» «Lara.» «Sì, lei. Comunque la cosa funziona così, ti garantisco.» «Okay, allora perché il cuscino?» «Ho pensato a un livello successivo di astrazione: se gli oggetti lì accelerano, allora anche un cervello cosciente può portarsi avanti, e acquisire in anticipo cognizioni che otterrebbe solo una settimana dopo.» «Oh.» Dario cominciava a capire. Forse. «Quindi tu stanotte dormi con la testa sul tavolo, e domattina sai come sarà il tempo mercoledì prossimo?» «Anche, ma ovviamente non lo faccio per il meteo.» «E per cosa? Per vincere al Superenalotto?» Lorenzo ghignò di nuovo. «Oddio. Davvero?» «Certo, perché no? Mica mi interessa mettere al servizio della scienza e del progresso questa cosa. Almeno, non per il momento. Intanto cerco di tirarne fuori qualcosa io. Niente di eclatante, punto a centrare un cinque, giusto per farmi un gruzzoletto. Poi magari tra qualche mese lo ripeto, e nel giro di un anno sono sistemato, no? Nel frattempo studierò per bene tutto, gli darò un nome figo tipo “Effetto Natura Morta”, e lo darò alle stampe.» Dario considerò per mezzo minuto quel piano, e dovette ammettere che sembrava sensato. «Sei sicuro che funzionerà?» «No, infatti, stasera vedremo. Ho pensato questo: per fare in modo che la mia coscienza guadagni l’anticipo del quale ho bisogno, serve che il mio corpo acquisisca prima l’abitudine a controllare i numeri. Per questo sto andando ogni 44 mattina a prendere il giornale e leggere le estrazioni del lotto, cercando di memorizzare i numeri. In questo modo, se questa azione diventa una mia costante, facendo scorrere in avanti la coscienza percorrerò in anticipo tutte le azioni abituali, e mi sveglierò ricordando già il giornale della settimana prossima con i numeri usciti, che poi potrò giocare per tempo. Che te ne pare?» «Cazzo, Lore, ti direi che sei un genio se non avessi giurato di non farti mai un complimento!» Dario era sincero. Sapeva che il suo compagno di casa aveva un gran cervello, che sprecava per lo più in cazzate. Questa era una delle sue idee più brillanti. Anche se all’atto pratico non avesse funzionato, restava davvero una bella pensata. «Però devi promettermi due cose» aggiunse. «Cioè?» «Intanto, se funziona e vinci quarantamila euro...» «La vincita di un cinque al Superenalotto paga in media quarantasettemila euro.» «Insomma, in ogni caso, per prima cosa paghi da bere.» «Fattibile.» «E poi, butti via questa schifezza di frutta.» Lorenzo sorrise e gli tese la mano. «Abbiamo un accordo, capo.» Dario aveva dimenticato mele, anomalie spazio-temporali ed estrazioni del lotto quando tornò a casa mercoledì sera. In testa aveva impressa soltanto la risposta di Lara al suo chilometrico messaggio che si estendeva nello spazio e nel costo di quattro sms. A quella solenne proclamazione di interesse e intenzione di approfondimento di una conoscenza superficiale che avrebbe potuto anche eccetera eccetera, lei aveva ritenuto corretto rispondere con un laconico: “ok domani sera?”. Da un lato era frustrante, dall’altro era perfetto. Era tutto il pomeriggio che pensava a come si sarebbe vestito, a dove l’avrebbe portata, a cosa le avrebbe detto... ma ancora non riusciva a figurarsi in che modo avrebbe potuto 45 concludersi la serata. La sua infatuazione per quella ragazza era quasi inspiegabile. Lara era indubbiamente carina, però non una bellezza da levare il fiato. Era simpatica ma non troppo socievole né brillante, e non condivideva con lui particolari interessi. Eppure, da quando l’aveva conosciuta una mattina sul treno, come amica di un’amica, ne era rimasto impressionato. Si erano incontrati poche altre volte, sempre per caso sullo stesso treno, e lui era riuscito a ottenere un contatto Facebook, qualche conversazione spicciola e un numero di telefono. Nonostante gli sforzi velati ma frequenti, tuttavia, non era mai riuscito a incontrarla al di fuori del contesto pendolare. O almeno così sarebbe stato fino al giorno dopo. Si stava avviando verso il bagno per una doccia, l’aria trasognata, quando Lorenzo gli si impose davanti. «Funziona» disse. Dario non capì, non subito. Quasi non riconobbe il coinquilino, perso com’era nelle sue fantasticherie. Poi focalizzò lo sguardo e l’attenzione. «Ah, okay. Cioè dici...» «Dico l’Effetto Natura Morta, rincoglionito!» Gli sventolò una mano davanti al naso come a volersi accertare delle sue reazioni, poi aggiunse: «Ho dormito sul tavolo stanotte, e a parte la scomodità, quando mi sono svegliato avevo un bel bagaglio di ricordi nuovi. Cioè, futuri.» Finalmente Dario riuscì a ricordare il piano del suo amico. «Wow, davvero? Quindi sai che numeri usciranno?» «Quelli di domani, sì. Ricordo il giornale comprato venerdì mattina e i numeri che riportava. Domattina esco e li gioco, e domani sera ho quarantasettemila euro in saccoccia!» Dario si rendeva conto della grandiosità della cosa, ma era troppo distratto dalle sue questioni amorose. «È stupendo, davvero stupendo. Quindi sai già quello che succede nei prossimi...» Un’idea gli balenò in testa. 46 «Ehi, aspetta. Sai qualcosa di Lara? Non ti ho raccontato nulla nei prossimi giorni?» «Uhm, no. Perché, vi siete visti?» «Usciamo domani sera. Nel sogno non ti ho detto com’è andata?» «No, in effetti non me ne ricordo. Anzi, ora che mi ci fai pensare, non ricordo nessuna conversazione con te nella prossima settimana... ma credo che dipenda dal fatto che ricordo solo le azioni sistematiche, quelle acquisite a livello quasi fisiologico dal mio corpo. Di te non ho un bisogno così viscerale...» «E di questo ringrazio il Signore» sentenziò Dario. «Va bene, lascia stare. Domani sarà una giornata importante per entrambi, vedrò di sbrigarmela come hai fatto tu.» Lorenzo parve deluso dal fatto che non gli avesse dato maggior soddisfazione, e se ne tornò in camera sua. Mentre si faceva la doccia, Dario ripensò alle parole del coinquilino: ricordava solo le cose acquisite dal suo corpo... e Lara per lui non era forse questo? Se era davvero innamorato come credeva, la loro serata insieme aveva sicuramente un ruolo centrale nel suo equilibrio psicofisico. E se, come aveva fatto Lorenzo, avesse dormito anche lui al posto del cesto della frutta, forse avrebbe potuto ricordare come sarebbe andato il loro primo appuntamento. Tentennò per il resto della sera tra l’idea del destino, l’opportunità di conoscere il proprio futuro, il paradosso del nonno e così via, ma quando era l’ora di andare a dormire si accorse di aver già preparato il cuscino sul tavolo in cucina. Non sarebbe stato confortevole, ma doveva sapere. Era troppo importante. In effetti dormì male. Non solo per la posizione innaturale, ma anche per una serie di sogni confusi che lo svegliarono più volte: visioni e rumori metallici, dolorosi, lamiere distorte e fumo acre, sirene e... «Che ci fai lì?» lo svegliò del tutto Lorenzo. Dario alzò la testa dal giaciglio improvvisato. Buttò 47 un’occhiata all’orologio: le 7:09. «Ho dormito qui» spiegò, anche se era evidente. «Volevo sapere di Lara e...» L’altro scosse la testa con disapprovazione. Era già vestito, stava per uscire. «Io vado a giocarmi questa schedina, almeno uno di noi fa qualcosa di utile» annunciò, agitando il foglietto sul quale aveva trascritto i numeri che ricordava. «Spero tu abbia dormito meglio di me lì sopra.» «No, per nulla. Ho fatto degli strani sogni... degli incubi. Ho visto...» e mentre lo diceva, capì di cosa si trattava: metallo, fumo, sirene. «Ho sognato un incidente. Un incidente ferroviario.» Lorenzo aveva già aperto il portone, ma a quelle parole si bloccò e tornò a guardarlo. Il suo sguardo si incupì. «Dario, quello non era un sogno. Era un ricordo.» Quaranta minuti dopo si trovava inquieto e nervoso in attesa del treno. Sulle prime non aveva dato peso alle parole di Lorenzo, ma riflettendoci lungo il tragitto aveva cominciato a crederci. Dopotutto era coerente con l’Effetto Natura Morta: i ricordi delle azioni sistematiche erano accelerati, e il pendolarismo era certo una delle più radicate nella sua fisiologia. Quindi era davvero possibile che presto sarebbe rimasto coinvolto in un incidente ferroviario. Forse quella stessa mattina. E c’era un’altra cosa che lo preoccupava. Il presunto incidente era l’ unico ricordo che gli era rimasto dopo quella nottata; inoltre, Lorenzo aveva detto di non ricordare, nella settimana successiva, nessuna conversazione con lui. Era allora possibile che quell’incidente fosse in realtà il suo ultimo ricordo? Il che equivaleva a chiedersi se fosse o meno sul punto di morire. La voce sintetica dell’altoparlante annunciò l’approssimarsi del treno. Istintivamente, Dario mosse un passo indietro, come se non fosse più tanto sicuro di voler montare. 48 Certo, anche se lui non fosse morto nel presunto incidente, non era detto che non ci fossero altre vittime, e chissà quanti altri feriti, e danni... per non parlare dei ritardi sulla linea. Sarebbe stato sicuramente preferibile evitare che si verificasse. Era una sua responsabilità? Sapendo che sarebbe potuto succedere, stava a lui muoversi per prevenirlo? Doveva comportarsi da eroe? Ma quali sarebbero state le conseguenze? Gli altri passeggeri avevano preso ad affollarsi sulla pensilina. Un passaggio a livello vicino scampanava per l’imminente passaggio dei vagoni. Se intendeva fare qualcosa, doveva decidere in fretta. Il treno comparve e si avvicinò, ragliando sui binari mentre frenava. Le carrozze iniziarono a scorrergli di fronte, sempre più lente, le macchie dapprima indistinte dei finestrini assumevano la loro forma e i passeggeri all’interno diventavano riconoscibili. Facce e vite sconosciute, delle quali forse teneva in mano il destino, decine di persone che non avrebbero mai saputo che lui... Lara! C’era anche lei quella mattina! Era stata un’istantanea, una breve apparizione nel riquadro illuminato del vetro, ma era lei! Aveva riconosciuto l’acconciatura, l’espressione imbronciata, la giacca verde oliva. Prima di accorgersene, Dario stava correndo. Inseguiva il treno per raggiungerla, per chiederle di scendere e... E no. Si rese conto che lei non gli avrebbe mai dato retta. Gli sarebbe apparso folle. Doveva trovare un altro modo per salvarla. Per salvare se stesso, e tutti gli altri. Ma come si fermava un treno in corsa? Avrebbe dovuto tirare il freno d’emergenza? Distrarre il capotreno? Menare il controllore? Le porte si aprirono, e i pendolari in attesa lasciarono scendere gli altri prima di montare. Dario salì con loro. Una cinquantina di persone in tutto doveva prendere posto. Venti-trenta 49 secondi al massimo, e il treno sarebbe ripartito. Si diede dello stupido: stava pensando a un modo per fermare il treno, e il treno era già fermo. Doveva solo pensare a come non farlo partire. Considerando il poco tempo a disposizione, gli venne in mente un’unica cosa. Scese in tutta fretta, corse ancora per portarsi in testa al treno, e da lì balzò al centro dei binari, direttamente di fronte alla locomotiva. Si posizionò a gambe divaricate, braccia alzate e busto eretto. Si immaginò come lo sconosciuto di Piazza Tienanmen contro i carri armati. Solo che lui non aveva una rivolta da portare avanti. Lì nel mezzo, a impedire la partenza di un treno regionale, cosa poteva giustificarlo agli occhi dei presenti? Gli venne in mente un solo modo: «Lara!» gridò. «Lara Cagna! So che sei su questo treno! E sono qui per dirlo davanti a tutti! Ti amo!» Tutto sommato, tornò a casa alla solita ora. Nonostante un’intera giornata passata in questura a firmare verbali e promettere di non fare altre stronzate del genere, rientrò in tempo per cena. Lorenzo lo aspettava sulla porta. «Che cazzo hai fatto?» lo investì. Sapeva già della sua disavventura tramite il messaggio che lui gli aveva mandato, ma il tono non era affatto preoccupato. Era decisamente incazzato. Dario non sapeva come iniziare a spiegare. Il suo piano aveva funzionato: per l’assurdo principio secondo cui un treno in ritardo attende tutti gli altri in orario, quello su cui sarebbe dovuto montare era rimasto fermo in stazione per oltre mezz’ora. E non c’era stato alcun incidente, se mai era previsto. «Mi hai detto tu che era un ricordo, Lore» spiegò con orgoglio. «Dovevo impedire quell’incidente. Molti avrebbero sofferto, io forse sarei morto, e Lara...» «Ma come cazzo ti è venuto in mente?» 50 «Dovevo farlo! Non capisci? Sapevo cosa sarebbe successo e...» «E hai cambiato il corso degli eventi, idiota!» sbottò l’altro, muovendogli le mani contro come se avesse intenzione di strozzarlo. «Hai controllato quali numeri sono usciti al Superenalotto? Te lo dico io: non quelli che ho giocato!» Dario fissò il coinquilino. «Cioè, vuoi dire che...» «Che hai alterato l’universo, e tutto ‘sto casino non è servito a nulla.» «È servito a salvare delle vite umane...» provò a giustificarsi. «Ah beh, grazie tante Batman. Ma vaffanculo!» Detto questo si voltò e se ne andò in camera sua. Dario lo rincorse: «Ma che problema c’è? Ti fai un’altra dormita sul cesto della frutta e ci riprovi dopodomani!» «No, caro. Non so perché, ma la tua pantomima da supereroe ha fatto collassare l’anomalia. Niente più Effetto Natura Morta, sul tavolo.» «Oh, mi dispiace» si scusò sincero. «Era proprio una buona idea.» «Di certo migliore della tua» lo rimbeccò Lorenzo. «Spero almeno che tu sia riuscito a salvare la tua bella principessa.» «Ecco, in effetti» confessò, «se l’è un po’ presa. Per il fatto che le ho fatto fare una figura di merda in tutta la stazione, che hanno chiamato pure lei a depositare in questura, ha dovuto saltare un esame e così via. Non credo che stasera ci vedremo... e probabilmente mai più.» Per la prima volta in quella conversazione, l’espressione di Lorenzo si addolcì. Sorrise. Ghignò. «Oh, non sai quanto mi dispiace!» cantilenò ironico. «Andrà meglio la prossima volta, signor Wayne.» Prima che Dario potesse invitarlo a sua volta a visitare il retto di chicchessia, il suo coinquilino sbatté la porta della camera e lo lasciò solo nel corridoio. 51 Dario aveva deciso di prendersi almeno un giorno di riposo. Aveva sospeso la sveglia, la sera prima, e si era alzato in tarda mattinata, intenzionato a oziare per tutta la giornata. All’inizio non notò niente di strano, solo un vago sentore dolciastro nell’aria. Poi, quando quasi inciampò su qualcosa abbandonato per terra, se ne accorse: la casa era tappezzata di mele. Su ogni sedia, ogni mensola, ogni mobile, ogni mattonella. Ogni superficie libera era occupata da una mela. Furioso, cercò Lorenzo in casa, ma il coinquilino era assente. Trovò però alcuni post-it appiccicati al cesto della frutta sul tavolo, nel punto che era stato l’origine di tutta quella storia. Dicevano: “NON TOCCARE le mele – esperimento in corso l’effetto natura morta è sparito da lì ma da qualche parte DEVE essere forse è ancora in questa casa se vedi marcire una mela prima delle altre avvertimi POI le butterò via” 52 Il Dottipardo Quando è nato il mio primo fratello avevo sei anni. Non fu affatto una sorpresa, papà mi aveva sempre detto che sarebbe avvenuto allora, e infatti andammo insieme nella Sala di Incubazione per prelevare il neonato. Non ci ero mai stato prima, ai bambini della mia età non era permesso entrarci. La giustificazione che ci fornivano i nostri padri era che fosse un posto pericoloso, ma dopo aver letto il Libro so che la Sala di Incubazione è una delle più delicate che il Dottipardo ci ha fornito. Perciò i piccoli devono tenersi lontani, c’è il rischio che compromettano il lavoro delle macchine che generano nuovi individui. In realtà per noi bambini sprovvisti di Codice sarebbe stato impossibile accedervi, ma i genitori ci intimavano comunque di tenerci alla larga da lì. La Sala si trovava lontano dalle abitazioni, nel complesso di edifici che comprendeva anche la Serra e il Reattore. Mio padre mi condusse per mano fino alla porta blindata, poi inserì il suo Codice ed entrammo insieme. Percorremmo il corridoio, con le luci che si accendevano al nostro passaggio e si spegnevano una volta superate di una decina di passi. Procedevamo in lenta discesa, e quando raggiungemmo le Incubatrici eravamo di almeno un paio di metri sotto il livello del suolo. L’aria era umida ma fresca, sembrava rimanere attaccata alle narici e riempire i polmoni. Io ero alquanto turbato da quell’ambiente sinistro. Papà dovette accorgersene, perché di nuovo mi prese per mano. «Va tutto bene, Marlo» mi disse, ma anche lui bisbigliava, come se non volesse farsi sentire dai bambini che stavano crescendo lì dentro. Seguendo la numerazione delle incubatrici, arrivammo davanti alla Numero 12. La stessa in cui ero nato io, sei anni prima. E mio padre, trenta prima di me. La spia verde sulla 53 console anteriore lampeggiava: significava che la nascita era imminente, ed era solo in attesa del riconoscimento del padre. Lo osservai mentre inseriva di nuovo il suo Codice sul pannello, e allora la luce verde divenne fissa. Un gorgoglio alla base dell’Incubatrice fu il primo segnale che il nuovo bambino stava per essere consegnato. Vidi il livello del fluido discendere all’interno dell’ampolla sferica, posizionata esattamente all’altezza dei miei occhi. Man mano che l’amnios veniva espulso, i contorni del feto nell’Incubatrice si facevano più nitidi. «Lo vedi?» mi disse papà, chinando la testa per portarla di fianco alla mia, e mettendomi le mani sui fianchi. Parlava piano, e potevo sentire l’emozione nella sua voce mentre vedeva nascere il suo secondogenito. «Adesso lo tiriamo fuori.» Detto questo, schiacciò un altro pulsante sulla console dell’Incubatrice. A quel comando il fondo della vasca si aprì, e un braccio meccanico accompagnò delicatamente il corpicino verso il basso. Il piccolo sparì alla vista per alcuni secondi, poi emerse da un’apertura laterale, adagiato su un cuscino gelatinoso. Mio padre si avvicinò, e con mani tremanti raccolse il neonato. Lo sollevò piano verso di sé, fino ad accertarsi che stesse respirando regolarmente, poi lo abbassò di nuovo perché anch’io potessi vederlo. «Ecco qui, Marlo» dichiarò infine. «Saluta tuo fratello Narlo.» Rimasi immobile per molti secondi, scorrendo lo sguardo sui lineamenti arrotondati di quella minuscola creatura. Provai a immaginarlo crescere, farsi grande come me, e poi anche di più, e diventare amici, più che amici: fratelli. Lui, ne ero convinto fin da quel primo momento, sarebbe stato la persona a me più vicina per il resto delle nostre vite. Ancora non sapevo che il Dottipardo aveva altri piani, per noi. Insieme al piccolo, l’Incubatrice aveva espulso – dal lato opposto – una copia del Libro. Mio padre la prelevò e la infilò nella borsa: Narlo l’avrebbe ricevuta a tempo debito. 54 Io stesso non avevo ancora avuto la mia. Quando uscimmo dalla Sala di Incubazione, mio padre con Narlo tra le braccia e io che gli camminavo davanti pieno di entusiasmo, incrociammo Marko e suo padre Harko, i nostri vicini. Marko aveva la mia età, e suo padre la stessa del mio: anche a loro spettava prelevare il nuovo fratellino. Gli adulti si salutarono, e Harko si sciolse in un ampio sorriso scorgendo il neonato. «Adesso andiamo a prendere un fratellino anche per te» disse Harko incoraggiando suo figlio. «Andiamo a conoscere Narko.» I due proseguirono per la Sala di Incubazione, noi per la strada di casa. Mio padre preparò la stanza per il piccolo, mentre io lo seguivo eccitato, determinato a non perdere di vista per un solo secondo il piccolo Narlo. Rientrati dal lavoro, i miei zii vennero a conoscere il neonato, anche loro entusiasti per il suo arrivo. La cena di quella sera fu una grande festa. Più tardi, prima di andare a dormire, mio padre mi diede il Libro, e io scoprii il mio Codice. Mentre Narlo cresceva, io iniziavo a conoscere il mondo che il Dottipardo aveva creato per noi. Imparai a leggere esercitandomi sul Libro, e le nozioni in esso contenute divenivano presto parte di me. Mio padre mi seguiva con soddisfazione, lieto che apprendessi così in fretta quanto c’era da sapere. «Quando avrai trent’anni» mi ripeteva spesso, «toccherà anche a te entrare nella Sala di Incubazione usando il tuo Codice. Diventerai padre, e allora tutto quello che hai imparato dal Libro ti servirà per crescere la tua famiglia.» Durante il giorno, quando papà era al lavoro all’Impianto di Riciclaggio, ero io a occuparmi di Narlo, come il Dottipardo raccomandava nel Libro. Mio fratello era vispo e acuto. Era sempre rimasto affascinato nel vedermi scorrere il Libro, e quasi per gioco avevo iniziato a dargli semplici lezioni. Lo lasciavo esercitarsi con 55 la mia copia, anche se non avrei dovuto, perché il Codice riportato su di essa era strettamente personale e nessuno doveva conoscerlo tranne me. Narlo si dimostrò un eccellente allievo, perché quando nacque Oarlo sapeva già leggere. Quel giorno, quando insieme a nostro padre tornammo nella Sala di Incubazione, lo vidi piuttosto turbato. Non sembrava condividere la gioia mia e di papà. Era come se l’intero procedimento di generazione lo spaventasse. «Anche tu sei nato qui» gli bisbigliai in un orecchio, in tono leggermente maligno. Gli volevo bene, certo, ma ero pur sempre un ragazzino, e ogni tanto mi piaceva scherzare con il mio fratellino. Ma lui non reagì come pensavo. «Anche tu?» domandò assorto. «Sì. Anche papà.» «Perché?» La risposta mi uscì da sola dalle labbra: «Perché così vuole il Dottipardo.» «Basta ragazzi» brontolò allora papà, interrompendo il nostro chiacchiericcio. «Silenzio, Oarlo sta arrivando.» Quando, al nostro rientro in casa, mio padre consegnò anche a Narlo la sua copia del Libro, contrassegnata con il suo Codice, lui non si mostrò sorpreso: in realtà aveva già letto molto del mio. Chiese invece: «Il mio prossimo fratellino si chiamerà Parlo?» Papà corrucciò la fronte. Mi rivolse uno sguardo severo, sospettando che io avessi riferito a Narlo quello che avevo letto nel capitolo sulla Nomenclatura. Ma non era così: evidentemente lo aveva capito da solo. «Sì, è così» ammise. «Non mi piace il mio nome. Posso cambiarlo?» «No, nessuno può cambiare il suo nome.» «Perché no?» «Leggi il Libro. Capirai.» «È tutto qui?» si impuntò lui, agitando il volume. «Sì. Tutto quello che il Dottipardo ha da insegnarci è scritto lì» lo rassicurò nostro padre. «Anche Marlo può dirtelo.» 56 Io annuii, ma senza troppa convinzione. Qualcosa in quel dialogo tra un bambino di sei anni e il suo genitore mi stava turbando. «E se nel Libro non trovo la risposta?» L’espressione di papà, fino a quel momento indulgente, mutò in una smorfia gelida. «Il Dottipardo ha tutte le risposte» tagliò corto. Poi si allontanò, e tornò verso la camera in cui aveva portato Oarlo. Narlo si girò verso di me, cercando il supporto che non aveva ricevuto. Ma io abbassai gli occhi sul pavimento, e qualche secondo dopo lo sentii dirigersi verso la sua stanza, lasciandosi dietro una scia di singhiozzi sommessi. Parlo aveva quattro anni, quando io e Narlo litigammo seriamente per la prima volta. Ormai ero abbastanza grande per lavorare, e come papà avevo preso posto all’Impianto di Riciclaggio, sostituendo Earlo che era stato dismesso il giorno del mio diciottesimo compleanno. Il lavoro non mi piaceva. Era ripetitivo e pesante, e ogni sera tornavo a casa sporco e stanco. Avrei preferito occuparmi degli animali nell’Allevamento, come Marto, o anche dell’Armeria, dove lavorava Margo, che vista da fuori appariva molto più interessante. Ma il Dottipardo ci aveva assegnato il compito del Riciclaggio, per cui accettavo la mia posizione senza protestare. Quel giorno tornai a casa parecchio demoralizzato. Lo stress aveva offuscato il mio senso della prospettiva, e credevo di odiare quella vita monotona e incasellata. L’idea che tutto questo fosse stato preparato per noi dal Dottipardo, in quel momento, non mi era di conforto. «Brutta giornata?» mi apostrofò Narlo notando la mia smorfia, con lo stesso tono canzonatorio che spesso io avevo utilizzato con lui quando era piccolo. Risposi con un grugnito. Lui, a sedici anni, ne aveva davanti ancora due di studi, prima di dover iniziare a lavorare all’Impianto. Ricordavo come alla sua età fossi eccitato alla 57 prospettiva di entrare a far parte della comunità in tutti i sensi, ma adesso che ci ero dentro la pensavo diversamente. «Sai, oggi ho letto il Libro» iniziò, senza che lo invitassi a parlare. Ero intenzionato a filare dritto verso la mia stanza, ma quell’osservazione apparentemente casuale mi colpì. Già altre volte Narlo si era soffermato a parlarmi di quello che leggeva nel Libro, e di quello che credeva di capire. Di solito ero costretto ad assecondarlo, per far terminare la discussione. Ma stavolta ero deciso a non dargliela vinta. «Ah sì? E che cosa hai trovato?» «Niente di nuovo... ma ho riflettuto sulla Nomenclatura.» «E allora?» «Allora... ti sei mai fermato a pensare a quanti nomi possono esistere così composti?» «Che cosa intendi? Si tratta di tutti i nomi possibili.» «Esatto, e sono seicentosettantasei. Ventisei per ventisei, il numero di lettere permutabili in ogni nome, una per indicare la famiglia e una per la generazione. E quanti siamo noi?» «Seicentosettantasei» risposi di getto. Era stabilito in uno dei primi capitoli del Libro, quello sulla Popolazione Sostenibile. Narlo mi fissò intensamente: «Ti pare un caso?» «No che non lo è! Questa è la popolazione del Complesso. Quando uno di noi viene dismesso, un altro prende il suo posto. A ogni nascita corrisponde la dismissione di un individuo della stessa famiglia di dieci generazioni superiore. Hai visto i Crematori. È tutto scritto nel Libro.» «Sì infatti. Ma perché non ci sono altri nomi? Altre persone?» «Stai dicendo un’assurdità.» «Perché?» «Perché il Libro dice chiaramente che questa è la Popolazione, e questa la Nomenclatura. Il Dottipardo...» «Ecco, sapevo che lo avresti nominato!» «Certo!» mi infervorai. «Tutto questo lo abbiamo avuto da lui! Lui ha creato noi e il Complesso, e ci ha lasciato le 58 istruzioni per preservarlo.» «Preservarlo da cosa? In previsione di cosa?» Non si rendeva conto di vaneggiare. «Narlo, ti stai ascoltando?» «No, tu non stai ascoltando me!» Mi si fece incontro, e mi guardò con astio. Domandò: «Che cosa facciamo qui? Nasciamo, viviamo sessant’anni, con un genitore e i nostri fratelli, e poi veniamo dismessi. E che cosa realizziamo in tutto questo tempo?» «La nostra vita, la nostra presenza, il nostro lavoro come il Dottipardo ha voluto che fosse.» «Il Dottipardo! Che cos’è il Dottipardo, Marlo?» Questo era troppo. «Non ho intenzione di proseguire questa conversazione» troncai netto, e mi avviai di nuovo verso la mia camera, come avevo avuto intenzione di fare fin dall’inizio. Narlo mi prese il braccio e mi trattenne. «Leggi il Libro» sibilò. «Leggilo tutto. Dall’inizio.» Poi mi lasciò andare, e uscì di casa a testa bassa. Non volevo dargliela vinta, non di nuovo. Ma c’era un sottinteso in quel suo ultimo suggerimento, quasi una sfida. Dopo essermi lavato e spogliato, mi misi a letto. Prima di addormentarmi, però, presi il Libro. Quella era l’eredità lasciataci dal Dottipardo, la somma di tutte le nozioni necessarie per portare avanti il Complesso. Non si trattava di frasi vuote e retoriche, ma di fatti, istruzioni, soluzioni. Tutto ciò che dovevamo sapere del mondo era lì dentro, a partire dal nostro Codice personale, fino alla generazione di nuovi individui nelle Incubatrici, dal modo di crescere le piante alimentari nelle Serre alle specifiche tecniche di tutti i macchinari che rendevano possibile la vita. Il Dottipardo aveva fatto in modo che noi sapessimo tutto questo, perché potessimo vivere i nostri sessant’anni e poter essere utili a tutti gli altri. Naturalmente lo avevo letto per intero. Ne conoscevo a memoria interi capitoli. Che cosa intendeva Narlo dicendomi di 59 leggerlo ? “Dall’inizio”, aveva specificato. Chiusi il Libro. Osservai la copertina di rigido cartone, consumata dagli anni. Quella copia era nata con me, nel momento in cui mi era stato assegnato il Codice. Lo riaprii. Lì, sulla prima pagina bianca, c’era proprio il mio Codice. Si leggeva: Manuale operativo – N. di serie 231432. Il mio primo figlio nacque il giorno successivo alla dismissione di papà. Ci aveva salutati tutti con un abbraccio, e si era diretto in silenzio verso il Crematorio. Lo avevo seguito con lo sguardo, vedendolo fare gruppo con i vicini della sua stessa generazione, tutti arrivati al sessantesimo anno. Andai a prelevare Rarlo da solo. La Sala di Incubazione si aprì alla digitazione del mio Codice. Presi il neonato e la copia del Libro che avrei in seguito consegnato a lui, quando fosse stato abbastanza grande. Fu emozionante diventare padre, eppure il fatto di non avere nessuno con cui condividere quell’esperienza mi faceva sentire tremendamente solo. Assistere alla nascita di Narlo insieme a papà, al confronto, mi era parso un momento molto più intenso. Rientrato in casa con il mio primogenito, trovai proprio Narlo ad aspettarmi sulla porta. Sulle prime non feci caso alla sua presenza, poi mi resi conto che non avrebbe dovuto essere lì. «Non sei all’Impianto?» chiesi stizzito. Da tempo i nostri rapporti erano piuttosto bruschi. «Volevo vedere Rarlo» si giustificò. «Dopotutto, sono suo zio. Ti avrei accompagnato alla Sala di Incubazione ma...» «Ma io non ti avrei fatto entrare» precisai. Una pausa, poi lui riprese: «È biondo» constatò osservando il piccolo. «Non come te.» «Perché dovrebbe essere come me? Sai come funziona l’Incubazione: i geni...» «Vengono rimescolati ogni volta, certo. Ma non sarebbe bello se un figlio assomigliasse al proprio genitore?» Non seppi rispondere. Era un’ipotesi priva di senso. 60 «Sei mai stato agli Allevamenti?» insisté. «Là, i cuccioli partoriti dagli animali spesso hanno lo stesso manto dei genitori. I due genitori. È molto suggestivo.» «Noi non siamo animali.» «No, certo. Eppure...» Lasciò la frase in sospeso, fissando il vuoto, perso in qualcuna delle sue assurde riflessioni. Mi aspettavo che continuasse a parlare, ma non disse altro, perciò proseguii verso la futura stanza di Rarlo, per metterlo a dormire. Stavo sistemando la coperta sul corpicino tiepido quando Narlo riapparve alle mie spalle, fermo sull’uscio. «Io non sarò mai padre» mormorò. «Questa è una cosa che tocca solo ai primogeniti, come te.» «Sì, è così.» Era l’unica risposta alla sua ovvia affermazione. «Mi piacerebbe diventarlo, un giorno.» «Non puoi.» «No, non qui, lo so. Ma mi domando se ci sia un altro modo.» Mi girai a guardarlo, esasperato. «Un altro modo?» «Sì. Un modo diverso per nascere, per vivere. E per morire.» «Stai di nuovo farneticando, Narlo.» Si avvicinò, portando il suo viso a pochi centimetri dal mio. Era più basso di me, ma riusciva comunque a imporre la sua presenza. Parlò piano, per non disturbare il sonno del piccolo. «No, ascoltami. Quello che noi facciamo qui è seguire una serie di istruzioni, che qualcuno ci ha lasciato affinché portassimo avanti le cose in questo modo.» «Il Dottipardo.» «Sì, ammettiamo che fosse lui. Ci ha detto come guidare la nostra comunità, come conservare il nostro stile di vita, in modo che potessimo proseguire così a tempo indeterminato. Anche per tutta l’eternità.» «Proprio questo era il suo scopo.» «Già, ma perché? Non vedi le bestie che vivono fuori dal villaggio? Anche loro nascono, vivono, crescono, muoiono. 61 Ma non hanno bisogno di Incubatrici, Crematori, e tutto il resto. Perché noi dobbiamo vivere così, invece? Perché il Dottipardo ha voluto rinchiuderci in questo sistema?» «Nessuno ci ha rinchiusi. Siamo liberi.» «Liberi di vivere sessant’anni, compiendo un lavoro già stabilito, all’interno di strutture già esistenti.» Non ero in grado di controbattere. «Marlo…» continuò lui, enfatico. «Chi è il Dottipardo?» «Il Dottipardo non è una persona» lo corressi. «Davvero?» Fece aleggiare quella domanda nell’aria per alcuni secondi, poi spiegò: «Conosci la famiglia che lavora alla Tipografia?» «Certo. Sono loro che stampano i Libri che poi vengono assegnati a ogni neonato.» «Bene. Come si chiama il loro figlio della generazione di Parlo?» «Pardo» risposi senza pensare. Stavo per aggiungere che non capivo dove volesse arrivare, ma poi il suono delle mie stesse parole mi colpì. Pardo . Come in Dottipardo . «Lo vedi, adesso? Dottipardo, Dotti-Pardo.» «Non... non capisco...» balbettai. Ma non era del tutto vero. Iniziavo a capire, ed era questo a farmi balbettare. «Non so chi fosse questo Pardo. E non so cosa “dotti” significhi, forse era un titolo, una professione, una designazione di qualche genere. Qualcosa che noi abbiamo perso. Ma questo Pardo era un tipografo, e la sua famiglia continua a esserlo. Il tipografo che ha stampato i primi Libri. I primi Manuali operativi. Tutte le istruzioni per far funzionare il Complesso, in modo del tutto indipendente e per un tempo indefinito. Il Dottipardo la cui memoria distorta è arrivata fino a oggi, era uno di noi.» Avrei dovuto farlo tacere. Avrei dovuto cacciarlo. Se non lo feci, forse non è solo perché ero sconvolto dalle sue parole. Forse era perché mi parevano credibili. 62 «Quanto tempo può essere passato, da allora? Pensaci. Una generazione ogni sei anni. Quanti Pardo sono già vissuti? Non abbiamo modo di saperlo. Forse solo basando il calcolo sui nostri Codici, ammesso che siano numeri progressivi. Ma in fondo non è importante quanto tempo fa abbia vissuto Dotti-Pardo. Quello che conta è capire perché ha scritto il Manuale.» «Il Libro» aggiunsi ottusamente. «Sì, il Libro. Siamo arrivati a considerarlo il fondamento della nostra vita, e in effetti è così... ma solo nei limiti di quello che possiamo fare. Non di quello che dobbiamo realizzare. Il Libro non contiene ordini, solo istruzioni. Possiamo fare molto di più, essere di più.» «Ma allora, perché...» cercai di raccogliere i pezzi di quanto mi stava rivelando. «La nostra è una comunità chiusa, autonoma. Ma in passato forse non era così. C’è tanto spazio, fuori dal Complesso. Doveva esserci altro, al di là di esso, un tempo. Poi è successo qualcosa. Qualcosa di sconvolgente, di distruttivo. Chi può saperlo? Gli uomini dell’epoca del Dottipardo hanno pensato che l’unico modo per sopravvivere fosse costruire questo sistema perfetto e indipendente. Hanno progettato e realizzato le macchine, e lasciato le istruzioni per chi ci avrebbe vissuto. Probabilmente doveva essere una cosa temporanea, ma poi è proseguita per inerzia. Forse chi doveva tornare ad avvisarci non lo ha mai fatto, o forse siamo l’avamposto in un mondo disabitato. Sono trascorsi secoli, millenni... e noi siamo sempre qui, a seguire il Dottipardo. E forse, nel frattempo, il mondo là fuori è finito, e noi siamo tutto ciò che rimane.» «Il mondo non è finito» ribattei. «Mio figlio è nato oggi.» Lo sguardo di Narlo si illuminò. Sorrise. «Esatto. Qualunque fosse il piano del Dottipardo, ha funzionato. Perché noi siamo vivi. Il mondo non è finito, non finirà. Ma dobbiamo avere il coraggio di scoprirlo di nuovo.» «Questo è il nostro mondo» gli feci notare. «Non possiamo 63 vivere fuori del Complesso.» «Nessuno ha mai provato.» «Nessuno potrebbe sopravvivere, fuori. Senza cibo, senza lavoro, senza compagnia. Non arriverebbe mai alla sua dismissione.» «E invece potrebbe arrivare anche oltre.» «Oltre cosa?» «Hai mai pensato che potremmo vivere oltre i sessanta anni?» Scossi la testa, sconsolato. «No, mi dispiace. Ti stai sbagliando. Sessanta anni, dieci generazioni. Questo è il nostro tempo. Nostro padre è stato dismesso ieri, te lo sei dimenticato?» «Avrebbe potuto evitarlo.» Quell’affermazione irrispettosa mi fece infuriare. «E cosa avrebbe dovuto fare? Rimanere qui con noi, mentre io andavo a prendere Rarlo? Alterare la Popolazione Sostenibile? Sei pazzo, Narlo!» Il bambino sussultò nella culla, disturbato dalla mia voce. Lo accarezzai dolcemente, cercando di tranquillizzarlo. «No, non è così» si oppose Narlo. Mosse un passo all’indietro, tornando verso l’ingresso della stanza. «E te lo dimostrerò.» Uscì dalla camera. Io rimasi lì, a guardare Rarlo che russava piano nel suo lettino, fino alla sera, quando i miei fratelli minori tornarono a casa. Gli presentai il loro nipotino. Le cena fu una festa. Ma Narlo non partecipò. Non si fece vivo nemmeno il giorno dopo. Non lo rividi più. Arrivati a questo punto, potreste chiedervi perché vi ho raccontato tutto questo. Se dopo quel giorno Narlo è scomparso, che impatto possono mai aver avuto le sue idee, posto che fossero credibili? Forse allora non avete notato un particolare. Non mi avete guardato bene. Fatelo adesso, non sentitevi in imbarazzo. 64 Non temete di offendere la mia vecchiaia, sosterrò il vostro sguardo. Ecco, ora che lo vedete, il mio vi sembra il volto di un sessantenne? Seguite il profilo delle grinze che mi increspano il viso, notate la pelle cascante delle guance e della gola, le macchie brune sulle mani. Non avete mai visto una persona ridotta così, vero? Perché io ho ottantaquattro anni. L’ultimo capitolo del mio racconto si svolge nel giorno in cui avrei dovuto essere dismesso. Ascoltate. Quella mattina mi svegliai di buonora, ma i miei figli e i miei fratelli erano svegli prima di me. Facemmo colazione insieme, poi iniziai a salutarli, uno per uno. Per ultimo lasciai Rarlo, il mio primogenito. «Domani sarai padre» gli ricordai. «Spero che saprai essere migliore di me.» «Non scherzare, papà» ribatté lui, commosso. «Siamo orgogliosi di te. Tutti quanti.» «E io lo sono di voi» ricambiai. Ci abbracciammo per l’ultima volta, poi uscii. Com’era costume, nessuno mi accompagnò oltre l’uscio di casa. Feci gruppo con gli altri della mia generazione, i sessantenni che sarebbero stati dismessi quel giorno: Marko, Marmo, Marto... tutte le persone con cui mi ero accompagnato nella vita. Saremmo stati insieme anche in quell’ultimo viaggio. Arrivati al Crematorio, iniziammo a entrare, uno per volta. Ognuno di noi inseriva il proprio codice nel pannello dell’ingresso, le porte si aprivano per accoglierlo e si chiudevano dietro di lui. La console si illuminava di rosso per qualche minuto, poi tornava attiva. Il successivo poteva allora inserire il proprio Codice, e la fila procedeva. Quando giunse il mio turno, digitai le sei cifre. Alzai gli occhi sull’ingresso, aspettando di vederlo aprirsi. Ma non si mosse. Tornai a guardare il pannello. Lo schermo segnalava 65 un avviso: codice non valido. Avevo digitato male? Ripetei l’operazione. Codice non valido . Il responso fu lo stesso per altre quattro volte. Ma ero sicuro di non aver sbagliato. Per qualche ragione, il mio Codice non permetteva l’accesso al Crematorio. Non potevo essere dismesso. Com’era possibile? Come per le Incubatrici, il sistema era progettato per accogliere solo i Codici previsti al momento giusto. Nessun altro avrebbe funzionato, in nessun altro momento, e... Per una sola volta. Ogni Codice poteva aprire il Crematorio solo una volta. Poi perdeva tutte le sue autorizzazioni, perché l’individuo corrispondente era stato dismesso. Non esisteva più, e il suo Codice moriva con lui. Ricordai allora Narlo, da piccolo, che giocava con il mio Libro. Una cosa che non avrei dovuto concedergli, ma chi poteva sospettare che la sua mente straordinaria sarebbe riuscita a ricordare il mio Codice da allora? E chi poteva immaginare che lo avrebbe usato, quel giorno, al posto mio? Quella era l’unica soluzione possibile. Narlo, che non vedevo da trent’anni, era sopravvissuto fuori dal Complesso. Poi era tornato un’ultima volta. E si era dismesso, con sei anni di anticipo. Con quella sua mossa, con il suo sacrificio, mi impediva di morire. E anche stavolta, anche in quella che era l’ultima sfida che mi aveva lanciato, tanto tempo prima, aveva vinto lui. È per questo che io sono ancora qui, decenni dopo che il mio tempo è compiuto. Non posso raccontarvi cosa ha fatto mio fratello nei trent’anni in cui è stato lontano dal Complesso, perché non lo so. Vi ho riferito la sua storia, ma sono necessariamente limitato a 66 quanto egli stesso mi ha concesso di sapere. Chissà quali altre rivelazioni ha avuto, nel corso del tempo. Non possiamo immaginarlo, ma la strada che Narlo ci ha indicato forse può condurci a quelle stesse scoperte. E anche più in là, senza i limiti da cui ci siamo fatti condizionare finora. Io sono la dimostrazione che la vita non è necessariamente quella che il Libro ci impone. Il Manuale operativo che il Dottipardo, il remoto tipografo che ha redatto la prima copia, ci ha tramandato, non è la nostra legge. È solo un ricettario di sopravvivenza, ma noi possiamo spingerci oltre. Guardatevi intorno. Guardate i vostri compagni. Guardate voi stessi. Non lo vedete? Il mondo non è finito. E non finirà. 67 Indice Spore Il giorno più importante Natura morta Il Dottipardo Cattivi genitori Il guardiano del faro Stelle cadenti Sinestesia La staffetta 3 19 39 53 69 81 87 99 111 © 2013 I sognatori, Lecce ISBN 978-88-95068-29-9 Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione totale o parziale senza previa autorizzazione dell'editore. Per contattare la casa editrice I sognatori, consultare il sito internet: www.casadeisognatori.com Copertina di Francesca Santamaria finito di stampare nel mese di novembre 2013 presso Digital Print srl Segrate (MI)
Scarica