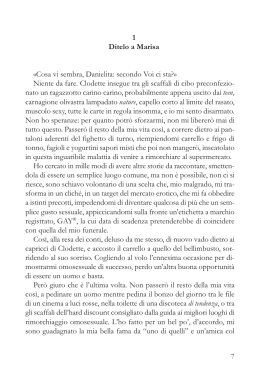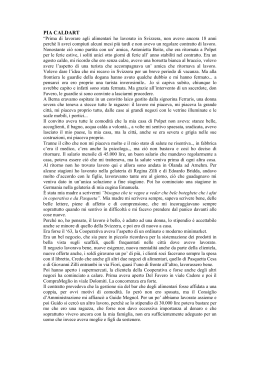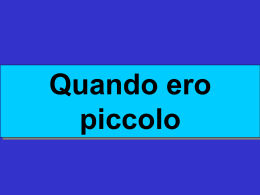Un giorno di ordinaria illegalità By Andrea Lombardi Copyright 2014 Andrea Lombardi ***** Smashwords Edition Cover design by Andrea Lombardi Questo ebook è concesso esclusivamente per il vostro uso personale. Questo ebook non può essere rivenduto o ceduto ad altre persone. Se desiderate condividere questo ebook con un'altra persona, potete acquistarne una copia aggiuntiva per ogni destinatario. Se state leggendo questo ebook e non lo avete acquistato, o se lo stesso non è stato acquistato esclusivamente per il vostro utilizzo, vi invito a tornare su Smashwords.com o a visitare il sito del vostro rivenditore di fiducia per acquistare la vostra copia. Grazie per il sostegno. ***** Indice L’irrinunciabile onestà e il fascino del proibito Il derby, i tre carabinieri e la parata del due giugno Il vecchio trucco dello specchietto Il gancio sinistro di Carbini e il buon senso dell’ispettore Furto d'auto con scasso e commozione cerebrale Vantaggi e inconvenienti di una condotta criminale Il commissario Marozza e il rendimento del risciò L’ombra del dubbio e dell’infanzia che fu Il controllore ha sempre ragione Atroce dilemma in una latteria di borgata Aperitivo con i tre carabinieri Note sull’Autore “Esattamente, signora, ha capito benissimo. Ma no, non mi deve ringraziare, sono più che sicuro che al posto mio lei avrebbe fatto la stessa cosa”. Il silenzio vagamente imbarazzato all’altro capo del telefono mi suggerì che no, probabilmente la signora Vertecchi, di cui fino a qualche ora prima ignoravo l’esistenza e che non avevo mai sentito né visto di persona, al posto mio non avrebbe chiamato per restituirmi il portafoglio, né tantomeno i trentasei euro eventualmente trovati al suo interno. “Trentasei, esatto,” dissi con aria fiera di fronte alla perplessità della signora. “Strano, ero sicura di essere uscita con non più di quindici euro in tasca”. “Beh, quindici, trentasei, la cosa strana è che ci siano ancora tutti,” le dissi sempre più consapevole della bella figura che stavo facendo. “Per caso ha trovato anche il coupon per una cena per due dal Re della Porchetta?”. “Ovviamente, signora,” risposi tra i denti perdendo in un attimo il sorriso e la speranza che si fosse scordata anche di quello. La signora Vertecchi tirò un sospiro di sollievo, e finalmente m’indicò il suo indirizzo per la consegna del borsellino e per offrirmi un tè caldo e tramezzini fatti in casa. Ah, i vantaggi dell’onestà! La sensazione piacevole e rassicurante di essere in pace con il prossimo e soprattutto con se stessi. E poi i tramezzini fatti in casa, non so se mi spiego. A giudicare dalla voce la signora doveva avere più o meno settant’anni, così come il marito che tossiva in sottofondo bestemmiando contro qualcuno o qualcosa in tono decisamente meno amichevole del suo. Proposi di inviarle il borsellino tramite posta assicurata e di rimandare i tramezzini ad altra occasione, che sicuramente non sarebbe mancata se avesse avuto nuovamente l’accortezza di smarrire qualcosa dalle parti di casa mia. Ci salutammo cordialmente e attaccai il telefono sotto un effluvio di ringraziamenti, mentre guardavo riflessa nella finestra del salotto la faccia serena di un uomo felice e fiero di sé. Era una sensazione di cui da sempre mi beavo, onesto fino al midollo per indole, educazione ed ossequioso rispetto del quieto vivere, e mai mi sarei aspettato, in quel momento, che tutto sarebbe cambiato di lì a poco, e che la pace che avevo nel cuore e la mia condotta mite sarebbero state presto soltanto un ricordo. Prima o poi per tutti, infatti, arriva il giorno in cui il fascino indiscreto del proibito bussa alla porta, ti guarda negli occhi e ti chiede se per caso non ti andrebbe di uscire ad ubriacarti e di mandare all’aria quel poco che hai combinato negli ultimi quindici anni. Per alcuni quel giorno è l’inizio di una vita dissoluta e scriteriata, condotta pericolosamente e a discapito della società. Per altri, ringraziando il cielo i più, è solo un tuffo nel brivido del mondo dei più furbi, una sbirciata al di là del muro, dietro la lavagna dei cattivi, lungo le strade losche e oscure di chi rinuncia alla pace interiore e con il prossimo in cambio di una vita costantemente sul filo del rasoio. Un biglietto in ultima fila per un horror di qualità, inquietante e divertente al tempo stesso, e con l’uscita a meno di due ore e cinque metri più in là. Quel giorno, inevitabilmente quanto inaspettatamente, arrivò infine anche per me. Dopo una vita più che onesta, all’insegna di una profonda e imprescindibile rettitudine morale, legale, sociale e contabile, senza aver mai rubato un centesimo e senza averci neanche mai pensato, non passando mai col rosso neanche alle due del pomeriggio di ferragosto e nemmeno in bicicletta, casco allacciato e luci accese anche di giorno, dopo aver sempre riconsegnato ai legittimi proprietari i portafogli caduti in terra, mettendoci anche dentro qualche soldo qualora fossero vuoti, come nel caso della signora Vertecchi, giusto per non alimentare sospetti, dopo una vita più che morigerata ed in linea con i codici penali di un buon novantotto percento del pianeta, mi ritrovai anch’io ad oltrepassare la sottile linea rossa che divide i buoni dai cattivi, una vita calma e a volte noiosa dal fremito del rischio e del senso di colpa che ti alita sul collo, e a provare quel brivido che ben conosce chi almeno una volta si è trovato a camminare sul lato selvaggio della strada. La revisione della mia Punto era scaduta ormai da due giorni, da quasi tre non avevo latte in frigo e da ormai più di sei ero stato colto da una voglia acuta e prolungata di ciambellone al cacao. Inizialmente avevo provato a placarla con dei saccottini alla marmellata riesumati dopo una spedizione archeologica nei meandri della credenza, quindi, dato fondo alla scorta di salatini e pacchi di pasta plurisecolari, ero passato al pan grattato e alla pasta d’acciughe, e a fissare con sguardo famelico un vecchio blocco di fogli protocollo. La situazione non avrebbe potuto che peggiorare, giacché lo scadere della revisione mi aveva di fatto tagliato fuori dal resto del mondo, e l’unico negozio a portata di piedi era il fioraio sotto casa. Scartata dopo lunga e sofferta riflessione l’ipotesi di nutrirmi di tulipani e rose gialle fino al ritorno dalle ferie del mio meccanico di fiducia, rincuorato dal fatto che fosse sabato e che il bar più vicino distasse meno di ottocento metri da casa, decisi di rischiare la fedina penale e il mio passato di persona per bene e di prendere le chiavi della Punto per dirigermi verso il peccato e l’illegalità. Erano le nove e quarantatré quando m’infilai in macchina diretto verso il bar ed un litro di latte per il mio ciambellone. Alle nove e quarantaquattro la paletta di un carabiniere fermò la mia fuga dal mondo degli onesti facendomi cenno di accostare con una certa veemenza. Si trattava, come ebbi presto modo di scoprire, di una pattuglia di tre appuntati di Cosenza diretti allo Stadio Olimpico per il derby Roma - Lazio, e che si erano persi all’incirca due ore prima dalle parti del Vaticano. Come fossero giunti fino a casa mia rimase un mistero sia per loro che per me, fatto sta che dopo averli ragguagliati sulla strada per lo stadio, già che c’erano mi chiesero patente e libretto per giustificare il ritardo con colleghi e superiori. In tutta la mia vita ero stato fermato solo un’altra volta, e, a compensare l’intangibilità di una condotta su strada peraltro impeccabile, mi sembrò più che giusto che la seconda volta dovesse essere proprio in concomitanza con la revisione scaduta. Tanto ero convinto della giustezza dell’accaduto che non azzardai la benché minima difesa, né provai ad impietosire quei tutori della legge così ligi al dovere fingendo una dimenticanza del meccanico o un raptus di diarrea alla stesura del verbale. Ringraziai anzi i carabinieri per l’impeccabile svolgimento delle loro funzioni, spiegai un’ultima volta il tragitto più breve per la tangenziale e mi rimisi in marcia con il permesso provvisorio che mi avevano gentilmente rilasciato. Neanche il tempo di inserire la terza e un’altra paletta sbucò da una volante della stradale seminascosta da una panchina. “Buongiorno a lei, agente,” dissi sorridendo con il permesso di circolazione già fuori dal finestrino, “per una bizzarra coincidenza sono stato appena—” “Scenda dall’auto, grazie,” rispose il poliziotto con una mano sugli occhiali a specchio e l’altra sulla fondina. “Subito, per carità,” dissi obbedendo e continuando a sventolare il mio permesso. “Come le dicevo, sono stato fermato appena venti metri fa—” “Lei ha un faro rotto, lo sa?” disse l’agente con un’occhiata severa, almeno credo, facendomi notare solo allora come stessi circolando con i fari accesi, o comunque almeno uno. “Mai prestare la macchina a Marina”, dissi tra me e me con un filo di voce. “Chi è Marina?” chiese l’agente con aria sospettosa. Alla faccia del filo di voce, pensai, e il riflesso degli occhiali a specchio mi fece pensare che il poliziotto doveva aver sentito anche quello. “Marina è la mia coinquilina,” gli dissi mentre già meditavo atroce vendetta verso chi, oltre ad avermi messo nei guai, in quel momento se la spassava al mare con la mia bicicletta. “È anche la proprietaria dell’auto?” chiese l’agente guardando schifato la carrozzeria sporca della Punto. “No, l’auto è mia, e anche casa”. Un’altra occhiataccia degli occhiali a specchio, sia a me che alla Punto. “Lo dicevo per completezza d’informazione, non per altro.” “Patente e libretto, grazie.” Non so se per l’improvvisa realizzazione che due contravvenzioni nell’arco di meno trenta metri avevano probabilmente pareggiato il conto con quasi vent'anni d’indifferenza delle forze dell’ordine nei miei confronti, o forse solo per la pia illusione che dietro quella divisa e quei due vetri argentati si nascondesse in realtà un animo candido e disposto verso il prossimo, fatto sta che in un istante decisi di fare quello che qualsiasi altro onesto cittadino avrebbe fatto al posto mio, qualcosa che fino a un paio d’ore prima sarebbe stato per me pura fantascienza. “Non per ostacolarla, agente, ma credo mi stia per venire un attacco di diarrea particolarmente violenta,” dissi con una smorfia quasi commovente. “Facciamo in fretta, non si preoccupi,” mi disse prima di allontanarsi per nove minuti abbondanti, durante i quali sarei probabilmente morto se fossi stato davvero in preda a un raptus di dissenteria acuta, e di tornare con i miei documenti, un altro permesso di circolazione e i suoi migliori auguri per una giornata che era iniziata a dir poco col piede sbagliato. Probabilmente quel giorno doveva esserci qualcosa di davvero sbagliato nei miei piedi, dato che nei duecentocinquanta metri successivi venni fermato, nell’ordine, da Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Guardia Forestale, una guardia giurata a fine turno, la squadra buoncostume al gran completo e un paio di suore in cerca di fondi per la nuova ala di un asilo. Non seguivo molto il calcio, ma cominciai a pensare che il derby di quel giorno dovesse essere davvero quel che si dice una partita a rischio, e, vista l’intensità dei controlli a più di dieci chilometri dallo stadio, potei solo immaginare come se la stessero passando i poveretti che avevano la sfortuna di abitare dalle parti dell’Olimpico. Dopo una raffica di multe per irregolarità più o meno gravi relative a più o meno tutti i componenti della Punto ad eccezione dei tappetini posteriori, e un paio di ammonimenti per le disastrose condizioni igieniche di quelli anteriori, con un rapido calcolo mi resi conto di come la mia voglia di ciambellone mi fosse già costata più di seicento euro e ottantasei ore di scuola guida obbligatoria. Pazienza, mi dissi, e nel dirlo sembrava quasi che ne fossi convinto davvero, ormai era inutile rimuginare su una scelta ovviamente sbagliata e su una mattinata disastrosa che, per mia fortuna e per i venticinque metri scarsi che mi separavano ormai dal bar, non avrebbe potuto che migliorare. Ovviamente quella non era la mia giornata, e mentre mi apprestavo a parcheggiare dopo essermi assicurato che non ci fossero palette alzate nel raggio di almeno cento metri, sentii una voce da dietro l’auto rivolgersi a qualcuno in tono non proprio amichevole. Un secondo più tardi intuii che la voce forse ce l’aveva con me, ricevendo l’incontrovertibile conferma sotto forma di due botte secche sul tettino e un urlo selvaggio che quasi spaccò tutti i finestrini. “Mi scusi, per caso ce l’ha con me?” chiesi non senza agitazione e dando un’altra occhiata in giro in cerca di almeno una delle mille volanti scomparse di colpo. “Certo che ce l’ho con te, in quanti siede su quel bidone?” rispose con voce roca e consumata dalla rabbia quello che mi apparve infine come un vecchietto malaticcio e decisamente alterato. “Ma perché si agita? Cosa vuole da me, mi scusi?” feci scendendo mentre il nonnetto zoppicava intorno alla macchina sbiascicando le sue ragioni. Ragioni che, a quanto sembrava, consistevano in una richiesta di cinquanta euro almeno per il danneggiamento dello specchietto della sua auto, di cui quell’anziano signore che continuava ad inveire indicando una vecchia Volvo sosteneva che io mi fossi reso colpevole durante la mia manovra di cauto avvicinamento al marciapiede. Riconobbi subito, per mia fortuna, una vecchia truffa di origini gitane, messa in atto dai malfattori della capitale per lucrare su specchietti graffiati ad arte ben prima dell’incontro con il malcapitato di turno. Anche se nell’aspetto e nell’atteggiamento di quel vecchietto non c’era, in tutta sincerità, nulla di gitano né di particolarmente truffaldino, mi rifiutai per principio anche solo di ascoltarlo, ridendogli anzi in faccia con la spavalderia di chi dopo nove multe in meno di mezzora si sente giustamente pronto a vivere la strada e i suoi conflitti più crudi. L’animo di quel signore si scaldò ulteriormente e così il suo linguaggio colorito, e pur non volendogli mancare di rispetto fui costretto a dirgli che se non se ne fosse andato subito la situazione sarebbe potuta degenerare, anche perché avevo fame, e quando avevo fame tendevo ad essere poco lucido. “Degenera? E degenera come?” fece il nonnetto piazzandomisi di fronte, costringendomi mio malgrado a poggiargli una mano sul petto per evitare che mi cascasse addosso. Feci appena in tempo a notare, ahimè con colpevole ritardo, che il mio specchietto di destra era effettivamente a penzoloni, prima che da dietro il vecchietto partisse qualcosa di fulmineo e pesantissimo, qualcosa che mi colpì in pieno volto spedendomi a terra come un sacchetto di calcinacci. Mi risvegliai in uno stanzone al secondo piano di un commissariato di cui fino a quel giorno avevo ignorato l’esistenza. Avevo il naso gonfio, tutti e due gli occhi neri e la mascella probabilmente dislocata, nonostante la quale riuscii comunque a rispondere all’ispettore di turno, tale Moschella, che continuava a chiedermi perché mai avessi aggredito quel povero vecchietto. “Il vecchietto?” dissi ancora confuso e indolenzito. Dovetti sforzarmi per qualche istante per capire a cosa si riferisse, forse a causa di una commozione cerebrale a cui accennarono gli agenti che per miracolo erano riusciti a sottrarmi al pestaggio di quello che rispondeva al nome di Antonio Carbini, classe ’36, da dietro il quale non era partito niente, ma che semplicemente mi aveva rifilato un gancio devastante con tutta la forza e la tecnica di ex-campione di pugilato qual’era. Vice-campione Europeo, per l’esattezza, pesi superwelter, anno 1964, e che adesso mi sedeva di fronte con in faccia solo i segni del gelato che gli aveva offerto l’ispettore Moschella, grande appassionato di boxe, in attesa che io riprendessi i sensi. “Questo signore è un monumento alla nobile arte, lo sa?” fece l’ispettore prima di spiegarmi come l’ultimo match della carriera di Carbini, che oltre al titolo gli era costato la milza, tre costole e mezzo e l’uso della gamba destra, fosse unanimemente considerato come uno dei più violenti nella storia del pugilato moderno. “Non ne dubito affatto,” dissi con aria sinceramente interessata, mentre la vista del gelato mi allargava il buco nello stomaco e continuando a ispezionarmi il volto per capire al tatto a quali danni fisici corrispondessero i dolori che avvertivo sempre più distintamente. Nonostante l’ammirazione indiscussa per quel bulldozer in pensione, obiettai all’ispettore che, secondo il mio modestissimo parere, ero stato io a subire l’aggressione e non a perpetrarla, a meno di non aver manifestato, dopo l’atterramento, i sintomi di un sonnambulismo particolarmente violento. Carbini continuò a gustarsi il suo cono alla nocciola mentre Moschella mi spiegava come il mio poggiargli una mano sul petto costituiva a tutti gli effetti, dal punto di vista legale e del buon senso, un chiaro atto ostile e l’inizio di un’aggressione fisica dalle conseguenze imprevedibili per l’offeso. “Ad ogni modo, non perdiamoci in cavilli e formalismi, suvvia” sorrise l’ispettore facendo l’occhietto prima a me e poi a Carbini. Scoprii presto che, nel complesso codice di parole d’ordine e ammiccamenti che garantiva la sopravvivenza nelle strade di borgata, quell’occhiolino era una spinta neanche tanto velata al raggiungimento di un accordo bonario tra onesti cittadini, che mi sarebbe costato appena il doppio di quanto chiesto inizialmente da Carbini, oltre a una cospicua mazzetta all’ispettore per archiviare una denuncia peraltro ancora non sporta. Accettai l’esborso di buon grado, ritenendo di pagare tutto sommato il giusto prezzo per poter finalmente entrare nel mondo dei grandi, e per imparare, come si suol dire, com’è che si campa. In ogni caso, non sapevo perché fossi uscito di casa in cerca di un litro di latte con in tasca il libretto degli assegni e quasi duecento euro in contanti, e devo dire che tuttora non so spiegarmelo, fatto sta che si rivelò una scelta decisamente azzeccata. Salutato l’ispettore Moschella e rinnovati i complimenti a Carbini per la tempra invidiabile e l’efficacia del gancio sinistro, me ne tornai da dove ero venuto, ovvero all’incrocio tra due strade di cui riuscii a ricordare il nome solo dopo qualche lunghissimo minuto, probabilmente ancora a causa di quella che doveva essere stata proprio una commozione cerebrale coi fiocchi. Giunto alla macchina infilai di corsa la chiave nella portiera, deciso a riprendere quella mattina da dove l’avevo lasciata e ad accelerare i tempi per riuscire a preparare il ciambellone prima che fosse ora di cena, e, soprattutto, prima di stramazzare al suolo in preda a un calo di zuccheri, grassi e proteine. Con mia grande sorpresa la maniglia restò immobile, lo sportello chiuso e la chiave per metà in mano mia, l’altra metà spezzata di netto nella serratura. Rimasi impietrito e sconcertato, convinto una volta di più di come la potenza fosse nulla senza controllo, quando qualcosa di duro e pesante mi colpì dritto sulla nuca, spedendomi di nuovo a terra con una commozione cerebrale nuova di zecca. Mi risvegliai nuovamente nello stanzone del commissariato, un formicolio in testa e sulle mani mentre i sensi mi riconsegnavano a dolori vecchi e nuovi, e subito mi coprii la testa per paura che Carbini fosse ancora lì e che avesse qualcosa da eccepire riguardo l’accordo bonario di non più di un’ora prima. Mi ritrovai invece di fianco una paffuta signora di mezza età con ancora in mano l’arma del delitto, una busta piena di zucchine e melanzane poco mature, di un bel violetto acceso e dure come sampietrini. “Che delusione,” sospirò l’ispettore Moschella dall’altro lato della scrivania, fissandomi con aria severa e vagamente schifata, “e pensare che l’avevo scambiata per una persona perbene”. Nonostante la scarsa lucidità offerta dal secondo atterramento della giornata, non ci misi molto a scoprire che io e quella signora condividevamo lo stesso gusto in fatto di automobili e ristrettezze economiche molto simili, e che uno strano caso del destino ci aveva portato ad acquistare, molti anni prima, due Punto identiche, dello stesso colore e perfino con la stessa targa salvo le ultime due cifre, che per una coincidenza ancor più bizzarra le avevamo parcheggiate a pochi metri l’una dall’altra e che, caso più unico che raro, qualcuno si era preso la briga, quella mattina, di rubare tra le due auto proprio la mia. Assorbito l’impatto dell’inaspettata dipartita di quello che era stato il mio unico mezzo di trasporto nel corso degli ultimi otto anni, e che viste le mie disponibilità finanziarie sarebbe stato probabilmente anche l’ultimo, c’erano da affrontare le legittime pretese della signora, nello specifico un cospicuo risarcimento danni e la mia reclusione per almeno sei mesi per tentato furto con scasso ed interruzione di esercizio della spesa al mercato. “Suvvia, signora,” fece Moschella di colpo nuovamente affabile e ben disposto nei miei confronti, “non mi sembra il caso di farne una questione di stato”. Ormai pratico dei modi sbrigativi per risolvere le questioni tra onesti cittadini, decifrai un altro occhiolino dell’ispettore, quindi pagai a lui un’altra mazzetta e alla signora ben più di quanto il più disonesto dei carrozzieri le avrebbe chiesto per estrarre la mia mezza chiave dallo sportello della sua Punto, offrendomi inoltre di accompagnarla a casa e di portarle la spesa su per le scale per chiudere la faccenda in modo più che amichevole. La signora intascò l’assegno ma rifiutò il resto della mia offerta. Mi disse che avrebbe usato l’ascensore e che non avrebbe mai portato a casa uno sconosciuto, anche perché mi confidò che purtroppo non ero proprio il suo tipo. Mi lasciò con un pizzicotto sul sedere e con il biglietto da visita della figlia, rinomata estetista ed esperta in pedicure, non si sa mai che da cosa nascesse cosa. Sinceramente anche la signora non era proprio il mio tipo, e di certo non avrei mai avuto la faccia tosta di chiamare la figlia per scoprire chissà cosa sarebbe mai potuto nascere. Eppure, a fronte degli innegabili intoppi di natura logistica e soprattutto economica, stavo iniziando a notare come le soddisfazioni personali non mancassero anche nel lato oscuro della società. Preso da un comprensibile entusiasmo e convinto che una condotta eticamente più disinvolta mi avrebbe presto regalato molto più di un ciambellone al cacao, decisi di proseguire su quella strada, sia fisicamente, giacché ero quasi giunto alla fermata della metropolitana, che metaforicamente. Quando mi apparve di fronte una bimba con gli occhi a mandorla e gonfi di lacrime, immobile sul marciapiede a fissare impaurita le strisce pedonali e le macchine che le sfrecciavano davanti, decisi quindi di agire di conseguenza. Avrei fatto una buona azione, mettendo in pratica, al tempo stesso, quanto imparato in quelle poche ore. Cosa apparentemente impossibile, se solo non avessi avuto la geniale idea di avvicinarmi alla bambina ed aiutarla ad attraversare con il rosso. “Hai bisogno di aiuto, piccolina?” chiesi lentamente e con tono rassicurante, porgendo la mano a quell’angioletto e sperando che capisse l’italiano. Ricevetti in cambio un’occhiata perplessa e qualche istante di silenzio, e costatai che no, probabilmente non aveva capito una parola. “Tranquilla, ci penso io,” sorrisi prendendola per mano, indicando le auto in corsa e il semaforo ancora rosso con la calma di chi ormai sapeva come piegare la legge ai suoi bisogni. “Aiuto, un pedofilo!” strillò la bambina tirando via la mano, e rivelando un accento romano da almeno due generazioni. Una tempesta di grida esplose dall’altro lato della strada, dove accanto al semaforo mi erano sfuggiti i membri ben piazzati di quella che doveva essere una delle famiglie più numerose di Pechino e dintorni, in attesa del verde per poter raggiungere la bambina che fissava commossa i suoi genitori, fratelli, cugini e zii dal primo al terzo grado. Provai a spiegare quel bizzarro malinteso rimandando al di là della strada un sorriso rassicurante e gesti incomprensibili, che peraltro mi sarei potuto risparmiare visto l’italiano perfetto in cui mi tornarono indietro insulti e minacce raccapriccianti. Finalmente scattò il verde per i pedoni, mentre tra le mani dei parenti della bimba apparvero come per magia una mannaia, tre polli vivi, due motoseghe e una bambola vodoo con annesso set di spilli. Scartato con un guizzo un tentativo di placcaggio della bambina presi a correre come se non ci fosse un domani, scostandomi non di troppo dalla realtà dato che cominciò a fischiarmi intorno il sibilo di qualcosa di molto simile ad involtini primavera ripieni di chiodi e polvere da sparo. Quel mucchio selvaggio di italo - cinesi indemoniati mi rimase alle calcagna per più di due chilometri, finché non riuscii a seminarli rifugiandomi nel reparto porno di un’edicola. Rimediato un altro pizzicotto sul sedere e le occhiatine maliziose di due arzilli pensionati riuscii a mettermi in salvo anche da loro, mentre iniziavo a intuire come servisse maggior dedizione sulla via della disonestà, e che per sfruttarne appieno vantaggi e privilegi occorreva non solo ignorare la legge, delinquere e corrompere, bensì anche un’indole più spavalda, menefreghista ed incivile in ogni ambito dell’esistenza. Fu così che quando, un paio d’isolati dopo, mi trovai di fronte la mano tesa di una vecchina ferma sul ciglio di una strada particolarmente trafficata, mi sembrò più che naturale, anzi quasi necessario, lasciare la mano a penzoloni e, appurato che la signora non fosse stata un’olimpionica di judo o di tiro al piattello, abbandonarla alla clemenza di un’orda di tassisti scalmanati. Non che non mi costasse niente, giacché in preda ai morsi della fame quella signora mi ricordò i pranzetti domenicali di mia nonna, che probabilmente ora mi guardava delusa dall’alto dei cieli lanciandomi le stesse occhiatacce della vecchina sul marciapiede. “Non se la prenda,” provai a difendermi con una scusa neanche troppo campata in aria, “è che non vorrei essere scambiato per uno scippatore o un depravato”. L’anziana signora, probabilmente tanto esperta dei pericoli del mondo quanto a corto di batterie per l’apparecchio acustico, al ‘depravato’ tirò fuori dalla borsa un paio di cesoie e mi si fece incontro con aria vagamente ostile. Forse anche stavolta ero partito col piede sbagliato, e non vedevo una reazione così accesa da quando insieme a mio fratello avevo sepolto nel fango la bici della maestra di matematica. Provai a placare gli animi offrendo una tisana al gelsomino, sottovalutando evidentemente il problema di udito della vecchina che in tutta risposta tolse il blocco alle cesoie. Sfruttando un varco nel traffico e confidando nei riflessi rallentati di una quasi novantenne con evidenti segni di artrite mi tuffai giù dal marciapiede, giusto in tempo per schivare il fendente di una lama sporca di rosmarino, e per venire investito con violenza inaudita da qualcosa di veloce, silenziosissimo e molto, molto pesante. Appena un istante per cambiare idea per sempre riguardo l’avvento dell’auto elettrica e poi persi i sensi. Mi risvegliai in un altro stanzone e, come mi spiegò la voce stridula di un agente piemontese, in un altro commissariato. Stavolta al formicolio di testa e mani si erano aggiunti una fitta al costato e dolori diffusi al braccio destro e ad entrambe le gambe. Avevo i pantaloni sporchi e graffiati dopo essere stato trascinato sull’asfalto per chissà quanti metri, e mentre ringraziavo il cielo di poter comunque respirare ancora mi comparve davanti la faccia burbera di un delinquente di borgata, stranamente privo di manette ai polsi e ceppi ai piedi che lo inchiodassero alla sedia per il bene dei presenti. Con mio grande stupore scoprii che si trattava del commissario Marozza, temutissimo e indiscusso padrone di quell’ufficio e del secondo piano di quella stazione di polizia. Scoprii anche che quella che mi aveva investito non era un’auto elettrica bensì un risciò, pilotato da un ex - olimpionico di inseguimento su pista che aveva deciso di reinvestire anni di duro allenamento in bici e una rabbia agonistica più viva che mai nell’accompagnamento urbano di giovani turiste e uomini d’affari con la patente sospesa e pochi soldi per il taxi. Mi complimentai per l’ammirevole e originalissima iniziativa imprenditoriale, riflettendo tra l’altro su come Roma fosse diventata a mia insaputa un ritiro per atleti in pensione e vecchie glorie olimpiche, prima di sentirmi chiedere i danni per il danneggiamento del risciò, ancora da quantificare, e novecentocinquanta euro per i mancati introiti di quel giorno. Spiazzato e un tantino risentito nel constatare che tutti quel giorno sembrassero mettere la mia salute quantomeno in secondo piano, provai ad obiettare che non vedevo un risciò a Roma dall’estate dell’89, e che probabilmente il proprietario e conducente non avrebbe guadagnato tanto neanche al centro di Londra nell’ora di punta. Con un filo di voce che sapeva di catrame e nicotina il commissario Marozza sussurrò che l’attraversamento pedonale in area non consentita e senza previa segnalazione era un reato da non prendere sotto gamba, e che se non ero d'accordo con la quantificazione del danno inferto avrei dovuto rimettermi all’operato di un giudice di pace e di un buon avvocato, se per caso ne conoscevo uno, oppure farmi portare da qualcuno un paio di mutande e una canottiera pulita e prepararmi a passare un paio di notti a Rebibbia. “Mentre ci pensa posso offrirle un caffè, qualche biscotto?” fece Marozza indicando un distributore di merendine che aveva tutta l’aria di non venire rifornito da almeno sei anni. Poco male, con la fame che avevo avrei mangiato anche il vetro del distributore e i neon appesi sul soffitto. Il ciambellone al cacao di cui continuavo a fantasticare rimaneva però l’obiettivo di quella giornata, e di certo non avrei rinunciato al piacere di gustarmelo a stomaco vuoto per un pacchetto di cracker di epoca etrusca. Il commissario scrollò le spalle con noncuranza, e capii all’istante, pur senza il consueto occhiolino, che era nuovamente giunto il momento di piegarmi a quella che mi sembrava ormai una giusta pratica oltre che usanza consolidata, e proposi al proprietario del risciò un ragionevole accordo extra-giudiziale e la solita mazzetta al commissario. Non so se perché non fosse di suo gradimento o semplicemente troppo caldo, ma il commissario lasciò cadere a terra il suo cappuccino al mascarpone, quindi saltò in piedi come una molla e mi afferrò per la maglietta, facendomi scoprire di colpo come in quella società spiccia e disinvolta che mi si era appena rivelata fosse possibile persino volare, almeno fino all’altro lato di una scrivania stracarica di scartoffie, che grazie al cielo ammorbidirono un atterraggio brusco almeno quanto il decollo. Scoprii anche che al mondo non proprio tutti erano disonesti ed egoisti fino al midollo, una scoperta che tutto sommato non avrebbe dovuto stupire più di tanto chi fino al giorno prima si fermava per dare la precedenza anche i cani randagi, e non solo sulle strisce. Di sicuro, nonostante l’aspetto da consumato criminale dei sobborghi di Marsiglia, non era disonesto il commissario Marozza, che non mi arrestò per oltraggio e corruzione solo dopo che riuscii miracolosamente a convincerlo di come avessi voluto provare una battuta per il concorso di cabaret a squadre organizzato dalla parrocchia di Statuario. Fortunatamente il commissario non doveva frequentare molto le parrocchie, e credo che in fondo entrambi non avessimo la benché minima idea anche solo del fatto che a Statuario ce ne fosse o meno una. Ancor più fortunatamente l’ex-ciclista e proprietario del risciò era tutt’altro che onesto, e, dando prova di grande umanità e delicatezza, decise di non sporgere denuncia in cambio di un assegno per il doppio dei danni che aveva richiesto e della mazzetta proposta al commissario Marozza. Varcata la soglia del commissariato e tornato finalmente all’aria aperta e al sole violento delle due del pomeriggio, iniziai a riflettere sugli eventi di quella mattina e, sotto sotto, a nutrire qualche dubbio riguardo il mio cammino sulla via dell’illegalità. Forse era solo il karma di quel giorno nefasto, ma dovetti comunque prendere atto che la mia condotta disonesta mi stava rapidamente sfuggendo di mano. Mentre mi chiedevo come avrei fatto a coprire quell’assegno prima della mattina seguente, già sapendo che non avrei potuto in ogni caso, chiamai Marina, quella che doveva essere la mia coinquilina ed affittuaria e che invece non vedevo né sentivo da più di due settimane, sperando non tanto in una parola di conforto o in un consiglio ragionevole, quanto che si fosse stancata del mare e che volesse darmi un passaggio a casa sulla mia bicicletta, suo unico mezzo di trasporto al di là della povera Punto con cui l’avevo scarrozzata in giro per i tre anni precedenti. Mi disse che se quella era una ripicca per i dieci mesi di affitto che ancora mi doveva sarei potuto anche marcire alla fermata dell’autobus, dove in effetti aspettavo invano ormai da un’ora un segno dell’esistenza di quel trasporto pubblico di cui ogni tanto mi parlavano parenti ed amici. “Tra persone mature non ci si comporta così!” urlò Marina prima di attaccarmi il telefono in faccia e di tornarsene al sole e all’acqua non troppo sporca di Terracina. C’era qualcosa che mi sfuggiva, un altro segreto ancora non svelato, forse, o forse quel giorno era solo una prova, un test da superare prima di essere accolto a braccia aperte da chi davvero sapeva come stare al mondo. Non mi sentivo così spaesato da quando avevo nove anni, da quella volta che avevo preso la scossa provando a mandare in corto il citofono della vicina. O forse da quando ancora quindicenne mi ero ritrovato sul bordo della Flaminia dopo aver rubato il Vespone di mio nonno per vedere se la benzina sarebbe bastata per arrivare fino a Terni. Non ricordavo come fossi tornato a Roma, né come sopravvissi alla furia manesca e catarrosa di mio nonno, fatto sta che di colpo realizzai che forse non ero stato sempre così onesto come mi ero convinto da qualche anno a quella parte. Doveva esserci stato un punto esatto, nel mezzo del cammin’ della mia vita, dove forse in seguito a chissà quale shock o scherzo finito in tragedia mi ero incamminato per la retta via, lasciando ad altri la selva oscura e sotterrando nel cimitero dei ricordi un passato decisamente da birbone. Ne conoscevo ancora più di uno, di birboni, persone di cui ovviamente non farò il nome per motivi di salute, presente e futura, che riuscivano a vivere più che dignitosamente, e comunque molto meglio di me sotto qualsiasi punto di vista, commettendo reati di varia natura anche solo per il fatto di alzarsi ogni mattina ed iniziare a respirare. Non pagavano bollette, multe, l’affitto, mantenendosi con attività di vario tipo, tutte rigorosamente illegali, e riuscendo al tempo stesso, salvo rare occasioni, a restare fuori di galera e a mantenere una vita sociale piacevole e mondana. Mi ero sempre chiesto come ci riuscissero, non tanto all’atto pratico quanto moralmente ed emotivamente, come fosse possibile, in altre parole, convivere con il pensiero che tutto ciò che hai non solo non ti è dovuto né garantito, ma che se il mondo andasse anche solo un po’ come dovrebbe tutto ti dovrebbe essere tolto e mai più restituito. Forse però questo era solo un mio pensiero, e loro, per l’appunto, non ci avevano neanche mai pensato. Vivevano così, punto e basta. Beh, di sicuro non sarebbero state quelle poche ore a farmi cambiare idea del tutto, a farmi tornare il monello armato di skate e bmx che solo ora mi ricordavo di esser stato, né tantomeno a rendere quelli che erano in fondo criminali a tutti gli effetti un modello a cui ambire. Una nuova prospettiva, però, mi era balenata in mente, l’ipotesi che una vita del genere, seppur non condivisibile in tutto e per tutto, fosse quanto meno umanamente possibile. E se quella vita era possibile si sarebbe forse potuta trovare anche una giusta via di mezzo tra quell’estremo e l’estremo opposto, la vita così rigida e diritta che avevo vissuto per tanti anni, senza patemi d’animo né particolari complicazioni, per carità, ma senza neanche un brivido né troppe soddisfazioni. Continuando ad arrovellarmi nel dubbio e nel sole atroce che mi aveva inzuppato di sudore e scollato di dosso qualche decina di cerotti, scelsi di non rischiare e di non sbilanciarmi, in ossequio alla prudenza che grazie al cielo non mi aveva ancora abbandonato. Non sarei tornato il rigoroso osservante della legge che ero fino al giorno prima senza aver provato fino in fondo l’ebbrezza del proibito, e senza rischiare, al tempo stesso, di fare il proverbiale passo più lungo della gamba, anche perché erano entrambe piene di lividi e anche il solo stare in piedi era una tortura non da poco. Decisi quindi che prima di tornare alla missione che mi aveva tirato giù dal letto e fuori di casa, quel litro di latte parzialmente scremato che stava assumendo le sembianze di un Santo Graal, e un ciambellone al cacao di cui probabilmente non avrei mai più voluto sentir nemmeno parlare, mi sarei concesso un’ultima, innocua marachella. Un po’ per sfizio, e soprattutto per necessità fisica, avrei approfittato di una corsa in autobus senza il biglietto. Innanzitutto perché non ne avevo uno e perché non c’era l’ombra di edicole o tabaccai nel raggio di un chilometro, secondo poi perché tutti lo facevano e l’avevano sempre fatto, ovviamente tranne il sottoscritto, nonostante non vedessi un controllore da quando avevo più o meno tredici anni. Ne rividi uno quel giorno, sul 654 diretto a Statuario, ed era molto diverso da quello che avevo visto tanti anni prima. La razza del controllore di autobus sembrava infatti essersi evoluta in una sorta di orso bruno di quasi due metri di altezza e centoventi chili di muscoli e pelo sul petto, con arcate sopraccigliari terrazzate e una mascella da varano. Il tono gutturale e minaccioso con cui mi chiese il biglietto e il barlume di follia omicida che circondava due pupille chiuse come spilli lasciavano intuire decenni di attenta e spietata selezione naturale finalizzata alla rifinitura genetica del perfetto mastino da trasporto pubblico su ruota, oltre che una giornata di lavoro particolarmente infernale grazie ai condizionatori rotti su undici delle dodici vetture ispezionate fino a quel momento. In uno spasmo improvviso di timore fisico e mancanza di pudore finsi di essere salito a bordo per inseguire il mascalzone che mi aveva scippato il portafoglio alla fermata per poi dileguarsi nella calca dell’autobus, senza accorgermi, purtroppo, che l’unico passeggero a bordo era una vecchina dall’età apparente di centoventisei anni che probabilmente non sarebbe arrivata viva al capolinea. Ringraziando il cielo, prima che il controllore potesse dire qualcosa o mettermi direttamente le mani addosso, mi accorsi del lupetto d’oro che portava al collo, e con una prontezza di riflessi che assolutamente non mi apparteneva mi ricordai per fortuna anche del derby. “Tra poco c’è la partita,” sorrisi facendo del mio meglio per instillare in quell’omone la voglia irrefrenabile di andare a prendere una birra insieme, “sempre forza grande Roma”. Sfortunatamente non potevo immaginare che il lupetto fosse in realtà un trofeo di battaglia, sottratto a un malcapitato romanista dal più irriducibile degli Irriducibili, temutissimo e conosciuto in curva nord con l’inquietante soprannome di ‘Cromagnon’, probabilmente per la conformazione neandertalesca del cranio e per delle mani semplicemente enormi. “Era una battuta, s’intende,” provai a salvarmi in angolo e dietro una fila di sedili vuoti, “non so se conosce il torneo di cabaret a squadre della parrocchia di Statuario...”. Ovviamente no. Cromagnon mi fissò in silenzio per un istante quasi eterno, quindi storse la bocca di cuoio in un ghigno che mi piegò le ginocchia. “Lo sai cosa gli faccio ai delinquenti come te?” ringhiò tra i denti lividi di tabacco. “La multa?” risposi speranzoso, temendo in realtà un altro pestaggio da parte di quello che aveva tutta l’aria di un campione di thai boxe. Per mia fortuna ed insperato sollievo scoprii invece che la disciplina praticata da quel controllore ultrà era il pattinaggio artistico su ghiaccio, specialità figura a coppie, di cui era campione regionale, peraltro ancora in carica. Per essere un pattinatore mi mollò comunque un montante niente male, anche se il trattamento che mi aveva riservato, e di cui sembrava andare molto fiero, era in realtà un acuto in falsetto da centoventi decibel sparato dritto dentro al timpano. Parzialmente sordo da un orecchio e completamente dall’altro, lo ringraziai per la dispensa dalla multa e gli consigliai la palestra dove il vecchio Carbini insegnava ancora la nobile arte a un paio di allievi e ad un esercito di blatte, quindi scesi alla fermata successiva sotto lo sguardo disgustato dell’autista e della pluricentenaria miracolosamente ancora in vita. L’autobus sparì all’orizzonte tra le case basse e malridotte di Tor Fiscale, e con calma e rassegnazione m’incamminai verso i quattro chilometri fino a casa e un altro bagno di sudore. Dolorante e pieno di lividi come una pera matura al sole da sei giorni, dopo il martirio di una scorciatoia attraverso il parco di San Policarpo, tra fratte di erba alta e frotte di guardoni, arrivai finalmente al bar vicino casa. Non sapevo quanto fosse merito della scorciatoia, ma ero comunque riuscito ad arrivare qualche minuto prima del tramonto, e nonostante fossi uscito di casa più di dieci ore prima mi sembrò in quel momento un traguardo ragguardevole. Stramazzai sul bancone, boccheggiando come un salmone in cima a una cascata e attirando perfino l’attenzione di Marcello, l’anziano proprietario che di rado rivolgeva la parola persino alla moglie. “Buonasera” disse ributtando subito l’occhio sul Corriere dello Sport. Risposi con un rantolo, quindi presi fiato a sufficienza per otto parole e per i seicento metri che mi avrebbero finalmente riportato a casa. “Un... un litro di latte,” sussurrai con tutte le mie forze, “se possibile parzialmente scremato”. “Il latte è finito, se ripassi tra otto ore trovi quello di domani”. Restai a fissare il retro del Corriere come se non avessi capito una parola. Avevo capito benissimo. Avevo rischiato salute, fedina penale e buona parte di un già esiguo conto in banca per un ciambellone al cacao che sarebbe rimasto solo un sogno, anzi un incubo, amaro come l’epilogo di quella giornata che sapeva di fallimento e disinfettante da due soldi, e che finalmente mi aveva messo di fronte alla scempiaggine dei miei sforzi e alla mia inadeguatezza, tanto come onesto cittadino quanto come perpetratore di qualsiasi crimine al di là del non lavarsi i denti dopo cena. Era stato tutto inutile, e, come la quasi totalità delle iniziative di cui mi ero reso protagonista più o meno volutamente da più o meno quindici anni a quella parte, anche quella giornata non era stata altro che un gran buco nell’acqua. O forse no. La miccia accesa quella mattina da una revisione scaduta e da un raptus da aspirante pasticcere non si era ancora spenta, e un’ultima, ribelle tentazione cominciò a insinuarsi in un animo sferzato da dubbi e paure ma forse non ancora pronto alla resa. Mi resi conto che non avrei mai più avuto un’altra occasione per rievocare l’ardore delle mie gesta di bimbo iperattivo e vagamente molesto, e che i sacrifici di quel giorno sarebbero stati davvero vani se non mi fossi completamente abbandonato almeno una volta all’indole feroce che alberga in ogni uomo e in ogni donna, una natura brutale e primitiva che spesso sa come nascondersi, ma non come sparire. Ecco, quello era il momento, era quella l’occasione, e quasi in preda a un’estasi mistica visualizzai il ribaltamento di un’altra giornata di umiliazioni e di sconfitte, di rabbia indicibile e sacrosanta per una missione naufragata ancor prima d’iniziare, una rabbia da incanalare nell’unica azione possibile in quel momento: rapinare Marcello e cercare alla svelta un altro bar dove sperperare il maltolto in un litro di latte e cornetti al miele a volontà per festeggiare il mio addio definitivo al mondo dei buoni. “Allora che fai, aspetti?” fece Marcello senza guardarmi, completamente all’oscuro dell’incendio che stava divorando una coscienza un tempo integerrima ed in pace eterna con il prossimo. Sarà stato il freddo, la fame o il fatto che mi facesse male qualsiasi parte del corpo salvo le dita dei piedi ed il ginocchio destro, o forse l’ultimo barlume di lucidità dopo ore di percosse e peregrinazioni, ma nell’arco di un istante l’incendio si spense come un cerino sotto la pioggia di un Canadair in volo radente. Mi resi conto che non sarei riuscito a rubare una gomma da masticare neanche se Marcello fosse stato ubriaco o a fumare la pipa fuori dal bar nell’intervallo del derby. Ne presi due pacchetti e tirai fuori gli ultimi venti euro che mi erano rimasti, in tasca o da qualsiasi altra parte. “Solo le gomme?” chiese Marcello. Mi guardai intorno in cerca di qualcosa da mangiare, non per gola quanto per istinto di sopravvivenza, ma l’unica cosa che avesse una parvenza di commestibilità era un mucchietto di briciole su un tovagliolo rosso, sul quale forse qualche ora prima riposava una pila di tramezzini. “Solo le gomme,” dissi trattenendo a stento le lacrime e rimpiangendo di colpo i cracker fossili del commissario Marozza. “Non ho il resto di venti,” disse Marcello continuando ad ascoltare dall’auricolare chissà quali notizie su un Roma - Lazio ormai agli sgoccioli. Lo fissai per un lungo istante, e nella sua faccia spenta di lattaio a fine turno riconobbi tanto la verità che avevo sempre conosciuto quanto la menzogna che mi ero andato raccontando per le passate undici ore. “Non fa niente, tranquillo,” dissi lasciando i venti euro sulla cassa, prima di uscire con un sorriso in faccia e due euro di gomme da masticare che, con lo stomaco vuoto da ormai più di venti ore, avrebbero potuto tranquillamente uccidermi. Ero finalmente ritornato in me, e, meglio tardi che mai, non potei che arrendermi all’evidenza del mio essere troppo onesto. Ero anche stanco morto e pieno di lividi, e di certo non avrei potuto derubare neanche un bambino di sei anni o una nonnetta di novanta, considerato soprattutto il rischio che tirasse fuori dalla borsa un’accetta o un fucile a canne mozze, ma questo era tutto un altro paio di maniche. Mi avviai verso casa tutto sommato felice, quando il trillo di un fischietto alle mie spalle m’inchiodò sul marciapiede. Nonostante fossi a piedi e attraversassi sulle strisce dopo aver guardato sia a destra che sinistra alzai le mani di colpo preparandomi all’arresto. Stavo già per sdraiarmi a terra quando riconobbi dietro di me un accento chiaramente aspromontano. “Ma che fai, guarda che è sporco per terra,” fece una voce divertita accompagnata da due risate in sottofondo. Mi voltai e riconobbi i tre carabinieri di Cosenza, che non erano mai arrivati all’Olimpico e che seduti a un tavolino si godevano l’aperitivo dopo essersi nuovamente persi sulla via del ritorno. Mi fecero cenno di unirmi a loro, un istante dopo aver bevuto l’ultima goccia di quello che doveva essere il mio latte e divorato i tramezzini che avrebbero potuto forse mantenermi in vita nel tragitto fino a casa. Accettai nonostante tutto con piacere, e dopo lo stress fisico ed emotivo di quella giornata tre pacche sulla spalla e un mezzo bicchiere di acqua tiepida mi sembrarono il paradiso. Così come mi sembrò più che giusto che dopo aver fantasticato di un futuro disonesto e criminale mi ritrovassi ora a tavola con tre carabinieri, dei quali condividevo nuovamente in pieno motivazioni, spirito e obiettivi. Non c’era più dubbio, ero schierato dalla parte giusta e, al di là di quel giorno, lo ero sempre stato. “Che dite, ragazzi, facciamo il vento?” fece uno dei carabinieri sorridendo agli altri due. Sorrisi anch’io, più che convinto che stesse scherzando e che scappare da un conto di più o meno quattro euro non sarebbe stato verosimile neanche per il più spiantato dei taccagni. Non stava scherzando, né lui né i suoi colleghi, o comunque non ne davano l’impressione mentre accendevano la ricetrasmittente per simulare una richiesta d’intervento fissando con aria circospetta l’ingresso del bar. Nella mia ingenuità di uomo nuovamente onesto domandai candidamente come potessero tre tutori della legge decidere intenzionalmente di violarla ai danni di un cittadino esemplare e lavoratore modello. “Non si può mica sempre rigare dritto,” disse il più divertito dei tre, “sennò che gusto c’è?”. “Se al mondo fossimo tutti buoni non ci sarebbero più i carabinieri,” fece il collega sollevando le spalle e divorando in fretta e furia un mezzo cornetto alla nutella. “Giusto,” sbottò il terzo, “e poi noi che facciamo, apriamo un’edicola e vendiamo film porno ai pensionati?” disse probabilmente sapendo di che parlava. Provai a spiegargli che il proprietario del bar mi conosceva da quasi trent’anni, ma prima ancora di potergli raccontare delle colazioni ai tempi delle elementari i tre carabinieri erano già spariti dietro l’angolo. Messo alle strette e riconosciuto l’inconfondibile rumore di un Corriere dello Sport lanciato di forza contro il bancone, partii anch’io a razzo verso l’incrocio, scordandomi per un singolo, fatalissimo istante di come Marcello fosse stato l’orgoglio della squadra olimpica di atletica, nonché primatista italiano sui quattrocento metri per più di un decennio, prima di darsi al pugilato e laurearsi, nel 1964, campione europeo dei superwelter, dopo un bagno di sangue di quindici riprese contro il ‘Becchino di Tor Marancia’, al secolo Antonio Carbini. ***** Note sull’Autore Andrea Lombardi è autore poco prolifico di sceneggiature di scarso successo, oltre che un vorace divoratore di taccuini, sui quali appunta racconti molto spesso autobiografici, o comunque almeno un po’. È nato a Roma, dove attualmente risiede, lavora, studia e si allena, riuscendo nonostante tutto a dormire almeno sette ore a notte. Oltre al racconto che avete appena letto, ha pubblicato anche: Racconti Spazzatour de force L’audace colpo della scimmia innamorata Un tranquillo giovedì di fine agosto Sceneggiature (in lingua inglese) TNT – Unarmed and dangerous The Games Plan
Scarica