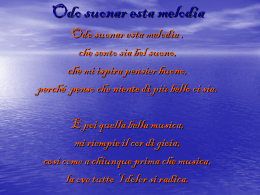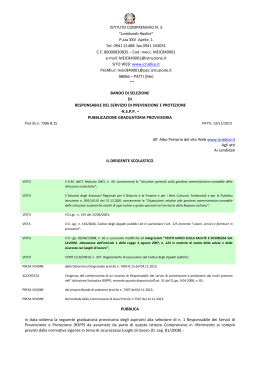Proprietà letteraria riservata © 2013 RCS Libri S.p.A., Milano ISBN 978-88-17-06722-5 Prima edizione: settembre 2013 Ci sono parole senza corpo e parole con il corpo. Libertà è una parola senza corpo. Come anima. Come amore. Parenti dell’aria e quanto l’aria senza confini definiti, resterebbero puro suono se abbandonate alla vaghezza dei rotocalchi o dei talk show. Hanno bisogno di qualcuno che presti loro la sua carne, il suo sangue e i suoi limiti perché diventino concrete. Di versarsi in un corpo che si faccia vaso perché ne possano assumere la forma e la storia. E poiché ogni corpo è diverso dall’altro, queste parole respirano diversamente a seconda dell’individuo cui vanno incontro. E, se ogni individuo è un inizio e una fine con una storia in mezzo, sono parole che hanno bisogno di essere raccontate. In questo libro ho cercato di dire come una libertà, la mia, sia germinata dai luoghi vissuti da bambino e poi abbia preso il volo dal mio incontro con la lettura. Non credo esista un mezzo di trasporto più veloce dell’immaginazione; così come non penso esista 8 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo un propellente più efficace di questa per spingere la nostra libertà al di fuori di noi stessi. un uomo seduto che legge non sta fermo; anzi: quanto più sta fermo e concentrato nella lettura, tanto più è alle prese con un viaggio nelle profondità cosmiche di se stesso, più veloce delle navi spaziali immaginate da Stephen Hawking. Come se la velocità si fosse cristallizzata in assenza di movimento. Quando mi trovo a fare delle lezioni nelle scuole, a un certo punto, per spiegare ai ragazzi come lavora la poesia, li invito a chiudere gli occhi mentre pronuncio una parola. La parola “albero”, per esempio. Poi chiedo loro di raccontarmi l’immagine di albero che si sono fatti nella testa: battuto dalla luce o in ombra, d’inverno senza foglie o fiorente nell’estate, nel vento o sotto la pioggia, inquadrato in una radura da lontano o tanto vicino da avvertirne il sussurro. Non c’è mai un albero uguale all’altro. Ecco cos’è per me libertà. E la scrittura serve proprio ad accendere questa potenza che vive in noi. Naturalmente, i ragazzi mi chiedono perché io scriva; è una domanda così disarmata che disarma. Col tempo, mi sono rassegnato a dire che si nasce col marchio della scrittura così come si hanno gli occhi celesti o neri, la pelle chiara o scura, i capelli biondi o castani, tanto poco è quello che sappiamo Qu ESta LI b Ertà 9 di noi. a loro e a voi posso solo raccontare come sono arrivato alla scrittura. È un’altra delle cose che ho cercato di fare in questo libro. Dite la parola “Spartaco” e, se ne conoscete la storia, vi viene in mente una forma di libertà, dite la parola “Cristo” e vi viene in mente la passione. Ho lavorato così, agendo continuamente con le immagini per riempire di carne concetti astratti. E dato che la sola persona al mondo che conosco un po’ meglio delle altre sono io stesso, ho raccontato di me per raccontare di cose senza corpo. Così nei mesi queste pagine sono diventate un’ossessione, la scrittura mi ha torto il collo e ha costretto il mio sguardo nei luoghi felici dell’infanzia o a muovere i miei passi dentro dolori intensi che pensavo di avere rimosso. Fino alla fine, l’ossessione non mi ha lasciato, tanto che, da un certo punto in poi, posti, sensazioni e personaggi abbozzati hanno fatto il loro ingresso nei miei sogni notturni. Penso che l’ossessione si sia sviluppata in parte per il gusto della sfida, in parte per l’esigenza di mettere un po’ di ordine in me stesso. Perché le parole servono anche a fare chiarezza, prima di tutto in chi le scrive. P.C. L’uomo che viveva con le porte aperte Potremmo cominciare così: dire che il bianco è il colore del silenzio, che un foglio immacolato è un posto dove tutti i colori sono andati via e ci hanno lasciati soli, pieni di una stupefatta solitudine, senza che il nostro sguardo possa trovare un appiglio, uno qualsiasi, per distendersi dentro una direzione, nel conforto di una linea che ci faccia dire: ecco, da qui si può, questo è il nostro sentiero, andiamo. E potremmo aggiungere: là dove non c’è direzione ogni direzione è concepibile, ogni partenza segna un approdo, ogni approdo porta con sé lo scalpito della partenza, e allora affidiamoci a questa disperata libertà, sospesi tra inquietudine e abbandono, slancio e inettitudine. E mentre le parole, proprio adesso, affiorano dal bianco come un’isola remota, potremmo pensare noi ci siamo, abbiamo scelto, si può partire da qui, da un punto qualsiasi, il nostro. C’è una porta socchiusa su una bella mattina di settembre, con il cielo fresco e con la luce entra l’odore buono dell’erba, perché stanotte è piovu- 12 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo to e adesso ogni fibra comincia a scaldarsi e lascia nell’aria il sapore di terra bagnata. Il giardino sono pochi passi poveri di fiori e vanno dalla mia mano che scrive a una siepe, metà in luce, dalla parte della strada che esclude, metà in ombra, dalla parte del prato che accompagna il mio sguardo. un solo vaso di begonie accanto alla porta, un’ortensia ai piedi di un acero logorato dall’edera, a destra un abete e un pruno sono gli accenti di una musica minima, le note concrete che mi invitano a guardare più in là, oltre la siepe, oltre la strada, oltre due case e una magnifica magnolia dalle foglie luminose e pesanti: un sipario che nasconde appena la collina di fronte, gremita di un verde che sale e afferra il cielo. Lo sguardo esaurisce la sua spinta dentro un azzurro senza nuvole e lì si ferma un momento, come per trattenerne la pigra purezza, così lontana da noi, così altera nella sua astrazione che finisco per considerarla un fatto ordinario, come se avesse il mio stesso tempo, la stessa matrice trascurata e domestica di ogni mio gesto quotidiano. Dal cielo torno al tavolo su cui scrivo, alla sua irredimibile imperfezione: il posacenere sporco, pile di manoscritti non letti e che non so se in futuro leggerò, un libro capovolto aperto a metà, una botti- Qu ESta LI bE rtà 13 glia di plastica vuota, quotidiani stropicciati, post-it con sopra numeri di telefono scritti in fretta e date che non rimandano a nulla. La minuzia di un vivere trattenuto per i lembi irrompe e fa clamore in me. Ma durante il ritorno, lo sguardo nell’ozio ancora vivo riesce a cogliere altri dettagli: un’antenna lontana è un chiodo fermo nell’aria, una nube di moscerini al di qua della siepe, una cavolaia che sdipana un gomitolo di traiettorie, due merli ai piedi del pruno fanno un giardino. E guardare è un movimento di spola, dal tavolo al cielo, avanti e indietro, dal disordine a un ordine senza repliche, che dura finché dura il mio soprapensiero. C’è una sospensione non cercata in tutto questo, un benefico lasciarsi levigare dal tempo, uno stare nello scorrere come un ciottolo nell’acqua del fiume, senza resistenze né spigoli. Silvio non offriva resistenze, non aveva spigoli, e mi viene in mente adesso, anzi, per prime mi vengono in mente le sue dita di canestraio, sottili e ossute o, per essere ancora più precisi, mi viene in mente il movimento di quelle dita, perché qualsiasi canestro, cesto, gerla si intreccia partendo dal basso, con un movimento di spola davanti e dietro alle bacchette, su su fino all’orlo, saldato da un cordone. Ed 14 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo è un movimento che affiora dalla profondità dei secoli, ripetuto chissà quante volte, da chissà quante dita prima che Silvio nascesse e tornato alla luce in questo istante, per una semplice analogia che ha legato il ritmo del mio sguardo in ozio al ritmo di quelle dita. Quando l’ho conosciuto, Silvio intrecciava soprattutto gerle, nessuno gli chiedeva più di fare canestri, chiunque avesse bisogno di un recipiente andava dal ferramenta e ne trovava di tutte le misure, dal secchio al bicchiere di plastica, per poche lire e subito. Era spuntato al campo Ceclis con la discrezione con cui spuntano le primule, delle quali ci si accorge da un giorno all’altro, quando danno un nuovo colore al prato. Il tempo, poi, era quello giusto, la primavera del Settantasette, il luogo: Chiusaforte. Neanche un anno prima, l’intero Friuli centrale era stato brutalmente scosso dal terremoto e Chiusaforte, incardinata com’è in una stretta valle nella punta nord-orientale della regione e un po’ defilata rispetto all’epicentro, aveva subìto danni imponenti ma non si erano contate vittime. Così, adesso, gran parte degli abitanti del paese risaliva il Friuli dopo essere stata sfollata per tutto l’inverno sulle rive dell’adriatico. Qu ESta LI bE rtà 15 Per me i colori del terremoto sono il bianco, il grigio, il nero: il bianco è il colore delle pietre macinate, delle ferite delle case, il grigio è il colore della polvere che copre i vivi e i morti insieme, il nero è il colore degli anziani che si aggirano fra le macerie, disorientati come giraffe nella neve. anche Silvio sarà stato coinvolto al momento dell’esodo, sarà stato un puntolino nero fra le macerie, avrà scorto come tutti noi, dai finestrini delle corriere militari che ci portavano a sud, il cratere di devastazione cui erano ridotte Venzone, osoppo, gemona. anche lui avrà portato con sé soltanto pochi stracci nella concitazione della fuga, in uno scenario da germania anno zero, e anche lui chissà da dove, da grado, forse, o Lignano o bibione avrà percorso a ritroso le strade che lo avrebbero di nuovo condotto a casa, ai pendii magri di Chiusaforte. avrà respirato a lungo appena sceso dalla corriera e quell’aria lo avrà vestito di una dolce consuetudine, come una vecchia giacca che conserva la memoria di un corpo e vi si ricongiunge. Non so quando sia arrivato al campo Ceclis, il villaggio di prefabbricati allestito in fretta e furia durante l’inverno, in una delle rare zone pianeggianti del paese, e dubito che qualcuno si sia accorto del suo arrivo: di solito le famiglie tornavano 16 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo alla spicciolata, dentro pulmini stipati o utilitarie prese in prestito per l’occasione ed era un vociare di saluti, bestemmie e riconoscimenti, in una confusione di masserizie e materassi bucati. Lui di sicuro sarà arrivato leggero come una rondine, con soltanto il suo zaino grigioverde in spalla. I prefabbricati di campo Ceclis non erano altro che baracche di legno disposte in lunghe file, dove intere famiglie vivevano in pochi metri quadri e dove ci si urtava e si litigava in continuazione dati gli spazi ristretti, per cui era molto più semplice per noi bambini vivere all’aperto, d’estate e d’inverno, anche perché l’attenzione allentata dei nostri genitori, ancora sviata dalla tragedia del terremoto, ci apriva ampi spazi di libertà. ben presto diventammo i veri dominatori del campo e l’esercizio del nostro dominio cominciava dall’argine oltre il quale scorreva il fiume Fella e terminava dall’altra parte, con l’alzarsi della massicciata della statale che portava a nord, verso l’austria e verso la Jugoslavia, verso i balcani e chissà quali altri mondi lontanissimi e inattingibili. Quasi cullati, in mezzo a questi due confini, il fiume e la strada, eravamo capaci di bruciare per interi pomeriggi in interminabili partite a pallone, che degeneravano fatalmente in altrettanto interminabili Qu ESta LI bE rtà 17 sassaiole. Fu durante una di quelle che con la coda dell’occhio scorsi per la prima volta Silvio: stava seduto su uno sgabello davanti alla porta della baracca che gli avevano assegnato e armeggiava con un grosso catino di zinco. un duro inverno e una primavera cruda stavano per restituirci l’estate, il sole splendeva sui vetri delle finestre, sul lunotto di un’utilitaria parcheggiata, accendeva di luce i nostri capelli sudati e noi riempivamo l’aria della vita restituita con i nostri gridi, con le nostre corse, con i nostri battibecchi di scriccioli. In genere capitava che tutto questo fosse interrotto dall’intervento sbrigativo di qualche adulto: una serie di bestemmie, la minaccia di un ceffone, una breve rincorsa, e si sciamava altrove a riaccendere i nostri giochi; ma Silvio no, se ne stava seduto lì davanti alla porta e di tanto in tanto sollevava lo sguardo dal catino. Ebbi anche l’impressione che sotto l’ombra del suo cappello a tesa esitasse l’ombra di un sorriso. La sera a cena seppi da mio padre che quell’omino era il canestraio di Chiusaforte, che non si era mai sposato e che era malato di cuore. Per i bambini, o almeno per il bambino che ero, il cuore è una cosa minuscola e misteriosa che ha la consistenza del buio e che nel buio di noi trova sede e riparo: 18 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo è l’epicentro della vita stessa e a quell’età la vita è per sempre e non c’è niente, se non appunto una malattia del cuore, che possa arrestarne la corsa verso un futuro privo di confini. Insomma, la malattia del cuore è la malattia stessa e io quella sera mi misi a letto con quella notizia, tanto più grande dei miei dieci anni, che Silvio era malato di cuore. Quando una persona cara scompare, la prima cosa ad andare via con lei è la sua voce, poi, ma ci vuole più tempo, sfioriscono nella memoria uno a uno i tratti del viso; solo i tratti che non contano però, perché quelli che definiscono una vita mettono radici robuste in chi li ricorda; infine ciò che permane di più sono le azioni, i gesti minuti, la condotta che accompagna il tenore di un’esistenza. Mi dispiace di non poter riferire con precisione come fosse la voce di Silvio, posso solo dire che non era acuta e non era profonda, forse era più simile a un soffio, a qualcosa di trascinato, come quelle piogge sottili che non finiscono mai e non hanno sussulti, governata più dalle soste che dalle partenze, più dai vuoti che dai pieni, almeno queste sono le tracce dell’impressione che ne ebbi la prima volta che lo avvicinai. avvicinarlo fu facilissimo, una cosa che sgorgò naturale, lo feci alcuni giorni dopo aver saputo che era Qu ESta LI bE rtà 19 malato di cuore, con i tempi e i modi che regolano lo spicciativo galateo dei bambini: un ciao, un come ti chiami, un io mi chiamo, un che cosa fai, ti piace giocare con le biglie, non tanto, allora andiamo a giocare al fiume, ed era tutto; nascevano amicizie salde come querce nell’istante stesso in cui divampava il gioco e messe subito a repentaglio l’indomani, da nuovi incontri con altri bambini. trovai Silvio seduto davanti alla porta di casa come la prima volta che l’avevo intravisto. ricordo un cielo stanco, lattiginoso, un pomeriggio di maggio senza sole e senza ombre, abbandonai la diffidenza di lupo che mi guidava ogni volta che dovevo avvicinarmi a un adulto, perché dai grandi non ci si aspettava mai niente di buono, e mi rivolsi a lui da bambino a bambino, forse perché conservavo l’impressione di quel sorriso affiorato mentre noi si giocava, forse per via della sua malattia che mi induceva a tenerezza, oppure perché davanti a me stava un ometto minuscolo dalla faccia scarna, dalla bocca completamente senza denti e dal mento sporgente che ricordava i vispi vecchietti dei western di Hollywood. Sia come sia: «Devi sempre stare seduto sullo sgabello?» gli chiesi, con candore e insolenza. Prima di rispondermi con le parole mi rispose con lo sguardo, e dentro il verde chiaro dei suoi 20 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo occhi c’era la spiovente dolcezza dei salici: «Sei il figlio di toni, vero? No, qualche volta sto seduto anche sulle sedie o sul divano, se capita». Non colsi l’intento canzonatorio della risposta, l’appetito della mia curiosità era tale che mi faceva saltare di slancio anche la canzonatura. «Papà mi ha detto che sai fare le gerle.» «Sì» sorrise, «so fare le gerle.» «Io non ho mai visto farle, posso venire da te a vedere quando le fai?» «Quando le faccio, puoi.» «allora va bene, ma dovrò stare zitto mentre le fai?» «No, non serve, facciamo che io ti parlo, tu mi parli e le mie mani lavorano lo stesso, d’accordo?» «adesso vado a cercare gli amici, ciao. allora vengo a vederti quando le fai.» «Vai, e torna se ti va» mi rispose, alzandosi dallo sgabello e mostrando una statura non molto superiore alla mia. Poteva bastare per quel giorno: un incontro fulmineo, dettato dalla fantasia fulminea di un bambino e screziato di dolcezza. Le gerle di Silvio erano note in tutta Chiusaforte per la straordinaria capacità di adattarsi alle schiene di chi gliele richiedeva: non c’era schiena storta, gobba, scoliotica, dritta, pingue, ampia o magra che Qu ESta LI bE rtà 21 non avesse corrispettivo in equilibrio, peso, forma e dimensioni nelle sue gerle, le quali rispondevano come una eco perfetta al richiamo del corpo. a chi andava da lui per una gerla veniva innanzitutto chiesto se dovesse portare cose leggere o pesanti, fieno oppure foglie, legna o ferrame, poi Silvio si alzava, domandava al cliente che gli mostrasse la schiena, ne percorreva l’intera superficie con le dita, dai lombi al collo, scovava anomalie e dissimmetrie tastando e sfiorando, accomodando i piccoli palmi sulle scapole, considerando l’assetto delle spalle: come se dovesse imprimere nella memoria sollecitata delle sue mani ogni carattere del corpo esaminato, che sarebbe stato di seguito tradotto in scelte precise di forma, di tensione tra festuche e bacchette, e di rapporto tra fondo e orlo della gerla stessa. Soltanto al termine di questa liturgia domestica si veniva alla questione del compenso, alla quale Silvio si sottraeva chiedendo di essere pagato in base alla maggiore o minore soddisfazione del cliente. Capitai qualche giorno dopo proprio in mezzo a una di queste ponderate contrattazioni che si svolgevano all’aria aperta. Silvio era alle prese con un donnone dalla faccia rossa che gli volgeva le spalle, mentre lui era salito sullo sgabello per 22 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo esaminarle meglio scapole e spina dorsale, facendo scorrere le sue mani come un soffio sopra una sporca maglia color senape. La donna puzzava di sudore, calzava degli stivali di gomma infangati e probabilmente era appena tornata dall’orto. rimasi lì accanto per tutta la durata dell’operazione, facendomi sfuggire i risolini silenziosi del bambino che non capisce, senza che né la donna né Silvio mostrassero di considerarmi, poi Silvio scese dallo sgabello, congedò la donna e finalmente parve accorgersi di me. «La gerla e la schiena devono essere una cosa sola, se la gerla va da una parte e la schiena tira dall’altra, è come quando due persone litigano e ne escono solo offese e dolori e magari anche le botte. C’è una gerla per ogni schiena e la gerla va trovata nella schiena di chi la deve portare e, per trovarla, prima bisogna conoscere la schiena, altrimenti cominciano i litigi e non è bello, specie se si va su in montagna e si è soli.» Si rivolse a me così, più o meno, mortificando con pacatezza i miei risolini e mettendomi in testa il sospetto che leggesse nel pensiero. «oggi è il primo giorno di vacanza, sono venuto per vedere il lavoro, come ti avevo detto» replicai, un po’ in imbarazzo, spostando il peso del mio corpo prima su un piede, dopo sull’altro. Qu ESta LI bE rtà 23 «È un giorno giusto per il lavoro, questo» mi disse, indicandomi il catino di zinco accanto alla porta, nel quale erano a mollo e sporgevano un’infinità di bacchette di legno. «Sono come gli spaghetti che mia madre mette a bollire. a cosa ti servono tutte quelle bacchette?» «Quelle saranno le costole della gerla e le daranno la forma, così come le tue danno forma al tuo petto» mi rispose, invitandomi a sedere per terra, mentre si sistemava sullo sgabello. accanto al catino, addossate alla parete, c’erano diverse fascine di bacchette all’asciutto e senza scorza; ne trasse alcune, ne provò la tensione sulle ginocchia, ne scelse una prima e vi praticò tre incisioni sulla punta. Poi, con un gesto delicato e deciso tirò, come quando si toglie la spina da un pesce. Ciò che ne uscì fu una bianchissima fettuccina, che più tardi seppi essere il midollo del legno. Che cos’è una gerla. Silvio non accetterebbe la rozza descrizione che sto per darvi, sul verde dei suoi occhi passerebbe un’ombra inavvertita. ad ogni modo, una gerla è un grosso cesto a forma di tronco di cono rovesciato, che si porta a tracolla; il fondo è fatto da una tavola sottile e arrotondata, d’acero se i carichi da portare sono più lievi, per i carichi più pesanti, invece, il legno scelto dev’essere duro 24 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo e leggero insieme, di solito il larice e più raramente il tasso. Lungo il perimetro del fondo vengono infilate solide bacchette di nocciolo intorno alle quali si sviluppa l’intreccio orizzontale fatto da festuche di vimini. Quando si arriva all’orlo, si salda tutto con un cordone anch’esso in nocciolo che, non per caso, dalle nostre parti si chiama la gjoe, la gioia. Con lo stesso legno del cordone si fanno gli spallacci, determinanti per l’equilibrio dell’insieme. Quel giorno Silvio aveva cominciato a preparare le festuche di vimini. «Il legno dev’essere verde, ancora in amore, vedi?» mi diceva, e c’era qualcosa di ipnotico in quella gestualità ribadita, e nel rumore sottile delle fibre che si separavano dalle fibre, qualcosa che frusciava come seta, come se il midollo del legno venisse letteralmente sguainato dalla bacchetta che lo conteneva. Mi trattenni con lui una buona mezz’ora, la prima estate entrava nelle narici, scaldava la pelle e io sentivo forte l’invito del fiume oltre l’argine; quando lo lasciai c’era già un buon numero di fettuccine accanto al suo sgabello. I risvegli di un bambino in vacanza sono una festa, davanti al risveglio c’è una lunga giornata di giochi, mettersi con impazienza i calzoncini corti, allacciarsi sommariamente i sandali, trangugiare un bic- Qu ESta LI bE rtà 25 chiere di latte e uscire di casa correndo fa parte della promessa dei giorni d’estate, che si schiudono uno di seguito all’altro, appetitosi come tante pesche aperte. «Vado da Silvio che fa la gerla» gridavo, già fuori di casa, inseguito dai rassegnati ammonimenti di mia madre. avevo preso l’abitudine di andare da lui ogni mattina sul presto – sul presto per me, ché Silvio si alzava a ore antelucane – per assistere ai progressi del lavoro; mi catturava l’idea che si potesse trarre un oggetto definito, con una forma appropriata e funzionale, dal caos di bacchette e scorze che avevo visto la prima volta. La forma saliva e si liberava dal fondo, e Silvio pareva aspettarmi, come si aspetta un passero sul davanzale di casa, del quale ci si stupisce a ogni ritorno. «Siediti qui» mi diceva, sorridendo con la bocca senza denti, «che andiamo avanti.» Si sistemava la gerla tra le ginocchia e cominciava a intrecciare le festuche alle bacchette di nocciolo, già ancorate al fondo, infilava la festuca tra bacchetta e bacchetta, davanti e dietro, davanti e dietro, poi tirava. La tensione praticata doveva essere sempre costante perché, se era maggiore, le costole della gerla si sarebbero chiuse verso l’interno; 26 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo se invece era minore sarebbero malinconicamente rimaste aperte verso l’esterno. Io, piccolo com’ero, non mi chiedevo affatto da dove venisse quella sequenza di gesti naturalmente sorvegliati, mi accontentavo di seguirne la precisione e la reticenza, ero il bambino incantato dal prestigiatore mentre cava dal niente la colomba o il coniglio. Me lo sono chiesto più tardi, da uomo fatto: qualcuno avrà insegnato anche a Silvio, magari quand’era bambino, perché ai suoi tempi si cominciava a lavorare presto, gli avrà insegnato a intrecciare, a preparare le festuche, a cercare i rami di salice giusti lungo il fiume e anche lui avrà dovuto ripetere e ripetere, ostinato e devoto, cercando di impossessarsi di un ritmo, finché quel ritmo si sarà impossessato di lui, delle sue mani, delle sue dita. Così, quello che vedevo non era un vecchietto dalla faccia scarna, dagli occhi verdi color salice, dalla bocca senza denti, ma una cultura al lavoro, risalita dai tempi lungo una catena viva di uomini che l’avevano condotta fin lì, e quelle che agivano non erano mani, ma il ritmo stesso di quella cultura. «ognuno nella vita porta il suo carico» mi aveva detto una volta, «e io faccio in modo che, almeno un po’, quel carico sembri più comodo di quello che è.» Qu ESta LI bE rtà 27 Credo che quel “fare in modo” si possa tradurre facilmente in un “fare con modo”, e che Silvio lasciasse l’impronta della sua persona in ogni intreccio che realizzava, e che un poco di sé gemmasse ogni volta che qualcuno portava un carico pesante con una sua gerla traendone l’impressione di una fatica minore: quello era il segno del suo essere artigiano, un niente, un soffio, un’impressione che aiutava. E oggi, in questo bel giorno di settembre, mentre la luce scalda la siepe dalla parte della strada ed entra l’odore dell’erba dalla porta socchiusa, penso, con qualche presunzione, che ci sia un legame tra il suo intrecciare e il mio scrivere: come lui sceglieva una a una le sue bacchette di salice, così io scelgo una a una le parole. Come lui intrecciava le festuche secondo un ritmo, così io cerco di intrecciare le parole secondo un ritmo. Come lui lasciava un’impronta di sé nell’intreccio, così io spero di lasciare l’impronta di un mio respiro nelle parole che ho sottratto al bianco del foglio, per sottrarre dal silenzio qualcosa dei lineamenti della sua esistenza. Silvio se l’è portato via la notte, il debole picciolo che lo legava alla vita aveva lasciato la presa in un breve volo dal cielo alla terra, dopo una lunga estate di bambino nella quale l’avevo frequentato ogni 28 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo giorno. Lo seppi da mia madre, appena tornato da scuola, so che corsi verso la sua baracca di legno e trovai il catino di zinco appoggiato alla parete, insieme al suo sgabello. “ti regalo il cielo senza nuvole, ti regalo il cielo con le nuvole sottili, ti regalo l’odore del fiume e quello dei salici in amore, ti regalo l’odore del legno caldo, ti regalo l’acqua che corre sulle dita, ma torna, ma tu torna” avrebbero voluto dire le poche lacrime mute mentre mi sedevo un’ultima volta per terra davanti alla porta chiusa. Silvio non tornò, né quel giorno né il giorno dopo, né per tutti i giorni che servirono a mutare lo strappo nel sorriso di un uomo che stava alto sopra la morte, viveva con le porte aperte e si stupiva nel mio stupore. Il tempo che ci vuole Caro b., è da un paio di settimane che intendo scriverti, ma il silenzio trova sempre pretesti buoni per essere silenzio. Ci si può appellare alla quantità industriale di mail lasciate inevase; al cellulare che squilla proprio quando i fogli sono già disposti sul tavolo, la penna in pugno; alla lezione da preparare all’ultimo minuto; ai malanni; alla febbre; alla visita inopportuna e non annunciata di un amico: il bello è che c’è una parte cospicua di verità in tutto questo. Le mail continuano ad affollare la casella, il cellulare squilla, e gli amici continueranno a farti visita nei momenti meno opportuni. tutte queste sollecitazioni sono esterne a noi stessi e un pretesto non è un pretesto se non ci si può rifugiare in esso uscendone con la coscienza pulita. Il pretesto, nel nostro caso, è il brusio che stringe le nostre esistenze e che diventa clamore. 30 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo Scrivere una lettera è un atto di devozione: il primo grande sforzo consiste nello scavare un fossato intorno a noi, alzare le nostre mura merlate e fare di noi stessi un castello, al riparo del quale il tempo possa distendersi a piacere assumendo la nostra forma, come l’acqua quando prende la forma del recipiente che la contiene. Lo sai: una lettera come si deve richiede cura, due, tre ore conquistate, tra minuta e bella copia, da offrirsi mentre vengono offerte. un gesto inaudito, se ci pensi, impigliati come siamo nelle maglie dell’età della comunicazione. E se la scrittura è un’estensione del nostro pensiero, ormai è diventata un braccio così lungo e flessibile da avvicinare chiunque e dappertutto, a reykjavik come a Calcutta. È un vantaggio impressionante, una velocità e una facilità di entrare in contatto che hanno reso il mondo più piccolo di una pallina da tennis e hanno legato luoghi diversi molto più di quanto abbiano fatto i primi voli transcontinentali. tu e io siamo nati in un tempo nel quale le lettere erano uno strumento di comunicazione necessario e abbiamo scavallato una china oltre la quale, di colpo, dopo due millenni d’uso, sono diventate uno strumento obsoleto. E se è vero che abbiamo Qu ESta LI bE rtà 31 scelto la tastiera in luogo di carta e penna e che la scelta ci ha consegnato un mondo sul palmo, è altrettanto vero che, da sempre, a ogni scelta corrispondono un guadagno e una perdita. oggi ti scrivo, i fogli sono sul tavolo e pian piano si andranno riempiendo, e penso che la prima cosa che è andata perduta sia la sensualità della scrittura, quando la penna procede e dopo si incaglia nell’incertezza seminando cancellature che, bada bene, sono visibili, non sono uno spazio vuoto sul monitor: diventano le tracce dell’intermittenza del nostro pensiero. E poi la penna la si conduce, come un capitano conduce la sua nave, il pittore il suo pennello: è un gesto che ha in sé lo spessore dei secoli e che rivela la personalità di chi lo pratica, non è un semplice battere su e giù per la tastiera il cui risultato è una pagina senza esitazioni in caratteri times. È andato perduto anche il tempo dell’attesa, che cominciava nel momento in cui la lettera veniva spedita e culminava nel piccolo soprassalto di curiosità e buonumore all’arrivo del postino, con bicicletta, divisa e borsone di cuoio a tracolla. Infine l’atteggiamento: scriverti vent’anni fa avrebbe comportato una ritualità domestica e ridotta, consueta e piacevole com’è preparare un caffè e ascoltarne il borbottio nella moka o il tintinnare 32 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo dei cucchiaini nelle tazzine; oggi, invece, scriverti una lettera è un evento raro e che accadrà sempre meno e io sono costretto a indossare l’abito da cerimonia per farlo, quasi dovessi confezionare un regalo sontuoso in replica ai tanti che mi hai fatto tu. Domenica scorsa ho assistito a una conferenza sul carteggio di una scrittrice friulana dell’ottocento e, mano a mano che i relatori si alternavano, definendo metodi, lasciando in sospeso nodi irrisolti nella sottile ricostruzione dell’ordine del tempo, a seconda delle biografie di questo o quel destinatario, mi si è affacciata l’immagine di un’équipe di chirurghi concentrata a salvare la vita di un paziente. Né più né meno. È il corteggio di pazienza, intelligenza, tenacia disposto intorno a oggetti fragili e concreti come sono le lettere appartenute a epoche in cui era possibile dire addio che mi ha colpito; il riannodare filo dopo filo l’architettura di una ragnatela di relazioni consumate più di un secolo fa che mi fa dire quanto i filologi siano i medici delle nostre smemoratezze. L’inchiostro si ossida e si stinge, la carta allenta le sue fibre; eppure, nella sua fragilità senza armi, una lettera porta in sé una durata senza paragone rispetto ai supporti nei quali versiamo la nostra memoria. Di qui a cinquant’anni, i dischi rigidi, le Qu ESta LI bE rtà 33 chiavette, i cd che utilizziamo oggi saranno oggetti bruti che nessun programma sarà in grado di leggere, remoti come dev’essere stata remota la Stele di rosetta agli attoniti soldati di Napoleone. Quanto ai filologi, avranno ben poche occasioni per esercitare la loro perizia, perché le lettere riposeranno in teche ben illuminate, lontane nel loro enigma quanto un manufatto etrusco. Ecco, anche per questo ciò che deve rimanere fuori dalle mura che ho appena alzato (almeno per oggi) è la parola “comunicazione”, che mi suggerisce un’atmosfera da quartier generale, con ufficiali di Stato Maggiore impegnati a stilare stringati dispacci che devono pervenire al fronte nel più breve tempo possibile e senza margini di ambiguità. Mentre accoglierei volentieri entro la cinta la parola “espressione” e quel tanto di sforzo esclusivo che implica aprire noi stessi all’altro. Come vedi la sto prendendo alla larga, neanche fosse, la mia, un’epistola di Cicerone, ma queste righe vogliono essere un calice alzato a te e al piacere della divagazione, e sono il solo modo di dirti quanto mi abbia colpito ricevere la tua busta. Certo, era bagnata ai bordi, dalla parte del mittente l’inchiostro blu era colato e chi me l’ha recapitata non era il postino con il borsone di cuoio ma un ragazzetto 34 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo fradicio di pioggia e con un giubbotto svolazzante color giallo acido; il soprassalto di buonumore, però, è stato lo stesso di sempre: come quando ci si ritrova in un luogo e in un tempo inaspettati. Ho due modi di aprire le buste: se contengono bollette, pubblicità o comunicazioni di carattere burocratico, ne sollevo il lembo di chiusura con l’unghia del pollice quel tanto che basta per infilare l’indice, tirare e sventrare, un colpo secco e selvaggio che lascia sul tavolo un ammasso informe di carta, insieme alla mia stizza pacificata. Se invece sono lettere personali, utilizzo un coltellino che faccio scorrere con cura cercando di non rovinare il mittente, in una ritualità che rende più caro il momento. Nel caso della tua, poi, ho usato una delicatezza supplementare: aveva i bordi umidicci, come ti ho detto, così ho dovuto ricorrere alla lama di un taglierino affinché i margini del taglio fossero netti e precisi, e al breve istante di concentrazione, le labbra serrate e protese, la busta appena socchiusa, si è sostituita una sorpresa di bimbo nel vedere, accompagnate da un biglietto, le fotografie che mi avevi promesso. te le avevo chieste la scorsa estate, durante una cena, il viaggio in macchina da roma ti era stato pesante e ne portavi i segni sul volto. Ma sotto il bersò Qu ESta LI bE rtà 35 dell’agriturismo in campagna, in mezzo alle voci degli amici, al fresco che cominciava a scendere dalla corona di monti più a nord, la tua stanchezza sembrava stingersi nell’atmosfera rilassata di una compagnia che si trova a tavola insieme. Se i bicchieri brillano alla luce delle lampade, se le risate si intrecciano e si spartiscono da un capo all’altro del tavolo, se le ombre scure degli alberi sono lontane e si alzano nel cielo denso della notte estiva, tutto può essere promesso, si fanno progetti e si segnano date senza illudersi che poi vengano rispettate, perché una cena è un momento di tregua e le città, come ha scritto un poeta dei tuoi posti, sono una “battaglia lontana”. Invece, adesso, mi ritrovavo in mano le tue fotografie e in spirito l’adempimento di una promessa che non mi aspettavo avresti mantenuto una volta tornato laggiù, nella battaglia. Non c’è piacere, per me, nel viaggiare, lo sai, ogni viaggio assume i contorni di una sfida fisica, il mio corpo risponde recalcitrando come un mulo azzoppato. Del resto, una lesione netta al midollo spinale impone un divorzio perpetuo tra il desiderio e le ossa i tendini la carne e l’acqua di cui siamo fatti; un organismo colpito chiede la pace, tutt’al più movimenti sorvegliati regolari e ripetuti, da 36 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo professionisti della malattia, mentre l’appetito alla vita e la volontà che è il suo braccio reclamano il contrario: esci muoviti e mangia il mondo, urlano. te lo dissi quasi da subito, quando mi accennasti alla strada dei poggi, al casolare sull’altipiano che dà sulla Val d’orcia, dove vivi se gli impegni di lavoro non ti costringono a roma: molto difficilmente avrei potuto raggiungerti per godere della spettinata bellezza dei tuoi luoghi. «Ma tu mandami delle fotografie, almeno darò uno spazio alla tua voce quando ci sentiremo» aggiunsi, senza crederci molto. E oggi ecco la quercia secolare sospesa sul ciglio del poggio, la grande chioma che è una nuvola scura tra le nuvole del cielo, ecco i profili mossi e morbidi della valle con la dismisura di una veduta che abbraccia, ecco il casolare e la pergola in castagno e tu in maniche corte, seminascosto da un primo piano di fiori rosa che non so riconoscere. Ecco la stessa quercia di prima e più in là la spennellata di tre cipressi neri dentro un tramonto del cui sublime senza ritegno ti scusi nel biglietto, e poi l’inquadratura dal basso del casale, le zolle arse, e gli alberi da frutto che tu e tua moglie Francesca avete piantato «per tenere viva e in ordine la terra», come mi avete detto. Qu ESta LI bE rtà 37 Vivere in un posto alto rassicura, la geografia di un luogo si mostra tutta in un breve giro di sguardo: come un fiume trova il suo estuario, l’ansia di chi osserva va incontro alla serenità, qualcosa di simile a uno stare immoto e compiuto. Perché tu non sei coinvolto, sei fuori dal paesaggio e, in virtù di questa astrazione, ti pare si raccolga nei tuoi occhi acquietati l’aspetto complesso del mondo, la relazione tra ogni singola forma chiarita d’un tratto. Diversamente da quando stai dentro il paesaggio, le tue dita impazienti di bambino non si ostinano a setacciare i frammenti muti di una figura, le tessere sparse sul tappeto, e non hai bisogno del dettaglio che rivela, sulle tracce del quale eri obbligato a metterti per ricomporre, ammesso che si trovi una composizione, l’insieme. La veduta dall’alto sdegna le piccole quantità e guarda l’orizzonte negli occhi, non è parziale quindi non appartiene al conflitto, non conosce né fatica né attrito. Il verbo che la declina è “comprendere”, mentre chi vive dentro il paesaggio è costretto a declinare il verbo “capire”, e c’è una bella differenza tra questa coppia di infiniti, la stessa che separa il verbo “abbracciare” dal verbo “afferrare”. tutto questo è metaforico, naturalmente. Ma se vivi in un luogo che sta in alto è possibile sentire 38 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo restituito il tuo peso di uomo, anche se sei un po’ più vicino alle nuvole e hai l’impressione di essere leggero. La mia testa è stata vicina al cielo per poco tempo, fino ai nove anni ho vissuto anch’io in un posto alto, come te. abitavo in cima a un colle, io lo chiamo così, in realtà si tratta di una proda morbida con la schiena appoggiata ai monti. una volta ho sognato di stare seduto sulla sommità di un’enorme collina, completamente verde, un mare verde appena mosso dal vento e battuto dal sole. Non c’era un albero, né uno sperone roccioso, non c’era un solo elemento che rompesse l’armonia di quel mare in pendio, ora brillante, ora d’argento e d’oro, a seconda di come le onde erbose mostrassero il dorso o il ventre. Se guardavo bene, se seguivo di onda in onda il pendio, giù fino al fondo senza fine, lo vedevo darsi a un lembo di azzurro più piccolo di uno stagno, e non era l’azzurro del mare, quello; quello era il cielo, con le sue nuvole pigre, e mentre il mio sguardo risaliva sulla groppa delle onde, i miei piedi stavano nel cielo, la mia testa nella pace. C’è una sola parola per dire cosa fosse quella sensazione: respiro. Credo che questo sogno sia un lascito, che si sia scavato un varco come un fontanile dal sottosuolo Qu ESta LI bE rtà 39 della mia infanzia, per trovare la luce nella forma di un regalo inatteso. Sai quanto me che i panorami interiori non sono affatto sovrapponibili a quelli che vediamo, tuttavia un nesso lega saldamente ciò che ho visto da bambino a ciò che ho sognato, ed è l’impressione di un respiro largo che mi accompagna ancora oggi, quando ripenso agli anni trascorsi su quell’altura. Ciò che vedevo da lassù era l’intero tratto di valle che accoglie Chiusaforte, ma l’aggettivo, anche se rimanda alle vastità che osservi dal tuo poggio, non ti deve ingannare: poco più di quattro chilometri dalla sua estremità occidentale a quella orientale erano sufficienti a riempire il mio sguardo, che si fermava poco al di qua del ponte di ferro a est. Lì la valle assume la forma di una gola e le falde dei monti salgono quasi toccandosi, divise da lo trazer de un bon brazho, un tiro di sasso, come ha lasciato scritto cinque secoli fa un ispettore dei boschi della Serenissima repubblica di Venezia, di cui Chiusaforte costituiva l’ultimo caposaldo prima dell’Impero. Il poco che guardavo, però, lo guardavo dall’alto, in primo luogo la statale, che passa ai piedi della proda, situata com’è proprio sopra al primo pugno di case che dà il via allo sgranarsi del paese, su su 40 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo fino al ponte di ferro, dove le case si diradano e lasciano il posto soltanto alla strada; poi il greto e il fiume che allora occupavano buona parte della valle; e poco più a est la cava, con le autorimesse, i silos per il cemento, un viavai di sgangherati autocarri e scavatrici gialle, e i grandi mucchi di ghiaia spartiti secondo l’ordine di grana della sabbia. Dopo vengono le caserme, dove stanziava un intero battaglione di alpini e poi, finalmente, il centro del paese con la sua chiesa troppo grande, che ancora oggi mi dà l’idea del cappello di un adulto che sia stato gettato svogliatamente in testa a un bambino. a terminare la carrellata da ovest a est, il primo ponte a ridosso del centro di Chiusaforte, che piega a sud, attraversa il fiume e punta verso la Val raccolana. Questi erano gli sparuti elementi riuniti nel mio sguardo, tolto dal mondo, lì, sull’altura, li percepivo minuscoli, e potevo coglierne le relazioni intime: il camionista, che lasciava la statale per entrare nella cava, non vedeva la scavatrice pronta a muoversi dietro il mucchio di ghiaia, ma io sì; così come sapevo che due ciclisti che procedevano in direzioni opposte, separati alla vista da un ampio tratto in curva, si sarebbero incontrati, mentre la corriera, ancora un giocattolino bianco e blu, sarebbe presto entrata in paese dove c’era Qu ESta LI bE rtà 41 qualcuno che l’aspettava senza sapere quando sarebbe arrivata. Pronostici facili per chi vive su un colle, e dall’alto può legare le parti in un tutto, un po’ meno scontati per chi vive laggiù, dentro le cose. al vedere, insomma, si aggiungeva il prevedere. E vedere e prevedere insieme concorrevano a tornire una medesima sensazione, fatta di calma e abbandono, alla quale non ero capace di trovare il nome che ho imparato a darle più tardi: contemplazione. un atteggiamento, comunque, sbilanciato dal fatto che l’altura di cui ti sto scrivendo si alza stretta dai monti, tanto che, ovunque mi voltassi, li avevo ad altezza d’occhi, e quelle pareti magre, segnate dai solchi, erano il retro della mia fantasia, dentro cui premevano altri mondi e cieli più grandi del cielo piccolo, fatto per il mondo piccolo dentro il quale vivevo, e dove stavo, sì, su una sedia, ma la sedia stava in fondo a un pozzo. In più, il desiderio di valicare – il piede pronto al viaggio – veniva acceso da un secondo aspetto: il colle è forato da una galleria ferroviaria e, specie d’autunno, nelle giornate umide sull’imbrunire, quando la valle faceva da cassa di risonanza, i treni diretti al Nord si annunciavano da lontano, con il suono cavo del metallo sul metallo, per poi 42 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo passare letteralmente sotto ai miei piedi. allora, venivo preso da un’eccitazione che mordeva l’inguine e correvo nel punto sotto il quale sarebbe sbucato il convoglio, ne contavo una a una le carrozze che sfilavano con le finestre illuminate e una a una sparivano dietro la svolta erbosa, i fanalini rossi dell’ultima rimasti nell’aria bruna, come un istante sospeso di concitazione. avrei voluto afferrare la coda di quella scia di finestre illuminate, per farmi portare lontano, dentro le battaglie del mondo, ma sempre tornavo a casa con la eco del treno dispersa in testa e un fremere sconosciuto che, ancora una volta, non aveva un nome e si chiamava passione. Così posso dirti che sono cresciuto strattonato tra contemplazione e passione e ho portato in me due persone separate e distinte che hanno faticato a lungo prima di riconoscersi e riconciliarsi, una astratta come un’icona bizantina, l’altra corrusca come un lavoro del Caravaggio. Ciò che faceva imbestialire di più mia madre, dopo le sbucciature e i lividi che mi procuravo nel salire sugli alberi vicini o nel correre a vedere i treni passare, era quando tornavo a casa con i pantaloni sporchi del verde dei prati: erano le macchie più difficili da mandare via, un lavoro aggiuntivo per Qu ESta LI bE rtà 43 lei, che faceva ancora il bucato a mano, con asse di legno, mastello e un grosso sapone giallastro che non accarezzava le narici come i detersivi cui siamo abituati oggi. Del boom economico degli anni Sessanta che, stando a quanto mostravano le pubblicità, aveva illuminato di facce sorridenti gran parte d’Italia, noi avevamo avvertito appena un sussurro, e Chiusaforte era stata investita soltanto da qualche spruzzo della grande mareggiata. uno degli spruzzi fu la lavatrice, entrata trionfalmente in casa durante l’estate del ’75, lo stesso anno in cui potemmo disporre di un vero bagno; prima per i panni c’era l’olio di gomito di mia madre, il bagno era una latrina vicino all’orto e mio fratello e io venivamo lavati nello stesso mastello del bucato, accanto alla stufa, tra strilli, sapone negli occhi, orecchie stropicciate, e ruvide strigliate ai capelli e alla schiena. anche su di me la lavatrice ebbe una ricaduta positiva: da quel momento in poi l’attenzione di mia madre per lo stato dei miei pantaloni cominciò impercettibilmente ad allentarsi e io potevo rientrare a casa, se non tranquillo, con il cuore un po’ meno pesante. Era il segno di un cambiamento e si raddensava nelle escandescenze sempre più attenuate di mia madre quando mi squadrava i panta- 44 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo loni imbrattati; ma ancora per qualche tempo quel mondo sarebbe rimasto piccolo e fermo, fondato sull’economia delle cose e dei gesti. E lo spreco, prima che una maldestra gestione delle risorse, assumeva la dimensione di una condanna etica, universalmente considerato uno sfregio alla fatica che c’era dietro ogni cosa necessaria a vivere. La fatica tangibile, dico, quella dei muscoli tesi, dei passi pesanti che cercano l’equilibrio sotto il carico, delle facce deformate dalle smorfie il giorno in cui c’è da portare una lavatrice in cima a un colle, collegato al borgo solo da sentieri e da una lunghissima prospettiva di scalini. Quel giorno lo ricordo distintamente: mio padre, dopo settimane che ne parlava, era riuscito a ottenere una Zoppas nuova fiammante pagabile a rate dal titolare del ferramenta, che però non si sarebbe mai sognato di trasportare la lavatrice lassù, in mezzo ai boschi. Così fu stabilito che, anche in ragione della comodità delle rate, la parte relativa al trasporto avrebbe dovuto accollarsela il cliente. Il punto è che il ferramenta era uno stambugio che stava nel borgo ai piedi del colle: bisognava affrontare una rampa ripida che si inoltrava fra le ultime case prima della cima, lì la rampa si ammorbidiva in un breve corso pianeggiante per poi, lasciate le case quasi alle spalle, Qu ESta LI bE rtà 45 riprendersi tutta intera la cattiveria di una salita ancora più ripida e lunga di prima. Papà e io scendemmo il colle una domenica di mezza estate, di buon mattino. ad aspettarci davanti al ferramenta c’erano il negoziante e un amico di mio padre che si era offerto per dargli una mano nel trasporto. Faceva già caldo, papà era in canottiera, infilati nella cintola portava i guanti da lavoro. I tre armeggiarono un bel po’ per sistemare la lavatrice su un carretto, poi la portarono nel punto esatto dove cominciava la salita. Lì vicino c’era un piccolo terrazzamento delimitato da un muro a secco che arrivava ad altezza vita: mio padre si sistemò sotto, mentre il negoziante e l’amico issarono la lavatrice sul modesto terrazzo e l’adagiarono sulla schiena di papà, provvedendo anche ad arrangiare una sommaria imbracatura di corde. Poi si cominciò a salire, mio padre con il carico, il suo amico dietro, che lo aiutava a reggere la parte posteriore della Zoppas e a dare equilibrio alla marcia, io che trotterellavo ora davanti ora dietro e che costituivo un sicuro impaccio alla salita. Credo che papà fosse già stanco al termine della prima rampa, la testa china, vedeva soltanto le sue scarpe, penso si concentrasse sui passi da fare. un passo in più era un passo in meno all’arrivo, sulla sella delle spalle 46 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo si vedevano i segni rossi marcati dalle corde. Quando arrivò a metà della seconda rampa vacillava, ma ormai era più facile continuare a portare il peso che deporlo. Fece diverse soste, con il suo amico dietro che provava ad assestargli meglio il carico, mentre io ero sul punto di frignare, spaventato dalla fatica, da quella cosa seria e austera che sono i passi contati. Poi, nel solo rumore del ghiaino sotto i piedi, arrivammo in vista della casa, mia madre e mia nonna si fecero incontro e aiutarono a sistemare la lavatrice nel praticello davanti all’ingresso; e mio padre, congestionato e rosso come il bargiglio di un gallo, con quella specie di golgota ormai alle spalle, mostrò un sorriso pieno di pudore come a dire “ma guarda un po’ cosa ho dovuto fare”. Eravamo tutti allegri, tutti stretti intorno alla lavatrice e nessuno di noi si accorse che quel parallelepipedo bianco con un oblò in mezzo, liscio e brillante sotto il sole nel verde brillante del prato, era un’apparizione innaturale quanto il monolite del film di Kubrick. La troppa luce spogliava ogni cosa della sua verità, quella mezza mattina d’estate; la fatica di mio padre si era dissolta nella calma pulviscolare che ci vestiva tutti, ne restava solo un grumo acido in fondo al mio stomaco, una coda dello spavento di Qu ESta LI bE rtà 47 quando l’avevo visto traballare sotto il peso quasi senza reazione. La grande casa sembrava sul punto di prendere il volo sospesa sul ciglio dell’altura, investita dalla luce, nell’aria, forata da parte a parte dal cantare degli uccelli, che la guarniva tutta e la rendeva leggera e massiccia insieme, come un veliero pronto per salpare. Invece era una casa pensata per restare, concepita nel lavoro del bisnonno e del prozio materni, e ogni pietra dei suoi muri trovava il suo giusto peso e il suo posto nel significato della parola “fatica”. E soltanto oggi posso dirlo con qualche serenità, la stessa parola era la fune che univa quel padre e quel figlio di metà anni Settanta e un padre e un figlio che edificavano insieme durante i primi respiri del secolo. La casa saliva lentamente dalla terra al cielo sul ciglio dell’altura e sul ciglio della grande guerra, e il suo salire non era fermato dalla neve, non era fermato dalla pioggia, non era fermato dal caldo. Il padre si chiamava Pietro e veramente nel nome era contenuto un destino: duro e silenzioso come un cuore impenetrato, possedeva il segreto della pietra. Era il migliore scalpellino della valle e aveva messo insieme centesimo dopo centesimo un piccolo gruzzolo lavorando in ungheria e romania. 48 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo Il figlio si chiamava umberto, veniva ricordato ancora come il ragazzo che cantava quando lavorava e, in un mondo fatto di sorrisi guasti, alcuni ne ricordavano anche la bella dentatura che si apriva in allegria nelle feste di paese. Poi, un giorno, la Storia venne a prenderlo, nella forma del postino con la chiamata alle armi, e lui lasciò il canto e il lavoro a mezzo, per andare sul fronte dell’Isonzo. un buon muratore vestito da soldato, che come tanti avrà tinto di rosso i muri con la scritta w La CLaSSE DEL ’97 e sarà sceso dal colle con un sorriso inappropriato alla guerra. Quando morì di tifo e broncopolmonite in qualche ospedale da campo nel 1918, il crescere della casa – che non era stato fermato dalla neve, non era stato fermato dalla pioggia, non era stato fermato dal caldo – parve scomporsi e arrestarsi, perché la morte dell’unico figlio maschio aveva scavato un grande buco di buio nella taciturna durezza di Pietro. Le due figlie e la moglie si spellarono le mani con la calcina e i sassi, presero la loro razione di pioggia e di vento al posto del figlio, cercarono di schiarire il buio del padre, finché il tetto toccò il cielo, la casa fu completata e l’accasciata ostinazione di Pietro nello sbarrare il passo alla vita si ammorbidì in rassegnazione. Così la casa, il cui compimento non era Qu ESta LI bE rtà 49 stato accompagnato dai sorrisi, attraversò una nuova guerra e nuovi lutti, e adesso era lì, con la lavatrice ai suoi piedi, l’aia con le bestie da cortile che si affacciava sulla valle, il suo grande solaio, la stalla con le due mucche, i pochi campi bitorzoluti e magri stretti lungo il pendio, l’ombra delle montagne alle spalle e, soprattutto, le fondamenta nella mia memoria di oggi. Quella casa è stata il luogo da dove si è irradiata la mia alba, tre anni di ricordi in tutto, tre anni di solitudine e libertà. Lì, d’inverno, aspettavo il ritorno di mio padre. Lavorava ad arnoldstein come scaricatore, tornava la sera sotto una cerata verde, spesso bagnata dalla pioggia, ma né pioggia né fatica cancellavano il suo sorriso quando mio fratello e io gli correvamo incontro abbracciandogli le gambe nella penombra del corridoio. Nei suoi pantaloni di velluto a coste si fermava l’odore del lavoro, limatura di ferro, grasso di camion, legno, catrame. Da quella casa, durante le prime giornate di febbraio, mia madre mi portava con sé nelle sue passeggiate verso un torrentello poco lontano, percorrevamo un sentiero bordeggiato da abeti sgrondanti profumo e neve, l’aria fredda e secca pungeva le guance. arrivavamo in un punto dove il torrente formava un’ansa minuta e la poca acqua nel ghiaccio scendeva in un 50 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo terrazzo naturale coperto di muschio, dove i bucaneve brillavano nell’ombra, un candore che veniva colto dalla mano di mia madre. Il tempo che ci vuole era il tempo che muoveva i nostri muscoli, le nostre gambe e il nostro sguardo; d’estate veniva il tempo giusto per inoltrarmi nel bosco con mio padre, infilavamo un tratturo che tagliava in mezzo ai roveti dove c’erano le fragole selvatiche e poi, mano a mano che si saliva, l’erba del sentiero lasciava il posto alle pietre. Io seguivo i passi e il respiro di papà, ne vedevo la schiena ampia, la roncola fissata alla cintura che batteva il ritmo del passo da montagna sulla sua coscia. E salire era il modo di mio padre per stare con me, nel lavoro, nel tocco dell’ascia quando aggrediva il tronco, nel silenzio del ritorno, quando i nostri capelli portavano l’odore di resina in casa. allora, dopo ogni ritorno in pienezza, avresti detto che l’alba di me si sarebbe irradiata su quei prati per sempre e che per sempre quei prati avrebbero scandito il ritmo dei miei passi di bambino. Ma il tempo del tempo che ci vuole stava per avere una fine: ancora per poco la nonna avrebbe curato le bestie, ancora per poco sarei salito in solaio nei giorni più caldi dell’estate, a dormire nel fieno, ancora per poco mio padre nel bosco mi avrebbe offerto le corniole, rosse, lisce, Qu ESta LI bE rtà 51 simili a bacche e asprissime in bocca e dissetanti, ancora per poco. Non c’è niente di più ampio dell’immaginazione dei bambini: è un cosmo che fa zampillare dal suo nero lo splendore delle stelle. Il 6 maggio 1976 alle 21.02, con il primo boato del terremoto, la fantasia di tutti i bambini friulani si riunì e si espanse come una dolente, gigantesca bolla per accogliere entro i suoi confini una nuova regione, la regione di un terrore primordiale da animali spaventati. Il presente immutabile venne scagliato in bocca a un futuro buio, privo di dimensione. Il secondo boato sollevò il solaio della grande casa che era nata con la guerra e le tegole lasciarono il tetto come uno stormo di uccelli terrorizzati, il canto di un mondo si sgretolò e versò il contenuto della sua ferita in forma di pietre macinate sul prato dov’era apparsa per la prima volta la lavatrice e dove aveva avuto compimento la fatica di mio padre. Noi trovammo rifugio nella notte dei crolli, mentre il boato si alzava come un pinnacolo stretto fra montagna e montagna. Irrompeva dentro i nostri corpi facendoli esplodere di terrore. gli alberi vicini scomparvero nella polvere, poi, nell’opalescenza tagliata dalle frane che non avremmo saputo dire 52 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo né da dove venissero né se si sarebbero fermate, il boato divenne un ruggito e il ruggito si ritrasse nella notte da dove era venuto lasciandoci nel buio, stretti in un prato in pendio, nella minaccia dello stesso suolo che prima di allora era stato misurato come se fosse la sola cosa salda, il solo baricentro delle nostre esistenze. Il mattino dopo, tutto apparve chiaro. Il tetto era crollato sul solaio, lo zigzagare di crepe ampie anche mezzo metro stringeva le pareti come un’edera maligna, un angolo di muro dalla parte dell’aia si era abbattuto sull’orto. Perfino io capii che non c’era rimedio, non avevo ancora nove anni quando accadde. Papà entrò in casa, la porta era saltata via dai cardini, ne uscì con poche cose, qualche coperta, del cibo, delle uova, pane, vino. Scendemmo il colle dalla parte più selvaggia, quella rivolta verso l’uscita della galleria, per evitare il borgo pericolante. Eravamo sei persone in tutto: mia madre davanti, con mio fratello piccolo in braccio, accanto a lei la zia, dietro mio padre sorreggeva la nonna, che non avevo mai visto così disarmata. Le tremava il mento, non saprei dire se per il pianto o la tensione, il suo corpo era una cosa incerta e scura che si appoggiava tutta alla saldezza insidiata di papà. Qu ESta LI bE rtà 53 Mi voltai più volte scendendo, e a poco a poco vidi scomparire la grande casa che non era stata fermata da due guerre. Contro il cielo che si metteva al brutto, sembrava il relitto disalberato di una nave. una casa e la forma di un vivere morirono così, in circa sessanta secondi, insieme alla mia certezza che stare in cima a un colle mi avrebbe preservato dalle battaglie del mondo: ero stato smentito una prima volta – anche se allora non lo sapevo – quando la storia aveva raggiunto umberto, obbligandolo a scendere sorridente gli stessi sentieri per i quali saliva con il suo peso di pietre, mentre questa volta si era incaricata la natura di trovarci e scrollarci da lassù. Da allora in poi non ho più vissuto su un’altura e sono stato costretto a capire prima che a comprendere; e se per caso mi è capitato di trovarmi in un posto alto, il morso di una pace perduta ha sempre raggiunto e toccato il mallo vivo del mio silenzio. La memoria è un panorama di colonne e capitelli spezzati, caro b., e noi ci aggiriamo in quei luoghi sulla pista di noi stessi, con la disposizione di archeologi che rimettano ordine tra quelle pietre, ricostruiscano laddove ci siano lacune, soffino la vita a una durata e a una profondità smarrite. ai bambini che hanno riunito la forza della loro immaginazione per contenere il terrore del terre- 54 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo moto durante quella sera del ’76, si è aperta dentro una faglia di precarietà, e credo che la mia ossessione per la scrittura muova dal buio di quella faglia e dal tentativo, patetico quanto ostinato, di riavvicinarne i lembi. Sono bastate un po’ di fotografie, un paio di vedute panoramiche e sono tornato dentro il tempo del tempo che ci vuole; ho tenuto alte le mura ben oltre il mio proposito iniziale di due tre orette da consegnarti in forma di lettera. È sera ormai, e non so quanto queste righe le abbia scritte per me o per te, in fondo poi non importa nemmeno. Diciamo che sono state scritte per me e per te e che via via sono cresciute facendo affiorare un colle e una casa dal buio di una faglia, spingendone un po’ più lontano la loro impermanenza, diciamo questo. tra poco smetterò l’abito da cerimonia, siglerò sulla busta il destinatario che, a questo punto, potrei benissimo essere io, riaccenderò il cellulare trovandolo di sicuro ingombro di chiamate senza risposta. Qualcuno ha appena versato con fragore nel cassonetto in fondo alla via un carico di bottiglie vuote, sento un cane abbaiare in lontananza, tutto è fermo, tutto potrebbe mutare. ogni sguardo è moltitudine Nevica. I fiocchi scendono pesanti. È neve che non attacca, questa. Scende veloce e fonde subito sulla strada. I rami dell’acero di fronte gocciolano come se piovesse, ai piedi del tronco le foglie sono una poltiglia marrone. Stanco per il suo stesso peso, il cielo si appoggia sui tetti delle case, tra poco la neve diventerà pioggia. L’infermiere è appena andato via, passa da me due volte alla settimana, alle otto precise. Ho bisogno di lui per sbrigare una delle più elementari necessità fisiologiche. Quando va bene mi lascia verso le nove, con la pressione bassa, un fischio dentro le orecchie, la testa pesante, l’acido che sale dallo stomaco e mette in bocca un sapore metallico che comincia ad attenuarsi soltanto a mezza mattina. alla spossatezza generale oggi si aggiunge la stanza in ombra, nel silenzio accendo la luce, che illumina il quadratino di tavolo dove mangio scrivo e studio. anche la luce sembra liquida, si riflette sulle coste dei libri, sulla maniglia d’ottone della porta, 56 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo sulle impronte nericce e bagnate che l’infermiere ha lasciato sopra le piastrelle chiare del pavimento. a tratti entra in casa il rumore delle macchine che dividono in scie l’umido della strada oltre la siepe. “Come giona nella balena” mi dico, quando scosto la tenda della portafinestra; come essere agglutinati dentro qualcosa di organico e sieroso, una consistenza molliccia che parte dal grigio biancastro che sovrasta i tetti, sgronda dal nero dei rami, tocca con il suo soffio freddo la camicia appiccicata alla schiena e trova il suo punto di concentrazione nel dolore che appare dietro i cavi orbitali e si affaccia alla nuca e al collo. In giornate che si presentano così in salita è meglio assecondare il ristagno delle forze, addensarsi intorno al nucleo delle azioni quotidiane e non dare per scontato nulla: ti prepari un caffè e stai attento a non sporcare il lavello mentre carichi la moka, fai leva su tutta la tua concentrazione nel lavare la tazzina e nel riporla asciutta e, quando torni dalla cucina al tavolino dove lavori, cominci con il mettere un argine al disordine partendo dalla boscaglia della posta che si è impadronita del tavolo in settimane di disattenzione. Ci vuole un passo liturgico, però: bisogna attribuire a ogni proprio gesto la forza simbolica del gesto appropriato; pen- Qu ESta LI bE rtà 57 sare, e dopo sentire, che da quella sequenza di azioni dipende il tuo contributo all’ordine del mondo. L’ala della colomba che a ogni battito riduce di un grano la montagna. Così cominci a separare le poche lettere preziose dal cumulo di inviti scaduti, leggi uno a uno questi ultimi prima di gettarli, quasi fosse una tardiva forma di risarcimento per non averli letti prima. Mentre la superficie del tavolo inizia a liberarsi, rivolgi la tua attenzione ai libri: ce ne sono di ogni formato, alcuni stanno impilati in maniera incoerente sulle sedie, con i più piccoli che reggono i più grandi, altri sono addossati alla stampante, molti sono dimenticati sul margine del tavolo che dà verso la porta e formano una specie di trincea e, di questi, più di uno è ancora chiuso nella sua busta gialla e sembra sul punto di cadere, sistemato com’è su scivolose cartelle di plastica e ritagli di quotidiani. allora afferri un capo del filo di arianna che ti porta a cercare per primi i libri che, mosso da chissà cosa, hai sfilato dagli scaffali. Per ognuno c’è un momento di attenzione mentre lo rigiri fra le mani, ad alcuni sfiori la copertina o il dorso con i polpastrelli e poi, quando sei sicuro di averli radunati tutti, cerchi di orientare le tue cure alla biblioteca, per scovare gli spazi ancora liberi nelle scaffalatu- 58 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo re. E c’è da dire che il posto lo trovi sempre e sempre c’è un’esitazione quando li riponi, un congedo che si trattiene, venato di imbarazzo, di chi non sa se e quando rivedrà un volto conosciuto. I volti nuovi, invece, ti aspettano sul tavolo: sono i libri-saluto, come li chiami tu, e ognuno di questi rimanda alla data e al luogo in cui ne hai incontrato l’autore e un’affinità è diventata una salda amicizia. Sono libri dedicati, i più preziosi, quelli degli amici e dei compagni di strada che hai accumulato in vent’anni di scrittura. Liberarli dal disordine assume un significato augurale perché saranno le navi pronte al varo: li sistemerai sul comodino per le letture serali, e accorderai loro il momento più gratuito della giornata, quando ti metterai a letto, nel riposo del corpo affaticato, il silenzio aperto come una corolla intorno a te. È da un po’ che ti aggiri per le stanze, sistemare i libri-saluto è stato facile, erano la pattuglia più esigua della folla che ancora ti aspetta, adesso è la volta di quotidiani e riviste, per i primi non ci vuole molta cura, in pochi minuti fai un fascio che finisce direttamente in uno scatolone; le seconde devi separarle per genere ed editore. È un’operazione che esegui compìto, come quando da bambino disegnavi le cornicette per separare il pensierino dall’esercizio Qu ESta LI bE rtà 59 di bella scrittura, la mano attenta a tracciare motivi floreali o geometrici nel rispetto il più possibile rigoroso della simmetria. alla fine, il tuo puntiglio di scolaretto sembra avere la meglio sul disordine. La superficie del tavolo, ormai, appare quasi completamente sgombra, rimangono le carte che ritieni indispensabili, mentre qua e là affiorano gli ultimi libri, stanno lì, davanti a te, alcuni sulle sedie, in ordine sparso come nuvole sfibrate di un cielo azzurro che ha appena visto la tempesta. Non sono i libri che hai scelto di sfilare dagli scaffali, non sono i libri dei tuoi compagni di strada, non sono nemmeno libri di autori noti, appartengono al rigoglioso sottobosco dell’editoria a pagamento o a microscopiche case editrici che ben raramente faranno sentire la loro voce dal fondo della grande foresta. allora, nel momento in cui il tuo interesse si appunta su titoli e grafiche improbabili, ti senti quasi sollevato, perché stai per fare qualcosa di compiuto, qualcosa che ha un inizio e una fine, una cosa solida, puntiforme, che non sfugge fra le dita come il fumo di una giornata cominciata nello spleen e che ha costretto più volte la tua volontà ad arenarsi nelle sue anse paludose. L’ala della colomba sta per ridurre di un grano la montagna. 60 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo I libri degli scriventi. o dei dilettanti. Ne ricevo, più o meno, una dozzina al mese, quindi, se per un paio di mesi ho lasciato tavolo e sedie in abbandono, vuol dire che ne avrò più di una ventina da considerare e, quando lo faccio, i miei sentimenti sono contesi da irritazione e tenerezza. L’irritazione viene prima, necessaria e inevitabile, mi afferra ogni volta che leggo spropositi o spaventose ingenuità che d’istinto vorrei correggere con la matita blu. Ma dopo un po’, tutti quei tentativi falliti, tutte quelle parole fuori bersaglio, tutti quei libri destinati a sfiorire nell’istante stesso in cui vengono scritti mi soffiano dentro una nota di tenerezza che abbraccia a un tempo sia me stesso sia l’autore sconosciuto che sto leggendo in quel preciso momento. Quando si legge, un mondo viene trapiantato in noi e noi veniamo trapiantati in quel mondo: è l’incantesimo di una scrittura riuscita, senza il quale, a rigore, un libro non è un libro. Eppure, dietro il fallimento, dietro questi non-libri, rimane la potenza del gesto di chi li ha scritti; uomini e donne che, come me, magari avranno impiegato anni per mettere insieme cinquanta poesie, che avranno mobilitato l’intero ventaglio delle proprie risorse – non importa quanto inadeguate – nel tentativo di Qu ESta LI bE rtà 61 consegnare al mondo l’incantesimo della scrittura riuscita. E anche se l’incantesimo non è riuscito e resta soltanto la caduta, quella caduta è contemplata e include me. È un fatto indispensabile perché è un fatto umano e il giorno in cui l’uomo cesserà di comprendere per via di parola se stesso e il mondo, sarà ricondotto alla sua sostanza bruta di animale, padrone soltanto dei suoi grugniti che taglieranno il vuoto risonante del suo stesso silenzio. Sfilare la parola appropriata dal grugnito e, nel farlo, liberarsi dalla bestia, anzi, no: raggiungere un ordine di consapevolezza dove la bestia è contemplata è un tentativo, forse il più nostro, che ci intaglia e ci distingue dal tumulto del nostro stesso sfondo brutale, tutti uniti, così, lungo un vettore diretto a forare la luce, la ragazzina che scrive il suo diario adolescente come lo scrittore davanti alla sua pagina. È il riconoscimento di quello sforzo imponente, prodotto dal suolo della foresta, mosso da narcisismo e disperazione, da vanità o da una sincera tensione espressiva, fatto di fruscii e soprassalti che induce ogni volta a raccogliere questi libriccini e a impilarli davanti a me, nello spazio ormai libero sul tavolo. tanto più acuto sarà lo spleen al quale voglio sottrarmi, tanto maggiore sarà l’attenzione che dedicherò a ognuno di essi perché ognuno è un’eco del grande 62 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo brusio, rappresenta lo spazio dove mettere ordine, il luogo in cui la possibilità di prendermi cura di me diventa concreta nel prendermi cura di quelle pagine ingenue. La neve è diventata pioggia, il mal di testa si va sciogliendo, rimane ancora il bruciore delle congiuntive e un senso di oppressione sotto le palpebre. I libri sono davanti a me, così ordinati formano una torre di babele domestica, che punta verso il soffitto. In genere, di ogni raccolta leggo un campione sostanzioso di poesie cerchiando con una matita le parole che non vanno e sottolineando qualche espressione efficace. oggi il libro in cima alla pila è una plaquette di poche pagine, sulla copertina beige, inclusa da una cornice, è raffigurata una “fanciulla” di profilo, in una “veste” stretta in vita da un “morbido cinto”, i capelli sono lunghi lisci e sottili e una ghirlanda le decora la fronte, il palmo della mano destra, sollevato all’altezza del viso, regge un uccelletto che attende il bacio zuccherino della “fanciulla”, già protesa nello slancio. Non è un bel disegno, si vede subito; è il disegno di uno che pensa che i bei disegni siano fatti così e io so in anticipo cosa dovrò aspettarmi appena voltata la copertina. E, infatti, la matita comincia subito a lavorare, cerchio con diligenza le parole e le espressioni che non Qu ESta LI bE rtà 63 mi piacciono, con un gesto di modestia e superbia insieme. In questi casi non mi è difficile scovarle, tutti questi libri sono legati da un riverbero suscitato da un corredo di parole che, in definitiva, si ripete più o meno identico: “rugiada”, “incedere”, “alfine”, “viandante”, “cristallo” (accoppiata di solito a “sogno” o “silenzio”), “arcobaleno”, “infinito”, “aquilone” e via così, secondo una norma soggetta a poche variazioni. Il punto è che sono parole cieche e senza carne, non gettano nessuno sguardo sulla realtà, perché da tempo ne hanno persa la presa; con le porte e le finestre sbarrate, nemmeno arsenio Lupin sarebbe capace di scassinarne le serrature per far circolare un po’ d’aria al loro interno. Di tutte, è la parola “viandante” che mi indispettisce di più: l’immagine che ne ho è quella di un ragazzetto lieto, con le guance di mela, i pantaloni di fustagno rattoppati, il bastone e la saccoccia. Credo che, così come mi si è configurata, l’immagine del viandante risalga a un mio ricordo remoto. Sono sicuro di averla vista stampata sul coperchio di una scatola di latta, il cui contenuto mi sfugge; potrebbero essere stati biscotti, o il grasso animale che mio padre usava quasi ogni sera per mantenere in ordine e flessibili i suoi scarponi da lavoro. In ogni caso, se 64 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo il viandante ha gremito le poesie dell’età romantica, diventando a poco a poco un plausibile luogo comune, in tempi in cui l’imperatore di Francia spingeva le sue armate a piedi alla conquista della grande russia, vederlo oggi, con le sue guancette rosse, il bastone e la saccoccia, misurare i suoi passi sull’asfalto, insidiato dalle utilitarie e disorientato dalle rotatorie, mi pare una prospettiva del tutto irreale. Così come in tex willer la pioggia è sempre “battente”, il riposo “ristoratore”, la bistecca “alta tre dita” e il pasto “frugale”, in poesie come queste il respiro è “tremante”, si corre “a perdifiato”, i sogni sono “sgualciti” o “infranti” quando si piange la perdita di un amato, mentre l’amore soffia su tutte le pagine un “alito d’infinito”. La differenza – sostanziale – è che dopo una cavalcata di giorni nel deserto del Nevada, sulle tracce di pericolosi banditi, dopo tutti i pasti frugali consumati alla luce fioca dei bivacchi notturni, dopo averli trovati, i banditi, affrontati e sgominati, una bistecca alta tre dita è sacrosanta. E il lettore di tex l’aspetta quanto il ranger come il segnale liberatorio della fine della storia, coccolato da un processo di lettura seriale. Ma il concetto di luogo comune non è applicabile quando si scrivono versi: perché la poesia è il luogo dell’inatteso, del lapsus, del- Qu ESta LI bE rtà 65 lo sguardo che concepisce il mondo con la coda dell’occhio e crea un ordine di esperienza nel momento stesso in cui l’esperienza dà forma alla poesia. Nei testi dei dilettanti, invece, lo sguardo rovescia la poesia nel suo contrario, diventa il luogo dove tutto è già stato visto, anche ciò che è ancora da vedere. Il risultato è un’innocenza che rimane al di qua dell’innocenza. Non esiste altro lessico se non il tuo, in poesia; e quel lessico deve accordarsi con lo sguardo tuo proprio, deve intrecciarsi alla relazione che il tuo sguardo stabilisce con i tuoi sensi e che i tuoi sensi stabiliscono con il mondo, finché il lessico stesso, le parole stesse, diventano relazione. un intreccio da cui una forma di verità molto parziale, la tua, si sviluppa e cresce con il tuo respiro. Si tratta di una precisione di linguaggio ineffabile e intraducibile, perché ha a che fare con te stesso e con il rapporto che tu solo, in quel momento, intrattieni con il mondo; una precisione mossa da criteri non verificabili, che molto spesso lancia le sue parole dentro la tua coscienza sfocata, come se fossero una manciata di sonde spinte nel buio dello spazio alla ricerca di pianeti sconosciuti. Ho cominciato a usare le parole con precisione in terza media, all’età di tredici anni, e sto ancora 66 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo imparando. L’occasione me l’ha fornita la più improbabile delle insegnanti per chi, come me, aveva delle inclinazioni letterarie: la professoressa di matematica e scienze rosa agolzer. Durante la primavera del 1980, il muro di berlino era ancora ben saldo e sembrava dovesse rimanere lì per sempre come la muraglia cinese, cadevano e si riformavano i governi Cossiga, di lì a nemmeno un anno ronald reagan sarebbe divenuto il quarantesimo presidente degli Stati uniti e ventiquattro o venticinque ragazzini spartiti in tre colonne doppie di banchi formavano la classe IIIa delle Scuole medie arturo Zardini di Pontebba. Il ragazzetto imbambolato e riccioluto in quarta fila accanto alla finestra e dietro al banco della più bella della classe ero io. La cattedra era abbastanza lontana perché io potessi ogni tanto divagare con lo sguardo fuori dai vetri: se nevicava, mi facevo ipnotizzare dal lento scendere dei fiocchi senza peso, il lungo bacio della neve mi portava via nel braccio tiepido del mio fantasticare, finché un tono di voce più alto dell’insegnante, o un bisbiglio del mio compagno di banco, mi riportava in aula. ritrovavo le file dei compagni davanti a me, la professoressa che, camminando adagio nello spazio tra la cattedra e la lavagna, spiegava la lezione e, in fondo, la Qu ESta LI bE rtà 67 parete con la carta fisica dell’Italia e quella politica dell’Europa, con la grande macchia di verde dell’unione Sovietica. Non era un verde astratto, quello, era un verde corpulento, che pesava sul confine con la Jugoslavia a pochi chilometri da Pontebba. Era un verde che trovava il suo riflesso nei cartelli gialli con su scritto ZoNa MILItarE, LIMItE INVaLICabILE; era un verde che si respirava quando ci passavano accanto le autocolonne appena uscite dalla caserma per le esercitazioni, in un grattare di marce e uno sbuffare di fumi di scarico. Era un verde che aveva la faccia annoiata delle guardie di confine, che tintinnava nell’urto dei sottogola con gli elmetti, che sussurrava quando qualche valligiano diceva che sui monti c’erano importanti stazioni radio americane, che aveva l’odore di grasso delle macchine e la diffidenza dei carabinieri. Era un verde tutto sommato confortante e consueto: di là loro, di qua noi, secondo una legge che pareva immutabile e concreta. Pontebba in quegli anni era un centro piuttosto importante: collocata nel punto in cui il Canal del Ferro comincia ad allargarsi, era cresciuta prospera proprio perché a ridosso del confine, anzi: fino allo scoppio del primo conflitto mondiale, dal confine era stata tagliata a metà. una parte austriaca e l’al- 68 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo tra parte italiana. Le due caserme di alpini, la caserma della guardia di finanza, quella dei carabinieri, un teatro, una banca e le sedi delle ditte di spedizione le conferivano un tocco cittadino e un fervore sconosciuti alla piccola Chiusaforte, che stava a Pontebba come Cenerentola sta a una principessa. Il movimento era già intenso al mattino, quando noi chiusani arrivavamo in piazza con un rabberciato scuolabus giallo. appena scesi, si veniva investiti dai rumori più frequenti nella vallata: quello degli autotreni diretti a nord, quello del metallo sul metallo, quando i ceppi dei freni d’acciaio mordevano le ruote delle locomotive, quello degli scossoni dei convogli quando venivano smistati allo scalo ferroviario. L’impressione era di stare dentro una forma di vita in transito, nelle arterie dei rapporti fra nazioni, in uno scorrere denso, congestionato dalla neve sporca ai lati delle strade e dal confine. La scuola stava su un’altura che dominava la stazione e per arrivarci bisognava fare una salita e attraversare un ponte sopra la ferrovia, dove d’inverno si veniva raggiunti dall’odore di catrame bagnato delle traversine e dalle zaffate dei piccoli locomotori diesel che smistavano i vagoni poco oltre. Lo stesso tratto di strada che facevamo a piedi noi ragazzini veniva percorso, ugualmente a Qu ESta LI bE rtà 69 piedi, dalla professoressa agolzer; solo che lei, al contrario di noi, pareva non venire irretita né dai rumori né dagli odori sviluppati da tutta quella concitazione: estranea e assorta, aveva in sé qualcosa della lontananza delle poiane che, naso all’insù, qualche volta ammiravo nei loro pigri giri che sfioravano le montagne. a dire il vero, in tre anni di medie, l’avevo vista arrivare a piedi solo in rare circostanze, probabilmente precedeva i ragazzini per evitarne il vociare e la confusione. E la maggior parte delle volte, al suono della campanella, la si trovava già in piedi sulla soglia della sala insegnanti, i registri e i libri stretti in un braccio, la borsetta nera nell’altro. Come la targa di bronzo che commemorava arturo Zardini, la professoressa agolzer sembrava far parte dei muri della scuola. Dotata di un senso del dovere scolpito nel granito, era l’istituzione pacifica e autorevole a cui si deve un taciturno rispetto; ma che è impensabile coinvolgere in una qualsiasi forma di dialogo, essendo, un’idea simile, grottesca quanto quella di parlare a un monumento equestre. Quando entrava in aula, portava con sé il silenzio: alta, con il cappotto grigio, i capelli ancora neri ben ravviati, gli occhialini rettangolari da astigmatica sotto i quali brillava l’azzurro cristallino e sa- 70 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo turo del suo sguardo, l’accompagnava un’eleganza severa e naturale, più congeniale a qualche istituto privato svizzero che a una scuola pubblica – e per giunta di paese – quale era e sarebbe sempre rimasta l’arturo Zardini di Pontebba. togliersi il cappotto, sistemare libri e registri ben ordinati sulla parte destra della cattedra, i guantini di camoscio sulla parte sinistra, e procedere all’appello era la sequenza di azioni controllate che aprivano il sipario sulla lezione, durante la quale la professoressa badava a esporre l’argomento prescelto con lentezza, chiarendo l’ombra di ogni concetto e assicurandosi che nessuno, nemmeno i più tardi, potesse dire di non avere capito. Erano lezioni chiare e accattivanti dove, ogni tanto, il granito nel quale era scolpita la sua coscienza veniva intaccato da una tenue ironia, che rivelava il tratto più morbido della sua persona e faceva alzare in aula i brevi sussurri della classe: uno stormire di foglioline mosse dalla brezza d’aprile che lei ricambiava con un fugace sorriso. Esigente con se stessa quanto lo era con noi, ci interrogava uno alla volta – naturalmente a sorpresa – setacciando la nostra preparazione per una buona mezz’ora. Quando qualcuno diceva delle bestialità, sgranava i suoi occhi azzurri in faccia al malcapita- Qu ESta LI bE rtà 71 to, poi li rivolgeva, sempre sgranati, alla classe intera, infine reclinava il capo, scuotendolo con sconfortata gravità, nello stesso momento in cui piegava le labbra all’ingiù più mortificata di noi, mortificati dalla sua mortificazione. Le interrogazioni più micidiali, tuttavia, erano quelle condotte al posto perché prevedevano, oltre a una buona preparazione, anche un certo uso della logica e qualche attitudine linguistica. In quei casi, dopo aver detto «chiudete il libro, oggi facciamo lavorare il cervello» provocando istantanei brusii allarmati, passava in mezzo ai banchi con imparzialità olimpica. tagliava il silenzio con i suoi passi finché si fermava al banco dello sfortunato cui toccava l’interrogazione. Il giorno di primavera in cui ebbi un poco più chiaro che cosa significa usare le parole con precisione, fu proprio in occasione di una di quelle interrogazioni insidiose. La mezza mattina era luminosa e la malasorte si posò in fretta sulla testa arruffata di Piero, a due banchi dal mio. «Che cos’è un parassita?» gli chiese la professoressa agolzer, formulando la domanda quasi come fosse rivolta a se stessa piuttosto che a lui. «un parassita è un essere vivente che vive alle spalle di altri esseri viventi» rispose Piero con una 72 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo certa sicurezza, sollevato dal fatto che gli fosse toccata una domanda così semplice. «allora Mauro, che in questo momento vive alle tue spalle, è un parassita. E Fabrizio, che vive alle spalle di Mauro, è il parassita di Mauro. Mentre laggiù Elena, che è l’ultima della fila e alle spalle ha solo la parete e il cartellone del corpo umano, non è afflitta da alcuna forma di parassitismo, giusto?» Silenzio. Piero si girò, contemplando sconfortato il viso pienotto e inespressivo di Elena e il cartello del corpo umano. La sua sicurezza si stava rapidamente trasformando in inquietudine, la definizione che aveva prodotto giaceva a pezzi nel fondo della sua mente confusa, sgretolata da una frase di un’evidenza cristallina. «un parassita è...» «...» «un parassita è...» «...» a questo punto il silenzio si fece solido e l’inquietudine di Piero divenne la disperazione del naufrago. Si era girato più volte verso di me, la faccia rossa, le orecchie arroventate, incontrando una mia generica espressione di solidarietà, ma niente che potesse somigliare al salvagente di un suggeri- Qu ESta LI bE rtà 73 mento. anzi, dopo un paio di sguardi avevo chinato la testa sul libro, mantenendo i miei occhi fissi sul banco, determinato a ignorare il naufragio che stava avvenendo a pochi metri da me. Non che fossi pavido, passavo i compiti ogni volta che potevo, ed era già un’impresa quando la professoressa agolzer, cui non sfuggiva quasi niente, se ne stava rintanata in cattedra. Figurarsi adesso, con il suo sguardo prensile così vicino. Sarebbe stato un suicidio e suicidio fu. La terza volta che la domanda echeggiò nel vuoto, sollevai lo sguardo trovando lo sguardo di Piero e provai ad abbozzare un suggerimento, finendo immediatamente arpionato dalla professoressa. «bene, Pierluigi, dato che la tua voglia di dire che cos’è un parassita sembra così incontenibile (incontenibile? A me pareva di essere stato più prudente di una guida sioux...) regala il tuo sapere ai compagni.» «un parassita è un essere vivente che vive a spese di un altro essere vivente» azzardai, con una voce tremolante quanto la grafia di un centenario. La professoressa agolzer sgranò gli occhi, ma si trattenne dallo sgranarli sull’intera classe; per un momento, venni investito da tutto il gelo del suo sguardo, poi le sue labbra sembrarono sorridere. «La tua definizione di parassita è meno disastrosa di 74 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo quella del tuo compagno, ma resta comunque una definizione barbara, manchevole di molti elementi. Diciamo che ti ha salvato quel “a spese” che hai buttato lì nella frase, non so quanto consapevolmente, ma diciamo anche che resta una definizione molto lontana dall’oggetto che stiamo trattando» disse pressappoco così, già rivolgendosi alla classe. Poi ricominciò: «Intanto bisogna partire dall’origine della parola, e questo né Piero né Pierluigi potevano saperlo: parassita viene dal greco, e precisamente da parásitos, che vuol dire commensale, qualcuno che sta vicino al cibo, insomma. E già da qui dovreste capire che, se c’è una mensa, ci deve essere anche un ospite, perché un commensale senza un ospite non è più un commensale, non è più un parásitos, giusto?». Nel dire questo suscitò l’attenzione della classe, ventiquattro o venticinque faccine stavano sospese nel silenzio. «Ma un parassita» proseguì «è un commensale molto particolare. È uno scroccone, uno di quelli che si infilano, non invitati, nelle feste e mangia a sbafo, più che può. Di più: se è lì alla festa, gli invitati, quelli veri, pensano che sia un invitato anche lui, dal momento che è l’ospite colui che regola le relazioni fra le persone. Perché molte persone non si conoscono fra loro ma tutte si riconoscono nel Qu ESta LI bE rtà 75 fatto che sono state invitate a quella festa e non a un’altra, da quell’ospite e non da un altro. E allora che succede? Che gli invitati lasciano fare allo scroccone quello che gli pare: mangiare, ballare, bere fino alla sazietà.» La professoressa agolzer si fermò e le ventiquattro o venticinque faccine si fermarono con lei. riprese il discorso tornando in cattedra: era il segnale che, per quel giorno, non ci sarebbero state altre interrogazioni dal posto. «Con questa storiella abbiamo messo insieme quasi tutti i mattoni utili per dare una buona definizione di parassita: c’è un ospite, c’è un commensale ma è un commensale scroccone, c’è una mensa o una festa, scegliete la parola che preferite, ci sono gli invitati e c’è il concetto di relazione o rapporto – anche in questo caso fate come sopra – e, soprattutto, invitati, ospite e commensale hanno una cosa in comune: nascono, si nutrono, crescono, si riproducono e muoiono. Sono degli esseri viventi, insomma; o, meglio, sono degli organismi viventi. Siamo noi, ed è il più piccolo dei batteri. Quindi proviamo a darla questa definizione: un parassita è un organismo o un’entità biologica che vive a spese...» e qui ebbi l’impressione che guardasse solo me con l’azzurro dei suoi occhi «di un 76 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo organismo di specie diversa che si chiama ospite, utilizzandolo come una nicchia ecologica e affidandogli in parte o in tutto il compito di regolare i rapporti con l’ambiente esterno. Ecco. Questa è una definizione accettabile di parassita. Che cosa abbiamo imparato dal nostro parásitos, oggi? Che le parole sono pesanti e ognuna di esse ha una storia, che alcune stanno legate fra loro in rapporti di parentela e che, quindi, vanno aperte come fossero delle noci. E come nelle noci si trova il gheriglio, allo stesso modo, una volta aperte, dentro le parole troviamo il concetto. E il concetto serve a orizzontarci con sicurezza dentro il nostro stesso pensare il mondo, non vi pare?» Qui, invece, fu Piero a guardarmi, mostrando la faccia di chi non aveva capito nulla. «L’abbiamo accertato proprio adesso: il concetto di parassita non avrebbe alcun senso se non esistesse il concetto di ospite. Le scienze fanno questo: aprono, indagano, verificano e constatano, sia che si tratti di una parola sia che si tratti di stabilire qual è l’attrito di una sfera su un piano inclinato. Diversamente, facciamo poesia.» La professoressa agolzer chiuse la sua arringa sulla parola “poesia”, e si capiva che a quest’ultima riservava una posizione ancillare rispetto alle “scienze”, come le chiamava lei, reputandola forse più Qu ESta LI bE rtà 77 adatta alle consolazioni di pensionati o vecchie zie, che a una seria contesa nei campi del sapere. rimasi per tutto il resto della lezione ingarbugliato tra parola e concetto, di cui non coglievo che superficialmente le differenze, però, cosa inaudita, sentivo che la professoressa non aveva tutte le ragioni. Certo, le parole bisogna conoscerle, le parole sono pesanti, bisogna studiarne l’origine, di questo ero convinto, ma mi pareva lo facessero anche i grandi scrittori, e che lo facessero bene, per giunta. avevo la testa piena di eroi, allora; l’anno prima la professoressa d’italiano ci aveva letto in aula la Chanson de Roland in originale, lasciando la classe immersa in un silenzio attonito; non avevo capito nulla della lettura, ma il ricordo di quell’incantesimo respira in me tuttora. Quelle parole scritte novecento anni prima che io nascessi avevano trovato un corpo, il mio, nel quale erano esplose con la potenza di una formula magica. Credo che la professoressa, leggendoci la Chanson così, all’improvviso, tracciando giusto i lineamenti essenziali della vicenda, volesse suggerirci qualcosa di elementare: che le parole sono belle di per sé stesse e che una composizione fatta in armonia ne esalta ancora di più la bellezza. Credo anche 78 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo che volesse dirci come la possibilità di coglierla, quella bellezza, esista in noi già da bambini, quando rotoliamo in bocca le parole buffe o quelle che ci piacciono, ripetendole fino a consumarle come caramelle. Si tratta di una possibilità che solo la poesia può risvegliare. Io quella possibilità ho cominciato a coglierla allora: la professoressa andò avanti per il resto dell’anno leggendoci numerosi brani dell’epos, da omero ad ariosto e io, sorpreso ogni volta, non sapevo come fare per raccontarla, quella sorpresa, sapevo solo che volevo trattenerla il più a lungo possibile dentro la mia fantasia. Così disegnai. Ho disegnato la parola “Nestore” e ne è uscita la figura di Nestore sul carro di guerra ai margini del campo di battaglia sotto le mura di troia. Ho disegnato la parola “Ettore” e ne è uscita la figura di Ettore a guardia alzata, la lancia dietro lo scudo, in attesa dell’assalto di achille. Ho disegnato la parola “aiace” e ne è uscita la figura massiccia di aiace, stretta tra le prore delle navi achee e l’attacco dei guerrieri troiani. Ho cominciato così, disegnando i nomi propri e, in qualche modo, continuo a disegnare tuttora, solo che adesso disegno la mia voce sui fogli e la voce trascina con sé qualcosa di mio. Qu ESta LI bE rtà 79 Non avrei saputo che cosa replicare alla professoressa agolzer, né lei avrebbe ammesso repliche, durante quella luminosa mattina d’aprile. Ma oggi qualcosa sarei in grado di dirle: e le direi che aveva ragione nell’esortarci a usare le parole con proprietà e precisione, ma che le parole non si possono ridurre a concetti né piegare ai loro significati, perché il concetto è un recinto astratto, funziona come le teche nei musei. Qui, adesso sta piovendo: è una pioggia pesante, che sento saltellare sulla lamiera delle grondaie, che batte sulla distesa di foglie morte ai piedi dell’acero e ogni goccia ha il suo timbro, a seconda di com’è disposta la foglia che colpisce. È una pioggia che batte dove prima era scesa la neve, è una pioggia che sembra trascinare a terra tutto il cupo malumore del cielo, durante una mattina in cui è passato l’infermiere quando ancora nevicava, lasciandomi solo nella stanza, alle prese con un disordine interiore e un disordine esteriore. Vogliamo metterla dentro una teca, questa pioggia? Possiamo farlo, potremmo definirla. “Perché piove?” chiederebbe soprapensiero la professoressa agolzer, dando inizio a una delle sue letali interrogazioni dal posto e cominciando per gradi a spiegarci il ciclo dell’acqua. 80 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo Potremmo sistemare in bacheca la pioggia di quando è passato l’infermiere ma allora, separata e chiusa dentro confini di metallo e plexiglass, non sarebbe più la pioggia che ho visto. Liofilizzata nella sua astrazione, diventerebbe solo la pioggia delle piogge, un puro segno intellettuale. E c’è un’altra cosa di cui non teneva conto la professoressa: che le parole sono materia, una materia molto strana, composta da suono e da silenzio, due sostanze che non sono riconducibili a nessuna tavola periodica degli elementi, ma che costituiscono la colonna vertebrale di ogni pensiero. Suono e silenzio. E bisognerebbe saperlo auscultare con cura il silenzio vivo che le parole sono capaci di sprigionare perché, quando va bene, è lo stesso silenzio che precede la nascita, lo stesso che segue ogni morte. È lo stesso silenzio che declina un’altra forma di conoscenza di cui, nel suo ottimismo positivista, la professoressa agolzer era all’oscuro: una conoscenza che non prescinde dall’istinto e dall’empatia, che lascia le farfalle libere nel cielo, e non si sogna nemmeno di sistemarle nelle teche, ognuna con il suo cartellino esplicativo. Infine, le direi che c’è un altro modo di usare le parole con precisione, è un modo che dà una forma tangibile all’indeterminatezza Qu ESta LI bE rtà 81 dei sentimenti e li radica, nero su bianco, nelle pagine dei libri. Verso la fine dell’anno scolastico, la professoressa di italiano ci tenne una serie di lezioni sulla Prima guerra mondiale. Con passione mediterranea, ci sottolineò più volte il fatto che per tre anni il piccolo Friuli era stato uno dei perni della tragedia europea. al termine di una delle lezioni, ben conoscendo lo slancio con cui avevo letto i brani dei poemi che via via ci andava proponendo, mi avvicinò. Nell’allungarmi una sdrucita edizione tascabile «tieni» mi disse, «dentro questo libro ci sono molte cose che riconoscerai.» Era Addio alle armi di Hemingway. aprii il libro tornando a casa, sull’affollato scuolabus giallo, in mezzo agli strilli degli altri ragazzini, agli urti delle cartelle di chi scendeva alla sua fermata, nel primo caldo veramente primaverile che filtrava dai finestrini. Cominciai lì e proseguii ogni volta che potevo per un’intera settimana e, mano a mano che la lettura procedeva, riconoscevo i miei luoghi. La desolazione delle pietre era la stessa che vedevo io; la pioggia cattiva che sferza le colonne in ritirata durante la disfatta di Caporetto e chiude in un rintocco funebre il romanzo era la stessa pioggia cattiva che il 82 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo cielo friulano scaricava sulla mia testa, dopo che le montagne raccoglievano tutte le nuvole salite dal mare. La tristezza dei ruderi bagnati era la stessa che vedevo ogniqualvolta passavo accanto alle case sventrate dal terremoto e non ancora ricostruite. I maccheroni scotti erano gli stessi che anch’io avevo mangiato in piatti di plastica durante l’emergenza, quando le cucine militari da campo lavoravano a ritmo serrato per sfamare i terremotati. Ma la cosa più impressionante furono i soldati: a un certo punto, Hemingway descrive i fanti di una compagnia in avvicinamento alla prima linea che marciano in fila indiana lungo i bordi di una strada. Ne coglie la fatica, le facce rosse e congestionate sotto gli elmetti troppo grandi, le uniformi che cadono male sui corpi piegati dallo sforzo e, soprattutto, coglie il loro disorientamento di ragazzini. Campo Ceclis stava proprio di fronte alla caserma Zucchi, quindi per noi bambini era la cosa più normale vedere i soldati armati di tutto punto marciare in fila indiana lungo i bordi delle strade, per raggiungere le montagne intorno, e io li avevo sempre considerati come uomini adulti, anche un po’ in soggezione per via del fucile che portavano in spalla e del tintinnio degli elmetti. Qu ESta LI bE rtà 83 Era un caldo e accecante pomeriggio di giugno quando incrociai una compagnia di alpini di ritorno da un’esercitazione: i soldati marciavano in fila indiana, lungo il bordo della strada come ogni volta, ma la cosa nuova era che io avevo terminato la lettura di Addio alle armi. Vidi le facce rosse e congestionate, gli elmetti troppo grandi, le uniformi sformate dei soldati che marciavano nel romanzo e, per la prima volta, li riconobbi per quello che erano: ragazzini, poco più grandi di me. rimasi impalato nel sole per un po’ a guardare la mia ombra sull’asfalto, finché il rumore dei passi pesanti si allontanò. Non ne ero consapevole, ma quel giorno al mio sguardo si era aggiunto lo sguardo di Hemingway. Da allora non ho più smesso di leggere e Hemingway, nei miei occhi, non è più solo, perché se è vero che ogni sguardo porta in sé gli sguardi di chi ha amato, lo sguardo di chi legge è moltitudine. Qui piove ancora, anzi, la pioggia si è fatta cattiva, a ogni ventata picchia più forte sui vetri delle finestre, è la pioggia di Addio alle armi, la riconosco. Io nel frattempo ho portato a termine il mio compito, ho letto i libri degli anonimi e mi sento più in 84 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo ordine. Sono tante le parole che ho cerchiato: giacciono inerti e fuori bersaglio ai piedi degli oggetti che intendevano esprimere, come le foglie morte ai piedi dell’acero. Non scriverò a nessuno degli autori, perché è più facile dare le belle notizie che le brutte. In più dovrei motivare punto per punto a ognuno di loro le ragioni di un fallimento, scrivere un breve saggio per ogni libro letto, il che francamente non è possibile. Ma se lo facessi, ogni lettera si aprirebbe con l’invito ad allontanarsi dai luoghi comuni per cercare le parole appropriate che altro non sono, in poesia, se non le tue. ognuno di noi ha il suo porto sepolto dentro di sé: quando io sprofondo nel mio, le prime parole che mi vengono incontro sono quelle della mia infanzia sul colle e sono la parola “ombra”, la parola “acqua”, la parola “pietra”, la parola “muschio”, la parola “nuvola”, la parola “fatica”, la parola “silenzio”. Con le parole, pian piano affiorano i luoghi e i volti e mi viene incontro mia madre, che mi prende per mano e mi porta a cogliere i bucaneve lungo le rive gelate del torrente a febbraio. E allora, in quel momento, mia madre, io, il candore dei bucaneve su letto di muschio e l’acqua sulle pietre levigate, siamo di nuovo uniti e rinnovati, Qu ESta LI bE rtà 85 custoditi dal silenzio, la parola che preferisco. E anche se so che il silenzio si declina in molte forme, quello che io amo è la cripta d’amore che custodisce e rinnova, dove si scende piano piano, con deferenza, a piedi scalzi. tutto il mondo al di là delle montagne «Venite, siori e siore, venite pure: questo è il forziere senza fondo, questa è la lampada delle meraviglie, questa è la porta del tempo. Per un soldino potete vedere Pasteur col microscopio, viaggiare con Charles Darwin scoprendo specie sconosciute, addormentarvi con Isacco Newton sotto il melo oppure, se non è la scienza il laccio che vi porta sulle nuvole, contemplate la rancorosa onestà di Cincinnato, fate un giro nelle cupe stanze di Enrico VIII o mordete il cielo e, con l’occhio dell’aquila, sorvolate i campi di battaglia. Da Canne ad adrianopoli, da austerlitz a waterloo, passando per l’ira del feroce Saladino e l’assedio di bisanzio. I progressi della tecnica? Non c’è macchina sbuffante, non c’è congegno cigolante, invenzione scintillante che qui non sia contenuta. Per non dire della varietà di insetti e di animali: tutto conteggiato, tutto archiviato, tutto separato per genere e per specie, dai cieli alle profondità marine, dai deserti di sabbia a quelli di ghiaccio, dalle steppe desolate alle foreste 88 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo tropicali, che nemmeno Noè sull’arca fece un lavoro così fino. Scegliete a vostro piacimento, a vostro ghiribizzo e poi lanciate una manciata di stelle nella notte della vostra fantasia. Venite, siore e siori, fatevi coraggio, tutto questo ve lo offro in cambio di un soldino.» Non indossava la marsina né il papillon né il cilindro logorato, non indossava i pantaloni a scacchi, il venditore porta a porta di enciclopedie. Dietro la tenda non aveva nessuna donna barbuta da svelare eppure i suoi modi erano quelli dell’imbonitore da baraccone, anche se meno fantasiosi e più inciviliti. Era un pomeriggio inoltrato di autunno, un sabato di sicuro, perché in cucina, a dare man forte a mia madre per la contrattazione, ricordo anche mio padre. Io avevo appena cominciato la terza elementare e vivevo sul colle. Penso che il venditore si fosse spinto fin lassù, non facendosi scoraggiare dalla lunga teoria di gradini, con la forza della disperazione. Chiusaforte in quegli anni non era un buon posto per i libri. a casa nostra, per esempio, l’unico era il Vangelo di mia nonna: letto, riletto e consumato per l’uso, lo conservo ancora. In alto a destra, sulla copertina nera, c’è l’incavo del suo pollice artritico. Si può immaginare Qu ESta LI bE rtà 89 la nutrita serie di insuccessi e di bestemmie contro cui andò a sbattere il povero venditore, finché qualcuno giù al borgo, per toglierselo in fretta dai piedi, gli riferì che in cima al colle c’era un bambino molto vivace e dell’età giusta: divorava tutti i giornalini che gli capitavano a tiro e qualcuno lo aveva visto anche sfogliare il giornale, un giorno che suo padre l’aveva portato con sé in osteria. Provasse lassù, il venditore, magari avrebbe avuto fortuna. In effetti, a sette anni leggevo già molto bene. Non con la cantilena, come fanno di solito i bambini, e nemmeno veloce, come fanno quelli più bravi per dimostrare la propria bravura, saltando punti, virgole e due punti, nemmeno la lettura fosse un concorso ippico. Leggevo con metodo, senza intoppi, certo, ma rispettando le pause e tentando di mettere nella pagina un po’ di espressione. Ero il pupillo della maestra per questo. una mattina dell’estate appena trascorsa ero sceso al borgo, dove avevo un amico che passava lì le vacanze. appena giunto in vista della casa, un’anziana mi fermò dicendomi che sua figlia aveva per me una “buona cosa”. obbedii volentieri perché, di solito, le “buone cose” della signora erano un pugno di succosissime caramelle rossana con la crema dentro, che io centellinavo lungo tutto l’arco 90 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo della giornata. Percorsi l’ombroso corridoio ed entrai in soggiorno, dove l’anziana mi fece accomodare sul divano, lasciandomi lì dopo avermi detto di pazientare un po’: sua figlia stava finendo di rassettare le camere e sarebbe scesa presto. rimasi composto per qualche momento, guardandomi le punte dei sandali sporche di polvere, poi la mia attenzione venne catturata da un cesto di vimini dove erano ammucchiate riviste femminili e quotidiani. Lì in mezzo spuntava la copertina di “Famiglia Cristiana”. Del settimanale mi attraeva la rubrica dei fatti straordinari, una paginetta corredata da disegni didascalici ed enfatici, sul modello delle illustrazioni di beltrame ai tempi della “Domenica del Corriere”. un cane smarrito che percorre centinaia di chilometri e ritrova il suo padrone, un uomo che esce incolume da una caduta dal quinto piano, la storia di un salvataggio in alta montagna, il resoconto dell’immersione abissale di un batiscafo nella fossa delle Marianne erano soggetti che accendevano la fantasia di chiunque, figurarsi quella di un bambino cresciuto chiuso tra le rocce e premuto dall’istinto del viaggio. Non ci pensai due volte ad allungare la mano verso il cesto, sfilando la rivista dal mucchio. L’avevo già ben aperta sulle ginocchia quando riapparve in soggiorno l’anziana. Qu ESta LI bE rtà 91 «Che fai?» mi domandò un poco alterata. «Sai che non si toccano le cose quando si è in casa d’altri?» «Sì, lo so, mia mamma me lo dice che devo stare attento e composto, ma questo giornale mi piace tanto. C’è una pagina dove fanno un disegno per ogni storia raccontata e le storie sono belle sul serio, finiscono quasi sempre bene, mica come quelle che mi racconta mia nonna, di orchi e di streghe che vengono a prendermi se faccio il cattivo.» tentai di giustificarmi così, più o meno, ma la vecchia rimaneva in piedi accanto al tavolo, diffidente. La sbirciai da sotto in su, intimidito: aveva lo sguardo interrogativo, le labbra strette, dalle quali partiva una moltitudine di rughe verticali. Per provarle la verità di quanto dicevo, non trovai niente di meglio che leggerle una storia. Scelsi quella del cagnolino smarrito, fatta apposta per intenerire. Cominciai ad alta voce, sciolto, sicuro, nonostante la sua presenza mettesse ombra alla lettura. Quando terminai il trafiletto, incontrai i suoi occhi grigi, prima spalancati per la sorpresa e, un attimo dopo, contratti in un’espressione ostile. La vecchia era nata nell’ottocento, sapeva fare sì e no la sua firma e credo che mai nella vita si fosse spinta più in là di bologna, dove fu profuga con mia nonna al tempo della disfatta di Caporetto. 92 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo Nessuno dei bambini di cui aveva esperienza si sarebbe sognato di aprire un giornale, e meno che mai avrebbe letto in quel modo, nemmeno gli adulti che conosceva erano in grado di farlo. Dopo un momento di sospensione, nel quale penso che raccolse tutta la sua buona grazia presente e futura, per resistere alla tentazione di trascinarmi fuori di casa così com’ero, con giornale e tutto, spezzò il silenzio dicendomi che sua figlia aveva ancora molto da fare e mi accompagnò fuori, senza caramelle e senza tante cerimonie. Se non la mattina stessa, di sicuro quel giorno, l’anziana salì il colle per confabulare con mia nonna. Non aveva mai visto prima un bambino leggere con una simile disinvoltura, le riferì. Certo, il piccolo era sveglio, ma leggere così le sembrava poco naturale. In più, d’inverno stava sempre solo – per quel che vedeva – e non si sa mai quali tarli si annidano nelle teste dei bambini; non per dire, ma a lei pareva che non fosse tanto a posto. Magari – la buttò lì – sarebbe stato il caso di farlo parlare con il prete, giusto per togliersi un pensiero. Male non gli farebbe, tanto più che la domenica, quando lo si vede andare a messa, ha sempre il muso lungo. La nonna ascoltò con cortesia, in memoria dei giorni di Caporetto e per il fatto che le due erano Qu ESta LI bE rtà 93 anche lontane parenti, con altrettanta cortesia replicò che erano questioni da sottoporre alla madre del piccolo, cosa di cui si sarebbe occupata subito, garantì, congedando l’amica e tradendo, nella fretta con cui lo fece, un moto di impazienza. L’episodio venne raccontato per filo e per segno in casa, la sera, quando eravamo tutti a cena. Mio padre lo liquidò con una scrollata di spalle e una risata ma, da quel giorno, la voce che il figlio di toni sapeva leggere qualunque cosa si propagò nel borgo con la velocità di un incendio dentro un fienile. Era in virtù di quei mormorii che adesso il venditore porta a porta si trovava lì, in cucina, con il suo abito scuro, il polsino candido della camicia che spuntava dalla manica della giacca, i capelli puliti e pettinati e le mani ben curate. aveva disposto sul tavolo alcuni volumi, le cui copertine di colori diversi brillavano alla luce di sessanta candele come lacca cinese. Nel mostrare le caratteristiche dell’enciclopedia ne aprì uno e mi coinvolse nella spiegazione. arrampicato su una sedia e vicinissimo a quell’uomo, sentivo salire l’odore buono di stampa a ogni pagina voltata: mi pareva che dentro quei libri fosse contenuto tutto il mondo al di là delle montagne. Smagliante, scorreva illustrazione dopo 94 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo illustrazione e ristagnava intero nel desiderio dei miei occhi e nelle mani che non riuscivo a trattenere, accarezzando più volte le pagine a imitazione del venditore. L’uomo elogiò teatralmente la mia curiosità, dandomi un buffetto sulla guancia e spettinandomi i capelli. Era riuscito a stabilire una confidenza di facciata che aveva già conquistato mia madre, ma quando mio padre, che fin dall’inizio lo aveva squadrato con sospetto, si spinse a offrirgli «un dito di marsala», capii che si era aperta una breccia. Nella mia silenziosa felicità, vedevo già i volumi ben allineati in camera, tutti miei, ognuno brillante della sua copertina colorata. Dopo il marsala, si arrivò alla contrattazione, che fu lunga e laboriosa. Il mio sguardo andava dalla faccia mal rasata di mio padre a quella profumata di dopobarba del venditore, come assistendo a una partita di tennis dove in palio ci sarebbero stati i tredici magnifici volumi dell’enciclopedia. Quando venne stabilito un prezzo di partenza – qualche decina di migliaia di lire – mi sentii perduto. a me, che maneggiavo al massimo le monetine in alluminio da dieci lire allungate ogni tanto dalla nonna, parve una cifra da sultano. Invece, un po’ alla volta, le due parti si vennero incontro. Mio pa- Qu ESta LI bE rtà 95 dre firmò dei documenti con incertezza e scrupolo e, alla fine, il venditore se ne andò, portandosi via il suo brio di circostanza e lasciando, nella fioca luce della cucina, un bambino felice e due genitori nel dubbio di aver fatto un pessimo affare. Era l’anno della lavatrice, portata sull’altura a suon di muscoli tesi e bestemmie soffocate per risparmiare il fiato: già pesavano sul bilancio precario della famiglia quelle rate; e adesso si prospettava un nuovo carico da pagare nei mesi, lira dopo lira. tuttavia, l’ombra che disturbava la coscienza dei miei genitori per aver fatto il passo più lungo della gamba venne dissipata quando il venditore tornò il sabato successivo per consegnare i volumi. Quella consegna ebbe il sapore di un varo: quasi nel suo significato letterale, perché mio padre rischiò di macchiare di vino una delle copertine fiammanti stappando una bottiglia con troppo entusiasmo. Era felice nella mia felicità, quel sabato; soddisfatto di avere potuto assecondare la mia inclinazione. gli occhi rapiti nella contentezza che mi cresceva dentro l’avevano portato lontano dalla fatica, dal freddo, dalle mani rovinate a forza di passare ganci d’acciaio nella neve, in mezzo ai vagoni da scaricare, alle bestemmie in tedesco. Io ci sono, avrà pensato, ho fatto qualcosa, il mio bambino è felice, 96 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo studierà, lo si capisce da quanto è contento. E non dovrà alzarsi alle cinque del mattino, non tornerà tardi la sera consumato, avrà le unghie pulite, dei vestiti a posto, un lavoro dove non ci si sporca perché mi sarò sporcato io. Io, per me e per mio figlio. In poco tempo l’enciclopedia diventò il mio solaio immaginario, mi bastava salire in camera dopo pranzo, sfilare uno dei volumi dalla scansia di legno che mio padre aveva preparato su misura, e dalle pagine aperte a caso sciamava il mondo. Così tante erano le cose da leggere e le illustrazioni da vedere che non mi servivo di alcun indice. Sceglievo il libro per il colore della copertina, mi sistemavo a letto a pancia in giù e affondavo, senza mediazioni, dentro la polpa del primo argomento che mi veniva incontro, con la libertà di un passero in giardino. L’odore di quella libertà sapeva di macchina, per via della stufa a nafta che scaldava la stanza, il suo colore era la luce del sole debole d’inverno sulle assi di legno del pavimento, il suo suono era il silenzio, il suo peso il peso di ogni volume sfilato dalla scansia e la sua forma era tutte le forme delle illustrazioni che accompagnavano la lettura. Il mio orizzonte di bambino, fino ad allora limitato dalle montagne, si allargò e comprese george Stephenson che mostrava a un pubblico incredulo la Qu ESta LI bE rtà 97 sua Rocket, la prima, vera, locomotiva al mondo. Il suo cielo si arricchì dell’ascesa del pallone dei fratelli Montgolfier, mettendomi davanti al fatto che l’aria calda è più leggera della fredda. Quindi si inoltrò a bordeggiare il taglio del Canale di Panama e, di scoperta in scoperta, alla fine venne inciso nel tanto più vasto orizzonte mostrato dall’enciclopedia. Se illustrare significa rendere qualcosa luminoso, durante quell’inverno sono stato un’illustrazione anch’io. anch’io una figura tra le altre fusa dentro i libri, partecipavo a chiarire con i colori della mia fantasia il bianco e nero delle parole, nello stesso momento in cui le parole chiarivano in me l’amore per la lettura. Le figure erano sempre didascaliche: un galeone prevedeva tanto mare, le vele gonfie e la luce del tramonto; un merlo era inconcepibile separato dal suo ramo, così come un re dalla sua corte e dalla sua cavalcatura. Però era proprio grazie a una simile astrazione che agivano con così tanta forza. Ci pensava la mia testa di bambino ad alterarne le forme e a dare movimento alle scene, aggiungendo qualche dettaglio ogni giorno. Del resto, prima di Internet le immagini erano ancora preziose, venivano custodite con cura e custodivano il tempo. 98 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo Sono stati utili i disegni dell’enciclopedia, lettura dopo lettura, come briciole di Pollicino mi hanno condotto dentro il bosco delle storie. Ma la loro funzione non si è limitata a fare da corrimano ai testi: le immagini si sono cristallizzate nella memoria e hanno aiutato il formarsi dei miei primi preconcetti, senza i quali non si dà conoscenza. Perché la natura di un preconcetto è quella di nascere per essere smantellato. L’idea che avevo di Cortez, per esempio – un condottiero coraggioso senza ombre – oggi è molto diversa di quella di allora. Eppure, senza l’immagine di lui alla testa dei suoi soldati di ventura quando si addentra nella foresta, non ci sarebbe stata la delusione nello scoprire in seguito che il mio eroe era poco più di un criminale. avessi conosciuto la figura di Cortez subito per quella che era, avrei registrato il fatto in maniera neutra. Cortez è un criminale. Punto. Invece così, uscita dal bozzolo dell’illustrazione, la sua figura è stata accompagnata da un sentimento che ha conferito profondità alla metamorfosi dell’eroe in conquistatore disumano. a ripensarli oggi, i disegni dell’enciclopedia mi inteneriscono per quanto erano rudimentali. tratti incerti, posture imprecise, paesaggi e scenari ar- Qu ESta LI bE rtà 99 tificiosi che hanno scolpito l’arco di una serenità febbrile, inghiottita la primavera successiva dalla notte in cui tutto parve crollare. una serenità fragile quanto un nontiscordardimé ritrovato fra le pagine di un libro. Mi imbattei in illustrazioni molto più sofisticate due anni dopo, durante l’aprile del ’78. Frequentavo la quinta elementare e, come i miei compagni, avevo alle spalle la vita in tenda e l’esperienza dello sfollato. Il terremoto è una corriera dell’esercito che ti porta lontano dai tuoi posti finché tu vedi il mare. Furono le scosse del 15 settembre 1976 che, con due strattoni violenti, finirono di sradicarci dalla valle: il primo all’alba, il secondo alle 11.30. In quella mattinata ancora calda, non crollarono soltanto i muri, come durante la scossa del 6 maggio, crollò di colpo la resistenza interiore di tutti, e gli alpini che si aggiravano per le tendopoli con il megafono, indicando i punti di raccolta per l’evacuazione, sancivano di fatto una resa. In un pomeriggio solo, gran parte dell’alto Friuli si svuotò, restarono gli uomini validi, gli operai, come mio padre, che avevano un lavoro oltre frontiera e pochi altri coraggiosi. Donne, vecchi e bambini furono distribuiti lungo il litorale adriatico, e gli anziani vissero la seconda Caporetto della loro esi- 100 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo stenza. Noi piccoli, invece, quando tornammo nella valle, eravamo ormai inscritti dentro un nuovo concetto di normalità. Normale era aver avuto parenti morti nelle zone più colpite, normale era che molti genitori si ubriacassero, normale che alcuni di noi venissero picchiati, normale che si vivesse in baracche di legno gelide d’inverno e torride d’estate, che ci si arrampicasse sui tralicci dell’alta tensione, che si passassero pomeriggi interi al fiume incustoditi, che si trovasse uno spiazzo vuoto dove prima c’erano case, che la scuola, dentro cui avevamo trascorso tre anni sui dieci vissuti, fosse una scatola vuota con i buchi al posto delle finestre. E in questo scorrere normale delle cose, era ancora più normale che in noi fosse cresciuta una libertà esaltata e violenta. In prima linea, ad arginare la nostra frenesia, fu la maestra. rappresentava il legame con il mondo di prima, ci aveva tenuti in terza e ci ritrovò alla fine dell’anno scolastico successivo. Sfollata anche lei, sapeva bene quanto poco avessimo studiato nei mesi che seguirono l’evacuazione. Fece il possibile per restituirci un po’ di stabilità, anche se ogni cosa in paese diceva il contrario, a cominciare dalla scuola stessa, un prefabbricato ben al di fuori del centro, oltre il ponte che attraversa il fiume. Ci blandì e all’occorrenza ci punì, materna o autorevole a se- Qu ESta LI b Ertà 101 conda dei casi. Faticò non poco, credo, perché mettere un po’ di tranquillità nelle nostre teste accese era come versare acqua dentro secchi bucati. Fu in questo clima di ricostruzione morale e intellettuale, che la maestra incoraggiò alcuni di noi a partecipare a un concorso letterario rivolto alle scuole elementari della zona. La prova consisteva nella scrittura di un tema sull’esperienza del ritorno. La maestra ci accompagnò a scriverlo in sala insegnanti, perché potessimo concentrarci meglio. Era la sola cosa fuori dall’ordinario, per il resto il tema era un tema, solo che lo scrivemmo con l’odore di caffè che riempiva la stanza, lontani dagli scherzi degli altri bambini e sorvegliati con scrupolo da una bidella. tornammo in classe un paio d’ore dopo, ognuno con i suoi fogli protocollo riempiti di scrittura. Di un’onestà trasparente quanto l’acqua di montagna, la maestra non controllò nemmeno se avessimo fatto errori di ortografia. Imbustò tutto così com’era, scrisse l’indirizzo della banca che aveva organizzato il concorso e consegnò i plichi alla bidella. È difficile che un bambino si dimentichi certe cose, insuccessi e riuscite si incidono nella sua memoria ben separati e senza sfumature: così per me il giorno in cui la maestra entrò in aula, mi fece 102 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo alzare in piedi e annunciò alla classe che io, proprio io, avevo vinto uno dei premi, ha ancora oggi il sapore di un trionfo. Fu una scena da libro Cuore dove io ero Precossi, per fortuna con una buona dose di aggressività che mi metteva al riparo dalle canzonature dei compagni. La premiazione vera e propria avvenne qualche tempo dopo. Ci radunammo tutti nell’atrio della scuola. Dietro a un tavolo sistemato su un palco dove erano allineati i premi, sedevano un rappresentante della banca, un paio di sindaci, il direttore scolastico e alcuni ufficiali degli alpini. Dopo discorsi che mi parvero interminabili quanto le prediche domenicali del parroco, si fece avanti un uomo imponente con la fascia tricolore il quale ci definì «piccoli esuli», mescolò rinascita e didattica e, commosso, disse che eravamo il futuro del Friuli. anche se quel futuro aveva i capelli spettinati, i denti sporchi e indossava grembiuli sotto cui c’erano i maglioni infeltriti che le organizzazioni umanitarie avevano rovesciato a cataste in tutta la regione. Quando venni chiamato a ritirare il premio, la maestra, in prima fila, mi prese per mano e mi accompagnò verso il palco, rossa dall’emozione. Di una calma olimpica quando ci insegnava i ver- Qu ESta LI b Ertà 103 bi o le equivalenze, ora la vedevo impacciata almeno quanto me. Strinse le mani a sindaci e ufficiali trattenendo a stento l’orgoglio, che oggi mi pare più di madre che di maestra. Io, invece, ero frastornato dalla presenza di tutti quei grand’uomini con fasce tricolori, nastrini sulle uniformi, occhiali dalle montature d’acciaio e abiti che indosso agli adulti di Campo Ceclis si vedevano soltanto in occasione di matrimoni e ricorrenze. Mi venne consegnato un libretto di risparmio con su tremila lire e un libro, con l’aggiunta di un fastidioso pizzicotto sulla guancia. tornai al mio posto che mi scappava la pipì, e feci ogni sforzo per trattenerla durante il resto della cerimonia, seduto il più possibile in ordine, con libro e libretto sulle ginocchia e punte dei piedi rivolte verso l’interno. Più tardi, mentre mi avviavo da solo verso casa bordeggiando la statale ingombra di autotreni, mi fermai nella cunetta per dare un’occhiata al libro. Prima, un po’ per pudore, un po’ per il fastidio della pipì, un po’ per la confusione durante il buffet a base di pasticcini e aranciata, non avevo avuto l’occasione di farlo. Estrassi il libro e mi appoggiai al guard rail, il libretto di risparmio nel buio della cartella, dimenticato. Lo spostamento d’aria dei camion pesanti mi alzava il colletto del 104 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo grembiule, ne avvertivo lo schiaffo sul petto, sulle guance. Il volume si intitolava Guida agli aeroplani di tutto il mondo e copriva il periodo d’oro dell’aviazione, dalle sue origini pionieristiche alla fine del primo conflitto mondiale. Lo sfogliai e fu un batticuore a ogni pagina. uno dopo l’altro, apparivano i modelli delle macchine volanti che hanno fatto la storia dell’aeronautica. Di ognuno erano descritti sviluppo, evoluzione e impiego. tutti i testi erano accompagnati da un piccolo trittico, una tabella che riportava le caratteristiche tecniche, e un disegno. ancora una volta, mi vennero incontro per prime le immagini. I disegni erano lontani anni luce dalle incerte illustrazioni della mia enciclopedia. Precisi, accurati e dai colori saturi, riempirono i miei occhi e da lì non se ne andarono più. una precisione amplificata dal fatto che gli aerei erano raffigurati al di fuori del loro contesto naturale: il cielo e le nuvole o il campo di volo. Isolati da una cornice, campeggiavano su un fondo bianco e, dentro quell’astrazione ogni dettaglio, ogni rapporto tra struttura e struttura era come amplificato: i colori della macchina spiccavano smaglianti. I disegni e le livree di ogni singolo aeroplano si rincorrevano Qu ESta LI b Ertà 105 splendendo. Considerate tutte insieme, erano uno sciame di farfalle tropicali che aveva trovato posto lì, in quelle pagine aperte e battute dal primo sole di aprile. Non pensavo esistessero così tante forme capaci di aggredire l’aria, fu come entrare in una città dove tutto è sconosciuto, tutto è lontanissimo dal gramo degli orti in salita, dall’ombra gettata dalle rocce, dal cielo piccolo recintato dai monti e visto con la prospettiva di chi resta a fondo valle. Credo che le mie due passioni, per la lettura e per il volo, si intrecciarono quel giorno, sul margine della statale, sfiorate dagli autotreni e schiaffeggiate dagli spostamenti d’aria. Consumai il libro come mia nonna aveva consumato il suo Vangelo, e per lungo tempo considerai gli aerei come pura forma, pura superficie, separandoli dalla loro funzione. Perché il cuore di ogni amore è un cuore astratto. E quando quelle strutture di legno ricoperte di tela e tenute insieme da tiranti d’acciaio si riempirono delle storie dei cavalieri dell’aria, la miccia era già accesa da tempo e sfrigolava dritta verso la scelta che feci tre anni dopo. Non ci fu nessuna incertezza, una volta terminate le scuole dell’obbligo. La discussione con i miei genitori fu molto breve. Stu- 106 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo diare bisognava studiare, e il solo istituto tecnico industriale che avesse una sezione aeronautica era a udine, in città. Scegliemmo quello. La campanella della stazione è l’incandescenza di un ragazzino pronto a partire, è una promessa fatta nel buio. Salii sulla littorina all’alba di un giorno di settembre con i pochi altri studenti del paese. trovai posto e sistemai il mio borsone da viaggio. I contorni delle cose erano ancora ombre. a ridosso di udine, l’interno color verde acqua del vagone si illuminò di una luce dorata, il mondo inquadrato dal finestrino si consegnò allo sguardo come un frutto cui portavo in dote il desiderio. Nella testa i cavalieri dell’aria bucavano le nuvole ritagliati nella carta. Io appartenevo al cielo. Sangue e ossigeno 1983, 10 settembre, sabato La mattina è tersa. Dal campo di atletica si vedono le montagne senza peso, come se qualcuno di notte avesse sostituito alle pietre un’anima. C’è appena un po’ di vento, che passa sulle cosce e sulle spalle libere del ragazzo ma non smuove le bandierine della pista di salto in lungo. Più in là, recintato, c’è un campetto da calcio, da dove arrivano i tonfi sordi dei palloni di cuoio e le urla da caserma di un allenatore. Faceva ancora buio quando il ragazzo è uscito di casa. Per dormire un po’ di più e non svegliare il fratello, si è preparato la borsa la sera prima, infilandoci in fretta un paio di pantaloncini rossi, una canottiera da atletica azzurra, un paio di scarpette da tennis – basse, come le vuole l’allenatore – e tutto il necessario per una doccia. Quando ha finito, ha portato la borsa in cucina, dove è stato avvolto da un silenzio denso. 108 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo Il padre è adagiato sul divano e segue un telefilm poliziesco in bianco e nero alla tv, mentre la madre è al lavello di spalle, che asciuga le stoviglie della cena. La cucina è illuminata. Il ragazzo si è fatto strada nel silenzio ignorandolo per come ha potuto, ha sistemato la borsa vicino al divano e si è accomodato a tavola a cercare di seguire il telefilm con il padre; invece si sente inseguito dallo sguardo della madre, lo avverte sulla schiena e sul collo come un laccio che si stringe. Sua madre è sempre di malumore quando lo vede prepararsi per andare in città e questa volta lo è ancora di più, perché lunedì riapriranno le scuole, lui dovrà tornare in collegio e ricomincerà daccapo il lungo periodo di separazione. Per cui lei non vede il motivo, non lo vede proprio, di scendere in città di sabato, mentre avrebbero potuto rimanere ancora un po’ insieme. a cena c’è stata una discussione accesa, con recriminazioni aspre da entrambe le parti, cose tra genitori e figli, dove si ferisce e si è feriti senza pietà. «Parti con il treno delle sei?» si sente chiedere il ragazzo, e nel voltarsi trova sua madre in piedi, con lo strofinaccio in mano. «Sì» risponde, sapendo che quella prima domanda è il passo incerto di una distensione. Qu ESta LI b Ertà 109 «E quando torni?» «Penso che sarò a casa alle tre, se faccio in tempo a prendere il treno dell’una e mezza a udine» dice, ormai del tutto voltato verso la madre. «Dovrai mangiare qualcosa, no?» osserva lei e, nel farlo, passa davanti al marito, che si era tenuto estraneo alla discussione di prima e che ora sbuffa perché gli è stato interrotto il telefilm. «Mangerò qualcosa al bar della stazione» risponde il ragazzo, mentendo. La madre, ora, è davanti al mobile vicino alla tv, apre un cassetto, tira fuori un borsellino nero, ne estrae due banconote marroni da mille lire e una, più piccola e azzurrina, da cinquecento. «Con quali soldi? tieni questi, almeno così so che non giri in città come un barbone» sbotta, lasciando le tre banconote sul tavolo e aspettando una reazione del figlio. Il figlio raccoglie le banconote, le ripiega, le infila nel taschino del giubbotto appeso all’attaccapanni e ringrazia. «Vado a letto, domani mi alzo presto, cercherò di non svegliarvi, buonanotte.» Nel dirlo, e nell’entrare in camera chiudendo la porta dietro di sé, lascia madre e padre nel cerchio di luce della lampada, in un silenzio meno opprimente di prima. 110 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo Non è uno che indugia al caldo delle coperte: i led luminosi della radiosveglia segnano le 5.30 quando scende dal letto, si infila i jeans nel buio e, già lucido, raggiunge a tastoni la porta della camera, sfiorando il fratello che dorme un sonno di sasso. accosta piano la porta ed entra in bagno, la luce che ha appena acceso è talmente fioca che lascia gli angoli della stanza in ombra, nonostante lo spazio sia angusto. Si lava il torso sul lavandino, con l’acqua fredda, perché quella calda ci mette un’eternità ad arrivare. Quando solleva la testa per lavarsi la faccia, lo specchio rimanda l’immagine di un adolescente dalle spalle ampie, dai tratti regolari, con i capelli che gli scendono sulla fronte in folti riccioli scuri. Si piace e sa di piacere. un vantaggio non da poco durante l’adolescenza, un’età crudele dove basta avere una faccia tormentata dai brufoli per essere scaraventati senza appello ai margini del branco. tuttavia, al di là della superficie ben abbronzata e ben allenata del suo corpo, sente di avere un’incrinatura anche lui, la crepa nella porcellana che potrebbe farlo andare in pezzi: gli piace la poesia; e per i posti che frequenta – il collegio di secondo ordine dove abita in città, l’istituto tecnico industriale, il campo di atletica della scuola – leggere versi costituisce una colpa Qu ESta LI b Ertà 111 ancora più grave che avere una faccia piena di brufoli. Quest’anno frequenterà la sezione aeronautica dell’istituto, di gran lunga la più dura, l’ha voluto lui, ha cercato con tutte le sue forze di adattarsi all’ambiente. all’inizio l’impatto è stato violento, veniva da una scuola piccola, di paese, e si sentiva inadeguato alla città. Il primo giorno non sapeva nemmeno arrivare all’istituto, così si è accodato agli altri studenti senza chiedere niente a nessuno per non essere riconosciuto subito come una matricola. Quando è arrivato al centro studi, dove sono concentrate una buona parte delle scuole della città, ha tagliato una folla di ragazzi e ragazze che lo hanno lasciato smarrito e confuso: avrebbe voluto tornare a casa, avrebbe voluto tutta la libertà di piagnucolare come un bambino. In quella massa è un puntino perso e, mentre gli autobus e le corriere scaricano a decine altri studenti, prova invidia per quelli fra loro che si riconoscono e scherzano e mostrano di avere una dimestichezza con la confusione del posto che a lui è ancora sconosciuta. Dopo un po’ che percorre il viale, riesce a leggere il nome del suo istituto, è lì dove il gruppo degli studenti è più fitto. L’edificio gli pare enorme, se confrontato con la piccola scuola 112 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo di montagna dalla quale proviene. al termine della gradinata c’è una porta a vetri dove entrano studenti a flusso continuo; segue il flusso e si ritrova in un atrio abbastanza grande da contenere quattrocinquecento ragazzini, tutti matricole, come lui. In fondo all’atrio, pigiato dalla calca, si solleva sulle punte quel tanto che basta per scorgere un professore brizzolato su un palchetto; sembra uno importante, forse è il preside o il vicepreside, e tiene in mano un microfono con il quale snocciola cognomi e nomi e svariati appelli al silenzio per sovrastare il brusio che si alza dalla folla di adolescenti tesi, irrequieti e smarriti. Il ragazzo intuisce che si stanno formando le classi, cerca di riconoscere il suo nome, ma la voce del professore gli arriva a tratti, disturbata dal rumore continuo. aspetta per un bel po’, vede gruppi di studenti che si allontanano diretti alle aule. Piano piano l’atrio si svuota, finché rimangono lui e pochi altri ragazzini impacciati. Non ha sentito il suo nome. anche gli altri studenti rimasti hanno l’aria di non sapere bene che fare, così si aggrega a loro e tutti insieme chiedono a un bidello dove sia la segreteria. Il bidello li guarda senza mostrare alcuna sorpresa: ogni anno, il primo giorno, dopo il marasma, rimangono in atrio dei de- Qu ESta LI b Ertà 113 triti. Loro sono quei detriti, le briciole cadute fuori dal sacco, e tocca a lui raccoglierle e rimetterle a posto. Vengono accompagnati in un ufficio, dove una segretaria, scorbutica e scocciata per l’imprevisto, consulta una serie di scartafacci e indica a ognuno la sua sezione. Solo e umiliato, il ragazzo entra in aula quando la lezione è cominciata da una buona mezz’ora, viene accolto dalle ironie di un professore basso e tarchiato; da uno sguardo rapido alla lavagna, dove sono disegnati triangoli e bisettrici, capisce che si tratta dell’insegnante di matematica. Sarà la sua nemesi per quasi tutto l’anno scolastico. In aula c’è un solo posto libero: il banco davanti alla cattedra. Mentre si siede e dà un’occhiata ai compagni, si rende conto di essere vestito in un modo del tutto inadatto alle circostanze: calza un paio di scarpe eleganti e indossa dei pantaloni scuri, con la riga, una camicia ben stirata di un color celestino, come quelle dei ferrovieri, e una giacca in tono con i pantaloni. È un uomo in miniatura, un piccolo geometra, è l’idea che sua madre si è fatta di uno studente che dovrà frequentare le “scuole alte”, come le ha definite una volta, spettinandogli i capelli con la mano. Lui sa che quei vestiti sono i risparmi dei suoi genitori, sa 114 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo che sono la felicità della madre, la stessa di quando hanno fatto il viaggio in corriera per comprarli in un negozio di abbigliamento fuori paese. Sa che quei vestiti per lei sono quasi l’occasione di un’attribuzione di insegne al primo figlio istruito della famiglia e l’orgoglio che c’è in tutto questo. Eppure, quando si gira mostrando la sua faccia con i capelli corti, tagliati di fresco, e vede i suoi compagni vestiti con magliette, jeans, maglioni sformati e scarpe da tennis, sa anche che potrebbe diventare il bersaglio degli scherzi di una classe intera, così i vestiti cominciano a scottargli sulla pelle e non vede l’ora di sbarazzarsene. Il primo giorno di scuola è stato un disastro, completato dal ritorno in collegio dove, di nuovo in ritardo, ha mangiato un pessimo minestrone, già freddo e denso, in una mensa semivuota. Ma il ragazzo che ha appena finito di lavarsi, mentre i suoi stanno dormendo, e si è infilato la camicia sulla pelle ancora umida è molto diverso dal ragazzetto smarrito di due anni prima, che ha dovuto affrontare un quadrimestre terribile meditando più volte di ritirarsi e di tornare all’ordine rassicurante del suo paese. Meno incantato e più cinico, ha imparato l’arte del mimetismo, ha saputo fare come l’insetto stecco, indistinguibile dai rami sui Qu ESta LI b Ertà 115 quali si appoggia, e oggi è in tutto simile agli altri studenti: si è fatto crescere i capelli, indossa jeans stinti, non ha più la cartella, ma un tascapane color verde militare dove mette l’indispensabile, prende i treni con disinvoltura e, se capita, infierisce quanto gli altri sulle matricole più sprovvedute. Legge ancora versi, d’estate, in vacanza, ma anche d’inverno, quando porta con sé nella sala di studio del collegio i libri di testo, in mezzo ai quali occhieggia sempre qualche raccolta di poesie. La sua vita è così: divisa da una paratia d’acciaio – il mimetismo come strategia evolutiva – da una parte gli studi di fisica, gli studi intensi di matematica e lui come adolescente spigliato e conforme, dall’altra, in penombra, un ragazzo che legge Leopardi, baudelaire, rimbaud, capaci di cancellare il mondo che vive ogni giorno e di muovere in lui lo sconcerto di sentirsi come l’evaso di un penitenziario. oggi però, non appena esce di casa, e il fresco dell’alba gli entra negli occhi e pizzica le guance, i due ragazzi che porta con sé per un momento si vengono incontro e si abbracciano. La mole delle montagne è più buia del cielo, ma a est si affaccia una sottile linea bianca dalla consistenza calcarea che esalta i contorni delle cime scure, mentre il buio è forato dal canto degli uccelli che si leva da un bo- 116 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo schetto di acacie oltre l’argine del fiume. Gli uccelli sono sempre i primi / pensieri del mondo gli suggerisce la voce di un poeta che ha appena cominciato a leggere e, subito, mentre indugia sulla porta di casa, un’altra voce, la sua, affiora allacciata alla prima: «Se gli uccelli sono i primi pensieri del mondo, il colore di quei pensieri dev’essere senz’altro il colore dell’alba» si sente dire e, dentro l’alba, con le voci che lo accompagnano, si avvia in fretta verso la stazione. È una bella mattina per allenarsi, piena di luce. Quando è sceso dal treno, udine si è riappropriata di lui con il rumore; quello continuo delle macchine, i rari colpi di clacson, il grattare pesante degli autobus arancioni. gli piace la città ai primi di settembre, non c’è ancora quella concitazione dell’autunno lavorativo, la luce porta con sé un ricordo d’estate e, nello stesso tempo, le strade non sono vuote come ad agosto, dove ogni settimana sembra un’interminabile domenica. Lui si riappropria della città un momento dopo quando, sull’autobus, vede scorrere le facciate delle palazzine battute dal sole, mentre sotto sono ancora in ombra, e nel verde degli ippocastani comincia ad affacciarsi una prima idea di giallo. Né uomo né bambino, anche lui, come la città, è in un momento di passaggio, la sua alba ha ormai Qu ESta LI b Ertà 117 preso il colore del mattino, ma il suo corpo vibra di impazienza. È l’aereo che scalda il motore prima del decollo e trattiene il suo scalpito per poi scatenarlo e lanciarlo a mordere le nuvole. Più che una scuola, l’istituto che frequenta somiglia a un’industria, con il suo ampio corpo centrale in cemento armato e vetri e i capannoni con i tetti a forma di dente di sega, dove sono ospitati i laboratori e l’officina aeronautica, capace di contenere sette, otto aeroplani di generose dimensioni. La vista dell’edificio in due anni gli è diventata familiare, l’incombere di tutto quel cemento e quel vetro non lo spaventa più. anzi, oggi, nella luce tersa, il bianco della facciata del corpo centrale sembra specchiarsi nel cielo e gli restituisce l’impressione di una calma assorta, qualcosa di solido come le sue montagne e, al contempo, qualcosa di protettivo, dove basta assoggettarsi a un insieme di regole stringenti per togliersi di mezzo il fastidio di pensare per conto proprio. Il ragazzo entra in istituto dalla parte del parcheggio degli insegnanti, mentre il sole comincia a scaldare gli smalti delle automobili; mano a mano che si avvicina alla grande porta a vetri, affretta il passo, desideroso di rincontrare i suoi compagni di squadra, che non vede da giugno. Dopo aver salu- 118 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo tato un paio di bidelli annoiati, infila il dedalo di lunghi corridoi interni che lo condurranno verso le palestre. Non è ancora arrivato quando ritrova i suoi compagni ancora prima di vederli, viene raggiunto dal rumore di una serie di schiocchi sordi, da tonfi, da risate impetuose che si intrecciano a lamenti esagerati, una profusione di vita cieca che proviene dallo spogliatoio, la cui porta è aperta. Entrando, si trova nel bel mezzo di un duello con gli asciugamani, i colpi si abbattono secchi sulle schiene nude, sulle cosce, sulle spalle. Più di una dozzina di ragazzi si rincorre scalza e vociante, le grida rimbalzano sulle pareti dello spazio ristretto e si tagliano a mezza strada nell’aria, come elettroni di una materia suscitata e impazzita. Non fa in tempo a sistemarsi che viene riconosciu-to da alcuni amici e coinvolto nel caos generale. Cerca di sfilare dalla borsa il suo asciugamano, ma è subito centrato da una staffilata alla schiena, e poi da una alla nuca, mentre con un braccio si protegge, con l’altro riesce finalmente ad afferrare la sua arma, e si getta a corpo morto dentro la lotta, colpisce ed è colpito, ride e si lamenta, insegue ed è inseguito, finché un urlo più alto delle grida e dei tonfi impone il silenzio e il duello cessa di colpo. Qu ESta LI b Ertà 119 L’allenatore è apparso d’un tratto e ora è lì, in mezzo a loro, come se ci fosse da sempre; il suo sguardo di disapprovazione passa da una faccia arrossata all’altra e gli ultimi risolini si spengono, i respiri affannati si placano. L’uomo, con una voce congelata dall’ira trattenuta, intima loro di prepararsi in fretta, ché c’è da andare in palestra per il riscaldamento, e dà un’arcigna lavata di testa al ragazzo il quale, solo allora, si accorge di essere l’unico ancora vestito. a quel punto, una serie di azioni sincrone, precise e concentrate ricompone ordine nello spazio che, fino a un attimo prima, era un subbuglio di atomi matti. Si aprono armadietti, vengono afferrati i calzoncini nelle borse, i tubolari sono infilati e le scarpette allacciate e saggiate con rapidità e con cura. È quasi un caso che il ragazzo ora sia lì, con gli altri, a fare la corsa di riscaldamento nella palestra con le ampie vetrate, da cui filtra una calda luce settembrina che macchia di chiaro il centro del parquet: sa correre e sa farlo bene, cento metri in undici secondi e quattro a soli sedici anni appena compiuti sono il lasciapassare che gli dà il diritto di appartenere all’élite della scuola. Il difficile periodo di ambientamento durante il primo anno si può dire concluso dal giorno in cui il professore di ginnastica che ora lo allena gli 120 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo aveva preso i tempi sui trenta metri. aveva dovuto farlo due volte, non fidandosi del vecchio cronometro a mano, e per due volte il ragazzo aveva ottenuto un tempo identico. avvicinato al termine della lezione, gli venne offerta l’opportunità di far parte del gruppo di atletica della scuola. Entrò in squadra così, senza nessun reale interesse, passando il setaccio di una selezione praticata durante le normali ore di ginnastica. E l’opportunità di distinguersi per scomparire e far parte a pieno titolo del branco, per di più in una posizione di rilievo, facendo dimenticare le sue origini montanare e la sua inettitudine alla città, gli parve la fune gettata a un naufrago in piena tempesta. Col tempo, ha imparato a stare bene dentro il suo corpo, a ricondursi nella concretezza di quadricipiti, deltoidi, dorsali, che si contraggono e si distendono secondo ritmi prescritti, tanto che, se all’inizio gli esercizi di preparazione alla corsa gli sembravano noiosi e pesanti, adesso li trova perfino piacevoli, per quella vacanza da sé che gli permettono. uno, due, tre, i numeri scanditi, la voce spoglia dell’allenatore, sono le rotaie dove lui può far correre la sua immaginazione, mentre il corpo, libero di sé, viene affidato tutto ai numeri che battono l’aria, nella tranquilla precisione della sua assenza. Qu ESta LI b Ertà 121 Così torna dentro l’estate, vicino al fiume, e si trova disteso e sente di nuovo sulla pelle nuda il tepore della sabbia bianca, e accanto a lui il mangianastri che manda la musica dei Dire Straits, e davanti a lui, ancora in piedi, la ragazza emiliana dal corpo snello e pieno che si raccoglie i capelli scuri. Mentre lo fa, i suoi gomiti, alti sopra la testa, disegnano le punte di una stella controluce e da quella prospettiva, dal basso all’alto, lei gli appare come la sintesi del sole, la punta di lancia dell’estate intera, il vuoto che preme nella gola passato e presente, adesso che la pensa, e uno, due, tre, i numeri scanditi cadono nell’aria. Il ritmo del fiume nella sua testa e il ritmo dei numeri cui è affidato il suo corpo procedono separati per un po’ finché l’allenatore, con tre colpi di fischietto, segna la fine degli esercizi di riscaldamento e porta i ragazzi al campo di atletica. Fuori, il vento lieve è una carezza, il vento lieve è un abbandono, la pelle del ragazzo si dà tutta intera al fresco della giornata acerba. Nello spazio aperto del campo, le poche parole, le battute fra ragazzi, si stagliano nitide nell’aria e vengono subito portate via, si dissolvono come bollicine nella concentrazione che comincia ad addensarsi, e che lui avverte nella tensione indefinita delle sue fibre. I cinque velocisti sono rimasti con l’allenatore e gli 122 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo altri ragazzi, separati per specialità, vengono affidati a un paio di assistenti. Si fanno gli ultimi esercizi all’aperto, corse sul posto, saltelli sulle punte, prove di scatto, finché tutti si dispongono ai blocchi di partenza. C’è sempre un momento, quando posa il ginocchio sinistro sul tartan, mentre con il piede destro che fornirà la prima spinta prova con cura l’adesione al blocco, in cui il ragazzo è preso da un vuoto nello stomaco e da un’eccitazione al ventre: sono i secondi che precedono l’esplosione. L’adrenalina dell’antico cacciatore riaffiora come il marchio ancestrale di quando muscoli, velocità, attenzione erano usati per inseguire o per fuggire, e la posta in gioco era vita o morte, pollice in su o pollice in giù, secondo le sole, brutali alternative date in natura. al “pronti”, i cinque ragazzi inarcano le schiene, così come sono, i palmi paralleli alla linea di partenza, le schiene alte, sembrano felini sul punto di graffiare. al “via”, lo scoppio di cinque corpi levigati si alza nella mattina di settembre, e cinque armonici sistemi di leve, modellati per due anni al solo scopo di coprire una distanza nel più breve tempo possibile, aggrediscono il tartan, che sotto i passi corre via veloce. Polpacci, adduttori, quadricipiti pretendono benzina, i polmoni catturano l’aria, il cuore in- Qu ESta LI b Ertà 123 via sangue nelle fibre più veloce che può, dentro ossigeno, fuori anidride carbonica, dentro ossigeno fuori anidride carbonica. Lui è nella corsia centrale, i compagni non sono che macchie confuse, sente vibrare il vuoto nella bocca, la punta della sua scarpetta non fa in tempo a premere la pista che già è in volo per un altro passo; è solo, è un cacciatore. La linea d’arrivo si avvicina, non vede nessuna schiena davanti a sé, passa il traguardo e procede ancora per una decina di metri, adesso è un arco scarico. respira, e settembre è dentro di lui. respira, e le montagne senza peso sono dentro di lui. respira, e la luce del mattino è dentro di lui. Si guarda attorno, vede i suoi compagni, il corpo è docile, non dà pensieri, lui è felice. 1983, 11 settembre, domenica Prima c’è il respiro, pesante. Non riesce a coglierne la sorgente, ma il respiro sta tutto intorno a lui. ogni tanto sembra rompersi, spezzarsi, allora il suo ritmo viene tagliato da una lama, e il suono che prevale è quasi un gorgoglio, che si attenua e si allontana in un crepitare di foglie secche, calpestate, per riprendere il suo timbro cupo, di nuovo 124 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo pesante, che gli ricorda un fiume in piena, lontano, o il rumore di una radio non sintonizzata. È buio, e il ragazzo sente freddo, sente un freddo grande, mai sentito prima, ha la sensazione precisa di essere inchiodato alla terra, come se la terra lo stringesse in un abbraccio soffocante e lo costringesse lì, dov’è il suo posto, terra nella terra, buio dentro il buio. Cerca di sbozzolarsi dall’oscurità che lo stringe, il rumore del fiume in piena continua e, a ogni sua pausa, il ragazzo ha l’impressione di precipitare dentro se stesso, verso un fondo senza dimensioni ma nero. Poi, quando il rumore riprende, gli pare di risalire, e nella risalita c’è già l’annuncio della pausa e della nuova caduta. E ogni volta che si avvicina al limite del fondo, quando teme che il rumore non lo raggiunga più e non lo strappi via dal suo precipitare, urla, urla più forte che può mentre risale. Durante una caduta che gli appare più lunga di altre, trova la sua uscita dal buio attraversando il bosco dei polmoni, il tunnel della trachea, il canale della gola, nella forma di un urlo messo al mondo in una luce abbagliante. Ma c’è un momento, uno soltanto, in cui il ragazzo resta sospeso, come quando un pallone lanciato in alto nell’aria si ferma prima di essere di nuovo catturato dal suolo, e sente che l’urlo non Qu ESta LI b Ertà 125 è che un soffio debole, ancora esterno a se stesso, a metà tra il pianto e un miagolio. Poi tutto precipita e il respiro, che stava fuori di lui, irrompe dentro di lui, percorre a ritroso la strada che lui ha risalito e il ragazzo avverte se stesso mentre geme. La luce che lo ha abbagliato prende la forma del riflesso d’acciaio, e il riflesso d’acciaio la forma di sbarre: una lunga, orizzontale, più in alto del suo viso, e altre più piccole, verticali. tutte insieme compongono la sponda di un letto d’ospedale. Il ragazzo prova a sollevare un braccio nella direzione della sponda, che gli appare lontanissima, ma una pressione morbida e tiepida arresta il tentativo: è una mano, più chiara della sua pelle scura. È bastato un breve sforzo perché tutto tornasse fuori fuoco. avverte qualcosa che si muove e si avvicina più in alto e dietro quella mano. Dal movimento, prima gli viene incontro un’indistinta macchia chiara, con le macchie vuote degli occhi e una macchia scura e sottile che suggerisce una bocca, poi la nuvola piano piano si raddensa e trova contorni e confini precisi: degli zigomi alti, uno sguardo cerchiato e lucido sotto sopracciglia folte, una barba non rasata, delle labbra serrate e carnose diventano i tratti familiari della faccia di suo padre. 126 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo Più indietro, seduta, intravede sua madre, ha il viso rosso, si trattiene, poi non lo fa più, si alza in piedi e va via senza dire niente. La sera prima, tutti quanti nel villaggio di prefabbricati sapevano dell’incidente, tutti tranne i suoi genitori. Di voce in voce, la notizia si era propagata e deformata, due ragazzi si erano schiantati in motocicletta contro uno sperone roccioso, percorrendo una strada montana a una velocità da incoscienti. C’era chi diceva che erano morti sul colpo entrambi, chi diceva che no, uno dei due si era salvato, e chi invece con convinzione dava per certo che fossero tutte chiacchiere, che i due, salvo qualche gamba rotta e un salutare spavento che avrebbero ricordato per la vita, fossero usciti a buon prezzo da uno schianto come quello. Ma in poco più di un’ora, la notizia si era stagliata evidente, un ragazzo era morto poco dopo l’arrivo in ospedale mentre l’altro non era messo bene, aveva subìto alcune fratture della cui gravità nessuno era in grado di riferire. alla fine si seppe con certezza anche chi fossero i due ragazzi coinvolti. allora, un valligiano più coraggioso di altri si incaricò di informare i due genitori prima dell’arrivo dei carabinieri che, di fatto, apparvero poco dopo. Qu ESta LI b Ertà 127 bussò alle otto e mezza passate, mentre faceva buio, e fu il padre ad aprire, interdetto; dietro di lui si scorgeva la tavola ancora apparecchiata per la cena, ma c’era un piatto solo. La madre capì prima che il valligiano parlasse e si accasciò sul divano. In un momento la piccola stanza che fungeva da cucina e soggiorno si saturò di tensione. Il padre resse l’onda di dolore un po’ meglio, strinse a sé sua moglie e, alla luce della lampada già accesa, i due, nel male, erano una candela nella tempesta. Se non altro la notizia era data e aveva avuto l’effetto di rompere l’anello di silenzio e imbarazzo che, fino a un istante prima, aveva protetto i genitori. In poco tempo, il villaggio fece scudo, gli amici più stretti apparvero per confortare, rendersi utili in qualche modo, anche se nessuno di loro aveva ben chiaro quale. Però le offerte non erano generiche, nascevano da una volontà spontanea e infatti, dopo un breve confabulare, il gruppetto di amici stabilì che era prioritario telefonare in ospedale. Non era una cosa tanto scontata: in quel settembre del 1983, mentre altrove si affacciava l’Italia della Milano da bere, nel villaggio di prefabbricati erano in pochi a disporre di un telefono in casa e quei pochi lo utilizzavano come fosse una mac- 128 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo china scostante e aliena: qualche telefonata – telegrafica – durante le ricorrenze ai parenti emigrati, qualche altra di condoglianze, congratulazioni per un matrimonio e niente più, secondo la diffusa convinzione che le bollette della Sip fossero più insidiose delle vipere che di tanto in tanto si incontravano nei sentieri di montagna. Qualcuno si ricordò che un’anziana signora ne possedeva uno, ma chi doveva chiamare in ospedale? Non certo i genitori, la madre era ancora sul divano, sconvolta, il padre sembrava reggere, ma non era il caso di sottoporlo a una nuova tensione. Così si fece avanti la moglie del valligiano che aveva dato la notizia, e un gruppetto formato dai due genitori, dalla donna e dal valligiano si diresse verso il prefabbricato dell’anziana signora. Dall’ospedale si seppe che si trattava di lesioni vertebrali, che non c’erano lesioni alla testa e che il ragazzo era sottoposto a esami. L’aggettivo “vertebrali” non venne ben compreso, “lesioni alle vertebre” venne allora più chiaramente specificato. Se in quel settembre del 1983 in pochi, nel villaggio, disponevano di un telefono, un numero ancora minore, tra gli adulti del villaggio, sapeva con esattezza che cosa fosse una vertebra e cosa comportasse un sua lesione. Nemmeno un anziano, che aveva Qu ESta LI b Ertà 129 fatto la campagna d’africa ed era pratico di ferite di guerra, era in grado di dire qualcosa di definitivo. Così il gruppetto rientrò in casa, si discusse ancora un po’, finché il fratello minore del ragazzo ebbe l’intuizione di sfogliare il suo dizionario tascabile, ma quello che lesse, in presenza degli adulti, non aggiunse molto alla comprensione generale. tutti, però, parevano un po’ più sollevati, almeno il figlio non si era fatto male alla testa, l’infermiere che aveva risposto li aveva rassicurati su questo. ormai si erano fatte quasi le undici e l’ultimo treno per udine scendeva a mezzanotte, lo spavento era stato grande e i due genitori erano ancora scossi. Partire a mezzanotte avrebbe significato arrivare in ospedale, tra autobus e tutto, almeno alle due del mattino, era più sensato avviarsi l’indomani, dopo qualche ora di riposo. Così, di conforto in conforto, ognuno tornò a casa sua, le luci si spensero e padre e madre attraversarono una notte insonne. Partirono all’alba, con il vestito buono, sotto una pioggia torrenziale. La grande, fatiscente macchina del Santa Maria della Misericordia di udine li inghiottì e li stritolò alle sette del mattino. La madre rientra in stanza dopo aver pianto sommessamente in corsia. assistere al risveglio del fi- 130 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo glio, vederne gli occhi spalancati riempirsi di sorpresa, poi di paura, poi di nuovo di sorpresa è stato un colpo che le ha fatto tremare le gambe. Si avvicina al figlio e lo guarda, ricomposta come può: da un’asta di alluminio pendono una sacca di sangue e un flacone, dal letto pende una sacca di urine rossastre, accanto c’è una grande bombola verde di ossigeno. un tubicino entra nelle narici del ragazzo, un grosso ematoma si estende dallo zigomo destro su fin quasi alla tempia e la faccia è imbrattata da un disinfettante color ocra. Il ragazzo piano piano comincia a mettere a fuoco meglio, vede la madre che si avvicina e, mentre si siede, infila qualcosa di simile a una nuvoletta bianca nella borsetta nera, sente il fastidio del tubicino infilato nella narice e avverte il gorgoglio continuo della bombola d’ossigeno: da tutti gli elementi messi insieme comprende che è in un letto d’ospedale. Prova a dire qualcosa, ma padre e madre vedono soltanto le labbra che tremano, dalle quali esce un borbottio inarticolato. Prova a farlo con più impegno, concentrandosi su ogni parola, e allora una spada si infila proprio in mezzo alle scapole, la punta affilata di dolore scoppia nei polmoni, stringe le mascelle e fruga in ogni alveolo di ogni dente, Qu ESta LI b Ertà 131 risale e fora gli occhi dal loro retro fino a farli lacrimare, finché il letto comincia a girare come una zattera in mezzo alla bufera, e lui ha la sensazione di essere abbandonato in mare. Il dolore intenso è luce, uno scoppio di luce che nasce negli occhi. La luce scoppia dentro e, quando va via, fuori lascia tutto in disordine come una mareggiata che si ritira. Ma per un po’ tutto viene inghiottito nello scoppio, spariscono i contorni: spariscono le cose, spariscono nel bianco perfino una madre e un padre. Dopo, da lontano, da dentro un grigio che si trattiene, si può afferrare una voce che dice: «Stai tranquillo, fermo, hai un trauma al torace, non parlare, noi siamo qui», e magari si avverte anche una carezza leggera sulla fronte e tenta di stare con gli occhi chiusi. Mentre il ragazzo cerca di parlare, nella medicheria del reparto un ortopedico dispone sui pannelli luminosi, una a una, delle radiografie. Le scorre con scrupolo, nel campo scuro la spina dorsale si presenta come una struttura opalescente, un ponte che si interrompe nel buio sopra l’altezza delle scapole. La terza vertebra dorsale è esplosa per l’urto, con ogni probabilità diverse schegge hanno lacerato il midollo. La quarta, invece, il midollo lo ha tranciato di netto, spezzandosi in due metà che 132 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo sono slittate su se stesse con l’effetto di una ghigliottina. Il medico si allontana dal pannello luminoso, prende una grossa busta gialla dalla quale estrae il responso della taC. Quando torna al pannello e sistema in ordine le immagini, si rende subito conto che il quadro, se possibile, è ancora peggiore: grosse schegge d’osso sono conficcate nel canale midollare, e inducono il sospetto che i danni si estendano anche a monte della lesione. a valle, invece, c’è un massiccio versamento di sangue che comprime il midollo fino alla dodicesima vertebra dorsale. Poi guarda le immagini del trauma toracico: se non altro sembra non ci siano rilevanti contusioni polmonari. Mette tutto nelle buste gialle, legge il nome sull’etichetta, legge la data di nascita. «Sedici anni» dice tra sé, «fine pena mai.» Il ragazzo non sa che un mese dopo, ormai fuori pericolo, verranno definiti i confini e l’estensione di quella condanna, nella forma di una diagnosi riducibile al brutale elenco che segue: – paralisi dei muscoli addominali; – paralisi dei muscoli paravertebrali dorsali medio-inferiori; – paralisi dei muscoli lombari; – paralisi di parte dei muscoli intercostali; Qu ESta LI b Ertà 133 – paralisi di tutti i muscoli degli arti inferiori, dai glutei ai piedi; – compromissione della sensibilità superficiale e della sensibilità profonda a partire dal livello mammillare; – compromissione della termoregolazione nella zona sottolesionale per tre quarti del corpo. L’organismo non risponde se esposto a temperature ambientali troppo calde o troppo fredde; – compromissione della sudorazione nelle superfici del corpo sottolesionali; – compromissione dello stimolo alla minzione e alla defecazione; – ritenzione urinaria; – ritenzione fecale; – ridotta funzionalità respiratoria; – alterazione delle funzioni sessuali; – permanente ipotensione ortostatica. Né sa che, tradotto in vita, quell’elenco significa che di lì a due giorni affronterà una disperata corsa in ambulanza per essere operato a bologna, che gli ultimi passi che ha mosso sono quelli di ieri, che non sentirà più la pressione del suolo sotto i suoi piedi, che non sentirà più scorrere l’acqua sulla pelle in tre quarti del suo corpo, né il vento, né carezze, né baci. Che sarà in balìa delle sue deiezio- 134 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo ni e dovrà adattarsi ai tempi dettati da intestino e vescica, che avrà febbri da infezione ricorrenti, che avrà piaghe ricorrenti, che morirà di freddo d’inverno e di caldo durante l’estate, che sarà forato dai cateteri, che sarà tirato spinto allungato per riuscire di nuovo a sedersi decentemente. Che sarà aperto sette volte come un fiore dal bisturi, che, troppo presto, vedrà morire delle persone. Che il ponte interrotto e opalescente che ha visto il medico nel campo scuro delle radiografie è il ponte interrotto della sua vita, il ragazzo non lo sa ancora. adesso sa solo che brucia di sete e che suo padre gli sta umettando le labbra con una garza bagnata, dalla quale lui succhia con avidità. Il dolore sta accucciato, in attesa di un nuovo sforzo, pronto ad aggredire, è una nota di fondo costante che però gli permette di osservare i suoi genitori. Da dov’è, steso, lo sguardo ostruito dalle sponde, ne coglie solo i busti con il vestito buono, e le facce disorientate e serie. allora pensa che da quando studia a udine si è allontanato da loro, i libri lo hanno separato da loro, la città lo ha separato da loro e, mentre pensa questo, nel pensiero si infila il ricordo di quando tutti e tre giocavano a scala quaranta, trovando il modo di deporre le differenze che si spalancano di filiazione in filiazione, stringendosi nel gioco. Qu ESta LI b Ertà 135 gli viene in mente sua madre che guarda di sottecchi il padre con il sorrisino di una bambina che sta per fare un dispetto e, di colpo, cala tutta la mano scartando la matta per suprema beffa, e allora uno brontola e due ridono, e sono tutti insieme. È accaduto neanche una settimana prima, dall’altra parte del ponte interrotto. E quando gli viene in mente questo, come per ricomporre un anello spezzato, o come per gettare un nuovo ponte, «avete portato le carte?» dice, con il filo di voce inseguito dal dolore. 2012, dicembre Così come d’autunno cadono le foglie, ogni giorno nel nostro corpo muoiono circa dieci miliardi di cellule. accade senza interruzione, mentre mangiamo, oppure mentre siamo in coda a un semaforo, o ci alziamo sbadigliando la mattina, mentre beviamo un caffè con gli amici, mentre facciamo l’amore o ci annoiamo davanti a un monitor. È un processo che ci accompagna dal vagito al rantolo, le cellule sono programmate per morire e per essere sostituite, un po’ come gli androidi di Blade Runner. 136 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo Il processo ha un nome, si chiama apoptosi, e garantisce l’equilibrio chimico del nostro organismo e la sua stabilità: una cellula muore e un’altra si divide per produrne una nuova. Se tutto va bene, non c’è alleato più affidabile del nostro corpo, si fa porta dei sensi, asseconda i desideri, ci assicura il piacere e sostiene le nostre fatiche, con una sorta di imperturbata serenità. È il nostro giorno senza vento, il cielo senza nuvole, il mare senza un’onda. Ma se qualcosa va male e una cellula si divide, si divide, si divide ancora senza criterio né redini, l’equilibrio si spezza e l’alleato diventa un nemico con il quale al massimo si può scendere a patti ben sapendo che, presto o tardi, la tregua strappata si incupirà in una veglia d’armi. Perché il corpo, su tutte, esige una sola cosa: equilibrio. Io ho lasciato l’equilibrio del mio corpo su un tratto d’asfalto di una strada di montagna tanti anni fa. Non è impazzita nessuna cellula; semplicemente, ho leso le sole che, una volta perdute, sono perdute per sempre: le cellule nervose. Non esiste più comunicazione tra il mio cervello e gran parte del mio corpo. Se adesso volessi sollevare il piede, il comando partirebbe dalla mia mente e, dopo aver fatto ben poca strada, si perderebbe nel vuoto all’altezza della terza verte- Qu ESta LI b Ertà 137 bra dorsale, lasciando il piede inerte come fosse il piede di un estraneo. In altre, rozze, parole, il mio cervello è un interruttore, il midollo spinale è un cavo elettrico e il corpo è una lampadina: se il cavo elettrico è tranciato, posso premere l’interruttore all’infinito, ma la lampadina resterà spenta per sempre. È accaduto a me, è accaduto a molti. Col tempo, ho imparato come si patteggia con un corpo segnato. Il mio, ad esempio, odia stare seduto, dopo qualche ora devo stendermi a letto perché la pelle, all’altezza degli ischi e del sacro, comincia ad arrossarsi e da lì al formarsi di piaghe lentissime da guarire, il passo è molto breve. Ed esiste un solo modo certo per evitarle: scaricare la pressione dai punti sollecitati stendendosi. Così salgo e scendo dal letto più volte al giorno ma, quando si dispone soltanto di deltoidi e dorsali, l’operazione diventa davvero un “salire”, davvero uno “scendere”, per la fatica che comporta e la disparità che intercorre tra energia dissipata e risultato ottenuto. tuttavia, negli anni, il letto si è trasformato in un tappeto volante, un luogo dove per un po’ ci si sottrae al mormorio del quotidiano e si vedono le cose da lontano e dall’alto, come se il letto avesse sostituito il colle dove ho vissuto la mia infanzia. 138 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo Da lassù, si vedono meglio le cose, il tempo scorre via dalle nostre vene, mentre si concede una tregua al corpo e il pensiero si libera del superfluo che ingombra la giornata. Ho concepito e scritto diverse mie poesie adagiato a letto. Non ci vuole molto: una matita, un taccuino e il mondo che si raduna intorno a te, e lascia i suoi segni sulla pagina da scrivere come baci sulla pelle di un’amata. Perfino la febbre, quando c’è e non è troppo violenta, può diventare amica. La mente che farfuglia e saltella di sasso in sasso è una bambina che attraversa l’acqua fresca di un torrente montano: si è liberi di divagare, senza la fune della logica che ci trattiene, possiamo darci alla sostanza tiepida dei sogni, percorrere le vie fluviali che ci portano nell’iride di tramonti violetti e, dopo, chiudendo gli occhi, salire a bordo del tappeto volante e vibrare nel cuore dell’aria più in alto che si può. abbandonarsi alla febbre è un atto di fiducia accordato al proprio corpo, e se si abita un corpo che tace perché in gran parte privo di sensibilità, l’atto di fiducia dev’essere moltiplicato. Perché non si sa mai con certezza dove quella febbre potrebbe condurre. Così si impara a definire i confini della propria patologia; anzi, si cerca di decifrare ciò che solo con difficoltà si riesce a stabilire: la eco che la Qu ESta LI b Ertà 139 malattia stessa riverbera nel nostro organismo e le risposte, molto spesso inattese, di quest’ultimo. Come ermeneuti concentrati su un testo fatto soltanto di sussurri. ormai so quanto lontano posso spingere il mio corpo prima che cominci a ribellarsi, è una confidenza fondata sull’ascolto scrupoloso di qualcosa che rimane muto. In tutto questo, la prevenzione è lo strumento che rimane per puntellare una tregua dopo che si è tanto ascoltato. Prevenire significa giocare d’anticipo, significa sapere quanto si può stare seduti prima che la pressione possa provocare danni alla pelle guaribili con un mese di letto se va bene, per quanto tempo si può trattenere l’urina prima che si scatenino infezioni, valutare con esattezza i tempi di un viaggio, le modalità e gli spazi di uno spostamento dalla macchina alla carrozzina, capire quanto costano in termini di traumi alla pelle le vibrazioni suscitate da un acciottolato e ingegnarsi a trovare strade alternative. È uno slalom praticato nei giorni, nei mesi, negli anni, durante il quale la tua mente si conforma e separa come una cellula: una parte da concedere a te stesso e agli altri, e l’altra, a guardia alta e in stato di allarme, come una sentinella sugli spalti di una fortezza. Partire da un equilibrio per- 140 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo duto per fondarne uno nuovo è stato un processo lungo, difficile e che è costato caro. Era una bella giornata di fine ottobre quando, dopo l’emergenza e l’intervento a bologna, venni trasferito dall’ospedale civile di udine all’istituto di riabilitazione. Dal fondo dell’ambulanza, con i vetri opachi per tre quarti, vedevo giusto lo squarcio azzurro del cielo, le chiome di alberi vivaci nei colori dell’autunno e le finestre alte delle palazzine. assicurato alla lettiga, il mondo girava con me quando l’ambulanza imboccava una curva, mentre il riflesso delle finestre battute dalla luce mi coglieva negli occhi. Le giostre. Da bambino. Chissà da dove mi si affacciò l’immagine di mio padre in pantaloni marron e camicia bianca che scompare e riappare a ogni giro. «tieniti che il mondo gira» mi incitava sorridendo, e io mi afferravo alla criniera di legno del cavallino, lontano dal mondo, lontano dal mio peso, libero come una lancia scagliata nell’aria. al ricordo, strinsi d’impulso le mani ai supporti metallici della lettiga, “tieniti che il mondo gira e non sei qui” suonò una voce nella mente. E davvero non ero lì, e chiunque avrebbe potuto fare di me qualunque cosa lasciandomi del tutto indifferente, perché il corpo che sussultava agli scossoni Qu ESta LI b Ertà 141 dell’ambulanza, che avvertiva il cigolare degli ammortizzatori, il tintinnare della flebo mentre urtava l’asta di alluminio non era il mio. Mio era il corpo che si stringeva al cavallino, col mondo che scompare e dopo, per incanto, torna nelle luci di qualche remota sagra paesana. Era trascorso più di un mese dal giorno dell’incidente, ma ancora non ero capace di toccarmi le gambe. La prima volta che l’avevo fatto, sfiorando d’istinto le cosce sotto le lenzuola, ne ero rimasto sconvolto e spossessato. Era stato come precipitare nel corpo di un altro, le cosce non rispondevano al mio tatto, le mani si erano posate sulle gambe di uno che non conoscevo e del quale avevo preso il posto rimanendo incatenato nel suo corpo per chissà quale forma d’incantesimo. Il sentimento era qualcosa a metà strada tra il ribrezzo e la paura, e badavo con ogni cura di tenere le mani fuori dalle lenzuola, i palmi rivolti in basso, ben lontani dalle gambe e dal bacino. La spinta a tenermi alla larga da me stesso, a farmi da parte mentre venivo bucato, mentre mi si lavava in fretta il sesso o mi si rivoltava per medicare le piaghe, veniva da lì. Separando le cellule nervose, il taglio del midollo spinale aveva allontanato da me anche il mio corpo. al contrario dei valligiani, sapevo 142 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo bene che cosa significasse una frattura vertebrale e che pochi tornavano da quella discesa al tartaro sulle proprie gambe. Quando gli infermieri tolsero le cinture che mi assicuravano alla lettiga e mi fecero scendere davanti all’entrata dell’istituto di fisioterapia, le portiere dell’ambulanza sbattute alle mie spalle, il sussulto che ne ebbi, l’aria pulita di ottobre sulle guance e le porte che si aprirono al mio arrivo, mi indicarono che l’emergenza era finita e, con essa, si era spezzato il filo sottile che mi teneva legato alla vita di prima. L’ospedale era molto più piccolo del Santa Maria della Misericordia, ci volle poco tempo per arrivare in reparto percorrendo un ampio corridoio, del quale vedevo le pareti color verdolino spento e il soffitto di pannelli bianchi con appesi i tubi dei neon. Entrai in stanza a mezza mattina, tre infermieri mi trasferirono dal ripiano duro della lettiga al letto, stando attenti a mantenere la mia postura orizzontale, poi collegarono il tubo del catetere a una sacca per le urine pulita, sistemarono dei cuscini sotto i polpacci e ai lati del bacino per evitarmi piaghe ai talloni e all’osso sacro, quindi uscirono informandomi che di lì a poco sarebbe passato il medico con la fisioterapista. Qu ESta LI b Ertà 143 rimasi per qualche minuto da solo, giusto il tempo di guardarmi attorno, la camera era piena della luce di fine ottobre e ospitava tre letti. a me avevano assegnato quello vicino a una grande finestra con un lungo davanzale. rispetto agli anonimi cameroni di otto persone dell’ospedale civile, qui l’ambiente suggeriva un’idea di familiarità: ai piedi dei letti, sistemato su un tavolino, c’era un televisore; sui comodini dei miei compagni assenti, gran parte dello spazio era occupato da due grossi stereo; da una capra, la struttura che ci aiutava a salire e scendere dal letto, pendeva un cuore di peluche. Le pareti erano affollate di cartoline e fotografie attaccate con lo scotch, un biglietto d’auguri risaliva alla Pasqua precedente. Sull’armadietto di uno dei due era attaccato il poster di una cantante in voga in quei mesi. Stringeva un microfono, aureolata di luce, in un costume di scena che le strizzava i seni enormi. C’era un’allegria saltellante incollata a quelle pareti, nei motti ingenui delle cartoline, nelle fotografie esibite: il tipo da spiaggia che stringe a sé una bella ragazza castana, lo stesso al volante di una macchina piena di alettoni e fari, l’altro con una maglietta nera dei Motorhead e una birra in mano, sorridente e con le iridi rosse per via del flash e delle luci notturne. Non lo compresi subito, 144 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo ma quell’allegria era il primo argine che i due avevano alzato per tenere lontano il dolore, assumeva quasi il valore di un esorcismo, come gli amuleti appesi agli stipiti delle antiche abitazioni romane. Lì per lì capii una sola cosa: la mia permanenza in quel posto non sarebbe stata né facile né breve. Il medico comparve poco dopo, in compagnia di una donna in tuta da ginnastica, mentre guardavo fuori dalla finestra che dava su un bel parco. Mi fece una visita accurata, mi punse con un ago per stabilire il livello della sensibilità cutanea, verificò l’escursione degli arti e io per tutto il tempo guardai il soffitto. appariva gioviale e non mostrò di notare il mio comportamento. Mi fece delle domande semplici per rompere il ghiaccio, mi chiese da dove venissi, quando a quel punto doveva saperlo benissimo, ma non appena risposi che ero di Chiusaforte, mi si rivolse subito in friulano, dopo aver fatto una battuta sulle teste calde che popolavano quella parte di vallata. Era la prima volta, in più di un mese di ricovero, che il senso di estraneità che mi stringeva allentava un poco la presa: fino a quel giorno ero stato un numero; il numero sei ha bisogno di, il numero sei ha la febbre, bisogna cambiare la sacca al numero sei, il numero sei dev’essere girato e via così, secon- Qu ESta LI b Ertà 145 do la spoglia litania di praticità che, almeno allora, faceva funzionare le corsie degli ospedali. adesso però qualcuno – un medico, addirittura – parlava in friulano al numero sei, che per un istante si sentì quasi a casa, e abbozzò perfino un sorriso. Fu un momento, una sosta d’ombra in un deserto, poi il medico mandò la donna, la fisioterapista, a chiamare un infermiere e, di nuovo in tre, mi girarono su un fianco per medicare le piaghe. Ne avevo un po’ dappertutto, sui talloni, sotto le ginocchia, all’altezza del bacino, ma la più preoccupante era la piaga sacrale, un cratere di dieci centimetri di diametro che suscitò l’attenzione del medico. avrebbero tolto le necrosi, l’avrebbero pulita, l’avrebbero fatta sanguinare per stimolare il processo di ricrescita delle cellule cutanee, mi informò, sempre in friulano, avvertendomi che la cicatrizzazione sarebbe andata un po’ per le lunghe. La visita era quasi finita; parlò la fisioterapista, la quale mi spiegò che i primi tempi mi avrebbero fatto fare degli esercizi a letto, per mantenere l’escursione di caviglie, ginocchia e per evitare retrazioni. Soltanto in un secondo momento avrei lavorato in palestra. Mi lasciarono un po’ più sollevato, qualcuno si stava occupando di me e mi pareva che lo avrebbe fatto seriamente. 146 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo Quando il medico aprì la porta della stanza, fecero capolino i miei genitori. avevano seguito l’ambulanza con l’autobus, poi si erano fermati in accettazione per sbrigare le pratiche del ricovero. Entrarono quasi in punta di piedi. Mio padre mi parve entusiasta del dottore, era riuscito a parlargli prima che mi visitasse e, appena accanto al letto, mi raccontò della sua sorpresa quando quello gli si era rivolto in friulano. Si sentiva slegato dall’impaccio di dover ricorrere al suo italiano pieno di incertezze, e confortato dal fatto che, se tutto il resto gli era estraneo, almeno la lingua sarebbe stata un luogo dove potersi muovere con disinvoltura. anche mia madre era sollevata; l’ospedale piccolo, facile da raggiungere, senza la complicazione del dedalo di sotterranei nella pancia del Santa Maria della Misericordia, le era piaciuto subito. allo stesso modo, dopo essersi guardata un po’ attorno, aveva apprezzato l’aria tutto sommato familiare della stanza e «il posto buono» – così si era espressa – dove mi avevano sistemato, accanto alla finestra. «Il male sta presto a venire e sta tanto ad andar via» sentenziò mio padre, poi aggiunse che mi avrebbero fatto andare in palestra, avrebbero riattivato i miei muscoli e avrei cominciato a camminare, prima piano piano, con le stampelle, e un doma- Qu ESta LI b Ertà 147 ni chissà, magari anche senza. Erano frasi semplici, dirette a confortarmi, trattenni in gola la commozione per quel candore e feci finta di crederci con entusiasmo. Vederli seduti l’uno accanto all’altra sulle sedie in fòrmica dell’ospedale così rinfrancati, così ignari di quel che si stava consumando, mi strinse il cuore. Nessuno aveva spiegato loro la mia reale situazione, né mai nessuno, saggiamente, lo avrebbe fatto in seguito. Sarebbero stati accompagnati piano dentro quel dolore grande, come due barche spinte con prudenza dentro un’acqua minacciosa. Per quanto riguarda me, la speranza è un lusso che in certe circostanze non ci si può permettere, ingombra la vista, e prospetta aperture illusorie. Ma regalare loro, sia pur per qualche mese, un po’ di sollievo fu una cosa che in quel momento feci d’istinto. Così, mentre mi mostrai saldo – e non lo ero affatto – nell’affrontare il duro percorso di riabilitazione, avvertii uno strappo provocato da un sentimento del quale allora non ero consapevole. Da quel momento cominciavo a diventare padre di mio padre e padre di mia madre. Quando rientrarono dalla palestra i compagni di stanza, mia madre stava finendo di mettere a posto 148 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo le poche cose nell’armadietto. uno, il tipo da spiaggia, che pareva sfinito e aveva gli occhi cerchiati e lucidi di stanchezza, chiese a mia madre di versargli un po’ d’acqua nel bicchiere. Dal modo in cui lo afferrò con entrambe le mani per non farselo sfuggire, capii che aveva una lesione a una vertebra cervicale. Notai una cicatrice tonda poco sotto il pomo d’adamo, mentre rovesciava la testa per bere: rivelava che gli avevano praticato una tracheotomia. Quello della maglietta nera dei Motorhead, invece, salì con un’agilità insospettata sul letto. Entrambi erano magrissimi. Eravamo tutti giovani e magri noi ragazzi della Fisiatria Nord, come se, per trarci in salvo, avessimo dovuto gettare tutto ciò che era superfluo e il nostro corpo avesse dovuto spremersi fino all’ultimo succo per volare via e sottrarsi alla presa del male. Eravamo magri nel corpo ed eravamo magri nell’anima. Come capita ai bambini e alle persone unite da circostanze difficili, non ci furono molti convenevoli quando ci presentammo, chiesi loro l’età e da quando erano lì. Il ragazzo che era salito a letto con un’agilità da pantera mi rispose che aveva avuto l’incidente quasi un anno prima, mentre l’altro era Qu ESta LI b Ertà 149 lì dalla primavera. Il male sta presto a venire e sta tanto ad andar via. I miei partirono il pomeriggio, con l’ultimo treno utile per tornare a casa, in punta di piedi com’erano arrivati. Sulla porta, mia madre si voltò e, arrossendo, mi salutò con un sorriso. Quella sera, le mani fuori dalle lenzuola, i palmi ben lontani dal corpo, mentre un compagno guardava la televisione e l’altro ascoltava musica con le cuffie, io, nella luce azzurrina della lampada notturna, ripensai al primo giorno di ricovero nell’istituto di fisioterapia, alla tenerezza disarmata dei miei genitori e al mio disincanto trattenuto. Quel giorno, finito l’orario della palestra, diversi ragazzi si erano affacciati per conoscermi (eravamo in quindici in tutto, distribuiti in cinque stanze: in posti così, dove le dimissioni erano rare, ogni ingresso costituiva una novità) e ognuno di loro pareva dirmi col suo corpo “benvenuto su questa luna dove la gravità è maggiore di quella della terra e noi si lotta per essere leggeri”. Quando spensi la luce e chiusi gli occhi, ebbi l’impressione che quel primo giorno fosse stato il battesimo della mia seconda vita. La piaga più grande tardò a guarire. Per qualche tempo rimasi febbricitante e stordito dalle molte vi- 150 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo site; l’ospedale non metteva restrizioni d’orario per cui, oltre ai miei genitori, c’era sempre qualcuno che passava a trovarmi. Poi, una a una, le persone si fecero vedere più raramente, come una pioggia che smette di battere sui vetri finché li accarezza soltanto. Il tempo si allungò. ormai, chi veniva portava impigliato nei vestiti l’odore dell’inverno. Era la cosa più bella fiutare l’aria fredda catturata dai tessuti, così tenue, così diversa dall’odore di disinfettante e da quello surriscaldato della stanza: mi regalavano i cieli puliti e la neve e gli abeti dei miei posti. Io perdonavo anche la loro legittima e non infrequente curiosità, pur di fiutare le tracce di quei cieli e quella neve quando, ancora in abiti pesanti, si avvicinavano per salutarmi. Poi, dopo un po’ di conversazione, lasciandomi sul comodino una scatola di cioccolatini, dei fiori o della frutta che sarebbe rimasta lì a marcire, i loro giacconi, i loro soprabiti, i loro berretti portavano via il cielo, e io rimanevo consegnato al silenzio. “Ci vediamo domani”, per un sedicenne costretto a letto e che ha per orizzonte da un lato la porta di una stanza e dall’altro una finestra che dà su una porzione di parco, significa “ci vediamo tra ventiquattro ore”, molte delle quali da attraversare nella più sassosa delle desolazioni. Qu ESta LI b Ertà 151 Interminabili mi apparivano certe ore pomeridiane: da quando avevo cominciato a stare meglio, i miei genitori partivano subito dopo pranzo e, se durante il pomeriggio non veniva nessuno, mi riducevo a contare una a una le gocce distillate dalla flebo cercando di assopirmi, oppure osservavo i merli intirizziti, che becchettavano nel pezzettino di verde inquadrato dalla finestra, o mi sistemavo walkman e cuffiette finché rientravano dalla palestra i miei compagni di stanza a portare la loro vitale confusione. Fu durante quei pomeriggi che mi tornò la voglia di leggere. Sentivo il bisogno di grandi spazi e di grandi storie, di afferrare la criniera del cavallino di legno e cavalcare lontano da lì. Il primo libro che chiesi di portarmi fu Moby Dick. L’avevo già letto due anni prima, durante le vacanze estive a Chiusaforte. Davanti al villaggio di baraccati era stata ricostruita da poco la scuola elementare: dove una volta si apriva lo spazio libero del campo sportivo, adesso, accanto al brutto e funzionale edificio, era rimasto un modesto rettangolo di verde recintato da una ringhiera. In fondo, nel punto più lontano rispetto al villaggio, saliva nell’estate un solitario ippocastano e, appena più in là, la strada sterrata che superava l’argine e portava al fiume. 152 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo Scavalcavo la ringhiera ogni pomeriggio di bel tempo, dopo aver messo in una borsa l’asciugamano, il costume e un libro, e ogni volta, per raggiungere la strada sterrata che metteva al fiume, passavo sotto l’albero solitario. Non so perché un giorno mi ci arrampicai. ricordo che era un primo pomeriggio molto caldo e in giro non si vedeva anima viva. In genere, quando arrivavo nella piccola ansa sabbiosa che noi ragazzi avevamo scelto per fare il bagno e prendere il sole, c’era sempre qualcuno. Non avevamo appuntamenti prefissati, ci si incontrava alla spicciolata, chi prima chi dopo veniva lì; sapevamo che avremmo trovato gli amici e le ragazze in costume con cui riempire di scherzi, musica, bagni e spruzzi il pomeriggio d’estate. Quel giorno, però, ero molto in anticipo, il sole calcinava la strada sassosa e restai per un po’ all’ombra dell’ippocastano, incerto se tornare a casa o aspettare lì il momento buono per fare il bagno. Poi, il mezzo bambino che ero prevalse, mi legai la borsa al polso e mi arrampicai. trovai un grosso ramo che formava una sella perfetta con il tronco dove appoggiai la schiena lasciando penzolare le gambe nel vuoto. rimasi così un po’, a guardare dall’alto la strada torrida, le file di prefabbricati scottate dal sole, le caserme con la piazza d’armi deserta e Qu ESta LI b Ertà 153 abbagliante. Di tanto in tanto la chioma dell’ippocastano rispondeva con il suo lessico di sussurri a qualche debole soffio di vento e io rispondevo alla chioma adattando la mia schiena al tronco. L’essere custodito dalle foglie, nascosto al mondo, con l’odore di umido, di linfa nelle radici, mi aveva messo dentro a un’intimità inviolata, un posto dove il tempo sembrava essersi fermato prima di toccarmi, caduto ai piedi del tronco dell’ippocastano. Estrassi il libro dalla borsa e cominciai a leggere. I romanzi, nessuno escluso, sono viaggi. alcuni più di altri, però, lasciano affiorare sulla loro pelle questo carattere intrinseco comune a tutti e io, allora, ero attratto in modo speciale proprio da questi ultimi. Moby Dick dichiara già dal perentorio e folgorante attacco la sua natura di viaggio fisico e metafisico insieme. anzi: più che un attacco, quel “Chiamatemi Ismaele” è un invito all’ascolto, per quel nervo di oralità che si inarca al suo interno. È come se il marinaio di Manhattan ci dicesse, durante l’ora di riposo, sulla tolda notturna di una qualche baleniera che incrocia ai tropici, “Venite qui, io mi chiamo Ismaele e ho una storia da raccontarvi” e noi fossimo realmente marinai tra marinai, sedu- 154 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo ti a capannello su quelle assi ruvide, fumando le nostre pipe, pronti a valutare con occhio critico misura e intensità di esagerazioni e omissioni del narratore che ci ha chiamati in causa. Il romanzo di Melville mi catturava per questa sua ragione di virile affabilità e l’impressione che mi lasciava dentro di racconto detto prima che di racconto scritto. un racconto srotolato su una nave dove le lunghe digressioni erano i nei portati con naturalezza da un corpo saldo, abbronzato e bruciato dalla salsedine degli oceani. In più, mentre io leggevo il romanzo nascosto dalle foglie dell’ippocastano, Chiusaforte era in piena ricostruzione. ovunque si andasse ci si imbatteva in armature, ponteggi, macchine da lavoro, ruspe, transenne, autocarri pieni di ghiaia che sollevavano la polvere a nubi, cavi d’acciaio e odore di pneumatici caldi. Da tutto questo si levava un che di sbuffante, di arrancante, di cigolante e di fervido che via via cambiava l’aspetto del paese, rimasto per decenni sprofondato in un’indifferente immobilità. avevano preso l’avvio anche i lavori dell’autostrada che avrebbe stroncato l’intera vallata ma unito con sicurezza il Nord-Est all’Europa centrale. a sud di Campo Ceclis, si erano predisposte lunghe file di baraccamenti per ospitare gli operai. Qu ESta LI b Ertà 155 Così, alle novecento anime scarse di Chiusaforte e agli ottocento alpini del battaglione in caserma, ora si mescolavano due, trecento uomini robusti provenienti da tutta Italia, a non contare la gravitazione di quelli che si erano stabiliti in posti ancora più piccoli. Scricchiolante sotto il nuovo peso che faceva felici pizzaioli e commercianti, il paese di sera si animava della manesca allegria di questa nuova gente; e i ceffi da ciurmaglia, che avresti potuto incontrare in qualche bettola di New bedford, congestionavano invece la discoteca, le tre pizzerie e gli undici bar di Chiusaforte. undici, dico. tanto per darvi l’idea dell’impetuoso soffio alcolico che spazzava ogni più remoto angolo della vallata in quei tempi di frontiera e di euforia. Lassù, in cima all’albero, tutto quello scamiciato fervore veniva raccolto e intrideva le pagine del libro, dando corpo e sostanza ai personaggi, rendendo più chiare e concrete le descrizioni d’ambiente e gli antri da angiporto che avevano ruvidamente accolto Quiqueg il selvaggio e Ismaele. Insomma, dal libro alla mia testa, New bedford, Nantucket e Chiusaforte diventavano tre astri, l’uno dall’altro illuminati. Lessi molto quel giorno, e arrivai tardi al fiume, non c’erano né ragazze né musica, ma non rimasi 156 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo deluso per questo, presi un breve bagno, e l’indomani ero ancora lì, accomodato sulla sella dell’ippocastano. Da allora, da quel periodo stralunato in cui la polvere sollevata la si sentiva scricchiolare sotto i denti, ogni volta che mi imbatto in unità di misura esotiche come “tese”, “braccia”, “pollici”, “galloni”, “libbre” o incontro parole come “cassero”, “velaccio”, “sartiame”, la mia mente si schiude come un grasso fiore tropicale, pronta ad abbracciare regioni remote segnate solo nelle carte di navigazione della mia fantasia personale, dove Nantucket può diventare Chiusaforte e Chiusaforte può diventare Nantucket. Moby Dick divenne un trampolino. Per tutta l’estate, e per l’estate successiva, presi l’abitudine di leggere sull’albero. Non solo prima di fare il bagno, ma tutte le volte che mi veniva voglia di rintanarmi, valicare i monti e veleggiare seguendo i miei solchi di spuma nelle acque oceaniche. Si può leggere nelle circostanze e nelle posture più disparate: in treno, in autobus, a letto, adagiati su un divano, sulla schiena nuda di un’amante, nella sala d’attesa di un dentista, all’ombra di un gazebo, sotto il portico di casa, sulla sabbia arroventata di una spiaggia. Ma, vi assicuro, per quanto mi riguarda, le letture più intense, quelle che mi han- Qu ESta LI b Ertà 157 no rapito e portato via, io le ho fatte seduto in sella all’ippocastano, d’estate, mentre il paese cambiava faccia e non sarebbe stato mai più lo stesso di prima. Perché in cima a un albero, con un libro in mano, tu sei il nodo in cui si incrociano e si allacciano due diverse forme di intimità: l’intimità che nasce dalla relazione con ciò che stai leggendo e quella delle foglie che ti raccolgono e ti nascondono, nell’odore sodo dei succhi spremuti dalla terra. In quella pancia di verde sei protetto da una segreta dolcezza; purché tu lo voglia, puoi vedere senza essere visto e le ore che scorrono veloci al di fuori di essa sono trucioli, diventano la segatura dei giorni. E tu alla fine scendi dall’albero meno consumato, più fresco e pronto alla vita perché hai nel forziere un ben custodito corredo di avventure nei mari. Cominciai per la seconda volta la lettura di Moby Dick che ero ancora molto debole. avevo la flebo attaccata e mi stancavo con facilità. Dopo un po’ che leggevo, le braccia si facevano pesanti, allora rimettevo il libro sul comodino. Erano letture brevi, mezz’oretta al massimo ogni pomeriggio, già sufficienti a rompere la distesa sassosa delle ore vuote e a darmi l’impressione di riannodare un filo con le estati trascorse a leggere su un albero e quelle interminabili dei tropici. 158 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo Filo dopo filo riannodato, trama dopo trama, Moby Dick non mi deluse nemmeno questa volta e nella calma senza scosse di quei pomeriggi, mi portò via di nuovo. Se la prima volta le lunghe descrizioni mi erano apparse come i nei ben portati da un corpo abbronzato, adesso le apprezzavo e le seguivo nel loro sciogliersi minuto. Il mio immaginario si rinverdì, spezzò la scorza delle ore desolate, e alla grandezza antica della descrizione dello scheletro del capodoglio e della sua enorme mandibola, dove avrebbe potuto passare una carrozza con pariglia, tornò bambino. tale e quale a quello che avrebbe voluto afferrare la scia delle carrozze illuminate che scomparivano dietro la svolta erbosa, tanti anni prima, al di là del ponte interrotto e sul colle. Piano piano passavano i giorni e io iniziavo a sentirmi più forte, le letture si prolungarono e le ore di noia si accorciarono. I libri sono degli specchi: soprattutto se li si legge da distesi, sorreggendoli sul petto, con gli occhi ad altezza delle pagine aperte, la postura particolare ne fa emergere la forma segreta. Solo che non restituiscono i tratti del tuo viso ma, nello scorrere dei personaggi in cui di volta in volta ti riconosci, nei luoghi descritti in cui vorresti essere, o in quelli dai quali vorresti Qu ESta LI b Ertà 159 fuggire, mostrano sempre qualcosa di te. Porte spalancate su mondi, dove è bene che la tua incredulità rimanga sul comodino, insieme ai bicchieri di carta con le medicine, al walkman e alla bottiglia d’acqua che riflette la luce al neon di un giorno corto di dicembre. avvenne un’altra cosa durante quella lettura. Se Moby Dick mi allontanava dalla povertà del mattino, quando gli infermieri mi medicavano le piaghe e mi voltavano e rivoltavano a letto per un’ora buona, e mi portava al largo durante i pomeriggi, un poco per volta mi riavvicinò al mio corpo. Per leggere, disteso com’ero, appoggiavo il libro sulla parte insensibile del mio petto. un’operazione che, di necessità, mi costringeva ad avvicinare le braccia alla parte di tronco che non sentivo: come se il mio corpo, tutto il mio corpo, si stringesse e si addensasse intorno alla lettura. Senza accorgermene, ristabilii un poco per volta la confidenza con me stesso. E se prima, durante le lunghe sedute di medicazione, gli infermieri avrebbero potuto farmi qualunque cosa lasciandomi indifferente, adesso cominciavo a informarmi sulla cicatrizzazione delle piaghe, chiedevo loro di voltarmi meno sbrigativamente, percepivo che quel corpo girato e voltato ogni mattina era il mio. una fuga terminò con un ritorno. 160 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo rimasi a letto per sette mesi, senza interruzione. Sette mesi. a fare i conti per bene, erano circa il tre per cento della vita che avevo vissuto fino ad allora. a Moby Dick si aggiunsero altre letture. Tifone, tanto per restare in mare, poi Cuore di tenebra, Se questo è un uomo, Papillon, ma anche riviste di storia dell’aviazione e raccolte di poesia. Il letto cominciò a diventarmi amico, il lungo davanzale della finestra iniziò a riempirsi di libri e di riviste, le piaghe, un giorno alla volta, con progressi impercettibili, si richiusero. E io ormai riuscivo a toccarmi perfino le gambe e ad accettare il fatto che fossero mie. Finché, un giorno di primavera, venne il momento di scendere dal letto. L’avevo aspettato con impazienza per mesi, al di là della porta si schiudeva un mondo che mi era precluso, del quale coglievo soltanto i rumori e le voci. Il rumore sferragliante del carrello della cucina che annunciava pranzi e cene, per esempio, oppure quello più leggero del carrello delle medicazioni, il rumore dei passi di mio padre che risaliva la corsia, le voci degli infermieri o dei medici. Intuivo il tratto di spazio che le separava dalla porta e prevedevo se qualcuno di loro sarebbe entrato nella mia stanza. Dal rumore degli pneumatici delle sedie a rotelle, ero persino capace di riconoscere, fra tutti i pazienti, i miei compagni Qu ESta LI b Ertà 161 di camera, ognuno dei quali aveva il suo modo di spingere la carrozzina. Pesante e vicino alla terra quello del tipo da spiaggia, quasi un fruscio brioso di seta quello dell’altro. I malati sviluppano un udito sottile, perché ogni rumore diventa il cartiglio di un sentimento. ogni rumore annuncia un’azione nel tempo congelato delle ore. ogni azione rappresenta la vita. Ma adesso che qualcosa accadeva proprio a me, che dopo mesi di attesa avevo la forza per scendere dal letto, non avevo più la voglia di farlo. gli infermieri mi infilarono un paio di calze elastiche che, nelle intenzioni, dovevano evitarmi bruschi cali di pressione. Fra lazzi e battute, mi sistemarono in posizione seduta, appoggiandomi a dei grossi cuscini, come fossi una bambola di pezza. al varo era presente anche il fisiatra che mi aveva preso in cura e sorvegliava con scupolo tutte le operazioni. Dopo avermi misurato la pressione un paio di volte, disse che era venuto il momento di scendere. un infermiere mi afferrò sotto le ascelle mentre un altro mi prese le gambe, e mi trovai sulla carrozzina. Mi sentivo stranamente leggero, la stanza, da quella prospettiva, sembrava più ampia, i biglietti e le cartoline alle pareti più in alto e più lontani, il pavimen- 162 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo to più vicino. Disorientato, guardai il medico, che mi sorrideva compiaciuto, poi fu come trovarsi in cima alle montagne russe e precipitare lungo la ripida discesa di rotaie: un formicolio percorse il volto intero, il cuore balzò in gola, il sorriso del medico e la stanza cambiarono di posto e scomparvero, inghiottiti da un velo nero. Mi risvegliai a letto con un mal di testa che stringeva le orbite e con il medico che mi controllava il polso. Con tutta naturalezza mi spiegò che i bruschi cali di pressione sono normali le prime volte che si scende, cambiando postura dopo che si è stati così tanto distesi. Quel giorno ero rimasto in carrozzina poco meno di un minuto. La strana luna sulla quale vivevo si era fatta sentire con tutta la sua forza di gravità. Ma io ero sollevato di essere stato di nuovo accolto dal letto. In sette interminabili mesi era diventato la mia scialuppa, la mia sala da pranzo, il mio bagno e il mio studio, il solo luogo al mondo che non mi fosse ostile, e dal quale così spesso prendevo il volo afferrandomi alle pagine dei libri. ripetemmo l’operazione in maniera identica e con identici risultati l’indomani. Poi il giorno successivo e il successivo ancora, sempre con la sorveglianza del medico e, in un paio di settimane, ero Qu ESta LI b Ertà 163 in grado di spingermi in corsia. Mi lasciarono solo, liberandomi con cautela nel lungo corridoio, come si fa con un pesce nell’acquario. Incontrai infermieri e qualche paziente in carrozzina, che di tanto in tanto era passato a trovarmi durante la permanenza a letto. Si fermavano, sorridevano e sottolineavano l’eccezionalità di quella mia prima passeggiata. Io ero poco più di un sacco ciondolante sistemato su una sedia a ruote, le orecchie erano tormentate da un fischio continuo, le parole di chi mi fermava arrivavano ottuse, come avvolte da stracci. Nella bocca senza saliva la lingua era un pezzo di carne che rispondeva poco alla mia volontà, però, per come potevo, cercavo di rispondere ai sorrisi. Dovetti stare molto attento durante quella prima, faticata, conquista della libertà. Mi spingevo con pochi colpi sulle ruote e, se il capogiro minacciava di farsi più violento, mi fermavo, finché il fischio alle orecchie si attenuava e cose e persone tornavano al loro posto. Spingendo e fermandomi, arrivai a lambire le grandi vetrate che si aprivano da un certo punto della corsia in poi. Mi fermai, del tutto spossato, vicino a una di esse. Non so quanto avevo impiegato a percorrere la cinquantina di metri che dalla mia camera mi avevano portato fin lì, ma il sacco che ero a quel 164 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo punto si era svuotato. Facevo i cento metri in undici secondi e quattro. appoggiai una mano sul vetro, mentre con l’altra mi reggevo puntellandomi sulle ginocchia. Il fresco che sentii sul palmo era un invito ad appoggiare anche la fronte, ma non potevo farlo: di sicuro qualche infermiere, vedendomi accasciato vicino alla finestra, avrebbe interrotto quella mia libertà con guinzaglio. avrei voluto chiudere gli occhi, ma non potevo fare nemmeno quello perché i capogiri sarebbero ripresi con maggiore violenza, così tenni la testa eretta e gli occhi ben aperti e guardai fuori. Si era affacciato il sole dopo che durante la mattinata era piovuto, ora tutto accecava nel riflesso della luce sulle cose ancora bagnate. tra un lembo di nuvola e l’altro si apriva un azzurro che pareva appena battuto dal conio della creazione. In basso, c’era una strada con un paio di utilitarie parcheggiate all’ombra di un muro che si levava altissimo, superava il mio sguardo. In cima graffiavano l’aria, con i loro segni neri, dei ferri ritorti in mezzo ai quali, battuti dal sole, dei cocci di bottiglia brillavano come diamanti nell’azzurro immacolato di quel pezzo di cielo. Sentire con triste meraviglia / com’è tutta la vita e il suo travaglio / in questo seguitare una muraglia / che Qu ESta LI b Ertà 165 ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. I quattro versi non uscirono zampillanti, lucidi e in un colpo solo, così come li riporto adesso sulla pagina: affiorarono un poco per volta. Dalla nebbia, come il profilo di un’isola misteriosa. Solo l’ultimo risalì la memoria tutto intero, il resto si agganciò a parole forti come “meraviglia”, “travaglio”, “seguitare”, finché la catena di suoni si ricompose, proveniente da chissà quale pomeriggio trascorso in sala studio quando ero in collegio. Così il muro, che poi seppi cingere un magazzino dei Monopoli di Stato, fece irruzione nella poesia di Montale, dando concretezza a quei versi che, a loro volta, ne illuminavano la superficie bruta in cemento armato, i ferri dentro la pancia del cielo, i cocci di bottiglia battuti dalla luce. E l’impressione che quelle parole fossero state scritte proprio per me, rompendo la solitudine di quel preciso momento in cui venni tentato dall’appoggiare la fronte sul vetro, diventò il sangue e l’ossigeno che attraversavano la mia carne, lasciandomi l’idea che, in qualche caso, il dolore può essere compreso. Che il dolore può essere portato dentro intatto e inoffensivo, come un proiettile che si è fermato accanto al cuore e che nessun chirurgo è stato capace di estrarre. tutto qui, se si ha la fortuna che le paro- 166 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo le ti vengano incontro e che, nella comprensione, sciolgano il nodo del male in una forma di desolata serenità che ti accompagna per il resto della vita. Io quella fortuna l’ho avuta. Le parole, con me, si sono sempre fatte avanti, lasciandomi ogni volta interdetto, come da ragazzino, quando la mia ombra rimase ferma sull’asfalto dell’estate mentre vedevo, negli alpini che passavano davanti ai miei occhi, i soldati di Hemingway diretti al fronte. Da quel giorno, la muraglia venne con me fino al momento delle dimissioni, mi seguì mentre andavo in palestra, dove l’obiettivo non era più limare di un decimo di secondo il mio tempo sui cento metri, ma fare male le cose che prima facevo con naturalezza; stava accanto a me quando andavo al bar dell’ospedale; era lì nel momento in cui i miei genitori capirono che non ci sarebbero stati né stampelle né bastoni a sorreggermi. Mi accompagnò ogni giorno di quei giorni e di quei mesi, la muraglia, mettendomi dentro la consapevolezza che ognuno di noi porta in sé un limite che è anche una soglia. Delle colonne d’Ercole che rappresentano l’invito a essere superate. Sono entrato in pronto soccorso la sera del dieci settembre del 1983. Sono uscito dall’istituto di riabilitazione nella mattinata del sedici marzo del Qu ESta LI b Ertà 167 1985. Sono date che si possono scrivere anche così: 10/09/1983 – 16/03/1985, con il trattino in mezzo. E benché inizio e fine abbiano importanza, è quel trattino teso fra loro come una fune che riempie di senso l’uno e l’altra e, illuminando, avvicina le due sponde. Come un funambolo, quella fune mi sono ingegnato a percorrerla tutta, cercando di rimanere in equilibrio tra soprassalti e incertezze e, soprattutto, evitando di farmi sbilanciare dalla paura di un baratro spalancato sotto ai miei piedi. allo stesso modo, del resto, hanno fatto i miei compagni di reparto, giovani e funamboli anche loro, ognuno con una sua strategia per rimanere sul filo e tutti animati dal grande, elementare istinto di sopravvivenza che ha reso possibile all’essere umano la conquista di ghiacci e deserti. Per questo non so con certezza se sia stata la lettura di Moby Dick ad avermi costretto fisicamente ad avvicinare le braccia al tronco insensibile, permettendomi la riconquista del corpo, o non, piuttosto, quella potente forza biologica. Né so dire quanto siano stati i versi di Montale in sé stessi, spinti alla luce dall’epifania del muro dei Monopoli di Stato, a dare avvio alla prima comprensione del dolore, oppure se sia stata la mia volontà che, come da un vaso colmo, in quel preciso momento, sia venuta 168 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo in luce e mi abbia spinto a cercare quei versi nelle profondità di me stesso. Dentro quel trattino fra due date posso metterci poche sicurezze. Senz’altro ho perso gran parte degli amici di prima: compagni di scuola, compagni di squadra o ragazzi del paese che all’inizio, passando a trovarmi, rappresentavano i pochi momenti di serenità nella giornata, da un certo punto in poi, divennero delle presenze imbarazzanti. Loro e io avvolti in un bozzolo di silenzio segnato dall’impotenza. Semplicemente, li guardavo come un reduce che torna a casa dal fronte, trovavo fatui i loro racconti da discoteca e di baldoria, incomprensibili le loro trepidazioni d’amore. Così, di volta in volta, le visite si fecero più brevi e più rade, finché presero il corso di una morte naturale. Ed era giusto così. L’età cadeva sulle loro menti fresche come un abito ben confezionato, era a me che ormai stava stretta e faceva affiorare da ogni suo strappo la crudezza di quanto era successo. Ho perso per strada anche i miei compagni di stanza, entrambi dimessi prima di me. Non conosco in quali luoghi il tipo dei Motorhead abbia portato la sua agilità, né so quanto il tipo da spiaggia sia riuscito a riedificare un mondo partendo dalle macerie del mondo di macchine potenti e belle ragazze dal Qu ESta LI b Ertà 169 quale proveniva. Poi, nonostante le promesse e gli scambi di numeri di telefono, sono stato io a lasciare un terzo compagno, arrivato un paio di mesi prima delle mie dimissioni e ancora disorientato e smarrito. Ed è naturale anche questo. rivedere le facce di coloro con cui si è condiviso per mesi – qualche volta per anni – l’esperienza di un dolore grande, avrebbe significato guardare in faccia il dolore stesso, ricondursi a vuoto dentro quell’esperienza. Invece il bisogno era di respirare a pieni polmoni la vita che premeva al di fuori dell’isola protetta dell’ospedale. all’elenco di perdite posso aggiungere anche quella del corpo sano e la rinuncia a qualsiasi forma di aspirazione a diventare un pilota. Ma ciò che è rimasto in piedi e che ha rappresentato la linea continua tra la vita di prima e la vita di dopo, è stata la letteratura. anzi, la passione si è liberata dal peso delle regole del branco. ridotta a una vita clandestina durante gli anni di collegio e di studio, ora bruciava più che mai. Mostrava i segni del suo divampare nell’affollato strepito di libri e riviste che ormai ingombrava per intero il lungo davanzale della finestra e parte del mio armadietto. Non mi accontentavo più di utilizzare i libri come un mezzo di trasporto per andare via lontano, adesso volevo catturarne e trattenerne la polpa 170 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo viva. In un primo momento sottolineando le frasi e le parole che mi colpivano, dopo, quando ne ebbi la possibilità, trascrivendole su dei quaderni. riservavo una facciata alle frasi e una alle parole; se quella dedicata alle prime costituiva il lavoro di un amanuense, l’altra si animava di un’attitudine creativa: mantenevo fisso un sostantivo, un aggettivo o un verbo e provavo ad accostare altri elementi per il puro e semplice gusto del gioco. Era la curiosità gratuita di un bambino che lancia un sasso contro un vetro per vedere l’effetto che fa. Chioma fulva. Chioma verdeggiante. Chioma educata. Chioma spumeggiante. Chioma di cometa. Chioma di sangue. Chioma delle onde. onde della chioma. Chioma fulva intorno alle montagne. Il tramonto è la chioma dell’estate. Così. Ho riempito in questo modo diversi quaderni, ma non ho riempito un tempo vuoto, perché è stato il tempo a riempirmi di sé. E, ancora oggi, considero quei balbettii le mie prime prove di poesia, se escludo gli scarabocchi con cui sporcavo i miei diari di scuola. Infine i miei genitori: attraverso la loro disarmata ingenuità, col tempo ho imparato a comprendere l’ingenuità di una generazione intera, l’ultima a confidare nel concetto di filiazione e la prima a entrare Qu ESta LI b Ertà 171 in massa nelle case di riposo. Il tessuto cicatriziale che ci ha di nuovo uniti è quanto mi è successo: dentro quel territorio impervio ci siamo mossi insieme, e io ho avuto l’occasione di attribuire il giusto significato alle parole “condotta” e “contegno”. Le sole lacrime che ho visto versare a mio padre sono state di felicità, il giorno delle mie dimissioni. Il sedici marzo del 1985 avevo paura. Custodito dal ventre tiepido dell’ospedale, avrei voluto rimanere lì, nella mia camera, a fare il monaco amanuense. Mi sarei accontentato di poco, qualche libro, qualche quaderno, una biro. Sarei stato un prigioniero intorpidito e felice. Mentre aspettavo mio padre, guardai il lungo davanzale vuoto, il letto ancora sfatto che era stato la mia isola di Circe. Le sue pieghe, nascondendomelo, mi avevano nascosto al mondo. all’arrivo di mio padre ero sul punto di piangere. Insieme, ci avviammo verso la palestra per salutare il mio nuovo compagno di stanza. Salutai tutti quel giorno, li salutai a lungo. Per trattenermi ancora un po’ salutai perfino il portinaio e scambiai con lui qualche parola di circostanza mentre mio padre aspettava. Fuori, al di là del vetro della porta automatica, il piazzale era stranamente vuoto, deserta la pen- 172 P I Er Lu I gI Ca PPE LLo silina degli autobus. Faceva freddo quel giorno di marzo, il cielo color metallo era tagliato dal vento e trascinava una pioggerella ostile. Quando Cortez sbarcò sulle coste del Messico, fece bruciare le navi. Con quel gesto intendeva spingere dentro la polpa di un mondo sconosciuto il coraggio dei suoi archibugieri. Innervato dalla disperazione, quel coraggio sarebbe diventato ferocia e quella ferocia avrebbe abbattuto un impero. Nel momento in cui mio padre prese la borsa da viaggio, io, senza la ferocia di Cortez, con una spinta decisa alla carrozzina, lasciai bruciare le mie caravelle alle spalle. Davanti, la porta automatica si spalancò su un continente ignoto. ringraziamenti Mettere un poeta al banco di prova di una scrittura narrativa, in prima battuta mi era parsa una sfida un poco folle. Come far correre a un centometrista i diecimila piani. Se sono arrivato a scrivere questi ringraziamenti significa che il centometrista ha fatto il fondista. E questo lo deve in gran parte alla presenza costante e al sostegno di Michele rossi e gemma trevisani: coloro che hanno lanciato la sfida. un grazie va anche a gian Mario Villalta, i cui preziosi suggerimenti hanno reso più lieve la stesura del quinto capitolo. Per le citazioni si veda: P. 35: Adesso io ho una nuova casa, in beppe Salvia, Cuore. Cieli celesti, rotundo 1988. P. 116: Prima luce, in giorgio Caproni, Tutte le poesie, garzanti 2010. P. 164-165: Meriggiare pallido e assorto, in Eugenio Montale, Ossi di seppia, oscar Mondadori 2012. Indice L’uomo che viveva con le porte aperte Il tempo che ci vuole ogni sguardo è moltitudine tutto il mondo al di là delle montagne Sangue e ossigeno ringraziamenti 11 29 55 87 107 173
Scaricare