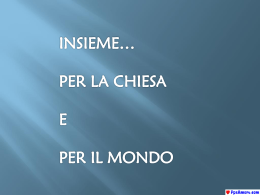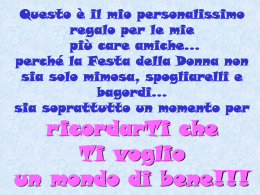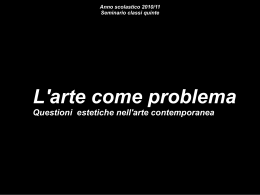QUARTO DIALOGO SULLA BELLEZZA TRA TOMASO KEMENY ED ENNIO ABATE I precedenti dialoghi tra Kemeny e Linguaglossa assieme ad altri interventi si trovano sul sito della Lietocolle libri a questo indirizzo: http://www.lietocolle.info/it/a_proposito_della_bellezza_dialogo_tra_t_kemeny_e_g_linguaglo ssa.html SULLA BELLEZZA E OLTRE Ennio Abate a Tomaso Kemeny e Giorgio Linguaglossa 1. Mi spiace dover criticare così frontalmente questo scritto [Cfr.DISCUSSIONE Tomaso Kemeny e Giorgio Linguaglossa a proposito della bellezza in questo blog] di Tomaso Kemeny. Perché ho avuto modo di conoscerlo di persona alla Casa della Poesia di Milano, ne ho stima e riconosco autenticità e forza al suo sentire. Non mi piacciono i polveroni né dare spettacolo del mio dissenso. Convinto però che esprimerlo abbia un senso e possa giovare al dibattito in corso e in accordo con lui, lo rendo ora pubblico, affiancando questo mio scritto agli interventi di Giorgio Linguaglossa e alla replica dello stesso Kemeny. 2 La prima critica generale che faccio a Kemeny riguarda la chiusura rigida del suo discorso al campo dell‟estetico, di affidarsi soltanto ad esso fino a fare della «Bellezza» quasi un feticcio, un‟entità salvatrice contro la «Morte». Le numerose maiuscole presenti nel suo scritto mi hanno reso subito guardingo. Mi segnalavano che il suo pensiero si muoveva tra astrazioni indeterminate (Brutto, Natura, Denaro, Bellezza). E indeterminato mi è sembrato il suo invito a ribellarsi che, se precisato, incontrerebbe sicuramente la mia simpatia. Kemeny – credo - ripete l‟errore che fu dei surrealisti (ma non solo di loro): mescola astrattamente desiderio e politica. Tanto perenne e infinito il primo. Tanto imprecisata la seconda. Quest‟ultima si riduce in fondo all‟uso di alcuni termini oggi di moda: «Impero», che è sulla bocca di tutti dopo il successo del libro di Hardt e Negri; «devastazione della Natura», un luogo comune (soprattutto in Occidente) dell‟ambientalismo apocalittico e decrescista alla Latouche; «Denaro», termine onnipresente nelle attuali (e superficiali) analisi della cosiddetta «finanziarizzazione», che hanno sostituito quelle marxiane dei rapporti sociali di produzione capitalistici ben più profonde ma ormai tabù. Il «Demone della Poesia» (io direi: l‟ideologia della Poesia e dei Valori) gli ha giocato un brutto scherzo. Lo ha indotto, in preda alla nostalgia, a indietreggiare ben oltre il terreno della modernità borghese: quello dell‟«ambivalenza della poesia». Allora i poeti riconobbero di essere sottomessi al potere o al denaro; e però non rinunciarono a inseguire tenacemente una qualche utopica «promessa di felicità» (Adorno), anticipandola nella loro opera. Li vedo ancora oggi come degli acrobati in posture instabili ma dinamiche: un piede saldo a terra e l‟altro già levato in alto (verso l‟utopia). Kemeny, invece, pare volersi liberare da ogni zavorra terrestre e da ogni ambivalenza storica per proiettarsi in un salto immortale e totalizzante verso la Bellezza. Ma per me essa è un simulacro, un fantasma, un pericoloso sogno. E non credo di essere uno degli odierni «ignavi» o un affezionato allo «stagno dei rospi razionalisti» se, come fece Dedalo con Icaro, gli faccio notare che in questa sorta di misticismo estetico le ali della sua utopia rischiano di bruciarsi del tutto, specie in un‟epoca come questa post-novecentesca che ha visto svanire anche quella utopia concreta pensata da Ernst Bloch. Né posso tacere che, malgrado la sua invocazione («E che la Morte non abbia dominio!»), il suo appello in fondo ci invita a giocare coi soliti «cadaveri squisiti» e nei soliti cimiteri onirici già frequentati , e non senza delusioni, dai surrealisti. 3. Sempre in segno di rispetto verso Kemeny, mi sono imposto di non liquidare con qualche battuta le sue «9 ragioni» e in modo analitico gli rivolgo le seguenti cinque critiche: 1. Non esiste un «Impero del Brutto». Esistono uomini, donne, animali, cose, che a seconda delle culture di riferimento, giudichiamo (quando giudichiamo esteticamente il mondo) belli o brutti. Accetterei perciò tranquillamente il punto di vista di Kemeny, se egli si fermasse a un uso circoscritto ed empirico dell‟estetica. Non quando, come in questo scritto - astrazione contro astrazione: «Morte» contro «Impero della Vita della Bellezza» - l‟estetico assurge a criterio esclusivo. E cancella persino il pur discutibile kalòs kai aghatòs dei filosofi greci o la stessa politica intesa come ricerca della res publica o del bene comune. No, la Bellezza no! - viene a questo punto da pensare allarmati. Non perché si abbia paura degli uomini belli, delle donne belle, delle cose belle. Ma perché gli innamorati del «Bello» in astratto fanno davvero paura. Quanto (mi) fanno paura quelli del «Bene» o della «Democrazia» o dell‟«Umanità» o della «Poesia» o della «Scienza» o di tutti i «Valori» astrattamente intesi. (Non aggiungo: del «Comunismo» perché di suoi innamorati non ne vedo in giro). Veniamo tutti dal Novecento e, malgrado le buone intenzioni, non siamo andati con certezza oltre. A me perciò viene subito in mente il nazista che poté trovare “bello” il fumo che saliva in alto nella nebbia notturna dalle ciminiere di Auschwitz. O l‟esclamazione arrogante di Enrico Fermi, infastidito dalle obiezioni di quanti temevano gli usi militari della bomba A: «Lasciatemi in pace coi vostri rimorsi di coscienza! È una fisica così bella!». E mi riempio di dubbi: e se il “brutto” contenesse qualcosa che tuttora garantisce la vita dei singoli (compresi i poeti) e delle società e la loro riproduzione? e se la vita, che al suo innamorato pare un valore assoluto rispetto alla morte, non fosse in sé né bella né brutta, ma insieme bella e brutta? 2. «Lo scollamento tra il mondo degli ideali-valori e il mondo effettuale» è antico; e la storia o la civiltà umana non hanno inventato finora nessuna “colla” per farli combaciare. Siamo tuttora costretti ad oscillare confusi tra i due poli; e, messi alle strette dalle circostanze, a scegliere: rimanere nel mondo immaginario ed etereo dei Valori o sporcarsi le mani col mondo effettuale. Kemeny sceglie la prima via e «la tensione verso l‟infinita bellezza-sublime» lo condanna a convivere da idealista – in modo dolente, mi pare, mentre altri si corazzano di superbia - con «l‟infinitamente piccolo e miserabile» che ci attornia. Altri (io tra loro) si sono convinti che le loro mani siano “sporche” dalla nascita (quanto quelle degli idealisti, che ritengono di averle invece pulitissime); e che conta non tanto il Valore in cui si crede, ma il grado di libertà (minimo in certi periodi della storia, più elevato in altri) costruibile dai singoli e dai gruppi sociali nelle circostanze date e non scelte. (Pertanto, a proposito delle «trovatine» degli artisti o dei poeti che Kemeny combatte, si deve precisare che possiamo rifiutarle non perché inadeguate all‟ideale Bellezza, ma perché ostacolano, con la loro parvenza di libertà, l‟accesso a una possibile realtà-libertà ben più alta e non puramente immaginaria). 3. La devastazione della Natura è (ho già detto sopra) un luogo comune dell‟attuale ambientalismo. Non nego le devastazioni tremende dell‟ambiente o del paesaggio avvenute o in corso. Diffido però di un pensiero ambientalista che separa le reali (non le presunte, perché allora precipiteremmo nell‟allarmismo e nell‟inganno) devastazioni della natura dalle devastazioni sociali. Separa cioè storia da scienza, natura da società. Né condivido la riduzione, che anche Kemeny accoglie in pieno, della natura a mito, a «Madre Terra» (una metafora ideologica, che il buon Leopardi seppe evitare). Se c‟è interdipendenza tra natura e società umane e bisogna tener presente che dalla natura tutti certamente dipendiamo, si sappia pure che oggi dai conflitti interni alle società (e agli Stati) dipende in massima parte ormai anche la sorte della natura. E allora non si capisce perché l‟ambientalismo su questi conflitti, che andrebbero gestiti in maniera possibilmente razionale, taccia. O li aggiri o li pospone, suggerendo indistintamente a tutti (quindi anche ai maggiori responsabili delle trasformazioni, che sono distruttive/costruttive, danno cioè benefici immediati a pochi e miseria o angoscia a molti) una lotta contro la «devastazione della Natura». Mantenendo così nel vago la causa principale che sta producendo da secoli ormai la generale e contraddittoria costruzionedevastazione sia dell‟uomo che della natura: il capitalismo. 4. E sempre nel capitalismo, prima con le società mercantili e poi con quelle industriali, il Denaro si è imposto come «misura» (del valore) di tutte le cose (natura compresa) e degli uomini, della cultura. Non soltanto delle «Opere d‟Arte» o della «Bellezza». Non è mai esistito un «Bello» incontaminato e senza legami (occulti o evidenti) con il «Denaro». Sarà banale, ma anche per pubblicare un libretto di versi c‟è bisogno oggi di un po‟ di denaro. E dovremmo risalire alle società primitive per non trovarne traccia diretta. Sebbene pure in quelle le cose “belle” avessero legami col potere magico-sacerdotale, che in effetti inventò o anticipò nei suoi templi la funzione ordinatrice e fluidificante svolta in seguito dal «Denaro» (dai mercanti, dalle banche) nei rapporti tra uomini e popoli. Il Denaro, dunque, resta il maggior simbolo astratto di poteri ben concreti. E purtroppo il pensiero estetico non riesce ad avvertirne il condizionamento, magari per concentrarsi (in parte produttivamente, ammettiamolo) sul puro estetico. Col rischio di non spiegarsi le ragioni per cui il Denaro (meglio: i rapporti sociali diseguali che esso raffigura, rappresenta) e non la Bellezza (o la Morale o la Sapienza) si sia imposto come misura; e come esso condizioni in profondità le altre sfere dell‟agire e del pensare umano, compresa l‟estetica. (E fa bene Linguaglossa, se intendo bene, a sollecitare una «critica dell‟economia estetica», che indaghi cioè sulla “connivenza” sorvolata o occultata tra Bello e sfera economica). 5. Le «9 ragioni» di Kemeny paiono rivolte esclusivamente a degli esteti, gli unici che a rigor dei termini dovrebbero essere più sensibili a un appello «in nome della Bellezza». Mi chiedo però: oggi che nella società dello spettacolo esiste un‟estetizzazione di massa (il fortiniano surrealismo di massa), la quale accontenta - diciamo - gli “esteti di bocca buona” (la massa degli esteti), quale Bellezza difenderanno mai coloro che aderissero a tale appello? O esso è rivolto a una élite capace di distinguere la vera o l‟autentica Bellezza da quella “falsa” inseguita dalle masse “estetizzate”(e anestetizzate!)? 6 Le obiezioni di Linguaglossa a Kemeny mi paiono rimanere sotto l‟ombrello del discorso estetico. Lo contestano, ma si limitano a contrapporre alla astrazione Bellezza un‟altra astrazione, la Parola (restiamo nel regno delle maiuscole!). Questa dovrebbe permettere ai poeti che la coltivassero o la ripristinassero in tutto il suo splendore (anche qui quanta nostalgia!) di «nominare il mondo, come hanno fatto Holderlin, Leopardi, Trakl, Mandel‟stam, Eliot»; e, per altra via dunque, di raggiungere sempre la stessa cosa: la Bellezza. Diciamo per la precisione: una Bellezza che si sia misurata con il mondo. Mi viene in mente un film: Andrei Rublëv di Tarkovskij. M‟impressionò. Vado a verificare: è del ‟69. Al di là del messaggio religioso del regista, mi colpì la descrizione della crisi vissuta dal pittore nei meandri violenti e sanguinolenti di un mondo feudale che si trasformava. Egli si fa coinvolgere dalla storia e dalle passioni della vita: i tartari assaltano la città; nella chiesa, dove sta dipingendo, si rifugia una sordomuta; e lui, per salvarla, è costretto ad uccidere. Poi, per espiare il delitto, decide di non dipingere e non parlare più per anni, fin quando riscoprirà il valore dell‟arte e tornerà alla pittura (l‟episodio per lui rivelatore e catartico è l‟incontro con un giovane che, sbalordendo tutti, fonde perfettamente una campana che pareva impossibile da realizzare). Linguaglossa accenna anche alla impossibilità di «parlare del Bello senza parlare della «critica dell‟economia politica» (l‟ho già citato); e così sembra spingere il discorso fuori dal solco estetico (ed estetizzante), ma poi ripiega. Le altre obiezioni a Kemeny mi sembrano di opportunità («che senso ha parlare, oggi, del Bello in un‟epoca di stagnazione stilistica e di conformismo retrogrado»). La spinta ad uscire dal puro estetico e ad affacciarsi sull‟abisso ignoto della «critica dell‟economia politica» resta incerta. All‟appello di Kemeny non risponde con un appello alternativo. Ad esempio: perché non andiamo - come poeti, eh! - a indagare anche noi su cosa sta accadendo in quel campo complicato (come faceva Dante ai suoi tempi studiando la teologia di Tommaso d‟Aquino)? 7 L‟accenno di Linguaglossa rimanderebbe nientemeno a Marx. Smuovere i poeti dalla Poesia e dal discorso sulla Bellezza per parlare o riparlare di lui? (Una volta, in altri tempi, circolò fugacemente un libro, «Marx per letterati: sconvenienti proposte» di Nicolò Pasero e lo vedo ripubblicato sul sito della Meltemi). O meglio di Das Kapital. Per chiarire in che rapporto stanno Bellezza e Poesia con questa «Cosa». Cosa? No, per Marx il Capitale, spuntato a un certo punto nella storia umana, non è una cosa (e io sospetto che non lo siano neppure la Bellezza e la Poesia). Esso non è né bello né brutto. Né un‟Entità Metafisica, né solo un‟Idea (come appunto la Bellezza, la Poesia, la Morale, la Democrazia). Uno che l‟ha studiato per una vita, Gianfranco La Grassa, dice per l‟esattezza che il capitale è un insieme di rapporti sociali di produzione, nei quali, a differenza di quelli del passato (feudali, del mondo antico), «la diseguaglianza reale [viene] celata dall‟eguaglianza formale dello scambio di merci tra i loro possessori posti su un piede di parità». Marx davvero aiuterebbe a capire che noi tutti - anche i poeti! - siamo dentro questi rapporti reali, costruitisi in secoli di storia e irreversibilmente consolidatisi a partire dalla rivoluzione industriale del Settecento. E che oggi vanno ancora mutando in forme non del tutto decifrabili neppure con le categorie (capitale, lavoro, profitto) da Marx tanto ben indagate. E che tali nuovi rapporti sociali (di produzione) si sono imposti col concorso di milioni di uomini e scelte precise di ceti dominanti. E che hanno modificato in modi sotterranei e poco evidenti anche i cosiddetti Valori eterni (Bellezza, Verità, Uomo, Vita). E che, se prima erano il principale rivestimento sublimato dei rapporti tra gli uomini, ora sono diventati un rivestimento sublimato secondario dei nuovi rapporti. Un declino, una decadenza, un tramonto, secondo alcuni; un progresso, una democratizzazione secondo altri. Sulle sue spalle di gigante, noi nanetti-poeti d‟oggi potremmo accorgerci che nelle società capitalistiche non domina in assoluto il Brutto; e che prima, in quelle precapitalistiche, non dominava in assoluto il Bello. Forse bello e brutto sono presenti nel capitalismo in forme diverse, in proporzioni diverse, con funzioni diverse che nel passato precapitalistico; e che più di ieri sono soltanto il contorno, la superficie, il logo, la faccia pubblicitaria, dei poteri reali che si fondano su ben altro. E riconosceremmo pure che questi poteri reali attirano, come accaduto in passato, anche il «Bello». Meglio: uomini, donne, animali, opere d‟arte o cose utili. I quali e le quali appaiono “belli” o “belle” – vedi un po‟! - soltanto o soprattutto quando entrano nell‟area d‟influenza di questi poteri reali: presidenti di repubbliche, magnati della finanza, guru intellettuali oggi; faraoni, imperatori, nobili del Medio Evo, borghesi dell‟ Ottocento ieri. Da Re Mida della storia sono essi, ben più degli studiosi di estetica e di noi poeti che ci affanniamo a discutere di bello e brutto, a condizionare pesantemente, irrimediabilmente, gli stessi giudizi estetici, che agli addetti ai lavori appaiono prodotti della libera ricerca intellettuale o poetica. 8 Torno di nuovo a Kemeny. Esaltando astrattamente la Bellezza (senza specificazioni storiche, sociologiche, antropologiche), egli trascura proprio questo legame indissolubile (e fondamentale finora) tra Bellezza e poteri. Questione, invece, chiarissima a certi autori del passato. Faccio tre veloci esempi (con mie sottolineature): 1) William Shakespeare. Lui, che di potere se ne intendeva, parlando dell‟oro, scrisse: […]Tanto così di questa roba Farà diventare bianco il nero, bello il brutto, giusto l‟ingiusto, nobile il vile, giovane il vecchio, prode il vigliacco.[…] (W. Shakespeare, Timone d’Atene, atto IV, scena III in Ceserani, De Federicis, Il materiale e l’immaginario, Vol 6, pag 595, Loescher, Torino 1981) 2) Daniel De Foe: [O denaro] tu sei la pietra di paragone della bellezza, giudice d‟ogni merito, arbitro della fantasia, stella polare dei sentimenti ( D. De Foe, Denaro, denaro! In «The Review, IV, 106, 16 ottobre 1707, sempre in in Ceserani, De Federicis, Il materiale e l’immaginario, Vol 6, pag 597, Loescher, Torino 1981) 3) Karl Marx, commentando il passo di Shakespeare citato sopra: […]Tanto grande la mia forza quanto la forza del denaro. Le proprietà del denaro sono proprietà e forze essenziali mie, del suo possessore. Ciò ch‟io sono e posso non è, dunque, affatto determinato dalla mia individualità. Io sono brutto, ma posso comprarmi le più belle donne. Dunque non sono brutto, ché l‟effetto della bruttezza, il suo potere scoraggiante, è annullato dal denaro. Io sono, come individuo, storpio, ma il denaro mi dà 24 gambe: non sono dunque storpio. Io sono un uomo malvagio, infame, senza coscienza, senza ingegno, ma il denaro è onorato, dunque lo è anche il suo possessore […] (K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, trad. it. Di G. Della Volpe, in K. Marx – F. Engels, Opere complete, Editori Riuniti, Roma 1976 sempre in Ceserani, De Federicis, Il materiale e l’immaginario, Vol 6, pag 661, Loescher, Torino 1981) Questi classici parlano di oro o denaro, ma senza mai dimenticare i rapporti reali tra gli uomini che oro e denaro rappresentavano. Quanto realismo e quanta cognizione precisa di come i dominatori (in questo caso i possessori di denaro o di oro) imponevano ai dominati la loro visione del mondo e facevano diventare bello quello che essi (quasi come oggi fa la TV) decidevano di far passare per tale! Alla luce di queste considerazioni (improprie? impoetiche? pessimistiche? lucide?), se i poeti credessero di essere ancora i gestori del Bello, di esserne i liberi professionisti, si sbaglierebbero. E se credessero ancora che i loro avversari (i sostenitori, passivi o attivi, di quello che Kemeny chiama «Impero del Brutto» e che io, invece, chiamerei capitalismo o, con La Grassa, capitalismi, intendendo anche quei sistemi affermatisi, dopo l‟epoca delle rivoluzioni comuniste e anticolonialiste, in Russia, in Cina o in India) abbiano in mano solo la bandiera del Brutto, prenderebbero una cantonata. Una valutazione errata della «realtà» (o del «mondo») non sarà mai un buon fondamento neppure per l‟auspicata (da molti) nuova poesia. I poeti oggi (o almeno quelli che non sono cortigiani dei potenti) devono pur sapere che non resta loro nessun copyright, imprimatur, brevetto sul cosiddetto Bello. E che, se si ribellassero agitando ingenuamente o fiduciosamente la bandiera del Bello, intendendolo come un Valore Universale, agiterebbero soltanto una bandiera che sta saldamente nelle mani dei potenti o dei loro cortigiani (proprio come succede con la Democrazia, la Morale e altri Valori). E, anche se agitassero, per reazione, come pur fecero le avanguardie o le neoavanguardie, quella del Brutto, agiterebbero lo stesso una bandiera dei potenti. C‟è da tornare a capire (perché c‟è stato già un tempo in cui qualcuno l‟aveva capito) che la discriminante su cui reimpostare una eventuale e solida «ribellione» non può essere estetica, che non c‟è da scegliere tra Bello e Brutto. La discriminante resta - anche per i poeti! – politica. Anch‟essi come tutti sono distribuiti nelle caselle gerarchiche mai fisse, ma che l‟andamento conflittuale spesso caotico e incomprensibile della storia umana continua a ribbovare e riprodurre senza farle davvero «saltare». Quelle dei dominanti e quelle dei dominati sono le più facili da individuare. In altri termini, con un po‟ di fortuna e d‟intelligenza, prima o poi si riesce a capire che - medico o insegnante o artista, o operaio o impiegato – si sta o in mezzo a chi ha reali poteri di decidere e determinare la trasformazione degli attuali rapporti capitalistici di produzione (e ha dalla sua denaro, scienziati, funzionari, spesso anche artisti e poeti che impongono le cose che devono passare per «belle» o che devono passare per un «brutto» artisticamente accettabile o commerciabile o spettacolarizzabile) o si sta tra chi è in posizione subordinata (e ha meno denaro, meno conoscenze, meno relazioni, e le stesse cose “belle” che gli stanno attorno o che produce non le può imporre come „belle‟ sul piano simbolico, perché questo pure è dominato da altri, è occupato dalle cose „belle‟ e „brutte‟ dei dominanti). Ah, queste cose come sono state dimenticate! E come le sapeva e diceva bene – e persino in poesia! - il pur cattolico e niente affatto buonista Manzoni: Ad innocente opra non v‟è: non resta Che far torto, o patirlo. Una feroce Forza il mondo possiede, e fa nomarsi Dritto: la man degli avi insanguinata Seminò l‟ingiustizia; i padri l‟hanno Coltivata col sangue; e omai la terra Altra messe non dà (Alessandro Manzoni, Adelchi Atto quinto/Scena VIII) Torniamocelo a dire anche noi: la Bellezza (come la Cultura, come la Poesia) è sottoprodotto dei poteri reali. Fino a qualche decennio fa Fortini lo ripeteva in tutte le salse. Eccone un esempio: Spesso mi è occorso di ricordare, in queste circostanze, il passo assolutamente straordinario della Odissea quando Ulisse ha compiuto la sua vendetta sui Proci, ha compiuto la terribile strage a colpi di frecce e tra i morti e gli agonizzanti si fa avanti il cantore, colui che in sostanza cantava narrazioni epico-liriche alla mensa dei Proci; gli si fa incontro, gli abbraccia le ginocchia, lo scongiura di non ucciderlo e lo scongiura di non ucciderlo dicendo: «sì, è vero io ho cantato per questi usurpatori ma l‟ho fatto perché vi ero costretto e d‟altronde sappi che io sono prontissimo a cantare anche per te; ma astieniti dal sangue di colui che in qualche modo è consacrato ad Apollo e che è quindi un personaggio sacro». Qui troviamo nello stesso tempo affermata l‟elemento di diciamo di grandezza e di miseria della tradizione letteraria, per cui per un verso c‟è una sorta di invisibile tonsura sacra sul poeta e, nello stesso tempo, c‟è l‟abiezione di colui che vive mendicando alla tavola dei padroni e dei potenti. Naturalmente Ulisse non uccide il cantore e da quel momento il destino del poeta e del letterato nella cultura occidentale è segnato. (Franco Fortini, Che cos’è la poesia? Intervista http://moltinpoesia.blogspot.com/search/label/Franco%20Fortini) a RAI Educational in 7. Il mondo effettuale (le società capitalistiche) funziona indipendentemente dal fatto che a chi ci vive dentro appaia bello o brutto, giusto o ingiusto, morale o immorale. Non potrà mai essere trasformato da una ribellione soltanto morale. Né da una improbabile crescita spontanea e massiccia dei desideri di Giustizia, di Pace, di Solidarietà, di Democrazia. E tantomeno di Bellezza. Fa male ripeterlo? Scoraggia? Distrae dalla Poesia? Non credo. È da poeti chiedersi quale poesia viene fuori, in apparenza spontaneamente, dagli odierni poeti che respirano in questi rapporti sociali di produzione capitalistica e che si vanno tuttora trasformando in mezzo a conflitti reali (guerre, crisi economiche e sociali), di cui ogni giorno i mass media ci danno una pallida eco. È da poeti interrogarsi su quale poesia potrebbe diventare possibile, se ci si sottraesse a questa respirazione coatta. I tentativi finora fatti (in particolare: socialismo e comunismo) di trasformare in senso razionale la poesia assieme alla società che l‟alimentava (e se ne alimentava) sono falliti. Siamo, se vogliamo usare la terminologia filosofica di Linguaglossa - al «nichilismo compiuto» (io, l‟ho detto, preferirei parlare di capitalismi ) e davanti alle rovine spesso grandiose della poesia (in minuscolo) che partecipò a quei tentativi di trasformazione. Puntare, come suggerisce Kemeny, all‟«esplosione della Beltà» trascurerebbe la distruzione della ragione (e delle nostre ragioni) compiutasi nel Novecento, isolerebbe i poeti nel regno di un astorico estetismo, li illuderebbe sulla possibilità di uscire facilmente - attraverso il sogno, l‟utopia astratta, la lotta per il Bello - dalla “complicità” in buona parte tuttora inevitabile con il sistema capitalistico. Il quale, finché non si riuscirà a far emergere forze capaci di costruire altri poteri in grado di soddisfare i bisogni materiali, culturali, spirituali delle società fuori dagli attuali vincoli, sicuramente vantaggiosi per pochi e svantaggiosi sotto tutti i sensi per molti, impedirà anche qualsiasi rinnovamento dei cosiddetti Valori (ivi compreso quello della Bellezza). Meglio allora essere servi coscienti della propria servitù – critici, dunque, e vigili e pronti a costruire in poesia e nella realtà piuttosto che abbandonarsi interamente al sogno. 8. Ho sostenuto sopra che la critica di Linguaglossa a Kemeny non si districa del tutto da quel (per me) nostalgico «anelito all‟Impero della Bellezza». Vorrei che lo facesse. Non credo che dovremmo arrossire se usiamo la parola „bellezza‟(in minuscolo). Mai la Bellezza è stata «innocente», se non nei Miti. Mai noi (o l‟umanità) ci siamo “congedati” dal «Bello», per il semplice motivo che mai abbiamo avuto tra le nostre braccia questa Astrazione. Abbiamo al massimo chiamato di volta in volta „bello‟ ciò che abbiamo desiderato o sperato: cose o persone o mondi, che allo stesso tempo ci apparivano (o credevamo potessero essere) belli e buoni e giusti e umani o magari santi. Si potrebbe continuare all‟infinito. Alcuni di noi, che pur veniamo dai tempi delle Grandi Narrazioni (che sono state grandi e buoni deliri sotto vari aspetti), abbiamo un piccolissimo vantaggio: non ci siamo rinchiusi del tutto magari in nome della Poesia, dell‟Arte, della Religione, dell‟Ideologia - nel nostro «linguaggio del bello» (o del buono o del progresso o del comunismo). E perciò, almeno un attimo, sotto i colpi delle sconfitte, della ripetuta «strage delle illusioni», delle evidenti e oscure trasformazioni in corso, ci siamo affacciati a una visione del mondo non più estetica, ci siamo accorti delle rughe, delle vene varicose sulle gambe, una volta statuarie, della Bellezza. Usiamo questo piccolo vantaggio. Ringraziamo i «maestri del sospetto» (Machiavelli, Marx, Nietzsche, Freud e molti altri) che una «critica del Bello» (ma anche della Verità, dell‟Arte, della Poesia) - diretta o indiretta - ce l‟hanno passata tra le righe delle loro opere. Tornare al Bello sarebbe rivestire di fiori le attuali catene del «nichilismo compiuto». Qui sono vicino a Linguaglossa. Ma non possiamo esitare sulla soglia. Dobbiamo procedere sulla vecchia via della critica delle Astrazioni, revisionare i nostri stessi maestri del sospetto quando fosse necessario; e non farci ostacolare nella comprensione dei reali conflitti che viviamo oggi in queste società capitalistiche che hanno spazzato via tutte le ipotesi di trasformazione razionale. Dobbiamo riprendere a ragionare non ad estetizzare (anestetizzarci). E usare le buone rovine di cui ancora disponiamo. Mentre Linguaglossa mi pare cerchi una soluzione ancora nel campo della verità religiosoletteraria («non provare a sostituire la parola «bellezza» con quella meno evanescente di «esperienza della verità» o «messa in opera della verità») e si chiede «come porre l‟esperienza del Bello nelle nuove condizioni del nichilismo compiuto», io mi chiederei che fare indipendentemente dal Bello e dalla Parola. Mi pare di poter dire che non sono né per la Bellezza né per la Parola. Sono per la critica continua, intelligente, tenace, di tutto quanto ci impedisce di accedere a una maggiore comprensione della realtà (e della poesia). Sono convinto che i poeti non debbano inseguire un fine (la Bellezza), non debbano neppure averne «paura» (chi ha paura della Bellezza è una domanda fuorviante e un po‟ intimidatoria). Il poeta deve criticare la Bellezza e gli altri Valori come Astrazioni pericolose, Ideologie, che gli impediscono di fare poesia. Se per poesia non s‟intende la propaganda di un Valore qualsiasi, né una forma laico-borghese di religione o un‟autoterapia o un‟autoconsolazione). Se per poesia s‟intende, invece, un‟attività intuitiva-pensante in sintonia per quanto è possibile (come accade anche per le scienze e altre forme di conoscenza) con le trasformazioni del mondo reale (preciso: interno ed esterno; soggettivo e oggettivo). Per inseguire queste trasformazioni reali anche i poeti devono capire in che collocazione si trovano rispetto ai poteri reali (ancora l‟esempio di Fortini sui Proci). E devono correggere l‟estetismo, la loro tentazione ricorrente. Chi mai obbliga la poesia (in minuscolo) a fare coppia stabile con il «Bello»? Baudelaire non la cercò nei fiori del male? Rimbaud non la trovò all‟inferno? Nessun medico ha prescritto ai poeti che debbano curarsi esclusivamente o soprattutto della Bellezza. O soprattutto ed esclusivamente della Parola (intendendo la Parola ispirata, che coglie la «Verità»). Ennio Abate 1 dicembre 2010/16 dicembre 2010 P.s. La posizione di Adele Desideri la rispetto, ma non coglie per me il problema principale. Che lei o noi, dopo Auschwitz (e gli orrori proseguiti dopo Auschwitz : Hiroshima, Vietnam, Burundi, attualmente Irak, Afghanistan), si riesca «ancora a dire di un paesaggio, di una poesia, di un'opera architettonica: "è bella"» è un‟affermazione leggermente ipocrita. Sembra si voglia preservare la poesia come spazio di buoni sentimenti o di Valori incorruttibili ed eterni, inattaccabili da quanto succede nel mondo «effettuale», nella storia. E Desideri, visto che si chiede «Che ne è di Dio, dopo l‟Olocausto?», trascura lo stesso pensiero teologico negativo, che pur si è fatto la stessa domanda, arrivando però a conclusioni meno rassicuranti delle sue. Sostenere poi che «gli orrori edilizi, la volgarità dilagante, i centri commerciali, la televisionepattumiera non sono ancora riusciti a distruggere né l'idea del bello, né le cose belle» dimostra solo una cosa: la enorme capacità degli stessi poeti di rimuovere i problemi posti in precedenza anche ai poeti da Adorno o da Benjamin o da altri poeti come Brecht, Fortini e molti altri. Questa rimozione mi pare un brutto viatico persino per quanti volessero scrivere soltanto buona poesia. Resta il fatto che una parte dei poeti e dei filosofi e degli scienziati ancora si pongono il problema che a Desideri e ad altri sfugge. E che è questo: quale rapporto c‟è tra orrore e cose belle? Cosa ci dice di noi stessi e della poesia questa sorta di tolleranza verso la normale coesistenza di orrore e bellezza, di ricchezza e povertà, di grattacieli risplendenti e di favelas o periferie, di scienza che costruisce «cose belle» e di scienza che crea oggetti di distruzione? Tomaso Kemeny a Linguaglossa e Abate Cari Giorgio Linguaglossa e Ennio Abate, pur con rispetto dovuto alla vostra disinteressata annosa ricerca del Vero e del Giusto, sento il bisogno di inviarvi queste righe. Ennio in particolare mi sembri vittima di un particolarmente invadente «principio di realtà» nonostante il fatto che, fin dagli inizi degli anni ‟70 Roland Barthes, con il suo Plaisir du texte e, poi, Jauss e la scuola di Costanza abbiano ampiamente sdoganato il principio di piacere come preponderante nella pratica della scrittura – lettura. Sull‟onda luttuosa dei francofortesi e delle loro filiali italiane, hai in misura significativa approvato la proscrizione implicita delle possibilità autentiche di espressioni poetico-artistiche nella situazione data, forse ritenendo che, dopo Auschwitz, Stalin e Little Boy sganciato sul Giappone, fosse il momento delle differenze desimbolizzanti e frammentanti, in qualche misura inevitabili col decentramento del soggetto desiderante. E fu, secondo me, questa proscrizione (tarda, in quanto dominante gli ultimi anni ‟60) a dare cittadinanza onoraria e ruolo dominante nei canoni deboli del „900 a opere aperte all‟informe (a cominciare dal verso libero - prosastico) e alla significazione irrisolta. In realtà fu il coro dei necrofori amorali e cinici a favorire la proliferazione di testi-mummia, messaggeri della manipolazione a freddo dei linguaggi e dell‟impotenza creatrice, di quel masochismo ibridante che indirettamente favorì la paccottiglia dei bestsellers e che spinse ad assegnare la nomea di artisti ai sarti (promossi a stilisti) e a conferire l‟aura di poeti a cantautori. E che dire del maestro di Giorgio quando esulta declamando come segue: «…dentro di te/ non c‟è niente/ c‟è soltanto il buco nero pieno di vermi/ e di serpenti velenosi…», quasi a sostegno del fatto che oggi, nel mondo della globalizzazione capitalistica, «la Bellezza sia una prostituta al guinzaglio del Potere». Nulla di più falso: come un NeoReMida, il Potere trasforma tutto ciò che tocca in similoro, il cui pseudo valore è fissato dal prezzo assegnato dal Mercato e non dal significato-estetico prodotto. Già Platone riteneva che la forza che eleva fosse il bello, la cui contemplazione, anche teorica, è quella che apre a ogni forma di virtù morale e civile. E l‟amico Alessandro Serpieri mi conforta affermando che «il bello è un bisogno prima che un desiderio». Del resto il valore antropologico della bellezza è evidente, la Terra essendo da millenni inseminata da forme di bellezza per tutti gli umani: si vedano le «Veneri» di Brassempouy (grotta del Papa, 22.000 a.C., a Saint-Germain-en-Laye) e di Lespugne (27.000 a.C., Haute-Garonne), nonché «il Grande cavallo pezzato», pittura preistorica (15.000, a.C., grotta a Pech-Mele) e, per un altro reperto, il «Boorak», «l‟uomo tuono», pittura rupestre (Terra di Arnhem, Australia). Dai pannelli vegetali della Papuasia, fino al carro rituale di Stettweg (VII sec. a.C., Stiria, Austria), dalla Nuova Guinea (l’uomo protetto dall’uccello, scultura in legno) alla Groenlandia (grande maschera di danza, arte eschimese, Parigi, Musée de l‟Homme), la forza magica della bellezza ha dato senso terrestre/cosmico alle espressioni umane in varie tradizioni etniche e forme. La scellerata volontà di potenza razziale di Hitler, esecutore massimo delle pulizie etniche, la demenziale dittatura ideologica di Stalin, che sterminò tutti i veri rivoluzionari in favore di una burocrazia da incubo, non sono motivo sufficiente per dimenticare la sublime eredità custodita dalla parola e dal pensiero di Ugo Foscolo che, per es., in Dell’origine e dell’ufficio della letteratura (1809), vede che l‟uomo, grazie alla fantasia, può «passeggiare sovra le stelle». E, per quanto la vita dell‟uomo fugga affannosa e le tenebre eterne della morte gli si addensino intorno, la fantasia creatrice lo riscatta alle stesse tenebre con «l‟armonia e l‟incantesimo delle parole». Ciò può avvenire solo grazie a quella «illusione» (termine foscoliano), o quella «sospensione dell‟incredulità» (termine usato da S.T. Coleridge), che sola ci permette di aprire le porte dell‟impossibile al vissuto. In un‟epoca in cui il termine «bellezza» veniva bandito dalle superstizioni epocali, nel 1982, scrivevo «La „bellezza‟ deflagra come appetito dell‟impossibile e di perfezione assoluta (anche se porta necessariamente le cicatrici del tempo storicamente marcato) e come tale non fiancheggia di certo la celebrazione dello staus quo (in “Residui di esperienza: il concetto di bellezza», in „L‟altro versante‟, Maggili editore, Rimini, maggio,1982, p.82). Mentre i Nazisti del Terzo Reich e l‟Armata Rossa si accingevano a stuprare e liquidare l‟Europa dei diritti civili e delle speranze rivoluzionarie (non si riprenderà più!), nel giugno del 1938, a Coyoacan nel Messico, Andrè Breton raggiunse Leon Trotsky e insieme stesero il manifesto antifascista e antistalinista dal titolo Pour un art révolutionnaire indépendent, per un‟arte contro ogni forma di imperialismo militare-economico, fondato sullo sfruttamento dell‟uomo sull‟uomo e sulla repressione della libertà di pensiero e di espressione individuali, per un‟arte che prepari un tempo in cui tutti i rivoluzionari del mondo sappiano “salutare la bellezza” come un bene individualmente e socialmente necessario. Per combattere oggi per la bellezza è fondamentale avere “quello sguardo mitico sul mondo e sull‟anima” di cui parla Giuseppe Conte (in “Il mito giardino”, prima ed. Tema Celeste,1990) e non farsi intimidire da un contesto sociale, facilmente criticabile, ma attivarsi a una resistenza individuale, preservando il pensiero dagli attentati del nichilismo e sottraendo l‟immaginazione e i corpi del sogno dalle evirazioni razionali perpetrate giorno dopo giorno dal principio di realtà. Così come il surrealismo nel passato, così, secondo modi, tempi e ragioni differenziate, il mitomodernismo ritiene che l‟ultimo valore fondante una possibile civiltà futura sia la “bellezza” (ultima Dea), sopravissuta con le Grazie (si veda l‟infervorata esclamazione davanti alle Grazie di Ugo Foscolo “Siete immortali, eternamente belle…”, in “Le Grazie, Carme ad Antonio Canova, Inno Primo, v.271”) alle catastrofi del „900. E, se è vero che il capitalismo globalizzante, motorizzando i proletari nei paesi di economia “avanzata” li ha trasformati in piccoli consumatori, con i frigoriferi riempiti di cibi preconfezionati e gli animi invasi dalle esigenze del superfluo, dilettandoli con spettacolarizzazioni mediatiche plebee, è falso, ripeto, caro Giorgio, pensare che la Bellezza possa venire prostituita dal potere, poiché Essa è ciò che al mondo manca, nonostante il terribile bisogno di Essa per la sopravvivenza della civiltà; e i mostruosi fallimenti delle promesse ideologiche del passato e dell‟involgarimento criminale del presente non ci autorizzano a trascurare la nostra libertà di combattere per la beltà e non ci permettono di sorvolare la nostra responsabilità per l‟effettuale trionfo del Brutto (si veda, a tal proposito, L’artista armato,contro i crimini della modernità del filosofo Stefano Zecchi, 1998). E, caro Ennio, quando Franco Fortini addita «la grandezza e la miseria» dei letterati, non fa che focalizzare rigorosamente una condizione «reale», con definite variazioni storiche. Ciò non ci autorizza a sbeffeggiare, con l‟alterigia di chi detiene le chiavi della Verità, coloro che ritengono fondamentale soddisfare il bisogno di bellezza nunc et semper. Liquidare teoricamente i tentativi di soddisfazione di questo bisogno, significa impoverire progettualmente l‟energia desiderante, quella che struttura l‟essenza stessa dell‟uomo e della donna dal tempo delle origini preistoriche. Nella situazione odierna parlare di Bellezza non è facile, e combattere per Lei (Fight for Beauty!) fa parte significativa del Dissenso al dato, in modo autonomo e permanente. Interpretare, poi, il desiderio di «Bellezza» come il desiderio di un «fantasma», in particolare in un Paese come l‟Italia (il Paese di Dante, Tasso, Foscolo, Ungaretti ecc., di Michelangelo, Leonardo, Raffaello, De Chirico ecc., di Rossini, Verdi, Puccini ecc., di Bruno e Vico, ecc., l‟Italia Paradiso degli esiliati come canta P.B. Shelley «Quanto è bello il tramonto/quando lo splendore del Paradiso/discende su una terra bella come te Italia,/Paradiso degli esiliati» in Giuliano e Maddalo), significa degradare la propria immaginazione ad ancilla di un pensiero politico inteso in tutta la sua alienante attuazione. Se è vero che il grado di libertà è da costruirsi dai singoli e dai gruppi sociali, è altrettanto verosimile che, per «cantare», è consigliabile rappresentare in modo stilisticamente personale ed alto ciò che può dare senso all‟esistenza e non è detto che la poesia non riesca a indicare qualche «uscita di sicurezza» dall‟Impero del Brutto che in ogni singolo istante valuta ogni cosa e attività secondo il Prezzo imposto dal Mercato. Se è vero che dai conflitti interni alla Società e tra gli Stati dipende la sorte della Natura, è anche vero che personificare miticamente il luogo dove siamo nati e dove vivremo finché la Morte non ci chiami, amandolo e invocandolo col nome di Madre Terra, significa amare il nostro destino, per quanto tragico, e significa evitare di identificarci ai pesci fuor d‟acqua in progressiva decomposizione. Se il Denaro è il simbolo astratto di relazioni e di poteri concreti, l‟eccessiva concettualizzazione analitica valorizzante i rapporti di produzione e di consumo può spingere all‟impotenza esistenziale e alla desimbolizzazione sistematica dei discorsi, riducendoli a una sequenza di segni comunicativi, condannandoli a languire nella gabbia allegorica aritmico-prosastica del nichilismo compiuto e dell‟insensato in poesia. Se è vero che nella Società dello Spettacolo è problematico distinguere tra il vero e il falso, continuare a oscillare tra il kitsch, la critica del virtuale e del dato, invece di concedersi senza esitazioni all‟ascolto del “Demone della Poesia”, significa consegnarsi alla nausea esistenziale tipica dei moralisti imbelli. Invito i poeti, i musicisti, gli artisti a non vergognarsi di diventare, ognuno alla propria maniera, medici della civiltà combattendo per la Bellezza e, senza prescrivere ricette, tracciare il prolungamento dei sentieri dell‟immaginazione collettiva impoverita, riacquistando, così, ai linguaggi espressivi la gloria che loro spetta. È giunta l‟ora di non trasfigurare la Terra Madre nella Valle della Morte (mi viene in mente una stanza memorabile di Giuseppe Conte- leggibile in L’Oceano e il ragazzo 1983): «Ritorno dove sono già stato/alle mura di una città calamitata/dalle costellazioni/diserbata, macigna, mare immobile/eterno/volo di pavoni di pietra e luce./Il sogno che io so di sognare/ l‟unico, il primo, mi conduce/là.) dove pavoneggiarsi come vittime (illuminate dal Vero) della Società e della Storia; è l‟ora di mormorare all‟ultima Dea: “Il sogno vincerà la re, la re, la realtà/ solo quando la ragione pratico-analitica/ alla tua forma divina/s‟arrenderà...» Tomaso Kemeny 14, XII, 2010
Scaricare