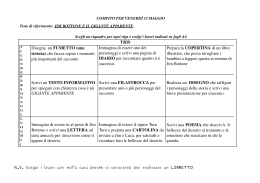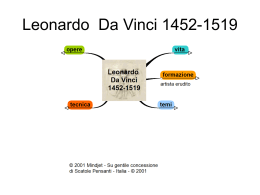Domenica La DOMENICA 27 FEBBRAIO 2011/Numero 315 di Repubblica cultura L’infinito gioco delle ombre ANTONIO GNOLI e AMBRA SOMASCHINI spettacoli Canta Napoli a New York e Tel Aviv CARLO MORETTI e JOHN TURTURRO Jonathan Franzen Le ambizioni Lui pensa ai soldi, lei al botox Un tranquillo matrimonio di paura ILLUSTRAZIONE DI GIPI Il racconto inedito dell’autore de “Le correzioni” JONATHAN FRANZEN a bellissima sorella minore di Antonia, Betsy, sapeva di non potersi aspettare neppure un briciolo di tatto o sensibilità da parte di Jim, suo marito — dopo tutto l’aveva chiesta in moglie dicendo «Se vuoi che ti sposi lo farò», e lei, dopo tutto, aveva accettato la proposta — quindi onestamente non poteva sentirsi offesa nel momento in cui lui prese a farle cenno dell’opportunità di ricorrere a qualche ritocco estetico. Far cenno per Jim era osservare, mentre Betsy si truccava davanti allo specchio della camera da letto, «Non è buffo che il naso e le orecchie continuino a crescere quando il resto del corpo si blocca?». Oppure, mentre festeggiavano loro due soli il ventesimo anniversario di matrimonio in una bisteccheria di Midtown dove tutti i camerieri lo conoscevano, annunciare di punto in bianco che se L una volta si faceva dei problemi morali riguardo alla chirurgia plastica ora «l’idea mi sta proprio conquistando». O, a cena fuori a mangiare aragoste con il suo partner di arbitraggio in borsa, Phil Hagstrom, e la giovane seconda moglie di lui, Jessica, sporgersi al di là del tavolo e poggiare il pollice che odorava di burro tra le sopracciglia di Betsy per poi dire, tendendo la pelle, con un largo sorriso didattico, «Non aggrottare la fronte, piccola». Betsy andava fiera delle sue doti fisiche naturali, fiera che fossero naturali — a quarantatré anni riusciva ancora a dimostrarne trentasei o trentasette — ma la eccitava, in qualche modo oscenamente, immaginare di mietere i frutti dell’aumento di volumi, di capitalizzare i vantaggi innati, incrementare il suo già imponente portafoglio estetico, potendo imputare tutta la responsabilità della trafila a Jim e alle richieste indelicate di Jim invece che alla propria vanità. (segue nelle pagine successive) le tendenze Borsello & hi-tech, ritorno al futuro LAURA ASNAGHI e IRENE MARIA SCALISE i sapori In principio fu il mais, poi venne l’Ogm CORRADO BARBERIS e LICIA GRANELLO l’incontro Riccardo Muti, “Il mio cuore allegro” LEONETTA BENTIVOGLIO Repubblica Nazionale 36 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 27 FEBBRAIO 2011 la copertina Franzen inedito JONATHAN FRANZEN (segue dalla copertina) Q uasi ogni anno il giorno delle elezioni Betsy faceva in modo di “scordare” di andare a votare, oppure solo dopo aver dato la cena ai figli e aver riempito di acqua bollente e schiuma profumata la vasca da bagno realizzata su misura in travertino con profondità extra “si ricordava” che i seggi erano ancora aperti e lo sarebbero rimasti per un’altra ora. Invece di rivestirsi, trascinarsi nella pioggia o nel nevischio e partecipare alla democrazia americana, si immergeva nella vasca e assaporava il piacere impuro di non aver votato contro la propria coscienza (che era stata democratica fin dall’infanzia a Cleveland) mentre Jim era andato e aveva premuto tutte le levette repubblicane disponibili sulla macchina per il voto, azionando poi brutalmente la leva grande quasi a enfatizzare l’odio sempre più profondo per i democratici progressisti, così che l’unico voto conteggiato del nucleo familiare andasse senza problemi a candidati che volevano sgravi fiscali per le famiglie ad alto reddito perché potessero spendere più soldi in articoli di lusso come la vasca da bagno di Betsy, fatta installare da Jim a suon di trentamila dollari sganciati sottobanco alla cooperativa per l’autorizzazione e in cui, come Betsy ammetteva disinvoltamente a se stessa, era piacevolissimo sprofondare in una umida e fredda serata di novembre. Betsy e Jim, un matrimonio come tanti, benessere senza aspirazioni, ricchezza senza soddisfazioni, scosse senza crepe. Il tempo che passa, le rughe che aumentano, la depressione che incombe, ciascun coniuge che diventa “depositario del segreto dell’inadeguatezza e della mancata ambizione dell’altro”. In un racconto mai pubblicato in Italia uno dei più grandi scrittori americani descrive come abbiamo dimenticato la cura per l’amore Bisturi e Prozac le correzioni per coppie felici Gli altri avevano sempre sovrastimato l’ambizione di Betsy e Jim. All’inizio i genitori di lei avevano immaginato che in segreto fosse addolorata per essersi sposata con rito civile, una cerimonia frettolosa e scialba, così diversa dal matrimonio in California, sulla spiaggia, di Antonia, la sorella. I genitori di Jim, a loro volta, avevano immaginato che il figlio si fosse infuriato quando Betsy, messo l’anello al dito, aveva smesso di lasciar intendere di voler diventare cattolica per lui. Sebbene Jim fosse schietto riguardo alla sua mancanza di interesse per qualunque cosa che non fosse far soldi e Betsy poco meno schietta sulle motivazioni che l’avevano spinta a sposarlo, nessuno aveva voluto credere loro. Jim aveva diligentemente speso una somma di pessimo gusto per la luna di miele a Parigi, e là, per due giorni, Betsy si impegnò strenuamente a seguire il programma turistico romantico da sposini, ma lei era incinta di cinque mesi, Jim pativa chiaramente l’impossibilità di accedere ogni ora ai mercati e la loro guida riccamente illustrata per yuppie danarosi agli autentici piaceri parigini per yuppie danarosi era come una guida dell’inferno. Lei non si era mai sentita più brutta e raramente aveva provato una più intensa antipatia per un’altra persona. La loro terza mattina in Francia, arrivati a metà del Pont Neuf sotto il cielo bianco di canicola Jim prese a strapazzarla urlandole brutalmente negli occhi: «Che cosa cazzo vuoi fare? Non mi hai detto una sola cazzo di cosa che vuoi fare!» e Betsy gli urlò in risposta: «Non voglio fare un cazzo di niente! Odio questa città e i piedi mi fanno male da morire e voglio andare a casa!». Al che Jim, a voce più bassa e aggrottando la fronte come sconcertato da qualche strana coincidenza, disse: «Ma è quello che voglio fare io». E all’improvviso tutti e due ridevano, si tastavano le braccia e le spalle e poco mancò che fosse il momento più romantico della vita di Betsy, lì, cotti dal sole e sudati nel bel mezzo di Pont Neuf, circondati dall’atroce bagliore della Senna, tutti e due d’accordo a gettare la spugna e a smettere di fingere. Andarono dritti al McDonald’s più vicino e poi tornarono nella loro stanza d’albergo extralusso per yuppie danarosi per una serie di giochi erotici da far rizzare i capelli inframmezzati da languide ore di tv in lingua inglese (Betsy) e di telefonate super tecniche all’ufficio di New York (Jim). Fare assieme i turisti terribili si rivelò così sconcio e stuzzicante. La resa congiunta alla noia, il rigetto dell’ambizione divenne il loro piccolo eccitante segreto. Alcuni, decise Betsy, semplicemente non erano bravi a vivere come altri: bravi per la cultura e l’avventura, bravi ad essere autentici e interessanti. «Io sono una persona di questo genere», pensò sollevata, «non dell’altro». Seduta agli Champs-Elysées mangiando un Bic Mac d’addio prima di tornare a casa con tre giorni di anticipo, provò uno slancio di gratitudine per Jim tanto forte da sembrare amore. E forse, pensò, era amore. Forse l’amore che dura non era altro che quello. Infischiarsene se tuo marito apostrofa in inglese i camerieri francesi chiedendo qualcosa dal sapore «più americano». Infischiarsene se tua moglie non ha la pazienza di fare la fila alla torre Eiffel. Compatire tuo marito perché la sua coscienza di cattolico lo aveva obbligato a sposare la prima ragazza che aveva messo casualmente incinta. Compatire tua moglie perché ha un approccio troppo femminile alla matematica e ai soldi per condividere il tuo interesse a seguire fino al quarto decimale i tassi di cambio franco/dollaro offerti da varie banche e agenzie parigine, contrapponendo il tasso migliore a quello ben più favorevole che un amico bancario di New York ti aveva fatto ottenere prima di partire, calcolando quante centinaia di franchi in più avevi avuto in cambio dei tuoi dollari rispetto a tutti questi yuppie americani che sapevano il francese e amavano il formaggio atteggiandosi a competenti e superiori. Ciascun coniuge depositario del segreto dell’inadeguatezza e della mancata ambizione dell’altro. Come due pessimi golfisti che a vicenda si incoraggiano a risparmiare colpi, migliorare il lie della palla, ottenere tanti mulligan, tante seconde opportunità. Ciascuno grato all’altro per la gran tolleranza: poteva essere amore? Apparentemente sì. Una dopo l’altra le coppie che inizialmente sembravano più felici di Betsy e Jim, più comunicative e espansive, presero a separarsi e divorziare e le mogli i cui matrimoni erano rimasti intatti confidavano a Betsy che la loro vita sessuale, ahimè, non lo era più, mentre Betsy, tra tutte la vecchia pigra Betsy, continuava a godere a intermittenza di rapporti dinamici con il suo compagno. Mentre altri genitori newyorchesi si organizzavano e si prostravano per far entrare i loro figli in speciali incubatrici di geni, Betsy e Jim si accontentavano per i loro, Lisa e Jake, di scuole meno esclusive, lasciavano che guardassero la tv e avessero libero accesso alle bibite, e non erano mica Betsy e Jim poi a ricorrere agli psicologi infantili e alle terapie familiari. O no? Il paragone con la sorella di Betsy era particolarmente gratificante. Antonia aveva sposato un dirigente della Silicon Valley con la faccia da coniglio che deliziava i genitori di Betsy raccontando di serate in compagnia di Bill Clinton e George Soros, e che, assieme ad Antonia aveva tirato su tre figli terribilmente interessanti. Uno aveva la testa rasata e una treccina di trenta centimetri e i suoi cortometraggi digitali erano stati in mostra al Sundance e a Toronto; l’altro aveva lasciato il liceo per leggere classici a Oxford su invito speciale. La figlia una volta aveva incollato assieme ottomila lattine di soda a formare una cella dentro la quale aveva inscenato uno sciopero della fame di tre giorni sul prato davanti alla Palo Alto High School, per protestare contro la strage di tartarughe marine ad opera degli imballaggi a sei anelli delle confezioni di lattine. Quando la madre le telefonava per aggiornarla su queste imprese, Betsy portava il cordless sulla terrazza all’ultimo piano, quella che spaziava sui cumuli smeraldini di Central Park, e rifletteva su quanto i suoi figli fossero piacevolmente normali e su come il marito di Antonia somigliasse a un coniglio spellato confronto a Jim. Jim, torreggiante, con la testa grande, era il suo protettore, il suo pitbull in completo gessato, il suo alano con i gemelli da polso. Nelle rare occasioni nuziali o funebri in cui tutta la famiglia era costretta a ritrovarsi, i suoi parenti di Cleveland fuggivano all’apparire di Jim. («Ci mancava questa rogna»). Solo Antonia era tanto temeraria da sfidarlo. Se li si lasciava soli per più di qualche minuto esplodevano in risse verbali sulla politica, villane e tristi. Bugie no stop sulla Fox — Sono antiamericani! Bugie no stop Jane fonda e il suo…. Ignobile! Corrotto! Incompetente! Ti pugnalano alle spalle… … e fu sull’onda di uno di questi litigi che Antonia prese da parte Betsy e le chiese con una smorfia: «Come hai fatto a sposare quello stronzo? Che cosa avevi in testa?». Betsy non aveva risposto, limitandosi a seppellire in silenzio la parola stronzo nel suo cuore, lasciandola imputridire finché sua madre non iniziò a telefonarle raccontandole episodi della infelice vita domestica di Antonia a Palo Alto e, in seguito, dell’esistenza da eremita che Antonia conduceva a Manhattan, dove si era trasferita per stare più vicino ai figli. «Abita a tre chilometri da te», diceva la loro madre, «È incredibile che tu neppure parli con lei». Betsy, seduta sulla sua terrazza, guardando al di là del parco, rispose allegra «In realtà sono meno di tre chilometri. Vedo casa sua da qui». Poi uscì e spese migliaia di dollari in gonne e vestiti aderenti, del genere che Jim amava vederle indosso. Un giorno d’inverno, non molto tempo prima che Jim iniziasse a menzionare la chirurgia cosmetica, Betsy ricevette una telefonata dalla figlia di Antonia, che viveva a Brooklyn. La figlia e la sua compagna davano una festa l’ultima sera di Hanukkah e speravano che Betsy e Jim andassero. Era uno strano invito, data la famosa antipatia di Jim per le festività ebraiche e la famosa antipatia di Antonia per Jim — Betsy sospettava che la figlia, invitandoli, volesse irritare Antonia — ma non c’era pericolo che Jim acconsentisse a partecipare. Almeno così pensava. Quella sera, tornato a casa dal lavoro, lui scoppiò a ridere e disse: «Una festa di Hanukkah versione lesbica? Senti senti. Meglio non dirlo a Hagstrom, sennò vorrà venire con noi a curiosare». La festa si teneva in una brownstone di Park Slo- Repubblica Nazionale LA DOMENICA DI REPUBBLICA 37 ILLUSTRAZIONE DI GIPI DOMENICA 27 FEBBRAIO 2011 L’AUTORE Nato nel 1959 e cresciuto in Missouri, Jonathan Franzen ha esordito nel 1988 con La ventisettesima città (Einaudi 2002) ed è stato consacrato dalla critica nel 2002 con Le correzioni (Einaudi 2002). È considerato uno dei grandi scrittori americani del Ventunesimo secolo. Pubblica racconti sul New Yorker e su Harper’s pe. Jim magari era andato con intenti maliziosi e offensivi ma nella casa in mattoni rossi lui e Betsy trovarono una trentina di ragazze e ragazzi con il viso pulito, posati, dall’aria sveglia, che bevevano vino, mangiavano cibo mediorientale e discutevano di argomenti che a Betsy erano, lo avvertì subito, nelle ossa, totalmente ignoti. Persino Jim, che normalmente non si faceva intimidire da nulla, esitò nell’ingresso finché la nipote di Betsy, una ragazza dai capelli corti, eccitata dal ruolo di padrona di casa, giunse in loro soccorso e li traghettò in acque tranquille, adatte a parenti più anziani invisibili. Lì trovarono ciotole di hummus e baba ghanoush. E anche Antonia, sola su un divano. Antonia era ingrassata dall’ultima volta che Betsy l’aveva vista, due anni prima. Sembrava una strega con i capelli mezzi grigi e stopposi e aveva l’aria torpida e assente, come fosse sotto farmaci, quando li salutò. «Ciao fascista», disse. «Ciao moglie del fascista». Rivolta a Betsy aggiunse: «Mi sembra di ricordare che tu ed io un tempo eravamo sorelle». «Era prima che mi sposassi», disse Betsy. «Giusto». Antonia si voltò verso Jim. «È ancora arrabbiata con me perché penso che tu sia uno stronzo». «Beh, anche tu sei una stronza», rispose Jim affabile. «Ecco. Vedi? Siamo sulla stessa linea». Antonia si mangiava un po’ le parole. «Non ha senso, giusto?». Betsy andò in cerca del bagno e controllò il trucco. Uscì e si mise a chiacchierare con una ragazza che poteva avere una trentina d’anni e sembrava sbalordita dalle risposte di Betsy alle sue domande cortesi su come impiegasse le giornate. «Ma non è una noia?», esclamò la giovane. Betsy si defilò in un angolo e si mise a osservare le altre ragazze briose che parlavano dei sindacati in Venezuela e del successo della Soft Skull Press e della fine della scena bhangra a South London e le veniva da piangere. Alle feste più normali c’erano sempre uomini che la guardavano e sentirsi così invisibile era sconfortante. Scolò un bicchiere di vino e se ne versò un altro abbondante. Lisa, sua figlia, aveva iniziato il college a settembre. Jake, suo figlio, quindici anni appena compiuti, era monosillabico e riservato. Sentiva la mancanza di entrambi e pativa la perdita di due dei suoi passatempi preferiti: far tardi con Jake a guardare le repliche su Nickelodeon e seguire religiosamente ogni partita di hockey su prato, ogni gara di nuoto e incontro di tennis di Lisa, accoccolata tra le altre mamme sentendosi parte di qualcosa. Varie volte in ottobre e in novembre Jim le aveva detto di prendere del Prozac, santo cielo, era stanco dei suoi musi. Finì il secondo bicchiere di vino e tornò al divano dove ora suo marito e sua sorella erano seduti fianco a fianco e litigavano come sempre, ma con uno spirito diverso. Da quando in qua, si chiese Betsy, fascista è un’espressione affettuosa? Era come se, nel tempo, grazie alle loro sfuriate, Antonia e Jim avessero guadagnato un’intimità e una confidenza che Betsy non aveva con nessuno dei due. «Quanto gli hai scucito poi a quel fallito?», chiese Jim. «Cinque milioni? Otto milioni?». «C’è un limite alla tua indelicatezza?». «Spero che tu non abbia toccato le sue patetiche stock options». «Dovresti venire da me una volta e valutare l’accordo», disse Antonia. «Ti lascerò solo con un metro e una calcolatrice e l’estratto conto. Pensa che bello. Potrai pensare solo ai soldi tutto il pomeriggio. Soldi e rabbia». «Voglio andare a casa», disse Betsy. Jim alzò gli occhi su di lei come sorpreso che fosse ancora alla festa. «Restiamo per il gioco della candela», disse. «Siediti, rilassati». Fu il gioco della candela a portare Betsy, qualche giorno dopo, da uno psichiatra di Park Avenue di nome Frank Clasper. Molte sue amiche e vicine di casa le avevano dipinto il Dr. Clasper come facile da raggirare, un distributore automatico umano caricato con gli psicofarmaci più in voga, e quando infine ebbe accesso al suo sancta santorum, dopo aver ascoltato la sua white noise machinee aver letto sulla maternità di Britney Spears più di quanto le interessasse sapere, scoprì con irritazione che Clasper si aspettava che lei parlasse di sé, che non bastava dirgli che era «un po’ depressa». Il medico portava occhiali con la montatura in corno, da collegiale, e aveva il modo di fare di chi è passato direttamente da un’adolescenza precoce alla tarda mezza età, poteva avere quarant’anni portati malissimo o sessantacinque portati benissimo. Le chiese cosa intendesse per «un po’ depressa». Betsy menzionò tristezza, scarsa energia, insonnia, perdita dell’appetito. Poi si interruppe e rivolse a Clasper uno sguardo incerto, sperando di aver detto abbastanza. Ma Clasper voleva sapere cosa di preciso l’avesse spinta a chiamarlo e ben presto si ritrovò a raccontargli tutto di Antonia, e della feste del gioco della candela. Conosceva il gioco della candela? «Me lo descriva». Era una tradizione della sua infanzia. Lei l’aveva del tutto dimenticato, ma Antonia doveva aver continuato a farlo con i suoi figli quando erano piccoli. L’ultima sera di Hanukkah, quando le candele della menorah si stavano consumando, ogni membro della famiglia diceva quale candela secondo lui si sarebbe spenta per ultima e tutti si riunivano attorno alla menorah e facevano il tifo per la prescelta. «Ho sempre odiato quel gioco», disse Betsy. «Va avanti all’infinito. Perché la fiamma può ridursi incredibilmente, diventare fievole, fievole, fievole, e ardere più a lungo di tutte. E poi, se la tua candela si spegne, devi comunque restare seduta mentre gli altri tifano per le loro. Ed è così stupido. Sono solo candele. Così in ogni caso, venerdì, non so perché mi ha irritato tanto, ma io ho scelto a caso una candela e mia sorella ne ha scelto un’altra e poi toccava a Jim scegliere. E lui ha scelto la candela di mia sorella». Clasper scriveva su un blocco note con una penna che agiva senza fare il minimo rumore. «Non lo capisco», disse Betsy. «Poteva prendere un’altra candela. La mia ad esempio. Avrebbe potuto scegliere la mia. O una terza candela. E stare lì seduta per mezz’ora con tutti quei giovani interessanti tanto più intelligenti di me, con mia sorella e mio marito che tifavano per la loro candela anche se si odiano, in teoria non si sopportano. In teoria. Ho dovuto restare seduta più a lungo di tutti, a guardare tutte le altre candele spegnersi, una cosa così deprimente. Una dopo l’altra». «Che cosa le hanno ricordato?» «Non so. La gente che muore?» «Sì. Che altro?» Scosse la testa e abbassò gli occhi. All’improvviso ebbe la sensazione di aver parlato troppo. «Le hanno ricordato la fine dei matrimoni?», disse Clasper. «Comunque... «, disse lei. «Si è sentita tradita da suo marito». «Mi ha detto lei di parlare». «E ha scelto di parlare di questo. Di sua sorella e delle candele. Perché?» «Perché dovevo dire qualcosa prima che lei mi facesse una ricetta». (segue nelle pagine successive) Repubblica Nazionale 38 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 27 FEBBRAIO 2011 la copertina Franzen inedito (segue dalle pagine precedenti) uole una ricetta? Gliela faccio», il Dr. Clasper prese un ricettario e le lanciò una lunga occhiata severa. «Mia sorella vinceva sempre», disse Betsy, distogliendo lo sguardo. «Quando eravamo piccole. Non so come faceva ma, tutte le sante volte, sceglieva la candela giusta. E per loro questo era Tutto. Giuro su dio, adoravano vederla vincere contro di me. Anche se lei era quella intelligente e io morivo di imbarazzo, e presumibilmente ne facevano una questione di giustizia». «Sì», disse Clasper. «Ma meglio interrompere ora». Posò la penna. «Ha intenzione di tornare da me?». «Dov’era l’ingiustizia?» «Potrei riceverla alle dieci venerdì». «Mi dica solo una cosa. Dov’era l’ingiustizia? Poi vado». «Davvero dobbiamo interrompere», disse Clasper. «Possiamo riparlarne venerdì se vuole». «Quella cosa sola», ripeté ostinata Betsy. Le era venuto in mente che se Clasper aveva quarant’anni portati male probabilmente non avrebbe avuto interesse per una quarantatreenne, ma se aveva sessantacinque anni portati bene era facilmente influenzabile. Chinò la testa e attese di verificare che valore avessero per lui le sue grazie. «Esiste il pregiudizio», disse lui infine, «che il bell’aspetto sia questione di fortuna. Un dono di nascita. Mentre l’intelligenza la sviluppi e la conquisti con fatica». Betsy sedeva immobile, respirando appena, emozionata. «Così per certe persone la ragazza bella è simbolo di ingiustizia sociale. Di immeritato privilegio. A volte è la ragazza stessa a sentirsi così. Ma ora davvero dobbiamo interrompere». «È così interessante parlare con lei», mormorò Betsy. «Signora Hanlon. Ora deve alzarsi e andare via. Vuol tornare venerdì?». Gli rispose di sì. Una volta fuori di nuovo però, e circondata da immobili straordinariamente costosi, dal mogano e dagli ascensori della vita di Park Avenue, ci ripensò. Immaginò di parlare di Jim con Clasper e di capire cose su Jim alle sue spalle e di lasciare Jim solo nella sua mancanza di ambizione, e il cuore le si gonfiò di compassione per lui. Sarà anche stato sgarbato con lei alla festa di Hanukkah, l’aveva ferita, ma non sapeva essere diverso. Era questo che lei amava in lui, era questo il loro accordo: non voler essere diversi. Nella situazione opposta — se Jim all’improvviso avesse avuto la pretesa di capirla e si fosse messo fare discorsi approfonditi con uno psichiatra arrivando a comprendere cose importanti sulla propria personalità — lei si sarebbe sentita abbandonata e tradita al punto da non poter sopravvivere. Le allusioni iniziarono sei settimane dopo, il giorno di San Valentino. Quella mattina, prima di andare al lavoro Jim sollevò gli occhi dal giornale e disse: «Vuoi sentirne una bella? Il primo ministro italiano si è appena fatto un altro lifting. È a capo di uno dei grandi paesi industrializzati e ha le palle di farsi un lifting. Ma ci pensi?». «Interessante», rispose Betsy. La sera tardi, prima di dormire, dopo il sesso, le chiese se secondo lei il seno di Jessica Hagstrom era naturale. «Beh in parte naturale», rispose Betsy con una risatina «e in parte no». La domenica dopo, prima ancora che lei si alzasse dal letto le portò un reggiseno e le consigliò di indossarlo non appena alzata invece di aspettare dopo colazione e lasciare che la gravità agisse per un’ora e più. «Okay», disse Betsy. Portò con sé il reggiseno nel suo spogliatoio e chiuse la porta. Un altro psichiatra, meno interessante di Clasper, le aveva dato delle pillole e ora ne prendeva una tutte le mattine. Le pillole avevano un forte odore sulfureo, di inferno, e la mandavano un po’ su di giri. Decise di prenderne due, per raddoppiare i giri. Aveva rifiutato unilateralmente di entrare in terapia con Clasper, aveva rinunciato per amore a quell’opportunità di essere diversa, e ora avrebbe dovuto ascoltare i consigli di Jim su come migliorarsi? Ingoiando la seconda pillola, oppose la mascella all’ambizione. Quella notte, mentre parlavano di un possibile viaggio alle Bahamas, Jim suggerì che forse, invece, potevano prendersi una vacanza chirurgica. «Un ritocchino per lui e per lei», disse. «Tu e io. Dai, scherzo». «Ci penserò su», disse Betsy. «V “Io ero rassegnata al fatto che sei uno stronzo, ma tu non ti sei rassegnato al fatto che non ho più venticinque anni. Hai violato il nostro accordo” E ci pensò su. Più che un pensiero: diede per scontato che si sarebbe fatta ritoccare lei per prima, presto, perché era la via più semplice per fare quello che facevan tutti, e poi avrebbe addossato la responsabilità a Jim, senza sentirsi in colpa e godendosi il risultato. Ma prima Jim doveva smetterla di rompere il loro accordo. Basta con le allusioni quotidiane. Era un punto preso da parte di Betsy, un comportamento assurdo, negarsi qualcosa che entrambi volevano, ma sapeva come si sentiva: lui doveva smettere di toccarla e tirarle la pelle con l’intento di migliorarla. Per tutto aprile e maggio le allusioni continuarono e Betsy, oltre alle pillole che puzzavano d’inferno iniziò a prendere un cocktail di tranquillanti e sonniferi che le dava quella zoccola del suo psichiatra. Ne assaporava gli effetti e apprezzava ancor di più la spensieratezza della resa, la pigrizia: giù la pillola e via! Era la sua personale forma di ribellione farmacologica. I giorni assolati di maggio le sembravano nuvolosi, finivano in poche ore. Le arrivavano zaffate di spinello dall’ala dell’appartamento riservata a Jake, talvolta anche di mattina, ma pazienza. Spesso ritrovandosi di fronte allo specchio non ricordava da quanto tempo era lì. Per l’ansia che le dava vedere la sua pelle diversa, all’improvviso molle come cera, non c’era niente di meglio che un altro calmante. E poi Jim smise di fare allusioni. Così. Di botto, come aveva iniziato. Ora che il decadimento di Betsy era certificabile lui perse interesse a migliorarla. Una settimana intera passò senza un solo accenno. Betsy ridusse le pillole e i giorni ripresero luce e infine una mattina, dopo essersi guardata allo specchio si sentì incoraggiata a stringersi a Jim e, con la bocca sull’orecchio, sussurrargli: «Sai quella vacanza chirurgica…». «Scherzavo», rispose lui. «Non per te. Ma io pensavo…». Jim si voltò dall’altra parte e allungando la mano le diede una pacca sul sedere. «Non preoccuparti. Stai bene così». Betsy portò i figli a Easthampton per due mesi. Tra una visita e l’altra di Jim nel suo letto il fine settima- na mangiava molta insalata, si ricopriva di crema solare, faceva strenuamente esercizio fisico ogni giorno con Lisa, corrompeva Jake con la birra per fargli guardare la tv con lei e osservava con crescente interesse i volumi aumentati che facevano mostra di sé ad ogni cocktail, su ogni spiaggia e in ogni ristorante. I volti scolpiti e rigidi. Quelli abbronzati e belli. Nel fresco climatizzato dell’alloggio in acciaio e vetro preso in affitto, con cuoca e giardiniere a tempo pieno, si sentiva come un faraone bambino infinitamente viziato, come la sorella di Re Tut o qualcosa del genere, in attesa di essere rinchiusa nella Valle dei Re. Di ascendere alla seducente immortalità, di essere laccata, dorata e sorridente all’esterno e chirurgicamente sterile all’interno, per poi, satura di ricchezza, completare l’opera trasformandosi in legno di cipresso e metallo prezioso e restando bella per sempre: questo sarebbe stato l’ultimo atto di deliziosa pigrizia della bimba faraone. Sopra la cassettiera di Jim tra il contenuto delle sue tasche — il ferma soldi, le chiavi della BMW e un tee da golf portafortuna — una domenica mattina Betsy notò una clip di metallo con sopra il logo del Metropolitan Museum. «Sei stato al Met?» gli chiese quando emerse dalla doccia. «Sì», rispose asciugandosi. «Come mai?» «Mi interessa l’arte, voglio imparare». Betsy aggrottò la fronte. «Vuoi dire come investimento?». «Sì, forse. Ma anche così, in generale». «E che cosa vuoi imparare sull’arte?». «Le varie scuole, gli stili. Impressionismo. Cubismo. Quelle cose lì». «Cose che dovrei imparare anch’io?». Jim alzò le spalle. «Non mi starei a preoccupare». Lui tornò in città e lei fu presa da un nuovo timore, un presentimento che si acuì quando tornò e trovò dei peli bianchi di cane, una bella quantità, sulla guida persiana davanti alla camera da letto padronale. «Chi è che ha un cane bianco?», chiese. «Non so», rispose Jim. «Un sacco di gente». «Sì ma chi è che è stato nell’appartamento ultimamente e ha un cane bianco?». «Sono rimasto in ufficio tutte le sere fino alle dieci o alle undici». Jim continuò a lavorare fino a tardi per tutto settembre, eccetto nei weekend quando, stranamente, rimaneva a casa e vagava da una stanza all’altra, passando il tempo con Jake, guardando la televisione e chiedendo a Betsy ripetutamente che programmi avesse. Se lei rispondeva che non ne aveva, annuiva e spariva. Se lei ne aveva, le chiedeva dove andava e a che ora sarebbe tornata. Un sabato Betsy andò a pranzo a Carnegie Hill con Jessica Hagstrom che, per qualche motivo, aveva voluto vederla da sola. Betsy incontrava spesso Jessica in compagnia, ma non avevano mai avuto una conversazione privata vera e propria e si chiedeva se il matrimonio di Phil e Jessica non fosse per caso in crisi. Quello che Jessica aveva da dirle, però, senza preamboli, non appena ebbero in mano il bicchiere di prosecco, era che Betsy doveva badare più a se stessa. Il timore che ultimamente era sempre latente in lei venne improvvisamente in superficie. «Come scusa?». Jessica sfregò lo stelo del bicchiere tra i palmi delle mani meravigliosamente giovani. «Pensavo solo che qualcuno dovesse dirtelo», rispose senza guardare Betsy, «Che magari potresti stare un po’ più attenta». Betsy incassò senza batter ciglio il commento che pensava riferito al suo aspetto fisico; la prese da uomo, come si suol dire. «Okay», disse. «Anche se vorrei dire in mia difesa che ho riflettuto molto sulla cosa. In realtà visto che stiamo parlando con molta franchezza forse tu sai darmi delle risposte a certe domande che mi faccio su questa esperienza». «Esperienza?». «Stavo pensando di farmi qualche ritocco». «Oh mio dio. È un’idea di Jim?». «Beh, inizialmente sì ma ora è più una mia Repubblica Nazionale DOMENICA 27 FEBBRAIO 2011 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 39 IL LIBRO Il nuovo libro di Jonathan Franzen, Libertà, uscirà per Einaudi il 15 marzo È la storia di un matrimonio americano contemporaneo, lo stesso tema affrontato nel racconto inedito che pubblichiamo in esclusiva in queste pagine idea…». «Ma è proprio quello che sto dicendo!» «Mi sono un po’ lasciata andare la primavera scorsa», disse Betsy, «ma ora ho ripreso a fare attività fisica, e sto più attenta a mangiare sano e…». «Quello che sto dicendo», la interruppe Jessica, «è che dovresti fare attenzione a quanto ami Jim». Betsy sgranò gli occhi. Jessica scosse energicamente la testa come a smentire le sue stesse parole. «Non so come dirlo diversamente. Mi preoccupa credo il fatto che tu non stia attenta come noialtre». «Noialtre?» «Come tutte. Come le altre donne. Ma sai, mi rendo conto che forse non è… che probabilmente non dovrei…». «Vuoi dire», esclamò Betsy alzando la voce, «tutte quelle che rubano i mariti? Intendi loro? Che non sono attenta come loro?». Scuotendo la testa Jessica aprì la borsa. Scivolò sul bordo della sedia e depositò due banconote da venti sul tavolo. «Mi spiace davvero», disse. «Mi sono appena ricordata che devo essere da un’altra parte tra dieci minuti». «Jessica…». «È stato un grosso, grosso errore». «Aspetta!» «Mi spiace» disse Jessica alzandosi. «Pensavo di doverti mettere in guardia perché ti ho sempre considerato una persona carina. Tutte quelle che erano state amiche di Christine mi trattavano male. Tu invece non sembravi farci caso, come se io non fossi l’ultima arrivata e pensavo che tu fossi più gentile delle altre. Ecco perché volevo fare qualcosa per te, tentare di metterti in guardia». «In guardia per cosa?». Ma Jessica non c’era più. Betsy bevve il suo prosecco e finì quello di Jessica. Mentre scendeva per Madison Avenue sotto l’effetto del vino le ombre lunghe già a metà giornata, l’improvvisa realtà dell’autunno, la disorientarono. Nella luce bassa che sdoppiava la visione vide come agli occhi delle amiche lei potesse sembrare narcisista e insopportabi- le, per via di Jim, vide che le amiche le sembravano unite tra loro più di quanto lei si sentisse vicina a qualcuna in particolare e che non se ne era mai fatta un problema perché non aveva mai avuto bisogno di loro, per via di Jim. Aveva gli occhi fissi sul marciapiede, ancora in lotta contro la luce mutata, quando passò accanto a un Jack Russell davanti al Corner Bookshop. Aveva il guinzaglio allacciato a un parchimetro e guardava fisso una persona all’interno della libreria. La persona somigliava molto a Betsy quando aveva venticinque anni. La persona teneva sottobraccio il marito di Betsy, che teneva in mano un libro aperto. Dava la schiena alla vetrina ma le spalle larghe, la dimensione della testa erano inconfondibili. Non leggeva narrativa ma era nel reparto narrativa. La persona aggrappata a lui aveva le dita sotto la sua ascella. Betsy sputò sul cane. Il cane ebbe un fremito. E Betsy sputò ancora. Il cane girò la testa per vedere la saliva che aveva sulla schiena e sul collo e prese a dimenarsi. Betsy inorridita di sé, corse via sul marciapiede, spintonando le persone, inciampando, sul punto di cadere. Quando Jim tornò a casa, un’ora dopo, Betsy era seduta nel grande salone di rappresentanza, quello che usavano per ricevere. Stava seduta come un faraone sul trono, eretta, le braccia abbandonate lungo i fianchi. Restò immobile quando Jim le si avvicinò. Disse: «Ti ho appena visto in libreria». Subito lui prese ad annuire con un sorriso nervoso come se lei gli stesse facendo una sfuriata invece di stare seduta in perfetto silenzio. Era una scena interessante. «Okay», disse lui. «Mi hai beccato». E poi, rabbioso: «Sei stata tu a sputare al cane? Qualche sociopatico schifoso ha sputato sul cane. Sei stata tu?». Restare seduta perfettamente composta, fare la bella statuina. La voce le frullò via da dentro come un uccello che emerge da un sepolcro. «Significa che ci lasciamo?». «Non lo so». Jim misurava la stanza a passi pesanti quasi a contrastare l’immobilità di lei. «Ma ora che la cosa è venuta fuori, ho intenzione di passare qual- ILLUSTRAZIONE DI GIPI “Non fare la stupida. Forse oggi ti do qualcosa in meno rispetto a ciò che ti davo un anno fa? Non saprei dire cosa ti manca. Quindi calmati” che notte e qualche fine settimana altrove». Un altro uccello frullò fuori dal sepolcro: «Non ti preoccupare di tornare». «Cosa? Non fare la stupida», disse Jim. «Forse ti do qualcosa in meno oggi rispetto a quello che ti davo un anno fa? Eh? Così su due piedi non saprei dire cosa ti può mancare. Quindi calmati». Suonava strano quel suo invito, dato che Betsy non ricordava di essere mai stata più calma di così. «Se stasera te ne vai», disse, «non voglio vederti mai più». Jim rise come rideva dei democratici. Uscì a grandi passi dalla stanza, si chiuse rumorosamente la porta di casa alle spalle e quando, un giorno dopo, ancora non era rientrato, Betsy mandò Jake da un amico e prese un taxi fino all’altro capo del parco, dove Antonia la strinse tra le braccia e le diede dei kleenex e cibo cinese e la fece pensare agli avvocati. «Andar via da casa?» disse Jim tre sere dopo, quando finalmente riemerse. «La stai facendo troppo, troppo grossa». Betsy era sveglia sdraiata al buio quando lui entrò in camera da letto. Senza alzare la testa né allungare la mano in cerca di un interruttore iniziò a urlare i misfatti di Jim. Lui andò a chiudere la porta del corridoio, caso mai Jake fosse ancora in piedi. «Okay, okay mi dichiaro colpevole», disse. «Vorrà dire che tu ora puoi tradire me, e poi siamo pari». Al che Betsy si alzo a sedere e accese la luce, per esser certa che lui vedesse il suo sguardo incredulo. «Quanto meno prendilo in considerazione», disse Jim. «Prima che le cose ci sfuggano di mano». «Sfuggire di mano? Sfuggire di mano? Tu ti scopi una — bambina — e vai per musei, in libreria…». «Puoi andare anche tu per musei. Nessuno te lo impedisce». «Ma tu odi i musei». «Sono un po’ noiosi, sì», ammise Jim. «Ma una volta che inizi a sapere un minimo di storia, dei Medici e che so io, lo sono meno». «Se tu fossi venuto da me e mi avessi detto “Facciamo assieme un corso al museo, impariamo qualcosa sull’arte assieme…». Jim fece un gesto di esasperazione. «Ma no. Invece “Vai a rifarti le tette”, “Vai a tirarti la faccia”. Da quando in qua a te piacciono i musei?. Non ho bisogno di ritocchi io! Sono ancora in splendida forma!». «Giusto. Per la tua età. Lo so. È solo che in questa fase sono interessato ai giovani. A stare con i giovani e scoprire come vedono le cose». «I tuoi figli sono giovani. Tuo figlio in fondo al corridoio è una persona giovane». «Quello che sto cercando di dirti è che non bisogna fare di questa cosa un problema così enorme. La supereremo, tu fai quello che hai bisogno di fare, io faccio quello che ho bisogno di fare e possiamo ancora invecchiare assieme». «Peccato che, a quanto sembra, io sia già vecchia». «Bets. Ci sono milioni di uomini che vorrebbero avere una relazione con te. Credimi. Oppure puoi iscriverti a un corso al museo. Puoi fare quello che vuoi. Pensavo che fondamentalmente fosse il nostro accordo. Essere un po’ tolleranti». Betsy sgranò gli occhi. Lui le rivolse un gran sorriso. «Giusto?». «Sì» rispose pacata lei. «Era il nostro accordo. Io ero disposta a rassegnarmi al fatto che tu sia un’incredibile stronzo. Ma tu non sei stato disposto a rassegnarti al fatto che non ho più venticinque anni. Sei stato tu a rompere l’accordo, e ora devi andartene». «Oddio. Mi sembra di sentire tua sorella». «Non sono io l’ambiziosa», disse Betsy. «Ah sì?». «Pensi che ti avrei sposato se…» «Non c’è motivo perché tu abbia questo atteggiamento nazista. Potresti solo rilassarti, come abbiamo sempre fatto». «Voglio che tu te ne vada». «E dove vado?». «Vai a vivere con la tua giovincella». «Non è esattamente una buona idea». «Allora vattene in albergo». «Senti, vado nelle stanze degli ospiti. Nemmeno mi vedrai». «Puoi restare una notte e fare le valigie. Ma poi via». «Piccola io scherzavo sui ritocchi. Te l’ho sempre detto no? Era per scherzo». «Mi fai schifo». Jim arretrò ondeggiando. «Meglio che tu ti calmi», disse. «Prenditi un po’ di tempo e calmati». Il giorno dopo Jim affittò una garçonniere al Mondrian, ma ci volle quasi un mese, oltre a una telefonata molto dura da parte dell’avvocato di Betsy perché lasciasse la stanza degli ospiti in cui si era accampato, riempisse qualche valigia e andasse via sul serio. Poco tempo dopo lui e la proprietaria del cane smisero di frequentarsi, a detta di Jake, che riferì anche come nella cucina della garçonniere non ci fosse nulla da mangiare, neppure noccioline e olive per il martini, e che Jim aveva preso ad utilizzare un servizio di incontri on line. Betsy doveva sforzarsi di non pensare a lui con una sconosciuta. Non c’era cosa che la avvilisse di più che sentirsi tenuta a compatirlo per la sua goffaggine e cafoneria. Quando la donna delle pulizie le disse che qualcuno passava di nuovo la notte nella stanza degli ospiti, Betsy non perse tempo a dire al suo avvocato di dire all’avvocato di Jim di dire a Jim di stare alla larga. Jim la chiamò sul cellulare il pomeriggio stesso. Disse che gli mancava casa sua e che non vedeva cosa ci fosse di male nel sistemarsi lì per la notte se arrivava molto tardi e andava via molto presto. Betsy gli attaccò il telefono. Lui richiamò e disse che anche se divorziavano non vedeva il motivo per cui non potessero continuare a vivere nella stessa casa, invecchiare insieme e prendersi cura l’uno dell’altra. Betsy spense il cellulare. Quella sera, non riuscendo a dormire, vagando per l’appartamento notò la luce accesa nella stanza degli ospiti, dietro la porta chiusa. Rimase lì a fissare la porta, raffigurandosi l’uomo rimpicciolito dall’altra parte. Di tutti i tradimenti di Jim, la debolezza nel suo tornare strisciando da lei era quella che le faceva più male. Betsy aveva sempre mentito a se stessa sul fatto di essersi accontentata di una vita in tono minore. La verità era che lei aveva idealizzato Jim. Solo ora, che non lo provava più, comprese l’immenso piacere che le aveva dato il rendersi stupida, capì che straordinaria fortuna avesse avuto Jim a trovare una moglie così candidamente indulgente come lei e quanto dolorosa fosse quindi anche la perdita che lui aveva subito. Se andava via era uno stronzo e se tornava era una mammoletta. L’ambizione di lei li aveva distrutti. Quindi toccava a Betsy andar via. Traduzione di Emilia Benghi (© 2011 Jonathan Franzen/Agenzia Luigi Bernabò Associates Srl) © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale 40 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 27 FEBBRAIO 2011 CULTURA* Dal mito della caverna di Platone fino agli abbagli della Modernità, che conquistando la luce elettrica si era illusa di aver vinto per sempre il mondo degli spettri e degli incubi. In una mostra che a breve si aprirà a Modena, ecco rappresentata in oggetti, disegni e forme, la storia della compagna più antica che l’essere umano abbia mai avuto Fonte d’ogni paura, ma anche di arte, gioco e spettacolo La nostra Ombra La sottile linea scura tra noi e il corpo dell’anima ANTONIO GNOLI ra i tanti significati che l’ombra riveste ce n’è uno che li sovrasta tutti: la metamorfosi dal visibile all’invisibile. Oliver Sacks ne L’isola dei senza colore ci racconta gli effetti di una malattia misteriosa che affligge una popolazione della Micronesia, ne ottenebra l’intelligenza, rendendo progressivamente ciechi o monocromi i suoi abitanti. Possiamo immaginare quest’isola come una terra di mezzo, sovrastata da ombre, alla stregua della Terra di Mordor nel Signore degli anelli in cui le tenebre hanno la meglio sulla luce; o Gotham City dove la vita si svolge all’insegna dell’oscurità. Lo sappiamo, le ombre appartengono alla nostra esperienza e alla nostra mente, alla nostra storia e alle nostre paure. Ci sono secoli più bui di altri; capolavori — come il Don Giovanni — che dell’ombra si nutrono; ci sono quadri di Caravaggio, di Turner, di De Chirico che dell’ombra hanno fatto la sostanza più intima. L’ombra misura il tempo della meridiana. Ma può darci la misura ben più allarmante del no- T stro declino. Per le sue caratteristiche sfuggenti è più prossima alla notte che al giorno, alla morte che alla vita, alla vecchiaia che alla giovinezza, alla malinconia che alla gioia. Ma essa, al tempo stesso, può diventare fonte di ristoro. Nel suo elogio, Borges la paragona alla propria cieca vecchiaia: è un’ombra mite che non fa male e somiglia all’eterno, egli dice. Duemilacinquecento anni prima, Platone — il primo e convinto ombrofobo — coglie negli effetti dell’ombra l’illusione che essa possa conformarsi al vero. Da cosa gli deriva tanta acredine? Platone ragiona in termini sottrattivi: l’ombra, per le sue caratteristiche, pregiudica il più eletto tra gli organi: la vista. È un allontanamento o una mancanza di luce. O meglio, della luce ne dà una fioca rappresentazione. Però quelle statue — di cui i prigionieri della caverna colgono le sagome, come proiettate da un sole esterno — richiamano per singolare analogia quanto la tecnica realizzerà col cinema alla fine dell’Ottocento. Il cinema è figlio della lanterna magica e della fotografia: della meraviglia e della realtà; dell’ombra e del vero. È come se Platone lasciasse il posto a una nuova forma di conoscenza (e di divertimento) nata da un diverso modo di percepire l’immagine. Nel cinema trionfano l’ombra della sala e le dissolvenze dello schermo. È la prima grande industria dell’immateriale. Non a caso Joseph Roth, ne L’Anticristo, definisce Hollywood «il paese delle ombre». L’ombra cinematografica sviluppa significati puntualmente inquietanti. Quella minacciosa del mostro di Dusseldorf o adunca e ingobbita di Nosferatu, ci avvertono di un disagio prossimo al terrore: nulla di buono si annuncia. Torna — sotto una forma diversa — la condanna dell’ombra: le si attribuisce il presagio di una morte prossima. Nel regno delle ombre sono in agguato i vampiri, lontanissimi antenati di figure che l’antichità aveva confinato nell’Ade. Dal regno dei morti — racconta il mito di Euridice — Orfeo tenta di strappare l’ombra dell’amata. Ma girando lo sguardo verso lei, la condanna all’invisibile. Col tempo l’ombra diventerà una presenza familiare, una convivenza necessaria con il corpo e gli oggetti. L’illuminazione elettrica — segno eloquente di un progresso scientifico — placherà quel senso di turbamento che le ombre (soprattutto nottur- Repubblica Nazionale DOMENICA 27 FEBBRAIO 2011 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 41 Teatro, cinema e pubblicità l’invisibile non si nasconde AMBRA SOMASCHINI agomainquieta, seconda natura. Fuggevole, illusoria e mutevole, il lato oscuro di noi. L’ombra ci accompagna e ci divide, attrae e spaventa, dissolve l’io dal suo centro e lo ricompone come in uno specchio dalla consistenza volatile e nera. Le trame d’ombra sono state cucite insieme dall’antichità al Novecento, ora raccontate da una mostra e un catalogo al Museo della Figurina di Modena (curati da Roberto Alessandrini e Paola Basile, 4 marzo-7 luglio). Un mosaico di filosofia, teatro, cinema e pubblicità in una sequenza che porta dal mito della caverna di Platone fino al moderno che dissolve il soggetto e mette in crisi la centralità dell’uomo nell’universo. La figlia del vasaio di Corinto, in Plinio il Vecchio, traccia sul muro il disegno del suo amore partito per un viaggio seguendo il segno di un’ombra proiettata da una lampada a olio. Il padre ne fa un modello d’argilla, scolpisce il suo pensiero. Le ombre platoniche sono sulla soglia che separa la luce dalle tenebre e le prime lanterne magiche sono le radici del cinema. Le ombre cinesi sono le antenate dei cartoni animati e le macchine per la silhouette costruiscono un universo mobile che si anima dietro i teli degli spettacoli popolari e diventa teatro. Il Settecento alle ombre si appassiona: le cineserie suscitano curiosità e il carattere delle persone si legge nelle sagome, mentre nell’Ottocento stampe e bolli chiudilettera svelano le forme dell’invisibile e le figurine semoventi rappresentano il lato oscuro del reale. Quello che Jung definirà la prima raffigurazione archetipa incontrata lungo il cammino della via interiore che porta a galla la coscienza e il nostro sé. L’ombra diventa la seconda natura degli esseri, un’appendice che si vende e si confeziona, come quella cucita da Wendy per Peter Pan. Si separa dal corpo e ne riproduce la sagoma fatta come un sacco vuoto. Siamo nella modernità e le ombre diventano cinema con l’espressionismo tedesco e il noir americano e finiscono sui Notgeld, i biglietti-denaro di emergenza usati in Germania per fronteggiare la crisi economica. E conquistano vita autonoma nelle fiabe e nei romanzi. Scrive Oscar Wilde: «Ciò che gli uomini definiscono l’ombra del corpo non è l’ombra del corpo ma il corpo dell’anima. Mettiti sulla sponda del mare con la schiena rivolta alla luna e taglia via l’ombra dai tuoi piedi che è il corpo della tua anima, e dì alla tua anima di abbandonarti, e questa lo farà». S © RIPRODUZIONE RISERVATA LE IMMAGINI Figurine e silhouette, pubblicità di diete e cioccolate, bolli chiudilettera. Materiale che verrà presentato dal 4 marzo al Museo della Figurina di Modena ne) avevano scatenato. Non si può fare a meno della propria ombra. Come non si può fare a meno del denaro. Ne sa qualcosa Peter Schlemihl — protagonista del racconto di von Chamisso — che la vende al diavolo in cambio di una borsa piena d’oro. Se l’ombra è barattabile vuol dire che possiede le stesse caratteristiche della merce: ha un valore di scambio. E d’altro canto, la stessa merce — con i suoi geroglifici — custodisce un’ombra enigmatica che la allontana dal valore d’uso per esaltarne il segreto che custodisce. Le ombre circolano indisturbate. Si tratta di dar loro una patente di innocua rispettabilità. Per un verso le leggi dell’ottica ne spiegano il fenomeno: le osservazioni attorno alle eclissi attenuano lo sgomento che gli antichi provavano davanti all’oscuramento del sole. Dall’altro, è la pubblicità a suggerire in che modo l’ombra allude al vero senza esserlo. Appartenendo alla categoria del somigliante, l’ombra può essere e non essere. Equivoca come un’immagine pubblicitaria, si concretizza nelle figurine e nei manifesti che reclamizzano — grazie alla tecnica delle ombre cinesi — cioccolata e formaggi. Un mondo di bambini — nelle fog- ge di adulti in miniatura — dispiegano con le loro manine ricomposte ombre di animali. Per invogliare al consumo, la merce — è quanto già accade negli expo universali — deve suscitare meraviglia e sogno. È distante la tersa e drammatica consapevolezza che Joseph Conrad esprime con La linea d’ombra. Nel romanzo si scorge il passaggio dall’età giovane all’adulta. E si tratta pur sempre di una linea invisibile e inafferrabile come un’ombra che inghiotte i nostri sogni, le nostre illusioni, nella bonaccia di un mare immobile. La stessa evoluzione che conduce alla conquista della luce elettrica, la stessa idea di progresso che spinge la ragione a cercare regole e chiarezza, la stessa convinzione che le passioni debbano essere messe a tacere per quel tanto di ombroso e di torbido che esse rivelano, mostrano a quale smania di pulizia si lascia andare il Moderno. Ma la battaglia per distogliere il mondo dagli spettri, dagli incubi, dalle follie non è affatto vinta. Occorrono pensatori forti e sospettosi per richiamare l’ombra alle sue complicazioni notturne, alle sue profondità ancestrali. La psicoanalisi riflette sugli incante- NOTEGELD Qui sopra le ombre che sostituivano il denaro in Germania e in Austria nel 1920 simi interiori, su ciò che l’inconscio continua a smarrire della propria identità. Prima Freud — con il lavoro sul perturbante — e poi Jung con l’archetipo dell’ombra scompaginano il quadro rassicurante di un individuo felice e conciliato. L’ombra estende nuovamente il proprio potere destabilizzante. Assume forme e toni che non ci aspettavamo. Torna sotto forma di simulacro (televisivo) e di segreto (politico). Quel tratto machiavellico dell’agire nell’ombra — perché il potere ama il nascondimento — sembra scontrarsi con le nostre coscienze. E se da noi oggi vigesse l’ombra di un governo, vorremmo che tutto tornasse alla luce del sole, senza ambiguità né resistenze, con la giusta trasparenza che si richiede a chi pretende di guidare il paese fuori dalle ombre. © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale 42 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 27 FEBBRAIO 2011 SPETTACOLI In principio furono Frank Sinatra, Dean Martin e Presley Da allora il filo rosso che lega molti artisti stranieri alla città di Murolo e Carosone non si è mai spezzato Ora tocca alla cantante israeliana, che domani presenta il suo disco intitolato “Noapolis”, immergersi in quella lingua e in quelle sonorità. Mentre il regista di “Passione” racconta perché i vicoli di questa metropoli sono una fonte inesauribile di ispirazione Song’e Napule Da Elvis a Turturro e Noa l’eterno fascino del Golfo CARLO MORETTI l bello delle canzoni» amava dire Renato Carosone «è che quando funzionano hanno una vita indipendente dal loro autore, dai dischi, dagli interpreti». Una volta scritte, appartengono a tutti. Una frase che l’israeliana Noa, mezzo secolo dopo, sottoscrive e completa con parole quasi identiche: «Io sono quelle canzoni, cantandole divento quelle storie e i sentimenti che le hanno fatte nascere». Israeliana dalla voce mediterranea, interprete della colonna sonora da Oscar de La vita è bella di Benigni, Noa è l’ultimo filo rosso che lega Napoli al mondo. L’ultima artista conquistata dal nobile repertorio delle canzoni napoletane che hanno fatto scuola. L’ultima in ordine di tempo a farsi stregare. Dopo Boris Vian, per esempio, che tradusse proprio il capolavoro di Carosone Tu vuo’ fa’ l’americano, alla fine degli anni Cinquanta, ironizzando sull’invasione della canzone italiana in Francia e sui francesi che imitavano i napoletani. Dopo il rapper francese Akhenathon, per il quale negli anni Novanta la stessa canzone di Carosone è servita a ironizzare su quanti in Francia imitava- «I no il rap di Harlem. E prima ancora, la grande melodia ha affascinato le voci della lirica ma anche artisti pop e rock: Elvis Presley rese appetibile ’O sole mio per il mercato americano cantando It’s Now Or Never, Dean Martin riprese in napoletano Dicitencello vuiee Guaglione, Frank Sinatra ’O marenariello e Luna rossa, interpretata decenni più tardi anche da Caetano Veloso. Tutti segnali di una vitalità che il tempo non riesce ad arrestare. E questo filo rosso che unisce Napoli al mondo passa ora anche per Tel Aviv: due porti di mare, di dolorose partenze e di agognati ritorni, di struggenti malinconie ma anche due città ricche di ironia e vitalità. Noa viene da lì, e le due città le considera facce di una stessa medaglia. Lì ritorna sempre, conosce alla perfezione quel filo e lo riannoda continuamente. Ha dedicato gli ultimi anni a far viaggiare tra le due sponde del Mediterraneo le canzoni della tradizione napoletana: Torna a Surriento, I’ te vurria vasà e Santa Lucia luntana sono così dapprima diventate melodie cantate in ebraico in un album intitolato, appunto, Napoli-Tel Aviv e ora, per il viaggio di ritorno verso casa, l’album in napoletano che esce domani e che si intitola Noapolis. Un disco che Noa ha fortissimamente voluto con- tro ogni remora che in principio la tratteneva. «Mi dicevo: ma cosa sto facendo? Come mi permetto? Io sono israeliana, americana, yemenita, come posso entrare nello spirito di quelle canzoni se accetto di cantarle nel dialetto in cui sono nate? Volevo rispettare la tradizione senza fare errori, sapevo che c’erano stati interpreti poco apprezzati perché avevano tradito lo spirito di quelle canzoni, rendendole più popolari, cantandole in un mix di dialetto e italiano. Ma ho lavorato tanto a lungo che oggi questi brani sono diventati parte di me». Sul perché poi Napoli e Tel Aviv siano così intimamente unite, Noa ha le idee chiare: «Sento che esiste una forte relazione tra la tradizione napoletana e la tradizione ebraica: c’è una somiglianza tra i due popoli, hanno sofferto le conseguenze della guerra, hanno patito conquiste, epidemie, povertà e come conseguenza di questa vita hanno dovuto lasciare spesso le loro case, viaggiare in cerca di fortuna intorno al mondo. Oggi trovi ebrei ovunque, proprio co- “Ormai io sono quelle canzoni, divento quelle storie e i sentimenti da cui sono nate” me trovi napoletani dappertutto». Dalla sofferenza possono sgorgare frutti pieni di sapori e colori: «Certo, c’è la cultura che nasce dalla sofferenza, c’è la malinconia ma anche il sense of humor: io credo che chiunque abbia sofferto nella vita ne produca tanto per poter resistere alle avversità». I suoi modelli sono stati soprattutto Roberto Murolo e Gilda Mignonette, la cantante degli anni Trenta, ma è impossibile per lei dire quale sia, tra tante canzoni tradizionali, la sua preferita: «La verità è che canto solo canzoni che amo, altrimenti proprio non ci riesco. Per questo nell’album non c’è ’O sole mio: non riesce ad emozionarmi, e non so perché». Napoli, dove Noa canterà il 3 marzo per presentare l’album, sta attraversando un momento molto difficile: «Mi sembra che i napoletani si stiano arrendendo rispetto a quanto accade, e inve- Repubblica Nazionale DOMENICA 27 FEBBRAIO 2011 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 43 1 2 3 4 Tammurriata nera a New York JOHN TURTURRO I LE CANZONI 1. ’O sole mio 10 12 LE IMMAGINI Qui sopra, una cartolina del 1890: il golfo di Napoli con il Vesuvio sullo sfondo A sinistra, John Turturro a Napoli in occasione dell’inaugurazione della festa di Piedigrotta e, sotto, la cantante israeliana Noa 11 13 ce dovrebbero uscire per le strade, manifestare, arrabbiarsi per quanto accade alla loro città. E lottare. Per questo sono felice di contribuire con un disco a mostrare a tutti la grandezza della cultura napoletana. Dietro la spazzatura io vedo la bellezza, e voglio mostrarla ai napoletani e al mondo. Uno specchio di fronte ai vostri occhi per potervi far vedere quanto siete belli. Non bisogna permettere a nessuno di portarsi via la nostra bellezza». © RIPRODUZIONE RISERVATA di Elvis Presley contenuta nell’album It’s Now Or Never 2. Funiculì, funiculà di Connie Francis 3. Guaglione di Dean Martin 4. Dicitencello vuie di Dean Martin nel disco Dino 5. Torna a Surriento di Demis Roussos contenuto in Serenade 6. Ciribiribin di Frank Sinatra 7. Luna rossa interpretata da Caetano Veloso 8. Torna a Surriento di Elvis Presley in Surrender 9. Tu vuo’ fa’ l’americano nel film La baia di Napoli con Sophia Loren e Clark Gable 10. Tu vuo’ fa’ l’americano di Boris Vian 11. L’americano nella versione di Akhenaton 12. ‘O marenariello di Frank Sinatra nel disco I Have But One Heart 13. Luna rossa di Caetano Veloso l mio primo incontro con la musica napoletana avvenne che ero ancora un ragazzo, a casa, in famiglia, ascoltando alcuni dischi della grande tradizione. Da adulto, quando iniziai a lavorare all’adattamento del capolavoro di Eduardo de Filippo, Questi fantasmi, conobbi meglio Napoli e mi innamorai subito di Tammurriata nera, una canzone meravigliosa, con una storia ancora oggi di grande attualità. Più in là decisi di inserire nella colonna sonora di Romance and Cigarettes il brano Do You Love Me Like I Kiss You, versione inglese di Scapricciatiello. Il film fu un successo, e dall’Italia i produttori Alessandra Acciai e Carlo Macchitella mi contattarono proponendomi un progetto che poi sarebbe diventato, negli anni, Passione. Fu in quell’occasione che conobbi il critico e sceneggiatore Federico Vacalebre. Fu lui a farmi ascoltare migliaia di canzoni. E fu così che venni letteralmente e definitivamente travolto dalla musica napoletana. James Senese è stato invece uno dei primi artisti che ho incontrato per la preparazione del film: la sua storia e la sua musica mi sembravano un giusto punto di partenza per un’opera che non voleva essere semplicemente una cartolina di Napoli e della sua musica, ma uno sguardo di uno straniero su una città complessa e ricca di contaminazioni culturali. Come Noa, anch’io sono sempre stato affascinato dagli incontri tra le culture. E Napoli, a modo suo, mi ricorda molto la New York degli anni Settanta in cui sono cresciuto: un luogo in cui i popoli si sono incontrati, si sono scontrati e hanno dato vita a un’identità assolutamente unica. Napoli è una città di forti contraddizioni, una città splendida, conquistata da popoli diversi, massacrata e ricostruita, una città con ferite aperte ma che sa ancora cantare e raccontarsi attraverso la sua musica e i suoi artisti. Fare una scelta delle canzoni e degli interpreti di Passione ovviamente non è stato facile: c’è un repertorio di canzoni troppo ampio e tantissimi artisti strepitosi, una sovrabbondanza di talenti. Quindi, quello che ho fatto nel mio film è stato cercare un equilibrio senza eccedere da un lato o da un altro, tentando di offrire allo spettatore un’ora e mezza di intrattenimento passando dalla rabbia all’amore, dallo scherzo alla pura passione. Per chi non conosce la musica napoletana, Passione è come una grande introduzione, una finestra che si apre su un paesaggio dall’orizzonte sconfinato. Chi ha visto il film negli Stati Uniti ha ritrovato alcune canzoni e alcune melodie che già conosceva, e allo stesso tempo è rimasto colpito dai nuovi arrangiamenti, dalla mescolanza con la musica araba e dal talento sorprendente degli interpreti. E per chi già conosce la tradizione partenopea Passione è allo stesso tempo una celebrazione del passato e un punto di vista nuovo sull’identità napoletana. Ho avuto la fortuna di incontrare nuovi talenti della scena musicale che hanno saputo confrontarsi con quelle che sono considerate delle vere icone. Da loro ho capito che la musica napoletana è viva e può ancora raccontare molto di sé, con uno sguardo consapevole alla propria storia passata e con uno slancio energico e passionale verso il futuro. 5 6 7 8 © RIPRODUZIONE RISERVATA 9 Repubblica Nazionale 44 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 27 FEBBRAIO 2011 le tendenze Utili & dilettevoli Non c’è solo il ritorno del borsello anni Settanta. Tracolle, cartelle, zaini e perfino shoppers sbarcano nel mondo maschile come accessori tanto indispensabili quanto trendy In pelle, tela o plastica hanno un unico obbiettivo: sollevare l’uomo contemporaneo dal peso dell’hi-tech IRENE MARIA SCALISE omini con le borse. Quello che sino a qualche tempo fa sembrava impensabile oggi è normale. La borsa maschile del 2011 più che ambigua è pratica. Più che glamour è utile. Una rivoluzione imposta anche dall’aumento del peso delle tecnologie. Già negli anni Settanta un illustre predecessore, il borsello, aveva clamorosamente spalancato una porta sull’universo della borsa al maschile. Poi la questione era stata archiviata per motivi di gusto: “il borsello fa tristezza”, era il comune pensiero. Nessuno, allora, avrebbe supposto il grande ritorno del borsello. E non solo. Via libera anche a cartelle, sacche, bauletti. Il tutto soprattutto per una giustificazione high tech: iPad, computer, iPhone e tablet, ormai diventati un’appendice inseparabile del maschio, U DARK SENZA ETÀ Tracolla in pelle e canavas in total black di Peuterey bags collection. È interamente prodotta in Italia ed è adatta per il giorno e la sera. Piacerà agli uomini di ogni età CAPIENZA TECNOLOGICA Messenger porta pc con patta frontale realizzata con due pellami diversi di Piquadro Ha anche un porta badge esterno, un porta bottiglie estraibile e una bustina interna Menbag in Se lui gioca con la borsa INFORMALE Tracolla in canavas e pelle di Louis Vuitton Per un look informale con sandali, giacca aperta e shirt in cotone giallo dopo aver vagato in cerca di asilo nelle piccole tasche di giubbotti e pantaloni, hanno richiesto una collocazione stabile. Messe così le cose, con circa un chilogrammo di tecnologia da trascinarsi tra un appuntamento di lavoro e l’altro, le soluzioni d’emergenza sono risultate decisamente insufficienti. Ed è tramontato il ricorso ad alternative improvvisate come la borsa della fidanzata (già notoriamente congestionata) o la sacca dello sport. L’uomo ha cominciato così ad autogestire il proprio bagaglio quotidiano sdoganando, ufficialmente, la specie “borsa per lui”. In pelle, in tela, in cuoio, colorata o neutra ha conquistato anche i più scettici. Secondo la British Chiropractic Association la vendita delle borse maschili, nell’ultimo anno, è cresciuta del ventuno per cento. A fare da apripista, in realtà, sono stati quelli che gli americani definiscono pomposamente celebrity. Infiniti blog e siti internet, dedicati a questa upper class trasversale che comprende attori, cantanti e calciatori, hanno immortalato il fenomeno. David Beckam, Jude Law e Tom Cruise sono stati fotografati con almeno una macho bagtra le mani. Ed è stato il boom. Niente a che spartire con quelle borse in stile metrosexual che, negli anni passati, avevano trionfato in passerella. Corredata di mille tasche e contenitori, la nuova icona protegge con la giusta cura le tecnologie più avanzate. Piace soprattutto ai manager di ultima generazione che viaggiano con il loro piccolo mondo business tra le mani. Si lavora ovunque e dovunque e avere l’ufficio a tracolla diventa d’obbligo. E anche i motociclisti esultano: è finalmente risolta l’annosa questione di dove collocare i propri beni sulle due ruote. Ma attenzione a non esagerare, avvertono gli esperti. Sempre l’associazione britannica dei chiropratici ha stimato che il peso medio delle borse supera i sei chilogrammi visto che, a quanto pare, un uomo su cinque porta sempre con sé il laptop o il tablet, uno su tre ha almeno un libro e più del cinquanta per cento almeno un cellulare. Con l’aggiunta, ovvia, di chiavi, occhiali, guanti e sciarpa. Tanto vale organizzarsi con modelli ben strutturati in grado di soddisfare tutte le esigenze. E gli stilisti hanno dato il meglio unendo estetica a funzionalità. © RIPRODUZIONE RISERVATA CHIC Per Canali la borsa ideale è in morbido vitello nero Adatta al look più elegante è anche molto funzionale CASUAL Alla giacca sportiva in tessuto tecnico con dettagli in pelle Armani abbina la shopping bag in vitello nero con doppi manici Repubblica Nazionale DOMENICA 27 FEBBRAIO 2011 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 45 EFFETTO VINTAGE Tracolla canavas water resistant cento per cento cotone organico e pelle griffata Timberland Ha una fodera interna in cotone I dettagli sono in metallo anticato Il creativo Giacomo Guidi “A misura di iPad ” LAURA ASNAGHI èchi lo ama e chi lo odia. Sul borsello, la borsa per maschi lanciata negli anni Settanta, il pubblico si divide tra favorevoli e contrari. Non ci sono mezze misure. Piace oppure no. E tra i grandi sostenitori c’è la griffe Piero Guidi che da trentotto anni, in pratica da quando è nata l’azienda, lo propone e lo commercializza nel mondo intero. A Giacomo Guidi, il creativo della maison, figlio di Piero e Nadia, i fondatori del marchio, abbiamo chiesto da cosa nasce questa passione per il borsello. La vostra azienda è, da sempre, pro-borsello. Cosa vi lega a questo accessorio? «Noi lo consideriamo un vero feticcio che non può mancare nel guardaroba maschile. È come la borsa per le donne, solo che il borsello deve avere caratteristiche precise». E quali sono? «Il nostro pezzo forte ha i puntali in metallo e la targhetta che può essere personalizzata con il proprio nome. E in più le dimensioni non possono superare quelle di un iPad, perché altrimenti si sconfina in altri tipi di borse da uomo». Quando pensa a un uomo con il borsello a chi pensa? «Penso a un grande drammaturgo come Samuel Beckett. Un intellettuale, capace di portare questo accessorio con molta naturalezza. L’approccio al borsello deve essere giusto e corretto, altrimenti è meglio lasciare perdere». Negli anni Settanta, il borsello aveva un suo coté mondano e c’era chi se lo portava anche in discoteca. Oggi è ancora così? «No, oggi prevale più un uso pratico, quotidiano, perché gli uomini, come le donne, vanno in giro con parte del loro ufficio addosso. L’iPad, per esempio, ci segue ovunque e occorre avere un contenitore comodo e poco ingombrante. Esigenze che il borsello soddisfa pienamente». Ma il borsello a chi è destinato? «Il nostro cliente tipo è un giovane che viaggia molto per lavoro e ha bisogno del suo borsello per superare rapidamente i controlli all’aeroporto e correre da un appuntamento all’altro con tutto quel che serve, senza avere borsoni al seguito». A cosa può essere paragonato? «Secondo me è il nuovo zainetto dei giovani, pratico, elegante e di grande utilità. Sta bene sia con i completi classici che con un bel paio di jeans. E il borsello passepartout deve essere in pelle nera o blu, oppure in nylon superleggero». Cosa risponde a chi considera il borsello la massima espressione della “cafoneria”? «Innanzitutto di non usarlo: il borsello richiede una allure particolare per essere indossato bene. E chi ha dei pregiudizi è meglio che lasci perdere. Il borsello è una scelta che va fatta con convinzione. Se uno si sente ridicolo, usi altre borse». E quali sono le alternative per un uomo? «Sono parecchie ma molto differenziate tra loro. Faccio un esempio: il modello shopping bag, non è da tutti, perché è un genere modaiolo. E chi lo adotta sa che viene etichettato così». Altre borse maschili? «Visto che nelle città il traffico è proibitivo e la gente tende a muoversi in moto o in bici, la tracolla da messenger va moltissimo. Mentre per avvocati, medici, ricercatori, il modello più ricercato resta la classica cartella professionale». C’ DINAMICO Borsa in nappa antique in originale blu Prada Ricorda i sacchi degli sportivi: perfetta per l’uomo dinamico che vuole portare con sé ogni cosa dal computer alla felpa © RIPRODUZIONE RISERVATA SPORTIVO Borsa maxi monocolore in lino delavè. Ha dettagli in vitello lucido e si può abbinare a un look sportivo e informale Proposta da Trussardi UOMINI D’ORDINE Cartella a due scomparti in canavas cerato e pelle con manici in cuoio a contrasto di La Martina Per riporre le cose con ordine e non creare confusione WEEKEND Il borsone Tod’s è realizzato in morbida vacchetta con impunture a vista. Ideale per le giornate con molti impegni: può trasformarsi in mini valigia per il weekend CENTAURO Borsello nero multitasche chiuse da zip in cotone spalmato con tracolla a nastro di Piero Guidi. Perfetto anche per la moto perché lascia le mani libere per guidare Repubblica Nazionale 46 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 27 FEBBRAIO 2011 i sapori Attraversando i secoli ha nutrito e nutre buona parte dell’umanità Da noi, arrivando dai Balcani, si guadagnò il nomignolo di grano dei turchi. Oggi, essendo quasi azzerate le qualità autoctone e assediato com’è dagli Ogm, la scelta migliore cade Antichi sul biologico. Per arrivare sulle nostre tavole sotto forma di polenta, biscotti, zuppe e insalate Sciroppo Olio Amido Conservato È l’ingrediente base della polenta: colore giallo (grazie alla zeaxantina) Fine ed elegante la varietà biancoperla, trevigiana Negli States il corn syrup sostituisce lo zucchero nei cibi gelatinosi, perché non cristallizza. Si usa anche per i gelati Estratto dal germe, l’anima nobile del chicco, ha sapore delicato ma un punto di fumo basso: inadatto alla frittura Conosciuto come Maizena va scaldato sopra i 70 gradi per addensare creme e vellutate. Con la farina, rende gli impasti fragranti I chicchi voluminosi distinguono la graminacea zea mays dal frumento Bolliti e inscatolati, si aggiungono alle insalate LA RICETTA Farina Sigrid Verbert è un’apprezzata scrittrice e fotografa di cibo Nel blog “Cavoletto di Bruxelles”, racconta le sue esperienze di cuoca curiosa, abile nel miscelare ricette della memoria e nuove tendenze gastronomiche Zuppa di mais e paprika Ingredienti per 4 persone •• •• •• • 2 panocchie ½ litro di latte 1 scalogno 1 1 cucchiaino di paprika affumicata in polvere 1 cucchiaio di farina di riso 1 cucchiaio di burro Lessare le pannocchie. Tritare la cipolla sbucciata e cuocerla nel burro senza che prenda colore Aggiungere le panocchie bollite e sgranate, la paprika e la farina di riso, mescolando.Versare il latte e cuocere a fuoco basso per 20’ Frullare e passare al setaccio, prima di servire caldo Mais ‘‘ LICIA GRANELLO ranone, frumentone, formentazzo, grano d’India, granoturco, meliga. Cento nomi diversi battezzano il cereale scoperto nelle campagne di Cuba dagli uomini di Cristoforo Colombo pochi giorni dopo aver messo piede per la prima volta sul continente americano. Nutre una buona parte dell’umanità da così tanto tempo, il maìz (nella dizione latino-americana), da meritare l’emozionante nome di radice greca che lo identifica nel glossario scientifico: Zea maya, da zao, vita, e mayze, pane. Più di cinquemila anni di pratica agricola dedicata non ne hanno scalfito l’importanza. Alimento imprescindibile nella storia culinaria della civiltà G Groucho Marx Mentre succhiava le ossa di pollo e le pannocchie di mais lo hanno sentito in un raggio di chilometri Molti, pensando a un’incursione aerea, hanno schermato le finestre da “LE LETTERE DI GROUCHO MARX” Il pane della vita atzeca, si è confermato secolo dopo secolo egualmente povero e necessario alla sopravvivenza di uomini e animali in tutti i Paesi che nel tempo — Sedicesimo secolo, per quanto riguarda l’Europa — hanno preso a coltivarlo. Compresa l’Italia, dove — arrivando dalle regioni balcaniche — si è verosimilmente guadagnato il nomignolo di grano dei turchi. Clima favorevole, rese importanti, facilità di produzione: le regioni del Po e la fascia centrale sono state a lungo la nostra culla del mais. Peccato che per incrementare la quantità abbiamo dimenticato la qualità, quasi azzerando le varietà autoctone, meno redditizie ma più robuste e valide, in favore degli ibridi. Un aumento di produzione che oggi ci consente di esser autonomi all’85 per cento. Ma il vero guaio riguarda il dilagare delle produzioni ogm, se è vero che il fabbisogno mondiale di mais viene coperto per la metà dagli Stati Uniti, dove gli organismi geneticamente modificati imperano (quasi) indisturbati. Da una parte all’altra del pianeta, la guerra di numeri e ricerche vede contrapposti i giganti degli Ogm — Monsanto in primis — e i ricercatori indipendenti. Tra le ultime analisi della Commission Française du Génie Biomoléculaire («Non è possibile concludere che il mais ogm Mon 863 sia un prodotto sicuro») e le rassicurazioni dell’industria, qualche settimana fa la Cina ha re- spinto al mittente una spedizione di mais contaminato da Ogm (Mon 89034) non approvato dal ministero dell’Agricoltura, in arrivo dagli Usa, malgrado il paese asiatico sia in deficit di produzione. Una decisione che rallegra Greenpeace e la Coldiretti, uniti nella convinzione che il principio di precauzione debba prevalere sugli interessi economici. Per questo, mai come nel caso dei chicchi d’oro da trasformare in polenta, biscotti o insalate, la scelta del biologico riesce particolarmente felice. A maggior ragione quando il mais arriva sulle tavole dei bambini e su quelle dei celiaci, dove l’assenza di glutine è requisito fondamentale. Se farina e maizena abitano qualche angolo della vostra dispensa, impastatele con un po’ d’acqua, un cucchiaio di extravergine, poco lievito e un pizzico di sale. Poi tirate la sfoglia, tagliatela a listarelle, rifinite con una spennellata d’olio, grani di fleur de sel e piazzate la teglia per dieci minuti in forno caldissimo. Sistemata la prima metà dell’happy hour, vi resterà solo da scegliere una buona bottiglia. © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale DOMENICA 27 FEBBRAIO 2011 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 47 itinerari Mondovì (Cn) Marano (Vi) Arezzo DOVE DORMIRE DOVE DORMIRE DOVE DORMIRE LO STUDIÒ DI PIAZZA Via delle Scuole 2 Tel. 0174-330887 Camera doppia da 80 euro PARCO DEGLI ANGELI Via Schio 77, località Malo Tel. 0445-602511 Camera doppia da 100 euro RELAIS LA TORRE Località Chiassa Superiore Tel. 0575-040067 Camera doppia da 70 euro DOVE MANGIARE DOVE MANGIARE DOVE MANGIARE IL BALUARDO Piazza d’Armi 2 Tel. 0174-330244 Chiuso lunedì a pranzo e mart. menù da 40 euro DUE MORI (con camere) Via Rigobello 39 Località S. Vito di Leguzzano Tel. 0445-511611 Chiuso lunedì, menù 30 euro LA TORRE DI GNICCHE Piaggia di San Martino 8 Tel. 0575-352035 Chiuso mercoledì, menù da 25 euro DOVE COMPRARE DOVE COMPRARE DOVE COMPRARE ERBA MATTA Piazza Maggiore 6 Tel. 0174-42583 CONFRATERNITA CEREALI Via IV Novembre 98 Tel. 0445-621677 FORNO PANE E SALUTE Corso Italia 11 Tel. 0575-20657 Dalla pellagra alla biodiversità CORRADO BARBERIS utto cominciò da Udine, da quel libretto Polenta di qualità in Friuli edito nel 1987 dalla locale Camera di Commercio e divenuto poi bibbia della Confraternita della Polenta Friulana e del suo Gran Priore Silvano Bertozzi. Quel libretto partiva infatti dalla constatazione che le varietà autoctone di mais erano ormai confinate su una manciata di ettari, soppiantate com’erano dagli ibridi americani cui era riuscito di innalzare il rendimento unitario dai 16,5 quintali del 1940 a oltre settanta. Enorme successo economico, con una riserva, però. I settanta quintali erano concepiti in funzione dei maiali da allevare, non dei cristiani da nutrire e soprattutto da deliziare, perché — rilevava il libretto protestatario — «la selezione per la produttività punta sull’accumulo di amido, il quale non favorisce gli aspetti che rendono gradevole la polenta». Sconvolti dal benessere del secondo dopoguerra, i friulani avevano con gioia mutato abitudini alimentari. Da generazioni erano stati, per così dire, martiri del mais, dal cui esclusivo ricorso avevano contratto la pellagra, la terribile malattia che, disseccando l’epidermide, provocava demenza e morte. Gli ibridi erano arrivati in un momento in cui si era fin troppo lieti di dimenticare il cibo ancestrale. Nel 1987 era però già cominciata la revisione critica. Una minoranza illuminata si domandava perché rinunciare a un prodotto simbolo della civiltà regionale. Cambiava il pubblico, da contadino a intellettuale, secondo quell’eterno avantindietro storico che Clemente Biondi, nel poemetto Giornata villereccia, aveva già cantato nel 1773: «cibo fu sol di rozza gente umìle / ma poi nelle città meglio condita / ammessa fu tra il popolo civile / e giunse alfin le delicate brame / a stuzzicar di cavalieri e dame». Furono cavalieri e dame a suscitare nel 1987 il movimento pro-polenta? Certo, sotto il profilo culturale che nobilita le minoranze audaci. Al Friuli rispondeva la Fiera bresciana di Castegnato, Franciacorta in Bianco, con largo spazio fatto negli stand alle vecchie varietà da cristiani Marano e Belgrano. In Garfagnana si rivendicavano i pregi delle pannocchie dalle otto file, tendenti ora al giallo, ora all’arancione. Dovunque la biodiversità diventava il nuovo credo alimentare. Si tornava ad ammirare le tradizioni, purché antiche, come quella del cucchiaio forato (sculièr col buso) servito ai braccianti insieme a una ciotola di polenta e latte, perché non esaurissero il liquido prima dell’impasto. Come racconta Ulderico Bernardi nelle Reverenti memorie del signor Pan e della Illustrissima signora Polenta. Gli umori cambiavano e va dato atto all’Istat di averli prontamente captati. L’Annuario Inea distingue con giusto puntiglio e qualche probabile sottostima le 7,2 migliaia di tonnellate di granoturco nostrano e le 10.357,2 di mais ibrido prodotte nel 2008, a prezzi alquanto superiori, di circa un quarto, a favore delle vecchie varietà. Ai cristiani va dunque nemmeno uno per ogni mille ai maiali. Poco, ma pur sempre qualcosa nel nome della tipicità. T 7 sono le varietà botaniche del mais 1894 l’anno in cui nascono i corn flakes 90 le calorie per 100 grammi di mais in scatola © RIPRODUZIONE RISERVATA Paste ‘d melia Pannocchia Pop corn Corn flakes Tortilla Farina di mais ottofile macinata a pietra, burro, zucchero e uova nei biscotti di meliga (mais) della tradizione cuneese Due ricette semplici: arrosto, sulla brace, o bollita, spennellata di burro fuso, aromatizzata con pepe e sale Chicchi soffiati o scoppiati, nella preparazione casalinga, salati e resi appetitosi con il burro, per lo snack da cinema I fiocchi che arricchiscono il latte vengono prodotti impastando, spianando e tostando la farina di mais, acqua, zucchero e malto Il pane messicano (arepa in Sud America): una cialda di masa harina, farina di mais, cotta sulla piastra, da farcire a piacere Repubblica Nazionale 48 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 27 FEBBRAIO 2011 l’incontro Il 3 febbraio scorso sviene e cade dal podio. Il mondo della musica trema “È il mio cuore che invece di essere un allegro maestoso diventa un allegro capriccioso”, scherza il maestro, “ma ora sto benissimo”. Ed è pronto a tornare al lavoro con la Chicago Symphony e a Roma con l’amato Verdi simbolo dell’Unità d’Italia. A luglio compirà settant’anni, “ma non li sento, continuo il mio viaggio entusiasmante come in un sogno” Classici Riccardo Muti H no!” lanciato con spiccata inflessione toscana». Fu sempre Nabucco, nell’86, la sua prima opera come direttore musicale della Scala, con la regia di Roberto De Simone: trionfale apertura di un viaggio conclusosi quasi vent’anni dopo in modo burrascoso, «come un temporale che arriva in fretta. Ciò che mi resta è la memoria di un periodo bellissimo in cui la mia vita si è veramente saldata con la Scala». Con quel Nabuccoruppe una tradizione scaligera instaurata niente meno che da Toscanini, che proibiva il bis di qualsiasi brano di un’opera. «Ma era così calda e persistente la richiesta del pubblico che decisi di ripetere il Va pensiero. E la mattina dopo, sui giornali, intervennero sul tema i massimi personaggi dell’industria, della finanza, della cultura e della politica: giusto o sbagliato eseguire il bis? Pareva un affare di Stato, in un’Italia dove l’amore per il melodramma pulsava ancora spinto fino alle forme smaccate del tifo. Oggi, nella deriva culturale Se l’arte viene penalizzata il paese crolla, divorato dalla bruttura di manifestazioni televisive che per i ragazzi stanno diventando pane quotidiano FOTO © SILVIA LELLI a un cuore ricco di musica, Riccardo Muti. Ma è anche un cuore bizzarro, che può sorprendere per stranezze ritmiche, «e invece d’essere un Allegro Maestoso diventa un Allegro Capriccioso», dice al telefono da Chicago il direttore d’orchestra. Sembra di ottimo umore, ben disposto e loquace. Pronto a volare presto sulla rotta dell’Italia. Eppure di recente il suo grande pubblico ha tremato: il 3 febbraio, durante una prova a Chicago, Muti perde i sensi, e la caduta dal podio gli provoca lesioni al volto. Ricovero, apprensione, fratture plurime alla faccia e inserimento di un pace-maker. Tutti i media internazionali ne parlano: Muti è un campione della musica tra i più acclamati e ammirati del pianeta. «In realtà sto benissimo, e il mio cuore è in condizioni che il bollettino medico dell’Università di Chicago ha definito superbe», dice tranquillo. «Però è soggetto a brachicardie: a causare lo svenimento è stato un improvviso ritmo troppo basso, e ora il pacemaker ha risolto il problema». Non ha alcun ricordo del malore e non si è spaventato, passando direttamente «dal movimento lento della Quinta Sinfonia di Sciostakovich alla visione di un gruppo di infermiere intorno al mio letto d’ospedale». Erano invece atterriti gli orchestrali «che mi hanno visto crollare a terra con un tonfo repentino e sordo», e lo spettacolo deve aver tolto il fiato a Domenico, il più giovane dei suoi tre figli, presente in sala. I musicisti con cui stava provando sono quelli della Chicago Symphony, orchestra che il maestro giudica «meravigliosa», segnalandola come «la prima degli Stati Uniti e una delle tre migliori al mondo» (sottintendendo, si suppone, che le altre siano la Filarmonica di Vienna, con cui collabora intensamente da quarant’anni, e i Berliner Philharmoniker). Con la compagine americana, della quale è music director, ha un’intesa così speciale «da sentire Chicago come una seconda casa», e l’inizio del suo incarico, nel settembre scorso, venne festeggiato con un concertone da rock star, che accolse nel Millennium Park venticinquemila spettatori plaudenti. L’abbraccio tra la fascinosa metropoli di Obama e il più mediterraneo tra i grandi musicisti odierni si è rinnovato nella situazione d’emergenza, come ci riferisce: «Qui, nel Northwestern Memorial Hospital di Chicago, mi hanno curato in modo straordinario, ed è profonda la mia gratitudine verso medici come il cardiologo Bradley Knight e il chirurgo maxillofacciale Alexis Olsson, che ha sistemato le fratture del mento e degli zigomi dall’interno non intaccando il mio viso rimasto uguale a prima, senza cicatrici». E quasi si commuove raccontando che «i musicisti dell’orchestra hanno appena voluto fare due concerti in ospedale per ringraziare dottori e infermieri della maniera attenta e generosa in cui si sono presi cura di me». Tra poco sarà a Roma per dirigere al Teatro dell’Opera, dal 12 al 24 marzo (e il 17, in sala, ci sarà anche il presidente della Repubblica), uno dei capolavori dell’amato Verdi, Nabucco, vessillo ideale dell’Unità d’Italia soprattutto grazie al coro del Va pensiero, intonato dagli ebrei banditi dalla propria terra e possente nell’esprimere l’universalità del sentimento patrio. Questo Nabucco è per Muti «irrinunciabile non solo per la felicità di ogni nuovo approccio a un’opera magnifica, ma per l’impegno preso con il teatro della capitale, con cui ho un rapporto privilegiato in Italia. Nelle ultime stagioni vi ho diretto Otello, Ifigenia in Aulide e Moïse et Pharaon con esiti di alta qualità. L’orchestra e il coro mostrano di aver intrapreso un cammino costruttivo, e già stiamo facendo nuovi progetti per il futuro». Regia e scenografia sono di Jean-Paul Scarpitta, i costumi li firma Maurizio Millenotti, il protagonista è Leo Nucci e l’allestimento sarà «poetico e semplice, come richiede un’opera che è quasi un grande oratorio messo sulla scena». In passato, oltre ad averlo inciso per la Emi nel ’77 (disco memorabile, con la Philharmonia di Londra), ha affrontato più volte questo titolo verdiano, a partire da un’edizione anni Settanta realizzata con Luca Ronconi per il Maggio musicale fiorentino, che «giocava sul duplice elemento biblico e risorgimentale, e terminava con Nabucco abbigliato secondo la classica iconografia del sabaudo Vittorio Emanuele II. Sovrapposizione interpretativa innocente, se paragonata ai sovvertimenti delle regie odierne. Ma all’epoca protestò il loggione, al grido di un “Ronconi in Ar- a cui assistiamo, un dibattito del genere sarebbe impensabile». Piace a Muti, citando il messaggio implicito in Nabucco, evocare il proprio amore patrio. Non ha mai temuto di dichiararlo, «anche a fine anni Sessanta, quando essere patriottici voleva dire farsi additare come individui sospetti di ideologie politiche che non mi sono mai appartenute. Ho sentito sempre come una benedizione l’essere nato nella terra di Dante, Leonardo, Raffaello e Caravaggio, piena di bellezze naturali e di splendore artistico, e ricordo che quando, nel ’71, cominciai a dirigere a Salisburgo, nel passare la frontiera tra Italia e Austria soffrivo molto nel vedere le bandiere italiane piccole e stracciate dal vento, mentre le austriache, lunghe e larghe, sventolavano con gioia». Oggi cittadino del mondo, Muti guarda all’Italia come a un paese «unito da una storia millenaria, dalla lingua e da un sentimento che nonostante tutto batte forte, al di là degli aspetti più superficiali e squallidi della nazione attuale». E insiste sul declino che ha investito i nostri teatri: «In Italia ci sono tanti bravi musicisti che vogliono competere col mondo e bisogna metterli in condizione di farlo. Non potrà mai accadere se non si sovvenzionano le istituzioni musicali. Se l’arte viene penalizzata il paese crolla, divorato dalla bruttura di manifestazioni televisive che per le nuove generazioni stanno purtroppo diventando il pane quotidiano. Capitali musicali come Roma, Napoli, Milano, Firenze, Venezia, Bologna e Palermo sono in gravi difficoltà, e questo è un delitto che non ci sarà perdonato, non solo dalle nostre generazioni future, ma dal mondo intero». Pochi giorni fa, dagli Stati Uniti, è giunta la notizia che Muti ha vinto due Grammy, gli Oscar della musica, col Requiem di Verdi inciso con i complessi di Chicago: uno per il migliore album classico dell’anno, l’altro per il migliore disco sinfonico-corale. E lui avverte che «bisogna riflettere su riconoscimenti tanto prestigiosi dati sì a Verdi e a un direttore d’orchestra italiano, ma anche a un coro e a un’orchestra americani. Triste constatare quanto sia scemato l’interesse internazionale nei confronti dell’apporto dell’Italia sul versante musicale». In prossimità di un compleanno tondo (compie settant’anni in luglio, «ma non li sento addosso per niente»), Muti ha pubblicato un’autobiografia, Prima la musica, poi le parole (Rizzoli), «molto voluta dai miei figli, che mi stimolavano a dare testimonianza dei miei incontri, delle mie esperienze, del mio entusia- smante itinerario nella musica vissuta sempre un po’ come in un sogno». È il ritratto appagante e privo di presunzione «di un uomo nato in una normale famiglia del Sud che tramite lo studio, la disciplina e una serie di bravissimi insegnanti, sia al liceo classico che ai conservatori di Bari, Napoli e Milano, si è ritrovato giovanissimo alla guida del Maggio musicale fiorentino, per poi dirigere la Scala lungo quasi un ventennio e raggiungere i podi delle massime istituzioni musicali europee e americane, incluso quello del concerto di Capodanno a Vienna, che ho diretto quattro volte». C’è un Muti malinconico, severo e fosco. E ce n’è un altro irruente, estroverso e pieno di genuino senso dell’umorismo. È questo Muti più solare a emergere da un libro colmo di aneddoti e di umanità, e aperto da un travolgente amarcord sui tempi dell’infanzia e della scuola a Molfetta in Puglia: «Però sono nato a Napoli: così volle mia madre, napoletana, per tutti e cinque i suoi figli maschi. Se un giorno girerete il mondo, ci diceva, quando vi chiederanno dove siete nati e risponderete Napoli vi rispetteranno, mentre con Molfetta perdereste tempo a spiegare dove sta». Napoli è radicata in lui anche musicalmente, come dimostra il bel progetto sulla scuola settecentesca partenopea che dirige da cinque anni a Salisburgo, e che ha valorizzato su una ribalta internazionale una dimensione «rilevantissima per tutto il teatro musicale europeo e innanzitutto per Mozart». È uno dei risultati ai quali oggi tiene di più, insieme ai Viaggi dell’amicizia del Ravenna festival presieduto da sua moglie Cristina, fervida organizzatrice di questi appuntamenti in forma di concerti nelle città più difficili e ferite, da Sarajevo a Gerusalemme e alla New York post-11 settembre, «quando diressi Va pensiero nel silenzio sinistro di Ground Zero. Luoghi in cui ho avuto davvero la sensazione che la musica fosse un profondo tessuto connettivo per tutti gli esseri umani, un atto d’amore capace di stabilire un autentico legame spirituale tra la gente». ‘‘ LEONETTA BENTIVOGLIO © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale
Scarica