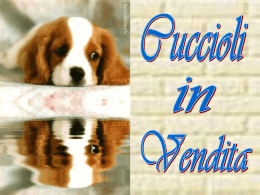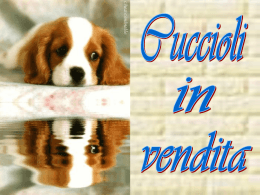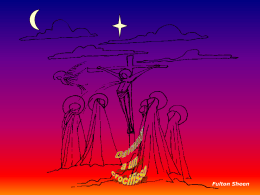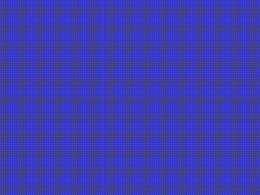Gaston J. Algard CHI LA FA, L’ASPETTI Romanzo © 2004 - Gaston Javier Algard [email protected] Chi la fa, l’aspetti Serie: «Histoires dangereuses» www.algardproductions.com © 2011 – Youcanprint Edizioni www.youcanprint.it [email protected] ISBN 978 88 66181 859 Giugno 2011 © Tutti i diritti riservati Questo romanzo è un’opera di fantasia. Nomi, personaggi, luoghi ed avvenimenti sono il prodotto dell'immaginazione dell'autore. Il ricorso a nomi di persone o luoghi reali è inteso esclusivamente per dare l'impressione di autenticità, ma non deve indurre a pensare che i fatti descritti non siano immaginari. Je remercie toujours ma mère et mon père qui m’ont donnée ma tête. Gaston J. Algard ©«La maison des crimes» ™ de Gaston J. Algard «HISTOIRES DANGEREUSES» 1996 Uno strano fallimento 1998 Omicidi necessari (racconti) 2002 Foto di un delitto 2004 Chi la fa, l’aspetti 2007 Omicidi in tribunale Mors omnia solvit 2008 Ma… che non si sappia in giro 2009 La piccola Gerusalemme 2010 Il grande inganno www.algardproductions.com [email protected] CHI LA FA, L’ASPETTI For Matilda and Laura, with many thanks. 1 Lunedì 15 Marzo, H 5.00 Era tanto tempo che non andava più con una donna vera. Le donne...? Cos'erano le donne per lui da qualche tempo..? Solo ricordi, ricordi degli anni passati… Così stava sognando Boulot, senza un altro nome, che solo con quello lo chiamavano tutti da anni. Veramente lì, tutti credevano fosse scritto Bulò non sapendo fosse un soprannome che si portava dalla Francia, c'est un gros boulot, cioè un uomo grasso e piccolo. Sognava che una bellissima femmina gli stesse rimboccando le coperte. Calde, o quanto erano calde e soffici quelle coperte... Sembravano di seta... Forse lo erano, non aveva mai dormito in un letto con le coperte di seta, neanche ai vecchi tempi quando era importante. Si girò di colpo, ma il dolore che sentì alla mano destra fu così forte che si svegliò. Si guardò intorno stordito. La vodka scolata la sera prima faceva ancora i suoi effetti. Non vedeva bene, era scuro, solo un lontano bagliore rossastro. Osservò la mano nella penombra, sanguinava. Bestemmiò parole incomprensibili, che ormai quello era il suo linguaggio abituale quando era da solo. Si alzò poggiandosi sull'altra mano, tenendo verso l’alto quella ferita. Gli sembrò che qualcosa brillasse a terra, illuminata dal riverbero di luce che entrava dalla finestrella senza vetri che aveva sulla destra. Era un coccio di vetro. Sicuramente un pezzo della bottiglia di vodka. La mano continuava a sanguinare e gli faceva un male cane. Mise la sinistra nella tasca della lunga palandrana che indossava per dormire, comprata al mercato di Porta Portese da un arabo, tirando fuori un pezzo di stoffa consunto. Fasciò la mano dolorante, mentre si alzava in piedi. Guardò incazzato verso il pagliericcio, una serie di cartoni ancora nuovi. Finalmente tornò in se, quel tanto da capire che si trovava come sempre a Roma sotto il ponte Marconi che era la sua casa, 13 nella piccola capanna di legno e cartone che aveva comprato da uno slavo, prima che fosse ammazzato dai suoi compaesani. Si affacciò sull’uscio senza porta. Qualcuno in lontananza gli lanciò un grido sghignazzando. «Ehi Bulò…! T'è passata la sbornia…?» Bestemmiò di nuovo, questa volta con più convinzione, parole francesi, italiane ed arabe. Si chinò, prese un barattolo di coca schiacciato scolato dopo la vodka, tirandolo sulla figura che intravedeva vicino al fuoco dall'altra parte dell'arcata del ponte. Lo colpì in pieno viso e quello lanciò un grido di dolore, allontanandosi dalla luce e sparendo nell'oscurità. Bofonchiando si diresse verso la riva del fiume, incurante della pioggia che veniva giù. Si inginocchiò e mise la mano dentro l'acqua gelida, dopo aver tolto la fasciatura. Cercò di muovere le dita, ma la ferita doveva essere profonda, perché le articolazioni gli dolevano. Lasciò la mano per qualche minuto nell'acqua, accucciandosi. Il freddo lo stimolò. Sotto non aveva le mutande. Alzò sulle ginocchia la palandrana perché non si sporcasse, ed urinò con un gridolino di soddisfazione. Un odore acre si sparse intorno, misto tra acetone e vodka. Non reagì. Quelli erano profumi ai quali si era abituato. Se fosse stato effluvio di acqua di colonia, ubriaco ancora com’era, sicuramente avrebbe vomitato. Lunedì 15 Marzo, H 5.30 Nel bar di Oreste, c'erano solo due avventori. I primi di quella giornata fredda ed umida. Lui stava scaldando la macchina del caffè, mentre si arrovellava il cervello per decidere cosa dovesse fare della moglie. Non ascoltava nemmeno i discorsi dei due che, parlando ad alta voce, commentavano l'omicidio di Gisella. La notizia, nonostante l'ora, già circolava nel quartiere. Si diceva che la vicina di casa, la sera prima, dopo aver sentito urlare aveva atteso un po’ poi, uscita sul pianerottolo, aveva trovato la porta aperta e addentratasi nell’appartamento aveva visto la Gi14 sella a terra in un lago di sangue. Terrorizzata, aveva chiamato la polizia. Abitava dietro l'angolo del palazzo la Gisella, al secondo piano. Lo sapevano tutti che riceveva per soldi gli uomini in casa. In definitiva, faceva la puttana. «Sarà stato sicuramente uno dei tanti…» diceva uno dei due all'altro. «Forse… Ma si racconta di un uomo che la veniva a trovare ormai da qualche settimana… Un vero signore, dicono…» «Chiacchiere… le solite chiacchiere… Chi vuoi che l'andasse a fottere se non la gente di qui…?» «Eppure, c'è chi l'ha visto… anche se cercava di non dare nell'occhio…» Il campanello della porta a vetri tintinnò. Un altro mattiniero. «Buongiorno a tutta la compagnia… Un freddo boiaccia, questa mattina…!» Un omone alto e robusto entrò, scrollandosi l'acqua di dosso. Lasciò l'ombrello zuppo in un angolo e si diresse verso il bancone stropicciandosi le mani per scaldarsi. Togliendosi il cappello, esibì una capigliatura folta e nera. Nel gesto, mandò schizzi a destra ed a manca. «Cazzo…! Stai un po’ attento…!» fece uno dei due, asciugandosi il viso ed allontanandosi da lui. Quello continuò a sorridere. Il faccione grasso esprimeva beatitudine. Gli occhi vivi, contornati da sopracciglia cespugliose, accompagnarono il sorriso. «Che sarà poi qualche goccia d'acqua…! Posso offrire…? La settimana scorsa gli affari mi sono andati non troppo male…» «Certo che ti vanno bene,» intervenne il secondo, «quando uno tratta pappatoria, guadagna sempre… La gente deve pur mangiare…» Oreste, in altre occasioni, sarebbe intervenuto. Conosceva Carlo Savioni da sempre e sapeva che era una persona a modo. Ma quella mattina aveva un diavolo per capello anche se, la testa quasi pelata, ne portava ormai pochi. Il volto liscio, senza pe15 luria, era quasi quello di un da bambino. Il viso di un buono, in definitiva. Il suo cruccio era quella moglie più giovane di lui che aveva voluto sposare per forza, anche se la madre lo aveva messo in guardia. Si era rivelata una gran puttana, peggio di Gisella, che almeno quella lo faceva per vivere. Anche la sera prima, con una scusa, se n'era scappata via un'altra volta. Era rientrata solo verso le 2 del mattino. Non aveva risposto alle sue domande, anzi, come lui aveva insistito gli aveva rovesciato addosso il bicchiere d'acqua che Oreste metteva sul comodino prima di coricarsi, aggiungendo - Così ti calmi i bollori! Brutto vecchiaccio spilorcio ed impotente…! L'acqua calda cominciò a friggere, riportando Oreste alla realtà. Non si girò nemmeno per chiedere cosa volessero. Erano i primi avventori della giornata, quasi da sempre. Prese tre tazze, dopo aver caricato la polvere di caffè macinato non troppo fine come piaceva lì, abbassando le leve. In pochi secondi un liquido nero fumante le riempì. Le portò sul banco. «Se ci metti un po’ di cognac andrebbe meglio…,» chiese sorridendo Savioni, «ne volete anche voi due...? Pago io, naturalmente…» domandò rivolgendosi agli altri. «Se proprio insisti…» rispose subito uno dei due. Oreste prese la bottiglia e ne versò generosamente per tutti e tre. «Basta così…?» «A meraviglia Oreste…» rispose Savioni, bevendo tutto d'un fiato, «quanto ti devo? Per tutte e tre, ovviamente…» «Tre euro e trenta..» rispose lui. «Giovani di belle speranze…, vi auguro buona giornata!» salutò dopo aver fatto tintinnare le monete sul banco. Si diresse verso la porta, s’infilo il cappello ed uscì. Il campanello tintinnò nuovamente. Uno dei due gli gridò dietro: «Hai dimenticato l'ombrello…!» ma quello non sentì, era già fuori. «Vedrai che torna subito… Fuori piove…» rispose l'altro. 16 «Lasciate perdere, tornerà, tornerà… » intervenne Oreste. Gli altri due alzarono le spalle, non troppo convinti. S’infilarono mantelle gialle di tela incerata alzando il cappuccio sul capo ed uscirono. Il campanello tintinnò di nuovo. Lunedì 15 Marzo, H 9.30 Boulot si era lavato, sbarbato e vestito. Benché fosse ridotto in quella condizione, teneva al suo aspetto. In mezzo alla gente nessuno avrebbe pensato di classificarlo un “barbone”, come normalmente sono chiamati i senza fissa dimora. In effetti, l'unico abito che possedeva era un po’ consunto ma, se non lo si guardava con attenzione nessuno se ne sarebbe accorto. S'infilò poi un loden, che aveva visto tempi migliori ed al quale aveva meticolosamente fatto delle riparazioni quasi invisibili. Sulla testa un cappello impermeabile, quasi nuovo, regalatogli dal medico del quartiere. Poi la borsa di stoffa grigia, che mise a tracolla. In altri tempi sarebbe stata notata. L'avevano solo mendicanti e persone senza una casa, obbligati spesso a trascinarsi dietro le loro povere cose. Ma ora, chiunque incontravi per la strada, si portava dietro un borsello, un borsone a tracolla, uno zainetto. Tutti un po’ mendicanti, pronti a partire per non si sa dove. Capricci della moda. Prima di muoversi, si controllò istintivamente con la mano sinistra sul petto. Sotto il maglione, appesa al collo, c'era la sua piccola cassaforte. Un vistoso cerotto gli copriva la ferita della mano destra. Sarebbe passato dal dottore, per fargli dare un'occhiata. Si guardò in giro, dopo aver sistemato i cartoni per coprire le poche cose da proteggere. Sapeva bene che nessuno avrebbe osato toccare nulla. Tutti, intorno, conoscevano la furia di Boulot. Qualcuno ne portava ancora il segno. La prima tappa era sempre da Oreste, dove faceva colazione. Quando entrò, c'erano poche persone in piedi o sedute ai tavoli. Si sedette d'angolo, lontano dagli altri. Oreste, appena lo vide, preparò un vassoio. Caffè e latte, due brioches, un mezzo filone 17 di pane fresco con tonno e pomodoro. Spesse volte, per Boulot, quello era l'unico pasto della giornata. Non amava spendere i risparmi che custodiva nella cassaforte. La sua regola era che, quello che consumava ogni giorno, doveva guadagnarselo. Così la riserva poteva rimanere intatta per ogni imprevisto che, data la vita che conduceva, sarebbe potuto capitare in qualunque momento. «Hai sentito della Gisella..?» gli domandò Oreste, poggiando il vassoio sul tavolo. Aveva con lui una certa confidenza. Spesso gli aveva parlato di fatti personali e Boulot gli aveva dato consigli preziosi e, soprattutto, lo riteneva riservato e discreto. Mai nulla era trapelato in giro dei loro discorsi. «Cos'è successo...?» chiese Boulot, iniziando a bere il caffè. «L'hanno fatta secca... Ieri, sembra verso la mezzanotte...» Boulot poggiò la tazza, rimanendo imbambolato. Conosceva Gisella, era l'unica donna che frequentasse negli ultimi anni. Per necessità corporali, diceva lui. «Morta…?» chiese stupito. «Già, morta ammazzata…» «Ma chi cazzo...?» si fermò, ripensando al giorno prima, quando era stato da lei nel tardo pomeriggio per festeggiare degnamente qualche soldo in più. «Non si sa nulla… Dicono che frequentasse un signore… Ma sono solo chiacchiere. Figurati se quelli si sporcavano con un tipo come la Gisella. Per me, è uno del quartiere…» «Povera Gisella… Mi dispiace, mi dispiace proprio…» rispose solo, cercando di nascondere l’angoscia che l’aveva assalito. Oreste lo lasciò, senza accorgersi di nulla, chiamato da altri clienti. Boulot continuò la colazione. Ma, nella testa, gli tornavano gli strani discorsi che la Gisella gli aveva fatto il giorno prima. Strani, veramente strani. 18 Lunedì 15 Marzo, H 10.10 Pagato il conto Boulot si avvicinò alla porta. Fuori della vetrata, la pioggia cadeva nuovamente a dirotto. Non sapeva che fare. Restare lì voleva dire perdere la giornata e, pagata la colazione, gli rimanevano solo settanta centesimi. Non poteva permetterselo. Accidenti a lui. Se non avesse comprato la sera prima quella bottiglia di vodka dopo essere uscito dalla Gisella, ora si sarebbe trovato in tasca quasi dieci euro. Oreste, dal banco, notò la sua esitazione. Guardando negli occhi il cliente davanti a se che gli dicesse basta, versò in un bicchiere del Campari. Infine aggiunse dell'acqua, rimise a posto la bottiglia dirigendosi verso Boulot. «Puoi prendere quest'ombrello…,» disse indicandoglielo, «l'ha lasciato stamattina Savioni... Non è venuto ancora a riprenderlo. Credo che non ne avrà bisogno per tutta la giornata, attaccato com’è al lavoro del negozio... Glielo puoi riportare tu, quando torni, stasera…» «Veramente… È un bell'ombrello, sembra nuovo... Guarda che bel manico… Ma sì, farò come dici tu lo riporto io stasera a Savioni… Grazie, non ho molto tempo…» poi, mostrandogli la mano aggiunse, «devo passare anche dal medico…» «Cosa ti è successo..?» «Quando uno è stupido, nessuna giustificazione è possibile…» rispose, citando una delle sue tante frasi di saggezza. Ringraziò nuovamente prese l'ombrello ed uscì, seguito subito da un altro avventore. Il campanello della porta tintinnò due volte di seguito. Lunedì 15 Marzo, H 10.35 Arrivò all'ambulatorio, tre palazzi dopo il bar di Oreste. Entrando poggiò l'ombrello vicino ad altri, in un cestello di ceramica cercando di non bagnare a terra. C'erano già tre persone che aspettavano. Un giovanottone alto e robusto con un giubbet19 to inzuppato d'acqua, una donna con un bambino di un paio d'anni che continuava a sbaciucchiare, ed una donna anziana vestita di nero che sembrava parlare con se stessa a bassa voce. Osservandola meglio si accorse che, nell'attesa, stava recitando il rosario i cui grani snocciolava nelle mani ossute. Si sedette paziente. Infine toccò a lui e l'infermiera lo fece entrare. Lo accolse un uomo alto e magro, in là con gli anni, in camice bianco i capelli radi e spettinati. Il viso scavato, come se fosse uscito da un campo di concentramento il giorno prima. Ma il sorriso era affabile ed il viso simpatico, portamento da vero signore. Ti metteva subito a tuo agio. Parlava lentamente, con voce profonda, pesando le parole. «Ciao Bulò…, come te la passi...?» «Ciao dottore, non male, come al solito... Il tuo cappello mi è stato molto utile con questo tempaccio da cani…» «Ne sono felice. Cosa ti serve...?» Gli mostrò la mano, strappando con un colpo secco il cerotto. Il medico la osservò con attenzione, tastando con delicatezza il palmo tutt'intorno, mentre lui l’apriva e la chiudeva. «È una brutta ferita… Ma non ci sono lesioni ai tendini. Com'è successo...?» Boulot gli raccontò tutto, con un po’ di disagio. «Bulò, te l'ho detto di non bere… Il tuo fegato ed i tuoi reni un giorno o l'altro ti mollano…» «Ha ragione dottore... Ma ogni tanto ci ricasco... E ieri volevo festeggiare, devo pur sopravvivere…» rispose, alzando le spalle. «Ti faccio un'antitetanica, per prudenza... Poi ti medicherò la ferita…» Gli indicò il lettino, invitandolo a sedersi sopra. Boulot appese la borsa a tracolla ed il loden bagnato su un attaccapanni. Si sedette, calando i pantaloni sino alle ginocchia. Mentre si rivestiva domandò: «Ha saputo di Gisella…?» 20 «Poverina… Sì, me l'ha detto la prima cliente che è venuta questa mattina. La notizia s’è sparsa velocemente… La conoscevano un po’ tutti…Vedrai che quelli della polizia verranno ad interrogarmi. Ma non credo d’essere molto utile. L'ultima volta che l'ho vista, sarà stato forse due settimane fa… La solita visita di controllo…» poi, come parlando a se stesso, «si rifiutava di andare da un ginecologo…» «Io, invece, l'ho vista ieri pomeriggio verso le 18, a casa sua... Dopo aver scopato alla grande, come sapeva fare solo lei, mi ha fatto uno strano discorso che, lì per lì, non ho capito bene…» «Qualcosa che pensi possa aiutare la polizia…?» domandò incuriosito, «se così fosse, ti consiglierei di presentarti spontaneamente, prima che vengano a sapere del tuo incontro... Sai che gente è quella… Pensano sempre male, specialmente se si tratta di persone senza fissa dimora…» Boulot non rispose subito, finché non si trovò sulla porta, pronto per uscire. «Non lo so ancora, debbo pensarci bene… Non amo frequentare quei posti e quelle persone… Li conosco troppo bene, troppo bene… E grazie di tutto, dottore…» «Fai come credi… Ma non pensarci troppo a lungo…» Lunedì 15 Marzo, H 11.10 Sulla porta dell'ambulatorio cercò invano l'ombrello di Savioni. Era sparito. Si guardò intorno. C'erano quattro persone nuove ad aspettare e c'erano solo tre ombrelli. Ma il suo non c'era più. Chiamò l'infermiera. «Ho lasciato qui un ombrello, con un bel manico intarsiato, nuovo, non c'è più... Non ha visto chi l'ha preso?» poi, come per giustificare la richiesta, «lo devo restituire, non era mio…» La bionda infermiera, non troppo attraente ma procace e molto truccata, lo guardò con occhi ebeti. Come si guarda uno scarafaggio. Sapeva chi fosse Boulot. Pensò subito che mentisse. 21 Forse era in cerca di un ombrello ed aveva inventato una scusa per prenderne un altro gratis. Finalmente rispose, con voce seccata. «Io non ho visto nulla... E poi non sono qui a controllare gli ombrelli, io…» Boulot comprese che non ne avrebbe ricavato nulla. Aprì la porta ed uscì. Come si sarebbe giustificato ora con Oreste e, soprattutto, con Savioni? Il negozio di Savioni era due strade avanti l'ambulatorio, in una via larga e piena di negozi. Decise di andarci immediatamente. La sua regola era che le cose vanno affrontate subito, altrimenti poi prendono d'aceto. E non voleva inimicarsi Savioni, che era sempre stato cortese con lui facendogli anche degli sconti. Il negozio era affollato, come al solito. Tutti preferivano spendere da lui invece che nei supermercati. Un bel negozio a tre vetrine, con un banco principale in fondo per i formaggi i salumi e la carne dov’era Savioni, ed altri due più piccoli dove servivano i commessi. Aveva sempre offerte speciali, forse per fare concorrenza ai supermercati della zona ed ora specialmente a quello che, da circa un anno, avevano aperto quasi a duecento metri da lui. Savioni gioiva nel servire la clientela e stava al banco come un comandante di una nave sul ponte di comando. Sempre con il sorriso e con un complimento od una battuta spiritosa per tutti. Si vedeva subito che gli affari gli andavano bene. La cassiera, anziana e simpatica, vigilava nella postazione strategica vicino all'unica uscita. Aspettò il suo turno. Savioni, come lo vide, lo salutò con un sorriso. «Cosa ti posso servire oggi Bulò...? Ho della mortadella dolce, da leccarsi i baffi… oppure del prosciutto squisito… ma se preferisci della gorgonzola che sembra burro…» «Veramente, non sono venuto per comprare… Dovrei parlarle un momento…» Savioni, scusandosi con gli altri clienti che attendevano, si diresse verso l'angolo del banco, in modo che Boulot potesse par22 largli senza che gli altri sentissero. «Questa mattina Oreste mi ha prestato il suo ombrello... Quello che lei ha dimenticato, andando a prendere il caffè…» «Ebbene…?» fece Savioni incuriosito, guardandolo ironicamente negli occhi. «Sono andato dal medico, per farmi medicare una ferita…» così dicendo gli mostrò la mano fasciata. «Continua Bulò…» «Quando sono uscito l'ombrello era sparito… L'infermiera non mi ha saputo dire chi l'abbia preso… forse per sbaglio…» Savioni lo guardò sottecchi. «Per sbaglio? Non credo proprio... Mi è costato un occhio della testa. Aveva un manico di pregio, non credo si siano sbagliati… Forse ne avevano bisogno… Sai com'è la gente, quando vede qualcosa di bello se la porta via e buonasera…» «Forse è come dice lei… Ma, in ogni caso, io mi sento in debito… mi dica quanto lo ha pagato e glielo rimborso…» Savioni lo guardò sorridendo, come se fosse soddisfatto di quello che ascoltava. «Caro Bulò, non mi sono mai sbagliato su di te... Sei una persona onesta e quello che mi dici ti fa onore, non ci pensare più. Amici come prima… Scusami, ma la clientela mi desidera…» Così dicendo lo lasciò, tornando velocemente al centro del bancone per servire i clienti che aspettavano. Lunedì 15 Marzo, H 12.10 Il vice-commissario Marinacci aveva già interrogato, nella mattinata, tutti quelli che sembravano aver conosciuto o frequentato Gisella ma, ad un attento esame delle loro deposizioni, nulla era saltato fuori. Così avrebbe dovuto lavorare veramente, per cercare di arrivare alla verità. E questa, per lui, era la cosa più tragica che gli potesse accadere. Quelli della mobile, la squadra investigativa della omicidi che naturalmente erano stati 23 subito avvertiti, avevano dato incarico al dirigente del commissariato di seguire la cosa, almeno per il momento. Avevano mandato la scientifica, ma tutto lì. Marinacci non ne era rimasto affatto contento, anche se il dirigente che proveniva proprio da li, gli aveva fatto i complimenti per la fiducia che avevano riposto in lui. La verità era che quelli non lo ritenevano un caso tanto importante al momento, salvo sviluppi. E poi avevano già grosse gatte da pelare che stavano da tempo sui giornali. Marinacci però, vecchio del mestiere, sapeva che appena avesse scoperto qualcosa di concreto, quelli si sarebbero subito precipitati ed il merito sarebbe stato solo del suo dirigente. Anni 59, figlio di un ferroviere che aveva cercato di farlo studiare inutilmente per fargli prendere la laurea, Marinacci era arrivato solo al diploma liceale. Vestiva con ricercatezza, camicia e cravatta sempre di colore. Alto un po’ più della media, corpulento. Era arrivato a vice-commissario non si sa come. Il suo capo era lì solo di passaggio, aspettando una promozione per fuggire. Lo lasciava fare, in quel quartiere della Magliana popoloso ed abbandonato da Dio, dove doveva vedersela con piccoli scippatori, ladruncoli ed immigrati di tutte le razze che, negli ultimi anni, avevano invaso la zona con commerci spesso clandestini. Per Marinacci quella era la sua ultima sponda, dopo un'attività oscura e senza particolari successi. Pensava di passare gli ultimi cinque anni della sua carriera in pace, senza rotture di coglioni, prima di ritirarsi. E così era stato sino ad allora. E adesso, ecco qui che gli capitava quella grossa rogna tra capo e collo, che avrebbe fatto parlare i giornali sempre avidi di fatti di sangue. Era rimasto incastrato, anche questa volta, per i soliti giochi di potere del suo dirigente e dei superiori. Non che la cosa lo turbasse più di tanto, alla fin fine. Ne aveva le scatole piene di tutto e di tutti. In particolare dei magistrati e di tutti quegli impomatati dirigenti di polizia dei quali, però, imitava il vestire. Ma, anche se non lo voleva confessare, ci teneva a non farsi ricordare per quest'ultimo fallimento. Perché la sua vita intera era stata 24 tutta un fallimento. Prima le due mogli, che l'avevano mollato. Poi l'unico figlio che, un bel giorno, gli aveva sbattuto la porta in faccia e se n'era partito per l'Africa dove, da notizie che gli erano arrivate, sembrava aver fatto fortuna nel commercio. Si accese, tossendo, la terza sigaretta del mattino. Il medico gli aveva detto di smettere, ma lui ormai non ne poteva più fare a meno. Tanto, per quello che contava la sua vita per gli altri… «Passami il patologo…» chiese al centralino, tirando un'altra profonda boccata. Attese un paio di minuti con la cornetta in mano, giocherellando con la destra con la sigaretta. Finalmente qualcuno rispose. «Dottor Valenti, chi parla..?» «Sono Marinacci dottore… Ha qualche notizia per me su quella Gisella, ammazzata ieri notte alla Magliana...?» «Marinacci, non deve rompermi i marroni, mi lasci lavorare... Appena avrò finito la chiamerò. O meglio, le manderò il mio rapporto che è poi quello che le serve… Ma poi, com’è che ve ne interessate voi, non è un caso della omicidi..?» Non rispose, avrebbe dovuto dire troppe cose e si sarebbe anche compromesso. «Va bene, va bene, non s'incazzi dottore... Volevo sapere se mi poteva anticipare qualcosa, ecco tutto... Qui nel quartiere nessuno sembra sapere nulla…» Dall'altra parte qualcuno sbuffò nella cornetta del telefono. «Cosa cavolo vuole che le anticipi? Non ho ancora messo le mani su quella femmina! Devo prima finire un'altra autopsia… Poi passerò a lei! Ho solo due mani, porca puttana!» Appunto, pensò subito, «Grazie per la comprensione dottore... A presto...» Abbassò rapidamente la cornetta, prima di dare il tempo a quell'altro di coprirlo di improperi, accendendo un'altra sigaretta. 25 Lunedì 15 Marzo, H 12.20 Boulot, malgrado gli impegni precedenti, anche quella mattina arrivò puntuale al suo posto di lavoro, il ristorante La Mimosa, che apriva solo per il pranzo e dove faceva il lavapiatti. Pochissimi lo sapevano e nessuno l'avrebbe potuto vedere, perché rimaneva sempre chiuso nel retro cucina. Questo gli permetteva, dalle 12.30 alle 17.30, di guadagnarsi la giornata e sopravvivere dignitosamente senza essere costretto a mendicare. Lui era contento e non doveva niente a nessuno. Certo, non aveva la possibilità di prendere una casa in affitto e dormiva sotto un ponte. Ma quelli erano affari suoi. Ma, cosa più importante per lui, disponeva di tanta libertà per tutto il resto della giornata, alla quale non avrebbe mai rinunciato. Dopo essersi cambiato, iniziò il suo lavoro. Quel giorno c'era un grande banchetto di nozze. Ma ormai era pratico. Doveva solo rifornire la cucina dei piatti che, man mano che arrivavano sporchi, metteva nelle due lavapiatti e poi rimandava puliti in cucina. Mentre lavorava quasi automaticamente, ebbe la possibilità di ripensare a quello che gli era accaduto. Ad un certo punto cominciò a ridere da solo. Il ragazzo che lo aiutava, lo guardò curioso. «Cos'è che ti fa tanto ridere, Bulò…?» «Siamo fortunati con questo lavoro… Per farlo bene, non dobbiamo pensare. Così abbiamo tutto il tempo di ragionare su questo e su quello. Non ti pare...?» Il ragazzo lo guardò con lo sguardo vuoto. «Non ti rendi conto...? Non capisci a quanta gente sia preclusa la possibilità di avere il tempo per pensare, assillata dai bisogni della vita...? Spesso inventati e pubblicizzati ad arte dalle multinazionali...?» Quello lo guardò di nuovo, come si osserva un marziano. Boulot alzò le spalle, sconfortato. 26 Verso le 16 il lavoro diminuì. Gli ospiti del banchetto boccheggiavano sui tavoli, dopo essersi riempiti d’ogni ben di dio che i genitori degli sposi, i paganti, avevano fatto servire. Boulot si era seduto e ripensava allo strano discorso che la Gisella gli aveva fatto quella domenica, dopo una pantagruelica scopata. Non riusciva, però, a focalizzarne il motivo. Proprio a lui che non era interessato alle chiacchiere di quartiere. Gisella gli aveva parlato di un uomo importante che faceva proposte a dir poco, come aveva detto? A sì, aveva proprio detto orripilanti la poverina, aveva detto proprio così. Lui gli aveva chiesto se sapesse cosa volesse dire quella parola. Lei gli aveva risposto che sì, lo sapeva bene. Voleva dire terrificanti, o pericolose… non ricordava bene. Ma si ricordava di averne sorriso, forse la Gisella usava male il vocabolario. Allora lui gli aveva chiesto chi fosse questo personaggio e lei, dopo un attimo di esitazione, gli aveva risposto che si trattava di una persona molto in vista, senza fargli il nome. Un po’ scocciato per questo tergiversare, gli aveva nuovamente chiesto perché ne parlasse proprio con lui e cosa c'entrasse lei in tutto questo. Lei era rimasta prima muta, poi aveva risposto: - perché tu sei uno che ha vissuto e perché io mi sono innamorato di questo cliente C'era ancora qualche altra cosa che gli aveva detto, ma non lo ricordava bene. Era troppo beato quel giorno dopo quella gigantesca scopata, per ascoltarla con attenzione. Forse si era anche assopito, mentre lei parlava da sola nella penombra della camera. Non ricordava più. Poi tornò a pensare a quello che aveva riferito al dottore sul fatto della Gisella e quello che lui gli aveva suggerito. Gli sembrò, riflettendo sul tutto, che se fosse andato alla polizia per raccontare questa storia, così fumosa, lo avrebbero preso per matto e si sarebbero incazzati terribilmente. Era meglio farsi i fatti propri. Se l'avessero chiamato, solo allora avrebbe deciso cosa dire e cosa non dire. In fondo lui, dalla Gisella, c'era andato solo per farsi una scopata, mica per confessarla. 27 Lunedì 15 Marzo, H 14.30 Savioni era appena uscito dal negozio per andare in banca. Il viaggio quotidiano per versare l'incasso della mattina appena trascorsa. Gianfranco il figlio di 22 anni, un ragazzone alto 1.90, si presentò inaspettatamente davanti alla signora Ornella, la cassiera. Lei lo guardò stupita. Da quando se n'era andato da casa, difficilmente veniva a trovare il padre. «Tuo padre è uscito... È andato in banca…» gli disse subito, senza sapere cosa aggiungere. Era affezionata a Savioni, ma conosceva anche il ragazzo da sempre, da quando era nato. Era al corrente dei loro dissapori e si trovava a disagio, non sapendo come comportarsi. Sui 55, piacente ed abbastanza formosa, capelli castani tirati dietro la nuca, sicuramente da giovane una bella donna. La sua vita era ormai tutta lì. Casa e negozio. Viveva sola, signorina da sempre, qualche strada più avanti, dopo aver assistito per anni la madre malata che gli aveva lasciato il piccolo appartamento. Prima che il ragazzo facesse la pazziata, come la chiamava il padre, tutto filava liscio nel negozio ed in famiglia. Savioni era vedovo da alcuni anni, ma non aveva mai voluto trovarsi una nuova compagna. Diceva sempre che stava bene così, da solo. Non era riuscita mai a capire perché il ragazzo non fosse rimasto. Quella era un'azienda ricca ed avrebbe avuto il futuro assicurato. Aveva solo capito che al ragazzo non andava di diventare bottegaio, come diceva lui. Aveva altre aspirazioni. Ma quali fossero, non l’aveva mai capito. Il padre aveva acconsentito a versargli un mensile poi, tutto ad un tratto da circa sei mesi, aveva rotto definitivamente i ponti lasciandolo all'asciutto. Le rare volte che parlava del figlio, pronunciava queste parole: - Deve imparare quanta fatica si fa a fare i soldi. Ha voluto essere indipendente? Ebbene, che si guadagni da vivere da solo. È troppo comodo fare il mantenuto «Come stai Ornella? Sempre schiava del padre padrone?» domandò il giovane, quasi a volerla stuzzicare. 28 «Perché parli in questo modo? Eri tanto carino, prima…» «Carino perché dicevo sempre signorsì?» «Gianfranco, ripensaci… Qualunque cosa vi siate detti, dimentica e ritorna da tuo padre… Qui saresti il padrone, lui ti vuole sempre bene.» «Ho capito, ti ha comprata, come compra chiunque con i suoi maledetti soldi… Forse ho fatto male a venire, ma mi trovo in un bell'impicco e pensavo…» «Aspettalo, allora... Vedrai che ti aiuterà…» Gianfranco si guardò intorno come a cercare l'ispirazione poi, senza aggiungere altro, uscì. Lunedì 15 Marzo, H 17.35 «Che ora è..?» chiese Boulot al ragazzo. Non possedeva un orologio e raramente gli interessava saperlo, salvo quando aveva un impegno. Il giovane guardò il suo swatch multicolori. «Sono passate da poco le 17.30. È ora di tagliare la corda…» Boulot si tolse i guanti di gomma, poi il grembiulone ripiegandolo con cura, mettendo tutto in un piccolo armadietto dal quale tolse il loden, il cappello e la borsa a tracolla. Li indossò lentamente ed uscì. Fuori non pioveva più. Si era alzato un lieve vento di tramontana che stava pulendo il cielo. L'aria frizzantina lo rianimò, dopo tante ore passate al chiuso in quel piccolo ambiente surriscaldato dalle lavapiatti. S'incamminò lentamente verso casa. Gli amici lo attendevano, come ogni lunedì sera. Si fermò solo da Savioni, dirigendosi ad uno dei banchi dov'erano i commessi. Prese due pagnotte fresche ed un fiasco di vino rosso. Passò dalla signora Ornella e fece segnare sul suo libretto. Pagava sempre il sabato, dopo aver preso i soldi dal ristorante. Quando arrivò si accorse d’essere solo. Non c'era ancora nessuno. Prese una delle sedie accatastate in un angolo, la mise vicino al grosso bidone dove avrebbero acceso il fuoco per cucinare e si sedette, aspettando paziente. 29 I primi ad arrivare, verso le 18.30, furono il Secco e la Sgrinfia. Vivevano insieme da molti anni. Forse avevano tra i 50/60 anni ognuno. Non si era mai capito, né Boulot faceva mai di queste domande. Salutarono con il braccio mentre si avvicinavano, perché erano sempre di poche parole. I soprannomi dei due non avevano bisogno di particolari spiegazioni. Lui, 1.80 circa, magro come un chiodo. Come sempre indossava una palandrana lunga sino ai piedi, sopra una tuta scura che lo faceva anche più allampanato. Anche se, quando mangiava, non lo si sarebbe detto. Lei certo bella non era, anche se cercava di curare come poteva i capelli biondi corti, tagliati a caschetto e l'abbigliamento che consisteva sempre in lunghi vestiti di lanetta con fiorellini con sopra gilet ricamati, quasi a fare coppia con il suo uomo. Il soprannome non si riferiva al suo aspetto fisico, ma ai suoi commenti brucianti su tutto e su tutti. Li esternava, però, solo a ragion veduta dopo averci pensato ben bene. Era, in definitiva, un'acuta osservatrice. Insomma, meglio averla amica che nemica. Il Secco, presa una sedia, si mise vicino a Boulot accendendo una pipa dal lungo cannello. La Sgrinfia, raccolte due cassette di legno da un mucchio, le ruppe senza fatica e cominciò ad accendere il fuoco nel grosso bidone, mentre srotolava succose salcicce da un involto tirato fuori dallo zaino. All'orizzonte s'intravidero prima Boccanera e poi, claudicante, Barbacane che lo seguiva lentamente appoggiandosi alla stampella, cercando di non inciampare nei gradini viscidi che dalla strada portavano giù sino all’argine del fiume. Un po’ più indietro Barabba che, come al solito, canticchiava strane melodie mentre si avvicinava. Mammatrona arrivò poco dopo, seguita dallo Sgorbio. Per ultima giunse Matrioska, riconoscibile anche da lontano, per il suo modo goffo di camminare impedita dai tanti abiti che portava indosso, cioè tutto il suo guardaroba uno sull'altro, motivo del suo soprannome. Man mano che arrivavano consegnavano alla Sgrinfia un involto di cibarie. Il loro con30 tributo per la cena. Lo Sgorbio montò una specie di tavolaccio, utilizzando due vecchie palanche ed un paio di cavalletti di legno, sistemando altre sedie intorno. Alle 19.20 come ogni lunedì il concilio, come lo chiamavano tutti nell'ambiente degli SFD1, era al completo. Mancava ancora il perorante. Ma quello sarebbe arrivato soltanto dopo cena, verso le 22, accompagnato da due garanti. La Sgrinfia distribuì sul tavolo le razioni. Tutti presero posto tirando fuori, dal proprio tascapane, un piatto, un bicchiere ed una forchetta. Qualcuno anche un cucchiaio. Seduto a capotavola, Boulot augurò a tutti buon appetito dopo aver ringraziato il Supremo di vederli tutti ancora intorno a lui ed in buona salute. Consumarono in silenzio il pasto, bevendo tutti un solo bicchiere di vino, secondo la regola che si erano imposti. Al termine qualcuno si accese una mezza sigaretta od un sigaro. Passarono poi a scambiarsi le ultime notizie. Cominciò lo Sgorbio. Aveva certo più di 55 anni, ma portati molto male. La barbaccia ispida ed incolta lo faceva più vecchio. Nessuno sapeva del perché lo chiamassero così. Lui diceva, ridendo e mostrando una dentatura a tratti latitante, che era stata la madre quando, partoritolo sotto Ponte Flaminio, lo aveva intravisto all'ombra del fuoco acceso per riscaldarlo. Ma forse erano solo storie. Boulot lo aveva incontrato circa due anni prima, aiutandolo mentre fuggiva inseguito da due drogati che lo volevano arrostire. In verità per aiutarlo aveva dovuto mollare un cazzottane ad uno dei due inseguitori, rompendogli una mascella. Avevano subito fatto amicizia. Ora nessuno lo disturbava più da tempo, dopo che si era sparsa la voce che era uno dei membri del concilio. «Al Flaminio le cose vanno male. Troppi extracomunitari…» «Anche qui non c'è male…» gli rispose Boulot, «crescono come i funghi…Ma pure loro hanno diritto di vivere…» 1 - SFD – Senza Fissa Dimora 31 «Certo, basta che non ci rompano troppo i coglioni… Io li rispetto, ma da me la prostituzione è aumentata… Sapessi cosa vedo la sera… È un mare inarrestabile.» «Certo! La polizia ci mangia sopra!» concluse la Sgrinfia. «Luoghi comuni Sgrinfia! Non essere sempre pessimista!» La rimbeccò Mammatrona, ma con voce cortese. Era l'unico che non aveva quasi mai nulla da raccontare sulla zona dove viveva, vicino Castel Sant'Angelo. Tra l’altro era uno dei più fortunati. Ancora abbastanza giovane, 45/48 anni o giù di lì. Aiutava le suore che distribuivano un pasto caldo all'angolo di Porta Cavalleggeri. Mangiava tutti i giorni e, quelle, lo facevano anche dormire in una cameretta dietro la grande cucina. Aveva studiato ed insegnato su nel nord. Poi, ma nessuno ne conosceva i veri motivi, aveva abbandonato tutto e da circa tre anni si era trasferito a Roma, facendo al principio vita errabonda. Qualcuno diceva che fosse stato per una donna. Di certo, trovava sempre un libro che, dopo aver letto, raccontava agli altri. A quello più interessato lo regalava, andando a cercarsene un altro. La passione dell'insegnamento era rimasta. Vestiva sempre leggero, un abito ricevuto da chi sa chi con sotto un maglioncino, inverno ed estate, ed un piccolo zainetto a tracolla. Tutta la sua casa. Viso sempre sbarbato, capelli lunghi neri da intellettuale, un paio di occhialetti di acciaio sul naso, occhi vispi ed indagatori. Aveva cura della sua persona, come Boulot. La conoscenza era stata occasionale. Un giorno anche Boulot era andato a mangiare dalle suore trovandosi da quelle parti e così, una parola tira l'altra, avevano simpatizzato. Il soprannome? Qualcuno diceva che se lo fosse appioppato da solo, per mantenere l'anonimato. Forse aveva sentito una parola in gergo romanesco, che lo aveva particolarmente colpito, - farsi venire un mammatrone - cioè uno grosso spavento e l'aveva adattato alla sua situazione. Vallo a sapere. Barbacane e Boccanera vivevano insieme, vicino al Ponte dell'Industria, in un vecchio barco attraccato ad una riva, abban32 donato alla fine della guerra dalle truppe alleate, dove prima c’era il cosiddetto Porto Fluviale. Qualcuno diceva che fossero gay, ma erano solo voci maligne. Barbacane, passati i 55, zoppicava per una ferita alla gamba destra ricevuta da un grosso cane peloso quando era ragazzotto, dopo che, cercando di entrare in un pollaio in campagna vicino Rieti dove viveva, quello gli si era avventato addosso. Lui, per staccarlo dalla gamba, lo aveva preso per il collo tenendolo fermo per la barba e lo aveva strozzato. Il soprannome glielo avevano affibbiato quelli del paese, ai quali raccontava in continuazione quella sua avventura. A parte questa menomazione, che lo costringeva a camminare con la stampella per le cattive cure ricevute, Barbacane era un brav'uomo. Un po’ ignorante ma molto saggio. Di quella saggezza che proviene da antichi insegnamenti rurali. Gli zii con i quali viveva in campagna, perché orfano, non lo avevano mai mandato a scuola. Di poche parole, perché ripeteva quasi sempre le stesse, aveva scelto di venire nella capitale dopo aver conosciuto Boccanera, che un giorno d'estate aveva bussato alla sua porta. Lo aveva accolto e sfamato. Quello, sui 50, che aveva uno scilinguagnolo ed un aspetto fisico da far invidia ad un predicatore d'altri tempi con la sua lunga barba rossiccia, lo aveva convinto a seguirlo raccontandogli cose favolose sulla capitale paragonate a quello che aveva a Rieti. Barbacane aveva così lasciato la casa degli zii ormai morti, nella quale viveva da solo perché nessuna donna dei dintorni lo aveva voluto come marito. Da circa quattro anni tutti e due distribuivano la fortuna ai passanti, con un pappagallino che estraeva i bigliettini della sorte, che Boccanera scriveva di suo pugno da uomo istruito qual'era. Campavano abbastanza bene, perché il potere della superstizione è il più forte che ci sia come diceva Boccanera e, lui, sapeva farlo fruttare accompagnando l'estrazione del foglietto con parole difficili che colpivano le flebili menti dei passanti, stressati dal caos cittadino nel quale vivono quotidianamente. Sicuramente questo era il 33 motivo per il quale qualcuno, chissà quando, gli aveva affibbiato il soprannome di Boccanera. Come la bocca nera e misteriosa di un oracolo, a dispetto della sua rossa barba. «Da noi non è così…» sortì Boccanera, che era solitamente quello dei due che parlava, mentre l'altro pendeva sempre dalle sue labbra. «Il quartiere è sì cambiato, ma sono quasi tutti bravi lavoratori... È vero che all'ex-mattatoio se ne vedono di cotte e di crude, con i compagni che lo hanno monopolizzato e con tutto il giro notturno di droga degli extra-comunitari lì intorno… Ma nel quartiere di Testaccio, dove di solito bazzichiamo, è tutta gente che lavora e pensa alla famiglia…» «E si riempie di debiti per campare, come dici sempre tu…» gli fece di rimando Barbacane. «Sì è vero... Ma è ancora gente sana... Non come in altri quartieri… E poi noi viviamo sul fiume, come fossimo in campagna… Ogni tanto peschiamo anche… Ti ricordi quei due grossi pesci dell'altra settimana?» aggiunse aspirando forte il mezzo sigaro che gli pendeva da un lato della bocca, tra i peli rossicci abbrunati dal fumo. «Quasi un chilo l'uno! Che mangiata ragazzi!» «E poi, se un giorno ci stanchiamo o le cose cambiano al peggio, ce ne torniamo nella tua casa su a Rieti, non ti pare?» «A certo, la casa e la terra stanno sempre lì.» Barabba sorrise, alle due ultime battute. Sui 58, era un altro della compagnia che parlava solo se lo riteneva veramente necessario. Ma, in compenso, come se discorresse con se stesso, canticchiava sottovoce canzoni dalle parole incomprensibili. Qualcuno diceva fossero in yiddish. Basso nella media e pelato, grasso ma molto più di Boulot era stato nei secoli passati, come diceva lui, direttore di una banca. Aveva fatto il birichino per una donna che lo aveva circuito facendogli rubare un bel pacco di milioni svaniti nel nulla insieme alla donna, scontando così sei anni di galera a Genova. Non amava parlare del suo passato 34 né della famiglia che aveva lasciato. Meglio, della moglie e dei tre figli che uscito di galera, gli avevano sbattuto la porta in faccia lasciandolo in mezzo ad una strada proprio come un barbone, tenendo per loro due case ed averi. Lui si era adattato, così come si era adattato ai sei anni di galera nei quali aveva dovuto anche subire alcune turpitudini che, però, aveva avuto la prudenza di non denunciare per non finire peggio. Memore delle esperienze passate, non faceva la vita da barbone. Trasferitosi a Roma, si era trovato un posticino di contabile nel ghetto, vicino Porta Ottavia, da un grosso commerciante ebreo di stoffe che, affermava quello, lo aveva accolto solo per carità dopo che lui gli aveva raccontato le sue precedenti esperienze. Più concretamente, avendo compreso la sua abilità nelle scartoffie e nei libri contabili, il commerciante lo aveva sistemato in un angolino del grande magazzino e se ne serviva per imbastire lucrosi traffici a danno del fisco rimpinguandosi la borsa. Aveva incontrato Boulot in un piccolo bar del ghetto e si era presentato soprannominandosi Barabba, ritenendosi come il ladrone graziato dopo l'avventura patita. Aveva una piccola stanzetta sopra il magazzino, il cui affitto gli veniva scalato dal magro stipendio. Ma era felice. Questo gli bastava. Quando poi, parlando del più o del meno, Boulot gli aveva fatto cenno di quella sua congrega che si riuniva il lunedì, era stato felice come una Pasqua. Riteneva di poter essere ancora utile, forse non tra i suoi ex pari, ma a quell'umanità che nessuno considera e che pure vive e soffre come tutti gli altri esseri umani. Matrioska, seduta vicino a Boulot, si accorse che tre persone venivano verso di loro, scendendo la scala del muraglione. «Sono arrivati, si lavora…, sparecchiamo la tavola…» disse ad alta voce alzandosi, con un forte accento toscano. 35 Lunedì 15 Marzo, H 20.35 «… Siediti Cravatta, non ho mica finito! Dove vuoi andare? Pensi che sia uno stupido...? La storiellina che mi hai raccontato non sta in piedi… Ricominciamo da capo...» Marinacci aveva parlato pacatamente, come ormai era abituato a fare con tutti i furbetti del quartiere. Strillare non sarebbe servito a nulla. Aveva il suo metodo, lasciandoli parlare di questo e di quello, finché non si stancavano e s’imbrogliavano. Poi cominciava a torchiarli, con metodo, esprimendosi a bassa voce perché non riuscissero a capire tutte le parole, facendo in modo di tenerli in tensione, perché quelli si aspettavano sempre un tranello. Su questo era imbattibile. Era capace di interrogare qualcuno anche per molte ore, senza dare alcun segno di stanchezza. Il metodo aveva dato sempre i suoi frutti, specialmente trattando con gente di modesta levatura mentale. Così era stato sino ad allora anche con er Cravatta, come chiamavano tutti Bianchino Impallomeni strozzino di professione, originario di Castellamare di Stabia che viveva a Roma ormai da sempre. Base di lavoro il bar del er Manciolo, alias Franco Biasutti altro filibustiere che, abbandonati moglie e figli nel profondo nord, si era trasferito in quel quartiere facendo prima i più disparati mestieri e poi, nessuno sapeva come, comprando qualche anno prima un baretto in una traversa interna di via della Magliana, che gestiva in proprio al fianco di una bionda procace, la Marina, ex-prostituta ravveduta che gli scaldava anche il letto. Si diceva che l'avesse finanziato er Cravatta, per utilizzare il locale come ufficio dove incontrare le sue vittime. Ma nessun documento lo attestava. Lo si diceva e, sicuramente, era vero perché er Cravatta era pesante, molto pesante, quando qualcuno non pagava i debiti. Trovava sempre un disperato che, per pochi euro, andasse a fare l'esattore. I soldi od un pezzo del corpo, a scelta del debitore. Er Cravatta, 55 anni passati, alto più della media, naso aquilino, capelli ed occhi nerissimi, furbi, sbarbato, vestito e camicia 36 di media qualità senza cravatta, guardò Marinacci per l'ennesima volta con viso ebete. Sapeva che prima o poi qualcosa avrebbe dovuto pur dirgli sulla Gisella, ma temporeggiava. Lui non aveva nulla a che fare con il delitto e, mai e poi mai, avrebbe voluto fare da testimone in tribunale od andare sui giornali. Era sempre stato un uomo circospetto. Ne andava della sua reputazione. «Commissario… ho già detto…» «Lascia stare il commissario, sono solo vice commissario… Non cercare d'incensarmi… Dimmi una buona volta quello che sai e te ne vai via subito… Lo sai che ogni minuto che rimani qui ci rimetti dei soldi? Se non sbaglio, sei qui dalle 3 del pomeriggio quasi cinque ore…» Marinacci sapeva come prendere le persone, quel genere di persone. Parlandogli di soldi, aveva toccato le corde più sensibili del er Cravatta. Ora doveva solo aspettare che reagisse, che si rendesse conto se gli conveniva ancora fare lo smemorato. Ma er Cravatta i conti li sapeva fare e bene. Quella storia rischiava di fargli perdere veramente dei soldi. Aveva già saltato due appuntamenti e, se continuava così, Marinacci avrebbe trovato qualsiasi scusa per chiuderlo in guardina. Lo conosceva da quando era arrivato in quel commissariato, perché aveva subito tentato d'incastrarlo per le denunce di un paio di clienti coraggiosi che, poi, di fronte a qualche più concreta minaccia, si erano rimangiati tutto. Ma Marinacci non lo aveva mollato, anzi, lo tallonava e non perdeva occasione per convocarlo, cercando di metterlo in mezzo a qualunque fatto accadesse nella zona. In definitiva ce l'aveva con lui. Professionalmente, ovviamente. «Facciamo un patto…?» chiese infine. «Pensi forse di essere il personaggio di un film americano?» rispose quasi ridendo Marinacci, aspirando una profonda boccata e dirigendo il fumo verso il tapino. «Intendevo dire…» rispose tossendo, «che non mi metta in mezzo a questa storia come testimone, non so niente del delitto, ma…» 37 «Ma…? Vai avanti…» «Forse qualche notizia l'ho sentita, lì al bar…, qualcuno che parlava ad alta voce… Sa come succede…» «Certo che lo so, per questo te l'ho chiesto… Tu stai sempre lì al bar, seduto a leggere il giornale… Capita di sentire qualcosa… Passa tanta gente… Ma perché non l'hai detto subito? Mi risparmiavi tanta fatica ed io, adesso, non è che sia molto ben disposto verso di te… Mi puoi capire, no? Potrei anche essere un po’ incazzato… Cinque ore con te, sono pesanti… Che ne dici?» Er Cravatta ingoiò il rospo, cominciando a raccontare. Lunedì 15 Marzo, H 23.15 Anche Diottria aveva finito di raccontare la propria storia. Prima che cominciasse, Boulot aveva fatto segno ai due garanti che lo avevano accompagnato e presentato, che il loro compito era terminato. Quelli salutarono e se n’andarono. Ora il problema era solo del concilio e, quello che avrebbero deciso riguardava solo Diottria. La Matrioska gli porse un bicchiere d'acqua, perché quello per la foga nel parlare, aveva la bocca secca. Deglutì tutto d'un fiato, si tolse gli occhiali dalle spesse lenti, guardandosi intorno, come a capire cosa accadesse. Ma lo sapevano tutti, con gli occhiali o senza, non vedeva a più di un metro. Il resto del mondo, per lui, era una nebbiosa incognita. Viso emaciato, con qualche macchia d’alopecia, capelli radi molto chiari tagliati corti, sicuramente sopra i 50, giubbotto pulito con qualche antica macchia, pantaloni jeans, un maglione che aveva visto tempi migliori logoro sul collo. Viveva nei dintorni di Ponte Testaccio, poco più avanti di Boccanera e Barbacane. Si arrangiava all'ex-mattatoio, facendo qualsiasi lavoretto gli procurasse qualche soldo. Si faceva sempre i fatti propri ed era sempre disponibile con tutti. Da molti anni aveva rinunciato 38 ad imporsi nella vita. La seguiva, così come gli si presentava ogni giorno, senza più aspirazioni né desideri. «Pensi che ti abbiano visto?» domandò Mammatrona, accorgendosi subito di aver fatto una domanda sciocca. Come pubblica accusa, in quel frangente, non poteva chiedere di più. Gli altri continuavano a guardarlo in silenzio. Se quello che aveva raccontato Diottria era vero, correva seri pericoli. Lunedì 15 Marzo, H 23.38 Marinacci infilò la chiave nella serratura del grande portone di ferro e vetro, gettando sul marciapiede il mozzicone di sigaretta prima di entrare. L'androne silenzioso, vasto e luminoso, lo accolse come sorridendo. Era il momento più felice della sua giornata, quando richiudeva dietro di se quel baluardo che lo divideva dallo schifo di tutti i giorni. Pigiò il bottone dell'ascensore, attese che arrivasse, entrò, chiudendo con calma gli sportelli attento a non far rumore, si appoggiò alla parete e spinse quello del quarto piano. Entrato in casa, accese la luce, richiuse la porta girando due volte la chiave nella serratura, lasciandola con le altre appesa alla toppa. Si diresse verso la camera da letto, in fondo, spogliandosi lentamente, ordinando gli abiti con meticolosità su due sedie vicino al grande letto. Nudo, andò nel bagno. Dopo essersi rinfrescato, lavato i denti e pettinato, infilò il pigiama e le pantofole. Adesso si sentiva un altro uomo. Si diresse in cucina, trovando sul piccolo tavolo la cena preparatagli dalla donna che gli accudiva la casa. Si sedette, dopo aver acceso la radio a volume basso, riempiendo l'ambiente di melodie italiane. Era l'unica stazione che ascoltava, una rete privata con musica degli anni passati, quelli della sua gioventù. Mentre cenava, fantasticava. Che fosse venuto il suo momento di gloria? 39 Martedì 16 Marzo, H 02.40 Gli occhi fissi nel buio, Oreste aspettava sdraiato nel letto in silenzio. Dalla tapparella della finestra, aperta a metà, le luci della strada ed i fari delle auto che passavano, costruivano strani giochi luminosi sul soffitto. Oreste fantasticava. A volte lampi veloci, altre volte orribili draghi che agitavano artigli o tentacoli tentando di carpire una vittima sconosciuta che fuggiva nel lato buio. Come le storie che gli raccontava la nonna, tanti anni addietro. La nonna… bei tempi quelli… Un rumore lo distrasse. Un'auto che si fermava giù in basso, sportelli sbattuti, il portoncino del palazzo che si apriva, la voce di una donna che ridacchiava, quella più baritonale di un uomo. Qualche attimo di silenzio, poi una risatina nervosa di lei. Infine uno scatto secco, passi per le scale, mentre un'auto si allontanava, altri lampi veloci sul soffitto. Dopo un tramestio nell'ingresso, la porta del bagno che si apriva e poco dopo si richiudeva, un'ombra entrava nella camera. I piedi nudi sul pavimento, strisciavano lentamente cercando di non urtare il letto. Le coperte si mossero, mentre un corpo caldo ed affannato si sdraiava sulla sua sinistra con un profondo sospiro. Allungando la mano, si accorse che la natica prosperosa della moglie era nuda, bollente. La carezzò, con tenerezza, come a chiedere aiuto, amore, comprensione. «Per favore…» rispose subito lei, con un filo di voce impastata dal sonno, «sono esausta, stai calmo… non ti far venire idee per la testa…» Poi più nulla, mentre lui, come fulminato dall'ennesima scarica elettrica negativa ritraeva la mano, girandosi dall'altra parte. Martedì 16 Marzo, H 8.35 Carlo Abelardi, giornalista della cronaca de Il Messaggero, anni 37, scapolo impenitente, curioso e maligno come può esserlo un arrampicatore sociale che vuole a tutti i costi sfondare, aspettava da circa mezz'ora che arrivasse Marinacci. Era riuscito 40 Gaston J. Algard Uno scrittore dalla vita avventurosa Gaston Javier Algard, figlio di un cittadino britannico e di una cittadina filippina, è nato nel 1938 in un villaggio nel nord delle Filippine durante la II Guerra Mondiale, poco prima dell’invasione giapponese. Tuttavia, per gli imprevedibili fatti della vita, dopo la nascita è sempre vissuto in Europa. Infatti suo padre, funzionario del Foreign Office, dovette partire per non essere fatto prigioniero portando con se il figlio per proteggere sia il ragazzo che la madre dalle ritorsioni dei giapponesi. Sua madre volle restare in patria per non abbandonare gli anziani genitori. Il padre, impossibilitato ad accudire al figlio per i pericoli insiti nella propria attività d’intelligence, lo affidò ad un cugino italiano che per difendere il ragazzo dalle leggi fasciste italiane che lo avrebbero considerato un nemico, lo registrò al municipio come figlio suo e della moglie. Essendo nel frattempo ambedue i genitori morti per eventi bellici, Algard è cresciuto con la nuova identità italiana. Laureato in Statistica ed in Giurisprudenza con tesi in criminologia, ha lavorato per molti anni sia come consulente d’imprese europee, che per magistrati in delicate inchieste ed in attività arbitrali. Tornato nelle Filippine, Algard ha riottenuto il nome e la nazionalità d’origine. Negli ultimi dieci anni ha scritto molti romanzi. Oggi vive tra la Svizzera, Malta e le Filippine. Lo scrittore Algard L’Autore sembra avere una speciale conoscenza della mentalità criminale, perché il delitto e la malvagità si nascondono spesso dove non appare. Le sue storie non sono dei thriller classici o dei polar alla francese. Si può certamente parlare d’inchieste ma nello stile d’Algard che, con fine ironia, fa emergere a volte il lato umoristico di avvenimenti a prima vista seri. L’Autore, assiduo lettore di libri storici e polizieschi, pur conoscendo francese ed inglese scrive i suoi racconti in italiano perché dichiara che questa lingua gli consente maggiore duttilità nella narrazione. Le storie di Algard sono reali ed immerse nel quotidiano in un continuo rapporto con l'umana debolezza, facendoci capire il perché alcuni arrivino a commettere crimini o delitti. Il tutto senza nulla togliere alla tensione emotiva del lettore, che si sente obbligato a girare la pagina per conoscere il seguito della vicenda. Katherine Goldsmith www.algardproductions.com [email protected]
Scaricare