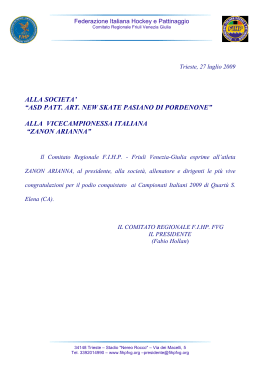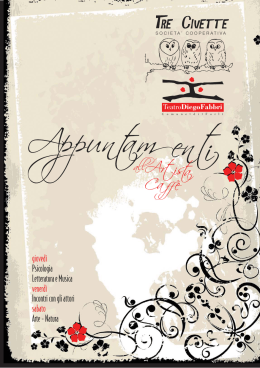Aroma di Cane manuscript.doc AROMA DI CANE Capitolo I “Quanto ho dormito?” chiese Arianna con gli occhi socchiusi. “Molto, piú di un´ora, abbiamo giá passato Milano.” Nella stazione di servizio un´altra sola macchina a far benzina. Marco spense il motore e si appoggió allo schienale massaggiandosi il collo. Le chiavi strette tra le dita, tiró su fino al mento la lampo del giaccone. Le mandó un bacio e scese. Ogni parola gli era uscita dalla bocca accompagnata da piccole nuvole di fiato caldo: il riscaldamento era guasto da settimane, ma nessuno lo aveva fatto riparare prima di quel viaggio a Zurigo. Sola nella macchina, Arianna si guardava intorno spaesata e lenta, strusciandosi le ginocchia infreddolite. Inquadrati nella cornice del finestrino, i colori violenti delle pompe, il nero opaco del tubo di gomma, l´annaffiatoio di plastica sporco appoggiato di sbieco al contenitore dei rifiuti. Da fuori la voce attutita di Marco:”Il pieno sí, grazie.” Piú oltre, i bandoni chiusi di un´officina e una parete di cristallo dietro cui, confuso tra effetti di luce e rifrazioni, brillava il cranio raso di un uomo chino su un bancone. Giró intorno lo sguardo per cercare gli squarci di verde che di solito ingentiliscono le aree di rifornimento; trovó un´aiuola d´erba, una fila di allori e dietro di loro, una fetta di aperta campagna, piatta e vuota. Marco si rimise al posto di guida mentre il benzinaio si allontanava pulendosi le mani contro i gambali della tuta azzurra. Le parve che avesse richiuso lo sportello con troppa violenza, lo spostamento d´aria le rintronó nella testa sgradevole e irritante. Sul sedile posteriore Giorgio pisolava immobile. Dopo aver alzato la testa all´inizio della sosta, si era subito ributtato giú; in viaggio smetteva di essere un cane e diventava una specie di appendice della tappezzeria, un grosso peluche che avrebbe ripreso vita solo quando lo avrebbero fatto scendere. La macchina ripartí: Lodi, Casalpusterlengo...”Siamo solo qui, bene!” pensó Arianna scrollandosi di dosso i rimasugli del torpore. Lo spettacolo della Pianura padana in pieno autunno era ancora tutto da consumare; se lo sarebbe centellinato, sarebbe stato un piacere farsi prendere dal suo fascino discreto, fatto di grandi spazi e di minuti dettagli; anche questa volta le luci, le condizioni atmosferiche, i colori, le colture, tutto avrebbe contribuito a creare nuovi equilibri di bellezza. Sotto il cielo grigio e basso guardava scorrerle davanti distese verdastre temperate dal giallo delle vigne, campi di terra nera e lucida, arata di fresco e dovunque pioppi nudi, allineati in piccoli boschi rettangolari, oppure alti e solitari in mezzo al niente. Presto si fecero avanti i tralicci dell´alta tensione, alti, rigidi, marziali, legati da lunghi fili neri che si accasciavano a mezzo tragitto in ghirlande molli, con un ritmo elegante e austero. Vicini a loro, ma seguendo altri percorsi, si alzavano i vecchi pali della luce, quelli piccoli, di legno, che portano l´elettricitá alle case coloniche.Un pó contorti, pieni di nodi e screpolature, le grosse viti conficcate nella loro polpa, le sembrarono i fratelli sfortunati di quei pioppi che invece crescevano vivi e diritti accanto a loro. La nebbia si faceva piú fitta via via che si avvicinavano al Po ed era nel suo abbraccio ancora lente che si vedevano svanire dietro il guarda-rail strisce di terra dai colori sempre piú imprecisi. Man mano che proseguivano la nebbia si inspessiva ingoiando vorace tutta la campagna. Solo le architetture, i volumi piú grossi, non si arrendevano all´annientamento delle cose: i cascinali, anche se vuoti e malridotti, si ostinavano a mostrarsi. “Guarda come sono belle quelle case...stanno andando a pezzi...” Disse Arianna senza staccaregli occhi dal panorama sfocato. Marco guardó di sfuggita da quella parte:” Ha una sua bellezza anche la distruzione...forse.” Non avrebbe aggiunto altro, é un uomo di poche parole, il silenzio di solito é il protagonista dei loro viaggi. Il dono della conversazione, dell´ampliamento verbale non é il suo forte. Non é certo stupido, né privo di profonditá interiore, solo che comprende, sente e elabora molto piú di quello che riesce a comunicare. Arianna aveva finito per accettarlo cosí com´era e amarlo lo stesso avendo imparato, anche grazie a lui che dire poco é altra cosa che avere poco da dire. Suo marito era un uomo che in ogni caso le piaceva molto, fisicamente poi lo aveva sempre trovato piú che bello. Lo guardó compiaciuta soffermandosi sul suo profilo gentile che la concentrazione della guida arricchiva di un´espressione pensosa, quasi corrucciata.” Marco é bravo... -le venne da pensare - é forse l´unico che mi sopporta sempre, anche quando sono al mio peggio...polemica, autoritaria, intollerante...come posso essere antipatica!”. Si reimmerse nella grnde sciarpa, ci si ritiró dentro fino agli occhi.” Nemmeno mia figlia, credo, mi tollera piú di tanto, a volte sembra proprio che mi odi, eppure io mi sono sempre impegnata tantissimo con lei. Mah! Avrá le sue ragioni e una di quelle é che é ancora giovanissima...aspetteró, forse un giorno mi verrá resa qualche giustizia. In definitiva , mi sopporta solo lui, lui e Claudia. Loro senz´altro soffrirebbero molto se io morissi, lo so. Sopportare, capire, amare...sono quasi la stessa cosa.” Cambió posizione e si ricompose la sciarpa intorno al collo. “Certo peró che contare le persone che ci amano é un´operazione breve, le cifre sono cosí piccole! Comunque quelli che hanno un cane, fanno senz´altro un punto in piú” Si volse verso il grosso animale accucciato e lo toccó.”Come non mettere in conto te!”. Lascó scorrere le dita sul suo pelo caldo e insinuó la mano tra l´ascella e il torace fino a sentire tra il pelame irsuto, il pulsare irregolare e inumano del suo cuore. Verso Ferrara la nebbia si ritiró. Sulla Pianura aveva comiciato a piovere, le gocce si facevano avvertire come un ticchettio sommesso sulla carrozzeria. Il buio concedeva ormai solo una striscia di grigio piú chiaro a ponente; laggiú le cime tozze dell´Appennino si alzavano in controluce segnando massicce il filo dell´orizzonte. L´autostrada stava prendendo il suo aspetto notturno, i fari posteriori delle altre macchine punteggiavano di rosso l´asfalto nero, tutto il visibile si concentrava nelle mezzelune di nitidezza disegnate dai tergicristalli. La pioggia si appiccicava sui finestrini laterali, finché il vento non la convogliava via in piccoli rigagnoli che percorrevano il vetro in diagonale e scomparivano nel niente. Ora che l´oscuritá aveva inghiottito del tutto la bella pianura e cancellato gli stimoli visivi, alla fine di una giornata lunga e densa, Arianna si sentí improvvisamente stanca e svuotata. Reclinó di piú il sedile, aprí gli occhi sul buio del paesaggio e prese a inseguire i pezzi di presente, passato e futuro che il caso sospingeva in disordine nella sua mente. Capitolo II Uscirono un paio di caselli prima della città, la meta era il piccolo paese dove abitava l’assistente di laboratorio a cui Marco doveva lasciare degli incartamenti. Arianna non ci era mai stata e questa era già una bella cosa, i posti nuovi le sembravano sempre molto interessanti; le piaceva guardare le sorprese che la strada butta davanti al viaggiatore: arredi urbani, giardini, piazze, ponti. Più di tutto però le piaceva guardare le case, anche le più comuni. Viste dal finestrino della macchina, si presentavano in carrellata, un tema con infinite variazioni, tutte uguali e tutte diverse. Trovava interessanti persino le case degli anni ’50, la miseria da dopo-guerra che esprimevano, il bisogno di ricostruire, la tristezza delle forme, dei materiali, l’essersi dimenticati delle decorazioni, della solidità, della bellezza, in nome di una modernità accettata e non posseduta. E poi l'architettura del riscatto economico e delle sue conferme: case spesso spigolose, aride, dure, a volte addirittura autoritarie e repulsive. Anche il piccolo centro che avevano attraversato contava un paio di questi infelici bunker civili, ma Arianna non fece a tempo a soffermarsi sulle loro facciate inteccherite perché qualcosa di molto più attraente si stava avvicinando: tra le macchie scure di un giardino arborato, si alzava una grande casa, una villa dei primi del ‘900 la cui purezza quadrata e essenziale era stata di recente intaccata da annessi in cemento armato, costruiti sui fianchi e sul retro. La circondava un muro alto un paio di metri dalla cui cimasa di pietra spuntavano cespugli di lauro. Finestre illuminate brillavano al pian terreno e qualche altra nelle dépendances. Nel giardino stavano parcheggiate alcune auto, raggruppate ai lati del grande cancello aperto, sovrastato da una lunga insegna luminosa: “Casa di riposo Villa Margherita”. “Oddio!”, pensò Arianna come se ne sentisse personalmente minacciata. Si voltò a guardarla con insistenza, cercando di vedere qualcosa di quello che si svolgeva dietro le tende bianche ma la sua curiosità si riempì solo delle storie orribili che tante volte aveva letto sui giornali a proposito dei pensionati per anziani. “… Essere vecchi – pensava - costretti ad alloggiare in questi posti, ghetti, se non lager… vecchi, inabili a difendersi, facili a sequestrarsi, deboli, fragilissimi in una società basata sulla convenienza e l’aggressività. Le violenze più o meno striscianti, le prevaricazioni, l’annullamento prima della morte…”. Forse stava esagerando, sapeva che esistono anche strutture civili, efficienti, gradevoli, protettive. “Sì, però, la mancanza di garanzie, l’essere nelle mani di qualcun altro, il poter solo sperare che tutto vada bene ed aspettare… proprio come un cane, sì, come un cane, aspettare e dipendere, dipendere e aspettare”. Senza spiegare a Marco il filo dei suoi pensieri gli disse: “Bisognerà imparare a suicidarsi!”. Anche lui si era voltato verso il giardino. “Perché?” e subito dopo “Hai visto che sequoia? Un gigante! Avrà più di cento anni!” “Sì, bella”. Arianna si appoggiò allo schienale mentre l’insegna di “Villa Margherita” si trasformava in un punto luminoso che indietreggiava veloce alle loro spalle. Si soffermò a prospettare come sarebbe andata se mai a loro due fosse capitato di invecchiare insieme. “Arrivati alle corde, un’eutanasia Marco non me la procurerebbe nemmeno se la vendessero al supermercato; gli ci vorrebbe troppa iniziativa. Bisognerà che ci pensi io, per me e anche per lui, se si rendesse necessario. Anzi, ci sta che lui non la vorrebbe neppure, sarebbe capace di adattarsi anche a una casa di riposo, al suo ritmo di galera, alla reclusione di fatto, alle umiliazioni di ogni tipo che prima o poi dovrebbe subire. Io, se mi trovassi rinchiusa in una struttura simile, fossi ancora lucida e mi potessi muovere, mi ingegnerei a rubare lamette e coltelli per dissanguarmi il prima possibile”. Le sembrava già di sentire il sangue uscirle dalle vene con una calda sensazione di sollievo. “Ma basteranno le amarezze del raziocinio per suicidarsi? Da vecchi, quando si sarà visto tutto, si avrà ancora l’energia per disperarsi, o si diventerà disposti a accettare qualsiasi cosa, come i cani, qualsiasi cosa, in cambio di continuare a vivere?”. L’auto si fermò di fronte a un villaggio residenziale, graziose villette a schiera con siepi di alloro che premevano dietro la recinzione. “Ci metto un minuto”. La rassicurò Marco. Rumore forte di sportello che si chiude , passi che si allontanano sull’asfalto, suono di un campanello attutito dalla distanza. Finalmente sola con Giorgio! Si sta bene soli col proprio cane, anche se dorme. Un cane ha il potere di aderire come una pellicola all’umore in cui ci troviamo, non ci contrasta mai, ci accompagna, discreto e benevolo, ci consola con la sua neutralità affettuosa. Arianna si sporse tutta verso di lui incuneandosi nella fessura tra gli schienali. Appena lo toccò si sentì subito meglio. “A quarant’anni bisogna cominciare a pensarci seriamente alla morte – gli diceva mentre lo carezzava – non farsi trovare del tutto impreparati. Nonostante i miti di eterna giovinezza che imperversano, non è troppo presto, il grosso del mio futuro è alle spalle, ora si tratta semmai di difendere postazioni ottenute, di mirare a consolidare. Consolidare che cosa? Il rapporto con Marco, quello con mia figlia, cos’altro credo di avere? Beh, ho una vita interiore, un mio sistema di pensiero… la libertà di suicidarmi, se volessi, e comunque la possibilità di tracciare qualche sentiero diritto tra me e la morte, così, tanto per mettere un po’ d’ordine. Ma saranno poi praticabili questi sentieri o finirò, come tutti, ad avere solo paura?”. Giorgio alzò la testa e sbadigliò emettendo un sibilo simile alle note acute di un miagolio. Lei gli strusciò con la punta delle dita la larga piazzola di pelle tra le orecchie. “Come sono contenta di avere te, come mi rendi la vita più leggera! Ma io ti ricompenserò, sai? A te ci penserò io, stai tranquillo. Quando verrà la tua ora, prima che tu soffra, chiamerò il veterinario a casa e ti farò fare una morfina tra le mie braccia, o due o tre, o quante ne occorreranno; ti accarezzerò fin quando la tua coscienza non comincerà a vacillare e solo allora lui ti darà una bella overdose di barbiturici, quella che tu non vedrai perché io ti abbraccerò quando ti verrà iniettata e tu non avrai modo di vedere niente, non ti renderai conto di niente; morirai, senza saperlo e tra le mie braccia, non sarà brutto, forse... e comunque, qualunque cosa succeda, io non ti mollerò mai, starò con te fino alla fine!”. Non smetteva un attimo di carezzarlo, “Come sei fortunato! Magari qualcuno venisse da me a dirmi cose cosí confortanti.” Ma un rumore di passi leggeri venne a sgretolare i suoi pensieri pesanti; Marco rientrò in macchina e le sorrise raggiante: “Ho una bella notizia: è quasi sicuro che presenteranno la mia ricerca al congresso di Monaco!”. Le dette un bacio volante sulla bocca e mise in moto, col sorriso che ancora si lasciava leggere attraverso le piccole rughe accanto agli occhi. Aveva quattro anni più di lei, ma il suo aspetto fisico era ancora più fresco del suo; senza creme, né diete, né palestre, si presentava al massimo come un ultra-trentenne: fronte liscia, niente pancia, capelli folti che gli ricadevano mossi sul viso quando leggeva o inclinava la testa. “Quasi non ci credevo, dopo tutti gli ingrippi e i sabotaggi che ci sono stati! Il nome di Carlo e il mio saranno al primo posto, è sicuro. Questa volta vieni anche tu a Monaco, vero? Magari ci stiamo un paio di giorni in più, si fa una vacanzina…”, le disse carezzandole il ginocchio. In passato lo aveva accompagnato a qualche congresso, le sedi erano sempre città interessanti, capitali europee, luoghi di villeggiatura internazionali; la tentazione era stata grande e lei aveva ceduto, ma poi, a conti fatti, era stata più la fatica del viaggio che la gioia di visitare posti nuovi; il tempo libero era sempre poco e gli obblighi molti, per cui tornava a casa stanca e con la certezza di non aver visto quasi niente. Ma quello che rendeva particolarmente pesante accompagnare suo marito, era l’atmosfera spesso affettata e poco amichevole che aleggiava tra i suoi colleghi, gente di cui a volte conosceva retroterra e precedenti poco edificanti. Le dava noia il puzzo di concorrenza spietata, di gelosia latente che saturava l’aria di quegli incontri, anche durante le conversazioni informali e le cene. Oltre a questo, aveva sempre l’impressione di avere a che fare con gente fondamentalmente ignorante: a parte la loro disciplina, la biochimica nel loro caso, sembrava che questi scienziati non si interessassero di niente; arti e belle lettere non toccavano nessuno, al massimo si poteva sentire una critica a un programma televisivo o a qualche film; nessuno provava piacere o semplicemente provava a approfondire un argomento, soprattutto se a sfondo umanistico o sociale. Solo alcuni audaci, a volte, toccavano temi musicali, ma anche quelli non superavano il tempo di tre battute e si spegnevano subito nel niente come fiammiferi. Il più delle volte le cene finivano col riportare pettegolezzi o aneddoti umoristici su terzi oppure si parlava di dove in Europa valeva la pena di mangiare cosa. Eppure Marco a quel convegno ci doveva andare. Gli argomenti contrari e a favore furono giocati tutti. Arianna - Le dispiaceva, ma a Monaco non ci sarebbe andata.Non se la sentiva proprio. Marco - Il congresso durava solo tre giorni, poi avrebbero potuto rimanerci come liberi turisti. Arianna - Tre giorni in cui una é obbligata a intrattenersi con squadre di chimici nevrotici, non lo si poteva chiedere a nessuno. Marco - Tra loro c´era anche qualche collega simpatico che lei conosceva e comunque, incontrare gente nuova era sempre un´ incognita piacevole. Arianna - Con loro non veniva mai fuori niente, senza contare che al ristorante mangiavano coi gomiti sul tavolo e si mettevano il coltello in bocca. Marco - E a lei che gliene importava, fintanto che non lo ingoiavano... e poi a Monaco c´ era la “Alte Pinakothek”, non l´aveva mai vista, avrebbe avuto tre interi giorni per centellinarsela. Arianna - I musei visti da soli e per forza , sono contenitori tristi. Marco - Lo avrebbe lasciato solo. Colpo ben assestato. Pausa. Arianna Doveva pur essere possibile anche quello, non si trattava di una separazione lunga, ormai erano tutti e due grandi abbastanza. Silenzio. Arianna - E con Giorgio chi ci stava? Marco - Con un pó di buona volontá avrebbero trovato una sistemazione anche per lui. Arianna - Ah sí? E dove? Chi se lo prendeva Giorgio? Capitolo III Giorgio di solito non lo vuole nessuno. Forse perché è ottanta kili o perché fa un po’ paura con le sue congiuntive rosse, o perché rincorre i polli, o perché, se gli si impone qualcosa che non gli va, magari obbedisce, però ringhia e ruggisce a denti stretti con voce cavernosa di leone.Difficile spiegare che più di quello non fa e che non ha mai morso nessuno; la maggior parte di amici e parenti, anche quelli che stanno in campagna, sono riluttanti e non si fidano a tenerlo con sé, per cui, tutte le volte che Marco e Arianna devono andare in qualche posto dove non lo possono portare, è un problema. Il più delle volte finisce che i suoi padroni vanno solo dove può venire anche lui. Giorgio non era un cane qualsiasi, aveva una storia personale, una piccola storia che aveva reso speciale la sua nascita: lui era figlio di una passione animale. I proprietari di sua madre, che abitavano in una raffinata ex-colonica sulle colline, erano riusciti, dopo molte fatiche, a trovare un degno marito per la loro bella alana nera. Controllati i pedigree, diagnosticati con cura i giorni di massima fertilità, visto che precedentemente i promessi sposi erano stati fatti incontrare, si erano piaciuti e avevano giocherellato volentieri, arrivato il momento giusto,fecero salire la loro Leda sul sedile posteriore del fuoristrada e la portarono a nozze, in un posto lontano, dopo le montagne, a quasi tre ore di strada. Il fidanzato, un giovane alano nero di possenti dimensioni, fu molto contento di vedersela davanti, tanto contento che le sue effusioni focose irritarono e presto spaventarono la cagna che non si era mai trovata stretta tra tanta foga. Si sentì minacciata, aggredita e lo respinse con l’unico linguaggio a disposizione di un animale: la violenza. Quando due alani trotterellano in un grande spazio verde, sono uno spettacolo principesco, ma quando una coppia di alani si fronteggiano e si battono, fanno davvero paura, anche ai loro padroni: si alzano per oltre due metri sulle zampe posteriori, ringhiano, sbavano, muovono enormi masse muscolari, ruggiscono, si feriscono; se hanno addosso il collare poi, scaraventano chiunque nell’atmosfera crudele e primitiva di un circo romano. Leda aveva paura e si difendeva azzannando. Né i richiami, né le grida riuscirono a separarli e lei smise di attaccare solo quando il maschio si allontanò zoppicando, sanguinante dagli orecchi, dalla bocca e da una zampa anteriore. Ci si dovette precipitare dal veterinario: diciotto punti. I padroni di Leda ci rimasero malissimo. Fecero in silenzio quasi tutto il viaggio di ritorno, erano mortificati, increduli, ma anche profondamente arrabbiati col proprio cane. Che da anni si coccolassero un animale capace di tale aggressività, non lo sapevano; se non voleva quel marito, bene, ma non c’era mica bisogno di straziarlo in quel modo! Dalle morbide coperte su cui giaceva, la cagna si sentì buttare addosso ogni genere di rimprovero: “Cattiva, sei proprio una bestia! Hai visto che disastro hai fatto?” le urlava la padrona “Contenta ora? Sei stata un mostro, noi ci teniamo in casa un mostro!”. Lei abbassò leggermente gli orecchi, ma non si mosse dalla sua posizione di sfinge, girò verso il finestrino i suoi dolci occhi scuri, profondamente incassati nelle congiuntive arrossate e riprese a guardare il paesaggio davanti a sé, felice di trovarsi di nuovo sulla sua cuccia, in posti e situazioni note. La sera, per punizione, non fu messa a dormire nel suo materasso del soggiorno, ma nella sua branda “da fuori”, piazzata dentro la serra, lontana dai suoi padroni. Altri guai non ne avrebbe potuti fare né subire: in aprile di notte non fa freddo e il giardino è tutto recintato con pali di ferro e rete anodizzata. La mattina dopo, il sole già alto, li colsero sul fatto, la Leda e il maremmano. Bianco come la neve, principesco nel suo ricco pelame lanoso, si stava accoppiando sui suoi fianchi lucidi, dando all’insieme l’aspetto di un bel manifesto antirazzista. Scoprire da dove veniva quel cane e come avesse fatto a entrare, fu più facile che mandarlo via: di andarsene non ne voleva sapere; anche a tirargli sassi e pezzi di legna da stufa, non si muoveva più di tanto, anzi ringhiava a collo basso e coda ritta, si spostava un po’ e attraverso ampi semicerchi si riavvicinava alla cagna, che da parte sua non mostrava nessuna voglia di rientrare in casa. Ormai comunque era troppo tardi, l’amore aveva fatto strappare la catena a cui la notte lo legavano e così il maremmano era scappato da una fattoria della zona, lontana peraltro diversi kilometri; scavarsi un passaggio sotto la rete poi, non era stato per niente difficile. A quel punto si poteva solo sperare che nascessero degli ottimi bastardi, poco numerosi e di buon carattere, così da trovare per loro un padrone che li avrebbe amati. Ne nacquero quattro, di cui uno, un maschio pezzato, morì subito dopo il parto. Rimaneva ora solo il problema di come piazzare tre cuccioli alanomaremmani, cani di taglia enorme, di utilità discutibile e di valore nullo. Marco seppe della cucciolata da un suo collega che abitava da quelle parti e a casa raccontò tutta la storia come un piacevole aneddoto tra il secondo e la frutta. L’effetto fu deflagrante: lui si era dimenticato di quanto la loro figlia Chiara fin da bambina avesse insistito perché prendessero un cane. Con la pubertà aveva smesso di chiederlo, ma questa bella storia soffiò aria nuova sulla brace del vecchio desiderio e l’amore per il cane rinacque con forza. “Prendiamone uno noi, dai babbo, prendiamolo! Poi ci penso io a lui, a portarlo fuori; mamma, gli farò da mangiare io. Per favore…”. La ragazza, allora quattordicenne, impugnò la presa del cucciolo con tutto l’ardore di un’adolescente, ci mise dentro la forza di uno scontro generazionale, ne fece la sua bandiera sul fronte domestico, un simbolo di autoaffermazione. Tra l’altro rinfacciò ai suoi che non aveva mai avuto un fratello o una sorella e che ora le negavano persino un surrugato. Dopo una settimana di discussioni, musi, ostruzionismi, rispostacce, alla fine l’ebbe vinta lei e i suoi genitori, toccati dalla sua ostinazione, decisero di prenderle il cagnolino. Quando glielo dissero, la sera a cena, Chiara smise di mangiare; si bloccò sulla sedia guardando il piatto davanti a sé e poi si mise a piangere. A dirotto. Singhiozzava col braccio sulla tavola, il viso nascosto nel gomito e non rispondeva niente a nessuno. Era la fine di giugno, i cuccioli erano nati da un paio di settimane; gli ultimi d’agosto, di domenica mattina, tutta la famiglia si mise in macchina per andare a prendere il nuovo venuto. Chiara era raggiante: piazzata sul sedile posteriore con accanto una copertina di lana e un guinzaglino rosso, si sentiva emozionatissima; guardava la strada scorrere lungo il finestrino e ogni kilometro le sembrava l’eternità. Anche Marco e Arianna erano contenti: per tutti e due era dai tempi dell’infanzia che non avevano più un cane in casa; anche per loro un’avventura stava per cominciare. Siccome era figlio di un amore di campagna, decisero di chiamarlo Giorgio: manto sale e pepe, pelo semicorto, orecchi grandi e penduli, pauroso e sempre affamato, e a tre mesi pesava quasi trenta kili e azzannava tutte le cose che trovava sulla sua strada, soprattutto se di legno o di cartone: le zampe delle sedie, la statuina di tek portata dall’Indonesia, le scatole da scarpe e il loro contenuto, il ficus del soggiorno; alla fine si decisero a dargli dei giocattoli di gomma e degli ossi artificiali e la devastazione passò. Comunque, servendosi della parola “pazzi” parenti e amici avevano dato loro di imbecilli per essersi presi un cane così grosso, impegnativo, probabilmente aggressivo, per poi farlo vivere sacrificato in un appartamento di città dove certo avrebbe spaccato tutto e fatto guai a non finire. Giorgio invece faceva di tutto per farsi amare e ci riusciva benissimo: affettuoso e ubbidiente, come qualcuno si sedeva sul divano, gli saliva in collo e subito ci si addormentava, di fianco, con i grossi arti nodosi delicatamente sospesi nel vuoto, oppure a pancia all’aria, le zampe posteriori divaricate e le anteriori raccolte sul petto, come un coniglino. Dormiva e subito russava. Tutti facevano a gara a sedersi per primi sul divano, di fronte al quale era stato sistemato un panchetto, così che si potessero stendere le gambe e stare comodamente a leggere o a guardare la televisione mentre il cane pisolava sullo stomaco o sulle gambe. Qualche problema comunque c’era; soprattutto creava trambusto il suo spargere orine e feci un po’ dappertutto, ma così è per ogni cucciolo e nessuno si inquietava più di tanto. Si comprò per lui una paletta, uno straccio, un sacco di segatura e allo stesso tempo si cercò di insegnarli a fare i suoi bisogni sui giornali sparsi apposta per questo nell’ingresso. Giorgio imparava presto, era intelligente e lo dava a vedere, rendendo i suoi padroni orgogliosi di lui come fosse davvero un figlio loro. Accoccolato nel suo grembo, Arianna spesso se lo carezzava come un bebè. “Un cane è un bambino, un bambino per sempre, non diventerà mai grande, avrà sempre bisogno di qualcuno. Avrai sempre bisogno di me, vero?” gli diceva passando la mano sul suo pancino tondo e pieno, segnato da un ombellico piatto, una macchia scura al centro di un largo spiazzo di pelle ancora rosa e priva di pelo; gli immergeva il viso tra le orecchie e respirava il suo buon profumo di lattonzolo. Da quando il cucciolo era entrato nella casa, Arianna era più rilassata e contenta: grazie a lui, poteva dimenticare molte delle cose che appesantivano la sua vita, dimenticarle in massa e dimenticarle spesso, conquistandosi così, come una facile droga sempre a portata di mano, ampi quadratini di felicità. Il cagnolino aveva una grande macchia di pelo bianco sul petto, altre simili sulle zampe posteriori e su una delle anteriori; tutte le volte che le guardava a Arianna tornava alla mente qualcosa che aveva imparato al maneggio dove spesso andava da bambina , quando stava in Maremma , un maneggio a conduzione familiare che viveva soprattutto della stagione turistica. Intorno alla piccola fattoria tinteggiata di rosa, uguale alle decine di altre costruite ai tempi della bonifica, gli spazi e i recinti erano così ampi che i cavalli ci sembravano liberi. Nel caldo del pomeriggio estivo, una zampa posteriore leggermente sollevata, riuniti a cerchio sotto l’ombra di una sughera, le loro forme larghe, armoniose e immobili, davano un grande senso di pace e di tranquillità al paesaggio, impersonavano l’idillio stesso della campagna; grazie a loro, a un passo da motoscafi e ombrelloni, la Maremma si dilatava e diventava l’Arcadia. Arianna andava al maneggio tutte le settimane, non per cavalcare, ma perché il cavallaio e sua moglie erano anche gli ortolani di casa; sua madre ci faceva la spesa: avevano un grande orto, un frutteto, i polli, le uova. Comunque, una cosa le sembrava particolarmente strana in quel posto: come quell’uomo magro e apparentemente scorbutico, Rino il cavallaio, potesse così tanto somigliare lui stesso a un cavallo. Viso lungo, naso aquilino, capelli lisci e neri tirati indietro, corpo asciuttissimo, dei cavalli aveva assimilato persino l’odore. Le braccia, toniche e abbronzate, percorse da vene in rilievo, non sembravano tanto diverse dalle zampe sottili delle bestie che accudiva. Lo aveva sempre visto lavorare tra sellame, recinti, foraggi; tirava, agganciava, piegava cinghie, morsi, briglie, sottopancia. Arianna non capiva a che servivano tutte quelle operazioni, né gliene importava niente, però l’affascinava guardare la velocità e la sicurezza con cui le compiva, la successione rapida di quei gesti misteriosi la incantava come fossero i rituali di una religione sconosciuta. Stava volentieri con lui, quando la mamma comprava la verdura e chiaccherava con sua moglie . Mentre strigliava o puliva la stalla Rino le raccontava cose straordinarie sul mondo dei cavalli: le diceva che se possono mangiare avena a volontà, ne mangiano fino a morirne e come si fa in quel caso a cercare di salvarli e come però è difficile e poi le diceva dello stallone che quando sente l’odore della cavalla spacca tutti gli ostacoli sulla sua strada, diventa una furia che nessuno riesce a tenere e poi ancora le diceva di tutte le sofferenze che si devono imporre a un puledro per arrivare a domarlo. Arianna se le ricordava bene e con orrore, l’avevano così impressionata che si rifiutò sempre di imparare a cavalcare, anche se nella sua terra quegli animali erano di casa come i pesci nel mare. “Ti piacciono i cavalli?” le avrebbe chiesto molti anni dopo un uomo su una spiaggia della Maremma. “Sì, molto – gli avrebbe risposto quasi inalberandosi – sono cinquemila anni che vivono con noi e ancora l’ultimo puledro deve essere domato come fosse il primo; nascono selvaggi e liberi, non ereditano abitudini di servitù. Il morso, a ogni generazione, se lo fanno pagare. E caro! Certo che amo i cavalli”! Rino lo stalliere le aveva insegnato anche una breve filastrocca che serviva a riconoscere il carattere dei cavalli a seconda di quante delle zampe portavano una macchia bianca sopra lo zoccolo: “… Macchiato da uno, non lo dare a nessuno; macchiato da due, forte come un bue; macchiato da tre, cavallo da re; macchiato da quattro, cavallo tutto matto…”. Mentre si lasciava tornare a mente la vecchia rima del cavallaio, Arianna risentiva nel naso il tanfo acre dello sterco , quell´odore pungente da cui non si poteva scappare; le tornava agli orecchi il cantare delle cicale sugli eucalipti e l’afa pesante che avvolgeva la fattoria nei lunghi pomeriggi senza ombra. Ora le faceva piacere vedere che si ricordava in maniera chiarissima di tante cose e anche le faceva piacere farsi riempire di belle speranze guardando le tre chiazze bianche sulle zampe del suo cucciolo. “… macchiato da tre, canino da re..”. Quando Giorgio divenne adulto e il suo carattere cominciò a prendere forma, tutti si accorsero che avevano a che fare con un cane di pace: non sopportava che intorno a lui si creasse agitazione; se c’era qualcuno che alzava la voce o sbatacchiava qualcosa, si arrabbiava e cominciava a abbaiare finchè, pur di farlo star zitto, la quiete tornava. Ma soprattutto non sopportava che si piangesse: anche a farlo sommessamente, se ne accorgeva e metteva subito in azione la sua barriera sonora. Quando Arianna perse la sua carissima amica Catherine, per molto tempo, soprattutto nell’intimità della casa, le succedeva di ritrovarsi a piangere; le bastava vedere un certo oggetto o ripercorrere un ricordo o un pensiero e l’afflizione per la scomparsa di lei le risaliva alla gola, pungente e incontenibile. Ma guai a sedersi col viso tra le braccia o a singhiozzare sul divano o appoggiata al muro, guai a lasciarsi scappare suoni di dolore, lui si alzava dalla cuccia, le si avvicinava con occhi inquieti, si piazzava davanti a lei e la investiva col suo abbaiare continuo e assordante. L’idillio tra Chiara e Giorgio durò un paio di mesi, poi gli amici, la scuola, gli amori lo trasformarono in un tiepido affetto, in una quieta amicizia con qualche ritorno di fiamma quando le cose andavano sentimentalmente molto bene o molto male. Marco invece si era profondamente affezionato al suo cucciolo e anche se i suoi ritmi di lavoro non gli lasciavano più di tanto tempo libero, faceva di tutto per stare con lui. Tutte le sere era col padrone che andava fuori e con lui che rimaneva a poltrire fino a tardi, sul divano davanti alla televisione. Nell´insieme, la vita nella casa si era molto arricchita da quando ci era entrato il cane e anche il mito della minor libertà che così spesso trattiene dal prenderne uno e che anche loro inizialmente avevano temuto, si era presto sgonfiato fino a diventare inavvertibile. Libertà era diventata per Marco e Arianna la possibilità di gioire della vicinanza del loro cane e se dovevano organizzare con piú fatica vacanze e uscite – lo facevano volentieri, accettandolo come qualsiasi altra necessità naturale. Nella casa, la persona con cui Giorgio stava più spesso era comunque la sua padrona. Durante il giorno stavano quasi sempre insieme; se lo portava in macchina a fare la spesa e anche quando andava a gettare la spazzatura nel cassonetto, lo prendeva con sé; era lei che gli dava da mangiare, lei che gli levava le pulci, lei che lo accarezzava tutte le volte che se lo trovava vicino. Lei che gli insegnava i comandi, il “qui”, il “seduto”, il “fermo”, ma anche parole come “latte”, “burro”, “patè”, “gatto”, “cane”, “ guinzaglio”, “parco” e tanti altri vocaboli ricorrenti e senz’altro importanti nella vita quotidiana di un cane molto amato. Lui imparava tutto. Insomma, tra Arianna e Giorgio era cresciuto un intenso rapporto, un’intesa simile all’amore, un legame pulsante e forte di cui nessuno dei due faceva mistero. Capitolo IV Il massimo del piacere per un cane urbano é che lo si porti a passeggiare nel parco, cosa molto diversa dalle solite uscite ai giardini pubblici o nei quadratini di verde vicino a casa. La cittá dove vive Giorgio ne ha uno, un pezzo di verde a lungo respiro, grande abbastanza da suggerire il selvatico, l’incolto, il bosco, il naturale, un posto in cui a volte succede di guardarsi intorno e non vedere nessuno, in cui la pioggia appena caduta lascia dietro di sé scie di profumi asprigni e misteriosamente familiari. Gli alberi non vi vengono potati e le foglie d’autunno cadono in libertà coprendo di strati soffici le tracce sui sentieri. Un parco così é un’oasi, ma anche una traccia di memoria della città che si ricorda di cosa esisteva prima che si impiantasse lei, quando i campi e i boschi stavano al posto degli orti, dei sobborghi, delle mura, dei palazzi. Ma ora per chi vive in un grande centro urbano, un parco è più che altro il lusso di dimenticare tutto quello che gli cresce intorno. Anche per Arianna è un grande piacere sentirsi di nuovo tra le braccia verdi della natura, percorrere viottoli, attraversare prati, costeggiare siepi in compagnia dei suoi pensieri e del suo cane che le trotterella sempre accanto, col naso schiacciato in terra o incollato alle foglie di un cespuglio. Giorgio la protegge, con la sua grossa mole e col suo aspetto minaccioso. Se lo si guarda negli occhi, ci si accorge subito della mitezza del suo carattere, ma se non si prende questa premura, allora un cane così grande , setoloso, dalle labbra pendule piene di bava, non ispira grandi avvicinamenti. A volte se lo chiama vicino, senza motivo, per la sola gioia di potergli fare una carezza; lui le si appoggia contro le gambe, si lascia lisciare i fianchi solidi, aspetta che gli arrivi il “vai!”, poi riparte di corsa verso tracce di scoiattoli o altri animali, odori interessantissimi, introvabili nelle sue solite passeggiate intorno a casa. Quel pomeriggio il parco era ancora bagnato dalla pioggia della mattina; le foglie dei cespugli si accendevano nei momenti in cui il sole riusciva a farsi largo tra spessi strati di nuvole grige. L’aria trasudava un forte odore di muschio e di terra umida. Tra siepi di lentaggine, il sentiero si apriva lucido e molle . Sulla mota morbida e rossiccia, si imprimono nitide le grosse impronte di Giorgio e il profilo dentato delle suole di Arianna; forme di cane, forme di uomo, la terra le registra vicine, quasi sovrapposte, a indicare la loro diversità così come il loro legame. Lei cammina con le mani pigiate dentro le tasche del giaccone, il bavero rialzato, il colbacco calcato e annodato sotto la gola. La sciarpa di lana copre il resto, lasciando fuori solo gli occhi e il primo tratto del naso. Grazie al freddo e al cattivo tempo, in giro non c’è nessuno e Arianna si gode in pieno questa preziosa solitudine; i grandi alberi e i viottoli l’avvolgono a gentile distanza, tessendo intorno a lei atmosfere intime e protettive. Ma il freddo si fa sentire, i piedi le si stanno già ghiacciando, Arianna stende ripetutamente le braccia all’infuori, compie esercizi ginnici improvvisati e scomposti; le piace muoversi senza scopo, sentire il calore nascerle dentro, provare il proprio corpo in quell’ambiente che sa di natura e di libertà. Fa gesti buffi e sgraziati ma non importa, tanto nessuno la vedrà. Attraverso una boscaglia di tigli e di quercie, arrivano un uno spiazzo aperto, un tratto erboso oltre cui il parco arborato ricomincia, solcato da un largo sentiero sinuoso. La radura è una piccola prateria, grande e raccolta allo stesso tempo, ariosa eppure finita. Con Giorgio sempre al suo fianco, si ferma, si piazza solidamente in mezzo al terreno e fa qualche flessione: si piega in avanti fino a toccare la terra con le dita, tre, quattro, cinque volte. Sta per prendere un lungo respiro prima di ricominciare, ma qualcosa davanti a sé la immobilizza e la fa raggelare: dall’altra parte della radura, solo tra l’erba gialliccia, un grosso rotweiler sta in piedi immobile puntando dalla sua parte. Sa benissimo cosa questo puó voler dire, si è trovata altre volte in situazioni simili. “E’ un maschio?” Sì, è un maschio. Il suo padrone? Intorno nessuno. “Mamma mia! Si azzufferanno”. Se lo sente, oppure lo teme fino a sentirselo. Si mette davanti a Giorgio, più nel tentativo di nasconderlo che di proteggerlo. Intanto grida nell’aria umida: “Lo tenga! Tenga il cane, presto!”. Grida verso nessuno. Comunque è troppo tardi: l’altro si sta già avvicinando al trotto, a testa bassa, come un toro contro un bandolero, dritto verso di loro. Anche Giorgio si sta irrigigendo, arretra gli orecchi, drizza la coda, alza il pelo. Si prepara allo scontro. Il rotweiler affretta il passo, è vicinissimo. Arianna riesce solo a gridare, grida come un’isterica, come chi è in preda al terrore, non riesce a fare altro, strilla e cerca di mandarlo via con gesti imperiosi e comandi inutili. Il cane si è fermato a un paio di metri; lei lo sa, è il fischio d’inizio; istintivamente si scansa, ma intanto non smette di gridare mentre l’inevitabile si compie. Si agguantano subito senza preamboli, tra bava e ringhiate selvagge. L’altro cerca di addentare Giorgio sul collo, ma lui tiene alta la guardia, scarta di lato e cerca a sua volta di azzannarlo sul dorso; ma non è abbastanza deciso né svelto né aggressivo. Arianna lo vede che viene morso, nel fianco, nella gamba, nel muso, poi non distingue più niente, tutto si svolge troppo rapidamente; è un ammasso di pelo e di muscoli che si avvolge a spirale, quello che succede la dentro non si lascia capire. Urla ancora, scaglia il pesante guinzaglio di cuoio e di metallo contro l’aggressore, lo prende in pieno ma quello nemmeno se ne accorge, così come lei non si accorge di qualcuno che si sta avvicinando e sbercia: “Jago, qui!… Jago! Deficiente, smettila!”. Sangue sta già colando sul pelo di Giorgio, dal muso e dalla schiena. “Lo tenga, lo tenga!” gli strilla. L’uomo è riuscito a aggirare il suo cane e a agguantarlo da dietro per il collare; ora lo sta strappando fisicamente via, con sforzo, perché quello continua a tirare in direzione opposta, si solleva sulle zampe posteriori, ancora ringhia e sbava. Il corpo a corpo è finito, lei si getta sul suo cane, scioccata ma lucida abbastanza da cercare di vedere con ordine quello che gli è stato fatto. Sta tremando tutta, di un tremito vistoso e incontrollabile, il cuore le batte forte, lo sente picchiare agitato contro il torace. Giorgio sta in piedi ansimante, coperto di macchie di sangue che impastano il pelo grigio un po’ dappertutto. Gli guarda per primo il collo e la gola, ma lì non vede lesioni, il grosso del sangue che cola viene, le pare, da una ferita sopra la spalla e da un’altra più piccola sotto l’orecchio. Continua la perlustrazione: un lungo squarcio segna la zampa posteriore destra, sopra il calcagno ciondola un brandello di pelle sotto cui una lunga striscia di carne rossa sputa sangue come una lenta fontana. Non sa che fare, non ha mai fatto nemmeno un corso di pronto soccorso, se ne rende conto solo ora. Forse dovrebbe cercare di riappicciare la pelle e fasciare, oppure bisognerebbe prima pulire la ferita. Già, e con cosa? Lì, in mezzo a niente… non lo sa. Si sarà leso il tendine, o addirittura l’osso? Gli fa fare un paio di passi tirandolo per il collare; sembra che la possa muovere, la zampa. Solo ora si guarda intorno, verso l’altro cane, in tempo per vedere l’uomo infilarsi nel sentiero dall’altro lato dello spiazzo, a passo spedito e tirandosi dietro un rotweiler al guinzaglio che ancora si volta e tira verso di loro. Arianna gli urla di aspettare, il suo cane è coperto di ferite, è colpa sua, le deve pagare i danni. Non gliene frega niente dei soldi, ma è la prima cosa che le viene in mente per ristabilire una qualche idea di giustizia che riequilibri tutta quella sopraffazione. Fa in tempo a dargli di stronzo , di porco criminale prima di vederlo inabissarsi nel folto del bosco e sparire trai lecci e i cespugli, quatto e silenzioso come un serpente. Il sangue cola dappertutto in grosse gocce cupe. Cade sulle foglie risecchite dei platani, sulla terra battuta, sui piccoli sassi grigi e striati, mezzi ingoiati dal terriccio. Arianna è in panico, tutti i suoi sforzi sono per riprendere a ragionare e fare la cosa giusta. Più di tutto teme che Giorgio stia soffrendo molto e non sa come aiutarlo; lui non si muove, né da’ segni di dolore, solo tiene la lingua di fuori, ansima e inghiotte con frequenza guardando fisso davanti a sé come se non vedesse niente. Si fruga nelle tasche, trova dei fazzoletti di carta con cui cerca di tamponare la ferita più grossa che invece, come una clessidra inarrestabile, continua a emettere flotti che si convogliano in piccoli rivoli e cadono in macchie larghe sull’erba e sulle sue mani. Intorno non c’è nessuno. L’intimità con il parco che fino a allora l’aveva nutrita e sostenuta, le si sta rivoltando contro, trasformata in un minaccioso senso di isolamento e di estromissione. Intorno a Arianna solo alberi e suono attutito di macchine lontane. Le sembra che la città la voglia punire con lo starle distante, vendicarsi con lei per averle preferito quell’angolo verde e selvatico, fino a poco prima amato proprio perché antitetico ai modelli urbani. La zampa posteriore è quella che butta più sangue. Si sfila dal collo il foulard che porta sotto il giaccone, cerca di rimettere in sede il brandello di pelle ciondolante, lo fascia tutto con quel suo pezzo di vestiario; le pallide rose, le foglioline verdi, i teneri tralci di glicine stampati sulla seta, si scuriscono e scompaiono imbevuti di denso colore rosso. Arianna gli riaggancia il guinzaglio e con i fazzolettini premuti sulla ferita del dorso, lo sospinge zoppicante verso la strada. Un veterinario, ora tutto per un veterinario! La percorre un tremito nervoso che si fa sentire più chiaro quando è costretta a fermarsi. “Non posso portarlo alla macchina è troppo distante e poi da lì al nostro dottore ci vorrebbe un’altra mezz’ora, bisogna che ne trovi uno qui vicino, subito!”. Quei marciapiedi, quelle strade, quelle case lontane che si intravedono oltre le cime degli alberi ora vengono desiderate, sono loro la meta ambita. Domanda affannata alla prima persona che incontra dov’è un ambulatorio veterinario. Per fortuna lo sa, è un uomo anziano con un piccolissimo cane al guinzaglio. Prosegue di fretta, troncando in malomodo la curiosità di quel signore che vedendo sangue dappertutto vorrebbe sapere che è successo. Subito si rende conto della sua ingratitudine; le dispiace. “Grazie, è stato molto gentile!” gli grida voltandosi indietro mentre quello è già lontano e lei continua a accellerare il passo. C’è circa un quarto d’ora, le hanno detto, un tragitto lungo, che si rivela a ostacoli, pieno di sentieri mai percorsi, poi di semafori, di case uguali che disorientano, di vie dal nome sconosciuto. Giorgio cammina con difficoltà, la lingua gli pende gocciolante come in un pomeriggio di luglio, ansima e ogni tanto, nelle piccole soste che la sua padrona gli concede cercando di mediare tra fretta e compassione, trema violentemente. Lei, a ogni pausa sente vampate di caldo emanarle dal viso e dal collo. Da passanti e automobilisti raccoglie sguardi pieni di transitoria curiosità. Per fortuna non piove, anche se il tempo si è ulteriormente rannuvolato e un cielo plumbeo preme contro le grondaie e le terrazze degli ultimi piani. Intorno a lei che si affretta, l’inverno continua a spruzzare di freddo opaco le strade del vecchio quartiere residenziale che sonnecchia indifferente nella tranquillità molle del primo pomeriggio; un quartiere sconosciuto e ostile. Finalmente la targa col nome della via che le era stata indicata. “Dai, Giorgio, tieni duro, siamo quasi arrivati”. La croce azzurra dell’ambulatorio è ancora lontana, ma già la si intravede sporgere dal filo delle case. Arianna si sente come un fondista agli ultimi metri del percorso, un percorso che è stato tutto segnato da piccole macchie di sangue scuro. Capitolo V La porta si apre con impeto. Nell’ambulatorio, i clienti in attesa zittiscono: Giorgio ancora ansima, piccole gocce rosse si appiccicano al pavimento, i vestiti di lei e le mani sono imbrattati di sangue fresco. “E’ stato attaccato da un altro cane”, dice subito, per difendersi dalla palese curiosità. Non se l’aspettava, ma scattano solidarietà e premure quasi affettuose: le offrono dei fazzolettini, si impegnano a occuparsi del ferito se lei vuole andare nella toilette a lavarsi; le farebbe bene un goccio di cognac, dice un signore e si offre di andare al bar a prenderglielo. Arianna aveva molto bisogno di essere confortata, ringrazia e quasi si commuove. Cerca comunque di controllarsi e intanto fa mente locale sul fatto che c’è un dottore per Giorgio, lì a un passo da lei, qualcuno a cui potrà finalmente passare il fardello di quell’incidente; quello che spettava a lei, l’aveva fatto. Si getta su una sedia, flette la testa all’indietro, lascia cadere giù le braccia e si permette un piccolo sorriso di vittoria. Sente il sudore colare e ghiacciarsi sulla schiena, il cuore batterle svelto, il respiro uscirle dalla gola denso, con lo spessore di un amalgama tattile. Giorgio si scosta dal suo fianco, ritira dentro la lingua e si mette a annusare le gabbie coi gatti che gli altri clienti tengono sulle ginocchia; loro si mostrano molto tolleranti, ridono e lo carezzano nonostante i piccoli felini si agitino e si schiacciano sul fondo delle ceste soffiando col pelo gonfio e gli occhi dilatati; questa vitalità del cane sembra a tutti un buon segnale. Arianna non ha bisogno di chiedere nulla, naturalmente la faranno passare per prima. Ma nonostante gli altri cerchino di sollevarla con consigli e racconti a lieto fine di altri incidenti simili, Giorgio continua a sanguinare e il tempo non passa mai. Quando la porta a vetri opachi si aprì e l’uomo vestito di bianco si affacciò, a lei sembrò si aprisse il paradiso. Infilò dentro quasi investendolo. Che cos’era successo? Morso da un rotweiler? Non era il primo. Guardiamo un po’… non era grave, niente lesioni serie, il tendine era illeso, un paio di punti e sarebbe tornato come prima. Lei era molto agitata, lui invece tranquillissimo, le diceva senza enfasi di non preoccuparsi e intanto sceglieva tra armadi e cassetti gli strumenti che gli sarebbero serviti. Arianna in genere non aveva molta fiducia nei medici, il primo impatto era una diffidenza vigile che solo dopo un pressante e impietoso esame dei comportamenti emersi nel corso della visita, si trasformava in fuga o adorazione. Il fatto che questa volta si trattasse di una situazione di emergenza, la rese meno critica: c’era poco da scegliere, le restava solo da sperare di non aver imbroccato uno dei tanti veterinariimprenditori, interessati più che agli animali alle finanze dei loro padroni. Di quelli aveva davvero paura. Cercò di essere ottimista, pur mantenendosi attenta; bisognava non farsi spiazzare dal fatto di essere totalmente nelle mani del caso. Si lasciò tranquillizzare dalla prognosi favorevole, ma allo stesso tempo continuò a domandarsi se quell’uomo sapesse il fatto suo, se i suoi strumenti fossero puliti, quanto fosse leggera la sua mano e solida la sua preparazione professionale. Si guardò intorno per cercare di quantificare la qualità della sua attrezzatura clinica, ma di apparecchiature propriamente chirurgiche – tipo tavolo operatorio o macchinari radiografici – non vide nulla. “Non sarà mica che non ne ha?” si domandò e divenne più inquieta. Il dottore era passato a radere le zone intorno alle ferite, il pelo cadeva senza rumore accumulandosi sul pavimento in folti batuffoli sparsi, come dal parrucchiere. Da un gancino sul muro staccò un lungo laccio e lo strinse forte intorno al muso del cane. “E’ proprio necessario così stretto?” “Purtroppo sì”. “Gli farà un’anestesia locale?”. Naturalmente gliela farà. Ecco, ci siamo, ora tutto è pronto, si tratta solo di ricucire: i lembi di pelle verranno riaccostati con un ago che li trapasserà e poi verranno tenuti insieme da un filo annodato con arte su ogni punto. Arianna non sa dove volgere la testa. Sentirà male? Deve controllarsi per non sbaciucchiare il muso di Giorgio mentre il buco dietro la spalla viene suturato. Gliene avrà fatta abbastanza di anestesia? Qualcosa sente perché è inquieto e cerca di scappare; ma la sua padrona lo tiene fermo, carezzandolo e parlandogli dolcemente, facendo coraggio a lui per far coraggio a se stessa; il tempo anche ora non passa mai, sta lì, pesante, immobile, la comprime e la schiaccia gravandola di ansia e tensione. Si guarda intorno per cercare qualcosa che distolga la sua attenzione da quello che sta accadendo a un braccio da lei: sulle pareti un manifesto con le razze canine, una stampa antica con mucche pezzate al pascolo, un certificato di laurea, accidenti come è giovane! Otto anni secchi meno di lei e già sa accomodare un cane, mentre lei è solo in grado di coccolarlo e certo nemmeno di difenderlo o proteggerlo. Sopra la scrivania sta appeso un calendario con un grosso cavallo da tiro e accanto a quello una foto – o perlomeno così le sembra – di David Oistrach con suo figlio Igor, armati di violino e archetto, sorridenti e soddisfatti davanti a un tavolo cosparso di spartiti. Che c’entrano loro con la medicina e la chirurgia? Era comunque contenta di porsi domande che divagavano da quella situazione. Il ferito, tremante e con la coda tra le gambe, approfitta del temporaneo allontanarsi del dottore che è andato a prendere un porta-aghi e tira con forza verso l’uscita; di nuovo lo trattiene con dolce fermezza, però lo capisce bene, anche lei non vede l’ora di infilare quella porta e andarsene. L’uomo torna con una nuova pinza che tiene ben saldo un piccolo ago ricurvo. Nessuno parla. Di nuovo Arianna volge lo sguardo in giro e di nuovo gli occhi le cadono sui violinisti. Magari fosse già a casa, a sentire bella musica insieme al suo cane e tutto fosse già passato! Si gira verso il chirurgo e lo vede che, inginocchiato di fianco al suo paziente, si sta occupando della zampa posteriore; anche lei è inginocchiata, ma contro il muso e dall’altro lato; del dottore vede solo la testa curva, le scapole spigolose fasciate dal camice e uno dei ginocchi che preme contro il linoleum del pavimento. “Poverino – pensa – in che posizione deve lavorare!”. E poi, sentendosene in parte responsabile, gli chiede: “Ma non sta scomodissimo così?” “Sì, abbastanza, però non c’è nessun altro modo .” Parlava senza alzare la testa dal suo lavoro “Che tipo acido! – pensa – era meglio se stavo zitta”. Invece una qualche conversazione è partita; mentre continua a cucire, le chiede informazioni sul cane, sull’età, se per il resto è sano, se ha avuto l’antirabbica; le chiede persino come si chiama. Arianna gli risponde cercando di evitare parole inutili, ma del tutto non le riesce, le scappa ugualmente qualche divagazione. “Dev’essere molto difficile suturare con precisione, in punti scomodi e così alla svelta… mi sembra”. “No, non è vero – le risponde col viso nascosta dalla schiena di Giorgio – qualunque donna che sa un po’ cucire, dopo un paio di volte farebbe un lavoro migliore del mio; le donne sono molto brave come chirurghe, hanno più manualità degli uomini. In ogni caso, nel nostro lavoro, le cose complicate sono altre…e non solo nel nostro lavoro!”. Alzò la testa al di sopra del paziente e la guardò con uno stretto sorriso ironico: “Singolare che qualcuno si occupi delle difficoltà che incontrano gli altri -le disse- e comunque … tra tutte le cose complicate, quella più difficile la sappiamo fare tutti, no?”. Sembrava essersi divertito molto a dire quelle parole nebulose. Arianna vide il suo sorriso ora aperto rinabissarsi dietro il suo cane. Non se l’aspettava, lì per lì non trovò niente da rispondergli, però le fece uno strano piacere sentire quella frase; che coincidenza! Solo qualche settimana prima aveva trovato quella stessa riflessione su un testo di Montaigne che diceva nella sostanza così: la morte ci richiede la cosa più difficile al mondo, ma non facciamone un problema, non stiamo a preoccuparci, tanto ci penserà lei a levarci tutti dall’impaccio! Anche Arianna sorrise, lo sguardo fisso sul pelame ruvido di Giorgio. “E’ vero, è proprio così!” fece in tempo a dire mentre il veterinario già si stava rialzando con in mano la vaschetta con gli strumenti. “Bene, ecco fatto!”. Concluse spolverandosi i ginocchi cosparsi di pelo grigio. “Gli sciolga pure il laccio ora”. Lei lo fece, ma le sembrò che qualcosa fosse stato dimenticato. “Sull’orecchio non lo ricuce?” “Se lei vuole, glielo ricucio dappertutto, ma sull’orecchio la ferita è piccola, il tessuto cartilaginoso, si chiude da sé, tra una settimana non si vedrà più niente”. La piccola operazione era quindi ufficialmente finita. Arianna tirò un profondo respiro di sollievo; ora che gli strumenti venivano ripuliti e riposti sentiva la tensione scivolare via. Era stato fatto proprio tutto e in fondo a Giorgio era andata abbastanza bene. Ora poteva anche permettersi di sorridere, di pensare,di osservare il veterinario, che forse non era poi lo sprovveduto che aveva temuto, anche se giovane; anzi, in fondo era lui, solo lui, l’angelo che aveva ribaltato tutta la situazione, non doveva dimenticarlo e perlomeno essergliene grata. In piedi accanto alla porta lo studiava cercando di non farsene accorgere: l’angelo, da bambino doveva essere stato di pelo rosso, lo dicevano i forti riflessi color tiziano che anche ora animavano i suoi capelli, mossi e semilunghi, che si accesero di quella tonalità quando si sedette vicino alla finestra per prescrivere gli antibiotici. Probabilmente aveva avuto i capelli rossi e le lentiggini che, scomparse dal viso, si facevano riconoscere sul dorso delle mani, ossute e lunghe. La pelle era chiarissima. Piuttosto piccolo e di corporatura gracile, a Arianna dette l’impressione di uno più adatto a scrivere poesie e romanzi, che a aprire e chiudere animali, o tantomeno far partorire cavalle e castrare giovani tori, cose che invece faceva tutti i giorni il veterinario del paese dove era nata. “Mi raccomando, questi antibiotici glieli faccia tutti, tra dieci giorni ci si rivede e si levano i punti.” Lei, quasi più di Giorgio, aveva voglia di uscire di là e respirare l’aria aperta del fuori, agognava quel senso di liberazione che si ha quando si esce da un ospedale, da un carcere, da un convento. Le fu chiesto un onorario al di sotto di quello che si aspettava; le fece molto piacere, non tanto per la convenienza economica, ma perché questo gettava un fascio di bella luce sulla figura di quell’uomo, non più ascrivibile tra i veterinari-imprenditori. Prima di uscire lui la salutò e le tese la mano, assumendo per l’occasione una posizione artificialmente eretta, quasi sugli attenti. Arianna la trattenne un attimo nella sua mentre lo ringraziava di cuore. Ora che tutta la paura era passata, fiumi di gratitudine si facevano avanti. “Mi scusi se mi sono mostrata diffidente, mi dispiace, ma ero molto agitata quando sono entrata qui”. E senza curare troppo la sintassi, aggiunse: “Lei è stato davvero bellissimo a prendersi cosí cura di lui; bellissimo! Grazie!”. Sulle labbra del dottore comparve un breve sorriso speciale, quello un po’ schivo e irrefrenabile che scappa quando si incassa un complimento dato a sorpresa e in tutta sincerità. Era il sorriso della completa recezione. Nella fanghiglia della comunicazione quotidiana, formale, pilotata, codificata, la spontaneità può avere effetti deflagranti, foss’altro per l’enorme densità di comunicazione che porta con sé. Parlare e comunicare non sono la stessa cosa: con uno si entra in contatto, ci si avvicina, con l’altro ci si tocca. Questo secondo caso non si verifica spesso. Rispetto all’estensione variegata di una conversazione, la comunicazione rappresenta una rara eventualità, è il piccolo centro nero del tirassegno: lo si colpisce raramente, ma se mai lo si prende, il punteggio è altissimo. Così accadde per il veterinario, colto di sorpresa dall’inatteso complimento e dalla gratitudine piena di entusiasmo della sua occasionale cliente. Era stato centrato nel suo orgoglio professionale, ma anche erano state toccate in qualche modo le corde sensibili della sua vanità personale. La pelle del viso gli diventò meno bianca e oltre a “Buonasera” non trovò nient’altro da rispondere. Capitolo VI Quella sera, per Giorgio dosi extra di carezze e attenzioni. All’ora dell’ultima passeggiata, Marco uscì armato di un ombrello, per difenderlo nel caso qualche cane lo avesse infastidito proprio ora che si muoveva a rilento e che la zampa gli faceva male. Gli fu persino comprato un pezzetto di patè, la sua leccornia preferita, quella che riceveva in occasioni molto speciali, quali il suo compleanno o il pranzo di Natale. Marco e Arianna rimasero a lungo incerti se avvisare o meno la figlia dell’incidente di Giorgio, poi alla fine decisero di farlo; come prevedevano, ne rimase impressionata e dispiaciutissima, ci vollero diversi argomenti per convincerla di non tornare subito a casa. Anche se non lo vedeva spesso, quello era comunque il suo unico, vero cane, una presenza importante, un pezzo della sua vita a cui si sentiva profondamente legata. Chiara aveva quasi venti anni, faceva il secondo anno di psicologia a Padova; aveva preferito iscriversi in un’altra città per rendere più giustificato e duraturo il suo stare lontano dai suoi; già dagli ultimi anni del liceo vedeva l’esame di maturità come il passaporto con cui le si sarebbero aperte le porte dell’indipendenza. Con suo padre andava molto d’accordo, fin da bambina lui la lasciava sempre fare, l’assecondava spesso fin nei suoi capricci; da adolescente, non si mostrava apprensivo, le concedeva molta libertà e dormiva tranquillo anche se lei rientrava più tardi del convenuto. Quando finalmente venne l’età per il motorino, Marco era favorevole a comprargliene uno, ma la madre, questa madre che si contrapponeva così spesso, lo rifiutò categoricamente. Terrorizzata dall’idea di vederla giacere sanguinante sull’asfalto, confondendo a pieno la paura col presentimento, passò anni a accompagnarla in macchina quasi dovunque finchè non venne per entrambi la liberazione della patente. Quattro ruote, a torto o a ragione, sembravano più sicure di due. Nell’educazione di Chiara era Arianna che quasi sempre stabiliva se una cosa si faceva o non si faceva, lei che le aveva imposto le lezioni di musica, il brutto apparecchio ortodontico, lei che le ripeteva in continuazione di stare diritta a tavola o di non metterci i gomiti sopra, di ringraziare qui, di salutare là. Col crescere della loro ragazza, cresceva anche la sua voglia di scappare da quel protettorato pesante; sua madre era rigida, rigorosa e per di più ingerente; per Chiara diventava sempre più difficile sopportare le sue varie intrusioni, tipo che si mostrasse critica sulle sue letture, sulla sua musica, che fosse ostile a alcune sue amiche, che mal sopportasse il suo attivismo in associazioni cattoliche. “I preti – si era sentita dire dalla mamma – hanno messo su il loro grande apparato di potere perché da secoli speculano sulla paura che tutti abbiamo della morte. Pensaci quando sei a fare i pacchettini per le missioni”. “Forse, ma io perlomeno faccio qualcosa anche per gli altri, e tu che fai, oltre che pulire la tua casa e preparare da mangiare per il babbo e per il tuo cane?”. A volte Arianna si meravigliava della distanza astrale che separava le loro visioni della vita, ma non ci poteva far niente; forse dopo, quando sarebbero diventate più vecchie, avrebbero trovato terreni su cui riavvicinarsi, ma per ora la frattura era profondissima. Molto più sano quindi che sua figlia vivesse per il momento lontano dalla zavorra di sua madre e si costruisse da sola il proprio sistema di valori. Ciò nonostante, i primi tempi della separazione furono duri: Arianna doveva fare grandi sforzi per non telefonarle tutti i giorni e quando finalmente la sentiva, rimaneva sollevata e raggiante solo per qualche ora poi, tornava a incupirsi. La casa si era svuotata senza di lei, anche Marco e Giorgio si erano fatti piccoli e sguazzavano come pesciolini in quel grande contenitore. Non avrebbe mai creduto che sua figlia le sarebbe potuta mancare così tanto, le sembrava che il loro cordone ombellicale non fosse mai stato reciso prima del giorno in cui se n’era andata. Sentiva dentro di sé un languore vischioso che strisciava sulla sua anima risucchiando gioie e energia senza restituire niente, qualcosa di molto vicino al dolore.E cosí per settimane. La sera, sul divano, le veniva da appiccicarsi a suo marito come un parassita. Gli sedeva accanto, quasi premendosi contro le sue gambe, con stretto in mano un romanzo aperto su storie che non ce la facevano a coinvolgerla . “Devi pensare che lei sta bene – le diceva Marco passandole un braccio sulla spalla – Chiara sta bene fisicamente e anche interiormente. A questo devi pensare, è un buon risultato, anche per noi, non ti sembra?”. L’adattamento è un’arma di cui in quel periodo Arianna potè sperimentare tutta la potenza. Un po’ alla volta, mese per mese, scoprì che poteva vivere anche senza sua figlia. In un primo momento se ne sentì in colpa, ma poi anche questa convinzione si indebolì fino a trasformarsi in una specie di fiera consapevolezza di aver saputo accompagnare il proprio cucciolo fino all’indipendenza. La volta che Giorgio venne morso nel parco, Chiara viveva fuori casa da oltre un anno. Grazie alla distanza e forse anche alla crescita di tutt’e due, i suoi rapporti con la madre erano migliorati, tanto che quando si vedevano, a volte per interi giorni, stavano quasi bene insieme. Arianna si attorcigliava il filo del telefono intorno al dito mentre raccontava l’incidente della mattina, compreso il nuovo veterinario a cui si era dovuta rivolgere; le faceva piacere essere costretta a parlare di lui. “Non sarà mica l’ambulatorio dietro al parco, quello vicino al supermercato?”. La interruppe Chiara. “Non lo so, non ci ho fatto caso… ma a ripensarci bene, mi sembra di averlo visto un supermercato … Ma perché? Lo conosci?”. Arianna si fece inquieta e più attenta. “Se è il veterinario che dico io e se è davvero bravo quanto stronzo, allora Giorgio è stato ricucito benissimo!”. “Che vuoi dire?” “No, niente, lì ci lavora uno che conosco, è stato un po’ con la Daniela, la sorella più grande della Susanna; te la ricordi la Susanna, quella di classe mia? E’ uno sempre pieno di donne, uno che si crede chissà chè perché è bello e bravino, che si permette di trattare male chiunque se gli gira torta. La Daniela ci soffrì molto, le faceva certe stronzate…”. Arianna ci rimase male, non aveva intuito niente del genere dal contatto con quell ´uomo; le sembrava inoltre una pesante intrusione che sua figlia lo conoscesse. “.. Ci fu un casino in casa sua quando lui la lasciò! Lei la prese malissimo, ingoiò otto pasticche di tranquillanti, la portarono all’ospedale. Non successe nulla, dormì per due giorni e basta, ma tutti si presero una gran paura; lui però niente, lo seppe, ma non si fece vivo mai”. Chiara tacque per qualche secondo. “E poi?” chiese sua madre. “Poi non tanto meglio: Daniela si prese un bell´esaurimento; invece di cercare di dimenticarlo si mise a odiarlo pubblicamente, a parlar male di lui a ogni occasione, con chiunque, anche con gente che quasi non conosceva, anche con me. Era una fissazione, attaccava certi bottoni…”. Arianna provava un piacere perverso nel venire a sapere tutte queste cose; per quanto sgradevoli era comunque un entrare nella vita privata del suo dottore. Aveva una gran fame di queste notizie. “Secondo me si era anche messa a studiare delle formule che lo distruggessero in poche parole. Una volta che ero dalla Susanna ricominciò con le solite lamentele e poi disse: “E’ un ottimo veterinario, preparato come ce ne sono pochi; un medico onesto, come ce ne sono pochissimi; un uomo rozzo e brutale, ottuso e ignorante come ce ne sono milioni”. Me la ricordo perché mi fece un certo effetto… una battuta così teatrale e poi perché noi l’abbiamo poi riciclata quella frase cambiando qualche parola qua e là…. La si può applicare a molti! - rideva Chiara dall’altra parte del filo - Io credo proprio che se l’era preparata a tavolino, non ti pare?” “Forse… ma può darsi anche che le sia venuta spontanea. Comunque non so se quello di Giorgio era lui. Com’è questo spezzacuori?” “Giancarlo? Uno piuttosto bello, alto, capelli neri, fisico atletico… ha dei bellissimi occhi azzurri, questo bisogna dirlo”. “No, quello di oggi è uno mingherlino e biondiccio”. “Ah, meglio così, mi sarebbe dispiaciuto se fosse stato proprio lui”. Arianna poteva riprendersi il suo sconosciuto. La giornata era stata intensa, pienissima. Quella sera si sedè sul divano imgombra di pensieri e emozioni corpose: la grande paura avuta per il suo cane, la gioia per l’uomo in camice bianco, la nota dissonante di sua figlia che quasi lo conosceva. Per tutto il giorno aveva ripercorso gli avvenimenti che le erano successi, ma dovunque partisse la loro ricostruzione, finiva sempre nel sorriso di quell’uomo, nel suo delicato imbarazzo quando l’aveva ringraziato, nelle sue mani lunghe da musicista che annodavano svelte il filo di sutura. Si trovò a strusciarsi contro queste reminescenze come una gattina, l’impressione che le avevano lasciato emanava tepore, creava atmosfere che chiedevano di essere continuamente rivisitate. Si trovò ridicola e si impose di pensare a qualcos’altro. Si fece un tè e si mise a leggere. Niente. Cominciava un capitolo ambientato in un caffè di Parigi e lo finiva in un ambulatorio della sua città, il pensiero ricadeva sempre lì, ossessivo come una goccia cinese. Forse era meglio si facesse una doccia e si sciacquasse di dosso i sedimenti della giornata. Si alzò e andò a prendersi un asciugamano fresco, ma sia nella camera che negli scaffali alti dell’armadio, ovunque si muoveva, la seguiva l’immagine del veterinario che, ovattata e tenace, si andava installando in pianta stabile nella sua mente. Entrare nel bagno fu come il cambiamento di scena al secondo atto: tutt’un’altra cosa, altra atmosfera, altra intimità. La stanza é piccola, pulita, essenziale, rivestita di piastrelle rettangolari incollate con ordine e rigore. Non é uno spazio favorevole ai cedimenti sentimentali, é quello che ci vuole. Si toglie i vestiti con un senso di liberazione. Prima che l’ambiente si riempia di vapori e condense, si guarda nel grande specchio: di fronte, di fianco, di dietro. Si domanda se quel corpo lo si può ancora chiamare desiderabile. E’ snello, tonico, sì, ma… insomma, qualche smagliatura sulle natiche, piccole vene dietro ai ginocchi… “Pazienza, a me che me ne importa? Basta che sia sano!”. Si scioglie la coda di cavallo e scuote la testa, cercando di allontanare anche le insidiose insicurezze sorte circa il suo aspetto. Il massagio caldo dell´acqua é un forte anestetico, fa dimenticare tutto, ora il tempo è scandito solo da sensazioni corporee, epidermiche, il resto scompare. Acqua, acqua, solo acqua. “Forse un albero o un cespuglio sotto la pioggia si sentono anche loro così bene!”. Le viene da pensare. Rimane a lungo sotto il getto dell’acqua, fino a surriscaldarsi , esce con la pelle arrossata e un denso calore che emana da ogni centimetro del suo corpo; si sente rilassatissima, quasi stanca, ha voglia solo di stendersi sotto le lenzuola e continuare a sentire quel calore irradiarsi da lei. Crede di non avere sonno. Rannicchia su un fianco, si pone domande inusuali: “In che modo sarà diversa l’etica medica da quella veterinaria? Anche i veterinari si dovranno attenere al Giuramento di Ippocrate? – si chiede mentre un certo torpore già comincia a farsi avanti -… forse no, perché altrimenti non potrebbero mai sopprimere un animale, anche se necessario; poi… quella storia di non peccare di ignoranza, imperizia, imprudenza…”. Faceva sempre più fatica a tirare le conseguenze dalle premesse. “Chissá quante volte si trovano a fare operazioni che non conoscono, a rischiare… poveracci! Hanno dovuto imparare tanto in così poco tempo, approfondire tante anatomie, tante patologie... prima curavano solo il bestiame degli allevatori e dei contadini, prima ancora solo i cavalli e i muli dell’esercito… erano ufficiali anche loro...”. Ormai le immagini e le definizioni non volevano più stare insieme; a un passo dall’inafferrabile soglia del sonno Arianna si trovò a chiudere il circuito in mezzo a speroni, nitriti, accampamenti militari, maniscalchi. Capitolo VII C’era da aspettare più di una settimana prima di tornare in quell’ambulatorio. I giorni passavano lentamente, come se il tempo si fosse inceppato intorno alle sue ore. Mentre Arianna puliva, cucinava, o peggio ancora stirava, i suoi pensieri continuavano a scivolare inarrestabili sul dottore. Concentrarsi sulla lettura le era molto difficile, uscire sola con Giorgio le procurava addirittura una sensazione di intimità col suo sconosciuto. Più complesso si rivelò il conciliare il suo nuovo interesse con Marco, sia di giorno che di notte, ma anche per quello trovò subito una soluzione: il problema non esisteva. Se solo chiudeva il circuito di suo marito quando apriva l’altro e viceversa, i due mondi non entravano nemmeno in contatto e non generavano nessuna tensione. “Se le cose non si possono unire, allora bisogna dividerle ”. I giorni passarono, tutti e nove; passò anche la mattina del decimo. La sera prima Arianna si era lavata i capelli e aveva riflettuto a lungo su cosa si sarebbe messa l’indomani; aveva scelto con attenzione speciale anche la biancheria. Le sembrò ridicolo, ma non ci rinunciò. Dopo pranzo Marco, che quel giorno era libero, si offrì all’improvviso di portarlo lui Giorgio. Arianna si sentì aggredita alle spalle, si dovette sforzare per non rispondergli male, ma seppe trovare subito un ottimo motivo per rifiutare. La scusa – la spesa che sulla via del ritorno avrebbe fatto dalla sua amica erborista – le venne a mente con una prontezza e una spontaneità di cui lei stessa si stupì, dal momento che non era nella sua natura né nelle sue abitudini dire bugie. Dovette ammettere che mentire è una qualità alla portata di tutti, una virtù plebea che ognuno è in grado di sviluppare, qualcosa collegabile senz’altro alla furbizia, all’adattamento, alla necessità, all’intelligenza in stato di non libertà. Andò all’attaccapanni e prese il guinzaglio; Giorgio, come sempre, si mise a saltellare per la stanza, a sbuffare, a fare piccoli giri su se stesso. Foss’altro per tutto quel teatro, portarlo fuori era sempre un piacere. Quel pomeriggio si era truccata con cura, sui mezzi tacchi aveva indossato jeans chiari e un golfino a tinte pastello su cui guizzava una piccola spilla a forma di pesce. Suo marito la guardò da sopra gli occhiali, si alzò dal divano e posò il giornale sui cuscini, facendo attenzione di lasciarlo aperto alla pagina che stava leggendo. “Come sei carina oggi!” le disse baciandola sulla bocca. Lei se ne sentì rafforzata ma anche giá in colpa. Marco li accompagnò fino alla porta e rimase a guardarli finché sparirono dietro l’angolo delle scale. In piedi sulla soglia stette a ascoltare il loro discendere: il suono ritmico dei tacchi, il ticchettare delle grosse zampe di Giorgio sul pavimento liscio, il suo respirare affannato per la grande gioia di poter uscire. Quando il portone si richiuse dietro di loro e per le scale si fece di nuovo silenzio, anche lui rientrò, si riempì un bicchiere di birra e riprese in mano il giornale, contento di avere a disposizione quasi tutto il pomeriggio. Fuori era piovuto da poco; per terra le pozze racchiudevano nelle loro cornici tondeggianti sprazzi di cielo grigio macchiato di blu. Sembravano quadri, belle composizioni di forme e colori che il vento variava in continuazione. Di solito Arianna si soffermava a guardarle in giornate così, ma oggi cercava solo di scansarle per non arrivare a destinazione schizzata di acqua sporca. “Stai attento a non infilarti nell’acqua, ecco, cammina qui, vicinissimo, bravo, così”. Ma le pozzanghere erano troppe e forse il cane troppo eccitato, fatto sta che quando scese di macchina nei pressi dell’ambulatorio si vide i jeans celesti schizzati di grigio scuro e il giubbotto blu macchiato di grigio chiaro grazie alle sbavature che Giorgio ci aveva fatto durante il viaggio. Entrò contrariata nell’ambulatorio dove stavano aspettando diverse altre persone; nessuno aveva voglia di fare grandi chiacchere, c’era quasi silenzio. Arianna guardò la sedia vuota su cui si era seduta col suo cane ferito e ne scelse di proposito un’altra; si trovò a riflettere sulla differenza enorme tra l’apprensione cupa di allora e la gioia speranzosa di oggi; c’era però qualcosa che legava quei due estremi: la suspence, il non sapere nemmeno oggi come sarebbe andata. L’avrebbe trovata attraente? Sarebbe riuscita a rendersi interessante, a incuriosirlo, a conquistarsi un pezzettino di attenzione speciale? Ce l’avrebbe fatta a fargli intrasentire come si interessava a lui? E gliene sarebbe fregato qualcosa? Era omosessuale? E se non lo era, gli piacevano solo le donne bellissime? Quello sarebbe stato un disastro! Man mano che uscivano i clienti venuti prima di lei, l’eccitazione aumentava, così come i dubbi nella sua testa. Giorgio, come suo solito quando lo portavano dal veterinario, non guardava nemmeno gli altri cani, di solito oggetto di grande interesse; no, guardava solo la porta d’uscita, si sedeva per un paio di secondi e subito si alzava per andare da quella parte. Anche l´ultimo cliente finalmente entró. Arianna é sola nella sala d’aspetto, vicinissima al centro del mondo. Il cuore batte forte, la saliva le ingombra la gola, tutte le tecniche di rilassamento che conosce sono sparite in blocco dalla memoria. Tira fuori lo specchietto, si rinfresca il trucco, si accomoda i capelli. Giorgio approfitta di essere sciolto e va dritto verso l’uscita dove si mette a raspare contro la porta. Si precipita a riprenderlo, ma lui non vuole staccarsi da lì; mentre lo sta tirando via a forza, operazione che permette pochi gesti aggraziati, il dottore appare in tutto il suo splendore nel vano della porta d’alluminio, accompagnando il suo ultimo paziente.“Faccio così tanta paura?” le dice. . Vedendolo Arianna ebbe un afflusso di emozione che per un attimo la bloccò. “Lasci che le dia una mano”. Con presa decisa afferrò per il collare il cane e lo tirò verso l’altra stanza; a quel punto lui si sentì sopraffatto, abbassò la testa, strinse la coda tra le gambe e entrò nell’ambulatorio dove una volta lasciato libero – come sempre in occasioni simili – si appiccicò con le costole alla sua padrona e cominciò a tremare. “Bella questa sutura – disse il veterinario dopo aver dato una rapida occhiata alle ferite – tra un paio di settimane non si vedrà più niente, si potrà far rimordere senza problemi!”. Arianna aveva difficoltà a parlare, non riusciva a dire nulla. Il dottore fruzzicò in una vaschetta di vetro opaco da cui scelse una pinzetta e delle forbicine. Lei provava piacere a seguire i movimenti delle sue mani, le sembravano aggraziate, sicure, abili; se le immaginò che le percorrevano i fianchi e le risalivano la schiena, calde e leggere. “Com’è andata poi, le è passato lo spavento? – le chiese mentre ripuliva gli strumenti con una soluzione trasparente – l’altra volta mi sembrò avere più bisogno di cure lei che il suo cane!. “Sì, ero molto spaventata, spero che storie del genere non mi succedano più”. Ecco, era fatta, il solo prendere a parlare la sbloccò; dette le prime parole si sentì subito bene, anzi benissimo, come alle prime battute di un esame per cui ci siamo preparati molto. Ora gli rispondeva con semplicità e naturalezza, la diga dietro cui da una settimana premevano sussulti romantici e fantasie erotiche, teneva a meraviglia e la grande tensione dell’attesa era svanita. Vedeva che standogli vicino, lui perdeva molto del suo potere di suggestione, lì le stava alla pari. Sapeva comunque di dover fare attenzione a ogni mossa, a ogni parola perché in quella visita si sarebbe giocata praticamente tutto, altre occasioni per avvicinarlo chissà se si sarebbero mai ripresentate. “Bisognerebbe che ora il cane stesse fermo e che mi tenesse un momento la zampa sollevata…” Si era inginocchiato per terra accanto a Giorgio, i jeans sotto il camice non proprio pulito fasciavano ginocchia magre e appuntite. Arianna si mise nella stessa posizione, dall’altra parte del paziente, a meno di un braccio da lui; se solo si fosse sporta un po’ in avanti lo avrebbe sfiorato, col seno, col viso; da quella distanza poteva leggere il premere della barba sotto la rasatura, ancora qualche centimetro e avrebbe sentito l’odore della sua pelle. “Che bellezza la mente, penso quello che mi pare e non mi si vede; vorrei baciarlo dappertutto e lui non se ne accorge, non lo sa; nessuno lo sa, solo io, ma io, non lascerò trasparire niente! Immaginare è bello, è libertà, libertà gentile: si ottiene il massimo e non si lede nessuno”. “Ecco fatto – disse rialzandosi – ora sistemiamo questi altri puntacci sulla schiena”. Togliere i punti è un’operazione banale e di pochi minuti, qualcosa che qualsiasi elettricista o casalinga saprebbe eseguire benissimo, ma per Arianna ogni movimento, ogni fase di quell’elementare procedere era una fonte di squisito piacere, una scusa per lasciare che lo spettacolo della sua perizia si traducesse per lei in seduzione. Alle ultime due suture suonò il telefono. Lui le tolse sveltissimo, si scusò e andò a rispondere; parlava in piedi, contro la scrivania, scarabocchiando su un foglio forme circolari. Il consulto telefonico, gestito soprattutto dall’altro capo del filo, si prolungava. Il veterinario se ne scusò a gesti, la guardò, le sorrise. Lei gli rispose con lo stesso linguaggio, gustandosi in pieno la vaga aura di complicità che si era venuta creando tra loro. Giorgio intanto aveva capito che i suoi problemi erano finiti e girellava annusando di qua e di là. “Mi dispiace, ma a volte le telefonate sono parte del mio lavoro”, le disse quando riappoggiò il ricevitore e andò a riporre gli strumenti nell’armadietto, proprio quello sotto cui era appesa la foto dei violinisti. Ecco, ora! Arianna partì: “Ma quelli sono gli Oistrach, che ci fanno in un ambulatorio?” gli chiese mentre cercava di riagganciare il guinzaglio al collare e non trovava la maglia. Lo sguardo del dottore si accese, si vedeva che era contento di rispondere a quella domanda; le raccontò che gli piaceva molto la musica e che quella non era una stampa, ma una vera foto, forse una volta appartenuta all’archivio di un teatro, un regalo che gli avevano portato dalla Russia. “Vede… - continuò staccando la piccola cornice dal muro e indicando con l’indice ossuto alcune parole in cirillico – si legge persino quale spartito hanno davanti: è la Sinfonia Concertante di Mozart, la K 364, Oistrach senior ci suona la viola e suo figlio il violino. Lo so perché ne ho sentito una registrazione… bellissima!”. “Palla-goal!” pensò Arianna. “Venerdì prossimo danno il concerto per Violino e Orchestra di Beethoven, l’opera 61, lo fa una giovane violinista giapponese che pare sia molto brava. E’ un pezzo stupendo, se posso ci andrò di sicuro”. Gli disse guardandolo in viso. Prima di battere questo rigore, si era studiata il programma di musica classica di quel mese in tutti i teatri della città e della provincia; su quella foto aveva puntato tutte le sue carte. “Sì, è un concerto molto bello. Grazie, non lo sapevo, se posso ci andrò”. Come l’altra volta, anche ora si mise quasi sugli attenti mentre le dava la mano. Tirata da un cane particolarmente pieno di energie, Arianna uscì dall’ambulatorio lasciandosi dietro un palmo destro leggermente sudato. Una volta fuori da quel posto, Giorgio non si sentì meno felice della sua padrona. Finalmente era fatta, per tutte e due. Per smaltire un po’ di gioia, fecero un giro dell’isolato fino a un piccolo parco urbano, con pochi alberi e aiuole incalpestabili, un giardino misero ma dove in compenso nessun cagnaccio né brutto essere umano minacciò la loro quiete e il loro senso di leggerezza. In mezzo a un vialetto d’asfalto Arianna abbassò la testa e improvvisamente si fermò; Giorgio, che era al guinzaglio, accusò lo strattone e la guardò interrogativo. “Perché ci penso solo ora, come ho potuto non cercarlo prima! Non so ancora come si chiama!”. Con movimenti concitati, frugò nella borsa cercandoci la ricetta degli antibiotici. Era Marco che era andato a comprarli, ma dopo l’aveva rimessa dove l’aveva trovata, nel libretto sanitario del loro cane, quello che si portavano dietro in ogni visita dal veterinario. Lì se ne stava anche ora, piegato in quattro come un vero bigliettino d’amore. Lo aprì lentamente, ma poi lo lesse con avidità: “Dott. Gabriele Sassi – Medico Veterinario”. Restò a guardarlo come fosse un’opera d’arte, lisciò con la punta delle dita quella breve intestazione, l’accostò alle labbra e solo allora rimise il foglio nel taschino della borsa, con grande cura, come fosse un documento importante. “Gabriele… che bel nome! Impegnativo! Il poliziotto del Paradiso, l’agente di Dio, roba grossa!” Spade di fuoco e tuniche svolazzanti l´accompagnarono fino alla macchina, alternate alle sensazioni di calore che le dava il pensiero del più recente e mortale dei Gabrieli. Sentirselo tornare alla mente dopo un pensiero diverso, la scaldava fin dentro le ossa. Capitolo VIII Nell’angolo del soggiorno, accanto alla cuccia di Giorgio, un ottimo impianto hi-fi sta appoggiato su un mobile lineare e capiente, il contenitore di tutti i dischi, le cassette, i CD della casa. Quella dispensa musicale é rigorosamente divisa in due sezioni, quella classica di Arianna e quella pop, jazz, rock di Marco. La musica é uno dei rari campi in cui i loro gusti non si incontrano, tanto che da sempre seguono ognuno i propri avvenimenti musicali, senza forzare l’altro a condividerli. Normale quindi che il venerdì Arianna andasse da sola a sentirsi un concerto di Beethoven. Tutto si svolse secondo il solito rituale: anche quella sera, come tante altre volte, lasciò al marito le rigovernature, lo sbaciucchiò e partì, avvolta nel suo grande cappotto nero che questa volta copriva con la sua lana calda un vestito scollato, un corpo inquieto e un’anima in ebollizione. Sarebbe venuto? Avrebbe raccolto la sua bottiglia in mare? Il dubbio era così totale che tutto rimaneva intorno a lei in statico equilibrio, niente si muoveva di un millimetro, non poteva azzardare nessuna ipotesi, nessun elemento le permetteva previsioni. Al massimo dell’eccitazione, era costretta a sguazzare nel massimo dell’inazione; doveva solo aspettare, proprio lei per cui la pazienza era una qualità sconosciuta. Pensò al suo cane, a tutti i cani, alla loro incredibile capacità di attesa: aspettano che gli si dia da mangiare, che li si porti fuori, che li si carezzi, che li si curi; aspettano che si torni a casa, che si sia fatta la spesa, aspettano in macchina, aspettano in giardino, per ore e ore; spesso senza lamentarsi, senza impazzire, senza morderti quando torni. “Che strazio essere un cane – pensava – io non ce la farei mai!”. Per tutta la settimana aveva cercato di prepararsi all’eventualità che il veterinario non fosse venuto. “Sarebbe la soluzione migliore – si diceva – dopo un paio di mesi mi passerebbe tutto, apprezzerei i vantaggi di non aver messo sottosopra niente e avrei lo stesso da parte qualche ricordo emozionante. Sì, se non venisse allora andrebbe tutto benissimo, come l’altra volta”. L’altra volta era una decina di anni prima, quando, con un menage tranquillo, una figlia piccola e un’età più portata all’avventura, si infatuò di un violinista che aveva conosciuto a casa di amici, un uomo bello e per di più di un certo successo. Per fortuna bastarono quelle sue due qualità a metterla al sicuro da ogni tentazione: lui pesticciò senza scrupolo i suoi delicati sentimenti e discrete avances, finchè, per mancanza prolungata di cibo, quell’amore si seccò e nessuno, a parte lei, ebbe a soffrirne; anzi, a posteriori, anche lei dovette dare una valutazione positiva di quell’esperienza, perché l’aveva vivificata, le aveva ricordato di essere capace di emozioni sconsiderate che credeva appartenere solo alla sua più lontana giovinezza. Quella volta, il bel violinista le era passato accanto e l’aveva stregata col suo sguardo assorto, col rapporto di intimità che si intrasentiva tra lui e il violino, col fascino irresistibile che emanava dal suo collo, segnato da una rosa discreta che cresceva sotto la mascella e si arrossava quando staccava il viso dallo strumento. Arianna avrebbe dato qualsiasi cosa per poterla baciare. La grande esaltazione la portò fino al punto di identificare senza riserve lui con la potenza della musica e viceversa; ai suoi occhi era diventato un idolo, un idolo d’oro. Da quel semidio le arrivò invece solo durezza e alterigia, qualità che le persone mediocri di spirito e molto sicure di sé sviluppano bene e alla svelta. La freddezza con cui furono accolte le sue timide profferte, la costrinsero a scoprire sulla propria pelle come l’esatto contrario dell’amore non fosse l’odio, ma l’indifferenza. Tuttavia, nonostante le pene da innamorata respinta, le umiliazioni, i dubbi sulla propria persona che quell’avventura sentimentale le procurarono, il concertista le lasciò suo malgrado una sostanziosa eredità. Quando il violino, le belle mani, il collo stretto nella camicia da concerto, furono tutti usciti di scena, l’accresciuto amore per la musica le rimase attaccato addosso come un’acquisizione permanente e entro` a far parte in pianta stabile della sua vita, rendendola più ricca, più intensa e più esposta a nuovi piaceri. Non provava rimpianti per aver vissuto quella solitaria avventura, anzi. La storia che ora le stava davanti, era molto diversa , tuttavia, riconoscendoci le colorazioni accese e il peso delle ansie provate allora , si sentiva aiutata e vagamente protetta da quel suo passato. Ma se oggi il veterinario fosse davvero venuto...allora le incognite che le si aprivano davanti sarebbero state tali e tante che il solo intravederle la frastornava. Nei giorni precedenti, speranza e paura avevano oscillato nella sua mente con la regolarità ossessiva di un meccanismo a pendolo, ma ora che il momento della verità incombeva, i contorni stessi dei due poli non si lasciavano più distinguere, si sfuocavano come un oggetto piazzato troppo vicino agli occhi. Non sapeva più cosa avrebbe voluto. Stanca dei suoi stessi dilemmi, prima di scendere di macchina estrasse dalla tasca dello sportello una fiaschetta di cognac e ne buttò giù un paio di lunghi sorsi. “Basta! – si disse – ora sto a vedere quello che succede e non voglio pensare ad altro”. Si incamminò decisa verso il teatro come chi va a esigere qualcosa di dovuto e con lo stesso spirito si sedette su una poltroncina verso il fondo della platea, un posto lontano dall’orchestra, ma ottimo per osservare il movimento di tutta la sala. Da lì scrutò attenta e inosservata i giovani uomini che entravano o già occupavano posti, ma nessuno era lui. Da dietro le quinte, simili a una leggera brezza musicale, si sentivano vibrare le ultime accordature degli archi; dietro la fine parete le note salivano, esili e solitarie. Il teatro si era riempito, le poltroncine vuote ormai sarebbero rimaste tali. I musicisti fecero il loro ingresso con un pesticcìo sommesso, entrarono compatti, in una massa morbida e densa di vestiti neri, avanzarono come asfalto caldo, come un corpo fluido che si spandeva sul palcoscenico fino a saturarne tutto lo spazio. Si sentirono suoni disordinati di legno calpestato, brevi spostamenti di sedie, ma presto quei rumori da branco in movimento avrebbero ceduto il posto al silenzio totale e poi a complesse costruzioni musicali, a note precise, lungamente studiate, concertate, misurate al decimo di secondo. L’attesa di questa trasformazione, anche lei parte del rituale del concerto, aumentava nel pubblico l’impazienza di ascoltare, il crescere della tensione si respirava nell’aria. Le luci si spensero, arrivò il direttore, scrosciarono gli applausi; arrivò la solista, giovane, piccola, filiforme, con un violino color ambra tra le mani; sola, diversa, gli occhi simili a lunghi solchi neri, vestita di un lungo abito rosso e illuminata dai riflettori contro il buio dell’orchestra, a Arianna sembrò una bambina rubata dal circo. Il dottore non era arrivato; lei applaudì con tutta la forza delle braccia, fino a sentire male; le lasciò ricadere sui braccioli e nel silenzio carico di attesa che precede la prima nota, si aggrappò a dei versi amici: “Se la musica è il cibo dell’amore, suona ancora, finchè il mio appetito, finalmente sazio, non ne ammali e ne muoia…”. Non si sentì per questo meno triste, ma certo un po’ meno sola. La musica partì, il lungo preludio orchestrale prese a salire, mentre la ragazza rimaneva lì, in mezzo al palco, con gli occhi bassi e lo strumento appoggiato lente contro le gambe; umile e paziente, aspettava che l’orchestra la lasciasse entrare. Alle sue spalle la musica gonfiò, prese torni grandiosi, poi si acquattò assottigliandosi sempre più fino a farle posto. Il violino si insinuò dapprima discreto nella trama, ma poi, più la composizione avanzava, più faceva sentire che era lui il protagonista, che quei suoni li organizzava lui. Era molto bello. Arianna si trovò a aderire al Concerto Opera 61 come un piccolo spillo a una grande calamita. La musica avanzava e la trascinava con sé, la consolava, la sorprendeva, apriva per lei finestre su panorami ariosi che le sembrava non avere mai visto. Il grande respiro di Beethoven la commuoveva, la tirava a sé lasciandole appena il tempo, a tratti, di rendersi conto di dove era. Il viso della giovane solista emergeva dal buio come una distesa di pelle bianca segnata dalle fessure strette degli occhi e dalle bande di capelli nerissimi che le scendevano lungo le tempie. Sembrava una bambola, una maschera, un essere statuario, senza anima. Eppure quella piccola giapponese, minuta, quasi immobile sul proscenio, stava buttando fuori tutta la potente muscolatura musicale di Beethoven, era diventata un suo viatico magico, una fragile fata che trasmetteva vigore e potenza. Ora era lei che comandava al respiro corposo dell’orchestra; il suo violino si stendeva come un filo tenace e sottile, a volte sottilissimo che volteggiava intorno al grande tessuto musicale disciplinandolo, bilanciandolo, conducendolo con grazia e con forza. Attraverso quel violino, Beethoven avanzava inarrestabile e nella sua marcia soffiava via il bel veterinario, ne affossava il fascino, ne offuscava la memoria. Già alla fine del primo movimento, Arianna si trovava in un posto molto diverso da quello in cui si era seduta all’inizio del concerto; ora viaggiava per altre province, si sentiva sazia, piena, non aveva bisogno di nessuno. Solo quando, con i toni trionfali di un inizio, la composizione musicale si concluse, si rese conto di come era andata lontano, di come era stata distolta, trasportata via e nel tornare gradualmente in terra, nell’alveo amarognolo della sua delusione di oggi, si sentì grata a Beethoven come al suo più caro amico. Grazie a lui, le sembrava di essere uscita da un bagno purificatore, i suoi pensieri erano diventati larghi, non si interessavano più di amanti e mariti. “Aveva ragione quel russo a dire che l’arte è prelevare qualcuno da un mondo e coinvolgerlo in un’altra sfera,- pensava- la bella musica ha proprio questo potere!”. Capitolo IX Arianna si avvicinó al banco del buffet. La sua china calda col limone arrivò fumante in un piccolo bicchiere di vetro e le portò una sferzata di nuova energia attraverso il vapore profumato che le entrava nelle narici e il sapore amarognolo, carico di alcool, che le tonificava il corpo e lo spirito. “Buonasera signora”! si sentì dire alle spalle. La voce era più che nota. Sentì salirle dal petto una vampata di calore che rese irrilevante la gozzata di china bollente appena inghiottita: davanti a lei stava il veterinario, con la sua pelle bianca, i capelli fulvi lucenti, il collo magro infossato in un golf nero che non riusciva a nascondere la minutezza del suo torace. Com’era bello, e suggestivo! Vestito così le sembrava un Amleto. Si sentì piombare in uno stato di confusione totale, ma lui le venne in aiuto chiedendole come era stato il concerto; aggiunse che se l’era dovuto perdere perché alle sette gli avevano portato un cane da operare d’urgenza per una torsione di stomaco e era uscito dall’ambulatorio solo alle nove: “Il cane però l’ho salvato, se perlomeno non gli viene un’embolia dopo!”, disse con un sorriso pieno di soddisfazione e intanto aggiunse con noncuranza diversi dettagli sull’intervento, prassi chirurgiche che la lasciarono turbata. “Alla salute del paziente allora!” – disse per chiudere l’argomento sollevando il caldo cilindro di vetro che teneva nella mano. Il dottore si rallegrò che dopo facevano Brahms, perlomeno rimaneva qualcosa di buono anche per lui; chiese un whisky e lo mandò giù alla svelta, dicendo che gli serviva per digerire il panino mangiato un po’ troppo di corsa. Le prime luci si stavano già spegnendo, il pubblico cominciava a rifluire nella sala, in uno largo sciame ronzante. “Andiamo anche noi?” le chiese. L´innocente “noi” suonó per Arianna come la piú erotica delle parole; l´agguantó al volo con tutte le implicazioni d´intimitá che avrebbe potuto contenere. Ascoltare Brahms le fu impossibile; se riusciva a acchiappare qualche frase era solo per un attimo, poi le note si disgregavano, si allontanavano e le tornavano agli orecchi come frammenti sparsi di cui non afferrava più il senso, suoni vaganti, come brandelli di conversazioni raccolte percorrendo un corridoio affollato. Nemmeno il veterinario seguiva molto attentamente: già era arrivato stanchissimo, quell’whisky poi, buttato giù di corsa e a stomaco quasi vuoto, gli dava un certo stordimento che unito al calduccio della sala e alla posizione comoda, gli imponeva grandi sforzi per non sbadigliare. Avrebbe preferito essere già fuori, nell’aria fresca, a passeggiare con la sconosciuta che lo aveva cercato con tanto impegno. Quel giorno glielo aveva raccontato al suo collega Giancarlo, quando l’aveva visto in ambulatorio: “Stasera uscirò con una tardona”. “Bravo! – gli aveva risposto dandogli una pacca sulla spalla – finalmente qualcosa di diverso, invece delle solite belle ragazze. Auguri e endorfine! … Poi mi farai sapere, eh?”. Invece non gli avrebbe fatto sapere granchè: anche se li univa una reciproca confidenza e Giancarlo era forse il suo migliore amico, Gabriele si mostrava sempre reticente a parlare delle sue storie di donne; proteggerle con la sua discrezione gli era sempre sembrato un dovere elementare. La signora di stasera non era certo il meglio delle sue conquiste, comunque lo interessava abbastanza, gli piaceva il suo corpo aggraziato e pastoso, il seno abbondante e poi la luminosità dei suoi occhi, il sorriso aperto… il resto era tutto da scoprire. Ma di lei lo aveva colpito soprattutto la spontaneità, la freschezza quasi infantile con cui lo aveva ringraziato la prima volta e poi ancora il saper prendere al volo le sue frasi a sfondo esistenziale, esche a perdere che nessuno mai raccoglieva. Arianna gli aveva suggerito un senso di invitante familiarità e gli aveva dato comunque l’idea di qualcuno da cui non si doveva difendere. Finalmente il concerto finì, passarono gli applausi, le chiamate, gli inchini. Gli ascoltatori cominciarono a incanalarsi verso le tende color porpora di nuovo aperte. Fuori dal teatro la sera era freddina, il pubblico si aprì a ventaglio davanti all’uscita e avvolgendo sciarpe e infilando guanti si disperse per lo spazio all’intorno, per sparire presto a piccoli gruppi dietro angoli di strade, dentro autobus, macchine, taxi. Gabriele, ritemprato dal freddo, attaccò con la musica appena sentita. “Bellissimo il ‘Requiem Tedesco’, così pieno di speranza, di luce… a lei piace Brahms?”. Ovviamente si era offerto di accompagnarla alla macchina, parcheggiata non molto lontano, appena oltre il fiume; da lì c’era circa un quarto d’ora di camminata lenta, un percorso che, se si voleva, si poteva fare passando per le viuzze del centro storico. Le imboccarono con le mani in tasca e il bavero rialzato. “Sì, mi piace molto. Quando sento un pezzo romantico davvero bello che non so riportare a nessun grosso compositore, allora penso che è Brahms e ci indovino quasi sempre”. “E’ forte, profondo, mistico, si sente che è un musicista tedesco. Pare che scrivesse sempre con la bibbia accanto. Stasera però mi sono perso diversi passaggi… a volte alla fine della giornata, sono troppo stanco per la bella musica. Un po’ mi dispiace perché è proprio stupendo il suo “Requiem” con quella nota bassa, fissa, ferma, quel pedale armonico che ingoia tutto quello che ci viene costruito sopra… insiste, sta sempre là, come una presenza divina”. Arianna si esaltava molto ai suoi commenti. “Ah, ma lei parla proprio da musicista!”. “No, non sono musicista, purtroppo ho solo fatto qualche anno di pianoforte”. “Beato lei! Io invece sono solo ascoltatrice e perdipiù amatoriale, non conosco la musica e non la produco, la consumo e basta. Ho seguito dei corsi d’ascolto, belli, appassionanti, ma non è da lì che può venire una preparazione, quelli sono una specie di pronto soccorso della musica. Però, mi dà piacere ascoltarla, la amo molto”. “E le sembra poco? Tra amare e possedere c’è un legame strettissimo”. “Anche tra conoscere e possedere”. E via così, chiaccheravano senza pause, senza intralci, gli argomenti fluivano come acqua, si ampliavano, diavagavano, ritornavano vicini al punto di partenza, il loro conversare si gonfiava come zucchero filato intorno al bastoncino. Camminavano attraverso la zona pedonale, un reticolo antico di piccole strade che sfociavano a delta sul lungofiume. Intorno c’era quiete, i suoni della città arrivavano attutiti, il selciato rimandava nitido il rumore dei loro passi. Con naturalezza Gabriele le si accostò di più e le avvolse il polso, con presa uguale e decisa, senza stringere, come quando si fa attraversare la strada a un bambino. Tra loro si fece silenzio. Arianna non si voltò a guardarlo, né ritirò il braccio, continuò a camminare lasciando lo sguardo scorrere su facciate di case silenziose, fu finestre chiuse, su saracinesche sprangate; guardava i lampioni accesi contro spicchi di cielo nero, non pensava più a niente, la pelle era diventata il suo unico luogo di percezione, il mondo cominciava e finiva lì. Sentì una mano scorrere sul dorso della sua, soffermarsi sulla fede nuziale, insinuarlesi tra le dita, stringerle; era leggermente sudata, come l’ultima volta all’ambulatorio. La piccola strada stava per finire, ancora pochi metri e si sarebbero trovati di nuovo sulla grande arteria della città dove li aspettavano i semafori, i bar, il traffico sostenuto della tarda serata. Arianna sentì che veniva sospinta dolcemente contro il muro, o forse fu lei che ci si appoggiò, che sollevò la testa e abbassò le palpebre fin quasi a chiuderle. Brividi tra la carne e i vestiti. Scomparvero la strada, la città, i rumori, gli altri. Quel bacio, lungo e liberatorio, le passò attraverso come un ago di miele, era un bacio che la cercava, la esplorava, con forza naturale di marea. Il respiro si fece più pesante, una lieve stretta delle labbra le serrò il lobo e lo trattenne per un attimo. “… Se ti potessi amare come vorrei , qui, contro questo muro, ora, non potrei nemmeno chiamarti per nome… non potrei dire al tuo nome quanto mi piaci; ma qualunque sia, sarà bellissimo, se solo si posa su di te, la fata di questa bella notte…”. Arianna volentieri si lasciava frastornare dalle sue parole, volentieri faceva finta di crederci. A quel punto si sentì in diritto di lasciarsi andare, di prenderselo, di gioire di lui per il massimo di quanto quel posto le permetteva; lui, l’uomo straordinario, a lungo atteso e ora vero davanti a lei. Che il dopo andasse al diavolo, ora era lì con l’odore della sua pelle e la presa dolce delle sue braccia. Nonostante fosse il primo dei baci avuto dal primo degli uomini che non erano suo marito, percepì quel contatto come un ricongiungimento, come se da sempre fosse esistito tra loro un grande legame , una familiaritá grande e antica. Più che una trasgressione, le sembrava di vivere la fine di una separazione; era come rivedere il fratello che dopo una lunga assenza riprende il posto a tavola, riabbracciare l’amico di vecchia data, tornare per un po’ nella casa dell’infanzia di cui si conosce ogni angolo e odore. Mentre si lasciava abbracciare, gli riversava addosso ondate di fiducia e di assenso. Il volto suo è scarno, le guance rientrano sotto gli zigomi, formano un vuoto, una cavitá rasata di fresco; carezzarla col viso, scendendo giù verso la mascella è un’emozione forte, una sospensione che mozza il respiro, una piccola, densa vertigine. “E’ lui, è proprio lui! Amami, Gabriele, amami, anche una volta sola, non ti pentirai…”, gli sussurrava senza dire una parola. Poco piú oltre si affacciarono al vicolo un gruppetto di persone, di lì a pochissimo li avrebbero raggiunti: cappotti scuri assiepati, rumore sovrapposto di passi, nuvole di fiato caldo, risa e parole, baveri rialzati, cappelli. Gabriele si scostò lentamente da lei, la guardò, le sfioró appena le labbra con la mano e, prima che gli altri li raggiunsero, la trasse a sé e la portò via, verso la strada grande. Arianna ritirò la mano, ma lo guardò negli occhi mentre la riaffondava nella tasca. “Non sei libera, vero? Lo immaginavo… non importa, l’importante è quando ci rivedremo; mi vorrai rivedere qualche volta, spero…”. Si fermò accanto a lei e continuò con lo sguardo la domanda. “Forse… dipende da tante cose, ora non so tanto bene quello che sto facendo”. “Ecco, guarda – le disse tirando fuori dalla tasca un taccuino e una penna – ti do il numero del portatile, del fax e del telefono dell’ambulatorio; il lunedì, mercoledì e venerdì ci sono la mattina, gli altri giorni il pomeriggio; poi c’è comunque la segreteria telefonica, mi puoi raggiungere sempre, il tuo numero potrei averlo?” “Non lo so… mi farò viva io, ora devo proprio andare”. “Ma non è nemmeno mezzanotte, ancora c’è tempo prima che la macchina ridiventi una zucca!” Lei rise. “E’ stato un bel concerto”, gli disse aprendo lo sportello. E pensava: “Un concerto straordinario! Come ti vorrei … se mi amassi ora, ti scotteresti, davvero! Vieni tra le mie braccia, vieni e vedrai…”. Richiuse la portiera e aprì il finestrino sul freddo della notte: “Buonanotte, dottore!”, e mise in moto. “Buonanotte!”, le rispose lui composto accennando a un lieve inchino della testa e rimettendo le mani nelle tasche del cappotto “A presto!”. Quando l’auto si fu allontanata, scrisse qualcosa sul taccuino, lo ripose e si incamminò verso il primo bar aperto che vide. Entrò. Forti luci a neon gli si scagliarono contro; frastornato da specchi, faretti, vetri, bottiglie, strizzò gli occhi ripetutamente e finalmente, dopo qualche secondo, prese contatto con l’aria del locale. Col gomito appoggiato sul banco e lo sguardo rivolto al traffico della via, disse al barista: “Mi dia… qualcosa, prego!”. Capitolo X La notte del concerto Arianna si era addormentata al suono delle parole che il dottore le aveva versato nelle orecchie contro il muro del vicolo. Il mattino successivo quella musica le ronzava ancora intatta nella testa, come pure il pomeriggio e il giorno dopo ancora; tutti i momenti di quella sera, dai più salienti ai più neutri, frullarono nella sua mente per diversi giorni finchè, alla fine di sofferti ripensamenti, la grande decisione fu presa: non avrebbe piú rivisto il veterinario. “Si finisce sempre col fare quello che si vuole della propria vita, non è vero? – si diceva – io la mia scelta l’ho fatta, non sono il tipo che cerca amanti e avventure, ho troppa paura, sono un coniglio. Infatti, se fossi stata una leonessa, non avrei dovuto aspettare quarant’anni per accorgermene; perlomeno tutti questi anni, le esperienze, le rughe, mi hanno insegnato che la mia qualita’è la prudenza”. E mentre rifletteva sui grandi rischi della passionalità, immaginava a un braccio da lei, gli occhi disperati di Anna Karenina nel momento in cui sta per buttarsi sotto il treno, persa tra luci nebbiose e stantuffi fumanti.. Si vedeva così e rabbrividiva all’idea della sua storia. La decisione che aveva preso, nell’insieme, l´avrebbe ripagata e alla grande: non si sarebbe sentita felice, ma nemmeno minacciata e il tempo l’avrebbe senz’altro aiutata a digerire quello che ancora le bruciava forte nello stomaco; ecco, sì, lui, il tempo, l’avrebbe presto liberata dalle nostalgie e poi Marco e Giorgio l’avrebbero sostenuta con la loro calda presenza quando si fossero presentati momenti di debolezza. Una volta scelta la rinuncia, infatti, la sua vita, anche se insidiata da cuocenti rimpianti, si sarebbe riadattata al ritmo e agli equilibri di sempre. La sera del giovedì successivo al concerto, mentre Marco versava il vino bianco che avrebbe accompagnato il risotto alle seppie, le disse: “Ci dev’essere un guasto al telefono, un contatto o qualcosa del genere; questo pomeriggio, ha squillato due volte e come ho risposto, è caduta subito la linea”. La notizia provocò a Arianna accellerazioni cardiache che cessarono appena ricordò a se stessa che Gabriele non aveva il suo telefono. Le bistecche di tonno alla livornese non furono quindi trovate meno buone e riprendendo l’argomento “congresso di Monaco” ripetè che lei preferiva rimanere a casa. La mattina successiva fu di nuovo venerdì. Il tempo non ne voleva sapere di rimettersi, faceva freddino e ogni tanto pioveva, ma quelle che per una scampagnata sono condizioni proibitive, diventano invece ottime giornate per chi porta fuori il cane in un parco cittadino perché ci saranno pochi altri quadrupedi in giro e si eviteranno avvicinamenti pericolosi e zuffe. Mentre camminava tra i vialetti motosi dei giardini vicino a casa, pensava che era una settimana precisa da quella sera del concerto. Sette giorni prima, a quella stessa ora, stava già scalciando perché c’era da aspettare ancora tanto, era inquieta, euforica, non sapeva come far passare il tempo che la separava dalle tanto attese ventuno meno un quarto. Ora invece si sentiva tranquilla, tutto si giocava in retrospettiva, ce l’aveva fatta a trasformare un ribollente futuro prossimo in un inoffensivo passato remoto. Il momento era ideale per rivedere tutto il lavoro fatto e nutrirsene a piene mani. Niente di meglio che passeggiare col cane se si vuol giocare con i propri pensieri. Il cane non solo ci accorda il tempo che perderemo in questa oziosa attività, non solo lo giustifica, ma anche ci ronzerà intorno contento, qualsiasi sia la qualità di quello che pensiamo: idee scoordinate, folli, stupide, indecenti, illegali, cattive, audaci, lui ci offre lo spazio e l’occasione per dare loro libero sfogo. Tra l’animale e il padrone si crea un’intimità lente, ma reale, una specie di complicità, fondata sul sentirsi tutti e due allo stesso tempo liberi e accompagnati. “Però sei stato stupendo, Gabriele – camminando guardava la terra molliccia accogliere a ogni passo l’impronta delle scarpe da ginnastica – bravo, gentile e anche coraggioso… dire cose del genere a una donna quasi vecchia. E poi anche baciarla, e come! Non saprai mai quanto te ne sono grata”. Spingeva le mani a fondo nelle tasche e sorrideva; stava bene lì sola con Giorgio, in quel bel pomeriggio grigio in cui le nuvole le stavano addosso come una coperta di piume. Tutt’a un tratto però, il dolce parco delle rimembranze che stava attraversando tremò, si incrinò e in un attimo si scompose in mille pezzetti che l’aria risucchiò e inghiottì: vicino a lei sentì una voce nota che chiamava per nome il suo cane. Per un momento fu il panico, poi un senso di minaccia, poi smarrimento, poi un denso grumo di piacere si fece avanti e spazzò via tutto il resto; si fermò e si girò inquieta. “Buonasera! – le disse il veterinario con un sorriso luminoso – come sta bene il tuo cane, è proprio guarito del tutto!”. Giorgio gli stava annusando le gambe, non capitava spesso nelle sue passeggiate qualcuno carico di tanti odori interessanti come quelli che aveva addosso lui. Arianna non diceva niente, lo guardava senza muovere il viso, sperando che la tensione gioiosa che la stava invadendo non trapelasse. “Mi dispiace di essere qui come un pedinatore – continuava mentre si piegava per accarezzare il suo paziente – ma non ho sentito più niente, ormai è una settimana. Perché non ti sei fatta viva, me lo avevi promesso”. Arianna avrebbe mantenuto la linea dura. “Come ha fatto a trovarmi, mi ha davvero pedinato? Non le sembra una grande invadenza seguirmi, essere qui senza essere invitato?”. Gabriele allargò le braccia. “Non avevo scelta”. Arianna somigliava a Napoleone per l’altezza modesta e un principio di ulcera gastrica, ma non certo per il coraggio né la rapidità d’azione; presa così alla sprovvista e su un terreno già poco solido, era incerta se giocare la carta del rimprovero, del disdegno o dell’indifferenza; non sapeva quale difesa impiantare per trasformare in attacco il senso di colpa per la leggerezza di quella sera e per neutralizzare la commozione tenera di vedersi davanti l’uomo che a tutt’ora riempiva di sole i suoi giardini più segreti. La decisione di non vederlo più era stata faticosa: aveva dovuto tirare in ballo fasci di considerazioni etiche, di sensi di responsabilità e siccome non bastavano, alla fine ci aveva dovuto buttare sopra anche il grosso pacco della paura dell’ignoto. Comunque quest’attacco non era previsto, Arianna per prima cosa andò a rifugiarsi dietro la difesa che sapeva più consistente, la paura appunto, sentimento che nelle sue precedenti riflessioni, aveva avuto tempo di rivestire di nomi, di luoghi, di fatti. Fu così che, rinserrate in una nuvola polverosa di cui non si vedeva la fine, tutte insieme in falange compatta, Anna Karenina in testa, le si fecero davanti Madame Bovary, Francesca da Rimini, Clitemnestra, la madre di Amleto e tutta la grande schiera delle donne infedeli e infelici che erano state la rovina propria e delle loro famiglie. Tutte unite, in un sibilo leggerissimo e acuto, le soffiarono nell’orecchio lo spettro delle loro storie. Arianna assunse un’aria accondiscendente: “Mi dispiace di aver fatto promesse che non ho potuto mantenere, è stato un grosso errore da parte mia, è vero, ma la mia libertà, come ha intuito, è molto limitata, così come il mio spirito d’avventura, come vede, per cui la prego di scusarmi, di dimenticare quella sera e di non cercarmi più”. Chiamò a sé Giorgio, così, senza motivo, per aggiungere una nota di noncuranza alla sua sentenza. “Che sto facendo? – pensava allo stesso tempo – lo sto mandando via davvero!”. Gabriele la guardava con le mani dietro la schiena, la testa leggermente flessa su un lato e le gambe divaricate piantate sul ghiaino.”Non avevo mai guardato i tuoi occhi di giorno...belli ! Non aver paura di me, io vorrei solo vederti qualche volta....finchè ci va. Tra noi c’`e una bella intesa...è una cosa rara, non ti sembra?” Arianna gli stava davanti, molto vicina e volentieri si faceva investire da ogni frase; attraverso le nebbioline del suo alito caldo notava per la prima volta le pagliuzze verde-bosco che punteggiavano l’iride castana. “Per favore, non insista, prenda il mio disagio di ora come compenso per le mie mancate promesse; mi dispiace veramente di aver fatto nascere dei malintesi; salutiamoci qua e dimentichiamo tutto il resto. Venga, andiamo verso l’uscita, non vorrei che ognuno prendesse la direzione opposta qui, in mezzo a questo parco d’inverno, come nel finale di un brutto film. Ma come ha fatto a trovarmi, con la targa della macchina?”. “Era la mia unica traccia”. Ammise il dottore. Lei aggrottò la fronte: “Ma non sono tenuti a dare queste informazioni!”. “E’ vero, ma le ho avute come favore personale”. Gabriele le raccontò la sua piccola odissea: dalla targa al nome, da quello all´indirizzo e al telefono. Naturalmente era stato lui a chiamare il giorno precedente, ma gli aveva sempre risposto un uomo. Di lui non chiese niente. Trovarla in giro in compenso, era stato facile: vicino alla sua strada c’era solo quel giardino pubblico e lui sapeva bene che quelli che amano molto il proprio cane, se possono, gli fanno fare una lunga passeggiata la mattina. Davanti all’entrata c’è un grande bar e lì aveva potuto aspettarla al varco, seduto al caldo, tra caffè e cappuccini. Lei lo ascoltava e ogni parola le arrivava come musica. Prima che raggiungessero il grande cancello d’uscita, ricominciò a piovere. Arianna aprì l’ombrello e istintivamente cercò di coprire anche lui; essere costretta a stargli così vicino era una gioia impagabile, non le sarebbe più ricapitato. “Insomma, che perlomeno tutto questo ci sia servito a chiarirsi. Arrivederci, dottore”. Ma lui non aveva nessuna fretta. “Arrivederci? Ecco, vedi l’hai detto. Bene, è una bella parola, la prendo alla lettera, tanto lo so che ci riincontreremo. Questa volta mi telefonerai, vero? Io non vorrei scegliere il momento sbagliato… - le camminava accanto con le mani in tasca, guardandola come si guarda un panorama amato – mi ha fatto molto bene rivederti, non sei diventata meno desiderabile nell’ultima settimana. Come ti bacerei volentieri, e dappertutto, comincerei dai tuoi occhi e finirei dove non c’è più niente”. Si sporse verso di lei, Arianna di nuovo arretrò. Sentiva una forte sensazione di calore spandersi dallo stomaco al ventre e alle cosce. “Lei non ha un suo ombrello? Si bagnerà tutto”. “Sarebbe pericoloso, mi potrei trasformare in una grande nuvola di vapore”. Arianna si mise a ridere ma lui non aspettò che smettesse. “E se diventerò una nuvole, farò come Giove e ti avvolgerò tutta senza lasciarti scampo…”. Lei sorrideva ancora mentre già gli faceva un cenno di saluto con la mano, come quelli che si fanno dalla nave e imboccava senza fretta la strada leggermente in salita, col cuore che batteva fortissimo e una gran voglia di voltarsi indietro. Sentiva quel calore fisico permanere, rimanerle attaccato addosso come un impiastro anche ora che la sua causa era partita nella direzione opposta. “Sarà la menopausa che arriva...” Si disse e si accostò ancora di più a Giorgio. Per lui invece era una giornata come tutte le altre, non c’era nessun motivo di accellerare il passo, né di rinunciare ai soliti piaceri olfattivi. Ogni tanto dava alla padrona uno strattone perché, come sempre, si fermava bruscamente per annusare un angolo di gradino o le pendici odorose dei grandi condomini, enormi monumenti urbani per lui interessantissimi ma che Arianna ora nemmeno vedeva. Capitolo XI Lo studio veterinario dove Gabriele lavorava, era composto da un´ampia sala d’aspetto con ai lati due porte, di cui una immetteva nel suo ambulatorio e l’altra in quello del suo collega Giancarlo. Da entrambi gli studi si poteva accedere alla sala operatoria, uno spazio comune le cui apparecchiature erano state acquistate a metà, mentre ognuno teneva nella propria stanza l’attrezzatura personale minuta, quel poco che serviva per le visite, i vaccini, le suture. Gabriele era proprietario al cinquanta per cento e non avrebbe mai potuto aspirare a tanto se non lo avesse aiutato l’eredità della nonna paterna che aveva lasciato le sue sostanze agli unici due nipoti, lui e suo fratello. Con quei soldi, appena laureato, si mise in società con Giancarlo , un medico con alle spalle una certa pratica di lavoro, più esperto di lui, ma non certo più ricco. Insieme, con un mutuo e qualche prestito in famiglia, riuscirono a metter su l’ambulatorio, un grande sforzo economico che gli anni stavano ripagando. Non c’erano mai stati gradi attriti fra di loro, anzi, erano diventati sempre più amici, per quanto si può riuscire a essere amici con lui, un uomo dai modi brevi, estremamente sicuro di sé, molto più bravo a farsi stimare che amare. Giancarlo era un tipo rude, rude di formazione: i suoi non sapevano meglio di lui cosa fossero i modi gentili, la mediazione, la considerazione della altrui sensibilità, i cerimoniali introduttivi, il valore di un rituale psicologico. In compenso sapevano benissimo che cos’era l’onestà e il lavoro: con la prima ci si riscatta da tutto quello che non si è, con l’altro si compra la casa e si fa studiare il figlio, un ragazzo molto intelligente, introverso e silentemente ambizioso. La casa in cui era cresciuto era formata da un lungo corridoio buio su cui si aprivano delle stanze; sua madre faceva bene da mangiare e suo padre posava pavimenti e piastrelle con la precisione e il rigore di un ingegnere. Nel salotto, il vuoto dei muri bianchi si interrompeva contro un brutto quadro con un paesaggio toscano, alcune foto del matrimonio e della Comunione, il calendario della banca e una piccola immagine di Padre Pio che, discreta e protettiva, pendeva sopra la soglia, attraversata da un ramo risecchito di ulivo benedetto. La libreria si trovava nella camera di quell’unico figlio e la riempivano esclusivamente le costole grigiastre e grinzose dei suoi libri di testo, dal liceo all’università. Il loro ragazzo era dotato di un solido raziocinio e di ottima memoria, a scuola era sempre andato bene, dalle elementari fino al centodieci e lode della laurea. Durante il suo lungo curriculum scolastico, Giancarlo ebbe a che fare con molti insegnanti, anche bravissimi, ma con nessun maestro, nemmeno mediocre; nessuno si soffermó sulla sua personalitá in formazione cercando di irrobustirne le qualitá, di pilotarne gli interessi, di dare indicazioni e esempi. Nessuno si occupó della sua crescita interiore né gli insegnó buone maniere dietro cui schermarsi. Anche lui, come tantissimi, fu costretto a costrirsi da solo un´anima o quantomeno un´identitá. Canalizzó le sue giovani energie nel lavoro, ne fece il suo pilastro, il suo riferimento. Su quello si misurava, da lí estraeva le gratificazioni che alimentavano la sua alta stima di sé e che lo dispensavano poi da dubbi e verifiche. Il grande traguardo della sua vita era di mettere su una clinica attrezzatissima di cui fosse l´unico direttore. La reputazione che si era conquistato era tale che spesso gli portavano casi compromessi dall’imperizia di altri colleghi. A vedere certi pasticci, si arrabbiava profondamente, fino a soffrirne. Andava nella stanza di Gabriele e alzando la radiografia ancora bagnata contro la finestra, gli diceva: “Guarda! Guarda qui come hanno ricongiunto questo femore! Cosa gli ci posso fare io? Questo è un ambulatorio, non è mica Lourdes! Accidenti all’ignoranza, quella troia che chiunque può possedere! Possedere – insisteva asserendo con la testa – e poi anche mantenere a poco prezzo per tutta la vita!”. Questo magari davanti a qualche delicata cliente. Era fatto così, e così bisognava prenderlo, anche se il suo carattere provocava spesso incomprensioni coi padroni dei suoi pazienti Ma il grosso della sua clientela, quelli preoccupati esclusivamente della salute dei propri animali, ci passavano sopra e gli rimanevano fedeli, anzi, aumentavano anno dopo anno, fenomeno che invece, nel caso di Gabriele, conosceva accellerazioni molto più lente. Tra le donne e Giancarlo invece, non andava troppo bene. Poche erano quelle che non si lasciavano toccare dal suo aspetto atletico, dalla luce notturna dei suoi occhi blu, dalla reputazione che lo circondava, dai suoi modi fermi e assertivi. In molte cercavano di entrare in sintonia sentimentale con lui, ma nessun rapporto ce la faceva a reggere più di qualche mese: occupatissimo col suo lavoro, il poco tempo che dedicava a loro risentiva dell´abituale durezza della sua natura, per cui i caldi sentimenti delle sue fidanzate, in poco tempo finivano col disidratarsi fino a irreversibili e sofferte essiccazioni. Non era un uomo esercitato a “dare” e tutte le ne accorgevano alla svelta. A quel punto, se non prima, le sue storie finivano, spesso accompagnate da scenate, lacrime e frasi velenose: “Solo un’animale può stare con te!”. Gli aveva detto una sua amante, ma lui né allora né dopo capì bene che cosa volesse dire. Ciò nonostante, non essendo né malvagio né ipocrita, chi lo conosceva senza implicazioni amorose, lo perdonava e si rassegnava a stargli accanto senza stargli vicino.Con Gabriele era comunque molto affabile, loquace, cameratesco, generoso di insegnamenti, a volte addirittura protettivo, quasi fosse il suo fratello più giovane. Gli faceva vedere le operazioni più difficili, gliele spiegava, gli riportava molto di quello che imparava nelle sere passate a studiare le montagne di pubblicazioni internazionali che riempivano gli scaffali del suo appartamento. Gabriele era un po’ la Cenerentola dell’ambulatorio, aveva meno clienti e il suo ruolo rimaneva quello di spalla della star. Senz’altro meno fanatico nel proprio lavoro, lo faceva con coscienza e scrupolo, sì, ma non proprio con passione; le sue mezze giornate libere le passava a leggere, a sentire musica, a suonicchiare il suo piano, a passeggiare in campagna, a godersi i piaceri del mondo insieme alle sue mutevoli fidanzate. Quando era più giovane ne aveva avuta una sola, la Rossana, sua compagna di liceo prima e di vita poi. Prima che arrivassero alla laurea, il loro amore ebbe tempo di crescere, invecchiare e morire. La morte non fu traumatica, ma ugualmente dolorosa per lo scompenso di dover rinunciare a familiarità solidificate in otto anni di vicinanza. Da allora, da quando si lasciarono perché videro che non avrebbero mai avuto il coraggio di sposarsi, le fidanzate erano diventate una componente costante della sua vita. Per qualche mese poteva capitare che non ne avesse nessuna, ma più spesso se ne ritrovava più di una alla volta e tutte sapevano di non essere l’unica. Era questa la precauzione che usava sempre e che permetteva una qualche durata ai suoi mobili e disinvolti menages. In ognuna riusciva a scoprire qualcosa che gli piaceva; le cercava, le trovava, le perdeva. Gabriele sapeva che stava vivendo un momento per lui molto propizio: libero nella professione, accompagnato ma non legato, non ricco ma nemmeno limitato da ristrettezze, aveva tutte le condizioni per gioire della vera ricchezza: il tempo, il tempo libero per fare quello che gli piaceva e tra le cose che gli piacevano, c´era anche il lusso di stare in ozio. Durante le ore che passava seduto in una piazza del centro o trai cuscini del suo divano, si perdeva in lunghi soliloqui, in introspezioni, osservazioni e riflessioni su temi a sfondo esistenziale Trovava affascinanti i viaggi del pensiero, l´assemblare concetti estraendo materiale dall´archivio del suo sapere e delle sue esperienze. Ancora non aveva scoperto quale fosse il senso della vita, peró si sentiva rafforzato dal solo fatto di cercare di scoprirlo, gli sembrava una grande avventura, una scommessa che avrebbe potuto anche vincere. Si sentiva vivo e ancora di piú quando era la morte l´oggetto delle sue meditazioni; spesso aveva l’impressione di avvertire l´esistenza scorrergli fisicamente tra le mani, come un rivolo d’acqua chiara; gli sembrava di poterla toccare, di sentire il suo fiato circondargli le spalle e sollevargli le braccia. Così stavano le cose quando il bastardo Giorgio e la sua padrona entrarono nell’ambulatorio a chiedere soccorso. A distanza di diversi giorni dall´incontro ai giardini, Gabriele si dispiaceva ancora molto che proprio quella probabile fidanzata, così promettente e misteriosa, non si fosse fatta più viva. Giancarlo gli chiese degli sviluppi dell’appuntamento con lei e quando seppe degli scarsi risultati, gli suggerì di non arrendersi, se davvero gli piaceva; sarebbe stata solo questione di tempo. “Vedrai, poi sarai ricompensato, e alla grande! – gli disse – le donne non giovani si impegnano così tanto per farsi perdonare di non esserlo che farsele è un piacere squisito e direi anche riposante: fanno tutto loro, stanno attente, si adattano, si contentano facilmente, ti rimangono grate… Se solo sono ancora passabili, è una meraviglia! Anzi, a proposito, ti consiglierei, in questi incontri, di abbassare molto la luce o spegnerla subito del tutto: sono donne che spesso approfittano dell’oscurità per diventare bellissime. Sono una specie di animalini notturni, delle volpi che quando scende il buio si sentono a loro agio, diventano vitali e danno tutto il meglio di sé: non vanno sottovalutate… Comunque, ricordati del Machiavelli: le donne e la fortuna bisogna forzarle e sbatacchiarle se si vuole che facciano il nostro gioco! Secondo me devi solo tornare all’attacco, devi mostrarti audace… insolente”. Questo non era la via che Gabriele si prospettava, ma gli faceva bene sentirselo dire, gli rafforzava la convinzione che doveva insistere e che il raccolto era alle porte. Pensò di scriverle e consegnarle la lettera durante una delle passeggiate col cane, senza rimanere con lei più a lungo del tempo di dargliela; le avrebbe anche portato una rosa bianca; se non faceva bene, male no di sicuro. Ma scrivere qualcosa di adatto a smuovere la resistenza di una donna ancora così lontana, si rivelò molto più difficile del previsto. Alla fine, tornó all´ipotesi di cercarla ai giardini con un boccio di rosa e un paio di belle righe che molto tempo prima aveva composto per un’altra donna, ma che si adattavano benissimo anche alle circostanze di ora. Qualche giorno più tardi, però, mentre il materiale per l’assalto amoroso veniva assemblato, il fax dell’ambulatorio sputò un messaggio che fece mettere tutto da parte: “Gentile Dott. Sassi, le condizioni del nostro cane Giorgio non migliorano, forse è necessario ricorrere all’intervento che ci aveva consigliato. Vorrei riparlarne con lei prima di prendere una decisione. Potrebbe telefonarmi? Mi troverà senz’altro lunedì e martedì mattina, tra le nove e le dieci, a questo numero. Nel frattempo le invio cordiali saluti”. Nessuna firma. Quel giorno i clienti trovarono il loro dottore più disponibile del solito, attento, in vena di chiacchere e ottimista rispetto alla guarigione dei suoi pazienti. La domenica Gabriele andò a Cortona con la sua fidanzata Cristina, con cui trascorse un dopocena particolarmente spumeggiante. Arianna quello stesso giorno era andata in campagna con Marco e aveva giocato con Giorgio a tirargli la palla più a lungo di quanto non avesse mai fatto. La notte dormì pochissimo e la mattina, insieme al caffé, prese una pasticca di tranquillanti. Ce la fece comunque a mantenere la calma mentre parlava al telefono. La conversazione fu tecnica e brevissima: se lui poteva, alle quattro e mezzo del giorno dopo, si sarebbe trovata al “Caffè dei Ponti”, un locale del centro dove quantomeno avrebbero gustato la miglior pasticceria della città. Capitolo XII “In un giorno particolare (venerdì 13 dicembre, alle ore 21), un periodo di tempo molto fertile (il Barocco musicale), espresso da compositori di alta qualità (Vivaldi, Albinoni, Galuppi), nati in una patria senz’altro speciale (la Repubblica di Venezia), questa bella musica appunto, verrà festeggiata in un posto straordinario (Pieve di Gropina, X secolo e dintorni). Ci vorrà venire la mia signora dagli occhi di cerva? Ti aspetto, ti immagino e ti aspetto”. Il biglietto era stato scivolato in fretta nella sua borsa; Gabriele glielo aveva dato di corsa, all’ultimo momento, quando si era già fatto molto tardi e a malincuore si erano decisi a lasciare il loro tavolo vicino alla finestra. Il “Caffé dei Ponti” era un locale arredato stile pub nord-europeo: molto legno, luci basse, separès, tavoli di formato diverso, candele e fiori recisi in vasetti di cristallo. Sul muro, gigantografie di paesaggi fluviali da tutto il mondo, dal Nilo verde, alle rocce rossastre del Reno, dai banchi di sabbia della Loira, alle rive brulicanti del grande Gange. L’acqua imnpregnava il locale dappertutto, la nebbia sui pioppi accanto al Po saliva su fino al soffitto, l’odore di morchia dei grandi carghi sulla Schelda sembrava mischiarsi all’aroma dei caffè e delle cioccolate. Nell’angolo più lontano dal banco si alzava nero e lucido un vecchio pianoforte verticale, ma quella sera era l’impianto stereo che provvedeva alla musica, musica a volume bassissimo, suoni quasi indistinti, schiacciati dal brusio fitto delle conversazioni, dal tintinnio dei bicchieri lavati, dai coltelli e gli apribottiglie presi e posati sull’acciaio del bancone. L’atmosfera era animata e allo stesso tempo tranquilla; tante persone, eppure l’impressione di essere liberi come non ci fosse nessuno. Oltre la vetrata, dietro i tendaggi semitrasparenti, lo scenario urbano brulicava come sempre, immerso nelle luci calde del tardo pomeriggio invernale, abitato dallo scorrere ininterrotto di visi e cappotti Dal loro tavolo, la città sembrava particolarmente bella e lontana. Parlando di tutto e di niente, il tempo era volato, accumulando tra loro un grumo di materiale che al momento li riempiva confusamente, ma che poi ognuno avrebbe ruminato e digerito per proprio conto, magari il giorno o l’ora dopo, quando l’intimità della propria solitudine avrebbe permesso di valutare e interiorizzare tutto. “Scusa, devo andare in bagno un attimo…” disse Arianna mentre si preparavano già a andar via. “E’ meglio comunque che di qui esca da sola…”, aggiunse a fil di voce. Lui depose il cappotto che stava per porgerle, lo poggiò sullo schienale della sedia e lentamente tornò a sedersi, senza mai smettere di guardarla. I servizi si trovavano nel sottosuolo. Arianna imboccò la scala di legno calma e tranquilla, come se fino a allora avesse chiaccherato con un suo lontano parente e non con l’uomo che da settimane turbava i suoi giorni e le sue notti. La calma, nel suo caso lo sforzo mentale di non pensare a niente e di concentrarsi solo su quello che stava facendo, le era al momento di grande utilità: era quella la muraglia che arginava la falange di sensi di colpa che avanzavano comprimendo una buona metà della sua anima; l’altra metà invece, esultava, pulsava, saltellava come un vitellino libero nel prato. Si rinfrescò il trucco, si ravviò i capelli. Tra le piastrelle bianche, lo specchio rimandava l’immagine di un viso non giovane, non bello, in mezzo a cui brillavano occhi di una luminosità abbagliante, pieni di una luce che lei stessa non si conosceva. “Oddio, allora mi si vede!”, si disse. Fuori dalla toilette delle signore, nel corridoio che portava alla scala a chiocciola, incroció Gabriele. Con naturalezza lui l’acchiappò al volo, come un ragno la sua tenera zanzara, e Arianna si trovò bloccata in un bacio mozzafiato la cui onda lunga la fece arrivare al piano superiore senza avvertire scalini. Gabriele la seguì con lo sguardo mentre saliva senza voltarsi, disegnando col suo avanzare leggero la spirale stessa della scala; sembrava davvero che si portasse dietro un lungo filo luminoso che insegnava la via. La guardò con nostalgia e desiderio. “Tutto va per il meglio e questo è il migliore dei mondi!”, pensò protetto dalla semioscurità del corridoio. Si sentiva davvero contento e ottimista, ora sarebbe risalito e appena partita Arianna, avrebbe senz´altro ordinato un buon cognac. Mancavano tre giorni al concerto del Barocco Veneziano. Poi due, poi uno, poi niente, anzi, quasi niente. La strada quella sera non finiva mai. Uscita dall’autostrada, a Arianna sembrò di essersi persa: la zona non le era nota e i riferimenti che si era cercata a casa, sulla cartina, non si facevano riconoscere sui cartelli indicatori che trovava per via. Dovette fermarsi e chiedere a un bar. Si trovò addosso gli occhi di uomini di tutte le età che, appena chiese informazioni al barrista , si trasformarono in grandi conoscitori del territorio; tutti sapevano suggerire che strada prendere a quella signora elegantemente vestita di nero, le indicarono percorsi classici e scorciatoie, le contarono i semafori, cercarono per lei riferimenti chiari, distributori, ponti, ristoranti; si dettero da fare. Problema comunque risolto, finalmente il percorso certo, finalmente tornata nel calore amico della sua macchina. Filava veloce tra campi stepposi, piccoli borghi già deserti, tratti di bosco disegnati da querce brulle le cui vecchie foglie invadevano di giallo il bordo dell’asfalto nero, illuminato a giorno dagli abbaglianti. Ormai era quasi arrivata ed era persino in anticipo. Ma una macchina apparve all’improvviso dietro di lei; quei fari senza volto la inquietarono e ancora di più quando le sembrò che sfareggiassero e mirassero proprio a lei. “Mamma mia, non morirò mica proprio stasera che lo posso vedere, accoppata da due balordi di provincia?”. Si sentì rabbrividire, il cuore prese a battere forte. Accellerò, sperando di trovarsi al più presto in un centro abitato, ma al primo rettilineo la vettura dietro di lei sterzò bruscamente a sinistra, scalò e accellerò rumorosamente fino a sorpassarla. Arianna trovò il coraggio di guardare in quella macchina; si aspettava di vederci quantomeno due o tre uomini. Ce n’era invece uno solo, lui, Gabriele. Sentì colpi di clacson, lo vide salutare con la mano e indicare il lato destro della strada. Troppe emozioni forti tutte insieme; passata in un soffio dallo spavento alla felicità concitata, si sentì avvampare nel viso e sul collo: lo specchietto retrovisore le mostrò un volto vistosamente arrossato, con chiazze più scure sulle guance e sul mento. “Accidenti, che sfacelo! Proprio ora…”, ma subito se ne dimenticò perché Gabriele era già lì, era questione di secondi. La piazzola dove parcheggiarono, ampia e coperta d’erba d’inverno, si immerse nel buio appena tutti e due spensero i fari. Forse lo fecero apposta di spegnerli. Sportelli che si aprono, sportelli che si chiudono, l’oscurità. Le braccia sue, l´odore, le labbra, la voce, il corpo che le aderisce addosso come un guanto morbido. Carezze, riconoscimenti, baci. La mano si appoggia sul pube, si apre come una larga pinna di pesce contro la stoffa sottile della gonna, il palmo preme, è un abbraccio caldo che subito si ripercuote dappertutto, si spande in ondate che si moltiplicano per il dorso, sul seno, sul ventre. “Non lo fare…”. Parlare diventa difficile, fasci di brividi avanzano e ostacolano la via, come fiori sparsi in terra davanti a una processione. “Non lo fare, non ora, ti prego, non lo saprei gestire…”. Gabriele le ubbidisce, docile e disponibile come un vero gentiluomo. Non sa che nel paradiso in cui Arianna sta per entrare è lui l’aria, la terra, il bosco, è lui l’origine della piccola falla nella diga che si sta inesorabilmente allargando. Ormai non ci si può far nulla, ora si aprirà, è troppo tardi per tamponarla, quella piccola innocente crepa, lentamente scavata da lunghe giornate intrise dell’acqua dell’attesa. La diga cede, la pressione di tanto tempo prende la strada incontrollabile della sua liberazione. Arianna si sente portare via anche se ora proprio non vorrebbe, ma è inutile trattenersi, inutile opporre qualsiasi resistenza; lei stessa è colta di sorpresa, non le era mai successo, non se l’era mai nemmeno prospettato. Quasi si aggrappa alle spalle di Gabriele che non capisce ancora bene che succede. Qualcosa di simile al pudore si fa avanti, si insinua tra le sensazioni che a ondate si pigiano e si sovrappongono, poi si ritrova sola e senza argomenti, con la faccia premuta contro la giacca di lui, le mani che stringono la stoffa vuota del cappotto, la voce soppressa dentro le sue pieghe. Lo abbraccia intorno al collo, il viso basso, piegato come chi chiede soccorso. La tensione della stretta lentamente si allenta. “Mi dispiace – gli dice imbarazzata, alzando occhi timidi su di lui – non mi era mai accaduto… così, da stupida, senza potermi per niente controllare... mi dispiace veramente". “Bellissima…– le dice tra file di piccoli baci – che bel regalo..”. Nemmeno a lui però era mai successo, se ne sente fiero, intenerito e disorientato allo stesso tempo. “Tutto questo per me?” Davvero? …”. Gabriele la stringe forte, non sa che fare e infatti non fa niente. Ormai comunque il disagio di Arianna si è diradato, ora sta bene, bene e basta. Sta rannicchiata nel suo morbido bozzolo di piacere, un guscio che l’avvolge e la protegge, un involucro fragile, ma capace di trattenere il tempo dentro di sé. Il tempo infatti ha smesso di passare, non la tocca più. Fuori da quel microcosmo, invece,l’ora correva lo stesso, silenziosa e irrimediabile: ancora un po’ e i musicisti si sarebbero seduti sulle loro viennesi nere, l’esecuzione avrebbe avuto inizio e il piacere di aggiungere all’amore la musica, sarebbe andato perduto. Decisero di prendersi anche il concerto, e fin dalla prima nota. “Vieni, andiamo con la mia!”. Gabriele le aprì lo sportello, si piazzò al volante e grazie a marce basse, curve in controsterzo e buona sorte, recuperò un po’ del tempo perso. Fecero quasi di corsa il tragitto tra il parcheggio e la chiesa: a un soffio dall’inizio, si potettero sedere, accaldati e ansimanti, sulle loro spartane seggioline. Gabriele si volse verso di lei, le sfiorò il ginocchio poi tornò a guardare la piccola orchestra da camera che, appostata sui blocchi di partenza, già assestava gli spartiti e palpava gli strumenti. I brani suonati, brillanti, leggeri, penetranti, fecero su almeno due degli ascoltatori una grande impressione: soffiarono loro addosso un’irrequietezza calda che partiva dalle orecchie e si assestava subito sullo stomaco, sulla pelle, nel cavo della schiena. “Farfalle nella pancia” è l’espressione che si usa in una lingua germanica per definire queste specialissime sensazioni. Quelle farfalle non si vollero posare, rimasero lì tutto il tempo a svolazzare, insistenti come mosche. Quando arrivò l’ultima nota dell’ultimo pezzo, Gabriele e Arianna si sentirono in qualche modo liberati; finalmente la musica se n’era andata dando loro un po’ di sollievo, permettendo che i semini virulenti che aveva insinuato nei loro capillari, si astenessero per il momento dal germogliare. Sentirono bisogno d’aria. Frastornati, si unirono al pubblico che defluiva lento in una nuvola di brusii e isolate frasi distinte. Fuori dal grande portone, oltre la scalinata dell’antica pieve, la notte d’inverno tersa e pungente, si fece loro incontro come un’enorme prateria nera dove era piacevole respirare. In lontananza, la valle si stendeva larga e increspata, punteggiata di aggregazioni luminose, lunghe e disordinate. Di fronte alla facciata pura e sobria, il grande piazzale a ghiaia crocchiava sotto i passi del pubblico in uscita. Lo delimitava un muretto a sassi, basso e invitante, un semplice segmento di pietre grige che pur riusciva a dare ordine e quiete al paesaggio intorno, segnando con chiarezza il confine tra il vicino e il lontano, tra il rigore della muratura e il movimento indisciplinato delle colline, tra le dimensione simmetrica e austera della chiesa e l’anarchia delle punte degli olivi che crescevano selvaggi nel campo sottostante. Lo spazio tra la chiesa e il muro era brullo e vuoto, un unico pezzo di vegetazione cresceva sul lato destro del portale, al centro di un’aiuola erbosa: era un’altissima palma, snella e pulita, la cui chioma toccava immobile il cielo stellato soffiando sulla pieve illuminata dall’interno un suggestivo aroma d’oriente. Gabriele e Arianna si soffermarono sui primi gradini per guardare vicini il vestito stupendo di quella sera; ci restarono in piedi, senza parlare, con le braccia che si toccavano. Ma tutto quel cibo e quella bellezza erano troppo, esigevano un contrappeso, un antidoto, un richiamo alla realtà: Arianna non ce la fece più e cercò l’orologio: bisognava andare; la sua macchina l’aspettava sulla piazzola a valle, pressante e cattiva; quando la raggiunsero, la odiò. Gabriele scese con lei e l’accompagnò fino allo sportello oltre cui si alzava umido un bosco di aceri spogli. Tutti i fari erano spenti, la notte si addensava intorno a loro, si insinuava trai ciuffi d’erba, trai rami degli alberi, saturava lo spazio tra la strada e i campi, tra le stelle e il piccolo spicchio di luna. Il buio, l’intimità accumulata, l´esaltazione della musica, la coscienza del distacco, tutto alimentava l’inquietudine che da tanto li accompagnava; ora che rimaneva poco tempo, ancora piú forte soffiava nell’aria la grande impazienza di abbracciarsi, baciarsi, prendersi. Arianna si sentiva addosso un languore antico, qualcosa che prese a crescere ancora di più quando si trovò stretta tra il freddo della lamiera e il corpo caldo dell’uomo amato che le si premeva contro, sul petto, sul ventre, sulle gambe. Chiuse gli occhi e dimenticó tutto quello che non era lui. Era tanto che non vedeva quel colore della vita, dagli anni dell’adolescenza, quando l´amore procedeva con la forza di un grande fiume, era tutt’uno con la realtà intera; in quel tempo i desideri viaggiano su misure assolute, sul trasporto totale, si addensavano in un unico impulso prepotente a cui lasciarsi andare era bellissimo e naturale. Arianna riconobbe quelle sensazioni e se ne reimpossessò con avidità. Che responsabilità avesse poi in tutto ciò la musica che aveva appena ascoltato non lo sapeva, però sapeva che c’entrava di sicuro, sciolta in chissà quali venature della sua anima; ne sentiva il fiato caldo soffiare sulle braci di quella sera. “...Certo che è stata così a lungo vietata nelle chiese, certo che è ‘l’ambiguità portata a sistema’, certo che è ‘la gemella dell’acqua’ – avrebbe pensato dopo, sulla via di casa – certo che, anche se costruita sulla disciplina e la matematica può diventare la grande nemica di ogni ordine e razionalità… certo”. Ma in quel momento non pensava affatto, non cercava spiegazioni a niente, anzi, si beava dell’incoscienza che la stava invadendo e che le schiudeva davanti l’intero ventaglio delle possibilità. Si trovò distesa sull’erba umida, da un lato le ruote della sua auto, dall’altro i rovi oltre l’erba, a un braccio da lei. E Gabriele dappertutto, importava solo sentirselo sempre più vicino. Farsi portare via da lui, subito e per intero. Non fare niente, lasciarsi fare, lasciarsi prendere senza riserve. Tutto procede da sé, è facile, il propellente è naturale e inarrestabile, comanda e decide tutto lui. Il ponte con la coscienza vigile è finalmente saltato. Il piacere cresce, diventa più che piacere, vasto, intero, cocente, fa quasi male. Gabriele è tutto, copre tutto, ha presa su tutto, esiste solo lui; ma poi ancora oltre, nemmeno più lui, un amalgama, una cavità larga che inghiotte senza fare paura. Lasciare ogni cosa, sentirsi mancare, uscire, partire, senza bagagli, senza nostalgie, insieme, per un po’, lontano, molto lontano. Il mondo che si lasciano dietro ora non conta molto; esiste sì, ma da un’altra parte, di lui non distinguono nemmeno una eco, nemmeno ne sentono il respiro aleggiare tra i rami brulli alle loro spalle. Forse delle macchine sono passate, forse la civetta ha volato con ali silenziose sopra di loro, forse insetti e ragni hanno percorso i vestiti e anche la carne. Un silenzio simile a quiete avvolge le due auto parcheggiate vicine sul lato della strada; si sente il respiro che cerca di tornare regolare; ci sono gocce d’acqua dappertutto, sull’erba, sui capelli, sul cofano, sulla pelle. Da lei distesa, piccoli rivoli scendono dagli occhi alle tempie, solo per qualche battito di palpebre. Gabriele li bacia, li beve, l’abbraccia più forte. Nessuno emette suono, la prima parola romperà la magia di quel momento sospeso. Aspettano ancora, aspettano il più possibile, poi un brivido di freddo arriva sulle gambe; la realtà si fa di nuovo sentire, le braccia si staccano, ci si separa, ci si rimette in piedi. Ma anche se ancora confusi, ci si accorge già che non è lo stesso mondo di prima. Capitolo XIII Le uscite di Arianna e Gabriele erano rare, difficili da organizzare e comunque sempre brevi, al massimo disponevano di tre o quattro ore, il più delle volte nella prima parte della giornata. Il sole pallido, il freddo, l’aria dura delle mattinate invernali accompagnavano i loro incontri che si svolgevano prevalentemente in macchina o in qualche locale pubblico della città, rarissime volte nell’appartamento che Gabriele divideva con un suo amico: lì Arianna si sentiva molto a disagio. Arrivavano nei luoghi convenuti gasatissimi, con piccoli regali, lettere e bigliettini da scambiarsi, ma dopo pochi minuti che chiaccheravano, li avvolgeva una grande calma, le conversazioni fluivano permettendo loro spesso il lusso di pause e silenzi. Come per tacito accordo, evitavano le storie personali, mentre invece miravano quasi con metodo alla conoscenza reciproca attraverso triangolazioni indirette. Parlando di tutto, di libri e di storie altrui, commentando fatti e persone che non li riguardavano personalmente, si osservavano, si studiavano, fino a far cadere pezzo per pezzo le vesti che ricoprivano le loro individualità più profonde e sottili. Arianna non sapeva se Gabriele avesse fratelli o che mestiere aveva fatto suo padre, non glielo aveva mai chiesto, ma sapeva che quando la fine della giornata lo trovava svuotato e in vena di malinconie, si metteva a letto con una sinfonia di Mozart e un dramma di Shakespeare tirati fuori a caso dagli scaffali e che in loro compagnia si rigenerava, aggiungendo poi a una combinazione già felice, il piacere di un ottimo whisky, un bicchierino che si sarebbe sorseggiato lentamente, come una pozione preziosa. Gabriele da parte sua non sapeva da quanto tempo Arianna era sposata, né con quale tipo di uomo, ma sapeva che tra le cose che più l’appassionavano e l’esaltavano, niente o quasi niente era cresciuto col contributo del suo consorte. Sapeva che di fatto era stata lasciata sola nei suoi percorsi interiori e che le si era formato intorno un grande vuoto; sapeva anche che proprio in quel vuoto si era introdotto lui e che di quello spazio era il re; ci poteva sguazzare libero e senza concorrenti. Sul banco del caffè in cui quella mattina sedevano, si ergeva un piccolo abete illuminato a festa; dicembre era inoltrato, il Natale si avvicinava, tutta la città si adattava docile al suo rituale di luci e artifici. Una qualche atmosfera di attesa aveva contagiato anche Arianna che di solito nutriva una profonda antipatia per queste feste invadenti e obbligatorie; questa volta invece se ne lasciava volentieri contaminare, stava al gioco, con lo spirito indulgente di chi concede un vantaggio a un avversario che non teme. Arianna si sentiva vicina allo spirito natalizio perché stava cullando l’idea di un grande regalo. Di fatto era un pezzo che covava qualcosa di grosso, qualcosa che stava a lei manovrare, far vivere e portare a fioritura. Prese questo qualcosa, lo impacchettò con cura, lo caricò anche ai suoi stessi occhi di suspence e si preparò a offrirlo a Gabriele, avvolto in carte preziose e fili lucenti. Lo lisciò, lo tenne in seno finchè, poco prima delle feste che li avrebbero senz’altro costretti a vedersi ancora meno, si preparò a offrirglielo. L’attesa di quel momento le procurò piaceri squisiti; tenere quella cosa ancora tutta dentro di sè, la riempiva di calore, di entusiasmo, di una luce speciale che sfavillava anche nel suo sguardo. Stava seduta di fronte a lui al tavolo di un caffè a quell’ora quasi vuoto; quello sarebbe stato il giorno della consegna, il grande momento si avvicinava. “… Ho un regalo, un regalo bellissimo …” pensava mentre le sue gambe vibravano nervose sotto il tavolo; eppure non gli diceva ancora niente, anzi stava lì, con le braccia incrociate sulla tovaglia rosa, davanti al suo latte macchiato, con lo sguardo fragrante che esprimeva sorriso molto più delle labbra. Voleva fino all’ultimo prendere tempo, lasció quindi volentieri che la conversazione andasse dove voleva: i viaggi? Bene, i viaggi. Venezia? Certo! Anzi, Venezia veniva proprio a pennello perché in quella cittá le era successa una storia straordinaria che ora, subito, gli avrebbe raccontato. Era successo qualche anno prima, una volta che lei e Marco trascorsero un’intera settimana in quella città dalle strade d´acqua. Armati di cartine e macchine fotografiche, girellavano da veri turisti, passeggiavano a naso in su lungo i canali , per i vicoli strettissimi e i brevi porticati, percorsi affascinanti che portavano immancabilmente a qualcosa di ancora più bello. Infilarono in una delle tante chiese che incontrarono per via; era sempre una sorpresa, tutte avevano qualcosa da offrire, non se ne usciva mai a mani vuote. Contrariamente alla facciata, l’interno di quella non era dei più interessanti, baroccheggiante e pieno di rifacimenti di altre epoche che lo rendevano piuttosto piatto e privo di personalità. Passarono quasi annoiati lungo le diverse cappelle che si schieravano ordinate lungo il transetto; marmi, colonne, tele buie e illeggibili, busti, lapidi, un alto cancello. Davanti a quello Arianna si fermò. Il cancello, soprattutto se collocato in un interno, è un elemento architettonico molto speciale, genera attrazione, dà l’idea del proibito, dell’invalicabile, del misterioso. E` una tentazione irresistibile, bisogna per forza ficcarci il naso. Così fece Arianna stringendo tra le mani le inferriate e premendo il viso tra gli intervalli. Quella volta il cancello fu all’altezza delle aspettative: in uno spazio di pochi metri quadrati, alto e spoglio, vide qualcosa di stranissimo e inquietante: il pavimento a losanghe di pietra d’Istria e marmo di Verona era cosparso di una ventina di gladioli freschi, varianti tra il rosso aranciato e il carminio, buttati là per terra, sparsi a caso, come una manciata di coriandoli. I loro fiori ancora in boccio, spuntavano dal grembo verde come stelle di porpora, vive e accese contro il freddo della pietra. Erano stati gettati con forza, ma anche con difficoltà; certo un braccio si era insinuato a fatica tra gli steli stretti della cancellata e da lì aveva lanciato il suo voluminoso omaggio, un dono allo stesso tempo selvaggio e gentile. A quel punto la curiosità era più che alle stelle, bisognava leggere a tutti i costi l’iscrizione sulla lapide mortuaria che emergeva dal pavimento e che costituiva l’unico arredamento della cappella. Attraverso i caratteri romani ,distanti, piccoli e sbiaditi, Arianna riuscí alla fine a ricomporre un nome: Claudio Monteverdi. Si fece silenzio, si guardarono. Gabriele si sentì attraversare da brividi sottili. Passarono alcuni secondi. Fissó lo sguardo sul cognac che stava facendo roteare dentro il piccolo calice. “Cazzo, che forza può avere un maestro!”, disse. “Bello Monteverdi… potente! E´musica antica, lontana peró bellissima.” Buttó giú un grosso sorso dimezzando il bicchierino. “ Ha scritto tanto in vita sua , tra l´altro molte Lamentazioni e tra quelle c’è anche un “Lamento di Arianna”, lo sapevi? E’ un frammento da un’opera incompleta, scritta i primissimi del ‘600.. Anch’io se ero Monteverdi, avrei composto per te tanta bella musica”!. Concluse cercandole lo sguardo dall’altra sponda del piccolo tavolo. “Davvero c’è un pezzo suo che porta il mio nome?”. Gli occhi le brillavano come se fosse stata davvero scritta per lei; sollevò le spalle e si abbracciò i gomiti che teneva appoggiati sul tavolo. “Mi fa tanto piacere, sarà senz’altro stupenda!”. Gabriele si intenerì del suo entusiasmo fondato su quasi niente, dovette ricollegarlo a quella prima volta, quando lei lo aveva ringraziato con lo stesso trasporto, dopo che aveva ricucito il suo cane. “L’immortalità non è proprio una vittoria sulla morte – disse Gabriele – però è certo un graffiarla a sangue! Gente che ti tira fiori e viene in pellegrinaggio da te dopo quasi mezzo millennio che sei putrefatto.” Arianna prese una lunga boccata d´aria .”Beato lui! Cosí amato, baciato dalla morte e non solo morso! …la morte…, forse ci sembra cosí mostruosa e inaccettabile – disse – solo perché non ci riesce di vederla se non attraverso il suo aspetto di distruzione e di limite ; ma se lei non ci fosse, con il suo togliere senso alla vita e tutto il resto, cosa ci sarebbe? Come si potrebbe vivere da immortali, che se ne farebbe di tutto quel tempo, in che termini scorrerebbe?”. Poi le venne da ridere. “E da tutti i grandi stronzi chi ci libererebbe? Nessuno! Invece no, perlomeno ogni settantina d’anni lei arriva e fa piazza pulita di tutti; e si ricomincia. Ci pensi che strazio sarebbe ritrovarsi a vivere tra banditi immortali? Non resterebbe nemmeno la speranza di poterli ammazzare. E che inferno diventerebbe per i giusti, gli onesti, le vittime… Ma per fortuna, grazie a lei, la grande democratica, gli stronzi vecchi devono far posto a quelli nuovi e nel ricambio possiamo tutti respirare il brivido della possibilità. Se la guardi così, allora anche la morte diventa un po’ più comprensibile o quantomeno più accettabile. In termini generali, voglio dire; in termini personali è molto più difficile, la propria morte é un affar serio, anche se poi, come si diceva una delle prime volte che ci siamo visti, ti ricordi? morire è la cosa più difficile al mondo, eppure alla fine la sappiamo fare tutti”. “Va bene, mi hai convinto, Che ci sia pure una fine! - lui rideva e intanto si dondolava all’indietro sulla sedia –“ però la malattia e la vecchiaia, quelle no, eh?”. Arianna scosse la testa. “Vedi come sei giovane – pensò – non ci pensi mica sul serio! Ci mediti sopra come fa un essere intelligente, però non ci pensi veramente, non sei arrivato ancora a averne paura, è una riflessione che ti attraversa la mente, ma all’anima non ci arriva. E’ giusto, è troppo presto per te”. Comunque, se c’era una cosa di cui non voleva parlare quella sera era proprio della morte, invece di nuovo si trovava a filosofare intorno a lei. Buttò giù le poche gocce di latte che ancora giacevano nel bicchiere imbrattato di schiuma, lo rimise con cura nel centro del piattino, guardò il viso asciutto di Gabriele su cui era bello leggere la cassa ossea e gli prese la mano, mano calda, fine e duttile, che si faceva muovere come lei voleva. La strinse nella sua scuotendola leggermente, come quando ci si congratula con un vincitore. “Ho una sorpresa… grande!”. Sorrideva, ma non aggiungeva altro. “Allora?” la incalzò incuriosito il veterinario. Arianna poggiò il mento sul palmo della mano, socchiuse gli occhi e lo guardò dalla loro lunga fessura. “Dal nove al dodici di gennaio, potremo prendere una vacanza tutta per noi; mio marito andrà a un convegno, lontano, in mezzo all’Europa. Per tre giorni sarò l’unica padrona della mia vita. Vuoi partecipare alla mia libertà?”. Lui non se l’aspettava, rispose alla stretta della sua mano fino quasi a farle male. Se ne accorse, se ne scusò, le chiuse le ginocchia tra le sue, ordinò alla cameriera che passava due bicchieri di spumante. “Accidenti!” disse. “Aspetta, però, ti devo dare delle istruzioni per l’uso già da ora; ci sono delle limitazioni. Ti devo dire come dovremo vedere questa fuga, perché di fuga si tratta, perlomeno per me. Ascolta, Gabriele, sarà una parentesi, una parentesi chiusa prima ancora che cominci, la dobbiamo vedere come qualcosa di passato, trascorso, finito. Mi capisci? Tutto quello che mi permetterò di dire, di fare, di accogliere in quei giorni, sarà genuino, sì, ma anche già morto, qualcosa che nascerà e finirà lí. Questa vacanza non è un precedente, è una prima e ultima volta, te la dovrai ricordare e dimenticare per sempre, sarà una specie di sonno pomeridiano dove al risveglio quasi niente dovrà essere diverso da prima”. Le scappavano dei “quasi” anche se non li voleva pronunciare, anche se si impegna a mantenere avvertimenti e promesse allineati sul filo d’acciaio di dichiarazioni assolute; diceva in cento modi la stessa cosa, insisteva ossessiva su quell’unico concetto. Gabriele la guardava e intanto si lasciava scivolare tra il pollice e l’indice ciocche dei suoi capelli. Li accompagnava fino alla punta e li lasciava ricadere, lisci e pesanti, sulla lana del golf. Arianna non si voleva zittire: “Ecco, apriremo una parentesi e lì dentro ci metteremo tutto quello che ci piacerà, e quanto ci piacerà. Lasceremo fuori lo stato anagrafico, le storie che ci hanno fatto, i precedenti, le cause, gli effetti, e all’interno di questo vuoto faremo valere altre regole; cioè: nessuna regola, tireremo su un recinto di libertà. Ti piacerebbe? Poi mureremo tutto vivo dentro e non ci torneremo più su, se non coi fili della memoria… come sarà bello, bellissimo… amarti in libertà, senza l’orologio che batte nelle orecchie, davanti a noi il giorno e la notte interi, averti una volta tutto per me, … fosse vero ! Io sì che saprei tenerti caldo, io sì che ti amerei … non ci sarebbe poeta, né ricco, né uomo potente che non invidierebbe il tuo letto, nessuno che non vorrebbe comprare il tuo posto, o meglio ancora rubartelo!”. Lo guardava come se invece che seduta sulla sedia legnosa di un caffé, si trovasse distesa tra i pizzi di una morbida alcova; gli si insinuava addosso col calore assiduo di una chioccia premurosa e le promesse scintillanti di una gran cortigiana. Gabriele si sentiva allo stesso tempo un bambino coccolato e un potente e irresistibile seduttore . L’aria intorno a loro si era surriscaldata e esalava già l’aroma frizzante dell’avventura. Arianna faceva volentieri finta di non sentirne lo spiffero pungente, ma attraverso la porta stretta di quella breve vacanza, dell’isola circoscritta che stava mettendo in piedi e nella cui ombra protettiva cercava di nascondersi, attraverso quella piccola porta, come ben sapeva, sarebbe potuto passare l’oceano. Forse l’atmosfera tutta intorno al loro tavolo trasudava qualcosa di infatuato e fortemente passionale. La cameriera, una ragazza carina, con neri capelli a caschetto, esile, giovanissima, ebbe un attimo di esitazione avvicinandosi coi bicchieri. Si fermò titubante e chiese: “Scusate, era per voi lo champagne?”. Lo depositò alla svelta, con gli occhi bassi e il sorriso rivolto alla tovaglia e al pavimento, poi andò dritta a rifugiarsi dietro le larghe mura di legno del suo bancone. Capitolo XIV Per Arianna c´era ora bisogno di una tana, di un rifugio, un posto caldo pronto ad accogliere una fuga di tre interi giorni. Il convegno era ormai alle porte, trovare qualcosa non era facile: la sua casa al mare era incastrata in un posto pieno di persone che la conoscevano, l’idea di finire in albergo le ripugnava e l’appartamento dove viveva Gabriele era reso impraticabile dall’amico con cui lo divideva. Bisognava cercare in giri più lontani. Come un segugio nel sottobosco, Arianna ispezionava con cura ogni eventuale possibilità; doveva essere un posto libero, gradevole, sicuro. Scartando via via le false piste, presto abbassò il naso su quella giusta: Claudia. Non si vedevano spesso durante l’anno: qualche telefonata, una visita intorno a Natale, i compleanni. Poi però veniva l’estate, il mare, la vicinanza geografica; allora i contatti si rinsaldavano, i fili interrotti si ricucivano e si gioiva a riprendere senza sforzo rapporti collaudati, solidi e ricchi di affetto profondo. Come negli amori veri, al primo contatto le distanze si cancellavano e la familiarità di sempre tornava a circolare come se mai fosse stata interrotta. Qualche anno prima Claudia l’aveva commossa aprendole davanti una raccolta di massime di uno scrittore del ‘600. “Leggi qui, non è bello? Mi sembra che riguardi anche noi”. C’erano un paio di righi sottolineati con la matita: “Le distanze non intaccano gli affetti – c’era scritto – spazzano via quelli deboli e confermano quelli forti, come il vento spegne le candele e alimenta gli incendi”. Arianna si ricordò con rinnovato piacere di quell’episodio. Ora che i suoi sentimenti erano in ebollizione, anche la consapevolezza del loro legame cresceva in intensità e apprezzamento. Quella che fino a allora era stata una valutazione razionale e posata sull’importanza di questa sua vecchia amica, si trasformava in una valenza calda, pulsante, nella gioia giovanile di avere qualcuno su cui appoggiarsi e confidare, qualcuno che sappiamo ci aiuterà. L’amicizia con Claudia risaliva al periodo breve e delicato tra l’infanzia e l’adolescenza: vicine di casa, vicine di età e in misura minore vicine di spirito, di tempo insieme ne avevano passato molto. Arianna si ricordava benissimo la casa di lei, in Maremma e soprattutto il suo giardino, se così si poteva chiamare il terreno sul retro che scendeva a terrazze fino all’oliveta. Nella parte più vicina all’abitazione, lungo la rete da polli che segnava il confine laterale, la madre di Claudia aveva piantato siepi di rose, di rosmarino, di lillà, cespugli di poco pregio, che non avevano bisogno di grandi cure, ma generosi nei loro frutti e profumi. Alla fine di marzo gli esili steli del Philadelphus si allungavano nell’aria tiepida carichi di luminosi fiori bianchi; era il loro odore, dolcissimo e penetrante, grato e sensuale che annunciava la fine dell’inverno, la dolcezza dei mesi caldi, le vacanze, i bagni, i vestiti da estate, leggeri e colorati. Nessuno ci aveva mai seminato l’erba, in quel giardino; ci cresceva quello che spuntava anche nei campi vicini: ranuncoli, trifoglio, margheritine, gramigna. A aprile e maggio, nel massimo del rigoglio vegetativo, il nonno ci veniva col falcetto e tagliava l’erba che si era fatta alta. Vestito con camice a quadri rossastri o turchini, il cappello di paglia calcato sulla fronte, chino sulla terra come da sempre tutti nella sua famiglia, il nonno falciava impietoso, con mano abile e sicura, ripulendo tutto fin negli angoli più lontani e nascosti. Se la lama incappava in un sasso, si metteva a bestemmiare, si fermava un attimo per guardare il danno e poi andava avanti. Con un sibilo breve e ovattato, gli alti steli si accasciavano ai suoi piedi in ciuffi compatti e ordinati; dietro di lui il giardino perdeva il suo aspetto selvatico, risorgeva, diventava uno spazio arioso e invitante. L’erba, ora corta e ben livellata, rendeva nitidi e accessibili anche i bordi della piccola vasca di cemento in cui d’estate, quando non andavano in spiaggia, le due ragazzine sguazzavano a ore intere. I pomeriggi erano lunghi, assolati, pieni di stridii di cicale e di caldo; i loro bikini casti, sobri, gonfi di piccoli seni in germoglio. “… Ma tu ci pensi mai a morire? O a quando moriranno i tuoi genitori?”. Le chiedeva Claudia. “Io? Sì, ci penso tanto, soprattutto la notte. Mi viene una paura… un groppo alla gola… devo accendere la luce e poi ci metto un monte a riaddormentarmi. E tu ci pensi?”. “Anch’io, tantissimo! Lo so che è naturale, ma mi sembra impossibile che un giorno non debba piú rivedere il mio babbo e la mia mamma”. Claudia si immergeva fino al collo nell’acqua e si guardava i piedi che strofinava nervosamente l’uno contro l’altro. “E bambini, tu ne vorresti avere?”, continuava. Arianna stava seduta sul bordo della vasca, flessa all’indietro, appoggiata sulle braccia magre; tirava fuori dall’acqua ora una ora l’altra caviglia guardando il sole splendere sulle tibie bagnate e l’acqua ricadere in fasce scintillanti dalle sue gambe abbronzate. “… Sì, certo, ma non ora. Quando sarò più grande, verso venticinque, ventisette anni; prima mi voglio divertire un po’… Tanto quando hai bambini non puoi fare più niente, chi ti aiuta? E poi bisogna anche partorirli… io ho paura, è dolorosissimo e ci si può anche morire!”. Dai capelli bagnati scendevano piccoli rivoli che le scorrevano veloci lungo le spalle e andavano a perdersi nella schiena e nelle pieghe vuote del reggiseno. “Però non è giusto – continuava – qualche volta potrebbero farli anche gli uomini i figli…”. “Già, e da dove li farebbero?”, ridacchiava Claudia dalla sua pozza. “Non lo so… gli potrebbero uscire da una palla…”. “Bell’idea, così verrebbero dei figli palluti… pallosi, coglionuti… coglioni!”. Ridevano e ridevano ancora, contro il cielo alto dell’estate; le sentivano ridere i passeri sul pino davanti a casa, e i rondoni che riempivano l’aria e i grossi olivi, in piedi da secoli sul pendio. Le sentivano ridere i declivi sotto il giardino e poi la pianura riarsa e il mare, il bel mare azzurro che lì non si mostrava infinito e minaccioso, ma anzi, modesto e tranquillo, si lasciava arginare docilmente dall’ismo fumante di Piombino e dalle coste rocciose dell’isola d’Elba. Anche dopo quegli anni, Claudia e Arianna non si erano mai molto allontanate, i fili cresciuti in quei pomeriggi d’estate si erano poi rinforzati attraverso quelli passati al chiuso, nelle loro camere, a chiaccherare e a ridere sedute sul letto, con accanto la musica a tutto volume e le sigarette nascoste dietro la libreria; insieme avevano ballato, detto bugie ai loro genitori, insieme avevano cercato di consolarsi per i fallimenti dei primi amori. Certo Arianna non avrebbe mai pensato che di lì a oltre vent’anni si sarebbe trovata a vivere inquietudini così simili a quelle di allora e che per di più avrebbe cercato aiuto e conforto nella sua amica. Le analogie finivano lì, però, le differenze di fondo si lasciavano cogliere e anche molto chiaramente: l’emotività prorompente di quegli anni, si fregiava dell’ignoranza, dell’inesperienza, della mancanza di punti di riferimento che l’aiutassero a scegliere, a moderarsi, a dirigersi, mentre l’affanno di ora si faceva sentire proprio perché gli istinti e i sentimenti contro i punti di riferimento, ci andavano a sbattere. Comunque ora era molto bello sapere che Claudia era ancora là e che l’avrebbe senz’altro ascoltata. Bastava chiamarla. Era tanto che ci pensava, ma non ne trovava mai il coraggio; alla fine si dette un ultimatum: o entro le dodici di oggi o mai più. Era quasi la fine della mattinata, la spesa era stata fatta, la casa pulita. Cercò di prendere ancora un po’ di tempo, andò da Giorgio, lo carezzò, lo sbaciucchiò, girellò un po’ per il soggiorno togliendo col dito la polvere da qualche cornice. Si sedè, si rialzò; poi agguantò tutta la sua volontà, tornò a sedersi e posò la mano sul telefono. Si raccolse, chiuse un attimo gli occhi, deglutì. Ripensò in un secondo a tutto quello che per giorni aveva soppesato: ai desideri, ai dubbi, agli scrupoli, ai rimorsi che affollavano le sue giornate. Erano già diverse settimane che vedeva Gabriele. Inghiottì il tutto in un solo boccone, come una medicina cattiva; riaprì gli occhi e compose il numero. La voce le uscì più disinvolta di quanto avrebbe sperato: … come stava qui, come stava là, se tutto andava bene… no, non si doveva preoccupare, non era successo niente di grave, solo avrebbe voluto parlare con una certa urgenza. “Poi ti spiego meglio a voce… domani pomeriggio è possibile? Bene domani sono da te”. Quando abbassò il ricevitore, era tutta sudata, ma ormai era fatta, lo scopo principale era stato raggiunto e non poteva più tornare indietro; la protezione del segreto totale era caduta aprendole però la via a un probabile alleato e in ogni caso d’ora in poi ci sarebbe stato qualcuno discreto e attento con cui poter parlare. Giorgio, disteso sul tappeto, sonnecchiava come sempre, sembrava non essersi accorto di nulla. Arianna lo guardò e si sentì a disagio davanti a lui, innocente. “E se capisse? E se intuisse qualcosa?”. Non ebbe il coraggio di andare a dargli una carezza, come faceva sempre quando si alzava. “ Perlomeno tu cerca di capirmi - gli disse da lontano - se anche tu mi rimproveri, allora…”. Il cane, sentendo che si parlava con lui, sollevò leggermente la testa e la guardò, ma visto che non si facevano preparativi né per mangiare né per uscire, lentamente la riappoggiò sul tappeto, cambiò appena posizione alle grosse zampe e riprese il suo felice ozio animale, libero da restrizioni morali, dubbi e passioni minacciose. Arianna continuava a domandarsi come avrebbe reagito la sua amica. Sulla sua discrezione poteva senz’altro contare, ma non altrettanto sulla sua comprensione, quella era un’altra cosa. Claudia era una donna rigorosa, la cui intelligenza posava su forti contrappesi morali; anche da giovane non aveva mai cercato l’imprevisto, tantomeno la trasgressione. Quando il suo ragazzo la lasciò dopo quattro anni di fidanzamento rimase stordita prima ancora che ferita: non si capacitava che un uomo facesse delle scelte d’amore per poi tirarsene indietro e cambiarle unilateralmente; più che malvagia, quella mossa le era sembrata immorale. Fu per lei dolorosissimo quanto inconcepibile, dovette ingoiare qualcosa di inaccettabile. Quella rottura ebbe l’impatto traumatico di un decesso, il vuoto diventò subito voragine: stati depressivi, abulie, paura di uscire da sola, di guidare la macchina; perse quasi dieci kili in un paio di mesi, smise di frequentare l’università, smise di leggere; non rideva, non piangeva. I suoi spesero capitali in psichiatri e terapeuti, ma tutti le scivolarono addosso come pioggerella sul tetto, lasciandola inerte e esposta come l’avevano trovata. Anche Arianna, che già non abitava più là, provò a aiutarla, scrivendole, andando a trovarla, invitandola da lei, ma ottenne solo tiepide reazioni che affondarono subito nella palude della sua inamovibile indifferenza. “Tutto cominciò a cambiare con quel minestrone, sai? – le raccontò Claudia quando, dopo oltre un anno, cominciò a star meglio – è vero, è ridicolo, eppure è andata proprio così”. Quella mattina stava bighellonando per la casa, come sempre. Come sempre non aveva voglia di far niente, di pensare a niente, quello che vedeva non le suggeriva niente, né la rimandava a niente… Con gesto meccanico aprì il frigorifero, gonfio di spesa appena fatta. Formaggi, carne, verdure. Sì, soprattutto verdure, tante, che si accalcavano negli scomparti più bassi e, stipate in spazi troppo piccoli, strabuzzavano dai cassetti trasparenti lasciando intravedere il premere di foglie di sedano e di riccioli di insalata. Quel pezzo di frigorifero appariva come un bosco, un caos vegetale, una giungla disordinata di gradazioni di verde contro cui spiccavano l’arancio delle carote, il rosso dei pomodori, il giallo caldo dei peperoni; dai cassetti si affacciavano toni cupi di cipolle rosse, di cavolo nero, di lucide melanzane color vinaccia. Claudia si sentì investire dalla prorompenza di quel raccolto lussureggiante, gonfio di odori accattivanti; avvertì la promessa dei loro sapori e se ne lasciò sedurre. Per la prima volta dopo tanto tempo, si sentì di desiderare qualcosa, una forza nuova si stava facendo largo dentro di lei, scalzando indifferenza, paure, sedimentazioni cupe; quella forza era come una piena che dilagava su un letto largo e asciutto, procedeva sovvertendo il terreno e sostituendosi a tutto quello che trovava sul suo cammino. Era il cielo da sempre grigio che si apre senza preavviso e sorprende la terra con squarci di azzurro in espansione. Era uno spiffero d’aria fresca e pulita puntato dritto su di lei. Claudia non avrebbe mai capito perché successe proprio allora e non prima, né dopo; quella rinascita tra capo e collo si sarebbe assestata presso di lei come un fenomeno incomprensibile, una guarigione in qualche modo vicina al prodigio. Con entrambi le mani vuotò il frigorifero e depose tutte le verdure in fila sul tavolo. Le guardò con commozione e amore. Fu il minestrone più lungo e emozionante mai fatto in quella casa: ogni elemento che tagliuzzava e gettava nel brodo, le faceva piacere; quasi carezzava i dadini di peperone mentre li lasciava scivolare nell’acqua; tagliava a fette sottilissime le foglie di spinaci e se ne sentiva fiera come se li avesse inventati lei. Un porro… stupendo! Che profumo fragrante! Ogni ortaggio che preparava le sembrava straordinario, le dava gioia, piacere tattile, olfattivo, interiore; selezionava i suoi ingredienti con entusiasmo, come stesse scegliendo pietre preziose per un gioiello, vestiti per un viaggio di nozze. Quel minestrone era il suo rientro, il ritrovato bisogno di esistere, il segnale verde di riconciliazione tra lei e la vita. Capitolo XV Per andare da Claudia c’erano un centinaio di kilometri, niente autostrade e molte curve a gomito che Giorgio odiava: non poteva dormire, veniva sballottato di qua e di là, ai tornanti più brutti doveva puntellarsi con le zampe anteriori se non voleva andare a sbattere col muso contro la portiera. Arianna lo sapeva e guidava pianissimo, esasperando gli automobilisti dietro di lei. Ma a qualunque velocità andasse, quel giorno pensava solo alla difficile confessione che l’aspettava; in versioni sempre diverse, ripeteva tra sé quello che avrebbe raccontato a Claudia, ma nessuna le sembrava mai abbastanza ben esposta e l’incognita di come lei avrebbe reagito rimaneva comunque totale. Concentrarsi sulla guida non le era facile; nemmeno il paesaggio, di solito amato e godutissimo, ce la faceva a spostare la sua attenzione: inutili i boschi di castagni nudi, inutili le buie foreste d’abeti e gli squarci aperti su pascoli vuoti e lontani. Nemmeno le bellissime montagne azzurre che chiudevano l’orizzonte, né le loro pendici piantate nella foschia, nemmeno loro sembravano abbastanza interessanti. Fu dimenticata persino la piccola chiesa romanica che sempre si soffermava a guardare e la cui spiritualità sobria l’aveva commossa la volta che erano andati a visitarla dall’interno. Ora i marmi bianchi e neri della facciata, i gradini scavati dai passi, i bassorilievi di tralci d’uva e leoni, la videro passare indifferente e spedita, uguale all’autobus di linea o al furgone del macellaio. Claudia l’aspettava con trepidazione: “Non ho quasi dormito stanotte, ero agitata per te”. Le disse aprendole la porta e dandole un bacio. La casa era una villetta ampia e anonima alla periferia della cittadina nel cui liceo insegnava scienze naturali; il marito gestiva l’unica scuola-guida del posto; lasciava che molti lo chiamassero “ingegnere”, ma in verità era solo perito meccanico. Che la moglie lo sapesse o no, in paese si diceva che fosse molto sensibile al fascino giovanile delle sue allieve. I loro figli, avuti molto tardi, facevano la prima e la quarta elementare. L’interno della casa era arredato senza audacia: niente kitch, niente design, alle pareti stampe antiche più o meno autentiche incorniciate di legno scuro, le ninfee di Monet comprate direttamente a Parigi e qualche marina livornese. Nell’ingresso un mobiletto vittoriano, nel soggiorno la grande libreria con venti anni di libri e davanti al caminetto divani rivestiti a grosse peonie rosa su fondo bianco. Il caffè fumava nelle tazzine, i biscotti preferiti di Arianna, infornati in tutta fretta la sera prima, si stendevano sul piattino d’argento sovrapposti ordinatamente uno accanto all’altro. Lo sguardo inquieto dell’amica si fissò su di lei e Arianna sputò subito il rospo. “Mi sono più o meno innamorata – le disse guardandola dritta negli occhi – e… vorrei chiederti le chiavi della tua casa di Marina. Sto essendo brutale, vero? Scusami, sono un po’ stravolta”. A questo era arrivata la sua scienza oratoria dopo giornate spese a comporre sottili preamboli e precisazioni. Tazza e piattino scesero dall’altezza della bocca di Claudia al piano di cristallo del tavolino. “Oddio, me lo sentivo!”. Strinse le labbra e voltò la testa verso la finestra dove proprio allora un motorino stava passando a marmitta stappata segnando col suo rumore violento il filo delle case. Seguirono lunghi secondi di silenzio intensissimo. Ecco, ora era proprio fatta. “Mettiti calma e raccontami tutto dall’inizio, fammi capire…”. Raccontare con calma era quello che Arianna più desiderava. Ci mise molto a riportare tutti o quasi i punti salienti, in compenso riuscì a dare un quadro chiarissimo, sia per il forte bisogno di alleggerirsi che aveva, sia perché si trovava di fronte qualcuno che la conosceva bene. Una volta buttato giù il grosso, poi si permise il lusso di indulgere nei dettagli e di parlare a ruota libera del suo giovane dio. “Mi dice delle cose stupende, sai? Mi stupisce, sa trovare delle parole.. ‘Il tuo petto racchiude il mio cuore…’ mi ha detto una volta prima di lasciarmi”. “Ma non è roba sua!” “Va bene, e allora? E’ bello lo stesso, non ti sembra? Mi fa così piacere sentire queste cose! Un giorno che gli dicevo com’è difficile per me questa storia, anche perché lui è ancora giovane e io sono vecchia, lui mi abbraccia per la vita e mi fa: ‘Sai che diceva Enrico II a Diana di Poitier?’ ‘Non avete mai avuto tante belle giornate in estate quante in autunno…’. Io lo ascolto mio malgrado e mi sento rinascere, quando mi parla in questo modo, tutti i miei problemi sembrano sparire. Poi, a casa, quando mi fui ripresa da quella citazione del re, andai a vedere sull’enciclopedia – io non conosco bene la storia francese – e ho letto che Diana di Poitier era già stata l’amante del padre di Enrico II, Francesco I, in qualche modo l’aveva ereditata insieme alla corona, ma nonostante fosse più vecchia di lui, l’ha amata fin quando è morto, anche se poteva avere tutte le più belle donne di Francia. Che storie singolari a volte racconta la storia!”. “Insomma – la provocava Claudia – è uno che rubacchia frasi da tutti”. “Sì, forse. Ma un ladro si giudica anche da quello che ruba: lui mi porta sempre tesori squisiti, ruba ai grandi ricchi e porta a me il bottino. E poi, non saprei se è proprio tutta roba rubata. Forse sarebbe esagerato dire che è un poeta, non credo ne abbia il genio, però… ne ha la sensibilità, questo sì; non è un poeta, ma gli somiglia. Se è vero che la poesia è un linguaggio che parla all’immaginazione, allora Gabriele alla mia ci parla di sicuro. Moltissimo. A volte con lui mi sembra di andare lontano e simultaneamente di entrare dentro l’essenza di qualcosa, voglio dire… vedere questo qualcosa da lontanissimo e allo stesso tempo sentirlo nella mia pelle. Mi segui? “Non proprio…” “Con lui mi sembra di capire di più, più in profondità, a volte sa trovare un paio di parole che messe insieme ne fanno risuonare altre mille, o centomila, riesce a farmi percepire degli interi, ecco sì, degli ‘interi’. Forse è solo suggestione, non lo so…”. “E a letto?”, tagliò corto Claudia con brutalità da inquisitore. Passarono secondi di silenzio. “Beh… - Arianna sorrise e guardò per terra, affondando la testa nelle spalle e stringendosi i gomiti nelle mani – come faccio a spiegarti… Ti devo premettere che non ci siamo incontrati spesso, non è facile mettere insieme tutte le condizioni. Sono stata qualche volta a casa sua, sì, ma non ci vive solo per cui mi ci sento a disagio, mi sembra sempre di essere spiata. Comunque, appena mi dimentico di essere lì, è il paradiso, è… come se lui fosse un uomo nato apposta per scopare”. “Bene! Perlomeno sarà un uomo con uno scopo nella vita!”, rise Claudia buttando la testa all’indietro e scoprendo le poche otturazioni che intaccavano la sua candida e regolarissima dentizione. Anche Arianna rise, però non voleva mollare l’argomento. “Davvero… ha una naturalezza quasi infantile, trascinante più ancora che seducente. Ti fa sentire come se tu fossi stata la sua amante da sempre, ti mette subito a tuo agio, tesse atmosfere speciali e raccolte intorno a te; ti invita… ti sa invitare e con una tale spontaneità che solo accogliere i suoi inviti diventa un grandissimo piacere. Tutto quello che ti offre ti sembra bello, essere docile con lui ti fa sentire libera non meno che amata, ti porta a volere quello che vuole lui come se fosse l’unica cosa che hai mai desiderato. Se ci penso bene, non mi riconosco tra le sue braccia, ma allo stesso tempo è come se quella, e solo quella, fossi io, al massimo di me”. Raccolse dal grembo la sciarpa di seta gialla con cui si era fino a allora trastullata, ne avvolse le estremità intorno alle mani e tirò la striscia di stoffa tendendola con forza, come fosse un pollo che vede il suo ultimo momento di luce. “Bello, desiderare un uomo così tanto! Beate le donne a cui è mai successo!”. Claudia tirò un sommesso, lungo respiro e la guardò con lo sguardo affettuoso e comprensivo di una vecchia nutrice. “E’ come se mi sapesse trasportare in un altro mondo che però è sempre stato il mio, - continuava Arianna – è difficile spiegare come fa, non lo so, è avvolgente e allo stesso tempo assertivo e poi… da lui ti puoi sempre aspettare una parola che ti accarezza. Anche là dove la maggior parte degli uomini si chiude nelle proprie sensazioni, lui non ti lascia mai sola, trova un gesto, un accenno, un mezzo per dirti che ti ama, per farti sentire che è lì con te”. “Il tuo piacere é il mio…” le aveva sussurrato nel tepore della sua camera. Ma quella frase Arianna non la riportò; chiunque l’avesse scritta, preferì non dividerla con nessuno... Poter parlare a qualcuno di Gabriele, era comunque un piacere che Arianna stava agguantando con tutta la forza di una prima volta. “E’ anche un uomo molto bello, sai? Ha occhi profondissimi, occhi che stanno proprio bene a un veterinario; ci trovi il colore dei felini, le luci del bosco… E poi ha una voce… una voce vellutata, musicale, un timbro dolce, suadente, a volte il solo ascoltarlo mi fa venire i brividi”. Cambiò posizione e accavallò una gamba; la sciarpa gialla, ora distesa nella sua lunghezza sul femore veniva meccanicamente lisciata, stirata, appiattita col palmo della mano fino a farla aderire come una calza alla forma della coscia. Parlare di Gabriele e stare ferma erano per Arianna due cose inconciliabili. “Sarà perché non lo vedo spesso o perché con lui mi esalto molto, ma ogni sua erezione mi sembra qualcosa di prodigioso, una meraviglia, un regalo grande; mi sento felice, commossa, orgogliosa come se quel meccanismo l’avessi inventato io e quello fosse l’unico prototipo. Il fatto che prenda piacere da me, proprio da me, mi pare un miracolo, la più grande delle fortune!”. Claudia sorrise, come quando un bambino piccolo dice innocentemente una cosa buffa. “Io non credevo esistessero uomini così, non l’ho letto in nessun libro, non l’ho visto in nessun film… è stupendo, per capire bisognerebbe che tu lo provassi”. “Grazie, potrei sempre decidere di sacrificarmi…”. Tutt´e due risero poi la stanza cadde di nuovo nel silenzio. Ci fu una pausa. “Ma allora con Marco come fai?”. Arianna girò la testa di lato, guardando nel niente, respiró a fondo e tornò agli occhi della sua amica. “Alzo di più il muro”. Lo sguardo davanti a lei rimaneva interrogativo. “Mi divido, mi schizzofrenizzo a livelli sempre più alti; faccio un enorme sforzo di distinzione, vivo in due posti, in due realtà”. “E ce la fai?”. “Per ora… scrollò le spalle – del resto non mi posso permettere troppi problemi: o semplifico o scoppio. Se voglio moltiplicare l’intensità della mia vita, e ti assicuro che lo sto facendo, mi devo dividere, non ho scelta”. “Sarebbe come dire che non vuoi rinunciare a niente”. “Credi che sia facile? Un uomo è il tuo passato e il tuo presente, l’altro il tuo presente e il tuo semi-futuro… Accidenti, questa parola ‘futuro’! Il mio passato continua a pulsare nel momento che sto vivendo, ma il momento che sto vivendo è anche infiltrato di promesse che ti invitano. Che dovrei fare… senza passato si vive male, ma ancora peggio senza futuro; e poi come si fa a rinunciare a un presente ricco, magari difficile da gestire, in nome di qualcosa che forse non esiste più o qualcosa che forse non esisterà mai? Rimarrebbe il niente”. Claudia pensò alle note stanche del suo matrimonio, ma non si fece spiazzare e subito si agganciò al pensiero dei suoi bambini, ai loro corpicini fragili, tutti da crescere e da proteggere. Si tranquillizzò e si permise un sentimento di commiserazione per la sua amica, oppressa da contraddizioni così laceranti. Ormai era tanto che stavano lì a parlare. Quel dialogo, le domande, le spiegazioni, le perplessità, le difese servirono a stendere un altro ponte tra loro, ma più di un vero ponte, si trattava di una passerella, fatta di funi e vecchie tavole. Claudia sapeva bene da dove aveva preso la rincorsa quel nuovo amore, ma più che capire la sua amica, la compativa e basta. Era costernata prospettando gli enormi problemi che ne sarebbero venuti fuori. “E il tuo rapporto con Marco nel suo insieme? E Chiara?” – insisteva. “Chiara è adulta, e non vedo cosa le tolgo se sono più felice e quanto a Marco… non crederai mica che lo voglia lasciare? Io ho un amante, non una crisi matrimoniale. Non potrei mai fare a meno di lui, delle nostre abitudini, delle nostre intese, conquistate con tanta fatica… io lo amo… molto, però con un altro spirito. Per ora sono due uomini distinti: con Marco parlo, vivo, faccio l’amore in un certo modo e con Gabriele in un altro, diverso, però sempre mio. Sono due amori complementari, ecco. Non è grave, vero?”. Claudia non rispose. Stava seduta in avanti, i gomiti sulle ginocchia, il viso tra le mani, si guardava pensosa la punta delle scarpe che ritmicamente batteva sul tappeto, provocando un suono ritmato, appena percettibile. Giorgio, disteso lì accanto, a quel battere aprì gli occhi, sollevò la testa per qualche secondo e poi la ributtò giù. “Insomma, te la sei andata proprio a cercare”. Le disse sollevando uno sguardo rassegnato. “Ho paura di sì… forse la passione è una piantina di serra che cresce solo se la si cura. Se all’inizio non l’alimenti, se la tieni fuori al ghiaccio, non ce la fa a sopravvivere. Io l’ho proprio coltivata; non è vero che è una fatalità, è una scelta. Come sono debole, però! L’età ci ha messo tanto a insegnarmi la prudenza e ora quel poco di gioventù che mi resta, in un soffio me la porta via. Purtroppo non sono una donna abile; se lo fossi saprei mediare tra audacia e prudenza e permettermi le gioie di tutte e due. Invece no, mi lascio schiacciare dalle loro forze in collusione e non riesco a mettere ordine in nessun posto. Di fatto, vado a caso, mi muovo d’istinto e i buoni consigli che a volte riesco a darmi, alla fine non pesano un grammo. Ho paura che non saprò gestire le storie difficili che mi permetto; sono proprio un’incapace, prima o poi combinerò dei casini…”. Tacque, si passò la sciarpa intorno al collo e prese a farla scorrere tirandola alternamente da un lato e dall’altro. “Oppure… oppure non devo decidere niente, tutta questa storia è un disegno del cielo e basta. Lui si chiama Gabriele, il nome di un arcangelo e gli arcangeli vengono mandati solo quando decisioni importanti sono state prese; prese da altri! Gli arcangeli chiudono paradisi, annunciano redentori, apocalissi… Che il mio Gabriele sia stato mandato per annunciare la fine del mio solido matrimonio?”. Si pentì subito della sua uscita, sia perché lei stessa non amava essere cinica, sia perché conosceva nella sua amica una radicata religiosità che non voleva certo ferire. “Anche Lucifero, se è per questo, era un arcangelo, anche lui prende decisioni e forse fa al caso tuo meglio degli altri”. La rimbeccò. Arianna sorrise e raccolse dal piattino un altro di quei buonissimi biscotti alla mandorla, fatti con amore apposta per lei; ne mordicchiò i bordi e il resto se lo lasciò sciogliere in bocca mentre si abbandonava sullo schienale del divano. Per un po’ nessuno disse niente. Filtrato dalle finestre chiuse, si sentiva un merlo fischiare sul diospero spoglio del giardino. Il silenzio continuava, denso e ruvido. Fu Arianna che riprese a parlare: “Vedi… è che io mi vieterei sì certe azioni, però ciò nonostante le desidero e quindi le immagino, le immagino e quindi, un po’ alla volta, ci credo. Come si fa, alla lunga, a vietarsi le cose in cui si crede?”. Ebbe un sussulto di energia, come quello di chi interseca all’improvviso una conferma solida delle proprie opinioni. Si sporse in avanti verso Claudia: “Ti ricordi gli ‘Stones’? Te li ricordi? Si sentivano sempre a casa mia, lo stesso LP, per ore e ore. Ti ricordi ‘Ruby Tuesday’: ‘… Loose your dreams and you will loose your mind…” – canticchiò bruciando i tempi musicali, ma guardando in viso la sua amica con occhi raggianti. “Ecco, vedi? Lo dicevano anche loro, è un meccanismo noto a tutti, qualcosa che è sempre esistito, i sogni vanno alimentati! Funziona anche con me perché è naturale”. “Sta pur sempre a te immaginare qualcosa o no, visto anche che sai dove porta. E’ una questione di scelta, di volontà; della tua”. Claudia, anche se coinvolta, stava a guardare la confusione nell’anima della sua amica come si guarda la finale di calcio di un’altra squadra: con partecipazione, ma lucida e senza coinvolgimenti. Se ne lasciava stupire, preoccupare, ma non propriamente toccare. Personalmente le sembrava inconcepibile che uno rischiasse di distruggere il raccolto di una vita intera solo per un’attrazione sopraggiunta, era convinta che si doveva poterlo evitare. Valutava con serena severità, si sentiva tranquilla, sapeva che a lei non sarebbe mai successo, lei l’avrebbe fatta subito abortire, l’avrebbe repressa una storia del genere, perché tra le due espressioni di saggezza tramandata “si finisce sempre con scegliere il proprio destino”, e “è sempre la vita che fa qualcosa di noi”, lei senz’altro aveva optato per la prima. Ma quanto a farlo capire a Arianna! Sapeva che per il momento non l’avrebbe smontata in nessun modo e poi, chi lo sa? Forse presto sarebbe passato tutto da sé. Per ora poteva solo aiutarla lasciandola parlare, e parlando chiarire a se stessa a che punto era e cosa si aspettava da quel pasticcio. Arianna, infatti, dopo tanto analizzare, spiegare, soppesare, pur non avendo le idee più chiare di prima, si sentiva più rilassata. Beneficiava della leggerezza che segue la confessione, anzi, si sentiva quasi protetta dalla donna che, praticamente costretta a assolverla, in qualche modo era diventata sua complice. Di questo sollievo le era profondamente grata. Si sporse in avanti e accarezzò la pancia di Giorgio disteso su un fianco ai suoi piedi. Tornò a appoggiarsi all’indietro, con la mano aperta percorse la tappezzeria a fiori del divano. “Che belle peonie! Sembrano proprio quelle del tuo giardino di quando eravamo bambine, te le ricordi?”. Claudia non si mosse, solo mentre le rispondeva, abbassò leggermente le palpebre: “Mamma mia, quanto tempo è passato! Il mio giardino sul mare… - disse – quando ci ripenso, quegli anni mi sembrano così lontani da non essere nemmeno mai stati i miei; non mi pare possibile di aver mai avuto dodici, sedici anni, quel periodo è tremendamente lontano, l’eco così flebile…”. “E’ vero, è così anche per me! Mi sembra strano di aver mai contenuto una ragazzina piccola, ignorante, incosciente, con la pelle liscia e gli occhi freschi. Anche per me i fili che mi legano a lei sono così lenti e lunghi che la sento come una specie di estranea… Che scherzi pesanti fa il tempo! Tu non te ne accorgi, ma lui cammina dietro di te e zitto zitto sgretola il sentiero alle tue spalle, così che anche l’andare indietro diventa difficile e persino il nostro stesso passato diventa qualcosa da difendere e riconquistare con fatica. E’ bello essere come noi, amiche dall’infanzia, è un privilegio, insieme si può ricostruire tanto di quello che siamo state, e non per nostalgia ma per autodifesa, per non lasciarci derubare”. Anche Claudia gioiva del fatto che l’argomento spinoso fosse stato accantonato e che si parlasse invece di cose che le riguardavano con la stessa intensità. Si era abbandonata sullo schienale, le mani rilassate in grembo e sulle labbra un´ espressione di assenso per le parole amarognole della sua compagna. “Ci pensi – continuò Arianna – se mai ci riuscirà di tenerci abbastanza stretto l´ordito della nostra storia e se mai ce la facciamo a diventare vecchie, ci pensi come sarà vertiginosa la prospettiva dietro di noi se ci voltiamo a guardarla? La nostra gioventù, forse anche la nostra maturità, che rotolano via lontano, che sfumano, che quasi smettono di appartenerci… dietro di noi una nebbia semi-abitata... e poi ancora oltre, quando moriremo e butteranno via le tracce della nostra esistenza, le nostre fotografie, persino quelle più care e importanti e così i libri, anche quelli che amavamo di piú.” Parlava giocherellando con la tazzina vuota che teneva tra le mani. Speró che perlomeno quelli non li avrebbero buttati. Si sollevò dai cuscini e riprese una posizione eretta. “Senti – continuò dopo una pausa – prima che diventiamo troppo vecchie e prima di morire, non ce l’avresti mica un bicchierino di cognac? Ora ci starebbe proprio bene!”. Anche a Claudia sembrò il momento giusto; si alzò e dal mobiletto sotto la televisione tirò fuori la bottiglia e due luminosi bicchierini di cristallo. Mentre lo versava, il suo colore ambrato ricordò a Arianna i riflessi di luce sui capelli di Gabriele la prima volta che lo aveva visto, in piedi accanto alla finestra; si accorse che a forza di parlare di lui e intorno a lui, a lui non aveva quasi mai pensato. Quando Claudia l’accompagnò alla porta, i lampioni della strada si erano già da tempo accesi. L’abbracciò forte e sospirò: “Ti telefonerò molto presto, non so che sperare… qualsiasi cosa ti vorrei augurare, mi sembra che vada in qualche modo contro di te”. “A volte sembra anche a me, chissà se me la caverò. Ma per ora grazie, grazie… e non solo per le chiavi”. Ricambiò l’abbraccio con una gratitudine speciale, qualcosa di nuovo che non le aveva mai espresso durante la loro lunga amicizia. In macchina posò il portachiavi di pelle sul cruscotto, là dove poteva vederlo sempre e durante il viaggio di ritorno raccontò a Giorgio che pisolava le bellezze della casa di Marina: la vista sul mare, il giardino con la palma, le tende di pizzo bianco, la sovracoperta di cotone damascato… Capitolo XVI Disse a suo marito che nei giorni in cui era a Monaco sarebbe andata con Giorgio alla loro casa sulla costa e che l’avrebbe comunque sempre trovata sul cellulare. Si sentì Giuda quando lo baciò all’aereoporto, ma le sembrava che il compenso per quel tradimento sarebbe stato così alto, che già di per se’ lo giustificava. Ciò nonostante l’ombra ingombrante di Marco non la mollava. Se ne liberó solo quando Gabriele l´abbracció e la bauliera inghiottì nel buio le loro valige. Solo allora,tutte insieme, in un unico flash, si accesero le luci abbaglianti dell’avventura. La strada verso il mare li accoglie vestita a festa; l’aria fredda e pulita di gennaio avvolge la campagna, la natura si offre immobile e nitida nella sua semplicità invernale. Toni di bruno sempre diversi compongono il paesaggio: i rettangoli dei campi arati, l’ocra variegato delle facciate in pietra, le distese di vigne spoglie, i boschi neri di faggi nudi e rugginosi di foglie di quercia. Il sole basso accende i volumi sulle chiome dei cipressi e estende a dismisura le loro ombre trasformandole in lunghe strisce scure appoggiate ai declivi dei campi. Il Chianti si esaurisce lentamente alle loro spalle, spariscono le colline, i loggiati semplici e eleganti delle case coloniche, i piccoli borghi a sasso, i campi a terrazze intessuti di olivi. Appena passato Colle Val d’Elsa, già la Maremma comincia a farsi sentire: i promontori si fanno più aspri, le case più sparse, i boschi più estesi, la terra più rossa . Dopo ogni tratto montagnoso, ombroso e pieno di curve, seguono vallate lunghe e ariose, che si sollevano gradualmente ai lati attraverso distese di terra rossiccia graffiata di fresco dagli aratri dei trattori. I rapporti tra spazi, colture e colori sembrano il prodotto di raffinate regie, compongono un tutto armonico grazie a cui l’ampiezza del paesaggio si fa leggere intera e senza sforzo. Capita che Gabriele e Arianna non incontrino macchine in senso opposto per kilometri e kilometri; allora é come se i campi, l’asfalto e l’aria appartenessero solo a loro. Quella, per Arianna, è una strada amata, fatta centinaia di volte senza annoiarsi mai, è la strada che la riporta nei paesi suoi. Racconta volentieri quello che sa sui posti che via via incontrano; Gabriele trova tutto interessante, ascolta, si stupisce, commenta, nell’abitacolo della macchina c’è poco posto per i silenzi. Scendono i tornanti di un´altra fila di monti, quelli più alti, di cui qualche tratto è stato appena disboscato. In alto, una poiana segna il cielo col suo volo lento e circolare. Dai balzi accanto alla via, fronde di querce si sporgono sopra la carreggiata, il sole invernale ne sfiora le foglie opache, seccherelle, bruciacchiate dal freddo delle notti, pronte a cadere per far posto a reticoli contorti di rami ruvidi, nodosi e scuri. La strada era lunga. Passarono altri larici e castagneti, altri pascoli e terrazze di olivi; poi la pianura che portava alla costa finalmente si aprì davanti a loro, larga e sgombra.”Eccolo, il mare!” disse Gabriele tutto gasato quando vide in lontananza il rigo blu apparire dietro una leggera salita. Sembrava un bambino che non l’aveva visto dalle vacanze dell’anno prima; durante il viaggio era stato più che allegro, l’aveva carezzata, sbaciucchiata, le aveva detto che la trovava irresistibile al volante. “… Sei la più bella maremmana che mi sia mai capitata, e guarda che ne vedo tante!”. Arianna lo ascoltava lusingata, ma anche se non ci fosse stato lui accanto, quell’ultimo tratto sarebbe stato per lei in ogni caso una fonte di particolare piacere: arrivata lì, si sentiva come il cavallo che ha annusato la stalla: nata in un posto di mare, il mare se lo portava fin dentro le ossa. Sul bivio che immette sulla litoranea, un uccellino morto segnava con una macchia grumosa il mezzo della strada; era stato schiacciato da tempo, ora giaceva quasi spalmato sull’asfalto grigio. Esili piume nere si dondolavano pigramente nell’aria smossa, salutando malinconiche le ruote che gli strisciavano accanto; lei fece finta di non vederlo così da dimenticarlo ancora più presto. La macchina filava tra cespugli di oleandri e distese arate di terra rossa e sabbiosa. “Qui gioco in casa, sta a me portarti in posti che ti piaceranno senz’altro, vedrai!”. Imboccarono una piccola pista laterale, sconnessa e molto stretta. Su un lato campi vuoti, punteggiati di vecchi girasoli risecchiti e neri, sull’altro un paio di piccole case coloniche circondate da recinti che si inoltravano fin dentro il bosco retrostante. Arianna ci puntò insistentemente lo sguardo cercando di non farsene accorgere. Quando scesero, il mare distava solo un sentiero di canne, una barriera breve che lo nascondeva alla vista e ne copriva il rumore, ma già ne lasciava filtrare l’aroma e l’invito. La macchina che stavano per chiudere, era l’unico pezzo estraneo a quel mondo, tutto il resto parlava prepotentemente di mare: mare la luminosità dell’aria, l’odore vago di salmastro, la pianura vasta che lo annunciava. Giorgio scese d’un balzo e si mise subito a trotterellare, annusare, spiscettare dappertutto; quel posto lo conosceva bene e senza aspettare che gli fosse indicato, imboccò per primo il viottolo di canne che portava alla spiaggia. “Speriamo che ci siano, speriamo, speriamo!” disse Arianna coi pugni chiusi e la testa nelle spalle come quando si fa uno scongiuro. Non volle dare altre spiegazioni. “E’ una sorpresa, te lo dirò solo se oggi non ci saranno”. Quando il mare finalmente apparve, largo e potente davanti a loro, rimasero qualche minuto in silenzio a guardare l’acqua, un piccolo omaggio al grande signore che respirava calmo a un passo da loro. Si abbracciarono come si abbracciano due amanti, ma anche come due prigionieri che sono riusciti a evadere dopo aver fatto insieme un lungo percorso pieno di insidie. “In che bel posto mi hai portato...!”. Giorgio invece, come sempre quando entrava nello spazio aperto della spiaggia, si era messo a correre all’impazzata disegnando larghi cerchi di impronte che andavano dal bagnasciuga all’inizio della boscaglia; alzando alti spruzzi di sabbia nell’aria, faceva una brusca frenata, si fermava un paio di secondi con le spalle abbassate e le zampe anteriori tese in avanti, poi ripartiva e faceva la stessa scavallata in senso opposto. Era sempre così, la gioia per la ritrovata libertà diventava per lui incontenibile. Il mare per il resto non gli piaceva tanto e ancora meno quando faceva caldo e c’era poca ombra. Di nuotare non se ne parlava mai: quando l’acqua gli sfiorava lo stomaco, era già l’ora di tornare indietro. Immerso fino a mezza zampa, provava a bere un po’, ma l’acqua salata non gli piaceva allora ci riprovava un po’ più in la’, dove sperava fosse migliore. Poi si arrendeva e tornava sotto l’ombrellone a ansimare e soffrire la calura. Negli ultimi anni d’estate non ce lo portavano più, ma nelle altre stagioni andare sulla spiaggia era per lui una vera festa; lo spazio, le lunghe passeggiate, le bottiglie di plastica gonfie e leggere, morbide da addentare, tutto gli piaceva moltissimo; d’inverno Giorgio e il mare diventavano grandi amici. Il pezzo di litorale che Gabriele e Arianna percorsero camminando per mano sulla sabbia umida non sembrò loro molto lungo, di cose da dirsi ce n’erano tante, ma quando si voltarono indietro, il posto da cui erano partiti aveva viaggiato molto, era andato indietro, indietro, fino a trasformarsi in un piccolo punto sfocato, vago e lontanissimo. Si fermarono dove la spiaggia finiva, arginata da un’aspra alzata di scogli appuntiti che proseguivano per un lungo tratto dentro l’acqua. Alle loro spalle, oltre la sabbia, cresceva un bosco recintato di pini marittimi, stentati e ingrigiti dalla salsedine. Era lì che Arianna insistentemente gettava lo sguardo, come se ci cercasse qualcosa. Si stesero sulla spiaggia, intorno non c’era nessuno, nessuno a perdita d’occhio. Gabriele era raggiante, l’abbracciò, la strinse a sé, prese a coprirla di baci, a dirle che col salmastro la sua pelle diventava commestibile, ma lei si schermì. Nonostante il litorale vuoto, non si sentiva a suo agio lì, adultera, in un posto che d’estate è noto per i nudisti e per i relativi guardoni sempre in agguato sulla collina sovrastante, armati di binocoli e teleobbiettivi. Arginare le avances di lui, le sembrò un lusso che meritava di non essere dimenticato; se l’era sentito scivolare addosso leggero e naturale, appena lo respinse ne sentì fisicamente la mancanza. Lui da parte sua non ne soffrì più di tanto, si sentiva contentissimo ed erano solo le undici. Steso supino sulla sabbia fine, il sole tiepido sui vestiti scuri, già si stava abbandonando a un dolce torpore, ma Arianna lo svegliò passandogli un braccio intorno ai fianchi. Era eccitatissima e non toglieva gli occhi dalla boscaglia. Giorgio si era alzato in piedi e puntava anche lui da quella parte. “Eccole, sono arrivate!” gli disse sottovoce. “Guarda, guarda là”. Gabriele sollevò il viso e dapprima non vide niente; poi, acuendo lo sguardo, si accorse di qualcosa che frusciava tra il fogliame in uno, due, tre, quattro posti diversi. Drizzò il collo, si appoggiò sui gomiti, si scansò i capelli che il vento continuava a spargergli sugli occhi e sorrise, stupito e incredulo. “I Macroceri grigi…!”. “Vieni, andiamo più vicino; se ci muoviamo piano non scappano, sono abituati a vedere gente e qui ci vengono spesso, meno che d’estate, quando c’è troppa confusione. Appartengono alla fattoria che abbiamo visto venendo qua, li tengono liberi su uno spazio di decine di ettari, tutto l’anno. Vieni!”. Giorgio stava a guardarli a orecchi tesi, allarmato abbastanza da non fare un passo; li aveva visti altre volte, ma questo non lo tranquillizzava più di tanto. Solo quando la sua padrona si avvicinò di più alla recinzione, la seguì, ma sempre titubante e col pelo ritto sulla schiena. Gradualmente, come quando si mette a fuoco un obbiettivo, dal sottobosco fitto cominciarono a emergere grandi forme grige che si muovevano per la macchia con passo dondolante e lento, così silenziose che bisognava drizzare le orecchie per sentirle avanzare. Le corna possenti, larghe, appuntite e ricurve, le giogaie pesanti come in una pittura rupestre, eleganti nel loro manto che dal grigio chiaro sfumava in un nero intenso sul muso, sulla spina dorsale e sulla punta delle zampe, un branco di mucche maremmane pascolava nella boscaglia, lì, a un passo dal loro mare di sempre. Stavano raggruppate entro un piccolo raggio, così che il bosco stesso sembrava crepitare tutto della loro presenza, discreta nei colori come nei suoni. Con lenta delicatezza allungavano il collo e con la lingua biancastra afferravano sottili foglioline o steli di parassiti rampicanti sui tronchi. Nemmeno il grosso toro, maestoso, scuro, tarchiato, coi suoi grandi testicoli rosa penzolanti, nemmeno lui faceva rumore quando si spostava flemmatico per brucare un’altra pianta o per annusare la coda di una giovenca. Di tanto in tanto, si distingueva appena il suono sommesso di qualche rametto secco calpestato contro il terreno sabbioso. Ma le corna non si impigliavano nei rami, i cespuglini di mirto e di acanto non venivano schiacciati dai loro zoccoli, sembrava che il bosco fosse fatto a misura di quei grossi bovini e viceversa. Con movimenti cauti e misurati, Gabriele si accostò alla recinzione, appoggiò le mani su due intervalli lisci di filo spinato e si sporse in avanti così da godersi lo spettacolo senza ostacoli visivi. Arianna gli stava accanto vicinissima e Giorgio appiccicato a lei. “Non le avevo mai viste brade… bellissime! – disse a bassa voce, come in una chiesa – vengono dagli altopiani dell’Asia. Si chiamano anche Macroceri dell’Ucraina, perché anche là ci vivono da secoli grosse mandrie. Pare che siano arrivati in Italia al seguito dei Longobardi e che poi dalla Pianura Padana si siano adattate a altre zone simili, tipo la Maremma e l’Agro Pontino. Sono sopravvissute perché tremendamente forti! Ancora fino a pochi decenni fa, d’estate si indebolivano molto per la siccità, anche quelle semibrade; nessuno dava loro da mangiare e da bere, un proprietario al massimo le sospingeva in un certo territorio e lì poi dovevano cavarsela da sole. Eppure ce l’hanno sempre fatta”. Gabriele le guardava con affetto e ammirazione “Che belle bestie! Vedi il toro? E’ ancora giovanino anche se attivo, ma quando sarà completamente adulto peserà oltre dodici quintali”. “Come sono ignorante! – disse Arianna – io ho sempre creduto che stessero in Maremma dalla preistoria, che si fossero evolute qui. Certo che a vedere come sono lente… quanto ci avranno messo dagli altopiani dell’Asia fino a qui?”. Il veterinario sorrise: “Il tempo di una migrazione… allora non c’era mica tanta fretta, ‘con un po’ di pazienza, il tempo avrebbe vinto lo spazio…’, così la pensavano. Comunque ora ti sembrano particolarmente lente perché stanno mangiando, altrimenti si muovono alla velocità di tutte le altre mucche, all’occorrenza sanno anche correre”. Il branco non pareva affatto disturbato dalla presenza di esseri umani; una giumenta si era soffermata davanti a un pino, vicinissima a loro e con un movimento verticale ritmato si strusciava la fronte contro il tronco ruvido e sottile. Gli aghi in cima ai rami tremavano con un leggerissimo fruscio. “Il Microsporum Cornua Bovi se lo prendevano proprio a fare così”. “Che cosa?”. “Era una malattia, la chiamavano anche Tarlo del Corno, un fungo, probabilmente presente sulla scorza degli alberi, che attaccava lo strato spugnoso delle corna, di solito uno solo, fino a renderlo cosí cavo che si rompeva in poche settimane a una ventina di centimetri dalla base, come fosse di cartone...Lo prendevano quasi sempre gli esemplari giovani, in primavera e in autunno, quando l´aria piú umida favoriva le proliferazioni micotiche. Però non era una malattia seria, tantomeno letale; ci vuol ben altro per aver la meglio su una maremmana – disse guardandola di traverso – queste bestie sono una razzaccia!”. “Accipicchia quante cose sai!”, la sua ammirazione per il dottore era in quel momento altissima. Lui continuava a osservare i Macroceri tenendosi aggrappato al filo della recinzione; teneva le palpebre un po’ abbassate, sia per il sole, sia per il piacere di parlarle sottovoce, nella complicità creata da una circostanza bella e eccezionale. Senza muoversi girò il viso verso di lei cercandone lo sguardo: “… Se so tante cose? Questo è niente, ne so tante altre. Un giorno te le racconterò tutte e tu dovrai stare lì ad ascoltarle fino all’ultima. E quando avrò finito, me ne inventerò delle altre e tu non saprai mai che me le ero inventate perché le renderò credibili”. Arianna sospirò e tornò a guardare verso il bosco: “Pensiamo solo a quelle che mi racconti oggi” gli rispose mentre andava a incunearsi di spalle dentro l’arco che lui formava tra la sabbia e il filo spinato.”Mi sento cosí bene insieme a te! Mi piaci tantissimo...e uno dei motivi é proprio questo...che tu mi insegni! Da te imparo sempre qualcosa, di veterinaria, di musica, di tutto! E non mi insegni con lo spirito arido dell`erudito, ma con naturalezza, con generositá, come un vero maestro.” Sentì le sue labbra sulla nuca, la mano sul seno. Socchiuse gli occhi e continuó. ”Non é che tu mi insegni perché io sono io, ma perché tu sei tu, é nella tua natura. Forse...tutte le persone intelligenti e belle d´animo insegnano, non se ne accorgono nemmeno, é che loro non ce la fanno a tenere tutto per sé, bisogna che arricchiscano anche gli altri. Come siete belli. E interessanti!” Seguirono il pigro spostarsi della mandria verso un altro angolo di bosco, finchè non la videro immergersi tra i cespugli fitti e sparire, naturale e silenziosa come era arrivata. Sapevano di aver vissuto dei momenti rari; la realtà aveva sfiorato l’idillio: da un lato la superficie vuota del mare, davanti la spiaggia larga e deserta, dall’altro una foresta abitata da animali bellissimi, antichi e mansueti. In quel momento e in quel posto, la natura si era mostrata integra, innocente e amabile, era riuscita a dare di sé un quadro falso, quanto credibile e dolce. Tutto, come nell’età dell’oro, lì sembrava essere piacevole e al proprio posto. Sulla spiaggia camminavano un uomo e una donna seguiti da un cane. Anche guardando loro si sarebbe detto che ogni cosa era piacevole e al proprio posto. Capitolo XVII Ritornarono al punto da cui erano partiti, la fame cominciava a farsi sentire. Arianna, conoscendo bene questo tipo di passeggiate, aveva messo nello zaino lattine e panini, oltre al cibo e l’acqua per Giorgio. Andarono sull’altra estremità della spiaggia dove lei conosceva un angolo particolarmente riparato e raccolto; per arrivarci c’era da attraversare un tratto asciutto ma scoglioso su cui il cane ancora più di loro aveva difficoltà a camminare, ma oltre quella barriera, li aspettava un altro paradiso, una piccola baia molto chiusa arginata da alti puntoni di roccia che nascondevano alla vista una lunga fetta di orizzonte; lì non soffiava nemmeno un alito di vento. Il pranzo frugale fu graditissimo, così come il dolce intorpidimento che gradualmente li avvolse; addormentarsi insieme sulla spiaggia fu un lusso che apprezzarono molto. Quando si risvegliarono l’aria era diventata più nebbiosa e il sole si era visibilmente abbassato. Non lo sapevano, ma il primo pensiero fu lo stesso per tutti e due: non c’era fretta… pensiero affabile, tranquillizzante e nuovo, tutto da gustare. Lei si alzò a sedere e si scosse con la mano la sabbia dai vestiti; guardò il mare e disse. “Da qui è passato Garibaldi, sai?” “No…! anche da qui?”. Gabriele, ancora dormicchiante, si distese più comodamente, la testa sul grembo di lei, i gomiti sulla sabbia, le mani incrociate sul petto, gli occhi semi-aperti sull’aria azzurra, frastagliata dai verdi cupi delle cime dei lecci. Aveva sorriso sentendo nominare Garibaldi; tutte le cose che sapeva su di lui, poche e confuse, gli tornarono in mente, ma si trattava più che altro di folklore: se lo vide in piedi, col mantello svolazzante sulla nave verso Palermo; seduto sui sassi dell’Aspromonte, amareggiato e ferito; anziano, artritico, ma ancora in forze, in viaggio trionfale verso l’Inghilterra e là la gente, le donne lungo la strada, tutti a aspettare di vederlo passare, come fosse un Dio. Gabriele da bambino aveva raccolto delle figurine sulla sua vita; si era divertito, ma gli erano servite a poco: si ricordava solo di una, quella in cui il futuro generale, si gettava nel mare in tempesta di Nizza per salvare un compagno che stava per annegare. “Eroi si nasce…”, si disse, ma lo spessore dell’ironia era così sottile che subito si frantumò contro l’ondata dei pensieri successivi: Garibaldi, lui, il guerrigliero, il generale, il mito, l’ideale splendente di tante generazioni; Garibaldi, macchia rossa e lontanissima nella mente di tutti. “Cosa avrà pensato e sentito quell’uomo in tanti momenti della sua esistenza? – si domandò – e che sapore avrà la vita di uno che si ritrova tra le mani allo stesso tempo il potere e l’ideale, un capo carismatico corteggiato da tutti e capace di non darsi a nessuno? Come si porrà con gli altri e con se stesso uno schivo delle dinamiche del potere, eppure l’uomo più pieno di potere personale di tutta un’epoca?”. “… Passò di qui quando era in fuga da Roma…” continuava Arianna. Gabriele lasció le sue riflessioni e si mise nella disposizione d’animo passiva e felice di chi sta per farsi raccontare qualcosa, sensazione rilassante e eccitante allo stesso tempo, come quando ci si siede sulla poltroncina di un cinema o si apre la prima pagina di un romanzo. Le palpebre abbassate gli lasciavano vedere la fine della spiaggia, la dolce curva cosparsa di rocce semiaffogate nell’acqua, il fianco ripido della collina sovrastante, i cespugli fitti e scuri che lassú si interrompevano improvvisamente per lasciare la roccia scendere in verticale e precipitare nuda verso la schiuma e gli spruzzi. “… Era ricercato dalle polizie di tutti gli stati, era quando doveva fuggire dopo la disfatta della Repubblica Romana; con pochi fedelissimi arrivò per mare fino a Ravenna; è da quelle parti che gli morì Anita, te la ricordi? Pare che fosse anche incinta…”. Certo che Gabriele se la ricordava l’Anita, l’altra figurina dell’album che ora gli tornava magicamente alla memoria: era una bellissima donna dai lunghi capelli neri che portava una camicia bianca scollata fin sulle spalle. Che stocco, l’Anita! Come dimenticarla? Se la rivedeva coi capelli sciolti, per niente incinta, la gonna azzurra ben stretta in vita e l’espressione ostinata, mentre avanzava nella palude di Comacchio, immersa nell’acqua fino al pube. Strano! Si ricordava anche questo dettaglio. “… Attraversò l’Appennino, passò nei dintorni di Firenze, da lì a Poggibonsi, a Colle Val d’Elsa e poi via verso il mare passando a piedi o a cavallo per la Maremma piena di boschi, sempre aiutato da staffette di patrioti. Quanti ce n’erano! E tutti rischiavano la vita; io non so se avrei avuto il coraggio, nemmeno per Garibaldi. Beh, insomma, arrivato vicino alla costa, entrarono in azione dei compagni di qui, i loro nomi sono rimasti famosi da queste parti, a loro sono state intestate delle strade, si trovano i loro ritratti sulla base del monumento al Generale, su a Scarlino; quando ci si va li vedrai anche tu; hanno tutti certe barbacce… non sembrano tanto diversi dai banditi che allora infestavano questi posti. Insomma, la notte lo nascosero in una casa in mezzo alla pianura, sulla strada, una casa padronale, grande e quadrata. C’è ancora la lapide sulla porta, è qui vicino anche quella, se si passa sull’Aurelia la si vede, è proprio lì, col cancello dell´aia aperto a un metro dall’asfalto. Pare che ci abbiano custodito gelosamente ogni traccia del suo passaggio, persino il resto del sigaro toscano che Garibaldi ci fumò, finchè, però, durante la guerra la casa fu occupata dai Tedeschi e il sigaro andò perso”. “Se lo saranno fumato loro di sicuro!”. Arianna, appoggiata sui gomiti, rise ma non volle mollare il filo della sua storia; la schiena reclinata all’indietro, continuò a raccontare mentre con lo sguardo percorreva la spiaggia bianca e il lungo filo opaco dell’orizzonte; dei gabbiani volavano alti in larghi cerchi silenziosi intorno ai puntoni di roccia, ma lei non li vedeva. “… Furono appunto questi quattro patrioti di Scarlino che attraverso i sentieri del bosco da dove siamo appena passati, accompagnarono Garibaldi fino a una caletta che si trova un po’ più a nord di questa; è una baia sassosa, un po’ chiusa e non molto bella, ma per attraccare non visti andava benissimo. Dovevano stare attenti perché lassù, sul crinale di questi promontori – Gabriele guardò da quella parte – c’era una serie di postazioni d’avvistamento, con sentinelle e tutto. Lì, in quella piccola baia, lo fecero salire sulla barca di un pescatore di Follonica, un tipo non proprio idealista, che si fece pagare per questo favore ma che dopo dovette di gran fretta scappare in Francia con tutta la famiglia per non essere preso, imprigionato e tutto il resto. Gli sarà dispiaciuto molto lasciare i suoi posti, credo… – Arianna socchiuse gli occhi – Chissà com’era bella Follonica a quei tempi! Ho visto delle vecchie foto… un nastro di case basse lungo un piccolo reticolo di strade bianche e polverose, case fatte a sasso, senza intonaco, i bambini in mezzo alla via, le donne sulla porta e l’aria di mare e il tepore che li senti anche sulla fotografia. Questo clima dolce, le palme, la Fonderia… alle spalle la palude, la malaria, i boschi pieni di banditi e davanti il Tirreno… Follonica era una specie di roccaforte senza mura. Fortuna inutile forse: chi vuoi che ci andasse lì nell’800? Nessuno, giusto i pastori in transumanza, quelli che venivano qui dal Pratomagno e dal Casentino, a piedi, senza donne, con le bestie… comunque, ti dicevo, questi quattro di Scarlino riuscirono a far imbarcare Garibaldi. Sembra che quando lo salutarono erano tutti molto commossi. Forse il Generale meno, forse lui era abituato, non si sa. Si sa che disse le parole che usava sempre quando si accomiatava dai patrioti”. Arianna si tirò un po’ più su con la schiena e cercò di imitare una voce baritonale. “Disse: ‘Addio, a tempi migliori!’ Bello, eh? Che coesione ideale con gli altri ci si intrasente! Chissà, forse avrà continuato a salutare così fino alla morte, a unità d’Italia avvenuta e sancita; non gliene saranno certo mancati i motivi…”. Gabriele non si mosse, ma stese la mano a cercarle il polso. Lei sentì insieme al calore della stretta anche il peso del messaggio: sentì l’affetto espresso sotto forma di rammarico perché nessuno di loro due stava già vivendo tempi migliori, anche quella era una fuga e di lì a poco si sarebbero separati per chissà quanto tempo. Fu un gesto che durò pochi secondi. Gabriele riappoggiò le mani sul petto, tirò su le ginocchia e se le guardò mentre le faceva vibrare leggermente una contro l’altra. “Così ora starei posando schiena, culo, piedi su un luogo storico che ha visto passare eroi nazionali…”. “No, non è qui, è appena un po’ più in là”. “Cosa vuoi che contino per la storia duecento metri più o meno, comunque… povero Garibaldi! Pensavo alla sua casa a Caprera: è vero che lì faceva un sacco di figli con giovani fantesche, però era pur sempre un ritiro. Di fatto ci è andato per morire”. Prese a roteare, lentamente i pollici delle mani che teneva giunte sul torace mentre rielaborava tra sé tutte queste cose. Passarono alcuni minuti di silenzio. “Sembra quasi che sia comune a chi è vissuto vicino alle idee, a chi si è più esposto, o a chi ha avuto una vita interiore più densa e delusioni più forti, il desiderio di morire in solitudine davanti al mare. Così è andata con Garibaldi, con la Yourcenar, col professor Aschenbach, con un personaggio di Shakespeare, … ora mi sfugge il nome… come si chiamava?” “Timone di Atene”, lo aiutò Arianna senza togliere lo sguardo dal mare. Gabriele, stupito, volse il viso verso di lei e il vento glielo invase di fini capelli color tiziano; la guardò con gioia e incredulità: “Straordinario! … Brava! Come fai a sapere queste cose?”. “Come vuoi che faccia? Come tutti – gli rispose stringendosi nelle spalle – le ho lette!”. “Allora, se leggi le stesse cose che leggo io, ci dobbiamo proprio sposare!”. Si girò verso di lei e prese a baciarla dappertutto, sullo strech dei jeans, sulla tela della giacca, sulla lana del golf, sul collo, sulle guance, sul mento. Questa volta Arianna si lasciò coprire dal suo corpo leggero che le scivolava sopra naturale e lieve come una serpe sulla sua erba. “Mi dispiace, non posso sposarti – gli diceva lei – sono già sposata!”. Socchiuse gli occhi e rise finchè un bacio non venne a tapparle la bocca. Finalmente in casa, la porta si chiude, si apre il tratto saliente dell’avventura. Il soggiorno, la cucina, la camera dei ragazzi; la camera grande, ordinata, silenziosa, semibuia. Il letto, grande, bianco, vuoto. Per la prima volta l’intimità di una casa intera tutta per loro. Arianna gliela mostra emozionata, ma anche impacciata. Giorgio li segue annusando dappertutto. La sua cuccia giace stesa nel soggiorno, le valigie aspettano accanto alla porta d’ingresso. Arianna scosta un poco le tende, dietro c’è il mare; una striscia di luce forte invade il pavimento di mattoni rossi, rischiara uno spigolo del cassettone, una gamba di poltroncina. Gabriele sta in piedi nel vano della porta. Fa qualche passo verso di lei che sta tornando dalla finestra in modo da intersecarla accanto alla testiera di ferro del letto. Il corpo delle donne che si amano è sottile nei punti giusti, facile a circondarsi con uno e poi con l’altro braccio. E’ morbido, elastico, le sue giunture si flettono docili dove è necessario. Il corpo degli uomini che si amano è tonico, flessuoso, invitante, caldo, aderisce al proprio come una carezza sulla guancia. Il letto è soffice, capiente, largo, quasi non lo si sente accogliere la schiena, la testa, il bacino, le gambe. Ecco, ora il mondo si immobilizza. Non ci si bacia nemmeno, si sta fermi, si respira, gli occhi sono chiusi, si percepisce solo attraverso la carne, le braccia, le mani. Si deglutisce, ci si stringe, non ci si crede eppure è vero, ogni centimetro di pelle dice che è vero. Il tempo di questi minuti non si fa prendere, eppure bisogna rincorrerlo, acchiapparlo, inchiodarlo, si dovrà poterselo ricordare, chiaro, preciso, così com’è ora perché si sa che passa questa volta sola. Aspetta ancora un momento, non ti muovere, amore mio, lasciami affogare dentro questo momento, che mi si incida addosso come una cicatrice, una cicatrice d’amore, che non va più via. Il silenzio si spezza all’improvviso, Giorgio abbaia alle loro spalle, non vuole che si faccia qualcosa alla sua padrona. Lei si scioglie dall’abbraccio, si alza, lo rassicura, lo accarezza, lo porta alla sua cuccia, gli dice di stare buono, rientra nella camera e chiude il resto del mondo alle sue spalle. E’ in piedi contro la porta, le mani dietro la schiena che ancora trattengono la maniglia, il sorriso aperto sulla penombra della stanza; a Gabriele non era mai sembrata così bella. Quella volta Arianna gli si sarebbe insinuata dappertutto, come acqua dentro nascosti anfratti di terra buia. Stretto intorno e dentro la donna, sentiva tutte le distanze annullarsi, il confine tra loro frantumarsi e lasciare il posto a una promisquità senza scalini, densa e imprendibile. Si accorsero tardi che il tempo era passato, lo diceva la luce fioca della finestra, i chiaroscuri imprecisi delle lenzuola. Il sonno era arrivato con la naturalezza di un caro amico annunciato, l’avevano fatto entrare, ospite gradito; ci erano scivolati dentro senza accorgersene, al seguito di sensazioni dilatate, attraversando ponti larghi lastricati di pietre dai contorni vaghi. Sulla spalla il respiro di Arianna, gli occhi suoi grandi, aperti su di lui come bagliori di mare di notte. Poi il suo sorriso e quelle parole tra carezza e puntura: “Come sei bravo! Chi ti ha insegnato?” gli chiese senza smettere di percorrere a piccoli baci la spalla, il costato, la pista tondeggiante delle sue ultime costole, prominenti e appena coperte dallo strato sottile di pelle bianca. Gabriele volse il viso di lato, cercando di nascondere nell’aria vuota accanto a sé un sorriso incontenibile, largo di soddisfazione e di giovanile imbarazzo. Ci pensò su prima di risponderle: “… Le donne, credo”. Disse alla fine. “Oh, loro…” Arianna aveva sollevato appena un po’ la testa e lo guardava seria. “Loro… Brave, bravissime! – il sorriso le si aprì – Sante! Pure! Benedette! E che fortuna per me trovarmi proprio qui tra le tue braccia!”. Gabriele si domandò per un momento se avesse fatto qualcosa di sbagliato, nessuna gli aveva mai detto cose del genere, dubitò di essere preso in giro, ma la sua amante, dolce e inarrestabile, continuava a stringersi a lui, a abbracciarlo e baciarlo dappertutto. Sentiva le sue labbra sull’estremità inferiore del torace dove le costole e lo sterno lasciano il posto a un leggero avvallamento su cui si posa una piccola ombra, tremendamente vicina al cuore. “E’ qui che ti toccavi stamattina, ci poggiavi il palmo aperto come per proteggerti… la tua bella mano… Te l’ho visto fare due volte, in macchina e in spiaggia, mi sembrava che affannavi. Ti faceva male?”. “Molto meno di quanto mi fa bene ora, bella dottoressa!”. “Non mi preoccupo mica per te, sai? Non credere. A me basta che tu duri questi tre giorni – e rideva – sono i nostri primi e ultimi liberi amori, lo sai, vero? Te lo ricordi, amico mio, tu, il più grande dei lussi, il piacere dei miei piaceri… come sei bello e bravo e amato e desiderato e cercato e sognato…”. Poi non disse più niente. Gabriele vide la massa bruna dei suoi capelli spargersi pesanti e lucidi sul suo petto, li vide strisciare compatti e lenti come grossi anfibi, scivolare via e debordare ricadendo in parte sul bianco dei lenzuolo, sempre più lontani; li sentiva carezzargli i fianchi, né freddi né caldi. Sollevò la testa, ma solo per lasciarla subito ricadere sul guanciale. Memoria, luoghi, luci, tempo si stanno sgranando, farsi prendere con amore è dolce e forte, una magia benefica, una spada di zucchero nel tenero della carne; lei lo passa attraverso, é un setaccio di velluto, morbido e caldo. Gli occhi di Gabriele si chiudono alla luce della camera e vanno a aprirsi su altre tonalità, più intense e più belle, pungenti di sale, vischiose di miele. La stanza sparisce, si dissolve come gocce sul fuoco, poi anche il mondo intero sparisce portando con sé tutto quello che non è lui; il respiro si mozza, sospeso tra la voragine e il cielo. Era tanto che non stava così bene. Capitolo XVIII Gabriele veniva dalla montagna, se montagna si può chiamare l’Appennino ToscoEmiliano. Di là quantomeno veniva suo padre, ufficiale medico nell’esercito, tenente quando nacque suo fratello Massimo, capitano quando otto anni dopo nacque lui. La casa in cui cominciò a vivere era quella della nonna paterna, era lei che aveva ereditato dal marito morto precocemente una certa agiatezza, composta da una grande casa a tre piani, terre a frumento a valle e ettari di castagneto in montagna. Gabriele se la ricordava vagamente la nonna, alta, magra, seria, devota, con una grande spilla ovale sul petto. Se la ricordava seduta accanto al fuoco che roteava il lungo manico di uno strumento strano, qualcosa di cilindrico con cui tostava le nocciole che a fine agosto cadevano dagli alberi dietro l’autorimessa. “Secondo me, la nonna era devota perché fino alla fine non era sicura che le fossero stati perdonati i suoi peccatucci…” – disse Gabriele a Arianna. “E quali sarebbero questi peccatucci se persino tu sai che ci sono?” “Beh – continuò abbassando il volume della voce fino a farlo diventare un bisbiglio – mio padre era il figlio del fidanzato di sua sorella, però dovette sposare lei perché era quella rimasta incinta. Sua sorella non glielo perdonò mai, alla nonna, mai!”. Arianna si mise a ridere: “Che tipo irrequieto la nonna! Però forse è solo colpa del tuo nonno, forse ce l’avete voi nel sangue di insidiare le donne che non dovreste toccare; è una questione ereditaria!”. “Forse di ereditario c’è che capita sempre a noi di farci insidiare da donne che non dovrebbero farsi toccare!”. “No, non è nemmeno per questo , è che voi siete una famiglia di uomini deboli! Deboli… e irresistibili!” Chiunque fosse il colpevole della sua devastante durezza, certo era che quella austera signora, bigotta, taciturna e avara di premure per Grabriele, passò attraverso la sua memoria leggera e incostintente come un sogno; nel fumo lontano della sua infanzia, quella nonna c’era sempre stata, quanto non c’era stata mai. Anche suo fratello fu irraggiungibile, non ce la fecero mai a incontrarsi: “grande” quando lui era bambino, lontano in collegio quando appena cominciava a scrivere.Suo fratello Massimo era un ragazzo e schivo ombroso, di soprannome tutti lo chiamavano “lo scuro”, nonostante i capelli da sempre molto più chiari dei suoi. Appena laureato in medicina, volle andare a esercitare in un posto in montagna ancora più isolato di quello dove avevano abitato loro; non si era sposato, ma viveva da molti anni con la lattaia del paese, una donna piccola e tonderella che aveva conosciuto grazie a un’appendicite. Massimo viveva anche con un cane, un pastore tedesco che si portava con sé dovunque andava; il cane lo accompagnava in macchina quando faceva il giro delle visite e si accucciava in un angolo dell’ambulatorio, tra la finestra e il lettino, quando riceveva lì i suoi pazienti. Si chiamava Pavel ed era l’ombra del suo padrone. Quando ebbe circa otto anni, cominciò a avere dei problemi seri al treno posteriore; fu quella la prima volta che Massimo andò a trovare suo fratello in città: gli chiese se su un cane della taglia del suo, si poteva praticare un’eutanasia servendosi delle stesse sostanze e dosaggi di un essere umano. Si informò dettagliatamente sulle terapie antireumatiche, sulle sintomatologie tumorali e poi ancora sugli indici di dolore provocati dai farmaci letali, sui preanestetici, su come agivano sulla lucidità del cane, sui dosaggi indicati per provocare un graduale sopore: “Quello che devo fare se mi voglio suicidare lo so bene, è che voglio essere sicuro, e dico sicuro, che con Pavel non farò nessun errore. Ho saputo che quello che di solito viene usato in veterinaria non garantisce che l’animale non soffra”. “E’ vero, anch’io non lo uso mai prima di aver iniettato barbiturici”. “Ecco, appunto, non mi perdonerei mai di aver tralasciato qualcosa, sono qui da te proprio perché non voglio correre nessun rischio, devo avere la certezza assoluta che non sentirà niente”. Era estate; i due fratelli stettero insieme un paio d’ore, seduti nel soggiorno davanti a una buona birra tedesca che Massimo lasciò quasi intatta nel bicchiere. Anche se nascosto sotto l’aspetto di una consulenza, quello fu il più lungo e profondo colloquio a quattr’occhi che Gabriele aveva mai avuto con lui; nemmeno in occasione del funerale del padre, si erano parlati altrettanto a lungo e con tanta intimità. Quando ripartì per la montagna, gli disse: “Addio, ti sono molto grato per il tuo aiuto, grazie!”. Gabriele sentì che ognuna di quelle parole, fino alla congiunzione e al pronome personale, aveva il peso della più totale compartecipazione, quel ringraziamento equivaleva a un patto di fratellanza dal cerimoniale breve ma dalle implicazioni pesanti e definitive. Il padre era morto tardi, troppo tardi. Ormai, per quanto riguardava i figli, avrebbe potuto campare altri cento anni, tutto quello che c’era da distruggere, era già stato da tempo distrutto. Non lo aveva certo arginato né compensato la madre, una donna obbediente fino all’idiozia, una specie di attendente a largo spettro di suo marito. Sopportava con pazienza i suo scatti d’ira, i suoi rimproveri ingiustificati, sottometteva tutto ai suoi desideri, o capricci, o prevaricazioni, essendo chiaro che la sua volontà in niente differiva da un ordine. Le obbiezioni che ogni tanto, esasperata, tirava fuori erano sempre deboli, imploranti e crollavano come case di carta alla prima offensiva. I figli, anche se in tempi e proporzioni diverse, impararono subito non solo come nella vita fossero soli e dovessero difendersi a spada tratta, ma anche quanto fosse benigna e onorevole l’arte della fuga. “Perché non hai fatto medicina anche te?” gli chiede Arianna. “Prima di tutto non avrei mai fatto qualcosa che mi accomunava a mio padre e poi sono nato in campagna, con gli animali ci sono cresciuto. Da bambini si andava nel campo dove pascolavano le mucche, Brune Alpine per l’esattezza, e ci si divertiva a schizzarci col loro latte mungendocelo addosso. E come si stava vicini alle bestie abbastanza da poter essere presi di sicuro! Oppure ce lo versavamo nel cavo della mano e lo si beveva, così, direttamente dalla mucca. Se avessi saputo allora quante malattie gravi si potevano prendere, che si rischiavano Tubercolosi, Brucellosi… aveva un fortissimo sapore d’erba, quel latte, ora mi farebbe schifo, ma allora piaceva a tutti, o si faceva finta che ci piacesse. Là gli animali erano dappertutto: si portavano manciate di erba fresca alle nidiate di conigli, si giocava tra i sacchi di mangime per i maiali. Dietro casa cominciava subito il bosco, a primavera poteva capitare di trovare un piccolo di ghiro, o di scoiattolo o uccellini di nido che quasi sempre morivano nella scatola da scarpe dove li si metteva, col piattino del latte accanto e la mollica di pane imbevuta. Una volta mi ricordo di aver incontrato persino un istrice; mi fece paura, era grande come noi… e brutto! E poi c’era il veterinario che ogni tanto veniva per qualche parto difficile. Era un uomo simpatico, che si perdeva anche con noi bambini. Gli allevatori che avevano le mucche lo tenevano in grande considerazione, lo chiamavano “Signor Dottore”, come mio padre. Quando il tempo era buono, arrivava con una stupenda moto fuoristrada, rossa e cromata e con dei pneumatici dentati larghissimi; diverse volte mi ci ha fatto fare un giro: salivamo su per il campo accanto a casa, io stavo dietro tutto aggrappato al suo giubbotto, ma da lì sporgevo la testa da un lato per vedere l’erba avanzare e sentire il vento sul viso. Mi piaceva tanto quella moto!”. La casa era un mondo, grande, indivisa, piena di passaggi, sgabuzzini, scalette, stanze inutilizzate piene di armadi, cassetti, oggetti strani e misteriosi che rendevano la loro esplorazione sempre sorprendente e fruttuosa. L’edificio di per sé era una costruzione quadrata di solido impianto ottocentesco, con grosse pietre angolari a vista sui lati della facciata. La separava dalla strada un piazzaletto a pietre in cui si erano ricavate delle aiuole con dentro oleandri rosa; sotto di loro crescevano giorgine, petunie, dalie. Sopra il portone si alzava una grata di ghisa a mezzaluna con al centro le lettere S e V, le iniziali del marito della nonna. Ai suoi lati si aprivano due finestre chiuse da inferriate sotto cui erano state murate due panchine di pietra serena che d’estate servivano da posto di ritrovo per stare a frescheggiare la sera. La rigida simmetria proseguiva altrettanto rigorosa ai piani superiori. L’architetto per il resto non si era permesso nessun peccato di fantasia, così che esternamente quella casa non differiva se non nelle dimensioni dall’ospedale militare in cui lavorava suo padre e da cui tornava, stanco e nervoso, solo il sabato pomeriggio per restare fino al lunedì mattina. Sul lato destro della facciata, arretrata rispetto alla casa di una dozzina di metri, si apriva un’enorme autorimessa buia, quasi tutta interrata nella collina, mentre dal lato sinistro si stendeva un grande giardino solatio, un’”hortus conclusus” la cui bellezza selvaggia e allo stesso tempo protettiva non si sarebbe mai fatta dimenticare. “Lo conoscevo tutto, pezzo per pezzo, aiuola per aiuola, conoscevo il percorso dei rami del fico, del melograno, del ciliegio; arrampicarcisi era come camminare per la strada di casa. Me lo ricordo in tutti i modi quel giardino: con le cicale che stridevano sul cipresso, coi grilli e le lucciole, coi martinacci che venivano fuori dopo la pioggia, con l’arancio forte dei diosperi quando tutto il resto già era colorato d’inverno, spoglio e risecchito; me lo ricordo con la neve… la gioia di affondarci i piedi dentro, nei vialetti e negli spiazzi dove non c’era ancora stato nessuno”. All’incrocio delle aiuole più grandi, quelle coi mughetti sul bordo e le siepi di bosso al centro, c’era una vasca rotonda limitata da una bassa spalletta di grossi sassi spugnosi. Tra il bordo e lo zampillo centrale nuotavano lenti grandi pesci rossi e dorati che i ragazzi cercavano di acchiappare con le mani, posando lo stomaco sui sassi meno appuntiti e sporgendosi tutti in avanti, le gamberelle diritte, i piedi puntati nel ghiaino bianco e crocchiante. Ma un altro sentiero d’acqua, e molto più inconsueto, attraversava il giardino; era lì che si era sfogata la creatività di quel povero architetto che aveva dovuto costruire il resto con moduli da caserma: grazie a notevoli lavori di sbanco, la casa era stata edificata contro il pendio della collina dalla quale, sul retro, emergeva solo per metà. Sul fianco sinistro, alcuni metri più in basso del muro di cinta del giardino, correva il torrente che poi andava a sfociare nel fiume sottostante. A monte il percorso di quel rio fu in parte deviato e una parte di quelle acque venne incanalata attraverso un sistema di tubi e attraversamenti sospesi, fino a essere portato dietro casa. Rasente al muro della casa stessa, abboccate a quei tubi, furono costruite due cisterne fuori-terra. Le coprivano grandi coperchi di legno traforato sotto i quali scorreva l’acqua che poi, convogliata sotto terra, fino alla strada, veniva reimmessa nel torrente. Se si alzavano i grandi portelli delle cisterne, in quel metro e mezzo di acqua corrente, sguazzavano ignare della loro sorte, lucide trote dalle schiene punteggiate d’azzurro mentre accanto, nella seconda vasca, strisciavano nere le anguille, con le loro schiene viscide e le bocche rosa, aperte su file di piccoli denti biancastri e aguzzi. Per Gabriele andare a vedere le anguille era il massimo della paura, della gioia, del ribrezzo. In mezzo al giardino, ombreggiata dai cipressi sul retro e da un ippocastano sul davanti, si alzava una piccola cappella neogotica con le volte a raggera dipinte di blu stellato. Dietro l’altare si aprivano due armadi a muro pieni di libri dalle costole dorate e altri oggetti misteriosi: lampade a olio, una canna col cappuccio di piombo per spegnere le candele, un cofanetto con l’incenso e finalmente qualcosa di chiaro e fruibile: una serie di campanelli di bronzo segnati ognuno con un numero e forniti di un bel manico di legno tornito. Dappertutto, anche quando d’estate il portone stava a lungo aperto, nella piccola chiesa si sentiva un forte odore misto di incenso e di muffa che richiedeva molto tempo per non essere più avvertito. Gabriele non lo sopportava; a volte tirava un lungo respiro e poi, con l’aria trattenuta, entrava di corsa a agguantare uno di quei campanelli che gli piacevano tanto e usciva altrettanto alla svelta senza mai riprendere fiato, solo per non respirare quell’odore. Ogni tanto ci veniva celebrata qualche messa, ma di solito veniva usata solo a maggio, quando ci veniva detto il rosario. Ci andavano la nonna, la mamma, la Milena che aiutava in casa e poi altre donne e ragazze di quel piccolissimo paese, così piccolo che non aveva nemmeno un negozio o una chiesa vera. A volte ci stava anche lui, ma per poco perché subito si annoiava, non succedeva nulla e tutti ripetevano all’infinito sempre le stesse cose. Ci rimaneva volentieri solo quando ci veniva la Simonetta, l’avvenente Simonetta dagli spessi capelli biondi che le scendevano sopra le spalle, mossi e voluminosi come un cappello piumato. Com’era grande e luminosa quando si chinava su di lui per dargli un bacio: il sorriso aperto, gli occhi splendenti d’azzurro, l’avrebbe sposata subito, anche se poi faceva lo scontroso quando lei gli rivolgeva la parola. Alla tata glielo aveva detto: era lei che voleva sposare e proprio lì nella cappella, sotto il soffitto dipinto di stelle fiammeggianti. L’aveva rivista di recente, aveva oltre cinquant’anni e era ancora bellissima. “E’ ancora nostra quella casa, sai? – diceva Gabriele a Arianna – nessuno di noi, anche dopo che è morto mio padre, ha avuto voglia di venderla. Una parte l’abbiamo scorporata e d’estate l’affittiamo, ma la parte più bella è ancora là, quasi uguale a allora. Mia madre ci va spesso con sua sorella mentre invece mio fratello non ci va quasi mai. Io ci torno molto volentieri, anche d’inverno quando ci fa freddo come a quei tempi. Non saprei spiegare bene perché, ma mi ci sento bene; stare lì in qualche modo mi rassicura… mi rafforza. Ci vado con amici, ma a volte anche da solo, mi porto dei libri, della bella musica…”. Nel paese, vicinissimo alla loro casa, viveva però un’altra donna importante, anzi, la più importante di tutte quelle che conosceva. Non aveva nessun ruolo, né rapporto di lavoro con la sua famiglia se non il fatto di avere un debole per lui e di perdercisi dietro con un’assiduità e una generosità sconfinate. Quell’amore veniva ricambiato senza riserve. Bruna, piuttosto in carne, dolcissimi occhi neri sul viso tondo, Maria non era forse mai stata la più bella del paese, ma da lei emanava una carica calda e una serenità quasi contagiose. Era la moglie di uno dei tanti taglialegna della zona, Vittorio, una specie di elfo, uno che a contatto del bosco c’era stato da sempre, tanto che il bosco giorno per giorno lo ricompensava: con il lavoro, ma anche con i funghi, i marroni, le corbezzole, gli asparagi, le fragole, i mirtilli, a volte i tartufi. Fin da piccolo Gabriele pensava che loro due, la Maria e Vittorio, si volevano molto bene, infatti una volta li vide in cucina che si baciavano. La loro figlia studiava in collegio perché da quelle parti non c’erano scuole superiori raggiungibili e questa circostanza spiegava in parte la grande disponibilità di quella donna verso di lui; ma forse ancora di più contava la sua convinzione profonda che i bambini fossero sacri per cui aveva deciso, in base a osservazioni o forse per puro intuito, che quel bambino lì aveva bisogno di essere difeso e scortato. “Portava un golf sbottonato sugli altri vestiti, un golf grigio scuro e quando le stavo in collo, molto spesso mi hanno detto, ci infilavo la testa sotto, tra il collo e la spalla. Più che il suo calore, quello che mi ricordo è l’odore, un profumo asprino e dolce allo stesso tempo, qualche cosa tra il latte e il muschio… buonissimo! Quando provo a catturare qualche pezzo di quegli anni, la rivedo solo come un’aura, una presenza dai contorni vaghi, invece vedo chiara l’apertura del golf, la catenina d’oro con la croce che portava, sento la sensazione di piacere di stare in alto, sollevato tra le sue braccia. Di mia madre non ho nessun ricordo del genere, figuriamoci di mio padre…”. Con Maria andava a dar da mangiare alle galline e al maiale, a cogliere i pomodori dall’orto, a vedere i coniglini appena nati e a volte anche il pavone che una sua parente teneva nel giardino intorno a casa. Tutte le settimane lei gli faceva un dolce a forma di ciambella che teneva nella dispensa solo per lui. Il bambino stava a vederlo impastare, in piedi su una sedia di paglia appoggiata alla madia; prima di versarlo nello stampo, gli dava dei pezzettini di pasta dolce, glieli metteva lei in bocca con un dito, come a un merlo di nido. La casa di Maria aveva la porta aperta d’estate e la chiave nella toppa quando faceva freddo. C’era sempre gente là, d’inverno accanto al fuoco, nella bella stagione sulla lunga panchina di legno appoggiata contro la facciata e quelli che venivano, quasi tutti abitanti del paese, si mettevano a coccolare Gabriele, a giocare con lui, a raccontargli storie, a arruffargli i riccioli rossastri. “Stai attento te – gli diceva il fattore – che rossi non son buoni nemmeno i maiali!”. E la Maria, prendendoselo su in collo: “Non dargli retta, la sua è tutta invidia perché, vedi, non ha nemmeno un capello su quella sua zucca mentre tu hai dei capelli bellissimi!… Vero che siete invidioso, Francesco?”. “Eh, se è vero! Guarda qua!”. E si levava il cappello su un cranio lucido e abbronzato. “I miei capelli son scappati tutti via dai brutti pensieri che facevo e che faccio ancora!”. E tutti a ridere. Lui non capiva niente, però rideva anche lui, mentre la tata lo pettinava sulla nuca con le dita. Ognuno gli aveva dato un soprannome, cosa di cui andava orgogliosissimo, tanto che in casa, appena gliene davano lo spazio, li ripeteva tutti in fila, specificando da chi veniva quale. Lì, dalla Maria, si sentiva davvero importante. Gabriele ogni tanto andava anche in città, nella casa col corridoio lungo e buio dove abitava l’altra nonna. Là gli succedevano altre cose: dal gelataio non bisognava andarci in macchina, ma stava vicinissimo, appena dietro l’angolo; per la strada lo tenevano per mano senza mollarlo mai, ai giardini pubblici c’era poco spazio, ma giocava con amici sempre diversi. Venne un periodo che dalla nonna ci andavano tutte le settimane perché mentre lei lo portava al cinema o al museo delle armature, i suoi andavano a vedere appartamenti in previsione del prossimo trasferimento nel capoluogo. A casa cominciò a sentire usare spesso l’espressione “trasloco”, una parola nuova che a un bambino di tre anni non diceva niente e che continuò a non interessarlo per diverso tempo. Una mattina di primavera però, venne un camion e cominciò a ingoiare i mobili di casa, il divano su cui si addormentava, il lettino, la scatola dei balocchi. La sua camera era diventata vuota, c’era rimasto solo l’ulivo benedetto ancora fresco appeso a un chiodo; era buffa, sembrava un altro posto. “Perché ci portano via la roba?”. “Non ce la portano via – gli disse sua madre – la spostano nella casa nuova, quella vicino all’altra nonna. Ora ci arrangeremo qualche altro giorno qui e poi, quando là sarà pronto, ci andremo a stare”. “Verrà anche la Maria?” “No, lei non può, ha la sua casa qui, ma tu potrai venire a trovarla tante volte, lei ti aspetta sempre”. Gabriele non si rese conto nemmeno lontanamente di cosa volesse dire la mamma con tutti quei discorsi. Persino quando caricarono anche lui sulla macchina insieme alle ultime cose, non si preoccupò per un viaggio che aveva fatto già tante volte; cosa fosse un grande cambiamento, cosa fosse un distacco, erano concetti che non capiva. Per dipiù non vide piangere né la nonna di montagna, né la Maria, né la Milena, per lui andava tutto nel più normale dei modi; qualsiasi cosa fosse accaduta, sarebbe stata naturale e accettabile; il fatto poi che fosse una cosa nuova era altrettanto normale. C’era solo da deglutirla, come qualsiasi altra. Lui non sapeva cosa fosse una causa o un effetto, o che avessero tra loro una relazione, le cose avvenivano e basta, per lui la necessità era regina e regnava senza minacce. La sua coscienza era come un enorme silos vuoto in cui gli avvenimenti precipitavano a rallentatore e rimbalzavano sul fondo morbido senza far rumore; non si doveva preoccupare di dove né come sarebbero ricaduti, né in che posizione si sarebbero assestati; nel suo contenitore c’era posto per tutti. Gabriele salì tranquillo nella macchina che lo avrebbe deportato dall’unica provincia dolce della sua infanzia, non si voltò nemmeno per guardare il gruppetto di persone che ancora li salutavano con i gesti della mano e che il primo dosso cancellò. Stava seduto appoggiato allo schienale, le gambe distese sul sedile, i piedi che appena sporgevano. Sui ginocchini rotondi e cicciuti c’era la crosta dell’ultima caduta sulla ghiaia del giardino; se la toccava gli faceva ancora un po’ male. Il percorso non aveva molto da offrire, allora si girò su un fianco e con in mano una splendida macchinina rossa, si mise a percorrere la pista di gomma nera intorno al finestrino. Capitolo XIX In città la vita non era male, tantopiù che la loro casa stava proprio all’estrema periferia, era uno degli ultimi baluardi di cemento armato contro i campi, le fattorie, le ville della collina. Gabriele aveva a disposizione un giardino grande forse un sesto del suo di montagna, ma pur sempre un posto aperto, con vialetti di ghiaino, una piccola serra che faceva da casina, una fontanella di cotto e una grande aiuola d’erba su cui cresceva un grosso albicocco vecchio e un po’ spelacchiato, un albero che viveva lì prima ancora che costruissero la sua casa. Visto che si ergeva proprio in mezzo all’appezzamento di terreno e che ricordava vagamente l’idillio della campagna, il costruttore ce lo lasciò e fece bene perché i suoi genitori, pur cercando di non darlo a vedere, si decisero per l’appartamento proprio grazie al fascino rurale del giardino. Quella pianta, alla cui ombra pensavano di mettere una tavola per i pranzi estivi, piacque loro molto, dava un aspetto vissuto alla casa di recente costruzione e inoltre ricordava molto l’albicocco che cresceva in mezzo al campo della casa di montagna. L’appartamento era piuttosto grande, ognuno aveva la sua camera e in più c’era una stanzina che faceva da studio in cui era stato piazzato il pianoforte verticale della mamma; ora che suo figlio era abbastanza grande, avrebbe cominciato a insegnarglielo, con pazienza e con tempi molto diradati, per non farglielo odiare. Precauzione fondata, la sua, dal momento che in quel periodo, più che dai tasti del pianoforte, Gabriele era attratto dai raggi della bicicletta, dal loro confondersi e sparire quando le ruote giravano, dal sommesso fruscio che facevano quando imboccavano la leggera discesa della strada dove stava la nonna. Era lei che lo scorrazzava sul seggiolino di metallo montato sul portabagagli, lo portava al cinema, oppure ai giardini, insieme facevano tratti brevi ma molto interessanti. “Non ti manca mai la tua casa vecchia?” lei gli chiedeva mentre pedalava. “Sì, un po’…” Le rispondeva distratto. Ma poi passava il grosso camion della spazzatura o l’ambulanza con la sirena che girava sul tetto e tutto lo sciame dei suoi pensieri si trasferiva lí cancellando subito la Maria, le mucche e i boschi di faggi. “Forse è meglio che alla sua età la metta da parte la bicicletta – diceva il babbo alla suocera – se casca e si rompe una gamba, poi ce ne vuole per guarire!”. “E’sessant’anni che pedalo – gli ribatteva lei – se smetto ora mi ammalo!”. Un giorno d’ottobre la nonna, frenando per scansare una macchina, cadde e si ruppe un femore. Bisognò operarla, ci furono delle complicazioni, l’atmosfera a casa diventò pesante, il tempo per star dietro al bambino poco, cosicchè alla fine i suoi chiesero a Maria se poteva tenerlo per qualche settimana. Il trasloco lo avevano fatto a maggio; a luglio era stato al mare con Massimo e la mamma mentre a agosto erano andati tutti dalla nonna in montagna. Gabriele aveva avuto poco tempo per nostalgie e cose del genere; prima ancora di poter soffrire delle separazioni, dell’impatto con l’asilo o dell’inverno in città, era stato reinserito nel suo vecchio nido dove poteva stare sempre con la sua Maria, andare con lei e Vittorio a raccogliere le castagne, dormire nella camera della loro figlia e farsi coccolare ancora di più ora che stava lì dalla sera alla mattina. Ogni tanto lo portavano dall’altra nonna nella casa grande ma per poco, lei non poteva stancarsi più di tanto con i bambini, per cui, dopo un salutino e un pezzetto di cioccolato, risaliva in collo alla sua tata e ritornava a casa. La sera, prima di addormentarsi, lei gli leggeva uno dopo l’altro i due librini in rima che i suoi genitori gli avevano regalato prima di partire; in pochi giorni imparò a memoria tutti i versetti di quello che gli piaceva di più. “Stamattina i due funghetti dal musino rosso e tondo hanno aperto i loro occhietti sulla luce del gran mondo… Ma è pazzesco! – diceva a Arianna dopo averle recitato mezzo libro – sono quasi trent’anni e me la ricordo tutta quella filastrocca!” Dentro la loro macchina diventava presto freddo, le calde rimembranze di Gabriele gli uscivano dalle labbra sotto forma di ondate umide che andavano a lambire i finestrini appannandoli come brina. L´auto era spesso l’unico posto in cui potevano stare un po’ insieme, era la piazza, il salotto, l’alcova, il giardino. In compenso potevano scegliere i luoghi più belli e esclusivi per parcheggiare la loro casa. Anche quella sera infatti, disappannando i vetri, si sarebbe aperto davanti a loro il panorama splendente della città di notte, tremolante di luci, vista dal piazzale di una delle più belle chiese dei dintorni. Quelle strofe imparate a memoria dai suoi librini, servivano a Gabriele per quando la sera venivano ospiti a veglia e lui prendeva qualcuno in disparte, gli si sedeva accanto e dopo averlo avvertito che sapeva leggere, apriva il libro alla prima pagina e spedito leggeva quello che ci stava scritto, poi la girava, leggeva veloce le rime della seconda e via fino all’ultima. Era facile, c’era solo una strofa ogni due pagine, piazzarla al punto giusto era uno scherzo; effetto garantito, gioia alle stelle. Non importava se poi vedeva quella persona volgersi con aria meravigliata e interrogativa verso Maria e poi lei scuotere la testa e dire a bassavoce qualcosa, l’importante era che durante lo spettacolo, ma anche un po’ prima e un po’ dopo, anche lui diventava perfettamente convinto di sapere leggere, ne provava il brivido, ne sentiva l’emozione, si trasformava sul serio in qualcun altro e perdipiù in qualcuno molto più grande di lui. Senza saperlo sperimentava tutta la pienezza del meccanismo teatrale: per un po’ gli altri credevano, con mente e cuore, che una realtà straordinaria fosse vera e lo credevano grazie a lui, l’attore, l’artefice del miracolo, il quale da parte sua per un po’ riusciva a sbalordire, a tenere alta la tensione, a far dimenticare tutto e credere solo a lui. E come un attore, una volta chiuso il libro all’ultima pagina, non si sentiva certo in colpa per aver detto una bugia, anzi, soddisfatto e felice, si rallegrava di cuore che la finzione fosse riuscita. Durante quelle veglie d’inverno, Gabriele imparava anche altre cose, che poi gli si sarebbero rivelate più o meno utili, ma gli sarebbero comunque rimaste ben impresse: qualche proverbio a sfondo erotico, tipo “Donne giovani e vino vecchio”, oppure “Donne e fuoco, stuzzicali ogni poco”, ma anche le sue prime barzellette, tra cui una anche molto sporca. In effetti era sporchissima, molto piena di cacca; a lui piaceva tanto, era la sua preferita, ma non potette mai riciclarla granchè perché l’aveva imparata in dialetto e tradotta in italianoperdeva tutto il suo potere. Provò a riportarne a Arianna un paio di frasi, ma si imbrogliava con le espressioni dialettali e poi gli veniva in continuazione da ridere. Si scusò, ma inutilmente, perché già comunque rideva anche lei. Tutto in montagna dalla Maria andava benissimo per Gabriele: il mondo girava intorno a lui carico di belle cose; c’era chi lo coccolava, chi gli leggeva, chi gli dava leccornie da mangiare; già aveva dimenticato la bicicletta, la nonna in città, gli amici dei giardini, quando un giorno, mentre meno se l’aspettava, vide arrivare il babbo e la mamma. Maria glielo aveva certo detto, ma lui o lo aveva dimenticato, o non gli aveva dato peso. Bene, comunque, che venissero a trovarlo, così c’era più gente nota per casa. Probabilmente era domenica, perché a tavola a pranzo c’era anche Vittorio. Tutti mangiarono in allegria, chiaccherarono, risero di come aveva imparato a leggere e dopo pranzo fecero un giro al fiume dove costruì delle dighe coi sassi delle secche; tornati a casa Maria gli dette una fetta di dolce particolarmente grossa per merenda. Verso la fine del pomeriggio, dopo che tutti si erano intrattenuti a conversare al sole invernale nel piazzalino davanti a casa, il babbo si alzò e disse che ormai era di partire. Gabriele ebbe un attimo di smarrimento: dicevano a lui? Lo prese una certa inquietudine, capì che qualcosa non stava andando nel verso giusto, si affrettò a dire che lui non ci sarebbe andato e che stava benissimo là. La mamma, vedendo come gli altri che ci sarebbero stati dei problemi, provò allora a spiegargli che la sua casa non era quella lì, che i bambini devono stare coi loro genitori e che l’altra nonna lo aspettava con dei bei regali. La Maria si fece coraggio e anche lei gli disse che i suoi avevano fatto apposta tanta strada per lui e che si sarebbero molto dispiaciuti se non ci andava. Gli argomenti entravano nei suoi orecchi per subito uscirne lasciando nella mente uno spesso strato di crescente timore. A ogni secondo, a ogni parola, il cerchio si stringeva; l’inquietudine presto si trasformò in paura, qualcosa di minaccioso stava prendendo forma intorno a lui, si sentì braccato e andò a rifugiarsi di corsa tra le ginocchia di Vittorio. Forse in qualche modo intuì che è il maschio quello che difende i cuccioli del branco. Sua madre gli si avvicinò. Ecco, stavano per catturarlo; scoppiò a piangere forte e si arrampicò come uno scimmiotto in collo al suo protettore che però lo sosteneva in piedi, senza difenderlo né respingerlo. “No, no! – si mise a urlare mentre lo stringeva nascondendogli il viso tra il collo e la camicia – io voglio stare qui!”. Cominciò a piangere, di un pianto che si faceva più forte man mano che nessuno veniva in suo aiuto; perché, pur essendo un bambino, il beniamino di tutti, perché nessuno ora lo aiutava? Abbandonato, tradito, in trappola, urlava e si aggrappava a quel collo come un polpo alla roccia su cui è stato catturato. Imparò cos’è il panico, cominciò a tremare. Vittorio istintivamente chiuse le braccia intorno a lui: “Su, non piangere, che poi torni”. La madre ci riprovò, gli carezzò la testa; sentendo che era lei a toccarlo, gli urli aumentarono, il pianto diventò convulso. “… Ma come non vuoi venire con noi… - gli disse in tono supplicante – ma noi siamo il tuo babbo e la tua mamma!”. “ No, no! – urlava con la voce già roca e scuotendo la testa da un lato all’altro – voi no! Andate via! Sono loro il mio babbo e la mia mamma!”. E terrorizzato si stringeva con tutte le sue forze a quell’unico appiglio. Faceva fatica a respirare, il naso gli si era completamente tappato eppure non alzava il viso da quell’angolo di salvezza sulla spalla del boscaiolo. Tutto era impastato davanti ai suoi occhi, non distingueva né il blu della canottiera, né i quadri della camicia, né i sassi del muro contro cui stavano seduti. Non vedeva né voleva vedere più niente, solo tentava di tenere dura la stretta anche mentre sussultava cianotico trai singhiozzi. Ma nessuno lo difendeva, anzi, l’assalto duro alla fine arrivò: si sentì strappar via. Si attaccò ancora di più alla presa, ma la forza che lo tirava indietro era più grande; ci vollero diversi strattoni, come per estrarre un brutto molare, poi Vittorio sparì dalle sue braccia, Gabriele si sentì portare via e sollevare nell’aria. Si divincolava, si contorceva, strillava, ma suo padre continuava a tenerlo saldo per sotto le ascelle. Attraversò la strada così, sospeso e scalciante, poi sentì lo sportello aprirsi e richiudersi dietro di sé. Buttato in malomodo dentro la macchina, col viso nella piega tra il sedile e lo schienale, avrebbe voluto entrare come un liquido in quella fessura, sparire, non esistere più. Piangeva con gli occhi chiusi, le palpebre l’unica muraglia, l’unico scudo per tenere lontano quel mondo cattivo che stava subendo senza capire; avrebbe voluto scappare, ma non più per tornare dalla Maria, bensì per distruggersi, per scomparire per sempre, per liberarsi una volta per tutte delle violenze che gli stavano imponendo. L’ingiustizia è qualcosa che al massimo si può accettare, ma non certo capire. Tantomeno la poteva capire il bambino Gabriele. Il velluto della tappezzeria puzzava, intriso di un vago odore di morchia e di benzina, gli venne da vomitare. Raggomitolato in un angolo, cercava la solitudine e il buio. Non lottava più, tutto era successo ormai, piangeva e basta, la vita intera si era trasformata in disperazione senza appello, acuta, totale. Stava a carponi, la testa nascosta tra le braccia, scosso dal tremito e dai singhiozzi. Lacrime salate gli entravano in bocca, quel sapore lo consolava, era la sua sola compagnia, la riprova fisica del suo dolore, roba sua, il suo mondo. Dalle labbra gli scendevano lunghi fili di bava, altri gli uscivano dal naso e andavano a impastarsi nella stoffa grigia del sedile così come dietro di lui si impastavano la coscienza del distacco, la ferita della violenza, l’umiliazione di essere piccolo. Il motore si accese, partirono, ma la sua sconsolazione non poteva toccare pozzi più profondi, ormai tutto gli era indifferente; rialzò la testa solo per vomitare, più volte, dentro e fuori la macchina. Suo padre era furioso, sua madre senz’altro addolorata e impegnatissima a tappare le falle di quella barcaccia, ma a lui non poteva importare meno, non aveva più niente da pedere. Nemmeno lo avrebbe consolato il sapere che in quello stesso momento altre lacrime venivano versate, lacrime da adulti, gonfie di dolore e di rabbia”. …Quel porco, quel caporale di merda! L’ha tirato via come un vitello che si porta a macellare, l’agnellino, il mio povero agnellino… e lei, sarebbe sua madre quella? Chissà dov’era quando l’ha partorito! La mucca spezza le funi, spacca la porta della stalla quando le portano via il vitello e quella baldracca ha lasciato che gli facessero di tutto… di tutto”. La Maria stette male per molto tempo e anche Vittorio, per tutta la vita, non avrebbe mai dimenticato quella sera. “Mi ricordo tutto così nitido… la paura, gli odori, i sapori, la disperazione. Da quella volta in macchina ho sempre vomitato, ho continuato fino a tredici o quattordici anni, poi ho smesso”. Gabriele aveva raccontato tutto l’episodio fissando il vetro davanti a sé, scorrendo le mani sull’arco superiore del volante. Ora ci tamburellava appena sopra con il pollice. Si voltò verso Arianna sorridendole leggermente; anche lei lo stava guardando, sgomenta e incredula. “Mamma mia!”. Non riusciva a dire di più. “Non ti rattristire angelo mio – le disse carezzandole il viso – sono sopravvissuto… i bambini sono meno fragili di quello che si teme, non si fanno sopprimere così facilmente. Comunque… non lo racconto volentieri questo episodio, anzi, a pensarci bene, mi sembra che è la seconda volta che lo dico a qualcuno”. Col dorso della mano aprì una larga finestra nell’appannatura del vetro e la città ricomparve sotto forma di punteggiature luminose sorrette da qualche diagonale di luci più forti e lineari. Gabriele tirò giù il finestrino e una corrente asciutta e fredda, carica di odori invernali, sparse nell’abitacolo ossigeno fresco e nuovo vigore; ma il carico di intimità e fiducia che quel raccontare aveva generato, permaneva ostinato, sciabordava intorno a loro, li avvolgeva come una larga vasca di acqua tiepida. Arianna prese a tempestarlo di domande sulla sua famiglia, gli chiese sui suoi genitori, su suo fratello, se la tata era ancora viva; il senso di quella storia le sembrava così incredibile e crudo che le venne persino il dubbio se non si fosse inventato qualche cosa. Era costernata, ma anche molto arrabbiata. “Come hai fatto a vivere tutta un’infanzia, un’adolescenza con quei mostri, a non diventare uno psicopatico o un mostro simile a loro?”. Voleva davvero saperlo. Gabriele sorrideva flemmatico, confortato dalla sua comprensione e in fondo più fiero del solito di essere sopravvissuto ai suoi inizi disgraziati. “Un po’ ho avuto fortuna, forse materiale genetico diverso… Non sono un genio, ma nemmeno un imbecille, ho capito subito, o forse è meglio dire intuito, che lì, in casa, avevo il nemico, che mi dovevo difendere, che il marcio non era dentro di me, ma di fuori; così mi sono salvato dal peggio, dall’autodistruzione, anche se poi, passare gli anni teneri a stare in guardia, a fare resistenza, qualche volta anche a attaccare, è stata dura, tantopiù che le cose le vedo chiare ora, ma a cinque, o dieci, o quindici anni, le subivo e basta. Non è stavo piacevole, però, vedi? – le baciò la mano che teneva nella sua – ne valeva la pena, a volte sono stato premiato, risarcito alla grande! Guarda, per esempio, che bel premio ho vinto… Vieni più vicina, lasciami sentire che buon profumo ha qui, sotto le orecchie, il mio premio, lasciami sfiorare questo bel collo, morbido, caldo…”. Se a Arianna avessero detto che le sue effusioni quella sera avevano un calore materno, si sarebbe risentita, però, se si fosse osservata bene, avrebbe sentito qualcosa di diverso nella sostanza dei suoi abbracci, qualcosa che si portava dentro un calore speciale, aggiuntivo, qualcosa che sapeva vagamente di cuccia, di nido, di culla. Capitolo XX Alta sopra la loro alcova mobile, distaccata e indifferente alle loro storie, troneggiava alle spalle la badia romanica, solida, elegante, maestosa; la facciata illuminata dai riflettori, la navata che si perdeva nel buio, sembrava una grande diva seduta. Agli amanti restava quasi un’ora e il desiderio di sdrammatizzare i racconti di quella sera; tenendosi per mano andarono a guardare più da vicino la stupenda costruzione, con l´intenzione di osservarla da veri turisti. Le sue forme pure, sobrie e simmetriche, suggerivano ordine e sicurezza, fin quando, su un lato, lontano dal portale, quasi a ridosso delle pietre angolari, si accorsero di qualcosa che insidiava tutto quel rigore: era un intarsio di marmo nero su campo bianco, relativamente piccolo, che non aveva nessun motivo di essere là. Raffigurava una specie di caravella a un albero che con la vela gonfia di vento, navigava diritta verso il portale. Azzardarono congetture: una misteriosa simbologia medioevale, un ex-voto di qualcuno scampato a un naufragio, un forte finanziamento fatto da un armatore, un architetto che veniva da una città di mare? Eppure, una volta notato quel dettaglio, bisognava leggere la facciata in un altro modo; la simmetria non era più assoluta, qualcosa era sfuggito alla disciplina, era sorto un elemento di disturbo, un’obbiezione, un guasto, qualcosa di dissonante che non si poteva ignorare. Grazie a quella nave, l’insieme si assestava su equilibri più complessi, più larghi, più difficili. Le mani di Gabriele avvolsero come una conchiglia la destra di Arianna. “… Forse è proprio vero che bisogna distruggere situazioni assestate, anche se piacevoli, se se ne vogliono costruire altre più ricche, più interessanti, non ti pare?”. Arianna si fece seria, alzò gli occhi verso di lui, poi tornò a guardare la navicella sul muro. “Non è l’unica via, si può costruire anche senza buttar giù e comunque, chi può permettersi il lusso di abbattere la propria cattedrale quando ci si è messo una vita a costruirla ed è là quasi finita? Distruggere è facile solo per chi ha in mano un altro progetto, più bello e più grande, per chi stringe tra le dita un mondo nuovo; gli altri non ce la fanno, per loro sarebbe solo un distruggere da vandali. Io sono tra quelli; sono troppo vecchia, di spirito oltre che d’età, le mie fedi hanno il fiato corto, non potrei mai ricominciare daccapo”. Si appoggiò più pesantemente a lui mentre continuavano a camminare verso il buio dietro la chiesa; poi cambiò totalmente registro: “Ma tu devi essere contento di quello che prendi da me, tu che puoi dire di essere desiderato da una donna fino alle lacrime; sei un privilegiato! Mi possiedi molto più di quello che credi, sai? La luce delle mie giornate sei tu. Sai quanti uomini invecchiano senza che nessuna donna si sia mai davvero sciolta tra le loro braccia, senza raccogliere da lei nemmeno una volta qualche lacrima di piacere? E certo non perché siano più o meno belli, gli uomini per loro fortuna sono più liberi da queste limitazioni, è che spesso non si sanno far amare più di tanto; le donne le sanno sessualmente coinvolgere forse, ma non le sanno far trasfigurare, non sanno costruire intorno a loro un teatro protetto e esclusivo in cui possono esaltarsi e far valere le loro qualità di protagoniste d’amore. Ti premetto che ti sto parlando di passionalità e non di erotismo, non è la stessa cosa, ci vuole un po’ d’anima per quello che voglio dire io, da entrambi le parti… Un uomo dovrebbe saper provocare nella sua compagna emozioni; non è la carne, ma l’emozione il propellente d’amore di tante di noi, il corpo poi le va dietro. Perché credi che tutte adoravano Puccini? Tutte, da Sarah Bernardt, alle aristocratiche, alle cameriere. Solo perché era piacente e famoso? Macché! Lo amavano per la bella musica che componeva, perché quella musica le faceva sognare!” “ Insomma, bisogna gasarle le donne per averle con amore, per esempio facendo finta di amarle, facendo il teatro dell’amore. E questo teatro, non è finzione nel senso di menzogna, è finzione nel senso di esagerazione, di esasperazione di qualcosa; con un simile, piccolo ritocco della realtà non si viene ingannate, ma gratificate… come potrei spiegarmi meglio… C’era un poeta francese di cui non ricordo il nome che in una delle sue poesie scritte dal fronte alla sua fidanzata, le parlava delle nove porte della donna. Forse, a proposito di quel conteggio, lui, in quanto poeta, sapeva che per arrivare bene alle porte dispari, si doveva passare attraverso quelle pari. Non solo, ma tra quelle, sempre perché poeta, sapeva che bisognava privilegiare senz’altro le orecchie. Probabilmente non è un caso che fosse francese; ecco, i Francesi… loro sono molto avvantaggiati in questo campo, il teatro dell’amore che l’hanno nel sangue, intriso nella loro cultura, nella loro impostazione della vita, lo respirano nell’aria; lo chiamano galanteria e lo mettono dappertutto. Infatti, me lo diceva anche Catherine che in Francia l’amore è il secondo lavoro di tutti, se non proprio il primo”. “E chi è Catherine?”, la interruppe Gabriele. “Una volta te ne parlerò, e volentieri, Catherine è una persona importante, ma ora vorrei continuare a spiegarti questa cosa, anche questo è importante, davvero!”. Gabriele la seguiva divertito, curioso di vedere dove sarebbe andata a parare e intanto cercava di collocare al punto giusto tutte le porte di cui parlava quel Francese. Arianna non aveva idea di come avrebbe concluso, buttava là queste valutazioni cercando di infilarle con ordine, come una collana di perle degradanti, ma di fatto era la prima volta che ci rifletteva, stava parlando di getto e sperava ardentemente, non tanto per lui, ma per sé stessa, di non vedere grosse contraddizioni spuntare all’improvviso nel cuore dei suoi ragionamenti in costruzione. A queste cose non ci aveva mai pensato prima, non ne aveva mai avuto motivo. Che gliene era importato fino a allora di analizzare come una donna reagisce a certi modelli di seduzione? “… Perché quella sospensione – continuava – che un uomo costruisce col suo teatro, è anche il grogiuolo che fará fondere il corpo e l’anima di una donna , verrá da lí l´ardore. Ti ripeto non sto parlando di comportamenti erotici, ma d’amore, roba molto più forte, che vale anche se per amore si intendesse un incontro fortuito o saltuario; alla passione non gliene importa niente della continuità di un desiderio, le importa solo la sua intensità, la passione è l’intensità”. Mentre la dissertazione andava prendendo forma, Arianna e Gabriele continuavano a camminare per mano, a passi lentissimi, entrambi guardando la terra ghiaiosa sotto i loro piedi. Arianna accompagnava con accentuazioni della sua stretta i punti che le sembravano salienti e oltre alla gioia di elaborare e approfondire un pensiero, si beava di poterlo fare accanto a lui, sapendo che l´avrebbe ascoltata con attenzione. Sentiva verso Gabriele una fiducia totale, parlava a lui come a se stessa. “… Forse, a proposito di seduzione – continuò – anche la figura di Don Giovanni, sto pensando a quella di Mozart, andrebbe rivalutata… A parte i suoi tratti violenti che non sopporto – quando si muove di spada è rivoltante – se si cancella appunto questo aspetto tracotante e primitivo, lui è proprio una bella figura, è una specie di benefattore: a tutte le donne, e dico tutte, giovani, vecchie, ricche, povere, belle, brutte, lui regala il brivido della seduzione di qualità. Getta oro a manciate ovunque cammina, é un uomo generoso! Magari ce ne fossero tanti così, pieni di queste energie benefiche. Basta liberarlo da ogni ruolo di marito o compagno stabile e ecco che diventa un eroe positivo, audace, prodigo, determinato…All´inferno? In paradiso doveva andare! Lui affascina perchè è un artista e come i veri artisti sa riconoscere la bellezza anche dove non è evidente, la sa estrarre, la obbliga a mostrarsi; non si contenta della realtà, le va oltre, la dilata, la manomette, le toglie o aggiunge quanto serve a renderla piú bella. E’ un uomo creativo, in tutte le donne sa trovare qualcosa di esaltante, qualcosa che gli servirà da alimento per la sua passione; infatti è dalla genuinità del suo desiderio che prende forza il suo potere di seduzione, è lì il propellente; lui è sincero, anche se solo per qualche decina di minuti. Infatti, Don Giovanni non va amato, va solo creduto; per un po’, per quanto dura. Va preso per quello che é: un’apparizione. E’ con questa miscela di veritá e finzione che riesce a accendere giovinette, ragazze, signore, è con la forza trascinante del grande attore che le sa portare ad ebollizione. A quel punto ne coglie la crema, qualcosa che sarà senz’altro delizioso per tutti e due e il resto lo lascia ai loro mariti, ai loro fidanzati, al vuoto delle loro vite prive del fuoco sacro di Don Giovanni. Dopo averle amate se ne va, è vero: in senso morale le abbandona, ma in senso teatrale sparisce, si dissolve, come in un efficace trucco scenico. E quale donna non vorrebbe andare a teatro e vivere uno spettacolo emozionante, solo perché a un certo punto finisce, il sipario si chiude e deve tornare a casa, salire le scale di un condominio, aprire la porta di cucina su pentole e cucchiai e quella di camera su un uomo che ha poco da dire e da dare. Perché, vedi… da una parte c’è la vita, dall’altra il teatro o il cinema o la letteratura o la musica, o l’arte o qualsiasi altro trucco inventato per risarcire l’esistenza, per farcirla di spezie, di sogni, di droghe. Don Giovanni non è che uno dei tanti grandi spacciatori; lui si è specializzato in amore, un prodotto che è stato per tanto tempo il principe delle droghe per signora. Di quello che spaccia lui di solito non si muore, è roba leggera che non da assuefazione; al contrario, offre più di un vantaggio: non solo lascia ricordi che migliorano nel tempo, ma dà anche lezioni di leggerezza, obbliga a riflettere sulla transitorietà dei sentimenti intensi e infine insegna che senza finzione si vive male. Senza finzione resta solo la realtà o, per chi vuole andare più oltre, la verità: roba dura, non ti sembra?”. Gabriele seguiva divertito le fini costruzioni di carta che lei stava imbastendo e che in parte forse poteva condividere, ma allo stesso tempo guardava l’insieme di quella serata e gli veniva da ridere: uno organizza con fatica un incontro d’amore clandestino da cui si aspetta sesso selvaggio e passione e invece si ritrova a fare confessioni dolorose e a camminare al freddo con una che gli fa l´apologia di Don Giovanni. Era proprio una serata buffa, non era così che l’aveva immaginata mentre a casa si radeva e si sceglieva i vestiti. Comunque andava benissimo anche in questo modo, gli piaceva sentirla chiaccherare contemporaneamente con lui e con se stessa; era come se le stesse palesemente davanti e al contempo la spiasse senza essere visto. In ogni caso era chiaro che il senso positivo delle sue divagazioni era rivolto a lui, in fondo se ne sentiva fiero e lusingato. Dette una rapida occhiata a tutte le donne della sua vita, fino a quelle più lontane e cercò di vedere se quelle allusioni carezzevoli coincidevano davvero col bilancio del suo passato amoroso. Gli sembrava di aver trovato affascinanti molte ragazze, di aver fatto sesso con una gran parte di loro, di aver evitato gran brutte figure, ma quanto a essere un seduttore paragonabile a Don Giovanni… più tardi, quando Arianna non sarebbe più stata con lui, ci avrebbe meglio riflettuto, chissá, forse era anche vero. Avvolto da questi caldi pensieri, camminava lento accanto a una delle sue più gradite conquiste e intanto, da province lontane della sua memoria gli saliva alle orecchie e volteggiava, leggera e maliziosa, l’aria di Leporello che legge a Donna Elvira la lista delle sedotte da Don Giovanni: “… In Italia 640, in Limagna 321, cento in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna… ma in Spagna son già 1003…” e rideva dentro di sé, a mezza strada tra orgoglio e ironia. Arianna si sciolse dalla sua stretta, gli carezzò il dorso della mano, risalì fino al polso e si fermò sul freddo orologio allacciato intorno alla pelle calda, alle ossa sottili. Lo lesse: “Vieni, andiamo via, Giovannino, lui ci sta dicendo che è giá tardi”. Quella sera Gabriele era di ottimo umore e nonostante la serata casta, si sentiva allegro e appagato, contento come un bambino che è stato tutto il pomeriggio alle giostre. Capitolo XXI Si chiamava Catherine, ma per tutti in paese era “la parigina”, anche se Parigi l´aveva sempre vista come qualsiasi altro turista, attraverso scorci e percorsi quasi obbligati, per brevi periodi e nelle stesse stagioni. Come tanti aveva potuto guardarla e amarla solo attraverso i vetri chiusi o aperti di qualche albergo. Non ci aveva mai fatto la spesa, né cucinato, né ricevuto posta, né comprato una vecchia poltrona alla Porte de Clignancourt. Era una città amata e straniera. Quando ci andava, le piaceva molto camminare lungo le quais della Senna, guardare gli alti muri che la contengono, sporgersi e poi pensare a quello stesso fiume lontano da Parigi, cespuglioso e selvaggio come quello che conosceva lei. Le piaceva il Louvre riflesso nell’acqua densa e gli occhi degli uomini che a volte cercavano il suo sguardo mentre le passavano accanto sui Boulevards; allora brividi sottili l’attraversavano, il fiato rimaneva sospeso e le veniva irresistibilmente da abbassare la testa e sorridere, stretta tra piacere e paura. Sempre troppo presto arrivava il momento di lasciarla, la Ville Lumière, proprio quando le sembrava di cominciare a orientarsi, di riconoscere qualche strada o negozio, di sentire nascere tra lei e la città un accenno di abitudine, una piccola vena d’amore. La lasciava a malincuore, eppure c’era un ché di gioioso anche nel tornare nei posti suoi, nel riconoscere la campagna ondulata, le isole verdi in mezzo alla Loira, le rive sabbiose, le siepi di lillà e di glicine appoggiate come cascate di fiori contro le case di arenaria bianca. I posti dove siamo nati non si rinnegano facilmente, nemmeno per Parigi, tantopiù se sono belli e dolci, immersi tra lunghe distese di campi, se ci si arriva attraverso piccole strade sinuose, strette tra querce alte e sottoboschi profumati. Dietro la curva larga cominciava il viale; da lì, tra i rami radi dei grossi platani, già si vedevano spicchi del tetto di ardesia grigia, poi il bianco di qualche muro e finalmente il grande cancello nero, spalancato da sempre sul giardino. Appena scendeva di macchina, socchiudeva gli occhi e tirava un respiro lunghissimo. Si sentiva allo stesso tempo a casa e straniera in quel posto, lei, la giovane Catherine, seconda figlia di un padre tiepidamente amato, il flemmatico, ma assertivo e vitale, marchese de Buissay, tenente colonnello nel distaccamento militare della vicina Saumur. Le tracce della sua famiglia si perdevano in tempi lontani, andavano indietro, indietro fin oltre le guerre di religione. Il nome che portava era ricchissimo di memoria, un chiodo saldamente piantato nella storia, un nome certo molto più florido delle loro attuali rendite e depositi bancari; proprietà, pensioni, privilegi, erano rimasti impigliati nei rovi della storia, lentamente erosi, sfilacciati, consumati da grandi e piccoli avvenimenti; di fatto, in casa di soldi ne giravano pochi e gli inverni al castello erano duri: solo il soggiorno a sud, quello accanto alle cucine, veniva riscaldato e quando lei tornava dal collegio per le vacanze di Natale, gli altissimi infissi della grande camera in cui dormiva lasciavano passare orde di spifferi gelati. Le tre Grazie, paffute e seminude che un pittore da poco aveva affrescato sul soffitto e che da secoli danzavano davanti a cespugli fioriti, rimandavano a caldi climi mediterranei, ma da quel sole non era facile farsi stiepidire; di fatto, finché non si addormentava, imperversava sempre lui, il freddo, aggressivo, insistente, sfacciato. Lei si rannicchiava nel grande letto a baldacchino e infilava quasi tutta la testa sotto le coperte, cercando di tener fuori solo il naso e la bocca. Il fiato usciva a piccole nuvole opache che si disgregavano subito contro il bianco del guanciale. A volte le veniva da pensare come sarebbe stato bello avere accanto a sé un fidanzato, un uomo amato che la scaldasse e che la tenesse tra le braccia dicendole belle cose; ma quell’uomo aveva un ovale vuoto al posto del viso, Catherine non sapeva che aspetto dargli, nessuno dei giovani che aveva conosciuto e che l’avevano anche baciata era mai riuscito a impressionarla, a spandere brividi sulla sua pelle giovanissima e bianca; non si era mai innamorata, così che in quelle sere d’inverno, anche i sogni d’amore facevano poca strada nelle umide stanze del castello di Buissay. Un po’ meglio andava d’estate, quando amici o parenti passavano da loro e ci rimanevano qualche giorno. Catherine approfittava di quelle occasioni per far entrare spruzzate di aria fresca nell’andamento piatto e spartano della sua vita, anche se alla fine erano più gli elementi liquidi che quelli gassosi a creare un po’ di straordinario. Quando c’erano ospiti, infatti, sul vino non si lesinava mai e dopo le prime portate, nessuno più stava a contare quanti bicchieri buttavano giù le ragazze, sia Catherine che sua sorella. Il vino, prodotto nella regione, anzi, nella fattoria poco sotto il paese che una volta era stata loro, spesso era un ottimo Crémant de Loire, bianco e mussante, un po’ più dolce dello champagne, ma altrettanto leggero e apparentemente innocente: andava giù come acqua e tornava su in risate facili, in immagini vagamente confuse, in tonfi nel letto dove alla fine della serata si gettava a peso morto per arrivare tutta d’un colpo alla mattina successiva, senza dormiveglia, senza freddo, senza pensieri, né sogni, né progetti di fuga. Ma anche quando i suoi bicchieri erano pochi, quelle serate, soprattutto verso la fine, se le sarebbe ricordate sempre come molto gradevoli. Quando mangiavano con gli ospiti, veniva apparecchiato fuori, sul prato che le due piccole ali del castello formavano con la lunga facciata dalle alte finestre bianche, uno spazio molto piacevole, raccolto e aperto allo stesso tempo. Dopo il dessert suo padre prendeva una bottiglia ben fredda di quel vino spumante, si piazzava davanti al tavolo con le spalle ai commensali, e la “sabrava”, cioè prendeva un “sabre” - una spada appunto -, un oggetto che in una casa con cinque secoli di militari alle spalle si trovava appeso o riposto un po’ dappertutto, e con un colpo secco e preciso recideva di netto il collo della bottiglia, a un paio di centimetri sotto il tappo. Il grosso sughero schizzava via lontano, portandosi dietro il suo involucro di vetro e finiva tra l’erba, a zittire qualcuno dei tanti grilli che riempivano l’aria della sera. Da quelle parti, nella stagione calda, i grilli c’erano sempre, si facevano sentire di giorno e di notte, insieme concertavano un sibilo pulsante che saturava tutto lo spazio, un suono simile a una fittissima e monotona sezione d’archi; erano loro la musica di sottofondo della sua terra e Catherine li avrebbe sempre attesi e amati. Il vino spumeggiava fuori dalla bottiglia come da una sorgente, ma non se ne perdeva molto perché i commensali si erano già alzati e stavano intorno porgendo i bicchieri. C’era un’atmosfera di composta euforia, tutti chiacchericciavano, le voci si sovrapponevano, ci si appoggiava alle spalliere delle sedie, si rideva… Allora il Signore di Buissay sollevava il calice e, guardando al di sopra di quello, in direzione dei grandi platani del parco, un po’ ironico e un po’ compunto, ripeteva il vecchio brindisi del suo corpo d’armata: “A nos femmes, à nos éscaliers, à nos chevaux, à nous qui les montons, et mort aux cons.”. Se c’era tra gli invitati qualche nuova ospite, allora per lei si perdeva in spiegazioni arcinote, ma intorno alle quali nessuno mostrava di annoiarsi: “… Nella Cavalleria di Saumur, Signora, questo gioco lo si fa da cavallo, colpendo al volo la bottiglia posata sul tavolo. Allora è molto più difficile, mi creda. Spero mi scuserà se stasera il mio cavallo non è voluto venire…”. Tutti ridevano e di nuovo si riempivano i bicchieri già vuoti. La spada, strumento muto di quel buonumore, non si sapeva mai dove metterla in attesa del suo prossimo servizio, per cui finiva sempre per essere appoggiata a caso sul tavolo ancora apparecchiato; la sua lama di ferro scuro spiccava contro il bianco della tovaglia damascata; giaceva là, rude e spaesata, circondata da delicate porcellane di Gien e eleganti argenterie. A volte, guardandola, Catherine si trovava a pensare quanti fegati e intestini aveva trafitto, quante urla aveva strappato, quanto sangue le era colato sopra, prima di diventare un brillante cavatappo. Se non riusciva a scacciar via subito quei pensieri, la prendeva una nausea sottile, un disgusto diffuso, uno strisciante e persistente disagio di fronte agli altri e a se stessa; ma perché nessuno si poneva quella stessa, ovvia domanda? Perché tutti facevano finta di nulla? Abbassava lo sguardo sul calice che trastullava tra le mani, guardava le bollicine sollevarsi dal fondo leggere e allegre, e si sentiva sola, ancora più sola che nella sua camera. A parte quelle serate, a casa non veniva quasi nessuno e i viaggi, di solito a Parigi o a Tolosa, erano rari e nemmeno tanto divertenti. Il più delle volte, anche d’estate, si rimaneva a casa e basta. Stretta tra la noia e l’austerità, rigirandosi nel suo letto di quercia scricchiolante, Catherine si scaldava al pensiero che prima o poi se ne sarebbe andata, a Parigi, all’estero o in un posto caldo vicino al mare. La mattina si guardava nello specchio dalla toilette, trattenuto da due grandi delfini di noce tarlato, e gli sorrideva con benevolenza, certa che non era lì che si sarebbe vista invecchiare. Poi un giorno, per miracolo o forse per intercessione di quelle brutte Muse che l’avevano vista tante volte tramare, come una vincita inattesa, le venne offerta un’occasione straordinaria. Fu il fratello di sua madre, lo zio che insegnava a Tolosa che gliela portò, racchiusa in una busta gialla con un francobollo straniero. Era settembre. Catherine l’agguantò al volo, quasi con avidità e già i primi di ottobre dormiva nella sua nuova camera, nella bella casa nel centro di Siena dove un docente universitario collega di suo zio, le aveva proposto di soggiornare almeno un anno, per insegnare il francese ai suoi due bambini. A Siena l’autunno vestiva per lei colori di primavera: libera per la prima volta da famiglia e collegio, depositata in un paese vagamente amato, in una bella città d’arte con clima asciutto e riscaldamento centrale, Catherine sentiva la vita, la sua propria vita, zampillarle intorno piena di luce e di ossigeno. Là si sentiva più forte e più bella. Aveva diciannove anni e il mare a soli sessanta kilometri. I suoi ospiti la tenevano in grande considerazione: il fatto che fosse di discendenza nobile contava molto nella casa del professore, un uomo che veniva da una famiglia di piccoli commercianti e le cui idee, se non propriamente reazionarie, si potevano definire senz’altro conservatrici. I parenti e amici che venivano in visita la trattavano con riguardo e si impegnavano a ostentare davanti a lei il loro miglior francese; ma dopo poche frasi, i più si arrendevano e passavano a un italiano lento e ben scandito, guarnito di spiegazioni su qualche vocabolo: “A Siena si parla il miglior italiano del paese, savez-vous, Mademoiselle de Buissay? Il migliore, “le meilleur”, veramente! “Catherine imparava anche da loro, comunque frequentava regolarmente un corso di italiano in un istituto della città e con l’aiuto dei libri, dei familiari, dei bambini e di Angela, la donna di servizio, progrediva velocemente, sentendosi sempre meno straniera in quella antica “ville rose” che per i suoi colori le ricordava tanto i suoi soggiorni a Tolosa. Siena l’aveva anche accesa d’entusiasmo per l’arte e la sua lunga storia. Colpita dalla qualità e dalla quantità delle belle cose che la circondavano, passava tutto il suo tempo libero tra chiese, musei e palazzi storici; la ricchezza della città non sembrava avere fine. Catherine si sentiva molto bene, a volte le sembrava che la vita seguisse docile il corso dei suoi desideri. In casa, oltre ai soliti frequentatori, passavano ogni tanto anche dei laureandi, quelli di cui il professore seguiva le tesi. Una sera di novembre, quando la città respirava tra luci accese e pioggerelle, passò di là anche Riccardo. Quando suonò il campanello, Angela non c’era; Catherine lasciò i bambini e andò a aprire. Riccardo stava a mani conserte sul pianerottolo, alto, magro, il cappotto chiaro schizzato di piccola pioggia. La guardò sorpreso: “Buonasera, signorina – disse con un breve inchino della testa – avrei un appuntamento col professore”. Anche lei, che non lo aveva mai visto prima, rimase impressionata dalla sua figura. Notò le guance incavate, il viso lungo , le palpebre ricadenti e leggermente oblique sotto cui brillavano occhi di una luce sfolgorante. Catherine rimase un attimo immobile guardando in alto verso di lui, poi si scostò al lato senza sorridere: “Prego…” disse rotolando in quella parola la “r” come suo solito e restringendo la “e” fin quasi a inghiottirla. Tornó nella stanza dei bambini portandosi addosso un semino di inquietudine che non l’avrebbe mollata e che già quella sera, quella notte, e poi il giorno dopo e i giorni dopo ancora, cominciò a germogliare e a spandersi. Era un semino informe e ancora innocente, ma pervaso di una luce fortissima che dava calore al suo solo pensiero. Nemmeno Riccardo riuscì a liberarsi da quell’incontro imprevisto. Subito cominciò a darsi daffare su tutti i fronti per trovare il modo di rivederla. Si impegnò al massimo per sapere delle sue abitudini, per avere il modo di incontrarla presto, sola e fuori da quella casa. Attraverso amici e amici di amici, riuscì a sapere dove si teneva il corso di italiano che frequentava. Era fatta! Da lì fu facile incontrarla per caso sulla via del ritorno, riconoscerla, salutarla, parlarle disinvolto e invitarla a visitare il Convento dell’Osservanza, una delle perle meno note, ma non meno belle di Siena. Sarebbe stato il sabato prossimo. Quel sabato pomeriggio venne davvero, atteso da entrambi sul filo di occupazioni diverse, ma con la stessa trepidazione e intensità. Girarono per il giardino, la chiesa e il chiostro, parlarono a lungo capendosi benissimo come se le difficoltà linguistiche non esistessero; ma mentre riempivano di sguardi intensi e di parole innocenti il tempo che velocissimo passava, tutti e due stavano in attesa di un qualche grosso avvenimento, di una rivelazione che già sentivano serpeggiare tra di loro; gli affreschi, i polittici, le lucide terracotte dei Della Robbia, erano tutti angeli che ammiccavano a un certo messaggio, l’aria tutta intorno a loro era satura di annunciazioni. Eppure non succedeva niente. Catherine aspettava senza fretta, sicura che qualcosa stava per accadere; la luce negli occhi di Riccardo era un lago splendente in cui si lasciava scivolare col piacere con cui ci si tuffa in un fondale noto, chiaro e privo di pericoli. Si sentiva piena della presenza di lui, della sua voce, delle sue parole, se lo sentiva vicino come se si conoscessero benissimo,. Riccardo tuttavia non disse niente di sentimentale, né osò mai sfiorarla, nemmeno quando si accorsero che si avvicinava l’ora di chiusura e si dovettero affrettare verso l’uscita. Fuori da quel convento la città si riaffacciò allegra, illuminata e ricca, intrisa dell’atmosfera speciale del sabato pomeriggio invernale. Passarono dietro al Palazzo Pubblico, lo costeggiarono e poi scesero nella larga piazza sottostante, dove sorgono i loggiati del Vecchio Mercato, un posto che, pur se a pochi metri da Piazza del Campo, di sera ha l’aria dimessa di un retrobottega, poco frequentato, illuminato modestamente e quasi privo di negozi. Su uno dei suoi lati, accanto a due grandi saracinesche grigie, si stendeva sul muro la lunga insegna spenta di un ristorante al momento chiuso. Le vasche di terracotta con i cespugli di lauro che d’estate schermavano i tavolini apparecchiati, erano rimaste là, polverose e inerti come navi in disarmo; ancora composte a quadrato, regolarmente intervallate da brevi spazi vuoti, delimitavano ora un inutile giardino, lastricato e oscuro. Quando ci passarono davanti Riccardo dette un rapido sguardo in giro poi, con forza gentile, la sospinse lì dentro. Il lauro si richiuse frusciante dietro di loro. Ci volle molto tempo perché arrivassero a dirsi qualcosa: prima dovevano baciarsi e ribaciarsi e ribaciarsi ancora; Catherine sentiva le mani percorrerle il seno e la schiena sotto il cappotto, non riusciva a tenere gli occhi aperti. Avvertiva intorno a sé quel fragile muro di verde e le sembrava una muraglia di ferro che proteggesse il paradiso, il paradiso vero; il mondo intero si era concentrato in quella briciola di spazio di cui Riccardo era l’unico epicentro. Se lui avesse voluto, avrebbe potuto prenderla così, quasi in mezzo alla strada, non avrebbe incontrato nessuna resistenza. Si baciavano senza stancarsi mai, loro, gli innamorati, lì, dietro il Palazzo Pubblico, a pochi metri dall’affresco in cui Guidoriccio da Folignano, partito da un lontano maniero, faceva la sua eterna cavalcata nell’aria azzurra scura verso una cittadella lontana, una meta che non raggiungerebbe mai. Anche Catherine si era lasciata alle spalle un castello, anche lei stava viaggiando nel blu fondo della notte, anche per lei il tempo era diventato trasparente, vuoto e sospeso. Il collo di Riccardo aveva un odore meraviglioso, la nuova barba premeva appena sotto la pelle, si faceva sentire tra le labbra come uno strato omogeneo di granulosità tenere e appetibile. Le mani sotto i vestiti l’assillavano dolcemente, la cercavano da ogni parte, come se tutto dovesse essere preso in quell’unico momento o mai più, come se lui vestisse quella sera i panni neri di un antico conquistatore spagnolo, forte di un’autorizzazione divina, che avanzava risoluto e inarrestabile, prendendo possesso di tutto quello che incontrava sul suo cammino. Di solito la nebbia a Siena non c’è, ma quella sera appena calato il buio, era improvvisamente comparsa, inondando piazze e vicoli, spandendosi consistente e spessa. Accovacciata nella bruma fitta, la cittá se ne lasciava toccare in ogni suo punto, si immergeva pigra coi suoi colori e le sue forme medioevali in un bagno per lei inusuale, in un’aria molliccia, umida e granulosa; intorno ai lampioni, la luce si addensava in aureole gialle, dense e quasi tattili. Alzando lo sguardo, la geometria delle case e delle torri si sgranava in architetture sempre più vaghe che il cielo presto ingoiava; non si vedeva oltre una decina di metri. Una cortina opaca invadeva anche la prospettiva delle strade, il loro stringersi in lontananza, così che quelle in salita sembravano proseguire su fino al cielo e quelle in discesa giù fino agli abissi più profondi. Ma nel cuore di quella città, a un passo dal suo Palazzo Comunale, pulsava in segreto una minuscola isola verde, calda, selvaggia; un piccolo nucleo lussureggiante, stracolmo di umori e temperature tropicali. Su quell’isola, Riccardo e Catherine erano gli unici naufraghi. Quando qualcuno è innamorato e per di più ricambiato, è difficile che non lo dia a vedere. Nella sua nuova casa se ne accorsero tutti presto, né al capofamiglia mancavano i modi per avere tutte le informazioni che voleva. “Mariani… - chiese il professore a Riccardo quando di nuovo andò da lui per la tesi – lei lo sa come si dice in francese “laurearsi a pieni voti e senza intoppi”?”. Riccardo tacque. Nella simioscurità dello studio, la lampada di bronzo illuminava il piano verde della scrivania, il portacenere fumante e la stilografica con cui mani nodose giocherellavano, facendola oscillare lenta sopra le pagine della cartella appena consegnata. Gli occhi dell’istologo si sollevarono chiari e pungenti verso di lui e lo beccarono che sorrideva con la testa abbassata. “Professore – e a quel punto la testa si sollevò e il sorriso gli si aprì del tutto – io, appena mi laureo, Catherine la sposo!”. E più che come una dichiarazione di intenti, lo disse col tono squillante di un ordine indiscutibile. Capitolo XXII I mesi passarono tra amori furtivi e progetti dorati. Da quando si era innamorata Catherine era diventata ancora più bella, o così perlomeno sembrava al futuro marito e a tutti quelli che la conoscevano. “Come si vede che ti piace tanto il mare – le diceva il fidanzato carezzandole il viso – te lo porti da sempre tutto negli occhi. Ma lo avrai il mare, amore mio, stai sicura che se ti piacerà andremo a stare in un posto dove lo potrai vedere ogni mattina e ogni notte”. Anche per lui era facile immaginarselo, il mare, mentre si immergeva nell’azzurro terso e intenso degli occhi di Catherine, occhi lucenti di donna giovane, grandi, puliti, sgombri di rimpianti e di nostalgie. Così, al seguito o alla testa del suo innamoratissimo marito, era finita in un piccolo centro della Maremma, lei, per il paese “la parigina”, per Riccardo la compagna, l’amante, l’amica, l’universo. Dopo due aborti e un bambino partorito morto, di figli non ne volle più sapere. La grande casa si gonfiò ulteriormente di cani, di gatti, di altri libri, di piante e di fiori di ogni genere. Riccardo le fece costruire una grande veranda nella facciata che dava sul mare, un giardino d’inverno dove l’inverno non entrava mai. Arianna andava tante volte a casa di Catherine e quando entrava in quella stanza, si sedeva al tavolo tondo con un piacere speciale: il tè e i biscotti lì erano più buoni, si guardava il mare e sembrava di stare nella cabina di comando di un transatlantico; la luce entrava dappertutto e l’aria aveva un odore vagamente acuto, come se oltre alla coppia di bianchi maremmani stesi sul tappeto, ci si aggirassero anche cinghiali e branchi di bruna selvaggina. Se mai era contrariata, Catherine trovava l’occasione per tirare fuori una frase ricorrente: “Touraine mi fè, disfecemi Maremma” diceva, poi ridacchiava e guardava divertita l’espressione disorientata sul viso della ragazzina. In quella bella stanza, senza confini tra fuori e dentro, dove i muri sembravano fatti di palme, di buganville, di foglie di peltandra, la bambina Arianna ci andava appunto molto spesso, quasi tutti i giorni, dopo la scuola; era lì che Catherine l’aiutava a fare i compiti. Se non poteva darle subito attenzione, tirava fuori un libro a caso tra quelli di grande formato che si pigiavano negli scaffali del soggiorno: “Sfoglia un po’ questo intanto – le diceva scivolando sul tavolo il pesante catalogo di un museo – tra un attimo sono da te”. Grazie alla sua seconda maestra, Arianna aveva imparato a decodificare certi simboli nascosti nei tanti quadri che vedeva: sapeva che uno con una foglia di palma in mano è un martire, che San Giacomo ha la conchiglia, San Lorenzo la graticola e Diana la mezza luna, che Santa Caterina, quella con la ruota dentata, non veniva da Siena, ma da Alessandria d’Egitto. A forza di sfogliare quelle pagine patinate, un po’ si orientava tra file di dei, di santi e storie della Bibbia. Tuttavia quei libri, con le loro belle immagini, le città antiche, i cavalli, i festini, i miti, le davano anche una certa apprensione perché spesso accadeva che girava pagina e si trovava davanti delle scene sanguinose e cruente: martirii, battaglie, torture. Fu lì che si insinuarono nella sua mente i primi, confusi dubbi sulla legittimità a esistere della sua specie. Quelle immagini la impressionavano molto e a volte le tornavano in mente la sera, quando stava per addormentarsi. “… Ma che fanno questi? – domandava a Catherine – Che schifo!”. “E’ vero, - sospirava lei guardando costernata un martirio di Sant’Agata o una Strage degli Innocenti – la vita però è anche questo, anzi, per alcune vite è solo questo. Bisogna sapersi difendere, a volte semplicemente nascondersi. Si dovrebbe tutti avere una torre dove poterci al bisogno rifugiare insieme alle nostre cose più care; cose piccole, maneggevoli, ma preziose. Sarai diventata grande quando ti sarai costruita anche tu la tua torre e le tue provviste, vedrai. Lo sai che c’è nella mia torre? – continuava Catherine prendendo un tono di sfida – ci sono tre “A”: Arte, Amore, Animali” e la guardava fissa, sgranandole addosso i suoi occhi più azzurri del mare di fronte. “Art, Amour, Animaux…” aggiungeva, e appena sfiorava parole francesi, la voce le cambiava di timbro, la frase seguiva una musicalità più dolce, il viso si fletteva leggermente su un lato e gli occhi le si socchiudevano un po’. Arianna non avrebbe mai capito, nemmeno molto dopo, quando anche la sua di torri si drizzava alta e agguerrita, nemmeno allora avrebbe saputo dire quante e quali cavità il mare non aveva saputo riempire nell’anima fine e gentile di Mademoiselle de Buissay. Quando Arianna entrò in quinta elementare, Catherine cominciò a dirle che era tempo di prendere familiarità col vocabolario, di imparare a trovarci subito quello che ci si cercava. “Le parole sono importantissime – le diceva – sono l’acqua della vita, soprattutto di quella sociale. Bisogna conoscerle, possederle in pieno, sono loro che danno la chiarezza della sostanza come la ricchezza delle sfumature, e le sfumature contano. Le parole sono strumenti da imparare a domare, da subito; devi averle tutte al tuo servizio, devi arrivare a piegarle finché non aderiscono come un guanto al tuo pensiero; se le conosci potrai dosarle come un abile farmacista e ottenere, alla frazione di grammo, la miscela che vuoi tu, senza contare che più ne sai usare, meglio le sai collegare, più alta sarà la densità di quello che comunichi, a te stessa e agli altri. Ah… - aggiungeva - naturalmente sarebbe bene anche avere qualcosa da dire…”. E ridacchiavano tutte e due, la maestra e la scolara, come se fosse stata detta una malignità o una barzelletta audace. Arianna stava molto volentieri con la sua “istitutrice”, anche se spesso non capiva quello che le diceva; ma non importava, accoglieva la valanga delle sue asserzioni con la sottomissione acritica con cui si ascoltano le previsioni del tempo, le credeva così come si crede a una guida alpina quando la si segue attraverso i percorsi insidiosi delle sue montagne, con passività e fiducia. Così, per pura docilità infantile, Arianna faceva quello che le veniva richiesto e cercava parole sul vocabolario, quelle sconosciute che via via incontrava, ma anche quelle note, nel tentativo di far sciogliere nella sua testa il rugginoso meccanismo dell’ordine alfabetico. “Ora vorrei cercare la parola “cronico” – disse un giorno a Catherine – l’ho sentita dire da Riccardo quando parlava col babbo a proposito della mamma”. Riccardo e suo padre erano molto amici, si vedevano spesso e la domenica andavano a pescare insieme, a volte anche con la barca, in alto mare. “ “Cronico” – lesse – si dice di malattie che si prolungano per un tempo indeterminato, per distinguerle dalle acute, che hanno uno svolgimento rapido”. Ci rimase male “… Vorrebbe dire che la mamma non guarirà mai?” chiese incredula. Non era possibile, tutte le persone che si ammalano, dopo un po’ guariscono, soprattutto quelle che non sono vecchie. E poi non era per niente chiaro che sua madre fosse malata. Non aveva la febbre, non doveva stare a letto, non le doleva da nessuna parte. Dov’era malata? Catherine intanto si era immobilizzata sull’orlo che stava imbastendo; posò il lavoro sul grembo, ma strinse un lembo di quella stoffa nella mano prima di mettersi a giocherellare con l’anello da cucito . “Riccardo vuol dire che la mamma avrà per molto tempo bisogno di qualcuno intorno a lei, forse dovrà prendere sempre, ecco perché la parola “cronico”, sempre delle medicine; ma prima di tutto non è sicuro che andrà in questo modo perché la medicina progredisce veloce, e poi, anche se così fosse, non è un disastro, sono moltissime le persone che vivono bene anche con queste limitazioni. E’ molto frequente, non ti preoccupare”. Arianna infatti non si preoccupava più di tanto per sua madre: non era certo una novità che stesse a ore chiusa in camera, né che mangiasse pochissimo, e non volesse mai uscire. Era tanto che le cose andavano così; per il resto, ogni giorno veniva la Luisa, puliva e faceva da mangiare, tutto era normale. Arianna non aveva certo notato che in cucina non si trovava un solo coltello nei cassetti, che la chiave del bagno e delle altre stanze erano sparite, che la luce nella camera dei suoi genitori di notte non si spegneva mai. Dato che c’era, chiese a Catherine anche cosa voleva dire “stato depressivo”, perché anche quello sentiva dire, ma sul vocabolario non l’aveva trovato. “Vuol dire che la mamma non sta bene nell’anima, che si sente sempre come fosse sola, anche se intorno ci sei tu, il babbo, la Luisa. La sua malattia è che vive come se davanti a sé avesse un muro…”. “Un muro?” “Un muro spesso e trasparente che la tiene lontana dalle persone a cui vuole bene, così come dalle cose, da tutte le cose, quelle belle e quelle brutte. E’ come in questa stanza, vedi? Lì, a un passo, c’è il giardino, l’aria aperta, il mare; lei magari ci vorrebbe andare, ma non può perché c’è un muro di vetro che la tiene di qua e che alla lunga le leva anche la voglia di oltrepassarlo”. “Ma esiste anche la parta…”. Obbiettò Arianna. “Infatti, ma uno stato depressivo vuol dire proprio questo, che la persona malata non riesce a trovare quel passaggio, per questo deve essere aiutata, curata… come la mamma”. Ma sua madre quella porta, nonostante terapie, consulti, ricoveri, non riuscì a trovarla mai. Cinque anni dopo entrò vestita nella vasca da bagno e non ne uscì più. Arianna si ricordava benissimo quei giorni, la gente, il funerale, suo padre, l’odore dei fiori, i carabinieri, l’inumazione. Tutto sembrava reale eppure non vero. Per qualche settimana andò a stare da Catherine, era senz’altro preferibile alla casa vuota, al suono della pendola, al viso sperso di suo padre. In quei giorni lei e la sua maestra lavorarono molto fuori, in giardino. Il pomeriggio il mare spingeva in gola aria salmastra e il vento spazzava con forza il cielo e la mente. Arianna se lo faceva entrare dentro tirando lunghissimi respiri voraci. Per fortuna c’erano oltre duecento metri di siepe di lauro da potare; alcuni rami erano spessi, le forbici non ce la facevano a tagliarli in una volta sola, contro quelli era bello accanirsi, insistere e stringere con tutte le forze le cesoie finché, dopo una dura lotta, il ramo non si staccava e cadeva frusciando sull’erba, con movimento lento e teatrale. I cani, grosse macchie bianche sul verde del prato, si sdraiavano accanto a loro e appena si spostavano per potare più oltre, si alzavano pigri e le seguivano, metro per metro. Il tè andavano a prenderlo nella stanza a vetri, come sempre. Mentre scansava una sedia intorno al tavolo rotondo Arianna urtò una palma: il vaso si rovesciò, la pianta andò giù, il terriccio si sparse nero sul pavimento. Lei si chinò per raccoglierlo, ma alla prima manciata che strinse tra le mani, si fermò e scoppiò a piangere, china col viso sulle proprie ginocchia, tanto curva che poteva sentire nel naso l’odore della terra umida sparso intorno. Pianse a dirotto per lunghissimi minuti e Catherine accanto a lei che le parlava, l’accarezzava, l’abbracciava. La siepe fu potata tutta, ebbe modo di ricrescere e di essere potata di nuovo; per molte volte. Il tempo passò e colmò con strati di foglie secche anche quella profonda voragine. Arianna aveva allora vent’anni, un anno di Filosofia alle spalle e il ventre e il seno già da mesi ingrossati. Fu allora che cominciò la lunga avventura del suo matrimonio; Marco era bello, dolce e affettuoso, l’amava teneramente e stava per avere un posto di assistente precario presso la facoltà di chimica di una grande città. Via dalla provincia, via dalla nuova moglie di suo padre, via dai posti gonfi di ricordi di piombo. Ma anche via da Catherine, dalla sua amica Claudia, via dall’aria sempre aperta e ventosa, impregnata di odori di mare e di bosco. Non importava, ora bisognava partire. Come dono di nozze, Catherine e Riccardo le regalarono un’elegante carrozzina azzurra e uno stupendo vocabolario etimologico, un libro che Arianna avrebbe amato moltissimo e che si sarebbe portata sempre dietro, anche nella clinica dove andò a partorire. Quando si internò, sapeva già tutto sull’origine di “feto”, “latte”, “placenta”, “vagina”, “vagito”. Il giorno del matrimonio Catherine le fece anche da testimone. I suoi occhi brillavano come stelle azzurre sotto le palpebre cadenti, illuminavano gli sposi sorridenti, la fascia del sindaco, i velluti rossi delle poltroncine. Quel giorno Mademoiselle de Buissay aveva addosso gioielli di famiglia e un vestito di seta cruda color oro e verde tenero; non era più giovane, ma ugualmente bellissima, sembrava un fiore tropicale immerso nel sole della mattina. Aspettò che tutti l’avessero fatto, e poi, quasi per ultima, andò a abbracciare la sposa. Svelta e discreta, senza farsi notare dagli invitati che parlottavano intorno, si sfilò dal dito un anello, una marquise di zaffiri vecchia cinque generazioni, e gliela mise nell’anulare della mano destra: “che ti veda felice come ha visto felice me”. Le disse a occhi asciutti mentre le loro guance si sfioravano. Quell’anello Arianna lo avrebbe portato sempre; nel corso degli anni gli cambiò posto un paio di volte e ora, già da molto, abitava sovrapposto alla fede nuziale, sull’anulare della mano sinistra. Da quando aveva cominciato a ripescare tutte queste storie lontane e a raccontarle in fila a Gabriele, non aveva mai smesso di giocherellare con quell’anello, quasi ne traesse una magica energia. Appoggiata contro di lui, stava seduta sul muretto di una chiesa di campagna; alle loro spalle si alzava un piccolo loggiato quattrocentesco, scrostato e muffoso, davanti scendevano lunghe strisce di vigneti e campi di giovani olivi. L’aria era ancora asciutta, il confine tra cielo e terra limpido e lontano. Il suo raccontare l’esaltava, le dava un piacere quasi fisico; le parole salivano su come se non lei, ma una qualche divinità le componesse attraverso la sua bocca; le uscivano chiare, fluide, piene di significato; attraverso di loro stava tessendo la storia stessa della sua identitá. Ma Catherine era ancora là che sorrideva, col suo vestito luminoso e i doni quando, senza motivo né preavviso, violenta e inarrestabile, una forza inattesa si fece avanti, si piazzò davanti a lei e ruppe improvvisamente il bel meccanismo che aveva fino a allora diretto. Arianna cominciò a rallentare, a incepparsi; i ricordi, fino a allora fluidi, smisero di susseguirsi in armonia, persero ordine e chiarezza, ruppero le righe, si dispersero. Sentì la voce diventarle meno sicura, la gola stringersi, i fili della narrazione andare a mescolarsi in un’unica matassa appiccicosa. Le chiare immagini che avevano alimentato il suo racconto stavano prendendo vie impreviste, autonome, selvagge, erano gocce di mercurio che non si lasciavano più acchiappare. La memoria razionale era saltata, presa d’assalto da una florida anarchia di nostalgie e di rimpianti che le bruciavano addosso come fuoco; era un attacco concertato di emozioni che mescolavano tutto e la sopraffacevano senza lasciarle vie d’uscita. Il cinguettio rado degli uccelli cessò, gli olivi e i vigneti si fecero diafani, poi sparirono del tutto dietro uno strato biancastro e salato. Era stata tanto tempo senza piangere, mesi, forse anni. Da quando conosceva Gabriele, alcune volte le era sembrato di stare per farlo, ma era sempre riuscita a contenersi finché la tentazione era passata. Ora però si sentiva come una città che si arrende dalle fondamenta, le mura si sgretolavano, le palizzate crollavano, non era più possibile difendere, nascondere, contenere niente; una grande massa vischiosa stava dilagando, trascinando con sé i pezzi doloranti della sua vita, dai sassolini, ai ciottoli, ai macigni. Arianna si lasciò andare a quel pianto di origine lontana, non cercava nemmeno Gabriele, anche lui era come scomparso, volato via. L’unica cosa che esisteva era una forza grande che la teneva premuta dentro un amalgama ribollente in cui il raziocinio non riusciva a mettere nemmeno un dito. Guardava fisso davanti a sé e non distingueva nulla, vedeva solo squarci di luce filtrare attraverso lacrime lente che le scendevano sul viso col ritmo disuguale di una pioggia rada. Sentiva allo stesso tempo sollievo e dolore, dolore e sollievo. Capitolo XXIII Due piccioni si corteggiano sul tetto. La primavera preme contro l’inverno, lo stringe coi primi biancospini e con miriadi di piccole foglie verdissime che spuntano ovunque da insignificanti cespugli; l’aria è gonfia di odori fragranti, era un pezzo che non se ne sentivano. L’erba nuova è ripartita e cresce inarrestabile dappertutto. I mandorli in fiore sopravvivono alle notti ancora fredde, presto seguiti dagli altri alberi da frutta; è chiaro che stanno vincendo loro, che tra un paio di settimane persino i rami nudi delle querce si dovranno arrendere e ripartire. In cittá le ombre sull’asfalto dei viali si inspessiscono giorno per giorno, a volte è persino gradevole cercarla, l’ombra, quando il sole preme sui vestiti troppo invernali. Anche la temperatura intorno alla vita di Arianna ha conosciuto grandi alzamenti: ha un amante da oltre sei mesi, un periodo breve durante il quale peró quantomeno una cosa in lei è vistosamente cambiata: ha imparato a mentire. Mente sistematicamente, come una prostituta; mente per depistaggi, per aggiunte, per omissioni; mente a suo marito, a sua figlia, a parenti, a vecchi amici, a conoscenti. Con Marco, ha acquistato alcune accortezze di metodo, tipo prendere tempo prima di ogni risposta e controllare subito se si contraddice, oppure cercare di depistare gli argomenti di conversazione lontano dal terreno scivoloso dell’organizzazione quotidiana. Si è creata abitudini e impegni nuovi che le consentono uscite e sacche di tempo da riempire con altre bugie. Chiama le sue crescenti furbizie “cautele”, i suoi ripetuti sotterfugi “necessitâ”. A volte riesce persino a convincersi che la situazione è equilibrata e proficua per tutti: lei è piú disponibile, piú distesa e proprio per questo suo distendersi la sua superfice aumenta e diventa piú facilmente divisibile per due. Passata la fase febbrile dei primi tempi, la sua nuova situazione sentimentale sta prendendo forme piú tranquille, sta cominciando a sedarsi. Si sente sicura, si permette piccole sfide alla prudenza: è andata con Giorgio a trovare Gabriele in ambulatorio. Era una sorpresa. E’ entrata col cane come una qualsiasi cliente. Hanno fatto l’amore appoggiati al tavolo di acciaio inossidabile, in dieci minuti, mentre Giorgio, che ha l’abitudine di intromettersi negli amplessi altrui, abbaiava e guaiva rinchiuso nell’attigua sala operatoria. Le è piaciuto moltissimo, esce dalla porta a vetri e saluta compostamente gli altri clienti in attesa, piú che certa che nessuno si è accorto di niente . Con Marco é premurosa e piú paziente del solito ; mette maggiore impgno a cucinare per lui, non lo accusa piú di assuefazione al televisore se si guarda intere partite e programmi sportivi. La TV é qualcosa che Arianna non sopporta, non riesce a sopportare l´idea di vedere il tempo della propria unica vita infrangersi e sbriciolarsi in spuma inconsistente davanti a un apparecchio acceso ; di conseguenza le dispiace di vedere qualcuno a cui vuol bene farne uso, crede in buona fede di aiutarlo se cerca di dissuaderlo dal guardarla. Ora é diventata piú tollerante. Che Marco si gusti pure le sue trasmissioni, purché sia contento. I loro rapporti sessuali non hanno subito sensibili variazioni né di frequenza né di qualitá. A parte questo peró, le sembra che il suo consorte le faccia a volte delle domande tendenziose, come per controllare l´esattezza delle sue risposte, ma in ultima analisi i suoi timori si sono sempre rivelati vani, prodotti piú dalla propria sospettositá che da qualla di lui. La mettono comunque a disagio certe coincidenze, come quando torna da un appuntamento clandestino e trova la cena pronta, un regalino, dei fiori o un´affettuositá verbale e fisica dichiarata e toccante. Ha imparato a non scomporsi nemmeno in questi casi ; si concentra e preme il pulsante di un meccanismo che si é gradualmente costruita e che manovra con sempre maggior disinvoltura. Con questo pulsante cambia programma : Gabriele viene con delicatezza rimosso e riposto nell´ala Sud del castello, dopodiché le porte si aprono sugli appartamenti a settentrione, un pó piú freddi e bui, ma pieni del rassicurante senso di soliditá che dá la tradizione. Giorgio fa il resto, riuscendo a rendere particolarmente gradevoli e festosi i rientri in famiglia. Quando lo porta fuori e puó permettersi di osservare in gaia solitudine la sua situazione, le capita di farsi prendere da una gioia debordante che richiede tutto il suo raziocinipo per essere controllata. « Nella vita avere un affetto profondo é giá un lusso – pensa mentre il cane le trotterella accanto facendo oscillare i suoi testicoli neri e lucidi - …averne due é un miracolo, ma tre !…Io invece ho intorno a me tre maschi stupendi, amati e che mi amano e uno piú bello dell´altro. »Si ritiene molto fortunata,ma allo stesso tempo avverte uno spiffero ghiaccio soffiare sulla sua ricca panoramica, sente la presenza di un´ombra minacciosa accovacciata sul suo futuro prossimo. « Come fará a durare ? » é la domanda che sempre si pone « Per ora dura, poi si vedrá. Lo diceva anche la mammma di Napoleone, la signora Letizia: ‘…Tant que ca dure…’ Io devo pensare proprio come lei. » Intanto peró cerca di spiare i piú probabili scenari che le si parano davanti: “Forse presto Gabriele si stancherá di me, mi mollerá e andrá a vivere con una delle sue giovani fidanzate. Mamma mia, speriamo di no! Che viva con la fidanzata mi sta bene, ma lasciarmi del tutto... Oppure Marco verrá a sapere di essere tradito e per la prima volta in vita sua diventerá durissimo e mi scaccerá. Chiara lo sosterrá al cento per cento e mi ripudierá come madre. Del resto, come potrei darle torto... Oppure tutte queste cose insieme, mi lasceranno tutti e mi ritroverè sola con Giorgio, sola con un cane; sí perché lui in nessun caso me lo lascio portar via”. Se lo chiama vicino, accarezza i suoi bei fianchi solidi e muscolosi. Sentendolo caldo sotto la mano, le viene da pensare che tra tutti è probabilmente lui che per primo dovrá morire. Se ne sente atterrita. Ma lui per fortuna non lo sa, fa qualche passo accanto alla sua padrona poi si stacca e va a orinare contro un grosso tronco ; annusa con passione un cespuglietto e riparte col passo leggero e la testa alta di chi ha davanti l´eternitá. Marco oggi ha finito di lavorare prima del solito e ne ha approfittato per fare un pó di spesa. La giornata giá calda e due piani di scale si fanno sentire: ha 44 anni, forse non si considera vecchio, ma volentieri usa l´idea di non essere piú giovane come alibi per alimentare la sua latente pigrizia, la sua reticenza abituale a intraprendere qualcosa senza esserne costretto. Poggia le borse davanti alla porta e aspetta che gli passi l´affanno. Dall´altra parte Giorgio lo ha giá riconosciuto e gli viene incontro pesticciando per il corridoio con brevi guaiti. ”Perlomeno c´é qualcuno che mi aspetta e é contento di vedermi!” Come sempre grandi feste: salti, scodinzolii, zampate e poi di corsa a prendere l´orsacchiotto e portarlo ai piedi del padrone che lo getterá nel soggiorno da dove lui di nuovo glielo riporterá. I rituali del rientro sono quasi sempre gli stessi. I cani sono esseri tradizionalisti e anche se si adattano a tutto, il massimo del piacere per loro é il ripetersi di ritmi e gesti noti. Sono come i bambini piccoli che vogliono rivedere lo stesso film o che gli si rilegga la stessa storia. Sulla tavola un biglietto:”Sono andata in centro, torneró verso le sei. Baci a volontá, Arianna” Marco si affonda nel divano, le mani sullo stomaco, le lunghe gambe distese sul tavolino; Giorgio, di nuovo calmo, si accuccia sul tappeto accanto a lui. Il biglietto viene appallottolato e gettato verso il cane che lo annusa per un attimo e poi lo ignora. ”Cosí oggi siamo andate in missione...” Si scansa i capelli dalla fronte, se li manda all´indietro passandoci dentro le dita come un pettine rado. Sensazione di fresco e di momentanea libertá. I doppi vetri delle finestre sono chiusi, la casa é avvolta nel silenzio. Intorno quiete e pulizia come nelle stanze di un monastero. Chiude gli occhi, i suoi occhi grigi che quando é al mare prendono cupi riflessi blu; Arianna glielo dice che, abbronzato e con quegli occhi, starebbe meglio su uno yacht con una top model che su un asciugamano accanto a lei. Ma anche quando é sua moglie a fargli dei complimenti sul suo aspetto fisico, si sente imbarazzato e non sa che rispondere. Molte volte si é proposto di tenersi in maggior considerazione, di valorizzare le sue qualitá, ma poi conclude che sta bene anche cosí e che comunque é troppo tardi per cambiare. Flette la testa all´indietro sui cuscini, il campo visivo si riempie del bianco omogeneo del soffitto, senza macchie né mosche, un grande schermo su cui puó proiettare le forme che abitano i suoi pensieri, immagini mutevoli e sfocate, ma tutte immagini di uomini maschi. ”Chi sará quello stronzo?...Un intellettuale smidollato, un musicista...o un bel tenebroso, irresistibilmente malinconico...uno studente di belle lettere pieno di idee sottili, un professore di liceo impegnato e colto, chiaccherone...” Marco conosceva bene dove stavano i punti deboli di sua moglie, ma anche escludendo imprenditori, palestrati o fiscalisti, la gamma delle possibilitá rimaneva vastissima. “Bisogna subito che sappia chi é!” si era detto inizialmente, appena si era accorto di non essere l´unico uomo nella vita di sua moglie. Aveva conosciuto fasi di rabbia, di disgusto, di smarrimento, di depressione e alla fine aveva trionfato la grande paura di perdere Arianna del tutto. Forse lo avrebbe potuto aiutare uno psicologo –aveva pensato – qualcuno che lo guidasse nel vedere dove aveva sagliato. Ma gli psicologi non gli piacevano, era convinto che si puó arrivare a capirsi anche con le proprie forze.I problemi del suo matrimonio erano solo affar suo e da solo avrebbe dovuto analizzare, pensare, criticare e autocriticarsi fino a scoprire cosa non aveva funzionato; le spiegazioni potevano essere tantissime. Sul piano pratico invece, aveva davanti due sole possibilitá: o inasprire la crisi affrontandola di petto con Arianna, o continuare a sopportare, prendere tempo, aspettare e intanto rendersi ancora piú insostituibile. Il tempo lavorava per lui, ne era sicuro: le loro affinitá profonde, la loro lunga vita insieme, Chiara e ora anche Giorgio, tutto li univa con un legame fortissimo di cui non si sarebbe potuta sbarazzare facilmente.Senza muovere la testa, giró lo sguardo verso la libreria piena dei loro libri mischiati fraternamente: l´atlante storico accanto al vocabolario etimologico, Agatha Cristie e Simenon stretti tra Checov e Tolstoy, materiali diversi ma parificati dal loro valore. Cosí era per loro due: diversi ma cementati dalla qualitá antica della loro intesa. Altrimenti, come avrebbero potuto stare vent´anni insieme? “Allora perché un altro uomo? - si chiede - Ho forse sposato una baldracca?” A volte gli sembrava di capire Otello e la sua voglia incontenibile di strozzare Desdemona, anche se poi questi attacchi di gelosia mediterranea duravano poco e presto tornava se stesso, un uomo in grado di sopportare, di prendere tempo, di aspettare. “E se invece non fosse vero niente? Se i miei sospetti non avessero fondamento? Prove schiaccianti non ne ho.” Ma nemmeno le vautazioni innocentiste duravano a lungo. ”Per forza non ne ho, faccio di tutto per non trovarne! E comunque in tutto questo non c´è niente di nuovo né di drammatico: faccio solo parte della maggioranza della popolazione adulta, cioé adultera. Sono trai piú senza essere morto. Non é male, vero Giorgio? ”Si piega sopra di lui e prende a carezzarlo in tutta la sua lunghezza con movimenti regolari, quasi meccanici. ”E poi, visto appunto il mio nuovo stato, anch´io ho diritto a maggior libertá: le studentesse, le colleghe...e ai congressi, le ricercatrici, le interpreti, le cameriere... le scoperó fino a farle rincretinire, vedrai!” dice a voce alta e battendosi le mani sulle ginocchia. Giorgio pensa che questa volta lo si porterá fuori , si alza di scatto e gli scodinzola davanti. Ma il padrone non si alza, solo si prende la testa tra le mani e fissa immobile il pavimento: sua moglie dov´era e che cosa faceva e con chi? E allo stesso tempo, come quando si segue il funerale di una persona cara, con intensitá e dolorosa chiarezza si trova a ripercorrere alcuni momenti belli della sua vita con Arianna: la prima volta che lei gli dette in braccio Chiara, o quando insieme rimasero ammutoliti davanti alla monumentalitá fiabesa della Sagrada Familia o quando in Sardegna fecero il bagno di notte e si amarono nell´ acqua tiepida mentre rivoli di placton fluorescente scivolavano sulle braccia e le mani. Giorgio gli si era avvicinato di piú e gli stava premendo il torace con la sua grossa testa, come fa sempre quando vuole essere coccolato. Marco gli accarezza il pelame tra gli orecchi, prima distrattamente, poi con sempre maggior tenerezza. Gli prende il muso tra le mani, il grosso naso nero e umido é a un palmo dal suo.”Vecchio Giorgio, dimmelo tu cosa devo fare...” Appoggia la guancia contro il pelo ruvido e con le braccia avvolge il suo collo di cane, caldo e solido come quello di un uomo. Capitolo XXIV Era la seconda settimana di giugno.Claudia si era trasferita al mare da pochi giorni quando Arianna si precipitó da lei.Arrivó in anticipo e in casa non trovó nessuno. Una vicina le spiegó dove avrebbe trovato la sua amica: in cima alla strada, a destra, sotto il glicine. “...Se il cancellino é chiuso, lo spinga, é sempre aperto.” La casa che cercava era piccola, a due piani, coperta da un intonaco ingrigito e sbollato, che a tratti lasciava scoperti larghi tratti di muratura a sassi; le pietre color ocra, venate di bianco, bozzolute e mal squadrate si affacciavano al sole raccontando con la loro rude soliditá la povertá, l’ingegno, l’ostinazione di chi le aveva murate. Quelle pietre venivano spesso recuperate nei campi, cosí come i travetti per i solai venivano tirati fuori dalle grosse ceppe del castagneto, e la sabbia per la malta dragata a mano dalla foce del torrente a valle. In quel tempo, piú che un’aggiunta al paesaggio, i nuovi edifici erano il risultato del paesaggio che si organizzava in case. Cosí era sorta anche lei, figlia misera di un territorio non molto piú ricco e come tante altre nel paese, era rimasta a lungo disabitata finchè piú tardi, i figli di quei genitori ostinati che pur dovendo emigrare non avevano voluto venderla, la utilizzavano per andarci in villeggiatura nei mesi estivi. Non aveva mai avuto la fortuna o la sventura di essere restaurata e ora se ne stava lá, affascinante e scrostata, in gaia povertá a mostrare la sua umile origine, rallegrata dal vigore di un vecchio glicine lussureggiante che 1’abbracciava su tutta la facciata. Mentre cercava il campanello sui colonnini di mattoni che sostenevano il cancellino, Arianna dovette soffermarsi a guardare la speciale serenitá che emanava dallo spazio davanti alla casa: una panchina di pietra sbrecciata ma ben tornita era stata murata a fianco della porta; si vedeva che proveniva da un monastero o da una casa ricca, la sua lavorazione era raffinata, le sue proporzioni armoniche. Eppure stava benissimo anche lí, protetta dal profondo pergolato di pali di legno che il glicine rivestiva di foglie verdissime; in qualche modo si combinava con l’altra grande pietra semicircolare che faceva da gradino davanti alla porta, un monolite spesso oltre trenta centimetri. nato secoli prima come macina di frantoio. L’atmosfera sotto quel loggiato era attraente, raccolta, pervasa da una luce morbida, animata dai giochi d’ombre del fogliame; era un ambiente che esprimeva in ogni sua parte l’invito a sedercisi in compagnia, a riposarsi. a chiaccherare senza fretta in amicizia e cordia1itá. Quel posto lasciava immaginare cosí chiaramente abitudini di vita di altri tempi che era come se le voci delle donne che si erano sedute lá a cucire, a spennare la cacciagione, a raccontare, fossero rimaste sospese in quella gabbia di verde e ancora vi fluttuassero, come se ne sentisse la eco trai tralci sporgenti e i sassi della facciata. Il campanello comunque non c’era. Arianna rimase esitante davanti al portoncino spalancato, le cui chiavi ciondolavano immobili dalla piccola serratura di ottone ossidato. Chiamó; nessuna risposta. Chiamó ancora; niente. Si avvicinô alle finestre aperte del piano terreno, ma flosce tende di tela bianca proteggevano l’intimitâ delle stanze. Da dentro nessuna voce, solo vaghi suoni di musica classica in lontananza. “Vada, entri pure!”. Disse una vecchietta sbucata dalla casa accanto; la donna le parlava appoggiata coi gomiti su un davanzale di cemento alle cui estremitâ si alzavano due gerani alti e striminziti. “Lei è amica di Claudia, vero? Vi ho viste tante volte insieme. La cercava?”. Arianna si sentí imbarazzata nell’essere riconosciuta da qualcuno che l’aveva vista spiare dalle finestre. “Mi hanno detto che Claudia era qui. . .“ si giustificó. “Sí, era qui ora con mia nuora; vada pure dentro, se non sono in casa saranno nel giardino di dietro. Vada, vada!”. Entró incerta nel vano scuro della porta, piú per sfuggire alle ingerenze di quella sconosciuta che per convinzione. Appena varcata la soglia, prima ancora che gli occhi si abituassero alla penombra dell’ingresso, l’avvolse un odore acre e diffuso. Lo riconobbe subito: era lo stesso che nel suo paese natale impregnava la casa dei nonni, del tabaccaio, della sarta, un odore asprigno e ostinato che riempiva gli ambienti per intero, acquattandosi nei muri, nelle travi, nei mobili, nei vestiti. Era il prodotto di tanti inverni al fuoco del camino, di rare imbiancature, di ricorrenti cene a base di cavoli e di cipolle. Era quello che da ragazzina chiamava, con accenni di nausea, “puzzo di casa vecchia” e che ora improvvisamente le rientrava nel naso sotto forma di aroma grato e invitante. Lo respiró a pieni polmoni. Il portoncino immetteva su un pianerottolo; da lí partiva una scala a mattoni, ripida e stretta, i cui ultimi scalini si perdevano nell’oscuritá del piano superiore, quasi li si salisse per scendere in caverne buie. Ai lati dell’ingresso si aprivano due porte, sulla destra la cucina, sulla sinistra una specie di sala da pranzo con un tavolo, sedie spaiate e un lettino a fiori coperto di cuscini che fungeva da divano. Appoggiata contro il muro, una libreria di finto legno piena di riviste e chincaglierie. La musica veniva dalla stanza successiva. Arianna chiamó ancora una volta poi si diresse da quella parte, verso una porta dischiusa, sverniciata e senza telaio. Bussó, attese un attimo, poi aprí. Nessuno. La musica a alto volume la investí, limpida e bellissima. Si accorse che nonostante lo squallore dell´arredamento si stava bene lí, con quei suoni. L´unica finestra guardava a ponente; il sole del pomeriggio premeva contro la tenda sottile, accendeva il rosso dei mattoni che a loro volta rimandavano riflessi aranciati sulle pareti, sui pochi mobili, sui cuscini, sul tappeto. La musica si sposava benissimo con quella luminositá estiva , sembrava fatta della stessa pasta calda. Veniva da una grossa radio portatile, nera e massiccia, posata per terra in mezzo al pavimento sconnesso e e a tratti avvallato. Il suono era ottimo, il pezzo un concerto per violino e orchestra. di quelli, le sembrava, che si componevano in pieno romanticismo. Non lo aveva mai sentito prima: languido, seducente, a tratti forte, a tratti sentimentale, stava facendo su di lei l’effetto di una potente calamita; gli occhi fissi sulla fonte di quei suoni, si mise immobile ad ascoltare. La musica non la mollava: epicentro mobile e seducente, quel violino stava diventando il padrone di tutta la sua attenzione, trovava sempre nuovi percorsi in cui trasportarla, non le lasciava modo di distrarsi un solo momento. La tenda, leggera come certi vibrati degli archi, si muoveva appena nell’aria ferma. Era lei che, gonfia di luce e sospesa nell’aria assolata, difendeva l’intimitá di quell’atmosfera, che teneva a distanza il resto delle cose, i passeri sul cipresso, le case davanti, la strada. Grazie a lei, Anianna stava lí sola e irraggiungibile. Ascoltare musica che ci prende è un po’ come viaggiare: non si è in nessun luogo, si esiste solo in quello che stiamo sentendo; si riesce quasi a afferrare il misterioso transitare del presente, a guardare negli occhi il tempo che scorre. Ma l’orchestra presto si zittí e Arianna temè che l’incanto fosse finito; passó dalla gioia all’irritazione. Invece, dopo pochi secondi, partì un altro movimento e tutto ricominció. Si sdraió sui grossi cuscini sparsi sul tappeto, le mani dietro la testa, gli occhi socchiusi nella luce morbida della stanza, la musica dappertutto. Si accorse subito quando l’orchestra cominció a affrettarsi, a stringere, a indicare la fine; apri gli occhi e aspettè senza muoversi che svanisse anche l’ultima nota. Di nuovo il silenzio. Un silenzio che ora sapeva di vuoto. Cercó subito il pulsante con cui spegnere l’apparecchio, le sarebbe dispiaciuto lasciare che altri suoni inquinassero le sensazioni che aveva accumulato. Aspettó a premere giusto il tempo per sapere di chi era quel brano: Wieniawski...” II Concerto per violino e orchestra”... Wieniawski... Cercó di raccogliere tutto quel poco che sapeva di lui. Il passato le venne in aiuto perché molti anni prima, quando si era innamorata del concertista, sulle ali di quell’esaltazione, si era fatta una cultura sulla storia del violino, aveva letto molto sull’argomento e per di piú con un’attenzione famelica. Le letture fatte sul filo dell’amore sono intessute di una colla tenace, dura da distruggere, forse per questo molto le era nimasto di quei libri e ora le veniva facile ripescarci quello che voleva. Wieniawski... violinista cecoslovacco, richiestissimo, un pó scapestrato... tournées in America... si era giocato a carte persino il violino... una leggera rigiditá nella mano destra. Era nato il dieci di luglio, se lo ricordava bene perché era lo stesso giorno del compleanno di Riccardo. Di che anno? 1840 o giú di li, ma non era per niente sicura. Questo solo si ricordava e per di piú ritratti di lui non ne aveva mai visti. “Se lo avessi conosciuto, lo avrei amato — pensava — uno che compone questa roba. . .“. Se lo immaginava seduto a scrivere davanti al pianoforte, la testa nascosta da un cesto di capelli ruvidi e rossicci. Se lo immaginava in un letto, la pelle bianca come Gabriele. Ma un motocarro passó scarrettante per la via e dette un colpo a quell´ ídillio fragile. Arianna si risveglió, ma anche se il bel virtuoso si era dissolto dietro la finestra piena di sole, la sua musica non se ne voleva andare e continuava a allacciarla con i suoi echi. Di controvoglia si alzó e cercó di riprendere contatto con se stessa e con lo spazio intorno a lei. Intorpidita nelle gambe come nello spirito, si rese conto con disagio che si trovava sola in una casa non sua, si ricordó che era andata lí per cercare la sua amica e che le avrebbe dovuto dirle cose dolorose. Stiró le braccia all’indietro, respiró a fondo piú volte e a malincuore si preparó a andarsene. Sulla soglia della stanza, peró, si volse indietro,lasció scorrere la mano sullo stipite di pietra sbrecciata, come toccasse una reliquia e gettó uno sguardo affettuoso sulla radio spenta, la tenda che appena respirava, il misero arredamento, il battiscopa alto, fatto di vecchio intonaco dipinto a smalto e crettato. Le dispiaceva lasciare quel posto. Quando fu fuori e vide Claudia che stava rientrando con la nuora della vicina, fece una certa fatica a salutarle, a farsi abbracciare, a chiedere come stavano, loro e il mondo. Claudia invece, l’abbracció con un altro spirito. La guardó con i suoi occhi fragranti di luce estiva, occhi lunghi, come sempre ben truccati, che ora la indagavano e le chiedevano insistenti perché era lá, in un sabato di inizio giugno, quando di solito solo a luglio si trasferiva nella casa al mare, a un paio di kilometri da lí. “Come stai?”. Le chiese sorridente e Arianna sentí subito che voleva dire: “Che ti è successo? Che hai combinato? Che ti ha fatto ancora quel tuo amante? In quale pasticcio ti sei cacciata? Che posso fare per te, che possiamo farci?”. “Bene, sto bene, grazie”. Rispose. Si volse verso l’altra donna che non conosceva e la salutó. “Mi scusi, sono entrata nella sua casa, sua suocera mi ha consigliato di andare a cercarvi lá; mi dispiace, se sapevo che non ci eravate non sarei entrata, mi scusi”. “Oh, non si preoccupi! Per come è messa questa casa, siamo noi che ci dobbiamo scusare con chi ci entra!”. Rise la donna mostrando denti sconnessi. Chiacchere e frasi di circostanza seguirono, frivole ma brevi perché Claudia agguantó la sua amica per la mano e riuscí in poche battute a salutare e a portarsela via, giú verso il vicolo stretto che sbuca nel centro del paese. Arianna, grazie alla sua sola presenza, stava giá meglio, come chi sa di essersi piazzato nel posto giusto al momento giusto; lá si sentiva temporaneamente al sicuro. Le due donne camminavano tenendosi sottobraccio, serrate come una coppia di danzatori, le gonne estive ondeggiavano intorno ai loro passi cadenzati; gonne chiare e leggere, dagli orli sollevati dal vento di mare, quello che soffia sempre il pomeriggio tra le ripide strade, gli scalini, le strettoie dell´antico nucleo medioevale. I vecchi seduti sulle panchine della piazza si dissero qualcosa e le seguirono con lo sguardo da sotto i berretti finchè non le videro inabissarsi dietro una discesa a gradoni. Non solo loro le avevano guardate, ma anche l’ortolano sulla soglia del negozio e il vigile urbano che passava con le mani ingombre di fogli e fascicoli. Non si poteva non guardarle: erano belle insieme, di taglia quasi uguale, pastose, curate, vestite di chiare sottane svolazzanti, traversavano la piazza unite e irraggiungibili come dive. Nemmeno le loro parole si lasciavano agguantare, il vento spazzava via il loro parlottare sommesso e lo disperdeva nell’aria calda, solcata da stuoli di rondoni. “... Allora, che ti è successo? Dimmelo subito, non farmi stare in ansia inutilmente. E’ per Gabriele, vero?”. “Sí, certo, è per lui, ci sono novitá che non mi aspettavo; andiamo a casa tua. ho hisogno di un po’ di quiete,.. Siamo venuti al mare solo per questo fine-settimana, ho lasciato Giorgio con Marco... vorrei delle mura, una porta chiusa e parlare con te... Come sono contenta di essere qui!”. Aggiunse stringendole il braccio. “I ragazzi sono al mare con mia suocera, la casa è tutta per noi”. La rassicuró Claudia mentre girava la chiave di una porta che per Arianna suscitava ricordi da brivido. Riconobbe il portachiavi; le venne voglia di carezzarlo, ma anche di strizzarlo e scaraventarlo lontano fin dentro il mare. Appena entrata, guardó subito nell’angolo dell’ingresso, dove avevano posato le valige quella volta; le sembró che l’angolo urlasse, vuoto e amputato. Claudia la installó con cura materna sulla poltrona grande del soggiorno , le portó una bibita fresca e si sedette davanti a lei. Il suo viso, leggermente abbronzato, sembrava molto giovane, illuminato dalla luce morbida che passava a fatica tra le persiane accostate. Fuori faceva giá caldo. Arianna non sapeva come cominciare, la sua amica cercó di aiutarla: “Non ce la fai piú a tenere insieme tutte queste storie?”. Lei scosse la testa prima di prendersela tra le mani e massaggiarsi la cute sopra le tempie. “No, non precisamente; anche quando ci siamo sentite l’ultima volta, te lo dicevo, andava tutto piuttosto bene, io ce la stavo facendo, ma... - posó le mani in grembo stringendole una contro l’altra e fissó lo sguardo davanti a sé, senza piú vedere il viso ovale di Claudia, né l’attaccapanni imgombro di cappelli e occhiali subacquei, né il grande manifesto liberty che arredava di toni bruni e rossastri la parte alta della parete. “E’ che Gabriele mi sta mettendo pressione, molta pressione, dice che cosí non puô andare avanti, che devo prendere delle decisioni. Secondo lui, dovrei stravolgere tutta la mia vita, me lo chiede come se fosse praticabile. E’ uscito di senno. ecco, questa è la novitá. E poi proprio ora che, secondo me, non sta nemmeno troppo bene, questa è la cosa che mi preoccupa piú di tutte, piú ancora delle sue idee farneticanti. Quelle si possono sempre rimettere a posto, ma il respiro affannato senza avere fatto niente... e le pulsazioni... mi ha spaventato, gli ho sentito il cuore andare cosi forte che pensavo scoppiasse. Ho insistito tanto, ma di farsi vedere da un cardiologo non ne vuol sapere; sta benissimo, dice, è stato sempre benissimo, ora come sempre e anche io devo smetterla di fare la mamma, che è un ruolo che gli sta molto antipatico. Mi dice che la sua piú importante malattia sono io che non voglio stare con lui, io che non lo amo e cose del genere”. Claudia ascoltava e taceva; stava seduta sulla punta di una poltroncina di vimini, guardava ora l’amica, ora la propria gonna di tela indiana con la cui gala giocherellava, lisciandola contro il ginocchio per poi di nuovo lasciarla libera e farle riprendere la sua originale increspatura vaporosa. Arianna raccolse la sua bibita e cominció a bere, a piccoli sorsi ritmici, il solido cilindro di vetro opaco le dava una sensazione di sostegno, come se tutta la sua persona si stesse appigliando a lui. Guardare solo il bicchiere voleva dire anche non vedere la camera semiaperta, lo spicchio di letto inquadrato nel vano limpido della porta. Nessuno ancora parlava: le scappó un sospiro profondo che le dette sollievo. “E´ anche successa una cosa grave, o quantomeno brutta...” Ultimamente Gabriele si era fatto piú esigente, piú audace, piú spavaldo, piú irragionevole. I segnali di questa progressione erano stati in un primo tempo sporadici, lei li aveva presi come lusinghieri attacchi d´amore. Poi si erano inaspriti fino a diventare ostacoli voluminosi. Una volta che era undata a casa sua, Gabriele si era stretto piú forte contro di lei e le aveva detto: “Le senti come ti desidero... chi altro ti potrebbe amare cosi? Solo io, perché sono io il tuo uomo, io e basta!”. Ma poi ancora, in un’altra occasione. le cose si aggravarono. Era sempre durante amplessi che le novitá si facevano sentire: quella volta Gabriele piú che amarla, l’assalí, l’agguantó, mostrandosi capace di una veemenza che Arianna non gli aveva mai conosciuto e che la lasció prima scossa, poi offesa, poi ancora spaventata: cercava di divincolarsi da lui, di sottrarsi, stupita e disorientata, ma lui non mollava. “Ma che ti prende?”. Non le rispose, anzi, si fece ancora piú violento,la serrava fino a farle male. Piú dell`aggressione fisica che stava subendo Arianna accusó fin dentro le ossa l´umiliazione che essa comportava ; accusó anche il tradimento, essendo la brutalitá una cosa tra loro tacitamente aborrita. Si sentí nascere dentro una forza eccezionale , un fiume d´adrelnalina la investí, si trovó a difendersi come una leonessa, con una forza che non avrebbe mai sospettato di possedere. Gabriele non era né un atleta, né un pugile, né uno scaricatore di porto, si trovava quasi alla sua portata, perlomeno tanto da potersene difendere. Scalció, spinse, smanaccó, finchè non si divincoló da lui e riuscí a uscire dalla camera. Naturalmente si rifugió nel bagno, l’unico immediato rifugio, l’unico posto con una porta e una chiave inserita dall’interno. Una volta dentro. si sentí al riparo, ma ancora piú confusa; dubitava di trovarsi in una situazione reale. Si accostó con la schiena contro le piastrelle del muro; il ghiaccio la tempró senza portarle altro soccorso: non sapeva che fare, né che pensare. Si appoggió con le braccia tese sopra il lavandino e nello specchio fu costretta a vedere evidenti arrossamenti sulle spalle, sui fianchi, sulla schiena. Non sentiva freddo, eppure la scuotevano ondate di brividi, proprio come quando Giorgio fu morso dal rotweiler; appoggió la testa al muro, si sforzó di calmarsi e ragionare; riuscí a capire solo che se voleva una spiegazione, quella era da cercarsi nella camera da letto e non nella stanza da bagno. Si accorse di essere nuda e per di piú in una casa dove vivevano anche estranei. Si buttó dell’acqua sul viso e sul collo, si mise addoso l´accappatoio bianco di Gabriele, quello che gli aveva regalato solo qualche settimana prima, giró la chiave e aprí lentamente la porta. Capitolo XXV Nel corridoio nessuno, nel resto della casa silenzio, la porta della camera semichiusa come probabilmente Arianna l’aveva lasciata. Ci si avvicinó col cuore in gola, aveva paura ma non sapeva nemmeno di che cosa. L’aprí lentamente, come se temesse che qualcuno lí dietro fosse pronto ad assalirla; guardó dentro con circospezione: nella penombra il letto accoglieva il corpo immobile dell’uomo fino a quel momento amato e ora per la prima volta anche temuto. Si accorse che respirava affannosamente. La paura per se stessa, in un attirno si trasformó in inquietudine per lui. Gli si avvicinó in punta dei piedi e lo sfioró appena con le dita sulla spalla: “... Gabriele,.. - gli sussurró -Gabriele, ti senti bene?”. Lui annuí senza muoversi né aprire gli occhi. Si stese al suo fianco; non osava toccarlo, le sembrava fragilissimo. “... Che hai, respiri male?”, continuó. “Passerá , non ti preoccupare, passerá. . Infatti dopo pochi minuti il disturbo cessó anche se lui continuava a tenere gli occhi chiusi. Arianna gli posó un bacio sulla spalla e gli cercó la mano che teneva stesa a palmo in su lungo i fianchi. Le sembró che il mondo intero tornasse a vivere solo quando la sentí reagire e serrarsi forte intorno alla sua. Ció nonostante rimaneva in allerta, non aveva il coraggio di muoversi, nemmeno di sollevare la testa per sbirciare l’ orologio sul comodino, come avrebbe dovuto fare a quell’ora. “Ti ho spaventato, vero?... Mi dispiace”. Le disse senza muoversi, investendola con la sua bella voce. Lei gli rispose baciandogli tutto quello che poteva raggiungere da quella posizione di casti amanti giacenti. “E ´che sto male... sto male spesso, e non nel corpo... Ti sei mai chiesta quanto mi manchi, cosa sono quando non ci sei? - prendeva pause tra una frase e un’altra - e quante volte non ci sei? La mia donna non c’è perché sta pranzando con un altro, sta dormendo con un altro, sta scopando con un altro.” Arianna, a un palmo dal suo viso, smise di baciarlo, si bloccó, per inghiottire ora doveva spingere a forza la saliva dentro la gola. “Le mie notti sono scure... ma anche le mie giornate. Tutte le cose che ti vorrei dire svaniscono, si perdono... non ce la fanno a aspettare il prossimo appuntamento, me le devo tutte reingoiare. Come faccio a tenere sotto controllo i desideri, le nostalgie, se hanno ore, giorni interi di tempo per crescere, per gonfiarsi...” Arianna teneva gli occhi spalancati nell´ oscuritá, fissi davanti a sé, il suo quadro visivo metteva a fuoco solo le pieghe dell’orecchio di lui, l’attaccatura dei capelli sul collo, la mascella, il piccolo pomo d’Adamo che sussultava sulla gola mentre parlava. Ogni parola la stava graffiando come una punta di ferro. “...Non lo senti come si sta bene noi insieme , credi che succeda spesso? Credi che avrai un’altra vita per poterne godere? Perché allora non rimani qui, o in un qualsiasi altro posto , ma con me? ... Non andare a dormire in letti lontani, il tuo posto é qui; tu hai bisogno di me, proprio di me; solo io capisco la tua storia, solo io vedo come sei bella...”. La mano di Gabriele era diventata sudata, si sciolse dalla sua e andó a avvolgerle il seno con la presa lieve di chi blocca tra l’erba un uccellino di nido. “... Noi dobbiamo stare insieme, sono io il tuo compagno di viaggio...volse il viso verso di lei e si accostó all´orecchio-... perché noi ci nutriamo dello stesso cibo. Non è vero, amore mio?” Le prese polso e lo tenne stretto. “Se non è vero che il tuo posto è qui, allora dimmelo; dai, dimmelo ora”. Arianna lo guardava in silenzio; Gabriele prese a carezzarle i capelli, li lisciava con il viso respirandone l´odore. “No, non mi dire niente, anzi sí, rispondimi, ma prima di dirmi qualsiasi cosa, vieni piú vicina, fatti abbracciare ...ti ho fatto paura... e proprio a te, la mia signora! Non ti ho fatto male, vero?”. Si volse sul fianco e la tiró a sé con tutto il braccio, col gesto rude che fa l’orso quando vuole avvicinarsi del cibo lontano. “Non mi era mai successo prima; scusami. Neanch’io sono contento di me, eppure non credo di essere uno schizzofrenico. Forse è che sono ancora abbastanza giovane da non ingoiare i miei desideri come una normale medicina, oppongo resistenza. Senti come é vellutata la tua pelle...come mi invita...” Gabriele continuava con mano lieve di chirurgo a scostare dalle spalle e dai fianchi l´accappatoio che ancora la copriva. Arianna non sapeva piú se quelle carezze si potevano chiamare piacere, le sembrava solo che aumentassero il suo disorientamento. Messa sotto sopra dall’incalzare di avvenimenti inattesi e incomprensibili, anche i gesti piú noti e gradevoli assumevano una colorazione minacciosa. Non sapeva quanto grande era la parte di sé che si lasciava andare alla sensazione di fresco della stoffa sollevata e poi di caldo della sua mano, e quanta parte invece stava tesa, in posizione di guardia, stretta tra i sensi di colpa verso Marco e quelli piú recenti verso il suo amante. C’era qualcosa che non tornava nella sua situazione, la stavano ingiustamente accerchiando. “Perché non mi sono trovata una amante normale -pensó- di quelli che: ci si vede il giovedi, si va a casa mia dalle quattro alle sei, etc. etc., senza pretese né complicazioni? Perché mi sono trovata un amore e non un amante? Perché cercavo l’uno e non l’altro, è evidente! E ora, di cosa mi lamento? Commiserarsi in malafede è inutile, è proprio da imbecilli. Ecco, forse sono solo imbecille, arrivo spesso a questa conclusione, è qui la causa delle mie disgrazie: ho vissuto questa storia da incosciente, come uno stupido apprendista stregone.” Ma le carezze del suo amante stavano vincendo sulle sue deboli autocritiche, l’accappatoio giaceva giá vuoto sotto di lei, come una terza persona senza vita; il guscio era stato abbandonato e al suo posto la copriva il corpo caldo di Gabriele. Tuttavia non era un giorno propizio per amori e passionalitá: Arianna di nuovo sentí il cuore del suo compagno battere velocissimo e irregolare.”Batte molto svelto...” gli disse aprendo occhi inquieti. Gabriele sembrava non trarne nessun fastidio,continuava a carezzarla come se quello fosse il cuore di qualcuno altro: “E` l´amore!”, rispose percorrendo la pienezza delle sue cosce calde, ancora tutte da abbronzare. Invece non era soltanto l´amore, ma qualcosa di piû oggetlivo e fisiologico, un disfunzione cardiaca non grave ma reale che Gabriele avrebbe forse dovuto prender sul serio, cosí come gli consigliava la sua amante-chioccia. Col WPW, che era il nome sintetico e musicale della sua malattia, ci si convive; con farmaci lo si cura, con un leggero intervento chirurgico lo si elimina, rare volte è una patologia di cui si muore, moltissime quelle da cui si guarisce. Basta prendere i sintomi, e ce ne sono sempre, e portarli davanti a dei buoni medici. Ma Gabriele non era né un allarmista, né un uomo prudente, per cui accolse volentieri la diagnosi tranquillizzante del suo medico curante da cui era andato qualche anno prima e non si fece nessuno degli accertamenti che lui gli aveva\ consigliato nel caso volesse stare piú tranquillo. Ogni tanto aveva delle evidenti accellerazioni di battiti, poteva succedere che per qualche minuto respirasse meno bene, ma poi passava tutto, anzi, a volte gli attacchi erano cosí leggeri che doveva fermarsi a ascoltare. Solo lei ne faceva un problema. Durante il percorso verso casa Arianna dubitava di aver vissuto situazioni vere, intanto peró volgeva le sue energie a dimenticarle. Si appoggiava a peso morto sulle tante facce della cittá, su qualsiasi cosa le passasse davanti e la distraesse dalla sua storia: negozi, motorini, case, qualcuno che camminava col cane. Guardava tutto con un´attenzione estrema. Bisognava farsi assorbire dallo spettacolo, trovare tutto interessante, aderire a quello che vedeva fino a non sentirsi piú e dimenticarsi. A casa coprí il suo umore alterato con la scusa stupida di un mal di testa. Giorgio le fece comunque tante feste, era stata via ore intere, l’annusó a lungo, le andó in collo quando si sedette. Arianna volentieri gli ricambió le effusioni, lo carezzó, si strinse a lui cercando di respirarlo e farsi contagiare dalla sua innocenza. Marco le preparó la cena e la forzó a rimanere distesa al buio sul divano. Rinunció anche al telegiornale purchè rimanesse lí tranquilla. La notte tuttavia non riuscí a addormentarsi. Erano appena le due, scivoló silenziosa via dal letto e per la seconda volta in una sola giornata, la stanza da bagno diventó il suo rifugio, lo spazio protetto in cui potersi rinchiudere a chiave, per riflettere, analizzare, disperarsi, sperare, piangere, intripparsi di dubbi su dubbi e non arrivare a niente. Capitolo XXVI Arianna ha raccontato tutto. Finalmente. Nella casa di nuovo silenzio. Da fuori, attraverso le fessure delle persiane, qualche stridio di rondine le ricorda che il mondo sta seguendo il suo corso di sempre. Sulla parete del soggiorno lo sfondo bruno del grande manifesto liberty si impasta con la penombra; ne emerge una giovane donna, in carne e seminuda, che come una falena avvolge a spirale una rivoluzionaria lampada a gas. I fianchi pieni fasciati da veli rossi, un braccio tornito sollevato in controluce, avvolge sensuale il nucleo abbagliante e bianco, alimentato con l’energia dell’avvenire. Claudia tiene ancora tra le dita il lungo bicchiere d´aranciata vuoto, ne fa oscillare i fondi rimasti avanti e indietro mentre ci guarda dentro assorta come un’indovina. “Salvare capre e cavoli non si puó, qualcuno va sacrificato, non se ne scappa! ”Le dice senza staccare gli occhi dai resti della bibita. Parla lenta, senza variazioni di tono, come chi ha in mente un quadro stabile e chiaro che deve solo essere esposto.” Me l´ero prospettato, ma non credevo sarebbe successo cosí presto.” Il suo discorrere calmo e monocorde dá a Arianna un transitorio senso di quiete. Claudia solleva lo sguardo su di lei: “A parte quello che poi alla fine farai, che cosa vorresti fare’?”“Non lo so”. “Avrai pure fatto dei ragionamenti, analizzato.,.”. “Ho analizzato tantissimo, ho spezzettato e ricomposto tutto tante volte, ma non arrivo a niente, tutte le soluzioni mi fanno solo paura”. “Lo credo! Comunque cerchiamo di fare un po’ d’ordine, se mai è possibile: prima di tutto lasciamo da parte le sue condizioni di salute, mi sembra che stai esagerando, in fondo è sempre un medico, lo saprá meglio di te se deve preoccuparsi e quanto; lascia perdere questa contingenza”. Arianna non si muove, ma mentalmente annuisce , la sua disponibilitâ a ascoltare e farsi convincere é in questo momento altissima, finalmente si puó adagiare su una posizione passiva, lasciare che qualcun altro, anche se per poco, si prenda carico dei suoi problemi. “Senti — alza la testa Claudia — posso essere cinica? Arida, tecnica, pragmatica, unicamente razionale? Posso?”. “Vai pure, è proprio quello cerco, io non so piú distinguere niente”. “Bene, ammettiamo senz’altro che Gabriele ti ami, che tu sia ora il centro del suo universo, che tu lo stia nutrendo col cibo che desidera. Supponiamo che tu divorzi o che tu vada comunque a vivere con lui; ammettiamo anche che questo vostro accordo continui, che non conosca grosse crisi. Ció nonostante...”. Ci fu una piccola pausa carica di suspence. La mosca che fino a allora aveva volato rumorosa intorno al lampadario e poi era scomparsa, si posa un attimo sulla caviglia di Arianna . Lei si sente percorrere da brividi di schifo sproporzionati al danno e la scaccia dandosi un colpo inutile quanto energico sul collo del piede. “Ció nonostante... tra te e lui ci corrono otto anni, una distanza pesante, molto pesante, non tanto ora, ma pensa dopo, quando sará lui a averne quaranta e tu dovrai ogni giorno combattere per arginare il deteriorarsi doloroso del tuo aspetto; dovrai curarti sempre di piú per ottenere sempre di meno. Che farai? Farai finta di nulla? Ti metterai nelle mani di un buon chirurgo?.... Invecchiare di per sé non è un dramma, se solo è in armonia con il resto della propria vita. Per te invece, sarebbe l’opposto, il disavanzo col resto del mondo verrebbe esasperato. Credi che ce la faresti a sopravvivere, a riconoscerti un ruolo dignitoso quando lui sará nell’etá in cui un uomo -- non tutti forse, ma quasi, pare — ‘si venderebbe l’anima per un pezzo di carne giovane’ come dice Kundera.”. Pensando ai bei romanzi di Kundera, Arianna sorride ma Claudia chiude subito la disgressione e continua: “Ce la faresti a reggere tutti i giorni l’umiliazione, o quantomeno il dubbio, di essere al di sotto dei suoi desideri? Quale amica o gruppo di amici, o cane o muta di cani ti aiuterebbe a compensare questi squilibri, a cosa ti attaccheresti? E’ vero che diventare vecchi vuol dire contentarsi sempre di meno, ma ce la farai a contentarti di qualcosa che tutti i giorni mette alla prova tutte le tue energie? E i rimorsi e i rimpianti che comunque ti accompagneranno, dove troverai le forze pei fronteggiare anche quelli? Lo saprai allora come lo sai ora che hai ripudiato vent’anni di vita con Marco, un capitale di unione enorme, cancellandoli non per necessitá, ma per scelta, senza nemmeno che tu gli possa imputare delle responsabilitá precise. E l’indice d distruzione che un divorzio avrebbe su di lui? E su tua figlia? Anche questo te lo dovrai prima o poi digerire, qualsiasi contraccolpo subiranno — e ce ne saranno di grossi — sará unicamente colpa tua e senz’altro cosi la vedrá Chiara. Per quanto la conosco, col caratterino duro che si ritrova, credo che non ti perdonerebbe mai di aver abbandonato suo padre, diventerai per lei la matrigna, premesso che voglia continuare a vederti. Lo so che sto facendo discorsi tutti improntati sul negativo, che anche altri scenari sono possibili, ma questi sono i piú probabili.” Arianna la interrompe asserendo con la testa.”Sí, mi dici il vero, il tuo é un discorso logico, sensato, me li sono immaginati anch´io questi epiloghi, anche se non ho avuto il coraggio di esporli in termini cosi crudi come hai fatto tu; ti ringrazio. mi hai dato delle conferme. Questo è infatti quello che sta su uno dei piatti della bilancia. Peró, guardiamo anche l’altro... Come farei a stare nella stessa cittá, a sapere dove Gabriele vive, che cosa fa, cosa gli manca e non andare da lui. Non ce la farei mai, mai! Bisognerebbe che scappassi in un altro posto, che la forza maggiore, la distanza, la necessitá mi tenessero lontano. Ma solo la mia volontá... lui per me è come una consuetudine fisiologica, come il battere del cuore, come il respirare; stare sempre senza di lui per me è... agonizzare. Lui mi riempie come il mio sangue, me lo porto addosso, dappertutto; è uno mio strato, uno strato profondo. Come faccio a scuoiarmi di mia propria mano?Claudia! — le dice sporgendosi verso di lei — tu non hai idea di come ci capiamo noi, su che lunghezza d’onda ci sentiamo, come é potente la gioia del riconoscimento che trovo con lui e a che livelli questo riconoscersi porta i nostri amori! Forse, se mi mandasse via lui, se mi dicesse che non mi vuole piú vedere, forse allora anch’io me ne farei una ragione; ma cosi, che io sola, in piena luciditá, debba fare una scelta cosi pesante... è superiore alle mie forze”. “E lui con te, allora? Costringerti a scelte che ti sconvolgono la vita, mi sembra piú un’aggressione che un atto d’amore. Amore è accogliere l´angolazione di un altro, capirla, rispettarla, è uno stadio evoluto dell’essere umano; sanno amare quelli in grado di considerare i problemi e la sensibilitá dell’altro, quelli che coltivano anche interessi superpersonali... tu mi parli di sintonie, di simbiosi, ma dove è la capacitá del tuo Gabriele di identificarsi con te, con la tua vita, con i tuoi bisogni? Ti chiede di non avere nessun altro, di rinunciare a tutto quello che non è lui, pesticciando i tuoi affetti e chiunque ti sta intorno,ti sembra amore questo?”. Arianna guarda la sua amica di traverso: “L’amore vuole sempre tutto!”. “Forse vuoi dire la passione, non l’amore; amore è prendere qualcuno com’è e amarlo lo stesso, per quello che ti dá.” Arianna si sta irritando: “Ma allora non hai capito niente, forse non hai afferrato bene che é una questione di misura. Lui sta con me piú o meno sei ore la settimana, a chi basterebbero? “ Anche Claudia si sta irritando, siede irrigidita sulla poltroncina di vimini e ne tormenta i braccioli con le mani. “Allora, se non vuoi ragionare, staccene pure sette volte 24, di ore, col tuo amante; staccene 168 e non ti lamentare di cosa succederá quando ce ne sarai stata 1680 o 16800 o un qualsiasi altro suo multiplo!”. Claudia era sempre stata brava in matematica, Arianna no, ma questa volta il linguaggio dei numeri esprimeva delle semplici veritá sentimentali e anche se con diverse implicazioni, a tutt’e due divenne chiaro che Arianna Gabriele non lo voleva mollare, a nessun costo, forse nemmeno a quello piú alto. Claudia, giá per natura delle due la piú razionale e senz’altro la meno coinvolta, riprese in mano la situazione. Il tono della sua voce tornó calmo e comprensivo. si appoggió alla spalliera raccogliendo le mani in gremho. “Lo so che non è facile, peró devi cercare di non smettere di pensare. Riflettere, guardare le cose dall’alto, con una visione panoramica, fa sempre bene; se si perde di vista l’insieme, non si capisce piú nulla, si prendono decisioni distorte, ancorate a niente... - tacque per diversi secondi - Comunque...per ora cerchiamo di concentrarsi sul futuro prossimo e di andare avanti con passi piccolissimi. Vedo che sei messa molto alle strette: bene, cos’è che cerca di fare per prima cosa qualcuno messo alle strette?”. E Arianna dalla poltrona di fronte: “Prendere tempo”. Il consiglio di Claudia non era forse geniale, ma comunque molto appropriato. L’idea del temporeggiare e di scansare l’ostacolo invece di farlo esplodere a lei non era venuta in mente, mentre invece era una strategia ovvia da applicare senz’altro. Il procrastinare non solo l’avrebbe sollevata da una scelta che non voleva fare, ma le avrebbe anche dato modo di chiarire a se stessa cosa avrebbe voluto a lunga scadenza, una riflessione che sistematicamente cercava di evitare. Da quella volta della colluttazione, Gabriele non le aveva piú chiesto di andare a stare con lui, anche se l’argomento continuava a strisciare sotto i loro inicontri; in forma velata e silente li pervadeva e li appesantiva. Nell’aria s’era instaurata una tensione nuova, volatile, ma reale; il fatto peró che di lí a poche settimane le vacanze dell’uno e dell’altra li avrebbero tenuti a lungo separati, spinse nella direzione di sospendere la questione, di impegnarsi in una tregua e di gioire al massimo del poco tempo che rimaneva loro da stare insieme. Gabriele non aveva avuto piú reazioni sconsiderate, solo era diventato piú irritabile e taciturno.Il suo collega Giancarlo, sulla cui discrezione poteva sempre contare, sapeva degli andamenti complessivi di tutta la storia, cosí come della strettoia in cui Gabriele si era voluto incastrare negli ultimi tempi. “Porca miseria! Ma tra tutte le donne che ti puoi permettere, dovevi andare a prendere proprio quella di un altro! E poi anche insisterci. Le donne sposate son casini, sempre casini!”. Giancarlo gli consigliava di non avere fretta e intanto, appena poteva , gli presentava nuove ragazze. Gabriele non si rifiutava, anzi, erano fonti di piacere e di gratificazione per lui, lo sollevavano, gli davano molta sicurezza, tuttavia non riuscivano a sconvolgere niente; nel suo piccolo harem fluttuante, nessuna insidiava seriamente la grande favorita. “Sei la duchessa delle mie fidanzate” le diceva e Arianna doveva sforzarsi per trovare in quel complimento un equilibrio tra lusinga e gelosia. “Ma se sei cosí pieno di fidanzate, se le cerchi, se ne hai bisogno, perché non ti va bene di continuare a vederci come facciamo ora, perché provi a chiedermi l’impossibile?’. “Perché le mie fidanzate sono dove non sei tu e non viceversa”. A parte le belle frasi che Gabriele sapeva sempre trovare per lei e che la incantavano, cominciava a credere che alla lunga ce l’avrebbe fatta a mantenere lo status quo; volentieri quindi interpretava i passati inviti a andare a vivere con lui come una sfida provocatoria, come la richiesta di un’impossibile prova d’amore fatta solo per misurare il suo potere su di lei. Quella paura di dover scegliere tra il tutto o il niente che per un paio di mesi l’aveva angosciata, si andava smorzando. In fondo stavano molto bene insieme, anche cosí. La stagione concertistica, fatta piú densa dall’aggiunta dei concerti estivi fuori cittá, aveva reso i loro appuntamenti piú frequenti: Schubert e Beethoven se li sentivano lo stesso dallo stereo di Gabriele, mentre l’amore fluiva tra loro dolce come un flauto. Ancora una volta in presenza di Arianna era capitato che lui accusasse quei battiti accellerati, ancora una volta si era spaventata e aveva tirato fuori il discorso di farsi visitare; Gabriele le rispose che semmai una visita la passasse lei, cosi che anche per il cardiologo restava qualcosa di bello da vedere. ‘E poi — aggiunse —se ero cardiopatico sai quante volte con te avrei fatto la morte di Attila?”. Arianna lo guardó. “E come è morto Atti1a?” ”La prima notte di nozze con l’ultima de sue giovanissime mogli. L’aorta non resse”. Lui rimase a guardarla soddisfatto, come chi ha appena fatto la mossa vincente in una una partita a scacchi. “Davvero è andata cosí? — gli chiese stupita — all’uomo piú temuto ,odiato e senza cuore della storia la sorte ha dato proprio l´amore per morire? E quella povera ragazza, che le avranno fatto? La sua notte di nozze tra le braccia di un barbaro vecchio e assassino e poi anche l’orrore della morte a un palmo dalla sua bocca. Poverina!”. Gabriele si mise a ridere “Ma come fai a pensare queste cose? Il flagello di Dio finalmente schianta e tu trovi solo da preoccuparti per la sua ultima vedova? Vedi come le cerchi tutte pur di poterti preoccupare per qualcuno; sei proprio un’inguaribile chioccia... una bella chioccia. piumosa e calda... la mia!” Forse lui aveva ragione, forse era ora che la smettesse di preoccuparsi per tutto oltremisura, di essere ipocondriaca anche rispetto alla salute degli altri. Si dovette ricordare di quello che le aveva detto uno psichiatra da cui una volta era andata. convinta di stare per diventare un’ansiosa cronica. “Signora, stia tranquilla, non succederá niente di quello che teme, proprio niente; cosa vuole che succeda? Il mondo si sa organizzare bene, se ne frega dei suoi timori, le cose vanno dritte lo stesso. Allora, perché contrapporsi a una realtá che statisticamente funziona meglio delle sue brutte previsioni? Salga sul carro del mondo e prosegua tranquilla con lui!”. E’ bello pagare uno specialista se poi si ottiene qualcosa che serve. Arianna da allora fu un po’ piú serena, o comunque cosí le sembró. A luglio partí per il mare con animo leggero, era quasi felice di quella interruzione che avrebbe reso ancora piú emozionante il loro rapporto, tenuto ora aperto da telefonate clandestine a ore speciali e con speciali segnali e codici. Ci furono anche delle importanti dimenticanze e imprevisti per cui Arianna dovette tornare tre volte da sola in cittá e una volta ci dovette anche pernottare. La macchina con cui lei si spostava era una vecchia Renault che aveva fatto quasi tre volte il giro dell’equatore. C’era molto posto per Giorgio, peró consumava olio in quantitá industriali e se si sollevavano le pedanine, il pavimento anteriore di destra mostrava un buco di diversi centimetri da cui si vedeva l’asfalto della strada correre via come un magico nastro grigio. Sulla statale verso il mare ebbe l’ennesimo guasto all’impianto elettrico e se la cavó solo perché uno del paese la riconobbe e la trainó col cavo fino al carburatorista. Ormai era chiaro che presto avrebbero dovuto sostituirla, ma stava a lei promuovere la cosa, perché Marco delle macchine e della loro manutenzione non si occupava affatto; lui le guidava e basta. Tuttavia sarebbero andati incontro a una spesa consistente, anche trattandosi di una utilitaria usata. Il giorno successivo a quell’ultimo guasto, dopo aver rimesso a posto in cucina, si sedette sul divano accanto a lui e sospirando gli annunciô: “C’è una cosa importante di cui dobbiamo parlare”. Marco si senti raggelare. Alzó occhi inquieti dal giornale e sembró irrigidirsi; si voltó verso di lei; la guardó dritta in viso. “Che cosa c’è? — aveva il tono allarmato di chi si aspetta una brutta notizia. Capitolo XXVII Sono i primi di agosto. Il prossimo fine settimana Gabriele a sua volta partirá ,andrá una decina di giorni alle Cinque Terre, da un suo amico che ha lí una casa e un entrobordo. “Sono contenta che tu ti possa un po’ riposare”. “Riposare? Spero proprio di no, ho intenzione di fare delle vacanze B.B.B.!”, le disse abbracciandola. “E che sarebbe?” gli chiese Arianna mentre tirava fuori dalla borsa un pacchettino della farmacia. “Barche, Birra e Belledonne”. Lei dette un’alzata di spalle. “Non suona poi tanto esclusivo, - commentó scartando la confezione che aveva in mano — ma perché proprio con me parli come se io fossi un tuo compagno di caserma? Credi di farmi ingelosire? Guarda, in farmacia ti ho preso questa roba. . .“. “Profilattici?” “ Quasi, è una crema a alta protezione; dattela sempre o con la tua pellolina chiara ti ustionerai tutto”. Gabriele sorrise e l’abbracció di nuovo cingendola intorno alla vita. “Grazie, mia bella fata premurosa! — la copriva di piccoli baci sul collo e sulle guance mentre si premeva contro di lei — Se mi ustiono, dalle belle donne non posso piú farmi toccare, vero?”. “Potrai sempre fartele senza che ti tocchino molto”. “Roba difficile, per questo ci vogliono molti esercizi”. Non la stringeva piú, ma aveva alzato le braccia e con tutto il corpo, la sospingeva a piccoli passi verso la camera, senza staccarsi da lei né smettere di sbaciucchiarla. “Ma difficile veramente — continuó — è quando anche lei è ustionata; vuoi vedere?”. Arianna rideva mentre a sua volta alzava le mani come chi si arrende e camminando all’indietro apriva col dorso la porta semichiusa. Nella stanza tutto era al suo solito: i rotolanti abbassati, il letto rifatto, il vecchio armadio di noce semichiuso; al suo solito anche il caos nella libreria. Oltre che riposti negli scaffali, molti volumi erano ammucchiati in terra senza nessun criterio, né di contenuto, né di formato; piccole edizioni economiche sostenevano come tartarughe di sasso grossi libri rilegati e vocaolari. Sembrava sempre che ci avesse soffiato la Bora su quegli scaffali, eppure non cadeva mai niente e in quella disposizione Gabriele ritrovava subito quello che cercava. Sulla parete di fronte alla finestra, il grande poster con un bosco di Cèzanne attirava su di sé la poca luce che filtrava dalle finestre e la rispandeva nella camera soffiandoci dentro atmosfere calde e lussureggianti, intrise di rossi cupi, di aranci, di ombre azzurre e viola. A Arianna piaceva molto quel quadro, non ultimo perché le ricordava da vicino le estati della sua Maremma, ne conteneva i suoni, i colori, i profumi. Ci risentiva il ronzio degli insetti, il caldo ostinato dei pomeriggi, la sensualitá del bosco di luglio, il suo invito fatto di odori grati, di mezze luci e promesse di frescura. Tutto era come sempre nella camera di Gabriele, eppure appena entrata e preso contatto con oggetti e atmosfere di solito care, si accorse guardandosi intorno che qualcosa quel giorno non andava, che il gioco d’amore appena cominciato si stava giá in qualche modo inceppando, compromesso da un vago ma crescente senso di malessere: chiara e pungente si faceva sempre piú avanti la consapevolezza che di lí a due giorni lui sarebbe partito e che non lo avrebbe rivisto per quasi un mese; tutto a un tratto si rese conto di essere scontenta, irritata che se ne andasse per tutto quel tempo quando la scelta di partire era dipesa tutta da lui. Solo ora sembrava capire che quell’incontro equivaleva a una separazione e che Gabriele e la stanza da letto e i libri e Cèzanne di lí a poco le sarebbero stati tolti. Lui non seppe leggere i cupi pensieri che attraversavano la sua mente, in compenso trovó come sempre dolci argomenti per farglieli dimenticare. Solo piú tardi, quando anche le ultime nebbioline dell’amore si furono rarefatte, il malumore si impossessó di nuovo di lei, quella stessa scontentezza di prima tornó a galla. Arianna non era del tutto cosciente, o forse non voleva esserlo, che questo suo scontento era un capriccio, qualcosa di pretestuoso e vano. Sapeva benissimo che da relazioni clandestine non si puó pretendere l’assiduitá totale, né avanzare pretese sul marito illegittimo. Era assurdo, ció nonostante stava imboccando quella strada, spinta forse dal desiderio di ricevere una qualche compensazione o dalla voglia di verificare, attraverso l’applicazione di un arbitrio, il livello del suo potere su Gabriele. Aveva una gran voglia di provocarlo, non le faceva paura il buttarsi a capofitto nel meccanismo per cui a volte si tende, in piena luciditá, a distruggere situazioni che ci sorridono; nonostante sentisse giá da lontano il cattivo odore dell´autolesione, continuava a perseguirla.. Non aveva ragioni di lamentarsi, anzi, giá da diverse settimane, poteva contare su molti motivi di soddisfazione, dal momento che i suoi piú ambiti progetti stavano procedendo nella giusta direzione. Dalla volta che Claudia, nel soggiorno della sua casa di Marina, era riuscita a trasmetterle un po’ di calma e a suggerirle direzioni di pensiero, Arianna aveva lavorato con piú profitto all’analisi di se stessa e dalla sua complessa situazione: aveva camminato con Giorgio e riflettuto, vegliato al buio e riflettuto, stirato i panni e riflettuto, finchè era riuscita a conquistarsi un quadro piuttosto chiaro di dove voleva andare. Se l’era messo a fuoco lentamente, scavando con fatica tra le pieghe strette della sua coscienza. Ora le restava da vedere in che misura Gabriele le avrebbe accettate e condivise. Non ne avevano ancora parlato, ma, al punto in cui era, avrebbe desiderato, per quanto la riguardava, non tanto di andare a vivere col suo amante “per sempre”, ma di instaurare con lui una relazione che durasse sempre, anche quando si sarebbe sposato o comunque avrebbe instaurato un rapporto stabile con un´altra donna. Che lui si unisse a una giovane compagna, che avesse dei figli, le avrebbe fatto piacere, purchè continuasse a avere sentimenti e dialoghi privilegiati anche con lei. Mirava a una stabile e fertile bigamia, come quella di certe grandi dame del ‘700 di cui aveva letto oppure di altre donne, meno famose e piú vicine al suo tempo, di cui aveva sentito dire le quali avevano avuto per tutta la loro maturitá e anche oltre, non tanto un amante, ma una specie di secondo consorte, un uomo a sua volta con un’altra sua situazione, a cui le legava un affetto e un’affinitá profonde, un particolare amore, un legame fortissimo che attraverso frequentazioni forse sporadiche, manteneva negli anni la sua forza e le accompagnava nelle fasi della loro vita, cosí come un binario accompagna l’altro, costruendo un solido percorso parallelo che. proprio per la costanza e la forza della sua binarietá, diventava il grande fondamento dei loro equilibri. A qualcosa del genere, raro ma non impossibile, come testimoniava la storia, puntava ora Arianna. Gabriele invece aveva altre mire, seguiva altre strade: davvero gli mancava la quotidianitâ con la sua innamorata, dormirci insieme, mangiare con lei. Quel ruolo di amante gli stava stretto, ma per ora andava mantenuto in attesa che il tempo maturasse nuovi sviluppi. Il fatto poi che nel loro rapporto non ci fosse posto per gelosie, lo risargiva in parte di queste mancanze, visto che accompagnarsi con nuove donne gli piaceva moltissimo. Cosí quella sera, l’antivigilia della sua partenza, era piú che contento: accanto la donna amata e davanti il mare e l’aroma avventuroso delle vacanze. “Un giorno le faremo anche noi le vacanze insieme, vero?”. Arianna lasció che un’inquietudine mista a rabbia avanzasse dentro di lei, le fece spazio, soffió sopra il suo fuoco. Le sembró che tutte le frustrazioni implicite nel suo menage si radunassero come formiche in una brulicante macchia nera che chiedeva sfoghi e compensi. Le prese una voglia incontenibile di aggredire Gabriele, di sfidarlo anche se in palio c’era solo qualcosa da perdere. “Le vacanze insieme? Per te é facile proporre cose del genere, tu non hai niente da perdere. Sarei io che dovrei rinunciare alle mie sicurezze, ai miei affetti, al mio passato, i rischi li correrei tutti io mentre tu, staresti con me finchè ti sta bene e poi... quando ti sarai stufato, mi mollerai e tanti saluti! Magari nel frattempo ti sarai trovato una bella ragazza, giovane e piena di chissá quali qualitá e ne farai il centro del tuo mondo. Non vedrai altro che lei; ci passerai insieme alcuni anni spumeggianti e i restanti tra la gioia di averla e l’apprensione di perderla; poi alla fine ti abituerai a dividerla con qualcun altro, finchè un’emorragia celebrale o un infarto verranno a liberarti del tutto dalle tue angosce!”. Ancora l’ultima sillaba non si era dissolta, che nella stanza tutto cambió.Arianna sentí il sibilo ghiaccio di un´ascia che scende, il crepitare di una frattura che si apre Si fece largo un silenzio carico di tensione, simile a quello che separa il lampo dal tuono. Aveva detto qualcosa di ignobile, malvagio, falso e palesamente distruttivo; lo aveva fatto apposta. Gabriele accoglie disarmato quelle parole, si stacca dal suo abbraccio, la guarda stupito, volge il viso contro il muro e in quella posizione rimane, sorpreso e profondamente ferito. Lei é giá spaventata per aver inferto un colpo cosí basso, per aver mirato con premeditazione alla fiducia come se non sapesse che sulla fiducia poggiano le fondamenta di qualsiasi intesa. Si scioglie subito in scuse, ritrattazioni e autocritiche, ma tutte vanno a sbattere contro un’indifferenza spessa e invalicabile. Panico e disordine si fanno avanti; di fronte all’irraggiungibilitá di Gabriele, la prende un senso di disperazione, di smarrimento e di impotenza. Si scusa in continuazione, con gli argomenti piú diversi. ma lui non reagisce, è come se accanto a lei giacesse un corpo privo di sensi. Col tono pacato e asettico con cui viene annunciato un treno in stazione, Gabriele le fa notare che a quell’ora doveva essere giá a casa. Arianna tace immobile per uno, due, tre pesantissimi minuti, poi smette di implorare e prende a rivestirsi, con molta lentezza, con la quiete artificiosa di chi, in seguito a un fatto traumatico, chiude tutti i circuiti e si muove per automatismi, astenendosi dal ragionare e dall´intraprendere. Gabriele, che ha voltato la testa per guardare la sveglia, è ricaduto nella posizione in cui l’aveva visto prima. Lei si inginocchia sul pavimento e gli copre di baci il braccio che tiene disteso fuori dal lenzuolo.” Ti prego, dimmi qualcosa!” Niente. Si alza e si dirige lentamente verso la porta. Sulla soglia si volta a guardare ancora il suo amante, sperando in un piccolo cenno, in uno spiraglio nel grande muro che le ha eretto davanti. Lo intravede avvolto nel letto, impassibile e inerte ; non un suono, non un gesto. Nel soggiorno raccoglie le chiavi della macchina, il foulard, la borsa a tracolla dentro cui ancora fruscia il sacchetto vuoto della farmacia. Chiude il portoncino alle sue spalle, ma prima di imboccare le scale, torna indietro e carezza con i polpastrelli la targhetta di ottone che porta inciso a piccole lettere il cognome duro e inattaccabile di Gabriele. Rientró a casa stordita, come se si stesse svegliando da un’anestesia che dissolvendosi lasciava il posto al dolore acuto della ferita. Le sembrava cosí macroscopica la stupidaggine che aveva fatto, che quasi dubitava fosse stato tutto vero. Marco non c’era. Giorgio la festeggiava come sempre, saltandole addosso, andando a raccogliere il suo orso di pelouche e lasciandolo cadere davanti a lei. Lo carezzó e lo sbaciucchió come sempre, che perlomeno lui non si accorgesse di niente. Cercó subito il telefono, fece tutti i possibili numeri di Gabriele, ma nessuno rispondeva. Prese il cane e nonostante il caldo lo portó fuori. Ogni dieci minuti, col cellulare cercava un numero che sembrava non appartenere a nessuno. Continuó a comporlo per tutto il resto del giorno, trovando i sotterfugi piú disparati per farlo, anche dopo che Marco era rientrato. Chiamó da tutti i possibili nascondigli: dal pianerottolo dell’ultimo piano del palazzo, dal garage, dalla piazzola coi cassonetti della spazzatura, dalla latteria all’angolo, aperta fino a tardi. Solo verso mezzanotte si arrese. “Giorgio,insegnami le tue qualitá di cane — gli diceva sola in cucina mentre gli preparava il pasto — ti prego, insegnami ad aspettare, insegnamelo ora, subito! Devo farcela ad arrivare a domani”. L’indomani non le avrebbe portato gran sollievo: il telefono non rispondeva e nemmeno l’andare a casa di Gabriele cambió qualcosa. Non ci trovó nessuno, potè solo scivolargli un accorato bigliettino sotto la porta, buttato lá con lo spirito di chi getta una bottiglia in mare. Se avesse avuto le chiavi dell’appartamento che piú volte lui le aveva offerto e che aveva sempre rifiutato, ora le avrebbe usate, foss’altro per toccare gli oggetti della casa che a tutt´ora vivevano in armonia con lui. Li invidiava tutti, uno per uno. Capitolo XXVIII Gabriele non c’era perché appena uscita Arianna aveva fatto i bagagli e era partito per la casa di montagna. Ci sarebbe rimasto un paio di giorni e poi avrebbe proseguito per il mare. Il minuscolo paese lo aspettava, pieno di vecchie conoscenze e posti amati. Quanto a Arianna, ora bisognava tenerla lontana e basta, riempirsi di altro cibo, non permetterle di rovinargli le vacanze, quella stronza che con lui, proprio con lui che non aveva mai eretto difese, si permetteva sfiducia e protervia. Al dispiacere del primo momento era seguita una profonda irritazione: era stato insultato con una meschinitá impensabile.” Niente di piú miserabile che attaccare chi si pone da amico.” , aveva sempre pensato. Di lei per momento non ne voleva proprio sapere. La casa in compenso lo accolse come un porto sicuro: riconoscere spazi, oggetti, atmosfere é un piacere grande; ricongiungersi alle cose da cui siamo stati originati dá forza e tranquillitá, non é una balla il mito di Anteo, figlio della Terra, che tutte le volte che toccava il suolo si risollevava piú vigoroso di prima. Era proprio cosí. Gabriele credeva molto nella potenza rivelatoria del mito, del lungo filo, del grande racconto dove alla fine convergono le storie di tutti. Ricondotto nella casa dell’infanzia, anche lui si sentiva un po’ Anteo. Appena arrivato, incontrô Massimo, il suo vecchio compagno di giochi, in vacanza con moglie e figli nella casa dei suoi. Lo invitó per due chiacchere dopo cena; parlarono e risero fino alle tre del mattino, insieme a una bottiglia di cognac quasi intera. Forse nella conversazione gli aveva anche parlato di Arianna e dei suoi dolori, ma il giorno dopo non se lo ricordava piú. Il cellulare giaceva spento nel fondo della valigia, prima di ripartire lo ripose nella dispensa della cucina; lo avrebbe ripreso quando sarebbe tornato lí per qualche giorno, ma per il momento era meglio tenersi al riparo da qualsiasi intrusione . Certo che presto ci avrebbe riparlato con Arianna, ma ora no. Anzi, pur non volendolo ammettere, ne sentiva giá un pó la mancanza; si ritrovava a pensare a lei piú spesso di quanto avrebbe voluto, sapeva che stava soffrendo e gli dispiaceva, ma teneva duro perché convinto che farsi rispettare è anche un dovere. Si ritrovava a pensare a lei anche al mare, quel pensiero lo sorprendeva quando meno se l’aspettava, non tanto nelle ore languide dell’ultimo pomeriggio, quando l´acqua diventa di un azzurro tenue e satinato, ma anche in piena mattinata, quando sentiva tutta l’energia che dá l’orizzonte aperto e guardava l’elica del motore sollevare spruzzi bianchi nelle virate che facevano intorno agli scogli di Portovenere. Gli veniva nostalgia di Arianna persino quando Irene, la bella ragazza di Milano che aveva incontrato in pizzeria, surriscaldava la sua camera al riparo dalla canicola e socchiudeva lentamente i suoi occhi color di acqua. Irene partí dopo cinque giorni e da quel momento Gabriele si sentí stanco, stanco e svuotato. Rimase tutto il giorno successivo sulla spiaggia, steso a leggere e a dormire, spalmato come sempre con la crema avuta dalla sua amante premurosa. Dormí tantissimo, era l’unica cosa di cui avesse voglia. Verso l’ora di cena si sentiva ancora intontito.Bene, era proprio quello che gli ci voleva. Il litrozzo di vino bianco che accompagnó la spigola arrosto contribuí a tenerlo cosí per molto tempo. Dopo cena rimase sulla terrazza del bar anche quando il suo amico e la sua ragazza rientrarono. Da lí guardava la piazza come un palcoscenico: un goccio di whisky — solo il terzo bicchierino secondo i suoi calcoli — e un’occhiata allo spettacolo che gli brulicava davanti: gruppi di adolescenti vestiti tutti uguali, famiglie dagli sguardi opachi, donne mature dai seni abbronzati che si affacciavano da scollature generose. Mandó giú un altro sorso, forse un po’ troppo lungo, ma ormai era andato; qualche bella ragazza, ventri obesi fasciati da magliette allegre, bambini, due cani che si annusano. Cani? Per un attimo si ricordó di essere anche veterinario e li guardó con affetto. Ancora un sorso: una coppia di giapponesi, un cameriere che incassa e ringrazia, un ragazzo che passa col motorino, tutti che si intersecavano senza sosta davanti a lui, racchiusi ognuno nella propria storia. “... Thomas Mann dice che non a tutti è dato di avere una storia - rimuginava Gabriele -il suo Castorp sí che ce l‘ha una storia. Perché Castorp sí e altri no? Boh?”. Buttó giú il poco che restava nel bicchiere. “E io ce l’avró la mia?”. Tutto sommato aveva bevuto molto lentamente, quando si alzó stava ancora bene in piedi, non aveva sonno, solo si sentiva la testa molto confusa. Fece una passeggiata per la cittadina prendendo strade a caso, secondo il gusto del momento. Accanto a un distributore vide del rosso con una striscia che brillava emergere dallo sfondo scuro della notte, ma piú si avvicinava, piú non era il rosso che staccava, bensí il bianco, il bianco delle cornee e poi il bianco del sorriso. Giovanissima, pastosa, occhi dolci e lunghi,Gabriele la guardava e la trovava molto bella, mentre un flash di coscienza gli suggeriva debolmente di non avvicinarsi. “... Cerchiamo di non diventare tutto d’un botto e puttanieri e negrieri”. Si disse. Vaghe e fluttuanti gli tornarono alla mente le storie di violenze, prevaricazioni e criminalitá che stanno dietro a queste ragazzine africane, buttate sui marciapiedi come spazzatura, molto spesso costrette, ingannate, picchiate. “Non ci penso nemmeno!” si disse. “Ciao bello, sei solo?” gli arrivó all’orecchio mentre la intersecava. La sua voce era morbida e calda, il suo accento impastava le parole fino a farle sembrare un breve tratto di musica sentito per la prima volta. Ormai era troppo tardi, fu costretto a posare lo sguardo su di lei: davanti a Gabriele si aprí un sorriso piú luminoso dei fari sulla strada; non poteva proprio piú far finta di niente. “Ciao bella stella della notte, non posso venire con te perché non ho soldi!”. Disse mentre continuava a guardarla con le mani in tasca e dondolandosi sui piedi. “Non è vero... - rispose lei ridendo e osciliando l’indice nell’aria davanti al suo viso. Flesse la testa di lato: “Davvero niente soldi per me, tesoro’?”. Si scostó la maglietta elasticizzata con sopra la striscia rossa che brillava e gli mostrô il seno per metá raccolto in una delicata impalcatura di pizzi neri. Il veterinario, ancora molto confuso dall´alcool della serata, rimase incantato a guardare lo stacco quasi inesistente tra le rose della trina, unite da una tessitura di tralci, e la turgiditá nera della carne; non riusciva a distinguere il confine tra le une e l’altra, come se quel rigoglio vegetale fosse stato da sempre lá e quella ragazza fosse nata cosí, con seni cosparsi di fiori. Continuava trasognato a guardarla e a sorriderle”. “Sei bellissima! Ma io non posso perché sono ubriaco, non ho soldi e sono ubriaco”. Da lí a un quarto d’ora il motore di un taxi vibrava silenzioso sotto casa. Nonostante la leggerezza nella mente lo aiutasse a neutralizzare qualsiasi sensazione, si sentiva sempre piú imbarazzato a trovarsi lí con lei, gli sernbrava che il tassista lo guardasse con la riprovazione di un prete rigoroso e puro, anche se forse lo invidiava e basta. Sapeva benissimo di non essere un uomo da prostitute. La prima e l’ultima volta con una di loro risaliva agli anni dell’universitá, la sera che andó a cena con alcuni suoi compagni di corso per festeggiare che avevano tutti dato l’esame di Anatomia Generale. Anche quella sera aveva bevuto come un cavallo. Ora peró era peggio, era pui vecchio, senza complici e aveva a che fare con una ragazzina con chissá quali orribili storie dietro di lei. Almeno fosse stata una delle tante troie nostrane, proliferate dappertutto sulla scia dello sviluppo economico; invece no, nemmeno quella semplificazione e per di piú si era accorto che la ragazza aveva unghie lunghissime, laccate di viola: gli fece paura l’idea di sentirsele addosso e poi gli venne da ridere immaginandosi tutto graffiato cosa avrebbe detto Arianna e cosa avrebbe detto Giancarlo. Comunque era chiaro che, anche volendo, non era quella la serata adatta per cogliere i frutti di quel parco lussureggiante: “Bella Venere nera, c’è qualcosa che non va tra noi stasera, mi dispiace. E’ vero che sono ubriaco, piccola mia, è vero sul serio...”. Non glielo disse, ma lo pensó con l’andamento lento e oscillante che aveva il suo pensiero in quel momento. Disse al tassista di aspettare lí. Con precisione insospettata infiló la chiave nel portoncino che subito richiuse alle loro spalle cercando di fare meno rumore possibile. Si trovarono sul piccolo pianerottolo da cui partiva la rampa di scale che portava senza altre interruzioni alle stanze dell’appartamento. Rimasero lí senza che lui accennasse a salire. La ragazza lo guardava senza capire. “Vuoi fare qui?” gli chiese col suo normale volume di voce. “Ssssh!”. Le fece segno di parlare piú piano e le posó l’indice sulle labbra dividendo in due spicchi luminosi il sorriso che aprí sotto la sua mano; infossó il collo nelle spalle come una bambina che ha fatto uno scherzo birbone e trattenne il riso. Gabriele si appoggió con le spalle alla porta acquistando cosí una buona dose di stabilitá.“ Fammi vedere ancora il tuo seno. . . “. Lei raccolse con entrambe le mani i lembi laterali della scollatura e la scostó fino a farla aderire alle costole sotto il petto. Tutto il bel giardino si mostró in panoramica e prese a sollevarsi lento davanti a lui, cosí come le rose e i tralci. Dalla vetrata sopra il portoncino la luce della strada ci spandeva sopra riflessi mobili e ambrati. Strisce di bianco tra le palpebre lunghe, labbra scure, piene e prominenti, appoggiate sull’ovale del suo viso come un fiore di carne. A Gabriele sembró di essere stato scaraventato in una visione. Lei cercó gli occhi del suo indeciso cliente, e gettó la testa leggermente all’indietro in un gesto che esprimeva fierezza e sensua1itá. Gabriele si commosse di fronte alla sua bellezza lontana, fatta di rilievi scultorei e di ombre su ombre e nonostante il vino, l’whisky e le remore morali, ebbe un moto involontario, tuttavia non si mosse. “Come sei bella, sembri una sacerdotessa minoica in una notte di festa!”. Le sussurró. Lei sorrise come se avesse capito il significato di ogni parola; gli occhi le brillavano quando intersecavano i raggi del lampione mentre i contorni del viso e i capelli lucidi e intrecciati andavano a impastarsi con l’oscuritá del pianerottolo, ci si immergevano fino a sfumare e perdersi dentro il vuoto nero dietro di lei. Gabriele sfioró il tepore morbido del suo petto come fosse la piú fragiie delle cose; gli sembrava che le sue mani stessero avvolgendo il cuore stesso della notte. La ragazza lo guardava in viso e gli sorrideva impercettibilmente, il motore del taxi frusciava dall’altro lato della porta. Gabriele fece un estremo sforzo di volontá: delicato e lento riuscí a ritrarsi dalle belle forme di carne bruna; se ne staccó a malincuore, sollevando prima i polsi e lasciando a loro il compito di tirarsi dietro il palmo e le dita, come faceva al pianoforte, quando doveva abbandonare la tastiera alla fine di un pezzo amato. “Ora o mai piú”. Si disse. Si frugó nelle tasche e cercó il portafogli. “Io non ti piace?” gli chiese sentendosi insultata. “No, non è questo, tu sei bellissima, una dea di ebano, una scultura d’amore! Ma io stasera ho bevuto troppo... abbastanza troppo, scusami!”. Lo stava prendendo una grande voglia di dormire, sí, dormire, sognare... sognare, peró senza morire; questo avrebbe voluto. Le pagó quasi il doppio di quello che gli aveva chiesto e poi le pagó anche il taxi. Le venne da darle un bacio sulla bocca, gesto di solito proibito in incontri mercenari, ma che lei non rifiutó. Abituato ai baci sulle donne bianche, si sentí quasi sperso su quelle labbra grandi e toniche; era tutt’un’altra sensazione, ne rimase stupito e spiazzato, come quando per la prima volta si riesce a nuotare nell’acqua alta e si sente a pieno il brivido di scoprire una sensazione nuova. Fuori si mise sugli attenti e chiuse lo sportello dietro di lei chinando rispettosamente la testa come se si stesse accomiatando da una badessa. Quando la rialzó, vide solo un braccio tornito che lo salutava dal finestrino. Ricambió il saluto e siccome non aveva piú fretta, stette a guardare il taxi finchè non diventó una piccola macchia punteggiata di rosso che spariva silenziosa in fondo alla strada diritta. Salí piano le scale e si buttó sul letto vestito. “Forse un altro bicchierino e la dimenticherei del tutto questa serata”. E invece no, non aveva niente da bere e quella sera se la sarebbe ricordata per molto tempo, avvolta da veli di nostalgia e odori di rimpianto. La mattina dopo, la testa pesante e l’alito cattivo, pensó che forse era l’ora di telefonare a Arianna. Capitolo XXIX Le riconciliazioni sono eventi rari, non è facile rimettere insieme quello che si è riusciti a rompere; anche Arianna lo sapeva. La grande paura di aver perso Gabriele era il sottofondo cupo dei suoi pensieri, l’area in cui strisciavano e si gonfiavano rimorsi e recriminazioni. I tentativi che faceva per capire cosa le era preso quella volta, non riuscivano a darle conforto, perché tutto il suo riflettere la riportava sempre alle solite misere conciusioni: era stata sfacciatamente stupida, sprezzante e incosciente come una ragazzina. Quella settimana fu una dclle piú difficili e dolorose della sua vita: cominció a dubitare seriamente della propria intelligenza e questo la mandó del tutto in crisi. Arianna sapeva di non essere un cervello eccezionale, peró si riteneva abbastanza in gamba da sentirsi difesa dalla quantitá di cui disponeva e questa è una condizione vitale per una donna che non ha la bellezza a svolgere una simile azione protettiva. Per lei era la capacitá di capire, di sapersi collocare, di non fare grossi errori la chiave del suo equilibrio, il filo di fiducia che la legava a se stessa . Dall’inizio della storia con Gabriele, aveva sempre cercato di muoversi facendo pernio su queste sue qualitá; non ci era riuscita sempre, ma quasi. Di solito non è facile dimostrare a qualcuno che non è scemo di esserlo, ma quest’ultimo episodio ci era riuscito in pieno, aggiungendo cosí al dolore sentimentale, il peso di una nuova, grave insicurezza. Da molti anni Arianna era arrivata alla conciusione che è nei rapporti con gli altri che si hanno conferme della propria intelligenza, molto piú che nei successi scolastici, sociali e economici; è lí la palestra davvero dura e difficile dove sono importanti l’elasticitá, la capacitá di sopportare sforzi, la costanza, la chiarezza degli obbiettivi e tutte le altre qualitá dell’atleta; proprio su quel fronte, quello piú complesso, si era dimostrata un disastro. “... Tutti prima o poi facciamo degli errori — le aveva detto Claudia da cui era subito andata come un bamhino perso — anche le persone in gamba ne fanno, è umano. La vita non è mica una scienza esatta, è un po’ come la medicina, deve tener conto di tanti fattori, è facile sbagliare; anche Ippocrate diceva che stimava molto il medico che sbagliava di meno, quindi non metterti in discussione piú di tanto, semmai cerca di dare un ordine ai tuoi pensieri e ai tuoi sentimenti e scrivigli qualcosa. Una lettera aiuta a capire chi la scrive, tanto quanto chi la riceve; scrivere è riflettere, scegliere, muoversi con criterio, è proprio quello che ti ci vuole. Se vi amate, vi perdonerete.” Arianna accolse a piene mani quel suggerimento, ci buttè dentro tutta intera l’energia che fino a allora aveva usato per incolparsi e avvilirsi. Fu un enorme sollievo, anche se poi erano piú i fogli nel cestino che le righe che rimanevano. Spesso durante la giornata, ma soprattutto quando portava fuori Giorgio, lavorava sul materiale di riflessione e poi a casa, con grande fatica, cercava di stenderlo sulla carta. Grande fatica, appunto, ma anche grande senso di liberazione e di avanzamento. Un po’ l’aiutava il fatto di non avere fretta, era chiaro ormai che avrebbe avuto di nuovo contatti con Gabriele solo al suo rientro e che non si sarebbe fatto vivo prima; tuttavia sobbalzava quando suonava il telefono e sentiva una delusione simile a una frana in un lago tutte le volte che dall’altro capo non c’era lui. Si era rassegnata con la mente, ma solo con quella; con lo spirito sperava sempre che la sua bella voce una volta o l’altra sarebbe venuta a sorprenderla, con la sua cadenza conciliante, bellissima da riconoscere. In fondo, pensava, era stato solo un malinteso, ci voleva ben altro per distruggere un’intesa bella e profonda come la loro, anzi, quell’episodio era servito a dimostrarle quanto era grande e insostituibile per lei il legame con Gabriele. Intanto aspettava, come una rassegnata Penelope che nell’attesa del grande ritorno tesseva la tela delle sue faticose analisi e autocritiche; solo che la sua tela non veniva ogni volta disfatta, bensi migliorata, spurgata, ne venivano via via eliminati solo i pezzi non buoni. Il prodotto di tanta fatica sarebbe stato il lavoro che avrebbe presentato al suo amante-consorte e che avrebbe costituito la premessa di una luminosa riunificazione con lui. Passava ore seduta al tavolo dello studio scrivendo su un blocco a spirale che diventava ogni giorno piû sottile. Nella casa anche quella mattina faceva caldo, cosí come caldo faceva nella strada, nei negozi, nei giardini. La calura riempiva l’aria come un cuscino gonfio che si appoggiava anche al suo corpo, nonostante le finestre tenute aperte tutta la notte e chiuse alle prime ore del mattino. Arianna aveva abbassato i rotolanti, tirato tutte le tende, aperto i ventilatori e al momento stava tagliuzzando l’insalata con addosso praticamente niente. Il caldo tutto sommato le piaceva; se non si doveva lavorare fuori, in casa dava sensazioni quasi piacevoli il muoversi senza vestiti. La spesa e la giratina con Giorgio erano state fatte prestissimo, in modo che tutti e due potessero poi ritirarsi per lunghe ore nelle stanze fresche dell´ appartamento. In quelle giornate il suo cane entrava in una specie di letargo estivo, si stendeva sulle piastrelle del pavimento e rimaneva lí a ore, immerso in quel suo misterioso sopore di cane. “Ma come fai a startene cosí tutto il giorno, non ti annoi? - gli domandava carezzandolo - possibile che tu possa dormire ventidue ore al giorno? Non ci posso credere, fai finta! E se fai finta, a che cosa pensi?”. Si avvicinava al suo grosso orecchio pendulo e gli bisbigliava: “Mi ami anche mentre sonnecchi o mi dimentichi come il nostro dottore? Faró presto la pace con lui, vedrai! Non si fa vivo ma non mi ha dimenticato, lo so, lui mi ama lo stesso anche se l’ho trattato molto male.” Sperava che Giorgio battesse la coda, cosí, come un segno affermativo del cielo, ma lui rimaneva steso immobile, come un vecchio tappeto peloso. Il telefono squilló mentre stava tagliando a pezzetti piccolissimi un gambo di sedano .Di nuovo un batticuore, di nuovo andare a rispondere pronta a incassare la solita delusione. “Sei tu, bellissima, ... ingrato e barbaro amore mio? Sei tu, stai bene?” Arianna in fondo non se l’aspettava, si senti investire da un’onda lunghissima, calda e raggelante allo stesso tempo. Il seno nudo registró subito la grande emozione e ancora di piú la cosa palpitante sotto di lui: aumentó i battiti e sparse le sue pulsazioni accellerate su in alto fino alla gola. Si appoggiô col dorso al muro e la parete le rimandó una forte sensazione di fresco, un contrappeso che l’aiutó a calmarsi. Non riusciva nonostante tutto a parlare: “Ehi!” riuscí a dirgli. E basta. “Non sei sola?” Pausa. Si stava riprendendo. “Si, sono molto sola...” gli rispose mentre il sorriso le si apriva e non ne voleva piú sapere di richiudersi. Sudori ghiacci dappertutto e una specie di grande allontanamento dalla realtá, dalla stanza, dagli oggetti che vede, dal suo cane, da tutto quello che le sta intorno. Le riconciliazioni sono appunto eventi rari e preziosi, quelle tra innamorati tuttavia un po’ meno perché lí le leggi di gravitá sono particolarmente forti e finchè dura il propellente d’amore, gli affetti tendono a ricadere nella posizione da cui sono stati sobbalzati via. Quella conversazione telefonica contenne tutti i tratti tipici di questi riavvicinamenti, qualcosa che produsse in entrambi sensazioni molto simili alla beatitudine. Convennero che si sarebbero visti tra tre giorni, quando Gabriele avrebbe fatto sosta in cittá prima di ripartire per un breve soggiorno nella vecchia casa di famiglia. Sarebbe stata un’occasione molto speciale, perché quella volta in montagna ci sarebbe andato anche suo fratello, senza compagna, avrebbe portato solo il suo cane, un altro pastore tedesco che stava sempre appiccicato al suo padrone e che si chiamava Bostik”. “... Mi sei mancata tanto...tanto!”, le disse prima di riattaccare. Quando posó il ricevitore, Arianna rimase ferma dov’era per qualche minuto, le sembrava che il calore che premeva sui muri esterni della casa, si fosse trasferito tutto dentro al suo petto e che l’aria in cui si muoveva, fosse la schiuma profumata che avvolge la felicitá, la felicitá quella vera, quella che avanza spazzando via tutto quello che trova sul suo cammino. Arianna cominciè a balzellare per la casa, andó da Giorgio e gli fece le feste cosí come di solito lui a lei; gli portó un biscotto, lo invitó a giocare. Lui si alzó e dopo averlo trangugiato le si piazzó davanti guardandola disorientato. Mise su una cassetta con le arie del “Don Giovanni” e mentre finiva di preparare l’insalata, le cantó a alta voce, accompagnando con la sua voce instabile soprani e tenori famosi; quella musica, pur se da sempre amata, non le era mai sembrata cosi bella, ricca, solare. Sentí il bisogno di impegnare le sue forze esuberanti in cose belle e buone, le venne molta voglia di cucinare: preparó per l’arrosto una salsa francese seguendo le istruzioni del ricettario fino all’ultimo grammo. Verso mezzogiorno si fece una doccia, si truccó con cura, si vestí e aspettó con la tavola coperta da una tovaglia candida, il ritorno del suo compagno-consorte. Finalmente la famiglia era di nuovo tutta riunita. Poche volte la vita le era parsa altrettanto serena, promettente e piena di luce e le cose del cielo mai cosí in armonia con quelle della terra. L’appuntamento con Gabriele fu un´apoteosi, la gioia grande di ricongiungersi, di ritrovarsi, di riprendersi, di toccare con mano che tutto è come prima, anzi no, ancora piú bello e intenso. Per la prima volta di nuovo con lui, a Arianna sembró di respirare anche l’aroma grato della soliditá incrollabile. Gabriele era abbronzato, ancora piú attraente, affettuoso e dolce; la fiducia e l’ammirazione per lui erano dagli ultimi avvenimenti vistosamente aumentate e alla luce di quegli ingranditori anche le sue braccia e le sue carezze somigliavano ancora di piú a quelle di un dio. Gabriele giaceva reclinato su un fianco, volto verso di lei le carezzava la fronte in direzione dei capelli. “Sai... quando ero al mare — le disse — una sera mi è tornata in mente la prima pagina di ‘La montagna incantata’. Strano... l’ho letto cosí tanto tempo fa e da allora non ci avevo quasi piú pensato! ... Secondo te... che vuol dire Thomas Mann quando scrive che non a tutti è dato di avere una storia?”. Arianna ci pensó un pó. Anche se a letto si riflette bene, non era una domanda facile. “Forse... vuol dire che si ha una storia solo quando si è conquistato un percorso di coscienza che la sostiene... quando siamo riusciti a mettere insieme delle idee generali, a largo spettro, universali ma che ci corrispondono e con quelle si è edificato lo scheletro su cui cresce la carne della nostra vita, della nostra storia, una storia che sta in piedi... credo”. “Forse... - riprese lui percorrendo col dorso delle dita la pelle morbida del suo collo - puó darsi che sia cosí. Ma puó darsi anche che lui volesse dire qualcos’altro, forse è una di quelle affermazioni che prendono significati diversi a seconda del lettore che trovano... a seconda della storia di quel lettore...’. Disse e gli venne da sorridere vedendo che senza volere era tornato alla domanda da cui era partito. Anche Arianna se ne accorse e sorrise. Lo guardó con le palpebre semichiuse, poi fissó lo sguardo sul soffitto: “Che bel libro quello! Perlomeno allora mi piacque tanto. Una volta, sai , quando ero giovane, una sera d’estate, mi ritrovai con degli amici in una piazza del centro, piena di gente e di bar. I tavolini erano occupati per cui stavamo tutti in piedi, oppure seduti dove capitava, a chiaccherare col bicchiere in mano. Lí rividi per caso un mio coetaneo, un ragazzo con cui a volte avevo parlato alla mensa universitaria dove veniva a mangiare anche lui. Non era propriamente un amico, era una delle tante persone che conosci appena e subito perdi. Anche lui aveva un bicchiere in mano, di birra per essere precisi, me lo ricordo bene. Non so come andó, ma dopo qualche minuto ci trovammo seduti sul bordo di un’aiuola, quasi per terra, a parlare proprio di quel libro. Partí una conversazione che sembrava non avere fine, bella, sentita, fitta, appassionata; era chiaro che ci era piaciuto tanto, era una vera gioia discuterci sopra. Quando ognuno ebbe tirato fuori tutto quello che aveva da dire — e ce n’era tanto, ti assicuro — non passammo a un altro argomento, ma rimanemmo lí, fermi e zitti; ci sentivamo contenti, saturi e quasi stanchi. Lui mi disse: “Bello! Non capita spesso di avere una conversazione cosí”. Io non so che gli risposi, ma mi ricordo benissimo che non gli credetti: come poteva essere tanto raro parlare di cose in fondo cosí normali...? - si volse verso Gabriele — pensa com’ero giovane! Invece aveva ragione lui, e alla grande! Da allora infatti non mi è ricapitato piú, né con un altro libro, né con un altro uomo, né con una altra donna e ora invece... vieni fuori tu con questo argomento... non hai idea che piacere e mi fai!”. “Vedi che amante insostituibile sono, ti faccio ringiovanire e poi anche cancello le tue disillusioni piú vecchie e incallite; piú bravo di me non ne troverai mai.” “Mai!” confermava Arianna. “Ce l’hai il cellulare con te in montagna?” gli chiese mentre raccoglieva i suoi pochi indumenti da estate. “Hai paura che rimanga bloccato tra i monti? Vado sull’Appennino, mica sull’lmalaia!”“Se hai con te il telefono, è come se tu rimanessi un po’ anche qui. A parte la situazione speciale di questa volta, è stato brutto non poterti raggiungere mai. E poi ti puó sempre far comodo, è un posto isolato...”. Non avrebbe voluto dirgli queste cose da mamma in trepida attesa, peró le scapparono lo stesso. “Non temere per me, bella chioccia, saró col mio fratello, col mio fratello maggiore che per giunta è anche medico; basta questo per tranquillizzarti?”. Quando fu uscita Gabriele si appoggió al davanzale e aspettó di vederla riapparire dal portone: il bianco del suo vestito illuminava l’asfalto come una margherita l’erba. Dalla strada anche lei guardó verso la finestra, contenta di trovarcelo affacciato. Si salutarono con la mano, come quando parte il treno. Era venerdí, lunedi o martedí sarebbe finalmente tornato. Domenica mattina Marco uscí a prendere il giornale piú tardi del solito; Arianna non resistè alla tentazione e telefonó ma nessuno rispose. La sera si presentó un’altra occasione e di nuovo provó. Niente, ancora spento. Il primo pensiero fu di preoccuparsi, ma pensando che era con suo fratello, si tranquillizzó. D’altra parte i sentimenti di colpa verso di lui erano ancora cosí freschi, che non si permise di rimproverarlo nemmeno tra sé e sé. Cercó di pensare ad altro. “Chissá che tipo è suo fratello, uno nato in quello stesso nido di vipere; poveraccio! Me ne faró parlare da Gabriele, visto che quando si è l’amante, il resto della famiglia non lo si incontra mai. Questo è forse solo un ulteriore, grande vantaggio degli amori illegittimi. . . “. La mattina dopo era un pó sbattuta: né lei né Marco avevano dormito granchè, a Giorgio era venuta la diarrea e il suo padrone due volte si era alzato nella notte per portarlo fuori dopo che lo sentivano mugolare alla porta. “Proprio ora che lui non c’è! Se domani non si fa vivo, mi arrabbio davvero!”, pensava. La mattina dopo, verso le nove e mezzo, il telefono squilló. Arianna si senti riavere, in un colpo dimenticó la lunga attesa e si affrettó a rispondere. Non era Gabriele. “Parlo con la signora Arianna?” chiese una voce maschile dall’altra parte. “Sí, sono io, con chi parlo?”“Sono il dottor Berchielli, sono il collega di Gabriele”. Lei si sentí raggelare. “E’ successo qualcosa’?”“Signora... Gabriele e io siamo molto amici, so cos’è importante per lui, per questo l’ho cercata. E’ sola? Posso parlare?”“Si che sono sola, cos’è successo?”“... Gabriele era in montagna con suo fratello, come forse sa.” “Certo che lo so, ma insomma, che c’è?” Il ghiaccio la stava prendendo tutta, non riusciva a inghiottire, le sembrava di non poter respirare. “... La notte di sabato ha avuto un forte attacco cardiorespiratorio. Suo fratello ha fatto di tutto, ma c’è voluto del tempo prima che potesse raggiungere l’ospedale. E andato in fibrillazione... Signora, ... Gabriele è il mio migliore amico, mi dispiace di essere a un capo del telefono e non con lei. La prego.... - anche la sua voce si stava deteriorando - rimanga tranquilla, stia calma, si sieda..,”. Si fece buio dappertutto. Il mondo diventó in un attimo una poltiglia appiccicosa e imprendibile. Quello che sempre si teme e che sempre si sfugge, l’idea di perdere un pezzo di noi irrimediabilmente, agguantó ogni atomo del suoessere , della stanza, del mondo. Arianna si dissolse, smise di aderire a ogni realtá, si inabissó in un caos spaventoso, grande quanto l’oscuritá. Tremava e non era piú cosciente di nulla, avvertiva solo l’enorme voragine aperta di colpo sotto di lei che la risucchiava forte dentro di sé, violenta e brutale. senza dare spiegazioni né giustificazioni, un buco nero che divorava tutto. Dalla strada, qualche passante alzó lo sguardo verso le finestre di un appartamento ai piani medi. Un grido acuto e lungo stava passando attraverso le tende, i doppi vetri, i rotolanti chiusi per andare a disperdersi nell’aria gonfia di caldo di un normale mattino d’agosto. Poi nella strada assolata si sparse solo la voce di un grosso cane che insistentemente abbaiava, abbaiava, abbaiava. Serena Romanelli Aroma di cane
Scaricare