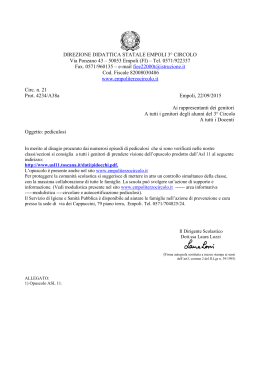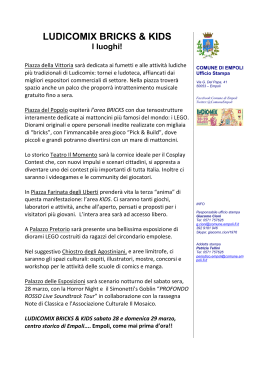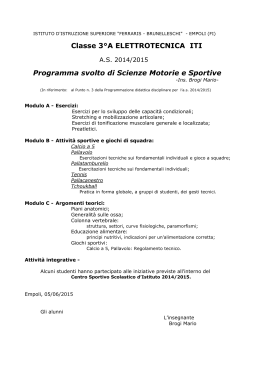QUADERNO E-Book N° 06/2012 rep. 00001/2012 Della Storia d’Empoli® [email protected] Coordinamento e Redazione: Carlo Pagliai e Paolo Pianigiani Paolo Fanciullacci I ragazzi del “Bafòre” Copyright: visione, stampa e duplicazione consentite previa citazione della fonte 22/04/2012 Paolo Fanciullacci I ragazzi del “Bafòre” Della Storia d’Empoli Franco e Paolo Fanciullacci, due dei ragazzi del Bafòre, insieme a Birillo E‐book edito da www.dellastoriadempoli.it Tutti i diritti sono riservati all’Autore 1 Un grazie ad Anna, che mi ha sempre brontolato quando ero al computer invece di tendere i panni, invece di essere andato a fare la spesa, invece di spazzare tutto quel “troiaio” davanti casa, invece di pulire le scarpe, ecc. ecc. Un grazie a Paolo Pianigiani che, a forza di dirmi di scrivere, mi ha ridotto quanto ho di più caro fra le gambe, a due mongolfiere. Un grazie a tutte le persone del “Bafòre”, a quelle che ci sono sempre e, più che altro, a quelle che non ci sono più. Per ultima, ma veramente la più importante, vorrei ringraziare la mia ex professoressa di lettere Renata Tamburini che, con la sua blandizie, mi convinse a ritornare a scuola dopo che avevo smesso per una settimana a causa di un quattro in un compito di latino. Ancora un grazie grosso così, Renata, di vero cuore. Se potessi, Ti abbraccerei. Della Storia d’Empoli In gita a Brotalupi, con babbo, mamma e Franco, mio fratello 2 Nota biografica sull'autore Paolo Fanciullacci nasce ad Empoli il primo di giugno del 1944. Sembra mentre è in corso un bombardamento aereo. Questo imprinting lo porterà ad avere una passione smodata per tutto ciò che vola, dalle farfalle, ai Jumbo Jet. Il solito imprinting gli fornisce anche una certa predisposizione al bombardamento naturale che cercherà di espletare specialmente durante i suoi futuri viaggi attraverso paesi esotici. Già nella prima infanzia gli viene attribuito il titolo di ''inventore'' dai suoi compagni di giochi, quando incollando quattro moscon d'oro ad un aeroplanino di carta da lui stesso costruito, lo trasforma in quadrimotore che si perde nei cieli del ''bafòre'' e che non verrà mai più ritrovato. Questo titolo gli resterà tristemente e indelebilmente addosso fino alla maturità. '' Il bafòre'' è una zona delimitata dalla confluenza delle linee ferroviarie Firenze‐Pisa ed Empoli‐ Siena dove sfrecciano treni sferraglianti diretti chissà dove. E' qui che comincia a fantasticare e a sognare di viaggiare per il mondo. Costruendo aquiloni e aeromodelli di sua invenzione, tralascia spesso gli studi e dopo aver ripetuto un paio di anni alle medie inferiori, in terza media, dopo un quattro a latino, decide di lasciare gli studi. Richiamato dall'insegnante di lettere, certa Renata Tamburini, viene costretto a rientrare nei ranghi dalle lusinghe di detta insegnante, che vede in lui una luminosa carriera di giornalista. Rimandato a ottobre con un tre a matematica, nell'estate successiva viene a sapere che a Pisa esiste un istituto tecnico superiore con una specializzazione aeronautica. Ha uno sconvolgimento cerebrale e riesce a superare la sessione di ottobre con un sei a matematica, pur preparandosi negli ultimi 15 giorni. Contro i voleri dei propri genitori, che lo vogliono ragioniere, vi si iscrive e si diploma brillantemente come perito capotecnico aeronautico con menzione onorevole di 2° grado. Dovendo fare il servizio militare, fa domanda come ufficiale tecnico in aeronautica ma viene scartato per visus inferiore al minimo richiesto. Non contento, unico esempio in Italia e forse del mondo, fa domanda come soldato semplice in aeronautica, contentandosi anche soltanto di spazzare le piste, ma viene inesorabilmente spedito al centro addestramento reclute dell'esercito, in quel di Trapani. In estate. In autunno è a Bagnoli (Na), dove diventa marconista. In inverno viene mandato al reparto operativo della Divisione Folgore a Treviso e inviato immediatamente in manovra. Rischia per due volte di essere mandato al carcere militare di Gaeta. La prima, dopo una trasmissione radiofonica a Roma per le forze armate a cui è stato inviato, come elemento scelto, insieme ad altri tre commilitoni. Durante la trasmissione a quiz, dopo avere udito la musica dell'inno ''Monte Grappa tu sei la mia Patria '', invitati a rispondere di quale musica si tratti, per primo urla nei microfoni della RAI : ‐ BIMBE BELLE FACCIAMO ALL’AMORE ! !‐ con grave disappunto di Silvio Gigli, l'allora conduttore della trasmissione. La seconda, al tempo dell'invasione della Cecoslovacchia da parte dell'Unione Sovietica quando, in piena manovra, sostituisce un amico al centralino e alla voce imperiosa di un generale che chiede di passargli Vittorio Veneto, lui passa la cornetta a un certo Vittorio Ballario di Preganziol da tutti chiamato Vittorio veneto per distinguerlo da Vittorio Soggiu di Cagliari detto Vittorio sardo. Terminato con disonore il servizio militare, fa domanda di lavoro in varie aziende di costruzioni aeronautiche. Della Storia d’Empoli 3 Nessuna lo prende in considerazione. Preso dalla disperazione, fa domanda alla Piaggio di Pontedera, che lo accoglie a braccia aperte e dove comincia la sua carriera di disegnatore prima, e progettista poi, presso l'Ufficio Studi e Ricerche. Con il primo stipendio compra un rottame di Alfa Romeo Giulietta Spider, di cui è innamorato e da cui non si separerà mai più. Con gli altri stipendi comincia a dare stura alla sua voglia di viaggiare e, insieme ad altri sconsiderati amici, comincia il suo peregrinare per l'Europa spingendosi fino in Russia, regnante Breznev, mèta a quel tempo già difficile a raggiungersi in auto. In Piaggio conosce un amico che è proprietario di una splendida imbarcazione a vela. E' preso dalla passione per il mare e si avventura per tutte le isole dell'arcipelago toscano, fino a spingersi, in compagnia di un altro disgraziato, in Corsica e in Sardegna. Durante una crociera in Corsica approda in un campo nudista ed è irretito da una certa Dagmar, nudista tedesca, vestita solo di un cappello bianco e di una collana di conchiglie. Se ne innamora. Novello Ulisse, viene salvato dai compagni che lo legano all'albero di maestra e che, insensibili alle sue grida e alle sue minacce, lo riportano in Italia con il cuore spezzato, ma libero. E' durante questa crociera che scrive ''Fafnir'', il primo, vomitevole, diario di bordo. Tornato in patria, come una farfalla, vola di fiore in fiore, finché sua nonna Cesira gli fa una terribile profezia : ‐Farai la fine del moscon d'oro, che vola,vola,andò a finire su una merda.‐ La terribile profezia quasi si avvera. Conosce tale Benvenuti Anna, insegnante di matematica che diventerà ancora più famosa di lui per i viaggi, tantoché in suo onore, all’ingresso delle frontiere di nazioni o all’ingresso di città e paesi verranno esposti cartelli con il suo nome tradotti in tutte le lingue: “Benvenuti in…” o “Benvenuti a…” Purtroppo per lei, lo sventurato la sposa, credendola ricca, e, forse, per una vendetta inconscia contro la matematica che lo ha fatto tanto soffrire da piccolo. Sarà deluso dal primo motivo. Insieme generano due extraterrestri, Letizia e Claudio. Alla Piaggio, in meno di un anno, con l'aiuto di un paio di indiani che non hanno mai disegnato, progetta quello che sarà l'ultimo motore a due tempi della storia Piaggio che, forse in onore dei suoi trascorsi marinari, viene montato su di un veicolo che chiameranno ''Skipper”. Dopo 26 anni di disonorato servizio, riesce a fuggire dalla Piaggio e si rifugia nella ditta Ariete. Qui, vista la sua esperienza di motori Piaggio, lo mettono a progettare macinini. Cosa che gli riesce con discreto successo. A 59 anni suonati se ne va in pensione. Muore d'infarto il 30 settembre 2005. Però, entro 3 minuti, il Padreterno, dopo essersi consultato con i diavoli, gli angeli e con i santi, e coadiuvato dal personale dell’ospedale di Empoli, con una pedata nel culo, lo ributta tra i vivi, che sono tuttora costretti a sopportarlo. Nel 2006 fonda il premio Orticello in contrapposizione al premio Campiello, a cui partecipa sotto lo pseudonimo di Marco Paolo, con la tremenda opera ''Il Milione (di SUM)''scritta dopo un viaggio in Uzbekistan. Non lo vince per un soffio, pur essendo in una rosa di concorrenti composta da lui soltanto. Ci riprova con un altro diario “ Andati e tornati dallo Yemen, Inshallah!” opera che è molto, molto, molto peggiore della prima. Non contento, ne scrive un altro dopo un viaggio in Marocco: “Alì Babà, o come veniva appellato un disgraziato costretto a viaggiare in Marocco”. Una vera disperazione. Se avete la sventura di capitare in biblioteca, ed avere fra le mani questo libercolo, non lo leggete. Datemi retta. Ne va della vostra salute. Oppure, meglio, consigliatelo al vostro peggior nemico. Della Storia d’Empoli 4 I ragazzi del “Bafòre” Prima di cominciare, una riflessione dell’Autore Il mio “amico” Paolo Pianigiani mi tira per la giacchetta a scrivere di ricordi. “Amico” lo metto fra virgolette, e non me ne voglia, perché alla data di oggi, non l’ho mai visto di persona. Amicizia, per me che sono di una generazione nata, non dico senza Internet, ma anche senza telefono, è una parola grossa. Con questa diavoleria di Internet, invece, puoi diventare “amico” di migliaia di persone, parlare o scrivere con altrettante e rimanere solo come un bischero davanti a uno schermo che ti risucchia come un gorgo, come un buco nero. Bisogna tenerlo a debita distanza, ma purtroppo tante volte non ci si fa. Entri per informarti di un certo argomento e mentre ti informi, in contemporanea, ne trovi un altro che ti interessa altrettanto. Mentre stai leggendo questo nuovo ti accorgi che ce n’è un altro altrettanto interessante. E così via. E, mentre cercavi notizie di un certo tipo di biplano del 1918 e dei suoi piani di costruzione, ti ritrovi a scrivere col Pianigiani di Piazza della Vittoria in Empoli o del casino, di buona memoria, di Via Carraia. Sempre in Empoli. E’ tremendo. Piano, piano, entri nell’imbuto del gorgo, del buco nero. Ti tira giù, sempre più giù, sempre più velocemente. E non esci più, se non sai nuotare bene. E’ il brutto e purtroppo anche il bello del mondo di Internet. Puoi essere in compagnia e amico di migliaia di persone, e intanto sei completamente solo nella tua stanza a picchiettare con i diti su una tastiera. Secondo me è la nuova alienazione, pericolosissima per i giovani che non sanno nuotare. Io, appunto, mentre giravo in questo vortice, ho incontrato “Della Storia d’Empoli” e in questa, il Pianigiani che mi tira per la giacchetta. ‐ Scrivi, scrivi,‐ mi dice,‐ scrivi dei tuoi ricordi, di quando eri piccolo, di qualsiasi cosa vissuta dalla tua generazione, perché ci interessa in “Della Storia d’Empoli”.‐ Una specie di “Amarcord” di felliniana memoria, insomma. Maremma! Sono già vecchio e, non solo, già oggetto di storia. Come Cesare e Pompeo! E allora mi ci provo, e che Dio me la mandi bona e senza vento o, come diceva quel potente (sotto tutti gli aspetti, a quanto pare) tizio di Hardcore di un recentissimo passato: ‐Che Lele me le mandi bone e senza mutande! ‐ P.S.‐ Se trovate errori o incongruenze, perdonatemi. Spesso scrivo di notte per cui non sono tanto a piombo e sono piuttosto rintronato. Caso mai, parafrasando un papa, “mi curreggerete”. A questo punto sarà bene cominciare da lontano. Della Storia d’Empoli 5 Introibo di Paolo Pianigiani Gliel’ho praticamente tirato fuori a forza, un capitolo alla volta. Lo teneva chiuso non so se in qualche cassetto o nel cuore… Mai visti dal vivo, noi due, sempre spippolando sulle tastiere: insieme a tanti altri amici si è messo insieme quella specie di rifugio antiatomico, sicuro al tempo inesorabile e alla stupidità degli uomini, che comincia ad’essere il nostro sito sulla storia d’Empoli. Ha preso nome da un manoscritto del dottore strizzacervelli empolese Vincenzio Chiarugi: www.dellastoriadempoli.it Paolo Fanciullacci: si fosse abitati vicini saremmo stati della stessa banda. Ma io son nato un po’ dopo e più verso il centro, lui nella periferia verso Pisa, al Bafòre. Ma ci siamo conosciuti lo stesso, siamo fatti della stessa aria, della stessa acqua di fosso, degli stessi profumi d’erba. Aveva ragione una professoressa di lettere, delle medie, che andò a recuperare un ragazzo che si era stufato degli studi e della scuola: diventerai un grande giornalista. Le vie del mondo portarono Paolo ad inseguire un sogno d’aquiloni, in quel mondo incantato che era allora la grande fucina d’idee sfreccianti sulle due ruote: la Piaggio di Pontedera. E alla Stazione d’Empoli, a far partire i treni non c’era il capostazione: c’era Brunèro, sempre preoccupato per la sua giacchetta; che s’incazzava se incontrava la Napoletana a picche, sempre pronta a fargli le corna, mezza strega e mezz’avanzo di casino, come qualcuno mormorava. Della Storia d’Empoli E allora, tira tira, finalmente il lavoro è finito. Ne abbiamo dato i capitoli, via via che Paolo li metteva al mondo. E ora sta qui sul monitor, tutto intero: con il titolo, il sottotitolo e le presentazioni. Manca per l’appunto un introibo, che sia in tono con il testo. Ho chiesto di farlo io, per condividerne, forse, la colpa, che ci faranno scontare a tutti e due in qualche purgatorio buggerone: io per colpe maggiori allo scrivere, lontane e vicine, lui, per ora, solo per questo lavoro qui, che colpe ne ha poche. Meriti tanti. Si dipàna, questo libro, come un racconto lungo nel canto del fuoco, ai nipoti, aspettando mezzanotte. Mentre i ciocchi rimandano gli schiòcchi cupi e le faville diventano stelle svolazzanti nel cielo nero del camino. E ripiglia fiato il narratore, ad ogni salto di capitolo. Questi ragazzi sono vivi, stanno crescendo, siamo noi… 6 Capitolo primo Il “BAFÒRE” E qui sarà bene spiegare cos’era il “Bafòre”, con l’accento sulla o. Per “Bafòre” veniva inteso l’incrocio della Tosco Romagnola, con la ferrovia Firenze‐Pisa. La strada, dopo una leggera salita, passa a “livello” della ferrovia. Da qui il nome di “passaggio a livello”. Anticamente, per fermare il traffico stradale quando passava il treno, venivano usate delle transenne, poi sostituite con sbarre, e per questo la zona del “bafòre” veniva, anticamente, anche chiamata “ I cancelli”. Si, mi direte, ma perché “Bafòre”? Perché quando fu costruita la ferrovia Leopolda Firenze‐Pisa, i treni andavano a vapore, ma come succedeva a moltissime parole nuove, il popolo minuto le storpiava. Così il vapore divenne “Bafòre” e “Bafòre” rimase anche quando i treni andavano ormai ad elettricità, o a corrente come si diceva da noi. La casa dove abitavo io, era situata proprio sulla strada statale, meglio conosciuta come Tosco Romagnola o Via Livornese. La casa era separata dalla strada solo da un piccolo marciapiede di un paio di metri. Era situata se ben ricordo, al numero 96, come indicava il numero blu sulla targhetta bianca smaltata. A 50 metri dal “Bafòre” vero e proprio. Faceva parte di un ciuffo di case con una “corte” a comune, come pure erano a comune il forno e il “pillone” per lavare i panni che era vicino al pozzo. Anche questo sulla statale. Questo ciuffo di case era abitato da sette famiglie. Noi ragazzi eravamo in cinque distanziati di un anno l’uno dall’altro. C’era anche un’unica bambina più o meno della nostra età, che abitava vicino a me. Poi c’era un giovanottello più grande di noi e altre due ragazze. Sorelle. Nella nostra banda si aggiungevano due fratelli che abitavano in una casa di contadino, ora completamente abbandonata, che era a un centinaio di metri più avanti verso il Ponte alla Stella. Sempre sulla statale. Questo ciuffo di case era, ed è, situato fra la ferrovia Firenze ‐ Pisa e la Empoli ‐ Siena che gli corre proprio dietro. Quindi, noi abitavamo al “Bafòre”. I miei possedevano anche una vignaccia vicino al Ponte alla Stella, ricavata da una striscia di terra fra la statale e la ferrovia di Siena. Adesso è completamente dismessa e sopra ci passa il ponte della superstrada. Se uno guarda bene, sepolta da una macchia di sterpi, c’è ancora la capanna degli attrezzi, o quello che resta di essa, che eressero mio nonno e mio padre utilizzando come colonne portanti traversine di legno della ferrovia e, come pareti, le canne prese dal canneto che cresceva sulla guancia della ferrovia di Siena. Tutte le case del “Bafòre” non avevano il bagno come comunemente si intende oggi. Noi ragazzi, ma anche i nostri familiari, il bagno lo facevamo in una tinozza, spesso montata sull’acquaio di cucina. Ogni tanto, quando era piovuto e si era raccolta tanta acqua piovana nel pillone di casa, allora ci era permesso di farlo lì dentro, e allora diventava una vera e propria goduria. Della Storia d’Empoli 7 Le funzioni corporali, invece, venivano fatte in latrina. Forse, per i giovani che non conoscono questo termine ne tantomeno il luogo , sarà bene spiegare come era. Normalmente consisteva in uno stanzino in cui ad una parete, di solito quella opposta alla porta di entrata, c’era una specie di scalone alto una sessantina di centimetri. Al centro di questo scalone c’era una buca con un diametro di 40‐50 centimetri che era in comunicazione con un condotto in gres del solito diametro che scendeva giù a precipizio direttamente nel “bottino”. Questa buca veniva tappata con un tappo di legno che aveva una specie di piòlo che fungeva da manico. Anche questo di legno. Nonostante questo tappo,e la finestrina sempre aperta anche d’inverno, in latrina non è che ci fosse una bell’aria. Quando poi si apriva il tappo, tutti i miasmi del bottino venivano su e prendevano alla gola. L’ammoniaca che si sviluppava, toglieva il respiro e faceva lacrimare gli occhi. Per fare le funzioni corporali accucciati su questa buca, bisognava starci in apnea. La carta igienica l’avevano ancora da inventare, per lo meno al bafòre. Questa era sostituita da pezzi di giornale, normalmente “l’Unità”, che mia madre non poteva vedere e che era l’unico giornale venduto porta a porta. Questo veniva strappato a foglietti quadrati, fatto un mazzetto e appeso a un chiodo della parete. Qualcuno adoprava anche le schedine della SISAL che era il totocalcio del tempo. Un secchio pieno di acqua, lì accanto, faceva la funzione di sciacquone, ma con parsimonia, perché l’acqua bisognava andarla a prendere al pozzo e questo comportava fatica d’estate e fatica e freddo d’inverno. Mi ricordo che da piccolo soffrii parecchio di stitichezza, molto probabilmente per il rifiuto di entrare in quella camera a gas e per la paura che mi incuteva quel buco. Mi curarono a olio di ricino e olio di fegato di merluzzo, che è la cosa più tremenda e cattiva che io abbia mai potuto assaggiare in tutta la mia vita. I residui corporali di tutta la famiglia non è che venissero eliminati. Anzi. Questi venivano usati come concime (ottimo, dicevano i vecchi) per le verdure degli orti o dei campi. Infatti tutte le case del “bafòre”, avevano un “bottino”per la raccolta di questi residui. Il “bottino” era un deposito interrato dove confluivano tutti i liquami della latrina. La mia famiglia era abbastanza fortunata ad avere la latrina in cima alle scale, al piano superiore della casa. Due dei miei amici, fratelli, non ce l’avevano. Andavano in capanna, fuori di casa, in inverno, primavera estate o autunno che fosse. Lì era stato interrato un bidone da benzina con il coperchio con un foro di 30 centimetri dove i miei amici, e i loro familiari, si accucciavano e scaricavano. Spessissimo, tutti noi ragazzi, abbiamo fatto le nostre riunioni di guerra o per il da farsi della giornata, davanti a uno di loro mentre era accucciato, intento ad aspettare l’ evacuazione. La casa del Fattori, contadino, che era più avanti verso il Ponte alla Stella, la latrina l’aveva esterna, in un corpo avanzato nella parte posteriore della casa al piano delle camere superiori. Scaricava direttamente in un’altra latrina a piano terra e quindi in un “bottino” confinante direttamente con la concimaia. Nella concimaia veniva raccolta invece tutta la lettiera delle mucche e naturalmente anche tutta la loro cacca. Della Storia d’Empoli 8 Nella concimaia i nostri padri spesso ci mandavano anche a rufolare per cercare lombrichi che servivano come esca per lasche e barbi che venivano pescati a canna in Elsa o in Arno. Si scavava con una vanga o una zappa e poi, con le mani nude, si stanavano i lombrichi da mettere in un barattolo. In casa mia per la raccolta dei liquami dal bottino, veniva usato un barattolone di lamiera preso da ‘Guazza’, l’erbivendolo di S. Maria. Era un contenitore di concentrato di pomodoro che a quel tempo, era venduto sfuso. A questo barattolone, che era una specie di secchiello, mio nonno aveva inchiodato un manico trasformandolo in un enorme “romaiolo”. Con questo attrezzo pescava nel bottino e lo rovesciava nei secchi da spargere per la verdura che aveva piantato nei filari della vigna di Ponte alla Stella. Molto più tecnologico era il “romaiolo” del Fattori che era sulla strada per il Ponte alla Stella. Al manico era stato inchiodato un elmetto tedesco che era abbastanza capiente e, essendo arrotondato nella parte inferiore, poteva raccattare proprio tutto il contenuto del deposito. Assomigliava proprio a un vero e proprio romaiolone da minestre. Era stato provato anche un elmetto inglese, ma non si rivelò adatto all’uopo perché era una specie di padella, e nel tirarlo su versava tutto il contenuto. Al “bafòre “ non si buttava via nulla. Neanche la merda. Per esempio la casa del Fattori, vicino a Ponte alla Stella, aveva un’aia sterrata, e quando arrivava il tempo di trebbiatura, alla fine di Giugno o nel mese di Luglio, quest’aia veniva “Imbaccinata”. L’imbaccinatura veniva fatta prendendo la cacca dei buoi e delle mucche (la baccina) che veniva stemperata in un mastello con un certo quantitativo di acqua. Quando la consistenza di questa putrida melma veniva considerata della giusta densità, e questo veniva fatto immergendo un dito nel mastello, veniva spalmata per tutta l’aia sterrata con delle scope di saggina. Dopo che il sole aveva seccato questa poltiglia schifosa, l’aia diventava secca, liscia, vellutata come un biliardo e di un bel verdolino chiaro. Ci si poteva spazzare anche uno spillo. Camminare a piedi nudi sulla superficie dell’aia trattata in questa maniera, per noi ragazzi, abituati ad andare scalzi in estate, era piacevolissimo. Con questo sistema, i chicchi di grano che potevano cadere durante la trebbiatura, potevano essere spazzati e recuperati, senza essere mischiati alla terra o ai sassi. Però, con tutto quello che ci circondava e soprattutto con i pochi e parchi lavacri che facevamo, come non si sia preso la peste, il colera, tetano o quant’altro, lo sa solo il Padreterno. Della Storia d’Empoli 9 Capitolo secondo L’asilo del Terrafino Avete mai pensato a quale sia il più lontano ricordo rimasto impresso nella vostra memoria? E’ un esercizio interessante. Io provai a farlo all’età di 8 o 9 anni. Chiesi a mia madre chi era stato quell’uomo abbronzato, con i baffetti neri, con un cappello di feltro marrone che, quando ero piccolo, era entrato in casa con un sacco di gente. Tutti lo abbracciavano, mi aveva preso in collo sbaciucchiandomi e mi buttava per aria riprendendomi al volo. Mia madre rimase allibita. Mi spiegò che non era possibile che mi ricordassi di quell’avvenimento. Era il 1946 o ’47 e quindi avevo due o tre anni e quell’uomo non era altro che mio zio Nello. Uno dei pochi sopravvissuti alla tragedia di El Alamein e di Tobruk. Gli inglesi avevano fatto prigioniero, lui, il suo mitragliere e tutto il carro armato di latta su cui ambedue scorrazzavano per il deserto della Cirenaica alla ricerca di un po’ di sabbia per piantarci una bandiera. Io non so se dipendesse da quei balzi per aria che mi fece fare o da tutta la gente che era entrata in casa, il fatto è che me lo ricordo tuttora. Ma come un flash. Era ritornato a casa, al “Bafòre”, da Casablanca dove lo avevano internato. In effetti , dei primi anni del dopoguerra, ho ricordi frammentari, dei flash (o flashes?) appunto. Flash. Il cane ‘Birillo’a cui mi appoggiavo per camminare (me lo ricordo alto, perché appoggiavo la mano alla sua schiena che era all’altezza della mia spalla). Altro flash. Me seduto per terra, in cucina, su una coperta grigia tipo militare a giocare con dei rocchetti di legno dei “filiforti” mentre mia madre sferraglia pedalando alla macchina da cucire al lume di una lampada a petrolio. Altro flash. Il contatto freddo della bachelite della cuffia della radio a galena che mio padre , al mattino, al rientro del turno di notte, mi metteva all’orecchio per farmi sentire il cinguettio dell’uccellino della RAI prima del giornale radio, mentre me ne stavo al calduccio sotto le coperte del “lettone”. Altro flash. Io e mio fratello che saliamo le scale per andare a letto con le candele in mano e ci divertiamo ad affumicare la parete bianca delle scale avvicinandone la fiamma a contatto. Ancora un altro flash. Mio zio Renato, che sapeva far tutto, in piedi sulla tavola della cucina mentre armeggia a un piatto di vetro bianco ondulato. Il piatto è attaccato a un filo che pende dai travicelli del soffitto e zio Renato armeggia per metterci la presa per il ferro da stiro e la lampadina. Poi flash (flashes?) sempre più fitti, più chiari e dettagliati. Per esempio l’asilo del Terrafino. Della Storia d’Empoli 10 E qui devo fare una premessa. Fino ad allora l’economia di Empoli si era basata, per la maggior parte, sulla produzione dei fiaschi e delle damigiane in vetro verde. Le donne rivestivano i fiaschi a domicilio con un’erba palustre chiamata sala. Con il salicchio invece facevano i cordini per fermare il fondo e per il trasporto del fiasco . Intorno alle vetrerie e per le strade di Empoli era tutto un viavai di carretti trainati a mano per prendere i fiaschi nudi e la sala dalla vetreria per poi riportarceli una volta rivestiti. Nell’immediato dopo guerra ci fu l’avvento di un altro tipo di industria che avrebbe avuto uno sviluppo eccezionale. La confezione di impermeabili o “trenci”. Della Storia d’Empoli Mamma e Babbo, da giovani Trench è parola inglese e vuol dire ‘trincea’. Credo che la parola derivasse dagli impermeabili dei soldati di trincea, lunghi quasi fino ai piedi, che venivano usati nella prima guerra mondiale, ma non ne sono sicuro. Comunque la parola la storpiammo subito con “trence” al singolare, per cui , al plurale, “trenci”. Con l’avvento delle confezioni il lavoro a domicilio per le donne, specialmente per quelle più giovani, cambiò radicalmente. Prima di tutto bisognava avere una macchina da cucire, saperla usare, cosa che le più anziane non tutte sapevano fare, e poi, invece del carretto, era meglio possedere una bicicletta. Mia nonna Cesira per esempio, non sapeva ne rivestire i fiaschi, ne cucire, ne tantomeno andare in bicicletta. Lei faceva strumenti di tortura. 11 Faceva la calza, o meglio, la “carza”. Si metteva un cannello di canna, tagliato in maniera particolare, avvolto nella cinghia del grembiule sul fianco destro. Lì vi infilava un ferro da calza, mentre l’altro lo teneva nella mano sinistra. Questo lo faceva frullare intorno a quello fisso a una velocità vertiginosa avvolgendo e tessendo chilometri di filo sfilandolo da una palla di lana bianchiccia di colore appena giallognolo. Praticamente del solito colore delle pecore. Con questo sistema gli uscivano dalle mani, guanti, calzini e quello che era peggio, quelle che venivano chiamate camiciole. Tutto color pecora e con una maglia serrata che sembrava cartone. Quelli che hanno la mia età e abbiano provato a indossare d’inverno, senza riscaldamento, questi cilici, possono testimoniare se dico la verità. Queste camiciole, che avevano le maniche lunghe, quando venivano lavate, si “impeltrivano” e diventavano rigide e strette. Ma quello che era peggio, bucavano e pizzicavano come se fossero fatte di spilli. Solo dopo averle portate un paio di giorni le cose miglioravano. Ma ad ogni cambio, erano strilli e urli. Mia madre allora diceva: ‐ Pensa a Nostro Signore che aveva una corona di spine! Che avrebbe dovuto dire Lui poverino?‐ Forse cominciai allora ad avere qualche dubbio religioso. Comunque mia madre possedeva la macchina da cucire a pedale, ricevuta come dote da mio nonno, e sapeva anche andare in bicicletta, cosa alquanto sconveniente per le donne del tempo, ma non sapeva come cucire i “trenci”. Si sparse la voce che c’era lavoro a domicilio per questo tipo di confezioni e più si lavorava e più si guadagnava. Ecco che allora i carretti delle fiascaie cominciarono a essere soppiantati dalle prime biciclette guidate da ragazze o giovani spose, con sopra al manubrio enormi fagottoni neri che andavano e venivano sulla statale. Mia madre decise di imparare anche lei per aiutare a incrementare le magre entrate di famiglia. E dove andò ad imparare? Si dette il caso che Pia, la figlia dell’appaltino del Terrafino, fosse molto brava in questo tipo di lavoro e si dava anche il caso che fosse amica di mia madre. E allora detto e fatto. Al mattino mia madre spediva mio fratello più grande a scuola, infilava me in un seggiolino agganciato al manubrio della sua bicicletta e partiva per il Terrafino. Mi lasciava all’asilo delle suore che era praticamente di fronte all’appalto, e andava da Pia ad imparare. Spesso mi lasciava tutto il giorno e mi riprendeva nel tardo pomeriggio. Quell’asilo (adesso gli asili si chiamano scuole materne), mi rimase nel cuore. Mi rimase tanto nel cuore e nella memoria che, passati tanti anni, ci mandai pure i miei figli. Prima Letizia e poi Claudio. Questo asilo era stato ricavato in una villa, credo settecentesca, che la proprietaria, Sandrina Pappodof, aveva lasciato in eredità alle suore del Cottolengo. Della Storia d’Empoli 12 In quanto senza figli e alquanto cattolica, aveva lasciato tutto. Villa, fattoria, tenuta, boschetto e non so quant’altro. La chiamavano “la Pappodof”, in quanto pare che avesse sposato un conte o principe russo fuggito dalla rivoluzione del ’17 e, a quanto raccontavano, ubriaco fisso. Questo però non so se sia verità o leggenda. Quando entrai per la prima volta nell’ingresso di questa villa, rimasi subito sbalordito dal pavimento lucido dell’ingresso e dalle vetrate colorate blu, rosse e gialle dei paraventi che davano sulle stanze. Non erano nulla di particolare, ma il fatto che fossero colorate al mio cervello di bambino, chissà cosa sembrarono. Come pure il pavimento lucido. Non ne avevo mai visto uno. I nostri pavimenti erano in mattoni, e solo per le pulizie di Pasqua venivano resi più rossi con il “ginabrese”. Magari poi veniva data una cera che li rendeva un po’ più lucidi, ma sempre mattoni erano. All’asilo del Terrafino, noi bambini, avevamo a disposizione delle stanze al pianterreno. Mi ricordo che una serviva come aula con sedie e tavolini azzurri. Un’altra, dove c’era un pianoforte e due enormi vasi cinesi negli angoli, serviva come aula di canto. Un’altra serviva come sala da pranzo con sedie e tavolini. Anche questi tutti azzurri. Un’altra per i giochi. Insomma non mancava assolutamente nulla per farci passare il tempo e insegnarci qualcosa. Ma quello che colpì me, bambino del “bafòre”, fu il giardino della villa. Prima di tutto era grandissimo. C’erano degli abeti enormi (ci sono ancora) con i rami più bassi che scendevano fino a terra. Nel mezzo c’era una vasca rotonda piena di acqua con lo zampillo centrale. Ad una estremità del giardino, in un angolo, confinante e vicinissima alla scarpata della ferrovia di Siena, c’era una grotta artificiale. Questa era rivestita con delle pietre vere, stranissime, tutte bucherellate come se fossero delle spugne, e dentro questa grotta, nella semioscurità, c’era una statua di una madonna con una fontanella. Dietro questa grotta c’era una scaletta esterna, a chiocciola, che portava su un terrazzino sulla sommità della grotta. Da lì potevamo assistere al passaggio dei treni della Empoli‐ Siena che allora, su quella linea, andavano ancora a vapore. Poi sul lato confinante con la scarpata della ferrovia, c’erano due gabbie enormi, fatte a voliera, con dentro due animali fantastici che io non avevo mai visto. Erano due pavoni, maschio e femmina. Quando vidi per la prima volta la coda di questo uccello completamente spiegata a ruota , piena di piume verdi, gialle e blu con una miriade di dischi che sembravano occhi a colori iridescenti, rimasi letteralmente a bocca aperta. Non avevo mai visto niente di simile e ne rimasi affascinato. Sarei rimasto a guardarlo per ore. Una volta però, mentre stavamo tutti ad osservare questo strano fenomeno, il pavone emise un urlo altissimo, lungo, spaventoso e raccapricciante. Scappammo tutti impauriti come gatti frugati dalla nostra suora che ci faceva da maestra. Cercò di tranquillizzarci spiegandoci che quello era il verso del pavone quando era contento. Ma ci convinse poco, e da quel momento stemmo sempre alla larga da quelle voliere, guardandole solo da rispettosa distanza. Della Storia d’Empoli 13 Molti anni più tardi, durante il servizio militare nella Divisione Folgore di Treviso, ci fecero fare una manovra di esercitazione in Friuli. Ci avevano fatto sistemare con le tende mimetizzate e le radio da campo, in un giardino di una villa semi‐abbandonata. Durante la notte mentre dormivamo, sentimmo un urlo prolungato ed agghiacciante. I miei commilitoni, sei o sette, che dormivano nei sacchi a pelo nella tenda insieme a me, si alzarono di scatto impauriti. Qualcuno corse addirittura a prendere la baionetta. Il fucile era inutile, perché non avevamo il minimo proiettile. ‐ O bischeri! ‐ dissi‐, ma che non avete mai sentito un pavone?‐ ‐Un pavone?‐ risposero. ‐Un pavone, un pavone‐, e mi rimisi a dormire. Il giorno dopo ne trovammo uno con la coda lunghissima che razzolava nel giardino abbandonato come se fosse un gallinaccio. Devo dire che feci una gran figura. Ritorniamo al Terrafino. Nel giardino del Terrafino oltre ai pavoni c’erano anche due tartarughe che io mi ricordo grandissime. Ogni tanto una di esse sbucava dalle siepi e noi correvamo a cavalcarla sul guscio, facendoci portare a spasso per il giardino. Non so che razza o tipo di tartarughe fossero, ma come grandezza me le ricordo poco più piccole di quelle marine ma con il guscio più alto e rotondo. Mi ricordo solo che le cavalcavamo. Ma, in quell’asilo, non c’era solo la villa e il giardino. Nel cortile di pietra serena antistante l’ingresso della villa, si affacciava anche una cappella con un piccolo altare con sopra una statua di una madonna. Tutte le mattine prima di iniziare le esercitazioni o i giochi, le monache ci portavano in questa cappella a dire le preghiere che consistevano in una Ave Maria, un Padre Nostro e un Eterno Riposo per i defunti. Alla fine di queste orazioni ci facevano cantare un canzone alla Madonna. Da quanto mi piaceva, io la cantavo con quanto fiato avevo in gola. Non ricordo tutte le parole, ma il ritornello si. Il ritornello faceva: Bellaa tu sei qual soleee, biancaa più dellaa lunaaa, e le stellee più belleee, non son belle al par di teee!!!... Mi sembrava bellissima, e sognavo di cantarla come serenata ad una bambina bionda più grande di me che mi piaceva da morire, ma che, naturalmente, non mi guardava nemmeno. Ho avuto modo, in tempi recenti, di risentirla cantata da Riccardo Marasco accompagnato dalla sua caratteristica chitarra‐ lyra e mi sono commosso, sommerso dai ricordi di allora. Che ci volete fare! Mi piace tuttora, nonostante che io non sia molto religioso. Nel solito cortile, fra la cappella e la villa, un poco più in dentro, c’era l’ingresso di un piccolo teatro di cui ebbi anche l’onore di calcarne le scene. Non mi ricordo in quale occasione, ma fu organizzata una recita in cui partecipavano tutti i bambini e bambine dell’asilo. Della Storia d’Empoli 14 Doveva essere la trasposizione di una qualche favola, in cui c’era una principessa triste che non voleva mangiare, non mi ricordo per quale ragione. So solo che questa principessa era impersonata da quella bambina bionda che mi piaceva da morire. Io dovevo fare la parte di uno dei cuochi che portavano i vassoi con le pietanze a questa principessa. Ognuno dovette imparare la propria parte. Poi incominciarono le prove. La principessa stava seduta su di un trono accanto ad un altro su cui era seduto un bambino in funzione di re. Noi cuochi, sette o otto, dovevamo sfilare uno alla volta davanti a questa principessa recitando la nostra parte. Ero talmente preso da questa recita, che quando arrivavo a casa, non facevo altro che girare intorno alla tavola di cucina declamando la mia parte con un coperchio di una teglia a mo’ di vassoio in una mano e smanacciando con l’altra, facendo ampi gesti indicando questo pseudo‐ vassoio. I miei erano esasperati. Mia madre cominciò a dirmi di smetterla perché ormai avevo imparato. ‐Basta, basta, basta!!!! Smettila !!!‐ mi urlava,‐ L’hai già imparata!!! Basta!! Basta!! Mia nonna Cesira, completamente sorda, che mi vedeva girare intorno alla tavola con il piatto in mano e smanacciare al cielo, credendo che avessi qualche turba mentale, consigliò mia madre a farmi vedere dal Salimbeni, che era il nostro dottore di condotta. Io, invece, continuavo imperterrito a provare e riprovare. Volevo fare bella figura con quella bambina bionda. E finalmente venne la sera della recita. Mi ricordo tutto come allora. Mi avevano messo un grembiule bianco che mi copriva a malapena i calzoni corti che allora portavamo tutti. Mi avevano messo una imbottitura per farmi una pancia finta e mi avevano tinto le guance e la punta del naso con un colore rosso paonazzo ricavato da della carta rossa bagnata che era stinta con l’acqua. Inoltre indossavo un cappello di cartone bianco a cilindro che simulava un cappello da cuoco. In più dovevo tenere le guancie gonfie per sembrare grosso e grasso. In mano avevo un vassoio di cartone bianco con dentro dei pezzetti di cartone marrone, che simulavano la pietanza. Ero il quarto cuoco di una fila di otto, pronti a entrare in scena. Dalla parte opposta del palcoscenico, invisibile alla platea ma visibile a noi, la suora regista dette il segnale sussurrando: ‐Avanti, avanti! Allora il primo cuoco avanzò al centro del palcoscenico, davanti alla principessa, fece l’inchino e declamò la sua parte. La principessa fece cenno di no con la testa con aria alquanto schifata. Poi toccò al secondo. Inchino, declamazione e solito diniego. La scena si ripeté anche per il terzo. Poi toccò a me. La suora mi fece cenno di avanzare. Gonfiai le gote. Avanzai nella luce del palcoscenico. Rimasi interdetto con il vassoio in mano. Vedevo l’oscurità della platea con tutti quei volti appena appena rischiarati e fui preso dal panico. La suora, preoccupata, mi faceva cenni disperati con le mani perché avanzassi: Della Storia d’Empoli 15 ‐Avanti! Avanti!!!‐. Guardando ancora la platea intravidi appena in seconda fila i volti di mia madre , mio padre, mio fratello, mio nonno e mia nonna. Tutti in fila, che mi guardavano. Presi coraggio. Avanzai baldanzosamente davanti alla bambina principessa e al bambino re, mi dimenticai di fare l’inchino, sgonfiai le gote, e con quanto fiato avevo in gola, urlai la mia parte che avevo provato per giorni e giorni: ‐LINGUE DI PAPPAGALLO!!!‐ Sembrò più un insulto a quei due, che una declamazione della pietanza. E senza aspettare il diniego della principessa me ne andai, come mi avevano insegnato, tutto tronfio, a gote gonfie e pancia all’aria, verso la parte opposta del palcoscenico, dove la suora con una spintarella mi mise da una parte. In compenso la bambina sorrise. In platea scoppiò una risata universale coperta da un applauso scrosciante. Quella fu la prima, unica e ultima apparizione sulle tavole di un palcoscenico da parte mia e la chiusura definitiva della mia carriera di attore. Mio fratello, dopo questa prova magistrale, mi prese per il culo per un bel pezzo. Anni addietro qualcosa di simile si doveva ripetere con mia figlia Letizia. Sempre sul solito palcoscenico. Come spesso succedeva, io e mia moglie lavoravamo e perciò eravamo occupati tutto il giorno. Venne il momento in cui bisognò affidare Letizia alla Scuola Materna, e, come ho già detto, preso da nostalgia, in quell’asilo ci mandai anche mia figlia Letizia. Riandai a vedere il giardino. La vasca del giardino c’era sempre, ma era piena di sabbia. Penso per sicurezza. C’era ancora la grotta con la madonnina, e c’erano ancora le voliere, ma i pavoni erano spariti e le tartarughe pure. La recita, però la facevano sempre. Anzi, dovevano fare anche scuola di dizione. Infatti una sera che ero rientrato dal lavoro e prendendo in braccio Letizia le chiesi cosa aveva fatto all’asilo. Rimasi esterrefatto della risposta. ‐ I bambini oggi hanno fatto troppa baraconda e la suora li ha sgridati tutti!!‐ Mia figlia, già a quel tempo era molto diligente. Molto probabilmente la suora cercava di insegnare ai bambini la pronuncia corretta delle nostre ‘ase per case ‘agne per cagne e così via. Insomma a non mangiare le nostre “c” toscane ed empolesi. Letizia, diligente com’era, capì subito l’antifona e la parola baraonda la corresse subito nell’italiano “corretto” baraconda. ‐Brava, le dissi, l‘estate prossima andremo tutti al mare a Vicareggio. Insieme alla maestra. Diglielo eh! mi raccomando‐. Non ne ho più saputo nulla. Ogni anno facevano una recita per Natale. Di solito rappresentavano la natività di Gesù. Lei ambiva fortemente a fare la Madonna. Il primo anno le fecero fare, con molta delusione, la comparsa. Una pastorella . Però, l’ultimo anno di asilo, finalmente, le toccò la parte della tanto ambita Madonna. A differenza di me, a casa non provò mai la sua parte, perché, diceva, doveva essere una sorpresa. La suora però parlando con mia moglie si sperticava in lodi e diceva: ‐ Se vedesse! Se vedesse! Sua figlia è deliziosa! Deliziosa! Semplicemente deliziosa!!!‐ Della Storia d’Empoli 16 Finalmente venne la sera della recita e andammo a vedere questa famosa Madonna deliziosa. Si aprì il sipario e ci trovammo di fronte a Letizia vestita di bianco con il velo azzurro sulla testa, come nelle migliori iconografie della Madonna, seduta a sferruzzare una improbabile calza, mentre una voce fuori campo narrava della vita del popolo di Nazareth e della vita di questa fanciulla. Ad un certo punto arrivò un bambino angelo con le ali bianche di cartone, una sù e l’altra ciondoloni, che disse: ‐ Maria, tu sarai madre e partorirai un bambino di nome Gesù‐. E se ne saltellò via. Mia figlia, Madonna deliziosa, alzò lo sguardo dai ferri e dalla calza, e, con una espressione e un sentimento da fare invidia a Eleonora Duse, pronunciò la fatidica battuta fra l’esclamativo e l’interrogativo: ‐ MA COME!?‐ Riabbassò gli occhi sulla calza e si chiuse il sipario. Ci furono applausi, ma anche risatine, forse anche un po’ sarcastiche. Per il resto della recita non profferì più verbo, limitandosi a mettere un bambolotto in una scatola che simulava la mangiatoia e standogli accanto insieme al bambino Giuseppe, al bambino bue, e al bambino asinello. Tre anni dopo, alla solita recita, sul solito palcoscenico, mio figlio Claudio fu molto più fortunato perché non dovette dire una parola. Nelle vesti del magio ( o mago?) Gaspare, portò la birra a Gesù Bambino. Gli altri bambini magi (o maghi?), Melchiorre e Baldassarre, portarono il vincenzo e loro. L’oro diventò loro, perché la suora, insegnante di recitazione, era settentrionale e aveva la “o” stretta. In famiglia non è che abbiamo avuto una gran fortuna come attori. Della Storia d’Empoli Babbo al telegrafo 17 Capitolo terzo La “SS 67” La SS 67 non era un reparto dell’esercito tedesco, ma stava , e sta, per Strada Statale 67. Era, ed è, conosciuta anche come Tosco Romagnola. La SS 67 era un mondo, o meglio, era il mondo che passava davanti a noi, ragazzi del bafòre. Su quella strada passava di tutto. Abbiamo visto passare colonne militari di decine e decine di camion con la stella bianca, con i cannoni a rimorchio che andavano in direzione Firenze con i soldati che ci salutavano sorridendo. Ma quello che ci faceva più impressione era il passaggio dei cingolati che facevano tremare il pavimento e tintinnare tutti i vetri delle finestre delle case d’intorno. Erano colonne di soldati americani che ormai, finita la guerra già da un bel po’, andavano in direzione Firenze o per chissà dove, tantoché questi passaggi si fecero sempre più radi fino a sparire quasi del tutto. Magari soppiantati dalle colonne dell’esercito italiano, ma ormai senza più cingolati. Non esistevano ancora i containers, e allora si vedevano passare anche delle motrici con strani rimorchi, bassissimi, con una miriade di piccole ruote e sopra al rimorchio, un vagone ferroviario pieno di chissà che cosa. Passavano rimorchi con sopra motoscafi enormi e a volte anche aeroplani smontati con le ali ripiegate con le coccarde tricolori. Negli ultimi anni ’40 fino a metà degli anni ’50, la SS67 era ancora frequentata dai barrocci trainati da certi cavalloni da tiro tutti agghindati di nastri e fiocchi. Si avvertiva il loro arrivo, dal lento scampanellio delle campanelle, campanacci e campanellini che accompagnava il “ci‐clop ci‐clop” degli zoccoli ferrati. Si sentivano arrivare dal Ponte alla Stella o dalla fattoria di Empoli Vecchio. In genere sotto al barroccio, all’ombra, per difendersi dalla calura, trotterellava anche un canino accanto alla lanterna spenta che dondolava in mezzo alle ruote. Spesso i barrocciai si fermavano al nostro pozzo per abbeverare cavallo e cane con il secchio di lamiera zincata in dotazione. Finito l’asilo, mia madre, chissà perché, invece che alle comunali, mi iscrisse alle scuole elementari delle suore di Santa Maria. Nei primi anni per andare a scuola, spesso mi affidava a Ganino. Altrimenti andavo a piedi. Sia all’andata che al ritorno. Ma non eravamo appesantiti da zaini da alpino come gli scolari di adesso. La nostra dotazione scolastica consisteva in un libro di “lettura”, un “sussidiario”, due quaderni “a righe”, uno per la “brutta” o “a sudicio” e uno per la “bella” o a “pulito”, due quaderni a “quadretti” per il solito motivo, un libretto di catechismo, un astuccio in legno contenente una penna, sei matite colorate “Giotto”, una gomma per cancellare, metà da inchiostro e metà da lapis, un pennino a “campanile”, uno a “lancia” e un nettapenne. Gli astucci potevano essere scempi , ad un piano, o doppi, a due piani di cui uno girevole. Quelli doppi erano molto ambiti. Quello doppio me lo hanno regalato dopo che sono passato in quinta elementare, sfruttando quello di mio fratello. Il tutto era contenuto in una cartella di cartone finta pelle, squadrata e dura che spesso si sfaceva a forza di tirarsela nel groppone a vicenda all’uscita della scuola. Della Storia d’Empoli 18 “Ganino”, procaccia di Ponte a Elsa, passava con un calessino tirato da un asinello piuttosto “odoroso”. Era un omettino magro che portava un cappello grigio sulle ventitré. Gli spuntava sempre mezzo sigaro toscano acceso all’angolo di una bocchina sormontata da due piccoli baffetti grigi. Mi piaceva un sacco andare a scuola sul calesse di Ganino. Mi piaceva guardare il dietro trotterellante del ciuco con la cinghia di cuoio che gli passava sotto la coda. A volte Ganino mi dava le tirelle di cuoio in mano per la guida del ciuchino e mi sembrava di essere chissà chi. Mi piacevano anche gli odori di questo calesse. L’odore della vernice del calesse, quello del ciuco, del cuoio delle tirelle, della balla del fieno che era dietro. Il tutto amalgamato dall’odore del sigaro di Ganino. Era proprio un bell’andare. Passava anche “Faille”, che faceva servizio passeggeri, con la sua carrozza gialla trainata da un bel cavallone. Se noi ci avvicinavamo per fare qualche metro a traino, montando sul predellino posteriore, schioccava la frusta facendo finta di frustarci, e ci urlava: ‐VIA!! Delinquenti!! VIAAA!!!‐ Invece chi passava e non si fermava mai, era un convoglio singolarissimo. Era un tizio che indossava un corpetto di pelo, lungo, bianco, penso di capra, senza maniche. Stava seduto su di un carretto, una specie di sulki, con delle ruote metalliche ricavate da dei tappi di fusto di benzina o di nafta, ed era trainato da una muta di una decina di cani che andavano sempre di corsa, per lo meno quando passava da noi. Lui li aizzava con schiocchi di una frusta lunga che arrivava fino ai primi della fila. Un po’ come i cani da slitta che si vedevano disegnati sui giornalini. Fra il rimbombare di tuono delle ruote metalliche, gli schiocchi di frusta e i latrati dei cani in corsa, era uno spettacolo vederli passare. Babbo Natale con la sua slitta e tutte le sue renne, avrebbe suscitato molto meno sorpresa di questa rumorosa attrezzatura. Da adulto ho saputo che quest’uomo passava anche da Pontedera e che i ragazzi di quelle parti gli facevano dei brutti scherzi. Ne facevano uno tremendo. Mentre la muta di cani, con tutto il suo traino, passava in velocità, buttavano dei pezzi di pane nella fossa che correva parallela alla strada , gridando ai cani :‐TOH! TOH! TOH!!!‐ E scappavano. Mi hanno raccontato che ne veniva fuori uno sfacelo. I cani, molto probabilmente abbastanza affamati, si buttavano tutti insieme nella fossa incuranti degli urli e dei berci dell’uomo, trascinando con se carretto, ruote, uomo e frusta in un groviglio di tirelle, di cani, di urli, di guaiti e di bestemmie. Noi, questo, non l’abbiamo mai fatto. Altro personaggio per noi strano, era quello che noi chiamavamo “Raccattamerde”. Costui normalmente veniva dalla direzione di Ponte a Elsa trainando un carretto con le sponde. Questo carretto era pieno di cacche di cavallo, ma forse anche di cristiano, e puzzava abbastanza da tenerci a debita distanza. Era coperto di mosche e ronzava come un alveare. Della Storia d’Empoli 19 “Raccattamerde” aveva una pala di lamiera rettangolare, larghissima e ricurva con la quale raccattava le cacche dei cavalli per strada e, con un colpo magistrale, le scaraventava nel carretto. Veniva spesso al passaggio a livello, perché quando il casellante chiudeva le sbarre, i barrocciai erano costretti a fermarsi. I cavalli spesso depositavano a monti i loro escrementi che per “Raccattamerde” erano una manna. Ho saputo in seguito da un eminentissimo avvocato e storico delle nostre vicissitudini empolesi, che questo tizio non dovesse essere altro che un commerciante di letame di Ponte a Elsa, suo conterraneo. Lui, lo storico, da ragazzo, insieme ai suoi compagni, faceva alla guerra contro i ragazzi di Pianezzoli tirandosi dietro “le covate di cavallo e di ciuco che allora abbondavano sulle strade bianche, suscitando le ire del Birigneri, negoziante di letame, che si incazzava a veder sciupare tutta quella grazia di Dio” (parole sue). Non era come adesso, che le merde si sprecano. Altro personaggio era “Raccattacicche”. Lui percorreva la statale, a piedi, lentamente, al bordo della strada, guardando fisso per terra. Cercava gli avanzi di sigaretta o di sigaro che i rari automobilisti o barrocciai buttavano dopo aver fumato. Anche lui si fermava al passaggio a livello frugando con gli occhi in tutti gli anfratti. Anche nelle fosse laterali. Il fatto che ci fossero le sbarre, che obbligavano a una sosta forzata chi percorreva la strada, faceva sì che l’eventuale barrocciaio o automobilista fumatore, dopo aver fumato la sigaretta o il sigaro, gettasse poi la cicca per terra. In quella zona, queste si accumulavano finché non passava “Raccattacicche”. Le raccattava tutte e le metteva in una grande scatola metallica, quadrata, da biscotti “Marie”. Una volta, che si era fermato da Leone, il casellante, lo vidi aprire questa scatola e prendere diverse cicche. Le sbriciolò. Poi prese una strisciola di giornale, ci versò il tabacco delle cicche, la arrotolò, bagnò con la lingua un lembo della strisciola a mò di colla, ricavandone così una specie di sigaretta. Se la mise in bocca e una volta accesa con un fiammifero, se la fumò tutta mentre aspettava che passasse il treno e che si riaprissero le sbarre. Non so se fosse più aromatico il fumo del giornale o il tabacco raccattato. Passato il treno e riaperte le sbarre ricominciò la sua ricerca verso Santa Maria. Raramente passavano automobili, tantoché potevamo scorrazzare con i nostri carretti a cuscinetti e con i monopattini, tutti rigorosamente auto costruiti, in lungo e in largo per la strada. Le auto che passavano erano per lo più Fiat “Topolino”. Erano molte di più le persone che passavano in bicicletta. Si cominciavano a vedere pure “Vespe “ e “Lambrette” e le sere delle domeniche d’estate, quando le sbarre erano chiuse, la strada si riempiva di “fiorentini” a bordo di questi scooter che ritornavano dal mare verso Firenze. A volte famiglie intere. Babbo alla guida della Vespa, mamma dietro, e figlio in piedi sulla pedana. Ma c’erano due veicoli che ci facevano veramente impazzire. Si sentivano arrivare dalla curva di Empoli Vecchio. Uno era la macchina rossa dello Scotti. Non so se fosse una Ferrari o un’Alfa Romeo. Era comunque una macchina da corsa, mi sembra monoposto a ruote scoperte che aveva un motore che urlava da far paura. Della Storia d’Empoli 20 Fatta la curva del leccio della fattoria di Empoli Vecchio, si lanciava sulla dirittura verso il passaggio a livello in direzione Ponte a Elsa. Quando sentivamo il rombo del motore, già a Santa Maria, correvamo verso il passaggio a livello e ci accucciavamo per vedere staccare le ruote da terra perché la leggera salita faceva da trampolino alla macchina in velocità facendola saltare per una decina di metri. Poi si allontanava con il suo rombo urlante in accelerazione verso il Ponte alla Stella dove sicuramente avrebbe fatto un altro salto. Se le sbarre erano chiuse, allora faceva manovra con delle sgassate tremende per tenere il motore su di giri, e tornava indietro con il motore che urlava tutta la sua potenza. E poi c’era “Fracassa”. “Fracassa” aveva una moto da corsa. E anche questa faceva un rumore indiavolato. Da lì penso che ne sia venuto il soprannome. Anche lui era annunciato dal rombo del motore. Dalla solita curva. Passava rombando a tutta velocità, sdraiato quanto era lungo sulla moto per avere la migliore penetrazione aerodinamica in una tuta nera come la pece, occhialoni e casco giallo. Il primo di noi che sentiva questi rumori, dava l’allarme :‐ C’E’ LO SCOTTI!!!‐ oppure :‐ C’E’ FRACASSA!!!‐ e noi uscivamo da tutte le parti in cui eravamo affaccendati, siano stati compiti o costruzioni di giocattoli o quant’altro, per assistere al passaggio di questi diavoli. Su quella strada abbiamo visto anche passare diversi Giri d’Italia con Bartali, Coppi, Magni, Bevilacqua, che erano i campioni del momento. Prima dei girini, passava quella che chiamavano la “carovana”. La “carovana” era composta per la maggior parte da strani veicoli pubblicitari, che spesso buttavano dai finestrini campioni dei prodotti pubblicizzati. Mi ricordo bene il veicolo della Binaca, che era un dentifricio del tempo, fatto proprio come un enorme tubetto di dentifricio bianco e giallo con tanto di tappo. Oltre che piccoli tubetti di dentifricio gettava anche delle carte per giocare ad una specie di gioco dell’oca, fatto però sul Giro d’Italia. Era ambitissimo da noi ragazzi. Una volta che era passato un primo drappello di corridori, Leone, incitato dai tifosi del luogo, fra cui mio padre tifoso di Coppi, chiuse le sbarre del passaggio a livello appena il gruppo scavalcò dal Ponte alla Stella. Lo scopo era quello di vedere i campioni da vicino. Fermi. Infatti si fermarono tutti, ma scendevano alla svelta di bicicletta, passavano chinandosi sotto alla prima sbarra, attraversavano di corsa i binari, ripassavano la seconda sbarra e saltando in sella al volo, ripartivano in bicicletta di gran carriera. Scese di bicicletta anche Bartali, di cui era tifosissimo il “Moro”. Mentre Bartali si chinava per passare sotto la sbarra, il “Moro”, corse ad abbracciarlo gridando: ‐BRAVO GINO!!!, VAI, VAI GINO!!! BRAVO! BRAVO!! Bartali, preso dalla corsa, si divincolò dall’abbraccio, si girò, e gli mollò un ceffone in piena faccia che si sentì lo schiocco a cinquanta metri. E ripartì. Il “Moro” ci rimase parecchio male, e non so se da quel giorno abbia cominciato a tifare per Coppi. Comunque questo fu niente al confronto di quello che fece suo fratello il ”Rosso”. Della Storia d’Empoli 21 Era invalso l’uso di gettare addosso ai corridori dell’acqua fresca, credendo di rinfrescarli e di dargli nuova lena. Quando passavano le corse in bicicletta, il Rosso” era sempre pronto sul ciglio della strada con il suo secchio di lamiera zincata, con cui dava da bere alle mucche, pieno di acqua fresca fino all’orlo. Quella volta che passò il gruppo e i corridori gridavano:‐No!No!No!‐, lui gliela buttò lo stesso. Non solo. Gli tirò anche il secchio, che gli sfuggì di mano. E fu un macello. Ne caddero una quindicina in un groviglio di ruote, pedali, e maglie colorate. Fortunatamente senza nessuna conseguenza. Lui se la dette a gambe levate e i corridori imprecando e smadonnando, un po’ alla volta, risalirono in bici e si dileguarono all’inseguimento dei primi. E, a proposito di biciclette, in estate, abbiamo visto anche passare i primi turisti, per lo più tedeschi, in file di cinque o sei elementi con gli zaini ai lati della ruota posteriore, a torso nudo e in pantaloni corti. Ogni tanto si fermavano a prendere acqua al nostro pozzo. Noi li guardavamo come se fossero extra‐terrestri. Quando poi si cominciò a vedere anche qualche donna, conciata nella solita maniera, rimanevamo letteralmente a bocca aperta. Altre macchine affascinanti che passavano sulla 67 erano le rarissime macchine americane. Erano enormi, larghissime e lunghissime, piene di cromature luccicanti e con delle pinne posteriori che sembravano timoni di aeroplani. E al proposito ricordo un episodio che capitò a me, ragazzino del “bafòre”. Era un 1° maggio, forse del ’50. A quel tempo il 1° maggio veniva festeggiato imbandierando strade e finestre con festoni di bandierine rosse triangolari di carta. Inoltre venivano distribuite porta a porta delle bandiere rosse molto più grandi, rettangolari, sempre di carta, con l’asta fatta di canna e con la scritta ‘W il 1° MAGGIO’. Questa distribuzione veniva fatta sicuramente da volontari del Partito Comunista di allora, che raccoglievano qualche soldo per la causa, dicevano, dei lavoratori. Stranamente ne aveva comprata una anche mia madre, che era cattolicissima e con i comunisti non è che andava tanto a braccetto. Erano i tempi descritti magistralmente da Guareschi con il suo Peppone e don Camillo e i comunisti mi pare che fossero stati addirittura scomunicati dalla Chiesa di allora. La SS67 da Santa Maria fino a Ponte a Elsa, era tutta una fiamma di queste bandierine. Il “Bafòre” non faceva certo eccezione, anzi. C’era anche chi aveva costruito, una enorme stella rossa con lampada interna che di notte avrebbe fatto invidia al Cremlino. D’altra parte il bafòre veniva anche chiamato “la piccola Russia”. Mi ricordo benissimo di aver visto al centro del “mettitutto” di quasi tutte le case del bafòre, dove c’era quella specie di nicchia tutta ricoperta di specchietti, la foto in bianco e nero di Iosif Vissarionovič Džugašvili, detto Stalin, con i suoi caratteristici baffoni. E non solo. Qualcuno lo aveva messo addirittura sopra al letto al posto che, in casa mia e in tutte le camere, era dedicato alla Madonna o al Crocifisso. Mia madre invece di mettere la bandiera rossa alla finestra, preferì darla a me. Della Storia d’Empoli 22 Naturalmente ne fui felicissimo, e mi misi a scorrazzare in su e in giù da casa mia al passaggio a livello e viceversa, tenendo alta la mia bandiera per farla sventolare. Si chiusero le sbarre. Mentre correvo verso il passaggio a livello, mi si affiancò una di quelle macchine americane, bianca, scoperta, enorme, piena di cromature, con le gomme a fascia bianca e con le code altissime, a pinna. Si fermò davanti alle sbarre. Mi fermai anch’io, ansante, a guardare quella meraviglia, più simile a una nave che a una automobile. Alla guida c’era un uomo di colore, in uniforme marrone, grandissimo, nero come la pece, con i capelli neri e ricci. Sui sedili posteriori una signora anziana con un cappello bianco e , accanto, un signore, anche lui anziano, con i capelli bianchi coperti da un panama bianco anch’esso. L a fiera del bianco. Ambedue con carnagione rosea. Si rivolsero all’autista dicendogli delle parole per me incomprensibili. Al che l’autista si rivolse a me : ‐ Dare me flag? Dare me bandera? Io dare soldo te. Dare me bandera?‐ Lo guardai stralunato. Lui tirò fuori un biglietto verde, forse un dollaro, e me lo offrì. ‐Dare me bandera? Io pagare te bandera‐, ripetè. Anche gli altri due anziani, bianchi, mi guardavano, aspettando una risposta. Stetti un po’ indeciso a guardare il dollaro e quell’uomo nero nero e poi: ‐No!‐, dissi, e scappai verso casa con la mia bandiera al vento. Mi sarebbe sembrato di vendere l’onore o chissà che cosa a vendere quella bandiera di carta rossa. Dai giornalini e dalle storie da libro Cuore, che ci propinavano ad ogni piè sospinto, ci veniva insegnato che la bandiera va difesa fino alla morte. E non gliela detti. Sulla SS 67 passava anche il terrore. Il terrore, per noi ragazzi, era “Pietrociucco”. Pietrociucco era (o sembrava?) un povero demente che percorreva la strada con un sacco in spalla vestito con una giacchetta aperta e sbracalata che gli pendeva da tutte le parti. Camminava curvo, con i piedi a guarda botteghe. Portava un berrettaccio sformato e calato sugli occhi. Occhi che avevano uno sguardo torvo e bieco, da assassino. Aveva sempre la barba ispida di quattro o cinque giorni, il viso scavato e quasi sempre un po’ di bava schiumosa intorno alla bocca sdentata semiaperta. Un orco. L’aspetto faceva veramente paura. Ma quello che faceva ancora più paura, era quando cominciava a urlare. E urlava quando noi ragazzi, forse per esorcizzare la paura che incuteva, gli gridavamo il fatidico grido che tutti i ragazzi, da Santa Maria a Ponte a Elsa conoscevano: ‐POSA LA LUCIA!!!‐ Della Storia d’Empoli 23 La lùcia, con l’accento sulla u, era la femmina del lùcio, cioè il tacchino ( spiegazione per i ragazzi d’oggi, che questi animali ora possono vederli agli zoo), intendendo che dentro il sacco che portava eternamente in spalla, nascondesse questo animale rubato sull’aia di qualche contadino. A questo grido, diventava una belva, anche se innocua. Moccoli e minacce di sbudellamenti venivano giù come la grandine. E noi dalla paura che avevamo, questo grido lo lanciavamo sempre da nascondigli, in maniera che non ci potesse né vedere né, tantomeno, trovare. Noi ragazzi credevamo veramente che nel sacco avesse una lucia. Ma vi fu un giorno che io mi dovetti ricredere. Mia madre era di Cortenuova, come “Pietrociucco”, e conosceva lui e la sua famiglia, da quando era ragazzina. Quel giorno io ero in casa, in cucina che dava proprio sulla strada, quando risuonarono i gridi di “Posa la lucia” dei miei compagni e gli sberci di Pietro. Pietro era proprio davanti all’uscio di casa mia mentre urlava con la sua vociaccia rauca: ‐ VI SBUDELLO TUTTI MAREMMA MAIALA!!!! TUTTI VI SBUDELLO!!!! VI SBUDELLO TUTTI!!! Mia madre uscì fuori e lo chiamò: ‐ Venite Pietro. Lasciateli stare quei diavolacci. Venite a bere un bicchiere di vino!‐ Rimasi paralizzato e terrorizzato. La paura che mi riconoscesse per tutte le volte che anch’io gli avevo urlato il fatidico grido, mi faceva tremare di paura e mi rincantucciai nell’angolo più lontano della stanza. “Pietrociucco” entrò in casa brontolando, brontolando. Poi invitato da mia madre prese il bicchiere di vino e lo vuotò tutto d’un fiato. Con quella voce da orco, profonda e rauca che faceva paura, chiese anche un pezzo di pane. Mia madre tagliò un grosso cantuccio dal panone di casa e glielo dette. Pietro si tolse il famoso sacco dalla spalla, lo posò in terra e piano, piano lo aprì. Non respiravo più dalla tensione e dalla paura. Da un momento all’altro mi aspettavo di vedere uscire la lùcia dal sacco e scappare saltellando per la stanza. E invece rimasi a bocca aperta. Il sacco era pieno di cipolle e pezzi di pane. Pietro gettò all’interno anche quello che gli aveva dato mia madre, si rimise il sacco in spalla e dondolando dondolando, gobbo gobbo, con i piedi a guarda botteghe, si diresse verso l’uscio che dava proprio sulla strada. Poi voltandosi, disse con quella vociaccia da orco: ‐ Grazie sposa!‐ e riprese il suo cammino. Ma appena arrivato al pozzo, trenta metri più in là, risuonò ancora il tremendo grido di “POSA LA LUCIA!”. E ricominciarono le imprecazioni, le bestemmie e le minacce di sbudellamento di “Pietrociucco”. Ma nessuno era affacciato sulla strada, e Pietrociucco continuò il suo peregrinare accompagnato dalle sue tremende litanie. Della Storia d’Empoli 24 Le transenne del passaggio a livello, che una volta venivano messe a mano in mezzo alla strada, ormai erano state sostituite da sbarre uniche che attraversavano completamente la strada e, quando si abbassavano, andavano ad appoggiarsi su di una specie di forcella dalla parte opposta. Non erano sdoppiate come sono adesso, ed erano notevolmente lunghe. Queste sbarre erano azionate mediante una manovella dal casellante, che lì aveva anche la casa dove abitava con tutta la famiglia, proprio a ridosso della ferrovia. Per noi ragazzi il casello ferroviario era un punto di riferimento come luogo di riunione per la programmazione di giochi o scorrerie da fare nelle campagne. Succedeva molto spesso che una volta abbassate le sbarre, la gente che doveva andare a Empoli proveniente dal Terrafino o da Ponte a Elsa , si fermasse a far due chiacchiere con il casellante prima che passasse il treno. Tutte le mattine si fermava sempre un tizio che mi sembra di ricordare, si chiamasse Peruzzi. Veniva da Ponte a Elsa con una bicicletta rossa. Noi lo chiamavamo ” i’ barbiere” perché pare che avesse una bottega di barbiere in Empoli o a Santa Maria. Come quasi tutte le mattine, si era fermato perché aveva trovato le sbarre chiuse. Aveva appoggiato la bicicletta alla forcella dove si appoggiavano anche le sbarre, ed era andato a chiacchiera con Leone , il casellante. Noi eravamo già radunati ed eravamo diretti verso il casello per rubare il “carburo” (poi spiegherò cos’era e il perché) quando vedemmo la bicicletta del barbiere appoggiata alla forcella. Vicino alle sbarre. Non mi ricordo di chi fu l’idea, ma ci fu qualcuno che disse: ‐ Si lega la bicicletta di’ barbiere alle sbarre?”. Detto e fatto. In men che non si dica, venne fuori un pezzo di fil di ferro della lunghezza di un metro o poco più. Fu avvolto alla canna della bici e alla sbarra e filammo via tutti come saette nel piccolo giardino di fianco a casa mia, da dove si poteva vedere quello che sarebbe successo. Poco dopo passò un lento e lunghissimo treno merci e una volta passato, Leone andò alla manovella sempre chiacchierando col barbiere, e cominciò a girare. Lentamente, lentamente le sbarre si alzarono con tutta la bicicletta, senza che nessuno si accorgesse della cosa. Quando la sbarra rimase in verticale, la bicicletta, lassù in cima, sembrava una bandiera. Il barbiere finita la chiacchierata, andò a riprendersi la bicicletta dove l’aveva lasciata. Dette in un urlo e cominciò a imprecare e a berciare, credendo che gliela avessero rubata. Ci fu un gran trambusto. Noi ce la svignammo oltre la massicciata della ferrovia di Siena, che ci fungeva da trincea e da nascondiglio e sempre osservando da lontano. Ci furono delle indagini da parte del barbiere anche fra le nostre case, finché Leone riabbassando le sbarre per un altro treno, vide ricalare piano, piano la bicicletta rossa, dai cieli alle cose terrene. Negli ultimi due metri la bici precipitò con un gran fracasso. La legatura del fil di ferro non doveva essere stata fatta proprio a regola d’arte. Leone chiamò a gran voce il barbiere che si aggirava ancora fra le case del “bafòre” e tutto finì in maledizioni e in accidentalloro e alle su’ mamme troie. Della Storia d’Empoli 25 Della Storia d’Empoli ... Altre macchine affascinanti che passavano sulla 67, erano le rarissime macchine americane ... 26 Capitolo quarto La ferrovia Insomma “il bafòre”, o ”i cancelli” come era anche chiamato a causa delle transenne che in antico venivano messe attraverso la strada, era un posto, oltre che di passaggio, anche quasi di ritrovo. La nostra vita di ragazzi si svolgeva tutta fra questa strada e le due linee ferroviarie. Negli anni ’50 sulla linea Firenze‐Pisa, nonostante fosse elettrificata, passavano ogni tanto ancora treni trainati da macchine a vapore. Quando si vedevano passare questi velocissimi mostri neri con le ruote rosse, in un turbinio di bielle, contrappesi, stantuffi, e rapidissimi sbuffi di vapore, ne eravamo affascinati. Anche il fischio con cui salutavano il casellante era un fischio particolare. Il fischio fatto con il vapore, era tutto diverso da quello delle motrici elettriche di cui si vedevano solo girare le ruote, senza il turbinare delle bielle. Sulla linea di Siena invece hanno continuato per un bel po’ a circolare i treni con le vaporiere , anche se spesso erano soppiantati dalle littorine. Ma erano vaporiere più corte e i treni molto più lenti rispetto a quelli della linea Firenze‐Pisa. Lenti anche perché, spesso, erano treni merci. Si poteva indovinare quando partivano dalla stazione di Empoli, dalla colonna di fumo che da nero diventava bianco e a sbuffi altissimi. Per noi ragazzi erano come segnalazioni indiane, come si leggeva sui giornalini di Tex Willer. Quando facevano la curva, con cui si staccavano dalla parallelità con la Firenze‐Pisa e passavano dietro alle nostre case, erano già quasi lanciate ma si sentiva il loro ansimare, lento e quasi animalesco, con il CIUUFF…CIUUFF …CIUUFF prolungato dell’essere ancora sotto sforzo. Per noi vedere treni fermi era abbastanza raro. Un paio di volte, però, li abbiamo visti anche deragliati. Infatti una notte, verso le due o le tre, mentre dormivamo tranquilli, io e mio fratello, nella camera “di dietro”, fummo svegliati da un boato spaventoso. Impauriti, e ricordando i racconti degli adulti, credevamo che fosse un bombardamento. Al “bafòre”si svegliarono tutti. A noi raccomandarono di rimanere in camera, mentre tutti scendevano a basso e in strada a vedere cosa poteva essere successo. Noi, affacciati alla finestra, cominciammo a vedere una moltitudine di lumi che correvano su e giù sulla scarpata della ferrovia Firenze‐Pisa e si sentiva urlare gente. Chi urlava di chiamare i pompieri. Chi urlava di chiamare i carabinieri. Chi urlava e basta. Ci fu un grandissimo trambusto quella notte. Noi ragazzi, scoprimmo quello che era successo solo al mattino del giorno dopo. Leone, il casellante, si era addormentato, non aveva chiuso le sbarre e un autotreno carico di blocchi di soda aveva attraversato il passaggio a livello mentre arrivava un treno merci in direzione Pisa. Il treno prese in pieno il rimorchio in una esplosione di blocchi di soda. Lo staccò di netto dalla motrice e lo trascinò per tre o quattrocento metri oltre il passaggio a livello, verso il ponte del fosso di “Pelle”, seminando il carico per tutto il percorso. Della Storia d’Empoli 27 L’autista del camion si accorse che non aveva più il rimorchio, soltanto quasi al Ponte alla Stella e solo allora tornò indietro, fermandosi davanti a casa mia. Credeva che il rumore sentito fosse dovuto ai sobbalzi nell’attraversare i binari del passaggio a livello. Forse dormiva anche lui. Noi ragazzi, tutti insieme, andammo a vedere la macchina che era deragliata, ma rimasta in linea. Faceva impressione a vedere questa enorme macchina con quelle ruote grandi e pesanti uscite dai binari. Non riuscivamo a renderci conto della forza spaventosa necessaria per far saltare un peso del genere. Lo stesso sconcerto ci prese quando vedemmo il rimorchio del camion. Era stato piegato a banana come se fosse stato di burro, con la forma della macchina del treno stampata su di un fianco e trascinato per centinaia di metri. Fortunatamente non ci furono feriti, ma Leone sparì dalla circolazione. Pare che si fosse dato alla fuga e che si fosse costituito solo tre giorni dopo, ai carabinieri di Empoli. Dissero poi, che ci fosse stato anche un processo e che Leone sia stato destituito e allontanato dal lavoro e dalla casa accanto al casello. Con tutta la famiglia. Noi ragazzi non lo vedemmo più. Fu rimpiazzato da Natale, un tizio che veniva da Firenze. Ma non era come Leone. Aveva modi un po’ troppo “cittadini” e più che altro, aveva una moglie piccola e graziosa con i capelli rossi. Fu subito battezzata “la Rossina”. Le sere d’estate i miei, insieme agli altri abitanti del bafòre, prendevano le sedie di casa e si mettevano fuori al fresco, con le spalle al muro e fronte strada a chiacchierare del più e del meno. Noi ragazzi, invece, andavamo a caccia di lucciole per fare qualche soldino. Quando eravamo stanchi, e avevamo messo diverse lucciole sotto un bicchiere, perché cacassero il soldino, allora ci venivano stese delle balle di yuta vuote sul marciapiede. Di solito ci entravamo dentro, tipo sacco a pelo, e ci si distendeva cullati dalle chiacchiere, dal canto dei grilli e dei ranocchi, guardando il cielo stellato. Natale e la Rossina non avevano figli e la sera, specialmente d’estate, per strada, cominciò tutto un via vai di persone per andare a veglia al casello. Ai tempi di Leone non è che si fosse mai verificato una cosa del genere. Quando c’era Leone, al massimo si potevano verificare riunioni fra i giovanotti, per andare a rubare cocomeri da qualche parte. Invece con Natale, venivano giovanotti, oltre che dal Ponte alla Stella, anche da Santa Maria. Si riempiva il casello. Dentro e fuori. E una sera, proprio d’estate e non si sa come mai, si verificò una battaglia a suon di uova marce, i puzzolenti barlacci, fra i nostri giovanotti e quelli di Santa Maria. Imbrattarono tutta la casa di Natale fino al tetto, e le colate dei barlacci spaccati sul muro resistettero diversi mesi a testimonianza della battaglia avvenuta. Con Leone non si era mai verificato. Paradossalmente, dopo poco più di un anno, il medesimo incidente che era capitato a Leone, si riverificò una notte. Alla stessa ora. Della Storia d’Empoli 28 Sembrò una copia esatta di quello capitato a Leone, solo che questa volta il rimorchio era pieno di sansa. Risentimmo il solito boato e, io e mio fratello, svegliati dalla botta, ormai esperti, ci dicemmo: ‐ Vai! S’è addormentato anche Natale!‐ Ed era stato proprio così. Al mattino, come la volta precedente, andammo a vedere quello che era successo. Il treno merci era ancora fermo e la massicciata era coperta di polvere di sansa puzzolente. Fortunatamente anche allora non ci furono morti. Solo il macchinista del treno credo che avesse riportato qualche leggera ferita, ma nulla di grave. Quella fu un’altra occasione per vedere un treno fermo. Sparirono così anche Natale e la Rossina, e ci fu l’avvento di “Parrino” con tutta la famiglia. Ma a lui, almeno fino a che io sono stato al bafòre, non gli successe mai nulla di questo genere. A proposito di treni fermi, io vissi quella che per me fu un’incredibile ”avventura” alla quale, infatti e purtroppo, non ha mai creduto nessuno. Era sicuramente di settembre o agli inizi di ottobre e io avrò avuto cinque anni o poco più, perché ancora non andavo a scuola. Stavo armeggiando inchiodando tavolette con bullette raddrizzate e arrugginite (rubate alla scorta di mio nonno, che le teneva come reliquie) per costruire un improbabile aeroplano nel piccolo cortile dietro casa mia, quando sentii lo stridio dei freni dei vagoni. Guardai sulla massicciata della ferrovia di Siena e vidi la macchina a vapore, nera, ansante e sbuffante. Ferma. Lasciai immediatamente quello che stavo facendo, e corsi subito sopra la massicciata. Era un piccolo treno di due o tre vagoni pieni di sassi di grossa ghiaia che veniva scaricata lateralmente ai vagoni stessi. Il treno si muoveva lentamente per una trentina di metri, scaricando da degli sportelli laterali nella parte bassa del primo vagone. Questi erano manovrati da un operaio che stava sopra al vagone stesso. Poi il treno si fermava, e smetteva di scaricare. Alcuni operai dietro, con un forcone particolare in acciaio, attizzavano la ghiaia sotto alle rotaie. Il forcone che adopravano per questa operazione, era manovrato da due operai. Uno teneva il forcone normalmente, mentre l’altro tirava la forca con una funicella, anche questa d’acciaio, a cui era legato una specie di manico da impugnarsi a due mani. La funicella era collegata appena sopra alla forca. Così, uno infilava il forcone nella ghiaia e cercava di spingere in avanti, e l’altro tirando la corda aiutava a spingere la ghiaia sotto alle rotaie. C’erano quattro o cinque coppie di operai a fare questo lavoro, e lavoravano tanto di conserva e in sincronia, che ne ero affascinato. Il rumore della ghiaia trascinata era talmente sincronizzato che sembrava un ritmo. Dopo aver guardato il lavorio di questi uomini, mi avvicinai alla macchina a vapore. Emanava un odore e un calore umido mentre ansava, ferma, con il suo pant‐pant…pant‐pant… pant‐pant... In quella zona la ferrovia compie un’ampia curva e i binari risultano molto inclinati per contrastare la forza centrifuga dei treni in corsa, ma a treno fermo, la macchina mi dava l’impressione che si ribaltasse dalla parte opposta a dove ero io. Della Storia d’Empoli 29 Dalla mia posizione, sul passino della ferrovia, senza chinarmi, potevo guardare sotto la pancia di quel mostro fumante fra le ruote rosse e le bielle degli stantuffi fermi, fumanti di vapore. Il macchinista, vestito di nero e con il berretto pure nero con la visiera, era affacciato dalla mia parte, mentre il fuochista stava impalando carbone nel fornello sotto la caldaia. ‐ Nini! Me la porti una ciocca d’uva?‐, mi sentii chiedere. A quel tempo, sulla massicciata lungo la ferrovia di Siena, erano piantate delle viti che facevano un tipo di uva bianca con dei chicchi piccoli e rossicci ma dolcissimi. Non ho mai saputo a chi appartenessero e per quale ragione fossero state piantate quelle viti sulla ferrovia. Guardai il macchinista lassù in alto. ‐ Allora, me la porti si o no?‐, mi ripeté. Corsi alla prima vite, colsi una ciocca che mi parve una delle più grosse, e ritornai sotto la macchina correndo. ‐ Sali!‐, mi sentii dire. Avevo da salire sul monte di ghiaia e in più la macchina era inclinata a causa dei binari in curva. Il predellino per salire sopra alla macchina, mi arrivava si e no all’altezza delle spalle. Con la ciocca in mano, non sapevo come fare. ‐ Vieni,‐ mi disse. Allungò un braccio, mi prese per la mano libera, e mi tirò su come un fuscello. Ero dentro la macchina del treno a vapore! C’era un caldo infernale. Osservavo spaurito tutti quegli “orologi” fumanti mentre il macchinista si pappava l’uva, un chicco dietro l’altro. E mi guardava. Di sottecchi. L’odore del carbon coke era pungente. Il fuochista aveva posato la pala e mi domandò come mi chiamavo. Ma non ebbi tempo di rispondere, perché in quel momento, da dietro, si udì una voce: ‐VAI!!!‐ Il macchinista che aveva finito l’uva, e aveva buttato il raspo, mi chiese: ‐Lo vuoi mandare il treno?‐ Io feci di no con la testa, tutto impaurito. Lui per tutta risposta mi prese in collo, mi fece afferrare con tutte e due le mani una leva lunghissima quasi orizzontale, appena inclinata verso l’alto, che stava al centro della caldaia e sopra al fornello. Aveva una maniglia lucidissima e calda. Mi lasciò andare ciondoloni. La leva si abbassò e un lungo e lento SSCC..III…UUU…FFF!! si sprigionò da quel bestione che si mosse lentamente. Mi riprese in collo e tirò su di nuovo la leva. Poi, sempre con me in collo, si affacciò guardando dietro. Dopo una trentina di metri si risentì gridare da dietro: ‐FERMA!!!‐ Il macchinista manovrò un’altra leva e il treno si rifermò stridendo. E ricominciò il pant pant…pant pant… pant… della macchina in riposo. Mi pose sul pavimento nero della macchina. ‐Vuoi scendere?‐, mi chiese. Feci di si con la testa perché non avevo neanche la forza di parlare. Della Storia d’Empoli 30 Mi riprese per le mani e mi calò giù dalla vaporiera, sulla ghiaia. Scesi a rotta di collo dalla massicciata, saltai il fosso della ferrovia, attraversai di corsa la corte a perdifiato verso casa, dove entrai in velocità gridando a mia nonna Cesira, sorda come una campana: ‐ HO MANDATO IL TRENO! NONNA!!! HO MANDATO IL TRENO!‐ Per tutta risposta mia nonna mi fece: ‐ EH? Che c’è, che c’è !‐. Chiaramente non capendo minimamente quello che dicevo e neppure la causa della mia eccitazione, sapendo quanta fantasia mi balenasse nel cervello a quel tempo. Quando tornò mia madre dal lavoro, e le raccontai che avevo mandato il treno, fu quasi lo stesso. A lei il discorso le entrò in un orecchio e le uscì dall’altro. Quando tornò da scuola lo raccontai anche a mio fratello, sperando che almeno a lui gli facesse impressione il fatto che avessi mandato il treno. Ma fu anche peggio. Lo raccontò agli altri ragazzi della banda e mi presero in giro per giorni e giorni. Tutte le volte che accennavo a questo fatto, cominciavano la canzonatura: ‐Paolo ha mandato il treno!! Paolo ha mandato il treno!! Paolo ha mandato il treno!!….‐ Finché non andavo via con le lacrime agli occhi. Non mi hanno mai creduto. Spero che qualcuno, ora, leggendo queste righe, ci creda. Io, all’età di cinque anni o poco più, ho mandato il treno. E ora non lo dico più. Della Storia d’Empoli ... Io all'età di cinque anni o poco più, ho mandato il treno... 31 Capitolo quinto Giochi da bafòre Era una vita avventurosa , la nostra, ragazzi del bafòre, e pericolosa. Oltre ai giochi che tutti i ragazzi della nostra età facevano, noi ne facevamo di quelli che, penso, solo pochi facevano o potevano fare. Infatti oltre a giocare a buchetta con le palline di terracotta colorate, a “ventini”, a tappini , con gli aquiloni, con i monopattini o con i carretti a cuscinetti o con altri giochi innocenti come facevano tutti i ragazzi della nostra età negli anni ’50, noi ne andavamo a cercare di pericolosi o a trasformare quelli innocenti in micidiali. Per esempio giocavamo con il “carburo”. E mi spiego. Il casellante della linea Firenze ‐ Pisa aveva diversi compiti. Il primo era quello di abbassare le sbarre dopo che aveva avuto la segnalazione telefonica dal casellante di Marcignana (altro “Bafòre”) se il treno veniva da Pisa, oppure dalla stazione di Empoli, se il treno veniva da Firenze. Inoltre l’arrivo del treno era annunciato da un campanello all’esterno e all’interno del casello. Una volta passato il treno a sua volta doveva segnalare il passaggio o a Empoli o al casello di Marcignana. Mentre passava il treno, doveva uscire e “far bandiera”. Doveva, cioè, farsi vedere dal macchinista con la custodia nera della bandiera rossa di pericolo, e perciò infoderata, appoggiata sulla spalla e inclinata in posizione rivolta verso la direzione del treno. Questo a significare che tutto andava bene e che il treno poteva proseguire. Se invece ci fosse stato qualche problema, la bandiera rossa doveva essere sguainata e agitata per fermare il treno. Anzi una doveva essere messa anche a due o trecento metri più avanti sulla ferrovia. Per la notte c’era a disposizione una lanterna ad acetilene. Questa lanterna aveva anteriormente una lente e all’interno dei vetri colorati che potevano ruotare potendo fare o luce bianca, o verde, o rossa. Quando tutto andava bene la luce doveva essere bianca. Rossa il treno si doveva fermare. Verde il treno poteva ripartire. Come ho detto era una lampada ad acetilene. L’acetilene è un gas infiammabile che bruciando fa una fiamma bianchissima. Per fare l’acetilene, questa lanterna aveva due serbatoi uno sopra all’altro. In quello superiore veniva messa dell’acqua che doveva gocciolare, attraverso un rubinetto che ne variava la portata, nel serbatoio inferiore dove c’era questo famoso “carburo”. Allora si sviluppava una reazione chimica che produceva il gas di acetilene. Il gas passava da un forellino tarato, giglè, (per gigleur) e qui veniva acceso con un fiammifero sviluppando la fiamma bianca. Il carburo, è inutile che ne elenchi la formula chimica, era in forma di grossi sassi e aveva un odore penetrante e acidulo. Veniva fornito al casellante in un fustino metallico con un tappo a vite perché non prendesse l’umido e veniva messo in un angolo del casello. Per essere utilizzato nella lanterna, questi sassi dovevano essere ridotti in sassetti più piccoli frantumandoli con un martello. Noi ragazzi per avere questo carburo avremmo fatto cose da pazzi. E spiego il perché. Della Storia d’Empoli 32 A quel tempo non è che avessimo molti giocattoli, e quei pochi ce li costruivamo da noi . Soltanto una volta all’anno, per la fiera, ci veniva regalato un fucilino di latta che sparava un sughero legato alla canna per il recupero, al massimo una pistola a “furminanti” o, esagerando, una pistola a “cassole”. Quando, per esempio, la mamma di qualcuno di noi utilizzava un raro barattolo di conserva di pomodoro, una volta vuoto, veniva immediatamente requisito da noi ragazzi. Quando ne avevamo due si costruiva il telefono. Bastava fare un foro con un chiodo nel fondo di ambedue i barattoli, passarci un filo di spago il più lungo possibile (ma molto meglio era un filo di rame) e fermarlo con un nodo o un chiodino all’interno dei barattoli. Si teneva il cavo in tensione e mentre uno parlava dentro al barattolo, l’altro utente doveva mettere l’orecchio all’interno dell’altro barattolo. Si potevano fare conversazioni a distanza sempreché ci dessimo il ‘passo’ per il cambio. Quando eravamo stanchi di questo giochino, interessante dal punto di vista fisico, ma noioso alla lunga, allora convertivamo il telefono per fare le “bòtte”. Ecco che spuntava la necessità del carburo. E qui si andava nell’avventuroso e nel pericoloso. Prima di tutto ci voleva la stagione adatta. Cioè bisognava che la terra dei campi fosse fangosa ma non troppo. Quindi ci voleva una canna piuttosto lunga, qualche pagina di giornale, dei fiammiferi e il barattolo forato. Per la canna non era un problema, ne avevamo quante ne volevamo, perché la “guancia” della ferrovia di Siena era piena di canneti. Lo stesso per il giornale, perché tutte le domeniche veniva distribuita porta a porta “L’Unità”, organo del Partito Comunista e, ogni famiglia, tranne la mia per la proibizione di mia madre, ne comprava una copia. Per i fiammiferi bastava che ognuno di noi ne prendesse due o tre dalla scatola di casa. Per il barattolo, o si prendevano i due del telefono di cui dicevo prima, o si aspettava che una delle nostre mamme consumasse un nuovo barattolo di conserva e allora veniva subito messo da parte per gli impieghi futuri. Poi ci voleva la materia principale. Il “carburo”. Qui entrava in ballo il gioco di squadra. Prima di tutto si faceva la conta a chi doveva toccare il compito di prendere il “carburo” dal fustino di Leone, il casellante. Poi si faceva la conta a chi toccava farlo chiacchierare e distoglierlo dall’interno del casello. In genere in due o tre. Ma la miglior cosa era aspettare che passasse un treno e allora era costretto per forza ad uscire, e quello era il momento più propizio. L’addetto ad aprire il fusto metallico prendeva due o tre sassi di “carburo” e se li nascondeva in tasca. Poi faceva un segno a quelli che parlavano con Leone e quindi, con una scusa o con un'altra, ce la filavamo alla chetichella. Si andava a casa del “Nini” e con un martello si frantumavano i sassi per renderli più piccoli. Poi ci si avviava verso la campagna, con barattolo, canna, giornale, fiammiferi e carburo frantumato, per cercare un posto adatto e lontano dalle nostre case. Quando trovavamo la terra adatta, si rifaceva la conta per i compiti. Chi doveva tenere la canna con in cima la pagina di giornale, chi doveva tenere il barattolo e chi doveva dar fuoco al giornale. Poi si faceva una piccola buca nella mota dove sarebbe stato alloggiato il barattolo. Si costruiva un piccolo cratere al centro della buca. Poi, a turno, si sputava tutti nel cratere e si mettevano due o tre sassetti di carburo nel piccolo cratere pieno di saliva. Questi cominciavano subito a “friggere”. Della Storia d’Empoli 33 A questo punto le operazioni seguenti dovevano essere fatte in sincronia e rapidamente. L’addetto al barattolo, doveva piazzarlo nella buca fino a mezzo con il fondello forato rivolto in alto, rincalzarlo ben bene con il fango, tappare con un dito il foro della parte superiore e aspettare che intanto il gas di acetilene si formasse. In contemporanea l’addetto al giornale doveva accendere il fiammifero e dargli fuoco, mentre tutti gli altri si mettevano dietro. A quel punto quello con la canna con il giornale incendiato, si avvicinava al barattolo e urlava a quello che tappava il foro: ‐VAI!!!‐, e piazzava sopra al barattolo la fiamma del giornale. Quello che tappava il foro scappava da noi che intanto eravamo tutti dietro a quello con la canna ad aspettare. Con uno scoppio tremendo, Il barattolo partiva in uno sfavillio del giornale in fiamme e in uno schizzìo di mota, raggiungendo altezze di trenta o quaranta metri . Quando lo recuperavamo, il barattolo aveva il fondello diventato semisferico ed era tutto gonfio e deformato. In genere si poteva usare due o tre volte, poi era da buttare. Però non andava sempre così bene. Poteva succedere che si formasse una fiammella bianca e lunga sul foro del barattolo senza che avvenisse l’esplosione. E allora con la canna, di lontano, spingevamo il barattolo fino a rovesciarlo e poi ripetevamo l’operazione. La volta che Carlino si era chinato sul barattolo con la fiammella sopra al foro, senza che questo fosse stato divelto, il barattolo partì, anche se con forza ridotta, e lo prese in pieno sotto al mento. Inoltre si riempì la faccia e i vestiti di schizzi di mota e di melma grigia che era il risultato dei nostri sputi e della reazione del carburo. Fu così che si portò dietro sotto la “baza”, un bell’ematoma rosso, che poi diventò viola, fatto a semicirconferenza, provocato dal bordo del barattolo. Sembrava un tatuaggio indiano. Gli rimase per oltre un mese, e ne andava molto fiero. Ma ci furono anche altri giochi che, a ripensarci oggi, mi fanno accapponare la pelle. Negli anni del dopoguerra durante le nostre scorrerie per le campagne e per i fossi, a volte si poteva incappare in quelli che venivano chiamati “residuati bellici”. Per esempio la figliola di Leone, il casellante, aveva perso un occhio, credo, pestando o tirando un filo di una mina o qualcosa di simile. E una volta sotto il ponte del fosso della ferrovia Firenze‐Pisa, vicino alla casa dell’Alderighi, (si vede ancora, abbandonata, accanto al parcheggio scoperto del “gabbione della COPPE” lato SS67) trovammo un pezzo di nastro di mitragliatrice o di fucile mitragliatore pieno di proiettili tutto fangoso e arrugginito. Era appoggiato sopra a una specie di cordolo sporgente dalla parete, dove cominciava la volta del cunicolo. Una volta portato a casa, la prima cosa che facemmo fu di togliere i proiettili dal nastro. Poi, sempre di nascosto dai nostri familiari, cercammo di piegare con le mani i proiettili prendendo con Della Storia d’Empoli 34 una mano la punta di piombo e con l’altra il bossolo di ottone. Piano, piano dopo diverse volte di questo trattamento, scardinammo le ogive di piombo dai bossoli. Fu una sorpresa quando, all’interno del bossolo di ottone, trovammo come degli spaghettini giallognoli al posto della polvere da sparo che eravamo abituati a vedere nelle cartucce da caccia dei nostri genitori. Comunque ne facemmo un piccolo monte su di un mattone e gli demmo fuoco. Ci fu una fiammata bianchissima e rapidissima. E ci pentimmo di aver bruciato tutto il contenuto. Chissà che avremmo potuto inventare con questa manna. Comunque ci rifacemmo quando se ne trovò uno con 5 o 6 proiettili molto grossi. A dire la verità, non mi ricordo da dove vennero fuori. Non sembrava uno spezzone di nastro, sembrava più un pezzo unico, da caricatore. Erano proiettili grossi e pesanti, forse di contraerea, con una ventina di millimetri di diametro ed erano lunghi venti‐venticinque centimetri. E anche qui, all’interno del bossolo di ottone, dopo il solito trattamento, trovammo i soliti spaghetti bianchicci ma molto più grossi e più lunghi. Dando fuoco ad uno spaghetto, questo bruciò in un istante. Non riuscì a bruciare neppure la carta su cui l’avevamo messo, da quanto fu rapida la combustione. Decidemmo allora di infilare uno di questi spaghetti in una cannuccia di paglia e dargli fuoco per vedere cosa sarebbe successo. Piazzammo la cannuccia caricata per terra e gli demmo fuoco. La cannuccia con un leggero sibilo, partì velocissima prendendo il volo e spengendosi quasi subito, ma ad una discreta distanza. Avevamo inventato il razzo!!! Finimmo quasi tutti gli spaghetti in questa maniera, facendo delle specie di rampe di lancio con tavolette, cannelli di canna, ecc. Per vederne l’effetto, qualcuno lo serbammo per dargli fuoco la notte, facendo concorrenza alle lucciole. Ma sempre di nascosto. Non oso pensare cosa avrebbe potuto succedere se nell’operazione di smontaggio delle ogive dei proiettili ne fosse esploso uno. Ma tant’è. Comunque trasformavamo anche i giochi “normali”, anche se non così esplosivi, in altrettanto giochi pericolosi. Per esempio costruivamo archi, frecce e “strombole” come tutti i ragazzi del tempo. (Per i non empolesi “strombole” sta per fionde). Ma noi facevamo di più. Per gli archi andavamo in giro finché non trovavamo un albero o un “chioppo”con un ramo abbastanza curvo per ricavarcene uno. Molto apprezzate erano anche le stecche di quegli ombrelli di incerato verde, pesantissimi, che noi chiamavamo “da pastore”. In effetti il pastore di “Davane” (di Avane) ne portava sempre uno a tracolla. Le stecche di questi ombrelli erano di vimini ed erano abbastanza elastiche, già curvate e molto probabilmente trattate con qualche sostanza perché erano molto elastiche. Della Storia d’Empoli 35 La pericolosità stava però nelle frecce. Quelle veramente pericolose erano quelle ricavate dalle stecche di acciaio degli ombrelli “normali”. Non è che fosse molto facile reperirle, perché a quel tempo passava l’ombrellaio che li riparava e un ombrello poteva durare una vita. Comunque qualche volta capitava di averne fra le mani qualcuno sfondato. E allora veniva immediatamente smembrato e cannibalizzato. Le stecche degli ombrelli di allora, erano fatte con del filo tondo di acciaio e all’estremità ,in cui c’era il buco per il fissaggio della tela, erano schiacciate. Piegandole più volte in questa zona con un paio di pinze, si rompeva il piccolo pezzo di estremità dove era il buco e ci rimaneva la stecca lunga con la tacca a semicerchio, residuo del buco, pronta per essere incoccata nella corda dell’arco. Non era finita. La stecca veniva poi strofinata sulle pietre fino ad avere una punta da spillo. Non c’erano direzionali, e la traiettoria non era un granché, ma posso assicurare che scagliando una freccia di questo genere su di una tavola di legno di un centimetro di spessore, non solo ci rimaneva conficcata, ma la poteva anche sfondare. Lascio immaginarne la pericolosità in mano a dei ragazzi robe del genere. Le frecce, meno pericolose ma molto più “indiane” e perfette, erano però quelle ricavate dai rami diritti dei “chioppi” che sorreggevano le viti ai bordi dei campi. A queste potevamo applicare i direzionali all’estremità opposta alla punta. Si tagliava a croce il dietro della freccia e ci si infilavano le penne ricavate dalle ali di pollo. Queste si prendevano da Gino che andava in giro dai contadini con una vecchia BSA, con una stia sul sidecar, a comprare polli e conigli che poi rivendeva in una bottega che aveva in Empoli. Lì ,al bafòre, dove abitava, spennava i polli e spellava i conigli in una rimessa che aveva sulla corte. Quando era vicino a carnevale o a Pasqua portava i luci (tacchini), e allora era proprio una manna, perché avevano penne adattissime allo scopo. Tra l’altro ce le potevamo mettere anche dietro alla testa a mo’ di Sioux o di Apaches, ciondoloni, o di Cheiennes, ritte, trattenute da un fazzoletto intorno alla testa. Una volta infilate le penne negli intagli della freccia, si legava strettamente con un po’ di spago l’estremità affinché non uscissero e il gioco era fatto. Con questo sistema le frecce potevano essere scagliate lontanissime e andavano abbastanza diritte, se la freccia non era curvata. Si metteva un bersaglio a contatto con un pagliaio e cominciavamo le nostre gare di tiro con l’arco. Per rendere più micidiali le nostre frecce, sulla punta si arrotolava, a cono, un po’ di latta ricavata da qualche barattolo, e si schiacciava con un martello o con un sasso. Venivano anche meglio bilanciate, ma molto più pericolose. (Inciso. A proposito dei tacchini di Gino, mi ricordo che gli faceva un trattamento particolare che non ho mai capito il perché. Una volta spennati ben bene, con un coltello affilato, gli faceva una incisione sulla pelle in corrispondenza dell’articolazione fra la zampa e la parte bassa della coscia del tacchino. Vi infilava il cannello di una pompa da bicicletta, e cominciava a pompare. La pelle del tacchino piano piano si staccava dalla carne e il tacchino, compresa la testa con i bargigli, si Della Storia d’Empoli 36 gonfiava come un pallone. A quel punto legava con un po’ di spago la gamba incisa perché l’aria non potesse uscire, e lo appendeva. I tacchini, così trattati, diventavano enormi. Quando li appendeva tutti in fila, facevano impressione. Chissà se lo faceva perché i tacchini sembrassero più grossi o perché ci fosse proprio una ragione di commestibilità. Non l’ho mai saputo. Fine dell’inciso.) Altri attrezzi che modificammo con un vero successo furono le cerbottane. Le cerbottane a quel tempo venivano fatte tutte, e da tutti, con cannelli di canna, che era altra materia principe per la costruzione di innumerevoli giochi del tempo. I proiettili, o “siruli”, che si usavano, venivano ricavati dalle pagine dei quaderni (altra materia prima). La pagina veniva divisa e tagliata in due per la lunghezza del foglio. Una delle metà veniva poi arrotolata sul dito indice e tirata alle due estremità. Ne veniva fuori un cono che veniva leccato sulla punta, con la saliva a mo’ di colla perché non si sfacesse. Poi lo facevamo cadere con la punta nel cannello fino a dove entrava, e in quel punto tagliavamo il cono, calibrandone così il diametro adattandolo alla canna e pronto per essere sparato, soffiando con un colpo secco nel cannello stesso. I cannelli così fatti, erano piuttosto corti e anche abbastanza larghi di diametro. La portata dei “siruli” era, tutto sommato, modesta. Dieci o venti metri al massimo. Poi feci una scoperta. In casa mia avevano messo un lampadario nel “salotto” e a questo proposito era venuto mio zio Renato. Quello che “sapeva far tutto”. Aveva portato dei tubetti di metallo cromato lunghi un metro con un diametro più o meno di un centimetro, filettati all’estremità per appendere questo lampadario. Il filo elettrico passava all’interno di questo tubetto che lui chiamava “tige”. Guardando mio zio mentre lavorava, stavo pensando a come avrei potuto trasformare quei tubetti per giocarci. Pensavo già alla canna di un fucile, se avessi potuto costruirmi il calcio con una tavoletta. Mio zio guardandomi mentre lavorava, e vedendo che ero più interessato ai tubetti che al suo lavoro, mi chiese se ne volevo uno. E me lo porse. Presi in mano questo tubetto e il cervello mi cominciò a frullare per sapere cosa poterne ricavare. La canna di fucile a cui avevo pensato, la scartai perché mi sembrava una cosa troppo statica. Tutti noi avevamo già un fucile con la canna simulata e ricavata da un manico di scopa. A quella avevamo applicata una molletta da bucato per scagliare gli elastici fatti con una catena di anelli ricavati da vecchie camere di bicicletta. Mi ricordo che ci pensai tutta la notte per sapere cosa farne. Ci pensai anche tutta la mattina dopo, durante la scuola. Finché non mi venne l’idea. Chissà se funzionava come cerbottana. Non vedevo l’ora di arrivare a casa per provare. E infatti la prima cosa che feci strappai una pagina di quaderno e la divisi in due come avevo sempre fatto. Ma il “sirulo” venne troppo grosso e una volta calibrato nella “tige”, risultò troppo corto. Dovevo dividere la pagina ancora. E infatti tagliata la pagina per il lungo in quattro parti, i Della Storia d’Empoli 37 quattro “siruli” che ne risultarono erano perfetti. Stretti e affusolati, lunghi una ventina di centimetri. Ne bastava tagliare solo un pezzettino nella parte grossa del cono. Ne infilai uno nella futura cerbottana, la puntai in alto e soffiai con un colpo secco. E fu veramente una sorpresa. Il “sirulo” uscì velocissimo e dritto dalla cerbottana con un piccolo schiocco e si perse lontanissimo. A una cinquantina di metri. Non ci potevo credere. Riprovai con un altro. Solita scena. Allora andai in casa presi la scatola di fiammiferi sulla cappa del camino e la misi sul bordo della tavola di cucina. Andai sul lato opposto con le spalle alla parete, incannai, presi la mira e soffiai. Ci fu uno sspLUT!‐STAK! quasi contemporaneo e la scatola volò per terra. Non solo. Il “sirulo” vi era rimasto conficcato. Avevo fatto un’invenzione! Corsi fuori con la mia nuova arma per avvertire gli altri della banda. E fu un successone. Non credo che Kalasnikov sia stato tanto più soddisfatto di me, quando inventò la sua delle armi! Piano, piano tutta la banda si armò con questo tipo di cerbottana. La fama di questa nuova arma travalicò i confini del bafòre e si videro ragazzi impugnarla anche a Santa Maria. Comunque riuscimmo a rendere ancora più pericolosa anche questa, che già pericolosa era. Non contenti dei soliti “siruli”, troppo morbidi e dopo qualche tiro non più recuperabili, li rendemmo rigidi e duri quasi fossero di legno, ma sempre leggeri. Infatti, una volta fatti una ventina di “siruli”, si spalmavano all’esterno con un dito intinto in un bicchiere di “colla” fatta alla solita maniera. Con acqua e farina. Poi li lasciavamo seccare al sole. Diventavano perfetti. Ma non bastò ancora. Contenti del risultato ottenuto, provammo ad applicare degli spilli in cima al “sirulo”, prima di spalmare la “colla”. E allora diventarono veramente pericolosi e micidiali. Li tenevamo in un barattolo di conserva che applicavamo al nostro fianco con uno spago. Come una piccola faretra. Devo dire però che questo tipo non è mai stato usato nelle nostre guerre, ma solo per tiro a segno su tavole o cartoni. Gli unici esseri viventi su cui ogni tanto le usavamo, erano le povere lucertole, di cui non avevamo proprio nessunissima pietà. Quando venivano colpite, queste povere bestiole, fuggivano con il “sirulo” attaccato sulla schiena. Un pò come le banderillas sulla schiena dei tori delle arene spagnole. Comunque, nonostante questi strumenti micidiali, eravamo abbastanza consapevoli della pericolosità e stavamo molto attenti a non farci e a non fare del male a qualcuno. Oltre alle frecce, agli archi e alle cerbottane, sempre come strumenti piuttosto pericolosi , erano le “strombole” (fionde), anche queste rigorosamente auto costruite. Anche per queste, quando avevamo individuato una forcella di qualche ramo che facesse al caso nostro, si tagliava e la portavamo a casa. L’impugnatura veniva fatta a misura della nostra mano. Gli altri ragazzi che non erano del bafòre, per gli elastici usavano le catene di anelli tagliati dalle camere d’aria delle biciclette. Le camere d’aria rosse erano forse migliori di quelle nere, ma avevano una potenza limitata. Della Storia d’Empoli 38 Noi invece avevamo la fortuna che il padre e il fratello di Carlino avessero un laboratorio di calzature. In questo laboratorio facevano anche delle scarpe con le suole di “para”che era una gomma elasticissima e resistentissima. Allora facevamo tagliare delle strisce di questa para, della lunghezza e larghezza necessaria. Questo veniva fatta con un trincetto affilatissimo dal fratello di Carlino. Quindi si legavano queste strisce alla forcella con una legatura particolare che non starò a descrivere, ma che era perfetta per l’uso. Nella stessa maniera, in fondo agli elastici, fissavamo una toppa di cuoio, prelevata dal solito laboratorio, che serviva ad accogliere il sasso da scagliare. Venivano fuori delle vere e proprie armi secondo i proiettili con cui venivano caricate. Ognuno di noi ne aveva una. Intagliata e personalizzata. Ci riempivamo le tasche di sassi adatti e andavamo a fare gli allenamenti e gare di tiro. In genere questi allenamenti e gare venivano fatti sui binari della ferrovia di Siena. Mettevamo una ventina di sassi di ghiaia della massicciata della ferrovia, che erano piuttosto grossi, in fila su una rotaia e attingendo dalle nostre tasche si cercava di buttare giù dalla rotaia questi sassi scagliando i nostri proiettili tenendo il conto di quanti ognuno di noi ne buttava giù. Spesso i sassi scagliati rimbalzavano sul fianco della rotaia e tornavano indietro. Abbiamo rischiato diverse volte di essere colpiti dalle nostre stesse armi. Ora lo chiamano “fuoco amico”. Qualche volta arrivava il treno da Empoli e non facevamo in tempo a togliere i sassi dalla rotaia. Ce li sbriciolava tutti, con il macchinista spenzolato fuori dalla macchina che sberciava come un ossesso. Altri bersagli erano gli isolatori di porcellana che reggevano i fili, penso del telegrafo, che correvano lungo la ferrovia. Non è che si rompessero completamente, perché dove era avvolto il filo erano di porcellana piena, e molto duri, ma i bordi del bicchiere erano più fragili. Si spaccavano tranquillamente. Era un piacere vederli saltare con tutte le schegge. Però, dopo che i carabinieri vennero a far visita alle nostre case per sapere chi era stato, smettemmo con simili bersagli. In compenso acquisimmo quasi tutti una buonissima mira. A volte (mi scuso con gli animalisti ma è la pura e santa verità) facevamo saltare una lucertola a 5 metri di distanza. Una volta sola ci fu un episodio veramente increscioso. Durante uno di questi allenamenti sulla ferrovia di Siena, avevamo finito tutti i sassi e stavamo per tornare a casa. Mentre si camminava lungo la ferrovia si vide un gruppo di donne che parlavano vicino alla strada, distante quaranta o cinquanta metri da dove eravamo. Il nostro capo, disse:‐Volete vedere che io riesco a colpire Mirella?‐ E noi tutti: ‐ Siii, eccolo lui! E poi se la chiappi la mandi all’ospedale! Ma smettila!‐ Il fatto fu che, o che sia stato preso nell’onore o che volesse dimostrare la propria bravura, prese un sasso bello tondo da terra, lo piazzò nella fionda, tese gli elastici, prese la mira, e scagliò. Sperammo tutti che mancasse il bersaglio. Dopo un secondo sentimmo Mirella urlare e mettersi la mano alla testa. L’aveva centrata in pieno. Sulla fronte. Scappammo tutti a gambe levate e non ci facemmo vedere più fino all’ora di pranzo. Ma quando rientrammo, avemmo le nostre. Della Storia d’Empoli 39 Avevi voglia di dire che non eri stato tu! Le bòtte venivano equamente distribuite, e chi era stato, era stato. A Mirella spuntò un bernoccolo in fronte che fu ricoperto con un rettangolo di carta gialla alternato da un pezzo di foglia di cavolo, appiccicati con il lardo dei fegatelli e se lo portò per più di una settimana, finché non si sgonfiò. Ci andò di lusso. E fu veramente un caso che Mirella non ci rimettesse un occhio. A parte quel caso fortunato, la mira comunque l’avevamo abbastanza buona. Qualche anno fa, durante una escursione in Birmania, ebbi a stupire un mio compagno di viaggio. Infatti mentre camminavamo in una strada sterrata di un paese per andare a vedere un tempio buddista, ci avvicinò un ragazzo che vendeva fionde da lui costruite. Erano ricavate da rami di albero e tutte lavorate. Erano abbastanza belle e ne comprammo due. Una per uno. Ce le abbiamo ancora. Io volli provare la mia. Raccattai un sasso e dissi al mio compagno: ‐La vedi quella canna?,‐ indicando una canna di bambù di quattro o cinque centimetri di diametro lontana una ventina di metri,‐ Vuoi vedere che riesco a colpirla?‐ ‐Eccoci!‐ fece il mio amico, avvocato, incredulo. Non stetti neanche a prendere tanto la mira. Tirai d’imbracciata, e …STACK!! , la centrai in pieno con un colpo secco. L’avvocato sgranò gli occhi. Sarà stato un caso, ma sono sicuro che quegli allenamenti sulle rotaie della ferrovia di Siena abbiano avuto la loro parte. La “banda del bafòre” aveva diversi “nemici”. Quelli più vicini erano una banda che stavano alle “case”. Le “case” era un altro ciuffo di case, appunto, che erano vicino al Ponte alla Stella. Questi ragazzi erano tutti più o meno della nostra età. Non avevano strombole, archi o quant’altro. Erano disarmati e ci sembravano, e forse lo erano, più poveri di noi. Allora ognuno di noi si era scelto il proprio nemico in funzione dell’età, e quando ci incontravamo ognuno prendeva il suo. Come i cavalieri di Ettore Fieramosca. E giù botte da orbi. Chi riusciva poi, durante la lotta, a mettere il nemico spalle a terra, risultava vincitore. Ma più che lì non si andava. Quando invece partivamo per la guerra vera e propria, in genere andavamo nel bosco del Terrafino, dove spesso c’era un’altra banda “armata”. Questo piccolo bosco, e infatti veniva chiamato boschetto, apparteneva alla fattoria del Terrafino e ne era abbastanza vicino. Ci si accedeva da un cancelletto sgangherato che dava sulla strada che va da Corniola Bassa al passaggio a livello del Terrafino. Noi partivamo armati di strombole e archi dal “Bafòre”. Camminando sulla linea di Siena si arrivava fino al rio di Ponte alla Stella. Da qui entravamo dentro il rio e lo si percorreva fino alla casa del Bagni. Da lì si usciva riprendendo la strada sterrata, si passava davanti alla casa del “Ghera”, tenendoci lontano dal cane a catena, e si sfociava nella strada bianca di cui sopra. Poi ci dirigevamo verso il cancello del boschetto del Terrafino. Della Storia d’Empoli 40 Da questo cancello si dipartiva un sentiero a zig‐zag che si inerpicava fino in cima alla collinetta, dove c’era una radura con in mezzo una torre rotonda, in mattoni, alta una decina di metri. Adesso non c’è più, ma forse sono rimasti i fondamenti. Per accedere alla torre, c’era un ingresso stretto con una porta ormai sgangherata che dava su una scala a chiocciola. Bisognava stare attenti ad entrare, perché a parte i disegni e le scritte oscene fatte con tizzi di carbone, era pieno di merde. Specialmente nel sottoscala. La scala portava fino al colmo della torre che era una terrazza, tonda come la torre, senza parapetto. Questo, molto probabilmente, era stato divelto perché se ne vedevano ancora le tracce. Bisognava anche stare molto attenti perché era facilissimo cadere di sotto. Nel bel mezzo della terrazza c’era un pinnacolo che portava un foro nel centro. Sicuramente nel passato doveva servire a issarci una qualche bandiera. La torre era contesa fra noi e i ragazzi del Terrafino, ma non so se fossero di Pianezzoli. Uno sicuramente. Mi pare che si chiamasse “Fanfara”, “Fanteria” o qualcosa di simile. La banda che arrivava prima, piazzava la bandiera sulla sommità e aspettava che arrivasse il “nemico”. Chi si avvicinava alla torre imbandierata, bisognava che lo facesse con molta circospezione e nascosto dalla vegetazione, perché i sassi scagliati dalle fionde fioccavano come la grandine. Tra l’altro attraversare la radura allo scoperto verso la torre, voleva dire prendersi qualche sassata piena. Ci fu una volta che arrivammo in contemporanea, noi e la banda di Pianezzoli. Mentre cercavamo di conquistare la torre per primi, e mentre ambedue le bande erano nascoste fra gli alberi intorno alla radura, sentii uno schiocco secco nel tronco di un querciolo, proprio vicino alla mia testa, e un FRUUUuuu….!!!! che si perse lontano. Detti un’occhiata e rabbrividii. La corteccia era sbucciata dal sasso fiondato da un nemico! Non riesco tuttora a capire come mai nessuno si sia mai fatto del male, né da una parte né dall’altra. Nel boschetto del Terrafino non c’era solo la torre, ma oltre a dei ponticelli che sembravano fatti di tronchi e che in realtà erano in cemento colorato, c’era anche una capanna. Anche questa tutta in finto legno. Dentro questa capanna, un giorno ci fu alloggiato un tizio, una specie di barbone, con tutta la famiglia. Moglie, anche lei piuttosto malandata, e un figlio neonato. Questo tizio lo si vedeva passare diverse volte anche dal passaggio a livello , con una biciclettaccia e uno zaino sulle spalle di tipo militare. Anche i vestiti, piuttosto malandati e grigio‐verdi, sembravano di tipo militare. Qualcuno diceva che fosse un reduce di guerra. Qualcun altro diceva che fosse un ex fascista scappato dal suo paese. Comunque era abbastanza misterioso e non parlava mai con nessuno. Quando andavamo nel boschetto e passavamo sul sentiero vicino alla capanna, a volte usciva fuori e urlava di girare alla larga perché intorno non ci voleva nessuno. Non ci voleva, perché, urlava, si svegliava il piccino che dormiva. Della Storia d’Empoli 41 Una volta che, nonostante gli avvertimenti, passavamo di lì per andare alla torre per la solita guerra, uscì correndo fuori dalla capanna , con una falce in mano, urlando che ci avrebbe tagliato la testa a tutti. Facemmo dietro‐front immediatamente scappando come lepri. Ma il sentiero a zig‐zag non ci consentiva di allontanarci tanto alla svelta da questo diavolo incazzato che ci rincorreva. Tra l’altro io e Carlino eravamo i più piccoli e non ce la facevamo a correre veloci come quelli più grandi. Quando con la coda dell’occhio me lo vidi dietro a una ventina di metri, invece di proseguire sui tornanti in discesa del sentiero, presi la decisione di saltare sul tornante di sotto per guadagnare strada. Feci un balzo saltando una siepe e senza guardare cosa c’era sotto. Mi ritrovai ad annaspare nel vuoto. Poi dopo un tempo che mi sembrò interminabile, toccai il pendio con i piedi ma non riuscii a fermarmi e, a ruzzoloni e a capriole, mi ritrovai a sbattere nel cancelletto di accesso sulla strada. Ero tutto sbucciato, sanguinolento e terroso, ma ero salvo. In più, ero arrivato prima di tutti. Mi misi sulla strada ad aspettare gli altri che arrivarono di corsa, uno ad uno, tutti trafelati. Compreso Carlino. Meno male ancora con la testa sulle spalle. Perché Carlino, fra tutti noi, era quello che aveva la facoltà di prenderle tutte. Nelle nostre scorrerie, non andavamo soltanto nel bosco del Terrafino, ma anche in quello di Cerbaiola. Specialmente quando dovevamo fare le pine verdi che ci servivano per fare altri giochi come i carretti. E un pomeriggio decidemmo di andare a far pine. Nel bosco di Cerbaiola, sotto la villa, mi pare del Vannucci, c’era una pineta con dei pini piuttosto alti. Il nostro capo, aveva la straordinaria abilità di salire sui tronchi come una scimmia e una volta arrivato ai primi rami, cominciava la scalata ai rami più alti carichi di pine. Le staccava e le lasciava cadere di sotto dove noi le raccattavamo e le infilavamo nelle borse di biodo che ognuno di noi si era portato da casa. Naturalmente stavamo a debita distanza. Come fu come non fu, una pina staccata, venne giù, rimbalzò su di un ramo, deviò dalla traiettoria, ne colpì un altro, deviò ancora e cadde diritta sulla testa di Carlino che era chino a raccoglierne un’altra. Non fece neppure un grido. Cadde a pancia giù e a braccia aperte. Rimanemmo di sale. Non si muoveva per nulla. A chiamarlo non rispondeva. Cominciammo a pensare che fosse morto. Un rivolino di sangue gli spuntò fra i capelli ed era bianco come un cencio. Il capo scese giù e ci mettemmo tutti intorno a lui, sdraiato, a chiederci quello che si poteva fare. Chi diceva di mandare qualcuno a chiamare i genitori, ma nessuno ne aveva il coraggio perché, sicuramente, le avrebbe buscate. Qualcuno propose di fare una barella e di trasportarlo a casa, ma rimanemmo terrorizzati al pensiero del nostro arrivo a casa con Carlino morto sulla barella. Qualcun altro propose di lasciarlo lì e far finta di nulla, così qualcuno lo avrebbe trovato e noi avremmo detto che Carlino si era Della Storia d’Empoli 42 perso. Infamammo quello che aveva fatto questa proposta oscena, ma Carlino era sempre lì e noi assolutamente inadeguati alla situazione. Non sapevamo proprio che fare. Intanto il tempo passava ed eravamo già vicino al tramonto, l’ora in cui dovevamo già essere a casa. Poi Carlino si mosse. Si voltò a pancia all’aria. Cominciò a guardarci tutti, stralunato. Poi cominciò a toccarsi la testa dove intanto gli era cresciuto un “bobolo” grosso come un’albicocca. Tra l’altro il sangue che si era però rappreso, gli aveva sporcato tutto il viso. Cominciò a farfugliare qualcosa e noi lo convincemmo a mettersi a sedere. Poi piano, piano rientrò in sé e pur non ricordando nulla di quello che gli era successo, cominciò a parlare e a dire che voleva tornare a casa. Noi non ne avevamo il coraggio. Non sapevamo proprio che pesci prendere. Alla fine il nostro capo, bòtte o non bòtte, decise per il rientro. Legammo un fazzoletto moccoloso intorno alla testa di Carlino, e ci avviammo verso casa. Arrivammo a buio inoltrato. I nostri familiari erano tutti radunati sulla corte, quando scendemmo in gruppo dalla scarpata della ferrovia di Siena. Non sto a dire gli urli e i berci con cui fummo accolti. Ne prendemmo tante e poi tante, quanto di più non ne potevamo. Tutti. Anche Carlino. E a letto senza cena, caldi caldi dai ceffoni. Così ci educavano negli anni ’50. Il telefono azzurro lo avevano ancora da inventare, e poi, anche se ci fosse stato, come avremmo fatto ad arrivare al casello di Leone che era l’unico luogo dove c’era un telefono! Il fatto è che, da quella volta, a far pine verdi, non ci siamo proprio più andati. Della Storia d’Empoli 43 Capitolo sesto Le prove di coraggio al bafòre Pure un divertimento innocente come l’altalena trovammo il verso di renderlo un oggetto pericoloso e da prova di coraggio. La capanna del Fattori, che era contrapposta alla casa colonica, al di là dell’aia, era adibita a fienile. Il soffitto di questa capanna era abbastanza alto ed era fatto a travi e travicelli dove erano appoggiati le tegole del tetto. Il pavimento era in terra battuta. Duilio, il padre del “Nini”, aveva fatto passare due corde, sdoppiandole, da due travi distanti più o meno due metri e mezzo e le aveva fatte calare fino ad un altezza di sessanta centimetri da terra. Poi aveva preso un tavolone da muratori e l’aveva appoggiato su queste corde. Praticamente la tavola poteva dondolare per il lungo, appoggiata su quattro corde, a parallelogrammo, e quindi poteva dondolare pur rimanendo parallela al terreno. Su questa tavola si poteva montare anche tutti insieme. Uno in piedi alle corde davanti, uno in piedi alle corde dietro, e gli altri a cavalcioni della tavola. Lo slancio lo davano quelli in piedi, prendendo bene il tempo. Questa altalena, faceva una oscillazione ampissima e attraversava quasi tutta la capanna. Data la sua configurazione, quando si arrivava al massimo dell’oscillazione, la forza centrifuga che si era sviluppata, faceva in maniera che si avesse l’impressione di essere scagliati fuori. Bisognava reggersi bene. Nella parte posteriore della capanna, normalmente c’era ammassato un monte di fieno che l’altalena sfiorava nel punto più alto della sua oscillazione. Per prima prova di coraggio, cominciammo a stare tutti in piedi, invece che a cavalcioni della tavola. I due all’estremità a reggersi alle corde, e gli altri attaccati gli uni agli altri. Come una catena. Una volta presa confidenza, cominciarono prove sempre più difficili. Per esempio,preso l’abbrivio massimo, a un segnale del primo, ad allargare le braccia. Ma solo per qualche oscillazione in su e in giù. Era una sensazione spaventosa. Sembrava di dover capitombolare tutti insieme da un momento all’altro. Poi decidemmo di provare a fare come Tarzan. Saltare dall’altalena in corsa sul monte di fieno. E ci provammo tutti. Uno ad uno. Tranne Carlino, che era troppo piccolo. Il primo che ci provò fu, il nostro capo. E ce la fece. Poi toccò a mio fratello. E anche lui ce la fece. Uno alla volta ce la facemmo tutti. Carlino rimase sull’altalena. Purtroppo ci accorgemmo troppo tardi che non era possibile scendere, perché la scala a pioli era appoggiata alla parete opposta del monte di fieno. Oltretutto, questo, era troppo alto per poter saltare di sotto. D’altra parte Carlino non avrebbe potuto portare la scala a pioli perché la scala era troppo grande e lui troppo piccolo. Era inutile chiamare aiuto. In casa non c’era nessuno perché erano tutti al lavoro nei campi. Mandare Carlino al bafòre a chiedere aiuto voleva dire chiamare le busse. Della Storia d’Empoli 44 L’unica via d’uscita era l’altalena. Gridammo a Carlino di aumentare lo slancio per arrivare vicino a noi, ma per quanti sforzi facesse, non riusciva a portare la tavola dell’altalena che a un metro sotto di noi. Si trattava di saltare, ma questa volta alla rovescia. Non c’era il fieno sotto, ma il vuoto. E L’altalena in movimento, con Carlino sopra. Facemmo la solita conta per chi dovesse saltare, e meno male che toccò al nostro capo. Si mise di fronte al punto dove arrivava la tavola con le sue oscillazioni. Noi eravamo tutti schierati ai lati. Carlino si era disposto dalla parte opposta della tavola, in piedi, reggendosi alle corde e guardando noi. Il nostro capo aspettò due o tre oscillazioni della tavola e, quando credette di aver preso il tempo giusto, saltò, cercando contemporaneamente di afferrare le corde. Una corda la afferrò, ma l’altra no. Non solo. Scivolò dalla tavola e rimase proprio come Tarzan attaccato alla liana, mentre scendeva verso terra. E non atterrò proprio come Tarzan, ma atterrò in ginocchioni e poi continuando a strisciare con le gambe nude, lasciando sulla terra battuta un bel po’ di pelle sia dei ginocchi, sia delle cosce. Riprese il volo continuando l’abbrivio e ritornò a terra strascicando i piedi nudi. Quando si fermò, fra il sangue, la polvere e la terra appiccicata alle gambe, sembrava un ecce homo. Comunque andò a prendere la scala e ci portò tutti in salvo. Quando tornammo a casa non si poteva certamente nascondere quello che era successo. Il nostro capo fu lavato e disinfettato con il vino della botte della cantina e poi rimbussolato bene bene. In seguito gli vennero un sacco di croste, conseguenza delle sbucciature ai ginocchi e alle gambe. Per noi fu un vero eroe. L’estate noi non andavamo al mare. Io non l’ho mai visto finché non ho avuto l’età di 13 o 14 anni. Appena finite le scuole, la prima cosa che facevamo, dopo aver buttato quaderni, sussidiari, astuccio e libro di lettura in un canto, ci toglievamo le scarpe e andavamo a piedi scalzi. E in canottiera. Magari con un fazzoletto sulla testa, annodato alle quattro cocche, perché il sole non ci facesse male. I primi tempi a camminare sulla ghiaia del passino della ferrovia o sul brecciolino delle strade sterrate era duro, ma nessuno di noi voleva far vedere che aveva i piedi delicati. E allora stringevamo i denti e si cercava di stare dietro a quelli che camminavano più speditamente. Anzi, quando era stato tagliato il grano nei campi, e rimanevano le stoppie corte e aguzze (noi le chiamavamo “zingoni”), si faceva la prova di coraggio. La prova consisteva nell’attraversare il campo di zingoni di corsa. Senza fermarsi. I primi tempi era veramente dura e mi ricordo che qualche volta arrivavo dall’altra parte con le lacrime agli occhi, ma senza dire ne ai ne bai. E lo stesso gli altri. Della Storia d’Empoli 45 Infatti, e questo non l’ho mai detto, il piangere per noi era una prova di debolezza e anche quando si buscavano, difficilmente si piangeva. Si stringevano i denti e le labbra, ma non si piangeva. Poi, a forza di andare scalzi, ci facevamo il “callo” e alla fine dell’estate potevamo camminare ovunque. Qualche volta potevamo incappare in qualche collo di bottiglia rotto che ci procurava un taglio nei piedi, ma questo , in genere, veniva prontamente disinfettato con un po’ di vino dalle nostre mamme. Quando ne eravamo lontani, si pisciava a turno sopra la ferita e si fasciava con un fazzoletto che portavamo sempre dietro. E avanti. Zoppicando. Sempre nell’estate, facevamo anche escursioni in territori inesplorati, mai visti e misteriosi, che per noi diventavano viaggi veramente avventurosi. Infatti nell’estate venivano delle squadre di operai a ripulire e a ricavare i fossi e i rii che solcavano la campagna di Pratovecchio e non solo. Quando questi rii erano ripuliti e spianati diventavano come piccole strade fra gli argini piuttosto alti e senza nessun ostacolo. In particolare a noi piaceva il rio di Ponte alla Stella, che era molto grande. Non sapevamo dove portasse. Allora ci armavamo di tutte le nostre armi camminavamo lungo la ferrovia di Siena fino al Ponte alla Stella, ci si calava dentro e ci si incamminava in una direzione o nell’altra per vedere dove portasse. Per noi era una misteriosissima trincea. La volta che passammo sotto il ponte della ferrovia di Siena, verso ovest, e poi sotto il ponte della SS 67, camminammo parecchio, attraversando tutta una campagna mai vista prima e fu una sorpresa quando arrivammo fino all’Elsa. Rimanemmo stupiti come Livingstone quando trovò le cascate Vittoria. Sull’Elsa, proprio lì vicino a dove eravamo sbucati noi, trovammo una barca legata con una corda ad un piolo conficcato nel terreno. Fu deciso di salire a bordo. Per farlo bisognava saltare dalla ripa, che era più in alto. Io non sono mai stato un gran saltatore. Quando si facevano le gare di saltare i fossi più grandi, io ci cadevo sempre dentro. Avevo paura. Saltarono tutti, e si accomodarono a sedere sulla barca. Io fui l’ultimo a saltare. Incitato da tutti, presi la rincorsa e saltai. Ma vuoi per la troppa rincorsa, vuoi per la mia atavica paura del salto, appena toccato il bordo della barca, questa si mosse in avanti, io mi sbilanciai indietro, e caddi in acqua. Non sapevo nuotare, e mi ricordo di aver visto tutta l’acqua sopra di me che gorgogliava mentre andavo giù per il tuffo. Detti una gozzata d’acqua e capii immediatamente di essere in una condizione estrema. Detti una sforbiciata con le gambe e una sbracciata fortissima verso il basso. Il risultato fu che emersi fino a mezza vita, come un delfino, tantoché gli altri mi ripresero al volo e mi tirarono in barca. Tutto molle, ma salvo. Me la vidi veramente brutta. Meno male che durante il tragitto di ritorno, piano piano la canottiera e i pantaloni si asciugarono. Le mutande, per asciugarle prima, me le ero messe in testa al posto del fazzoletto. Lo avevo perso Della Storia d’Empoli 46 nel tuffo. Prima di arrivare a casa, le rimisi al posto giusto. Per il fazzoletto feci finta di averlo perso. Almeno quella volta scansammo le busse. Adesso di quel rio al Ponte alla Stella, ci sono rimasti solo i muretti di mattoni sulla 67 con il tabernacolo della madonnina. Rifatta. Il rio dopo avere attraversato il ponte sotto la 67, si intuba e va a finire sotto la carrozzeria Righi e Fini. Poi penso che continui tutto sotto la zona industriale del Terrafino. Spero che arrivi sempre all’Elsa. Addio Livingstone! Della Storia d’Empoli La mia famiglia 47 Capitolo settimo Gli animali del bafòre Se c’è qualche anima sensibile o qualche animalista convinto, che abbia la disavventura di leggere queste pagine, lo pregherei di saltare quanto racconterò qui di seguito, ma è la pura e santa verità. Parafrasando Pirandello: così era, se vi pare. Lo racconto per dovere di cronaca in maniera che i ragazzi di oggi sappiano come erano i ragazzi e la vita al bafòre negli anni ‘50. Della Storia d’Empoli Intanto gli animali del bafòre dovevano servire tutti a qualcosa. Non c’erano animali “inutili”. Dovevano aiutare tutti, in qualche modo, al vivere comune, oppure dovevano essere sacrificati per alimentazione. Inutile dire dei buoi o dei ciuchi. I cani erano tutti da caccia, sia da “penna” sia da “lepre”. Non esistevano cani da “compagnia”. I barboncini o simili, venivano dileggiati e disprezzati, come d’altronde i loro padroni. Guai ad averne uno. I cani del bafòre erano rispettatissimi, ma non vezzeggiati. Erano cani seri. E fedelissimi. I gatti venivano tenuti per dare la caccia ai topi, ma se non facevano bene il loro mestiere, in qualche modo venivano allontanati se non addirittura fucilati. Non esistevano animali che mangiavano a ufo. Il maiale, i polli e i conigli mangiavano tutti a ufo. Per crescere e ingrassare. Ma con uno scopo ben preciso. Gli animali selvatici venivano cacciati e uccisi per alimentazione oppure catturati o allevati per fare da richiamo ad altri sventurati colleghi. Purtroppo un animale del bafòre difficilmente moriva di vecchiaia. Neppure i cani e neppure i gatti. 48 A quel tempo, al bafòre, non c’era cane che fosse tenuto al chiuso o a catena. I cani erano tutti liberi di vagare dove volevano e tutti conoscevano i cani di tutti. Per questa libertà di cui godevano, spesso attraversavano le due ferrovie e la strada. Questo fatto poteva risultare letale. Prima o poi venivano travolti dal treno o da qualche rara automobile. Quando succedeva con il treno, noi ragazzi andavamo, morbosamente e impietosamente, a vederne i brandelli rimasti di queste povere bestie. La solita fine la potevano fare i gatti. Il rapporto ferrovia‐strada‐cani‐gatti era molto difficile da gestire proprio per la libertà di cui godevano. C’erano solo i cani Ruffo, che si salvavano. Mi spiego. Non è che i cani Ruffo fossero una razza di cani, no. Anzi, i cani Ruffo erano tutti dei bastardoni piuttosto grossi, incrociati forse con i bracchi e i pastori maremmani. Il fatto è che, mentre i nostri cani avevano tutti un nome ben preciso, Birillo, Baffino, Bistino, Zuma, ecc. ecc., Duilio, padre del “Nini” e contadino verso il Ponte alla Stella, tutti i cani che metteva, li battezzava con il nome di Ruffo. Nemmeno Ruffo 1°, Ruffo 2° o Ruffo 3°. Tutti, e forse da generazioni, sempre e comunque Ruffo. Tutti i cani Ruffo venivano messi legati a una catena fissata con un moschettone a un filo d’acciaio che andava dallo spigolo della casa colonica allo spigolo della “loggia”, al di là dell’aia. Il Ruffo di turno veniva slegato solo per la battitura del grano e veniva legato dietro casa, vicino alla concimaia. I Ruffo morivano tutti di vecchiaia. Ci fu anche un nostro cane da “penna”, Tom, bracco tedesco, duro come le pine, disobbediente e testardo come non ne abbiamo avuti mai, che svicolò dal solito probabile destino. Il fatto ce lo raccontò Leone, il casellante. Una mattina, sulla linea Pisa‐Firenze, forse per la segnalazione di qualche semaforo, un treno merci rallentò alquanto, fino a fermarsi. Col secondo vagone si fermò proprio in mezzo alla strada, fra le sbarre. Quel vagone doveva essere un vagone postale, perché si affacciò un tizio che vide Tom che stava sopraggiungendo di fianco al treno abbaiando e correndo. Lo chiamò fischiando e facendo : ‐Toh!! Toh!!, Toh!!‐ E quell’imbecille di cane che fece? Spiccò un salto e salì sul vagone. Il treno ripartì e di Tom non avemmo più notizia. Sparito. Mio padre e mio nonno, cacciatori incalliti, non se ne fecero ne in qua ne in là. Anzi, mio nonno Beppe sentenziò: ‐Era un cane che mangiava e basta. Ha fatto la fine che si meritava. Ci ha pensato da sé a’ andà’ via‐ Dopo due giorni entrò in casa Musetta, una cagnolina “da lepre” buona, ubbidiente e più che altro, nel crescere risultò bravissima nella caccia. Stimatissima da tutto il “bafòre”. Della Storia d’Empoli 49 Con i rettili, non avevamo nessunissima pietà. Non solo li uccidevamo, ma eravamo di una crudeltà tale verso di essi, che forse solo i bambini possono averne. Quasi tutti i ragazzi del tempo, in primavera, facevano i lacci con l’avena selvatica per catturare le lucertole. Una volta catturata la lucertola o veniva strozzata con il solito laccio, o gli veniva tagliata la coda per vederne i movimenti autonomi (si diceva che la coda mandava gli accidenti. Ma si diceva anche, “che gli accidenti son come le foglie e chi li manda li raccoglie”), o sbatacchiata per terra. Noi, ragazzi del “bafòre”, come sempre, facevamo di più. Si cercava qualche cicca di sigaretta vicino al passaggio a livello e si sbriciolava. Poi mettevamo i fili del tabacco davanti al muso della lucertola catturata, ancora al laccio. La lucertola, forse credendo che fossero vermiciattoli o forse attirata dall’odore, ingoiava subito quei fili di tabacco. Con ingordigia. Ed ecco che avveniva una reazione strana che ci affascinava. La lucertola cominciava a gonfiare, a gonfiare, a gonfiare fino a diventare larga come un ramarro. Poi smetteva di agitarsi e finiva i suoi poveri giorni in questa bruttissima maniera. Mi pento e mi dolgo di tutti i miei peccati, ma era così che facevamo. Con le serpi, o “biacchi”, se non avessimo avuto paura, avremmo fatto anche di peggio, ma con quelle ci limitavamo a ucciderle senza tanti complimenti. I grandi spesso ci mandavano a “far nidi” per catturarne i piccoli che poi venivano allevati in gabbia per usarli poi come richiamo per le battute di caccia a capanno. Una volta, durante una di queste spedizioni, il “ Nini” era salito su di un albero con il tronco cavo. Siccome gli era sembrato di vedere uscire un passero dall’interno del tronco, pensò che ci fosse un nido nascosto, e ci infilò un braccio. Dette in un urlo, e si precipitò di sotto. Aveva una serpe, verde e azzurrognola avvinghiata al braccio che soffiava con la bocca spalancata. Dette uno scossone con il braccio e se la scrollò sbattendola a terra. La serpe, lunga un paio di metri, tentò la fuga zigzagando fra le zolle, ma ebbe vita breve. A forza di zollate e di sassate la rendemmo impotente e con un ultimo colpo, con una grossa pietra, sulla testa, la finimmo. Si trovò una canna lunga, ce la legammo ciondoloni con dei rami di “sarcio”, e la portammo a casa come un trofeo, facendo i turni a portare la canna in spalla. Ognuno voleva la sua parte di gloria. Alla fine della primavera, i fossi e i rii della campagna erano pieni di acqua residua delle piogge invernali. Il fango che intorbidava l’acqua, ormai era stato depositato completamente e si potevano vedere distintamente ranocchi e salamandre nuotare nell’acqua limpida fra la vegetazione del fondo. Quello era il tempo della pesca ai ranocchi e la caccia alle salamandre. Le salamandre venivano uccise con una canna appuntita a mo’ di fiocina e buttate via. Solo per il gusto di ucciderle. I ranocchi invece venivano pescati con “l’ancorino”. Della Storia d’Empoli 50 Quest’ancorino era una specie di amo piuttosto grosso e a tre punte. Veniva legato con un filo ad una canna piuttosto lunga. La pesca consisteva nell’avvicinare piano piano l’ancorino sotto la pancia del ranocchio senza che questo fuggisse. Poi con un colpo secco si tirava su. Il ranocchio faceva un volo per aria rimanendo infilzato nell’ancorino. Si recuperava e si infilava in un calzinotto, che portavamo dietro per la raccolta. Quando il calzino era pieno e gonfio di ranocchi si tornava a casa. Il risultato della cattura veniva diviso a turno fra le nostre famiglie. Una volta la mia, un’altra volta quella di un altro e così via. Le nostre mamme li sbuzzavano, li spellavano gli facevano le “cosce”, che era un modo di sistemarli, li infarinavano e li friggevano. E naturalmente si mangiavano. Indorati e fritti. Contorno: il radicchio selvatico, trovato sulla guancia della ferrovia. Altro tipo di pesca che veniva fatto sempre da noi ragazzi del bafòre, era la pesca con le “ture”. A primavera inoltrata, come dicevo prima, i fossi e i “cavi” della ferrovia erano ancora pieni di acqua. Durante le piene dell’inverno questi fossi molto probabilmente entravano in contatto con l’acqua dell’Elsa o dell’Arno, perché si verificava che in questi fossi, oltre ai ranocchi e alle salamandre, rimanessero intrappolati anche pesci. A volte anche grossi, come carpe e “reine”. Per questo tipo di pesca, portavamo una zappa o due e una grossa zucca secca piena di acqua che ci faceva da contenitore per i pesci pescati. Entravamo nell’acqua e facevamo allora delle “ture”, specie di dighe di fango. Alla distanza di venti‐trenta metri l’una dall’altra. Poi si prendevano le zappe e si cominciava a sciabordare l’acqua in maniera da intorbidirla completamente. Fatto questo, ci mettevamo uno accanto all’altro con le mani a pettine dentro l’acqua. Poi, partendo da una “tura”, si percorreva tutto il fosso in questa configurazione verso l’altra “tura”. I pesci con l’acqua torbida cercavano di venire a galla. Si vedevano le boccucce in superficie che masticavano aria e acqua. Si andava a tasto, ma quando sentivamo il pesce guizzare fra le mani, eravamo svelti a stringerlo e buttarlo nella zucca piena d’acqua. Con questo sistema siamo riusciti a catturare delle carpe anche di più di un chilo. Una volta prendemmo un pesce che non avevamo mai visto. Era di un colore giallognolo con delle striature nerastre e con un muso bruttissimo, pieno di “baffi” neri. Neppure i nostri genitori, tutti pescatori e cacciatori, non riuscirono ad identificarlo. Forse ci riuscimmo noi andando ad informarci su un di album di figurine incollate in cui erano rappresentati tutti gli animali della terra. C’erano tutti, da quelli preistorici fino a quelli recenti. Alla sezione pesci, ce n’era una con un disegno che assomigliava tantissimo al nostro. L’album lo identificava come “Pesce Gatto” ma anche come originario e abitante dei fiumi dell’India. Ci sembrò altamente improbabile che fosse arrivato fino al bafòre, nel cavo della ferrovia di Siena! Ma chissà! Con questo sistema di pesca , nel cavo di “Pelle”, che passava sotto la ferrovia Firenze‐Pisa attraverso un cunicolo di mattoni, invece che pesci, riuscimmo a prendere sei, dico sei, bisce acquatiche, molto simili a serpi ma di colore marrone scuro. Appena vennero catturate con le mani, si presero per la coda e si sbatacchiarono con la testa su una pietra. Tipo frusta. Della Storia d’Empoli 51 Non contenti, appena finita la pesca, salimmo sulla guancia della ferrovia e le legammo con dei “sarci” (rami di salice rossi e fini. Materia prima per legare viti e costruire cesti) su di una rotaia del binario, e aspettammo un treno. Ne arrivò uno fischiando a intermittenza. Passò. E delle serpi non ci rimase neppure il seme. L’ho già detto, con i rettili non avevamo proprio nessuna pietà. Chissà perché. A pensarci bene, però, non è che i nostri padri e madri fossero tanto a di meno in fatto di crudeltà. Mia madre e mia nonna, per esempio, tiravano il collo a polli e piccioni con estrema facilità, lasciandoli a sbattere le ali mentre li tenevano appesi per le gambe. I conigli venivano uccisi spezzandogli il nodo del collo con la famosa “botta a conigliolo” che era una specie di colpo di karatè dato con il taglio della mano fra capo e collo della povera bestia. Questo però lo facevano gli uomini, perché le donne non avevano abbastanza forza. Comunque ho visto anche una contadina che per tirare il collo ad un papero, in assenza di uomini, lo aveva messo con il collo sotto a un manico di scopa su cui era montata con i piedi. Quindi tirò per le gambe la povera bestia. Tirò fino a che l’osso del collo non cedette. D’altra parte gli animali da cortile prima o poi dovevano essere sacrificati e quelli erano i sistemi tramandati da secoli e secoli. L’ASL , o chi per essa, era di là da venire. La protezione animali non si sapeva neppure se esistesse ne tantomeno che cosa fosse. L’animale che proprio di vecchiaia non sarebbe mai morto, era il maiale. E quello che mi faceva veramente paura e compassione, e non solo a me, ma anche agli altri componenti della banda, era l’uccisione del maiale. Il primo che vidi uccidere c’ero quasi affezionato. L’avevo visto crescere. Mi ricordo che mio padre era andato a comprarlo in bicicletta a Varramista, vicino a Pontedera. Io e mio fratello eravamo a letto con il morbillo. Vedemmo arrivare sulla porta della camera mio padre con questo maialino pulito e roseo in braccio. Per farcelo vedere. Sembrava un cucciolino ed emetteva dei piccoli grugniti quando si solleticava sotto la pancia. Poi, fu rinchiuso nello stanzino. All’ingrasso. E purtroppo per lui, crebbe ed ingrassò fino a dicembre. Il mese dedicato. Quando fu decisa l’esecuzione, in casa cominciò un gran trambusto. Non ci mandarono neppure a scuola. Pentole di acqua furono messe a bollire ovunque ci fosse un fornello. Fu chiamato un tizio esterno al bafòre, non so se da Santa Maria o dal Ponte a Elsa. Il boia. Fu tirato fuori il maiale dallo stanzino a forza, tirandolo per le orecchie e spingendolo dietro perché non voleva uscire. Strideva da far paura. Sicuramente si era ammoscato di quello che gli stava per succedere. Poi il boia cominciò a grattargli sotto la pancia, mentre mio padre e mio nonno lo reggevano. Il povero maiale, come ipnotizzato, piano piano si adagiò su di un fianco. Allora gli furono legate alla svelta le zampe con un cordino e anche il muso che non potesse aprir bocca. Il boia a quel punto tirò fuori l’arma preposta all’esecuzione: il “Buaciri”. Della Storia d’Empoli 52 Era questo “Buaciri” (bucaciri) una specie di spillone di tondino di acciaio di una decina di millimetri e lungo una quarantina di centimetri, con una specie di maniglia ricavata dal solito tondino ritorto. Il boia, compì allora un rito strano. Partendo dalla coscia posteriore, cominciò a misurare con il palmo delle mani, il fianco del maiale fino a fermarsi in un certo punto con una mano. Impugnò il “buaciri”con l’altra e, con un colpo secco, lo conficcò quanto era lungo, nel fianco della povera bestia. Nel punto esatto dove era rimasto con l’altra mano. Gli stridi che questo povero animale urlava al cielo, furono tremendi. Bucavano gli orecchi. Mi ricordo che scappai verso il casello di Leone e mi rinchiusi dentro finché non sentii più quelle strida disperate. Poi ritornai a casa. Quando era già cominciata la festa. Il foro del “buaciri” era stato tappato con uno zipolo di sarcio. Per prima cosa il maiale fu abbrosticciato con ciuffi di paglia in fiamme. Fu poi rasato dalle setole con coltelli affilati come rasoi, bagnandolo via via con acqua bollente. Fu legato con le gambe posteriori allargate ad una scala a pioli, e issato a testa in giù. Gli fu messo un catino sotto al muso per la raccolta del sangue. A quel punto, con la massima naturalezza, mia madre e mia nonna Cesira , si disposero ai lati reggendo un caniccio a contatto della pancia del maiale. Mio padre partendo dall’alto con un coltello affilato, cominciò la squartatura. Tutte le budella si riversarono nel caniccio, mentre il sangue veniva raccolto nel catino sottostante. Tutte le operazioni del poi le tralascio. Questo era il sistema con cui venivano macellati i maiali a quel tempo. Per lo meno al bafòre. Poi, non so per quale ordinanza, venne proibita l’uccisione con il “buaciri”. Non solo, ma mi pare di ricordare anche, che bisognava pure denunciare il maiale al dazio e chiamare un veterinario o un addetto del comune per l’uccisione mediante pistola. Naturalmente pagando il dovuto. Fu così che, codesto anno, fu deciso di ammazzare il maiale di nascosto per evitare la tassa. Non mi posso assolutamente dimenticare la tragicomica scena a cui dovetti assistere quell’anno. Dopo innumerevoli riunioni familiari, fu deciso di uccidere il maiale senza farlo stridere e senza far rumore, in maniera che nessuno potesse fare la spia per quanto riguardava il possesso e tantomeno l’uccisione del maiale. Come? Intanto la povera bestia fu spinta in casa, nella stanza “didietro”, attigua alla cucina che ci fungeva anche da cantina. Eravamo tutti lì. Io, mio fratello, mia nonna Cesira (quella sorda), mio nonno Beppe, mia madre, mio padre e naturalmente la vittima, il maiale. Mio nonno reggeva il maiale abbracciandolo per il collo. Mio padre brandì il martellone, che era il martello più grosso della povera dotazione di arnesi che era in casa. Lo scopo era quello di tramortire, con un colpo ben assestato sulla testa, il povero maiale. Poi si sarebbe passati alla uccisione vera e propria. Della Storia d’Empoli 53 Mio padre alzò il martellone e calò un fendente che avrebbe ucciso un elefante. Ma proprio mentre il martello calava, il maiale fece uno scarto con la testa. Il martello colpi di striscio la testa e colpì in pieno un orecchio della povera bestia. Penso che le strida si sentissero da Empoli. Il maiale si liberò dalla stretta di mio nonno e si mise a correre per la stanza come impazzito, stridendo al massimo che gli potevano consentire i polmoni fra le urla di noi ragazzi, quelli di mia madre e di mia nonna. Una bolgia dantesca. Mio nonno Beppe cercò di mettere fine a questa sarabanda infernale. Come un torero si mise di fronte al maiale in corsa, cercando di fermarlo prendendolo per gli orecchi . Per tutta risposta il maiale abbassò la testa e gli si infilò fra le gambe. Fu così che mio nonno si trovò a cavalcioni, appoggiato con le mani al culo del maiale che continuava a stridere e a girare per la stanza fra le urla di disperazione di mia nonna Cesira e di mia madre. Nonostante tutto, a me e a mio fratello, nel vedere quella scena di mio nonno, che cavalcava alla rovescia il maiale che strideva a tutta banda, girando per la cantina, ci prese una crisi di riso irrefrenabile e fummo sbattuti fuori senza tanti complimenti. Poi vedemmo uscire mio padre che salì in camera. Ritornò con la carabina da capanno. Rientrò in cantina e si sentì la botta dello sparo. Finirono gli urli e ci fu una quiete irreale. Rientrammo dentro e trovammo il maiale in terra che scalciava appena con un foro in mezzo alla testa da cui sgorgava un po’ di sangue. Mio padre stava togliendo il bossolo della cartuccia dalla canna della carabina. Le donne cominciarono subito a sistemare in cucina. La festa poteva cominciare. La cosa non è che passasse sotto silenzio, ma meno male che non ci furono spiate. Questa era la vita, e purtroppo anche la morte, degli animali del bafòre. Bisogna però dire che gli animali del bafòre, in confronto agli animali che oggi troviamo interi o spezzettati nelle vetrine nei nostri attuali supermercati, per lo meno in vita, vivevano liberi (a parte i maiali). Quelli di adesso vivono in campi di concentramento, in gabbia, senza potersi muovere, imbottiti e alimentati con chissà quali sostanze, con la luce sempre accesa per poter crescere più alla svelta e macellati con sistemi da sterminio di massa. E ora portatemi pure a Norimberga o davanti a qualche altro tribunale, ma così era, se vi pare. Della Storia d’Empoli 54 Capitolo ottavo Il sesso per i ragazzi del bafòre I termini che possono venire adoprati qui di seguito, sono quelli che adopravamo da ragazzi al bafòre. Per favore, non scandalizziamoci. Ormai siamo nel 2012. Maremma come eravamo tonti! Ma tonti, che più tonti non si può, noi, ragazzi del bafòre. D’altra parte nessuno ci spiegava nulla. E quello che si poteva imparare, lo imparavamo “sul campo”. Al bafòre, negli anni ’50, non esisteva assolutamente quella che adesso, pomposamente, viene chiamata educazione sessuale. Per esempio quando nacque “Borisse”, figlio del “Negusse”, (per noi i vari Boris, Jaris, Loris, Negus, ecc. diventavano tutti Borisse, Jarisse, Lorisse, Negusse, ecc.) non chiedemmo a nessuno ne da dove venisse ne come fosse arrivato. Era arrivato e basta. Non si facevano domande del perché e del percome. Per noi lo potevano aver comprato anche in bottega, e lo accettammo come un futuro componente della banda. Chiuso. L’unico componente di sesso femminile della nostra fascia di età, era quella bambina che mi stava accanto. Per la verità i primi approcci con l’altro sesso io li ho avuti quando ero abbastanza piccolo, perché questa bambina, più piccola di me, cercava sempre un qualche cantuccio per farmi vedere la “passerina” mentre voleva vedere e toccare il mio “pimperino”. Mi ricordo che la prima volta ne rimasi alquanto sconcertato. Credevo che glielo avessero tagliato. Poi crescendo e parlando con gli altri più grandi “capii” come era la faccenda. Questa bambina non potendo giocare con i giochi che facevamo noi maschi con fucili e pistole, cercava sempre di giocare a giochi che poteva fare anche lei. Per esempio a nascondino, a “rubabandiera“, a palla prigioniera, ecc.ecc. Qualche volta “ai dottori”. Anche se di malavoglia, quelle volte, la assecondavamo . Una volta che il dottore di turno le aveva prescritto su una ricetta di carta gialla tre supposte, io, come infermiere, andai dal farmacista e le acquistai presentandone la ricetta. Il farmacista mi dette una scatolina del formaggino MIO con tre ghiande dentro. Quando ritornai dalla paziente la feci mettere a “buo punzoni” e gliele rifilai tutte e tre. Una dietro l’altra. Però bagnandole prima, come avevo visto fare a mia madre con la supposta che aveva dato a mio fratello. Il fatto è che a quel tempo i bambini, la cacca, la facevano nel “cantero”, che era un vaso in lamiera smaltata da tenere normalmente sotto al letto. Quando la paziente espletò le sue funzioni corporali, il risultato della cura fu lampante. La paziente, sotto stretto interrogatorio di sua madre, fece i nomi dell’ospedale, del primario, del farmacista e dell’infermiere. Venne fuori un finimondo. Della Storia d’Empoli 55 L’unico che fu condannato incappando in una foresta di ceffoni, fu il sottoscritto. Il primario e il farmacista, invece se la cavarono anche se, a parer mio, furono i maggiori responsabili. Comunque, a parte questo episodio increscioso, questa bambina la accettavamo nei nostri giochi a cui poteva tranquillamente partecipare. Per esempio, e come ho già detto, a nascondino. Guarda caso quando ci nascondevamo, lei faceva sempre in maniera di nascondersi con uno di noi. Una volta nascosti, cominciavano le avances da parte di lei. Mentre per noi la massima preoccupazione era di trovare il momento giusto per andare a far “bomba”, lei cercava di farsi toccare nei suoi anfratti più reconditi. Era una disperazione averla sempre appiccicata. E poi noi avevamo una specie di regola che non si discuteva. Cioè quando ad uno di noi, chiunque fosse, scappava da pisciare, al grido ”MI SCAPPA DA PISCIA’!!!”, in qualsiasi gioco si fosse intenti, si doveva interrompere tutto. Si correva tutti insieme davanti a un muro, uno accanto all’altro, come un plotone di esecuzione, e si orinava. Non sapevamo nulla del detto “Chi non piscia in compagnia o è un ladro o è una spia”. Noi lo mettevamo già in pratica da tempo, pur senza saperlo. Questo in genere veniva fatto contro il muro del forno che dava sulla corte. La bambina di cui sopra, questa cosa si ostinava a farla anche lei insieme a noi. Il risultato era chiaramente disastroso, per gli ovvii motivi. Questa era un’altra ragione del perché si cercava sempre di estrometterla dai nostri giochi. Con questo fatto di pisciare tutti insieme cominciammo a notare anche le differenze fra pisello e pisello. Quelli del nostro capo e di mio fratello, per esempio, essendo più grandi, erano notevolmente più grossi. Noi, come resto della banda, più o meno lo avevamo tutti uguale. C’era solo uno di noi che in cima aveva una specie di velo biancastro e faceva un pò impressione, ma come dimensione rientrava nello standard. Quando eravamo a giocare sull’aia del Fattori e c’era da fare la pisciata comune, spesso questa si trasformava in una gara a chi pisciava più lontano o a chi durava di più. Di fianco alla loggia dove veniva custodito il carro dei buoi e varie attrezzature agricole, c’era un muretto che dava sul pratino che fiancheggiava il cavo della ferrovia di Siena. Questo muretto era molto più in alto del pratino, e spesso ci serviva come base di lancio per scaraventare di sotto polli, gallinelle e paperi per osservare chi volava meglio o chi arrivava più lontano. Quando si faceva la gara della pisciata lunga, non c’era nulla da fare. Vincevano sempre loro, mio fratello o il nostro capo. Poi capimmo anche il perché. Prima di cominciare a pisciare, se lo menavano un po’, gli diventava duro, e a quel punto ci battevano di tre lunghezze. Provammo anche noi. Migliorammo alquanto, ma rimanevamo sempre molto più indietro. La bambina era rigorosamente estromessa da questo tipo di gara per il motivo già detto, ma non disdegnava di assistere. Crescendo, cominciarono a verificarsi cose strane nella nostra banda. Per esempio durante la gara della pisciata lunga, il nostro capo cominciò a dire che voleva sentire la “scossa” e incitava mio fratello a provare anche lui. Della Storia d’Empoli 56 Per sentire questa “scossa” il capo e mio fratello si menavano il pisello di santa ragione fino a che uno urlava: ‐Eccola, eccola ! L’ho sentita! L’ho sentita. Maremma che ”scossa”!‐ ‐ Anch’io,‐faceva mio fratello,‐ l’ho sentita anch’io!‐ Si provava anche noi, più piccoli, a menarseli, fino a farsi diventare i piselli rossi fuoco, ma questa famosa “scossa” non c’era versi di sentirla. Ci volle qualche anno perché cominciassi a sentirla anch’io. Ma ce ne volle e non abitavo più nemmeno al bafòre. Intanto crescevamo. La bambina si fece alcune amiche di scuola e smise di giocare con noi. Ogni tanto durante le nostre escursioni, trovavamo il gruppo di bambine a giro sul prato della ferrovia a cogliere margherite. Ci guardavano ridendo e confabulando fra di loro, ma non ci rendevamo assolutamente conto di cosa avessero da confabulare e di cosa avessero da ridere di noi. Avevo cominciato ad andare a scuola anch’io e, come ho detto da qualche altra parte, frequentavo le elementari dalle suore di Santa Maria, invece delle comunali che erano vicine al circolo “comunista” e che invece aveva già frequentato mio fratello. Venne ad abitare fra la fattoria di Empoli Vecchio e il passaggio a livello, una famiglia che non mi ricordo da dove venisse. In questa famiglia c’era una bambina che diventò amica di quella che mi stava accanto. Si dette il caso che frequentasse anche lei la solita scuola delle suore, se pure una classe inferiore. Sarà stato il fascino della straniera, sarà stato il fatto che frequentasse la solita mia scuola, sarà stato il fatto che ogni tanto venisse a trovare la sua amica accanto a me, il fatto è che io me ne innamorai perdutamente. Me ne innamorai talmente, che un giorno volli esternare visibilmente questo mio amore per lei. Quando si arrivava a scuola, bisognava mettere i nostri cappotti a una rastrelliera attaccata al muro prima di entrare in classe. Io avevo notato che lei portava un cappottino rosso e lo aveva attaccato accanto al mio. E allora che feci? Decisi di mettergli in una delle tasche quanto di più prezioso avevo nelle mie. Un’automobilina blu che invece delle ruote, nella parte inferiore,aveva una sfera. Quando si spingeva andava lontanissima, anche se la macchina si metteva di fianco o addirittura a marcia indietro. L’avevo trovata come sorpresa in una scatola di formaggini MIO. Il risultato fu che io persi la macchinina, e lei non seppe mai chi le avesse messo quell’automobilina nella tasca del cappotto. Fine di un amore. Tra l’altro anche se lo avesse saputo e mi avesse concesso il favore di dichiararmi ufficialmente come possibile fidanzato, non avrei saputo assolutamente e minimamente come e cosa fare. In quel tempo cominciai a sentire anche parole strane dai giovanotti più grandi e di cui non ne conoscevo assolutamente il significato. O meglio, il significato lo sapevo, ma non propriamente quello giusto o per lo meno quello che gli veniva attribuito. Della Storia d’Empoli 57 Per esempio una volta sentii dire in un crocchio di giovanotti, che sghignazzavano al casello del bafòre, che era stata vista una certa Tizia nella fossa del campo di “Chiodo” a “trombare” con un certo Caio. Io questo fatto del trombare non è che mi risultasse tanto chiaro. Il trombare mi riportava alla banda che seguiva il baldacchino durante le processioni delle feste solenni che si svolgevano alla chiesa di Santa Maria, accompagnando i cori di “Noi vogliam Dio”, “ T’adoriam Ostia Divina” o “Siamo arditi della fede” che la gente in processione cantava a squarciagola. I musicanti avevano trombe, tromboni, clarini, tamburi e grancassa e per me era chiaro che quelli che avevano i tamburi tamburavano, quelli con i tromboni trombonavano e quelli con le trombe, trombavano. Dal racconto di quei giovanotti, mi figurai che quella Tizia imparasse a suonare la tromba da Caio. Il perché ridessero e sghignazzassero riuscivo a capirlo. Dato che tutti i musicanti della processione erano tutti uomini, vedere una ragazza suonare la tromba in processione, sarebbe stata una cosa veramente ridicola. Quello che non riuscivo a capire, era il perché prendesse lezioni proprio nella fossa del campo di Chiodo. Lo stesso dubbio mi venne quando nel cercare canne per fare lance, in un canneto, trovammo una specie di covile fatto con le foglie di canna. Mio fratello si rivolse al nostro capo: ‐ Qui ci devono essere stati a trombare‐, disse. Anche lì! Boh! Per me era proprio incomprensibile. Ci fu anche un altro termine che mi mise in estrema confusione, quando una domenica, sempre al casello di Leone, sentii i soliti giovanotti che domandavano dove fosse un compagno che non era con loro. ‐ E’ a chiavare in casino‐ rispose uno. Questa risposta mi mandò in crisi. Che ci faceva quello lì al casino, che tra l’altro non era neanche casa sua, ad aprire e chiudere le porte a chiave? Per spiegare da dove nasceva questa mia confusione e bene che metta in chiaro la situazione. Prima di tutto, “il casino”, per noi del bafòre, era, ed è, una costruzione dove abitavano diverse famiglie. Questa costruzione era, ed è, sulla 67 a due o trecento metri dalla fattoria di Empoli Vecchio dopo il passaggio a livello. Diversi anni fa il comune di Empoli ne aveva messo anche un cartello, blu, su di una parete, in alto, per indicarne la località. Però, eufemisticamente, avevano scritto “Le casine”. Macchè casine e casine! Quello era ed era sempre stato “il casino”. Da secoli. Infatti dopo un po’ lo tolsero. Si vede che si erano accorti dell’errore madornale che avevano fatto. Il fatto del chiavare, poi mi riportava a mio nonno Beppe. Perché? Perché mio nonno Beppe aveva una vigna vicino al Ponte alla Stella e, insieme a mio padre, aveva costruito una capanna per gli attrezzi. Della Storia d’Empoli 58 Era una capanna in cui le colonne portanti erano state ricavate da traversine di legno della ferrovia, mentre le pareti erano fatte di canne intrecciate. Mio nonno aveva aggiunto una porta sgangherata a cui aveva applicato una toppa con una serratura alquanto rugginosa che apriva e chiudeva con una chiave enorme. Tutte le volte che entrava o usciva da questa capanna, e lo faceva spesso, tirava fuori questa chiave. Chiudeva se usciva, o apriva se entrava. Tutte le volte. Per quale ragione chiudesse a chiave, non lo so. Chiunque con un paio di forbici da pota poteva aprire un varco nelle pareti di canna. Ma anche soltanto con una spallata avrebbe potuto entrare attraverso le pareti. Per me mio nonno, facendo tutte quelle operazioni di apri e chiudi, faceva un gran chiavare. Ritornando a quel tal giovanotto, che aveva da chiavare al casino? Boh! Non riuscivo proprio a spiegarmelo. Crescendo, riguardo al trombare, cominciai a sentire cose anche più strane. Al casello ferroviario, oltre che Leone e poi Natale, facevano servizio anche altri casellanti che davano il cambio ai titolari. Questi nuovi venivano da fuori. Ne capitò uno che mi pare fosse della Rotta. Era un giovanotto moro con gli occhi verdi e abbastanza giovane. Al “casino” abitavano tre sorelle una più belloccia dell’altra. La minore, che avrà avuto 16 o 17 anni, portava una unica treccia di capelli neri, lunga, che le arrivava fino alla vita. Spesso sormontata da un fiocco vicino alla testa. Com’è come non è, cominciammo a vedere sempre più frequentemente questa ragazza che arrivava al casello in bicicletta. Guarda caso, sempre quando c’era quello della Rotta. ‐ Per me quello la tromba‐, fu il commento del nostro capo rivolgendosi a mio fratello. A questo punto non capii proprio più nulla. Che voleva dire ‘ la tromba’ rivolgendosi a una ragazza? Il fatto di trombare, nel senso di suonare la tromba, mi andava anche bene ma il fatto di trombare qualcuno che voleva dire? Chiesi spiegazioni a mio fratello, e per tutta risposta mi beccai uno scappellotto e un: ‐ Chetati, che tu se’ piccino‐. E rimasi nel dubbio. Siccome ne sentivo parlare sempre più spesso, e mi ero accorto che questo fatto implicava sempre un maschio e una femmina, decisi di togliermi questo dubbio. Un giorno che mi capitò a tiro la bambina che mi stava accanto, le sparai a bruciapelo: ‐ Si va insieme in una fossa a trombare?‐ Non l’avessi mai detto! ‐ Ora lo dico a tuo fratello!‐ Mi rispose ridendo, ‐Glielo dico subito subito, guarda sta arrivando‐. In quel mentre stava arrivando davvero mio fratello, e io capii immediatamente che quello che avevo detto doveva essere una cosa alquanto sconveniente. Quella brutta spiona gli corse incontro. Il fatto che avessi detto una cosa che non si doveva dire e di cui non conoscevo il significato, mi fece andare in bestia. Della Storia d’Empoli 59 ‐Non glielo dire!‐ urlai e intanto raccattai da terra un bussolo vuoto che era nei dintorni e lo scagliai verso la spiona, purtroppo senza prenderla. Continuai a raccattare sassi per tirarli a tutti e due e li misi in fuga. Ero arrabbiato nero. Da lì cominciai a capire che non era tanto il caso di parlare di trombare o di trombate. Intanto a scuola, per lo meno dalle suore, si studiava catechismo. Mi ricordo che nelle prime classi si imparavano a memoria sia le domande che le risposte. Poi a lezione, la suora maestra ci faceva la domanda e noi, tutti in coro, si rispondeva a cantilena. Tipo giaculatoria. Per esempio: ‐ Chi ci ha creato?‐ E noi tutti in coro: ‐ Ci ha creato Dio‐ La suora : ‐Chi è Dio?‐ E noi tutti in coro: ‐Dio è l’Essere perfettissimo, Creatore e Signore del cielo e della terra.‐ E così via di questo passo. Queste giaculatorie le imparavamo a pappagallo, forse senza sapere neppure quello che si diceva. Infatti quando arrivammo in quinta e ci dovevamo preparare per la prima comunione, oltre che il catechismo a scuola, bisognava andare anche a dottrina. Tra l’altro non so che differenza ci poteva essere fra catechismo e dottrina, a parte il fatto che la dottrina ci rubava il tempo per andare a volare gli aquiloni o per giocare ai banditi. Cominciammo a studiare cose parecchio più complesse. Per esempio differenza fra peccati veniali e peccati mortali, differenza fra limbo, purgatorio,inferno e paradiso, virtù cardinali e virtù teologali, vizi capitali, comandamenti, sacramenti ecc. ecc. Un macello. Quando non si capiva qualcosa e si chiedevano spiegazioni, la suora a volte ci rispondeva con risposte sibilline che ci mettevano ancora più dubbi di prima. Per esempio, sulla lussuria, vizio capitale, ci veniva detto che era il peccato mortale di fare atti peccaminosi. Era come dire che era peccato fare peccato. Per me era un rompicapo. Come pure l’accidia. Ma che era quest’accidia? Poi, siccome nessuno mi spiegava esaurientemente in cosa consistessero, mi feci un’idea per conto mio di questo tipo di peccati. Siccome ci avevano raccontato la parabola che era più facile che un cammello passasse dalla cruna di un ago che il ricco potesse entrare nel regno dei cieli, io mi immaginai che chi era ricco viveva nel lusso perciò doveva peccare di lussuria. Per l’accidia sicuramente doveva essere il peccato di mandare gli accidenti, tantoché smisi di mandarli ai miei compagni. Salvo in casi estremi. Una volta venne a far visita a mia madre una signora di Ponte a Elsa, non so se parente, coperta di collane e braccialetti d’oro. Quando andò via, innocentemente, dissi a mia madre: Della Storia d’Empoli 60 ‐Quella donna era piena di lussuria‐, intendendo chiaramente che era piena di cose di lusso. Mia madre si girò di scatto con la faccia cattiva e mi aggredì: ‐ Non ti azzardare mai più e mai poi a dire una cosa simile, perché se no ti do un ceffone che ti fo girare la testa da quell’altra parte‐. A questo punto capii che il peccato di lussuria doveva essere proprio tremendo. Non si poteva neanche rammentarlo. Come il Dio invano. Ci avvicinammo al momento della Prima Comunione e il giorno antecedente bisognava stare in ritiro. Inoltre bisognava prepararsi alla confessione. La suora ci informò sui peccati che bisognava confessare e cioè: disobbedienze, marachelle, arrabbiature dei genitori, digiuni non osservati, ecc. ecc. Dopodiché il padre curato ci avrebbe dato la penitenza da scontare. Mi sentii sollevato, perché di questi peccati ne avevo da confessare quanti ne volevo e ne potevo aggiungere anche altri. Però la cosa di cui ero più timoroso, era la penitenza da scontare. Quando finalmente toccò a me, dopo che mi ero inginocchiato nel confessionale, snocciolai tutte le mie nefandezze a padre Diodato. E cominciai. Avevo tolto la sedia a mia nonna Cesira mentre si metteva a sedere ed era caduta con il culo per terra, avevo randellato le forbici a mio fratello che si erano conficcate nella porta dietro alla quale si era rifugiato, avevo mangiato due cantuccini di nascosto, ecc. ecc. Poi, per concludere, pensando di far bella figura, gli dissi che avevo peccato anche di accidia. ‐Eh? Che?‐, fece padre Diodato. ‐Ho detto tre accidentatté a un mio compagno‐ Dalla grata mi parve che padre Diodato si mettesse a ridere, ma forse era un’impressione. Poi mi disse: ‐ Hai commesso atti impuri?‐ Porca miseria, questa non me l’aspettavo! La suora non ce ne aveva mai parlato di questi atti. L’unico atto di cui ero a conoscenza era l’atto di dolore che ci avevo messo un sacco di tempo a impararlo a memoria. O cos’ era quest’atto impuro? Cominciai a pensare vorticosamente fino a che mi venne in mente che mi ero sporcato le mani nella concimaia a cercare lombrichi per mio padre da usare come esca. Non solo, ma me l’ero anche sporcate nel pulirmi il culo, perché mi si era sfondato il giornale che allora si adoprava come carta igienica. Più atti impuri di così! Non ne avrei potuto trovare di peggiori. ‐ Si‐, risposi trionfante. ‐Tre Padre Nostri, tre Ave Marie e tre Gloria Patri. Dimmi l’atto di dolore‐, fu la sentenza. Recitai tutto d’un fiato, mi benedì e mi disse: ‐Vai!‐ O che penitenza era questa? Io ero abituato a ceffoni e scappellotti. Quelle si che erano penitenze! Ma questa era una barzelletta in confronto! Ebbi modo in seguito di sperimentare che, qualsiasi nefandezza avessi potuto confessare, Padre Diodato Prestini mi dava sempre tre Padre Nostri, tre Ave Marie e tre Gloria Patri. Della Storia d’Empoli 61 Se gli avessi detto che avevo dato fuoco a mia nonna Cesira e l’avessi buttata dalla finestra, lui mi avrebbe detto: ‐Tre Padre nostri, tre Ave Marie e tre Gloria Patri. Dimmi l’atto di dolore.‐ Per forza gli hanno intitolato una strada a Santa Maria a Ripa! Comunque nonostante le mie confessioni, andò a finire che la Prima Comunione me la fece fare lo stesso. Anzi mi scelse per leggere la preghiera comune di fronte all’altare, per tutti i bambini e bambine che passavano a comunione quel giorno. Nel 1954. Diceva che sapevo leggere meglio di tutti. Però, quegli atti impuri, prima di capire che cavolo fossero, mi ce ne volle. Eh, se mi ce ne volle! Della Storia d’Empoli ... mi scelse per leggere la preghiera comune 62 Epilogo Nell’ottobre del 1955 la “banda” del bafòre era già mezza sparita. Mio fratello aveva già 15 anni ed era entrato a lavorare come apprezzato tipografo alla tipografia Caparrini di Empoli. Il nostro capo, di 14, lavorava già come apprendista tornitore in una officina di precisione. Sempre in Empoli. Io avevo cominciato a frequentare le scuole medie “Renato Fucini” ad Empoli, e stavo già combattendo con il “rosa, rosae…” della prima declinazione di latino. Gli altri erano tutti più o meno nelle mie condizioni. I giochi di gruppo si facevano sempre più radi. Poi, quasi alla fine di quell’ottobre, in una bruttissima domenica piena di sole, avvenne la tragedia. Era quasi l’ora di pranzo. Io avevo preso la sedia piccola che adoprava mia nonna Cesira per sferruzzare la sua calza, e mi ero messo sul marciapiede con la spalliera al muro, con le gambe anteriori della sedia sollevate e mi stavo leggendo l’ultimo numero del “Vittorioso”. Dalla porta aperta sulla strada, si diffondeva il profumo della “nana” in umido. Sicuramente come primo ci sarebbe stata la famosa “pastasciutta e nana”di mia madre. Sentii arrivare Bianca che piagnucolava: ‐ O Madonnina! O Madonnina che è successo! O Madonnina Madonnina!‐ Veniva di corsa, tutta trafelata, con il viso coperto di lacrime, sulla 67,dalla direzione del Ponte alla Stella, con le mani nei capelli. Entrò in casa mia senza neanche guardarmi dicendo piano: ‐ Oh Flora! Oh Flora!‐ Sentii un urlo di mia madre accompagnato da un rovinio di pentole che cadevano per terra. Le vidi uscire ambedue, con mia madre che urlava correndo, e Bianca che cercava di trattenerla. Tutti gli abitanti del bafòre uscirono fuori, sulla strada, facendo crocchio domandandosi che poteva essere successo. Si venne a sapere che avevano investito mio fratello Franco al Ponte alla Stella e che era stato portato all’ospedale di Empoli con una macchina di passaggio. Tornava da una battuta di caccia al capanno insieme a mio nonno Beppe. La macchina aveva scansato mio nonno e aveva preso in pieno mio fratello scaraventandolo nel campo sottostante. Mi ricordo che la domenica sera mi portarono all’ospedale a fargli visita. Dormiva profondamente con mia madre accanto al letto da cui non si staccò mai. Il dottor Mancini lo aveva operato alla milza, ma si era riservato la prognosi. Il lunedì non andai a scuola e la sera sembrò che mio fratello se la potesse cavare. La mattina del martedì verso le nove, mentre ero a giocherellare sulla corte, vidi arrivare a tutta velocità la Topolino giardinetta di mio zio Emilio che fece inversione proprio sulla corte. Vidi mia madre all’interno che piangeva disperata. Capii immediatamente della tragedia che si era abbattuta sulla nostra famiglia. Della Storia d’Empoli 63 Corsi verso casa, ma fui preso al volo da mio zio Nello, quello di El Alamein e di Tobruk, che nel frattempo era arrivato insieme mio padre. Mi ricordo che salirono le scale di corsa, mio zio con me in collo e mio padre dietro, in un urlio generale ed entrarono nella camera dove dormivamo io e mio fratello. Chiusero la porta e mio zio mi gettò sul letto. Aveva il viso rigato di lacrime e mormorava qualcosa che non capivo. Poi fece una cosa che non potrò mai dimenticare. Prese il Crocifisso che mi era stato regalato dal padre curato per la mia prima comunione e che tenevamo sul comodino fra i due lettini per le preghiere serali, e lo scaraventò per terra. Andò in mille pezzi. Poi uscì singhiozzando, mentre mio padre mi stringeva e mi abbracciava bagnandomi di lacrime. Poco dopo, non mi ricordo chi fu, qualcuno mi riprese in collo e mi portò via. Passando davanti alla porta aperta della camera di mia madre e di mio padre vidi, disteso sul letto e immobile, mio fratello con gli occhi semichiusi. Quella fu l’ultima volta che lo vidi. Mi portarono dai miei nonni a Cortenova e seppi che ci fu un funerale a cui partecipò quasi tutta Santa Maria e quasi tutto il Ponte a Elsa. I giorni seguenti furono veramente da disperazione. Mia madre guardava fissa nel vuoto. Non mi guardava più nemmeno, e se non avessi avuto mia nonna Cesira che mi accudiva, non mi avrebbe dato neppure i vestiti. Appena poteva andava al cimitero di Santa Maria e ci passava le giornate. Quello che era peggio, quando doveva apparecchiare la tavola per il pranzo, apparecchiava come un automa come aveva fatto sempre. Quando si accorgeva che eravamo in cinque, invece che in sei e doveva togliere un piatto e una scodella, ricominciava a piangere a vita tagliata, e si rifugiava in camera. E tutti a piangere. Non facevamo più vita. Finché un giorno mio zio Nello venne da mio padre e gli disse: ‐ Portala via da qui. Dai retta a me, vendete tutto e cambiate ambiente. Qui Flora è legata a troppi ricordi. Se la smuovi e la porti in un altro ambiente ci sta che in qualche maniera si riprenda. Qui rischia di andare al manicomio.‐ Fu così che la casa del “bafòre” fu venduta e comprata una casa vicino ad Empoli. Tornammo nel prolungamento della già esistente Via Piave, fra Santa Maria ed Empoli. Si chiamava Via Piave anche quella dove tornammo noi, ma a quel tempo era una “strada” chiusa e privata. Chiamarla strada era difficile, perché a quel tempo più che una strada era un campo pieno di erbacce con due viottole una a destra e una a sinistra. Quando pioveva era un vero pantano. C’erano delle buche che sembravano trincee. Mi ricordo che ogni proprietario, davanti alla propria casa, si ingegnava a portare ghiaia per limitare il fango e cercare di spianarla. Ma era una lotta impari. Via Piave ingoiava tonnellate e tonnellate di ghiaia come se fossero noccioline. Però avevamo un “bagno”, con la vasca, anche se ancora non c’era l’allacciamento idrico che venne di lì a poco. Della Storia d’Empoli 64 Mia nonna per diverso tempo, continuò, portandomi dietro, ad andare a far visita al bafòre dove eravamo accolti con calore da tutti gli ex vicini. Si aggirava poi, per le stanze vuote di quella che era stata la nostra casa che non era ancora abitata, rincorrendo chissà quali ricordi. Ma ormai, col bafòre, era tutto finito. Mia madre, in compenso, si riprese, pur continuando ad andare al cimitero tutte le domeniche. In via Piave trovai diversi ragazzi più o meno della mia età. Completamente diversi però da quelli del “bafòre”. Non costruivano aquiloni, meno che mai strombole, archi, frecce, o quant’altro. La pesca dei ranocchi non sapevano nemmeno che fosse e figuriamoci la pesca con le ture. Il carburo poi! Questi giocavano a pallone. E con il pallone di cuoio. Sapevano di terzini, di centrattacchi, di ali, di rigori e di fuori gioco. Io non sapevo neppure cos’era un terzino o un fuori gioco! L’unico pallone che adopravamo noi del bafòre, era quello che, non sempre, ci veniva regalato una volta all’anno. Infatti, quando ammazzavano il maiale, qualche volta ci veniva concessa la vescica del maiale che normalmente veniva usata per metterci il lardo da adoprare in cucina. Quando la davano a noi, dopo averla “disinfettata” con l’aceto, si gonfiava a bocca si legava il “cannello” e poi si prendeva a pedate finché durava. Quando scoppiava, si aspettava l’anno dopo. Se no, palle di stracci. Inoltre, in via Piave, quasi tutti portavano i pantaloni lunghi. E le scarpe, anche d’estate. E così mi adattai anch’io alla vita “cittadina”. Il bafòre piano, piano sparì dalle mie abitudini. Sarà stato per lo chock subito o per il cambiamento di ambiente, a scuola non è che andassi un granché bene. Inoltre ero continuamente affascinato dagli aeroplani e dal fenomeno del volo. Non riuscivo a capire come un oggetto si potesse sostentare in un mezzo così leggero come l’aria. Poi conobbi la bottega del “Balilla”e gli aeromodelli. E mi gettai a testa bassa nella costruzione di questi “giocattoli”. Cominciai a capire il perché e il percome si potesse volare. E non fui contento finché, in seguito, non andai a studiare aerotecnica e costruzioni aeronautiche. Tutte le volte che passava un aereo, mi mettevo a naso in su, a guardarlo finché non lo perdevo di vista. Mia nonna Cesira, sorda, allora, mentre spazzava, mi diceva: ‐ Che è passato un aeroplano?‐ Al mio cenno di assenso con la testa, mi rispondeva: ‐ E’ passato un aeroplano? Tu avessi ‘n culo che ho ‘n mano. Bah, ho una grenata!‐ Cercando con questo di dissuadermi dalla mia mania. Ma non c’è mai riuscita. Comunque questo fatto di voltare gli occhi al cielo ogni volta che passa qualsiasi cosa che voli, non mi è ancora passata. Che passi un aereo da turismo, un deltaplano, un elicottero, la scia di un Jet o anche un semplice gabbiano, non posso fare a meno di guardare in su, verso il cielo. Se c’è mio figlio Claudio nei dintorni, ricordandosi di quanto gli avevo raccontato di quello che mi diceva mia nonna, mi fa: ‐Che è passato un aeroplano?‐ Al mio cenno di sì con la testa, allora mi risponde: ‐ E’ passato un aeroplano? Tu avessi ‘n culo che ho ‘n mano!‐ Ma lui non è che abbia una grenata. E io lo rincorro. Della Storia d’Empoli 65 Della Storia d’Empoli 66 Della Storia d’Empoli Franco, mio fratello 67 Della Storia d’Empoli Fine 68
Scarica