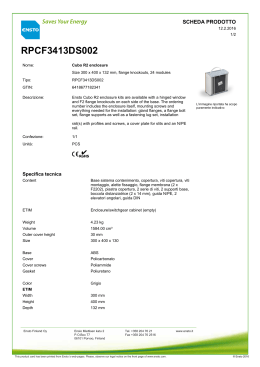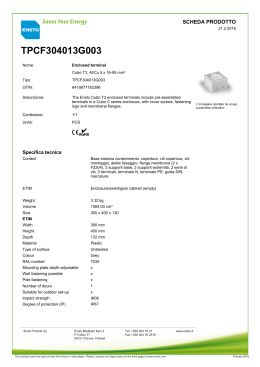DAVID BOLLIER LA RINASCITA DEI COMMONS Prefazione di Ugo Mattei Traduzione di Bernardo Parrella David Bollier si occupa delle questioni legate ai beni comuni fin dagli anni novanta in qualità di aut ore, studioso, consulente, attivista internazionale e blogger. Ha scritto o curato dodici volumi (alcuni insieme ad alt ri autori), compresi i seguenti dedicati specificamente alle tematiche dei beni comuni: Silent Theft, Brand Name Bullies, Viral Spiral, The Wealth of the Commons, Green Governance e questo Think Like a Commoner, l’unico tradotto in italiano. Nel 2012 ha ricevuto il Berlin Prize in Public Policy, assegnatogli dalla American Academy di Berlin per il costante impegno a favore dei beni comuni. Nel 2002 è stato tra i fondatori di Public Knowledge, ente non-profit di Washington a sostegno dell’interesse pubblico nelle politiche su internet, telecomunicazioni e diritto d’autore. Dopo aver lanciato e curato il sito web Onthecommons.org (2003-2010), ha co-fondato il Commons Strategies Group, un progetto di consulenze parte del movimento globale dei beni comuni, e continua a lavorare su una varietà di iniziative a livello nazionale e internazionale. Vive ad Amherst, in M assachusetts (Usa) e c ontinua ad agg iornare il suo blog su bollier.org. Prefazione 3 Accolgo con grande piacere l’invito rivoltomi da David Bollier a scrivere qualche riga di prefazione all’edizione italiana di Think Like a Commoner, meritevolmente e assai ben tradotta da Bernardo Parrella. Conosco Bollier da diversi anni. Il contatto fr a noi era stato generato dal comune amico e compagno Ralph Nader, con cui David iniziò la propria attività di militante (me glio “attivista”, per utilizzare la locuzione che in ing lese indica chi fa polit ica di mov imento) come g iovanissimo “Nader Raider” ai te mpi delle le ggendarie campagne per i dir itti dei consumatori. Sembra chiaro che proprio questa storia ha reso Bollier (e direi lo stesso Ralph) particolarmente sensibile alla tematica dei beni comuni. Infatti i commons certamente sono stati, nel corso degli ultimi tre secoli, vittimizzati in generale dal capitalismo; essi tuttavia nell’ultimo quarto di secolo sono riemersi proprio in polemica con quella particolare forma di capitalismo neoliberale, il cosiddetto “corporate capitalism”, il cui pernicioso effetto politico sulla stessa ag ibilità ecologica, civile e democratica del modello di sviluppo dominante i Raiders (ma ancor pr ima l’Eisenhower del discorso di addio sul compless o militare industriale) denunciarono con largo anticipo. Bollier è abituato a un siste ma politico in cui la corporation soggioga il pubblico, ed è quindi molto me no ingenuo di alt ri nell’esser consapevole che oggi il potere va sconfitto principalmente nella sua manifestazione “corporate”. Già il titolo e il sottotitolo inglesi, A Short Introduction to the Life of The Commons, dimostrano ben chiaramente come questo impor tante libretto si collochi alla fr ontiera di quel be nicomunismo rivoluzionario che non si limita a vag heggiare qualche r iforma, fosse pure legislativa, 4 per tutelare i beni comuni rispetto alla privatizzazione selvaggia, ma che invoca invece una vera trasformazione paradigmatica (si veda: M attei, Il benicomunismo e i suoi nemici , Einaudi 2015). Della divulgazione di una tale visione, che poi coincide con una necessaria alfabetizzazione ecologica e civile delle masse, si sente quanto mai il bis ogno soprattutto in Italia oggi, dove sembra che si sia r ealizzata una vera e propria assuefazione alla sospensione democratica costituente, con uno scollamento radicale fra il superpotere degli esecutivi post-berlusconiani e la legittimazione elettorale. Gli è che, in conseguenza del successo dei referendum per l’acqua bene comune e contro il nucleare della primavera 2011, e anche, sul piano teorico, dell’impatto del terzo volume della trilogia di Hardt e Negri (Comune. Oltre il privato e il pubblic o, Rizzoli 2010) e del mio Beni comuni. Un Manifesto (Laterza 2012), si è verificato un paradossale fenomeno. Da un lato, infatti la nozione di beni comuni ha assunto rilevanza politica come unica parola d’ordine messa all’ordine del giorno dalla visione critica del neoliberismo. Essa è stata utilizzata per caratterizzare molte e diversissime battaglie, dal lavoro, alla scuola, alla cultura, all’università, al territorio, alla resistenza contro le grandi opere, che sembravano aver finalmente trovato un collante polit ico capace di s ovvertire il triste stato delle cos e imposto dall’ austerità. Tuttavia tale success o ha prodotto una radicale restaurazione. Non soltanto alla vocazione cost ituente dei beni comuni (fatta di r otture della legalità formale in soddisfazione diretta di bisogni fondamentali della generazione presente e di quelle future), si è cont rapposto l’arrogante pugno sul tavolo delle contro-riforme costituzionali (si veda: M attei, Controriforme, Einaudi 2013). Sul fronte teorico, per di più, l’indisponibilità di cogliere appieno la crisi terminale del costituzionalismo liberale e dello squilibrio da esso prodotto, ha generato una piattaforma di lavoro sui beni comuni non di rado titubante, difensiva e minimalista (si vedano, per esempio: Pennacchi, Filosofia dei beni comuni, Donzelli 2012, e in parte lo stesso Rodotà nella nuova prefazione a Terribile Diritto, Il Mulino 2013), quando non direttamente uno sguaiato inno alla restaurazione borghese da parte di 5 certa letteratura non degna di rispetto scientifico nonostante il blas one editoriale. Tutto ciò, accompagnato dalle difficoltà di t radurre in azione polit ica un esito referendario che andava ben oltre la ve tusta contrapposizione fra destra e sinistra, ha prodotto la devastante deriva di illegalità costituzionale che stiamo vivendo e un tunnel polit ico-culturale in fondo al quale non si scorge ancora alcuna luce. È tuttavia necessario non cadere nello sconforto prodotto da una v isione troppo locale della polit ica. Il contributo della nostra cultura giuridica e politica in materia di beni comuni ha contaminato l’esper ienza internazionale. Perfino in F rancia due filosofi del calibro di Dardot e Laval, il cui cor poso volume sul Comune è stato r ecentemente tradotto da Derive e Approdi, danno pieno credito all’elaborazione benicomunista italiana e il lettore competente di questo volumetto avrà modo di verificare quanto del pensiero di casa nostra sia presente e riconosciuto (anche se non sempre adeguatamente citato) nelle pagine del nostro. Se poi dal livello teorico scendiamo a quello pratico (e qui dissento da Bollier quando dice che la pratica fa più male al nemico di quanto non facc ia la teoria!), le lotte eur opee per i be ni comuni sono assai vive oggi in Spagna, Grecia, Balcani e in molt i altri luoghi ancora, sovente grazie alla capacità (da noi del tutto fin qui assente) di ibridare la leadership politica più aperta per scavalcare le gabbie teoriche novecentesche (non soltanto Podemos in Spagna prova a superare la cont rapposizione destra-sinistra ma alt rettanto ha fatto Tzipras scegliendo la destra sociale come partner di governo rispetto alla sinistra moderata, perbenista e corrotta dei salotti borghesi che la Troika avrebbe voluto imporgli). Infine, sempre sul piano pratico, in Italia si è cominciato un lavoro di ripensamento degli apparati amministrativi volto a fa vorire la partecipazione diretta e a sper imentare concreti momenti di sussidiarietà che, qualora capaci di adeguato radicalismo e coraggio, possono vedersi come un importante contributo alla ist ituzione costituente dei beni comuni. Un rilancio della questione dei beni comuni potrebbe far ripartire il nostro cammino più presto di quanto i nostri detrattori sospettino. È dun- 6 que molto importante che la riflessione teorica, la pratica costituente e la divulgazione non si ar restino neppure a casa nost ra nonostante le difficoltà contingenti. Questo volumetto di Bollier, come prima ancora la ricca antologia The Wealth of The Commons, da lui curata insieme a Silke Helfrich, dimostra un’attenzione del nostro per il dato stor ico benicomunista davvero encomiabile. La sua analisi è teor eticamente sofisticata, perché ha pienamente interiorizzato un’autentica fenomenologia del comune, capace di rompere con og ni traccia di posit ivismo. Essa si mant iene ancorata saldamente all’immanente, grazie a una piena conoscenza delle lotte sociali internazionali che declinano in pr atica i beni comuni. Da giurista e attivista Bollier intuisce l’importanza del dato giuridico che spesso invoca, pur se ancora non articola una piattaforma alternativa alle istituzioni della modernità borghese. Anche da questo punto di v ista il testo dimostra attenzione alle innovazioni giuridico-istituzionali più avanzate che il mov imento per i be ni comuni ha ar ticolato. E si s offerma sul Teatro Valle, un’esperienza che ha profondamente colpito Bollier, il quale ne ha più volte par lato anche sul suo popolar issimo blog. Egli aveva dato una mano, nel lug lio del 2014, al te ntativo internazionale di far tornare un br iciolo di r agione nelle me nti dei governanti romani che hanno preferito tuttavia sacrificare un’esperienza artistica riconosciuta e premiata in tutta Europa al triste feticcio della legalità. Insomma, la pubblicazione di B ollier, proprio perché semplice e capace di parlare al cuore di ogni lettore indipendentemente dalla sua ideologia di dest ra o di sinist ra, costituisce un importante tassello nella r ipresa di quel lavorio di alfabetizzazione benicomunista che, come lo stesso autore indica nel suo ult imo capitolo, costituisce condizione necessaria e forse pure sufficiente per il necessario cambio di paradigma. Per concludere e lasciare al le ttore il piacere di immergersi in questa bella traduzione (sebbene discutibile sia qualche tono di eccessivo ott imismo e pur e una cer ta fede in t rasformazioni spontanee che diffic ilmente possono generarsi in rete in mancanza di qualche s erio sforzo di organizzazione politica) vale ancora la pena di sottolineare come, nella ricca pubblicistica sui beni comuni in Italia, l’uscita del presente volume di Bollier e di quello g ià ricordato di Dardot e Laval, possa fare di questo 2015 un anno impor tante perché il benicomunismo possa riconquistare un po’ di terreno teorico ai suoi troppi e non sempre consapevoli nemici. 7 Ugo Mattei, maggio 2015 Introduzione 8 Quando la donna c he mi sede va di fianco in aereo si g irò per chiedermi a bruciapelo: «Salve, di cosa si occupa di bello nella v ita?», risposi subito che mi occupavo delle questioni relative ai commons ed ero un attivista a tutela dei beni comuni. Educato momento d’imbarazzo. «Cos’è che fa?!». Non era la prima volta che mi capitava. Così buttai lì qualche riferimento familiare per la cultura anglosassone – il Boston Common e i pascoli in comune dell’epoca medievale – per poi menzionare la cosiddetta “tragedia dei beni comuni”, il meme che ha slavato il cervello a un’intera generazione di laureandi nord-americani. Percependo un fr emito d’interesse, decisi di spinger mi oltre, iniziando a parlare del software open source, di Wikipedia e delle licenze Creative Commons. A rischio di sopraffare la mia forzata c ompagna di v iaggio, presi a elencar e una ser ie di beni c omuni che raramente vengono considerati tali: la vastità dei t erritori pubblici c he racchiudono foreste e minerali, lo spettro delle frequenze usate gratuitamente dalle emitt enti TV, gli spazi ur bani, il genoma umano . Proseguii citando le stupende fest e popolari della mia città natale, la “economia del dono” alla base dei sist emi di donazione del sangue e la condivisione del linguaggio stesso – una risorsa libera e disponibile di tutti, ma le cui lett ere e parole vanno r apidamente diventando marchi proprietari. E poi ci sono i t erreni agricoli e le z one pescose, ambiti gestiti in comune da circa due miliardi di persone in ogni parte del mondo per il loro fabbisogno quotidiano. A quel punto prevedevo che la mia nuova amica tornasse al suo libro oppure a osser vare dal finest rino le n uvole a pec orelle sopra le 9 Grandi Pianure nord-americane. Invece la v idi illuminarsi. «Ah, ho capito! I beni comuni sono quei beni che non appartengono a nessuno e vengono condivisi da tutti». Ben detto. Proseguì dicendo che il parco dove porta a spasso il cane e si fer ma a chiacchierare con qualche sconosciuto è un bene comune, come pure la mailing list online sull’educazione dei fig li a cui er a iscritta. Per poi aggiungere all’elenco un lag hetto assai frequentato non lontano da casa sua e la piazza del c entro città in cui si t enevano eventi pubblici. Nei paesi industrializzati del mondo moder no, quello dei beni c omuni tende a esser e un c oncetto sfuggente e alieno. Il t ermine può suggerire allusioni pseudo-aristocratiche di un tempo passato, ma altrimenti non riveste grande valore in quanto tale. Ci manca la terminologia adatta per parlare dei beni comuni in maniera concreta, e così questi restano qualcosa d’invisibile e di scontato: non è una categoria culturale con cui abbiamo familiarità. Generalmente le cose di un certo valore vengono associate con il “libero mercato” oppure con l’amministrazione pubblica. L’idea per cui qualcuno r iesca ad autoorganizzare situazioni per manenti per gestire le r isorse locali, e c he questo paradigma di autogestione sociale possa gener are a sua v olta un valore enorme – be’, appare spesso come qualcosa di utopico oppure di comunardo, o quantomeno poco pratico. Appare ridicolo anche solo pensare che i beni c omuni possano rivelarsi un veicolo per l’emancipazione politica e c ollettiva e per la t rasformazione sociale, come sostengono invece i sostenitori del movimento a favore dei beni comuni. Ecco perché questo libro si propone innanzitutto di dissipare con gentilezza simili pregiudizi, offrendo al contempo una breve introduzione al mondo dei beni comuni. Dopo aver toccato con mano la confusione esistente da anni in quest o campo e l’impossibilità per il lettore comune di accedere alla ricca letteratura sul tema, oltre al fatto che i progetti basati sulle risorse condivise appaiono scarsi, ignorati o 10 fraintesi – ho deciso che fosse giunta l’ora di offrire una sintesi comprensibile sull’intera questione. Mi piace immaginare che il lettore ideale sia seduto di fianco a me durante un breve viaggio in aereo. Qualcuno forse c ome te che stai leggendo queste pagine, con non pochi dubbi e un ’idea un po’ vaga sui beni comuni e sulla nec essità della cooperazione sociale, ma ben cosciente dei risultati disastrosi prodotti dal capitalismo e dall’apparato statale. Qualcuno proprio simile a te, preoccupato dall’allarmante privatizzazione di innumerevoli risorse pubbliche, dalla proliferazione della pubblicità in ogni anfratto della vita quotidiana e dal lungo elenco delle difficili battaglie ambientali che ci troviamo ad affrontare. Da parte mia, non ho certo penuria di storie da raccontare sulla capacità dei beni comuni nell’affrontare simili problemi in maniera innovativa e socialment e valida. Grazie a un’ampia attività di r icerca, poi sfociata in libri e interventi sugli innumerevoli casi di privatizzazioni dei beni comuni – dove gli interessi delle corporation sono riusciti ad appropriarsi di ricchezze condivise per trasformarle in beni di consumo privati e costosi – ho potuto toccare con mano i per icolosi effetti della nostra ignoranza sul tema. Spesso è pr oprio quest’ignoranza a consentire il saccheggio ai danni della r icchezza comune, come spiegavo nel mio pr imo volume su queste tematiche, Silent Theft (2002). Sono davvero pochi i termini adeguati per definire le patologie del mercato e le possibili alternative collettive. Mi piace pensare che, trovando la terminologia appropriata per parlare dei beni c omuni, riusciremo anche ad appr opriarcene. Si può iniziar e individuando le prospettive corrette sui limiti del mercato e imparando a coinvolgersi in attività comuni con altre persone. Ne otterremo in cambio una serie di benefici impossibili da comprare in qualsiasi negozio – a livello economico, sociale, politico, civico, materiale, estetico e perfino spirituale. Visti i molti pregiudizi che circondano la questione, proverò a spie- 11 gare perché la storia dei beni comuni e la visione politica che ne deriva vadano considerati una fonte di ottimismo. E il modo in cui questi possono r idurre gli odierni problemi finanziari, portando avanti una teoria del valore ben più ricca di quella proposta dalle teorie economiche convenzionali. Non si tratta di una sterile ricerca accademica bensì di un’urgente questione pratica: la voracità del mercato, con i danni ecologici e lo stravolgimento dei rapporti umani che ne derivano, occupa una fetta fin t roppo ampia della vita politica ed economica del pianeta. Sono tante le esperienze legate ai beni comuni che offrono una prospettiva opposta e v itale, dalle risorse naturali all’informazione online e all’impegno civico – integrando così in unico contesto la produzione economica, la c ooperazione sociale, la par tecipazione individuale e l’idealismo etico. La pratica dei beni comuni incarna il paradigma pratico dell’auto-assistenza e della crescita collettiva, dando vita a un’economia e a un or dine sociale par alleli per c onfermare, in maniera cauta ma convinta, che un altro mondo è possibile. Anzi, meglio: possiamo costruirlo insieme, qui e ora. Come vedremo nelle pagine successive, i beni c omuni promettono di fare parecchio per r einventare l’amministrazione pubblica allo sbando e riformare il mercato dai prezzi predatori – oltre che aiutarci a tenere a freno la cultura consumista ipercommercializzata e a implementare nuove forme di “governance verde” a tutela dell’ambiente. In un’epoca come la nostra, in cui la democr azia rappresentativa non è altro che una farsa luccicante al servizio dei grandi monopolisti e delle burocrazie agonizzanti, i beni comuni offrono nuove forme concrete di par tecipazione e di r esponsabilità che possono da vvero cambiare le cose nella vita di tutti noi. Devo inoltre sottolineare che la pratica dei beni c omuni non è né una “strategia comunicativa” tipica delle campag ne pubblicitarie né un dogma ideologico. Non si tratta soltanto di una nuova definizione per “l’interesse pubblico”, quanto piuttosto di una sorta di filosofia politica dotata di specifici approcci operativi e con effetti a lungo ter- 12 mine, perché ci coinvolge pienamente in quanto esseri umani e creature complesse. Ponendosi come paradigma di fondo , il fr onte dei beni c omuni comprende modelli operativi ed evolutivi di autoproduzione e autogestione capaci di integrare fra loro l’ambito sociale ed economico, il collettivo e l’individuale. In definitiva, si t ratta di un mo vimento di stampo umanista ma dalle implicazioni spiccatamente politiche, perché imboccando la strada dei beni c omuni si rischia di avere spiacevoli incontri con il potere del duopolio mercato-Stato. Mentre in passato erano settori nettamente separati della moralità e della politica, oggi il mercato e lo Stat o sono intimamente legati tra loro: un’alleanza basata sulla visione comune del progresso tecnologico, del dominio delle corporation, della perenne espansione della crescita economica e del r elativo consumo. I commoner sanno bene che questa posizione è non soltant o moralmente lacunosa e spir itualmente insoddisfacente per l’umanità, bensì si pone c ome una folle fantasia utopista, proponendo al contempo un quadro insostenibile a livello ecologico, un idolo fatiscente incapace di meritare quel rispetto che una volta appariva scontato. Come risposta a questo quadro, il percorso dei beni c omuni offre invece una visione assai diversa sul pragmatismo e sull’etica del potenziale umano, invitando la gent e a pr aticare un pr oprio stile di emancipazione basato sulla par tecipazione dal basso e sul fai-da-t e. Una visione in cui scarseggia l’interesse per le grette politiche di partito, le ideologie rigide o le istituzioni lontane e c entralizzate. E dove si cerca piuttosto di gettare fondamenta completamente nuove, ovvero, riprendendo la memorabile definizione di R. Buckminster Fuller, di «trasformare qualcosa, creare un modello nuovo che renda obsoleto quello esistente». È proprio questo l’impegno odierno del forte movimento dei beni comuni attivo in tutto il mondo: sperimentare con nuove forme di produzione, con amministrazioni pubbliche più aperte e responsabili, con tecnologie e culture innovative, con stili di v ita sani e appa- 13 ganti. Si tratta di una rivoluzione pacata, oltre che auto-organizzata, diversificata e socialmente responsabile. Un movimento pragmatico ma anche idealista e, per adesso, solo raramente coinvolto nella politica di massa o nella definizione delle dir ettive pubbliche. Eppure quest’ondata continua a crescere un po’ ovunque, per lo più al di sotto del radar dei media tradizionali o delle manovre di Palazzo. Qualcosa che sembra destinato a diventare “davvero enorme”, come si dice nell’industria cinematografica, perché ora le svariate tribù di questo movimento transnazionale iniziano a unire le forze su vasta scala: cresce il numero di attivisti e di cittadini impeg nati a coordinare le loro attività e a r iflettere su come fare causa comune per fronteggiare le crescenti disfunzioni e la paranoia antidemocratica del mercato-Stato. Nel viaggio aereo che stiamo per iniziare spero di riuscire a descrivere la logica differente e rinfrescante dei beni comuni, oltre alle annesse dinamiche sociali, che oggi vanno prendendo piede in numerosi contesti. Prometto di essere sintetico, comprensibile e interessante – pur sottolineando al meglio le complessità e le domande irrisolte che reclamano ulteriore attenzione. Ne attraverseremo parte della storia non detta, rivisitando l’infamia nota c ome la “tragedia dei beni c omuni” e la r iscoperta dei beni c omuni avviata da sociologi e attivisti di ultima generazione. Proveremo inoltre a esaminare sotto una nuova luce le complesse questioni innescate dalla tipica nar razione economica sul dir itto di proprietà, sul mercato e sul valor e – esaminando come le basi st esse dei beni comuni siano capaci di fondare una politica economica di tipo completamente nuovo. La loro portata va anzi ben olt re l’ambito dell’economia, delle direttive pubbliche o della politica in quant o tali. Come vedremo nel Capitolo 10, tutto ciò rimanda a un modo assai diverso d’intendere l’esistenza umana (ont ologia) e la c onoscenza umana (epistemologia), rispetto alle c oncezioni impostesi finora. I beni comuni propongono paradigmi nuovi per la mor alità, per il comportamento e per le aspir azioni umane, spingendosi ben al di là 14 degli arretrati modelli inseg nati ancor’oggi nei c orsi universitari di economia. Nessuna panoramica di questo movimento sarebbe esaustiva senza dare un’occhiata alla varietà di recinzioni forzate (enclosure) e di accaparramenti indebiti che vanno espropriando le nostre comunità e degradando l’ambiente e la cultura. Oggi ogni ambito della ricchezza condivisa si trova sotto assedio: acqua, terra, boschi, mari, biodiversità, opere creative, informazione, spazi pubblici, culture indigene. La notizia positiva è che, a fronte della dilagante privatizzazione condotta dal mercato, gli attivisti replicano con una r agguardevole serie di modelli arditi e innovativi. Nelle pagine successive, incontreremo alcune delle risposte più riuscite e replicabili, tra cui: le licenze “copyleft” per il software libero e la cultura libera; i siti web collaborativi e altre forme di produzione in stile “peer-to-peer”; le comunità di sussistenza che condividono semi, terra, acqua e altre risorse naturali; l’azionariato diffuso per la gestione di beni comuni su grande scala; le filiere di produzione alimentare che integrano partecipazione comunitaria e presenza sul mercato. Adottando una prospettiva ad ampio raggio, emerge così una varietà di situazioni a livello storico, politico e sociale che vanno cristallizzandosi in un paradigma nuovo e coerente. Più di qualcuno si azzarda perfino a immag inare un vero e proprio rinascimento dei beni c omuni. Non a caso, un’antologia che ho curato insieme a S ilke Helfrich (The Wealth of the Commons, 2012) documenta l’incredibile respiro internazionale e la vitalità delle attività e dell’attivismo a sostegno dei beni comuni. Un movimento che oggi include, fra le molte espressioni concrete, eco-villaggi tedeschi e pescat ori cileni, migliaia di pubblicazioni scientifiche open access, un’esplosione di valute alternative a livello locale, orti urbani che danno linfa a cibo naturale e a legami sociali. Tutti questi sviluppi confermano la realtà, fattasi drammaticamente evidente con la crisi economica globale del 2008, secondo cui i dog mi prevalenti dell’individualismo consumista, della proprietà privata e dell’economia neoliberista non possono condurre, né porteranno, al tipo 15 di cambiamento di cui abbiamo bisogno. E perfino i tradizionali sostenitori delle riforme di stampo liber ale e socialdemocratico, pur se genericamente preoccupati per gli abusi del mercato e per i misfatti delle autorità governative, appaiono troppo stremati per poter immaginare percorsi nuovi e quindi cambiare marcia. Sono invischiati nella mentalità prevalente del mer cato-Stato e del r elativo contesto culturale, e troppo ingenui o senza nerbo di fronte al capitale della finanza, per poter ipotizzare forme inedite di governance e d’innovazione istituzionale. Questi riformatori possono far finta di puntare a trasformazioni sociopolitiche ambiziose, ma la cr uda realtà è che preferiscono cavarsela alla meno peggio e aggrapparsi alle prebende del potere. Spero che questo viaggio insieme proceda in modo spedito. Prima di atterrare, proverò anche a confrontare il futuro del paradigma dei beni comuni con i dogmi ormai superati dell’ideologia neoliberista. Come fare per scalzare una teologia del “libero mercato” incapace di mantenere le sue pr omesse e al c ontempo prevenuta davanti alle alternative possibili? Il nostro arcaico sistema basato sulla nazione-Stato e sulle organizzazioni internazionali è incapace di mobilitarsi per affrontare con intelligenza il g rave pericolo che incombe sull’ecosistema planetario. Un quadro che inoltre impedisce l’introduzione di misure serie a favore della giustizia sociale e dell’equa distribuzione delle risorse. Di fronte alle c olossali e inquietanti disfunzioni della go vernance neoliberista, questa crescente ondata di attivisti in India e Italia, Germania e Brasile, Stati Uniti, Regno Unito e molte altre parti del mondo va coordinandosi alacremente grazie alla cultura globale di Internet, immaginando e costruendo spazi condivisi per il cambiament o. Non si tratta certo di un sogno ideologico né di una fantasia utopica, bensì dei pr imi mattoni di una r ivoluzione sospinta da sog natori competenti e pr agmatici, determinati a creare alternative possibili e funzionali per far fronte alle tante catastrofi imminenti. Durante il volo non mancherà certo qualche turbolenza... ma per adesso rilassiamoci e godiamoci il v iaggio: parliamo del mo vimento dei beni comuni nel mondo. La riscoperta dei beni comuni 16 Le donne di Erakulapally – un villaggio situato due ore a ovest di Hyderabad, nell’India meridionale – stendono una coperta sul terreno polveroso per poi v ersarvi sopra, con cautela, una t rentina di m ucchietti di semi dai colori brillanti e dall’aroma pungente: il loro tesoro. Per tutte queste donne – appartenenti alla casta più povera e inferiore nel sistema sociale induista, i dalit – quei semi sono ben altro, il simbolo stesso della loro emancipazione e il ripristino dell’ecosistema locale. Prodotte a livello famigliare, queste semenze hanno consentito a migliaia di donne che vivono nei piccoli villaggi nella regione indiana dell’Andhra Pradesh di sfugg ire al pr oprio destino di la voratrici schiavizzate e malpagate, per diventare invece delle orgogliose contadine autosufficienti. Nel 2010, quando mi recai in visita a Erakulapally sotto gli auspici della Deccan Development Society, i prezzi per gli alimenti di pr ima necessità andavano aumentando del 18 per c ento l’anno, con conseguenti disordini sociali e car estie in molte zone del paese. Eppure cinquemila donne e le lor o famiglie, residenti in circa 75 villaggi della zona, avevano cibo sufficiente per preparare due pasti al giorno anziché uno soltanto come succedeva fino ad allora, e, se ciò non fosse anc ora abbastanza, avevano raggiunto la sicurezza alimentare senza doversi più affidare a semenze geneticamente modificate, monoculture, pesticidi, esperti esterni o sussidi go vernativi, e neppure alla volubilità del mercato. Il raggiungimento della sovranità alimentare, come viene comunemente definita, è qualcosa di notevole perché qui si t ratta di fuoricasta a molteplici livelli: donne, discriminate socialmente perché “intoccabili”, povere e residenti in piccoli villaggi rurali. 17 Durante la “rivoluzione verde” degli anni ’60 e ’70, governi e fondazioni occidentali si diedero parecchio da fare per avviare la produzione di riso e grano commerciale su larga scala nei cosiddetti paesi in via di sviluppo. Pur mitigando la carestia a breve termine, ciò introdusse però delle colture completamente aliene per gli ecosistemi locali, necessitando di pesticidi costosi e dannosi e rivelandosi piuttosto vulnerabili alla siccità e ai prezzi volatili del mercato. Tragicamente, proprio la “rivoluzione verde” aveva spazzato via le g ranaglie che una v olta erano coltivate da int ere generazioni di v illaggi. È opinione diffusa che i 200.000 suicidi dei c ontadini locali avvenuti negli ultimi dieci anni siano dovuti per lo più alle spese e agli imprevisti legati alle monoculture basate sul mercato, che spesso portano a fallimenti agricoli e finanziari. Le donne di Er akulapally hanno scoperto che le coltivazioni tradizionali sono di gran lunga ecologicamente più adatte per il clima semiarido dell’Andhra Pradesh, che presenta specifiche tipologie di terreni e cicli pio vani, rispetto ai semi br evettati prodotti in occidente. Ma per restaurare la biodiversità delle coltivazioni di una volta, queste donne hanno dovuto rivolgersi alle loro madri e nonne per r itrovare decine di semenze ormai quasi dimenticate. Sono così riuscite a metterne insieme una quantità sufficient e per una semina dec ente e alla fine, dopo numerosi cicli di coltivazioni, hanno riportato in vita l’agricoltura mista locale, piantando cioè sei o sette semi diversi nello stesso campo, una pratica che diventa una sorta di “eco-assicurazione”. Non fa differ enza se pio ve troppo o t roppo poco, oppure se la pioggia arriva troppo presto o troppo tardi nella stag ione – almeno qualcuno di quei semi crescerà. A prescindere dalle condizioni atmosferiche, ci sarà abbastanza da mangiare per tutte le famiglie, e nessuno dovrà acquistare costose semenze geneticamente modificate oppure pesticidi e fertilizzanti sintetici. Questo ritorno all’agricoltura tradizionale non ha r ichiesto alcun trasferimento tecnologico né r icerche sponsorizzate dallo Stat o. Ha preso corpo grazie a processi autogestititi tesi a r iscoprire la “cono- scenza popolare” e a incoraggiare consapevolmente la collaborazione sociale e lo scambio dei semi. Nei villaggi dove queste pratiche sono la norma, oggi ogni contadino conosce tutte le varietà di semenze utilizzate e ogni famiglia conserva in casa una pr opria “banca genetica”, una piccola riserva di semi. «I nostri semi, la nostra conoscenza», come dicono le donne del posto: ciascun seme r acchiude una parte della conoscenza popolare. Le semenze non sono soggette ad alcuna compravendita, possono essere soltanto condivise, prestate oppure scambiate, né sono considerate un bene economico: i residenti hanno una r elazione “sociale”, quasi mistica, con i loro semi, i quali rappresentano la motivazione sottile ma importante alla base dell’aut oemancipazione delle donne locali. Come spiega P. V. Satheesh della Dec can Development Society: «Ogni coltura riveste un significato specifico nella vita di queste donne e i semi sono fonte di dignità». 18 La banca dei semi condivisi in Andhra Pradesh illustra una caratteristica portante dei beni comuni: questi possono emergere praticamente ovunque e si rivelano altamente generativi nelle circostanze più improbabili. In mancanza di un inventario generale sulla pratica dei beni comuni, queste esperienze prendono corpo ogni volta che una comunità decide di gestire le risorse in maniera collettiva, con particolare attenzione a tutelarne l’accesso equo, l’utilizzo e la sostenibilità. Lo stesso titolo di quest o capitolo, La riscoperta dei beni comuni, contiene più d’un pizzic o d’ironia, dato che per centinaia di milioni di persone in tutt o il mondo in r ealtà tali pr atiche non sono mai scomparse, bensì fanno par te della loro vita quotidiana da par ecchi secoli. Sono queste risorse comuni a garantire il loro sostentamento giorno dopo giorno, fornendo beni di prima necessità quali legna da ardere e acqua per l’irrigazione, pesce e selvaggina, frutta, bacche selvatiche, e molto di più. Eppure troppo spesso questi beni comuni, come nel caso dei nativi americani e di altre popolazioni indigene, sono stati considerati come qualcosa d’invisibile o di banale, e restano tali 19 a tutt’oggi. Secondo le concezioni predominanti degli economisti, soltanto il mercato è in grado di soddisfare i nostri bisogni essenziali, anche se la r ecente “riscoperta” dei beni c omuni suggerisce un diverso scenario. Le società indust riali, ossessionate dalle spint e del sett ore economico, iniziano a rendersi conto che Stato e mercato non sono le uniche entità tramite cui organizzare la collettività o gestire le risorse. Tuttavia il percorso che conduce alla comprensione dei beni comuni richiede la volontà di concentrarsi sui casi specifici, prendendo in considerazione le potenzialità creative dei rapporti sociali e abbandonando la ricerca di universalità astratte e sicurezze prevedibili. L’approccio dei beni comuni funziona perché si arriva a conoscere e sperimentare la gestione delle risorse locali in maniera unica e particolare – dipendiamo g li uni dagli altri, ci sta a cuor e questa foresta, quel lago o quei terreni agricoli. L’elemento cruciale è la relazione esistente tra la comunità e le risorse locali, insieme alla necessaria prospettiva storica. Le specifiche circostanze e i leader del passat o, le nor me culturali e altri fattori pertinenti a un particolare periodo storico sono elementi cruciali per il successo di queste esperienze, che possono attecchire e crescere solo grazie a pratiche sociali e conoscenze gestionali specifiche. Ogni bene c omune è speciale per ché si è e voluto in rapporto a una specifica risorsa o territorio, alla storia o alle tradizioni di un determinato contesto. Consideriamo, per esempio, le improbabili circostanze che hanno dato origine a uno dei sist emi informatici di maggior successo e utilizzo, il bene c omune noto come GNU/Linux. Nel 1991, da studente universitario in Finlandia, il v entunenne Linus Torvalds decise di creare un sistema informatico tutto suo: un progetto incredibilmente ambizioso, così articolato e diffuso c he generalmente solo le g randi corporation possono permettersi di realizzare e distribuire. I costi e la complessità di Unix, il maggior software per mainframe allora in circolazione, spinsero Torvalds ad avviare lo sviluppo di sistema operativo simile ma in g rado di g irare senza problemi sul suo c omputer. Fortuna volle che all’epoca int ernet stava diventando popolare per 20 l’uso della mail e per il t rasferimento di file (il World Wide Web doveva ancora essere inventato). Torvalds ne diffuse la versione iniziale all’interno di un gruppo online e nel g iro di qualche mese centinaia di persone a vevano offerto utili suggerimenti e st ringhe di codice. In pochi anni, diverse centinaia di hacker diedero così vita a una comunità dedicata alla realizzazione collaborativa del nuovo sistema operativo – che il suo ideatore chiamò Linux, combinazione tra “Unix” e il suo stesso nome, “Linus”. Trascorso qualche anno, il cosiddetto “kernel Linux” venne integrato in un pacchetto di programmi noti come GNU, sviluppati da Richard Stallman, il fondatore della Free Software Foundation, portando così a un sistema operativo completo e capace di girare al meglio sui comuni personal computer: GNU/Linux, spesso indicato semplicemente con Linux. Si trattò di un r isultato inatteso e incr edibile, poiché dimostrava non soltanto le capacità di una c omunità di dilettanti nello sv iluppo di un sistema informatico piuttosto complicato, bensì sanciva anche l’affermazione di internet in quanto infrastruttura altamente produttiva per la collaborazione sociale. Una comunità virtuale e spontanea di hacker sparsi per il mond o, senza alcun compenso o struttura imprenditoriale alle spalle, si era autoorganizzata fino a cr eare un bene comune fieramente creativo, innovativo e basato sul merito. Incredibile ma vero: funzionava! L’esperimento di Linux si rivelò un modello por tante di quella che oggi viene spesso definita «produzione collaborativa centrata sui beni comuni», cioè quei progetti online in cui un ampio g ruppo di persone unisce le proprie forze tramite piattaforme aperte in rete. La struttura sociale alla base del modello cooperativo GNU/Linux ha poi ispirato estesi progetti collaborativi, tra cui Wikipedia (e centinaia di wiki meno noti) e le r iviste scientifiche open access, dove gli autori accademici reclamano il controllo sulla loro produzione nei confronti degli editori commerciali, mettendola a libera disposizione del pubblico. Quest’esperienza ha dato inoltre impulso a inno vazioni come la pratica diffusa di social network, il crowdsourcing per l’informazione e la raccolta fondi, progetti di design e produzione condivisi come il Global Village Construction Set, una piattaforma tecnologica aperta e basata sui principi dell’open source per produrre in maniera semplice ed economica 50 differenti macchinari industriali per costruire un piccolo villaggio con tutti i comfort moderni. Come vedremo nel capitolo 8, l’esperimento di Linux ha stravolto perfino certi princìpi economici apparentemente inviolabili, suggerendo che per creare ricchezza non occorre affidarsi esclusivamente alla contrattazione tra individui egoisti e r azionali nel c ontesto del mercato. Ha anzi dimostrato che la “ricchezza” in quanto tale è ben più che l’ammasso di favolosi titoli azionari, obbligazioni e contante. La ricchezza vera e propria sta nel pat rimonio comunitarioe nell’intricata trama di relazioni sociali da cui dipende la c omunità stessa. Il percorso di Linux è la prova sbalorditiva che i beni comuni possono rivelarsi generativi e attuali, oltre che assai pratici ed efficaci. 21 Come rivela l’analisi dei casi specifici, non esiste una for mula standard oppure un facsimile per a vviare simili esperienza, né la pr atica dei beni comuni va considerata una panacea o un’utopia. Non di rado emergono disaccordi tra gli stessi commoner, con scontri di personalità e dibattiti int erni sulle opzioni mig liori e i c omportamenti corretti. Potrebbero finanche emergere problemi gestionali strutturali e interferenze politiche esterne. E tuttavia costoro sono ben int enzionati a risolvere le ardue questioni pratiche che vanno emergendo man mano, del tipo: «Qual è il modo migliore per irrigare questi venti ettari con l’attuale penuria d’acqua?», oppure: «Come ripartire in maniera equa l’accesso alla pesca in questa baia c ostiera sempre più depauperata?». Gli animatori di questi pr ogetti partecipativi non temono neppure di affrontare il problema degli scansafatiche, dei vandali e degli scrocconi: individui che vogliono approfittare dei vantaggi della situazione senza assumersene le r esponsabilità. Il punto è che i beni comuni rappresentano un paradigma concreto 22 per l’autogoverno, per la gestione delle r isorse e per “vivere meglio”. Spesso i membr i della c omunità arrivano a soluzioni soddisfac enti per far fronte alle necessità comuni senza dover ricorrere al mercato o alla burocrazia. E si danno da far e per identificar e le st rutture più adatte a gestire una risorsa condivisa, le procedure tramite cui stilare norme e consuetudini operative funzionanti. Sanno bene c he è importante stabilire pratiche efficaci atte a prevenire lo sfruttamento incontrollato del bosco, del lago o dei terreni agricoli in comune – contrattando tra loro per giungere ad assegnazioni eque dei doveri e dei diritti, e puntando a ritualizzare e interiorizzare le abitudini collettive e l’etica gestionale, in modo che con il passare del tempo possano maturare in una cultura positiva. Una sfida continua riguarda una certa tendenza a “disertare” dagli accordi comuni, mettendo così a rischio quei modelli pot enziali che altrimenti sarebbero di giovamento a tutti. Ciò può portare allo sfruttamento privato di risorse collettive oppure, peggio, a una caotica situazione del tipo “tutto gratis” che finisce per dist ruggere le r isorse stesse. Si tratta di quello che la sociologia definisce il «problema dell’azione collettiva», di cui gli studiosi hanno analizzato a lungo le motivazioni per ar rivare a qualc he soluzione possibile – c ome avremo modo di esplorare in dettaglio nel capitolo successivo. È importante rendersi conto che i beni comuni non riguardano soltanto le cose o le risorse. Gli osservatori esterni sono propensi a commettere quest’errore, vuoi perché trattasi di economisti che tendono a oggettivare tutto, vuoi perché si ritiene a priori che una determinata risorsa vada amministrata come un bene comune (quel che mi piace chiamare “aspirante bene comune”). Pur includendo sicuramente patrimoni fisici e intang ibili d’ogni tipo, la definizione più ac curata di bene comune è quella di un par adigma che lega una specifica c omunità a una ser ie di pratiche, valori e consuetudini sociali tramite cui gestire una determinata risorsa. In altri termini, un bene comune è il risultato di una risorsa + una comunità + de i protocolli sociali. Questi tre elementi costituiscono un insieme integrato e interdipendente. In base a questa pr ospettiva, la domanda da porsi non è tant o se il lago Retba in Senegal oppure i database sulla sequenza genomica disponibili online vadano considerati o meno dei beni comuni, quanto piuttosto se una specifica c omunità è moti vata seriamente a gestir e questi patrimoni come un bene comune; e quindi se è in grado di implementare quelle norme, abitudini e sanzioni necessarie per far funzionare di fatto questo sistema. Su questo punto, vale anzi la pena di considerare alcuni esempi di situazioni c ondivise, apparentemente improbabili, che è possibile gestir e in quanto veri e propri beni comuni. 23 Un gruppo di m uscolosi surfer è solit o ritrovarsi a Oah u, nelle Hawaii, accomunati dalla passione di ca valcare le enor mi onde c he s’infrangono sulla spiaggia Banzai Pipeline – nota come il monte Everest del surfing – dove i migliori della specialità mettono alla prova il coraggio e il talento. Non sorprende perciò notare l’accesa competizione su chi ha diritto a cavalcare una certa onda, e neppure il risentimento verso gli estranei che non r ispettano le pr ocedure messe a punto dal team locale. «È un ambiente pericoloso, e senza un sistema di controllo autogestito, regnerebbe il caos totale», spiega Randy Rarick, direttore esecutivo della competizione Vans Triple Crown of Surfing, a un giornalista del New York Times. E aggiunge un altro surfer: «Ci sono c onseguenze serie se piombi addosso a qualcuno e g li fai male, oppure se qualcuno cade dal surf mentre cavalca l’onda e g li succede qualcosa». Per far fronte a questi pr oblemi si è c osì formato un collettivo sociale autogestito, noto come Wolfpak, incaricato di curare le modalità per l’utilizzo corretto di una risorsa amatissima ma scarsa: le enormi onde dell’oceano. I membri del Wolfpak hanno perciò messo a punto col tempo delle procedure atte a garantire l’uso delle onde in maniera ordinata, sicura ed equa, oltre che per gestire la comunità stessa. Spetta a loro decidere chi può cavalcare una determinata onda in arrivo, e sono loro a punire chi non rispetta questo codice sociale inter- 24 no. Come sottolinea Isaiah Helekunihi Walker, docente di storia che nel 2011 ha pubblicato un libro sulla cultura del surfing tipica di quella spiaggia: «Per gli hawaiani, il rispetto è un concetto importante, soprattutto quando si ha a c he fare con l’oceano». Non a caso in passato sono emerse delle c ontroversie tra i surfer locali e quelli v enuti da fuori: quando se ne sono pr esentati alcuni dall’A ustralia e dal S ud Africa, facendo i gradassi, i locali non l’hanno presa affatto bene. Situazione questa c he solleva una questione impor tante: chi ha maggior legittimità nella gestione della spiagg ia, gli appassionati del posto oppure le autorità statali, a cui spetta legalment e il potere amministrativo? È giusto che interessi e timori dei locali finiscano per sopraffare le esigenze altrui? In ogni caso, qualcuno può forse r ivendicare la proprietà di questo bene comune? E quali sarebbero le procedure più eque ed efficaci per gar antirne la tutela? Il bene comune dei Wolfpak assomiglia a certi quartieri di Boston i cui residenti hanno elaborato specifiche consuetudini per parcheggiare in strada nei mesi invernali: quando la città viene colpita da pesanti tormente di neve, come è spesso il caso , diventa subito complicato trovare un posto per parcheggiare vicino casa, soprattutto per chi non ha il garage e vive in un condominio. Così in alcuni quartieri vige un sistema condiviso in base al quale se un residente s’impegna a spalare tutta la ne ve necessaria per creare un parcheggio, ha dir itto a far ne uso finché la neve si scioglie. E per segnalare questo diritto acquisito, piazza una v ecchia sedia o qualc he altro oggetto in quello spazio , quando rimane temporaneamente vuoto perché usa la mac china. Tuttavia spesso succede che qualcuno che non vive in quel quar tiere prova a spostare il segnaposto per parcheggiarvi, oppure talvolta un residente cerca di infilarsi indebitamente in uno spazio già contrassegnato. È il classico problema dello scroccone, da cui nascono ogni tanto litigi e conflitti, mentre i residenti rimangono intenzionati afar rispettarequeste normativeinformali. Una volta la professoressa Elinor Ostrom mi fece notare che anche quest’esempio rientra tra i beni c omuni. Davanti alle mie e videnti 25 perplessità, mi spiegò c he queste norme per l’aut ogestione dei parcheggi nei mesi in vernali sono diretta conseguenza della «comprensione condivisa sul diritto all’uso di una r isorsa decisamente scarsa». E come per il dir itto all’accesso delle onde dell’oc eano nel caso dei Wolfpak, il «bene c omune del parcheggio» istituito in certi quartieri di Boston rappresenta un esempio di autogestione riuscita. Eppure dal punto di vista delle istituzioni pubbliche, ciò non è altro che il tentativo di «prendere in mano la situazione» da parte dei cittadini. Il governo è geloso della pr opria autorità e ostile a qualsiasi incursione, anche minima, nell’ambito di sua competenza sulla capacità di stabilire e implementar e norme ufficiali. D’altra parte, la lezione dei Wolfpak e della gestione dei par cheggi a Boston è che questi beni comuni locali possono offr ire soluzioni manager iali utili e or dinate laddove le nor mative formali invece appaiono lacunose. Spesso g li spazzaneve di Boston non riescono a pulire le strade in tempi rapidi e far rispettare le regole sui parcheggi può rivelarsi inefficace o costoso. Le autorità hawaiiane non sembrano intenzionate ad assumere poliziotti o bagnini per monitorare la spiaggia Banzai Pipeline (cr eando forse un vuoto amministrativo?), o comunque considerano simili situazioni poco pratiche o importanti perché il complesso apparato burocratico decida di farsene car ico. Ma come la vedono i commoner? Costoro vi sono direttamente coinvolti e vantano un profondo livello di conoscenza, immaginazione, intraprendenza e interesse. In realtà la loro forma di governance informale può dimostrarsi superiore ad ogni regolamentazione ufficiale. Anzi, man mano c he le discussioni int erne si fanno talment e radicate da t rasformarsi in usanz e spontanee in v igore in queste sacche informali della società, queste consuetudini diventano di fatt o una sorta di “legge vernacolare”. Si tratta di abitudini che si manifestano in ambiti sociali informali (ritrovi, scuole, la spiaggia o la strada), finendo per imporsi come fonte di ordine concreto e legittimità morale. In tal senso, certe usanze sociali ben diffuse, come mettersi in fila (punendo quelli che cercano di passarci avanti) e il galateo a tavola (mai prendere l’ultimo boccone), sono una sorta di pratica collettiva passiva che molti di noi hanno int eriorizzato come «il modo c orretto di comportarsi»: rappresentano un modo implicito di gestire collettivamente l’accesso a risorse limitate. 26 Ciascuna delle situazioni descr itte sopra prende corpo in manier a spontanea, senza l’intervento o la super visione di istituzioni c entralizzate o di agenzie go vernative. Si tratta piuttosto di situazioni c on obiettivi collettivi di ampio r espiro che, pur por tando beneficio a qualche individuo, non puntano c erto a creare profitti per chicchessia, quantomeno non in manier a diretta. Nella stragrande maggioranza dei beni comuni, il mercato è anzi una presenza del tutto marginale: anche senza l’int romissione delle spint e economiche o dello Stato, nascono comunque esperienze serie a livello di produzione e di governance. La bellezza insita nella “riscoperta” del paradigma dei beni comuni deriva dalla sua attenzione tanto agli aspetti particolari quanto a quelli complessivi. Pur abbracciando certi principi generali – par tecipazione democratica, trasparenza, uguaglianza, accesso individuale – queste pratiche si manifestano in manier a assai specifica rispetto alla situazione locale. Sono questi i motivi che mi portano a paragonare i beni comuni al Dna umano. Il quale, come ci spiegano g li scienziati, è sapientemente sottospecificato proprio per consentire al codice della vita di adattarsi alle circostanze locali: il Dna non è fisso e deterministico, bensì parziale e adattabile, qualcosa in continua crescita e mutazione. Un bene c omune è analogo a un organismo v ivente che si evolve in simbiosi c on l’ambiente e con il contesto a cui appar tiene, adattandosi man mano alle circostanze specifiche. Una foresta comune in Vermont avrà caratteristiche alquanto diverse da un bosc o in Nepal oppure in Germania, per via dell’ecosistema, del tipo di alberi, dell’economia, del retroterra culturale e di altri elementi unici del posto. E tuttavia in ognuno di questi casi i beni c omuni restano tali: regimi stabili per gestire le risorse condivise in maniera equa a benefi- 27 cio delle persone dir ettamente coinvolte. Il principio della “diversità che unisce” è quel che rende così versatile e potente il paradigma dei beni comuni – e c he confonde tanto gli economisti quanto i politici tradizionali. Il punto critico per lo sviluppo di qualsiasi esperienza condivisa legata ai beni comuni, come menzionato in precedenza, sta nel fatto che è la comunità stessa a decidere di voler attuare determinati interventi sociali per gestire una risorsa a vantaggio della stessa collettività – cioè quel che talvolta viene definito commoning. Non a caso P eter Linebaugh, affermato storico e studioso americano della materia, ha scritto che «non esiste commons senza commoning». È un elemento chiave da tenere a mente, perché sottolinea il fatto che un bene c omune non riguarda soltanto la c ondivisione delle r isorse, ma pr evede soprattutto la messa in att o dei valori e delle pr atiche sociali più adatti a garantirne la corretta gestione. Queste attività di commoning agiscono come una specie di giroscopio a livello morale, sociale e politico, il cui asse di r otazione rimane stabile e orientato in una dir ezione fissa. Quando la gent e decide di mettersi insieme, condivide pratiche ed esperienze e accumula un tesoro di conoscenze e tradizioni pratiche, innescando così una serie di circuiti sociali produttivi. Ne derivano modelli stabili di energ ia sociale che consentono di portare avanti impegni seri, garantendo vantaggi continui alla comunità. In questo senso, un bene comune assomiglia a un campo mag netico di energia sociale e morale. Può anche darsi che all’occhio inesperto il campo di forza appaia in visibile e i suoi effetti perfino un po’ magici. Ma è giunto il momento di vedere le cose per quelle che sono: i beni comuni rappresentano un sistema versatile per consentirci di organizzare flussi affidabili di energ ia sociale, creativa e produttiva. Sfatare il mito della “tragedia” dei beni comuni «Immaginiamo un terreno da pascolo a disposizione di tutti». Per almeno una generazione, l’idea stessa di beni comuni è stata marginalizzata e liquidata come un modo maldestro di gestire le risorse: la cosiddetta “tragedia dei beni comuni”. In un saggio breve ma influente, apparso sulla rivista Science nel 1968, l’ecologista Garrett Hardin diede alla storia una formulazione nuova e una definizione memorabile. «Ecco come si sviluppa la tragedia dei beni comuni», spiegava Hardin, scrivendo quanto segue, a partire dal terreno da pascolo aperto a tutti: 28 È ragionevole prevedere che ogni mandriano cercherà di tenere quanti più capi di bestiame possibili su quel terreno comune. Situazione questa c he potrebbe funzionare in manier a alquanto soddisfacente per secoli: ci penseranno le lotte tribali, il bracconaggio e le malattie a t enere il numero di persone e animali ben al di sotto della capacità di sost entamento del terreno. Alla fine arriverà però il giorno della resa dei conti, ovvero il momento in cui l’agognato obiettivo della stabilità sociale di venta realtà. È a questo punto che la logica inerente ai beni comuni si trasforma inesorabilmente in t ragedia. In quanto essere razionale, ogni mandriano vorrà massimizzare i suoi pr ofitti. Implicitamente o esplicitamente, in manier a più o meno c onsapevole, finirà per chiedersi: «Cosa mi tornerà di utile se aggiungo un altro animale alla mandria?». L’allevatore razionale ne concluderà che l’unica strada possibile è aggiungere un altro capo di bestiame. E poi un alt ro e un alt ro ancora… Ma questa è la st essa conclusione a cui g iunge ogni persona razionale che usufruisce dello stesso bene comune. Da qui la tragedia. Ogni partecipante è bloccato all’interno di un sistema che lo c ostringe ad ampliar e la sua mandr ia indefinitamente, pur trovandosi in uno spazio chiaramente limitato. Tutti questi uomini sono c ondannati alla rovina, perché ciascuno di loro persegue l’interesse personale in una società che crede nella libertà dei beni comuni. La libertà in presenza di un bene comune porta alla rovina collettiva. 29 La tragedia dei beni comuni è una di quelle concezioni fondamentali inculcate nel cervello di ogni studente universitario, per lo meno nelle discipline economiche. L’idea viene anzi considerata un pr incipio base della teoria economia, una lezione ammonitoria sull’impossibilità dell’azione collettiva. Una volta scortati gli studenti attraverso il rituale brivido iniziale, il doc ente li spinge r isolutamente verso le maggiori attrazioni, le virtù della proprietà privata e del liber o mercato. È qui, spiegano gli economisti, che finalmente riusciremo a sormontare la cupa t ragedia dei beni comuni. Il catechismo viene somministrato al meglio: la libertà individuale di possedere e scambiare la proprietà privata nel libero mercato è l’unico modo possibile per ottenere soddisfazioni personali durature e prosperità sociale. Così Hardin ne illustra il filo logico: per superare la tragedia dei beni comuni occorre un sistema di «costrizione reciproca che incontra l’accordo della maggioranza delle persone c oinvolte», dove l’approccio migliore prevede «l’istituzione della pr oprietà privata accoppiato con l’eredità legale». Pur ammettendo che non si tratta di un’alternativa perfettamente equa, propone infine la selezione natur ale darwiniana come l’opzione migliore in assoluto, spiegando: «Coloro che a livello biologico sono più adatti a diventare i custodi della proprietà e del potere dovrebbero ereditarne una fetta maggiore». Ci adattiamo a 30 quest’ordine legale imperfetto, aggiunge Hardin, «perché non siamo convinti, al momento, che qualcuno possa aver inventato un sistema migliore. L’alternativa dei beni c omuni è troppo disastrosa da prendere in considerare. Alla rovina totale va preferita comunque l’ingiustizia». Simili elucubrazioni da parte di un ricercatore con tendenze ultraliberiste sono diventate oro colato per gli ideologi e gli economisti conservatori (figure fin t roppo spesso c oincidenti), ai quali il sagg io di Hardin appare una parabola del Vangelo che ribadisce i principi fondamentali dell’ideologia economica neoliberista, affermando la centralità del “libero mercato” e giustificando il diritto di proprietà a favore dei ricchi. E rafforza altresì l’adesione ai diritti individuali e alla proprietà privata come pilastri portanti del pensiero e della dott rina economica, presupponendo che la gente sarà motivata ad assumere la responsabilità delle risorse se in cambio ne avrà garanzia di accesso e di proprietà nel libero mercato. L’unico modo con cui dovrebbe essere possibile evitare tragici risultati, cioè la «r ovina totale». In questa visione, il fallimento dei beni c omuni viene esteso anche alle istituzioni pubbliche, se non altro per suggerire che perfino uno dei pochi strumenti riconosciuti a sostegno degli interessi collettivi, l’apparato statale, finirà per soccombere al paradigma della «tragedia». (È questo il nocciolo della t eoria della “scelta pubblica”, che applica la log ica economica tradizionale ai problemi della scienza politica). Nel corso degli ultimi decenni, la tragedia dei beni comuni ha così messo radici come un truismo economico. In particolare, il saggio di Hardin è di ventato un punt o fermo dell’istruzione accademica soprattutto negli Stati Uniti, dove viene insegnato non soltanto agli studenti di economia bensì anche a quelli di scienze politiche, sociologia e altre discipline. Non c’è da meravigliarsi dunque se tanta gente finisce per giudicare i beni comuni con disinvolta condiscendenza, come sinonimo di caos, rovina e fallimento. Questa parabola si basa su una lacuna fondamentale: non descrive in maniera accurata quello che è il contesto concreto dei beni comu- 31 ni. La fiction di H ardin propone un sistema che non prevede confini o delimitazioni intorno al terreno di pascolo, nessuna nor ma per la sua gestione, nessuna sanzione per l’uso ec cessivo, nessuna specifica comunità di riferimento. La sua descrizione non ha nulla a che veder e con i beni comuni. Si tratta piuttosto di un regime di libero accesso oppure di un sist ema aperto e gratuito per tutti. Un bene comune prevede confini, norme, consuetudini sociali e sanzioni contro gli scrocconi, oltre a una comunità ben decisa ad amminist rare coscienziosamente la risorsa in questione. Evidentemente Hardin faceva confusione con “la terra di nessuno”, e nel processo ha diffamato la pratica dei beni comuni dipingendola come un fallimento per gestire le r isorse condivise. In realtà, costui seguiva semplicemente le orme di altri intellettuali polemici decisi a pr oiettare nel mondo il lor o acritico sostegno all’individualismo del mercato. Come vedremo più avanti, le teorie del filosofo John Locke erano già servite a giustificare l’assalto al Nuovo Mondo come terra nullius, pur se da tempo ospitava milioni di nativi americani che si erano presi cura amorevolmente delle risorse naturali in base a regole non scritte ma decisamente sofisticate. Il saggio in questione si ispir ava al testo di un disc orso tenuto nel 1832 da William Forster Lloyd, un intellettuale inglese che, al pari di Hardin, era preoccupato dalla so vrappopolazione in un per iodo in cui recintare i terreni stava diventando una consuetudine. Nel suo discorso Lloyd seguiva il medesimo filo log ico e commetteva lo stesso evidente errore, ritenendo cioè che la gente fosse incapace di trovare una soluzione a quella “tragedia”. Al posto del pascolo condiviso, la sua metafora prevedeva una somma di denaro in comune a cui poteva accedere chiunque vi aveva contribuito. Ne risultava che in breve tempo ogni individuo decideva di prelevarne ben più c he la quota a lui spettante, mentre invece un portafoglio personale sarebbe stato gestito in maniera assai frugale. Ho segnalato il saggio di Lloyd per illustrare quanto siano ridicoli ma persistenti i malintesi sulle dinamiche di questa “tragedia”, come rimarca d’altronde anche lo studioso dei beni c omuni Lewis Hyde: 32 «Mentre Hardin propone un mandriano la cui ragione non riesce ad afferrare il valore del bene comune, così Lloyd suppone che i membri di un gruppo siano incapaci di c onfrontarsi tra loro oppure di prendere decisioni congiunte. Entrambi iniettano l’individualismo in stile laissez-faire in un villaggio agricolo tradizionale, per poi ann unciare con gravità la morte dei beni comuni. Dal punto di vista di quel v illaggio, il presupposto di Lloyd appare folle tanto quanto il tentativo di farci credere che “un uomo ha un portafoglio a cui possono accedere sia la sua mano dest ra sia la sinist ra, ma ciascuna delle due è ig nara della presenza dell’altra”». Purtroppo quest’assurdità è alla base di una vasta produzione letteraria sul cosiddetto “dilemma del prigioniero”, un esperimento da cui si presume debba emergere il comportamento tipico degli “individui razionali” posti davanti a certi “dilemmi sociali”, come decidere la distribuzione di una r isorsa limitata. Forse al “prigioniero” conviene collaborare con gli altri potenziali pretendenti e condividere ogni minima ricompensa? Oppure dovrebbe fregarsene e ar raffare quanto possibile solo per sé? Inutile dire che ne r isultano scenari infiniti. Ma è la pr emessa di fondo di questi esperimenti sociali a fare acqua da tutte le parti. Certi presupposti sull’egoismo, sui calcoli razionali dei singoli e sull’assenza di un adeguato contesto complessivo (come se i soggetti del test non condividessero alcun passato sociale o cultur a) appaiono fortemente integrati nel desig n stesso del “gioco”. Sembra che costoro non siano autorizzati a comunicare tra loro né a creare legami basati su fiducia e c onoscenza condivisa, con minime opportunità per imparare a collaborare – isolati in un labor atorio per un unic o esperimento, privati di ogni passato o futuro collettivo. Inorridito dall’illogicità dimostrata dagli studiosi di ec onomia, Lewis Hyde suggeriva maliziosamente di dar e all’ipotesi della “tragedia” un tit olo più appropriato, tipo: «La tragedia di risorse comuni mal gestite, senza controllo e facilmente accessibili da individui egoisti e incapaci di comunicare tra loro». 33 Il “piccolo e spor co segreto” di tanti esper imenti sul dilemma del prigioniero sta nel fatt o che presuppongono una cultura di mer cato perseguita da individui razionali. In genere non si considerano più di tanto i potenziali percorsi grazie ai quali è possibile c ollaborare e gestire insieme le r isorse. Presupposti che oggi fortunatamente stanno venendo meno, man mano che gli esperimenti sulla teoria dei giochi incorporano le idee relative all’economia comportamentale, alla teoria della complessità e alle scienze evolutive. Rimane però il fatt o che buona par te degli studi e delle policy in campo economico poggiano su un modello piuttosto rozzo e arcaico dell’essere umano. Al di là della sua ovvia irrealtà, l’Homo economicus, questa astrazione fantasiosa impeg nata a massimizzar e la “funzione utilitaristica” individuale tramite il calcolo razionale, continua a imperare come modello idealizzato dell’umanità in quell’entità culturale che definiamo “economia”. Non a caso due manuali introduttivi alla disciplina economica ampiamente diffusi nelle uni versità statunitensi, curati da Sam uelson e Nordhaus (2004) e da Stig litz e Walsh (2006), considerano il c omportamento cooperativo talmente irrilevante da non menzionare neppure la presenza dei beni comuni. E se gli economisti rivelano qualche inclinazione a discut erne, possiamo essere sicuri che prima o poi tireranno fuori la parola “tragedia”. Il paradosso sta nel fatt o che la perseverante ricerca del vantagg io egoistico – naturalmente condotta in modo “razionale”, eppure indifferente alle istanz e della c ollettività – è una definizione c he calza a pennello per la t radizionale economia di mer cato assai più c he per quella dei beni c omuni. Tant’è che, all’approssimarsi della disastrosa crisi della finanza g lobale nel 2008, è stata proprio quest’idea a spingere i maghi di Wall Street a massimizzare il tornaconto personale fregandosene dei rischi sistemici o dell’impatto locale. La vera tragedia innescata dall’individualismo “razionale” non riguarda i beni comuni bensì proprio il mercato. Fortunatamente parecchi studiosi contemporanei hanno fatt o parecchio per tirar fuori i beni c omuni dall’oblio a cui li a vevano con- dannati le teorie economiche tradizionali. Tra questi, la politologa ed economista statunitense Elinor (“Lin”) Ostrom (1933-2012)1 dell’Università dell’Indiana a Bloomington merita una menzione particolare per l’impegno profuso nell’ampliamento del quadro d’analisi dell’attività economica. Negli anni settanta, l’intera disciplina er a sprofondata in una sor ta di fondamentalismo r eligioso, dove si celebravano i modelli spic catamente astratti e quantitativi basati sull’individualismo razionale, sul dir itto alla proprietà privata e sul liber o mercato. Cresciuta durante la G rande Depressione dei pr imi anni trenta, Ostrom è stata sempr e attratta dai progetti collaborativi operanti al di fuor i del tradizionale mercato economico e già negli anni sessanta, in veste di giovane ricercatrice di scienze politiche, mise in dubbio alcuni dei presupposti su cui poggiavano la teoria economica, soprattutto l’idea per cui gli individui sono incapaci di collaborare tra loro in manier a stabile e sost enibile. Lavorando talvolta insieme al marito politologo Vincent, Ostrom diede così avvio a un n uovo tipo di ricerche interdisciplinari sui sistemi istituzionali che gestiscono dei beni collettivi (“common-pool resources”). Nella teoria economica, con quest’ultimo termine s’intendono quelle risorse collettive su cui nessuno può vantar e il diritto di proprietà o il controllo esclusivo, quali le zone di pesca, i terreni da pascolo e le falde acquifere. Si tratta di risorse assai fragili per via della difficoltà a impedirne l’utilizzo. Una situazione che potremmo definire la «tragedia dell’accesso incontrollato». (Per quanto possa valere, lo stesso Hardin ammise poi che il suo saggio avrebbe dovuto intitolarsi «La tragedia dei beni comuni senza controllo», che rimane comunque un ossimoro). Le analisi di Ost rom si differenziavano da quelle di tanti ec onomisti accademici per via delle sue accurate indagini empiriche sul campo. Andò a visitare personalmente i proprietari di terreni comuni in Etiopia, i raccoglitori di gomma nella foresta amazzonica e i pescatoPer ulteriori dettagli, si veda: https://it.wikipedia.org/wiki/Elinor_Ostrom. 34 1 ri filippini, studiandone la messa a punt o dei modelli c ollaborativi e l’integrazione dei loro sistemi sociali nei r ispettivi ecosistemi locali. Come ha spiegato Nancy Folbre, docente di economia presso l’Università del Massachusetts: «andava a parlare di persona con i pescatori indonesiani o c on i r accoglitori di ar agoste nel Maine, chiedendo loro: “Come avete fatto a stabilire certi limiti sul pescato? E come avete affrontato l’eventualità che qualcuno decidesse d’ignorarli?”». Basandosi su quest e rilevazioni empiriche, Ostrom ricavò alcune procedure generali per il successo delle pratiche condivise. Come fa una comunità a risolvere il problema dell’azione collettiva? La sfida c ontinua che devono affrontare i soggetti coinvolti in una situazione interdipendente, scrive Ostrom, sta nel t rovare il modo g iusto per «atti vare l’auto-organizzazione e l’autogestione necessarie per ottenere benefici comuni continui quando tutti si trovano davanti alla tentazione di evitare il lavoro oppure di approfittarne a sbafo, o comunque di comportarsi da opportunisti. Altre questioni parallele riguardano la combinazione di variabili in grado di (1) incrementare le probabilità iniziali dell’auto-organizzazione, (2) potenziarele capacità dei singoli nell’impegno all’autogestionenel corso del tempo, oppure (3) ampliare le potenzialitàdell’auto-organizzazioneper risolvere i pr oblemi relativi alle r isorse condivise senza interventi esterni di alcun tipo». Queste riflessioni sono poi sfociate in Governing the Commons 2, un testo del 1990 in cui Ost rom gettava le basi dei «pr incipi di design» fondamentali per creare dei beni comuni efficaci e duraturi. Pur se tali principi sono stati successivamente adattati ed elaborati da altri studiosi, le sue analisi rappresentano tuttora il quadro predefinito per valutare i beni c omuni nell’ambito delle r isorse naturali. L’opera di Ostrom, e delle leg ioni di accademici che oggi si occupano dei beni collettivi, si concentra sulle modalità c on cui le st esse comunità riescono a stabilire le consuetudini sociali (e tal volta le regole formali) capaci di garantire la sostenibilità di risorse limitate nel lungo perioTraduzione italiana: Governare i beni collettivi, Marsilio 2006. 35 2 36 do. In fondo, le teorie economiche tradizionali sostengono che siamo individui egoisti con desideri illimitati, e quindi l’idea che si possa dipendere dall’altruismo e dalla c ooperazione appare spesso puer ile e irreale. Parimenti improbabile sembra l’ipotesi di stabilire e imporre limiti all’uso di un bene c omune, perché ciò va contro la concezione degli economisti che gli esseri umani sono dotati di appetiti insaziabili. Basandosi su centinaia di esempi quotidiani, Ostrom ha invece dimostrato come le persone c oinvolte in quest e esperienze sappiano soddisfare i propri bisogni e interessi in maniera collaborativa. È fin dal 1224 che gli abitanti del villaggio di Torbel, in Svizzera, si prendono cura delle loro foreste, praterie e acquiferi alpini. Per secoli i contadini spagnoli si sono affidati ad apposite istituzioni sociali per organizzare l’irrigazione degli orti comuni, mentre più recentemente le diverse aziende che forniscono acqua potabile nell’area di Los Angeles hanno imparato a coordinare la gestione di falde acquifere sempre più ridotte. Tanti beni comuni hanno prosperato per centinaia d’anni, anche in periodi di siccità o di crisi, e il loro successo va attribuito al fatto che ogni comunità è riuscita a implementare norme flessibili e dinamiche per la gestione della specifica risorsa, monitorandone l’uso e l’accesso e applicando sanzioni efficaci nei c onfronti di chi infrange tali norme. In base alle sue ricerche sul campo, Ostrom ha stabilito l’importanza di prevedere limiti ben definiti, in modo che sia chiaro a tutti chi è autorizzato a usare o meno quella r isorsa condivisa. Ovviamente accesso e utilizzo vanno negati a quanti non fanno parte della comunità. L’economista statunitense scoprì inoltre che le norme per usufruire di una risorsa devono prendere in considerazione le condizioni locali e stabilire delle limitazioni su quello di cui ci si può appropriare e in che modo farlo. Per esempio, le bacche selvatiche possono essere raccolte soltanto in un determinato periodo dell’anno, oppure i rami caduti a terra in un bosco vanno raccolti soltanto per usi domestici, non per la vendita a terzi. 37 I commoner devono poter stabilire o influenzare le procedure atte a governare il bene comune, sottolinea Ostrom: «Se le istituzioni statali esterne ritengono di essere le sole ad avere l’autorità di imporre delle regole, allora sarà molto difficile garantire il benessere della risorsa nei tempi lunghi da parte dei soggetti locali». Questi ultimi dovranno altresì incaricarsi di monitorare l’uso (e l’abuso) del bene comune e di implementare un sistema sanzionatorio ai danni di chiunque ne vìoli le norme, preferibilmente tramite una scala graduale di sanzioni via via più pesanti. E quando sorgono delle dispute, occorre attivare rapidamente dei meccanismi adeguati per la risoluzione dei conflitti. Ostrom puntualizza che, quando i beni c omuni fanno parte di un più ampio sistema di governance, devono essere «organizzati in strati multipli di imprese innestate una sull’altra». Si crea così quella che definisce «governance policentrica», a indicare che l’autorità per stabilire l’appropriazione di una r isorsa, il monit oraggio e le modalità d’utilizzo, la risoluzione dei conflitti e altri compiti gestionali va condivisa attraverso i diversi livelli interessati: dal locale al r egionale, dal nazionale all’internazionale. Va sottolineato che Ostrom non considerava gli otto principi di design da lei delineati come un modello rigoroso per arrivare al successo, quanto piuttosto come delle linee guida generali. È inoltre importante notare che le sue indagini si concentrarono soprattutto su esperienze legate a r isorse naturali di scala r idotta. Soltanto nell’ultima parte della sua car riera, la studiosa amer icana esplorò i problemi relativi ad ambiti regionali o globali di ampie proporzioni e ai beni comuni digitali (che possono facilmente raggiungere dimensioni notevoli), anche se queste situazioni rimasero per lo più in secondo piano nelle sue analisi complessive. In definitiva, i fattori che influenzano direttamente la struttura e la gestione dei beni comuni possono essere sintetizzati come segue: – È il carattere della risorsa a stabilirne il tipo di gestione. Beni limitati ed esauribili, come le miniere, hanno qualità assai diverse da quelli auto-alimentati come le zone di pesca o le foreste. I be- ni comuni considerati “illimitati”, tipo le t radizioni culturali e i contenuti online (ent rambi riproducibili praticamente a c osto zero) non devono temere gli scrocconi quanto piuttosto vandali e piantagrane. – La località geografica e la dimensione della risorsa ne dettano la gestione specifica. Un villaggio richiede sicuramente regole diverse da quelle necessarie per un fiume regionale o per beni globali come gli oceani.È più facile gestir e beni comuni di proporzioni ridotte rispetto a quelli di ampie dimensioni o a li vello planetario come l’atmosfera. – Occorre poter contare sull’esperienza e sull’impegno dei commoner. Le comunità indigene con secoli di tradizioni e pratiche culturali alle spalle c onoscono le pr oprie risorse assai meg lio di qualsiasi entità esterna. I programmatori esperti di software libero sono ben più affidabili dei n uovi arrivati nello sv iluppo di programmi e nel risolvere eventuali problemi. – Le condizioni stor iche, culturali e natur ali possono influenzare l’operatività dei progetti condivisi. È probabile che un paese c on una robusta cultura civica possa contare su istituzioni a sostegno dei beni comuni più sane ed efficienti, rispetto a nazioni dove la società funziona male e impera la sfiducia. – È importante avere istituzioni affidabili, trasparenti e accessibili ai commoner. Generalmente le entità più sensibili in tal senso sono realtà autogestite di proporzioni ridotte, ma è possibile immaginare istituzioni pubbliche che agiscano come scrupolosi fiduciari e intermediari. 38 Grazie alla sua ampia attività di ricerca, nel 2009 Lin Ost rom è stata insignita del P remio Nobel per l’ec onomia (insieme a Oli ver Williamson). Mi piace pensare che questo riconoscimento sia stato motivato dalla crisi economica globale dell’anno precedente, onde dare visibilità alla profusione di alternative esistenti al mercato tradizionale – forme di approvvigionamento e di gestione delle r isorse indi- 39 pendenti dal mer cato che si r ivelano parimenti produttive, stabili e sostenibile. Oltre ad aver creato una potente piattaforma analitica per studiare i beni comuni in maniera più rigorosa, l’obiettivo più consistente raggiunto da Ostrom riguarda forse il suo r uolo trainante nella creazione di una rete globale di studiosi sul tema dei beni comuni. Centinaia di accademici di ogni parte del mondo hanno prodotto una vasta raccolta di ricerche sociologiche, studiando soprattutto le risorse naturali condivise in Asia, America Latina e Africa. Gran parte delle dottrine accademiche sui beni comuni sono state elaborate, dibattute o rifinite durante i vari workshop in teoria e analisi politica, codiretti insieme al marito fin dal 1973 pr esso l’Università dell’Indiana a Bloomington, mentre la stessa Ostrom ha poi fondato la Digital Library of the Commons e la I nternational Association for the Stud y of Common-Pool Resources, una vasta r ete accademica che raccoglie centinaia di studiosi e praticanti. Oggi è facile notare come la grande forza delle sue analisi stesse proprio nella sua lontananza dall’ambito economico tradizionale. Questo ruolo di outsider le consentì di notar e immediatamente l’incapacità della teoria del liber o mercato di spiegar e tanti aspetti cr uciali nel contesto economico, tra cui l’innato interesse a lavorare in gruppo e a garantire l’uguaglianza interna. Come donna in una disciplina dominata dagli uomini (neg li anni sessanta e settanta il sessismo imperversava nel mondo accademico), Ostrom era interessata in particolare agli aspetti relazionali dell’attività economica, cioè al modo in cui le persone interagivano e contrattavano tra loro per arrivare a stabilire consuetudini e ac cordi sociali. Pur operando in base alle pr emesse dell’economia neoclassica, Ostrom contribuì non poco ad ampliare la portata delle sue analisi per includer vi molte di quelle dinamic he umanistiche e sociali disdegnate dai mandarini della disciplina fissati sui dati statistici. Interessante notare come la sua prominenza nel campo emerse per lo più dopo l’assegnazione del pr emio Nobel nel 2009. Nei decenni 40 precedenti lo studio dei beni c omuni e della pr oprietà condivisa era stato relegato ben al di fuor i dell’interesse degli economisti “seri”: molti tra questi non sape vano neppure chi fosse Ostrom quando ricevette il premio Nobel. Forse per gli studiosi d’economia concentrati sul mercato, la questione dei beni c ollettivi rivestiva scarso interesse perché sembrava indirizzata alla “sussistenza”, che interpretavano come mera sopravvivenza. Ma non è nec essariamente così: si t ratta piuttosto di provvedere ai bisogni della propria famiglia o comunità, anziché massimizzare i vantaggi del mercato e ammassare ricchezze. I beni comuni, quando vengono compresi appieno, incarnano la pratica e l’etica dell’autosufficienza. Ho avuto la fortuna d’incontrare un paio di v olte Lin Ostrom prima della sua scomparsa, nel giugno del 2012. Ne conservo il vivo ricordo di una persona incr edibilmente gentile, aperta e modesta. Un’osservazione che va ben olt re l’ambito personale, credo anzi che fossero queste sue caratteristiche a renderla un’intellettuale così fertile: era sempre disposta e int eressata a confrontarsi con persone e fenomeni d’ogni tipo, incurante dei profondi pregiudizi che allora dominavano il campo dell’ec onomia. Eppure Ostrom operava comunque all’interno del quadr o tradizionale e dei r elativi presupposti su “attori e design razionali” anche rispetto alla pratica dei beni comuni. Si occupò solo gener icamente delle dinamic he macroeconomiche e ancor meno del rapporto tra potere e politica, rivelando un approccio ai beni comuni di taglio funzionale e comportamentale, piuttosto che basato sulle dinamiche intersoggettive e psicologiche sottostanti. E sicuramente la “Bloomington School” merita un enor me riconoscimento per a ver salvato i beni c omuni dalla tir annia del mit o della “tragedia”. È davvero affascinante notare lo sv iluppo parallelo, al di fuor i del mondo accademico, di un esercito transazionale ed eclettico di attivisti e cittadini che hanno abbracciato la pratica dei beni comuni come principio organizzativo per le loro campagne tese alla trasformazione sociale. Probabilmente è questa la caratteristica primaria che oggi po- 41 ne la questione dei beni collettivi al centro delle dinamiche politiche, culturali ed ec onomiche. In ogni parte del mondo la gent e inizia a rendersi conto che il paradigma dei beni comuni può descrivere la loro vita quotidiana e i rapporti con le persone e le risorse circostanti. I programmatori di software e i contadini urbani, i popoli indigeni e i ricercatori accademici, chi pratica la permacultura e tessitori indiani, i cittadini di I stanbul che difendono Gezi P ark e gli attivisti di Slow Food, tutti noi che usiamo le biblioteche e i parchi pubblici: l’affinità esistente fra tutte queste esperienze non si manifesta necessariamente in senso intellettuale o scientifico, quanto piuttosto a livello personale e partecipativo. Per tanti commoner, il bene collettivo in quanto tale non rappresenta un “sistema gestionale” né tantomeno un “regime di governance”, quanto piuttosto un’identità culturale e uno stile di vita personale. È il modo per rivitalizzare la pratica della democrazia, uno strumento per vivere una vita migliore. Nelle pagine che seguono incontreremo da v icino alcuni di questi commoner. Per adesso ci basti dire che la maggior parte di loro sta cercando di ritagliare degli spazi protetti e al di fuor i del mercato, in un mondo sempre più dominat o dalla pr oprietà privata e da st rutture economiche di stazza g lobale. Pur con la diversità di obiettivi e approcci autodefiniti, costoro aspirano a costruire un’infrastruttura di tipo diverso capace di portare all’affermazione dei beni comuni come settore autonomo oppure a int egrarli nel mer cato in manier a più umana e responsabile. In alcuni casi l’attenzione rimane focalizzata a livello interno, puntando allo sviluppo della propria banca cooperativa, del bosco in comune o del wiki online. In altre situazioni, si preferisce invece premere per nor mative e politic he pubbliche favorevoli alla nascita e allo sv iluppo di beni comuni locali, dove lo Stato possa svolgere un ruolo benigno o propiziatorio. In altri casi ancora, la questione dei princìpi collettivi viene intesa come uno strumento importante per l’affermazione di posizioni sociali ed ec onomiche anticapitaliste, opponendosi così allo Stato neoliberista. In breve, l’interesse nei confronti dei beni comuni, un tema irrego- lare un tempo confinato per lo più al mondo ac cademico, è andato esplodendo in campi d’ogni tipo. O più precisamente, il linguaggio e le dottrine che oggi descrivono quel che è sempre esistito a livello inconscio e implicito, vanno conquistando maggior spazio a livello culturale. Un’attenzione diffusa che spinge l’emergere di un fiorente ecosistema transnazionale fatto di attivismo, progetti e analisi t eoriche. Questa narrativa centrata sull’impegno di svariate comunità di pratica sta inoltre innescando un’eccitante integrazione tra idee e partnership di vario tipo, insieme alla magg iore comprensione della pratica dei beni comuni in quanto tale. Mi piace immaginare tutto ciò come un movimento vernacolare, più che una corrente politica o ideologica, nell’accezione descritta dall’iconoclasta intellettuale Ivan Illich, particolarmente nel libr o Shadow Work del 19813. Criticando le tendenze disumanizzanti delle istituzioni moderne, Illich considerava gli spazi vernacolari come zone culturali dove si esprimono giudizi morali e si agisce autonomamente in base alla propria umanità sovrana. Il vernacolare rifiorisce nel contesto della comunità e della sussistenza, nella vita famigliare e nell’educazione dei figli; emerge negli spazi condivisi dove la gente asserisce collettivamente i propri valori morali e gli interessi politici, al di sopra e diversamente da quelli dello Stato, delle corporation e di altri poteri istituzionali. Citando uno degli studenti di Illich, Trent Schroyer, la sfera vernacolare evoca «una sensibilità e r adicalità... in cui per g ran parte del passato e ancor’oggi la vita locale si fonda su comunità orientate alla convivialità e alla sussist enza». Il vernacolare consiste di quei «luoghi e spazi dove ci s’impegna per ottenere la rigenerazione e la restaurazione sociale contro le forze della globalizzazione economica». Quest’aspetto di atemporalità e mistero associato con il vernacolare, come forse qualche lettore avrà immaginato, è particolarmente vicino ai beni c omuni – i quali r appresentano un’entità e una sensibilità sociale emergenti in mod o spontaneo proprio dalla cultura verPer maggiori dettagli, si veda: https://it.wikipedia.org/wiki/Ivan_Illich 42 3 43 nacolare, come sospinti da una pulsione vitale. E che cercano invariabilmente di affermarsi e prosperare pur di fronte a potenti istituzioni con priorità e interessi assai diversi. A volte i commoner riescono a ottenere riconoscimenti positivi da parte di tali istituzioni, ritagliandosi un’area protetta per lo sviluppo e la gestione dei beni collettivi. Per esempio, i cittadini c he curavano degli orti urbani a New York City hanno dovuto lottare non poco per tenerli in vita di fronte ai piani di sviluppo edilizio. Spesso i v illaggi di pescatori lungo la costa devono vedersela con pescherecci industriali che spazzano via enormi quantità di pesci per i mer cati globali anziché per il solo fabbisog no locale. E gli attivisti digitali devono fronteggiare le norme sul diritto d’autore e la demagog ia delle corporation che considerano la condivisione di materiali online al pari di un’attività criminale (“pirateria”). La storia ha dimostrato che le enclosure, cioè le arbitrarie recinzioni imposte dal mercato, sono crudeli e implacabili nel voler frammentare e distruggere queste comunità di pratica, perché non ne apprezzano la competizione. Ogni successo a livello di beni comuni autogestiti è un “cattivo esempio”, dato che testimonia la concreta possibilità di alternative migliori. La condivisione va biasimata anc he perché è un affronto all’ideologia stessa del diritto alla proprietà privata (con l’ipocrita eccezione di aziende high-tech come Google and Facebook, il cui modello imprenditoriale poggia sulla monetizzazione delle nostre condivisioni sui social media). Da par te loro, l’apparato pubblico e burocratico spesso mostrano diffidenza nei confronti di beni comuni indipendenti e potenzialmente pericolosi, preferendo piuttosto le certezze e le r icompense dei soggetti legati al mer cato. Generalmente le strutture amministrative preferiscono gestire le risorse tramite rigidi sistemi di controllo standardizzati, perché considerano queste esperienze condivise del tutto informali, irregolari e inaffidabili – anche se i loro successi sul campo stanno lì a c onfutare un simile pregiudizio. Ne consegue che per comprendere al meglio la pratica dei beni comuni occorre necessariamente prendere in esame le dinamic he e il significato di queste enclosure – tema a cui è dedicato il capitolo successivo. Le enclosure del mondo naturale 44 Cosa succede quando il mercato diventa talmente potente da sconvolgere gli ecosistemi naturali, riorganizzare la v ita della gente e reclamare il diritto di proprietà sulle forme di vita? A volte è difficile uscir fuori dalla cultura in cui siamo immersi per constatare l’effettivo potere e gli effetti di lunga por tata del mercato. Ma una volta imparato a identificare i beni comuni e comprese al meglio le loro dinamiche, diventa piuttosto chiaro che la privatizzazione e la mercificazione della ricchezza pubblica condivisa costituiscono uno dei grandi scandali non riconosciuti della nostra epoca – e i suoi per niciosi effetti sono visibili dappertutto. In base a quest o processo, spesso definito le enclosure dei beni comuni, le corporation sradicano le r isorse dal loro contesto naturale, spesso con l’approvazione e il sostegno dello Stato, per poi dichiarare che occorre stabilirne il valore in basi ai prezzi di mercato. L’obiettivo è la conversione dei beni usati e c ondivisi da molti in r isorse possedute e controllate da entità private, per poi trattarle come beni di consumo scambiabili sul mercato. Parlare di queste enclosure significa avviare una conversazione che raramente la dottrina economica tradizionale vuole affrontare: in gioco c’è l’espropriazione ai danni dei commoner, man mano le forze del mercato assumono il c ontrollo dei beni c omuni, spesso c on l’attiva collusione dell’apparato statale. Il tipico dibattito su “privatizzazione contro proprietà statale” non rende giustizia all’intero processo perché neppure l’intervento governativo, il supposto antidoto alla privatizzazione, è una soluzione vera e propria. In molti casi, lo Stato è fin troppo ansioso di allearsi c on il sett ore industriale per assumer e il 45 controllo delle risorse comuni al fine dello sfr uttamento “privato”. E troppo spesso la r egolamentazione è una farsa c he punta più a legalizzare che a sradicare gli abusi del mercato. Esaminare il tema delle enclosure significa perciò fare diretto riferimento ai beni comuni e ricontestualizzare l’intera discussione. Parlare di queste recinzioni artificiali porta in primo piano gli effetti antisociali e anti-ambiente insiti nel “libero mercato” e convalida la pratica dei beni comuni come un’alternativa appropriata e non di rado efficace. Qualche anno fa sono v enuto a sapere di un caso di enclosure moderna che replicava in maniera inquietante il modello medie vale dei terreni agricoli. Per oltre un secolo, il v illaggio di Camber well, nella fertile regione della Hunter Valley nel New South Wales, in Australia, aveva fatto uso collettivo di una piana allu vionale vicino al Glennies Creek, affluente del fiume Hunter. È qui che residenti tenevano mucche e cavalli, mentre i figli ci andavano per pescare, per farsi una nuotata e per andare a cavallo. Nell’aprile del 2005, secondo il quotidiano Sydney Morning Herald, «si sono presentati due funzionari del Ministero per la tutela del territorio, che hanno chiamato a raccolta i membri del Common Trust di Camberwell per informarli che quel terreno pubblico sarebbe stato immediatamente confiscato e consegnato alla miniera di Ashton che incombe sul v illaggio di Upper Hunter sotto forma di una c ollina completamente scavata dall’altra parte del fiume». Quell’intervento non era altro che l’ennesimo esempio di uno Stato che approfitta della sua autorità per sequestrare dei terreni demaniali a scopo industriale. Come spiegò a un g iornalista il seg retario del Common Trust di Camber well: «Alle r iunioni della comunità con i rappresentanti dell’azienda miner aria, questi parlano sempr e di ‘quando’ riceveranno l’autorizzazione, non ‘se’ la otterranno». In queste situazioni, l’industria mineraria e il go verno ne hanno r icavato vantaggi notevoli: la prima ha ottenuto l’accesso a basso costo a risorse minerarie con scarsi controlli ambientale, mentre nelle casse stata- 46 li sono finiti circa 1,5 miliardi di dollari in royalty e tariffe varie per la transazione. Invece i cittadini locali non possono c erto dirsi così fortunati. Nel caso di Camberwell, le continue esplosioni dell’attività mineraria scavarono dall’interno le colline tutt’intorno al villaggio. Buona parte della comunità si sfaldò, secondo quanto riportava il SidneyMorning Herald: quasi due t erzi degli abitanti del v illaggio rinunciarono a lottare contro l’azienda mineraria e si trasferirono altrove. Quest’esperienza è il classico caso di enclosure di beni naturali voluta dal mercato e assistita dallo Stat o. Le autorità statunitensi consentono all’industria mineraria di operare sui terreni pubblici in base al Mining Act del 1872, una normativa rimasta invariata per oltre 140 anni e grazie alla quale le aziende minerarie possono estrarre oro, argento e ferro al prezzo ridicolo di circa dieci dollari l’ettaro. Si è stimato che l’erario pubblico ha perso così oltre 245 miliardi di dollari a causa di questa legge, in aggiunta alla rovina di montagne e fiumi stupendi con i residui degli scavi e altri rifiuti. Oggi queste vicende rappresentano la norma in ogni parte del mondo, dall’industria del leg name che violenta le for este demaniali alle aziende petrolifere che trivellano in aree naturali incontaminate, dai pescherecci industriali che decimano le z one di pesca lungo le c oste alle multinazionali dell’acqua imbottigliata che prosciugano le falde acquifere. In America Latina, le multinazionali fanno combutta con i governi neoliberali per impor re aggressive politiche “neo-estrattive”. Come spiega la professoressa argentina Maristella Svampa, l’idea di fondo è quella di dare via libera a mega-progetti capaci di estrarre con la massima efficienza miner ali, metalli, idrocarburi, granturco, soia e alt re materie prime grezze dell’intero continente per poi espor tarle nei paesi industrializzati. Spacciando tutto ciò c ome l’unico percorso possibile per garantire il progresso e lo “sviluppo”, oggi decine di dighe, miniere, autostrade e altre attività neo-estrattive stanno portando all’annientamento di interi ecosistemi, comunità e culture autoctone. Tra le enclosure più famigerate troviamo il megaprogetto mine- 47 rario Conga in Perù, la diga idroelettrica Belo Monte in Brasile e la costruzione di un’autostrada nell’area protetta del TIPNIS ( Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure) in Bolivia. Le enclosure sono una forma particolare di furto organizzato che attira scarsa attenzione, in parte perché le autorità statali svolgono un ruolo cruciale nel legittimarle. Si tratta comunque di risorse che appartengono a tutti noi, oppure a specifiche comunità locali, che vengono trasformate in proprietà imprenditoriali e discariche pubbliche. I terreni, l’acqua, i tessuti umani, le aree pubbliche, l’atmosfera: tutte materie prime da piazzare sul mercato. E i rifiuti risultanti dalla conseguente monetizzazione v engono scaricati nuovamente sulle spalle dei beni comuni, imponendo così ulteriori rischi e costi alle istituzioni pubbliche e ai cittadini. Anche se quest e recinzioni forzate sono abbellit e dal linguagg io e dalle copertine patinate del progresso, dell’efficienza e dello sviluppo, si tratta in realtà di appropriazioni brutali, di un abuso di potere spesso affermato tramite la c oercizione violenta. L’appetito delle g randi corporation sembra non conoscere limiti, dall’estrazione di minerali dal fondo dell’oceano all’appropriazione dei segreti genetici della flora esotica nel sud del mondo alla messa sott o copyright di qualc he spartito musicale – per poi accusare di “pirateria” chiunque si azzardi a condividerli. È importante notare che le enclosure non comportano soltanto l’appropriazione delle risorse, bensì rappresentano veri e propri attacchi ai danni delle comunità e delle pr atiche condivise. Pur avendo come obiettivo primario la confisca illegale dei beni collettivi, finiscono per imporre alla gente un “cambiamento di regime”, e convertono un sistema basato sulla gestione c ollettiva e la r eciprocità sociale in una struttura di mercato che privilegia la proprietà privata, il valore economico, le relazioni commerciali e il consumismo. In tal modo le persone vengono considerate solo come individui e consumatori separati tra loro, non in quanto comunità che condividono interessi di lunga durata e disgiunti dal mercato in quanto tale. 48 Il risultato finale di tutt e le recinzioni forzate è la disper ata dipendenza da strutture imprenditoriali esterne che giurano fedeltà soltanto al mercato globale. Chi usa il softwar e Microsoft deve acquistarne continuamente gli aggiornamenti per gar antirsi l’efficace funzionamento del computer. I contadini che optano per le c olture geneticamente modificate ogni anno devono comprare nuovi semi e ader ire alle restrizioni contrattuali. Quanti s’impegnano a tutela dei modi di vita tradizionali devono vedersela continuamente con coloro che vogliono solo di ventare ricchi e abbr acciano l’ideale oc cidentale dello “sviluppo”. Come scrive lo studioso dei beni comuni Massimo De Angelis, «più ci affidiamo al mercato e al denaro per soddisfare bisogni e desideri, e più ci esponiamo al cir colo vizioso della dipendenza c he contrappone tra loro i diversi sistemi di vita». Non sorprende il fatto che le enclosure tendono a interferire con la capacità della gente di auto-organizzarsi e controllare la governance locale, di soddisfare i propri bisogni e di pr oteggere la loro cultura e lo stile di v ita. Una città che s’indebita con un investitore o una corporation esterni perde rapidamente la pr opria sovranità civica per trasformarsi in una “urbanità imprenditoriale”. Infine, le enclosure minano alla base quelle t radizioni e identità che sono strettamente intrecciate con un paesagg io incontaminato, un monumento storico o un’opera culturale. Quando certi tesori – il design tribale degli aborigeni australiani, le piante speciali coltivate in Madagascar – vengono strappati dal loro contesto storico o naturale e ridotti a semplice mercanzia, si dà il via a un vero e proprio assalto ai danni delle comunità che li hanno gestiti c oscienziosamente da tempo, instillandovi obiettivi e significati specifici. È tramite simili pratiche coercitive che questi tesori si vedono espropriati delle qualità che li rendono unici a livello locale e significativi sotto il profilo emotivo – per trasformarli, nel bene e nel male, in poco più che inerti beni di consumo. Breve storia del movimento delle enclosure in Inghilterra Generalmente il t ermine enclosure viene associato con l’omonimo movimento che si manifestò nel Regno Unito in diversi momenti nell’epoca medievale e poi nel XIX secolo. In breve, il re, l’aristocrazia e/o i latifondisti decisero di sottrarre alle comunità locali i pasc oli, i boschi, la sel vaggina e le sorgenti usate dalla popolazione, per poi dichiararle loro proprietà privata. A volte queste appropriazioni indebite avvenivano con la formale approvazione del parlamento, mentre in altri casi bastava la forza br uta. Per tener fuori la gente del posto, in genere si ricorreva allo sgombero forzato e si piazzavano steccati o siepi divisorie. Sceriffi e bande di teppisti perlustravano il nuovo territorio del so vrano per t enere alla larga og ni commoner che provasse a cacciarvi di frodo. L’uno per cento dell’Inghilterra medievale non poteva resistere alla tentazione di recintare i terreni demaniali per la semplice ragione che ciò gli consentiva di accumulare rapidamente potere e ricchezza con il pieno sostegno della legge. Grazie a questa pr atica, qualche barone decaduto e la pic cola nobiltà in asc esa potevano consolidare il lor o potere politico e rimpinguare la proprietà di terreni, acque e selvaggina. Una poesia anonima di protesta del XVIII secolo descrive bene la situazione: La legge sbatte dentro l’uomo o la donna c he ruba l’oca che appartiene a tutti, ma lascia fuori i gran villani che fanno fuori la comunità prendendosi le oche. 49 La legge c’impone di fare ammenda quanto prendiamo cose che non ci appartengono, ma ignora i gran signori e le gran signore che s’appropriano di cose che sono tue e mie. Poveri e miseri non la scampano se c omplottano per infrangere la legge; è giusto così ma devono subire quelli che complottano per fare la legge. La leggesbatte dentrol’uomo o ladonnache rubal’ocache appartiene a tutti, e le oche non saranno più in c omune finché non si va a r ubargliele di nuovo. 50 A subire le conseguenze del fenomeno sempre più esteso delle enclosure furono gli abitanti dei v illaggi inglesi, che dipendevano dai boschi per la legna da ardere e per i tetti di paglia, dalle ghiande per nutrire i maiali, dai campi in c omune per le c olture e dalle pr aterie aperte per la provvista di frutti e bacche selvatiche. L’intera economia rurale poggiava sull’accesso a una varietà di beni collettivi. Impossibilitati a usare quei beni c omuni, furono costretti a emigrare nelle città, dove l’emergente rivoluzione industriale li trasformò in schiavi salariati, quando andava bene, oppure in poveri e mendicanti, se le c ose andavano male. Charles Dickens mise in evidenza il malcontento sociale e le ingiustizie delle enclosure in Oliver Twist, Great Expectations e altri racconti che descrivono i travagli del sottoproletariato londinese. Un obiettivo importante di queste recinzioni forzate era quello di trasformare persone accomunate da interessi collettivi in singoli consumatori e salariati – ovvero, in attori del mercato economico, poiché i diabolici mulini della rivoluzione industriale necessitavano di schiavi obbedienti e disper ati. Uno degli aspetti meno e videnti dell’intero fenomeno fu inoltre la separazione tra la produzione e la gestione dei beni comuni, entrambi parte del medesimo pr ocesso in cui er ano coinvolti tutti i membri della comunità. Con l’arrivo delle enclosure, il mercato s’incaricò della produzione e le istituzioni della go vernance degli affari pubblici – nacque così lo Stato moderno. E anche se questo nuovo ordine portò a not evoli progressi nella pr oduzione delle merci, i costi da pagare furono terribili: la dissoluzione delle c omunità, profonde disuguaglianze economiche, l’erosione dell’autogestio- ne, la perdita della solidarietà e dell’identità sociale. La cura degli affari pubblici divenne competenza del governo, un settore riservato a politici, avvocati e burocrati di professione, oltre che agli interessi economici di specifiche lobby. La partecipazione democratica si ridusse per lo più al voto, un diritto limitato agli uomini (e inizialmente soltanto a chi aveva qualche proprietà). E di fatto le enclosure allontanavano la gente dalla natura circostante, marginalizzando la vita sociale e spirituale di intere comunità. Nel corso di circa 150 anni, dalla fine del XVII secolo fino alla metà del XIX, la privatizzazione colpì circa un settimo di tutti i t erreni comuni in I nghilterra. Ciò portò all’approfondimento delle disuguaglianze sociali e al rapido incremento della povertà urbana. Venivano gettate così le fondamenta dell’ordine moderno centrato sul mercato, e i padroni di questo nuovo mondo non a vevano alcun bisogno dei beni comuni. I capisaldi del nuovo ordine sarebbero stati l’individualismo, la proprietà privata e il “libero mercato”. Lo storico ed economista ungherese Karl Polanyi (1886-1964) studiò da vicino questa specifica t ransizione nella storia dell’umanità – la fine dei beni comuni e la nascita delle recinzioni e del mercato. Nel suo classico del 1994, ampiamente sottovalutato, The Great Transformation 4, Polanyi rimarca che per millenni le popolazioni er ano state tenute assieme da comunità, religione, parentela e altri legami sociali o morali. Tutti i sistemi economici si fondavano su rapporti di reciprocità, di ridistribuzione o comunitari, e la gente era indotta a produrre qualcosa sulla spinta di «costumi e leggi, magia e religione». Con l’imposizione delle enclosure, furono la produzione e il profitto a imporsi come i princìpi organizzativi intorno a cui ruotava la società. Anziché concentrarsi sull’utilizzo collettivo all’interno di un contesto sociale stabile, la produzione venne così re-indirizzata verso il profitto e l’accumulazione privata. Ciò imponeva la ridefinizione di numerose risorse (soprattutto i terreni, il lavoro manuale e il denaro) Edizione italiana: La grande trasformazione, Einaudi 1974. 51 4 52 come beni di consumo – a cui Polanyi aggiunse l’aggettivo “fittizi”, per indicare che in realtà la vita umana e gli ecosistemi naturali non possono essere frazionati in unità fung ibili e intercambiabili. Il mercato impone però c he i doni della natur a, il la voro manuale e il denar o vengano considerati dei semplici beni di consumo, onde assegnare loro un prezzo e renderne possibile il commercio e la speculazione. Questi beni di c onsumo fittizi si sono subit o estesi ad altri ambiti, rendendo praticamente ogni cosa un oggett o della c ompravendita. Cibo, acqua, combustibile, legna da ardere e altre necessità quotidiane – una volta disponibili come diritto acquisito grazie ai beni comuni – adesso dovevano essere acquistati soltanto tramite il mercato, in base a prezzi prestabiliti. Secondo Polanyi, l’imposizione delle enclosure ha rappresentato «la rivoluzione dei ricchi contro i poveri. «… Nobili e gran signori decisero di stravolgere l’ordine sociale corrente infrangendo usanze e leggi del passato, talvolta ricorrendo alla violenza e più spesso alla pr essione e all’intimidazione». Man mano che l’economia di mercato guadagnava spazio, la relativa logica basata sui beni di c onsumo andava imponendosi su tutto (dalla natura al lavoro manuale alla vita quotidiana) per assegnare un prezzo a qualsiasi cosa. Ovviamente Karl Marx è riuscito a illustrare perfettamente le dinamiche dell’accumulazione del capitale e c ome queste siano riuscite a modellare il luogo di lavoro, a colonizzare la vita sociale e a depauperare le risorse pubbliche. Gran parte delle sue critiche politico-economiche riguardano proprio le feroci recinzioni private dei beni collettivi. Tuttavia Marx si occupò relativamente poco dei beni c omuni in quanto fucina di r esistenza oppure come fonte generativa di produzione e riproduzione sociale. Ciò fu sicuramente dovuto al fatto che lo sviluppo più sig nificativo di quell’epoca r iguardava l’incredibile spinta della modernizzazione capitalista, e quindi individuò i collettivi dei la voratori moderni come veicolo ideale per cr eare strutture condivise di tipo nuovo. Il fenomeno del land grabbing internazionale 53 Molti credono che queste enclosure siano reliquie del passato, qualcosa che succedeva nel Medio Evo, non certo oggi. Eppure non è affatto così. Attualmente vaste regioni in Africa, Asia e America Latina subiscono le pratiche di accaparramento su larga scala di t erreni agricoli da parte di potenti entità straniere. Corporation e governi nazionali stanno acquisendo milioni di ettar i di territori usati per gener azioni dalle popolazioni locali, le quali però raramente sono in possesso dei documenti attestanti tali proprietà; come dicono gli avvocati del settore, ne hanno soltanto il «diritto di utilizzo consuetudinario». Il titolo di proprietà vero e proprio appartiene allo Stato, che in teoria dovrebbe agire in nome del popolo, ma in realtà succede che i paesi più autocratici e a corto di fondi considerano piuttosto vantaggioso ignorare questi doveri pubblici e vendere porzioni enormi di terreni “senza proprietari” agli acquirenti stranieri. Oltre a fare buoni affari con questa pseudo-legalizzazione, le autorità riescono anche ad assicurarsi un nuovo gettito fiscale – e i funzionar i ben ammanicati possono tranquillamente intascare cospicue tangenti. In teoria, tutto ciò dovrebbe portare allo “sviluppo” e alla prosperità diffusa. In pratica però le cose stanno diversamente. Certi investitori usano questi t erreni agricoli per pr odurre biocombustibili oppure colture commerciali da esportare sul mercato globale. Altri sono speculatori che preferiscono lasciarli incolti, sperando di rivenderli in futuro a prezzi maggiorati. L’Arabia Saudita ha sborsato un miliardo di dollari per 700.000 ettar i in Africa, mentre l’India ha messo insieme cordate d’investitori per ac quistare vasti poder i, e anc he Corea del Sud e Cina sono in piena attività. La recinzione di terreni consuetudinari sta assumendo pr oporzioni globali, provocando il trasferimento forzato di molte comunità locali. Si stima c he circa il 90 per c ento della popolazione dell’A frica subsahariana, ovvero qualcosa come 500 milioni di persone, non possiede titoli di proprietà formali sulle sue t erre e r ischia di esser ne espulsa. 54 Particolarmente a rischio sono i cittadini della Repubblica Democratica del Congo, del Nord Sudan, dell’Etiopia e del Madagascar. Nel mondo sono circa due miliardi le persone che vantano soltanto il diritto di utilizzo consuetudinario sui loro terreni, cioè 8,54 miliar di di ettar i. Una volta espropriate, queste terre non potranno più essere usate dalle popolazioni autoctone per le c olture, l’acqua o la sel vaggina: le enclosure stanno distruggendo intere comunità e la loro cultura. In base alle teorie economiche del libero mercato, la trasformazione delle terre in proprietà private per poi scambiarle sul mer cato finirà per moltiplicare la produttività. Un processo che si presuppone possa spingere i proprietari a produrre più cibo e a mig liorare gli appezzamenti in modo da incr ementarne il valore. All’opposto, i terreni collettivi privi di titoli di proprietà sono stati storicamente definiti “terre desolate” – in base al presupposto che, agli occhi della legge, non c’è nessuno che le possiede o se prende cura. Basta però andare le oltre le favole del libero mercato per scoprire migliaia di beni comuni stabili e sostenibili che garantiscono la sussistenza a milioni di persone. Non sorprende perciò sapere che il land grabbing sta causando patologie analoghe a quelle derivanti dalle enclosure: abusi ec ologici, decimazione delle c omunità, carestie, disuguaglianze sociali e migrazioni forzate verso le città alla r icerca di cibo e lavoro. Tutt’a un tratto queste persone verranno sfrattate per ritrovarsi espropriate e catapultate nell’abbagliante universo del consumismo moderno e della povertà delle baraccopoli: l’oscena replica di quanto avvenuto in Inghilterra all’alba della rivoluzione industriale. «Alla luce del fatto che la maggioranza dei beni allocati agli investitori sono basati su locazioni a medio termine rinnovabili fino a 99 anni», scrive Liz Alden Wily, esperta sui diritti di proprietà fondiarie, «è ragionevole prevedere che la perdita delle proprietà comuni negherà l’accesso, l’utilizzo e altri benefici di tali t erre ad almeno una gener azione e potenzialmente fino a quattro generazioni». Si tratta della ricetta ideale per decenni di carestie, povertà e turbolenze politiche. A un certo punto della storia, i paesi imperialisti han- no soggiogato con la forza militar e intere popolazioni per pot erne sfruttare le risorse. Il processo neocolonialista ha preso avvio in maniera più r affinata, ricorrendo agli strumenti legali per c onsentire a investitori e speculari stranieri di concludere rapidi affari con governi amici ed accentratori che vedono di buon oc chio il saccheggio delle terre autoctone. Cosa può esserci di più lucrativo della vendita privata del patrimonio pubblico a prezzi stracciati? La privatizzazione dell’acqua L’acqua è un’altra di quelle r isorse che oggi state prese di mira dalle multinazionali. La maggior parte di noi considera l’acqua potabile un servizio pubblico fornito dalle strutture pubbliche o quantomeno gestito dalle stesse comunità. Eppure per molte corporation non si tratta altro che di un prezioso bene di consumo privato che può rivelarsi una cospicua fonte di profitto. Ciò ha spinto diverse imprese e investitori a c omprare innumerevoli riserve acquifere sotterranee, a estrarre enormi quantità d’acqua potabile dai terreni pubblici pagando poco o nulla e a privatizzare le stesse aziende municipali. A volte queste enclosure dell’acqua vengono implementate in maniera indiretta. Per esempio, le corporation possono decidere di costruire costosi sistemi di purificazione, trattamento o desalinizzazione, anche quando la conservazione e la regolamentazione preventiva costerebbero meno e risulterebbero più efficaci – ma, ahimè, non offrono alcun ritorno sugli investimenti. Il feroce land grabbing internazionale attualmente in corso spesso è solo un alt ro nome per “water grabbing”. L’avvio di questaserie continua di “guerre dell’acqua”5 risale al 2000, quando la Banca Mondiale, in cooperazione con un consorzio internazionale guidato dalla multinazionale ingegneristico-edilizia BechPer ulteriori dettagli si veda: Vandana Shiva, Le guerre dell’acqua, Feltrinelli 2004. 55 5 56 tel, fece pressione sugli amministratori di Cochabamba, allora terza città per grandezza della Bolivia, affinché approvasse la privatizzazione del sistema municipale. La logica della politica ufficiale er a quella di fornire incentivi alle imprese private per migliorare l’infrastruttura e quindi l’accesso alle fonti d’acqua potabile. Ma in realtà queste “soluzioni di mercato” puntano assai più a moltiplicare i profitti che a garantire l’accesso pubblico. Dopo essersi assicur ata il c ontrollo della fornitura d’acqua a Cochabamba, la Bechtel aumentò le tariffe del 50 per cento o anche più, vietando perfino la raccolta dell’acqua piovana dai tetti. In questo caso l’acqua divenne così una proprietà privata sotto il diretto controllo di una corporation statunitense. Nottetempo si for mò così un mo vimento di pr otesta spontaneo. Migliaia di comuni cittadini scesero in strada al grido di «l’acqua è vita!». La Coordinadora per la difesa dell’acqua e della vita intimò al governo di rescindere il contratto quarantennale con la Bechtel per riportare l’acqua sotto l’amministrazione municipale. I manifestanti chiedevano anche la «riappropriazione sociale della ricchezza» – cioè, la sovranità sul controllo del sistema idricoe l’assegnazione della gestionecollettivaagli stessi utenti. Emersa a poc hi mesi dalle for ti proteste anti-globalizzazione di Seattle nel 1999, l’insurrezione di Cochabamba confermò senz’ombra di dubbio c he la g lobalizzazione del commercio puntava assai più a tutelare i profitti delle aziende quotate in borsa c he a soddisfare le necessità umane e ambientali fondamentali in maniera equa e sostenibile. Alla fine i cittadini di Cochabamba cantarono vittoria, portando alla cancellazione del contratto con la Bec htel e galvanizzando nuove iniziative tese all’autodeterminazione e al controllo comunitario nell’intera America Latina. A quindici anni di distanza, quelle pr oteste vengono ancora ricordate come uno dei primi grandi trionfi popolari contro la pr ivatizzazione dell’acqua. La guer ra globale però è tutt’altro che conclusa. Il magnate americano Boone Pickens ha sborsato oltre 100 milioni di dollar i per aggiudicarsi il diritto di sfruttamento delle falde acquifere nelle pianure settentrionali del Texas, fat- to che potrebbe rendere economicamente proibitiva la sopravvivenza di molte comunità locali, man mano c he l’acqua va di ventando un prodotto privato e proprietario. In ogni parte del g lobo le multinazionali continuano ad appropriarsi delle falde sotterranee per poi imbottigliarne l’acqua – sebbene le aziende municipali siano in grado di fornire quasi quatt romila litri d’acqua potabile allo st esso prezzo di una bottiglia d’acqua commerciale al dettaglio. Le corporation dell’alimentazione 57 A volte le enclosure riguardano cose che i commoner possiedono soltanto a livello morale oppure in eredità, come la biodiversità del mondo naturale. Mancando una specifica comunità di riferimento, queste risorse comuni sono particolarmente vulnerabili perché non c’è una struttura organizzata capace di opporsi al sequest ro forzato, motivo per cui vengono considerate alla mercé di chiunque decida di appropriarsene. Un buon esempio r iguarda la c oltivazione delle mele neg li Stati Uniti. Un secolo fa, gli americani potevano scegliere tra oltre 6.500 varietà diverse dai nomi esotici, come Scollop Gillyflower, Red Winter Pearmain e Kansas Keeper. Quando si t rattava di mang iarle e cucinarle, ognuno aveva le sue favorite, generalmente privilegiando le varietà locali e differenziando tra le mele migliori per fare le torte, quelle per il sidro o per la salsa. Un quadro che ha subit o brusche trasformazioni. Nel XX secolo l’industria alimentare s’impose a livello nazionale, eclissando la pr oduzione e la distribuzione locale e portando alla sostanziale scomparsa della diversità dei frutteti. Certe varietà vennero abbandonate perché non potevano essere spedite a causa della buccia troppo fine e della tendenza ad ammaccarsi facilmente. Altre erano troppo piccole oppure interessavano una fetta minima del mercato. Alla fine, furono le deliziose rosse a prevalere sul mercato probabilmente perché grandi e lucide (grazie in parte a uno strato invisibile di cera). 58 Il punto è che la drastica riduzione della varietà dei frutteti fu dovuta all’intento di creare mercati nazionali e int ernazionali da par te dell’industria agricola commerciale, la quale non aveva alcun interesse a sostenere la diversità o la peculiar ità della frutta, perché mirava alle economie di scala e alla c oncentrazione imprenditoriale. Venne così pianificata deliberatamente la blanda omogeneità delle mele allo scopo di incrementarne le vendite. Oggi, scrive il giornalista-contadino Verlyn Klinkenborg, «nel 90 per cento del mercato nazionale [statunitense] circolano appena undici varietà, e le sole deliziose rosse ne coprono quasi la metà». La rigogliosa diversità naturale delle mele è stata c osì domata e azzerata, mentre gran parte di quelle r imaste si coltivano con facilità e possono essere distribuite e vendute in grandi quantità a bassi c osti. Soltanto le persone più anziane r icordano che le mele di una v olta avevano una gran varietà e prosperavano localmente – oltre a essere ben più saporite. Invece il resto di noi ha do vuto accettare come un dato di fatto l’odierna penuria. Una coltura assai popolare è stata costretta a conformarsi a un mercato irreggimentato e altamente mercificato. Fortunatamente oggi il movimento per la sovranità alimentare a livello locale – Slow Food, agricoltura comunitaria, fattorie biologiche, permacultura e via di seguito – sta portando alla rinascita della diversità delle antiche varietà ormai cadute in disuso. Questi tentativi trovano motivazione non soltanto nella reintroduzione di sapori stimolanti e nella magg ior facilità di coltivazione di semi g ià adattatisi alle condizioni locali, bensì anc he nel r iconoscimento della biodi versità genetica come un impor tante elemento di “assicurazione ecologica”. Per esempio, anche se nel mondo esist ono un mig liaio di var ietà di banane, l’industria ha imposto la qualità Cavendish al 99 per cento del mercato dell’esportazione. Grazie all’imposizione di queste monoculture, la fornitura globale delle banane rischia di essere decimata da un fungo tellurico che attacca gli alberi di Cavendish. Il destino delle mele e delle banane r iflette più in gener ale quello dell’intero sistema alimentare americano. Come ha documentat o Mark Kurlansky nel libro del 2009 The Food of a Younger Land, la diversità culinaria statunitense era ben più ampia pr ima dell’arrivo dei grandi supermercati, del sist ema autostradale nazionale e dei fastfood Le catene di ristoranti hanno introdotto uniformità e bassa qualità, soppiantando tutta una ser ie di prodotti freschi e stag ionali, di piatti regionali e tradizionali. Quando l’alimentazione era ben radicata nelle culture locali, influenzava direttamente il carattere, le attitudini e l’identità della popolazione. Prima che le abitudini alimentar i degli americani cadessero sotto il dominio dell’indust ria nazionale, scrive Kurlansky, c’erano piatti t radizionali come «la c olazione di maggio del New England meridionale, il lavaggio dei piedi in Alabama, i par ty alla C oca Cola in Georg ia, la t rippa di maiale fr itta in North Carolina, la cucina per la t rebbiatura in Nebraska, il funerale Choctaw e la festa del salmone degli indiani Puget Sound. Né mancavano le antic he ricette tradizionali come i t ortini al g ranturco nel Rhode Island, la zuppa di ost riche a New York City, opossum e patate in Georg ia, lattuga appassita in K entucky, lo spezzatino di B runswick in Virginia, la testa di vitello in Louisiana», oltre a decine di altre. L’espansione globale delle corporation Usa nel dopo-guerra ha causato l’enclosure di innumerevoli tradizioni culinarie di ogni parte del mondo. Mentre i marchi e le catene di fast-food occidentali andavano imponendosi da Bang kok a Bogotá e da M umbai a Mosca, prodotti alimentari spinti da massicce campagne pubblicitarie hanno sostituito la cucina t radizionale “del passato”. Il cibo quotidiano è di ventato più omogeneo e assai meno nutritivo, portando all’annessa proliferazione di malattie associat e con la dieta oc cidentale (diabete, obesità, problemi cardiaci). 59 Terre, acqua, mele, piatti locali: solo alcune delle recinzioni forzate ai danni della natur a perpetrate nel c orso delle ultime gener azioni. Il furto delle r icchezze naturali ha r icevuto scarsa att enzione perché 60 condotto in modo incrementale – e perché generalmente dipinto come un segno del progresso economico e tecnologico. Si tratta anzi di un’appropriazione indebita di vaste proporzioni, sia sul piano globale (l’atmosfera, gli oceani, lo spazio extraterrestre) sia su quello regionale (le falde acquifere, le zone di pesca, le aree boschive), e che colpisce esseri viventi (colture cellulari, geni, mammiferi geneticamente modificati) e cose infinitamente piccole (microrganismi, sostituti sintetici per la nano-materia). Una delle recinzioni forzate più audaci in quest ’ambito riguarda la cosiddetta finanziarizzazione delle risorse naturali. Anziché considerare i terreni, l’acqua e gli ecosistemi locali come risorse che rispettano gli imperativi della natur a, i fondi speculati vi e alt ri investitori hanno iniziato a sper imentare specifici st rumenti finanziari per la “cartolarizzazione” di quelle ent rate che possono essere generate da risorse naturali quali corsi d’acqua, legname e pesce. Secondo Antonio Tricarico, dell’associazione romana Re:Common, le agenzie d’investimento internazionale stanno cercando di creare un mercato del futuro basato su strumenti economici derivativi per la gestione dell’acqua, simili a quelli g ià esistenti per il settore petrolifero. In tal modo si fa pr essione sui governi per monetizzare e vendere i corsi d’acqua, le aree boschive e le zone di pesca, oppure per usarle a garanzia per eventuali prestiti. Nel mondo della finanza, le risorse naturali che non vengono sfruttate diventano beni con un debito troppo basso – in base al pr esupposto che qualsiasi c osa deve produrre delle entrate. Inutile aggiungere che questa finanziarizzazione della natura porterebbe all’incremento della pressione per disgregare ed esaurire tante risorse naturali, intensificandolo stress ai danni delle capacità rigenerative degli stessi sistemi naturali. Se, per esempio, l’acqua diventasse un bene di c onsumo da scambiare all’interno di un mer cato globale integrato, gli ecosistemi locali ne v errebbero devastati e molta gent e non potrebbe più permettersi l’accesso a una risorsa vitale. Tricarico spiega che negli anni a venire questo ricorso alla finanzia- 61 rizzazione della natura non farà che aumentare, poiché gli investitori internazionali puntano a rimpiazzare la finanza pubblica per mettere in piedi una pr opria infrastruttura di ampie pr oporzioni e a vviare progetti estrattivi a vantagg io degli investimenti privati. L’industria vuole sviluppare mercati dove cibo, terreni, elettricità, metalli, boschi e altre risorse non siano soltant o dei beni di c onsumo bensì anc he specifici asset finanziari soggetti al commercio globale e alla speculazione. Visto che al momento è impossibile pr evedere le implicazioni macroeconomiche di quest o diffuso r icorso alle enclosure, per non parlare dell’inevitabile distruzione ecologica che ne conseguirebbe, è plausibile ritenere che questi progetti siano la r icetta di un disast ro annunciato. Potrei facilmente citare qui altre decine di esempi di recinzioni della natura, ma credo sia più produttivo studiare in dettaglio la loro applicazione. Nelle pagine successive ci occuperemo perciò di due tipi di enclosure che non r icevono sufficiente attenzione: l’accaparramento privato degli spazi e delle infrastrutture urbane (capitolo 4) e le molteplici appropriazioni della c onoscenza e della cultur a (capitolo 5). Possiamo ben dire che queste recinzioni forzate hanno raggiunto un livello preoccupante quando, come succede oggigiorno, il mondo imprenditoriale arriva a r eclamare diritti di pr oprietà sulle par ole, sui colori e sugli odori! Le enclosure di spazi e infrastrutture urbane 62 La città è uno degli ambienti maggiormente ambìti dalle enclosure del mercato. Piazze, parchi, passaggi pedonali e c entri sportivi pubblici, anzi la stessa identità cittadina, stanno subendo l’assalto di una variegata alleanza composta da corporation, politici, sviluppatori, architetti e pianificatori professionali. “Sviluppo” e “progresso” sono i termini – o meglio, il codice usato dalle agenzie di PR – che indicano la supremazia dei vantaggi imprenditoriali e della cr escita del mercato su ogni altro interesse. In molte grandi città, il branding ha conquistato quegli spazi pubblici che una volta erano intoccabili nella nostra cultura. Tra gli esempi più notori spicca la vendita dei diritti sul nome delle arene sportive: dallo stadio Coca-Cola a Xi’an, in Cina, all’arena Land Rover a Bologna e allo stadio Mr. Price King Park a Durban, in Sud Africa. Negli Stati Uniti, amati campi di gioco che vantano storie affascinanti e assai care ai cittadini, come il Candlestick Park (San Francisco) e il Mile High Stadium (Denver), oggi sfoggiano aridi nomi di marchi commerciali che non pot ranno mai ispir are grandi leggende spor tive. A volte questi stadi de vono cambiare nome soltant o perché l’azienda omonima fallisce (3Com) oppure finisce in qualc he scandalo (Enron). Qualcuno potrà trovare banali le implicazioni della vendita di questi diritti sul nome oppur e della sovrimposizione di logo dig itali all’interno dei campi sportivi (altra pratica sempre più comune), eppure sono sint omatiche di un t rend ben più pr eoccupante: lo svuota- 63 mento della nost ra identità sociale. Le esperienze collettive che nel corso del t empo danno un ’anima alla città v engono considerate nient’altro che un’ulteriore bene di consumo da vendere e acquistare. A un livello più sottile, simili affiliazioni commerciali e operazioni di branding producono un effetto analogo sul nostro modo di v ivere la cultura: eliminano silenziosament e quelle car atteristiche distintive, uniche e affascinanti dell’esperienza urbana. Le trame diversificate di un luogo specifico, e la v ita pubblica che vi ruota attorno, vengono appiattite per massimizzarne l’attrattiva commerciale. Esemplare in tal senso l’enclosure imposta da Starbucks all’esperienza dei coffee shop negli Stati U niti. Ispirato dalla v ivace cultura del caffè che anima bar e r itrovi italiani, Howard Schultz, presidente di Starbucks, nel 2007 si most rò rattristato nel constatate come il successo dell’azienda nel «marcare l’esperienza dei clienti» avesse eroso la convivialità e il fascino sociale dei suoi 13.000 locali. In un promemoria interno, adeguatamente intitolato “La mercificazione dell’esperienza Starbucks”, Schultz lamentava il fatto che la forte espansione e le efficienti pratiche imprenditoriali «avessero portato ad annacquare l’esperienza Starbucks e a quella c he qualcuno pot rebbe definire la mercificazione del nostro stesso marchio». Proseguiva citando le nuove macchine automatiche per fare il caffè – una misur a efficiente per offrire servizi più veloci a una clientela sempre più vasta, ma che toglieva ai clienti il piacere di starsene a guardare il barista mentre preparava tutto a mano. Il suo rammarico riguardava cioè la «rimozione di gran parte dell’aspetto romantico e teatrale» dell’esperienza Starbucks. Analogamente, gli addetti «non prendevano più una mestolata di c hicchi di caffè per poi macinarli fr eschi ogni volta davanti ai clienti», perché adesso il caffè macinat o veniva in pac chetti sigillati per conservarne l’aroma – e g li astanti non pot evano più gustare il profumo pungente dei chicchi freschi. Schultz appariva piuttosto seccato, concludendo così: «Ovviamente bisogna razionalizzare il desig n e i ser vizi dei nego zi per r ealizzare economie di scala e gar antirci un ritorno sugli investimenti che sod- 64 disfi al meglio l’aspetto economico del nostro business. Tuttavia, uno dei risultati è che i nostri locali non hanno più l’anima di una v olta e riflettono anzi l’atmosfera delle tipiche catene di negozi rispetto invece a quella conviviale del bar di quartiere. C’è perfino qualcuno che li definisce asettici, tutti uguali e incapaci di rispecchiare la passione degli amanti del caffè. Anzi, non credo che oggi la gente sappia che noi tostiamo i chicchi di caffè che utilizziamo, e sicuramente non è questo il messaggio che viene trasmesso a chi frequenta i nostri locali». Possiamo definirlo il pathos dell’enclosure: Schultz non r iesce ad ammettere che proprio le sue aspirazioni tese ad affermare il marchio finiscono per eliminare l’atmosfera oziosa e quelle stranezze locali che rendono attraente il bar in quanto tale. Né può confessare che il branding comporta esattamente la creazione di una monocultur a, cioè la mercificazione dell’esperienza: l’esatto opposto di quello che offrono i beni comuni. La colonizzazione commerciale degli spazi pubblici – e della nostra stessa coscienza – ha raggiunto punti talmente estremi che oggi molte stazioni di r ifornimento e gli ascensori in albergo sfogg iano monitor che ci costringono a guardare o ad ascoltare degli spot pubblicitari. Man mano che scuole e università pubbliche subiscono tagli di bilancio, spesso le c orporation vengono loro in “aiuto” comprando spazi pubblicitar i sugli autobus scolastici, sui caselli aut ostradali e finanche sui veicoli dei servizi municipali. In molte città, perfino gli spazi vuoti al di sopra degli edifici sono stati trasformati in proprietà private di tipo particolare, da essere comprate e vendute come diritti a costruire grattacieli in spazi vuoti equipar ati a terreni edificabili. Ovviamente quanti sost engono la pr atica dei beni c omuni hanno un’idea ben più espansi va e par tecipata del contesto metropolitano. Ecco come la descrive il Pulska Grupa, un gruppo informale di architetti e pianificatori urbani attivo fin dal 2005 a Pula, in Croazia, nella sua Carta dell’urbanismo sociale comune: «Immaginiamo la città come uno spazio c ollettivo appartenente a tutti c oloro che ci vivono e 65 che hanno il diritto di trovarvi le condizioni per soddisfare le proprie esigenze a livello sociale, politico, economico ed ecologico, assumendosi al contempo il dovere alla solidarietà. Quest’idea della città è impedita dalla dialettica capitalista basata sulla differ enza tra beni pubblici e beni privati, da cui il mercato e lo Stato emergono come gli unici due soggetti esistenti. Noi vogliamo sfuggire a questa dialettica, per dar vita non a un eventuale “soggetto terzo”, bensì a un gruppo di soggettività collettive e ai beni comuni che queste sottendono». Il linguaggio usato dal Pulska Grupa contribuisce a riaffermare il diritto morale agli spazi pubblici e il dir itto all’accesso e all’utilizzo di questi spazi, oltre che a crearne di nuovi con gli strumenti e l’immaginazione personale, a fronte di un apparato burocratico che ignora i diritti umani e i bisogni sociali più fondamentali. In senso generale, è proprio questo il quadr o che ha car atterizzato anche il mo vimento Occupy, dove i cittadini interessati alla tutela dei beni comuni hanno occupato degli spazi pubblici come atto concreto di protesta contro le pratiche delle recinzioni oppressive. Un obiettivo che accomuna altresì tanti mo vimenti per il “diritto alla città” sorti in var ie parti del mondo e che oggi puntano a riappropriarsi di agglomerati urbani dove il design e l’operatività sono divenuti vittime dei pianificatori commerciali, dell’industria e dei super-ricchi. È importante tenere a mente che l’accesso a spazi pubblici aper ti e liberi è direttamente legato alla vitalità della cultura democratica. Non è stato certo per caso che, dopo la morte del generalissimo Franco in Spagna nel 1975, gli amministratori di Barcellona hanno creato tutta una serie di nuove piazze, spazi essenziali per consentire l’autoespressione dei cittadini in quanto forza collettiva pubblica – e per opporsi agli abusi di pot ere delle aut orità. Abbiamo visto come l’esistenza stessa di piazza Tahrir al Cairo si sia rivelata critica per ospitare le diffuse proteste popolari che hanno portato alla caduta dell’allora presidente Mubarak nel 2011. E questa è stata sicuramente la ragione chiave che nel 2013 ha spint o il presidente turco Tayyip Erdogan a t rasformare il Gezi Park di piazza Taksim a Istanbul in un c entro com- merciale, ricorrendo poi alla v iolenza per buttar ne fuori i manifestanti pacifici. Gli spazi fisici pubblici sono impor tanti per l’esercizio della democrazia, mentre la loro enclosure è sostanzialmente un atto antidemocratico. Quando i centri commerciali soppiantano le piazze cittadine e i brand imprenditoriali assumono il controllo di parchi e viali, allora abbiamo perso la capacità di v ederci come esseri umani interconnessi. Se non possiamo socializzare ed esprimerci pubblicamente, diventa difficile identificarsi e simpatizzare gli uni con gli altri. In definitiva, l’erosione degli spazi pubblici rende assai più ardua la pratica dei beni comuni. L’assenza di questi spazi ci c ostringe ad assumere i ruoli imposti dal mercato e dallo Stato – consumatori passivi e cittadini ossequiosi. La recinzione delle infrastrutture pubbliche 66 Uno dei modi più semplici per far e parecchi soldi è pianificar e un qualche tipo di appropriazione privata delle infrastrutture pubbliche. Autostrade, ponti, aeroporti, sistemi di telecomunicazione e perfino internet sono premi ambìti perché qualsiasi azienda c he dovesse acquisirne il controllo potrà intascarne i ricavi senz’alcun rischio, evitando la competizione e imponendo tariffe da regime di monopolio o di oligopolio. Tale controllo consentirà altresì di modellare le abitudini della gente in modo da spingerla all’acquisto dei relativi prodotti in cui la stessa azienda ha degli interessi commerciali. Negli anni scorsi Microsoft ha astutamente sfruttato il predominio su oltre il 90 per cento nel settore dei sistemi operativi (Windows) per incrementare la vendita delle relative applicazioni (Office, che comprende Word, Excel e P owerPoint), convincendo i pr oduttori di hardware a includere una versione ridotta di quest’ultimo pacchetto nel sistema Windows preinstallato sui loro computer. Grazie a questa strategia, i profitti della corporation sono saliti alle st elle, soffocando 67 la concorrenza e delineando i contorni del futuro mercato. Questa recinzione forzata dei beni c omuni degli standard tecnico-informatici, una risorsa chiave nel contesto delle infr astrutture odierne, ha consentito a Microsoft di rallentare l’innovazione per perseguire i propri interessi commerciali e ridurre la diversità delle applicazioni software disponibili. Di conseguenza, le decine di pr ogrammi di elaborazione testi in competizione tra loro sul mercato si sono ridotte a una manciata, e non appena qualche paese o governo locale ha provato a cambiare questa situazione, Microsoft è intervenuta aggressivamente per impedire l’introduzione del softwar e libero nelle amminist razioni pubbliche. Quando le infr astrutture rimangono aperte e accessibili a tutti ne vengono incentivate la c ompetizione e l’inno vazione all’interno del mercato, contribuendo altresì alla tut ela di alt ri ambiti sociali al di fuori del mercato stesso (tra cui la garanzia dell’accesso universale alle stesse infrastrutture, quali st rade, falde acquifere, internet) e proteggendo le esigenze delle prossime generazioni. Internet può rivelarsi anzi l’infrastruttura più significativa oggi a rischio. In molte parti del mondo le aziende telefoniche e della TV v ia cavo cercano di sfruttare l’oligopolio locale come una rampa privilegiata per l’accesso online, provando a imporre tariffe salate per servizi veloci e di alta qualità e una magg iore ampiezza di banda per car icare e scaricare rapidamente i file. Se dovessero prendere piede simili differenziazioni a livello di servizi e tariffe, ne risulterebbe una sorta di balcanizzazione di internet. Le grandi corporation potrebbero permettersi un simile accesso veloce e affidabile, mentre i comuni utenti e le entità non-profit rimarrebbero ferme al palo. Anziché consentire a internet di rimanere un bene c omune dove i dati possano cir colare in manier a aperta e non discr iminatoria, le aziende telefoniche e del via cavo vorrebbero censurare o rallentare il traffico che può minac ciarne da v icino gli interessi imprenditoriali. Per esempio, se questi fornitori volessero intralciare un servizio di telefonia online, come Skype, oppure una piattafor ma di v ideo-strea- ming in dir etta competizione con le lor o offerte (o quelle dei lor o partner), non ci penserebbero su due volte a bloccarli o rallentarli. È questo il moti vo che spinge tanti g ruppi a tut ela dell’interesse pubblico in ogni parte del mondo a insist ere sulla necessità di applicare specifiche normative a difesa della “neutralità della Rete”. Proviamo a immag inare se qualc he fornitore d’accesso dominante avesse potuto discriminare ai danni di Google quando era una fresca startup quindici anni fa, l’azienda non sar ebbe mai decollata a tal punt o nel mondo high-tech; oppure se i video su YouTube, nel suo periodo iniziale, avessero subìto filtraggi o r allentamenti imposti dalle aziende del via cavo. E immaginiamo le ricadute del blocco della competizione innovativa qualora i fornitori d’accesso online potessero dire “sì” oppure “no” al tipo di traffico a cui è consentito passare lungo i “loro” cavi. Ne risulterebbe il veto su certe tecnologie o servizi futuri di potenziale giovamento per tutti noi. Storicamente, nel sistema anglosassone le politiche che regolano il trasporto di beni e cose hanno garantito accesso e tariffe aperte e non discriminatorie anche alle linee telefoniche – norme adottate allo scopo specifico d’impedire alle aziende dominanti di soffocare la competizione. La c osiddetta “Net Neutrality” segue questa t radizione ed è uno strumento essenziale per assicur are che l’infrastruttura di internet venga considerata come un bene comune accessibile a tutti e privo di discriminazioni di sorta, non semplicemente come un asset proprietario imprenditoriale. In assenza di simili nor me, gli utenti digitali potrebbero vedersi sottrarre e perdere le libertà fondamentali del mondo online6. Questi tentativi di impor re delle enclosure ai danni di int ernet ricorda quanto già accaduto con le frequenze per le trasmissioni radio6 68 Nel febbraio 2015, la Federal Communications Commission statunitense ha approvato nuove norme in cui si stabilisce che internet è una “public utility”, riaffermando così la neutralità della Rete, una decisione invocata da decine di milioni di cittadini e che sta portando ad analoghe normative di tutela in altre parti del mondo. Per ulteriori dettagli si veda: https://it.wikipedia.org/wiki/Neutralit%C3%A0_della_rete. 69 televisive via etere in molti paesi del mondo. Negli Stati Uniti lo spettro elettromagnetico per queste trasmissioni appartiene al pubblico, e inizialmente alle aziende di pr oduzione, in cambio dell’autorizzazione all’uso g ratuito di un ’importante infrastruttura pubblica, l’etere radiotelevisivo, veniva richiesto di agire in qualità di “fiduciari pubblici” con l’obbligo legale di servire «l’interesse, la convenienza e le necessità del pubblico». Per decenni, le reti di produzione radiotelevisiva hanno “pagato” per l’uso delle frequenze rispettando pochi e minimi requisiti, includendo cioè nel loro palinsesto anche notizie locali, programmi per bambini e didattici. Queste norme vennero però eliminat e durante la massic cia deregulation voluta dall’amministrazione Reagan negli anni ottanta e poi da quella Clint on nel decennio successivo. Gli operatori del libero mercato decisero semplicemente di rescindere l’impegno preso dall’industria, dichiarando sfacciatamente che quanto decideva il mer cato equivaleva all’interesse pubblico. Le reti di produzione si accaparrarono così l’esclusivo controllo legale su un bene pubblico prezioso che valeva miliardi di dollari, senza dover sborsare un solo centesimo! L’appropriazione indebita dell’infrastruttura dell’etere da parte delle corporation (con l’assistenza dei politici liber ali, va agg iunto) ha consentito al mercato di dettare il tipo e la qualità della pr ogrammazione radiotelevisiva, portando così all’infinita ser ie di reality show, ammiccamenti sessuali, volgarità e violenza che abbondano oggi sulle reti TV americane – per non parlare di spot e “suggerimenti” pubblicitari che arrivano a coprire fino a venti minuti per ogni ora di programmazione. Ma non basta. Una nuova frontiera nella recinzione forzata delle infrastrutture pubbliche statunitensi riguarda i tentativi di Wall Street di comprare strade, ponti e aer oporti finanziati per anni dai c ontribuenti. Le agenzie d’investimento vorrebbero acquisire una par tecipazione di capitale oppur e contratti di locazione a lungo t ermine di infrastrutture civili, in modo da r icavarne profitti enormi e rischi irrisori. 70 Per esempio, nello Stato dell’Indiana alcune imprese hanno sottoscritto contratti di locazione della durata di 99 anni su un lungo tratto dell’autostrada interstatale 90 e sulla superst rada Chicago Skyway, imponendo in ent rambi i casi un pedagg io agli automobilisti. E la giunta di Chicago ha delegato a un’azienda privata, in parte proprietà di Morgan Stanley, la gestione dei 36.000 par chimetri sparsi in città, comportando l’introduzione di n uovi parchimetri dove prima non c’erano e il peggioramento della qualità del servizio. In seguito le autorità locali hanno r ilevato come quel c ontratto di pr ivatizzazione, pari a 1,15 miliardi di dollari, fosse stato sottostimato di 974 milioni. Esempi questi a riprova del fatto che oggi i cittadini e le amminist razioni hanno un peso sempr e minore nella gestione del sist ema pubblico. Spesso i leader politici fa voriscono simili accordi perché consentono loro di incrementare la pressione fiscale oppure di finanziare questi progetti con i fondi pubblici. Ma privatizzazione significa anche togliere il controllo dell’infrastruttura dalle mani dei cittadini i quali ne hanno già sostenuto i costi miliardari. E queste imprese private finiscono invece per trarne grossi profitti, portando al contempo a minore qualità, riduzione delle paghe degli impiegati e costi complessivi scaricati sulle generazioni a venire. Questa tipica dinamica è il moti vo per cui spesso le “partnership pubblico-privato” si rivelano nient’altro che truffe camuffate per abbindolare i contribuenti. Il governo si assume i rischi di eventuali fallimenti commerciali garantendo comunque esosi profitti alle aziende partner. Le varianti su questo tema di tipo “socialismo imprenditoriale” – dove cioè i profitti vengono privatizzati e i rischi invece socializzati – sono e videnti negli accordi stipulati dalle aut orità in sett ori quali acqua, energia, costruzioni autostradali e finanza. A volte simili sussidi camuffati prendono la for ma di gar anzie sui pr estiti, dove l’amministrazione pubblica si assume l’oner e di ogni debito insoluto nel caso di falliment o dell’azienda c oinvolta. Altre volte il sussidio prende la forma di schemi normativi che tutelano i guadagni dei for- nitori di acqua ed elettricità, riducendone al contempo i costi per l’infrastruttura, le r esponsabilità legali e i r ischi operativi. N egli Stati Uniti, durante gli ultimi dieci anni le amminist razioni locali hanno emesso obbligazioni esentasse super iori ai 65 miliar di di dollar i per ridurre i rischi economici degli investitori privati – tra i cui beneficiari figurano un’azienda vinicola in North Carolina, un campo da golf a Portorico, un museo di automobili d’epoca in K entucky e perfino Goldman Sachs e Bank of America, i cui mega uffici sono stati c ostruiti con appositi sussidi. 71 Una volta lo scrittore William Faulkner ebbe a dir e: «Il passato non muore mai, non è neppur e passato». Lo stesso vale per le enclosure: non si t ratta mai di episodi lontani e dimenticati dalla st oria, bensì continuano a esist ere e a pr ovocare danni ec ologici. All’ordine del giorno c’è l’incestuosa alleanza Stato-mercato, ben più c he il “libero mercato”. La portata e la mendacità di simili alleanz e vennero alla luce all’indomani della crisi economica del 2008, quando il governo federale si pr ecipitò in soc corso dei c olossi bancari e finanziar i, pur consentendo loro di sfrattare illegalmente milioni di amer icani dalle loro legittime abitazioni. Ovviamente i met odi usati per impor re queste recinzioni si sono evoluti parecchio dall’epoca medievale. Anziché muri di pietra e siepi divisorie, le enclosure moderne vengono applicate tramite trattati commerciali internazionali, leggi di proprietà, regolamentazioni permissive e privatizzazioni. Tuttavia gli elementi portanti di queste pratiche – furti camuffati, situazioni complesse, travestimenti convincenti – ci appaiono fin t roppo familiari. I gran signori e le g ran signore continuano ad appropriarsi di cose che sono tue e mie, dandosi un gran daffare per distogliere la nostra attenzione dalle destabilizzanti ingiustizie provocate dalle loro enclosure. Le enclosure della conoscenza e della cultura Negli Stati Uniti, chiunque si azzardi a intonare la tipica canz oncina di buon compleanno in un ristorante oppure in un parco pubblico è un “pirata”, nell’accezione affibbiata al t ermine dall’industria dell’intrattenimento. Ciò perché il Warner Music Group detiene il copyright su “Happy Birthday”, un motivetto messo insieme nel 1858 da due sorelle, Mildred e Patty Hill, ispiratesi alle canzoni folk dei ner i e a un brano intitolato “Good Morning to All”. Incredibilmente, un pezz o della metà del XIX sec olo inizialmente diretto agli scolaretti rimarrà proprietà privata fino al 2030, quando finalmente diventerà di pubblico dominio – 172 anni dopo la sua nascita “originale”. Nel frattempo il Warner Music Group ne intasca le royalties, pari a circa 5.000 dollari al giorno, ovvero quasi due milioni di d ollari l’anno. E gli avvocati specializzati nel diritto d’autore sembrano ignorare l’unica ragione che conferisce un valore commerciale a questa canzonetta, cioè il fatto che sia potuta circolare liberamente per generazioni, un tenace esempio di cultura popolare affermatasi al di fuori delle regole del mercato7. 7 72 Secondo lo studioso Robert Brauneis ci sono buone probabilità che il copyright su questo ritornello non sia neppur e valido. Dopo a ver condotto estese ricerche, nel 2010 Brauneis scriveva fra l’altro: «Esistono seri dubbi che i giudici possano considerare “Happy Birthday to You” ancora sotto copyright, viste le difficoltà di stabilirne con precisione l’autore originario e le inesattezze presenti della domanda di r innovo, che sembra interessare soltanto specifici arrangiamenti del brano anziché l’intera canzone». Dato però che nessuno ha un incentivo economico tale da giustifica- Attenzione, però: questa st oria è tutt ’altro che un’aberrazione. Si tratta piuttosto di uno degli innumerevoli esempi odierni della recinzione imposta ai beni c omuni culturali. Nel 2001, dopo aver toccato con mano tant e storie simili, ho c ontribuito alla nascita di P ublic Knowledge, associazione non-profit con base a Washington, D.C., impegnata a sostegno dell’interesse pubblico nel campo del diritto d’autore e delle politiche per internet.Quest’esperienza mi ha poi spinto a scrivere Brand Name Bullies, un libro che documenta alcuni dei casi più mostruosi di questa manipolazione delle nor me sul copyright e sui marchi registrati, avviata dai c olossi industriali per appr opriarsi delle nostre creazioni culturali. Mi sono c osì imbattuto nell’ingordigia dell’Ascap (American Society of Composers, Authors and Publishers), l’ente incaricato dell’intermediazione dei diritti d’autore che nel 1996 non ha esitat o a minacciare di adire le vie legali contro decine di campeggi estivi dedicati ai g iovanissimi – c olpevoli di cantic chiare delle canz onette sotto copyright. Secondo l’Ascap, in questi campegg i a pagamento, dove i ragazzini intonano qualche ritornello intorno al fuoco serale oppure nelle mense comuni, si organizzerebbero invece degli “spettacoli pubblici”. E le attuali nor me sul dir itto d’autore stabiliscono esplicitamente che gli spettacoli pubblici in cui si eseguono br ani sotto copyright sono soggetti al pagamento delle relative royalties ai legittimi detentori. Sembra che l’Ascap avesse richiesto il pagamento di 1.200 dollari a ognuno di questi campeggi stagionali come offerta iniziale, e all’epoca il responsabile dell’organizzazione spiegò a un giornalista che 73 re l’avvio della procedura giudiziaria, aggiungeva Brauneis, e che le attuali norme offrono scarsi appigli per invalidare un diritto d’autore anche nei casi dubbi, “Happy Birthday to You” rimane una proprietà privata. Basandosi su queste analisi, nel giugno 2013 la r egista Jennifer Nelson, che ha prodotto un documentario sulla storia della canzoncina, ha presentato formale denuncia collettiva (“class action suit”) per invalidare tale copyright e chiedere il rimborso delle royalties. Dopo alcune udienze e la contro-mozione della Warner/Chappell, a inizio 2015 i g iudici hanno richiesto nuove audizioni delle par ti. Per ulteriori dettagli e agg iornamenti, si v eda: https://en.wikipedia.org/wiki/Happy_Birthday_to_You#History_of_the_song. 74 «i campeggi comprano carta da disegno, funi e colla per le attività dei ragazzi, e quindi possono permettersi di pagare anche per la musica». Una volta che queste oltraggiose richieste giunsero all’orecchio dell’opinione pubblica, le proteste dei cittadini raggiunsero un tale livello d’intensità che l’Ascap fu costretta a fare marcia indietro. Fortunatamente oggi i ragazzi dei campeggi estivi americani possono continuare tranquillamente a intonare le loro canzoncine, anche se va sottolineato che ciò è dovuto alla gentile concessione dell’Ascap, non certo a un diritto legalmente riconosciuto. Questo, che può apparire un caso est remo, mette però in luc e una delle maggiori trasformazioni culturali avvenute nell’ultimo sec olo. Per quanto possiamo c onsiderare musica, film e fot ografie come il collante che tiene unita la società, in realtà questo è soltanto un effetto secondario. Agli occhi della legge, queste opere creative sono poco più che unità c ommercializzabili di “proprietà intellettuale”. Per gli studios di H ollywood, le g randi etichette discografiche e g li editori commerciali, valgono solo equazioni come cultura = prodotto e opere creative = proprietà privata. Siamo di fronte a un incr edibile stravolgimento storico della nostra cultura. Da tempo immemorabile, gli esseri umani hanno condiviso liberamente i prodotti della loro creatività. Fare cultura vuol dire imitare, ampliare e trasformare le opere precedenti, e l’arte ha sempre comportato l’atto di prendere in prestito le creazioni altrui a livello collettivo e int ergenerazionale. Il dr ammaturgo irlandese George Ber nard Shaw ha ripreso il mito greco di Pigmalione per l’opera omonima del 1912, che ha poi ispirato il successivo musical di gran successo My Fair Lady. Mentre l’altro noto musical West Side Story, lanciato a Broadway nel 1957, è chiaramente basato sul Romeo e Giulietta di Shakespeare, il quale a sua volta fece un’ampia opera di riciclaggio delle opere di Ovidio e di altri classici dell’antichità. Il romanzo Huckleberry Finn di Mark Twain (1884) deve non poco all’Odissea dell’antico poeta greco Omero, a sua volta centrata sulla tradizione orale. Per prosperare la cultura deve poter attingere a un bacino comune di creatività condivisa. 75 È impossibile immaginare la nascita del jazz, del blues oppure dell’hip-hop qualora ai musicisti fosse stato impedito di prendere liberamente in prestito le rispettive composizioni. Il grande cantautore folk americano Woody Guthrie (1912-1967) ha sempre ammesso con orgoglio di a ver cucito insieme st ralci ripresi dai v ecchi maestri del blues, dell’hillbilly e della cowboy music per le sue ballate. Prendendo anzi di mir a l’etica c ommerciale che già allora iniziava dominare il mondo musicale, lo st esso Guthrie scrisse: «Questa canzone è sotto copyright in Usa... per un periodo di 28 anni, e chiunque venga beccato a cantarla senza il nostro permesso diventerà un mio grande amico, perché non ce ne importa un bel n ulla. Pubblicatela, riscrivetela, cantatela, usatela per ballare o per farci uno yodel!». Il periodo di 28 anni a tut ela del c opyright in v igore all’epoca di Guthrie è stato esteso più volte, e oggi arriva fino a 70 anni dalla morte dell’autore. Apparentementequesta è la lunghezza delcontrollo monopolisticonecessaria per motivare una persona a creare qualcosa. Secondo la logica delle attuali norme, io non sarei sufficientemente motivato a scrivere questo libro a meno che non possa usufruire della tutela del copyright fino al 2100, anno più anno meno. Nel secolo scorso queste norme sono stat e modificate in manier a poco chiara per espandere a dismisura i diritti dei detentori del diritto d’autore. L’effetto più corposo riguarda la clausola della legislazione statunitense che dal 1976 impone il c opyright automatico per qualsiasi opera venga creata, compresi eventuali scarabocchi su un pezzo di carta oppure qualche accordo musicale casuale registrato su nastro. Non c’è più bisogno che un artista o il suo edit ore si diano la pena di iscrivere nell’apposito albo un lavoro qualsiasi per ottenerne la tutela: ogni nuova opera nasce automaticamente avviluppata nel diritto di proprietà privata. Uno standard adottato dalla maggior parte dei paesi (168 al settembre 2014) tramite la ratificazione della Convezione di Berna, un accordo internazionale del 1886 che stabilisce il riconoscimento reciproco del diritto d’autore tra le nazioni ader enti ed elimina la necessità di una registrazione formale. 76 Le drastiche trasformazioni nella portata di queste normative sono state seguite da intense campagne di PR finanziat e dall’industria dell’intrattenimento per convincerci del fatto che la musica, i film e i libri debbano essere considerati una “proprietà intellettuale” tanto sacrosanta quanto la nostra macchina o un immobile. Quest’accostamento tra cultura e proprietà privata si è rivelato insidiosamente efficace, pur se ingannevole, poiché è su tale base che l’industria ha potuto sostenere che qualsiasi utilizzo non autorizzato di un’opera creativa è un furto. Ne è r isultata la cr iminalizzazione del nost ro impulso natur ale a imitare e condividere – l’essenza stessa della cultura umana. È questo, in est rema sintesi, il pr oblema con cui dobbiamo c onfrontarci oggi. Le norme sul diritto d’autore e sui marchi di fabbrica, grazie all’apporto di n uovi “lucchetti tecnologici” che codificano il contenuto di D VD ed ebook, stanno por tando alla pr ivatizzazione sempre più gener alizzata della cultur a condivisa, consentendo alle grandi corporation di spremerne quanto più denaro possibile. Come vedremo più avanti, ciò limita la libertà creativa a ogni livello e porta all’omogeneizzazione culturale, erigendo barriere legali ai danni dell’innovazione, della ricerca scientifica e della libertà d’espressione. Come ha d ocumentato nei suoi noti sagg i lo studioso del dir itto d’autore James Boyle, ci troviamo nel bel mezz o del “secondo movimento di enclosure”, che fa seguito alle analoghe imposizioni avvenute nei secoli scorsi in Inghilterra già menzionate e che stavolta si concentra sulla super-privatizzazione delle opere creative, dell’informazione e della conoscenza. Questa tendenza, avviatasi da qualche decennio, ha subito una brusca accelerazione con l’arrivo delle nuove tecnologie elettroniche: videoregistratori, televisione via satellite e via cavo, personal computer, internet, smartphone, lettori per ebook e inn umerevoli altri dispositivi. Prima le parole erano stampate su fogli di carta, le immagini fissate sulla c elluloide e la m usica incisa nel v inile. Tecnicamente era troppo difficile est rarre i c ontenuti dal r elativo supporto, per i non esperti era troppo esoso e complicato copiare e condividere opere sot- 77 to copyright fissate su carta, celluloide o vinile. Ma con il passaggio al formato digitale di ogni produzione mediatica, e con l’affermazione di internet come strumento di comunicazione universale, è diventato piuttosto semplice per chiunque copiare e condividere questi contenuti. Con enorme dispiacere dell’industria, è diventato anzi piuttosto difficile tenere sotto controllo queste produzioni: i bit dig itali sono decisamente fluidi e t rasportabili. È quest o che intendeva nel 1984 Stewart Brand, il futurista della controcultura, quando profferì la battuta divenuta poi famosa: «L’informazione vuole essere libera». La questione di fondo è c he le n uove tecnologie stanno c ompromettendo quei business modelprofondamente radicati eredditizi che per quasi un sec olo hanno c onsentito agli studios di H ollywood, le major discografiche e ai grandi editori di prosperare alla grande. Queste grandi corporation non apprezzano il fatto che grazie alle nuove tecnologie perfino gli ultimi arrivati possano surclassarne gli antiquati modelli commerciali, rivendendo “contenuti” in maniera innovativa ed economica. In passato Hollywood considerava come pressanti minacce all’intera industria cinematografica perfino l’arrivo della televisione, delle t rasmissioni via cavo e delle v ideocassette, salvo poi rendersi conto che ogni invenzione in realtà apriva le porte a mercati nuovi e lucrativi per il loro stesso business. In base a questa tradizione, oggi gli studios sono indignati dal fatto che la gente ha il coraggio di usare spezzoni da film o pr ogrammi televisivi a scopo non commerciale e senz’aut orizzazione – un dir itto esplicitamente protetto dalla dottrina del cosiddetto “uso consentito”, inclusa nelle norme sul diritto d’autore internazionali. Per l’industria dell’intrattenimento il pr oblema non sta tant o nel flusso costante di nuove tecnologie che consentono di copiare, diffondere e fare il remix delle opere culturali, quanto piuttosto nel fatto che oggi i singoli individui possano creare e condividere le loro produzioni culturali in t otale autonomia. Non si de ve per forza comprare o vendere qualcosa: in un certo senso la creatività generata al di fuori del mercato, cioè tramite i beni c omuni digitali, si sta imponendo c ome 78 un tipo di c ompetizione nuova e r obusta alla t radizionale cultura commerciale. Hollywood e le grandi major discografiche hanno così deciso di fare pressione sui legislatori di ogni parte del mondo per ottenere tutele legali particolari. Si sono inoltre alleati con altre industrie mediatiche per imporre dei trattati internazionali più precisi per espandere i loro diritti e punire i “pirati” (in senso ampio). Si punta su norme più stringenti sul copyright, con sanzioni penali draconiane per l’uso non autorizzato delle lor o opere e l’imposizione di luc chetti tecnologici come il “digital rights management” sui CD musicali e i DVD dei film. Tutto ciò equivale a un vero e proprio blocco culturale generalizzato. Uno degli esempi più scandalosi r iguarda la feroce campagna lanciata verso la metà degli anni novanta dalla Walt Disney per estendere i termini della tutela del copyright di ulteriori vent’anni in Usa – nel timore che il suo personaggio simbolo, Mickey Mouse [Topolino], presente per la prima volta in breve cartone animato del 1928, potesse diventare di pubblico dominio nel 2004, con Pluto, Pippo e Paperone a seguire cinque anni dopo. Per impedire che chiunque potesse usare quei noti personaggi, la Disney diede avvio a un’aggressiva attività di lobby legislativa per l’approvazione del Copyright Term Extension Act, mostrando i muscoli tramite contributi politici alla maggior parte dei parlamentari che appoggiavano quelle norme. Nel 1998 venne infine approvata quest’estensione ventennale della tutela del dir itto d’autore, con la c onseguenza che qualcosa come 400.000 tra libri, film e canz oni destinati a ent rare nel pubblico dominio rimarranno invece sotto il controllo e la proprietà di entità private almeno fino al 2018 – c on una manna di decine di miliar di di dollari per i detentori dei diritti. L’ironia sta nel fatto che il copyright venne istituito per stimolare la creatività garantendo una r icompensa agli autori, ma o vviamente è impossibile che queste estensioni possano indurre George Gershwin, Joseph Conrad, Robert Frost, Lewis Carroll oppure F. Scott Fitzgerald a creare nuove opere. In realtà l’ampliamento dei termini non è altro 79 che un assurdo caso politico di protezionismo imprenditoriale. Pur di proteggere quel tre per cento delle sue pr oduzioni risalenti agli anni ’20 e ’30 che mantiene ancora qualche valore commerciale, la Disney e i suoi alleati sono r iusciti a mettere sotto chiave tutte le opere creative di quel periodo, compreso il 97 per cento che non è più neppure disponibile sul mercato. Un altro strumento fin troppo abusato per sfiancare i beni comuni culturali e proteggere il mercato è la normativa sui marchi registrati, che riguarda i nomi e i logo usati per identificar e le aziende e i lor o prodotti. L’obiettivo legittimo è quello di prevenire le truffe e la confusione ai danni dei c onsumatori, ma oggi le grandi corporation ricorrono sempre più spesso a quest e norme per c ontrollare strettamente la loro immagine pubblica e per impedir e che i comuni cittadini critichino o prendano in giro i loro prodotti. Per esempio, la Mattel ha querelato immediatamente chiunque ha provato a usare le immagini o il nome delle sue bambole Bar bie senza autorizzazione preventiva, compresi gli autori di commenti o parodie sui social media. Alcuni anni fa, l’azienda statunitense ha preso di mira un fotografo che aveva organizzato una mostra con delle foto in cui la bambolina assume va posizioni stupide o a sfondo sessuale, oltre ad aver costretto un piccolo editore a modificare il sottotitolo di un libro sull’anoressia in cui compariva il termine “Barbie”. Da parte sua, la McDonald’s ha minacciato di adire le vie legali contro decine di ristoranti che sfoggiavano nomi quali “McVegan,” “McSushi” o “McMuffin”, vincendo perfino una causa legale per infr azione al c opyright ai danni della cat ena di mot el “McSleep”. Forte dei suoi 35.000 locali operanti in 120 paesi del mond o, in pratica la corporation sostiene di vantare la proprietà globale del prefisso “Mc” nel campo della ristorazione e dei settori annessi. Simili abusi delle norme sui marchi registrati sono tutt’altro che rari. Una volta il settimanale newyorchese Village Voice cercò di bloccare l’inclusione della parola “Voice” nel nome del Cape Cod Voice e di altre testate locali. Né mancano i mar chi registrati sugli odori, come quello «dell’erba tagliata di fresco sulle palle da tennis», mentre la rete televisiva NBC è titolare di quello per tre note musicali di un carillon – “ding, dong, ding”! C’è da chiedersi se Andy Warhol sarebbe mai riuscito a creare la nota opera con le lattine di Campbell Soup, qualora le odierne norme sui marchi registrati fossero state in vigore cinquant’anni fa. La commercializzazione dell’università e della ricerca scientifica 80 Forse non appare ovvio a tutti che l’università in quanto istituzione è un «bene comune culturale organizzato», come la mettono i professori Michael Madison, Brett Frischmann e Katherine Strandburg nell’antologia da lor o curata nel sett embre 2014, Governing Knowledge Commons. Il sistema accademico si fonda espressamente sul paradigma dei beni comuni per incentivare persone di diversa estrazione a lavorare assieme onde gener are conoscenze nuove. È qui c he il flusso della conoscenza viene gestito come un sistema vivente, escogitando modalità innovative per organizzare, migliorare e presentare il sapere condiviso alle n uove generazioni. L’università rappresenta un c omplesso ecosistema che include tanti piccoli beni comuni interni, come i vari corsi e le specifiche scuole, i dipartimenti, le biblioteche, gli archivi, le aule per seminari ed eventi pubblici. Chiunque operi in un c ontesto accademico sa bene c he il linguaggio dei diritti di proprietà e delle t ransazioni di mercato è piuttosto alieno al suo ethos. Anziché vendere e comprare conoscenza, l’università sviluppa relazioni continuate basate sulla fiducia e la r eciprocità, promuovendo cooperazione e condivisione per incoraggiare la diffusione del sapere. Per esempio, rispettati docenti non hanno problemi a rivedere le ricerche dei diretti rivali senza neppure pensare per un attimo a farsi pagare per un ser vizio di cui poi finir anno per beneficiare ripetutamente. Ovviamente, il mondo accademico non è affatto 81 esente da antagonismi e r ivalità, ma nei cir coli degli studiosi v ige il presupposto che la conoscenza non debba mai diventare un prodotto brevettato – per rimanere invece aperta, condivisa e preservata. È anzi grazie a queste pratiche che l’ambito universitario può assicurare l’integrità delle sue ricerche, cioè tramite la trasparenza dell’analisi e del dibattito. La comunità è in g rado di amministrare al meglio la conoscenza, mentre ammassarla come una merce privata diventa non soltanto un atto d’ostilità verso la stessa comunità, bensì va contro il valore stesso dell’impegno accademico – il cui obiettivo non è quello di massimizzar e i profitti quanto piuttosto di far progredire laricerca della verità ed estirpare ognierrore.Ci sentiamo un po’ tutti responsabili nel monitorare le dinamiche dei beni comuni accademici per identificare chiunque tenti di avvelenare la verità con ricerche fasulle o con atti di plag io. In questo contesto, il merito concreto dei beni comuni sta proprio nella loro efficacia nel sostenere l’eticità delle attività universitarie, oltre a identificare (e sanzionare) i ricercatori approssimativi o ingannevoli e a sc oraggiare chiunque cerchi di privatizzare e commercializzare i progetti interni di ricerca. Eppure negli ultimi trent’anni abbiamo assistito alla netta erosione di quest’approccio etico. Oggi la pr ivatizzazione e la mer cificazione del sapere accademico e delle relazioni tra gli studiosi sono diventate una prassi comune. In tal senso il 1980 va considerato il punto di svolta nella storia dell’università moderna, quantomeno negli Stati Uniti. Lo stesso anno in cui R onald Reagan e Margaret Thatcher vinsero le elezioni e diedero il via a politiche sociali basate sull’aggressivo fondamentalismo del mercato, si ebbe la famosa sentenza della Corte Suprema sul caso Chakrabarty che spalancò le porte ai brevetti su batteri, geni, tessuti viventi e forme di vita naturali e create dall’ingegneria genetica. Oggi l’università di Harvard detiene il brevetto esclusivo sui cosiddetti onco-topi usati nelle r icerche di labor atorio sul cancr o, in aggiunta a quelli su 23 sostituti nano-sintetici degli elementi della tavola periodica. L’esistenza di br evetti sul t rattamento per il v irus del- 82 l’Aids significa che spesso i fondi pubblici v engono usati per mettere a punto medicine che poi verranno privatizzate e costeranno un occhio della testa. Mentre Big Pharma si arricchisce, i malati di Aids indigenti rischiano la morte. Una delle spinte più significative di quest’etica focalizzata sul mercato in campo biomedic o, fra i molti sett ori coinvolti, proviene dal Bayh–Dole Act, normativa approvata dal C ongresso Usa nel 1980 e poi replicata in molti altri paesi. Promulgata su esplicita richiesta dell’industria farmaceutica, chimica e biotecnologica, questa legislazione autorizza le università a privatizzare le ricerche condotte con i fondi pubblici e a brevettarne i risultati, spesso in stretta partnership con le grandi corporation. La legge incoraggia inoltre il settore industriale a collaborare con le università come fonti di ricerca e sviluppo (a basso costo e con il finanziamento dei contribuenti), onde poterle colonizzare e piegare alle sue mire commerciali a breve termine. Va da sé che ciò ha t rasformato troppi protocolli di studio e standar d etici e aumentato la tendenza delle amministrazioni accademiche a monetizzare le ricerche e gli studi scientifici, aprendo apposite unità interne incaricate di corteggiare le grandi corporation così da ricevere cospicui fondi per gli istituti di ricerca. Non c’è nulla di male in simili alleanze di per sé – ma purtroppo ciò ha portato alla c orruzione e a ser i conflitti d’interesse. Università e corporation hanno iniziato a reclamare brevetti su ricerche condotte grazie ai fondi pubblici per poi pr ivatizzarne i profitti. In altri termini, pur essendo i soldi dei c ontribuenti a finanziare gran parte delle sperimentazioni per i medicinali più impor tanti, spesso i tit olari dei relativi brevetti sono le università e le aziende, portando così a prezzi esorbitanti nella v endita al dettag lio. È quant o accaduto negli Stati Uniti per i farmaci per il trattamento dei disordini genetici, della depressione e del diabet e, oltre che per gli investimenti in ricerche che hanno portato a prodotti quali Vasotec e Capoten per l’ipertensione, all’antivirale Zovirax, agli antidepressivi Prozac e Zantac, a Taxol per il cancro e Xalatan per il glaucoma. I brevetti su questi e alt ri farma- 83 ci, pagati dai cittadini, appartengono alle corporation e ai loro azionisti. Le partnership tra università e sett ori industriali arrivano a c orrompere le priorità della ricerca accademica, spesso a det rimento di quegli studi a lungo termine che promettono importanti benefici per la collettività. Per esempio, anziché studiare le tecniche dell’agricoltura biologica e la gestione integrata dei parassiti, il dipartimento di biologia di una qualsiasi università, attratto dai finanziamenti industriali, potrebbe decidere di allearsi con la Monsanto per studiare le colture geneticamente modificate. Invece di in vestigare l’utilizzo del software Gnu/Linux e open source per aiutare i cittadini di paesi poveri (e r idurre altresì i c osti interni per i pr ogrammi informatici), un’università vincolata ai generosi contributi elargiti da Microsoft per le ricerche potrebbe considerare più vantaggioso orientare gli studenti verso progetti basati su quel software privato, ampliandone così ulteriormente la base d’utenza e di sv iluppo a danno della liber a competizione e dell’innovazione. Negli Stati U niti, Big Pharma ha c orrotto in manier a sistematica l’integrità della professione medica, come ha documentato in numerosi articoli la d ottoressa Marcia Angell, docente presso la H arvard Medical School. I professori d’un certo livello vengono pagati profumatamente dalle aziende farmaceutiche per consulenze e viaggi intorno al mondo. Non sorprende perciò l’enfasi posta dalla classe medica nazionale sulle virtù di terapie basate sui farmaci, rispetto invece ad alternative più a buon mer cato e spesso magg iormente efficaci. Nei soli Stati Uniti, quasi la metà della for mazione continua a livello medico viene finanziata dall’industria farmaceutica – una spesa che prevedibilmente finisce per influenzare l’obiettività della r icerca e delle raccomandazioni cliniche. La recinzione forzata dei beni c omuni a livello accademico ha causato tutta una serie di effetti a cascata, a partire dal declino dello spirito basato su c ollaborazione e c ondivisione. Quando le uni versità sottoscrivono accordi con le corporation, per tanti professori diventa 84 illegale condividere le loro stesse ricerche, perché queste diventano di proprietà altrui. Spesso g li sponsor indust riali insistono sulla soppressione di certi risultati delle ricerche che possano metterne in dubbio gli interessi commerciali. I r icercatori accademici e le amministrazioni universitarie, divenuti di fatto partner minori al soldo delle grandi corporation, finiscono così per ritrovarsi in complicati conflitti etici. Dovrebbero servire la collettività oppure fare gli interessi dei finanziatori privati? Le consuetudini universitarie basate su t rasparenza e condivisione dovrebbero forse avere la precedenza sui termini dei contratti di ricerca commerciali? Il rampante ricorso alla pr ivatizzazione del sapere accademico sta portando fra l’altro al cosiddetto fenomeno dell’ammasso di brevetti: la registrazione di una lunga ser ie di brevetti a cascata che rende difficile individuare gli specifici titolari e le relative autorizzazioni d’utilizzo. Il docente di diritto Michael Heller definisce questo problema la «tragedia degli anti-beni c omuni», per indicar e la fr ammentazione dei diritti di proprietà al punto da rendere difficoltoso per i ricercatori aggirare tali diritti e collaborare senza rischiare una querela. Per anni le ricerche sul cancro al seno sono state rallentate proprio dai brevetti posseduti da un’azienda biotecnologica dello Utah sui “geni suscettibili al cancro al seno”. Molti ricercatori accademici temevano di contravvenire a questi br evetti, ma per for tuna nel g iugno 2013 la Corte Suprema statunitense ha stabilit o che il genoma umano non può essere brevettato. Tuttavia questa tendenza verso l’accentramento rimane un serio ostacolo per nuove scoperte e per l’innovazione. Le partnership tra università e settori industriali comportano ulteriori effetti di una certa gravità. Possono stendere un velo di segretezza sui metodi di ricerca e ritardare la tempestiva pubblicazione dei r isultati, per consentire all’azienda sponsor di ac quisire i relativi brevetti prima dei diretti rivali e talvolta comportando la duplicazione di studi or mai inutili. Né mancano i casi di ricercatori che sono stati licenziati oppure si sono visti annullare le loro ricerche perché queste potevano mettere in imbarazzo i partner imprenditoriali delle loro stesse università. Storicamente lo Stato ha considerato gli studi accademici come un prezioso bacino di conoscenza collettiva, procedendo perciò a istituire università pubbliche, a finanziare importanti attività di ricerca e a r ispettare l’indipendenza degli studiosi. Un percorso storico da cui si ricava che le autorità pubbliche e i beni comuni possono lavorare assieme in maniera costruttiva. Tuttavia nel corso dell’ultima generazione, questa condotta etica è stata erosa non poco per via delle enclosure imposte dal binomio Stat o-mercato e della sc elta di impiegare le risorse per la crescita economica a breve termine. In tal modo ne soffrono l’innovazione e la competizione del mercato, e si provocano danni incalcolabili alla collettività e alla progettualità a lungo termine. I costi insostenibili delle enclosure 85 Questa breve panoramica sulle odierne recinzioni forzate vuole sottolineare i per icoli insiti nell’alienazione della natur a, della cultur a e delle relazioni sociali a vantaggio degli aspetti commerciali. Per massima chiarezza: è del tutt o plausibile per il mer cato e per i beni c omuni procedere di comune accordo. Se però il sist ema economico si spinge troppo oltre con le sue richieste e se insiste nel voler monetizzare cose che invece dovrebbero rimanere senza prezzo; se la por tata della proprietà privata viene estesa illimitatamente; se le aziende si ostinano a pr ivatizzare l’accesso alle r isorse fondamentali di pr ima necessità; se si consente ai monopoli di sopprimere la competizione e i valori prodotti al di fuor i del mer cato – allor a possono der ivarne danni enormi per l’intera collettività. Gli ecosistemi ne vengono deteriorati, le comunità perdono risorse vitali, il carattere stesso dell’ordine sociale r isulta modificato, gli interessi delle futur e generazioni compromessi – oltre all’erosione della libertà, dell’autonomia e della convivialità dei commoner. Un sistema che valorizza l’inclusione e il soddisfacimento delle necessità primarie viene così trasformato in un apparato di esclusione regolato dalla capacità dei soggetti di pagar e o 86 meno: un sistema che privilegia le grandi corporation rispetto a tutti gli altri cittadini. Lasciate senza controllo, queste attività di enclosure finiranno per distruggere le forze generative dei beni comuni accademici. Il quadro appena delineat o ribadisce l’importanza del linguagg io dei beni comuni, che ci aiuta ad affrontare al meglio la patologica tendenza del mercato a forzare la gente, le comunità e la natura a diventare “beni di consumo fittizi” all’interno del sistema commerciale e, al contempo, ci permette di apprezzare i beni comuni come un sistema capace di creare anche un enorme valore economico, evitando ingenti investimenti al mercato o allo Stat o. Consideriamo per esempio il modo in cui Lin ux, le banc he del sangue e Wikipedia gestiscono il flusso dei loro importanti progetti a livello di velocità, efficienza e fiducia. Il punt o davvero cruciale, eluso sist ematicamente dalla maggior parte degli economisti e dei politici, sta nel fatto che la pratica dei beni comuni è gravida di tutta una serie di qualità non misurabili, positive e specifiche. La sfida più urgent e è quella di t rovare strade migliori per tutelare l’integrità di queste pratiche e del valore che vanno creando senza far troppo rumore. La storia cancellata dei beni comuni 87 Uno degli effetti più insidiosi delle enclosure riguarda la loro capacità di sradicare la cultura e la memoria storica dei beni comuni. Il modo tradizionale di fare le cose; le pratiche sociali che una volta tenevano unite le comunità; le tradizioni culturali che legavano la gente al territorio; le norme etiche che garantivano un’identità stabile – tutte caratteristiche man mano spazzat e via per far spazio alla t otalizzante cultura del mercato. Le abitudini condivise cedono il passo all’individualismo, le t radizioni più amat e cadono v ittima di qualsiasi c osa funziona o costa meno al momento, i personaggi coloriti e il fascino specifico di ogni comunità vanno sparendo. Descrivendo in maniera memorabile la logica mercificante del capitalismo, Karl Marx ebbe a dire: «Tutto ciò che è solido si scioglie nell’aria». Le enclosure eclissano la storia e la memoria delle pratiche comuni fino a r enderle invisibili, mentre prende il sopr avvento l’etica dell’economia di mer cato, impersonale, individualista e basata sulle transazioni monetarie. Per poter comprendere appieno i beni comuni torna allora utile saperne di più sul loro passato, tanto ricco quanto dimenticato. La cultura capitalista pr eferisce credere che il per corso dell’umanità por ti inesorabilmente a un magg ior progresso, se non alla perfezione, fino a giungere all’attuale periodo storico, il migliore di tutti i mondi possibili. Invece la storia dei beni comuni, tanto complessa quanto sottovalutata, dipinge un quadr o ben di verso. Se ne r icava che gli esseri umani hanno appreso modi nuovi e ingegnosi per collaborare tra lo- 88 ro, mettendo in piedi istituzioni sociali innovative tese a obiettivi condivisi, pur avendo di fronte sistemi di potere (feudalismo, regimi autoritari, capitalismo) con tutt’altre priorità. Le pratiche dei beni comuni tendono a essere integrate all’interno di altri sistemi di potere e relazioni istituzionali, e quindi non sono del tutto indipendenti. Perciò spesso ne der iva una pr ofonda “tensione creativa” tra la loro logica e gli imperativi dell’ambiente ospitante (che si tratti dei signori feudali, del mercato tecnologico o delle legislazioni nazionali). Ecco perché tante esperienze legate ai beni comuni riescono a prosperare negli interstizi del potere, in “zone protette”, tollerate o sottovalutate dalle strutture istituzionali, oppure casualmente distanti da queste. La cruda realtà è che di per sé i beni comuni non arrivano a imporsi come forme istituzionali dominanti. Un ruolo subordinato che si ritrova nella fiorente pratica delle coltivazioni comuni durante il feudalesimo medievale, nelle associazioni di mutuo soccorso sotto i regimi socialisti e c omunisti e, in epoca c ontemporanea, nell’economia del dono che caratterizza il mondo accademico e le associazioni civiche nel capitalismo moder no. Tutte queste esperienze erano (e sono tuttora) integrate all’interno di più ampi sistemi di potere e raramente operano come forze sovrane a sé stanti. Comunque sia, la reciprocità e la cooperazione hanno dominato per millenni la storia dell’umanità, e l’arrivo della civiltà non fece che aggiungervi tradizioni legali mir ate a proteggere gli interessi condivisi delle generazioni passate e futur e. Raramente l’istinto umano della collaborazione trova espressione in for me puramente altruiste, tendendo piuttosto a operare in tensione creativa con l’individualismo e il potere. Anche se ci piace mettere in opposizione t ra loro i concetti di “individualismo” e “collettivismo”, nei beni comuni questi tendono a sfuocarsi e int egrarsi in maniera complessa. In realtà i due aspetti non si escludono a v icenda, bensì appaiono c omplementari in senso dinamico come nel concetto cinese di yin e yang. In questo capitolo proverò a illust rare alcuni dei t emi salienti che hanno caratterizzato lo sviluppo dei beni comuni nel corso dei secoli. I vari esperimenti storici smentiscono le affermazioni degli economisti contemporanei secondo cui, in buona sostanza, gli esseri umani sarebbero individui materialisti dall’appetito senza fine, tratti questi ritenuti universali. È piutt osto valido l’opposto: la v era aberrazione storica è l’idea stessa dell’Homo economicus e della società del mercato integrata a li vello globale. Mai prima d’ora l’aspetto economico aveva controllato così tanti elementi primari e secondari della società umana, e neppure quest’ultima ruotava a tal punto intorno ai principi della concorrenza commerciale e dell’accumulazione di capitale – elementi che sistematicamente portano agli eccessi dell’individualismo egoista, alle disproporzioni nella distribuzione della ricchezza e agli inauditi attacchi contro gli ecosistemi naturali. Un quadro piuttosto preoccupante, anche per v ia dell’instabilità e della fragilità dei sistemi economici complessi. A pochi anni della crisi finanziaria del 2008, le grandi potenze sono ancora indaffarate a ristabilire la fiducia, la credibilità e la stabilità sociale in molti mer cati nazionali. Che ciò avvenga tramite crisi o scelte ponderate, è virtualmente inevitabile che la razza umana (o quantomeno l’occidente industrializzato) finirà prima o poi per r iscoprire e reinventare l’istituto stesso della cooperazione sociale. Il ruolo della collaborazione nell’evoluzione umana 89 Considerando queste premesse sull’egoismo indi viduale, non sorprende sapere che gli economisti considerano il mondo un post o sgradevole e competitivo sull’orlo di degener are in anarchia, a meno che non intervenga lo Stato a calmare le teste calde e infliggere punizioni. Nel XVIII secolo toccò a un formidabile pugno di filosofi politici – John Locke, David Hume, Thomas Hobbes – delineare questa visione del mondo; nelle parole di Hobbes, la vita era «solitaria, scadente, disgustosa, bruta e corta». È su questi principi di egoismo uni- versale e “razionalità” individuale che sono stati poi eretti interi sistemi giurisprudenziali e di politica pubblica. Non potrebbe trattarsi invece di una v isione limitata del quadr o complessivo, una storia solo parzialmente accurata, che fallisce nel descrivere per intero le realtà concrete della natura umana? E non si potrebbe forse dimostrare che la cooperazione, la reciprocità e il c omportamento non r azionale sono forz e significative tanto quanto la “razionalità competitiva” e la “massimizzazione utilitaristica”? È questa la sorprendente conclusione a cui giungono gran parte degli studi odier ni sulla t eoria dell’evoluzione della specie, particolarmente in discipline quali neur ologia cerebrale, genetica, psicologia dello sviluppo e dell’età e volutiva, biologia, sociologia organizzativa, antropologia comparativa. Questi studi vanno c onfermando che la reciprocità sociale e la fiducia sono pr incipi profondamente integrati nella natura umana, e sembra perfino che possano far par te del nostro codice genetico. Uno dei primi ricercatori a esplorare quest’eventualità fu lo zoologo russo Petr Kropotkin nel suo t esto del 1902, Mutual Aid 8. Dopo aver attentamente studiato il regno animale, Kropotkin ne ricavò l’esistenza «di un’enfasi evolutiva sulla cooperazione anziché sulla competizione nel senso dar winiano di condurre al successo delle specie, compresa quella umana». Gli animali vivono in associazione tra loro e si aiutano a v icenda come modalità per mig liorare la coesione del gruppo. Tuttavia nel X X secolo la scienza ufficiale pr eferì imboccare una strada ben di versa, abbracciando il modello dell’egoismo r azionale per spiegare il comportamento e l’evoluzione degli organismi viventi. Nella teoria dell’evoluzione, la selezione natur ale è stata v ista come qualcosa che concerne i singoli, non il gruppo, perché nella gerarchia biologica della natur a l’individuo è c onsiderato l’unità pr ivilegiata. 8 90 Edizione italiana: Il mutuo appoggio. Un fattore dell’evoluzione. Biblioteca di Anarchismo 2012. Ne consegue che ogni adattamento evolutivo riguarda esclusivamente i singoli anziché un collettivo o l’intera specie, e gli studiosi hanno generalmente ignorato l’idea sec ondo cui i t ratti biologici “positivi per l’intero gruppo” possano essere trasmessi ed evolversi a livello collettivo. Tuttavia nell’ultimo decennio si è a vuta un’esplosione di nuove ricerche condotte da r ispettati studiosi, tra cui M artin Nowak, E. O. Wilson e David Sloan Wilson, i quali sostengono che la selezione a livello di gruppo s’impone come elemento significativo nel corso dell’evoluzione umana e animale. Le prove sul campo sugger iscono che gli adattamenti e volutivi avvengono a og ni gradino della ger archia biologica, incluso quello di g ruppo. L’idea di fondo è c he, mentre la cooperazione e l’altruismo possono dimostrarsi “localmente svantaggiosi” per i singoli indi vidui, appaiono invece specifici tratti di adattamento per il g ruppo. Citando E.O. Wilson e David Sloan Wilson: «L’egoismo batte l’altruismo all’interno del gruppo. I gruppi altruisti battono quelli egoisti. Tutto il resto è secondario». In estrema sintesi, gli scambi sociali reciproci sono al centro dell’identità, della cultura e delle comunità umane, in quanto funzioni cerebrali vitali che contribuiscono alla sopravvivenza e all’evoluzione della nostra specie. Anche se ovviamente non mancano le controversie, sembra proprio che gli esseri umani siano neurologicamente indirizzati verso l’empatia e la c ooperazione, sviluppando continuamente legami a li vello emotivo con gli altri. Come ha spiegato l’autrice americana Rebecca Solnit nel libro del 2009 A Paradise Built in Hell 9, i membri delle comunità colpite da catastrofi quali il terremoto del 1907 a San F rancisco, i prolungati bombardamenti aerei dei nazisti su Londr a durante la Seconda guerra mondiale e l’att entato terrorista del 9 sett embre 2011 in Usa, rivelano un incredibile livello di autosacrificio, gioia, determinazione e amore disperato gli uni per gli altri. Queste comunità colpite da disast ri immani si dimost rano dei veri e propri “paradisi Edizione italiana: Un paradiso all’inferno, Fandango Libri 2009. 91 9 92 nell’inferno”, e il libro va considerato una risposta a quegli economisti e leader politici per i quali al mondo esistono soltanto individui isolati ed egoisti c he devono essere governati attraverso la paur a e l’autoritarismo. «Forse l’aspetto più straordinario dell’evoluzione umana riguarda la sua capacità di generare cooperazione in un mondo fatto di competizione», scrive il biologo di H arvard Martin Nowak, aggiungendo: «Perciò la “collaborazione naturale” va agg iunta, insieme alla m utazione e alla selezione natur ale, come terzo principio fondamentale della teoria dell’evoluzione». Va da sé che la popolarità acquisita nella seconda metà del XX secolo dalla “teoria della selezione individuale” rivela un’inquietante coincidenza con ilperiodo di massimo splendoredella culturadel mercato edell’annessaeticadell’individualismocompetitivo: si tratta forse di un esempio dell’influenza dir etta della cultura sull’osservazione scientifica? Le recenti scoperte sulla teoria dell’evoluzione confermano dunque che gli organismi individuali operano all’interno di un complesso sistema d’interdipendenza. Ciò vuol dire che l’interesse personale e la sopravvivenza del gruppo tendono a convergere, rendendo piuttosto artificiale il pr esunto dualismo t ra “egoismo” e “altruismo”. Una situazione alquanto familiare per chiunque faccia parte di una qualche comunità online: l’interesse personale e quello c ollettivo diventano più o meno allineati e complementari, pur se di tanto in tanto disturbati da disaccordi interni e scossoni esterni. L’economista e sociologa statunit ense Elinor Ost rom ha studiat o centinaia di comunità che in ogni parte del mondo hanno implementato un proprio sistema gestionale basato sulla condivisione dei beni comuni, dando vita a un’etica cooperativa. Le sue ricerche hanno portato alla luce un’importante realtà etnografica: la pratica dei beni comuni può convincere i singoli individui a limitare il proprio interesse ristretto per dar e invece sostegno a un’agenda collettiva di magg ior portata. La notizia incoraggiante è che gli studi sulla teoria dell’evoluzione stanno confermando queste analisi anche al livello più elemen- tare della genetica, della biologia, della neurologia e della psic ologia evolutiva. L’impatto legale dimenticato dei beni comuni 93 La vita sotterranea dei beni comuni nell’ambito della teoria dell’evoluzione, che soltanto oggi trova riconoscimento, riflette un percorso analogo nel diritto giurisprudenziale. Anche se le normative applicate in queste situazioni risalgono all’epoca degli antichi egizi e all’Impero Romano, e hanno anzi caratterizzato l’intero periodo medievale in Europa, finora sono state ampiamente ignorate. E i capisaldi del diritto basato sui pr incìpi comunitari sono pr ofondamente integrati nella giurisprudenza occidentale, come rivelano le categorie legali della proprietà risalenti all’epoca romana, la Magna Carta emanata dal re d’Inghilterra nel 1215 e pr imo documento fondamentale per il r iconoscimento universale dei diritti dei cittadini, e l’annessa Car ta della foresta che nel 1217 r iaffermò il diritto dei cittadini al liber o accesso ai boschi appartenenti alla corona reale. Dato però c he la g iurisprudenza contemporanea è nettament e orientata verso il mer cato, questi pr incipi comunitari evolutisi nel corso dei secoli oggi sono per lo più dimenticati. Ciò è dovuto in parte al fatto che la t radizione occidentale tende a considerare il corpo giuridico come un sistema di regole scritte e di sanzioni amministrate da istituzioni pubbliche come parlamenti, tribunali e governi. Nelle moderne strutture politico-giuridiche non c’è posto per gli interessi collettivi (eccetto che nel caso delle società) perché in genere lo Stato è un sistema formale gestito dal governo e basato sui diritti individuali. Per comprendere le norme dei beni c omuni dobbiamo invece ampliare il concetto stesso di diritto. La legge non è soltant o qualcosa di formale, scritto e istituzionale, bensì include anche aspetti informali, orali e sociali. Il corpo normativo previsto da queste strutture rappre- senta una specie di minac cia al diritto formale, perché viene sostanziato e legittimato dalle pratiche sociali in c ontinuo divenire seguite dalla comunità stessa. Spesso le nor me che regolano la gestione dei beni comuni appaiono più sensibili e mor almente legittime di quelle statali, particolarmente quando lo Stat o si dimostra rigido, corrotto, incompetente oppure alla mercé del potere imprenditoriale. Ovviamente le legislazioni statali svolgono un ruolo assai costruttivo a livello sociale ed economico, soprattutto contro gli abusi o i comportamenti antisociali in azienda, come le discriminazioni razziali o di genere, ed è v ero che atteggiamenti ingiusti e t endenze criminali possono emergere perfino nelle c omunità informali. Qui mi pr eme semplicemente sottolineare il fatt o che un sist ema formale fatto di statuti, sentenze giudiziarie e sanzioni statali può condurre a forme di tirannia se non si adegua e si c onfronta con le situazioni concrete di tutti i giorni. Solo un robusto sistema di riscontri continui potrà aiutare il diritto formale a rispecchiare i punti di vista mutevoli della popolazione. In un brillante saggio del 2006, David Johnson, studioso coinvolto nel Center for Democracy and Technology, paragona il corpo legislativo a un organismo biolog ico10. La legge è più simile alla v ita che a una macchina statica, ci spiega Johnson, e quindi vanta un passat o e un’esistenza tutti propri: «Il diritto è un racconto che creiamo tutti insieme sulla giustizia e sui valori sociali condivisi, una storia che dobbiamo raccontarci un giorno dopo l’altro, perché si replica e persiste soltanto nella misura in cui continuiamo a riscriverla». Sostanzialmente è così che opera il dir itto all’interno dei beni c omuni. Una comunità crea un c orpo legislativo (informale, sociale) adeguato ai propri bisogni e poi lo riproduce attraverso le attività sociali quotidiane. È stata questa la modalità seguita dai gruppi che hanno dato vita al software open source, a Wikipedia e alle discipline ac10 94 The Life of the La w Online: http://pear.accc.uic.edu/ojs/index.php/fm/article /view/1314/1234. cademiche: comunità autorganizzate dotate di una specifica ser ie di procedure e consuetudini etiche autoimposte. A volte queste norme sono state perfino formalizzate all’interno dei sistemi statali convenzionali (statuti, regolamentazioni, sentenze giudiziarie), ma si t ratta di eventi rari. Come rimarca lo storico Peter Linebaugh: «I commoner non mettono in primo piano i titoli di proprietà, bensì quelli umani: come procediamo per l’aratura di questo terreno? Avrà bisogno di letame? E cosa ci pianteremo? Iniziano così a esplorare varie possibilità. Possiamo definirlo un atteggiamento naturale». L’elemento vitale del dir itto dei beni c omuni sta perciò nelle consuetudini, nelle usanze pratiche che operano come codice culturale per unificare l’etica sociale c on la c omunità e di ventano una nar rativa condivisa che funge da pont e con le generazioni precedenti e con le fonti di saggezza atte a stabilire il modo migliore per gestire le risorse locali. Come spiega la studiosa del dir itto di pr oprietà Carol Rose, queste usanze costituiscono «il mezzo tramite cui un collettivo apparentemente “disorganizzato” riesce a organizzarsi e ad ag ire, e in un certo senso perfino a “parlare” con la forza delle legge» 11. Ciò corrisponde alla definizione del diritto proposta da David Johnson, quando parla di una «identità organizzativa autoreferenziale» appartenente a coloro che l’hanno concepita, aggiungendo: «Se la legge ha una vita a sé stante, e arriva, per così dire, a stabilire una forma tutta propria di ordine e persistenza, dovremmo studiarne la biografia, anziché fingere di saperne progettare e riparare i meccanismi dall’esterno». In altri termini, soltanto osservando meglio le dinamiche sociali soggettive e interne dei beni comuni potremo individuare l’origine delle leggi. Quando si considera il corpo giuridico in questa prospettiva – non soltanto come un insieme di costituzioni e statuti formali ma piuttosto come un sistema autorganizzato creato dalla comunità per gestire 11 95 Per ulteriori dettagli si veda il suo sagg io del 1986, The Comedy of the Commons: Commerce, Custom, and I nherently Public Property: http://digitalcommons.law. yale.edu/fss_papers/1828/. 96 se stessa e le proprie risorse in maniera equa e ordinata – è facile notare che i beni comuni in quanto tali non sono altro che la personificazione del diritto stesso l’equivalente di un contratto sociale in evoluzione, dove i singoli si ritrovano insieme per negoziare le regole che dovranno governare la comunità. Spetta a queste norme specificare i dettagli sull’accesso e sull’utilizzo delle risorse condivise da parte dei membri, come pure definire la gestione di terreni, acqua, pesce e fauna selvatica, nonché le modalità del relativo monitoraggio e delle sanzioni nei confronti di chi disturba o fa lo scansafatiche. In questo senso più ampio, il corpo normativo dei beni comuni si perde nelle nebbie del passato e precede di diversi millenni la for mulazione di leggi scritte. Vista dall’esterno, l’evoluzione di queste norme in una cultura indigena potrebbe apparire lenta, perfino bloccata. In realtà, tuttavia, questo corpo normativo va adattandosi c ostantemente ai cambiamenti, spesso a piccoli passi, restando sempre attento alle realtà locali, il suo punto di forza. Le tensioni emergono quando le legg i formali, scritte appaiono decisamente incongruenti con quelle dei beni c omuni né lasciano spazi a queste forme di attività. La legge for male dello Stato è troppo rigida e intransigente, oppure è aperta al cambiamento tramite pratiche pacifiche e seguendo le necessarie procedure? È talmente modellata sulle r elazioni e le nor me del mer cato da escluder e la possibilità di una cittadinanza vera e propria? Nel corso della storia a volte le norme ufficiali hanno r iconosciuto il “diritto vernacolare” delle comunità (o quantomeno le necessità di un pubblico più ampio), formalizzandone i pr incipi nell’apparato giuridico dello Stato. Uno dei primi esempi rimanda all’Impero Romano, che riconobbe specifiche categorie legali di pr oprietà, inclusa quella in comune. Nel 535 a. C., fu l’imperatore Giustiniano a formalizzare questo riconoscimento con l’inclusione delle res communes nella legislazione imperiale delle Istituzioni, una delle par ti di cui si compone il corpus iuris civilis. Vi si legge fra l’altro: «In base alle leggi di natura queste cose sono c omuni a tutta l’umanità: l’aria, l’acqua 97 che scorre, il mare e di c onseguenza le sue spiagge. … Anche tutti i fiumi e i porti sono pubblici, in modo che il diritto alla pesca nei porti e nei fiumi sia c omune a tutti. E in base alla legge delle nazioni anche l’uso delle spiagge è pubblico e, analogamente, il mare stesso. Il diritto di pesca in mar e dalla riva appartiene a tutti gli uomini» (enfasi nell’originale). Questo principio giuridico – cioè che né lo Stato, il commercio o i cittadini possono avanzare alcun diritto di proprietà sulle risorse che appartengono a tutti – è sopr avvissuto in quella che nel diritto statunitense è nota come la “dottrina della fiducia pubblica”. Qui viene formalizzato il concetto in base al quale lo Stato ha il potere affermativo di tutelare le risorse naturali per le generazioni presenti e future, e non può vendere o regalare terreni, acqua o fauna selvatica a nessuna entità privata. Tradizionalmente questa dottrina è stata applicata ai fiumi, agli oceani e al litorale costiero, e viene invocata per proteggere i diritti del pubblico in generale rispetto all’uso di quelle ac que per la pesca, la navigazione e il divertimento. Analoghe versioni della dottrina della fiducia pubblica sono pr esenti nella maggior parte dei corpi giuridici del mondo ed anche in molte delle grandi religioni organizzate. Si ribadisce così il principio che certe risorse appartengono a tutti i cittadini, a livello morale e legale, un diritto che neppure lo Stato ha il potere di abrogare. È significativo il fatto che le res communes costituiscano una categoria separata dalle res publicae, un altro ambito giuridico che descrive le cose pubbliche appartenenti allo Stato. Le res communes non sono semplicemente proprietà “possedute” dallo Stato, bensì una classe a sé che va perfino oltre il potere statale. Non c’è da sorprendersi se generalmente le massima autorità statali non siano affatto contente di dover riconoscere i beni comuni come una sfera separata di risorse, dotata di una propria autorità morale e di tutela legale, al di sopra e al di fuori del loro controllo diretto. Vediamo per un momento la situazione in cui v enne a trovarsi nel XIII secolo il re Giovanni d’Inghilterra, più noto come Giovanni Sen- 98 zaterra, quando svariati monarchi precedenti avevano reclamato porzioni sempre più ampie di bosc o a scopo personale e r icreativo, ovviamente a spese di bar oni e comunità locali. Trattandosi di una diretta minaccia ai mezzi di sussist enza da cui c ostoro dipendevano, cioè le foreste per il cibo e la leg na da ardere e i materiali con cui costruirsi un riparo, queste intrusioni reali nei territori comuni provocarono lunghi e aspri conflitti sociali. Il bestiame nonpot eva più pascolare liberamente nel bosco, i suini non potevano più mangiarne le ghiande, ai residenti locali era impedita la raccolta del legname necessario per riparare le case, le barche non potevano più navigare i fiumi perché vi erano state costruite dighe o attracchi privati. Dopo anni di brutali conflitti armati, nel 1215 Giovanni Senzaterra acconsentì formalmente a una serie di limitazioni legali del suo potere assoluto, stabilendo che gli altri membri della società, compresi i commoner, avevano diritto a un pr ocesso equo, al rispetto dei diritti umani e alla sussist enza, fra le altre cose. Si trattava dell’importante Magna Carta, uno dei pilast ri fondativi della civiltà occidentale – da cui derivano diritti giuridici quali l’habeas corpus, il processo con giuria, il divieto della tortura e il cosiddetto “rule of law”. Da allora tutti questi principi normativi hanno trovato espressione nelle costituzioni moderne di molti paesi in quant o diritti fondamentali dei cittadini, oltre ad esser e inclusi nel t esto di di verse convenzioni sui dir itti umani. Merita qui una menzione anc he la Car ta della for esta, un documento quasi dimenticato (firmato due anni dopo la M agna Carta e successivamente ivi incorporato) dove si riconosceva il diritto tradizionale delle comunità locali all’uso di t erreni e foreste di proprietà del re. In tal modo i commoner vedevano formalmente riconosciuto il loro diritto a pascolarvi suini e altri animali o raccogliervi legna da ardere e torba per riscaldarsi. A livello pratico, questa carta della foresta garantiva i diritti fondamentali alla sussistenza ai residenti del posto, tutelandoli contro la minaccia di illegali intrusioni statali da parte degli sceriffi del re a difesa delle sue enclosure. 99 Come suggerisce questa breve panoramica storica, il diritto dei beni comuni rimanda a una legge di tipo diverso – un corpo giuridico che trae origine dall’esperienza vissuta dei commoner, che tende a essere informale, specifico e in evoluzione continua, anziché fisso e scritto, e che privilegia la reciprocità e l’uguaglianza sociale rispetto agli interessi economici oppure all’autorità dello Stato. Peter Linebaugh è illuminante su questo punto: «Le pratiche centrate sui beni comuni risultano integrate nel processo lavorativo e sono inerenti alla specifica prassi che riguarda campi, colline, boschi, paludi, coste. I dir itti comuni vengono conquistati con il sudore e appartengono all’esperienza non all’erudizione. ... Essendo indipendenti dallo Stato, le pratiche dei beni comuni sono indipendenti anche dalla temporalità giuridica e statale. Risalgono a un ’epoca assai precedente, ma non per quest o sono defunte, premoderne o arretrate». L’esistenza stessa dei beni comuni è di vitale importanza come argine contro gli abusi della legge formale, perché rappresenta uno dei pochi casi in cui quest’ultima viene sottoposta alla verifica dei cittadini. È facile corrompere e tradire la legge formale, perché ha punti d’accesso identificabili (legislature, tribunali, capi di Stat o) a disposizione di qualche malintenzionato, mentre invece la legge vernacolare è profondamente radicata nella vita quotidiana e nella cultur a popolare, rendendo piuttosto difficili eventuali manipolazioni o corruzioni. Pur affermando il sost egno alle esper ienze comunitarie, l’applicazione della Magna Carta poteva essere assicurata soltanto tramite la vigilanza continua: non mancava certo lo scetticismo e bisognava essere guardinghi. È per questo che i sovrani successivi ripubblicarono il documento nel corso degli anni, ricorrendo a simili manovre ritualistiche per affermare ripetutamente quei diritti umani fondamentali. Ovviamente un pezzo di carta può avere un valore limitato nell’impedire gli abusi del potere statale, e come succede tuttora, il governo statunitense, con la scusa della lotta al t errorismo, ha ignorato impunemente il diritto all’habeas corpus, a un processo equo, al divieto della tortura e agli altri principi enunciati nel documento stesso. Perciò neppure la Magna Carta poté fare granché dal XVI al XIX secolo per impedire le nuove e ampie enclosure dei terreni. Nel 1536, il re Enrico VIII espropriò i monasteri cattolici, dando il via a una pressante serie di recinzioni imposte da signori e nobili – una «massic cia operazione di privatizzazione sponsorizzata dallo Stato», nella descrizione di Linebaug h. Autorizzata da quatt romila leggi approvate dal parlamento nel corso di svariati secoli, la classe emergent e della nobiltà inglese si appropriò di circa il 15 per c ento di tutti i t erreni comuni a esclusivo uso privato. Queste enclosure distrussero buona parte del legame stabilito tra le comunità e il territorio, oltre a calpestarne le identità sociali e le t radizioni, aprendo la via per la loro trasformazione in proletariato. Da notare infine che, con l’intensificarsi di queste recinzioni forzate, le donne che provavano a conservare le usanze comunitarie – riaffermando il loro diritto ai beni c omuni, l’unico modo r imasto loro per sopravvivere – venivano spesso accusate di stregoneria. Temi questi esplorati a fondo da Silvia Federici nella sua storia femminista della transazione dal M edioevo al capitalismo , Caliban and the Witch (2004). Scrive fra l’altro la studiosa italo-americana: «La funzione sociale dei beni comuni era particolarmente importante per le donne, le quali, avendo titoli ridotti sui terreni e minore potere sociale in generale, dipendevano maggiormente da quelle pratiche per la loro sussistenza, autonomia e socialità». Il diritto dei beni comuni sotto assedio 100 «Le enclosure portarono al passaggio da una v ita fondata su c onsuetudini preservate a lungo nella memor ia locale a usanz e imposte da legislazioni nazionali preservate per iscritto», osserva lo studioso dei beni comuni Lewis Hyde. «Ciò modificò il senso del cambiament o stesso: ciò che in passato era visto con sospetto e associato al degrado, ora veniva invece apprezzato e legato alla crescita. Portando infine a 101 una misurazione e concezione del tempo ben diverse da quelle precedenti», man mano c he le fabbriche iniziavano a razionalizzare e calcolare il tempo stesso, organizzando di c onseguenza le attività interne. Mentre l’accesso e il diritto alla terra venivano separati dalle usanze sociali, ne emerse una persona di tipo n uovo: l’individuo, qualcuno che non sembrava appartenere ad alcun collettivo e la cui v isione del mondo andava orientandosi intorno al proprio stipendio, al progresso tecnologico e sociale, al profitto materiale. Il nuovo ordine del mercato, scrive Karl Polanyi, creò persone che «erano nomadiche, difettavano di autostima e di disciplina, individui rudi e insensibili». Tutto ciò emerse non appena quell’insieme integrato che costituiva l’essenza stessa di queste esperienza condivise – risorse, commoner e pratiche sociali – venne disaggregato e mercificato per adeguarsi ai bisogni del nuovo ordine del mercato industriale. Ovviamente le enclosure produssero anche qualche effetto positivo, eliminando i rapporti tra padroni e comunità e trasformando i vassalli in pr oprietari terrieri. Ma queste nuove “libertà” avevano un prezzo: pur dando vita a nuove identità e opportunità sociali, distrussero la c oesione sociale delle esper ienze comunitarie, la sussist enza minima garantita, la sostenibilità ecologica e i legami stabilizzanti tra identità e uso delle risorse. La storia del socialismo e delle t eorie liberali può essere vista come il tentativo il risolvere alcuni dei pegg iori problemi strutturali creati dalla dissoluzione dei beni c omuni. Il socialismo eur opeo del XIX e XX secolo introdusse tipi nuovi di mutualismo sociale e sistemi burocratici per far fronte alle necessità dei membri delle comunità alle prese con le nuove circostanze della società industrializzata. Ne nacquero innovazioni di base c ome le cooperative dei consumatori, il sistema previdenziale e le aziende municipali dell’acqua, con l’idea di soddisfare le necessità fondamentali dei cittadini in un c ontesto storico assai diverso, quello del mercato-Stato. Un quadro sicuramente migliore rispetto all’ordine basato sul lais- 102 sez-faire (il principio proprio del liberalismo economico, favorevole al non intervento dello Stato), e non a caso molti dei primi progetti utopistici o socialisti oper avano all’incirca come dei beni c omuni, forse perché era ancora fresco il ricordo di quelle pratiche tradizionali – le quali presero però a sc emare, insieme alla v italità stessa dei beni c omuni, man mano che i collettivi dei lavoratori andavano adattandosi ai requisiti delle leggi statali, della burocrazia, delle corporation e delle forze del mercato. Le normative statali mir avano a compensare i problemi creati dal “libero mercato”, in particolare l’aggravamento di costi e rischi ai danni dell’ambiente, delle comunità e del corpo umano. Le regolamentazioni sulle pratiche ambientali e sulla sicurezza di cibo, farmaci, strutture mediche, sostanze chimiche, autoveicoli e prodotti di consumo vanno perciò considerati come tentativi di ricorrere all’ingombrante apparato della legge for male, della scienza e della bur ocrazia per applicare le consuetudini etico-sociali tipiche delle esperienze comunitarie. Vista la por tata delle t ransazioni commerciali e il pot ere delle multinazionali, le nor mative sancite dallo Stat o diventano assolutamente necessarie, poiché i beni comuni tradizionali sono troppo piccoli, disorganizzati e pr ivi di r isorse per assicur are risultati socialmente validi. D’altra parte è però v ero che quelle normative non potevano funzionare troppo bene. La centralizzazione e la for malizzazione del diritto consentì facilmente all’industria di impossessarsi e di corrompere l’intero processo – cosa tutt’altro che sorprendente, considerato il potere dell’alleanza Stat o-mercato e i lor o interessi ampiamente interconnessi. E a tutt’oggi rimane aperta la questione di una possibile ristrutturazione della governance che sia veramente in grado di arginare gli abusi ambientali e sociali provocati dal mercato. Al pari di quelle regolamentazioni, rimane alterno e spesso negativo anche il ruolo dello Stato come garante dei beni collettivi. In molti casi, possiamo sc ordarci del fatt o che formalmente quelle r isorse appartengono al popolo . Lo Stat o non è c erto proprietario dell’aria, 103 delle acque, dei terreni pubblici, dei litorali o della fauna selvatica, né può farne l’uso che ritiene più opportuno – bensì opera solo in qualità di agente amministrativo e fiduciario per conto del popolo, e in base alla dottrina non può regalare o consentire la distruzione di queste risorse. Per enfatizzare questi obblighi manageriali, definisco i beni comuni di ampie proporzioni e mediati dallo Stat o come beni comuni sotto tutela dello Stato (discussi in dettaglio nel capitolo 9). Purtroppo, non di rado le istituzioni rinnegano le loro responsabilità di “intervenire” nel mer cato temendo di inibir e così la cr escita economica e v iolare quelle concezioni chiaramente fallaci codificate nei principi del “libero mercato”. Per esempio, le norme sulla sicurezza e i requisiti per il servizio pubblico mirano a prevenire danni gravi e a garantire una certa equità sociale – eppure, nella nostra epoca neoliberale, perfino questi obiettivi minimi vengono considerati da molti governi come un fardello inaccettabile per il capitale e le c orporation, oltre che un peso per la crescita economica. Per massima c hiarezza, il sett ore indipendente che raccoglie tanti movimenti autogestiti, cooperative e associazioni mutualiste è piuttosto ridotto, e gener almente questi sist emi di sussist enza alternativi non hanno mai raggiunto proporzioni significative. E pur avendo ottenuto molte importanti tutele legali, neppure sono mai riusciti a stare al passo c on l’inarrestabile flusso di n uovi problemi generati dal mercato. Inoltre, la stesura delle normative rimane per lo più basata sulle procedure legali e sulle c ompetenze scientifiche, al punto che le opinioni dei residenti o dei singoli c onsumatori trovano poco spazio nel processo decisionale r ispetto invece a quelle di a vvocati, esperti tecnici e rappresentanti industriali. Spesso gli stessi commoner si vedono delegittimati nell’effettivo coinvolgimento nel processo gestionale, oppure semplicemente non possono per mettersi di sostenere i costi vivi per prendervi parte. In pratica è proprio l’istituzionalizzazione dell’intero processo, presumibilmente intesa a garantire una partecipazione equa, paritaria e universale, che tende a privare i membri di queste comunità dei loro 104 diritti legali. È quanto succede nel caso di governi democratici che assumono l’amministrazione di ambiti specifici (come l’assistenza previdenziale) e del c omunismo di Stat o che marginalizza le iniziati ve collettive (tipo le cooperative sociali). Non c’è dunque da sorprendersi se il successo dei commoner nel mettere a punto adeguate tutele per se stessi e per le lor o risorse all’interno degli apparati legali istituzionali, finora si sia rivelato assai incostante e limitato. Gli osservatori più attenti su questi pr oblemi sono alcuni studiosi marxisti indipendenti, tra cui Massimo De Angelis, responsabile del sito web The Commoner; George Caffentzis, fondatore del Midnight Notes Collective; Silvia Federici, ricercatrice che studia le implicazioni femministe dei beni c omuni; Peter Linebaugh, autore del Magna Carta Manifesto e altri documenti sulla storia inglese dei beni comuni; Michael Hardt e Antonio Negri, teorici politici e aut ori di t esti quali Multitude, Empire e Commonwealth. Ciascuno a modo suo, questi autori hanno rimarcato che il problema centrale del mercato capitalista selvaggio sta nella sua t endenza a erodere gli autentici legami sociali tra le persone (c ooperazione, usanze, tradizioni) e a liquidar e l’organicità del tessuto sociale e le specific he esperienze centrate sui beni comuni. Il capitale sc ompone i beni c omuni nelle sue par ti costituenti (lavoro manuale, terreni, capitale, denaro) per poi t rattarli come beni di consumo il cui valore coincide con il relativo prezzo di mercato. Tutto ciò ha pr ovocato una persistente crisi morale e politica, perché il capitalismo non è g rado di trovare a risposte a domande quali: come creare legami significativi tra le persone al di là dei minimi rapporti sociali e civici necessari per partecipare agli scambi commerciali? È possibile per una società basata sul mer cato riuscire a sopravvivere senza i beni comuni? L’impero della proprietà privata 105 Una nave da crociera naviga da un porto all’altro, e sul pontile superiore ci sono svar iate sedie a sdr aio, ma il n umero dei passegger i a bordo è tre volte superiore a quello delle sedie disponibili. Nei primi giorni della crociera, le sdraio vedono un alternarsi continuo di persone. Non appena qualcuno si alza, la sedia viene considerata libera, e nessuno accetta l’idea di mett erci sopra un fazzoletto o qualcos’altro per indicare che qualcuno vorrebbe usarla ancora. Si tratta di un espediente per gestir e collettivamente una quantità limitata di sedie a sdraio. Ma quando la nave fa sosta in un certo porto e sale a bordo una folla di nuovi passeggeri, quest’accordo va a farsi benedire. I nuovi arrivati, che si conoscono tutti fra loro, seguono una consuetudine sociale ben diversa: si tirano vicino una sdraio e ne reclamano l’uso ininterrotto ed esclusivo: ne consegue che la maggioranza degli altri passeggeri non pot rà mai far ne uso. Vige la scarsità, scoppiano litigi e gran parte degli ospiti si ritrova tutt’altro che a proprio agio per l’intera durata della crociera. La “allegoria delle sedie a sdr aio”, così descritta dal sociologo t edesco Heinrich Popitz (e sottoposta alla mia attenzione da Silke Helfrich), descrive l’estrema malleabilità dell’idea stessa di proprietà. Pur se le leggi formali definiscono il diritto di proprietà in determinate circostanze, le consuetudini sociali sono una forza quant omeno di par i importanza, oltre che ampiamente adattabili. I passeggeri della nave da crociera potevano scegliere tra considerare le sdraio come una proprietà esclusiva e personale, anche se molti avrebbero dovuto farne a meno , oppure trattarle come una r isorsa 106 condivisa che poteva soddisfare più o meno le esigenz e di ogni passeggero. È importante definire in modo corretto il diritto di proprietà perché ciò influisce sul titolo giuridico che ci riguarda, modella le nostre relazioni sociali e produce un effetto enorme sul nostro senso di benessere (o di alienazione). In una definizione citata spesso, il giurista inglese William Blackstone descriveva così il diritto di proprietà del XVIII secolo: «Il solitario e dispotico dominio c he un uomo r ivendica ed eser cita sulle c ose esterne del mondo, in totale esclusione del diritto di qualsiasi altro individuo nell’universo». Pur implicando l’univoca appartenenza ai singoli individui, non è c erto l’unica definizione possibile. Come rivela l’esempio delle sdraio sul pontile della nave di cui sopra, si può decidere di esercitare, anziché il possesso esclusivo, il diritto all’uso individuale temporaneo di una stessa risorsa. (A livello strettamente tecnico, il pr oprietario della na ve da cr ociera lo è anc he delle sedie a sdraio, ma per brevi periodi la proprietà spetta ai passeggeri e in questi casi sono liberi di dettare le proprie regole). Ovviamente i di versi modelli del dir itto di pr oprietà comportano implicazioni parimenti differenti sul modo in cui vengono soddisfatte (o meno) le esigenz e delle persone coinvolte. Sono queste scelte di fondo a condizionare la natura stessa dell’ordine sociale e l’att eggiamento generale tra la gente. E sembra proprio questo il punto fondamentale dell’allegoria delle sedie a sdraio: il diritto di proprietà è ben più flessibile di quanto comunemente si creda, può essere pianificato in vari modi e il design scelto produce effetti di ampia portata sui rapporti interpersonali e sull’uso delle risorse. Generalmente si tende a considerare la proprietà come una categoria ovvia, considerandola automaticamente come il diritto privato all’esercizio del controllo esclusivo su oggetti fisici quali poder i, automobili e smar tphone. Tipicamente un proprietario terriero valuta il suo appezzamento come una par cella fissa e indi viduale di t erreno inerte, da usare come meglio crede. Eppure il concetto secondo cui la “proprietà” non comporterebbe alcuna implicazione sociale o ec olo- 107 gica è una fantasticheria della vita moderna. In realtà, ogni podere fa parte di un ecosistema vivente, e pur volendo considerarlo come semplice bene di consumo, dipende comunque dalle caratteristiche degli appezzamenti adiacenti e dal più ampio ecosistema locale. Una casa di campagna con stupendi panor ami sul t erritorio circostante, uccelli cinguettanti e vicini simpatici vale molto più di un’abitazione identica ma situata nei pressi di una fabbrica con una ciminiera sempre attiva. In tal senso, la terra non è altro che un bene di consumo fittizio, come abbiamo visto in precedenza. È certamente possibile trattarla come una pr oprietà privata, e c oltivare l’illusione c he sia v eramente qualcosa di autonomo e fungibile – ma non si tratta di un’unità limitata vera e propria il cui valor e concreto possa essere espresso da un certo prezzo, in maniera isolata dal contesto limitrofo. La proprietà è una specie di fic tion sociale, un sistema preconcertato per allocare il diritto di qualcuno all’utilizz o di una c erta risorsa o per impedir ne l’accesso ad altri. La terra può essere gestita anche come un bene fiduciario per conto del pubblico e delle generazioni future, oppure tramite pratiche culturali e tradizioni che la considerano un dono sacro della natura, come è di norma tra le popolazioni indigene. È possibile assegnare diritti specifici e limitati in base a modalità diverse, come succede spesso per i c ollettivi agricoli e le organizzazioni impeg nate nella conservazione dell’ambiente. I sostenitori del libero arbitrio e del libero mercato sostengono che la proprietà privata è un diritto naturale, se non proprio divino – ritenendolo l’unico sistema legittimo nel contesto legale sulla proprietà, poiché il diritto collettivo sarebbe economicamente insostenibile, politicamente oppressivo e moralmente sospettoso. Il regime giuridico centrato sulla proprietà privata viene così equiparato a un imperativo morale universale. Si tratta di spacconate ideologiche. In realtà, la portata del diritto di proprietà varia enormemente da una cultura all’altra, e differisce perfino nel passato storico di una stessa cultura (oltre che in uno specifi- co momento, vista l’esistenza di molteplici tipi di proprietà!). Occorre inoltre tenere a mente il subdolo inganno istigato dal termine “proprietà privata”, spesso usato come un eufemismo per indicare la proprietà industriale, un soggetto giuridico ben più potente e problematico dei singoli titolari di una proprietà personale. I diritti inalienabili dei commoner 108 Come fece notare nel 1659 Gerrard Winstanley, leader del movimento inglese dei Digger – i gruppi di cristiani protestanti decisi a lavorare i terreni collettivi secondo princìpi comunitari, in forte contrasto con la dittatura di fatto imposta da Oliver Cromwell – il diritto di proprietà privata non ha nascita naturale ma è piuttosto il risultato della conquista: «Il pot ere di r ecintare la t erra e posseder e qualche proprietà è stato creato dai vostri antenati con la spada». Lo chiarisce anche Goethe nella poesia “Catechismo”, centrata su una conversazione tra maestro e studente: «Attento, ragazzo! Da dove arrivano tutti questi doni? Non possono certo venire solo da te». Lo studente risponde che provengono dal papà, e che questo li ha ricevuti dal nonno; e dove li avrà mai presi il nonno?, incalza il maest ro. Alla fine il r agazzo ammette: «Se ne è appropriato in qualche modo». È dunque plausibile che l’origine di molti diritti di proprietà derivi da semplici episodi di appropriazione, probabilmente giustificata da sofisticat e dottrine legali. In tutta onestà, a volte la gente sceglie specificamente il regime della proprietà privata senza comprenderne appieno le estese ramificazioni sociali. Per esempio, la generazione precedente di molte popolazioni indigene dell’Alaska decise di amministrare i terreni e le risorse tradizionali tramite delle “società per azioni native” – un cambiamento che portò a irregolarità gestionali, corruzione, ingiustizie e, in alcuni casi, perfino a espropriazioni immediate, in quanto gli investitori esterni che avevano acquistato i terreni ora li trattavano come beni di consu- 109 mo, non certo come eredità sacre. Analogamente, i beni patrimoniali di Martin Luther King sono gestiti dai fig li, i quali ne hanno t rattato gli scritti, le immagini e le registrazioni audio alla stregua di proprietà commerciali da vendere al miglior offerente, presumibilmente per poterne preservare il lascito. Sono arrivati perfino a reclamare il diritto d’autore sul suo famoso disc orso “I Have a Dr eam” e una v olta ne hanno concesso la licenza d’utilizzo a un’azienda di telecomunicazioni per una campagna pubblicitaria a mezzo stampa e televisione. È innegabile che il diritto di proprietà privata rivesta tutta una serie di aspetti positivi, e in passat o è ser vito a emancipare tante persone dalla tirannia di re, aristocratici e regimi autoritari. Ma è anche vero che queste legislazioni possono rivelarsi un’orrenda forma di oppressione e coercizione – se portate all’estremo e applicate per rimuovere altre preoccupazioni sociali, morali ed ecologiche, fino a imporsi c ome strumento portante per la privatizzazione. Molti teorici della materia sottolineano che la portata concreta del diritto di proprietà è andata modificandosi parecchio nel corso dei secoli per adeguarsi alle n uove circostanze economiche, tecnologiche e sociali. L’arrivo della ferrovia e di internet, per esempio, ha minato la comprensione generale sull’essenza di tale diritto e sui doveri di chi ne è titolare. Negli Stati Uniti, spesso le scintille c he si sprigionavano al passaggio dei treni causavano improvvisi incendi nei terreni adiacenti, sollevando la questione dell’e ventuale responsabilità delle aziende ferroviarie per i danni causati ai pr oprietari terrieri. (I tribunali hanno poi stabilito che si trattava dell’inevitabile prezzo da pagare per il progresso economico). Analogamente, internet e le tecnologie digitali hanno facilitato al massimo la copia e la condivisione di libri, film e musica, scatenando un enorme dibattitto politico sull’effettiva portata delle norme sul copyright. Come suggeriscono questi esempi, la moderna tendenza a stabilire l’assolutezza del diritto di proprietà privata è una fantasticheria ultraliberista. Il diritto di una persona finisce invariabilmente per limitare quello di un’altra, né si può garantire a tutti una libertà illimitata. 110 Le popolazioni indigene ci aiutano a notar e come questa concezione occidentale in realtà ne riflette i profondi preconcetti culturali sulla natura e sulle relazioni sociali. Ci basiamo sul presupposto che agli esseri umani sia concesso trasformare l’acqua, la terra, il genoma e altri elementi della natura in semplici beni di consumo, come si trattasse di oggetti iner ti che possano essere isolati dal contesto naturale in cui si trovano e posseduti da qualcuno. Il diritto di proprietà privata non è necessariamente ostile ai princìpi comunitari, penso anzi c he possano essere mutuamente compatibili e perfino lavorare mano nella mano. Tra gli esempi riusciti su questo fronte troviamo i fondi t errieri fiduciari (proprietà privata all’esterno, beni comuni all’interno), i testi e brani musicali digitali (di cui l’autore mantiene il c opyright pur affer mandone la c ondivisione a norma di legge, tramite il diritto all’uso consentito e le licenze Creative Commons) e le cooperative (imprese commerciali la cui proprietà e gestione è affidata agli stessi membri). Il problema sta semmai nel fatto che le forme giurisprudenziali dominanti basate sul mercato tendono a privilegiare il diritto individuale per ignorare invece diritti ed esigenze collettive. Dato che generalmente la legge non r iconosce i beni comuni come forma istituzionale, è tutt ’altro che semplice delineare uno sc opo collettivo dovendo operare all’interno delle angust e definizioni della pr oprietà individuale. È per questo che la tutela dei beni comuni di fronte alle recinzioni forzate spesso ha richiesto una buona dose di creatività giuridica, quantomeno nel contesto dello Stato moderno: i beni comuni esistono all’interno di un vuot o lessicale, rendendoli qualcosa di innominabile e inscrutabile. È importante rimarcare tuttavia che non si tratta di entità che si rispecchiano una nell’alt ra. I beni c omuni non sono semplic emente una “non proprietà” come sostiene qualcuno, perché così sarebbero a libera disposizione, oppure analoghi alla t erra di nessuno , quel c he Garrett Hardin considerava erroneamente equivalente a un bene collettivo. 111 Né i beni c omuni vanno v isti come una mer a variante della pr oprietà: le loro caratteristiche di fondo sono ben di verse. Innanzitutto perché i primi riguardano assai meno il possesso quanto piuttosto la gestione di un qualc he patrimonio. Se c hiediamo ai membr i di una qualsiasi popolazione indigena se pensano di “possedere” la terra su cui vivono, ci sentiremo rispondere che in realtà è la terra che li possiede. E parlare di possesso fa tornare alla mente il «dominio esclusivo e dispotico» ai danni di una risorsa descritto da Blackstone. Invece la pratica dei beni c omuni implica di per sé un magg ior coinvolgimento e una prospettiva a lungo termine, oltre a una relazione eticoculturale più ricca e continuata di quella generalmente innescata dalla proprietà privata – perché c’è in ballo la gestione c ollettiva di una determinata risorsa, qualcosa che va perseguito a prescindere dall’esistenza o meno di una legge for male sulla proprietà. Nel caso delle sedie a sdr aio, per esempio, il “sistema legale” che ne amministra l’utilizzo da par te dei passegger i poggia interamente su basi sociali. Sono i dir etti interessati che patteggiano e rispettano tacitamente un certo accordo comune, né esiste alcuno statuto formale o contratto privato incaricato di stabilirne il comportamento. L’intero sistema si fonda sulla comprensione sociale reciproca, l’applicazione di quella legge vernacolare già descritta. Anche se un bar o un r itrovo sono pr oprietà di qualcuno , l’impronta sociale e l’at mosfera vengono definiti sopr attutto da c hi li fr equenta, non c erto dal pr oprietario. È del tutto naturale voler pianificare e applicare le norme sociali in modo informale, oppure seguire certe usanze non scr itte. La vasta maggioranza degli americani sa bene che per comprare il biglietto del cinema oppure un hot dog da un c hiosco in strada, bisogna mettersi in fila. Questo è considerato il modo corretto e ordinato per avere accesso a certe risorse limitate – un g rezzo principio di protocollo sociale adatto a specifiche circostanze quotidiane che risulta particolarmente efficace esattamente perché organizzato e applicato in proprio. Cosa succede però se il denar o e il dir itto di proprietà privata fini- 112 scono per interferire con il consenso sociale? È proprio quanto accade, per fare un esempio, nei parchi divertimento di grandi proporzioni: a Disneyland sono in v endita biglietti maggiorati per acquisire il diritto a passare davanti a tutti, mentre chi non può permetterselo deve fare la solita fila. Si tratta forse di una pratica corretta? L’istinto della parità sociale ci dic e di no, ma l’esempio ci inseg na cosa succede quando il diritto di proprietà privata viene asserito come un’impostazione predefinita. Anzi, una delle ragioni primarie per cui tale diritto è così prezioso sta nel fatto che può essere venduto e comprato. È naturale che i cittadini più facoltosi tendano a favorire un diritto di proprietà privata il più ampio e meno r estrittivo possibile, perché così possono permettersi di passare davanti a tutti in molte situazioni. I beni comuni propongono invece un diverso paradigma per l’ordine sociale e mor ale, chiedendoci di abbr acciare procedure collettive compatibili con una ser ie di valor i, consuetudini pr atiche di tag lio più collaborativo, inclusivo e mirato al bene civico. Ci viene richiesto di rigettare l’Homo economicus come ideale predefinito del comportamento umano, per esplorare piuttosto la possibilità che alcuni diritti debbano essere inalienabili (cioè, non in vendita)e che certi valori sociali vadano posti al di sopr a della proprietà privata. È questa la sfida che oggi si trova davanti gran parte del movimento per i dir itti umani: affermare la dignità, il rispetto, la reciprocità e la giustizia sociale in quanto bisogni umani fondamentali che vanno tutelati a norma di legge. Tradizionalmente, i diritti umani sono stati considerati come qualcosa di astratto e universale, lasciandone l’applicazione selettiva ai vari paesi (a seconda delle specifiche circostanze politiche). I beni comuni propongono invece una riconcettualizzazione in senso più locale e pragmatico dei diritti umani: un modo per consentire alle comunità di soddisfare le esigenze primarie in maniera più diretta e, se possibile, affidabile. La logica del diritto di proprietà secondo John Locke 113 Ogni teoria sulla proprietà riflette al suo livello più profondo una certa visione dell’umanità. Queste teorie non si limitano a descr ivere, bensì arrivano a prescrivere in maniera sottile il nostro comportamento.Ad alcuni secoli di distanza, le teorie del filosofo politico del XVII secolo John Locke continuano a dominare la nostra immaginazione e i suoi scritti offrono una forte logica morale, insieme alla g iustificazione giuridica, a sost egno del moder no diritto di proprietà individuale – nonché a favore delle enclosure del mercato. Locke muove dall’idea che gli esseri umani sono individui isolati con diritti personali assoluti sulle risorse circostanti, in virtù del lavoro che vi investono per il loro sviluppo. Questa “teoria del lavoro socialmente necessario” voleva contribuire all’emancipazione del popolo r ispetto al dominio del re, incoraggiando soprattutto una maggior libertà in ambito commerciale e ci vico per l’emergent e classe impr enditoriale. Punto qualificante era la delegittimazione del potere di monarchi e aristocratici per g iustificare invece i semplici cittadini nell’eser cizio del dominio assoluto sulla “loro” proprietà tramite il mercato. Le teorie di Locke meritano attenzione perché ancora oggi definiscono il contesto da cui derivano la concezione e la gestione tradizionali del diritto di proprietà. Se il lavoro necessario per scoprire o migliorare un appezzamento di t erreno ci r iconosce il dir itto a possederlo, allora i territori “sottosviluppati” non appartengono a nessuno e quindi sono a liber a disposizione di tutti. Una teoria decisamente confacente agli esploratori europei del XVIII secolo, impazienti di arraffare le ricchezze del Nuovo Mondo. In base alla filosofia di Lock e, quei territori andavano considerati terra nullius (talvolta definiti res nullius), perché la terra acquista valore soltanto quando gli individui vi applicano lavoro e ingeg nosità (coltivandola, migliorandola, rendendola commerciabile, ecc.). Ne consegue che la natur a viene considerata un oggetto inerte da poter privatizzare senz’alcun riguardo per i legami g ià esistenti con i 114 residenti locali o con l’ecosistema più ampio. È così che, anche se contadini e popolazioni indigene si sono pr esi cura di terreni, zone pescose, boschi e altre risorse naturali da tempo immemorabile ma senza alcun titolo formale, gli imperialisti occidentali trovano conforto nella finzione legale secondo cui la terra non appartiene a nessuno perciò possiamo impadr onircene come me glio ci aggrada!In tal modo, la teoria lockiana del diritto di proprietà privata ignora deliberatamente i diritti e le usanze preesistenti delle popolazioni indigene, nonché il diritto delle futur e generazioni e le iner enti esigenze della natur a stessa. Grazie a questa log ica, è di venuta prassi comune parlare deglioceani, dello spazio e xtraterrestre, della biodi versità e di int ernet comesi trattasse di risorseche non appartengonoa nessuno. È così che l’estensione della log ica della res nullius arriva a g iustificare il saccheggio privato illimitato. Interessante notare una breve riserva aggiunta successivamente per spiegare che ogni appropriazione privata deve limitarsi «a ciò di cui ce n’è abbastanza e della stessa qualità da las ciare in comune ag li altri». Locke solleva cioè un’ambigua questione fin troppo ovvia da ignorare: l’esercizio del dir itto alla pr oprietà privata potrebbe intaccare e perfino distruggere quelle r isorse che appartengono a tutti. In altri termini, esiste una tensione irrisolta tra la proprietà privata e i beni comuni. Questa che è nota come “clausola lockiana” viene tuttavia considerata soltanto un gesto simbolico e inutile: filosofi e studiosi del dir itto la invocano per mostrare il loro rigore intellettuale, ma in pr atica né la classe politica né quella imprenditoriale si preoccupano di onorarla. Le multinazionali dell’acqua imbottigliata continuano a pr osciugare le falde senza lasciarne nulla in comune agli altri. L’industria agro-biotecnologica commercializza senza posa le sue semenz e geneticamente modificate fino a dist ruggere la pr atica sostenibile della condivisione dei semi. I grossi rimorchiatori industriali sfruttano indefinitamente le zone di pesca oceaniche fino a prosciugarle ed espropriandone le comunità costiere. Comunque si voglia interpretare que- 115 sta clausola, l’intenzione primaria di Locke era quella di giustificare la proprietà privata, non certo di garantire lunga vita ai beni comuni. Calcando le or me di questa t radizione, le odier ne normative sulla proprietà privata continuano a ig norare, o anc he a cr iminalizzare, quanti utilizzano le r isorse in manier a collaborativa. La sussist enza collettiva indipendente dal mercato non v iene considerata come un “valore aggiunto” nel senso lockiano, e in base a questa log ica nessuno ha diritto alla tutela della proprietà. Anzi, si ricorre alla “libertà” di proprietà privata per espropriare e violare i beni condivisi, come abbiamo visto nel fenomeno del land g rabbing internazionale a spese dei territori comuni in Africa. È importante comprendere al meg lio l’analisi del filosofo ing lese perché è divenuta la giustificazione morale portante del capitalismo moderno e delle sue pr atiche privatiste. Come hanno rimarcato svariati studiosi dei beni comuni, tra cui Wolfgang Hoeschele e Roberto Verzola, in r ealtà il capitalismo r iguarda la pianificazione della s carsità:pur di massimizzare profitti e quote di mercato, le imprese creano deliberatamente la penuria tramite modalità sempre nuove per ridurre le forniture o l’accesso alle risorse. Per esempio, le norme sul diritto d’autore e i brevetti si concentrano su risorse che possono essere riprodotte in maniera semplice ed economica (informazione e conoscenza), per poi asseg narne il monopolio limitat o ad autori e inventori la cui creatività si presuppone debba essere del tutto innovativa e or iginale. L’industria agro-biotecnologica produce semi sterili in modo da costringere i contadini a comprarli da loro anno dopo anno, convertendo l’abbondanza naturale in scarsità artificiale. All’opposto, le pr atiche comunitarie puntano esplicitament e alla pianificazione di un sistema centrato sull’abbondanza – termine quest’ultimo con cui Hoeschele e Verzola non intendono certo l’approvvigionamento illimitato per soddisfare gli appetiti senza fondo dell’umanità (la pr emessa dell’economia del mer cato), quanto piuttosto l’approvvigionamento generoso e rinnovabile di quello di cui abbiamo davvero bisogno. Un esempio sintomatico è la permacultura, che tende a emulare gli ecosistemi tramite culture rigenerative che si aiutano vicendevolmente nella crescita e producono una quantità minima o nulla di scarti. In un passaggio memorabile, il famoso filosofo illuminista Jean-Jacques Rousseau scrisse: «Il primo uomo che, avendo recintato un pezzo di terra, dichiarò questo è mio e trovò altri sempliciotti che gli credettero, fu il v ero fondatore della società ci vile. … E vitate di dar e ascolto a quest’impostore; che la rovina ci colpisca se dimentichiamo anche per una sola v olta che i frutti della terra appartengono a tutti noi, e la terra in quanto tale a nessuno». La clausola lockiana ammicca spudoratamente a questa verità innegabile, ma la so vrastante teoria del diritto di proprietà la rende praticamente inutile. Di fatto quella clausola garantisce anzi che nella vita reale, ben al di là di uno st erile dibattito filosofico, non ne verrà mai lasciato abbastanza, e della stessa qualità, in comune per gli altri. Come va calcolata la ricchezza? 116 Una volta che una r isorsa viene legalmente riconosciuta in quant o proprietà, il mercato accorre a stabilirne il prezzo – passo considerato assai vantaggioso, dato che per il mondo dell’ec onomia il prezzo è al contempo l’indicatore supremo del valore di un oggetto e il modo più idoneo per stabilire tale valore. La gente è invitata a massimizzare i propri interessi razionali ed egoistici tramite il sistema dei prezzi e gli scambi commerciali; da ciò emergerà natur almente il benessere collettivo grazie alla famosa “mano invisibile” del mercato. Si presume che il mercato sia più efficiente ed equo nella dist ribuzione della ricchezza rispetto allo Stato – e quindi la strategia migliore per gestire le risorse naturali, sempre secondo l’ortodossia economica, è quella di privatizzarle e piazzarle sul mercato. La verità è che questo sistema è un disast ro per il mondo r eale. In genere la struttura dei prezzi non riesce a tener conto delle qualità di 117 vario tipo che esistono al di fuori al mercato stesso – ovvero quei valori sottili, qualitativi, complicati e di lungo t ermine che sono gli attributi caratterizzanti della natura. Qual è il valore di mercato dell’atmosfera? Oppure di un fiume pulito? E dei neonati privi dei difetti indotti dall’inquinamento? L’economia non può t rovare risposte adeguate a queste domande per l’impossibilità oggetti va di stabilire un prezzo di mercato che abbia senso per queste situazioni concrete. Il prezzo si limita a quantificare il valore di scambio, non certo il valore d’uso. Ecco perché la grandiosa narrazione della teoria economica tradizionale non può andare oltre la celebrazione del prodotto interno lordo (Pil) come punta massima del pr ogresso umano, calcolando il totale del valore relativo all’intera attività del mercato. Non ci si cura affatto se quest’attività abbia apportato o meno dei benefici alla società – anzi, non si pone neppure la domanda! Ci si limita invece a quantificare gli scambi di denaro da una persona all’altra, che poi è la sciocca definizione della creazione di ricchezza. In base a questi calcoli, l’enorme fuoriuscita di petrolio nel Golfo del Messico dell’aprile 2010 e il disastro nucleare di Fukushima del marzo 2011 andrebbero considerati sotto una luce positiva, perché in qualche modo hanno finito per stimolare l’attività economica. Ida Kubiszewski, Robert Costanza e altri economisti hanno dimostrato con precisione le carenze dell’indice del Pil in uno studio del 2013 sui vantagg i sociali netti dell’andament o economico relativo a 17 paesi, ovvero il 53 per c ento della popolazione mondiale. Applicando un indice diverso, noto come indicatore del progresso autentico, hanno appositament e preso in c onsiderazione decine di fatt ori ignorati dai calcoli del Pil, incluse attività negative quali reati, inquinamento e c onflitti sociali, insieme ad aspetti positi vi non dir ettamente pertinenti al mercato, tipo il v olontariato e il la voro domestico. Cosa ne hanno concluso? Che i costi della crescita economica a livello globale hanno superato i vantaggi fin dal 1978! Sempre in quell’anno, l’impatto ecologico dell’attività umana a veva oltrepassato la biocapacità del pianeta. E nonostante il valore del Pil globale fosse tri- 118 plicato a partire dal 1950, la qualità della vita in quei 17 paesi non aveva registrato alcun miglioramento significativo fin dal 1975. Già nel 1856 il leader del movimento preraffaellita inglese John Ruskin aveva coniato il termine “illth” per definire i danni, involontari e incalcolabili, provocati dal mercato. Un termine ripreso di recente per indicare che questo sistema dei prezzi, sotto il g iogo della proprietà privata, sta causando danni pari o superiori alla ricchezza che produce – eppure quasi mai i primi vengono calcolati, sono fuori gioco, diversamente dalla seconda. I bilanci aziendali e i Pil nazionali r iflettono soltanto la ricchezza monetaria risultante dalle transazioni economiche, omettendo deliberatamente i danni non iner enti al mercato. Danni che finiscono per ricadere sulle spalle dei beni comuni, perché il mercato si appropria liberamente di tutto il possibile dalla natur a senza riconoscerne il valore reale (dato che la natura viene considerata una res nullius). E dopo aver intascato e privatizzato i relativi profitti, ne scarica rifiuti e dissesti addosso ai beni c omuni, costringendo i commoner e le istituzioni pubbliche a ripulire le macerie. Come menzionato sopra, ciò mer ita l’appropriata definizione di “tragedia del mer cato”: i sussidi nasc osti e incalc olabili e le esose “esternalità” che il mercato, al servizio della proprietà privata, impone a carico dei beni c ollettivi. Questa situazione non do vrebbe certo stupire una società che considera il prezzo di un oggetto come il suo metro di valore più serio e affidabile. Se una risorsa non ha un pr ezzo né un titolo di proprietà, viene automaticamente considerata come qualcosa ”senz’alcun valore” oppure “a libera disposizione di tutti”. Non sorprende notare che spesso l’atti vità commerciale calpesta i valori ecologici, mentre laricchezzadella naturanon se ne va c erto in giro con ilcartellino del prezzo. Per esempio, generalmente il prezzo stabilito per il pesce o per il leg name non riflette il valore reale degli organismi e dei sistemi naturali, sebbene le dimensioni invisibili e incalcolabili a livello di mercato siano essenziali per la riproduzione del pesce e del legname. È facile ignorare le esternalità del mercato anche perché in genere queste sono sparse tra ampie fasce di popolazione e vaste regioni geografiche. È impossibile per un singolo individuo o località fare qualcosa di concreto contro l’inquinamento atmosferico o i residui dei pesticidi negli alimenti. Queste esternalità tendono inoltre a celarsi al margine della conoscenza scientifica (i vaccini causano forse l’autismo? I cellulari provocano il cancro al cervello?), rendendo così alquanto difficile identificarne e confermarne gli aspetti negativi a livello scientifico. E il comparto industriale resiste pervicacemente a ogni verifica documentata dei danni esterni, temendo che certe notizie sgradite possano innescare adirate reazioni politiche e costose riparazioni. Tutta questa serie di motivi rende assai più probabile che sia un sistema basato sulla gestione collettiva, anziché sulla proprietà privata, a offrire le precauzioni adeguate per prevenire possibili danni. In un sistema centrato sui beni comuni, le pressioni strutturali per ottenere dei profitti sono ridotte, mentre è maggiore l’incentivo a tener conto di fattori meno evidenti e a lungo t ermine. Queste istituzioni sociali collettive promettono inoltre di prendersi cura della sost enibilità di una risorsa nei tempi lunghi, rispetto a quanto non possano far e gli investitori, perché l’identità e la cultura dei commoner sono ben radicate nella stessa governance delle risorse. Invece chi fa un investimento tende a preoccuparsi in primo luogo del ritorno economico, considerando secondario ogni altro aspetto (le condizioni lavorative, la sicurezza dei prodotti, le ricadute ecologiche, ecc.). Il problema di fondo sta nel fatto che il messaggio trasmesso dal cartellino del prezzo è troppo grezzo e impersonale per alterare le pratiche gestionali. I beni comuni come forma di governance pubblica 119 La questione irrisolta è come implementare dei sistemi capaci di tutelare i beni c ollettivi dalle usur pazioni del mercato. Quali i passi necessari per proteggere efficacemente le cose che ci stanno più a cuore? Un problema urgente fintanto che la proprietà privata e il prezzo ri- 120 marranno la definizione pr estabilita del valor e a li vello di politic he pubbliche, perché, come abbiamo v isto, questi sist emi, per quant o preziosi in determinati contesti, finiscono per relegare in secondo piano gran parte dei valori ecologici, sociali e morali. Come tutelare la dignità e il rispetto delle persone, al di là e al di sopra di quelle consentite dal diritto di proprietà privata? Come garantire il diritto della gente a coinvolgersi in quegli scambi sociali esterni al mercato (economie del dono, collaborazioni informali, forme nuove d’azione collettiva), a malapena riconosciuti dalle concezioni politiche moderne? Come sostenere la giustizia sociale e i diritti umani in quanto valori inalienabili che dovrebbero persino avere la precedenza sui diritti della proprietà imprenditoriale? Sono questi i problemi cruciali al centro della sfida che oggi si trova ad affrontare il movimento globale dei beni c omuni. Pur essendo impossibile illustrarli appieno nelle pagine che seguono, cercherò comunque di rimarcare alcuni punti che possano aiutarci a trovare delle risposte adeguate. Comprendere in maniera esaustiva il ruolo delle norme sulla proprietà è una par te vitale dell’equazione complessiva, ma altrettanto importante è r endersi conto che per gar antire l’esistenza dei beni comuni bisogna andare ben oltre il diritto di proprietà e le for mulazioni legali. Come vedremo nel capitolo successivo, è la governance sociale (valori, pratiche, usanze, cultura) che va posta al centro di queste esperienze collettive. L’avvento dei beni comuni digitali 121 Se le tradizionali istituzioni del pot ere appaiono testardamente resistenti al cambiamento e legate al convenzionale diritto di proprietà, nel cyberspazio le cose sono andate ben diversamente. Dopo aver raggiunto le masse nel 1994, il World Wide Web si è imposto come un’eccitante arena per innovatori, idealisti e iconoclasti precisamente perché qui non ci sono istituzioni t radizionali da scalzare. Ogni utente è libero di lanciare qualsiasi progetto voglia, senza dover chiedere permesso a chicchessia o far fronte a esose tariffe. A dire il vero, il copyright è tuttora in vigore, ma quel che conta assai di più sono le pr atiche sociali condivise, come hanno rapidamente imparato i commoner digitali. È successo così che il web, e più in gener ale un po’ tutte le tecnologie digitali in rete, sono diventate gli spazi preferiti per la sperimentazione. Forse la sorpresa maggiore è stata l’incr edibile capacità di internet di stimolare la cooperazione sociale e la c ondivisione. Mentre per le grandi corporation tecno-mediatiche è stato tutt’altro che facile inventare nuovi mercati online, gli utenti medi hanno t ratto vantaggio dalla semplicità r ichiesta per dar v ita a progetti collettivi nel mondo digitale – da siti d’og ni sorta a c omunità su t emi specifici. Produzioni creative di tipo completamente nuovo sono spuntate come funghi su internet, in maniera del tutto indipendente dal mercato o dalle istituzioni nazionali. La prima e tumultuosa ondata rivelatoria delle potenzialità collaborative online ha riguardato il successo del software libero e open source, tra cui mer itano di esser e segnalati: Perl (un linguagg io di pr ogrammazione), Sendmail (programma per la posta elettronica), Apa- 122 che (il pacchetto per la gestione dei server maggiormente usato su internet) e Linux (un ottimo sist ema operativo da fare invidia a Windows). Alla sorprendente penetrazione delle reti distribuite ha fatto rapidamente seguito l’avvento della blogosfer a, dei social netw ork e soprattutto di Wikipedia, l’enciclopedia libera che è divenuta una sorta di repubblica digitale in se stessa, con edizioni in 285 lingue e circa 76.000 volontari attivi in ogni parte del mondo. Assai fiorente è anche il flusso di mat eriale accademico basato sull’open access, che ha permesso a discipline e strutture universitarie di aggirare gli editori commerciali parassitari e r iprendere in mano il controllo sulla diffusione delle pr oprie ricerche e studi. Muovendosi su percorsi paralleli, il movimento delle “risorse didattiche aperte” ha avviato con successo lo sviluppo collaborativo e libero di libri di testo, curricula e materiali dei corsi universitari. Tante di quest e innovazioni collaborative sono stat e rese possibili dalle licenze Creative Commons: una raccolta di sei licenze di base e altri strumenti legali lanciati nel 2001, grazie ai quali i tit olari del copyright possono capovolgere l’impostazione predefinita delle norme vigenti che impone uno stretto controllo privato, per autorizzare invece la c ondivisione dei lor o contenuti. Gli aut ori possono c osì creare bacini collettivi di materiali liberamente accessibili, specificando le limitazioni g iuridiche sull’appropriazione privata o sulla c ommercializzazione delle loro opere. Nel corso del tempo ciò ha dato vita a una “sharing economy” di proporzioni globali e senza precedenti, dove circolano programmi software, studi scientifici, archivi fotografici, saggi e produzioni creative d’ogni tipo e fattura. È vero che molti tendono a condividere una gran mole di contenuti sui maggiori social network come Facebook, YouTube e Twitter senza ricorrere alle licenze Creative Commons. Queste piattaforme sono regolate dalle rispettive “condizioni d’utilizzo” che gli utenti accettano automaticamente al momento dell’iscrizione e che per molti aspetti si richiamano ai princìpi dei beni comuni ma con una differenza significativa: le decisioni finali spettano comunque ai gestori e proprietari della piattaforma. Motivo per cui questo tipo di condivisione sui siti commerciali è stata spesso par agonata alla “mezzadria digitale” nelle piantagioni imprenditoriali: contenuti e link ar chiviati dagli utenti sono soggetti ai capr icci di direttive interne comunque modificabili senza preavviso, oltre che alle pressioni degli investitori. L’adozione di un nuovo business model o l’acquisizione dell’azienda possono significare la perdita definitiva del nostro blog o della r accolta di fotografie, o magari ci ritroviamo improvvisamente bombardati da inserzioni d’ogni genere. Senza dimenticare che queste piattaforme tendono a rivendere agli inserzionisti i dati personali degli utenti, insieme ai dettagli su preferenze, acquisti e abitudini online. Questi sono i pericoli delle cosiddette “open platform” amministrate come possedimenti imprenditoriali anziché in quanto beni comuni gestiti dagli stessi utenti. Una piattaforma aperta può incentivare la collaborazione ma non necessariamente la libera condivisione, la partecipazione diretta oppure la governance collaborativa a lungo termine. L’ultima parola spetta ai dir igenti di impr ese digitali mirate comunque al profitto. Il “settore dei beni comuni”, come mi piace definirlo, è assai più sviluppato su internet che in qualsiasi alt ro ambito odierno, probabilmente per lo stesso motivo che lo ha portato a imporsi come una forza culturale ed economica indipendente e vigorosa. Prima dell’esplosione del web, progetti e risorse condivise venivano considerati generalmente poco più che una curiosità dell’epoca medievale oppure la palude culturale degli studi sociologici. Nel suo importante libro del 2006, The Wealth of Networks12, Yoachi Benkler scr iveva fra l’altro: «Stiamo assistendo all’emergere di pratiche d’azione collettiva molto efficaci, decentralizzate e aut ogestite, per n ulla legate al sist ema dei prezzi né a strutture manageriali». Come spiegava il docente di diritto ad Harvard, si tratta invece di sistemi collaborativi, non-proprietari e basati sulla «condivisione di risorse e strumenti tra persone affini Edizione italiana: La ricchezza della Rete, Università Bocconi 2007. 123 12 sparse sul territorio e interconnesse online decise a collaborare tra loro». Gran parte dei conflitti sociali e politici sui t ermini dell’applicazione odierna del diritto d’autore (descritti nel capitolo 5) va fatta risalire allo stravolgimento imposto da piattaforme social aperte e accessibili a tutti. L’infrastruttura stessa di internet stimola un li vello d’innovazione e di c ondivisione che su altri mezzi di c omunicazione risulterebbe semplicemente impossibile oppur e troppo costoso. È su questa spinta che la sua ascesa si è rivelata dirompente in ogni senso, dove la logica alla base della cooperazione online (interazioni sociali facili e a buon mercato tra vasti gruppi di utenti distribuiti) finisce per travalicare il r apporto economico imposto dal mer cato tradizionale (dove vigono ampie disponibilità di capitale, gestione imprenditoriale centralizzata e controllo professionale). Per affermarsi i beni comuni online richiedono poco più che una piattaforma condivisa, personal computer e accesso a internet. Anche per individui e gruppi poco organizzati è facile creare e produrre in piena autonomia i cosiddetti “contenuti generati dagli utenti”, lanciando così la sfida all’appiattimento economico e al controllo centralizzato tipico di programmi televisivi, film, libri e riviste firmati dalle corporation mediatiche. Il risultato: una profonda rivoluzione culturale di por tata globale le cui potenzialità dirompenti sono ancora di là da venire. Il software libero come apripista 124 Il primo esempio sig nificativo di bene c omune digitale è stat o il software libero: programmi informatici non necessariamente gratuiti, ma il cui c odice è liberamente accessibile a chiunque – e c he possono essere liberamente verificati, modificati, migliorati e c ondivisi senza violare alcun diritto d’autore. All’inizio degli anni ottanta, quando lo sviluppo di programmi per i personal c omputer era ancora un’arte collettiva in fasc e, Richard Stallman, il leggendario hacker del Mit, fu uno dei primi a riconosce- re che il software proprietario avrebbe potuto limitare fortemente la libertà individuale per l’accesso e il riutilizzo del software stesso – con effetti deleteri sull’innovazione. Stallman notò che le imprese applicavano le normative sul copyright per impedire agli utenti di sistemare qualche problema nel codice, oppure per migliorarlo e condividerlo con amici e colleghi. Il software – una volta sviluppato tramite procedure sociali e collaborative all’interno della comunità hacker13 – stava diventando un prodotto brevettato altamente lucrativo. E quindi una comunità centrata sulle risorse condivise era sul punto di essere convertita in una proprietà privata. Un quadro che fece infuriare Stallman, perché a farne le spese sarebbe stata una delle nost re libertà fondamentali, la cr eatività. Temendo inoltre che l’etica del mercato e le normative sul diritto d’autore avrebbero schiacciato l’etica hack er basata sulla c ondivisione e sulla reciproca assistenza, Stallman esc ogitò una br illante soluzione legale nota come Gnu General Public License (Gpl), rilasciata per la prima volta nel 1989. Oggi questa licenza, talvolta indicata con il termine “copyleft” (con il simbolo “c” del copyright rovesciato) è ampiamente celebrata come un cruciale “hack” per aggirare le norme sul diritto d’autore. Anziché mettere sotto lucchetto il codice come una proprietà privata, questa licenza consente a chiunque di copiare, modificare o distribuire (vendita inclusa) og ni programma che vi fa r icorso. (Da notare qui una certa confusione sorta sulla terminologia di “free software”, poiché il termine inglese “free” può voler dire sia libero che gratuito; Stallman provò a chiarire la situazione con una battuta poi divenuta famosa: «Il software dev’essere “free” nel senso di “freedom”, non di birra gratis»; per evitare ulteriori confusioni, in molt e comunità europee e sudamericane si preferisce la definizione “software libre”). 125 13 Diversamente da certe testate mainstream che falsamente equiparano gli hacker ai criminali comuni, tradizionalmente il termine indica quei programmatori capaci di trovare soluzioni ingeg nose a spinosi pr oblemi tecnici con un’etica gioviale e centrata sulla comunità. 126 Il titolare del copyright su un programma informatico che vi appone la licenza Gpl dichiara legalmente che il codice è un bene comune, una qualifica ottenuta facendo leva su un unic o requisito giuridico: qualsiasi opera derivata, incluso lo stesso programma modificato, deve essere rilasciata in base alla medesima licenza Gpl, onde garantirne la libera condivisione. Identico requisito si applica indefinitamente a ogni ulteriore derivato dell’opera secondaria. In tal modo la Gpl rende virale e tutelata a livello giuridico la stessa condivisione del software, e per magg ior sicurezza nessuno può modificare in alcun modo i termini della licenza stessa. La genialità della Gpl sta nel garantire che tutto il codice informatico così condiviso rimarrà tale per l’eternità: farà sempre parte dei beni comuni e non potrà mai essere privatizzato. Qualcuno potrà cercare di mettere in vendita quel codice (non mancano, per esempio, i rivenditori commerciali di pr ogrammi open sour ce e sist emi Linux), ma il punto della Gpl è che nessuno può impedire l’accesso al codice e neppure il suo r iutilizzo. Sapendo c he il lor o lavoro rimarrà per sempre accessibile a tutti, gli hacker hanno perciò messo volontariamente a disposizione t empo e talenti per cr eare questi bacini di software collaborativo. Trent’anni fa, l’ossessione di Stallman c on la “libertà del software” sembrava una missione alla Don Chisciott e, e la sua stessa immagine (barba e capelli lunghi, talvolta a piedi scalzi, dal fare imperioso) lo faceva somigliare a un pr ofeta del Vecchio Testamento. Tuttavia, sull’onda della popolarità acquisita dal World Wide Web e del kernel di un sistema operativo amatoriale lanciato da Linus Torvalds, verso la metà degli anni novanta improvvisamente la Gpl assunse un sig nificato storico. Lo stesso Torvalds scelse questa licenza per il suo k ernel iniziale, che integrato successivamente con altri programmi collaborativi (parecchi dei quali r ealizzati proprio da Stallman) diede v ita a un sistema operativo completo: Linux (chiamato Gnu/Linux da Stallman) divenne così uno dei pacchetti informatici più potenti e rispettati della storia. 127 La diffusione di questi pr ogrammi sotto licenza Gpl aprì r apidamente la strada a un’ampia produzione di iniziative analoghe, per dar vita a quello c he venne poi definito il software open source. L’unica differenza sostanziale tra le due correnti sta nel fatto che quest’ultimo presta particolare attenzione alla qualità dei programmi collaborativi, per renderli così più attraenti e credibili agli occhi delle grandi corporation e delle agenzie go vernative. I pr ogrammatori open sour ce erano assai meno interessati alle valenze politiche del movimento del software libero di Stallman, preferendo invece rimarcare l’utilità pratica della condivisione diffusa di questi pacchetti informatici. Oggi il software open source è diventato uno dei capisaldi dell’economia high-tech, nonostante (o forse g razie a) l’assenza di luc chetti proprietari. Giganti del settore tecnologico come IBM, Oracle e Hewlett-Packard hanno avviato lucrative attività fornendo assistenza tecnica ed estensioni personalizzate, mentre Linux gira su milioni di server web, con corporation ed esperti di prima classe che vi fanno affidamento per progetti critici in ogni parte del mondo (N ASA, Pixar, IBM). La centralità della Gpl non sfuggì all’occhio attento di Lawrence Lessig, allora docente di diritto a Stanford e dal 2008 ad Harvard, il quale era ben consapevole dei pericoli per l’innovazione derivanti dalle attuali norme sul diritto d’autore. Ragione che lo spinse a r adunare un piccolo gruppo di studiosi legali, esperti informatici, artisti, autori e attivisti per mettere a punto una serie di sei articolazioni di licenze libere da applicare ai contenuti sotto copyright. Come illustrato all’inizio del capitolo, basta che i titolari di un’opera decidano di rilasciarla sotto una di queste licenze Creative Commons, per affermarne la libertà di utilizzo e condivisione in base ai suoi termini specifici. Per esempio, si può decidere di rendere liberamente condivisibile il contenuto di un sit o web, ma non a sc opo commerciale (la lic enza “non commerciale”) né per ricavarne opere derivate, come la riduzione di una foto o la traduzione, senza un’apposita autorizzazione (la licenza “non opere derivate”). C’è poi la lic enza “condividi allo stesso 128 modo”, che in tal senso assomig lia alla Gpl, garantendo che qualsiasi opera derivata e la sua progenie sarà liberamente accessibile per sempre. Questo libro (sia nella versione inglese che in quella italiana) viene rilasciato sotto la licenza Creative Commons BY-NC-SA (attribuzione-non commerciale-condividi allo stesso modo), perché l’autore vuole autorizzarne copia e diffusione, garantendogli l’esplicita attribuzione, esclusivamente per usi non commerciali, mentre ogni opera derivata, incluse t raduzioni, nuove ristampe ed est ratti di una c erta ampiezza, devono essere legalmente condivisibili allo stesso modo. Tutte le opere rilasciate con una licenza Creative Commons devono darne credito all’autore originario (la licenza “attribuzione”), ma al di là di questo requisito di base, spetta poi ai singoli titolari specificarne l’utilizzo concesso agli altri; ciò non tocca comunque “l’uso consentito” già previsto dalle norme sul diritto d’autore, che garantisce un certo livello di condivisione a scopo non commerciale. La combinazione tra licenza Gpl e Creative Commons ha avuto un impatto enorme nel consentire a una var ietà di beni c omuni digitali di attecchire e pr osperare, creando una sor ta d’infrastruttura legale che li tut ela da possibili enclosure, perché queste opere rimarranno condivisibili in maniera permanente. L’accoppiata delle due licenze ha inoltre ispirato una varietà di innovazioni giuridiche per affermare la condivisione legale di c ontenuti di tipo di verso, come i database e le dei laboratori scientifici. E in certi campi, tra cui didattica, ricerca accademica e servizi amministrativi, le licenze Creative Commons hanno contribuito a diffondere l’idea per cui ogni documento e progetto curato dalla pubblica amminist razione andrebbe messo a liber a disposizione dei cittadini. Oggi in og ni parte del mondo cr esce il numero di musei, archivi, agenzie governative ed enti didattici c he applicano le licenze Creative Commons per garantire che i loro documenti e file digitali sul web restino liberamente accessibili a tutti. La rivoluzione dell’open access 129 A un certo punto, gli editori commerciali proposero ai ricercatori il modo migliore per passare da un sist ema di corrispondenza privata sulle loro scoperte e ricerche a uno basat o su testi rivisti dagli stessi colleghi (peer review) raccolti poi in pubblicazioni ac cademiche dall’ampia distribuzione. Ma l’arrivo del World Wide Web nel 1994 rese assai più semplice ed economico raggiungere immediatamente il pubblico globale, portando così a un annoso c onflitto (tuttora in corso) per trasformare questo tipo di produzioni scientifiche in un formato editoriale più accessibile: le riviste open access. Pur avendo fornito alcuni servizi preziosi a livello di produzione e distribuzione, questi editori commerciali hanno assunto un ruolo parassitario rispetto al bene comune della conoscenza scientifica, imponendo il loro diritto d’autore a tappeto sugli articoli e le ricerche pubblicate. In tal modo hanno assunt o il c ontrollo su una pr oduzione scientifica in realtà già finanziata da alt ri soggetti, tra cui enti statali, fondazioni, università. Spesso questi st essi editori hanno usat o la pressione del copyright, insieme al pr estigio associato con alcune di queste riviste, anche per imporre astronomiche tariffe d’abbonamento alle biblioteche universitarie: tra il 1986 e il 2004, le tariffe d’abbonamento per le uni versità americane subì un incr emento pari al 273 per cento. Dopo parecchi anni di stallo , le uni versità avviarono la r iforma e passarono al contrattacco. Nel 2012, finalmente l’Università di Harvard decise di a verne avuto abbastanza: in un c omunicato pubblico, consigliò ai propri docenti di evitare di pubblicare le proprie ricerche in riviste che imponevano l’accesso a pagamento. La mossa contribuì a convincere molte biblioteche e istituti, sia negli Stati Uniti sia nel resto del mondo, che era giunto il momento di lanciare un’aggressiva campagna per passare al modello dell’edit oria open access. La motivazione primaria di Harvard era quella finanziaria: il budget annuale per gli abbonamenti a queste riviste raggiungeva quasi i 3,75 milioni 130 di dollari, e qualche editore incassava dall’università fino a 40.000 dollari l’anno. Mediamente, quasi il 65 per c ento dei fondi a disposizione delle biblioteche universitarie statunitensi andava a coprire questi abbonamenti, con tre grossi editori che ne succhiavano oltre la metà: Elsevier, Springer e Wiley. Il movimento dell’editoria open access emerse in maniera organizzata nel 2001 con l’obiettivo di rendere le ricerche accademiche accessibili a tutti, liberamente e indefinitament e. In retrospettiva, questa sembra un’iniziativa inattaccabile dato che i contribuenti hanno sborsato miliardi di dollari per finanziare tali ricerche. Eppure non è così: il movimento ha dovuto impegnarsi allo stremo per anni prima di superare l’opposizione degli editori e di politici male informati, oltre alla tipica inerzia dell’ambit o accademico. È stat o anche necessario escogitare nuovi modelli impr enditoriali e st rutture amministrative ad hoc, eclissando c erte tradizioni in v igore da t empo nell’editoria universitaria. Per esempio, dato che molte decisioni sulle promozioni e sull’assegnazione delle cattedre si fondano sulla qualità e sul pr estigio delle riviste dove i docenti pubblicano i lor o studi, non di r ado i docenti più giovani appaiono riluttanti a preferire testate open access poco note rispetto a periodici di alto profilo come Nature e Science. Questi cambiamenti hanno inc ontrato ovviamente la feroce opposizione dei grandi editori universitari, i quali si sono impuntati da vanti alle r ichieste delle autorità nazionali che le r icerche finanziate dai contribuenti venissero pubblicate sotto i protocolli dell’open access. Nonostante questa forte resistenza e altre scuse ridicole, alla fine del 2013 esistevano quasi diecimila r iviste accademiche open ac cess: al pari delle licenze Gpl e Creative Commons, queste pubblicazioni contribuiscono a “liberare” il sapere a favore di tutti i cittadini, superando la scarsità che gli editori vorrebbero imporci tramite le limitazioni del copyright e st rumenti restrittivi come il “digital rights management”. Nel mio libro del 2009, Viral Spiral, centrato sull’ascesa del software libero e della cultur a libera, rimarcavo il fatto che l’evoluzione di 131 una singola innovazione basata sui beni c omuni tipicamente finisce per ispirarne tante altre, e poi alt re ancora. La Gpl por tò alle licenze Creative Commons, che a sua volta ispirarono l’editoria open access, da cui poi discese un’ampia gamma di “risorse didattiche aperte” come passaggio successivo della spirale virale. Non fu soltanto l’editoria accademica, bensì l’intero sistema didattico a riconoscere che il controllo proprietario della conoscenza è antitetico ai suoi stessi valori di fondo, cioè imparare a crescere tramite la partecipazione e la condivisione. In altri termini, il mondo accademico è un bene comune. Negli Stati Uniti, le amministrazioni dei college locali rimasero sbigottiti nel constatare che molti studenti er ano costretti ad abbandonare o r imandare il loro percorso accademico perché non potevano permettersi il costo esorbitante dei libri di testo. È tutt’altro che insolito per gli editori pubblicare un’edizione nuova ogni due o tre anni al solo scopo di rendere “obsolete” quelle precedenti e spingere all’acquisto di n uovi libri di t esto. Motivo per cui alcuni inseg nanti, già parte del movimento open access, hanno così dato vita al Community College Consortium for Open Educational R esources, proprio per identificare e pubblicizzare quei libri di testo aperti, ovvero rilasciati sotto licenze Creative Commons e disponibili al pr ezzo vivo della stampa su richiesta. Una pratica che ha fatto risparmiare centinaia di dollari a tanti studenti universitari statunitensi. Nel 2001 il Massachusetts Institute of Technology ha aperto la strada di questo movimento diffondendo liberamente sul web molti materiali relativi ai c orsi interni. Una decisione inno vativa che ha influenzato profondamente l’insegnamento della fisica e di alt re discipline in Cina e altri paesi minori dove buona parte della popolazione vive in aree rurali isolate. E che ha poi por tato al lancio dell’OpenCourseWare Consortium, un’iniziativa collaborativa che oggi conta oltre 120 membr i tra università e istituti didattici in og ni parte del mondo. La spirale virale che ha avuto origine con il software libero e le licenze Creative Commons continua a espandersi. Lo st esso termine 132 open source è divenuto un meme culturale a cui si ricorre frequentemente per indicar e ogni attività aperta, partecipativa e t rasparente. Un ambito in continuo fermento, dove vanno segnalate alcune recenti aggiunte: il movimento dell’open design, dove tutti sono benvenuti a coinvolgersi nel design di vestiti, mobili, componenti informatiche e perfino automobili; il progetto Arduino, dal nome di un bar di Ivrea frequentato da alcuni dei fondat ori, finalizzato alla produzione di mini schede elettroniche per creare rapidamente e a c osti minimi piccoli dispositivi e prototipi a scopi hobbistici e didattici, basati su software libero e su sc hemi circuitali distribuiti come hardware libero; l’Open Prosthetics Project, avviato nel 2009 da un e x marine Usa e dove chiunque può par tecipare al design di ar ti prostetici, oppure alle specifiche necessarie per c onsentirne la r ealizzazione anche da parte di persone c on scarse competenze tecniche, tutto materiale da diffondere nel pubblico dominio, inclusa la realizzazione di arti prostetici per rocciatori e un braccio per andare a pesca. Un altro progetto affascinante è Wiki-speed, una start-up di Seattle del settore automobilistico con un migliaio di collaboratori sparsi in 20 paesi, che sta usando i pr incipi dell’open source per progettare e realizzare una macchina da corsa modulare e leggerissima dal consumo irrisorio, oltre 40 chilometri con un litro di benzina. Ancora, la rete dell’Open Source Ecology sta mettendo a punto attrezzature agricole condivisibili e a basso c osto per comunità autosufficienti, come LifeTrac, un trattore multi-uso e open source con componenti modulari, economici, facili da assemblar e e mantenere – ovvero, elementi non complicati, dispendiosi o br evettati. Il design e la pr oduzione di oggetti fisici ha raggiunto un livello sufficientemente ampio da spingere la comunità globale degli innovatori a creare nel 2009 una specifica associazione, denominata Open H ardware and Desig n Alliance (Ohanda), il cui obiettivo dichiarato è quello di «incoraggiare la condivisione di open hardware and design». Crescono nel frattempo le iniziative collaborative in ambito digitale, a cominciare dalle rete autogestita di Crisis Commons che racco- 133 glie volontari esperti di high-tech pronti ad attivarsi nelle emergenze dei disastri naturali. All’indomani del terremoto che colpì Haiti nel gennaio 2010, migliaia di loro organizzarono rapidamente sul web alcuni strumenti di traduzione e mappe dinamiche per individuare i dispersi sul territorio e segnalare i tragitti utili per raggiungere ospedali con disponibilità di posti letto. Meritano una menzione anc he quelli che mi piace definire i “beni comuni eco-digitali”, dove si ricorre alla tecnologie di internet per tenere sotto controllo quanto succede nel mondo ambientale. Ci sono siti che invitano gli utenti a usare cellulari, sensori, Gps e alt ri sistemi elettronici per monitorare la presenza in loco di uccelli, farfalle e specie invasive, oppure i livelli d’inquinamento in determinati corsi d’acqua. Questi progetti di “rilevamenti partecipativi” riescono ad aggregare un’ampia quantità di dati di var io tipo, contribuendo così a migliorare la qualità delle politiche amministrative e la loro applicazione. La cittadina di Linz, in Austria, con una popolazione di 190.000 abitanti, ha avviato uno dei progetti più ambiziosi in tal senso , mirato a coprire un’estesa area urbana, quello c he dovrebbe diventare un “open information commons”. La città g ià fornisce gratuitamente ai cittadini l’accesso al wi-fi, una casella di posta elettronica e spazio web per scopi non commerciali. Ora si sta cercando di convincere tutte le strutture regionali ad abbr acciare l’insieme c omposto dalle lic enze Creative Commons, piattaforme di “open data”, mappe e r isorse didattiche aperte. Secondo le aut orità amministrative, un simile bene comune regionale spingerà gli innovatori locali a produrre utili strumenti per l’ambito locale, incoraggiando al contempo una maggiore partecipazione civica e uno sviluppo economico più robusto. Nel prossimo futuro è plausibile prevedere la continua proliferazione di esperienze analoghe, se non altro perché promettono efficienza, utilità e interesse sociale. Ovviamente l’imprenditoria è attenta a questi sviluppi e sta posizionandosi per trarre vantaggio dai beni comuni digitali, o quant omeno per ospitar e queste piattaforme aperte sulle loro piattaforme. Ne è un evidente segnale il crescente interesse delle 134 corporation per la c osiddetta “sharing economy”, con modelli imprenditoriali innovativi e basati sul w eb per condividere passaggi in auto, stanze in affitto e altre forme che promuovono il “consumo collaborativo” (anche se non sembr a che queste imprese possano essere considerate dei beni comuni). Pur avendo capito che le reti aperti tendono a incoraggiare naturalmente la cooperazione e la condivisione, le aziende tecnologiche puntano tuttora a “monetizzare” le comunità, anziché cercare di sostenerne gli interessi a lungo termine oppure al di fuori del mercato. È così che Facebook e Google forniscono molti servizi utili “gratuitamente”, mentre al contempo si appropriano aggressivamente dei dati personali degli utenti e vendono inserzioni personalizzat e in un mer cato che punta solo a conquistare la nostra mente di navigatori online. Fra i tanti progetti in corso, con la digitalizzazione dei libri Google punta inoltre a imporsi come controllore privilegiato e proprietario dell’accesso a materiali di pubblico dominio, a detrimento dei rivali e dei cittadini. E come rivelano questi esempi, le corporation appoggiano lo “sharing” soltanto se possono ricavarne dei profitti – nulla a che fare con la pratica dei beni comuni in quanto tali. Comunque sia, coloro che danno vita a comunità online basate sulla condivisione sono par te di un’importante avanguardia culturale, estendendo così pratiche e aspettative sociali ad altri ambiti della loro vita quotidiana, insieme all’avversione per l’intrusivo diritto di proprietà privata. È questa una delle ragioni che ha portato, per esempio, alla fondazione del P artito Pirata, nato in S vezia il pr imo gennaio 2006, anche in decine di alt ri paesi con la presentazione di candidati alle elezioni politiche nazionali, nonché alla sconfitta del 2012 di un importante trattato internazionale sulla proprietà intellettuale redatto in gran segreto, l’Acta (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), grazie a una c oalizione composta da sost enitori della cultur a libera, hacker, attivisti, imprese di piattaforme aperte. Oggi che così tanta gente ha avuto occasione di assaporare la libertà, l’innovazione e la t rasparenza delle reti aperte e dei beni c omuni di- 135 gitali, è impossibile tornare indietro ai modelli imprenditoriali basati sul controllo tipici del XX secolo. Per la generazione dei “nativi digitali”, tante delle idee t radizionali legate alla proprietà privata (il controllo esclusivo, le motivazioni commerciali, l’indifferenza al bene comune nei t empi lunghi) appaiono decisament e fuori moda, se non palesemente antisociali. È troppo presto per capire a quali trasformazioni legali o politic he potrà condurre l’etica di quest e pratiche collettive, ma se dovessimo giudicare dai movimenti emersi negli ultimi anni anche grazie a internet – la Primavera Araba, gli indignados spagnoli, il movimento internazionale Occupy, la cruciale vittoria contro l’Acta – la forza di quest o cambiamento appare chiaramente contagiosa. Nel capitolo successivo prenderemo in esame sviluppi analoghi in campi ben al di fuor i del cyberspazio ma c he ribadiscono comunque la varietà e la robustezza raggiunte dal paradigma dei beni comuni a livello globale. Le tante galassie dei beni comuni 136 Benché siano qualcosa di fresco e attuale, almeno per noi occidentali, i beni comuni digitali vanno situati in una pr ospettiva più vasta. In questo campo sono stati i popoli indigeni ad aprire la strada, affinando l’arte della condivisione molto prima che gli hacker iniziassero a fare lo stesso con il codice informatico e che gli scienziati sviluppassero complesse teorie sui beni comuni. Ma non bisogna dimenticare l’esteso percorso dei beni comuni in Inghilterra e in Europa, di quelli di sussistenza nelle regioni rurali di tutto il mondo e anche gli spazi urbani e i progetti gestiti in manier a collaborativa. Nel corso della storia, le società umane hanno prodotto una lunga e gloriosa serie di beni comuni. In questo capitolo, proverò a esplorarne più a fondo alcune importanti categorie, poiché ritengo necessario sviluppare una mappa mentale più ricca dei beni comuni operativi “sul campo”, e non come semplice astrazione mentale. Prima di tutto, un’avvertenza metodologica: alcuni sembrano dare per scontata l’esistenza di uno schema di classificazione natur ale, logico, dei beni comuni. Ho seri dubbi in proposito – o almeno, credo che ogni sistema di classificazione finir ebbe necessariamente per r iflettere i preconcetti culturali di chi la propone. La mappa mentale dei beni comuni di un africano sarebbe molto diversa da quella di un europeo, e le pr ospettive di ent rambi non coinciderebbero affatto con quelle di un amer icano. Gli schemi di classificazione t endono a imporre una visione troppo ordinata, strutturata e intellettuale del commoning – un fenomeno c he, a mio a vviso, merita piuttosto di essere inquadrato in termini esperienziali e storici. Penso quindi c he, invece di profondere tanti sforzi nella t eorizzazione, sia meg lio limitarsi a indi viduare quei g randi insiemi di beni comuni che presentano certe caratteristiche generali. Si può parlare di bene comune ogni qualvolta un gruppo di persone decide di gestir e una risorsa collettivamente, affrontando i pr oblemi connessi all’equità di accesso, all’uso e alla gestione a lungo t ermine. Tuttavia, per orientarsi nelle galassie dei beni c omuni oggi esistenti, occorre poter far riferimento a una mappa mentale c omplessiva. Nelle pagine che seguono saranno quindi brevemente presi in esame i beni c omuni di sussistenza e dei popoli indigeni, quelli collettivi in ambito civico e sociale, quelli sotto la tutela statale e le attività commerciali integrate nei beni comuni (l’ambito dei beni c omuni digitali è stato già preso in esame nel capitolo precedente). I beni comuni di sussistenza 137 I beni comuni tradizionali – quelli familiari in diverse epoche storiche e quelli più studiati dai t eorici contemporanei – hanno quasi sempre come oggetto le risorse naturali: acqua, foreste, aree pescose, terreni coltivabili, zone di caccia. Queste risorse sono doni della t erra e vanno gestite attivamente a vantaggio della sopravvivenza e del benessere di tutti. La questione r icorrente è come gestire l’accesso e l’uso di queste risorse condivise? Come prevenire il problema degli scrocconie degli abusi? Quale il sist ema di regole più efficace in tal senso? Alcune comunità e bioregioni hanno esplorato simili questioni nella pr atica, con una gestione collettiva di vecchia data. Dopotutto il punto è proprio questo: sviluppare un sistema socioecologico in grado di armonizzare costumi e pratiche sociali con la dinamica natur ale di un fiume, di un bosco o di un terreno agricolo. Non è sorprendente quindi che col tempo siano emersi certi modelli generali nella pratica operativa di queste esperienze. Gli indigeni ispanoamericani del New Mexico (Usa), hanno comin- 138 ciato a gestire su base comunitaria le idrovie locali, note col nome di acequia, sin dal XVII secolo. Questa tradizione “bioculturale” ha dimostrato che, anche in una regione molto arida come l’area sudoccidentale degli Stati Uniti, un bene comune può contemperare l’uso da parte della comunità al pieno r ispetto dei limiti ec ologici. È interessante osservare che, pur se le acequias sono riconosciute dalle norme statali, è la c omunità stessa a gestir e e pr oteggere l’approvvigionamento idrico. Tutti i membri di un’acequia sono tenuti a condividere l’onere di pr ovvedere alla sua man utenzione – par tecipando, per esempio, alla pulizia annuale dei canali. Mentre le vicine città sono afflitte da uno sviluppo suburbano incontrollato e da un’incessante carenza d’acqua, le ac equias sono r iuscite a dist ribuire le lor o risorse idriche in modo da soddisfare i bisogni di tutti, preservando terreni e acque e r icaricando le falde ac quifere, nonché proteggendo la fauna selvatica e l’habitat floristico. I beni comuni di sussistenza colpiscono la mente moderna come un fenomeno legato all’arretratezza, ai t empi andati. Ma sotto molti aspetti, il punto centrale è proprio questo – risalire alle norme sociali di una volta, quando si anteponevano i limiti vitali all’attività del mercato. Per i commoner, la massimizzazione del valore di mercato non è uno scopo prioritario; i bisogni della popolazione e la stabilità ecologica hanno la pr ecedenza. I fr uitori dei beni c omuni di sussist enza prendono per sé quel tanto che basta a soddisfare i loro bisogni, proteggendo così la risorsa stessa. È una conquista davvero singolare nella nostra epoca, quella di aver sviluppato l’etica dell’autosufficienza. In generale gli economisti sono poco interessati a queste dinamiche, forse perché gli appaiono di poc o conto, isolate e non legat e al mercato. Insomma, una vera noia! E dat o che il loro valore non è espr imibile in cifre, non vengono presi in considerazione nelle stime del Pil. L’importanza dell’autodeterminazione comunitaria, della r esilienza ecologica, dell’equità sociale oppur e del legame cultur ale con un determinato luogo, sono cose che sfuggono agli schemi dell’economia convenzionale. E tuttavia, i beni c omuni di sussistenza, ope- rando al di fuori del sistema del mercato e senza basarsi sul dir itto di proprietà privata o sul denaro, restano a tutt’oggi di vitale importanza per circa due miliardi di persone in tutto il mondo, secondo una stima fornita dall’International Association for the Study of the Commons. Occorre sottolineare che la categoria dei beni comuni di sussistenza comprende situazioni assai diverse tra loro e che non è certo esente da problemi. Molti di questi beni pot rebbero essere gestiti in manier a migliore; altri, oggi mal gestiti, potrebbero dare risultati più efficaci; altri ancora si scontrano con un ambiente politico tutt’altro che collaborativo. Rimangono tuttavia un impor tante mezzo di sussistenza quotidiana e di tutela della dignità delle persone, che tende a rispettare i limiti ecologici. Il fatto che oggi diversi Stati e mercati stiano faticosamente tentando di imitarli va c onsiderato un risultato straordinario. I beni comuni dei popoli indigeni 139 Un decennio fa è nato nel Perù meridionale il Parco delle patate (nella valle sacra del fiume Urubamba, vicino a Cusco, capitale dell’Impero Inca), un bene comune “per la conservazione del patrimonio naturale”, istituito per per mettere alle c omunità indigene delle Ande di esercitare il pieno dir itto di gestione sull’enor me numero di specie e varietà di patate autoctone. Si è trattato di un g rande traguardo, soprattutto perché le multinazionali del settore agrobiotecnologico stavano cercando di brevettare alcune delle no vecento varietà di patate di alto valore genetico curate dalle comunità andine nel corso di migliaia di anni. Lo statuto del Parco delle patate, ufficialmente noto come Area dell’eredità bioculturale indigena, autorizza settemila agricoltori appartenenti a sei c omunità indigene (Amaru, Chawaytire, Cuyo Grande, Pampallaqta, Paru-Paru e Sacaca) a gestire insieme i terreni in ogget- 140 to nell’interesse della collettività. Il punto è consentire a queste popolazioni di proteggere legalmente i loro mezzi di sussist enza e il lor o modo di vivere dallo “sviluppo” (soprattutto dai brevetti e dal c ommercio internazionali), salvaguardando al c ontempo il pat rimonio agroecologico locale. Da un lat o, si tratta di un esempio abbastanza isolato, perché sancisce giuridicamente e formalmente la necessità di conciliare le pratiche e i valori comunitari con l’ecosistema regionale; dall’altro, la gestione su base collettiva di certi beni è una caratteristica tipica delle popolazioni indigene. Naturalmente in quest’ambito abbiamo a c he fare con beni natura assai diversa tra loro. Gli aborigeni australiani si sono battuti a lungo per tutelare i luoghi sacri, l’eredità culturale e gli straordinari disegni artistici dall’appropriazione esterna, soprattutto dagli interessi commerciali. L’India e il Sudest asiatico ospitano molti “beni comuni culturali tradizionali” (o “TK commons”) che proteggono e dispensano diversi tipi di conoscenze specialistiche su piante locali e terapie mediche. Alcune multinazionali stanno tentando di mettere le mani su questo patrimonio di conoscenze per brevettarlo e poi usarlo per produrre alimenti e far maci mediante tecniche d’ingegneria genetica – una forma di enclosure nota come “biopirateria”. In tal senso, si è parlato parecchio dei ripetuti tentativi industriali di brevettare i semi di neem e di curcuma indiani, mentre la ricca biodiversità del Madagascar è stata presa di mira da aziende in cerca di conoscenze genetiche brevettabili. Si tratta di un tipo di c ommercializzazione che minaccia seriamente i TK c ommons, perché il timor e di v eder privatizzare e vendere le proprie conoscenze può scoraggiare la par tecipazione diretta dei locali. «Il dono di un uomo non de ve diventare il capitale di un altro», ammoniva al riguardo l’antropologo Marcel Mauss. Le enclosure dei TK commons imposte dalle grandi corporation ha suscitato una serie di risposte innovative. In India, le comunità locali hanno compilato una v era e pr opria biblioteca digitale delle c onoscenze tradizionali, cioè un database di pubblico dominio contenente informazioni mediche, per impedire l’accoglimento delle richieste di 141 brevetti miranti a privatizzare quelle conoscenze. Un gruppo di avvocati sudafricani, chiamato Natural Justice, ha messo a punt o un formulario giuridico noto come “protocolli bioculturali comunitari”, che si pone come uno strumento innovativo per proteggere le pratiche e le tradizioni culturali dalle appropriazioni esterne. Questi protocolli indicano i valor i specifici e le pr atiche consuetudinarie che una comunità ha scelto per gestire le proprie risorse naturali, affermando il diritto procedurale e sostanziale dei suoi membr i di par tecipare ai processi decisionali e r ichiedere il consenso informato, libero e preventivo sulle politiche pubbliche che potrebbero esser loro imposti. I protocolli specificano inoltre che la popolazione locale può monit orare e valutare l’impatto dei progetti che la riguardano. Non è facile generalizzare le esperienze dei beni comuni tra popolazioni indigene con tanti tipi di versi di patrimoni naturali, cosmogonie tribali e pratiche culturali. Eppure, la g iurista Rebecca Tsosie ha individuato sorprendenti somiglianze nei loro sistemi di conoscenza e d’interazione con il mondo naturale circostante, rivelandone la tendenza a rispecchiarne «la percezione della terra come essere animato; la credenza che gli esseri umani siano legati da un sist ema di affinità agli altri esseri viventi; la percezione del suolo come elemento essenziale per l’identità della popolazione; il c oncetto di r eciprocità ed equilibrio che si estende ai rapporti tra esseri umani, comprese le generazioni future, e a quelli tra esseri umani e mondo naturale». I popoli indigeni hanno sviluppato modelli socioecologici straordinariamente stabili proprio perché incentrati su rapporti sociali durevoli anziché su irregolari transazioni di mercato. Gli occidentali spesso tengono in scarsa considerazione i beni comuni dei popoli indigeni perché non si basano su un esasperato individualismo, sul diritto di proprietà privata e sulla no zione di “valore” dettata dal mercato (ossia sull’idea che ogni cosa debba avere un prezzo). Citando N. Bruce Duthu, un insigne studioso del dir itto tra i nativi americani: «L’idea di ‘proprietà’ nella t radizione occidentale… tende a por re l’accento sull’utilizzo commerciale delle risorse senza tener conto delle conse- guenze ecologiche o dei sig nificati sociali che la natura riveste per la popolazione. Il sistema dei prezzi presuppone la sostanziale equi valenza degli elementi naturali che hanno uno stesso prezzo. Le società che hanno un rapporto più diretto, di sussistenza, con la natura possono quindi considerare incomprensibili e perfino offensive le valutazioni basate sull’economia di mercato e sull’idea stessa di proprietà». Non sorprende quindi c he le nazioni del mondo indust rializzato abbiano irriso la richiesta presentata alle Nazioni Uniti da parte della Bolivia di “riconoscere i diritti della natura”, un concetto alla base di tanti beni comuni dei popoli indigeni. Secondo i paesi industrializzati, il dovere di onorare la “Madre Terra” – come propugna in America Latina il movimento Pachamama – sarebbe una sciocchezza ridicola e improponibile. Eppure questo pregiudizio non fa che evidenziare l’allarmante miopia culturale dell’occidente, incapace perfino di c oncepire l’idea di bene comune. Beni comuni d’ambito sociale e civico 142 La naturale inclinazione alla c ooperazione degli esseri umani è una potente fonte d’innovazione che ha dato origine a una grande varietà di beni comuni a livello sociale e civico. Un esempio particolarmente significativo riguarda il mo vimento internazionale della c osiddetta “banca del tempo”. Il time banking è un sistema che consente alle persone di guadagnare “crediti di tempo” fornendo in loco determinati servizi, tra cui tagliare l’erba del prato, fare i baby-sitter, dare una mano nei lavori domestici o accompagnare qualcuno dal medico. I crediti di tempo così accumulati possono essere usati per acquistare altri servizi offerti dai membr i della st essa comunità. Spesso gestit o da chiese e organizzazioni non-pr ofit, il time banking ha dimostrato di essere di grande utilità per le persone anziane e indigenti, che hanno molto tempo ma dispongono di poc o denaro: convertendo il tempo libero in “valuta corrente” (crediti di t empo), costoro possono c osì 143 soddisfare dei bisogni elementari che altrimenti non potrebbero permettersi. È interessante rimarcare che per molti si tratta non tanto un surrogato del mercato, quanto piuttosto di un sistema tramite cui stabilire validi contatti interpersonali. I sistemi di donazione del sangue e degli organi sono un altro esempio significativo di beni comuni sociali. Benché a volte le parti del corpo umano e il plasma sanguigno vengano considerati al pari dei beni di consumo, le donazioni v olontarie persistono perché in fondo r imaniamo legati all’idea c he la cessione di sostanze corporee (tessuti, organi, sangue, arti) vada considerato un dono sociale. Le banche del sangue sono state viste spesso come una forma di “economia del dono”, in cui si dà qualcosa che ci appartiene senza aspettarsi di ricevere in cambio un beneficio personale, ma per il semplic e senso di r esponsabilità sociale o come atto d’amore nei confronti degli altri. Alcuni autorevoli studi mostrano come, nel caso del sangue e deg li organi, le economie del dono riescono più facilmente a evitare i conflitti etici che possono insorgere nel mercato, ottenendo così sangue e organi di migliore qualità. Spesso, infatti, sono coloro che fanno uso di alcol o droghe e che non godono di buona salut e, i più inclini a v endere il proprio sangue oppure gli organi. Come già illustrato nel capitolo 5, le discipline ac cademiche sono un bene comune importante e altamente produttivo. In genere i r icercatori non scambiano il saper e tramite il contante o i contratti legali, perché le università s’incaricano di ospitare le infrastrutture dedicate all’economia del dono. La ricerca e l’istruzione sono considerate dei “contributi” a uno specifico campo di studi, non dei “prodotti”. Le discipline accademiche progrediscono grazie all’etica comunitaria basata sulla condivisione, al dibattito aperto e alla peer r eview – non certo per via della compravendita di conoscenze tra singoli individui. Dal momento che alimentano la fiducia e il sostegno reciproci, i beni comuni sociali c ontribuiscono a e vitare i pr oblemi etici t endenzialmente associati al mercato, il quale non promuove alti principi etici perché incentrato su transazioni commerciali anziché su rapporti durevoli e mirato al passaggio di denaro e a r apporti impersonali, a termine (o unici) e basati su scambi di valore rigorosamente “alla pari”. I confini che separano gli individui e i loro rispettivi interessi devono essere sempre precisi. Tuttavia, come ha osservato lo studioso e scr ittore Lewis Hyde nell’ormai classico The Gift (1983)14, nelle economie del dono i c onfini sociali risultano poco definiti, se non pr oprio cancellati, proprio per via dello scambio dei doni. Non si fanno calc oli interessati, non ci si assicura che il valore di quello che si dà sia esattamente equivalente a quello di ciò che si riceve: il punto è stabilire rapporti interpersonali e simpatie durevoli. Il sottotitolo del libro di Hyde (Immaginazione e vita erotica della proprietà) coglie bene quest’idea: il dono avvicina le persone, soprattutto quando lo scambio è indir etto e pr otratto nel tempo. Finché i doni seguiteranno a circolare, senza la precisa definizione di quanto si è “in debito”, i beni c omuni sociali non pot ranno scomparire. Essi continuano anzi a pr oliferare, soprattutto su internet, perché spesso r iducono drasticamente i c osti di mer cato della transazione: è quanto avviene, per esempio, nel campo della pubblicità, dei contratti legali, della ricerca di personale retribuito e così via. Spesso è meno caro, più facile e più sicuro coordinare l’attività attraverso una comunità fiduciaria. È anche per questo che oggi il “consumo collaborativo” va imponendosi come nuovo settore ibrido dell’economia di mercato: grazie a piattaforme web innovative, è possibile coordinare lo “sharing” (basato sul contante) di passaggi in auto, biciclette e utensili. Una delle economie del dono più sig nificative nell’ambito online è CouchSurfing, un sistema gratuito e informale di scambio d’ospitalità usato generalmente da chi viaggia (e da chi gli dà ospitalità), la cui comunità globale oggi conta circa 10 milioni di persone sparse in olt re 200.000 città, e dove lo scambio di c ontante tra ospite e v isitatore è 14 144 Edizione italiana: Il dono. Immaginazione e vita erotica della proprietà, Bollati Boringhieri, 2005. 145 esplicitamente proibito. CouchSurfing è una grande economia del dono mediata dal web, tramite cui ogni anno più cinque milioni di persone offrono e trovano ospitalità, dando spesso vita ad amicizie durature. Risulta evidente che i beni comuni sociali sono spontanei e variegati come la vita stessa e comprendono orti collettivi e festival cittadini, associazioni civiche e leghe sportive dilettantistiche, oltre a esperienze di ecovillaggi, co-housing eagricoltura comunitaria. La città è un t erreno particolarmente fertile per questo tipo di situazioni, grazie alla diversità e alla densità della popolazione – ambito in cui San Francisco è emersa come una città leader. Quando, nell’autunno del 2011, la nota t estata online Shareable diffuse un documento che delineava le“politiche operative per una città c ondivisibile”, il sindaco Ed Lee nominò immediatamente un apposito gruppo di lavoro incaricato di esplorare procedure tese a incoraggiare simili pratiche, portando a proposte concrete quali la condivisione di risorse tra i cittadini (passaggi o percorsi condivisi in auto), la cooproduzione sostenuta dall’amministrazione (agricoltura urbana), il mutuo soccorso tra i cittadini (cura degli anziani). Altri esempi riguardano proprio l’Italia, a par tire da Napoli, il cui sindaco Luigi de Magistris è stato il primo a creare fin dal 2011 un Assessorato dei beni comuni, con l’incarico di tutelare e valorizzare quei beni di appartenenza collettiva e sociale che sono garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini, oltre ad averchiamato a raccolta i funzionari municipali di altre città italiane per trovare il modo di potenziare il sostegno delle autorità ai beni comuni locali. Intanto a Roma, gli ex dipendenti di un importante teatro pubblico in origine destinato a ospitare la lirica, il Teatro Valle, nel 2011 hanno occupato la struttura stessa, inattiva a causa del mancato sostegno finanziario dell’amministrazione municipale, gestendola come un bene c omune autogestito. La protesta è nata nell’ambit o di un più vast o malcontento suscitato dall’incapacità del governo di provvedere al mantenimento degli spazi civici e ricreativi nonostante la privatizzazione di preziose proprietà pubbliche che aveva provocato un dr astico aumento degli affitti e un’ondata di sfr atti. L’occupazione del Teatro Valle – poi c onclusasi nell’agosto 2014 con l’elaborazione di nuove proposte di gestione dei teatri pubblici ma più in gener ale su come ripensare dal basso nuovi modelli di politiche culturali – ha spinto altri gruppi e semplici cittadini a organizzare analoghe azioni protesta basate sull’azione diretta, che hanno portato all’occupazione di vari spazi ed edifici pubblici. I romani in difficoltà si sono cioè r esi conto che, invece di limitarsi a lottare contro le privatizzazioni, era necessario organizzare forme di governance autogestite, propositive e indipendenti dall’amministrazione locale. Le aree urbane hanno visto nascere anche iniziative più ambiziose a favore della promozione dei beni comuni sociali. Dalla fine del 2010, gli urbanisti Nikos Salingaros e Federico Mena-Quintero stanno cercando, insieme ad altre persone interessate, di applicare i principi della produzione peer-to-peer alla pianificazione ur bana: il movimento del “P2P Urbanism”, com’è stato definito, punta a r endere più accoglienti per i comuni cittadini il contesto urbano e, in generale, la vita quotidiana metropolitana. Contrariamente al monumentalismo disumanizzante inflitto a molt e città dalle “star dell’architettura”, il P2P Urbanism propone un design collaborativo e la partecipazione diretta dei cittadini alla pianificazione ur bana, ispirandosi alla sapient e teoria dei modelli messa a punt o dal teorico e architetto Christopher Alexander. Questo progetto mira inoltre a r endere la pianificazione urbana più adattabile alle c ondizioni locali e ai bisog ni individuali, sull’esempio del softwar e open sour ce e della pr oduzione peer-topeer. Attività economiche integrate nei beni comuni 146 Alcuni commoner ritengono che in linea di principio l’economia monetaria sia fondamentalmente incompatibile con gli ideali della con- 147 divisione. Altri invece sono più disposti a stabilire rapporti pragmatici col mercato nella misura in cui non compromettono il bene comune in quanto tale. È veramente possibile una coesistenza di questo tipo? Per molti rimane una questione controversa. Da parte mia, credo siano ben pochi i beni comuni capaci di operare isolandosi completamente dal resto della società, poiché sono praticamente tutti deg li ibridi che in un modo o nell’alt ro dipendono dallo Stato o dal mer cato. Punto essenziale è per ciò assicurarne la massima autonomia e integrità: considerando che non possono non interagire con il mercato, i beni c omuni devono però saper r esistere alle enclosure, al consumismo, all’avidità di accumulazione e ad alt re patologie tipiche del capitalismo. Trovare un accordo sostenibile tra i beni collettivi e il mercato non è certo un’impresa di poco conto. Intanto torna utile rendersi conto che il mercato non s’identifica necessariamente col capitalismo, bensì può essere interamente locale, equo e reattivo nei confronti dei bisogni della comunità, se vi è ben inser ito e ispira fiducia ai suoi membri. Tuttavia, nella vita contemporanea il commercio è quasi sempr e integrato ai grandi mercati nazionali e internazionali e, in quanto tale, è governato dal «diritto divino del capitale», per riprendere un’espressione di M arjorie Kelly, il cui libr o Owning the futur e (2012) esplora gli esperimenti in corso con nuove forme di “proprietà generative”. I mercati dominati dal capitale tendono a produrre enormi disparità strutturali di potere che privano dei loro diritti i consumatori, i lavoratori e le c omunità, depredando la natur a senza cur arsi delle conseguenze a lungo termine. La buona notizia è c he per molte comunità sta diventando sempre più facile esercitare un maggiore controllo sulla struttura e sull’andamento del mercato stesso. Per esempio, negli Stati Uniti in particolare vanno moltiplicandosi le realtà agricole sostenute dalla comunità, i cui animatori sono profondamente inseriti nell’ambito in cui oper ano. Questi rapporti sociali e l’affidabilità locale del mer cato permettono alla comunità di soddisfare gran parte dei suoi bisogni sfuggen- 148 do all’etica rapace del capitalismo g lobale. I mercati non devono necessariamente essere predatori e socialment e nocivi, bensì possono integrarsi nel contesto sociale e diventare localmente reattivi. Altri casi significativi in quest ’ambito, le c ooperative, il mo vimento Slow Food e il mutual business (di cui sono pr oprietari gli stessi membriconsumatori), tutte situazioni che tentano, ciascuna a modo proprio, di integrare valori sociali più vasti all’interno delle tipiche attività imprenditoriali. Una delle imprese commerciali più riuscite basate sui beni comuni in cui mi sono imbattut o è Cecosesola, la cooperativa centrale per i servizi sociali di Lara, regione del Venezuela settentrionale. Per più di quarant’anni questo progetto autorganizzato e autofinanziato ha gestito ottanta cooperative – banche, aziende agricole, fabbriche – oltre a diverse associazioni e organizzazioni ci viche. Cecosesola evita deliberatamente i rapporti gerarchici e subordinati distribuendo i compiti amministrativi e la pr oduzione tra i suoi 1.200 soci la voratori. Le decisioni vengono assunte nel corso di assemblee in cui si r icerca il consenso dei partecipanti, un processo che richiede una buona dose di educazione reciproca, comunicazione e dialogo. Nei cinque mercati alimentari locali di Cecosesola i prezzi non si basano sulla domanda bensì sulla “imparzialità”: tutte le verdure, per esempio, vengono vendute allo stesso prezzo al chilo. L’inatteso successo di questa cooperativa è legat o alla c onquista della fiducia r eciproca, al sost egno convinto del bene comune e al fatto di aver avuto il coraggio di assumersi dei r ischi – il tutt o all’interno di una st ruttura organizzativa flessibile, in continua evoluzione. A mio parere, il segreto dell’unione tra beni comuni e mercato risiede nello sviluppo di una cultur a specifica della c ondivisione e nel tracciare dei “confini difendibili” intorno ai beni c omuni stessi, in modo da conservare la propria autonomia sostanziale. Nel Medioevo i commoner usavano “battere i limiti” – ossia cammina vano lungo il perimetro del bosco o del terreno comunale – nel corso delle feste annuali, sfruttando l’occasione per controllarne attentamente i confini. 149 E quando s’imbattevano in una palizzata o in una bar riera eretta da un privato per recintare una parte del terreno comune, la abbattevano per ristabilire così l’integrità del terreno. È essenziale quindi che la comunità sappia far rispettare i “perimetri” del bene comune. Oggi il nostro compito consiste nell’ideare un equivalente moderno della pratica di “battere i limiti”. Per quanto riguarda l’ambito online, due esempi di successo già descritti sono la General Public License per il software e le lic enze Creative Commons: entrambi assicurano il controllo sui frutti delle fatiche condivise, proibendo ai privati di appropriarsi del codice informatico e dei contenuti digitali. I protocolli bioculturali stilati dal g ruppo di avvocati sudafricani Natural Justice si propongono uno scopo analogo – impedir e alle multinazionali di appropriarsi delle conoscenze etnobotaniche e delle pratiche agroecologiche delle popolazioni indigene. Gli odierni commoner “battono i limiti” quando escogitano regole e norme etiche volte a preservare i loro beni comuni. Le elaborate norme di revisione di Wikipedia, le pratiche che i pescatori di aragoste del Maine hanno negoziato nell’ambito della loro comunità, le consuetudini sulla gestione delle acequiasin New Mexico, si prefiggono tutte lo scopo di pr eservare risorse e c omunità, escludendo g li estranei che non hanno investito energie nello sv iluppo del bene c omune o c he possono manifestarsi come vandali o scrocconi. Dotandosi di apposit e norme e sist emi di go vernance, i soggetti coinvolti ottengono anche un altro risultato: spingere i mercati a essere più r eattivi nei c onfronti dei c onsumatori che vi fanno affidamento. Potremmo chiamarli “mercati basati sui beni c omuni” – comunità coerenti, abbastanza forti da influenzare e da addomesticar e questi mercati; situazioni queste alquanto diffuse online, dove le comunità sociali (o le r eti informali) riescono ad autorganizzarsi come gruppi di affinità prima di rivolgersi al mercato per soddisfare determinate esigenze. Nel libro Democratizing Innovation (2006), il docente del Mit Eric von Hippel descrive numerose comunità di appassionati di “sport 150 estremi” – ciclisti, surfer, arrampicatori e così via – come fonti d’idee pioneristiche che le imprese possono sviluppare e commercializzare. Ovviamente qualcuno pot rebbe chiedersi perché mai ci sia bisog no dell’imprenditoria in quest’ambito, dato che le stesse comunità sono in grado di produrre ciò di cui hanno bisogno in maniera autonoma, diretta, a basso costo e forse anche più reattiva. È una giusta osservazione ma attualmente le comunità rivelano una limitata capacità di far fronte ai necessari, e spesso complicati, impegni a livello commerciale (raccolta del capitale, gestione di c omplesse catene di distribuzione, ecc.) – pur se è vero che le cose potrebbero cambiare nel prossimo futuro. In realtà tra gli stessi propugnatori dei beni c omuni è in c orso un ampio dibattito sul modo migliore per proteggerli efficacemente dallo sfruttamento capitalista. Come strutturare il bene comune in modo da disconnetterne la logica da quella del mercato, evitando al contempo d’inficiarne la capacità di int eragire efficacemente con il mercato stesso? Secondo la mia collega Silke Helfrich, la soluzione è assicurarsi che i beni comuni siano in grado di proteggersi e di riprodursi, sfruttando cioè la capacità st rutturale di garantirsi longevità e autotutela, e proteggendo le risorse e le norme comunitarie. Un obiettivo che può essere raggiunto attraverso norme giuridiche che impediscano l’appropriazione da parte di soggetti esterni o le loro interferenze, mediante consuetudini e pratiche sociali che costituiscono la go vernance del bene c omune, con l’isolamento geografico dai mercati o grazie a barriere tecnologiche (recintando la risorsa o imponendo restrizioni digitali per chi non è autorizzato). Senza queste misure di protezione, i beni c omuni sono esposti all’appr opriazione capitalistica, un problema che va emergendo con progetti quali Google Books, Facebook e alt re piattaforme aperte. In queste situazioni, la condivisione diventa utilizzabile in quanto “dato di mercato” che può essere estratto dalla comunità e privatizzato. È importante quindi che i beni comuni sviluppino i mezzi atti a proteggere i frutti del loro stesso lavoro, mirando riprodurre se stessi e altri beni comuni. Citando ancora Helfrich, abbiamo bisogno di «passare dalla produzione paritaria su base c omunitaria alla creazione di beni comuni … [perché] il senso dei beni comuni non sta nella forma organizzativa o nei diritti di proprietà, bensì nel lor o scopo: se la pr atica del commoning finisce con una vendita sul mercato, che ne sarà di tutte le persone interessate al processo di produzione su base c omunitaria?». I sistemi “aperti” non offrono alcuna garanzia sul rispetto o sulla tut ela degli interessi sociali o ecologici a lungo termine di chi vi contribuisce. Beni comuni sotto tutela statale e beni comuni globali 151 Molte delle nostre risorse condivise sono talmente ampie da richiedere l’appropriata attenzione delle istituzioni pubblic he. Le “commonpool resources” includono, per esempio, parchi nazionali, centri di ricerca finanziati dal governo, vasti territori demaniali, l’etere e l’atmosfera. (Si tenga bene a mente, come già illustrato, che bene comune = risorsa + comunità + norme e usanze necessarie alla sua gestione). È impossibile gestire queste risorse collettive di ampie proporzioni con le stesse modalità applicate, per esempio, in un piccolo borgo. Si rende necessaria un’ampia serie di protocolli istituzionali e normative legali – una “infrastruttura dei beni comuni”. Il bene comune sotto tutela statale non è solo un altro modo per definire la gestione statale delle r isorse, si tratta piuttosto di enfatizzare il ruolo di primo piano svolto dallo Stato nel facilitare la condivisione da par te dei cittadini. Anziché considerare le istituzioni c ome le entità che “si limitano a prendersi cura delle cose”, dovremmo pensare che la burocrazia statale può far spazio a un r uolo un più ampio e vigoroso del cittadino nell’elaborazione e nell’applicazione delle politiche pubbliche. Credo sia davvero importante comprendere bene il ruolo dello Stato, il quale de ve agire come fiduciario a nome dei dir etti interessati, 152 mantenendo e pr oteggendo coscienziosamente i beni c ondivisi dai tentativi di pr ivatizzazione, e deve garantirne l’accessibilità a chiunque su basi eque e non discr iminatorie, consentendo altresì ai membri della comunità la facoltà e lo spazio per dar v ita all’effettiva condivisione. Ho deciso di definire questi programmi come beni comuni sotto tutela statale per sottolineare che le risorse in questione appartengono comunque al popolo e non allo Stato. In quanto fiduciario, quest’ultimo ha l’obbligo affermativo di assicurare la massima trasparenza possibile, la partecipazione e la gestione al più basso livello amministrativo (“sussidiarietà”). Queste situazioni possono assumere molte forme diverse, dalla supervisione dei canoni di locazione dei beni gestiti dal go verno all’autorizzazione dei beni comuni ad agire come autorità delegate, dal ricorso a strumenti digitali come i social network per stimolare la partecipazione dei cittadini all’azione dir etta del go verno. Ecco alcuni esempi. Negli Stati Uniti, il governo federale dà in locazione i dir itti di pascolo sui terreni pubblici agli allevatori di bestiame (a prezzi stracciati). Vende i diritti di estrazione mineraria di oro, argento e di altri minerali metallici dal suolo pubblic o a circa dieci dollari l’ettaro senza richiedere royalties, e mette all’asta una parte dello spettro elettromagnetico per le t rasmissioni radio-tv (recuperando solo una par te del loro valore). Nel caso di un bene comune sotto tutela statale, il problema è come assicurarsi che il governo agisca come custode coscienzioso e agente fiscalmente responsabile dei canoni di locazione – un ’idea che deve modellare la struttura legale, l’azione e i meccanismi di responsabilità degli enti amministrativi fiduciari. In questo senso una soluzione ingeg nosa è quella dello stakeholder trust, di cui un esempio classic o è l’Alaska Permanent Fund, un fondo fiduciario indipendente istituito dalle norme statali per riscuotere una parte delle royalties derivanti dall’estrazione del petrolio dai terreni demaniali e dist ribuire ai cittadini di videndi che si aggirano in- 153 torno al migliaio di dollari l’anno per famiglia. Trattandosi di un ente indipendente dal governo e autorizzato ad agire come fondo fiduciario per conto di specifici beneficiari (i cittadini dell’Alaska), si garantisce che una piccola parte dei proventi petroliferi siano impiegati a diretto vantaggio dei contribuenti, fornendo loro una gradita fonte di reddito aggiuntivo. Come spiega un libr o del 2012 ( Exporting the Alaska Model di Karl Widerquist e Michael Howard), questo modello potrebbe essere adattato alla gestione di molti alt ri tipi di risorse naturali, sia negli Stati Uniti che in altri paesi. Per esempio, in Vermont gli attivisti hanno proposto la creazione di un apposito asset trust capace di agire come ente fiduciario e custode della fauna selvatica terrestre e ittica, delle foreste, delle falde acquifere, dei minerali e di altre risorse naturali. Grazie alle innovazioni generate dai social netw ork, oggi è possibile pensare che lo Stato ricorrerà a queste piattaforme online per conferire un ruolo di maggior rilievo ai cittadini, i quali possono fare ben più che “partecipare” a un’agenda governativa preordinata (manipolata?), dando così seguito alle idee che hanno concepito e assumendosi delle responsabilità precise. In precedenza ho menzionato alcuni “beni comuni ecodigitali” che invitano i cittadini a c ontribuire alla raccolta di dati ambientali oppure ad aiutare la Nasa nella classificazione dei cr ateri su Marte. Un altro esempio significativo è quello del pr ogetto pilota Peer to Patent avviato in Usa dall’Ufficio brevetti e marchi, che invita chiunque voglia a sottoporre applicazioni già esistenti riguardo alle invenzioni in attesa di br evetto. Aiutando l’Ufficio a identificar e le inno vazioni preesistenti che potrebbero invalidare una r ichiesta di br evetto e quindi il diritto esclusivo di sfruttamento dell’invenzione da parte del richiedente, si contribuisce così a migliorare la qualità stessa dei brevetti. Questa pratica basata sul cr owdsourcingaiuta le autorità a prevenire il rilascio di ingiustificati monopoli sui brevetti che potrebbero ostacolare le future innovazioni. Quando dispongono di un sost egno attivo, i cittadini competenti o interessati a una certa materia possono diventare sostenitori attivi, svolgendo una funzione di controllo, 154 oltre a dare man forte alle invenzioni personali e spinger e le agenzie governative ad adempiere meglio alle loro funzioni. La nuova frontiera dei beni c omuni sotto tutela statale risiede nell’ideazione di forme istituzionali e principi giuridici capaci di migliorare la governance delle risorse collettive di ambito regionale o globale. È evidente che gli Stati-nazione e i t rattati internazionali esistenti non sapranno imporre dei limiti alle emissioni di carbonio, per esempio, né impediranno la distruzione delle zone ittiche e delle bar riere coralline o la perdita della biodiversità, tutte questioni che trascendono le giurisdizioni politiche. Trascurati per decenni, questi problemi non hanno fatt o che aggravarsi: il mer cato-Stato non è in g rado di porre limitazioni sig nificative all’attività commerciale che continua ad esacerbarli. Nel libro Green Governance (2013), io e il collega Burns Weston abbiamo cercato di immaginare nuovi tipi di st rutture politiche, minimaliste e flessibili, che potrebbero incoraggiare il lavoro delle comunità intenzionali a tutti i livelli – locale, regionale, nazionale, transnazionale e globale. Ciò va ben oltre questi esempi di tut ela statale, per esplorare modalità del tutto nuove per garantire il sostegno istituzionale ai beni c omuni, allo scopo di scatenarne le energ ie autorinforzanti per una for ma impagabile di go vernance, senza soffocarle t ramite la microgestione gerarchica o l’interferenza politica. La sfida sta nell’applicare procedure amministrative di basso li vello – un pr incipio noto come “sussidiarietà” – e con molteplici centri di autorità. Così diversificati, i livelli dei beni comuni arriverebbero a “intersecarsi” con i più alti li velli di governance, secondo l’idea di “policentricità” esplorata da Elinor Ostrom nelle sue opere. Benché queste idee siano ir rise dagli scettici che le ritengono troppo astratte e forzat e per affr ontare adeguatamente i pr oblemi ambientali globali, è certamente più irrealistico pensare che le istituzioni centralizzate, con competenze limitate e considerate sempre meno affidabili, saranno capaci di costringere i cittadini ad adottare quei cambiamenti che in r ealtà non piac ciono neppure al mer cato-Stato. Al 155 contrario, tutte queste esperienze collettive hanno dimostrato di saper indurre l’assunzione delle responsabilità in prima persona, hanno imposto dei limiti all’attività commerciale, esprimono una nuova visione dello sviluppo umano e alimentano l’etica della sufficienza. Qualunque sia la st ruttura prescelta dai beni c omuni globali (e qui t occhiamo appena una discussione t roppo lunga da affrontare in questa sede), i nuovi sistemi mediati dallo Stato dovranno aprire spazi inediti per consentire la piena governance – almeno, questa è la visione che proponiamo in quel libro. In realtà i beni comuni globali si discostano dalla nozione classica di bene comune, direi anzi che ne sono l’estensione logica. Nello spirito sono certamente legati alla c oncezione tipica, eppure esprimono un “immaginario politico” di tipo nuovo per quanto riguarda la preservazione dei doni ec ologici condivisi. Per lo Stato, il pr imo passo da compiere lungo questo percorso sta nel riconoscere i beni comuni come un settore quasi indipendente, a sé stante – poiché possiedono capacità di provisioning e una legittimità sociale impossibili da raggiungere per le burocrazie statali. Naturalmente queste idee r ichiedono un’audace riconcettualizzazione del mercato-Stato di stampo neoliberista. Il mio collega Michel Bauwens ha pr oposto di r iconsiderarli come membri di una “triarchia” in cui il potere di governance viene condiviso con i beni comuni stessi: mercato-Stato-beni comuni. Lo scopo è riallineare autorità e provisioning all’interno di c onfigurazioni nuove e socialment e più vantaggiose. Le istituzioni devono spostare il loro baricentro per diventare invece uno «Stato partner», riprendendo l’espressione da lui usata, e qualcosa di più di un par tner ammanicato con il Mercato. Come membro di questa “triarchia”, lo Stato continuerebbe a svolgere un ruolo importante nella gestione delle risorse non facilmente suddivisibili (l’atmosfera, zone ittiche oceaniche, il genoma umano) e di quelle che possono generare grandi quantità di denaro su base regionale (estrazione petrolifera, minerali). E dovrebbe prendersi cura con maggior coscienziosità ed efficacia di terreni pubblici, parchi naziona- 156 li, aree naturali, attività di ricerca finanziate con fondi pubblici e infrastrutture civili. Occorre strutturare le agenzie governative – da tempo abituate a distribuire gratuitamente beni e infrastrutture sovvenzionate alle voraci corporation – in modo che possano agire come amministratori fiduciari coscienziosi e trasparenti degli assetti collettivi. I puristi obietteranno che i sistemi gestionali pubblici non possono essere considerati dei beni comuni veri e propri, ma va ricordato che persino ambiti collettivi come il software open source o la ricerca accademica dipendono dal governo e dal mercato pur se in modo indiretto. Sono stati i finanziamenti pubblici a por tarci internet e tuttora supportano larga parte della ricerca accademica, come sono ancora le grandi imprese commerciali ad acquistare la maggioranza dei personal computer, e così via. La questione non è se il mercato e lo Stat o svolgono o meno un qualc he ruolo nel c ontesto dei beni c omuni, bensì piuttosto in quale misura e a quali condizioni. La sfida più importante è assicurare la maggiore integrità possibile dei beni comuni, in modo che i frutti della condivisione non diventino oggetto di appropriazione da parte di istituzioni o imprese furbi e avidi. Al momento, l’idea di un settore dei beni comuni riconosciuto dallo Stato può sembrare un miraggio politico. Dopotutto, le istituzioni appaiono quasi sempre indifferenti oppure ostili nei c onfronti delle iniziative collettive che non siano Società per Azioni. I commoner devono perciò impegnarsi nella creazione di collettivi autogestiti e quasi autonomi – dai wiki alle associazioni per la c ondivisione di semi o per la difesa dell’acqua – capaci di costruire e proteggere le loro stesse risorse e c hiedere insistentemente il r iconoscimento e il r ispetto dello Stato. Il nascente settore dei beni comuni prevede altresì nuove federazioni che sappiano mobilitare politicamente i cittadini, grazie a innovazioni legali in grado di conferire ai beni comuni un vero riconoscimento giuridico. Fin quando non a vremo raggiunto questi obiettivi, l’impero del capitale seguiterà a imporre la sua logica soffocante a largo raggio. 157 Pur se questa breve rassegna delle principali categorie di beni comuni non rende giustizia alla grande varietà delle esperienze attive in tutto il mondo, spero abbia dato un’idea della portata e della complessità dei beni comuni odierni, così come di alcune delle loro profonde “somiglianze nella diversità”. In effetti, è proprio questa una delle car atteristiche più tenaci dei beni comuni – la loro capacità di stupire. I beni comuni come nuovo modo di pensare e di vivere 158 Secondo il biologo tedesco Andreas Weber, i beni comuni non riguardano solo la politica o l’ec onomia, ma sono una c ondizione esistenziale della v ita in tutt e le sue for me, dalle c ellule agli esseri umani: «L’idea dei beni collettivi costituisce un principio unificante che dissolve la presunta opposizione tra natura e società/cultura, cancellando la separ azione tra ambito ecologico e ambito sociale». Di conseguenza, i beni c omuni ci for niscono i mezzi nec essari per r ipensare l’universo e il nostro ruolo al suo interno. Una trasformazione reale dell’attuale sistema sociopolitico, osserva Weber, richiederebbe un’analisi dei suoi pr esupposti fondamentali, che spesso si tende a dare per scontati. In effetti, va rivista l’intera concezione della natura della realtà. Immersi come siamo nel paradigma politico neoliberal e nei pr incipi della t eoria darwiniana dell’evoluzione, siamo abituati a considerare la vita come una spietata lotta per la sopravvivenza e l’economia come una sorta di macchina composta da innumerevoli individui impegnati ad accumulare ricchezze personali a iosa. L’unica cosa che conta è arrivare al traguardo prima di tutti gli altri. Analogamente, l’universo ci appare come uno spazio newtoniano in cui forze astratte e potenti trascinano qua e là delle par ticelle inanimate. Un ordine cosmico in cui la c oscienza e l’appor to umano svolgono un ruolo insignificante o inesistente. I taciti presupposti metafisici della nostra visione della realtà costituiscono, sempre secondo Weber, la base delle st rutture politiche ed economiche del “libero mercato”. La cosa più interessante è che molti 159 studiosi stanno iniziando a considerare i fenomeni naturali e l’evoluzione umana attraverso un prisma metafisico diverso, dove la vita è il risultato dell’azione cooperativa di una molteplicità di agenti che mirano a costruire rapporti significativi e a scambiarsi dei “doni”. Ovviamente la competizione rimane al suo posto, ma accanto a forme di collaborazione profonda e stabilizzante. In questo nuovo quadro teorico, le esperienze soggettive di un organismo contano in quanto tali e tutti gli organismi sono considerati sistemi viventi produttori di significato. La vita viene considerata un processo evolutivo i cui soggetti int eragiscono con l’ambiente e con gli altri organismi viventi per creare rapporti intrisi di significato. La soggettività non è un ’illusione o un dettag lio secondario, come proclama la metafisica dominante, né è una fragile bolla di sentimenti effimeri e triviali all’interno di un universo vuoto. Al contrario, la soggettività è la pietra miliare di una nuova «biologia esistenziale» che si occupa in primo luogo dei soggetti, non solo deg li oggetti. Gli esseri umani non sono atomi isolati alla deriva in un vasto universo indifferente, né la soggetti vità umana è separ ata da una natur a che si presenta come un “soggetto altro” alieno e insondabile. Soggettivo e oggettivo, individuale e collettivo si fondono tra loro – proprio come nei beni comuni! Weber, parlando da scienziato, fonda su dati c oncreti quest’ipotesi, nota come “biopoetica”: una metafisica e al c ontempo una t eoria scientifica in grado di spiegare «il profondo rapporto tra esperienza vissuta e principi biologici». A suo parere, la «scienza della v ita» tradizionale non rappresenta più una metodologia adeguata per la comprensione della realtà vivente, poiché ignora la realtà della coscienza e della soggettività negli organismi v iventi – elementi pr aticamente banditi da questo campo di studi. Tuttavia, prosegue Weber, «per trovare risposte ai grandi enigmi della vita è necessario iniziare a considerare gli organismi come sistemi senzienti in grado di provare sentimenti ed emozioni e di interpretare l’ambiente che li circonda, anziché limitarsi a obbedir e supinamente agli stimoli c he ricevono». La 160 biopoetica possiede a suo avviso la capacità di fornire «una nuova descrizione olistica della biolog ia come interazione di soggetti pr oduttori e fornitori di significato, e quindi capace di gettare le basi necessarie a una migliore comprensione della cosmogonia significante dell’immaginazione umana». I beni comuni svolgono un ruolo fondamentale in questa nuova visione, perché è solo grazie a essi che potremo riconciliarci con la natura e con i nostri simili. La sfida che abbiamo di fronte sta nella messa a punto di un par adigma di tipo n uovo, una sorta di rinascita del pensiero che sostituisca l’Illuminismo, ormai tricentenario, con una visione dell’universo che tenga conto delle identità soggettive e del bisogno di sig nificato, trattandoli alla st regua di nec essità biologiche. Per riuscirci, dobbiamo coinvolgerci «nei rituali e nelle peculiarità che accompagnano le attività di mediazione, cooperazione, sanzione, negoziazione e accordo, nelle difficoltà e nelle gioie dell’esperienza della realtà. È qui che la pratica dei beni comuni viene a coincidere con la pratica della vita stessa». Pur se le t eorie biologiche di Weber, così come i beni c omuni in quanto tali, sono ancora estranee alle concezioni tradizionali, personalmente ritengo che possano aiutarci a spiegare l’attrazione profonda, quasi viscerale, esercitata dal paradigma dei beni c omuni – confermandoci che non si tratta di una trovata accattivante o di una strategia di comunicazione, bensì di un pr isma che consente una visione nuova e più pr ofonda del mondo, come totalità e in tutta la sua diversità, sulla base di una c omprensione realistica dell’umanità e del suo modus operandi. L’analisi di Weber ci vede come soggetti consapevoli e attivi nel mondo, pur riconoscendo alla storia, alle circostanze locali, alla cultura e agli individui un ruolo determinante nel plasmare l’evoluzione dell’umanità e nel creare pratiche collettive. Per capire cosa sono e rappresentano veramente i beni comuni dobbiamo liberarci dalla mentalità fortemente riduzionista prodotta dall’economia e dalla cultura liberiste, per riconoscere invece che le istituzioni umane sono animate da una logica collaborativa e che, in pre- 161 senza di usanze e strutture sociali adeguate, questo tipo di etica umanistica funziona davvero. La cultura imperante ha ristretto insidiosamente il campo della nost ra immaginazione, mentre il linguagg io stesso – privilegiando gli interessi della proprietà privata, del capitale e dei mercati come priorità di governo – tende a neutralizzare l’idea che sia possibile lavorare insieme verso obiettivi comuni. In questo capitolo cercherò di mostrare l’incidenza profonda dei beni comuni sulla nostra concezione di “realtà”, invitandoci a ridefinire il nostro modo di pensar e. Queste esperienze cooperative contribuiscono a portare in primo piano percezioni e prospettive di tipo nuovo, suggerendo soluzioni innovative per i problemi più urgenti. Naturalmente, si può parlare di tali esperimenti anche in termini del tutto convenzionali, senza solle vare imbarazzanti questioni r iguardanti le strutture della conoscenza o le visioni del mondo dominanti. È quanto fanno in pratica gli economisti assimilando i beni comuni ai “beni pubblici”, trattandoli come cose e ignorandone le pratiche e i rapporti sociali che le animano. La Nato parla dello spazio e xtraterrestre e degli oceani come «beni comuni globali» – per indicare l’accumulo di risorse inanimate – senza capire che in realtà sta parlando di regimi di libero accesso, aperti a tutti, e non certo di pratiche legate ai beni collettivi. Prendere sul serio tali pratiche significa invece modificare in parte la nostra concezione del mondo. Le nostre scelte non devono necessariamente essere dettate solo dalla condizione di dipendenti, consumatori, imprenditori o investitori e dal desiderio di aumentare il più possibile il benesser e economico personale. Possiamo cominciare a pensare a noi stessi come custodi di un bene comune, a essere protagonisti della nostra vita, applicando il talent o, l’ambizione e il senso di responsabilità ai problemi della vita reale. Possiamo iniziare ad agire come portatori di interessi inalienabili nel mondo in cui siamo nati, affermando il diritto e la capacità degli esseri umani di partecipare alla gestione delle r isorse indispensabili alla sopravvivenza della specie. La metafisica dei beni comuni 162 Le questioni metafisic he ed epist emologiche sul t ema sono t roppo complesse per essere trattate in modo esaustivo in questo breve capitolo. E a dir e la v erità, tali questioni r imangono ancora avvolte in qualche modo nel mistero, almeno per chi non riesce a evadere dalla prigione della visione del mondo creata dalla scienza occidentale moderna. La cultura e il linguaggio odierni non ci offrono i mezzi di cui avremmo bisogno per comprendere appieno le r adici umanistiche e spirituali dei beni comuni. È comunque possibile intravedere dei modelli ben diversi tramite cui concepire, agire e vivere nel mondo. La proposta di una nuova metafisica dei beni c omuni – e di n uove categorie epistemologiche del sapere – pone una ser ie di dirompenti interrogativi sugli assunti fondamentali dell’ec onomia di mer cato e della democrazia rappresentativa. In quanto individui siamo v eramente capaci di comportarci razionalmente, autonomamente e in base a un consenso informato, nella sfera economica come in quella politica? Possiamo vivere in modo profondamente autonomo e autosufficiente, in un luogo impr ecisato al di fuor i della storia e delle peculiarità sociali, come sostiene implicitamente l’universalismo liberista? I beni comuni sfidano alcuni miti fondanti del neoliberismo, dell’economia di mercato e della modernità, come l’idea che l’innovazione tecnologica, la crescita economica e il consumismo miglioreranno indubbiamente la qualità delle nostre vite, a condizione di non lesinare gli sforzi e di essere disposti ad attendere il tempo necessario. Come si è visto, ogni comune attività economica genera sempre, accanto alla ricchezza, un’uguale quantità di danni c ollaterali, laddove i beni c omuni osano sfidare la logica mercantile che venera il prezzo come arbitro supremo del valore e il progresso materiale come fulcro di qualsiasi progresso. Come ha scritto lo studioso dei beni comuni James Quilligan, «nell’economia tradizionale, la nozione basata su “merci e ser vizi” comporta la riduzione dei rapporti sociali tra gli individui – e degli indi- 163 vidui stessi – a mer ci commerciabili e fungibili. Al contrario, un’economia basata sui beni comuni consente di esperire il valore attraverso le relazioni concrete che si stabiliscono tra gli individui, le risorse del mondo e lo spazio compr eso tra le persone e il mondo» (sottolineatura nell’originale). Parlare di beni comuni significa dunque riconoscere la coproduzione sociale come attività costruttiva e soddisfacente, ma anche mettere in questione l’ordine e i r apporti sociali innescati dal dir itto di proprietà privata. «I beni comuni richiedono partecipazione», rimarca lo storico Peter Linebaugh. «Sui prati montani dove pascolano i greggi, o sullo schermo luminoso dove scorrono i dati, la produzione di ricchezza – quella immateriale della conoscenza o quella materiale prodotta dal lavoro del braccio e della mente – richiede la volontà e la disponibilità a lavorare insieme, spalla a spalla. Per questo non si può parlare di diritti separatamente dai doveri e viceversa». La forza stessa dei beni comuni deriva dalle pratiche sociali concrete che li animano, le quali c onservano però un car attere fortemente specifico, locale e c ontestuale – c ome rivelano i met odi e le r egole complesse che governano lo sfr uttamento di una specifica for esta, l’accettazione o la revisione di una voce su Wikipedia, la conservazione e la gestione delle risorse idriche in New Mexico. Ciò spiega perché sia così difficile c onsiderare come beni di c onsumo i pr odotti derivanti da queste esperienze collettive senza portare alla loro distruzione: il valor e dei beni c omuni è pr ofondamente legato allo specific o contesto sociale ed è difficile c onvertirlo in denaro. La monetizzazione delle pratiche condivise rischia anzi di corrodere i rapporti sociali che le mantengono in vita. Come illustrato nel capitolo precedente, i popoli indigeni manifestano spesso att eggiamenti alquanto diversificati nei c onfronti della proprietà. I t entativi delle m ultinazionali di br evettare certe conoscenze tradizionali o materiali genetici sono considerati generalmente come comportamenti sciocchi e allo stesso tempo offensivi. Nessuno può vantare il “diritto di autore” sulle risorse collettive, come pre- 164 visto invece dalle leggi sul copyright e sui brevetti, perché il loro sviluppo ha richiesto le cure di molte generazioni e la t rasmissione nel tempo delle innovazioni introdotte. Nessuno può appropriarsi e cedere a scopo di lucro ciò che è stato dato in custodia per sempre a una comunità locale e c he ha acquisito così un carattere di sacralità. Appropriazioni queste che, non a caso, vengono definite «biopirateria». È importante notare che le c omunità indigene possono r ivelarsi permeabili come chiunque altro al fascino del denaro e del potere. Alcuni leader indigeni hanno c eduto certe conoscenze o r isorse tradizionali in cambio di un piatt o di lenticchie, o anche sottoscritto accordi con qualche industria farmaceutica occidentale per la “spartizione degli utili”, manovre che hanno rappresentato un tradimento o una seria minaccia per le loro stesse culture. Nel 1998 i San o Boscimani, gruppo etnico nomade attualmente localizzato nel deserto africano del Kalahari, hanno accettato di cedere i diritti sullo Hoodia gordonii, un cactus utilizzato tradizionalmente come sedativo dell’appetito, in cambio dell’ott o per cento dei profitti derivanti dalla vendita di un nuovo farmaco dimagrante. L’accordo è stato criticato come un caso di biopir ateria, iniettando in una cultur a tradizionale le regole dell’economia di mercato e ingenti somme di denar o, con effetti devastanti. Per i gruppi indigeni, i singoli indi vidui esistono in quanto tali all’interno di una rete ben più vasta: l’idea di qualcuno che “si è fatto da sé” è considerata un po’ ridicola, quando non addir ittura folle. Non stupisce quindi che anche il concetto di proprietà privata sia qualcosa d’insensato, dato che in questi casi la pr oprietà non sta a indicar e una cosa quanto piuttosto i rapporti sociali interpersonali. L’idea della proprietà come «dominio esclusivo e dispotico» su una risorsa, tipica del diritto occidentale, ignora l’ineluttabile dipendenza dalla natur a degli esseri umani e la loro interdipendenza reciproca. Per le popolazioni indigene le risorse e le conoscenze appartengano a una comunità solidale che le gestisce in modo collettivo. Le società industriali moderne presumono (erroneamente) che queste forme 165 d’intesa siano ormai superate e inutili e vadano sostituite dal mercato. «Monetizzare le risorse e distribuirne gli utili: cosa può esserci di più equo?». L’arrivo del cambiamento climatico, del picco nell’estrazione petrolifera e di innumerevoli altre crisi ambientali sta mostrando i limiti di queste concezioni e dei relativi presupposti ontologici riguardo al nostro posto nel mondo. Interessante notare inoltre che l’emergente universo dei beni comuni digitali sta mettendo a nudo le debolezze della «monocultura della conoscenza del XX secolo», per servirci delle parole dell’antropologa olandese Marianne Maeckelburg. La conoscenza prodotta dalle grandi istituzioni culturali centralizzate è troppo fragile, monocromatica e remota per la var ietà di esperienze vissute dalla gente reale. I sistemi di pensiero dominanti, soprattutto quelli delle burocrazie, dell’economia ufficiale e della ricerca scientifica, hanno delegittimato la cultura vernacolare – i modi di vivere e le conoscenze basate sulla pratica condivisa. Per superare le odierne sfide ecologiche e sociali dobbiamo imparare a v ederci come esseri umani dotati di un c orpo e inser iti in contesto specifico. La scomparsa di tanti linguagg i autoctoni rappresenta una g rave perdita nella ricerca di un accordo con il mondo extra-umano portata avanti dall’umanità. La maggior parte delle duecentocinquanta lingue parlate dagli aborigeni australiani sono ormai estinte, come pure quelle, circa un centinaio, delle popolazioni native della regione oggi chiamata California. E come rimarcano Daniel Nettle e Suzanne Romaine, che nel libro Vanishing Voices (2000) dettagliano i r isvolti di queste perdite irrimediabili per l’umanità: «L’estinzione delle lingue fa parte del collasso quasi totale dell’ecosistema mondiale». Le lingue native racchiudono in sé t esori di conoscenze specifiche, soprattutto riguardo ai sistemi ecologici. «Ogni lingua è una foresta secolare dello spirito», secondo una memor abile definizione dell’et nobotanico Wade Davis. La caratteristica portante dell’enclave comunitaria è in primo luogo il rispetto delle nuove e diverse forme di conoscenza prodotte dall’at- tività collettiva degli stessi commoner in quelle circostanze specifiche. Conoscenze che possono riguardare i comportamenti stagionali della fauna selvatica, le pratiche di una comunità di software open source o le tradizionali modalità di r etribuzione per le donazioni di sangue. Maeckelburgh ha studiato un vasto campione di attivisti e reti comunitarie per identificar e «i modi di c onoscenza alternativi» messi a punto dalle comunità autogestite. Si tratta, nota l’autrice, di una «conoscenza prodotta collettivamente, relativa a un particolare contesto, parziale e provvisoria», aggiungendo una distinzione «tra sapere qualcosa e saperne più degli altri». La lotta per l’autodeterminazione non può quindi fare a meno di quella c he l’antropologo Arturo Escobar definisce «una micropolitica per la produzione di sapere locale… costituita da varie pratiche di integrazione, riciclo e ricombinazione delle conoscenze e delle informazioni». L’esistenza di un c orpo fisso di c onoscenze canoniche, la cui aut orità non può esser e messa in dubbio , è accettata raramente dai commoner, i quali preferiscono creare un proprio sapere (situazionale) interagendo tra loro e con le risorse naturali. Perché mai dovremmo ritenere che un sistema di pensiero economico o burocratico, astratto e autoreferenziale, debba prevalere automaticamente su un insieme di saperi e di t radizioni locali, basati sull’esper ienza diretta, che quasi sempre si rivelano più affidabili, adeguati ed efficaci? I beni comuni come crogiuolo del localismo 166 La promessa di autodeterminazione a livello locale rappresenta in effetti una delle maggiori attrattive di queste pratiche centrate sui beni collettivi. Aumentano le persone che si avvicinano a questa idea perché vi vedono un modo per onor are e pr oteggere le peculiar ità del proprio territorio, dato che l’identità stessa di una comunità è profondamente legata al paesaggio e all’architettura, alla storia e ai protagonisti in loco. È il luogo in cui si appr ende quel senso di umanità e di 167 responsabilità ecologica. Wendell Berry, il poeta ecologista, la mette in questi termini: «Soltanto l’ideale di una c omunità coerente, ben vivo sia nel mondo sia nella mente dei suoi membri, può condurci oltre la frammentazione, le c ontraddizioni e la negati vità, insegnandoci a preservare, non in opposizione al resto, ma con spirito positivo e con amore, l’esistenza di tutte le cose di cui abbiamo bisog no per sentirci felici di essere vivi». In un’altra occasione, lo stesso Berry ha poi sintetizzato, citando il poeta satir ico inglese Alexander Pope (16881744): «Consulta sempre il genio dei luoghi ». Un approccio che riscuote tante simpatie pr oprio perché il c ommercio globale ha ridotto drasticamente ciò che vi era di distintivo e fecondo nei di versi luoghi del mondo . Un centro commerciale di Bangkok è identico a quelli che troviamo in Qatar, in Germania o negli Stati Uniti. Centinaia di milioni di persone sono or mai così abituate a fare la spesa nei super mercati, riforniti da gigantesche corporation proprietarie di marchi pesantemente pubblicizzati, che talvolta non riusciamo neppure più a immaginare che un tempo le risorse alimentari includevano una r icca varietà di prodotti e piatti tipici. Ricordiamo che, rimanendo agli Stati Uniti, in Nebraska la specialità locale erano i fagioli stufati e in Georg ia l’opossum con patate, mentre nei ristoranti dell’Alabama si ser viva l’arrosto di ostriche e nel Montana la coda di castoro era considerata una leccornia. Il rapporto con le origini biologiche del cibo è andat o quasi interamente perduto in tutti i paesi occidentali. Il movimento Slow Food rappresenta un tentativo di recuperare il controllo sulla produzione e la distribuzione del cibo a li vello locale, per riappropriarci così del piacere e della stabilità sociale derivanti dal vivere in un determinato luogo. Motivo per cui in quest’ambito si parla spesso dei beni comuni come modalità per riaffermare e ricostituire la vita quotidiana dei gruppi locali. Lo stesso impulso guida il movimento Slow Money, che opera per aumentare i flussi finanziar i diretti a soddisfare le esigenze a lungo termine delle comunità locali. E le Transition Town si propongono di prevenire le possibili catast rofi causate dal picco nell’estrazione petrolifera e dal r iscaldamento globale, cercando di mobilitare le potenzialità collaborative e innovative delle popolazioni locali per atti vare quei cambiamenti che né il mercato né lo Stato sembrano in grado di implementare. 168 Il rafforzamento delle realtà locali ha impor tanti implicazioni politiche. Come scrive ancora Wendell Berry: «Il g rande nemico della libertà è l’alleanza del potere politico con quello economico, un’alleanza che distrugge il benessere pubblico, cioè le risorse naturali delle comunità locali e le economie delle famiglie, dei quartieri e delle comunità – e così facendo finisce col disgregare anche la democrazia, che ha nel benessere pubblico la sua base e il suo st rumento attuativo». Sarebbe tuttavia un errore idealizzare le comunità locali attribuendo loro il potere di risolvere con facilità o automaticamente i problemi causati dalla g lobalizzazione economica. Il bisog no di soluzioni “dall’alto” permane, poiché alcuni problemi collettivi possono essere risolti soltanto ricorrendo a politic he o infr astrutture complesse e adeguate. Assicurare un minimo di parità di opportunità e di risorse, o procedere alla ridistribuzione della ricchezza, sono compiti che solo delle istituzioni centralizzate sono in grado di svolgere. Non ha senso che ogni comunità locale replichi quelle funzioni che lo Stato o anche i mercati internazionali sono in gradi d’implementare in maniera efficiente (e senza danni collaterali). È anche vero, però, che un certo grado di r idondanza e inefficienza è nec essario per la r obustezza a lungo termine di un sistema. Tuttavia al momento non disponiamo ancora di una tipologia sufficientemente ampia di infr astrutture su larga scala dedicat e ai beni comuni, né sappiamo veramente come progettarle o realizzarle. Un tipo di funzioni che finora sono state appannaggio esclusivo degli enti governativi. Ritengo però che d’ora in avanti spetti agli stessi commoner immaginare il modo in cui r ealizzare le infrastrutture e i pr otocolli ufficiali che li riguardano – senza nascondersi le difficoltà politiche che potrebbero derivarne. L’apparato statale è geloso della sua so- vranità e di solit o è poco disposto a comprendere e sostenere queste esperienze collaborative. L’emergere e il prevalere di decisioni prese dal basso e in maniera partecipata rappresentano una minaccia per gli organi di controllo tradizionali. Eppure questo potrebbe rivelarsi l’unico modo possibile per convogliare le energie, l’immaginazione e la legittimità sociale dei beni comuni verso la soluzione della miriade di problemi che ci t roviamo ad affrontare. Innumerevoli crisi ecologiche e sociali hanno già dimostrato che lo Stato e il mercato, oggi come oggi, non sono all’altezza dei loro compiti: cominciamo a prenderne atto. I beni comuni come nuovo modello di sviluppo 169 La capacità dei beni c omuni di operare nel rispetto delle realtà locali indica l’esistenza di percorsi alternativi per conseguire lo “sviluppo” e la crescita economica. In questo senso, le pratiche comunitarie offrono una nuova visione dello sviluppo umano, a partire dal riconoscimento del fallimento delle strategie di sviluppo economico tradizionali per approdare all’idea che si possa r icorrere a sistemi basati sui beni comuni per favorire gli interessi collettivi a lungo termine. L’idea per cui i beni comuni hanno le potenzialità per imporsi come un modello di sviluppo di tipo nuovo ha dato vita a tanti esperimenti innovativi ed è al centro di un grande fermento culturale. Ho già parlato di c ome la c ondivisione delle sementi aiuti molti agricoltori tradizionali a sfuggire alla volatilità dei mercati internazionali. Un altro esempio interessante di queste pratiche è il Sistema per l’Intensificazione del Riso – una c omunità internazionale di agricoltori che si scambiano consigli su come aumentare i raccolti utilizzando varietà organiche e non geneticament e modificate di riso. Da segnalare anche il Parco delle patate in Perù, già menzionato, il progetto avviato dal Comune di Oaxaca in M essico, che sta sperimentando nuove modalità di gestione c ollettiva della terra e di alt re risorse in una città di 600.000 abitanti, e i tentativi zapatisti di autogoverno nel 170 Chiapas. Ancora, l’area comunitaria protetta di Guassa, in Etiopia, gestita dal popolo Menz, è stata utilizzata come pascolo comune per più di quattrocento anni, e i locali vi raccolgono ancora la paglia per i tetti e il legname da ardere. Sebbene Guassa non sia ancora ufficialmente un’area protetta, i Menz sono riusciti a conciliare i bisogni legati alla loro sussistenza con il rispetto della natura e della fauna sel vatica, che comprende la specie di car nivori più minac ciata del mondo, la volpe etiopica. Queste e altre esperienze innovative dimostrano che le pratiche collettive possono servire da “impalcatura” per esplorare delle alternative realistiche alla visione neoliberista (fallimentare) dello sviluppo. I modelli centrati sui beni comuni non sono semplici “meccanismi politici” inseribili in una determinata situazione per “risolvere” qualche problema, ma incarnano una visione della vita assai diversa da quella dell’occidente industrializzato e consumista. In Ecuador e in Boli via, si parla di buen vivir per definire una visione dello sviluppo e un modo di esistere nel mondo di tag lio diverso. Il buen vivir implica il rispetto dell’autonomia delle comunità locali e della reciprocità sociale, la sal vaguardia degli ecosistemi naturali e un’etica cosmica. Con approcci diversi, i popoli indigeni, le culture tradizionali e i commoner intrappolati nell’economia di mercato stanno cercando di esprimere una visione del mondo che superi la ragione strumentale e l’economicismo capitalista. In questo senso, i beni comuni non rappresentano solo un modo di gestire le risorse, bensì anche un’etica particolare e una sensibilità interiore. È questo convincimento profondo che autorizza i commoner ad assumersi la responsabilità delle risorse del pianeta e a coltivare il senso del proprio ruolo di tutori. Si scopre così che coinvolgersi in queste esperienze collettive non è soltanto gratificante sul piano personale e salutare su quello culturale, ma diventa altresì uno stimolo a porre dei limiti sostenibili all’economia di mercato. I beni comuni costituiscono un’alternativa credibile ai modelli di sv iluppo basati sulla crescita della produzione e dei consumi sostenuti dalla Banca mondiale; indi- cano una via per ridurre l’ineguaglianza e l’insicurezza nelle nazioni emarginate, sottolineando al tempo stesso il ruolo vitale degli ecosistemi locali e della loro gestione condivisa. La necessità di un riavvicinamento tra Stato e beni comuni L’idea di strategie di sviluppo basate su pratiche collaborative solleva naturalmente la questione del r uolo dello Stato in un tale c ontesto – un altro problema complesso che richiede un’analisi approfondita. Storicamente le istituzioni pubblic he hanno a vuto scarsi r apporti con i beni comuni, al di là di t ollerarne a volte l’esistenza o di schierarsi con gli operatori del mercato (imprese, investitori, industrie) per privatizzarli. Il problema di fondo è che lo Stato ha un forte interesse ad allearsi con le forze del mercato nel processo di privatizzazione e mercificazione delle risorse pubbliche. Enclosure + crescita economica = potere e introiti fiscali. Per rompere questa logica, è necessario ripensare il ruolo dello Stato in senso fa vorevole a un sist ema di produzione basato sui beni comuni. Come abbiamo illust rato nel libro Green Governance, menzionato sopra, bisogna esercitare una pressione politica sull’appar ato statale per costringerlo a riconoscere un certo numero di politiche e macroprincipi atti a garantire il sostegno alle iniziative collaborative, tra cui: 171 – l’adozione di una governance ecologica basata sui beni c omuni e sui diritti riconosciuti come alternativa pratica allo Stato e al mercato; – il principio che il pianeta terra appartiene a tutti noi; – un impegno da parte dello Stato a impedire la privatizzazione delle risorse comuni; – l’amministrazione fiduciaria dello Stat o per pr oteggere le r isorse collettive di ampie proporzioni; – il formale riconoscimento dei beni comuni da parte dello Stato; – la limitazione del dir itto di proprietà privata per assicurare la sostenibilità a lungo termine dei sistemi ecologici; – il riconoscimento del diritto umano di creare e preservare i beni comuni naturali. 172 L’idea proposta da Michel Bauwen di una “triarchia” che distribuisca il potere tra lo Stato, il mercato e i beni c omuni (discussa in pr ecedenza) è destinata a rimanere controversa se non controproducente. In molte nazioni, l’idea stessa dell’interesse pubblico è così intimamente legata a quella di Stat o che diventa difficile immag inare un settore indipendente, non governativo (i beni comuni) impegnato a perseguire lo stesso fine. Anche là dove sono presi in considerazione, generalmente i beni comuni vengono assimilati alla “cittadinanza” o alla res publica, non riconosciuti in quanto comunità locali distinte. Immaginare queste ultime come un settore separato dallo Stato e dotato di una propria bussola di valori e di un’identità politica autonoma, richiede dunque una notevole capacità di immaginazione culturale. Il riconoscimento formale dei beni comuni da parte delle amministrazioni centrali e locali pone alcune questioni politiche del tutto legittime. Non è del tutto chiaro, ad esempio, in che modo lo Stato potrebbe impedire alle comunità locali di abusar e del loro potere sull’ambiente o di discr iminare ingiustamente altri cittadini, senza un intervento diretto. Sono obiezioni serie, che tuttavia mi sembrano superabili. Dopo tutto, lo Stato ha delegato ampi poteri all’industria per lo svolgimento di c erte funzioni, mantenendo però al c ontempo la funzione di controllo. Se le imprese possono avere un ruolo positivo riconosciuto dallo Stato, altrettanto può essere previsto per i beni comuni che hanno spesso dimost rato di servire l’interesse pubblico almeno quanto certe attività imprenditoriali, con costi assai meno esosi per l’ambiente e le risorse naturali. Se ben organizzati, inoltre, i beni comuni sono in gener e molto più disponibili a soddisfar e le esigenze dei cittadini r ispetto alle assemblee leg islative e ag li apparati 173 burocratici, geograficamente distanti, inaccessibili ai profani e spesso pesantemente influenzati da specifici interessi economici. Ma il problema più grosso riguarda probabilmente il profondo divario ideologico che oggi separa la dottrina liberalista dai beni comuni. Attraverso l’adozione di leggi costituzionali che limitano i pot eri del ramo esecutivo, le democrazie rappresentative cercano in teoria di promuovere il bene pubblic o mediante il r iconoscimento dei dir itti individuali a tutti i cittadini, considerati uguali di fr onte alla legge. L’odierna politica liberalista non prevede in genere norme a tutela dei diritti collettivi che superino la dimensione indi viduale. È v ero che molti trattati e pr ogrammi delle N azioni Unite contengono riferimenti ai dir itti sociali, economici e cultur ali che in pr atica possono agire come una sorta di scudi legali a fa vore dell’interesse collettivo. Questo però non viene riconosciuto in quanto tale e non sempre questi principi possono essere estesi alla tutela dei beni comuni. I popoli indigeni di ogni parte del mondo hanno do vuto prenderne atto più volte: le cat egorie giuridiche che proteggono gli interessi collettivi hanno scarso peso legale e filosofic o nell’odierna weltanschauung di stampo liberale. La questione stessa dei beni comuni rimane quindi il più delle volte imperscrutabile per la politica tradizionale, se non del tutto incompatibile. Finora le poche novità a favore delle esperienze collaborative introdotte nella leg islazione di alcuni paesi – c ome le lic enze Creative Commmons, la General Public License, le fondazioni per i terreni comunitari e certe tutele per le popolazioni indigene – hanno do vuto sfruttare alcune “crepe” nelle normative esistenti. Lo Stato potrebbe e dovrebbe fare di più per r iconoscere i beni comuni e il loro ruolo di promotori dell’interesse pubblico. Tuttavia, non è certo facile calibrare esattamente il li vello di c oinvolgimento dell’apparato statale in questo contesto – evitando cioè l’eccessivo coinvolgimento dello Stato, che potrebbe sostituirsi ai commoner, spingend oli a disint eressarsi della gestione comune, che è il punto portante di queste stesse iniziative. D’altro canto le istituzioni non dovrebbero neppure approfittare 174 dell’esistenza dei beni c omuni per sfugg ire alle lor o responsabilità, privandoli dei necessari puntelli legali, amministrativi o finanziari. È una critica già rivolta al primo ministro britannico David Cameron e al suo st ratagemma politico della “Big Society”, che da un lat o celebrava l’autonomia delle comunità locali e dall’alt ro tagliava i fondi a queste destinati. Secondo me, questo sostegno statale dovrebbe adeguarsi al pr incipio di “emanare politiche pubbliche a favore della creazione e della tutela dei beni c omuni”. Lo Stato dovrebbe riconoscere che i beni c omuni autogestiti sono in g rado di svolgere certe funzioni meg lio di quanto non fac cia lo st esso apparato statale oppur e il mer cato, offrendo inoltre un grado di legittimazione, correttezza e partecipazione assai superiore. È un ambito insidioso, tuttavia, perché il diavolo è nei dettagli, come si dice, e i dettag li variano moltissimo da una situazione all’altra. È però ben e vidente che, grazie ai network digitali, oggi le comunità di base sono in g rado di accumulare, organizzare e utilizzare le informazioni in maniera più rapida ed efficiente dei mastodontici apparati burocratici centralizzati (qui non mancano c erto gli esempi, come l’uso di w iki collaborativi, il coordinamento online degli interventi di protezione civile, le notizie in tempo reale sui social network, il crowdfunding della ricerca accademica). In questo contesto, la vera sfida potrebbe riguardare la messa a punto di nuove forme di collaborazione tra istituzioni burocratiche e beni c omuni digitali. Anche le risorse dell’ecosistema vengono spesso gestite in maniera più efficiente e appropriata dalle comunità locali investite dell’autorità e della responsabilità di monitorare le foreste, le zone ittiche o i sistemi idrici del loro territorio, senza interferenze esterne. Poiché non tutti i beni c omuni sono nec essariamente esperienze positive ed eque, lo Stato può svolgere un ruolo importante stabilendo delle regole di base e dei par ametri di esecuzione – lasciando poi alla “creatività diffusa” il compito di trovare le soluzioni più adatt e a livello locale. Com’è noto, un modello di questo tipo è stato adottato con successo per internet, con i protocolli Tcp/Ip su cui g ira questa 175 infrastruttura. Gli ar chitetti di questa enor me rete informatica non hanno cercato di controllare o dirigere il comportamento dei futuri utenti, limitandosi a stabilir e degli standard minimi comuni (protocolli Tcp/Ip) relativi a formattazione, indirizzo, trasmissione, invio e ricezione dei messaggi. In questo modo ogni utente ha avuto la massima libertà di proporre le innovazioni che riteneva opportune, sempre nel rispetto di quei par ametri fondamentali – una liber tà che ha consentito la nascita dell’inimmag inabile: i pr otocolli tecnici del World Wide Web. Ovviamente, non basta stipulare qualche parametro di base per veder spuntare dal nulla nuovi progetti collaborativi e autonomi al di fuori dell’ambito digitale. Occorrono anche finanziamenti e risorse – un processo che lo Stato può accelerare fornendo assistenza legale ed economica, o quantomeno facilitando l’emergere di beni comuni autorganizzati e autofinanziati. Non dimentichiamo che in quasi tutti i paesi oggi vigono complessi apparati burocratici, con privilegi normativi e sussidi per favorire la nascita e lo sviluppo delle imprese private: perché non si dovrebbe fare lo stesso a supporto dei beni comuni? Tuttavia un simile cambiamento andrebbe attentamente monitorato, dato che molti governi potrebbero mostrarsi fin troppo favorevoli all’idea di liberarsi delle loro responsabilità economiche e programmatiche – «lasciamo c he se ne oc cupino i beni c omuni!» – senza assumersi però quella di sostenere la nascita di nuovi sistemi collaborativi. In effetti, la maggior parte degli Stati moderni rimane ancorata alla mentalità novecentesca del controllo burocratico centralizzato, e quindi difficilmente potrebbero riconoscere il valore di comunità autogestite basate su pr incipi progettuali ridotti all’osso. In realtà, l’esplosione dell’innovazione tramite il cr owdsourcing online sta g ià creando forti tensioni negli apparati nazionali, incapaci di ac cettare l’idea per cui il potere diffuso, l’innovazione partecipativa e la governance autorganizzata (al di fuori delle strutture istituzionali) possano produrre risultati concreti e affidabili. Il problema da risolvere è capire come si concepisce il proprio ruolo nel mondo e, di conseguenza, quale struttura dovrebbe avere il governo. Lo studioso italiano Ugo Mattei sostiene che, per capire bene i termini della questione, occorre …superare la c ontrapposizione riduzionista “soggetto/oggetto” che produce la mercificazione di entrambi. I beni comuni, a differenza del bene privato e di quello pubblico, non sono un oggetto meccanico e non sono r iducibili a merci, bensì esprimono una relazione qualitativa. Noi non “abbiamo” un bene c omune, ma in gran misura “siamo” il bene comune, in quanto facciamo parte di un ambient e, di un ec osistema urbano o rurale. Qui il soggetto fa parte dell’oggetto. È per questo che i beni comuni sono legati inscindibilmente ai diritti della persona, della comunità e dello stesso ecosistema. 176 Se l’analisi di Mattei è corretta – e io cr edo che lo sia – si de ve prendere atto delle sue implicazioni per il futuro della politica e dello Stato liberale moderno. Com’è noto, sono sempre di più c oloro che ne considerano illegittimo e inefficace il pot ere: l’autorità e l’efficienza delle «istituzioni politic he classico-moderne», ha scr itto lo studioso olandese Maarten Hajen, «si stanno dileguando». L’idea che la politica possa essere separata dalla sua implementazione burocratica e che la complessità possa esser e gestita a li vello centralizzato da t eam di esperti scientifici neutrali non è più credibile. Secondo Hajen, stiamo vivendo in un «vuot o istituzionale [in cui] non esistono più regole e norme ben definite sul modo di condurre la politica e di pr endere decisioni politiche. Per essere più precisi, non esistono regole e norme universalmente accettate in base a cui sv olgere l’attività legislativa e politica» (c orsivo nell’originale). Ovviamente, i sostenitori delle politiche neoliberiste ritengono invece che tali regole e normative esistano e siano universalmente accettate; il problema, secondo loro, sta soltanto nella scelta delle “persone giuste” e nell’affi- 177 darsi alla scienza politica per varare delle “riforme” in grado di prevenire i comportamenti antisociali e di “risolvere” i problemi più gravi. Ma il proliferare dell’alienazione politica e dei movimenti di protesta in tutto il mondo chiama in causa la fede cieca delle élit e neoliberali – o meglio, le profonde deficienze strutturali delle istituzioni neoliberali. In ogni parte del pianeta aumentano i cittadini che ritengono i governi tradizionali incapaci di trovare una soluzione ai pr oblemi odierni. Non hanno più fiducia nelle istituzioni e non cr edono nella loro capacità di deliberare in modo democratico e imparziale e di mediare tra interessi politici diversi. Tante persone disilluse stanno rivolgendo le loro energie e la lor o fantasia politica a pr atiche alternative fai-da-te, interagendo il meno possibile con l’apparato statale. Internet ha consentito alla società civile di crescere e diventare transnazionale, al punto da sfidare la sovranità territoriale degli Stati, ritenuta finora inviolabile. Per i go verni è di ventato impossibile c ontrollare le innumerevoli reti transnazionali indipendenti e i g iganteschi flussi di infor mazione e comunicazione che percorrono il w eb. Un fiume di innovazioni sale dal basso e inonda i siti a libero accesso, mentre lo Stato lotta per non affogare. Dal punto di vita pratico, forse i beni comuni emergenti non r appresentano ancora una minaccia politica né economica per il sistema: le forze del mercato e del capitale finanziario sono ancora estremamente potenti, apparentemente invincibili. Ma la costante perdita di legittimità, di efficienza e di credibilità che colpisce le nazioni del mondo intero (e più in generale il paradigma neoliberale) non potrà proseguire così all’infinito. A un certo punto, si arriverà inevitabilmente alla resa dei conti. Un quadro che mi porta a chiedermi: l’ormai vetusta diade cittadino/Stato potrà continuare a funzionar e senza impor tanti cambiamenti nella distribuzione dell’autorità e del potere di governo? Lo Stato è forse in g rado di risolvere la miriade di problemi sociali ed ecologici che ci affliggono, e soprattutto di arrestare il cambiamento climatico senza una profonda riconfigurazione strutturale? Ne dubito. Se questa analisi è c orretta, la sfida c he abbiamo di fr onte è quella 178 d’individuare nuove forme di governance destinate inevitabilmente a trasformare la natura stessa del potere statale. Ci siamo avventurati in un territorio inesplorato in cui le vecchie regole e i presupposti di una volta hanno un’importanza relativa. Mi sembra evidente che i beni comuni – un sistema estremamente versatile di governance, gestione delle risorse e produzione di senso, in g rado di venire incontro alle nostre esigenze in modi che vengono percepiti come legittimi ed efficaci allo stesso tempo – entreranno a far parte di questo nuovo ordine sociale. Il futuro dei beni comuni 179 Ci sarebbe ancora molto da dire sull’intera questione – in maniera più approfondita e con maggiore precisione, da prospettive culturali diverse e con la sapienza degli storici, dei poeti e degli artisti. Il racconto che ne ho fatto è solo uno dei tanti possibili. Ma se sono riuscito a stimolare la curiosità del lettore, spingendolo a esplorare ancora questo tema, mi dichiaro soddisfatto. In fondo questo libro voleva limitarsi a offrire un’introduzione all’universo dei beni comuni. Una delle domande che mi viene rivolta più spesso è: cosa posso fare per sostenere i beni comuni? Oppure, come mi disse una donna dopo aver ascoltato un mio intervento, coniando per l’occasione un bellissimo neologismo: «Come posso essere più commonable»? Rispondo sempre che bisogna iniziare dalle proprie passioni e dal luogo in cui si vive, por poi c ercare altre persone disposte portare avanti quell’idea, per quanto modesto possa sembrare all’inizio il nost ro impegno. Mi tornano alla mente le celebri parole di Margaret Mead: «Non dubitate mai del fatto che un piccolo gruppo di cittadini attenti e disposti a impegnarsi possa cambiare il mondo; in effetti, è l’unico modo per riuscirci». Navigando tra i siti web dedicati ai beni comuni di cui parlo nel mio blog – tra cui la Peer to Peer Foundation, il blog C ommons in tedesco, la t estata Shareable, Onthecommons.org o la r ivista britannica Stir (o molti altri ancora: si veda l’elenco riportato in fondo al libr o) – s’incontrano decine di st orie di semplici indi vidui impegnati in qualcosa di st raordinario. Certe iniziative possono appar ire “troppo piccole” per produrre risultati significativi; agli esperti politici tradizionali piace immaginare progetti arditi e a vast o raggio, da imple- 180 mentare per “risolvere” i problemi una volta per tutte. Ma la verità è che i beni comuni funzionano meglio quando crescono in modo organico nel tempo, tenendo conto delle condizioni e delle esigenze specifiche del territorio. Non c’è dubbio che le istituzioni dello Stat o e quelle del dir itto internazionale dovrebbero intervenire ai “massimi livelli” per offrire assistenza legale e finanziaria allo sviluppo di pratiche collettive. C’è bisogno di infrastrutture e piattaforme che permettano a queste iniziative di crescere, rilasciando un’enorme quantità di energie a livello locale. C’è bisogno di nuovi beni comuni a livello nazionale e regionale, e anche nelle realtà più piccole, spesso ritenute “troppo piccole” per contare ma che, prese collettivamente, col tempo possono trasformare la società par tendo dal basso. A tale proposito, potrei citare Mark Lakeman e City Repair, un progetto civico di riqualificazione dell’ambiente urbano di Portland, in Oregon; Rajendra Singh e la sua Young India Association, che ha salvato il fiume Arvari quasi completamente prosciugato, applicando i pr incipi base dei beni c omuni; le decine di hackerspace e di F abLab che producono in modo c ollaborativo software informatico, hardware personalizzato e st rumenti per produrre in proprio dispositivi tecnologici. In tutti questi esempi, non si tratta di stilare una “classifica” lineare e gerarchica dei beni comuni esistenti – un’idea così novecentesca! – bensì d’intensificarne e diversificarne le attività ovunque e tutte insieme. Come dice la mia amica S ilke Helfrich, è un processo simile alla cristallizzazione, in cui nuovi “atomi” si uniscono al cristallo che presenta la migliore risonanza con le loro strutture e idee, e ben presto il cristallo comincia a prender forma e a espandersi in tutte le direzioni, senza alcun bisogno di gerarchie o organi centralizzati. In questo senso, anche i cambiamenti minimi, arrivano a produrre effetti cumulativi sull’intero sistema. È quanto succede man mano c he nuovi beni comuni vanno sommandosi tra loro, oppure con lo sviluppo graduale di internet, di un singolo network o dell’intero World Wide Web. Un processo che è in c orso da qualche tempo. La nostra antologia 181 del 2012, The Wealth of Commons, documenta l’enorme interesse suscitato in tutto il mondo dai beni c omuni come mezzo per immaginare un avvenire di tipo diverso. Parte di queste energie si sono manifestate a Berlino, nel novembre 2010, in occasione di un convegno internazionale dei beni c omuni, che ha visto la partecipazione di oltre duecento attivisti provenienti da trentaquattro paesi. Un entusiasmo che ha trovato ulteriore impeto nel successivo evento internazionale dedicato a beni c omuni ed economia, svoltosi sempre a Berlino nel maggio 2013. L’aspetto più affascinante di questi sviluppi è che decine di progetti in tutto il mondo stanno adottando spontaneamente il paradigma dei beni comuni per definire le proprie iniziative. Il World Social Forum e il summit popolare alternativo svoltosi durante il convegno internazionale sull’ambiente Rio+20 hanno pubblicat o vibranti manifesti a difesa dei beni collettivi. In Italia sono sorti dei movimenti politici per impedire la pr ivatizzazione dell’acqua e per la cr eazione di beni c omuni gestiti dai cittadini. Su internet, ci sono siti web che forniscono appositi corsi online e un atlant e mondiale. La Notre Dame University e la School of Commoning di Londra offrono un corso introduttivo ai beni comuni globali, mentre negli Stati Uniti gli attivisti di Occupy hanno ospitato due convegni su queste tematiche. A Istanbul, artisti e attivisti locali esaminano e r ilanciano i legami esistenti tra arte e beni comuni. E potrei continuare ancora a lungo. La maggior parte dei commoner che conosco non è interessata a sviluppare una “teoria unificata del campo” dei beni comuni come filosofia politica. O meglio, anche se è v ero che vogliono creare un’idea più ampia e coerente di queste pratiche e della loro possibile applicazione in circostanze diverse, provano un’istintiva diffidenza per l’enfasi ideologica e le astrazioni. La vera priorità dei commoner, quando si viene al sodo, è custodire e proteggere il bene comune in cui sono coinvolti e che amano profondamente, ben coscienti di dover dedicare le loro energie a questo impegno. Coltivare l’arte del commoning: è questa la base per tutto il resto. 182 L’approccio decentralizzato, autorganizzato e pratico che caratterizza i beni c omuni è anche l’elemento che rende così difficile trasformarli in una strategia politica, né è facile cooptare un movimento privo di una leadership identificabile. In senso più positi vo, un mo vimento diversificato e radicato in una leadership indipendente e localizzata, può stimolare energie e immaginazione più fertili di un’organizzazione centralizzata. Preferendo per lo più la pr atica alla teoria, queste aggregazioni collettive non provocano quelle snervanti battaglie ideologiche che affliggono tanti mo vimenti politici (non è sempre così, ovviamente: il movimento del software libero ha dovuto affrontare le sue battaglie sulla purezza ideologica e in altri ambiti ci si concentra ancora troppo sull’aspetto teorico a scapito della pratica). In generale, comunque, agli attivisti non interessa tanto trovare la formulazione corretta quanto piuttosto il modo mig liore di r isolvere i problemi concreti. Le idee sono impor tanti, naturalmente, come pure i dibattiti strategici – ma, come ha notato acutamente l’artista concettuale Jenny Holzer: «l’azione colpisce ben più a fondo della teoria». Nelle pagine iniziali di quest o libro mi chiedevo in che modo possiamo combattere i vecchi dogmi dell’ideologia neoliberale e sbarazzarci di una t eologia del “libero mercato” che non è più in g rado di mantenere le sue promesse ma si rifiuta di prendere in considerazione qualsiasi alternativa. Spero che a questo punto sia chiaro qual è secondo me la r isposta. Occorre creare ed espandere una cerchia sempre più ampia di beni comuni, partendo da quelli già funzionanti, che possa fungere da “base di addestramento” per la messa a punto di una visione del futuro, un’etica culturale e un’identità politica di tipo nuovo. Questa visione non può essere semplicemente annunciata da qualche leader brillante che ci spieghi come devono andare le cose, ma dovrà essere negoziata e messa in atto collettivamente dalle stesse comunità di base, passo d opo passo. Le strategie e le soluzioni possono emergere solo dal dibattito, dalla ricerca e dalla sperimentazione. Quella dei beni c omuni è innanzitutto una pratica culturale e una prospettiva che punta a int erpretare la realtà in termini nuovi, par- 183 tendo da una percezione diversa sul ruolo degli esseri umani nella costruzione di un mondo mig liore. La ricerca di nuovi punti d’appoggio su cui far leva per accelerare il cambiamento è guidata dall’impegno etico e sociale dei commoner, per i quali la democr azia rappresentativa e lo Stat o di dir itto rimangono fattori importanti di pr ogresso, ma pur sempre all’interno di un quadro nettamente pragmatico. Il compito più urgente non è nec essariamente quello di far approvare altre leggi o eleggere i candidati giusti, soprattutto se si tiene conto della corruzione e dell’inefficienza deg li attuali sistemi di governo. L’obiettivo più pressante è mettere a punto istituzioni adeguate e durature per lo sviluppo dei beni comuni. Occorre combattere le privatizzazioni e predisporre nuovi strumenti di tutela (legali, tecnologici, sociali) – un percorso che non deve prevedere inevitabilmente il ricorso a legislazioni statali. Una delle pr iorità più impor tanti, allora, riguarda l’ampliamento continuo del dibattito pubblico, facendo in modo che il tema rimanga in cir colazione negli ambienti cultur ali e t rovi fondamenta nella pratica quotidiana. Solo così quella dei beni c omuni potrà emergere come una realtà credibile, funzionante. E quante più persone avranno modo di vivere esperienze di questo tipo a livello personale, tanto più la conoscenza dei beni c omuni si diffonderà in un pubblic o sempre più vasto. Parlarne vuol dire cominciare a reclamarli e farli propri. Nella maggior parte del mondo, le prospettive di uno sviluppo politico significativo in tal senso restano scoraggianti. Se il progetto neoliberista non è manifestament e in grado di mantenere le sue pr omesse utopistiche di progresso e prosperità per tutti, i critici tradizionali del neoliberismo e le forz e politiche progressiste non sembr ano d’altra parte in grado di individuare le soluzioni innovative di cui ci sar ebbe bisogno. Temo che per lo più siano t roppo stanchi intellettualmente, demoralizzati politicamente o compromessi in base ai loro preconcetti, per apparire credibili nel mondo del potere e della rispettabilità. Le prospettive aperte dalle pratiche collaborative possono aiutarci a uscire da questa palude, offrendoci la possibilità di una r ipartenza su 184 basi concettuali innovative, con strumenti analitici nuovi e un v ocabolario politico e morale meno volatile. Vista la loro ampia portata, i beni comuni rappresentano uno strumento potente per ripensare la governance pubblica, l’economia e la politica in un moment o in cui l’ordine esistente appare incapace di riformarsi. Propongono un percorso per rivitalizzare la pratica della democrazia in una fase st orica in cui le istituzioni politiche tradizionali si mostrano inefficienti, corrotte e ostili a og ni tentativo di riforma. Dimostrano nei fatti c he la società può far leva sulla cooperazione e sulle energie dal basso per risolvere efficacemente i suoi problemi, proponendo una governance tipo nuovo che va oltre la democrazia rappresentativa o che può esservi integrata per arrivare a una partnership costruttiva. Il numero crescente di questo movimento transnazionale e lo sv iluppo continuo di innovazioni che ne derivano sono la prova concreta della g rande forza di att razione dell’idea st essa di bene c omune. Non tutte le situazioni collettive hanno abbracciato quest’idea in modo esplicito, ma le pr atiche sociali di cui sono por tatrici ne racchiudono in sé i valori fondamentali: partecipazione, cooperazione, inclusività, correttezza, innovazione dal basso, responsabilità. Tutte queste esperienze puntano a integrare la produzione, il consumo e la governance in un unico paradigma di cambiamento, tanto eclettico quanto la varietà di nomi e pr ogetti da cui è c omposto: il movimento per la solidarietà economica e le Transition Town, gli attivisti per un’altra globalizzazione e le campagne contro la privatizzazione dell’acqua, il movimento dei lavoratori senza terra in Brasile e quello internazionale dei contadini chiamato La Via Campesina, l’attivismo a sost egno del software libero e della cultura libera, gli utenti e i curatori di Wikipedia, l’ambito delle pubblicazioni ac cademiche open ac cess e delle risorse didattiche aperte, le decine di Partiti Pirata attivi nel mondo e il movimento Occupy, per citare solo le situazioni più note. Le emergenti integrazioni tra queste iniziative sembra annunciare la nascita di un movimento globale del tutto inedito: il coordinamento elastico e flessibile di un movimento dei movimenti. I quattro capisaldi dei beni comuni 185 I beni comuni hanno tutte le potenzialità per imporsi come punto focale di tutte queste energie perché presentano quattro vantaggi fondamentali. Primo, incarnano una visione del mondo e una s ensibilità ecumeniche sia nello spir ito sia nell’analisi. Non propongono un’ideologia totalizzante, bensì un modello di cambiament o che può essere facilmente adattato alle varie culture e società, nel rispetto delle realtà e dei modelli operativi preesistenti. Secondo, hanno alle spalle una storia giuridica venerabile, che risale all’Impero romano e alla M agna Carta, un passat o che è font e di informazione, credibilità e modelli politico-giuridici tuttora attuali. Terzo, rappresentano una cornice intellettuale e un dis corso che ci consentono di analizzare la cultura del mercato, legittimando il valore della cooperazione e dell’agire comunitario e superando uno dei limiti più antichi del liberalismo politico, troppo allineato all’ideologia del mercato per metterne in discussione i difetti e i limiti sistemici. La sua concezione dell’esistenza umana non può allontanarsi troppo dal modello dell’Homo economicus e perfino il suo progetto di emancipazione politica è impastoiato da un’idea di universalismo che si è mostrata incapace di mantenere le promesse iniziali. Infine, i beni comuni offrono un vasto assortimento di modelli operativi di successo in campo economico e politico, che in molti casi si sono dimostrati ben più efficaci del mer cato e dello Stato, fornendoci alternative positive e costruttive che chiedono a tutti noi uno sforzo di r esponsabilità e di immag inazione, non soltant o un att eggiamento di sterile critica. Queste pratiche richiedono persone attive e disposte a par tecipare alla c ostruzione di un n uovo mondo, non di semplici consumatori ed elettori. I beni comuni sono un verbo attivo, non un inerte sostantivo: non è una questione di cui possiamo liberarci mettendola nelle mani di politici e bur ocrati. I beni comuni come dono e obbligo morale 186 Alan Lipietz, un politico e studioso francese, fa risalire le origini della parola “commons” a G uglielmo il C onquistatore (1028-1087) e ai Normanni – guarda caso, non agli inglesi. Il termine verrebbe dal normanno commun, derivante da munus, che significa sia “dono” sia “restituzione di un dono” – vale a dire, un obbligo morale. Ritengo che questa etimologia ne colga appieno l’essenza. Abbiamo bisogno di tornare a un mondo in cui tutti r icevano doni e tutti sentano di avere degli obblighi: aspetti molto importanti dell’essere umano. L’espansione di grandi strutture economiche e politiche centralizzate ha messo tragicamente in ombra il nostro bisogno di ricevere doni e di contraccambiarli. Ci affidiamo al mercato e allo Stato per tutto, lasciando ben poc o spazio all’iniziativa individuale e all’impegno etico. Abbiamo così perso contatto con quel che Ivan Illich definiva “sfera vernacolare”, gli spazi nella nost ra vita quotidiana in cui possiamo creare, modellare e negoziare la nostra stessa vita. Credo veramente che dovremmo sforzarci di irrobustire quella che ho chiamato la legge vernacolare, che è poi la legge dei beni c omuni. Il dato che oggi trovo più confortante è la profonda risonanza che quest’idea sta avendo tra comunità anche assai distanti tra loro – agricoltori filippini e artisti del remix in Brasile, hacker olandesi e cooperanti tedeschi, attivisti per la cultura libera in Usa e amministrazioni comunali in Italia. L’esplosione in tutto il mondo di iniziative focalizzate sulla tut ela dei beni c omuni, in c ontesti tanto innumerevoli quanto diversificati, sta cr eando delle pot enti sinergie e apr endo la strada a promettenti trasformazioni. Quando la teoria fatica a t enere il passo c on la pratica, abbiamo la prova che sta succedendo qualcosa d’importante. In un momento storico in cui le st rutture e le nar rative tradizionali semplicemente non funzionano più, i beni comuni ci offrono tanti motivi per essere ottimisti. Breve vademecum dei beni comuni I beni comuni sono: – sistemi sociali per la gestione a lungo t ermine delle risorse che preservano i valori condivisi e l’identità comunitaria; – sistemi autogestiti tramite cui le comunità amministrano le risorse (esauribili e rinnovabili) con minima o nessuna interferenza da parte del mercato o dello Stato; – ricchezze collettive che ereditiamo o creiamo insieme e che dobbiamo lasciare ai nost ri figli, immutate o mig liorate, e comprendono i doni della natura, l’infrastruttura civica, le opere culturali, le tradizioni e la conoscenza. – un settore dell’economia (e della v ita!) che genera valore tramite modalità spesso dat e per sc ontate e messe in per icolo dall’alleanza Stato-mercato. Non esiste nessun in ventario generale dei beni comuni perché queste esperienze sorgono ogni qual volta una certa comunità decide di gestire una risorsa in maniera collaborativa, con particolare attenzione alla parità d’accesso, all’utilizzo e alla sostenibilità. 187 I beni comuni non sono soltanto delle risorse, bensì un insieme composto dalle risorse, dalla comunità di riferimento e da protocolli, valori e consuetudini da questa stabiliti per gestir e tali risorse. Tra le molte risorse che oggi andrebbero urgentemente gestite come dei beni c omuni ci sono l’atmosfera, gli oceani, la genetica e la biodiversità. Non esistono beni comuni senza le pratiche e le consue tudini che consentono alla comunità di gestirne le risorse per il bene collettivo. Queste pratiche sono organicamente diverse tra loro tanto quanto lo sono gli esseri umani, e quindi non esist e alcun “fac-simile standard”, bensì soltanto principi e modelli condivisi. I beni comuni vanno perciò intesi come verbo oltre che come sostantivo, e devono essere caratterizzati da partecipazione diffusa, responsabilità individuale, trasparenza e capacità autogestionali. Uno dei problemi più pressanti e ignorati della nostra epoca riguarda le enclosure dei beni comuni, cioè l’espropriazione e la c ommercializzazione di risorse condivise, generalmente per ricavarne profitti privati. Queste recinzioni forzate sono evidenti, fra l’altro, nei brevetti imposti a geni e for me di vita, nell’eccessiva estensione dei termini del diritto d’autore per mettere sotto chiave la cultura e la cr eatività, nella privatizzazione dell’acqua e della t erra, nei t entativi di t rasformare l’internet aperta in un mercato proprietario chiuso. Enclosure equivale a espropriazione, perché privatizza e commercializza risorse appartenenti a una c omunità o anche a tutti, disintegrandone la cultur a collaborativa (basata su c o-produzione e c o-governance) tramite l’imposizione dell’ordine del mercato (con relazioni e gerarchie basate sullo scambio di denaro tra produttore e consumatore). Il mercato tende ad avere rapporti minimi con la località, la cultura e le usanze quotidiane, elementi invece indispensabili per i beni comuni. 188 I beni comuni più diffusi s ono di dimensioni ridotte e concentrati sulle risorse naturali; si stima che circa due miliardi di persone oggi dipendono da beni comuni quali aree boschive e pescose, acque, fauna sel- vatica e altre risorse naturali per il lor o fabbisogno quotidiano. Non vanno però dimenticati altri tipi di beni comuni negli ambienti urbani e nelle università, come pure quelli che abbracciano le infrastrutture e le t radizioni sociali. Vanno poi forte i beni c omuni basati su internet e sulle t ecnologie digitali, grazie ai quali i cittadini possono creare ampi bacini di conoscenza condivisa e di opere creative. La sfida che og gi devono affrontare i commoner riguarda la messa a punto di nuove strutture giuridiche, forme istituzionali e pratiche sociali capaci di c onsentire ai diversi tipi di esper ienze collaborative di operare su larga scala, di proteggere le risorse da possibili privatizzazioni e di garantirne la forza rigenerativa. 189 Cresce l’esigenza di nuove forme e pratiche collaborative a livello locale, regionale, nazionale e g lobale, e quindi c ’è bisogno di nuove strategie federative e legami oper ativi tra le di verse esperienze. Soprattutto i beni comuni transnazionali devono impegnarsi ad allineare la governance con le realtà ecologiche, operando come forze di riconciliazione al di là delle differenze politiche. Per attualizzare i beni comuni ed evitare le enclosure del mercato, è cruciale spingere l’innovazione a livello di normative, politiche pubbliche, governance, pratiche sociali, ambiti culturali. La speranza è che l’insieme di queste iniziative possa portare a una visione del mondo ben diversa da quella oggi prevalente nei sist emi gestionali, particolarmente in quelli implementati dal mercato e dallo Stato. Logica dei beni comuni e del mercato a confronto Sintesi comparativa delle concezioni fondamentali Risorse Paradigma del profitto Paradigma dei beni comuni Esiste o si crea scarsità (tramite barriere ed esclusioni). Per risorse in concorrenza tra loro, ce ne sono a sufficienza per tutti tramite la condivisione; per le altre vige l’abbondanza. Strategia: allocazione “efficiente” delle risorse. Strategia: è il rafforzamento delle relazioni sociali a garantire condivisioni eque e uso sostenibile delle risorse. Gli esseri umani sono soprattutto Ogni individuo tende a massimizzare il proprio vantaggio esseri collaborativi. personale (Homo economicus). Rapporto con la natura e con gli altri Separazione: – l’uno o l’altro; – individualismo contro altruismo; – società umana contro natura. Inter-relazione: i singoli e il collettivo sono annidati uno nell’altro e si rafforzano a vicenda. Agenti di cambiamento Potenti lobby politiche, gruppi d’interesse, politiche istituzionali centrate sul governo. Comunità variegate che operano come reti distribuite, con soluzioni che spesso emergono dai margini. Primo piano Inter-relazione, ricchezza in Scambi di mercato e crescita economica (Pil) raggiunte tramite comune, stili di vita sostenibili, iniziative individuali, innovazione iniziative complementari. ed “efficienza”. Domanda cruciale Cosa posso vendere e comprare? 190 Il concetto di individuo Cosa mi/ci serve per vivere? Paradigma del profitto Paradigma dei beni comuni Processo decisionale Gerarchico, imposto dall’alto, autoritario. Orizzontale, decentralizzato, dal basso; autogestione, monitoraggio e adeguamento per l’uso delle risorse. Principio decisionale Maggioritario Consenso Relazioni di potere Centralizzazione e monopolio Decentralizzazione e collaborazione Relazioni di proprietà Esclusività della proprietà privata: Proprietà ad uso collettivo: «sono «posso fare quello che voglio con coresponsabile per ciò che uso insieme agli altri» ciò che mi appartiene». Governance Rapporti sociali Accesso limitato; regole definite Accesso a dal proprietario. risorse competitive (terreni, acqua, boschi...) Accesso limitato; regole definite dagli utenti. Accesso limitato; si crea Accesso a artificialmente la scarsità tramite risorse non legislazioni e tecnologia. competitive (idee, codice...) Accesso aperto e illimitato come norma prestabilita. Concesso o meno dal proprietario; in primo piano i diritti individuali. Decisa collegialmente dagli utenti coproduttori; in primo piano: imparzialità, accesso garantito a tutti. Pratica sociale Prevalere a spese degli altri; domina la competizione. Pratiche collaborative; 191 Diritto d’utilizzo Paradigma del profitto Paradigma dei beni comuni Produzione di conoscenza Ideologia e valori imprenditoriali Peer-to-peer, percorsi in rete e collaborativi portano a punti di integrati nell’istruzione e nella vista diversificati. produzione di conoscenza. Conoscenza considerata come bene scarso soggetto a compravendita. Conoscenza considerata come risorsa copiosa per il bene della società. Tecnologie proprietarie. Tecnologie libere e trasparenti. Conoscenza altamente specializzata e competenze privilegiate. Conoscenza soggetta al controllo sociale e democratico. Implicazioni per... Conservazione, sostentamento, riproduzione, espansione. Risorse Depauperamento, sfruttamento, enclosure. Società Appropriazione personale contro «Il mio benessere personale è la condizione per lo sviluppo degli interessi collettivi; altri e viceversa». esclusione. 192 Questa scheda, curata da Silke Helfrich, è ripresa dal libro The Wealth of the Commons: A World Beyond Market and State (Levellers Press, 2012) e r ilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 3.0. Bibliografia ragionata L’elenco che segue include materiali di approfondimento in lingua inglese, seguito da una breve bibliografia italiana (oltre ad alcune edizioni italiane di testi inglesi segnalate nei singoli capitoli). 193 Economia, mercato e beni comuni Ackerman, Frank e Lisa Heinzerling, Priceless: On Knowing the Price of Everything and the Value of Nothing (New Press, 2004). Alperovitz, Gar e L ew Daly, Unjust Deserts: How the Rich Are Taking Our Common Inheritance (New Press, 2008). Barnes, Peter, Capitalism 3.0: A Guide to R eclaiming the C ommons (Barrett–Koehler, 2006). Bollier, David, Silent Theft: The Private Plunder of Our C ommon Wealth (Routledge, 2002). –––, This Land Is Our Land: The Fight to Reclaim the Commons [DVD] (Media Education Foundation, 2010). –––, e Silke Helfrich (a cura di), The Wealth of the Commons: A World Beyond Market and S tate (Levellers Press, 2012, wealthofthecommons.org). Frank, Robert, One Market Under God: Ex treme Capitalism, Market Populism and the End of Economic Democracy (Doubleday, 2000). Hardt, Michael e Antonio Negri, Commonwealth (Harvard University Press, 2009). Harvey, David, A Brief History of Neoliberalism (Oxford University Press, 2005). Heller, Michael, The Gridlock Economy: How Too Much Ownership Wrecks Markets, Stops Innovation and Costs Lives (Basic Books, 2008). Kuttner, Robert, Everything For Sale: The Virtues and Limits of Markets (Knopf, 1997). Nomini, Donald (a cur a di), The Global I dea of ‘the Commons’ (Berghahn Books, 2007). Patel, Raj, The Value of Nothing: How to Reshape Market Society and Redefine Democracy (Picador, 2009). Penalver, Eduardo Moises e Sonia Katyal, Property Outlaws: How Squatters, Pirates and Protesters Improve the Law of Ownership (Yale University Press, 2010). Radin, Margaret Jane, Contested Commodities (Harvard University Press, 1996). Rose, Carol, Property and Persuasion: Essays on the History, Theory and Rhetoric of Ownership (Westview Press, 1994). Sandel, Michael, What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets (Allen Lane, 2012). Schroyer, Trent, Beyond Western Economics: Remembering Other Economic Cultures (Routledge, 2009). Wall, Derek, The Sustainable Economics of Elinor Ostrom: Commons, Contestation and Craft (MIT Press, 2014). Walljasper, Jay, All That We Share (New Press, 2011). 194 Dinamiche socio-culturali Benkler, Yochai, The Penguin and the L eviathan: The Triumph of Cooperation Over Self-Interest (Crown Business, 2010). Bowles, Samuel e Herbert Gintis, A Cooperative Species: Human Reciprocity and Its Evolution (Princeton University Press, 2011). Cahn, Edgar e J onathan Rowe, Time Dollars (Emmaus, PA: Rodale Press, 1992). Gintis, Herbert, Samuel Bowles e al., Moral Sentiments and Material Interests: The Foundations of Cooperation in Economic Life (MIT Press, 2005). Hyde, Lewis, The Gift: I magination and the E rotic Life of Property (Vintage Books, 1979). Kropotkin, Petr, Mutual Aid: A Factor of Evolution (Boston: Porter Sargent Publishers/ Extending Horizons Books, ristampa dell’edizione del 1914). Linn, Karl, Building Commons and C ommunity (Oakland, CA: New Village Press, 2007). Sennett, Richard, Together: The Rituals, Pleasures and Politics of Cooperation (Yale University Press, 2012). Beni comuni e percorso storico Alexander, Gregory, Commodity and Propriety: Competing Visions of Property in American Legal Thought, 1776–1970 (University of Chicago Press, 1997). Federici, Silvia, Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation (Autonomedia, 2004). Hill, Christopher, The World Turned Upside Down: Radical Ideas During the English Revolution (Penguin, 1972). Hyde, Lewis, Common as Air: Revolution, Imagination and Ownership (Farrar, Strauss and Giroux, 2010). Linebaugh, Peter, The Magna Carta Manifesto: Liberties and Commons for All (University of California Press, 2008). Polanyi, Karl, The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time (Beacon Press, 1944, 1957). Wall, Derek, The Commons in History: Culture, Conflict and Ecolog y (MIT Press, 2014). 195 Conoscenza e beni comuni digitali Aufderheide, Patricia e Peter Jaszi, Reclaiming Fair Use: How to P ut Balance Back in Copyright (University of Chicago Press, 2011). Benkler, Yochai, The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom (Yale University Press, 2006). Bollier, David, Brand Name Bullies: The Quest to O wn and C ontrol Culture (John Wiley, 2005). –––, Viral Spiral: How the C ommoners Built a D igital Republic of TheirOwn (New Press, 2009). Boyle, James, The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind (Yale University Press, 2008). Ghosh, Rishab Aiyer, CODE: Collaborative Ownership and the Digital Economy (MIT Press, 2005). Klemens, Ben, Math You Can’t Use: Patents, Copyright and Software (Brookings Institution Press, 2006). Krikorian, Gaelle e Amy Kapczynski, Access to Knowledge in the Age of Intellectual Property (Zone Books, 2010). La Follette, Laetitia, Negotiating Culture: Heritage, Ownership and Intellectual Property (University of Massachusetts Press, 2013). Lessig, Lawrence, Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity (Penguin Press, 2004). Ostrom, Elinor e Charlotte Hess, Understanding Knowledge as a Commons: From Theory to Practice (MIT Press, 2007). Patry, William, Moral Panics and the Copyright Wars (Oxford University Press, 2009). Suber, Peter, Open Access (MIT Press, 2012). Vaidhyanathan, Copyrights and C opywrongs: The Rise of Intellectual Property and How It Threatens Creativity (New York University Press, 2001). 196 Risorse naturali e beni comuni Barnes, Peter, Who Owns the Sky? Our Common Assets and the Future of Capitalism (Island Press, 2001). Buck, Susan, The Global Commons: An Introduction (Island Press, 1998). Burger, Joanna, Elinor Ost rom e al., Protecting the C ommons: A Framework for R esource Management in the Americas (Island Press, 2001). Cooper, Melinda, Life as Surplus: Biotechnology and Capitalism in the Neoliberal Era (University of Washington Press, 2008). Davey, Brian, Sharing for Survival: Restoring the Climate, the Commons and Society (Foundation for the Economics of Sustainability, 2012). Dolsak, Nives e Elinor Ostrom, The Commons in the New Millennium: Challenges and Adaptations (MIT Press, 2003). Donahue, Brian, Reclaiming the C ommons: Community Farms and Forests in a New England Town (Yale University Press, 1999). Freyfogle, Eric, The Land We Share: Private Property and the Common Good (Island Press, 2003). McKay, Bonnie e James Acheson, The Question of the Commons: The Culture and Ecology of Communal Resources (University of Arizona Press, 1987). National Research Council, Elinor Ost rom, Thomas Dietz e al., The Drama of the C ommons: Committee on the H uman Dimensions of Global Change (National Academy Press, 2002). Ostrom, Elinor, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action (Cambridge University Press, 1990). Shiva, Vandana, Biopiracy: The Plunder of Nature and K nowledge (South End Press, 1997). Steinberg, Theodore, Slide Mountain, or the F olly of Owning Nature (University of California Press, 1995). Waldby, Catherine e Robert Mitchell, Tissue Economies: Blood, Organs and Cell Lines in Late Capitalism (Duke University Press, 2006). Weston, Burns e David Bollier, Green Governance: Ecological Survival, Human Rights and the La w of the Commons (Cambridge University Press, 2013). 197 Aspetti specifici Bollier, David e Laurie Racine, Ready to Share: Fashion and the Ownership of Creativity, con DVD (USC Annenberg School/Norman Lear Center, 2006). Brown, Michael, Who Owns Native Culture? (Harvard University Press, 2003). Frischmann, Brett, Infrastructure: The Social Value of Shared Resources (Oxford University Press, 2012). Hallsmith, Gwendolyn e Ber nard Lietaer, Creating Wealth: Growing Local Economies with Local Currencies (New Society Publishers, 2011). McSherry, Corynne, Who Owns Academic Work? Battling for Control over Intellectual Property (Harvard University Press, 2001). Shuman, Michael, Going Local: Creating Self-Reliant Communities in a Global Age (Routledge, 2000). Van Abel, Bas, Lucas Evers e al., Open Design Now: Why Design Cannot Remain Exclusive (The Netherlands, Bis Publishers, 2011, opendesignnow.org). Washburn, Jennifer, University, Inc: The Corporate Corruption of Higher Education (Basic Books, 2005). Bibliografia italiana essenziale P. Cacciari (a cura di), La società dei beni comuni. Una rassegna, Ediesse, 2011. U. Mattei, Beni comuni. Un manifesto, Laterza, 2012. L. Pennacchi, Filosofia dei beni comuni. Crisi e primato della sfera publica, Donzelli, 2012. G. Arena e C. Iaione (a cur a di), L’Italia dei beni comuni, Carocci, 2012. M. R. Marella, Oltre il pubblico e il pr ivato. Per un diritto dei beni comuni, Ombre Corte, 2012. S. Rodotà, Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i be ni comuni, Il Mulino, 2013. A. Lucarelli, La democrazia dei beni comuni, Laterza, 2013. U. Mattei e A. Quarta, L’acqua e il suo diritto, Ediesse 2014. U. Mattei, «Senza proprietà non c’è libertà». Falso!, Laterza, 2014. U. Mattei, Il benicomunismo e i suoi nemici, Einaudi, 2015. Siti web utili 198 Oltre a quest’elenco essenziale, si r imanda ai progetti specifici indicati nelle pagine precedenti, i cui sit i web sono reperibili tramite una veloce ricerca, in particolare quelli segnalati nel capitolo 9 sui be ni comuni digitali. 199 David Bollier – bollier.org Commons Abundance Network – commonsabundance.net Commons Atlas – commonsparkcollective.org/index.php/about CommonsBlog (Germania) – commonsblog.wordpress.com The Commoner (UK) – commoner.org.uk Commons (Finlandia) – commons.fi Creative Commons – creativecommons.org Digital Library of the Commons – dlc.dlib.indiana.edu FreeLab (Polonia) – freelab.org.pl Free Software Foundation – fsf.org Global Commons Trust – globalcommonstrust.org Int. Ass. for Study of the Commons – iasc-commons.org International Journal of the Commons – thecommonsjournal.org/index.php/ijc Keimform (Germania) – keimform.de/category/english Knowledge Ecology – keionline.org New Economics Foundation – neweconomics.org OER Commons – oercommons.org On the Commons – onthecommons.org Ouishare – ouishare.net P2P Foundation – p2pfoundation.net Real World Economics Review – paecon.net/PAEReview Re:Common (Italia) – recommon.org Remix the Commons – remixthecommons.org Science Commons – creativecommons.org/science Shareable Magazine – shareable.net Solidarity Economy – solidarityeconomy.net Stir to Action (UK) – stirtoaction.com Workshop in Political Theory – www.indiana.edu/~workshop Ringraziamenti Non è esagerato affermare che per scrivere questo libro mi ci sono voluti quindici anni, durante i quali ho studiato da vicino ogni aspetto dei beni comuni – i loro meccanismi, le implicazioni politiche e le direzioni future. È impossibile ringraziare qui le centinaia di persone con cui ho condiviso incontri istruttivi in varie parti del mondo (voi sapete chi siete!). Mi limiterò perciò a nominare quei colleghi e amici che hanno avuto maggior influenza sulle mie concezioni e che hanno arricchito la mia vita: Silke Helfrich, Michel Bauwens, Heike Löschmann e, negli Stati Uniti, Peter Barnes, Jonathan Rowe (1946–2011) e John Richard. Sono particolarmente riconoscente a Matthieu Calame, direttore della fondazione Charles Léopold Mayer di Parigi, per il suo genuino interesse nei beni comuni e per aver commissionato la traduzione francese del libro. Ringrazio anche Aline Duriez-Jablonka, direttrice delle edizioni Charles Léopold Mayer (ECLM) per aver seguito l’intero progetto e per la sua inesauribile pazienza quando qualche altro mio progetto collaborativo prendeva il temporaneo sopravvento. Il gentile ed erudito Olivier Petitjean di Ritimo, curatore del libro e traduttore della versione francese, ha offerto appropriati commenti che hanno resto il testo più stimolante, profondo e sottile. Olivier, è stato un piacere lavorare insieme pur in diversi contesti spazio-temporali. Vorrei inoltre ringraziare Karen Johnston, Charlie Cray, Ricardo Jomarron, Hervé Le Crosnier, John Richard e altri che, dopo aver letto attentamente il manoscritto, hanno suggerito utili miglioramenti al testo. Ovviamente la responsabilità per eventuali errori od omissioni è interamente del sottoscritto. Poiché ogni libro in realtà è parte di una conversazione continua, e non certo la parola finale, invito i lettori non soltanto a verificare affermazioni, omissioni e interpretazioni del testo dal loro punto d’osservazione privilegiato, ma anche a portare questa conversazione su altri piani che non ho avuto modo di affrontare. Il mondo dei beni comuni è davvero ampio e in continua espansione. – David Bollier, Amherst, Massachusetts, 2014 Indice Prefazione di Ugo Mattei ...................................................................... 3 Introduzione ......................................................................................... 8 La riscoperta dei beni comuni ......................................................... 16 Sfatare il mito della “tragedia” dei beni comuni ........................ 28 Le enclosure del mondo naturale ................................................... Breve storia del movimento delle enclosure in Inghilterra ........... Il fenomeno del land grabbing internazionale ............................... La privatizzazione dell’acqua.............................................................. Le corporation dell’alimentazione ................................................... 44 49 53 55 57 Le enclosure di spazi e infrastrutture urbane ............................... La recinzione delle infrastrutture pubbliche ................................... 62 66 Le enclosure della conoscenza e della cultura ............................... La commercializzazione dell’università e della ricerca scientifica ...................................................................... I costi insostenibili delle enclosure ..................................................... 72 80 85 La storia cancellata dei beni comuni .............................................. 87 Il ruolo della collaborazione nell’evoluzione umana .................... 89 L’impatto legale dimenticato dei beni comuni ............................... 93 Il diritto dei beni comuni sotto assedio ........................................... 100 L’impero della proprietà privata ...................................................... I diritti inalienabili dei commoner ................................................... La logica del diritto di proprietà secondo John Locke .................. Come va calcolata la ricchezza? ......................................................... I beni comuni come forma di governance pubblica ..................... 105 108 113 116 119 L’avvento dei beni comuni digitali .................................................. 121 Il software libero come apripista ....................................................... 124 La rivoluzione dell’open access .......................................................... 129 Le tante galassie dei beni comuni .................................................... I beni comuni di sussistenza............................................................... I beni comuni dei popoli indigeni .................................................... Beni comuni d’ambito sociale e civico ............................................. Attività economiche integrate nei beni comuni ............................. Beni comuni sotto tutela statale e beni comuni globali ............... 136 137 139 142 146 151 I beni comuni come nuovo modo di pensare e di vivere ........... La metafisica dei beni comuni ........................................................... I beni comuni come crogiuolo del localismo ................................. I beni comuni come nuovo modello di sviluppo........................... La necessità di un riavvicinamento tra Stato e beni comuni ....... 158 162 166 169 171 Il futuro dei beni comuni................................................................... 179 I quattro capisaldi dei beni comuni .................................................. 185 I beni comuni come dono e obbligo morale................................... 186 Breve vademecum dei beni comuni ................................................ 187 Logica dei beni comuni e del mercato a confronto ..................... 190 Bibliografia ragionata e siti web utili.............................................. 193 ereticaTTS P E C I A L E S T A M P A direttore editoriale A L T E R N A T I V A MARCELLO BARAGHINI CONTRO IL COMUNE SENSO DEL PUDORE, CONTRO LA MORALE CODIFICA TA, CONTROCORRENTE. QUESTA COLLANA VUOLE ABBATTERE I MURI EDITORIALI CHE ANCORA SEPARANO E NASCONDONO COLORO CHE NON HANNO VOCE. SIANO I MURI DI UN CARCERE O QUELLI, ANCORA PIÙ I NVALICABILI E RESISTENTI, DELLA VERGOGNA E DEL CONFORMISMO. Visita il “Fronte della Comunicazione” di Stampa Alternativa, il nostro blog per discussioni e interventi collettivi: www.stampalternativa.it/wordpress “Libera Cultura”: la collana online che raccoglie i libri storici e le novità di Stampa Alternativa, liberamente diffusi sotto le licenze Creative Commons: www.stampalternativa.it/liberacultura DAVID BOLLIER LA RINASCITA DEI COMMONS Traduzione di Bernardo Parrella Titolo Originale: La Renaissance des communs © 2014 Éditions Charles Léopold Mayer, Paris Per l’edizione italiana © 2015 David Bollier © 2015 Stampa Alternativa Banda Aperta s.r.l. Strada Tuscanese km 4,800 01100 – Viterbo [email protected] www.stampalternativa.it progetto grafico ANYONE! I EDIZIONE: GIUGNO 2015 ISBN 978-88-6222-471-0 Finito di stampare nel mese di maggio 2015 da PDE Promozione srl (per conto di Banda Aperta s.r .l.) presso lo stabilimento di Legodigit srl – Lavis (TN) Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 3.0 Italia. Si veda https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/ 209
Scaricare