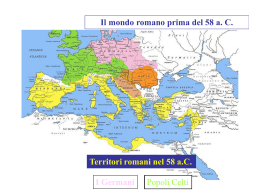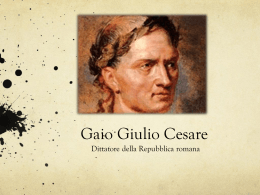www.timeoutintensiva.it, N° 19, Racconti a Margine, Dicembre 2011 “Cesare Mongolo” racconto di S. Vasta « Quando ero piccolo, potevo avere 7 o 8 anni, vivevo in un condominio con un grande atrio interno, sul quale si affacciavano quasi tutte le finestre delle cucine di ogni casa. Veniva usato dalle famiglie come un posto sicuro dove tenere a giocare i figli, specie i più piccoli, dato che l’unico accesso all’atrio era permesso da una grande cancellata che veniva chiusa alle nostre spalle dal portiere, un cerbero che ci controllava come un secondino. Invece di tenerci in casa, i nostri genitori avevano la fortuna d’avere uno grandissimo box interno al palazzo. Un grande box di cemento, diverso dai box in legno per bambini da tenere a casa, ma con funzioni simili, cioè metterci in uno scatolo da cui era impossibile scappare. Così venivamo controllati sia dalle madri che ogni tanto si affacciavano a guardarci sia dal signor Nicola, il cerbero. Quell’atrio era per me una cosa viva; vi si svolgeva gran parte della mia vita lì dentro. Gli amici, i primi giochi, le prime botte, i primi calci al pallone. La signora del quarto piano che cantava in continuazione arie d’opera steccando tutte le note più alte, mia madre che si scambiava vivande dalla finestra tramite un sistema ingegnoso di saliscendi con la sorella che abitava 2 piani sotto; le sorelle Marchese, che urlavano in continuazione contro i mariti, rintanati da Ambra “la rossa”, una che faceva la vita. A volte il condominio le si rivoltava contro per il discreto quanto “amorale” via vai notturno. Ma Ambra prestava anche soldi, e cacciarla sarebbe equivalso per i condomini stessi a pagarle tutte le cambiali sull’unghia. Avanzava soldi da tutto il palazzo, e non li dava ad usura. Tranne un piccolo interesse non ci guadagnava altro. Era anche il monte di pietà del quartiere. L’altro motivo per cui Ambra era tollerata, era il suo essere per gli uomini del vicinato, un motivo di svago dato che per “simpatia condominiale” ai vicini forniva prestazioni rare ma gratuite. “Omaggi segreti” li chiamava. Ed in questo era riservatissima. Omaggi fatti perché fossero gentili col suo Cesare, il figlio mongolo. Sì, Cesare era un ragazzo mongoloide grande e grosso, con gravi difficoltà della parola tanto che molti stati d’animo, la gioia o la rabbia, li esprimeva 1 con suoni gutturali che spesso spaventavano i bambini ed i ragazzi che giocavano. Sapeva essere molto dolce e gentile, ma d’improvviso per un nonnulla diveniva irascibile e violento. Era gli estremi del carattere espressi senza mediazioni, impulsivamente. Quella montagna dai pantaloni corti, vicino la quale si era sempre in ombra, le volte che scendeva nella “gabbia dei leoni” come veniva chiamato l’atrio, stava a girare lungo i muri, sempre attaccato alla cornetta di un telefono tutto rotto che aveva trovato chissà dove. In quella cornetta pezzi pezzi faceva lunghissime discussioni per ore percorrendo e ripercorrendo il perimetro dell’atrio, e tutto filava liscio. Poi, come sempre, qualcuno lo insultava, o lui per curiosità strappava di mano ai ragazzi qualcosa che l’aveva colpito, figurine, soldatini di piombo, catenine, giornaletti. Ed iniziavano le botte. Ma lui ne dava raramente. Non prendeva mai nulla per rubarlo, ma solo per curiosità, tanto che stava lì fermo a rigirare l’oggetto conquistato tra le mani a chiedersi che fosse, mentre il legittimo proprietario tentava di farsi valere con calci urla e pugni a quella massa informe dagli occhi piccolissimi. Lui non ci faceva caso, li lasciava sfogare sul suo corpo, e poi glielo riconsegnava o se lo metteva in tasca e non c’era verso di farglielo ridare. Sino a quando non decideva lui. Era mal visto comunque un pò da tutti, perché in qualche occasione, specie quando gli facevano la baia gridandogli “Arancina coi piedi”, perdeva il lume della ragione e chi gli capitava sotto lo massacrava letteralmente di botte. Con relativa protesta di tutti i genitori. Ambra allora gli urlava contro, scendeva a precipizio nell’atrio e lo picchiava con un cucchiaio di legno che, su quelle carni abbondanti, le si rompeva regolarmente, e, se il condominio cominciava a lamentarsi, ricordava ad ognuno i crediti dovuti abbuonando qualcosa alla famiglia “colpita” dal “suo” Cesare. Poi veniva la dolcezza, ma dopo giorni di mutismo e di lamenti, giorni in cui Cesare non scendeva. E li vedevi madre e figlio dondolarsi nel balcone sul dondolo di legno come due innamorati. Ma il problema presto si ripresentava, perché Cesare quando s’infuriava non conosceva il limite della sua forza né il limite della sofferenza altrui. Era questo il suo principale problema; nell’amore come nell’odio era estremo. Era capace di stritolarti in un abbraccio affettuoso o di strangolarti nella colluttazione pur senza in effetti volerti ammazzare, ma arrivava a stringerti il collo sino a farti perdere i sensi, sino a tramortirti. Così scorrevano le giornate. L’unico con cui Cesare andava d’accordo ero io perché diversamente da tutti, lui non mi faceva nessuna paura. Tanto che avevamo inventato un gioco tutto nostro. A volte, vedendomi distratto, per farmi spaventare mi si avvicinava quatto quatto da dietro cercando in tutti i modi di non farsi vedere. Ma quasi sempre prima di lui arrivava la sua ombra, quell’ombra che piano piano mi oscurava il cielo, e che me lo annunciava. Così lo fregavo sempre. Quando lo sentivo arrivare di soppiatto, mi eccitavo moltissimo e cominciavo a ridere in silenzio preparandomi a quel “BUUM” urlato alle mie spalle, che non mi faceva spaventare più di tanto, ma che dovevo dimostrare di temere facendo un improvviso saltello. E tutta questa euforia era perché aspettavo il “solletico” che le sue mani dopo il finto spavento mi facevano. Arrivavo a ridere a crepapelle sino all’apnea, al singhiozzo, alla fame d’aria. E lui, rideva pure sino a buttarsi a terra e a fare giravolte per la contentezza. Eravamo amici, anche se d’una amicizia senza parole. E tutto perché una volta avendogli 2 chissacchì regalato un gioco di costruzioni ad incastro avevo insieme a lui passato tanti pomeriggi a spiegargli, lui così maldestro con quelle mani troppo grandi, come poteva, incastrando i pezzi di legno, ottenere le figure del libretto di istruzione. Avevo 7 anni allora, e ricordo che quel bellissimo gioco occupò i miei ed i suoi pomeriggi per un’intera primavera. E fece di noi due amici inseparabili. Cesare non era affatto stupido come sembrava, anche se la sua intelligenza era come nascosta, misteriosa. Improvvisa come i suoi colpi di testa. Se ne stava a volte ad ascoltarmi in silenzio con quel suo sguardo istupidito, onomatopea del suo essere mongoloide, ma scoprivi che aveva afferrato tutto, anche le cose più complesse. Poi, quell’anno, venne l’estate, il caldo era torrido e nella “fossa dei leoni” ognuno di noi cercava quanta più ombra possibile. Ma anche così quasi non si resisteva, i giochi di movimento erano ridotti al minimo, e passavamo le giornate a parlare dell’ultima domenica che eravamo stati al mare, col pensiero alla successiva quando ci saremmo tornati. Allora le vacanze erano cose per ricchi. Per noi arrivavano ogni sette giorni. Gli altri sei erano fatti di gabbia e di caldo. Cesare data la mole era sempre sudatissimo e smanioso. Quando Nicola il portiere si assentava Cesare cominciava ad armeggiare col catenaccio del cancello, come se aprirlo potesse portare una ventata di aria pura. Di uscire non m’era passato mai neanche per l’anticamera del cervello. Era un desiderio rimosso. Accantonato come impossibile. Ed invece era proprio questo che l’ombra mongola voleva. Una mattina sentii i passi di Cesare arrivare da dietro mentre io per terra ero intento a contare i doppioni delle figurine. L’ombra mi sovrastò e lui dietro. Già mi aspettavo il solito gioco, il suo urlo, il mio finto spavento, il solletico, le mie risate, le sue capriole. Invece quell’ombra mi prese per mano e mi trascinò letteralmente alla cancellata. Eravamo soli, il cerbero era su che divideva la posta. “Cosimo... tu... tu guarda”, e fatto sparire quel vecchio catenaccio nella sua manona, come d’incanto, dopo uno strattone, si aprì. Quel gigante ottuso aveva come un mago reso in un attimo possibile la cosa più proibita, ciò che ognuno di noi ragazzi sognava, ma che neanche ci si diceva, date le punizioni che ne sarebbero venute. Poter uscire non visti era eccitante e pauroso ad un tempo, era mettere il naso nell’altro mondo, fuori dal nostro girone, e da soli; era trasgredire gli ordini impartiti avventurandosi come i grandi nel mondo poco conosciuto del quartiere, andare in esplorazione, curiosare. Io alla vista del catenaccio aperto mi ritrassi impaurito guardandomi d’intorno, ma Cesare mi trascinò dall’altra parte e richiuso il catenaccio non so come, ci ritrovammo presto a camminare per strada mano nella mano. Lui era il capitano della spedizione e dalla risolutezza con cui procedeva sembrava sapesse dove portarmi. Affidai la mia paura alla sua mano che teneva stretta la mia e piano piano quel guardarmi intorno impaurito lasciò il posto all’eccitazione della fuga. Ci mettemmo a correre urlando come forsennati, per scacciare la paura, per darci coraggio. Fu come spalancare delle tende su quella giornata di sole e aperta la finestra andare libero su d’un palcoscenico assolato, io che fino ad allora avevo sbirciato il mondo nascosto dietro il sipario plissettato della gonna di mia madre. Camminammo parecchio e rallentammo solo sul lungomare. Da quel momento tutto ci sembrò più facile. Affondando la lingua nel gelato comprato con i soldi che Cesare non so come aveva rimediato, ci scordammo di tutto. Quel cioccolato era 3 dolcissimo, ad ogni leccata i miei occhi si chiudevano su quel sapore come a non farne sfuggire nemmeno un soffio; finalmente potevo godermelo a testa alta e non tutto sbilanciato in avanti “se no ti gocciola sulla magliettina”, e finalmente anche i miei vestiti ne assaporarono l’essenza mentre glielo sgocciolavo sopra. All’ombra di Cesare tutto sembrava magico quel giorno, anche le persone che guardavano quella strana accoppiata, gigante scemo più bambino, trascinarsi felice quasi fossero i padroni del mondo. Così dopo un pò arrivammo a S. Erasmo, una chiesa prospiciente un moletto, dove andavano molti pescatori che cercavano di stare lontani dalla confusione, dato che erano molto pochi quelli che vi facevano il bagno. Il sole di quella giornata era come rendesse ai miei occhi tutto più bello, brillante. I pescatori con le loro lenze, dei ragazzi in fondo che facevano gare di tuffi, le barche al largo, il monte, il cielo azzurro... ci sono momenti che vorresti il tempo si fermasse, tanta é la felicità di sentirsi parte di un tutto così armonico. Poi ci furono delle urla, i ragazzi avevano visto Cesare e gli facevano la baia tirando anche manciate di pietrisco. Quando nella gabbia succedevano queste cose lui si imbufaliva e caricava il gruppo con tutta la sua mole. Erano botte da orbi. Ma quella volta con uno strattone ed un grugnito l’ombra mi trascinò lontano da loro, verso dei grandi blocchi frangi onda, e inseguiti dalle urla, cominciammo la scalata bruciandoci le mani sulle rocce arroventate. Cesare nei tratti peggiori mi faceva arrampicare sulle sue spalle così da facilitare e rendere più spedito il cammino. Appollaiato sulla sua schiena avevo il tempo di riposarmi e godermi il paesaggio dall’alto del gigante. E fu dopo uno di questi tratti che mi depositò su una piccola spianate in cemento prospiciente il mare, nascosta tra le rocce, ed abitata soltanto da un vecchietto seduto al bordo con i piedi in acqua ed intento a pescare con una canna lunghissima. Quando ci sentì arrivare si voltò e riparandosi gli occhi dal sole disse Ciao Cesare, come stai? E la mamma ? Forse era troppo affaccendata per accompagnarti? Per tutta risposta lui gli si avvicinò e vidi scomparire quell’esile figura nell’abbraccio che Cesare gli stava dando mormorandogli all’orecchio parole incomprensibili. Va bene Cesare, va bene... non così forte... anch’io ti voglio bene... anch’io... ed il tuo amico non me lo presenti? mi sentii sollevare da terra e fui depositato pochi metri più in là davanti due occhi acquosi dall’espressione molto mite, da cui si dipartivano rughe profonde che superati i confini di quel volto avvizzito dagli anni, si perdevano in una massa di capelli e barba bianchi. Lo ricordo bene come fosse adesso, potevi dargli qualsiasi età oltre il centinaio. Avevo davanti Matusalemme in carne ed ossa e non riuscivo a staccare gli occhi da quelle crepe aride. Guardandolo pensai che avesse pianto sempre. Come se per anni le lacrime avessero scavato quei solchi e poi fosse arrivata un’improvvisa siccità. Mi strinse la mano come fossi grande, Io mi chiamo Lucio... - disse-, e poi dopo una pausa riprese; “ed ho tanti anni più di te”... arrossii moltissimo del fatto che si fosse accorto del mio stupore, come se avesse letto i miei pensieri.. “Cosimo, piacere”, la mia voce uscì tremolante come un battito d’ali, e diedi uno strattone alla sua mano come mi aveva insegnato mio padre... ma la mia mano restò stretta alla sua e provai timore e rispetto per quell’uomo che mi scrutava, ed una strana sensazione di familiarità come se l’avessi sempre conosciuto... fu un attimo perché poi sentii afferrarmi il polso e provai dolore quando Cesare lo strattonò per sciogliere le 4 nostre mani da quell’abbraccio... ci divise... “Cesare, dai ! smetti di fare il geloso... sedetevi qui accanto tutti e due sù... e tu chiedi scusa al tuo amico... avanti...” con riluttanza il gigante si rimpossessò del mio polso e me lo baciò... come quando le madri baciano la bua dei bambini: “Così ti passa”? mi chiese. Ma io continuai per un pò a massaggiarmi il braccio, seduto di fronte al mare ma lontano da quel signore ad una distanza che Cesare reputò rassicurante, occupandone poi gran parte interponendosi con la sua mole tra noi.» « Eravamo però troppo irrequieti per stare seduti con i piedi in acqua a guardare il mare e non fare niente, per cui cominciammo a fare mulinelli, schizzi, la lotta coi piedi ritrovandoci tutti bagnati. Lucio aveva tentato di togliere a Cesare i panni umidi ma lui non ne aveva voluto sentire. Io ero invece rimasto in mutande. Il caldo era torrido, Cesare sudava come una fontana e si asciugava con il davanti della canottiera piccolissima verde militare, che indossava. Così mi alzai senza aspettarlo e mi avventurai su degli scogli affioranti qui e là, divertendomi a saltare dall’uno all’altro. Trovai ciò che cercavo alla fine, una piccola conca poco profonda dove potermi fare il bagno. Non sapevo ancora nuotare. Mi ci buttai quasi fosse il mare intero, il blu più profondo, e quando i miei piedi toccarono mi accorsi che poco di me restava a scaldarsi al sole. Era più profonda di quello che credevo. La testa usciva fuori a stento, ma i piedi erano ben saldi sul fondo. Stiedi lì in quell’oasi chiusa al mare, ma piena della sua freschezza a sguazzare e guardare il cielo dimentico di tutto, felice. Provai ad immergermi più volte, poi presi coraggio e con il naso chiuso dalla molletta delle dita, mi immersi ad occhi chiusi, un pò più a lungo. Quando emersi guardai il sole ma non c’era più, mi ritrovai all’ombra, al riparo del gigante che dall’alto, messo tra me ed il sole, mi guardava sguazzare. Solo quando fu in volo il suo urlo mi diede l’idea di ciò che sarebbe successo. Quella montagna di carne mi venne addosso per gioco sorridendo, inconsapevole che persa la presa dei miei piedi, per me quella pozzanghera era l'abisso. Mi venne addosso a gambe aperte in un tuffo, io mi infilai tra loro -non c’era modo di sfuggirgli- e affondai col suo peso sul torace sino a distendermi sul fondo. Come contraccolpo a quella botta sul petto, l’ossigeno sfuggì e le mie mille bolle risalendo ci avvolsero lasciandomi senza fiato, aprii la bocca ma l’aria che cercavo entrò liquida in gola, la sentii irritarmi e affogarmi il respiro, la voce non mi usciva, annaspai, le mie mani morsero i suoi cuscinetti, e non so dove trovai la forza per aggrapparmi a lui e, come fosse un ascensore, risalii con lui che riemergeva. Affiorai tossendo in mezzo all’uragano delle onde provocate dal suo tuffo, lo abbracciai forte al collo e quando si alzò fui trascinato in alto a tossirgli e sputargli sul petto. Restò lì in piedi con me appeso, convinto che giocassi, ma la mia faccia paonazza dovette dirgli cosa era realmente successo e quando svenni mi sentii afferrare dalle sue mani prima del buio. Mi svegliai a faccia in giù disteso sul cemento dove Lucio poco prima pescava. Proprio lui mi comprimeva le spalle ritmicamente massaggiandomele, e sentivo l’acqua perdersi in rivoli fuori dalla mia bocca. Mi sembrava di essere una bottiglia piena, spremuta a far uscire l’acqua. Tossivo. Sentivo anche sempre più distintamente delle voci... era Lucio che parlava con tono duro e preoccupato a qualcuno che pensai fossi io stesso, ma che poi capii essere 5 Cesare. Quante volte ti ho detto che devi stare più attento. Non puoi pensare solo a giocare... sì, ho capito, l’hai fatto per giocare con lui ma quasi l’annegavi... tu non ti rendi conto Cesare ma oggi hai fatto una cosa molto grave che poteva causare una tragedia... il tuo amico poteva morirci... e tu? Tu invece volevi solo giocare perché gli vuoi bene; ma l’amore può anche uccidere, se non si sa dosare. Sai se sapesse nuotare ? Non hai pensato che col tuo peso potevi schiacciarlo al fondo?... non so se mi capisci... forse capisci solo il cucchiaio di legno della mamma quando ti picchia... forse parlarti é inutile; ah ecco, si sta svegliando... ora lo giriamo...”. Cesare intanto piangeva... girava in tondo, si dava pugni in testa, si strappava i capelli. Poi mi girarono e lui si mise lì a sgocciolare lacrimoni e a farmi ombra... io tossivo, senza riuscire a smettere, ma dopo un pò mi sentii un pò meglio. Allora Lucio mi prese in braccio, mi distese a ridosso delle rocce, a riparo dal sole dandomi come cuscino le gambe di cesare che seduto lì con me, per un pezzo mi accarezzò i capelli guardandomi ed emettendo un lamento di dolore a bocca chiusa quasi continuo ma flebile a percepirsi, un lamento che accompagnava ogni carezza. Sentivo piano piano ritornarmi le forze, e quelle attenzioni allontanavano dai miei pensieri i momenti più brutti. Dopo un pò mi alzai, “Ti farebbe bene sciacquarti nell’acqua fresca e bassa”, mi disse Lucio proteggendosi gli occhi con la mano, e con un gran tuffo ecco Cesare con l’acqua alle ginocchia che mi invitava a raggiungerlo. “Io aiutare” mi disse e mentre mi faceva gocciolare dalla conca della sua mano l’acqua fredda sulla testa mi ripeté più volte “scusa Cosimo scusa ed abbassò lo sguardo mentre lo guardavo. E presto eravamo di nuovo lì a tirarci l’acqua e ridere come nulla fosse stato.>> Nota dell’Autore: Questo Racconto, di pura fantasia, è dedicato a tutti i disabili, che stanno attraversando grandi difficoltà, nel supporto alla loro disabilità, per il deficit di assistenza pubblica, di welfare, determinato dai tagli “imposti” dalla crisi economica. S.V. 6
Scarica