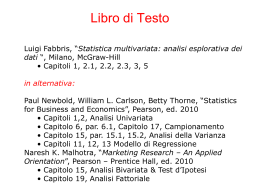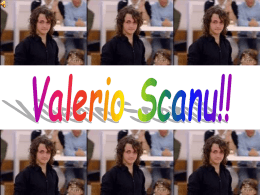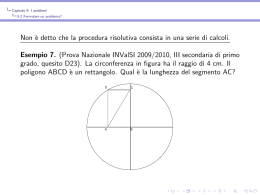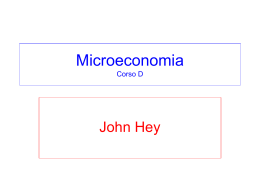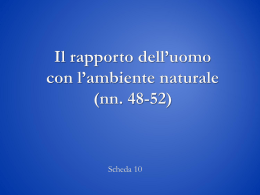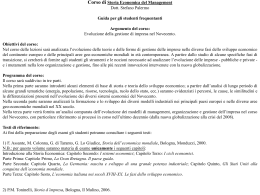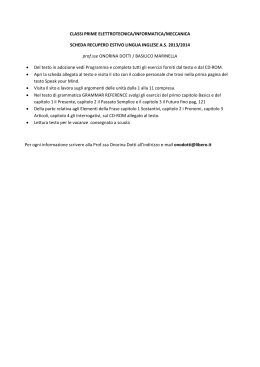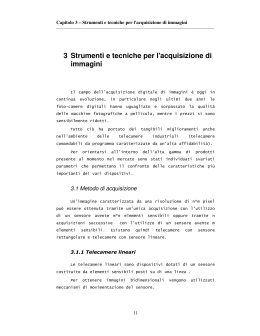LO SCRIGNO DI PROMETEO COLLANA DI DIDATTICA, DIVULGAZIONE E STORIA DELLA FISICA Direttore Ettore G Università degli Studi di Milano Piero Caldirola International Centre for the Promotion of Science Comitato scientifico Sigfrido B Università degli Studi di Pavia Giovanni F Università degli Studi di Ferrara Marco Alessandro Luigi G Università degli Studi di Milano LO SCRIGNO DI PROMETEO COLLANA DI DIDATTICA, DIVULGAZIONE E STORIA DELLA FISICA La conoscenza completa delle leggi fisiche è la meta più alta a cui possa aspirare un fisico, sia che essa abbia uno scopo puramente utilitario. . . sia che egli vi cerchi la soddisfazione di un profondo bisogno di sapere e la solida base per la sua intuizione della natura. Max P La Fisica ha come scopo capire il rapporto tra l’uomo e la natura, non solo da un punto di vista scientifico, ma anche filosofico, e ha cambiato in modo irreversibile la nostra vita tramite le sue ricadute tecnologiche. La spiegazione e la divulgazione dei concetti che stanno alla sua base, dati quasi per scontati, ma lungi dall’essere noti o compresi da molti, e l’evoluzione delle tecniche sperimentali, che hanno permesso di scoprire le leggi che regolano i fenomeni naturali e delle teorie via via elaborate, sono perciò argomenti di studio e riflessione di rilevanza primaria. Questa collana si rivolge a chi abbia desiderio di approfondire o discutere questi temi ed è aperta a chi voglia collaborarvi con contributi originali. Pier Raimondo Crippa La strana storia dei pigmenti neri Trent’anni di ricerche sulle melanine (–) Copyright © MMXV Aracne editrice int.le S.r.l. www.aracneeditrice.it [email protected] via Quarto Negroni, Ariccia (RM) () ---- I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell’Editore. I edizione: settembre A Giulia e al ricordo di Paola e Pietro Indice Introduzione Capitolo I Di cosa si parla Capitolo II Gli inizi Capitolo III I metodi fisici e la biofisica delle melanine Capitolo IV Gli anni Ottanta Capitolo V Verso la struttura secondaria Capitolo VI Ci si può arricchire con le melanine? Capitolo VII Compaiono sulla scena nuovi gruppi (ricchi e potenti) Capitolo VIII E intanto, alla periferia dell’impero Capitolo IX Storia e attualità delle neuromelanine Capitolo X Altre melanine con le quali la mia storia ha termine Indice Conclusioni Bibliografia Introduzione Quando ho cominciato a scrivere queste note sulla struttura delle melanine e sulla sua relazione con le loro funzioni, mi sono subito reso conto che se ne avessi fatto l’argomento di una trattazione scientifica rigorosa mi sarei trovato ad affrontare un compito quasi impossibile perché avrei dovuto approfondire argomenti che fanno parte di varie discipline, anche molto diverse dalla mia. Sebbene abbia fatto ricerche in questo campo per più di anni e mi ritenga perciò un esperto, non me la sono sentita di trattare con pretese di completezza un tema così vasto. Quello che vi apprestate a leggere non vuole perciò essere un “trattato” ed è anche lontanissima dai miei propositi l’idea di scrivere una rassegna scientifica, completa di commenti e riferimenti bibliografici, che descriva in profondità tutte le principali ricerche sull’argomento. Confesso che mi sarebbe piaciuto farlo, ma poi hanno prevalso in me due consapevolezze: la prima, di essere fondamentalmente pigro (e perciò sapevo che non sarei arrivato in fondo a un’impresa del genere) ed in secondo luogo avevo voglia di parlare anche un po’ di me stesso. Per spiegarmi meglio dirò che la nostra vita di ricercatori scientifici ha diversi motivi di interesse tra i quali metterei ai primi posti la facilità di incontri con persone stimolanti e la libertà di scelta riguardo a ciò che si fa o si vorrebbe fare. Se qualcuno leggerà queste mie note, spero si possa render conto che vicende apparentemente piccole come la partecipazione ai congressi, i seminari scientifici e la quotidiana vita universitaria in genere (per lo meno nell’epoca in cui io l’ho vissuta) comportano sì molto impegno, ma sono per loro natura capaci di dare anche profonde soddisfazioni. Il tono di questo libretto è perciò molto divulgativo sotto l’aspetto scientifico e colloquiale per quanto riguarda i fatti della mia vita. Spero che l’eventuale lettore mi perdoni, sorvolando sui miei giudizi e le mie scelte, quando mi riferisco a persone, se non li condivide, e non rimarcando troppo le omissioni che possono a volte essere involontarie, ma spesso sono invece frutto di una decisione personale, più o Introduzione meno inconscia. Soprattutto mi piacerebbe che non reagisca con un intollerante “Ma cosa mi importa dei fatti tuoi e dei tuoi viaggi!”. Ho introdotto invece queste aggiunte e queste digressioni perché credo siano necessarie a presentarmi meglio e a descrivere il mio carattere e il perché di alcune mie scelte. E poi, mi si creda, perché sentivo la necessità di ripensare a molte delle vicende che ho vissuto non solo per presentarle ad altri, ma soprattutto per me stesso, in qualche modo per rivivere le mie sensazioni ed emozioni, per esempio nell’incontro con i luoghi dove ho lavorato e con le persone con le quali ho condiviso qualcosa, sia essa lavoro o amicizia. Sono ben lontano dall’essere uno scrittore di professione ed al rileggere molto di quanto ho scritto mi accorgo degli squilibri tra le varie parti, delle discontinuità temporali o, peggio, concettuali e della pesantezza che alcune necessarie ripetizioni conferiscono al discorso che, sinceramente, avrei voluto risultasse leggero ed anche spiritoso, per lo meno per la parte autobiografica. Ma non sto scrivendo un’autobiografia, sto solo cercando di connettere il lavoro di ricerca che ho (abbiamo in tanti) fatto con alcune delle vicende che ho attraversato nella vita. Questo comporta che il discorso a volte si spezzi, perché un ragionamento scientifico richiama alla mente un episodio personale che è stato trascurato ed allora questo viene inserito troppo bruscamente, costituendo talvolta, me ne rendo conto, una sorta di iato o un vero salto logico. Di tutto ciò ovviamente mi scuso in anticipo e spero che tali difetti da scrittore dilettante non costituiscano un appesantimento del discorso ma che permettano invece (come mi è successo nello scrivere) di prendere un attimo di respiro in un contesto che altrimenti potrebbe apparire quantomeno monotono. Ho intitolato il tutto La strana storia dei pigmenti neri: mi sembra che il titolo richiami bene i legami che collegano con un unico filo i vari stadi delle ricerche nel loro susseguirsi temporale, ma con una successione non lineare, bensì complicata dai vari ripensamenti e da numerosi cambiamenti di prospettiva. Si parla di pigmenti neri perché questo è l’aggettivo quasi obbligatorio quando ci si riferisce alle melanine (anche se vedremo che esse non sono tutte, o del tutto, nere). Vi sono molte autobiografie di scienziati illustri, e meno illustri, i quali sono riusciti a far risaltare le loro conquiste scientifiche nel contesto di vite che sono state caratterizzate da eventi drammatici o vissute in periodi particolarmente difficili o in luoghi ricchi di sconvolgimenti Introduzione storici, come sono stati la guerra o le battaglie ideologiche per affermare le loro idee, in paesi dove gli eventi politici erano ad esse duramente avversi. Queste autobiografie di scienziati celebri sono numerose e spesso culminano nella gloria dei riconoscimenti ottenuti, in primo luogo il premio Nobel, ma anche la pletora degli altri premi, piccoli e grandi, conosciuti solo da ci si trova implicato. Oppure quando arrivano alla notorietà dei titoli dei giornali (in verità questo caso non è frequente perché ciò che riguarda la scienza non trova spazio nella stampa, a meno che non venga presentato come qualcosa che può influire, positivamente o negativamente, sulle nostre vite). Per contro, quello che vorrei emergesse da questi miei appunti è che la vita di un ricercatore mediamente serio, come io giudico benignamente me stesso, è ricca di soddisfazioni simili alle loro, o perlomeno comprende gli stessi dubbi, gli stessi slanci, gli stessi periodi di entusiasmo e di frustrazione: in poche parole mi farebbe piacere che un lettore, specie se giovane, si sentisse desideroso di percorrere una strada di questo tipo. Poi i risultati saranno di livello molto diverso da quelli ottenuti, che so io, dai vari premi Nobel (dei quali è facile reperire e leggere le autobiografie scientifiche), ma non per questo devono essere messi in secondo piano. Dopo tutto la fatica è stata probabilmente molto simile e le uniche differenza tra me e lui (non certamente differenze da poco, non voglio apparire immodesto!) sono un bel po’ di intuito in più, la tenacia e l’intelligenza. E perché no, un po’ di fortuna. Per scrivere la parte scientifica di queste mie note ho raccolto e riletto un centinaio di articoli che mi sono sembrati abbastanza importanti e che si prestavano meglio ad essere mescolati tra loro e riassunti. Grazie poi a Internet, ho cercato di spulciare le notizie e le curiosità che mi sembravano interessanti e pertanto degne di essere raccontate e commentate. Ma sono quasi certo che alcune di esse, magari importanti, mi sono sfuggite. L’argomento delle mie ricerche è stato il pigmento noto a tutti come melanina. Di questa sostanza, che si trova in natura in quasi tutti gli organismi viventi, si conosceva relativamente molto poco ai tempi in cui ho iniziato a studiarla, ed eravamo di conseguenza in pochi ad interessarcene. All’inizio, nella fase pionieristica, non avevamo le idee chiare né sulla sua struttura né sulla sua funzione, compresi a maggior ragione i “meccanismi” di questo funzionamento. L’unica cosa che si cominciava a conoscere era la composizione chimica bruta La strana storia dei pigmenti neri e le differenze tra i vari tipi di melanine, grazie ai lavori di coraggiosi e perseveranti chimici organici. Però c’erano alcune caratteristiche che spinsero alcuni fisici ad occuparsene: il suo conclamato ruolo di fotoprotettore (quindi la sua interazione diretta con la radiazione elettromagnetica) e l’insolita caratteristica di presentarsi come un solido insolubile in acqua, che è il solvente biologico per eccellenza. A poco a poco si cominciò a parlare di una sua struttura primaria, poi di una struttura secondaria ed in seguito, delle loro relazioni con il suo ruolo fisiologico. Da un altro punto di vista le ricerche in campo bio–medico e specificatamente in campo dermatologico ed oculistico ponevano sempre nuovi problemi da risolvere approfondendo sempre più l’aspetto molecolare. Di alcuni di questi problemi discuterò nel corso della narrazione e si vedrà come a poco a poco una sostanza diffusa ovunque e considerata di non primaria importanza è venuta ad acquistare un rilievo pari alle altre molecole più blasonate della biochimica e della fisiologia. Un particolare rilievo lo vorrei riservare alla neuromelanina che era una vecchia conoscenza dei neuroanatomisti ma la cui ipotetica funzione era basata su alcune deboli ipotesi che richiedevano una conferma che è venuta, ma solo in parte solo in tempi recenti. Molti biofisici ad un certo punto della loro vita se ne sono interessati con più o meno successo ed anch’io ho dedicato alcuni anni ad applicare quello che sapevo sulle melanine a questa sfuggente sostanza nel tentativo di chiarirne struttura, funzione e risvolti patologici. Intrecciate con questo avanzamento delle conoscenze sono le mie vicende personali le quali scorrono parallelamente nel tempo. In fondo, quando e perché mi sono messo in testa di occuparmi di melanine ed in che modo, e quali sono stati i risultati più interessanti che ho ottenuto? In tutti questi anni, quali altri interessi ho maturato e quali sono stati gli avanzamenti che ho giudicato più significativi? Ed è anche per questo motivo che ho inserito nel testo un certo numero di fotografie mie e di alcune persone con le quali sono venuto in contatto. Sono prevalentemente fotografie scattate ai tempi di cui parlo e che quindi raffigurano le persone come io le ho conosciute. Nel fare questo, confesso che non ho potuto evitare un senso profondo di nostalgia. Sono stati i miei tempi, i nostri tempi! Questo è quanto ho cercato di spiegare mettendolo per iscritto. Questo è quanto i miei eventuali lettori troveranno in questo libretto. Introduzione Figura . Miss Melanin: fu disegnata al computer da Cristiano Viappiani e per qualche anno fu rappresentata nell’angolo di tutti i nostri posters ai congressi Capitolo I Di cosa si parla Una prima conoscenza delle melanine della pelle e dell’occhio Da che punto cominciare questa storia, che vorrei raccontare a qualche collega ed amico disposto a leggermi, in un modo che essa appaia abbastanza scorrevole e che comprenda una buona parte di quello che ho visto e vissuto in un ampio arco della mia vita? I ricordi sono appiattiti dal tempo, ma tra di essi emergono, come picchi paragonabili ai tracciati di uno strumento analitico, momenti che si sono impressi nella mia mente lasciando tracce più significative. Farò così: partirò da uno di questi prendendolo come un marker e mi lascerò portare, avanti e indietro rispettando magari poco la cronologia, ma guidato dalla memoria (che però è un aiuto di cui non ci si può sempre e ciecamente fidare). Inizierò dall’arrivo a Washington nell’ottobre del con il breve trasferimento nel sobborgo di Georgetown in una calda giornata di sole. Ero con mia moglie Paola e provenivamo da New York in un viaggio che era anche di piacere e che includeva, tra altre mete, anche Houston e New Orleans. C’erano sopratutto ragioni di lavoro come motivazioni di quel viaggio: a Houston un contatto con il vecchio amico e collega John McGinness ed ora un seminario che dovevo tenere su invito del professor Vaclav Horak. Dietro a questi impegni, l’interesse comune che avevamo per le melanine. Comincio a scrivere questi “ricordi scientifici” mentre mi trovo nella casa della mia figlia Giulia, a São Paulo in Brasile, in giorni di maltempo nel gennaio , da poco collocato in pensione dalla mia università, l’università di Parma, nella quale ho insegnato e fatto ricerca per quasi quaranta anni. Amo molto leggere biografie e autobiografie ed ho da poco iniziato l’autobiografia di Eric Kandel, premio Nobel per la Biologia e Medicina per le sue scoperte nel campo della La strana storia dei pigmenti neri memoria. Suona abbastanza ironica questa coincidenza, dopo quanto ho detto sopra sui ricordi. È ovvio che, al suo confronto, trovo abbastanza esagerato dare forma di libro alla narrazione di un periodo entusiasmante e fruttuoso della mia vita professionale. Non sono affatto presuntuoso: non ho riconoscimenti ufficiali da raccontare, ma solo un certo numero di soddisfazioni molto personali, ma queste appartengono alla categoria dei sentimenti e come tali non sono facilmente esprimibili con parole. Mi ripeto: lo scopo di queste pagine, è limitato al desiderio di mettere in ordine i ricordi, che riguardano una forse piccola, ma significativa avventura del pensiero nella quale anch’io sono stato attore per oltre un trentennio e di ripercorrere, non solo cronologicamente, quanto ho potuto osservare vivendola “dall’interno”. Questo per mio piacere personale, ma anche perché la visione che posso avere ora delle correlazioni tra i vari campi di ricerca con i quali ho necessariamente dovuto interagire può essere utile a quanti si occupano oggi dello stesso problema ma non hanno ancora la curiosità e il tempo di approfondire i fondamenti storico–critici del loro lavoro (anche se non credo che qualcuno di loro avrà l’occasione e la pazienza di leggermi). La conferenza che avrei tenuto alla Georgetown University è una di queste piccole/grandi soddisfazioni ed è per questo che da essa inizierò il mio racconto. Non amo parlare in pubblico, specialmente in una lingua che non è la mia, e quando mi trovai davanti un’aula gremita del dipartimento di chimica, per un attimo mi chiesi cosa ci facessi lì, in quel luogo ed in quel momento. Il luogo era la sede delle ricerche di Vaclav Horak, il primo che avesse osato affrontare già nel il problema dello studio del comportamento elettrochimico (in parole povere, il problema del trasferimento di elettroni nei processi di ossidazione e di riduzione) in sostanze così complesse ed allora significativamente sconosciute come le melanine. Il momento invece mi era chiaro, perché ero stato proprio io ad aprire la strada delle misure fisiche su questi composti considerandoli come biomolecole che erano attive allo stato di aggregati solidi, dopo che McGinness le aveva descritte teoricamente come solidi amorfi. Detto in parole semplici, pensavamo che le melanine potessero essere fisiologicamente attive nelle cellule cutanee che le contenevano (ed in molte altre cellule di vari organi) nella forma di piccolissimi granuli ellissoidali (c.a., · , µm) e non . Di cosa si parla disperse o in soluzione, come nel caso di quasi tutte le altre molecole funzionali come, per fare un esempio, molti enzimi. La caratterizzazione delle macromolecole biologiche viene attuata tradizionalmente descrivendone la struttura primaria, secondaria, terziaria e così via (se si presentano delle “superstrutture”) come è stato fatto con successo nel caso delle proteine, del DNA e dei polisaccaridi. Per struttura primaria — il primo passo — i biochimici intendono la struttura chimica, ovvero la natura e la sequenza di molecole semplici che unite danno origine alla sostanza (spesso si usa dire: al biopolimero) come è, o dovrebbe essere, nel suo stato funzionale. Conoscere la struttura primaria consiste in altre parole nel conoscere i mattoni fondamentali costituenti la struttura complessa ed il modo con cui essi si uniscono. È evidente che a questo livello sia indispensabile l’apporto della chimica organica. Nel , Henry Stanley Raper individuò nella tirosina, un amino acido, il precursore che, in un processo nel quale un enzima che veniva estratto dalle piante, la tirosinasi, svolgeva in vitro un ruolo cruciale, conducendo alla formazione di due molecole chiave (ora chiamate DHI e DHICA, acronimi inglesi di diidrossiindolo e acido diidrossi–indol–carbossilico, la forma carbossilata del DHI, vedi la Fig. .). Figura .. I monomeri fondamentali nella costruzione dell’eumelanina (DHI e DHICA) e le loro forme redox. DHI è indicato anche come idrochinone (HQ) e su di esso sono mostrati i possibili punti di attacco. La struttura semichinonica (SQ) è un radicale libero. L’esistenza di tutte queste forme redox non è del tutto certa nel caso del DHICA
Scarica