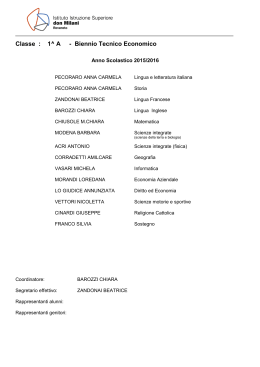1. INTRODUZIONE Diego Cescotti LE RAPPRESENTAZIONI OPERISTICHE DI ZANDONAI A ROMA ATTRAVERSO LA STAMPA PERIODICA La fortuna romana di Zandonai Le prime apparizioni pubbliche di Riccardo Zandonai vennero accolte negli ambienti musicali italiani con vivaci reazioni di curiosità e d’interesse. Il mondo dell’opera, rimasto da poco orfano di Verdi, viveva nell’attesa quasi messianica di un ingegno di nuova generazione che ambisse a raccogliere l’eredità nativa per condurla verso un necessario rinnovamento di forme e di stili, superando anche l’esperienza verista i cui maestri storici mostravano ormai di aver esaurito gran parte della loro carica originaria, primo fra tutti Pietro Mascagni, già avviato per la sua stessa problematica longevità creativa a diventare l’epigono di se stesso. Dal canto suo Giacomo Puccini, dopo il successo internazionale di Fanciulla del West, affrontava il suo ultimo decennio produttivo che non sarebbe stato privo nemmeno esso di momenti tormentosi. In una tale situazione la spavalda entrata in scena del giovane maestro roveretano alimentò in molti l’impressione che il comune auspicio potesse finalmente realizzarsi. Serio, modesto anche fisicamente, con addosso quel tanto di onesta rudezza che gli derivava dalle origini montanare ma senza per questo essere minimamente frenato da timidezza o soggezione; forte anzi della fama conquistatasi nella classe pesarese di Mascagni nonché dell’apertura di credito ottenuta dalla maggiore casa editrice musicale italiana, Zandonai venne a trovarsi nelle giuste condizioni per diventare in breve l’enfant-gâté dell’intellettualità dei salotti e dei foyer; caricato per di più della qualifica di artista ‘irredento’, che non fu irrilevante, per il tipo di ricaduta, nell’azione di costruzione sociale del suo personaggio. Tito Ricordi, con il pragmatismo dell’uomo di mondo che sa fiutare le buone occasioni, aveva ritenuto di interpretare i sentimenti modernisti che percorrevano la parte più viva dell’intellighenzia nazionale puntando decisamente su di lui, nella sicura intuizione che le condizioni per raccogliere la sfida gli si presentavano in quel momento particolarmente favorevoli. Così, in quegli anni Dieci di attesa e di svolta, la fortuna di Zandonai operista poté dirsi iniziata con tutti i crismi ed avviata a consolidarsi nel tempo; anzi un’accorta amministrazione dei propri talenti gli permetterà di godere di una certa rendita di sicurezza anche nei più difficili anni Venti, quando non basterà ad impensierirlo il Nerone di Boito, evento abnorme e super-pubblicizzato ma giunto fuori tempo massimo, e nemmeno la geniale ma postuma Turandot. Tolto il pur importante precedente del Grillo del focolare (Torino, 1908), l’avventura zandonaiana prese decisamente l’aere con l’opera Conchita (Milano, 1911), la quale metteva in luce come propria dotazione originaria tali qualità di slancio, buona salute e spregiudicatezza da valere al suo autore un’accettazione niente affatto convenzionale o settoriale. E tuttavia, per le ragioni imponderabili che regolano e condizionano le fortune dell’arte, sarà in modi e forme piuttosto disomogenee e diversificate da luogo a luogo che i favori del pubblico si articoleranno nel prosieguo, atteggiandosi ad esempio a una costante mistura di cautela e freddezza preconcetta nel caso dell’ambiente milanese della Scala; mentre al contrario gli arriverà dalle platee meridionali un riscontro di calore umano straordinario, quasi per una ragione di consentaneità istintiva. Inoltre Zandonai, che si rifiuterà quasi sempre all’esposizione sui palcoscenici internazionali, intuirà le possibilità offerte dalle sedi provinciali sparse per il Paese, comprese quelle marginali e periferiche, che coltiverà con particolare cura ottenendone risposte buone quando non entusiastiche. Il caso romano, che qui viene indagato nello specifico, assume in questo panorama un ruolo di importanza fondamentale, non solo per l’ovvio prestigio della piazza, ma anche perché l’ampia scelta di titoli rappresentati su quelle scene e il largo numero di anni in cui vi persistette il richiamo della sua musica consentono, più che per gli altri luoghi, di ricavare dati utili a definire la storia e la qualità 1/1 / della ricezione zandonaiana nel corso del tempo. Per questo, le recite al Teatro della capitale meritano tutta l’attenzione dello studioso. A prestar fede al puro dato cronachistico, tutte le opere di Zandonai conobbero al momento della loro comparsa romana un esito di pubblico quantomeno positivo: e questo è già un risultato tutt’altro che scontato, se è vero che a quei tempi si usava ancora decretare dei fiaschi a teatro, specie all’indirizzo delle opere nuove. Volendo poi andare più a fondo nella valutazione del dato, si apprende che la comparsa o ricomparsa sulle scene di quei lavori non avvenne mai senza suscitare una certa animazione, a testimonianza di una validità loro generalmente riconosciuta quali oggetti che imponevano ogni volta l’apertura di una discussione e prefiguravano una dinamica evolutiva di assimilazione e di gradimento. Ovviamente, se sul pubblico il potere di suggestione di quelle opere si realizzò più o meno costantemente ad ogni loro apparizione, sul fronte della critica competente la facoltà di manifestare riserve e dubbi era esercitata più a ragion veduta, ma – sembra – senza intenti pregiudizialmente denigratorî, e anzi con un atteggiamento complessivo che potrebbe dirsi di sostanziale benevolenza, come più oltre si vedrà. La copertura informativa e di commento poteva dirsi sicuramente adeguata: essa si concentrava soprattutto nelle cronache delle ‘prime’, dove passione e polemica s’intrecciavano in abbondanza di impressioni tra accese prese di posizione, rilievi puntigliosi, interpretazioni ispirate e ipotesi spericolate, definendo un quadro multiforme e spesso abbastanza contraddittorio dal punto di vista documentaristico ed estetico. Era poi a partire dal secondo giudizio, normalmente più posato, che si delineavano meglio le sfumature di apprezzamento e si fissavano le graduatorie di gusto: e così nella consuetudine delle repliche avveniva che i giudizi si consolidassero in senso positivo e si facessero più convinti; che ad una prima lettura un po’ rigida nell’analisi seguisse una visione più serena e globale; che alla considerazione estetica del dettaglio di stile tenesse dietro un ragionare sulla sostanza dell’opera nel suo insieme, sulla sua resa in palcoscenico, sull’efficacia o meno della soluzione drammaturgica adottata. Sarà poi alla lunga distanza che si registrerà un’effettiva scrematura fra un titolo e l’altro1, indice di contingenze svariate ma anzitutto di un riconoscimento di valore diversificato maturatosi via via, come lo stesso computo delle riprese rende evidente: Francesca da Rimini avrà altri 10 allestimenti dopo il primo, Giulietta e Romeo 5, Conchita, I Cavalieri di Ekebù e La farsa amorosa 2, mentre per Melenis, La via della finestra e Giuliano non si presenteranno occasioni ulteriori2. Il declino della fortuna zandonaiana, ben avvertibile negli anni Trenta, è cosa di cui bisogna oggettivamente prendere atto e cercare di motivare, al di là della constatazione ovvia del cambiamento graduale nei gusti e nelle mode, che sono dati altrettanto provati ma funzionanti con ritmo di accelerazione diverso da autore ad autore. La prima responsabilità potrebbe attribuirsi a una certa stanchezza e disaffezione da parte dell’autore nei confronti di un mondo teatrale sottoposto a politiche incerte e sostanzialmente penalizzanti, il che produsse come risultato indotto un effettivo appannamento ispirativo nella sua musa, con relativa minore lucidità nella precisazione degli intenti estetici e ritardata capacità di rinnovare il proprio armamentario linguistico: in questo senso le frequenti espressioni di «nausea» e «disgusto» verso il teatro lirico che le lettere private del maestro reiterano proprio in questi anni, sembrano testimoniarlo senza equivoci3. Il dissolvimento nel tempo dei titoli più deboli vede pertanto il concorso di fattori complessi, non meno psicosociologici che estetici, e non sempre facilmente deducibili dalla lettura progressiva dei reperti giornalistici. Nei tempi più recenti si può anche ipotizzare che sia valsa per Zandonai quella legge un po’ crudele secondo la quale è concesso difficilmente a un’opera che non sia un grande e indiscusso capolavoro di sopravvivere intatta alla scomparsa del suo artefice: talché quei prodotti usciti dalla sua onesta bottega artigiana, una volta venuta a mancare la presenza carismatica e il vitalismo animatore del loro creatore, si sono visti privati all’improvviso del sostentamento, 1 Per questi problemi e per un quadro generale delle rappresentazioni zandonaiane a Roma e altrove, cfr. Diego Cescotti, Analisi di una fortuna artistica: il caso di Riccardo Zandonai, Atti dell’Accademia roveretana degli Agiati, vol. I, A, 1992, pp. 67-86. 2 Forse può valere, nella considerazione della fortuna diversificata tra opera e opera, anche il conteggio delle repliche complessive, così come si ricavano dai documenti del tempo (cfr. più oltre le Locandine). Da queste si apprende che Francesca da Rimini ha avuto 68 repliche, Giulietta e Romeo 27, I Cavalieri di Ekebù 13, Conchita e La Farsa amorosa 11, Melenis, La Via della finestra e Giuliano 3 Si vedano ad es. gli articoli di Rossellini, qui ai nn. 272 e 471. In uno sfogo epistolare di Zandonai a D’Atri (22.41935) il musicista esprime molto chiaramente il suo stato d’animo al riguardo, minacciando perfino un suo ritiro dalle scene operistiche. 1/2 / precipitando automaticamente nel grigiore della routine stagionale, che li ha drasticamente selezionati, riproposti in modo sempre più stanco e con criteri anche qualitativamente scarsi, nonché recensiti spesso dalla stampa con noncurante sciatteria o malcelata supponenza. Seguendo le realizzazioni del secondo dopoguerra si è così assaliti dal sospetto che il diminuito favore critico sia da addebitarsi il più delle volte ad allestimenti scadenti e ad insufficiente fiducia da parte degli operatori culturali coinvolti nell’impresa, e che dunque, più che di corso ondivago delle fortune sia da parlare, per quei lavori, di mutate condizioni per il loro giusto accoglimento, essendo mancati loro non solo dei buoni cast vocali ma anche una messa in scena moderna e spregiudicata che li sapesse rimeditare dal profondo. Il corpus degli articoli romani conferma il dato che già si suggeriva all’inizio: gli anni migliori per l’immagine pubblica di Zandonai furono quelli della prima affermazione, quando la carica di energia positiva e di originalità ideativa di cui egli era portatore apparve in grado di sbaragliare ogni possibile rivale e di far sì che la sua scalata al successo fosse condotta su toni esaltanti: da ciò deriva il particolare fervore documentato in ambito critico negli anni Dieci – quelli in cui il maestro roveretano produsse a raffica Conchita, Melenis, Francesca da Rimini e La via della finestra, quanto a dire un terzo e più della sua intera produzione teatrale. L’ideale del giovane Zandonai si volgeva a un prodotto di compromesso fra la tradizione del melodramma nazionale, di cui cercava di conservare per quanto possibile la funzione del canto quale tramite privilegiato del sentimento espanso, e un innesto di modernità di marca europea, esplicantesi soprattutto in una concezione armonico-timbrica adeguata alle nuove sensibilità d’oltralpe, e in sostanza mirando dichiaratamente a sposare le ragioni comunicative dell’espressione aperta con le categorie più rischiose del ‘difficile’ e dell’‘aristocratico’. Sta qui, nella sintesi di questi elementi contrastanti, la croce di tutto il discorso valutativo sulla drammaturgia zandonaiana quale esce dai vari fogli d’epoca, sottoposta, come appare, alle forche caudine di un unico fondamentale quesito: come e fino a che punto il musicista si colloca nella secolare tradizione nativa? Ovvero, come riesce egli a soddisfare le giuste esigenze di novità, modernità, audacia senza tradire quelle premesse? Non si tratta di domande retoriche, ché il valore di Zandonai come compositore è stato costantemente misurato sull’entità variabile del suo attaccamento al grande modello nazionale, ora incoraggiandolo ad affrancarsene, ora ammonendolo a non dimenticarsene per seguire il richiamo di sirene forestiere, secondo una contraddizione che è solo apparente: si tratta infatti di due modi diversi ma equivalenti di interpretare le qualità nazionali del moderno, fondate in entrambi i casi sulla condanna della attitudine ‘tedesca’ alla pura e fredda sperimentazione e nella parallela salvaguardia di quella spontaneità di canto da sempre rivendicata orgogliosamente come patrimonio nativo delle popolazioni latine. Ma intanto, proprio perché sottomessa a questa estetica ambigua, la scelta operativa zandonaiana di stare in equilibrio tra arditezza del lessico e chiarezza del messaggio non fu sempre felice e priva di malintesi, rivelandosi anzi elemento atto a riattizzare in versione aggiornata l’eterna diatriba fra classicisti e romantici circa le ragioni dell’intelletto e le ragioni del cuore, con tutto quel che ne consegue di stantìo e di pretestuoso. Non è nemmeno escluso che taluno attribuisse alle origini ‘austriache’ di Zandonai certa sua presunta difficoltà ad esplicare un vero talento cantabile. Di fatto era proprio il canto lirico ad essere entrato storicamente in crisi quale tramite del sentimento stilizzato, tanto più se forzato ad accompagnarsi a un sostegno strumentale che ormai rivendicava pienamente i propri diritti e si poneva quale fattore primario dello svecchiamento e aggiornamento linguistico da tutti auspicato. Quale giovane musicista di frontiera sensibile ai fermenti primo-novecenteschi, Zandonai non sfuggì al richiamo ‘tecnicistico’ della sontuosità sinfonica applicata all’opera, e fu anzi storicamente tra i primi in Italia a compiere il passo, giocando in questo ambito, e su livelli di assoluta eccellenza, le sue carte migliori. Si deve a Nicola D’Atri l’aver còlto subito la novità quando, con vera consapevolezza profetica, sostenne, proprio in riferimento a Zandonai, che «l’operista italiano dell’avvenire sarà anche sinfonista o non sarà»4. 4 Per la citazione completa, cfr. qui al n. 3. 1/3 / Senonché in Italia, nonostante le altissime prove pucciniane, il fenomeno non vedeva ancora pubblici completamente avvezzi a un tale passaggio e anzi, per quelle che erano ancora le convenzioni e le resistenze del melodramma di tradizione, la qualità sinfonistica, se troppo scaltrita, poteva disturbare per il rischio di esteriorizzarsi in pura decorazione. Torna alla mente l’aneddoto di Gustav Mahler che davanti a una Tosca austriaca di alcuni anni prima aveva esclamato con fastidio: «Al giorno d’oggi [1903] ogni scalzacane sa orchestrare in modo eccellente». Il pericolo che si paventava per i giovani operisti era quello di un’eccessiva fiducia, di un abuso di effetti per puro sfoggio, che facesse perdere di vista le ragioni del palcoscenico e rendesse troppo aspra la competizione fonica con lo strumentale ad ogni occasione di aumento della temperatura emotiva. Ma se questa era la realtà comune un po’ tutti i musicisti di quell’inizio di secolo, ciò non deve esimerci dal riflettere sull’eccezionalità del fenomeno-Zandonai e sul quel cliché di ‘mago dell’orchestra’ che accompagna stabilmente l’intero arco della sua parabola creativa quale vero nerbo del suo linguaggio elaborato, nonché unico elemento di stile in grado di mettere d’accordo, pur nelle diverse sfumature di apprezzamento, i critici di tutte le tendenze. Qualcuno, nel corso del tempo, avrà ad osservare che con una tale dotazione Zandonai avrebbe fatto bene a dedicarsi di più al genere sinfonico, senza cercare contaminazioni troppo azzardate con il campo dell’opera. Ciò che infatti venne spesso discusso fu il fatto che un uso spregiudicato, nel melodramma, di quel particolare ‘impressionismo’ sinfonico alla moda finiva per sconquassare l’assetto compositivo generale e modificare nel profondo i tradizionali rapporti ed equilibrii tra i piani strutturali, a cominciare da quel nervoso fraseggiare delle voci ridotto quasi a un disperdersi di frammenti caleidoscopici iterati ove si valorizzava più che mai il dettaglio significante e minuto, allusivo di una condizione umana non più organizzata in modo compiuto ma viceversa franta e ridotta in pulviscolo. Tutto ciò aveva poi immediate conseguenze sul piano della rappresentazione scenica, con lo spostamento della focalizzazione dal vivo dramma dei personaggi a tutto quanto costituisce sfondo, decorazione ambientale, esteriorità e contorno. Un illuminante articolo del 1920 tratto dal quindicinale «Musica»5 sembra interpretare la questione in termini di polemica antiwagneriana, quando afferma che «con la moderna trama orchestrale, tecnicamente abile e complicata, non è compatibile la melodia tradizionale», sì che è l’orchestra ora ad appropriarsi della condotta melodica, incessantemente variata e modulante, mentre «i vari personaggi [...] si rassomigliano tutti con le loro continue e spesso inespressive declamazioni canore appoggiate ad armonizzazioni e sonorità orchestrali più o meno efficaci ed appropriate». Altrove si stigmatizza ulteriormente il fatto che il nuovo trattamento ha l’effetto di privare le figure sceniche di quella necessità vitale che sola può impedire loro di tramutarsi in fantocci mossi da fili fin troppo visibili: cosa che, in una prospettiva novecentesca, cominciava ad essere perseguita come progetto e cifra distintiva (si ricordi a titolo di curiosità che Conchita è contemporanea a Petruska). Ma intanto, scegliendo di allinearsi come meglio poteva alle ineludibili tendenze di quel primo quindicennio del secolo, il nostro musicista si attirò le censure di chi, puntando su categorie estetiche ambigue quali la ‘verità’ dell’accento e la ‘sincerità’ dell’espressione, aveva trovato in artisti nobilmente conservatori come Ildebrando Pizzetti un riferimento più consono. Le accuse a Zandonai riguardavano il sospetto di artificiosità e di edonismo, sembrando la sua esibita destrezza nient’altro che un deprecabile cedimento verso il puro effetto vuoto di sostanza, tale da far sospettare l’esercitazione formale fine a se stessa, il manierismo di chi camuffa le proprie défaillances inventive sotto un cumulo di bellurie, l’attitudine rinunciataria di chi per incapacità o disinteresse non sa affrontare i nodi drammatici concreti e vitali. Nelle sue pagine meno felici, insomma, era come se Zandonai, attraverso l’escamotage tecnico, mimasse il dramma senza viverlo veramente; ne costruisse sapientemente il clima psicologico, l’atmosfera esterna, le condizioni e i presupposti, ma poi si arrestasse nel momento di configurarlo con accenti propri. Secondo questo punto di vista critico, la musica di Zandonai, autentica mimesi di una concezione esistenziale di crisi, assumeva su di sé le ragioni della sua disgregazione tramutando la vita in frenesia vitalistica, 5 Cfr. n. 178. 1/4 / sostituendo l’operosità ispirata in affastellamento laborioso, snobilitando l’eloquenza in vociferazione esasperata6. Per tentare di dare pieno senso alla problematicità della drammaturgia zandonaiana non si dovrebbe evadere il quesito sulla parte di responsabilità avuta dalla scelta dei libretti e dallo stesso atteggiamento accomodante tenuto in qualche caso dal maestro nei loro confronti. I libretti scritti per Zandonai palesano una indubbia ricerca di originalità ma, a detta di quei tali umanisti primonovecenteschi, le figure che li animano e che vorrebbero essere eccezionali spesso finiscono per essere solo eccentriche, cioè al postutto poco credibili. L’annoso problema della qualità etica ed estetica dei libretti zandonaiani e delle ragioni della loro congenialità o meno con il mondo immaginativo del compositore è uno di quelli che non si risolveranno mai, nonostante siano stati affrontati infinite volte anche ai suoi tempi, tanto che si può dire non vi sia una sola delle sue opere che non abbia incontrato qualche riserva da questo particolare punto di vista. Ciò che alla lettura dei soggetti si evidenzia è una certa diversità di proposte dall’uno all’altro, come per dar modo al compositore di misurarsi con situazioni varianti dal registro tragico al semiserio, dal realistico al fantastico e al mistico: e ciononostante bisogna riconoscere che nel passaggio al pentagramma non si segnalano poi differenze sostanziali in quanto quei testi formano, a livello concettualeimmaginativo e per trattamento musicale, un corpus nell’insieme piuttosto omogeneo e tale che le impronte digitali dell’autore, sia se applicate a una tragedia medievale o a un borghese vaudeville, risultino sempre chiaramente riconoscibili fin dal primo ascolto, non per indifferenza allo spirito del testo ma per una sorta di sobrio, coerente controllo delle proprie corde espressive che sembra voler omologare l’esperienza umana a una visione fondata sui canoni basilari dell’austerità e della nostalgia. Palesi analogie nel fraseggio di Paolo e in quello di Marzio (nel Bacio) parlano da sole. Osserviamo a tale proposito che la riconoscibilità del tratto zandonaiano è un altro dei punti fermi emersi dal repertorio critico qui esaminato, e vale come attestazione solidale della forza e originalità della sua personalità artistica, ma indubbiamente anche di una sua quale insita rocciosità. Per questo c’è da supporre che il pubblico destinatario di quelle opere avesse imparato ben presto a individuare nelle loro peculiarità i manierismi stilistici che concorrevano a delineare un linguaggio e uno stile divenuto inconfondibilmente ‘zandonaiano’, e che per ciò stesso risultasse difficile ed ozioso il volervi ricercare predecessori e imitatori7. Stante l’interesse pressante e massiccio della critica scritta per le opere del nostro autore, viene da chiedersi se e come questi abbia rispettato i dettami e i consigli in essa contenuti. A quanto è dato di constatare, il rapporto con la stampa, pur con le osservazioni anzidette, era piuttosto franco e non mancava di voci ‘di stimolo’ anche da parte dei critici amici, ma più sotto forma di osservazioni sulla sistemazione di dettagli che di messa in discussione della visione drammaturgica generale. Nei primi tempi l’accento laudatorio più elevato e autorevole gli venne da Nicola D’Atri, il consigliere e mentore più ascoltato, che per ragioni di prestigio personale aveva tutto da guadagnare dall’esaltazione del genio zandonaiano da lui stesso annunciato al mondo, e che, forte del potere di condizionamento goduto dall’alto della sua riconosciuta autorevolezza, diede il la a buona parte della critica romana. Nella costruzione pubblica del personaggio-Zandonai, e non solo a Roma, non si può infatti non scorgere l’abile e occulta regìa di D’Atri, egli stesso per qualche tempo critico musicale sulle pagine del «Giornale d’Italia» e già uomo politico in carriera, ma più 6 Ne La crisi musicale europea dello storico Giannotto Bastianelli, un testo del 1912 che costituì un punto di riferimento fondamentale per gran parte della critica di quei tempi, si legge (p. 11) un’osservazione che sembra adattarsi assai bene all’operatività del giovane Zandonai, laddove sostiene che lo «stato di coscienza» degli artisti decadenti (ovvero, per Bastianelli, tutti gli artisti del tempo senza eccezioni) «è l’atto d’una volontà che non si afferma più vitalmente, ma, in fondo, ha paura della vita e cerca quasi di attenuarne le responsabilità, o d’inazzurrarla con la malinconia nostalgica della stanchezza, o di arrossarla con le furie d’un vacuo stato orgiastico, posizioni tutte e due non spontanee, non pure, ma volute sistematicamente onde evitare il virile pericolo d’essere incalzati dal terribile enigma vitale». [citato dall’edizione Vallecchi, 1976]. 7 Nemmeno con Mascagni i commentatori hanno mai veramente riscontrato analogie che andassero al di là del gesto esteriore, come da tempo è assodato in sede critica e come lo stesso Zandonai ha peraltro sempre sostenuto. Quanto al confronto con Puccini, venne quasi sempre evitato (si veda però l’articolo n. 432, che contiene un tentativo postumo di accostamento tra i due musicisti), né se ne trovano rispetto a Respighi, Alfano o altri operisti coevi che in qualche modo vi si sarebbero potuti prestare. Forse ci si aspetterebbe più spesso di vedere la produzione ‘leggera’ di Zandonai messa a paragone con quella omologa di Ermanno Wolf-Ferrari, ma stranamente questo accostamento non viene mai tentato se non, in un tardo esempio, per riconoscere all’autore de Il Campiello un talento infinitamente superiore. Non è dunque nel confronto tra Zandonai e gli altri musicisti italiani del suo tempo che va cercato il meglio di questi articoli romani. 1/5 / in generale uomo di cultura e d’affari: una figura centralissima e influente del mondo culturale capitolino, con forti entrature in tutti i palazzi che contano. Instancabile nell’opera di convincimento, persuasione, apostolato, questa eccezionale figura di mecenate farà dell’affermazione del suo protegé lo scopo principale della vita, spendendosi in prima persona ogni volta si fosse reso necessario un suggerimento, una segnalazione, una raccomandazione, un’azione di propaganda o di sostegno. Anche per effetto di questa azione instancabile si venne a formare fin dalla prima ora all’interno della critica musicale romana, se non proprio un compatto fronte pro-Zandonai, certamente un allineamento favorevole accomunante tutte le maggiori firme, da Matteo Incagliati a Raffaello De Rensis, da Adriano Belli a Alberto Gasco, i quali, anche per autonome considerazioni di fede, stima e ammirazione, riversarono all’indirizzo del maestro trentino incoraggiamenti generosi, quando non addirittura alati peana, con ciò trasmettendo l’impressione che la culla della giovane scoperta di Casa Ricordi fosse accudita con amorosa sollecitudine da una folla di parche avide di capolavori. La posizione estetica avversa non fu altrettanto compatta, come risulta da talune posizioni soggettive o dalla linea di tendenza di talune testate, prime fra tutte «Il Popolo romano», «Il Tevere» e «Il Tempo». Proprio riguardo a queste ultime due si registra il caso più rilevante di netta e invincibile idiosincrasia da parte di Bruno Barilli, autore di una serie di stroncature alquanto forti e bizzarre contrassegnate da indubbio sfoggio di autocompiacimento lessicale e immaginifico. È curiosa la parabola critica di Barilli, allineatosi nel suo primo intervento al coro dell’esultanza generale per poi rimanere folgorato sulla via di Damasco di un’estetica oltranzista e diventare uno dei detrattori più feroci di Zandonai, complice forse un umanissimo senso di invidia – che l’esito non brillante dei propri cimenti compositivi aveva inasprito – nei confronti di un collega tanto acclamato8. L’eccentricità della critica barilliana si era peraltro manifestata a contrario già nella recensione alla prima romana di Francesca da Rimini, ove veniva definita «pagina magnifica» proprio quel discusso secondo atto che non piaceva quasi a nessuno. È ancora pienamente da meditare il fatto che la fortuna di Zandonai a Roma cominciasse a virare in senso negativo proprio a partire dagli anni Venti, con l’avvio di tutta una serie di avvenimenti capitali e tra loro intrecciati: l’approdo al periodo della maturità con la conseguente redifinizione di metodi e stili, la crescente dipendenza da Nicola D’Atri, il sopraggiungere del librettista Arturo Rossato e l’ipoteca da questi posta su tutti i successivi lavori, la svolta intrapresa con Giulietta e Romeo, nonché ovviamente l’avvento del fascismo con tutto ciò che ne conseguì anche riguardo alle politiche culturali e al ruolo della critica giornalistica. Il caso-Barilli lascia intravedere in filigrana, più che scorgere con chiarezza, una costruzione teorica tutta da centrare che tornerà sotterraneamente e un po’ misteriosamente in tempi più recenti, per lo più dopo la morte dell’autore, avente per oggetto i cosiddetti ‘nemici di Zandonai’, ovvero un largo settore di musicisti e critici ostili che gli avrebbero amareggiato la vita infierendo sistematicamente contro la sua opera. Il pensiero va a quei cenacoli modernisti sostanzialmente antimelodrammatici, che in linea con l’ortodossia razziale fascista auspicavano un rinnovamento radicale nel segno di ritrovati valori di semplicità, sobrietà e purezza d’intenti, traslati spesso dall’illustre fondaco delle forme preromantiche italiane, e guardavano quindi principalmente a compositori come Alfredo Casella o Gian Francesco Malipiero e al loro europeismo d’avanguardia come una salutare reazione a quelle che sembravano loro pure fumoserie ottocentesche. Non molto di queste polemiche si rende evidente negli interventi della stampa romana dove i pezzi negativi nei confronti dell’autore di Francesca, più che dettati da un progetto comune o riferiti a un movimento ben definito e organizzato di ‘nemici’, sembrano provenire da voci dissenzienti che si inseriscono com’è norma nel dibattito culturale, magari facendo pesare determinate pregiudiziali culturali o il potere d’influenza di un ruolo pubblico: potrebbe essere questo il caso di Roberto Forges8 Nel marzo 1924 Barilli aveva fatto rappresentare per la prima volta al Costanzi la sua opera Emiral, già premiata a un concorso governativo. Essa, a detta di Matteo Incagliati che ne riferisce sul «Giornale d’Italia», provocò reazioni violente da parte del pubblico schierato, sì che «la vasta sala del “Costanzi” [...] parve trasformarsi in una bolgia infernale». Sembra non si trattasse di un’opera mal fatta, ma piuttosto noiosa e monotona e soprattutto priva di espressività e di commozione. Stranamente il caustico notista si era rivelato tradizionalista in musica, capace magari di avviare un episodio interessante ma poi mancante del respiro e del gesto per svilupparlo a dovere. Un’opera, dunque, che al tradizionalista Incagliati risultò tutt’altro che animata da «spirito rivoluzionario o anarcoide», nella quale «tanto meno vi vaga o vi soffia dentro la scintilla del genio». 1/6 / Davanzati, altro severo censore dell’arte zandonaiana , che troviamo nel 1924, homo novus del regime, alla reggenza della segreteria generale dei Fasci di combattimento. Comunque sia, si può supporre che negli anni di Zandonai il partito ‘modernista’, pur altrimenti vivace, avesse attecchito meno negli ambienti operistici romani e che in ogni caso fosse tale da rappresentare per lui più un fastidio che un’insidia: per convincersene basterà ricondursi alle rovinose cadute presso il massimo teatro della Capitale delle opere avveniristiche di Malipiero, da Canossa (1914) alla Favola del figlio cambiato (1932). Contro ogni opinione corrente al riguardo, c’è da credere che Zandonai abbia tenuto moderatamente conto della critica in genere quando si trattò di rivedere alcune sue partiture ed operare qualche sfrondamento. Certo non poteva arrivare al punto di togliere completamente di mezzo l’atto della battaglia in Francesca, come più volte aveva consigliato il critico della «Tribuna»; ma in compenso si convinse a levare il secondo quadro del terzo atto dei Cavalieri di Ekebù che appariva pleonastico e non troppo ricco di interessi specifici. Anche la riduzione da tre a due atti della Via della finestra è da vedere come conseguenza di circostanziate critiche alla lunghezza del lavoro che avrebbe spento molta della verve necessaria a una commedia leggera. Non è comunque facile comprendere appieno la parte eventualmente avuta dai critici negli indirizzi estetici via via adottati: va da sé che questo era il campo privilegiato di Nicola D’Atri, influente mediatore in ogni materia che avesse a che fare con la costruzione di un’opera e presente in modo fin ossessivo attraverso un’azione tambureggiante su ogni tipo di dettaglio. Quanto poi a definire nei suoi portati gli effetti e la natura – tonificante o deleteria a seconda dei pareri – del suo intervento su Zandonai, specie nella scelta dei libretti da musicare e conseguentemente sulla gestione dei rapporti con Rossato, è materia più volte sollevata ma che abbisogna ancora di approfondimenti9. Forse si può ipotizzare un condizionamento più marcato della stampa in generale nel caso cruciale di Giulietta e Romeo, opera che rivela un’indubbia scelta di campo e che per la sua voluta impostazione più tradizionale (nel senso verdiano di ritorno all’antico) avrebbe dovuto, negli intendimenti, ovviare a certe accuse di tecnicismo dottrinario e di melodismo a corto respiro venutegli dalle prove precedenti. Altrettanto dicasi per il successivo approdo ai Cavalieri di Ekebù, inteso quale volontà di aprirsi a maggiori ampliamenti di prospettive dopo la scivolata nel nazionalpopolare che non gli era stata foriera di approvazioni incondizionate. A questo punto si può capire come sulle poetiche teatrali e sui problemi di drammaturgia le opinioni presenti nel nostro campione siano molte e differenziate; viceversa queste si fanno più solidali e meno equivoche nel riconoscimento della peculiare qualità della musica zandonaiana in sé: una musica che anche laddove si indirizza all’espressione della dolenzia malinconica ed estenuata conserva nel fondo un suo tratto stilistico impositivo denotante sana visione e mente limpida. Tolte le sezioni in declamato, punto dolente di tutta l’opera post-verdiana, si riconosce alla musica del maestro trentino di non annoiare; se mai mette a dura prova i nervi; può essere impegnativa e stancante, fin irritante per eccesso di sollecitazioni, di esasperazioni espressive, di accumuli sonori o per uso di tessiture vocali ipertese e iterazioni ritmiche ostinate, tuttavia è sempre generosa, impulsiva, alacre, palpitante, ritmicamente mobile, contrastata, efficacemente sintetica nel raggiungimento dei climax e degli effetti, gratificante nel soddisfacimento delle attese, abilissima nell’evocare un ‘ambiente’ geografico o psicologico e nel preparare una situazione emotiva, conseguente nel suo articolarsi e dipanarsi; e se talvolta l’inventiva si fa debole, essa per questo non cade mai nel volgare o si fa approssimativa, anzi è sovente raffinata e rifinita ma al contempo vòlta costantemente alla comunicazione. È più d’uno il caso, in questi resoconti, in cui si salva il musicista e si mette in discussione il drammaturgo, non perché gli si sia voluta negare la dote di abile uomo di teatro, ma perché sull’assetto formale della sua scrittura e sul pregevole artigianato orchestrale che lo affianca gli attacchi si sarebbero più facilmente spuntati. Il fenomeno, cui si accennava più sopra, del destino diversificato sofferto dalle opere del maestro prima e dopo la sua morte illumina un aspetto non secondario della sua fortuna, al di là di motivi estetici o culturali. Alludo all’incidenza del fattore umano e della simpatia personale, qui più volte 9 A questo potrà dar risposta l’amplissimo epistolario in dotazione alla Biblioteca Civica “Tartarotti” di Rovereto, di cui è stata compiuta recentemente la trascrizione integrale. 1/7 / testimoniata, che interveniva a supportare ogni nuovo impatto del maestro con l’ambiente romano, specie quando la sua presenza fisica in teatro coincideva con il lavoro di concertazione10. Il quesito sulle attitudini direttoriali zandonaiane, mancando ai posteri qualsiasi traccia sonora registrata, è destinato a rimanere irrisolto, né si sfugge al sospetto che a volte se ne sia riferito sui giornali con un pizzico di enfasi glorificatrice; cionondimeno le attestazioni di stima e di apprezzamento per la sua attività di concertatore sono troppe e troppo circostanziate perché le si possa revocare in dubbio. Il minimo che si può dire è che egli – caso non frequentissimo presso i compositori – era evidentemente in grado di valorizzare all’estremo le musiche sottoposte direttamente alle proprie cure. Vi sono qui almeno un paio di occasioni in cui l’osmosi tra autore-direttore e pubblico osannante si fa straordinariamente intensa, complice tutto il contorno festoso ed elegante del Santo Stefano romano: un’esperienza artistica e mondana a dir poco esaltante e capace di dare risonanza nazionale al protagonista della serata, proiettato alle massime vette dell’apprezzamento e della simpatia. 10 La fortuna di Zandonai direttore è indagata in Diego Cescotti, Zandonai e l’orchestra - L’attività direttoriale, Salò, “L’Oleandro”, 1995. 1/8 / L’opera a Roma ai tempi di Zandonai Per tradizione, il massimo teatro della Capitale riapriva ogni anno il 26 dicembre11 e questa prima occasione di ritrovo della saison invernale si risolveva in un autentico e ambìto rito mondano per élites vecchie e nuove, ansiose di sfoggiare ricchezze e sorrisi, spesso sotto lo sguardo austero e benevolo di qualche principe di casa Savoia. L’atmosfera non sarà sempre così fiabesca, dato che la conformazione di quell’aristocratico uditorio si modificherà via via nel corso degli anni inglobando un gran numero di parvenus provenienti – si fa notare con un’ombra d’ironia – dal settore commerciale, non più imbarazzato dagli alti costi dei biglietti. In ogni caso il Santo Stefano a Roma non mancò mai di esercitare il suo fascino, e per quel giorno almeno diventava l’argomento principale delle cronache giornalistiche cittadine. La carriera pubblica di Zandonai presso il teatro romano si apre nel 1912 nel corso della prima stagione regolare del Costanzi sotto la leggendaria gestione Carelli-Mocchi, che come tutte le leggende non è estranea a vicende avventurose. Si narra che il giorno della ‘prima’ di Elettra (l’opera-clou della stagione, che aveva a protagonista la stessa Emma Carelli, apprezzata cantante oltre che impresaria energica e capace) un incendio si sviluppò nei magazzini del teatro e fu lei stessa a prodigarsi coraggiosamente nello spegnimento, per salire poco dopo le scene ed affrontare il tour de force straussiano12. Un mese dopo andava in scena Conchita, novità della stagione, che si giovava di una norma in base alla quale la direzione artistica doveva impegnarsi a presentare ogni anno un’opera inedita di autore italiano. I cartelloni del tempo erano confezionati su titoli di sicuro richiamo, con un’attenzione particolare a Wagner che, come in tutti i teatri italiani, era ritenuto il più adatto ad inaugurare degnamente una stagione (nel 1911 Sigfrido, l’anno successivo la Walkiria). Un Parsifal nel ‘14 fece epoca per la mirabile esecuzione e per lo straordinario concorso di pubblico che affollò la sala in tutte e 22 le repliche. Il momentaneo ostracismo votato alla musica wagneriana nel corso della Grande Guerra priverà il pubblico di quei mistici riti13; ma in compenso gli permetterà di accostare lavori poco o punto noti di Massenet, Charpentier o Saint-Saëns che l’accordo italo-francese in funzione anti-tedesca aveva promosso. L’esatto contrario avverrà poi nell’epoca delle sanzioni. In questo contesto vide la luce la prima attesissima romana di Francesca da Rimini, data in due stagioni consecutive per complessive 12 recite. Ma il momento magico per quest’opera prediletta dal pubblico si ebbe nel Santo Stefano del 1921, quando essa fu chiamata ad inaugurare trionfalmente – e italianamente, come non si mancò di rilevare – la stagione sotto la guida dello stesso autore. Quattro anni dopo l’exploit si ripeterà, avendo dovuto sostituire all’ultimo momento un Don Carlos saltato che sembrava compromettere il buon inizio di stagione. Se paragonati agli odierni, i cartelloni di quegli anni ci appaiono straordinariamente ricchi e vari di proposte, in un susseguirsi pressoché ininterrotto di spettacoli lungo tutto l’arco dell’anno, tra stagione regolare d’inverno e quella definita ‘popolare’ in estate-autunno, più tutta una serie di recite straordinarie, balletti, concerti sinfonici e quant’altro. Nel 1919-20 la zandonaiana Via della finestra condivise lo status di novità assieme a L’uomo che ride di Arrigo Pedrollo e Mirra di Domenico Alaleona. Tornò, desideratissimo, Wagner con un Lohengrin replicato per 12 sere a teatro esaurito. La media si mantenne sui 18 lavori annui per la stagione regolare d’inverno fino al 1925-26, che fu l’ultima dell’era Carelli e del Teatro Costanzi in quanto tale, passato ora direttamente sotto lo Stato e sottoposto a profonde trasformazioni gestionali e produttive. Il Teatro Reale dell’Opera – questo il suo nuovo nome – è nel bene e nel male una emanazione della politica culturale del regime: strumento di consenso da un lato e laboratorio attivissimo dall’altro14. Si nota 11 Era questa una norma valida un po’ per tutti i teatri in Italia (vedi l’articolo di E. Checchi, al n. 500). L’anticipazione al 7 dicembre, giorno di S. Ambrogio, fu fissata per Milano a partire dal 1912; Roma ne seguirà l’esempio dalla stagione 1936-37. 12 Sulla figura di Emma Carelli, cfr. n. 502. Una visione assai meno mitologizzata della coppia Carelli-Mocchi e della loro gestione del Teatro Costanzi traspare da più di una lettera di Zandonai recentemente portata alla luce, dove ad es. si parla esplicitamente, per quella dirigenza, di «covo di briganti». 13 «Il corno di ‘Sigfrido’ non deve risuonare sotto il cielo latino durante la guerra», tuonava in prima pagina l’«Orfeo» del 3.12.1916 . 14 Si veda al n. 504 l’articolo di «Musica», dove viene presentato orgogliosamente al lettore il nuovo teatro dopo i lavori di ristrutturazione. 1/9 / subito una frenetica intensificazione dell’offerta, che però ha come conseguenza una notevole diminuzione delle repliche per ciascun titolo presentato, e ciò a danno dei lavori nuovi bisognosi di farsi conoscere. Sono comunque previsti per statuto almeno due spartiti inediti a stagione. Ben 25 sono le opere in cartellone nel 1929-30, e tra esse qualcuna meno scontata come il Guglielmo Tell e l’Arianna e Barbablù di Dukas, oltre a un Tristano e a un Trovatore con Lauri Volpi. L’ultima fatica di Zandonai, La Farsa amorosa, viene inserita come novità assoluta nel cartellone 1932-33 e recepita con un certo entusiasmo. In questa fase storica più populistica anche le voci prima meno favorevoli al maestro trentino si convinsero a riconoscere e celebrare la sua capacità di toccare il cuore del popolo e di divertirlo in modo semplice e immediato. Una svolta in senso nazionalistico è evidente a partire dal 1935, quando abbondano le opere nostrane, nuove e nuovissime. L’elenco di queste ultime per l’anno citato è significativo: Cirano di Bergerac (Alfano), Il dottor Oss (Brazelli), Notturno romantico (Pick-Mangiagalli), Il Dibuk (Rocca), Orseolo (Pizzetti), La Fiamma (Respighi), Mosè (Perosi), La Passione (Liuzzi), oltre ovviamente ai titoli di repertorio, italianissimi anch’essi: Iris, Adriana Lécouvreur, Andrea Chénier, Trittico, L’amore dei tre re (Montemezzi) e così via. Il massimo sforzo produttivo di quegli anni è probabilmente quello realizzato nella stagione 1937-38, con il record di 33 opere allestite, tra cui un’integrale dell’Anello del Nibelungo rappresentato in cinque giorni e una Donna senz’ombra presente Strauss. Appartiene in pieno allo spirito dei tempi l’apertura, nel 1937, dello spazio all’aperto alle Terme di Caracalla che inaugura il teatro per le masse e che fa il paio con la stagione sinfonica estiva alla Basilica di Massenzio. L’accentuata presenza tedesca è evidentemente in relazione all’intesa di ferro con la Germania di Hitler15, con tutta una serie di scambi culturali reciproci i quali permetteranno ai romani di assistere, tra l’altro, a prestigiosi allestimenti dell’Opera di Berlino (Fidelio, Il Ratto dal serraglio, Orfeo ed Euridice di Gluck i titoli più ghiotti); mentre i complessi del Reale ricambieranno con una stagione di opera italiana alla Deutsche Oper. Grande risalto viene dato in questi anni anche alle opere contemporanee di autori italiani con titoli come Arlecchino di Busoni, Volo di notte di Dallapiccola, Belfagor di Respighi, Coro di morti (“madrigale drammatico”) di Petrassi, cui si aggiungerà abbastanza sorprendentemente il Wozzeck di Alban Berg16. Passata la bufera bellica, inizia per il Teatro dell’Opera un periodo di decadenza nel quale rimarrà a lungo invischiato. Il momento in questione è meno documentato, forse perché oggettivamente meno ‘glorioso’ dal punto di vista produttivo e artistico, né vale ora impegnarsi in ricognizioni dettagliate visto l’interesse vieppiù scemante per l’oggetto specifico del presente studio. Nel contesto romano la parabola zandonaiana si definisce con notevole chiarezza: un’ascesa vigorosa negli anni Dieci, una buona tenuta nei Venti, l’avanzare di indubbi segni di crisi nei Trenta, la discesa nei Quaranta, inarrestabile fino ad oggi. Il riscontro pubblico avuto in quel primo ventennio che va da Conchita del 1912 a Farsa amorosa del 1933 si compendia in una successione di trionfi quali pochi musicisti italiani viventi potevano aspettarsi, ancorché sia necessario apporre un filtro critico particolare a tutti quei resoconti giornalistici che si occupano appunto dell’aspetto ricettivo. Sarebbe arduo, infatti, oltreché del tutto scorretto, dedurre l’entità del successo romano di ogni singola opera zandonaiana sulla sola scorta di un dato effimero e fuorviante quale quello degli applausi e delle chiamate alla ribalta, peraltro rese ineludibili dal loro essere eternate sulla stampa secondo una contabilità sempre minuziosissima quanto singolarmente approssimativa e discordante da giornale a giornale. Il che vale implicitamente a indicarne la totale inattendibilità, il consenso essendo manovrato in modo accertato da un’agguerrita claque stipata nelle gallerie che riusciva ad assicurare a una recita anche la cifra sbalorditiva di trenta e più chiamate complessive alla ribalta per autori e interpreti. Se nella presente rassegna sono stati conservati questi particolari piuttosto disdicevoli di contingenza comportamentale è stato solo per non togliere ai brani letterari una nota di colore forse opportuna, nonché per meditare sulla mistificazione che spesso si nasconde dietro la 15 Lo stesso dittatore presenzierà, nel ‘38, all’esecuzione del secondo atto di Lohengrin al Foro Mussolini. Per questa ricostruzione documentaria sono stati consultati i seguenti testi: Vittorio Frajese, Dal Costanzi all’Opera, Roma, Capitolium, 1977-78 e AA.VV., 50 anni del Teatro dell’Opera 1928-1978, Roma, Bestetti, 1979. 16 1/10 / proclamazione di un successo. Non sembra essere questo comunque il caso di Zandonai, dove il successo di pubblico ci sarebbe stato ugualmente, ma contenuto entro toni ed àmbiti più consoni. In fondo la sua musica, per quanto attraente potesse sembrare, doveva suonare piuttosto difficile al primo ascolto per gli orecchi dell’epoca e, salvo le eccezioni che pure vi sono, tale da non strappare ovazioni clamorose e impulsive, tantomeno a scena aperta. 1/11 / I lavori rappresentati Delle undici opere edite di Riccardo Zandonai, tre non videro mai la luce a Roma: Il Grillo del focolare, Una Partita e Il bacio, l’opera rimasta incompiuta. Il battesimo si ebbe con Conchita e fu un inizio davvero sfolgorante. Conchita è il prodotto insieme geniale e scaltro di un giovane talento inseritosi nell’agone con felice scelta dei tempi, quando più acuta era percepita la necessità di un’azione forte e originale che servisse a condurre il melodramma italiano entro il XX secolo. Nessuno, all’epoca, volle negare che Zandonai possedesse una personalità musicale di sicuro spicco per qualità di forza e per capacità di atti d’audacia: quelli, appunto, che nella fattispecie gli avevano consentito di passar sopra a un libretto scadente pur di piazzare un prodotto d’urto che avrebbe fatto parlare di sé. Perché non sembra esservi dubbio sul fatto che la scelta del soggetto erotico di Pierre Louÿs per il lancio in grande stile nei teatri italiani fosse un colpo pubblicitario assai abile date le sue ovvie potenzialità provocatorie, né che l’eventualità di un succès de scandale fosse stata messa nel conto dagli autori e, in primis, dallo stesso editore Ricordi. Opera di piglio deciso, di salda tecnica e di impatto scenico felicissimo, Conchita costituisce l’esempio migliore dello stile giovanile di Zandonai. Essa catturò immediatamente l’attenzione nonostante tutti gli scompensi, le intemperanze e le manchevolezze di esperienza che vennero prontamente messe in luce dalla stampa. Fu sottoposta al giudizio del pubblico romano nel marzo 1912, a cinque mesi dalla prima milanese al Dal Verme, per ritornarvi altre due volte, nel 1930 e nel 1940: e la cosa che più colpisce in queste riprese è che, nonostante il grande intervallo temporale che le separa, il favore critico non solo non scemi ma in qualche caso – anche per l’attenuarsi delle remore moralistiche – si mostri perfino più solido, al punto da indurre qualcuno a considerare questo frutto indiscutibilmente acerbo come il prodotto più valido di tutto l’orto zandonaiano: un’opera battistrada, insomma, che avrebbe dovuto servire da modello a una linea drammaturgica originale in direzione di sviluppi ‘altri’ rispetto a quelli effettivamente seguiti. Più d’uno, a posteriori, credette di dover lamentare l’abbandono di questa linea e lo stesso Zandonai, nel 1925, smentendo implicitamente l’affermazione di un critico secondo la quale la sua opera ‘andalusa’ non dimorava tra le sue preferite, ebbe a rammaricarsi della troppo scarsa attenzione riservatale dai teatri italiani17. A tutt’oggi lo spartito conserva nelle parti migliori quel carattere fresco e accattivante che gli aveva assicurato un posto di privilegio tra la produzione di allora; ma sicuramente, qualora ritrovasse la via delle scene, necessiterebbe di una regìa particolarmente intelligente e anticonformista che sapesse investire il dramma di una opportuna ironia, senza sottrarsi per altro verso alla evidenziazione del retrogusto peccaminoso che costituisce la spezia piccante del soggetto. Come si evince dalle recensioni giornalistiche del 1912, l’accoglimento dell’opera si divise tra il riconoscimento del suo puro valore musicale da un lato e la cautela di fronte a un intreccio ritenuto abborracciato e maldestro dall’altro: il che era anche un modo per deplorare la spensierata prodigalità con cui Zandonai aveva investito il proprio non comune talento in un’impresa guastata da tanti vizi d’origine. Alla riduzione librettistica di Vaucaire e Zangarini si rimproverava tra le altre cose di poggiare su una struttura generale debole e traballante, con situazioni sceniche mal calibrate: il tutto servito da una prosodia approssimativa e da un gergo triviale. Non sfuggono in effetti le proporzioni sghembe tra atto e atto e le situazioni che non evolvono, com’è il caso dei ben quattro duetti tra i protagonisti disseminati in ognuno degli atti. L’ambientazione andalusa garantisce un’esteriorità coloristica d’effetto, ma a differenza che in Carmen di Bizet – un testo inevitabilmente preso a termine di paragone – non riesce a diventare voce autentica del dramma. I peggiori difetti furono riscontrati nella delineazione dei personaggi, nessuno dei quali appariva mosso da pulsioni autentiche, tanto meno Mateo, imbarazzante e penoso nel suo ruolo di maturo e nevrastenico amoroso, così lontano da tutti i suoi omologhi tenorili del teatro d’opera. Già s’è visto come la perdita della vitalità e integrità della passione per far posto alle sue degenerazioni fosse uno dei prezzi da pagare al sentire dei tempi moderni. In questo, anche Conchita Pérez è molto distante 17 Cfr. n. 96. 1/12 / dalla sorella maggiore Carmen, a cui guarda con spirito di emulazione, essendo però meno coerente di lei nell’accettare la guida di un’aggressività esplicita che la preservi da involuzioni piccoloborghesi. C’è insomma in lei meno vitalismo nicciano e più propensione decadente al sogno e al richiamo della malinconia, come ben appare nel suo anelito alla «piccola casetta queta» che l’eroina di Merimée non avrebbe mai barattato con gli anfratti montuosi dei contrabbandieri. Di Carmen ella conserva il ruolo sociale di ammaliatrice, segnata come per una predestinazione dalla straordinaria avvenenza gitana che sa perfettamente sfruttare a suo vantaggio; ma per ragioni soprattutto di ipocrisia estetica da parte dei fruitori ciò non fu sufficiente a renderla simpatica, tutt’altro. Il soggetto pruriginoso de La femme et le pantin era già noto a molti sotto forma di dilettevole lettura privata; ma appunto una cosa era assaporare il piacere segreto e un po’ autocompiaciuto nel silenzio della propria biblioteca, altro vedere quello stesso soggetto affidato al più popolare e icastico dei generi di spettacolo, che inevitabilmente ne avrebbe esaltato ed esasperato la scabrosità originaria, con la sottile e aperta complicità della musica. Eppure proprio i tratti di ‘normalità’ perbenistica a cui si era voluto piegare il personaggio di Conchita furono i primi responsabili della sua perdita di mordente e di verosimiglianza. Ciò che presumibilmente gli ascoltatori dell’epoca non potevano tollerare era il suo istinto alla libertà di autogestione, il suo porsi come soggetto umano autonomo e responsabilizzato che non vuol dipendere da un maschio inteso come virtuale sfruttatore e padrone – salvo poi ‘redimersi’ in ultimo per il dovuto contentino alla morale corrente: un finale indubbiamente posticcio e un po’ farisaico che ha il solo scopo di ristabilire l’ordine e mandare a casa tutti tranquilli. È pur vero che la sottomissione viene ottenuta a prezzo di un ricorso notevole e già molto moderno al sado-maso con finale annullamento della personalità (Conchita: «...io son cosa tua...» /Mateo: «...Mia! Come una schiava...»), e che questo potrebbe aprire un’appendice piccante al consolatorio happy end: sta di fatto che l’amore, convenzionale elemento di riscatto per la figura femminile del teatro d’opera, è in Conchita così dubbio e capriccioso, così fragile e umorale, che nessuno in coscienza potrebbe garantire sulla sua serena prosecuzione in un ipotetico quinto atto. Il trapasso repentino dall’odio furibondo all’amore dichiarato nello spazio di poche battute costituisce una delle trovate più fragili dell’azione, in quanto svia la possibilità di un dénouement alla Carmen, verso cui sembrava irresistibilmente spingere. Se, com’è probabile, lo rinvia a più propizia occasione, il pubblico se ne deve disinteressare. È comprensibile che le inverosimiglianze psicologiche del plot non fossero atte ad appagare l’ascoltatore medio di quegli anni, né per altro verso – si presume – dovettero trovar consenso gli slogan da femminista ante-litteram («Io sono mia»; «Questa mia carne è mia, la dono a chi mi pare») con cui l’orgogliosa donna enunciava il proprio credo libertario. L’eroina melodrammatica – osservava ancora molti anni dopo un commentatore a proposito di un altro personaggio zandonaiano – deve avere la funzione «di purificare, guidare e sostenere con la femminile dolcezza e con spontanei sacrifici l’uomo amato» o, se sceglie la strada della ribellione, deve poi sottomettersi, proprio come Carmen, a una morte riparatrice. I critici della carta stampata – tutti ovviamente appartenenti al genere maschile – si incaricarono, quali portavoci autorizzati del sentire comune e quasi per un accordo preventivo, di vendicare la cattiva figura fatta da don Mateo Diaz impegnandosi in una gara di misoginia a base di aggettivazioni colorite, fino ad arrivare, nei casi estremi, ad esprimere un’autentica soddisfazione per quelle «sacrosante bastonate» che hanno il solo torto di giungere con due atti di ritardo, denunciando peraltro subito dopo l’indelicatezza di quello stesso eccesso di brutalità del quale non si conosceva l’uguale in tutto il teatro d’opera fino a quel momento, escluso forse l’odioso precedente di Golaud che si riduce all’abiezione di trascinare per i capelli l’incolpevole sposa lungo la sala del castello di Allemonde. I resoconti del 1912 testimoniano invece lo scarso effetto di shock ottenuto dalla realizzazione del quadro che, alla lettura del testo, parrebbe essere il più osé: quello del baile gaditano di García al secondo atto. È prescritto dal libretto che la donna si esibisca a pagamento in uno strip-tease piuttosto audace su ritmo di flamenco; ma quelle cronache ci informano che niente di tutto questo era stato reso esplicito in scena (delle altre produzioni non si sa), generando anzi nel prosieguo una soluzione abbastanza inverosimile. In sostanza la danseuse era vista comparire decorosamente vestita e probabilmente sobria nei movimenti di danza, ciò che non giustificava le escandescenze di 1/13 / Mateo sopraggiunto18. Non solo: alla musica di Zandonai si era obiettato di non essere qui abbastanza canagliesca, ovvero di non aver egli saputo cogliere il preciso suggerimento fornito dall’ambigua situazione. Da sempre accreditato come spirito sano, integro, diretto e forte – e in breve poco compromesso con le poetiche decadenti, – il musicista-montanaro si vide così confermato nel luogo comune. Da quanto esposto sin qui ci si spiega come sull’esito globale di quest’opera abbia pesato tutto un cumulo di considerazioni extra-artistiche da parte di un uditorio ancora poco avvezzo a simpatizzare con figure femminili vampiresche di cui pure il teatro musicale europeo del Novecento non aveva, né avrebbe negli anni successivi, fatto mancare esempi significativi e clamorosi. Una cosa sembra chiara: in questo suo primo importante cimento Zandonai si inserisce nella tendenza a rappresentare il femminino operistico attraverso le categorie del patologico, dell’isterico, dell’aggressivo, del(l’auto)distruttivo, superando in questo l’ancora attuale modello pucciniano; in parallelo, l’uomo di fronte a lei perde malamente ogni allure eroica e financo ogni dignità per ridursi a misero pantin, secondo un processo di svirilizzazione che si rinnoverà in molte figure che seguiranno e che la comune esasperazione vocalistica singolarmente accentua e sanziona con un marchio inconfondibile. Il conflitto si configura così come spietata lotta dei sessi per la supremazia, fra attrazioni fatali e repulsioni violente, illusioni di normalità e ricadute nel gorgo perverso. Al di là di ogni altra considerazione, quello di Conchita rimase comunque, per i suoi stessi caratteri estremistici, uno dei ruoli femminili più ambìti dalle cantanti di forte temperamento istrionico come Gianna Pederzini, che nell’edizione del 1940 vi riversò il suo geniale talento di attrice, adattando alla figura dell’ardente gitana il suo timbro mezzosopranile19. Con Melenis, l’opera che segue di lì a poco, Zandonai si trova alle prese con uno studio di psicologia femminile non meno impegnativo del precedente, ché la sua nuova primadonna, sebbene diversissima da Conchita, appare figura altrettanto enigmatica e inquietante. La sua non è più solo la storia di un amore difficile, ma la parabola tragica di un essere guidato da una passione esagerata, che la mancata corresponsione rende ossessiva e morbosa: un caso di monomania penosissimo per l’equivoco di cui si alimenta. Il retore Marzio non appare mai interessato a lei come persona; la mediocre natura di cui è fatto gli impedisce di comprendere la voce dell’istinto che gli viene dalla seducente greca e gli fa preferire un matrimonio importante quale premio per la sua ambizione di ascesa sociale. Così il percorso affettivo di Melenis avviene in perfetta solitudine, negletto e malinteso, e addirittura senza un partner degno del nome. Un’impostazione drammatica di tal genere porta con sé ovvie conseguenze. In primo luogo non vi possono essere duetti d’amore veri e propri: le scene tra i due protagonisti sono in realtà dialoghi a una dimensione, senza espansione o scambio di sentimenti. Duetti Marzio non ne avrà nemmeno con la sua futura sposa, che è stata voluta dagli autori semplice presenza scenica priva non solo della tipica funzione di antagonista ma anche di canto e di qualsiasi connotazione musicale. L’unico interesse del libretto è per Melenis e per il suo destino che appare segnato in partenza ma che alla fine, in accordo con le premesse, si compie sbalorditivamente tra l’indifferenza generale. L’anomalia dell’assunto drammatico si riversa così sullo scioglimento, che è pressoché inedito nel contesto operistico: nessuna eroina che si rispetti abbandona la scena così inosservata, non compianta né rimpianta da alcuno, con la beffa del lungo corteo nuziale sullo sfondo che neutralizza il pathos sviluppatosi nel momento della trafittura mortale con lo spillone agendo da anticlimax decorativo in pieno trionfo di squisitezze floreali. La singolare figura dell’etera è disegnata con cura particolare, contornata da un’aura di esotismo e di mistero, volta a volta dolce e flessuosa, tenera e malinconica, aggressiva e selvaggia20; con ampie pagine solistiche e un motivo-sigla che l’accompagna e in qualche modo ne descrive 18 In aggiunta alle remore del librettista Zangarini, si ha testimonianza del fatto che la stessa Tarquinia Tarquini, creatrice del ruolo alla prima milanese del 1912 e nella successiva lunga tournée negli Stati Uniti, aveva manifestato per suo conto delle pruderies che finirono per condizionare in qualche modo tale attenuazione ‘moralistica’ del personaggio. 19 Un omaggio a Gianna Pederzini è contenuto nell’articolo dell’«Impero», qui al n. 507. 20 Dice di lei il liberto Cleandro: «Quando cerca amor sembra una lupa», e poco dopo la descrive quasi come una pantera: «Procede a sbalzi, fiuta/con le narici tese». 1/14 / simbolicamente la natura appassionata e dolente (un arco melodico che si espande e subito ripiega su se stesso): un personaggio «splendido», come è stato riconosciuto ancora di recente21. Di certo è l’unica persona viva all’interno di un mondo di cartapesta il quale, specie nel secondo atto, si va a comporre in una di quelle raffigurazioni coreografiche del tutto esteriori della storia antica che nel nostro immaginario sono istintivamente collegate all’estetica del kolossal cinematografico. Ben si sa come la spettacolarizzazione dell’antichità classica, e della romanità trionfante in particolare, sia spesso la palestra delle peggiori nefandezze artistiche, e qui il pericolo corso da Zandonai era davvero grande. Come già per la plaza de toros al quarto atto di Carmen, il Circo romano-imperiale è visto dall’esterno e le grida del popolo, rapide, balenanti, feroci si fanno udire da fuori campo; ma poi la scena viene invasa poco per volta da masse di gente: una folla anonima da principio, che si precisa man mano in una serie interminabile di comparse andanti a formare un quadro storico grandioso e imponente22. Non occorre rilevare come tutta la retorica pompière associata all’immagine della Roma antica costituisca il lato discutibile di questo attardato grand-opéra del giovane Zandonai, in quanto obbligata ad esprimersi musicalmente attraverso convenzioni abusate e prevaricanti (l’enfasi dell’Inno a Cesare e delle varie invocazioni ed esclamazioni, il piglio marziale...), sì che l’elemento drammatico che riporta più dappresso alla vicenda umana di Melenis (il grido disperato di lei all’annuncio delle nozze di Marzio con Marcella) ancora una volta passa senza un gesto che la catapulti in primo piano. Non così negli altri due atti, dove il musicista può attingere a momenti di lirismo più intimo; valgano per tutti il suggestivo preludio al terzo atto, già venato di presagi di morte, e in genere tutte le pagine che vedono al centro la protagonista. Melenis ha conosciuto due sole apparizioni sulle scene: l’ultima, quella romana di cui ci occupiamo, nel marzo del 1913, dopo di che è scomparsa definitivamente dal repertorio. Un destino così inequivocabilmente avverso porterebbe a ritenerla senz’altro un’opera fallita, un infortunio momentaneo sulla via di una migliore definizione stilistica, un incidente di percorso tosto riassorbito od oscurato dall’avvento ormai imminente del capolavoro. In realtà la sua specifica vicenda critica rende la questione più complessa, pur se la sua interpretazione corretta imponga di procedere con cautela induttiva. I novant’anni trascorsi da quelle fulminee apparizioni sul palcoscenico rendono problematica la considerazione attuale di questo spartito, la cui sola lettura al pianoforte senza il conforto della verifica sulle scene, se può informare sulla qualità della musica, meno può dire sull’efficacia reale della drammaturgia. Senonché, se ci si affida alle uniche fonti d’informazione in questo caso possibili, che sono le opinioni espresse dai vari critici musicali dell’epoca, ci si avvede che, contrariamente alle aspettative e pur con tutti i rilievi avanzati, Melenis ha ricevuto nel complesso responsi piuttosto positivi, anzi in taluni casi si ha l’impressione che essa abbia goduto di favori perfino superiori ad altre di maggior giro e fortuna. Il dubbio, per noi che ne parliamo dopo così tanto tempo, è che si tratti di un’opera più valida di quanto non si sia disposti a credere, un’opera alla quale è semplicemente mancata la possibilità di farsi conoscere meglio e di costruirsi una prospettiva storica attraverso la consuetudine del palcoscenico. Non arrivo a dire che oggi essa potrebbe avere una facile circolazione, però mi sembra che molti di quelli che all’epoca erano ritenuti errori d’impostazione o incongruenze non accettabili in quanto al di fuori di un corretto uso delle poetiche melodrammatica rivestano invece ai nostri occhi caratteri di indubbia attualità. Penso ad esempio ad elementi, qui solo abbozzati ma significativi, quali l’incomunicabilità e l’incomprensione tra esseri umani, la sostanza deficitaria dei loro incontri, la sottolineatura di estraniazione nei momenti cruciali, e così via: elementi tutti che nel più generale contesto del teatro contemporaneo sono ormai diventati degli autentici topoi. Il libretto dunque, ad una serena rilettura, risulta meno meschino di quanto sembrasse ai nostri predecessori del 1913, proprio perché noi non avvertiamo più come carenza insostenibile in un testo operistico la 21 Cfr. Renato Chiesa, Le matrici linguistiche e la posizione di “Francesca da Rimini”, in Riccardo Zandonai, Milano, Unicopli, 1984, p. 177. 22 Può essere di qualche interesse ricavare dal libretto cosa viene prescritto in quest’opera in fatto di comparse. I ruoli assegnati alle masse sono i seguenti: senatori, patrizi, consoli, littori, cavalieri, legionari, centurioni, autocrati, pretoriani, tribuni, edili, cortigiane, atleti, mimi, bestiarii, aurighi, ancelle, buccinatori, clienti, saltatori, coretidi, musici, flabelliferi, lecticarii, fanciulli auledi, fanciulle tibicine, donne con cembali e con lire, matrone, donne e fanciulli della plebe, cristiani, popolo. 1/15 / mancanza di una storia d’amore soddisfacente, né disturba se l’amore è proposto in varianti spiacevoli o degradate o se veicola minore commozione. Gli aspetti innovativi che vi vennero positivamente còlti negli anni Dieci riguardavano dunque ben più il linguaggio che non la drammaturgia. In altre parole, taluni aspetti specificamente tecnici della partitura, assai simili a quelli messi in risalto per Conchita e quindi definibili come ormai tipici del formulario lessicale zandonaiano, la qualificarono agli occhi del pubblico come lavoro dagli spiccati caratteri di modernità, soprattutto per quanto riguardava il trattamento sinfonico del materiale e quel tal procedimento ‘a collage’ del repertorio melodico che corrispondeva, come s’è visto, alla visione lucida di un mondo in frantumi. Le reazioni, come al solito, furono ammirate e prudenti: si riconobbe volentieri a Zandonai di incarnare l’operista moderno che deve essere anche sinfonista agguerrito; ma ammonendo al contempo che il sinfonista è comunque da ritenersi inferiore all’operista proprio perché più limitato all’artigianato architettonico e di assemblaggio. Così si trovò il destro di rimproverare a quest’opera l’inibirsi il respiro lirico per mortificarsi nel cesello calligrafico onde pervenire a una raffinata effettistica sonora, e il nascondere quindi una costituzionale afasia melodica e inventiva. E d’altronde, la perizia orchestrale di Zandonai veniva sempre esaltata in se stessa in modo generico, senza sentire il bisogno di scendere in un qualche dettaglio tecnico che invece sarebbe utile a noi per capire fino a che punto il suo carattere di novità fosse stato recepito. Non si pretende che l’impiego, nello strumentale di Melenis, del flauto basso o Albisiphon – non certo abituale a quei tempi in quanto di recentissima invenzione – fosse avvertito come un fatto rivoluzionario, ma ci si aspetterebbe di trovare qualcosa di più di un paio di rapidi cenni a parziale testimonianza di un certo atteggiamento sperimentalistico del giovane Zandonai23. Al contrario, nelle critiche di impostazione più retriva ciò è visto con biasimo, negandosi che «le combinazioni strumentali» possano mai produrre «qualche cosa di nuovo» o suscitare «una commozione immediata, spontanea» 24. Quanto alle critiche favorevoli a quest’opera nella sua unica apparizione a Roma, occorre sceverare la presa di posizione partigiana di Nicola D’Atri dalle altre più serene. Le riserve avanzate sono esattamente le stesse già notate a proposito di Conchita anche per quanto ha a che fare con il libretto, che, pur riconosciuto meno bieco, appare, al di là dei reali demeriti, «inconsistente, macchinoso, convenzionale»25; la delineazione psicologica dei personaggi è ritenuta fallimentare, e sbiadita la stessa focalizzazione della protagonista, il cui femminino non è più soddisfacente di quello della sigaraia di Vaucaire e Zangarini. Nella convinzione che un giudizio attuale potrebbe essere più equilibrato e complessivamente assolutorio, Melenis va considerata una tappa indispensabile dell’apprendistato zandonaiano, quella che conclude il suo periodo di formazione e di puntualizzazione stilistica. È stato notato che in questa partitura sono contenuti già molti presagi della Francesca da Rimini, e questo è sufficiente a renderla se non altro degna di attenzione e di rispetto. Quando Francesca da Rimini approdò al Costanzi nel marzo 1915, la sua fama si era diffusa già da tempo tra le file dei melomani capitolini in seguito ai buoni responsi ottenuti in altri teatri26; tuttavia la storia dell’affermazione romana di quest’opera non pare essere quella di un amore a prima vista. Ciò si spiega forse col fatto che i fruitori di quei lontani decenni partivano da una situazione di maggiore omogeneità di valori; intuivano la superiorità di Francesca ma non la vedevano ancora stagliarsi nettamente sulle altre dello stesso autore. Per noi invece che affrontiamo l’analisi del teatro zandonaiano con il beneficio di un ampio filtro temporale e critico, il suo valore rispetto alle consorelle appare scontato e perfino topico: Zandonai “è” Francesca da Rimini, il suo nome si identifica totalmente con essa nel nostro immaginario. Per dirla in altro modo, la nostra visione attuale si avvantaggia di quella ‘scrematura’ qualitativa cui si accennava più sopra, in virtù della quale siamo certi che la selezione operatasi nel tempo con il concorso di tante generazioni di 23 Nessuno, ad esempio, ritiene che l’innovazione possa meritare un’intervista apposita su un giornale specializzato. Si vedano comunque la segnalazione su «Orfeo» (n. 475) e l’accenno contenuto nell’articolo su «Il Giornale d’Italia» (n. 38). 24 Cfr. n. 41. 25 Cfr. n. 39. 26 Gli echi della prima torinese avevano trovato molta amplificazione su tutti i maggiori giornali della Capitale (v. Appendice 1). 1/16 / ascoltatori e di tante indagini musicologiche non possa essere che quella giusta, sì che l’eventualità di una competizione non è nemmeno pensabile. Non deve quindi suscitare meraviglia il fatto che dai presenti materiali Francesca non la si veda uscire nettamente e immediatamente confermata nel suo primato, né che il suo status di capolavoro venga dichiarato senza infingimenti, per la prima volta, soltanto nel 1925, alla quarta ripresa romana, quantunque nessuno avesse fino a quel momento manifestato dubbi fondati sulla sua qualità e riuscita. È solo il naturale mutamento delle prospettive che fa risultare oggi la risposta ad un’opera minore come Melenis una sopravvalutazione e quella a Francesca da Rimini un disconoscimento: in realtà si tratta più semplicemente di un meccanismo di assimilazione graduale e prudente, come richiedono tutti i lavori di un certo impegno e sostanza. Del resto – e lo rivelano eloquentemente i dati concreti della sua diffusione – a Francesca il tempo ha reso piena giustizia, essendo questa l’unica delle opere zandonaiane ad aver retto alla prova degli anni e ad essere ancora ripresa di quando in quando nei diversi teatri. Anche ai suoi tempi essa entrò prontamente in repertorio, come testimoniano le quattro realizzazioni nei primi dieci anni solo a Roma. Il caso di Francesca da Rimini, anche letto nell’esclusiva angolatura del dato romano, sembra quello di un’opera per la quale è esistito un ideale e diretto rapporto tra la consuetudine di ascolto e il gradimento scaturitone. Infatti il maggior numero di produzioni (12) distribuite in un arco vasto di tempo (90 anni) ha consentito un processo di evoluzione valutativa praticamente ininterrotto attraverso le generazioni e dunque un sedimentarsi di opinioni che non possono che aver giovato alla piena comprensione del lavoro. Da quanto è emerso in premessa, si intuisce che il blocco di articoli in nostro possesso riguardanti Francesca da Rimini è di gran lunga il più cospicuo in termini di quantità dell’intera collettanea e anche quello che, per lo meno nel primo ventennio, contiene al suo interno alcuni tra i pezzi più pregevoli ed esaurienti da un punto di vista critico-analitico. Quella che ne esce è una visione articolata e completa della sua fortuna così come si è costruita attraverso tutti gli scivolamenti di giudizio, anche notevoli, da volta a volta e magari all’interno della stessa rappresentazione a seconda della testata giornalistica e della persona che se ne è occupata, ma in realtà riflesso delle tendenze estetiche del momento. In altre parole, la vicenda pubblica di quest’opera, proprio per la sua capacità di tenere a lungo il repertorio, rispecchia come nessun’altra dello stesso autore tutte le difformità di atteggiamenti culturali che accompagnano passaggi storici tra loro diversissimi. Nel corso di codeste continue riconsiderazioni, il geniale lavoro zandonaiano appare ora fresco e giovanile ora precocemente invecchiato, e il discrimine è spesso costituito in entrambi i casi dal nodo del dannunzianesimo che ne può essere tanto un sigillo di qualità a garanzia di una materia letteraria ben superiore alla media librettistica del tempo, quanto un giogo fastidioso e stucchevole per tutte le ricercatezze estetizzanti di cui si sostanzia e che col mutare delle mode perdono inevitabilmente un po’ alla volta i loro pregi palesando il loro aspetto più caduco. Una cosa sembra certa: tolti alcuni momenti ad essa meno favorevoli, Francesca riesce sempre a riempire i teatri, forte di un suo fascino arcano che è il segreto della sua riuscita, al di là di valutazioni pedanti e di mode passeggere; anzi si vedrà che proprio per questa sua capacità di essere anche un lavoro di cassetta qualche pragmatico direttore artistico vi ricorrerà in determinate occasioni, come si fa d’abitudine con le varie Tosche e Traviate di scorta, per dar tono a una stagione asfittica o per vivificare un momento produttivo difficile. La ricetta con cui Francesca era stata confezionata era tale da avvicinare ogni stratificazione di pubblico e da soddisfarne le diverse attese: anzitutto la raggiunta dignità del testo poetico metteva una pietra sopra alle vituperate esperienze librettistiche precedenti e permetteva un incontro raro e felicissimo di questo con l’espressione musicale dal quale usciva oltremodo valorizzato ed esaltato. Quanto al commento orchestrale, esso appariva ancora più smagliante del solito, a tratti un po’ ridondante ma tale da colorire efficacemente il dramma. Un lavoro dunque che procurava occasioni di intrattenimento colto ma che andava anche dritto al cuore della massa, alla quale regalava finalmente una storia d’amore in piena regola, suggellata dalle terzine dantesche più universalmente citate: una vicenda di puro romanticismo immersa in un paesaggio medievale ricco di umori nascosti e di violenze esibite, tra garrule canzoni di primavera e sferragliar di battaglia, suoni 1/17 / malinconici ed evocativi di viole e pifferi e urla di torturati e attraversata da presagi, attese, rimorsi, vendette, tradimenti, soprassalti del sangue... La sua appartenenza stilistica parve subito dividersi abbastanza equamente fra il romanticismo tristaniano e le estenuatezze nuancées dei decadenti francesi, forse per la parallela suggestione del Pelléas, ma anche con zone non trascurabili di crudo naturalismo per le quali si mostrava funzionale la lezione mascagnana. Tuttavia le cose non saranno viste sempre in modo così chiaro e schematico: i commentatori si dovranno impegnare a lungo nella delineazione stilistica del lavoro fino a che, in una sua tarda riconsiderazione, tutte le eredità vere o presunte saranno rigettate e si riconoscerà ad esso di avere un’impronta autenticamente zandonaiana. Forse una delle migliori e più efficacemente riassuntive definizioni datene è quella che parla di “frutto sagacissimo e lungimirante di opposte tendenze in un’epoca di transizione”27, individuando appunto nel suo carattere nobilmente eclettico uno dei suoi meriti precipui. Ad esultare per il risultato raggiunto fu soprattutto il partito tradizionalista, a giudizio del quale Francesca si poneva nel solco di Verdi, simboleggiando la «redenzione del dramma lirico» dalle umiliazioni inflittegli dalle «concettosità nordiche» e dalla «infatuazione esotica»; e il suo autore, lungi dall’allinearsi a quelle pericolose tendenze anti-melodiche del tempo, si confermava nel pieno recupero dei principî e valori che avevano fatto grande la patria del bel canto. C’era indubbiamente un po’ di esagerazione esaltata in queste continue riproposizioni del concetto, quasi che il raggiungimento di una tale presunta purezza di intenti fosse cosa di cui era necessario autoconvincersi; del resto lo stesso Zandonai raccontò un giorno con un certo divertimento che la sua opera era stata percepita dai tedeschi come perfettamente in sintonia con la loro estetica, sottintendendovi un’etichettatura ‘wagneriana’. Qualcuno dei critici romani riconobbe che il melos non vi era alla fin fine molto fluente e ricco; altri, più correttamente, non vi videro rinnegate le premesse poste dal musicista fin dall’inizio della sua carriera, che erano indubbie premesse di modernità in senso cosmopolita. Un’opera complessa, insomma, questa Francesca da Rimini, che – come rileverà il De Rensis nel 1925 – all’inizio, per ragioni diverse, «scontentava un po’ tutti»: gli «avanguardisti» e i «parrucconi», ma poi «proprio la fusione ammirevole” di lirismo vocale e virtuosismo orchestrale fecero “di quest’opera di Zandonai, più di tutte le sue altre, un capolavoro pensato ed ispirato»28. I dettagli di ricezione contenuti nella serie di articoli esaminati chiariscono che, equivoci a parte, i punti topici vennero generalmente còlti e le graduatorie di merito stilate: indimenticabile il finale primo, riuscitissimo il poetico atto terzo, rumoroso e confuso il secondo, non perfettamente centrato lo scioglimento finale. A riguardo del secondo atto e della sua condanna quasi unanime, osserverei che in quel caso non si calcolò nel giusto modo l’essenziale funzione drammatica del contrasto, essendo abbastanza ovvio che il quadro della battaglia, lungi dal costituire una forzatura o un diversivo, risponde alla necessità di evitare il languore protratto che il mondo femminile inevitabilmente veicola, sicché la sua soppressione non avrebbe portato che a un pericoloso squilibrio dell’assetto formale generale. Lo si dovrebbe vedere quindi come un elemento probante dell’acuto senso del teatro posseduto già in modo completo dal maestro trentenne. Qualche problema di focalizzazione incontrò il personaggio di Malatestino, di cui non si intese sempre la virtualità tragica e la funzione di pernio del dramma d’amore e di sangue. Forse agiva in questa minimizzazione l’abitudine consolidata di ricercare la rappresentazione della natura bieca e malvagia nel cliché melodrammatico della stentoreità baritonale anziché nella sottigliezza perfida e insinuante di un tenore acuto dal timbro stridente: di fatto Malatestino, anche per la sua tessitura vocale in funzione del ruolo giocato nell’azione, è un personaggio affatto moderno. Quanto al primo quadro d’ambiente, che rispecchia il modo tipico di Zandonai di aprire un’opera, fu valutato da qualcuno come piuttosto disordinato e frastornante, ma è da pensare che l’esecuzione in oggetto non fosse stata impeccabile, come spesso accade per questa pagina insidiosissima. Qui la frammentazione melodica era giustificata dalla scena stessa e dai suoi eventi; ma l’antica insofferenza si rifece sentire nei commenti e, parallelamente ad essa, la deplorazione 27 28 Cfr. n. 95. Ibidem. 1/18 / per la parsimonia di pagine liriche ad ampio respiro e magari a svolgimento compiuto atte a consentire l’applauso a scena aperta. Dovendo scegliere fra i tanti gli articoli più lodevoli per trattazione, si potrebbe optare per il pezzo del «Giornale d’Italia» (60) nel quale sembra comporsi il tradizionale dissidio di vedute fra pubblico e critica, accomunati entrambi nella commozione per l’opera di poesia; mentre in occasione della terza ripresa del 1921 si segnala la alata esercitazione letteraria di Matteo Incagliati (79) che vede l’intervento di Zandonai perfettamente compenetrato sia nell’archetipo dantesco che nella drammatizzazione dannunziana, onde la sua musica «è la musica di Francesca, di cui rispecchia compiutamente l’anima e profila gli aspetti esteriori, psicologicamente, esteticamente». Si tratta di uno dei commentarî più positivi per il lavoro zandonaiano, un unico inno di lode sciolto al cantore impareggiabile che ha saputo cogliere poeticamente il sentimento d’amore di un’anima tormentata. Dal lato delle curiosità di cronaca si pone invece la rappresentazione dopolavoristica appositamente predisposta nel 1932 dalle organizzazioni fasciste per le masse, evidentemente ritenendosi che i caratteri di raffinatezza decadente di quest’opera non costituissero un ostacolo alla ricezione da parte di un pubblico non acculturato di estrazione rurale. Può essere, questo, niente più che un dettaglio folcloristico, peraltro viziato da una robusta propaganda demagogica: però si misura anche da siffatti particolari di minuta attualità la natura di un’opera d’arte quanto alla sua fruizione sociale. Non risulta, ad esempio, che uguale sorte sia stata condivisa dai lavori di Pizzetti e dall’ala colta dell’operismo del tempo, meno toccata dal fastidio di essere popolare. L’ultima volta che Zandonai assistette al successo romano della sua creatura da un palco di proscenio del Teatro Reale dell’Opera fu nell’aprile 1937, dopodiché iniziò per essa una navigazione assai meno esaltante. Il primo segnale di degrado lo si avvertì, anche per ragioni esterne, nel 1944, quando a una Francesca da Rimini necessariamente un po’ rappezzata si fece ricorso per inaugurare il Santo Stefano di guerra, quasi a richiamare nostalgicamente i fasti passati; ma fu un mezzo fallimento: «dopo 3 sole rappresentazioni dovette essere ritirata per la poca “cassetta” che fruttava» 29. Il clima di disfatta è rispecchiato dagli stessi giornali, scarnificati nelle pagine e dai toni spesso lividi. Curiosamente, a fare le spese di un contesto così alterato è la stessa figura di Zandonai, che comincia ad essere sfruttata a livello politico. Un primo indizio lo si rintraccia nella descrizione forse un po’ romanzata del trapasso dell’artista mentre, come un patriota ottocentesco, è visto inneggiare all’Italia libera con le ultime forze rimastegli30. Più fosca e di effetto l’affermazione secondo cui egli sarebbe stato neanche troppo indirettamente «assassinato dai tedeschi di Adolfo Hitler» dopo che «i camerati fascisti avevano fatto il possibile per preparare la vittima al sacrificio supremo»31: prima rivelazione sorprendente – che la ritrovata libertà di parola fa venire alla luce – circa i già citati ‘nemici di Zandonai’. Che ciò non sia solo conseguenza della particolarità del momento storico lo si arguisce dal fatto che la voce non si attenua neppure molto tempo dopo. Ancora nel 1960 un articolo di Nino Piccinelli su «Momento Sera» ripete quasi con le stesse parole le molte perorazioni apparse sul «Messaggero» a firma di Renzo Rossellini e dedicate al maestro e amico, riferendo di una «prepotente minoranza musicale «ufficiale» – non si sa se a Roma o altrove – che sarebbe in passato riuscita «con ogni mezzo a stroncare l’artista e le sue opere»32. L’età repubblicana sorta dal disastro bellico offre uno stile di recensione complessivamente più austero, e dalla nuova sobrietà – che spesso però non è altro che pochezza di contenuti – risentirà in negativo la fortuna dell’opera ‘dannunziana’ di Zandonai. Non brillano per chiarezza di idee codeste note piuttosto pretenziose della nuova generazione di critici del dopoguerra, forse spinti da un riflesso condizionato a rifiutare aprioristicamente tutto quanto era coinvolto col passato recente33. A partire dalla produzione – pare scadentissima – del 1963, il taglio degli articoli si fa più 29 Cfr. V. Frajese, cit., III, p. 178. Cfr. n. 463. 31 Cfr. n. 122. 32 Cfr. n 139. 33 Se ne distaccano per sostanza e carico di esperienza i critici della vecchia guardia, da Rossellini che invita a considerare l’opera nel suo valore complessivo al di là dei dettagli che possono sviare, a Lunghi che in un importante pezzo sul «Giornale d’Italia» (n. 134) trasfigura la propria esperienza di fruizione nelle immagini bizantine dei mosaici ravennati, trasferendola quindi nel campo della magìa, dell’incantamento. 30 1/19 / moderno e meno emotivo, proponendo solo qua e là qualche ipotesi interpretativa originale ma in fondo privilegiando la stringata informazione alla estesa analisi. C’è senza dubbio più libertà anche nel criticare le presenze artistiche e in generale l’organizzazione del teatro, realmente caduto molto in basso per il prevalere sempre più asfissiante degli interessi politici su quelli artistici: situazione che si aggrava per la produzione di dodici anni dopo (1975), che è l’ultima realizzata dal Teatro dell’Opera nel XX secolo34. In quest’epoca più vicina a noi il discorso critico si arricchisce peraltro di nuovi interessanti contributi che si segnalano anzitutto per una più disincantata conoscenza del mondo estetico di Gabriele d’Annunzio e per un più consapevole riconoscimento del ruolo storico giocato da Zandonai in quel frangente. Ma, ciò che più importa, Francesca da Rimini, a tanti decenni dalla sua prima comparsa su quelle scene, risulta ancora un’opera valida che si rivede sempre volentieri e con un certo senso di nostalgia per altri lontani e più poetici tempi in cui c’erano sentimenti di passione e bellezza e mezzi adeguati per esprimerli. Come ogni operista che si rispetti, Zandonai non si sottrasse al dovere di dire una parola anche nel versante ‘leggero’; ma c’è da presumere che l’esperienza della Via della finestra sia stata più un atto di buona volontà che di profonda convinzione. La motivazione addotta dal compositore in quel caso parla di necessità di trovare un momentaneo riposo dopo le acute tensioni guerresche ed erotiche di Francesca da Rimini, che in quel particolare momento storico valeva anche come tentativo dichiarato di riportare la gente al sorriso dopo gli orrori della Grande Guerra. Ma poiché per un artista scrupoloso il cimento creativo, anche il più svagato, non esclude lo sforzo dell’impegno e della ricerca, questo lavoro minore di Zandonai non fu per lui solo un divertissement fine a se stesso bensì un’esercitazione sagace vòlta ad arricchire la gamma del suo formulario espressivo e come tale frutto di un’impellenza insieme artistica ed umana la cui giustificazione è intrinseca al progetto. Purtroppo è questo uno dei casi segnalati in cui la limitatissima vicenda pubblica (una sola produzione a Roma e poche altre in giro) impedisce di vederne una evoluzione critica qualsiasi e di immaginarne una sua ipotetica funzionalità attuale. In quella sua unica comparsa l’opera non incontrò ostilità particolari, e nondimeno essa si prestò ad alcuni fraintendimenti che riguardavano un interrogativo tutt’altro che secondario: qual era il grado di comicità lecitamente esigibile da essa? Definire con chiarezza il suo genere e ambito non era sentito all’epoca come esercizio retorico, ché a ciò erano legate tutte le aspettative in essa riposte alla vigilia. Ora è fin troppo evidente che in quell’occasione si equivocò alquanto sul suo presunto status di ‘opera buffa’ (anacronistico fin dalla definizione), trattandosi invece, come si legge sul frontespizio dell’edizione a stampa, di una ‘commedia giocosa’, dunque di un genere di mezzo carattere da cui ricavare al più qualche motivo di sorriso dolce-amaro35. Eppure chiunque avesse preteso di conoscere la specifica Weltanschauung di Zandonai non avrebbe potuto attendersi da parte sua l’abdicazione al registro elegiaco-malinconico a favore del burlesco puro, né la facile permeabilità della sua natura austera all’alleggerimento nell’ironia salace, nell’allusione capricciosa, nell’ammiccamento malizioso. Così accade che, pur se il pretesto scenico è trascurabile – com’è senz’altro il caso de La Via della finestra – i condizionamenti automatici intervengono puntualmente nella sua scrittura quando si tratti di sottolineare un conflitto, dovunque si profili o manifesti, attraverso l’inquietudine cromatica delle linee melodiche, gli interventi di certa timbrica orchestrale, le asprezze di una vocalità tesa, quasi a voler ricordare che al di là del sorriso c’è pur sempre un motivo di riflessione più profondo, un’immersione più sentita nel mistero della commedia umana. La Via della finestra si può intendere come uno studio di caratteri e di situazioni quotidiane risibili applicate a una sostanza anti-eroica, quale era latente nell’immaginario zandonaiano fin dal Grillo del focolare, l’opera prima a cui questa idealmente si riconduce. Non si tratta propriamente di un’opera da camera, ché il suo organico strumentale, per quanto trattato con brillantezza speciale, rientra in quello di una normale orchestra sinfonica appena un po’ snellita; e tuttavia la materia teatrale rimane alquanto 34 Per l’undicesima edizione di quest'opera, che ha visto la luce nel novembre 2003 mentre questo testo era in fase avanzata di impaginazione, si veda l'apposito Supplemento 2003. 35 Vedi l’appropriato confronto con Falstaff istituito da F. Cenciarini in «Musica» (n. 178). 1/20 / raccolta, sì che andrà tenuto presente, nell’atto di visionare le cronache romane, che il passaggio dal Teatro Rossini di Pesaro, luogo della prima rappresentazione assoluta, alla ben più vasta sala del Costanzi nocque in qualche misura alla sua perfetta messa a fuoco. Il quesito sulle potenzialità vere o presunte di Zandonai nel campo del comico non è mai stato risolto e nemmeno affrontato a dovere, forse perché sentito come un po’ viziato di anacronismo. È solo un pregiudizio che il Novecento musicale, genericamente inteso, sia un secolo poco incline alla risata: l’umorismo, anzi, più che mai vi diviene un’arma formidabile per mostrare senza infingimenti le contraddizioni della realtà e abbattere il perbenismo degli assetti sociali consolidati. Nel ricercare le soluzioni al problema di una comicità moderna, il musicista trentino mostrò di avere idee precise, mediando ancora una volta fra tradizione e attualità. Senza minimamente intrigarsi nel grottesco surrealista, egli si rivolse ai meccanismi della farsa settecentesca, così perfetti nella funzionalità delle loro simmetrie, stemperandoli al calore del suo umanesimo romantico. Dove il ricorso al comico si rivelò utile all’affinamento della scrittura fu nel maggior controllo del materiale in funzione del decongestionamento sonoro, della semplificazione armonica, della leggerezza di strutture e di linee, così come il genere imponeva. Gli equivoci dell’intrigo, che richiamano ai convenzionali espedienti di tanta opera buffa, sono trattati con gusto e perizia: dalla gag delle tre donne che sbirciano a turno dal buco della serratura, al continuo nascondersi dei personaggi per sentire all’insaputa degli altri cosa avviene in scena; dalla dissimulazione di Renato e del Marchese in giardino resa tradizionalmente con la convenzione degli ‘a parte’, alla caratterizzazione del ruolo della servetta36 furba e pettegola. Zandonai, dal canto suo, accrebbe l’illusione stilistica di quest’opera definita ‘cimarosiana’ anteponendo all’azione un appropriato preludio strumentale in modo brillante mosso e utilizzando a sostegno delle voci frequentissimi accompagnamenti orchestrali ad accordi pulsanti, staccati e ribattuti. Né il finale dell’opera sembra voler sfuggire al topos proprio a soggetti celebri quali Le nozze di Figaro o La buona figliola: quello secondo cui la conquistata riconciliazione tra i personaggi dopo tutti i malintesi, i dispetti e le mattane succedutesi nelle scene precedenti riporta l’intera vicenda a una morale che ha il suo fondamento nella ricerca della felicità attraverso l’amore e il perdono. Ma purtroppo Giuseppe Adami non era dotato della finezza e dell’acume di Lorenzo Da Ponte, e ciò ebbe le sue conseguenze in sede di valutazione del lavoro, ove una volta di più si ripropose lo scontro pesante con un libretto debole e, nel caso specifico, poco felice già nella scelta del soggetto. Il vaudeville di Eugène Scribe da cui esso è tratto era sentito old-fashioned già nel 1920, né all’adattamento fattone da Adami si riconobbe di aver migliorato le cose, mancando proprio della leggerezza e della spigliatezza indispensabili al genere, specie in rapporto alla rischiosa esilità della trama. Il ritornarci sopra da parte di Zandonai alcuni anni dopo per ricondurre l’opera alla più appropriata misura dei due atti fu cosa assai opportuna; ma contro la sostanziale staticità dell’azione egli stesso poté fare poco, da cui ne consegue la ripetitività di situazioni e di ‘affetti’ e un eccessivo ricorso, nel tono generale, alla malinconia lacrimosa e autoindulgente. I commenti dell’epoca colgono poco le situazioni e i movimenti scenici sopra descritti, forse non interpretandoli come sufficientemente efficaci quanto a valenza comica. L’unico ‘gesto’ registrato – ma anche equivocato – è quello che dà motore e titolo alla commedia, ovvero il duplice passaggio dalla finestra da parte di Gabriella. Senonché almeno il primo di questi, che è un salto un po’ spericolato, avrebbe dovuto sortire, se ben realizzato, un sicuro effetto-sorpresa. Esso venne inteso al più come un’infrazione alla norma del buon senso comune, e dunque come un pretesto troppo tenue per essere occasione di divertimento, caricato com’è per giunta di sottintesi morali (il castigo, il rimorso, il perdono); forse anche un atto condannabile in quanto insubordinazione di una moglie nei confronti del proprio marito oltreché sconveniente per la performance fisica che impone alla primattrice. Vero è che venature di mestizia percorrono il lavoro e ad un certo punto della vicenda, anzi, sembrano prendere il sopravvento. Questo, a ben guardare, deriva da un ben preciso nodo di fondo: la tematica matrimoniale non si presta all’effetto comico qualora non sia trattata con spirito di parodia o non venga completamente dissacrata, com’è il caso di altri lavori del Novecento ben più 36 A ciò è ridotta, nel libretto di Adami, la figura di Giovanna, che nella fonte originale rivestiva il ruolo più notabile di fattoressa. 1/21 / disinvolti riguardo al tabù dell’intangibilità del vincolo coniugale37. La coppia zandonaiana, per quanto caparbia e litigiosa, si prende ed è presa troppo sul serio, contribuendo con i suoi screzî e le sue ripicche a definire la petulanza del ménage borghese a cui poco giova l’elemento di animazione costituito dallo stereotipo della suocera intrattabile, anch’essa personaggio troppo ragguardevole socialmente per essere una maschera autenticamente buffa38. Un fatto che invece varrebbe meditare rispetto al problema più generale del comico nel teatro d’opera contemporaneo e al modello di soluzione che Zandonai aveva in mente sta nell’interesse manifestato più volte da questi per L’Heure espagnole (1911) di Maurice Ravel. Proprio Ravel, a proposito di quella sua rara escursione nel giocoso, aveva sostenuto che l’orchestra moderna era la leva più adatta per sottolineare ed esasperare la materia comica poiché attraverso l’esaltazione delle infinite potenzialità dei timbri strumentali a fini di drammatizzazione il gioco degli attori in palcoscenico si faceva volutamente più astratto e stilizzato, e dunque pretestuoso come a un soggetto farsesco si conviene. Forse un confronto diretto fra i due lavori non parrebbe fuori luogo, e in ogni caso sarebbe interessante verificare quantomeno se l’uso dei ritmi spagnoleggianti che nella bottega dell’orologiaio raveliano caratterizzano l’ambiente locale e conducono il gioco lucidissimo degli amori e dei tradimenti abbia una qualche eco imitativa nelle nostalgiche stornellate fuori scena di una bucolica Toscana ottocentesca che all’interno del testo zandonaiano hanno tanta parte nel creare l’idillio crepuscolare, specie là dove il meccanismo burlesco cede il posto al dramma degli affetti. Per le sue varie occasioni di sorriso e di compartecipazione emotiva il prodotto che ne risulta è elegante, garbato o, come correttamente ebbe a riassumerlo Alberto Gasco, «piano, borghesemente provinciale e italianamente melodico»39. Un lavoro – verrebbe da aggiungere – che la scarsa consuetudine del pubblico italiano di allora con poetiche innovative à la manière de Ravel, e la vincolante associazione istintiva del ‘comico’ a tutta la tradizione dei settecentisti ‘napoletani’ fino a Rossini, rese di ricezione in parte insoddisfacente. Esso aprì comunque delle prospettive a lungo raggio, ancora tutte da scoprire, ma che così, a bruciapelo, verrebbe fatto di ritenere raccolte in qualche modo da autori ‘teneri’ come Nino Rota o ‘bizzarri’ come Vieri Tosatti. Dopo la gaia parentesi di Via della finestra, Zandonai tornò all’impegno serio con Giulietta e Romeo, un’opera in tutti i sensi determinante anche per la collocazione esattamente centrale che occupa nel suo catalogo, equidistante persino cronologicamente da Conchita e da Farsa amorosa. Se poi la svolta che quest’opera-pernio presupponeva non andò esattamente in senso progressivo, è cosa che non deve stupire né scandalizzare: una qualsiasi poetica musicale è continuamente soggetta a ridefinizioni e a volte è necessario all’artista arretrare di qualche passo per confermarsi su certe posizioni o per averne una visione più obiettiva. Quanto a Giulietta e Romeo, più che di restaurazione si dovrebbe parlare di aggiustamento di prospettiva, e ciò spiega la indubbia ambiguità di segno che connota storicamente questo testo, il quale peraltro si inscrive perfettamente nella generale linea di tendenza al riflusso testimoniata nella musica italiana nei primi anni Venti. Il disagio del momento storico è abbastanza avvertibile nella necessità di ancorarsi alle sicurezze passate senza però rinunciare alle conquiste intervenute nell’ultimo periodo. Giulietta rispecchia in pieno questa crisi, apparendo frutto di un compromesso più cercato che ottenuto tra le ragioni di un linguaggio sonoro consapevole della sua evoluzione storica e le esigenze di massima comunicazione ai fini di un consenso popolare pieno e ampio, com’era stato nella grande stagione del melodramma dell’Ottocento. Il progetto di riavvicinamento alle masse (un sogno per ogni artista moderno, spesso celante smisurate ambizioni faustiane) ha comportato nella fattispecie una semplificazione strutturale di fondo, in primis attraverso la volgarizzazione e riduzione alle sue dimensioni più esteriori di un soggetto sentimentale ultra-famoso; quindi, musicalmente, mediante un recupero del canto lirico espanso da connettere al clima espressivo teso ed appassionato di 37 Si pensi ad esempio alla frizzante operina Neues vom Tage (1929) di Paul Hindemith o alla buffoneria surrealista di Apollinaire Les Mamelles de Tirésias (1917), messa in musica molti anni più tardi da Francis Poulenc. 38 A meno che – beninteso – Zandonai non abbia voluto significare intenzionalmente che il matrimonio è un dramma e come tale va trattato: un’ipotesi suggestiva, che nessun critico ha pensato di avanzare. 39 Cfr. n. 167. 1/22 / quella vicenda, esaltando nel contempo ancor più l’apparato decorativo-ambientale per mezzo dei fascini combinatorî e suggestivi del moderno sinfonismo. Non si può dire che tali propositi teorici siano stati pienamente compresi dalla critica della prim’ora, sì che Giulietta e Romeo, lungi dal segnalarsi come capostipite di un nuovo genere di teatro, riconfermò il carattere sperimentale e transitorio della drammaturgia zandonaiana e come tale assolutamente conseguente a tutti gli altri lavori conosciuti, solo più ‘ideologica’ e ibrida. Se c’era in essa più volontà di canto, si trattava comunque di un melos meno convinto e deciso nelle sue connotazioni; le linee su cui il lavoro si snodava erano bensì sottomesse ad un progetto di maggiore unitarietà, fino ad apparire ‘classiche’ e castigate, ma poi si sforzavano di riconquistare credibilità e sostanza ricorrendo alla magniloquenza del gesto. Purtroppo la prodigalità e il parossismo finiscono sempre per ottenere l’esito contrario a quello voluto, ché paradossalmente più l’enfasi vocale si impone quale istintiva conseguenza del calore passionale più sembra mimare l’impotenza espressiva e farsi pura vociferazione d’effetto: ed è quello che si verifica puntualmente in questo spartito. Il problema era probabilmente organico alla stessa sceneggiatura librettistica che, snaturando il quadro famigliare, faceva gravare sulle sole spalle di Tebaldo Capuleti tutta la tematica dell’odio di parte, col risultato di rendere questo personaggio troppo incombente e monolitico nella sua delineazione psicologica. Né le cose miglioravano con la coppia degli amanti clandestini, la cui inidonea caratterizzazione quali teneri adolescenti li caricava troppo spesso di un che di eroico che non si addice al loro archetipo. Inoltre le disseminazione di artificiosità culturalistiche sotto forma di arcaismi lessicali e preziosità d’immagini poetiche non contribuiva a favorire quella chiarezza e semplicità d’espressione che erano i canoni dichiarati del lavoro, anzi finiva per avere funzione inibitoria sulla veridicità umana e la capacità di commozione delle dramatis personæ. Insomma, non bastava che lo spartito possedesse un respiro melodico più ampio e definito se poi agli attori era messo a disposizione un linguaggio verbale e musicale affettato e poco sincero. Quanto alla patina falso-popolare che affiora in tante parti, essa era dovuta alla scelta della fonte cinquecentesca di Luigi da Porto e al taglio che ad essa si era dato; ma anche in questo caso l’operazione antiquaria non sortì l’effetto sperato e fu in gran parte responsabile della ricezione non lineare del lavoro: se proprio si voleva mettere in musica la più classica delle storie d’amore – così sembra di capire dai commenti giornalistici più perplessi – meglio sarebbe stato non allontanarsi dalla sublime universalità shakespeariana anziché rifarsi alle fonti venete con tutto il loro corollario di particolari locali e idiomatici che alla lunga annegano ogni cosa in una oleografia sviante. Si arrivò a dire, con palese esagerazione ma significativa angolazione di lettura, che il momento topico del duetto al verone era la parte meno riuscita dell’opera, e per altro verso si guardava alla figura comprimaria del Cantatore come al virtuale protagonista musicale in quanto il suo breve intervento al terzo atto si configurava come l’unico pezzo chiuso della partitura che fosse in grado di veicolare commozione autentica e di imporsi per quell’immediata memorizzabilità che è il segreto di ogni melodista. Che il lamento del Cantatore sarebbe stato un brano destinato alla massima popolarità lo si era capito subito, talché con un’iniziativa piuttosto rara un quotidiano ad alta tiratura decise di riprodurre con grande rilievo, accanto all’annuncio della ‘prima’ imminente, le due pagine dello spartito che lo contengono perché potesse essere scorso sul pianoforte di casa dal pubblico dei lettori40. L’episodio si inquadra molto bene nel sentire generale del momento, che era di grande aspettativa (a Roma in quei giorni non si parlava d’altro) e che aveva trovato alimento con largo anticipo sulla carta stampata attraverso tutta una serie di interviste, fotografie, indiscrezioni, anticipazioni, ampi sunti del libretto pubblicati a puntate, analisi della famosissima storia. Il massiccio battage propagandistico che sta dietro al lancio di Giulietta e Romeo si spiega una volta di più con la vitalità e il potere di condizionamento del nutrito gruppo di sostenitori di Zandonai capeggiato da D’Atri (che era il dedicatario dell’opera); ma anche con il fatto che la ‘prima’ assoluta al Costanzi contava quale rivalsa nei confronti della Scala, teatro che, per ragioni mai interamente chiarite, si diceva avesse votato una sorta di ostracismo nei confronti dei lavori del 40 Cfr. n. 184. 1/23 / maestro trentino. Con queste premesse, l’opera doveva aver successo per forza; e tuttavia non si sfugge all’impressione che vi siano non poche forzature nei resoconti, solo un paio dei quali si permettono di cantare decisamente e ostentatamente fuori del coro, uno in particolare seguendo la via distruttiva fino all’esasperazione del partito preso. La virulenta e un po’ sgangherata reprimenda di Bruno Barilli41 si indirizza miratamente a elementi di linguaggio e di stile quali l’ipertensione sonora, i pieni eccessivi, la vocalità pletorica, e in modo più sfumato all’abilità di Zandonai quale uomo di teatro, che viene messa sostanzialmente in discussione. Ciò che soprattutto preme al critico è di ridimensionare meriti e valori del musicista, imputando il suo successo attuale come figura pubblica all’azione combinata di poteri culturali e politici e dunque insinuando nemmeno tanto velatamente che egli faccia parte di una consorteria biecamente commerciale. Alla lettura integrale dei reperti si ha l’impressione che la Giulietta e Romeo del 1922 abbia messo di fronte per la prima volta due fazioni critiche contrapposte: e tale radicalizzazione la si percepisce dalla stessa prosa degli articoli di sostegno, più schierata del solito nell’opera di convincimento, se non in posizione di aperta polemica42. Coraggio, «supremo orgoglio» e onestà d’artigianato sono le doti riconosciute a Zandonai dalla maggior parte dei critici in questa sua impresa, a cui aggiungeremmo un inequivocabile spirito battagliero: e d’altronde non era forse come l’intrepido capitano di una nave in mezzo alla burrasca che appariva l’autore-direttore nella stessa denigratoria imagerie barilliana? Se il suo tentativo era stato quello di creare un prodotto nazional-popolare che andasse incontro ai favori del pubblico più vasto (a dispetto, si direbbe, del parterre du roi che avrebbe affollato la prima del 14 febbraio), ne fu ripagato proprio dalla risposta dei meno esperti, i quali si lasciarono volentieri suggestionare dalla nuova versione musicale del soggetto d’amore per antonomasia, reso in modo singolarmente sintetico ma con ricchezza di tratti piacevoli e di azzeccati coups de théâtre tra cui, abilissimo per ideazione e collocazione, l’episodio famoso – o famigerato, a seconda dei pareri – della cavalcata di Romeo. La cavalcata è un evento essenzialmente gestuale, non va valutata per i suoi meriti musicali ma per l’effetto che si propone: solo a questo patto non sarà rifiutata aprioristicamente come cascame di un wagnerismo deteriore. Nel suo tumultuoso svolgersi, l’interesse drammatico si sposta dal palcoscenico (vuoto) al golfo mistico, e il direttore d’orchestra, qui eccezionalmente gratificato nella sua immagine demiurgica, ne diventa il protagonista incontrastato. I suoni che l’orchestra in subbuglio s’incarica di convogliare portano irresistibilmente a un barbarico scatenamento di tensioni represse che il ritmo incalzante ed ossessivo conduce sull’onda della più pura irrazionalità. Poco importa che quella scansione non corrisponda affatto al ritmo naturale del galoppo: a nessuno verrebbe mai in mente di cercarvi corrispondenze realistiche. La cavalcata da Giulietta e Romeo appartiene al novero di quei ‘brani caratteristici’ della letteratura musicale moderna come il Boléro di Ravel o la Danza dei sette veli di Richard Strauss che sembrano assolvere al rito dionisiaco di liberazione catartica degli istinti e alla cui fascinazione ipnotica reclamante lo sbocco finale nell’urlo dell’ovazione si assoggettano spesso e volentieri, con la massa, anche il colto e lo snob. Questo era stato compreso talmente bene dall’autore che si convinse a predisporne una versione concertistica in abbinamento con la Danza del torchio, divenuta uno dei favourites dei concerti sinfonici per almeno due decenni43. Traspare abbastanza bene dalle cronache del 1922 quella passione al calor bianco che l’opera nel suo complesso era riuscita a suscitare, più che tra il pubblico aristocratico-borghese della platea e dei palchi, tra quello popolare appollaiato in loggione, ove sono registrate scene di dissenso 41 Cfr. n. 173. Mi riferisco qui al lungo articolo di S. Ruberti su «Musica» (n. 407) che smonta punto per punto la citata critica barilliana, la quale dovette apparire esagerata pure all’interno dell’esteso campionario di irriverenti stroncature di cui l’estroso musicologo marchigiano si era reso famoso. Va anche rilevato che tanto Zandonai quanto Rossato hanno sempre sostenuto concordemente che la stampa romana si era comportata in quell’occasione in maniera tutt’altro che amichevole nei confronti della loro opera, salvo rivedere le loro posizioni negli allestimenti successivi. 43 Va ricordato nondimeno che nella sua prima versione la cavalcata si spegneva nel pianissimo, rimanendo privata di quel finale à sensation al quale ci si è poi abituati. 42 1/24 / manesco44. Ma, esauritosi il clamore della prima comparsa con tutto il carico di entusiasmo connessovi, il lavoro andò man mano calando nella temperatura dei consensi, pur se alla seconda ripresa del 1924 con cast interamente nuovo e di qualità migliore l’evidenziazione dei difetti strutturali sembrò condotta con minore accanimento. Sei sono le produzioni che qui si documentano, l’ultima nel 1952, e il tracciato rivelato dalla rassegna stampa non fa che evidenziare malinconicamente la progressiva disaffezione del pubblico. L’ultimo blocco risulta addirittura patetico tanto i toni di chi ne riferisce sono sbrigativi, negligenti i commenti, amare le constatazioni di contabilità: Giulietta non fa più cassetta, la sala è riempita solo per metà. Codesta riedizione, che comunque ha un suo motivo di pregio nella presenza del tenore Franco Corelli allora al suo debutto romano, rivela tutti i caratteri dell’operazione di routine, niente più che un riempitivo per saturare il cartellone. Nel frattempo l’abbonato aveva avuto modo di individuare ed apprezzare i momenti migliori dello spartito e li attendeva con ansia. Sembra che l’atto meno felice nel riscontro fosse il secondo45 e che il quadro mantovano al terzo atto con la bella animazione del mercato e il successivo intervento del Cantatore contasse tra i momenti preferiti; invece stranamente quasi nessuno si ricorda di segnalare l’accorato lamento di Romeo “Giulietta, son io”, che però – va aggiunto – nella sua stesura originaria possedeva un profilo melodico meno individuato. Quanto al duetto finale al sepolcro di Giulietta, esso non riuscì mai a conquistarsi i favori del pubblico per quella sua certa prolissità e pletoricità che danneggia considerevolmente l’effetto drammatico della morte per amore. Di fronte alla rimessa in riga secondo il verbo del ‘ritorno all’antico’, che aveva presieduto all’ideazione di quest’opera, è da presumere che l’autore abbia fatto non poca autocritica; in ogni caso nella sua produzione a venire egli mostra di aver superato il limite tracciato per questa Giulietta. Se infatti la qualifica di “opera italianissima” lo poteva in quel frangente assicurare circa l’avvenuto raggiungimento del suo proposito, essa dovette altresì indurlo a rivedere proprio quei concetti di ‘italianità’ che, se intesi secondo i canoni classici, non erano certo stati rispettati fino in fondo. Lo stesso pubblico alla fine trovava questa partitura un po’ verbosa, densa, pesante e ingenerante una certa stanchezza come per troppo materiale da digerire. Se il computo degli applausi è mai servito a qualcosa, qui lo si vedrà rispecchiare con precisione pressoché aritmetica la fatica progressiva del pubblico – che però non si comprende come poi reagisse davanti a un’Elektra o a un Rosenkavalier – nell’assimilazione del lavoro, nonostante il surplus di adrenalina comminato un po’ a tradimento subito prima della scena finale con la suddetta cavalcata. Non inopportunamente, qualche critico si permetterà di suggerire dei tagli di alleggerimento, ancorché quelli poi effettivamente praticati non si siano rivelati molto destri, sacrificando essi tutte le parti di dialogo utili alla perfetta comprensione dell’intrigo, specie quelle riferite all’espediente del finto veleno fornito da Isabella a Giulietta46. Giulietta e Romeo è la creatura operistica che Zandonai ha preso maggiormente sotto le sue cure anche in veste di direttore d’orchestra, il che però non autorizza a dedurne che fosse in assoluto la sua preferita. I dati della sua diffusione, secondi solo a Francesca, interessano allestimenti veri e propri, registrazioni a cura dell’EIAR e circolazione via etere. A coronamento di tutto, l’opera fu prescelta insieme con altre sei a rappresentare l’Italia a Berlino nel 1941, in occasione degli scambi culturali tra i due Paesi alleati47, e ci andò nella stessa formazione presentatasi al Reale di Roma nel marzo di quell’anno, con Magda Olivero protagonista. Fu un inevitabile tributo da pagare ai tempi e alla storia, ma è escluso che da quel rito di ‘italianità’ esibita nel cuore del Reich a un pubblico di alti gerarchi l’opera se ne sia avvantaggiata nel ricordo postumo. La successiva ripresa romana, 44 In un tardo ricordo del novembre 1965, Luigi Miorandi Sorgenti rievoca sul «Gazzettino» quella serata che lo vide testimone oculare proprio in loggione. Secondo lui «si prevedeva ed intuiva una grossa battaglia e si temevano forti contrasti per questa nuova opera del nostro musicista» e parla delle «polemiche che essa suscitò tra critici e oppositori». 45 Vedi però la posizione un po’ defilata di D. Alaleona sul «Mondo» (n. 202), che valuta molto bene proprio il secondo atto cogliendone elementi di solito sfuggiti al resto della critica. 46 La soppressione del personaggio di Frate Lorenzo, la cui funzione nel dramma è convogliata da quello, inventato, della fante Isabella (che riassume in sé anche il ruolo della nutrice), non è che uno dei tratti in cui la sceneggiatura rossatiana si discosta dal modello noto. 47 Le altre previste erano: Un Ballo in maschera, Norma, Falstaff, La Fanciulla del West, L’Italiana in Algeri, L’Elisir d’amore: dunque la voce dell’Italia musicale contemporanea si era stabilito dovesse essere quella di Zandonai. 1/25 / avvenuta nell’immediato dopoguerra, vedrà le sue quotazioni drasticamente crollate. Si arriverà a dire che è «l’opera meno riuscita di Zandonai» 48. Se Conchita, con il suo tratto di generosa estroversione nei colori sonori e nelle movenze gestuali, si configurava come l’esempio più significativo dello stile giovanile del maestro, I cavalieri di Ekebù vanno intesi a buona ragione come i più rappresentativi dello stile maturo. Qui tutto si compone in una misura più sobria, e la verità espressiva è raggiunta tramite un lavoro ‘in togliere’ che rende la struttura relativamente più chiara e trasparente. Forse era bastato, ai primi ascoltatori del 1925, confrontare l’incipit di quest’opera, così freddo e immoto nella evocazione suggestiva degli spazi glaciali, con quelli di tutte le opere precedenti per avvertire subito il cambio di registro assunto da Zandonai nel definire in modo sintetico e interiore l’evento teatrale còlto nel suo clima dominante. Tuttavia la grande comunicativa che il compositore era riuscito a conseguire con la sua recente Giulietta e Romeo non andò perduta, anzi lo riconfermò nella sua idea di melodramma come di genere ‘popolare’, lontano da sperimentalismi troppo arditi ma nemmeno appiattito su poche formule inamovibili: insomma un genere colto ma sempre disponibile, nelle sue linee di fondo, alle esigenze del grande pubblico che sono poi le stesse di sempre: belle melodie cantabili appoggiate a una commovente storia d’amore. Rileva Alberto Gasco che nei Cavalieri le occasioni di pezzi ‘chiusi’, addirittura predisposti per ricevere l’applauso, sono più consapevolmente ricercate e che i disegni melodici sono più ampi e ariosi del solito, col rischio magari di risentire in modo «preoccupante» dell’influenza di Mascagni49; mentre, secondo una voce raccolta da Matteo Incagliati, la nuova scrittura zandonaiana sarebbe da intendere come un parziale allineamento alle istanze europee di decongestionamento sonoro e di essenzializzazione, tipiche ad esempio dell’estetica neoclassica50. Che poi il retaggio naturalistico tornasse riconoscibilmente a far capolino dimostra solo come esso si rivelasse ancora ineludibile per un operista italiano quando si trattava di dare efficace contorno ai momenti scenici cruciali e segnatamente al pathos amoroso e collerico. Ma intanto il maggiore autocontrollo esercitato da Zandonai sulle proprie predisposizioni all’enfatico porta a supporre che egli avesse fatto tesoro degli appunti critici mossigli dopo le fortune abbastanza alterne della sua precedente opera ‘nazional-popolare’ e vi reagisse con una riconsiderazione globale della sua drammaturgia, avviata ora verso maggiori sottigliezze di trattamento. Per cominciare, l’intento di adattare il proprio teatro a canoni più internazionali aveva indotto il musicista a misurarsi con un testo dagli assoluti caratteri di originalità, e anche in questo orientamento va letta una decisa reazione al recente passato, ché rispetto ad esempio alla stretta e un po’ coercitiva ambiance veneta di Luigi da Porto, i sapori della saga scandinava di Selma Lagerlöf costituiscono gli ingredienti della pietanza più esotica mai cucinata dallo Zandonai successivo a Conchita. Ci si è molto interrogati, anche in tempi recenti, sul quoziente di ‘nordicismo’ presente nel patrimonio culturale originario di Zandonai e si è cercato di giustificarlo con il fatto delle sue origini così propinque al mondo tedesco. Certo, le ragioni antropologiche hanno il loro peso indiscutibile, ma bisognerebbe anche vedere fino a che punto egli abbia subìto l’onda lunga di certe mode culturali di un passato non più recente ma ancora forti di un loro fascino per un operista: quelle che avevano prodotto, tra le altre cose, la Loreley di Catalani e Le Villi di Puccini; e più ancora quanto abbia consonato, da uomo del suo tempo, con certe espressioni musicali, moderne ma di impostazione tardoromantica, che provenivano direttamente dal grande Nord, in particolare con quelle di Jan Sibelius, un autore che ai tempi in cui Zandonai lavorava all’ideazione dei Cavalieri di Ekebù aveva già fatto conoscere tutte le sue sette sinfonie oltre a numerosi poemi sinfonici e musiche di scena. D’altronde, se il nordicismo era veramente un elemento fondante della 48 Cfr. n. 236. Cfr. n. 254. 50 Cfr. n. 360. 49 1/26 / personalità umana e artistica del Nostro, viene da chiedersi perché egli se ne sia occupato una sola volta, e sia pure per questa occasione importante51. Quella intrapresa non era stata una strada facile o priva di pericoli, né tale da essere prontamente intesa anche dalla critica più avvertita. Qui una volta di più si mise pesantemente in discussione la scelta del testo, sottintendendo che non bastava rivolgersi all’opera letteraria di un premio Nobel per avere un libretto perfetto; ciò malgrado fu riconosciuto volentieri ad Arturo Rossato di essersela cavata come meglio non si sarebbe potuto. In realtà non era pensabile adattare la Saga di Gösta Berling a libretto se non facendone tutt’altra cosa, tanto più che l’idea programmatica di base era di riportare i quadri della leggenda svedese entro una misura e una forma italianamente melodrammatiche. Il ritaglio di una piccola serie di episodi fra i tanti che il romanzo proponeva e la loro profonda modificazione nelle situazioni e nei personaggi aveva come scopo di incentrare un po’ forzosamente il fuoco della vicenda nell’amore affatto operistico della coppia assurta a protagonista; senonché non è sempre vero che una storia d’amore, anche se opportunamente esaltata nella presenza scenica, risulti un topos melodrammaticamente funzionante, quando non vi sia sufficiente materia narrativa che lo dinamizzi: e qui il rapporto tenore-soprano acquista un rilievo decisamente sproporzionato non solo rispetto al romanzo di Lagerlöf ma anche rispetto alle altre vicende umane presenti nel plot, pur risultando al contempo cospicuamente semplificato nella psicologia. Non sappiamo come e fino a che punto gli svedesi abbiano accolto il travisamento del loro romanzo nazionale e si siano riconosciuti nel prodotto ‘latino’ della ditta Rossato-Zandonai, ove fra l’altro il folklore musicale è tutto d’invenzione: si sa comunque che la versione dell’opera ritradotta nella lingua del posto sotto la supervisione diretta dell’autrice ha circolato nei primi decenni della sua storia con una certa frequenza presso i loro teatri, con giusto compiacimento dello stesso Zandonai. Nell’ambiente italiano non sfuggì che il musicista con quest’opera aveva aperto una nuova prospettiva nel suo percorso teatrale, e pertanto la statura dei Cavalieri di Ekebù apparve subito tale da competere con quella di Francesca da Rimini e in qualche caso di superarla. Tuttavia, per la novità del testo e dell’approccio generale, si crearono anche incomprensioni e malintesi. Nei casi meno favorevoli, l’operazione venne letta come un qualcosa di artificiosamente esotico e ricercato che disorientava gli habitués e non aggiungeva benemerenze al curriculum zandonaiano: il cambiamento di rotta appariva piuttosto esteriore che reale sì che, pur non negandosi le interessanti novità di un linguaggio sempre più scaltro e rifinito, tutto rimaneva ingabbiato nello schema convenzionale di un puro melodramma italiano, della cui linearità e funzionalità era però privo. La sceneggiatura di Rossato dimostrava non poche abilità di sintesi e felici intuizioni poetiche, come nella trovata del ‘teatro nel teatro’ al secondo atto (notevolmente arricchita nei confronti dell’originale) o nel poetico quadretto del Natale al terzo; il problema stava piuttosto alle origini, nella messa a fuoco di situazioni difficili e insidiose e di persone che stanno spesso tra il reale e il fantastico o che presentano tratti di assoluta inafferrabilità. La stessa Comandante delle ferriere, che si era voluto far assurgere al ruolo di co-protagonista, denuncia talora la sua inconsistenza di base quando nelle corrispettive parti del romanzo la sua definizione è vaga o nulla: se ne veda la presenza affatto gregaria lungo tutto il secondo atto. Un commentatore del tempo arrivò a dire che Zandonai, di fronte a un tale «pasticcio scandinavo», si sarebbe progressivamente disamorato del soggetto man mano che lo sviluppava, trovandosi costretto in qualche punto a ricorrere al mestiere per supplire a un’ispirazione che non poteva andare più in là dell’interesse iniziale52. Non vi sono pareri concordi al riguardo: qualcun altro riconoscerà a Zandonai una sincerità e una spontaneità assolute, il che concorderebbe con le affermazioni di lui secondo le quali il coinvolgimento nel lavoro era stato completo; altri ancora considererà i Cavalieri di Ekebù una riuscita solo parziale in quanto si sarebbe dovuto trarre maggior profitto dagli elementi del misterioso e del demoniaco anziché dell’amoroso abusato, avendo in mente magari la soluzione weberiana del Freischütz. Più che i momenti di accensione passionale, con il loro sospetto di fittizio 51 Si veda però la conclusione della sua breve intervista in seguito al trionfo di Stoccolma, quando espresse il desiderio di ripetere l’esperienza con una nuova opera di carattere nordico (cfr. n. 455). 52 Cfr. n. 250. 1/27 / e di pleonastico, piacquero le pagine, invero non poche, ove predomina il tono elegiaco e malinconico, la accorata espressione della nostalgia, la poesia del paesaggio boreale: vere oasi di espressione fine e contenuta. Furono viste con simpatia anche le puntualizzazioni bozzettistiche connesse allo sviluppo dell’elemento burlesco e caricaturale, che apportavano qualche istante di alleggerimento e di opportuno diversivo53. Proprio la presenza collettiva dei Cavalieri (e delle fanciulle) conferisce al lavoro il suo spiccato carattere corale e la sua particolare tinta sonora; inoltre nel finale, con il grandioso episodio del ritorno al lavoro nelle ferriere, essa contribuisce a rendere apoteotica la morte della Comandante, ritornata in extremis ad essere il deus ex machina della storia. In ogni caso il cospicuo ingrediente corale non poteva surrogare l’abbondanza dei dialoghi necessari a spiegare lo svolgersi della vicenda e percepiti alla lunga come un po’ farraginosi e ingeneranti quello che si potrebbe definire il ‘tedio del declamato’, tanto che per la prima volta riguardo a Zandonai si parlò partitamente di opera noiosa. Nella versione originale, prima che si attuassero le molte amputazioni invalse poi nella pratica, essa veniva ad essere anche molto lunga. Il fatto che nel marzo 1925 due diverse produzioni dei Cavalieri di Ekebù fossero allestite pressoché in contemporanea dai due maggiori teatri italiani54 evidenzia l’impegno organizzativo dell’Italia musicale del tempo nel dare il massimo risalto a un’opera nuova che in quei giorni costituiva l’evento spettacolare primario. La stampa si allineò al clima di forte attesa e di larga risonanza con ampie presentazioni comparse in anteprima, interviste, indiscrezioni e infine recensioni puntigliosissime come forse non era avvenuto nemmeno per Giulietta e Romeo. La ripresa al Reale nel 1938 fece rientrare il fenomeno entro ambiti più composti e distaccati, anche se non si rinunciò all’amplificazione clamorosa, com’è il caso de «L’Italie», il giornale in lingua francese di Roma, che pubblicò la sua recensione in prima pagina su quattro colonne. Va detto che la lettura meno analitica giovò al gradimento complessivo del lavoro, peraltro a quell’epoca già snellito dai tagli. Si scopre una punta di rammarico nella constatazione che Zandonai, con solo un po’ più di coraggio nell’abbandonare talune viete consuetudini melodrammatiche, avrebbe potuto segnare con questo quasi-capolavoro una svolta decisiva verso un nuovo tipo di teatro. Ancor più disincantate le opinioni critiche appaiono in occasione dell’ultima ripresa romana del 1954: se è vero che Rossellini, uno degli ultimi tenaci sostenitori rimasti, ribadisce l’alto impegno artistico dell’autore e spiega il declino della sua fortuna con la diversa struttura organizzativa del teatro d’opera nel dopoguerra che penalizza le produzioni nuove o recenti relegandole in poche repliche, altrove si guarda a quest’opera del 1925 come a un reperto assai più antico di quanto non sia, identificando il suo punto debole in quella sorta di impotenza a cantare in modo libero e spontaneo che era stata tipica di tutta la generazione di passaggio a cui Zandonai apparteneva. In questo clima di forte ridimensionamento dei pregi di Zandonai operista a dieci anni dalla morte, spicca per cinismo l’intervento di un notista il quale si chiede a che serva montare le opere di un autore moderno quando la scomparsa di questi libera dal vincolo di un omaggio o di un debito di riconoscenza nei suoi confronti55. Il suo voto è stato accolto: dagli anni Cinquanta questa partitura non percorre più le scene di nessun teatro italiano. «Riccardo Zandonai non è il temperamento musicale più incline ai rapimenti contemplativi» – osservava un critico all’indomani della ripresa romana di Giuliano56, non scorgendo premesse a una svolta misticheggiante in un autore che si era sempre distinto nell’espressione dell’amore carnale quando non di patologie del comportamento implicanti sentimenti torbidi e repressi. Era dai tempi di Conchita che Zandonai si portava dietro la fama di cantore esclusivo di passioni umane accese e violente, anche se il recente scarto stilistico attuato con I cavalieri di Ekebù avrebbe dovuto mettere sull’avviso che qualcosa stava cambiando nelle linee guida del suo mondo poetico. Anzi, l’approdo a Giuliano doveva apparire assai sintomatico del momento, in quanto testo programmaticamente 53 I Cavalieri di Selma Lagerlöf, oltre che innocui e simpatici cialtroni, sono però anche pieni di tratti negativi che Rossato ha volentieri evitato di trasferire nel suo libretto, preferendo conservar loro le caratteristiche appunto comico-patetiche e grottesche. 54 Milano, Teatro alla Scala, 7 marzo; Roma, Teatro Costanzi, 28 marzo. 55 Cfr. n. 276. 56 Cfr. n. 284. 1/28 / più intimo e scabro, lontano cioè nelle intenzioni dalla stagione tardo-romantica che in Zandonai può dirsi esaurita con Giulietta e Romeo. Proprio per questo ebbe a pagare un certo prezzo quanto a fortuna. Il caso di Giuliano è uno dei più irrisolti di tutta la produzione del maestro di Rovereto, né la presente ricostruzione documentaria contribuirà pienamente a chiarirlo: le cronache del 1928, a cui occorre fare esclusivo riferimento, benché ampie e circostanziate, riflettono una visione troppo lontana e parziale per essere del tutto soddisfacenti e non permettono di capire se l’opera sia da considerarsi niente più che un’incursione momentanea ed eccezionale in un terreno inesplorato o se il compositore vi avesse investito qualche progetto più solido e futuribile. È certo che non fu con favore incontrastato che l’opinione pubblica guardò alla ‘conversione’ di un autore così terreno e terragno ai temi dello spirito – e d’altronde sembra che un tale passaggio sia in qualche modo obbligato per la maggior parte degli artisti creativi, normalmente in seguito a una profonda crisi religiosa o esistenziale. Niente di tutto ciò è attribuibile – a quanto se ne sa – allo Zandonai poco più che quarantenne e con già sette opere all’attivo, se non la usuale inquietudine dello sperimentatore che non si accontenta del già fatto. Questa sua esigenza insopprimibile di misurarsi con un tema spirituale potrebbe addirittura configurarsi come un capriccio: che egli riuscì nondimeno a realizzare nei tempi stabiliti ad onta dei tentativi di dissuasione da parte della Casa Ricordi, subodorante non a torto un cattivo affare commerciale. Se le cose stanno così, la concretizzazione del disegno – che testimonia tra l’altro dell’autonomia di cui Zandonai godeva nella scelta dei soggetti da musicare – la si direbbe la riuscita azione di un artista per far trionfare le ragioni dello spirito sui meschini calcoli di profitto: una rivendicazione orgogliosa della libertà creatrice contro ogni mercificazione che tenda a controllarla e limitarla57. Se poi a indurre il compositore al cimento con cori angelici, bagliori ultraterreni e simbolismi oscuri fu anche il fuggevole richiamo di una moda, è cosa che andrebbe indagata più a fondo. Di fatto, la tendenza al mistico e all’esoterico nella musica europea del Novecento era più che una realtà fin dai tempi del Martyre de St. Sébastien o dei Poemi skrjabiniani, via Satie, e nello stesso catalogo italiano non mancano esempi probanti, da Pizzetti a Malipiero, da Respighi a Ghedini. Quanto a Zandonai, una certa predisposizione contemplativa di impronta panteistica si era manifestata da sempre nella sua arte (si pensi soprattutto ai primi poemi sinfonici, ai quali altri se ne aggiungeranno negli anni Trenta), laddove c’era da dar voce ai suoni della natura e tradurne in musica i messaggi arcani: un atteggiamento questo – va precisato – esteticamente più convincente di quello ‘ufficiale’ legato al culto, che in lui aveva dato e darà vita a pezzi piuttosto convenzionali. Ma soprattutto, per un artista curioso e indagatore com’egli era, il cambio di registro doveva essere occasione di uno stimolante esercizio di stile giustificato dalla volontà di ricerca e dall’esigenza di consolidare le conquiste recenti in un testo adeguato all’espressione stilizzata, esaurito il quale sarebbe tornato al suo mondo più consono: Giuliano rimase infatti un’opera unica e isolata, non inaugurò una tendenza né avviò un filone. Chi ha inteso l’approdo di Zandonai all’agiografia come una sorta di deviazione di percorso nella sua poetica più autentica non ha tenuto conto che un autore dalla natura concreta e sanguigna come la sua non avrebbe mai potuto correre il pericolo di cedere alla sdolcinatezza del santino zuccheroso. In questo, la sua opera rientra perfettamente nel modus operandi a lui proprio: il protagonista è anzitutto un uomo appassionato e ardente di vita (un altro dei suoi tipici tenori svettanti), la cui violenza innata è causa della sua caduta e insieme tramite della sua salvezza; un uomo per il quale la via della santità passa attraverso prove terribili. Vicenda aspra e guidata da un destino inesorabile, questo Giuliano è un dramma di contrasti estremi quali la vita raramente offre. Occorre dire che la storia è poco convincente? Ma i miti, le leggende, le fiabe, le vite dei santi non devono convincere, devono avvincere e, se presentate in teatro, fornire pretesto per uno spettacolo attraente, come avveniva nelle antiche sacre rappresentazioni. Con un libretto quale quello confezionato per l’occasione da Arturo Rossato, ove la natura selvaggia e brutale del primo Giuliano spicca senza attenuazioni per meglio definire il conflitto interiore che poi lo trasforma, la 57 Cfr. l’importante articolo di Fausto Torrefranca sull’azione, a suo dire nefasta, avuta da editori come Ricordi sui musicisti ad essi affiliati (n. 62). 1/29 / varietà dello spettacolo è assicurata, ma la veridicità rimane un problema estetico al di fuori dei suoi propositi, va accettata come atto di fede. Proprio la particolarità del racconto aveva richiesto agli autori una struttura non ordinaria che rendesse ragione dell’iter psicologico connesso alla figura protagonistica: così i due atti che rappresentano il suo dramma umano sono incorniciati da un prologo e da un epilogo che ne costituiscono la proiezione nella dimensione ultraterrena, prefigurata e riassunta nel primo caso, realizzata nel secondo58; ma con notevoli rimandi tematici ed espressivi dall’uno all’altro ed ampio ricorso all’elemento corale quale amplificazione ed estrinsecazione delle voci della natura e dei cori angelici esprimenti il sentimento panico e laudatorio. Si potrebbe correttamente intendere il genere del lavoro come una combinazione originale fra la tragedia, il mistero e il dramma, poiché la fatalità omicida – fulcro della vicenda e momento di svolta del personaggio – è in linea con tante azioni incomprensibili della stolidezza umana che generano lutti e sciagure e impetrano salutari lavacri catartici; mentre la rappresentazione icastica dell’evento ferale serve alle esigenze del dramma d’intreccio a forti tinte; così come poi quella edificante va a vantaggio dell’ammaestramento morale, nello spirito del teatro popolare del Medioevo. Sull’esito dei due piani narrativo-espressivi sembra che nessuno al tempo nutrisse dei dubbi (ma una verifica attuale sarebbe interessante): cioè la parte ‘drammatica’ ebbe una risposta più positiva rispetto a quella ‘mistica’, così che Giuliano ne usciva decisamente meglio come uomo peccatore che non come santo redento dalle mortificazioni e dalle preghiere. L’ambientazione della parte ‘storica’ presenta tratti di medievalismo, ma così vaghi che non arrivano a prevaricare e in ogni caso non sono più riconoscibili che in Flaubert, che però, com’è noto, non è la fonte primaria della presente riduzione librettistica, anche se non c’è dubbio che Rossato la conoscesse benissimo. Dove invece Rossato non seppe rinunciare alla preziosa verniciatura culturalistica è nel raffinato antiquariato lessicale che, pur nel pregio del verso sciolto musicalmente nell’endecasillabo, risulta troppo lontano dallo spirito di ingenuità della sacra rappresentazione a cui il testo idealmente si ispira. Attacchi quasi unanimi si meritò in sede critica la realizzazione della parte mistica allorquando questa esce dalla suggestione dell’aura di beatitudine celeste per avviarsi verso l’enfasi dell’apoteosi reclamante il tutto-volume della musica zandonaiana, con un accostamento periglioso alla retorica pompieristica tipo Mefistofele. Qui però si dovrebbe vedere come la scena era stata gestita in teatro, e se per caso l’effettistica non ne fosse uscita troppo assecondata. Lette in partitura, si tratta, per il prologo e l’epilogo, di due superbe pagine sinfonico-corali, utili fra l’altro a definire il modo di porsi zandonaiano nei confronti del simbolo. Musica spaziale e vaghezze impressionistiche ne sono i fondamenti, ma vi si notano anche una perdurante scrittura omoritmica, che accentua la suggestione di lontananza temporale, e una insolita ampiezza delle linee melodiche. Si sarebbe dunque preferito che una siffatta atmosfera fluttuante ed eterea fosse conservata fino in fondo anziché risolversi nella solarità aperta e calda della passionalità propria dell’autore che riporta un po’ troppo concretamente sulla terra, con tutti i rischi connessi di caduta retorica nella ricerca dell’effetto plateale. Tuttavia anche la parte ‘umana’ racchiusa nei due atti poteva incontrare qualche riserva per tutte le incongruenze di fondo pertinenti al tono di leggenda atemporale di cui il libretto aveva conservato le tipiche iperbolicità. Tale tendenza all’esagerato, all’esasperato, al patologico (che è cifra riconoscibile nella drammaturgia zandonaiana tout-court, quasi per una intima necessità del musicista di misurarsi con casi umani fuori dell’ordinario) è la chiave giusta di lettura di questo Giuliano, senza la quale l’itinerario umano dell’eroe eponimo apparirebbe poco convincente sia quando egli, cacciatore spietato, è visto preda di furori sanguinari, sia poi quando repentinamente si volge, sull’onda del pentimento, alla fede e all’amore universale: una conversione – osserva con molto acume uno dei critici esaminati – che non è vista nel momento del suo generarsi come in Parsifal, ma avviene per così dire tra un atto e l’altro, a dimostrazione della difficoltà per gli autori di ricavare dalla dinamica dell’intreccio una giustificazione plausibile59. 58 Cfr. nell’intervista a Lo Giudice il chiarimento di Zandonai circa la versione modificata di queste due sezioni estreme rispetto all’edizione napoletana di due mesi prima (n. 454). 59 Cfr. n. 379. 1/30 / Probabilmente oggi si sarebbe molto più disponibili nei confronti di un lavoro teatrale scarso di precisi riferimenti realistici o anche completamente astratto; non così a quanto pare negli anni Venti, quando il peso delle ‘assurdità’ e ‘inverosimiglianze’ si faceva sentire in modo determinante. A quei tempi di perdurante gusto veristico un melodramma italiano non poteva ancora trattare un soggetto di chiaro contenuto etico e spirituale prescindendo dai canoni appunto melodrammatici, tra i quali primariamente l’intreccio amoroso, magari rimosso o indiretto come in Suor Angelica. Per questo venne creata la dolce figura di Reginella, infelice compagna di Giuliano, che apporta alla corrusca vicenda il calore di un sentimento umano vivo e sincero, ma che, per la natura stessa della storia, non può assolvere in pieno il ruolo canonico di personaggio amoroso. Le scene tra lei e Giuliano difficilmente assomigliano ad autentici e soddisfacenti duetti d’amore, il rapporto umano tra i due elementi della coppia essendo quello di un’affettuosità quasi fraterna che ha il suo momento rappresentativo più valido nella poesia del focolare all’inizio del secondo atto e che la storia stessa esclude da amplificazioni passionali ardenti. È a Reginella tuttavia che Zandonai ha affidato il motivo melodico più ispirato e memorabile dell’opera, quella evocativa canzone dell’usignolo che intride di sé molta parte del materiale tematico successivo e che, esattamente come il lamento del Cantatore, deve la sua riuscita e il suo fascino alla giusta combinazione di semplicità popolaresca ed espressione intima e malinconica che tocca direttamente le corde emotive dell’ascoltatore. Da quest’esperienza unica esce dunque uno Zandonai a più facce, in parte riconoscibilissimo, in parte nuovo e inaspettato, e se pure Giuliano nel suo complesso risente dell’intento sperimentale, in molte delle sue scene fa intuire gli effetti di una meditazione originale. Gli attributi trovati dai vari critici per definire questa partitura sono talmente abbondanti ed eloquenti che una loro semplice e parziale citazione conclusiva potrà dare utile conferma della validità del lavoro così come in quei lontani anni era stata percepita. Si legge dunque su queste recensioni di «chiarezza», «scorrevolezza», «fluidità», «melodiosità», «trasparenza», «immediatezza», «limpidezza», «alleggerimento», «semplificazione», «purezza»... Il periodo di cinque anni che intercorre tra Giuliano e La Farsa amorosa (preceduta di poco dall’atto unico Una Partita) è tra i più lunghi se rapportato ai ritmi medi di lavoro produttivo mantenuti da Zandonai fino a quel momento, come se l’autore, dopo l’esperienza mistica, avesse sentito la necessità di sottoporre la propria poetica a un generale ripensamento e a una lunga meditazione, nonché a una radicale svolta, come il carattere opposto dei due lavori indurrebbe a ritenere. Per tutta una serie di motivi La Farsa amorosa suscita in noi non pochi interessi e curiosità. Anzitutto il fatto di essere rimasta l’ultima opera compiuta e rappresentata del maestro60 la rende importante nella considerazione e nella valutazione, sebbene essa, giungendo molti anni prima della scomparsa fisica di lui, non presenti alcun valore emblematico né tantomeno sia da intendere con funzione di testamento spirituale. Pure, se considerata in confronto con le altre del catalogo zandonaiano, essa non solo non risulta un lavoro minore ma si situa anzi ai primi posti per qualità e riuscita, ciò che rende abbastanza anomalo il fatto della sua circolazione oggettivamente scarsa nel corso dei decenni e l’assoluta trascuratezza degli studi su di essa. Se guardiamo allo stile di scrittura che la caratterizza, risulta evidente uno scarto, una discontinuità in direzione di un ulteriore alleggerimento di concetti e di strutture da vedere in linea con il momento storico e con i sempre latenti «istinti di natura non tragica» già notati in Zandonai da qualche critico più perspicace61. È significativo infatti che le colonne portanti del suo catalogo, quelle che lo reggono agli estremi, siano entrambe costituite da lavori ‘leggeri’, ma che anche negli altri centrali si individuino tentativi di conseguire attraverso un opportuno ampliamento dello spettro espressivo una più perspicua rappresentazione della vita in pienezza e varietà di atteggiamenti. Avviene così che qualche personaggio caratteristico, grottesco o apparentemente buffo intervenga a illeggiadrire il dramma degli eroi principali e attivi quel processo di allentamento delle tensioni, di abbassamento 60 Non si considera qui l’opera incompiuta Il Bacio, comparsa molto tempo dopo e mai rappresentata sulle scene, che per tutte queste ragioni è sempre rimasta distaccata dalle altre e chiusa in una specie di limbo riservato ai soli studiosi. 61 Cfr. n. 411. 1/31 / del turgore lirico, di appello al sorriso sfumato che sono i segni di una raggiunta saggezza e maturità artistica62. Definito autore «terrigeno e terragno, notturno e sensuale»63, Zandonai sembra riassumere in sé le istanze di un romanticismo realistico e umano che qui si sposa con una materia sanamente popolaresca e intrisa di sentimenti semplici e universali, trovando il pretesto ideale per architettare, con il tramite degli otto personaggi in gioco, una rappresentazione della natura umana disincantata e burlesca che inevitabilmente occhieggiava al modello archetipico del Falstaff. Il musicista che nel 1933 presentava per la prima volta al pubblico romano la sua Farsa era un uomo alle soglie dei cinquant’anni, il quale vantava ormai una posizione eminente e un prestigio indiscusso nel panorama musicale italiano: stimato, rispettato, premiato con riconoscimenti pubblici al punto forse da essere un po’ imbalsamato, messo in vetrina, superato dai miti di ‘giovinezza’ creativa che erano negli ideali dell’epoca. Ci si chiede come sia avvenuto che Zandonai, dopo l’esito ampiamente positivo di questo suo lavoro, non pensasse di dare più nulla al teatro d’opera. In parte dovette trattarsi di un fatto di stanchezza o di rinuncia – che però la sua intensa attività di sinfonista e concertatore sembrerebbe smentire – o meglio, come già si diceva, per una sorta di disamore verso una forma d’arte che gli aveva dato la fama e che ora era gestita dai poteri in maniera per lui penalizzante. È anche pensabile che si sia trattato di oggettiva difficoltà nel reperimento di soggetti adatti alla musicazione, ché in realtà la compulsazione e discussione di testi tra lui, Rossato e D’Atri continuò indefessa e arrovellata lungo tutti quegli anni. La situazione è poliedrica e va indagata anche nel versante psicologico, dove non si fatica a immaginare per il nostro autore una effettiva difficoltà ad accettare come proprie certune tendenze estetiche emergenti a quel tempo, risultandone per conseguenza un inaridimento della vena creativa, aggravato per giunta dal peggiorare delle condizioni di salute. D’altronde sarà opportuno non sofisticare troppo su queste considerazioni ipotetiche circa il silenzio zandonaiano negli ultimi undici anni della sua vita, ché una dozzina di opere all’attivo nell’arco di una carriera non lunghissima sono di per sé un traguardo eccellente per chiunque, specie nel difficile periodo di transizione in cui egli si trovò ad agire. I critici, non che di scrivere troppo poco, gli rimproveravano al contrario di avere la mano troppo facile e lesta, e in questo essi disconoscevano ingiustamente la sua notoria scrupolosità artigianale. D’altro lato non si impedivano di premere di continuo su di lui per sapere cosa era in preparazione nel suo laboratorio, alimentando nell’opinione pubblica attese e speranze forse eccessive per la sua responsabilità artistica, e purtroppo, per una equivoca visione iper-idealistica e antistorica cui non solo Zandonai ma nessuno a quei tempi avrebbe saputo corrispondere, si aspettava sempre il capolavoro illuminato e benedetto dall’afflato dell’arte superiore. Quello che è certo è che con Farsa amorosa il compositore si congedò dal teatro d’opera nel modo migliore, rivelando a posteriori di aver gestito la sua carriera con giusto calcolo di scelte, dando il massimo quando il vento spirava tutto a favore e le idee da esprimere erano tante, dedicandosi poi nell’ultima parte della vita ad amministrare i suoi successi e il suo nome attraverso un’attività essenzialmente di divulgazione. Nello scrivere questa partitura solare, schiettamente mediterranea, egli corrispose al generale slancio nazionalistico verso la riscoperta, lo sfruttamento, la nobilitazione delle radici tradizionali che era in atto allora in Italia. Tuttavia la sua incursione nel genere fecondo della farsa non si risolse in una facile ricreazione stilistica bensì fu da lui interpretata secondo una sua propria soluzione formale che ancora una volta spiazzò coloro che erano troppo ansiosi di apporre etichette. Si rinverrà quindi un certo sbandamento della critica tra chi crederà in buona fede di scoprire autentici motivi richiamanti le classiche tradizioni del ‘buffo’ e altri che lo escluderanno in nome di 62 Variamente distribuiti nelle opere zandonaiane, si trovano di questi personaggi caratteristici che implicano un codice espressivo diversificato: si pensa tra gli altri al pungente Ser Toldo di Francesca da Rimini (personaggio che per la sua appartenenza all’entourage di Ostasio da Polenta non ha comunque nulla di comico, così come il Giullare nella scena precedente incarnava, ad onta della sua funzione sociale di gaio intrattenitore, tutta la paura e la violenza che si respiravano nelle corti medievali), nonché a più d’uno dei Cavalieri di Ekebù. Quanto a Giulietta e Romeo, è motivo di rammarico che in conseguenza dell’estraneità della sceneggiatura rossatiana al modello shakespeariano sia stato sacrificato il personaggio del loquace e stralunato Mercuzio, che avrebbe potuto aggiungersi proficuamente alla galleria dei gioviali caratteristi: in compenso il Cantatore, creato ex novo, ha un bagaglio espressivo interamente malinconico (analogo sacrificio comporta la sostituzione della salace balia con la trepida fante Isabella). Va da sé che nella Farsa amorosa, anche in virtù di un libretto abilissimo, il processo di alleggerimento e di caratterizzazione da parte di Zandonai riuscirà del tutto compiuto. 63 Cfr. n. 314. 1/32 / un modernismo altrettanto irrinunciabile. Forse la sintesi migliore risulta alla fine quella compromissoria avanzata da Raffaello De Rensis che parla di «opera comica d’indole romantica e di sensibilità moderna»64, individuando nel suo riuscito mélange di stili e di approcci la ragione della sua riuscita ma escludendo un po’ troppo recisamente la eventuale componente neoclassica. Il critico infatti prosegue constatando che i personaggi «hanno più della comicità interiore, che è umana, che del grottesco esteriore, che è artificio», così che nella loro presentazione scenica prevale l’aspetto della profondità, dello scavo dei caratteri attinente alle «virtù psicologiche» che sono durevoli e non alle «frivolezze» che sono fugaci. Questo per dire che Zandonai aveva còlto, della farsa, il pretesto esteriore, legato alla possibilità di gestire in palcoscenico un’azione rapida e gustosa, ricca di inganni e di equivoci, ma senza abdicare alla sua natura fondamentalmente seria che reclamava pur sempre l’arioso patetico, lo sfogo lirico quali supporti alla situazione drammatica. Un altro esercizio di stile dunque, compiuto per arricchire il suo bagaglio di una nuova esperienza e insieme per divertirsi e divertire con una vicenda popolaresca e fortemente connotata nell’ambiente scenico, che in questo caso tratta di una Brianza di manzoniana memoria. Il compositore, insomma, segue ancora il criterio già adottato nella Via della finestra: quello di allineare nello stesso lavoro occasioni di spasso e momenti di sentita drammaticità, aperture al sorriso (mai al riso esplicito) e venature di malinconia, abbandono lepido e riflessione seriosa. Già si è visto come non fosse nelle sue corde la comicità aperta, sguaiata; quello che a lui mancava per natura e per eredità culturale era l’istinto eversivo e lo spirito caustico, nonché quell’umor acido che a Puccini, in quanto anche animato da spiritacci toscani, era tornato molto utile nel delineare efficacemente i gretti parenti di Buoso Donati. In Farsa amorosa le trovate sono forse meno irresistibili che in Gianni Schicchi, il ritmo è meno indiavolato, la comicità più sfumata, ma in questo il libretto ha una responsabilità solo parziale. Gli è che Zandonai non si burla delle sue creature: se mette in scena le debolezze umane non è con cinismo irridente che guarda ad esse bensì con la benevolenza e compartecipazione della persona comprensiva e assolutoria; sorride dei difetti umani ma senza mancare progettualmente di rispetto. Lo Schicchi rimane comunque un testo di riferimento ineludibile per l’uguale ricorso alle macchiette regionalistiche e a un linguaggio idiomatico usato per disegnare ridevolmente un quadro tipicamente italiano di pretta colorazione popolaresca65. Personaggi come il Podestà appaiono nel complesso inoffensivi nella loro stilizzazione di cattivi in maschera, e così il ripetuto raglio asinino che costui si becca e che dovrebbe suonare come una sorta di sonoro oltraggio al potere da lui rappresentato è più che altro una trovata da teatro di varietà: suscita il riso automatico ma non colpisce con la forza di uno strale. Con questo si vuol dire che don Ferrante, qualora sia correttamente interpretato, può perfino riuscire simpatico nell’esorbitanza della sua vanità pavonesca e del suo risibile abuso di autorità, pur trattandosi indubbiamente di figura di potente vessatorio. La parte autenticamente comica è riservata alle macchiette comprimarie (Frulla e Spingarda in particolare), che qui conoscono una vera riscossa; la coppia dei protagonisti amorosi vi fa da contraltare sentimentale, ma in questo ricadono in una caratterizzazione nel complesso meno originale e riuscita, nel suo ondeggiare tra comico e patetico. Lo stesso tenore amoroso (Renzo) palesa una qualche disinvoltura morale nel corso della vicenda, ma come Renato nell’altra opera del 1919 ha la sventura (teatrale!) di essere un marito fedele. In qualche modo si riproducono le smagliature sopra segnalate riguardo alla volontà di definire una comicità piena ponendo al centro della trama una situazione troppo seria e scarsa di sviluppi quale un matrimonio felice tra persone oneste che per di più sono state private di quelle puntualizzazioni caratteriali e somatiche presenti nel brioso Sombrero de tres pícos alarconiano. Non troppo ben fornita di femminile civetteria e di spirito capriccioso apparve così ai primi uditori la buona moglie Lucia, la quale si guarda dall’approfittare della corte assidua e ridicola di cui la fa oggetto il Podestà e dallo stuzzicare le di lui smanie per prendersene gioco e magari trarne qualche vantaggio personale; e viceversa si mostra incline a rifugiarsi troppo spesso in un inopportuno registro piagnucoloso correndo più di un rischio di diventare noiosa e poco interessante. 64 65 Cfr. n. 297. Ancora più patente risulterà il riferimento nel I atto del Bacio, con l’illustrazione grottesca dell’avidità parentale. 1/33 / In questa sostanziale ricaduta nella stessa impostazione della Via della finestra è da vedere il rispetto zandonaiano dei valori e delle maniere proprie della società borghese entro cui egli coltivava la sua arte nobile, signorile e lontana da ogni volgarità e dove non viene mai meno il tono di garbata eleganza che gli era connaturato. Lo stesso libretto di Arturo Rossato, pur non rinunciando del tutto a dar risalto a situazioni grassocce, si impegna a fornire il suo testo di immagini poetiche e di evocazioni naturalistiche, che qui, come d’uso, hanno una gran parte e formano un contrappunto ambientale riuscitissimo, in grado di stemperare l’acidità del clima farsesco nella dolcezza del quadretto idillico-pastorale. Pur con gli equivoci e i tentennamenti di sempre, specie in relazione alla funzione dell’elemento comico, l’opera, che veniva data a Roma in prima assoluta e sotto la direzione dell’autore, ebbe una risposta assai buona di pubblico e di critica. Il carattere particolarmente gradevole e simpatico di questo lavoro era stato percepito con sollievo da quanti auspicavano il rinascere di un teatro più leggero e spigliato nelle tematiche e nel trattamento dopo tanti drammi foschi e truculenti o anche scialbamente sperimentali. Non sfuggì a nessuno che Farsa amorosa si inseriva nella frenetica produttività operistica di quel periodo con ben più autorevolezza della media corrente, e che nel suo genere era sicuramente da considerarsi la più riuscita e quella degna di maggiore attenzione. Alcuni particolari d’impianto erano stati prontamente notati e apprezzati, primo fra tutti l’allentamento della struttura continua basata sul declamato a favore di una certa quale restaurazione delle forme chiuse, evidente soprattutto in momenti quali gli indovinatissimi pezzi concertati disseminati lungo i tre atti66. Naturalmente vi fu anche qualcuno tra i critici che prese le distanze in nome di ragioni superiori d’arte che qui sarebbero clamorosamente tradite, ma che a vero dire è forse un po’ pretestuoso invocare per un lavoro nato con intenti più modesti di sano artigianato: si veda fra tutte la posizione un po’ sprezzante di Fedele D’Amico che rappresentava all’epoca, con molto fervore giovanile, il partito dei ‘pizzettiani’67. Ma ciò che sembra distinguere Farsa amorosa dalle altre del nostro autore è l’enfasi messa nella valorizzazione dell’aspetto scenografico-coreografico ovvero il suo essere stata intesa progettualmente anche come occasione di spettacolo sfarzoso e di grande presa visiva, a cui contribuiscono armoniosamente e l’azione vivace e mossa, e la variopinta fastosità dei costumi ispano-brianzoli, e il susseguirsi di ‘quadri’ scenici popolareschi: vendemmiate, bicchierate, momenti di danza, passaggi corali. Un congedo, questo di Zandonai, sotto il segno della giocondità, quasi a voler lasciare testimonianza futura di un’arte che un giorno forse si sarebbe lasciata rimpiangere. 66 67 Cfr. n. 459. Cfr. n. 415. 1/34 / Obiettivi e finalità del lavoro - Natura e caratteristiche dei materiali cartacei L’origine di quest’impresa è riconducibile al Convegno nazionale di studi sulla figura e l’opera di Riccardo Zandonai tenutosi a Rovereto nell’anno centenario (1883)68, che fu occasione per un primo tentativo di fissare su serie basi metodologiche un discorso ad ampio raggio su questo musicista e sul ruolo da lui avuto nella cultura italiana del Novecento. Al momento delle conclusioni di rito Fedele D’Amico, che era stato l’autorevole presidente della due-giorni roveretana, aveva avanzato alcune proposte operative di cui, a suo avviso, la ricerca musicologica avrebbe dovuto farsi prontamente carico per un opportuno scandaglio della personalità artistica del maestro. Tra le più impellenti, D’Amico suggeriva una storia della fortuna critica ricostruita attraverso i contributi della stampa periodica: lavoro fino allora condotto con troppi caratteri di occasionarietà e parzialità per poter dirsi del tutto attendibile quanto a dati conoscitivi generali, e nondimeno prefigurante aperture e chiarificazioni assai stimolanti. L’appello dell’illustre studioso valeva anzitutto come indicazione di metodo, in quanto suggeriva agli interessati di perseguire un approccio di rigorosa scientificità onde sottrarre definitivamente i destini del compositore a tutte le residue e tenaci forme di ‘beatificazione’ sedimentatesi in una certa consuetudine critica provinciale di impostazione biografica e aneddotica, che per converso potevano aver determinato reazioni ugualmente deprecabili di rifiuto pregiudiziale. Tutto questo nella consapevolezza che il modo migliore per ridare smalto a una figura d’artista resa un po’ opaca dal tempo fosse quello di attrezzare un severo apparato filologico che intervenisse nel vivo delle poetiche e ne rischiarasse spassionatamente e con equanimità i lati esaltanti come quelli caduchi69. Il presente lavoro sulla stampa romana dichiara subito il proprio ossequio progettuale all’indicazione ermeneutica uscita dalla glossa a quel convegno, avendo come suo intendimento di contribuire, attraverso la nuda oggettività dei materiali e un supporto di commento essenzialmente metacritico, alla rimessa in discussione di una produzione operistica sicuramente ragguardevole che però, vista in prospettiva storica, mostra di aver mantenuto meno di quanto aveva promesso ai tempi della sua venuta alla luce. Nelle sue direttive pratiche, l’operazione è consistita nel disseppellire dagli archivi e dalle emeroteche, ove giacevano da decenni, tutte le fonti documentarie che riguardassero la vicenda pubblica delle produzioni teatrali zandonaiane nella Capitale, e nel predisporne quindi una raccolta sistematica e un riassetto per titoli secondo successione cronologica. La limitazione metodologica alla città di Roma si giustifica da più ordini di considerazioni e fondamentalmente dall’evidenza del dato quantitativo dei materiali recuperati, che ha sconsigliato per ora un’apertura di compasso ad altre realtà locali. Idealmente il lavoro si pone come pendant di un altro analogo, condotto diversi anni addietro e avente per tema l’attività romana di Zandonai quale direttore sinfonico70, differenziandosene tuttavia in ragione del peso informativo e documentario assai maggiore. Ciò si spiega facilmente col fatto che mentre la figura di Zandonai sinfonista poteva interessare l’opinione pubblica dell’epoca non più che a livello di momentanea curiosità e all’interno di un contesto ricettivo di 68 Gli atti sono pubblicati nel citato volume Riccardo Zandonai, a cura di Renato Chiesa, Milano, Unicopli 1984. Il momento più problematico della risposta pubblica a Zandonai, collocabile negli anni dal 1945 ad almeno i Sessanta, con qualche eco prolungatasi fin quasi ai nostri giorni, ha coinciso con un florilegio di pubblicistica di intonazione vittimistica che, lungi dal rendere giustizia alla figura del maestro, è servita spesso agli stessi cultori per un autoconsolatorio lamento sulla «misconoscenza» e il «tradimento» di cui il loro beniamino sarebbe rimasto vittima. Non si contano, sui giornali locali e non, le testimonianze e gli omaggi resi alla memoria del maestro attraverso due momenti canonici: quello della ritualità collettiva organizzata nelle pomps and circumstances celebrative (manifestazioni pubbliche, discorsi ufficiali, onoranze civiche, scoprimento di lapidi e busti, apposizione di ghirlande, messe in honorem e simili) e quello del compianto soggettivo nell’intimità del ricordo privato, della memoria sentimentale, con abbondante ricorso all’aneddotica minuta tesa a volte a una propagazione agiografica dell’immagine del personaggio; il culmine in tal senso è raggiunto da Renzo Rossellini in un suo tardo articolo intitolato significativamente Il Santo (cfr. n. 471). Non sfuggono alla regola del luogo comune neppure le due simpatetiche e edulcorate biografie scritte rispettivamente dalla cognata e dalla vedova del maestro in tempi non più recenti (Vittoria Bonajuti-Tarquini, Riccardo Zandonai nel ricordo dei suoi intimi, Milano, Ricordi 1951; Tarquini Zandonai-Tarquini, Da “Via del Paradiso” al n. 1, Rovereto, Manfrini, 1955), entrambe sostanzialmente inservibili per un utilizzo scientificamente improntato. Un approccio più moderno si riscontra nel periodo successivo al citato Convegno del centenario e segnatamente negli anni Novanta con lavori come quelli di Konrad Claude Dryden, Riccardo Zandonai. A Biography, Frankfurt, Lang 1999. 70 Cfr. Diego Cescotti, Zandonai direttore d’orchestra - I concerti di Roma, in «Quaderni zandonaiani» 1 e 2, Padova, Zanibon, 1987 e 1989. 69 1/35 / mera contingenza, la sua immagine di creatore di melodrammi risultava la più autentica e quella in grado di dominare in modo appassionante e duraturo il dibattito culturale in Italia per tutti gli anni in cui egli si espose alle ribalte. Nell’un caso come nell’altro, Roma si è rivelata la città d’Italia più di tutte sollecita ad accogliere l’attività del maestro trentino, a sviluppare le risposte più vivaci e stimolanti e a produrre i documenti e le testimonianze più eloquenti di quel dibattito71. Il massimo teatro della Capitale ha ospitato i lavori di Zandonai in un periodo che va dal 1912 al 2003, per un totale di 30 allestimenti comprendenti due prime assolute72. La fioritura giornalistica sviluppatasi attorno a questa produzione si è rivelata oltre ogni previsione doviziosa, talché a mano a mano che procedeva il lavoro di raccolta, è venuta ad acquistare dimensioni notevolissime. A completamento del lavoro, il blocco principale riguardante il discorso critico su ognuno dei suddetti allestimenti (escludendo per le ragioni anzidette il più recente del novembre 2003) si è attestato sui 319 articoli; ma invero si vedrà che quelli qui riprodotti sono in numero ben maggiore, arrivando alla non piccola cifra di 51073. È avvenuto infatti che nel corso dell’opera di acquisizione sia stata rintracciata più o meno casualmente tutta un’altra produzione di contorno, in vario modo attinente all’argomento, che dopo qualche esitazione iniziale si è deciso di affiancare all’altra per un opportuno ampliamento del dato cronachistico. I 189 pezzi supplementari sono stati pertanto sistemati in otto Appendici ragionate e organiche le quali seguono la seguente scansione: - Nella Ia Appendice trovano posto gli interventi dei giornali romani resi in occasione di rappresentazioni zandonaiane tenute in teatri di altre città. È chiaro che non si poteva evitare di documentare i resoconti, spesso amplissimi, delle grandi ‘prime’ alla Scala o altrove, specie nei casi eclatanti di Francesca da Rimini (Torino 1914), I cavalieri di Ekebù (Milano 1925) e Giuliano (Napoli 1928)74, e d’altronde si deve intendere questo come un campione alquanto ridotto, dal momento che solo i quotidiani più importanti come «Il Giornale d’Italia», «Il Messaggero» o «La Tribuna» potevano disporre di inviati speciali da mandare nei luoghi degli avvenimenti da recensire. Diverso è il discorso per le produzioni minori e provinciali, per le quali si sono rivelate assai utili quelle testate che come «Il Giornale d’Italia» erano fornite di edizioni regionali, con corrispondenti fissi. In casi come questi l’allestimento originale di un’opera di Zandonai, pur se indubbiamente votata a un’amplficazione minore a livello nazionale, assumeva per la realtà locale coinvolta un autentico valore di avvenimento a cui il giornale dava giustamente il massimo rilievo75. - Alcuni di questi articoli sulle varie opere sono sembrati rivestire un carattere più ponderoso di saggio, anche per il fatto di essere svincolati dall’attualità stretta dei giornali quotidiani ed essere collocati nelle riviste specializzate a uscita più dilatata. Si è pertanto ritenuto di differenziarli inserendoli in un’Appendice speciale (la IIa), con l’avvertenza che non sempre, per i brani a metà fra il saggio e la cronaca, è stato facile decidere in quale delle due rispettive Appendici sistemarli. Sono compresi in questa sezione anche tre programmi di sala del Teatro dell’Opera di epoca più recente. - L’Appendice IIIa raccoglie brani giornalistici più specificamente interessati alla figura di Zandonai uomo e artista: brani spurî in alcuni casi, che parteggiano un po’ della cronaca e dell’intervista. Vi si ritrova l’ormai noto racconto romanzato della sua infanzia a Sacco e della sua anomala e sacrificata educazione artistica, assieme a tutta una serie di servizi che mostrano il musicista nel suo côté privato. Questi ultimi, spesso notevolmente estesi e corredati di fotografie raffiguranti il riposo dell’artista nel buen retiro di Villa San Giuliano tra le sue occupazioni 71 Cfr. Diego Cescotti, La carriera musicale di Riccardo Zandonai vista attraverso una ricognizione dei luoghi, in Musica e società nella storia trentina, a cura di Rossana Dalmonte, Trento, U.C.T., 1994 e Id., Zandonai e la stampa romana, in Riccardo Zandonai nel 50° della morte, a cura di Renato Chiesa, Atti della giornata di studio, Rovereto, 11.11.94, Accademia roveretana degli Agiati, 1995. 72 Per un quadro completo si veda l’Elenco cronologico. 73 Per un migliore orientamento è stato predisposto un indice progressivo (v. Elenco degli articoli riprodotti). 74 Mi sembra anzi utile consigliare, per le suddette opere, di affrontare queste corrispondenze per prime e procedere successivamente con gli articoli romani, al fine di avere una visione più organica e cronologicamente corretta. 75 In questa Appendice sono considerati anche altri lavori non presenti nel panorama romano come Una Partita e Il Bacio. 1/36 / preferite, rivelano una cura particolare nell’offrire al lettore un’immagine quotidiana e simpaticamente accostabile dell’uomo famoso76. - Una piccola rassegna di scritti per mano dello stesso Zandonai (o forse meglio di qualche suo occasionale ghost-writer) è stata compendiata nell’Appendice successiva, la IVa. Il maestro, notoriamente, non amava affidare alla carta stampata le proprie idee o i propri programmi estetici, e dunque non ci si dovrà attendere di trovare qui dei brani di contenuto determinante. Si tratta per lo più di scritti legati a fatti contingenti, sotto forma di lettera al giornale o di pseudo-intervista. Dal campione affiora l’atteggiamento del musicista nei confronti di certi temi di attualità, che egli affronta con passione non disgiunta da vis polemica, rivelando tuttavia anche uno spirito sereno e una tipica predisposizione all’humour che addolcisce l’esposizione ferma delle proprie convinzioni. - Più abbondante la parte relativa alle interviste (Appendice Va), in cui il compositore è visto preferibilmente nella sua veste pubblica, ufficiale, sullo sfondo di un teatro nell’intervallo di una prova. Il discorso verte sul lavoro e i progetti futuri o si impegna, pur con una certa cautela, in puntualizzazioni estetiche. Una parte però è ancora riservata a questioni domestiche attinenti gli svaghi del tempo libero, a beneficio della curiosità del lettore comune. Queste interviste ricostruite a mente sui rapidi appunti di un block-notes e con ogni evidenza sottoposte ad intromissioni successive onde adeguarne lo stile e parafrasarne il contenuto possono sembrare, se confrontate alle attuali, un poco ingessate e formali e non sempre felici nella stesura. Ne esce comunque abbastanza bene il profilo di un uomo tutto d’un pezzo che si esprime per frasi nette, a tratti lapidarie: forse poco incline alla dialettica sottile ma capace in ogni caso di tener testa con passione e con spirito gioviale a un intervistatore sempre garbato e rispettoso. - L’Appendice VIa rende conto dei pezzi in memoriam apparsi su vari giornali quali omaggi alla figura del musicista scomparso. La rievocazione della vita e delle opere del maestro in essi contenuta può accostare questa sezione alle Appendici IIIa e Va, con in più l’ombreggiatura consona al tono ufficiale di cordoglio. Forse lo specimen avrebbe potuto essere più corposo se non fosse che nel giugno 1944, quando Zandonai morì, i giornali erano ridotti all’osso e occupati per intero dalle notizie provenienti dal fronte e, nello specifico, dai commenti sulla liberazione di Roma, avvenuta un giorno avanti il suo decesso. Più regolare si farà il rito delle commemorazioni nelle rispettive occasioni celebrative o anniversarie. - Nell’Appendice VIIa si trova un piccolo campione di pezzi che per eterogeneità di contenuto non si sarebbe saputo dove sistemare altrove. Essa reca nella seconda parte il lungo ma spigolato settore riservato al «Travaso delle idee»: non più che poche righe di annuncio o di commento in stile calembour, di nessun valore conoscitivo in sé, ma emblematico di un certo modo svagato e fulmineo di fare informazione culturale. Purtroppo qui gran parte del potenziale parodistico va smarrito per la nostra difficoltà o impossibilità di cogliere l’attualità dei riferimenti politici di allora nonché per la mancanza della vignetta di riferimento la quale, ‘travasando’ il concetto in immagine, ne costituiva l’indispensabile complemento. Quanto al curioso e anonimo reperto da “Quadrivio” (499), una breve giustificazione è necessaria. Esso probabilmente non intendeva fare alcun riferimento diretto a Zandonai, ma il tentativo di ricondurre il dramma di Francesca da Rimini a una misura di estrema sintesi e scarnificata lucidità espressiva – vale a dire agli antipodi di quella dannunziana – può forse dir molto su certe tendenze culturali del tempo: quelle diremo così nazionalistico-moderniste, ovvero futuriste, con le quali il pensiero zandonaiano ebbe sempre un po’ a scontrarsi, come meglio si constaterà alla lettura. - L’Appendice VIIIa assembla un ultimo quantitativo di articoli dai soggetti più varî ma sempre in qualche modo ruotanti intorno al musicista e al suo tempo. Si tratta di pezzi di cronaca, polemica musicale, appunti di costume, note di colore, per lo più in riferimento alla vita musicale romana e alle vicende del suo teatro d’opera, ma con qualche altra curiosità succosa (il fiasco al concerto dei giovani sinfonisti – rimarchevole anche come voce di un intransigente nazionalismo musicale emergente in quegli anni – ; il carteggio Pascoli-Zandonai, ecc.). L’ultimo pezzo della serie e dell’intera raccolta (il n. 510) è anche l’unico a non appartenere a un giornale romano; ma la 76 Questo è il settore nel quale l’interpretazione creativa prevale maggiormente sul dato oggettivo, con tutta una serie di approssimazioni riguardo a date, persone e particolari, che in qualche caso si renderanno immediatamente evidenti al confronto. 1/37 / competenza e lo spirito con cui si sofferma sulle cose della Capitale ne hanno imposto l’inclusione con funzione di ideale chiusura77. Al fine di meglio comprendere la particolarità ma anche i limiti di una miscellanea di questo tipo è necessario aver chiaro che essa, per il fatto di rivolgersi ad oggetti quasi completamente al di fuori della stretta attualità, è inevitabilmente limitata nella – o esclusa dalla – interpretazione di una reale valutazione critica dei fenomeni estesa fino ai nostri giorni. Ciò è tanto più evidente nel caso delle opere meno circolanti o addirittura rimaste senza giudizio d’appello, per le quali i commenti del tempo, apparsi sulla stampa come necessariamente provvisorî e suscettibili di variazioni e integrazioni, sono poi rimasti surrettiziamente fissati con carattere di definitività semplicemente perché è mancata l’opportunità di una controprova. Prescindendo da tali pericoli, insiti nella natura squisitamente precaria dei reperti, l’intento informativo non mancherà di esercitarsi purché si sappia correttamente scorporare questi ultimi dalla mera registrazione di contingenze evenemenziali per restituirli alla loro più vera essenza fenomenologica. Solo così quelle opere d’arte rese obsolete dalla cessata frequentazione sulle scene potranno esser fatte rivivere come tappe di una originale storia del teatro zandonaiano suscitando nel lettore antichi ricordi o stimoli per ulteriori indagini. Peraltro è evidente che proprio il drastico diradamento degli allestimenti avutosi negli ultimi decenni connota il presente corpus giornalistico in senso nettamente storico, al di fuori di agganci con l’attualità stretta. Le testate giornalistiche su cui si è attuata la ricognizione assommano a 7678 e comprendono quotidiani ‘storici’ ad alta tiratura che coprono l’intero periodo e altri importanti ma di vita più breve in quanto legati a particolari momenti politici, oltre a una costellazione di testate minime, uscite spesso per un breve spazio di anni o di mesi79. Non si è creata una distinzione espositiva tra quotidiani e altri periodici, fossero essi specialistici o più ampiamente culturali e di costume, né tra pubblicazioni destinate a un pubblico colto e altre riservate a una fruizione popolare: la natura dei contenuti risulterà abbastanza evidente da caso a caso. Un primo mutamento di approccio, di stile, di linguaggio si noterà forse nel confronto tra i testi del tempo di Zandonai e quelli del dopoZandonai, in ragione della perfetta coincidenza esistente tra la fine della vicenda biografica dell’autore e il crollo di tutto un sistema sociopolitico culminato nella guerra, con la immediata conseguenza di una profonda trasformazione nella visione, nel tono e nel contenuto informativo. Definire l’orientamento estetico delle varie pubblicazioni sarebbe discorso altrettanto pretestuoso quanto trovarvi sfumature ideologiche: i due aspetti peraltro vanno di pari passo. Si confida che la linea di tendenza di dedurrà facilmente di volta in volta al semplice riscontro della lettura e dopo essersi familiarizzati con testate e firme, specie nei casi estremi di aperto sostegno o di evidente ostilità alla proposta zandonaiana. Né fattori più esteriori connessi con la confezione del giornale valgono a illuminare i problemi. Ad esempio, quello che potrebbe sembrare un buon indizio rivelatore d’interesse da parte della stampa, e cioè lo spazio riservato nei palinsesti tipografici, si rivela in realtà troppo dipendente da contingenze pratiche per essere assunto a canone valutativo. A una visione comparativa, appare chiaro che l’estensione degli articoli è un dato che muta capricciosamente da periodo a periodo, così come variabilissimo è il numero complessivo delle pagine dei vari giornali, che vanno dal foglio singolo negli anni di guerra alle oltre cinquanta delle epoche vicine. Va osservato però che pezzi molto diffusi non mancavano nemmeno nei primi anni e che anzi, proporzionalmente alle dimensioni più modeste, si dedicava alle cose di musica uno spazio ben più ampio allora che non oggi. Del tutto speciale – e oggi impensabile, anche nel caso delle star più acclamate – è la collocazione degli articoli di recensione direttamente in prima 77 Oltre agli articoli di cui si è parlato, riguardanti nello specifico le rappresentazioni romane e più genericamente il discorso sulle opere e i giorni di Zandonai, è stato rinvenuto e raccolto un gruppo di reperti, in numero di 221, che per le più diverse ragioni non possedevano i requisiti per essere qui riprodotti. Si tratta in sostanza di meri annunci, brevi trafiletti, note redazionali anonime e simili scampoli, che nulla aggiungono al già noto ma che si è inteso comunque di segnalare in una lista apposita, dove possibile con un’indicazione sussidiaria tra parentesi che ne specificasse brevemente il contenuto: si veda alla voce Elenco degli articoli non riprodotti. 78 Si consulti per questo il relativo elenco (Elenco dei giornali e delle riviste). 79 Per completezza di informazione segnalo gli altri periodici romani consultati che però si sono rivelati sprovvisti di articoli su Zandonai. Essi sono: «Arte ed artisti», «Cosmopolita», «Il Giornale di Roma», «Libera arte», «Il Mondo» (settimanale), «Omnibus», «L’Ora d’Italia», «Il Reporter», «Supremazia», «La Vita artistica». 1/38 / pagina e a più colonne, onde ottenere la massima amplificazione di effetto: lo stesso Zandonai ne beneficerà in qualche occasione. Nemmeno sulla qualità intrinseca è possibile essere troppo schematici. Prevalgono numericamente gli onesti componimenti dei gazzettieri che assolvono alla loro funzione informativa senza aggiungere molto al dibattito culturale, ma che sono sempre in qualche modo utili a definire una media. Agli estremi opposti si situano i brani di alto livello concettuale ed espositivo – vere e proprie prose d’arte – e, dall’altro lato, le strampalate esercitazioni zeppe di errori e di improprietà, con l’aggiunta qua e là di qualche pezzo bizzarro e sorprendente. Non sempre le riviste culturali corrispondono alla dignità del loro compito, alcune anzi sono assolutamente deludenti; in compenso ne esistono di quelle dalle quali ci si può aspettare qualche contributo positivo: valga per tutte la “Nuova antologia”, prestigiosa rivista letteraria che annida abbastanza spesso tra le sue pagine scritti di cose musicali80. Quanto agli estensori degli articoli, il panorama è vastissimo. Delle molte firme emerse alcune sono ricorrenti, altre più occasionali, altre ancora trasmigranti da un giornale all’altro, non tutte identificabili con nome e cognome, anzi spesso camuffate sotto sigle, pseudonimi o abbreviazioni. Si è calcolato approssimativamente che coloro che hanno scritto di Zandonai sui periodici romani sono più di 150; di 130 di essi si conosce il nome per esteso81. Esiste tra essi la massima diversità di provenienza e di esperienza, dai critici togati o dai musicologi di professione ai musicisti momentaneamente prestati al lavoro esegetico, fino ai semplici pubblicisti-cronachisti di routine: anche qui la disparità qualitativa non abbisogna di alcuna premessa. Depone a favore della critica professionale il fatto che molti titolari di firma, da Gasco a Lunghi, da Barilli a Colacicchi, fino a Cogni, Alaleona, Mancini, Scardaoni, Alderighi, Viti, Ghislanzoni, Rossellini, ecc. fossero anche compositori in proprio, autori alcuni di opere rappresentate nello stesso Teatro dell’Opera, altri anche apprezzati esecutori. Si dànno casi di figure rappresentative di importanti entità culturali: Giorgio Barini ad esempio era dirigente dell’Accademia Filarmonica Romana. In compenso è mancato il contributo fattivo di una personalità carismatica di letterato-musicofilo, come Montale a Milano, che sapesse reinterpretare creativamente i testi recensiti coniugando competenza, genio ed estrosità. Il panorama dei periodici romani che coprono il lungo periodo analizzato è talmente variegato ed esteso da offrire più di una ragione al sospetto che nella presente rassegna qualche pezzo sia rimasto inevaso. Del resto le annate storiche conservate nelle biblioteche quasi mai sono integrali, vuoi perché lacunose fin dall’origine, vuoi per il loro stato di degrado che ne esclude la vista ai lettori almeno fino a quando non ne sarà affrontata la bonifica. La parte più cospicua degli articoli è stata raccolta presso l’emeroteca della Biblioteca Nazionale Centrale “Vittorio Emanuele” di Roma; ma si è fatto capo anche ad altre strutture capitoline come la Biblioteca Alessandrina sita presso l’Università “La Sapienza” e quella di Storia Moderna e Contemporanea. Le riviste musicali d’epoca sono state rinvenute per la quasi totalità nella Biblioteca del Conservatorio di Santa Cecilia; i programmi di sala nell’archivio del Teatro dell’Opera. Un’utile integrazione, specie per la produzione minore riferita a recite provinciali, si è potuta attuare dalla consultazione degli oltre 150 fascicoli conservati nel magazzino della Biblioteca Civica di Rovereto82. Si avverte in conclusione che è rimasta fuori dalla presente rassegna la non piccola attività esecutiva e di registrazione effettuata nelle sedi e per cura dell’EIAR, l’ente nazionale radiofonico, 80 Qualche curiosità desta il caso di tre riviste di argomento teatrale pressoché omonime: «Le Maschere», «La Maschera» e «Maschere», di cui le prime due di uscita contemporanea, tanto da far sorgere tra di esse una diatriba legale. In pratica, «Le Maschere» (“Rivista illustrata d’arte e di mondanità”) denunciava «La Maschera» (“Periodico illustrato di arte scenica e mondanità”) di essere una maldestra e sleale contraffazione; ma evidentemente la vertenza non si risolse se ancora dieci anni dopo il periodico incriminato risultava regolarmente distribuito. 81 Se ne veda la lista. 82 I casi di irreperibilità sono i più diversi. In alcune raccolte conservate («L’Italie», «Il Piccolo», «Il Quotidiano», «Brillante», «L’Impero», «Il Mondo», «La Maschera», «Maschere», ecc.) non è stato possibile, per i motivi suddetti, accedere alle mensilità richieste. In altre occasioni si è potuto avere il mese ma è mancato il giorno, ovvero si è trovato il giorno ma non la pagina in cui si presumeva la presenza di un articolo. Talvolta, anche in presenza della pagina, si è incappati in deturpazioni per ritagli o comunque in una condizione di illeggibilità per degrado. Controlli incrociati tra le diverse emeroteche non sempre sono andati a buon segno. Casi di mancata identificazione si sono avuti invece nella raccolta di Rovereto, con articoli privi di ogni contrassegno che permettesse di risalire alla testata e alla data di apparizione (i casi sono segnalati di volta in volta, oltre che in elenco). 1/39 / in quanto questa particolare produzione non risulta esser stata sottoposta a recensione giornalistica (ma un controllo in proposito non sarebbe inutile); mentre per quella inerente alla direzione di concerti sinfonici si rimanda ai citati «Quaderni zandonaiani»83. Tanto meno si è potuto indagare su altre presenze ufficiali o informali del musicista a Roma, per le quali sarebbe occorso uno spoglio capillare, pagina per pagina, di tutti i giornali disponibili. Al fine di ottemperare alle condizioni di massima scientificità, il corpus è stato presentato per intero e in versione integrale. Si sono soltanto omesse, in quanto inessenziali, quelle appendici di cronaca mondana riferite alle ‘prime’, composte da interminabili liste di nomi e, nel caso, dei titoli nobiliari dei più illustri fra gli intervenuti allo spettacolo: si è derogato, a mero titolo di esempio, solo in un paio di occasioni (cfr. nn. 77 e 199). In tutti gli altri casi, e con l’eccezione di sporadiche divagazioni fuori tema, non si sono operati tagli, e dunque nemmeno nei resoconti esecutivi e della messa in scena, non perché questi siano particolarmente illuminanti ma perché si è creduto utile avere un quadro anche della prassi esecutiva riferita alle varie circostanze e ai vari momenti storici. Come criterio generale di presentazione, si è optato per una visione organica, frazionando la materia per blocchi e procedendo opera per opera secondo l’ordine cronologico di comparizione, da Conchita a Farsa amorosa, sia per quanto riguarda le ‘prime’ che per tutte le successive riprese. Si è avuto cura di segnalare volta per volta l’eventuale corredo iconografico, costituito parte da fotografie, disegni, ritratti a matita e caricature, parte da riproduzioni di bozzetti e, più raramente, foto di scena. Quanto alla prosa dei vari articoli, si è ritenuto più pratico conservarla pressoché intatta, con rari interventi correttivi solo nei casi più ineludibili. Soprattutto è stato ritoccato, snellito e modernizzato l’uso della punteggiatura, che appariva spesso sovrabbondante e incongruo. Ci si dovrà dunque attendere di trovare qua e là frasi scoordinate, incomprensibili, palesemente scorrette nella forma e nel contenuto, che in quanto non aggiustabili sono state ricopiate tali e quali, senza alcun commento aggiuntivo, e tutt’al più con un qualche segno di evidenziazione. Dove è stato possibile individuare la svista o l’errore tipografico (ad esempio il salto di una riga), si è intervenuti con annotazioni in calce. Dove invece, per la cattiva qualità del reperto cartaceo, alcune parole o righe sono risultate illeggibili, si è tentata una ricostruzione a senso di logica, inserendo nei punti disastrati delle integrazioni tra parentesi quadre. Come regola generale si è preferito non correggere le piccole sgrammaticature e le storpiature dei nomi propri di persone o titoli di opere, per i quali casi si è introdotto il [sic]. 83 Dalle fonti note, le produzioni EIAR (poi RAI) a Roma furono, salvo errori, in numero di 15, come segue: 12.05.1929 Giulietta e Romeo 13.11.1929 Conchita 29.01.1930 Francesca da Rimini (sede non certa) 15.06.1930 Giulietta e Romeo (sede non certa) 29.07.1931 La via della finestra 14.09.1935 Giulietta e Romeo 17.09.1936 Una partita 03.10.1937 Giulietta e Romeo 08.12.1940 Francesca da Rimini 01.08.1942 Giulietta e Romeo 19.07.1947 Giulietta e Romeo [RAI] 25.11.1948 I cavalieri di Ekebù [RAI] 09.07.1950 Francesca da Rimini [RAI] 13.12.1958 Francesca da Rimini [RAI] 20.06.1972 I cavalieri di Ekebù [RAI] Quanto agli articoli sui concerti sinfonici romani diretti da Zandonai, raccolti e pubblicati per intero sui «Quaderni», essi assommano a 257, ai quali si è aggiunta in epoca successiva un’altra dozzina di reperimenti. 1/40 /
Scarica