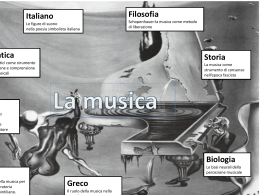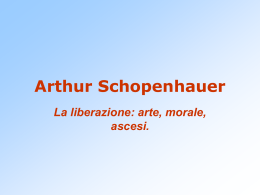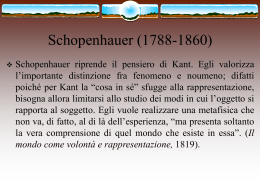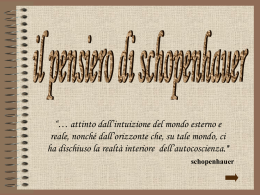Giustizia e compassione in Schopenhauer Ferruccio Andolfi La vita. Arthur Schopenhauer nasce nel 1788 a Danzica da un agiato commerciante, e da una giovane donna di vasta cultura, che una volta sottrattasi alla tirannia di un marito geloso, diventa una scrittrice di successo, animando i salotti letterari di uomini illustri. Una famiglia simile gli permette di avere un’ottima educazione e di arricchire attraverso molti viaggi la sua esperienza del mondo. Fin dalla prima giovinezza arriva a padroneggiare tutte le principali lingue europee oltre che il greco e il latino. La famiglia è però per lui anche una fonte di sofferenze: il padre muore suicida quando Arthur ha soltanto 17 anni, e in seguito i rapporti con la madre, a cui egli imputava qualche responsabilità, diventano assai difficili. La madre dal canto suo lo rappresenta, rivolgendosi direttamente a lui in una lettera, come un giovane pieno di grandi qualità, ma insop-‐ portabilmente saccente e destinato ad esacerbare l’animo di quelli che gli stanno intorno. A Weimar, dove la madre si trasferisce, conosce Goethe, che cita sempre con lode e resta uno dei suoi pochi interlocutori intellettuali. Anche se si guarda dal seguire l’ammonimento che Goethe gli rivolge: «Se vuoi gioire del tuo valore, devi conferire valore al mondo». La lettura delle Upanishad, testo sacro dell’induismo, insieme a un particolare sviluppo della filosofia kantiana, rappresentano le premesse della pubblicazione, nel 1818, della sua opera maggiore, Il mondo come volontà e come rappresentazione, che non ha però alcun successo, gran parte delle copie finiscono al macero. Né ha maggior successo una seconda edizione, apparsa nel 1844. Dal 1820 al 1831 insegna all’Università di Berlino, ma i suoi corsi, fissati provocatoriamente nello stesso orario di quelli di Hegel, vengono disertati dagli studenti. I tre «ciarlatani», come egli definisce i grandi filosofi idealisti Fichte Schelling ed Hegel continuano ad esercitare una maggiore influenza sui suoi contemporanei. Si sposta a Francoforte nel 1831, per sfuggire all’epidemia di colera. Alla fine degli anni ’30 compone due scritti di etica, Sulla libertà del volere umano, premiato dalla Società norvegese delle scienze, e Sul fondamento della morale. I paragrafi 14-‐20 di quest’ultima opera sono particolarmente importanti per le que-‐ stioni che affronteremo oggi. Nel 1851 acquista finalmente notorietà grazie a un’opera scritta in stile brillante, i Parerga e paralipomeni [Digressioni e completamenti]. Per questa via ottiene l’attenzione del pubblico anche l’opera principale, ristampata nel 1859, Muore nel 1860, a Francoforte. Il momento storico-culturale. Nei lunghi secoli in cui il cristianesimo è stato dominante ha rafforzato negli animi il bisogno di una meta finale della vita, la salvezza dell’anima o il Regno di Dio. Ma anche quando esso comincia a declinare continua a sussistere la nostalgia di una meta divenuta irraggiungibile. «Il pensiero di Schopenhauer – suggerisce un suo autorevole interprete, Georg Simmel – è l’espressione assoluta filosofica di questo stato d’animo dell’uomo moderno». Anche per lui c’è un fondo ultimo delle cose a cui tutto può essere ricondotto, la «volontà di vivere», un impulso instancabile che non trova mai soddisfazione perché non riesce ad andare oltre se stesso. La vita è condannata all’assenza di valore e di senso proprio in quanto non si è rinunciato all’idea che debba averne uno nella sua globalità. Possiamo intendere meglio il senso della posizione rappresentata da Schopenhauer se la confrontiamo con quella di Nietzsche, suo discepolo infedele,. Questi rovescia il sentimento dell’insignificanza della vita in quello della sua pienezza. Evoluzionista a suo modo, egli concepisce la vita come un processo di elevazione e accre-‐ scimento. Il problema dello scopo finale viene meno perché si acquista coscienza che la vita medesima, ogni suo momento, può diventare il fine della vita. Ogni stadio dell’esistenza umana non trova il proprio fine in un elemento assoluto e definito ma in uno 2 stadio immediatamente superiore in cui la vita è diventata più ricca. (Schopenhauer e Nietzsche, in Friedrich Nietzsche filosofo morale, Diabasis, Reggio Emilia 2008, pp. 75-‐86). L’egoismo e la malvagità. La relazione tra giustizia e com-‐ passione si situa nel campo della moralità. Per capire come viene affrontato il problema da Schopenhauer ci rifaremo innanzitutto allo scritto di etica prima ricordato, Il fondamento della morale. Ma il pieno significato di quei due termini può essere afferrato solo se li si colloca all’interno della visione complessiva della realtà, che Schopenhauer ci ha trasmesso nell’opera maggiore. La trattazione della moralità parte da una rassegna di ciò che non rientra in questo campo, vale a dire degli «stimoli anti morali». Lo stimolo a cui la generalità delle azioni sembrano obbedire è l’egoismo, cioè l’aspirazione a conservare la propria esistenza e ad assicurare con tutti i mezzi il proprio benessere. Normalmente è nell’egoismo che le azioni trovano la loro spiegazione. In questo significato fondamentale esso fa tutt’uno con l’essenza dell’uomo, che nella sua individualità è que-‐ st’aspirazione. La sua volontà è diretta a rimuovere ogni ostacolo che si oppone alla propria affermazione. «Vuole, scrive Schopenhauer, godere possibilmente tutto, avere tutto, ma siccome ciò non è possibile, almeno dominare tutto». Ognuno fa di sé stesso il centro del mondo e suppone che la propria fine rappresenti la fine del mondo. Questa presunzione di essere il centro del mondo, e un centro di infinito valore, dipende dal fatto che ciascuno percepisce direttamente se stesso, e degli altri ha invece una conoscenza solo indiretta, attraverso la «rappre-‐ sentazione». Questa forza autoaffermativa apre un largo fossato tra uomo e uomo, ed è considerato un miracolo che qualcuno possa saltarlo. Se non fosse contrastata da potenze esterne, terrene o ultraterrene, o da autentici impulsi morali, il risultato non potrebbe essere altro che la guerra di tutti contro tutti di cui parla Hobbes. 3 Nell’egoismo non viene ancora raggiunto il culmine dell’im-‐ moralità. In esso il danno altrui non è cercato per se stesso ma, se necessario, solo come mezzo per raggiungere i propri fini. La cattiveria e la crudeltà costituiscono un grado più alto dell’egoi-‐ smo in questo viaggio dantesco nel lato tenebroso della natura umana: per esse le sofferenze altrui sono un fine in sé dal cui raggiungimento scaturisce un godimento, che oggi definiremmo «sadico». Per frenare queste inclinazioni si è ricorso non solo alle potenze terrestri della polizia e dello Stato, ma anche a quelle ultraterrene della religione, che promette premi e castighi nell’aldilà a seconda del comportamento. Ma, osserva Schopen-‐ hauer, anche ammesso che queste minacce e promesse sortis-‐ sero effetto, le azioni non avrebbero valore morale perché sarebbero radicate nel puro egoismo di chi vuole ottenere un premio o evitare un castigo. Le azioni disinteressate. Il secondo passo per Schopenhauer è di stabilire che nella nostra esperienza esistono indubbiamente casi di azioni puramente disinteressate. In mezzo alla folla degli iniqui è indubbio che è dato ritrovare un piccolo manipolo di persone giuste. L’assenza di motivazioni egoistiche, che si ritrova in questi comportamenti, rappresenta il criterio delle azioni dotate di valore morale. La soddisfazione che si prova nel compierle e l’approvazione che esse suscitano sono indizi della loro esistenza. Ma Schopenhauer si propone di andare oltre chiedendosi che cosa possa indurre l’uomo ad azioni di tale natura. L’estensione delle azioni egoistiche è immensa. Esse non comprendono soltanto le azioni che hanno direttamente per meta il proprio vantaggio immediato, ma anche quelle che si prospettano vantaggi lontani, quali la stima degli altri o la salvezza eterna. Persino dei principi che sembrano essere indirizzati al comune vantaggio, come quelli universalistici di Kant («agisci soltanto secondo la massima che a un tempo puoi volere che valga come legge universale per tutti gli esseri 4 ragionevoli»), sono a ben vedere egoistici, perché chi li osserva si ripromette di beneficiarne come oggetto di attenzione da parte degli altri. L’unico caso in cui l’azione ha valore morale si realizza solo quando si ha di mira esclusivamente il bene dell’altro, si obbedisce cioè alla preoccupazione che l’altro non abbia danno ed ottenga anzi aiuto. Questo avviene a condizione che io soffra per il male dell’altro, sentendolo come mio proprio, che mi identifichi cioè in qualche modo con lui, annullando la differenza. Si tratta del fenomeno reale, e niente affatto raro, della «compassione», ovvero della partecipazione alla sofferenza dell’altro. La propria soddisfazione, e felicità, in questo caso è riposta nell’annullamento del dolore dell’altro. Questo avvenimento, che Schopenhauer definisce «miste-‐ rioso», rinvia per la sua comprensione, a una speculazione metafisica, che nell’opera etica che stiamo esaminando è ridotta a un breve cenno, mentre trova svolgimento nel Mondo come volontà e rappresentazione. Innanzitutto la compassione, nell’interpretazione che ne dà Schopenhauer, differisce da un meccanismo di simpatia che porti a condividere ogni genere di passioni, dolorose o gioiose che siano. Essa si riferisce alla sofferenza e non al benessere dell’altro, che si suppone lasci indifferenti, quando non suscita invidia. Perché mai questa limitazione? Perché ad essere immediatamente sentito è il dolore, la privazione, la mancanza, mentre la soddisfazione non è altro che la cessazione del dolore. Il positivo è dunque il dolore, mentre ciò che siamo soliti chiamare felicità risulta soltanto dalla cessazione di questo stato. La questione è piuttosto complessa. Feuerbach in seguito richiamerà l’attenzione sul fatto che per provare compassione è necessario avere una particolare sensibilità per la felicità propria e degli altri. Solo così la mancanza di felicità dell’altro può colpirmi. L’impulso ad essere felici è dunque l’elemento base della vita etica, e rispetto ad esso la compassione ha un valore relativamente secondario (Etica e felicità, Guerini e Associati, Milano 1992, p. 74 s.)-‐. Altri invece, come Simmel, noteranno che restringere lo sguardo agli effetti di piacere e 5 dolore delle azioni, per raggiungere conclusioni pessimistiche o ottimistiche, fa perdere di vista i valori oggettivi che si sviluppano attraverso le azioni. Le neuroscienze da parte loro confermano l’esistenza di meccanismi neurologici, prima ancora che psicologici, di consonanza ad emozioni altrui di ogni genere. La giustizia. Di fronte al dolore altrui posso reagire in un duplice modo: a un primo livello astenendomi dall’essere causa io stesso di questo dolore, o, a un livello più alto, recando un aiuto attivo. È il confine tra «non ledere» e «soccorrere», tra le due virtù della giustizia e dell’amore del prossimo, che si pos-‐ sono chiamare «cardinali», perché da esse proviene ogni altra virtù. Entrambe hanno radice nella «compassione naturale», un fatto innegabile che quando fosse assente metterebbe in forse la stessa «umanità». Qui c’è da notare, per quanto riguarda il nostro tema, che la giustizia è presentata come una modalità, la prima e meno elevata, dell’atteggiamento compassionevole. In parecchie etiche contemporanee essa tende ad occupare l’intero campo della moralità, e l’atteggiamento compassione-‐ vole viene persino estromesso da questo campo. Queste etiche riprendono un’antica tradizione, , che risale agli stoici, a Spinoza e a Kant, che lo stesso Schopenhauer ricorda e contro la quale si appella a Rousseau, profondo conoscitore del cuore umano, che ha tratto la sua sapienza non dai libri ma dalla vita. Dopo Schopenhauer, Nietzsche e più di recente Hannah Arendt hanno ribadito le critiche rivolte alla compassione, rappresentandola come una disposizione naturale, che espone chi la prova a un rischio fusionale, e umilia chi la riceve (per un’analisi di questa tradizione e quella che al contrario Schopenhauer inaugura si veda il mio Due modi di universalismo etico: giustizia e compassione, in “La società degli individui”, n. 18, 2003, pp. 7-‐ 20). Il primo influsso della compassione si esercita dunque nella forma di un’opposizione ai dolori che io stesso causo ad altri invadendo con la mia individualità, mossa da una incontenibile volontà di vita, la loro sfera vitale. La massima di non far torto a 6 nessuno, la virtù della giustizia, ha qui la sua origine. La proprietà e la persona degli altri diviene oggetto di rispetto. Negli animi nobili si forma una volta per tutte il proposito di rispettare i diritti di ognuno e di addossarsi sempre la propria parte di responsabilità per non addossarla agli altri. Il concetto di giustizia è negativo, essa ingiunge cioè di non far torto ad altri (il torto è il concetto positivo). Questo è in definitiva il senso di «dare a ciascuno il suo», di non toglierglielo. Proprio perché la giustizia impone soltanto di non ledere, essa può essere imposta da un organismo coattivo, lo Stato, che ha l’unico scopo di proteggere i singoli l’uno dall’altro e tutti insieme dai nemici esterni. Guai a fare invece dello Stato un’istituzione di moralità, come credono «alcuni filosofastri tedeschi» (l’allusione è allo Stato etico di Hegel). Contro le azioni lesive dei diritti lo Stato erige il baluardo delle leggi. L’amore del prossimo. I filosofi antichi hanno riconosciuto come virtù la giustizia ma non l’amore del prossimo (caritas, agape). In pratica è sempre esistito ma a parlarne e a considerarlo la più grande delle virtù, almeno in Europa, è stato per primo il cristianesimo. In Asia l’illimitato amore del prossimo era già stato oggetto d’insegnamento mille anni prima. Diversamente che nella giustizia la compassione ispira azioni positive, non mi trattiene solo dal ledere l’altro ma mi spinge ad aiutarlo. A costo anche di sacrifici e della stessa vita. L’origine di questo amore del prossimo sta nella partecipazione immediata, che non ha bisogno di argomentazioni. Qui il motto è «omnes, quantum potes, iuva»: da essa derivano quelli che sono stati definiti da Kant doveri della virtù o imperfetti. Per avere valore morale ed essere prive di ogni valore egoistico, le azioni devono derivare appunto dalla pietà. Nell’esercitare la compassione il mio motivo deve essere però unicamente il bisogno altrui. Se invece nella buona azione ho di mira il mio proprio bene, nelle mille maniere in cui ciò è possibile – una ricompensa in questo o nell’altro mondo, la stima che ne posso guadagnare, l’aspettativa che una universaliz-‐ 7 zazione della benevolenza possa un giorno venir buona anche per me – allora l’azione perde valore morale. Lo stesso accade se l’intento è quello di umiliare colui a cui faccio del bene o svergognare un terzo che non faccia del bene. (Qui Schopen-‐ hauer previene le critiche mosse da Nietzsche alla compassione come umiliazione dell’altro). Come dice il Vangelo, occorre che la mano sinistra non conosca ciò che fa la destra. Com’è possibile che un dolore che non colpisce me possa diventare un motivo mio e spingermi ad agire? È possibile se partecipo al suo sentimento, sia pure dall’esterno mediante la visione, se lo sento mio, eppure non dentro di me, ma dentro a un altro. Ciò suppone che io mi sia identificato con l’altro e che la barriera tra io e non io sia per il momento abolita. Allora non lo vedo più come un estraneo nonostante che la sua pelle non contenga i miei nervi. Questo procedimento è misterioso, la ragione non può renderne direttamente conto. Eppure è un fatto innegabile. Le neuroscienze ne hanno tentato recentemente una spiegazione con l’ipotesi dei neuroni specchio, che si attivano appunto in presenza di forti emozioni altrui. Ridescrizione metafisica. Le pagine finali del Fondamento della morale introducono al «mistero» della compassione, accennano cioè alle ragioni che la giustificano. Ma per una vera indagine su queste ragioni bisogna riandare alle pagine del Mondo (§§ 61-‐ 67). Questo, come suggerisce il titolo dell’opera, può essere considerato in due modi diversi: come mondo di rappre-‐ sentazione, costituito cioè attraverso le categorie che il soggetto imprime sui dati della sensibilità , situato nello spazio, nel tempo e in una rete di rapporti causali; oppure come oggetto di una percezione immediata, a partire da quella specialissima che abbiamo del nostro corpo. In questa seconda figura esso appare come l’effetto di una volontà di vita, che agisce ciecamente nell’universo, dando luogo alla varietà dei fenomeni. La volontà di vita è pensata da Schopenhauer come l’equi-‐ valente della cosa in sé, che Kant aveva ammesso in via ipotetica 8 come ciò che sta oltre il mondo della rappresentazione e le sue categorie. Proprio in quanto questa realtà non obbedisce alle leggi dell’intelletto, Schopenhauer afferma che procede in maniera cieca. La cecità del modo di procedere di questa forza cosmica fa sì che essa generi incessanti sofferenze. Possiamo formarci un’idea del suo modo d’agire a partire dal nostro modo di desiderare, che non mette capo a nessun soddisfacimento definitivo e, quando un bisogno è soddisfatto, sempre ci spinge in avanti producendo nuovi bisogni. Le pause di questo moto incessante non sono del resto meno dolorose: quando il desiderio si spegne subentra la noia. Anche se sarebbe più giusto dire che nel nostro desiderio si esprime quell’unica irrequieta e inarrestabile volontà di vita. Ogni essere vivente, infatti, mentre crede di perseguire i propri obiettivi, è un portato di questa forza. Tutto ciò che Fondamento della morale si trova espresso nel linguaggio dell’etica, può essere riespresso in termini metafisici e perciò stesso molto più drammatici. È quello che Schopenhauer aveva effettivamente fatto venti anni prima nell’opera maggiore. Ogni torto o malvagità appare allora come un contrasto della volontà con se stessa, che porta gli individui ad affermarsi in una lotta senza quartiere, cercando ciascuno di invadere il dominio dell’altro in una varietà di forme, che vanno dalla incorporazione fisica (cannibalismo) all’omicidio, alla lesione, al furto, alla riduzione in schiavitù, all’appropriazione del lavoro altrui. Il rimorso si spiega come l’oscuro sentimento che, nel momento di recar danno all’altro l’individuo raggiunge di tormentare se stesso, o, potremmo meglio dire, di essere il luogo in cui la volontà tormenta se stessa. La giustizia ha un carattere reattivo e derivato: «non si sarebbe mai fatta parola del giusto se non vi fosse l’ingiusto». Un quantità di azioni che pure sono indizio di sensibilità morale, come recare sollievo a chi muore di fame, non rientrano nel campo della giustizia. Questa si limita a negare la negazione che viene tentata della mia volontà, e può comportare l’uso degli stessi mezzi, violenza e menzogna, che sono stati impiegati per 9 commettere il torto. La giustizia è originariamente un concetto morale che impone limiti a chi intende commettere ingiustizia; quando invece ci si preoccupa di non subire ingiustizia, esso diviene giuridico, con l’invenzione dello Stato e delle leggi. Esso non deve porsi finalità morali ma solo di protezione dall’in-‐ giustizia attraverso l’imposizione di pene. Questa attribuzione alla pena di pure finalità di protezione sociale costituisce un notevole progresso rispetto a teorie, come quella kantiana, che concepivano la pena come semplice compensazione per la compensazione. «Nessun uomo ha la facoltà di stabilirsi giudice e compensatore in senso puramente morale» (Mondo, § 61). La pena non si riferisce, come la vendetta, al passato, ma ha solo uno scopo di deterrenza rispetto a chi volesse, in futuro, macchiarsi di delitti simili. Se non dovesse avere questa giustificazione la punizione si ridurrebbe a un secondo inutile male aggiunto a quello già accaduto.. A questa idea terrena di giustizia Schopenhauer affianca il concetto, sviluppato nel § 63, di un’«eterna giustizia». Se si abbraccia questa prospettiva, il mondo appare perfettamente giustificato, in un perfetto equilibrio di colpa e dolore. Ci si rende conto che esso è solo il risultato necessario della volontà che impone ad ogni essere di essere quel che è. Solo uno sguardo empirico sulla realtà, ingannato dal «velo di Maia», che ne offusca l’essenza, crede che il singolo individuo possa sottrarsi, in quanto sofferente, alla malvagità, imputata ad altri, quasi non fosse affar suo. La malvagità e il dolore colpiscono sempre l’unica identica essenza, anche se i fenomeni in cui questa e quella condizione si manifestano esistono come individui distinti. Tormentatore e tormentato costituiscono un tutt’uno: il primo sbaglia a non sentirsi partecipe del tormento, l’altro nel non ritenersi partecipe della colpa. Questa elevata dottrina, che vuole vedere più lontano del principium individuationis, toglie ai singoli l’illusione di poter condurre una vita felice e innocente in mezzo a innumerevoli dolori altrui, ma rischia anche di toglier loro ogni disponibilità a protestare e ribellarsi contro un destino comunque segnato, e per di più dichiarato «giusto». Sebbene 10 Schopenhauer rovesci di segno la razionalità che secondo Hegel dovrebbe governare il mondo, anche per lui «il mondo stesso è il giudizio universale». La giustizia come attitudine dell’animo comporta un primo riconoscimento dell’identità di natura dei diversi ego. Rinuncia a violare i diritti degli altri. Più in là, in questa via di «redenzione», Schopenhauer colloca la generosità, che spinge ad assumersi privazioni per attenuare i mali altrui. La povertà volontaria e l’ascesi rientrano in questo itinerario. Vengono ricordati gli esempi di Pascal e di taluni hindu. Questa dedizione fattiva indica che il generoso pone una minor differenza tra sé e gli altri di quella comunemente ammessa. Ciò provoca una serenità dell’animo, la sensazione di muoversi in un mondo di fenomeni amici, che convive con la coscienza del destino universale di dolore. Quando l’azione morale è ispirata alla fondamentale intuizione «questo sei tu», dove “questo” è ogni essere, cessa ogni influenza della conoscenza, astratta e inefficace, della imperatività della legge e del dovere (§ 66). Il puro concetto è infecondo per la virtù, non cessa di affer-‐ mare Schopenhauer, il vero amore è compassione che esclude ogni egoismo. Ma non è così semplice separare l’uno dall’altra. La partecipazione al bene dell’altro, ammette Schopenhauer, si mescola, persino nella vera amicizia, al compiacimento per la presenza dell’amico, per il fatto che la sua individualità corrisponde alla nostra. E il pianto, compagno della compassione, esprime, come Petrarca ha ben capito, «pietà per se stessi. Anche quando a muoverci al pianto è il dolore, o la morte altrui, questo avviene perché nel destino dell’altro scorgiamo il destino dell’umanità intera, e principalmente di noi stessi (§ 67). Questa pietà universale rende impossibile continuare ad affermare questa vita con continui atti di volontà. La virtù trova il suo prolungamento nella rinuncia e nell’ascesi. La castità è un primo passo sulla via dell’ascesi. Ogni sofferenza è benvenuta. Il male viene ripagato col bene. Mortificazione e digiuno fino al desiderio della morte come annullamento dell’essenza fanno 11 parte di questo percorso, che Schopenhauer trova incarnato nelle vite dei santi di ogni confessione religiosa. Questa negazione della volontà scaturisce da una conoscenza intuitiva e non da quella astratta dei filosofi, che possono trovare al più a posteriori nei concetti una giustificazione della condotta. Questa è la ragione per cui Schopenhauer ritiene particolar-‐ mente istruttivi gli esempi tratti dall’esperienza, dalle biografie dei santi, dei penitenti o dei pietisti cristiani. Nelle remote tradizioni a cui queste vite si sono ispirate si predica un amore del prossimo e la rinuncia a ogni egoismo; l’amore è esteso a ogni cosa vivente; la rinuncia si spinge fino alla donazione dello proprio guadagno quotidiano; si raccomanda un’illimitata pazienza verso gli offensori; si ricambia il male con la bontà; ci si astiene da nutrimento animale; è prevista una completa castità e la donazione del proprio patrimonio; si pratica la contem-‐ plazione in assoluta solitudine; la mortificazione della volontà è spinta fino alla morte volontaria (intesa come un lasciarsi spegnere e non nella forma del suicidio, che comporta un’affermazione della volontà in una paradossale ricerca della felicità assente in questa vita). La pratica diffusa già in epoche così remote e da parte di tante genti attesta che questo sforzo di superamento della volontà di vivere appartiene all’essenza dell’umanità. Per lo più la conversione a una vita ascetica è prodotta dall’esperienza del dolore direttamente provato, che nel migliore dei casi produce un allargamento della coscienza al dolore come condizione universale (§ 68). Questa rigenerazione ottenuta attraverso il distacco e la rinuncia genera uno stato di serenità e «muta tristezza». È una grande verità che Schopenhauer vede annunciata anche nella dottrina cristiana del peccato originale e della redenzione. La salvazione mediante la grazia appare estranea alla persona e anzi indica come necessario per essere operante «il negare, il sopprimere la persona stessa». L’effetto della grazia, o di ciò che Schopenhauer vi fa corrispondere: l’acquisizione di una supe-‐ riore conoscenza, è dunque la soppressione del carattere in ciò che ha di proprio e una grande somiglianza dei caratteri, per 12 diversi che fossero prima della soppressione (§ 70). Dal punto di vista filosofico la condizione così raggiunta di soppressione della volontà non può essere rappresentata che come una condizione privativa, come il nulla. Ma Schopenhauer lascia intendere, a conclusione della sua opera, che per chi ha superato il mondo e raggiunto una pace che sovrasta ogni ragione, un nulla appare piuttosto l’universo che siamo soliti considerare così reale (§71). Conclusioni. Per Schopenhauer la giustizia e la compassione sono solo tappe sul cammino della redenzione che comporta nel suo esito finale la negazione della volontà di vivere. Tuttavia il fascino di questa posizione non sta affatto in questa negazione ma piuttosto nell’intuizione che la vita di questo mondo non si regge senza l’azione continua e costante di sentimenti di giustizia e di forze compassionevoli. La soluzione prospettata da Schopenhauer alle sofferenze del mondo è attinta da tradizioni mistiche e monistiche occidentali ma soprattutto dai libri sacri delle religioni asiatiche. Malgrado ciò essa presenta, come è stato notato da uno studioso di religioni orientali, Giorgio Pasqualotto, una unilateralità che il concetto buddhista di compassione (Karuna) è ben lungi dall’avere. Diversamente dal Mitleid Schopenhaueriano, che esaurisce in sé ogni potenzialità etica, Karuna si rapporta ad altre tre virtù fondamentali: l’equanimità (Upekkka), la benevolenza non discriminante (Metta) e la gioia altruistica (Mudita) trovando in esse il suo equilibrio. Si inserisce in un itinerario di perfezionamento aperto a tutti, mentre Schopenhauer si limita a registrare la rarità dei comportamenti compassionevoli, dipendenti da caratteri individuali ritenuti immutabili. Infine Karuna non suppone alcuna fondazione metafisica e pertanto neppure un rovesciamento nichilistico (Buddha e Schopenhauer: Karuna e Mitleid , «La società degli individui, n. 18,2003, pp. 91-‐102). Il modo in cui è pensata la relazione tra giustizia e compas-‐ sione configura un’etica non intellettualistica, i cui valori sono immediatamente percepiti come veri piuttosto che giustificati mediante ragionamenti. Al filosofo spetta il compito di dare 13 ragioni ma egli non ha nessun titolo di privilegio per quanto concerne la pratica della vita morale. La giustizia non solo non esaurisce il territorio della morale ma è in qualche modo dettata dalla virtù più alta della compassione, è, si potrebbe dire, una compassione incipiente. Questa sua collocazione ne determina la qualità: la giustizia dovrà essere essa stessa compassionevole, e nel punire non potrà spingersi oltre l’obiettivo della sicurezza sociale. Quanto all’«eterna giustizia», essa equivale all’ordinamento dato dell’esistente. Il suo riconoscimento comporta l’abbandono di qualsiasi volontà di cambiamento per una sorta di abbandono fatalistico al destino. Nella compassione infine l’identità tra io e tu agisce nel senso di un’abolizione di quel limite, che la giustizia impone viceversa di rispettare. La scissione individuale tra i diversi esseri scompare. Ma così siamo al di fuori dell’antinomia di egoismo e altruismo. «L’unità assoluta dell’essere sopprime il tu nella sua esistenza particolare, ma sopprime anche l’io». L’azione altruista va a vantaggio di un essere assoluto e indifferenziato. La formula apparentemente altruistica della morale adottata da Schopen-‐ hauer – non far danno, anzi aiuta – descrive l’aspetto più estrinseco della condotta morale. Il motivo più profondo è espresso piuttosto dalla formula: «sii quel che sei», ovvero identificati con il tutto, perché «tu sei questo». Ciò non ha niente a che fare con una disposizione caritatevole (per quest’os-‐ servazione e quelle che seguono rinvio a G: Simmel, Schopen- hauer e Nietzsche, Ponte alle Grazie, Firenze 1995, p. 164 s.). L’invito «sii quel che sei», può indicare esattamente il contrario di ciò che ha in mente Schopenhauer, cioè che la nostra condotta viene determinata da una individualità inconfondibile, concepita come ultimo elemento dell’essere, senza riferimento a un’unità totale che sia al di sopra o al di sotto della persona. In questo caso quell’invito non significa «sii ciò che anche l’altro è», ma anzi «sii ciò che l’altro non può essere, ciò che esclusivamente tu puoi essere. 14 Se si aderisce a un simile punto di vista diventa impossibile concepire come unico valore morale la rinuncia a se stessi, perché propriamente diventa impossibile rinunciare totalmente a se stessi, negli stessi atti più generosi di dedizione. Al più si potrà fare distinzione tra forme più o meno elevate di egoismo e riconoscere una qualità elevata a quei comportamenti “egoisti” in cui l’affermazione di sé è perseguita attraverso un momen-‐ taneo oblio di se stessi e magari attraverso la stessa compas-‐ sione. Nel contesto definito da Schopenhauer l’altruismo perde ogni senso. Se dal punto di vista dell’istanza metafisica decisiva il tu vale quanto l’io, anche l’io vale quanto il tu, e non ci sarà ragione perché un’azione che procura a chi agisce una certa misura di felicità debba essere meno valida di quella che la procura al suo prossimo. Come mai Schopenhauer fatica ad intendere la distinzione tra fatti morali così diversi? Simmel risponde che questo dipende dal fatto che la sua natura è piuttosto estetica che non etica. Questo difetto di sensibilità per la dimensione etica potrebbe essere la ragione per cui manca in lui «una giusta misura per i fatti dell’ascetica e della negazione di sé», ed egli finisce per accettare persino le sue degenerazioni patologiche. Ammettiamo pure che il compito della moralità sia il superamento della dualità: la soluzione del problema non può consistere in un salto in un’unità trascendente senza che l’esi-‐ genza perda la sua serietà. Non è il salto in una unità indifferenziata che produce valore morale ma piuttosto la capacità di tenere in equilibrio le due forze che compongono l’individualità: il necessario riferimento a se stessi con la dedizione all’altro. Che cosa resta allora dell’insegnamento di Schopenhauer privato che sia del suo sfondo metafisico? Il richiamo a una vita in cui la compassione, intesa nel senso più lato, e quindi capace di aprire il cuore non solo al dolore ma anche alla gioia altrui, dia il tono alla vita di individui e comunità Le riserve che si possono avanzare verso un atteggiamento pietistico rivolto verso deter-‐ 15 minate persone, perciò stesso privilegiate, cadono una volta che si sia ammesso, con Schopenhauer, che essa ha una portata universalistica e abbraccia ogni altro e persino se stessi. Non c’è bisogno di supporre alcuna unità mistica né di far cadere il principium individuationis perché questo avvenga, L’etica di Schopenhauer, assai più che la sua appendice metafisica, allude a una situazione desiderabile di forte consonanza sentimentale degli individui, e sottrae giustamente l’agire etico alla razionalità di leggi da ritrovare faticosamente. La moralità si situa al di là dell’ambito in definitiva giuridico della legge morale: anzi, come abbiamo visto, è l’ambito giuridico della «giustizia» ad essere incluso in un più generale anelito alla benevolenza, che ne tempera il rigore. 16
Scaricare