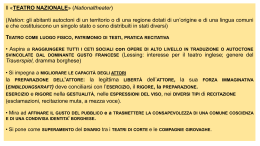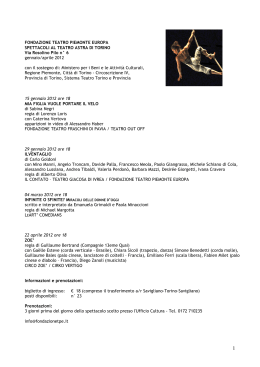STAGIONE 2015 2016 AMLETO di William Shakespeare Libretto di sala a cura di Claudia Braida Sabato 14 novembre 2015 Ore 21.00 LIBRETTO DI SALA Shakespeare: dati biografici essenziali 1564 William nasce a Stratford on Avon, nella contea di Arden e John Shakespeare, terzogenito di otto figli. Warwick, da Mary 1582 Si sposa con Anna Hathaway, più vecchia di lui di sette anni, e sei mesi dopo ha da lei la prima figlia, Susan. 1585 Nascono i due gemelli, Hamnet (che morirà fanciullo) e Judith. 1586 Shakespeare lascia la famiglia e si reca a Londra, dove trova lavoro presso The Theatre, di cui impresario James Burbage. 1597 Grazie all'amicizia con personaggi illustri, entra a far parte della compagnia del Lord Ciambellano. 1599 Inaugura il nuovo teatro The Globe, che gestisce insieme a Richard Burbage, figlio di James 1601 Inizia la stesura di “Hamlet” 1609 Diviene socio del Burbage nella gestione di un altro teatro, quello coperto di Blackfriars 1610 Shakespeare torna a Stratford, forse in seguito ad una malattia. 1616 Muore, nel mese di aprile. Elenco di tutte le opere teatrali di Shakespeare, secondo la consueta divisione in generi (proposta da Mario Praz) e la cronologia di E.K. Chambers: Commedie: Comedy of Errors, 1593-94 The Taming of the Shrew, 1594-95 The Two Gentleman of Verona, 1595 -96 Love's Labour's Lost, 1595-96 Midsummer Night's Dream, 1596-97 The Merchant of Venice, 1597-98 Much Ado About Nothing, 1599-1600 As You Like It, 1600-1601 Twelfth Night, 1600-1601 The Merry Wives of Windsor, 1601-1602 All's Well That Ends Well, 1604-1605 Measure for Measure, 1606-1607 The Winter's Tale, 1611-1612 The Tempest, 1612-1613 Drammi storici: Henry VI, parte prima, 1591-92 Henry VI, parte seconda, 1591-92 Henry VI, parte terza, 1592-93 Richard III, 1593-94 Richard II, 1596-97 King John, 1597-98 Henry IV, parte prima, 1598-99 Henry VI, parte seconda, 1598-99 Henry V, 1599-1600 Herny VIll, 1612-1613 Tragedie: Titus Andronicus, 1594-95 Romeo and Juliet, 1595-96 Julius Caesar, 1600-1601 Hamlet, 1601-1602 Troilus and Cressida, 1602-1603 Othello, 1605-1606 King Lear, 1606-1607 Macbeth, 1606-1607 Antony and Cleopatra, 1607-1608 Coriolanus, 1608-1609 Timon of Athens, 1608-1609 Pericles, 1609-1610 Cymbeline, 1610-1611 Per quel che riguarda le opere liriche, la composizione de Sonetti risale, sempre secondo Chambers, al 1595-1600; altri critici propendono invece per un periodo più ampio, compreso tra il 1589 e il 1609. Venus and Adonis fu pubblicato nel 1593, Lucrece nel 1594; al 1601 risale invece la pubblicazione di The Phoenix and the Teurtle Il male nelle tragedie di Shakespeare As if we were villains on necessity…and all that we were evil in, by a divine thrusting on. An admirable evasion of whoremaster man to lay his goatish disposition to the charge of a star! (Come se fossimo delle canaglie per pura necessità…e tutto quello ch’è in noi di malvagio, lo fosse per effetto d’un incitamento soprannaturale. E’ una bella scappatoia da vero bordelliere, quella d’affibbiare a una stella la nostra inclinazione alla lascivia!) (King Lear). E’ possibile tracciare, nella tragedia shakespeariana, un preciso confine tra colpa e fatalità, tra libertà e necessità, cioè, in definitiva, tra il peso che assume la responsabilità umana nelle vicende raccontate rispetto al ruolo rivestito da agenti esterni al comportamento umano? Le tragedie di Shakespeare si riconnettono senza dubbio a quelle dell’antica Grecia nel mettere a tema l’esistenza umana, i suoi nuclei problematici e il male che in essa si annida. Soprattutto le più grandi opere della maturità come “Hamlet”, “Macbeth”, “King Lear”, “Othello” rappresentano le tinte fosche delle passioni umane nelle loro spinte primitive e nei caratteri essenziali: il male antropologico e cosmico diventa in questi drammi una realtà oggettiva, onnipresente e quasi tangibile, capace di comunicare ancora oggi il brivido del diabolico. Nondimeno, secondo alcuni commentatori, Shakeaspeare prende le distanze dai drammaturghi greci proprio nel momento in cui elimina dal suo orizzonte il problema del rapporto dell’uomo con la fatalità degli eventi; Il Fato, si dice, è manovrato dagli eroi stessi e gli interventi soprannaturali divengono semplici convenzioni drammatiche per rappresentare i loro conflitti personali. E’ indubbiamente vero che, nelle tragedie del drammaturgo inglese, la situazione esterna non gioca affatto un ruolo fondamentale: l’interesse si rivolge ai personaggi e alle azioni che essi compiono nel corso della vicenda, conducendola fino all’acme. L’essere umano sta dunque al centro della scena come l’autentico oggetto di interesse: la tragedia si fa innanzitutto tragedia dell’individuo, di una singola personalità morale, di un destino determinato non dall’ereditarietà o dall’ambiente ma dalla responsabilità e dalla capacità di scelta. Rimane tuttavia indiscutibile, a mio avviso, in Shakespeare, la presenza di un elemento “fatale”: l’uomo, che pure agisce secondo volontà e in libertà, spesso non è in grado di prevedere le conseguenze delle proprie mosse e finisce col restare travolto dall’azione che lui stesso ha avviato. Inoltre, l’impressione che la maggior parte degli eroi shakespeariani ci dà è quella di appartenere originariamente a una natura libera e aperta, contraddistinta non dalla malizia bensì dalla generosità e persino da un certo candore. I protagonisti di queste tragedie appartengono solitamente ai più alti livelli sociali: principi o re, come Hamlet, Lear e Macbeth, o grandi uomini di Stato come Marco Antonio, Bruto, Coriolano e Othello, o membri di grandi famiglie, come quelle dei Capuleti o dei Montecchi. Ciò porta con sé che il destino di ciascuno di questi uomini di elevata condizione non rimanga un fatto privato, ma coinvolga una città, un regno, una nazione, un impero: il loro benessere e la loro rovina sono contemporaneamente il benessere e la rovina di molti. Ma più che questa effettiva nobiltà è significativa, come dicevo, la ‘nobiltà’ interiore da cui tutti questi grandi sono contrassegnati; rammentiamo le famose parole che Lady Macbeth rivolge al marito prima dell’uccisione di Duncan: I fear thy nature; it is too full o’th’ milk of human kindness to catch the nearest way. Thou wouldst be great; art not without ambition, but without the illness shoul attend it. What thou wouldst higly that wouldst thou holily (Temo la tua natura: è troppo piena del latte dell’eterna dolcezza per tener la via più breve. Vorresti esser grande; non ti manca l’ambizione, ma ti manca il malvolere che dovrebbe accompagnarvisi: quel che tu ardentemente desideri vorresti ottenerlo santamente (Macbeth). In Macbeth e nella maggior parte degli eroi shakespeariani noi riconosciamo degli esseri in qualche modo straordinari, percepiamo che in essi c’è qualcosa di colossale, qualcosa che ci fa ricordare le figure di Michelangelo. La loro imponente statura reca in sé i segni di una fondamentale bontà di carattere e di una profonda grandezza d’animo: ecco perché, anche davanti a coloro che si rendono colpevoli di orribili crimini, come appunto Macbeth o Richard III, non possiamo che provare, insieme al terrore e al disgusto, una pietà e un timore perfettamente ‘tragici’. Proprio sullo sfondo dei tratti eccezionali si staglia tuttavia, in ognuno di essi, una precisa ‘imperfezione’, costituita generalmente da una certa inclinazione all’irrazionalità e alla passione incontrollata. Nella vanità e nella sconsideratezza di Lear, nella sfrenata ambizione di Macbeth o di Richard, nell’eccesso e nella precipitazione di Romeo e Juliet, nell’indomita gelosia di Othello come nella passione ubriaca di Antonio per Cleopatra noi riconosciamo una decisa unilateralità, la forza di una pesante Fatalità che travolge l’eroe e lo sottomette alla violenza di impulsi incontrollati. Il cuore degli eroi shakespeariani, l’abisso della loro coscienza, sono abitati dalla possibilità fatale della colpa, da una componente passionale indistinta che minaccia di insidiare intelligenza e volontà, volgendole al male: A rarer spirit never did steer humanity. But you gods will give us some faults to make us men (Uno spirito più eletto non guidò mai la natura umana: ma voi, o dei, ci date qualche difetto per farci uomini) (Antony and Cleopatra). La nuova fatalità che il drammaturgo introduce non è dunque una legge estrinseca all’uomo e neppure appartiene al suo sangue, o al suo patrimonio genetico, ma è una sorta di debolezza del volere, di fragilità etica: è la minacciosa possibilità del peccato. Il “neo maligno” di cui parla Hamlet nella quarta scena del terzo atto sta appunto a significare metaforicamente tale impurità morale che l’individuo reca in sé. A causa di questa fatale imperfezione gli eroi shakespeariani si rivelano spesso incapaci di distinguere tra apparenza e realtà, non sono in grado di riconoscere la verità e di scegliere il bene. Ecco quindi la vanita di Lear, che preferisce l’affettata adulazione di Goneril e Regan alla sincerità di Cordelia; ecco la miopia di Othello, che crede ingenuamente alla bocca infernale di Jago e non alla purezza di Desdemona; ecco ancora Macbeth, ostinato nella propria ambizione quando ormai la sua disastrosa fine è già un fatto sicuro; ecco infine Antonio, portato alla rovina dalla sua smisurata passione. In Shakespeare la libertà umana si dà quindi in modo non assoluto ma sempre come libertà ‘segnata’ e, in qualche modo, ‘ferita’: non si insiste sull’inevitabilità del destino quanto nel dramma greco, appunto perché gli eroi non sono determinati dagli dei, o dalla necessità, o dal destino a commettere un atto ‘fatale’, ma dalla loro stessa volontà. Questa libertà del volere, tuttavia è infetta: il personaggio shakespeariano è fatalmente incrinato. Ci siamo limitati fin qui a considerare l’eroe e la sua parziale irrazionalità come centri della tragedia e cause fondamentali del suo svolgimento; occorre però osservare che spesso il male più concreto e raccapricciante viene posto da Shakespeare non nella persona dell’eroe ma in altri personaggi e precisamente nei “villains”, cioè i cattivi, le canaglie, nel ritratto dei quali il poeta impiega tutta la sua maestria. Tra le figure dei ‘peccatori lucidi’ stanno anche protagonisti come Richard III o Macbeth; quest’ultimo , in particolare, è il personaggio che più suscita, per la sua ambivalenza, una mescolanza di terrore e di simpatia, di sgomento e di attrazione. Nella sua complessa psicologia, a momenti di tormento interiore e di vivo rimorso si alternano momenti di irrigidimento glaciale: I have almost forgot the taste of fear…I have supp’d with horrors; direness, familiar to my slaughterous thoughts, cannot once start me (Ho quasi dimenticato il gusto della paura…mi sono saziato di orrori; lo spavento, ch’è compagno consueto dei miei pensieri di massacro, non è più buono a farmi trasalire) (Macbeth). Ma il vertice della capacità analitica e della sottigliezza immaginativa è stato raggiunto da Shakespeare con il personaggio di Jago, l’incarnazione diretta e unilaterale del male ‘allo stato puro’. Le macchinose azioni dell’alfiere di Othello non sono suggerite né dall’ambizione, né dalla vendetta, né dalla gelosia: egli si volge semplicemente al male in quanto male e prova un insulso piacere di fronte alla sofferenze altrui. In Jago Shakespeare dimostra, come già in Richard III, che spesso il male è compatibile con eccezionali doti intellettuali e con straordinarie lucidità e sagacia. Concludendo, il processo di antropologizzazione del male compiuto dal drammaturgo inglese fa sì che in qualche modo la tragicità dell’ingiustizia si acuisca nei suoi drammi: sono gli uomini stessi i fautori di enormi delitti e di mostruose crudeltà nei confronti dei propri simili, sono le loro coscienze che divengono capaci di concepire assassinii, mutilazioni, torture, menzogne: To be honest, as this world goes, is to be one man pick’d out of ten thousan! (Essere onesto, in un mondo che va così, è essere un uomo scelto fra diecimila!) (Hamlet) Claudia Braida Da AMLETO, versione di Filippo Gili “Solo, ora. Solo. E misero. Misero e vile. Misero, vile, servo e accattone. E’ mostruoso. E’ mostruoso, è mostruoso che un attore, per la passione del niente, un sogno di passione, entri a tal punto in un’immaginazione da diventare un altro, da diventare pallido, colle lacrime agli occhi, il viso sfatto, voce rotta, gesti e azioni tutto per dare vita a una immaginazione… nulla, cioè. Ecuba! Ma chi è Ecuba per lui? Chi è lui per lei da piangere in quel modo? E se gli infilassi nell’anima le mie, di ragioni, non dovrebbe inondare la scena di lacrime? Non farebbe sanguinare anche le orecchie di un colpevole? Non farebbe inorridire gli innocenti? Non li inchioderebbe tutti, innocenti, colpevoli, ignoranti? Mentre io? Fermo, piccolo, tardo, opaco, inetto, non agisco nel nome di un re, cui gente maledetta ha distrutto regno e vita? Sono un vile, io? Chi? Chi? Chi me lo dice? Chi mi dice codardo? Chi mi spacca la faccia? Chi mi prende per il naso? Chi ributta le menzogne in gola per inchiodarle giù, giù, giù, dentro ai polmoni? Chi? Dio… Dio! Come faccio a sopportarlo… ho il fegato di un coniglio, è evidente, sennò avrei già ingrassato tutti gli avvoltoi della zona con le budella di questo miserabile. Maledetto puttaniere! Schifoso, impudente, vile! Mi vendico!... Lascia stare, asino, hai un padre assassinato, il cielo e l’inferno ti chiedono di far giustizia, e tu qui a pulirti la coscienza con due bestemmie da serva e tre improperi da puttana. Fai schifo. Schifo! Usa il cervello. Il cervello. Ecco… può succedere che un colpevole, a teatro, possa essere così colpito da tradirsi involontariamente e confessare la colpa. Che è senza bocca, ma parla. Voglio far recitare ai miei attori qualcosa che gli ricordi l’assassinio di mio padre. Lo guarderò fisso negli occhi. E se avrà anche solo l’ombra di un fremito, saprò che fare. Hai visto mai lo spettro fosse un diavolo in maschera che ha deciso di dannare un povero cristo malinconico e fragile come me… prove ci vogliono, riscontri. E che ci sta a fare il teatro? Come altro la si agguanta, la coscienza del re?” Atto II, scena II “Essere o non essere. E’ questo il problema. Se c’è più coraggio nel tenersele nell’anima, le frecce e le pietre di una sorte infame, o nell’impugnarle, mettersi a combattere, e tentare di annientarle. Morire. Dormire. Nient’altro che dormire. E dormendo zittire il male al cuore, zittire i mille traumi di cui la carne è erede. Non c’è un epilogo migliore. Morire… dormire… dormire… forse sognare… ma qui ti blocchi, per dio! Perché se la morte funziona come il sonno, i suoi sogni quali sono? Che c’è di là? E’ questo che sospende, immobilizza. Questo dà alla tragedia il tempo di una vita intera. E chi andrebbe fino in fondo, sennò, a beccarsi ai fianchi le cinghiate del tempo, la sua faccia tosta, il suo fregarsene galoppando, l’arroganza e lo scherno dei potenti, il dolore di chi ama e non è amato, la lentezza delle leggi, la burocrazia che se ne frega, tutti gli schiaffi e i calci che una brava persona si prende dall’indegno, se si potesse chiudere il conto con un semplice pugnale? Chi vorrebbe continuare a quattro zampe, col peso della vita sopra, se non fosse la paura di che c’è dopo la morte ad incollarci qui, invece di volare verso un luogo da cui non si torna? E’ la coscienza che ci frega. E’ così che ci fa vili. Per questo l’argento vivo dell’agire scade di fronte all’ombra pallida del pensiero.“ Atto III, scena I Da: N. Fusini, Di vita si muore. Lo spettacolo delle passione nel teatro di Shakespeare, Mondadori, Milano 2010 “Non c’è verso né scena né atto dell'Amleto che non dica il problema del suo protagonista: il sentimento dell'impossibilità dell'azione, con l'angoscia che ne deriva. Impossibile è per Amleto passare all'atto, impossibile il passaggio stesso, in quanto esso mette in evidenza, per l'appunto, il problema del legame: se, nel passaggio, esso tenga. Perché è evidente che, se tra una cosa e l'altra, tra un tempo e l'altro, non c'è più la certezza del legame, allora il ritmo stesso della tragedia non potrà che essere impedito, ed essa sussulta. Arrestandosi, trattenendosi, il dramma crea in se il vuoto; voragini si aprono in cui precipita ogni ordinata sequenza. Del resto, v’é solo squilibrio in Amleto, oscillazione interiore tra il rifiuto e l'accettazione, movimenti dell'anima alternantisi tra l'obbedienza e il tradimento. Finché di vuoto in vuoto l’anima trapassa fino alla morte. All'inizio è una violenza esterna che crea il sentimento di vuoto nell'anima. Una morte improvvisa, inspiegabile, precipita sull'or fano che, tradito, esposto alla miseria della condizione umana, di fronte alla scomparsa del padre trema. Si ritrova nel fondo di abbandono, separato. C'è veramente un vuoto, e nell'anima di Amleto un'energia non orientata intasa di melanconia il cuore e lo impietra nel nero colore dell'abito. Poi, quando Amleto sa, l'energia trabocca in movimenti disordinati- la follia, l'aggressione verbale oscena, la repulsione per Ofelia, l'assassinio inutile di Polonio. Squilibrio dopo squilibrio, ogni gesto è eccessivo, e manca il proprio oggetto; anzi vuole mancarlo, come appunto chi desideri solo il vuoto, non l'azione che concilia, riunifica e risana. ll vuoto si fa interiore, prende Amleto in ogni sua fibra. Ha il sopravvento su ogni ragione: è forza cieca che lo guida insensata mente, al di la di ogni sua proclamata intenzione. Si che allo squilibrio risponde con uno squilibrio falsamente compensatore. Non v'è appunto che squilibrio nel mondo di Amleto: mai convenienza. E quando la si protesti, essa prende la figura barocca dell’ossimoro e del chiasmo, non la proporzione rinascimentale. […] Il legame, e cioè come fare nodo tra mondi diversi, è al cuore della tragedia shakespeariana, che da questo sforzo è condotta a trasgredire la forma classica. Nell'Amleto, del legame è messo in scena il rischio: che il legame non tenga è il problema. Si fa tragedia del movimento opposto, per cui ogni cosa si scinde e va a pezzi. “Dis- join” è qui la parola chiave. Tragedia è che non si riesca ad annodare una cosa con l'altra, che tutto si spezzi, «si sciolga, dissolva, risolva in rugiada» (I, ll, 129-30), e cioè in acqua che cola. In tale movimento dissolutivo l'anamorfosi trionfa, le forme generano altre forme, dilatano, raddoppiano… «Vedi quella nuvola, non ha la forma di un cammello? …Non sembra il dorso di una donnola, non sembra una balena?» (llI, ll, 38o-5). Amleto scherza al suo modo sadico, fa il pazzo con Polonio, ma è anche un sentimento intimo che esprime. Basta leggere il suo primo monologo: parla con se stesso, non finge, e confessa come un alone cresca intorno alle figure, come ogni contorno svapori in linee indefinite e indefinibili. Niente sta contenuto nel suo profilo. Il primo nodo a cedere è quello del Kin, che annoda tutti gli altri; e così pericola tutta la struttura. Sotto la scossa di questa dinamis trema la struttura dell'azione drammatica. Il nodo della generazione cedendo, si allenta il nodo del Tempo. Non è in mano di Amleto il tempo; a lui sfuggono le diatesi verbali, dimora nel frattempo. Anzi, l'interim di Amleto è l'evidenza stessa di come il tempo per lui frani nell'interruzione che intervalla e frattura il nodo del Tempo. Questa, del resto, abbiamo visto, e non altra è la colpa di Amleto: l'interruzione. Invece di porsi come figura che medi –metaxu, chiamerebbe tale figura Simone Weil -Amleto ostenta il buco nel Tempo. Cosi baroccamente esibito, il buco del Tempo rivela un'interna fermentazione dinamica dei tempi, in cui il soggetto non può prendere domicilio. Non re di Danimarca, pienamente investito del nome del Padre, e dunque destinato al trono, ma piuttosto re «di un guscio di noce» ( II,ll, 255) si vorrebbe Amleto. Preferisce senz'altro sostare nel sospeso intervallo del proprio indugio, piuttosto che muoversi nelle caselle di un tempo ordinato dalla parola di un Altro, venuto dall'aldilà per obbligarlo all'azione che, fosse in lui, non sceglierebbe di compiere. Nell'indugio, si potrebbe dire, Amleto trova la sua anima.” LA MESSA IN SCENA Note di regia E’ un progetto che nasce con Daniele Pecci. Quando Daniele mi ha chiesto se volevo curare la regia di un ‘Amleto’ con lui protagonista, è stato come ritrovarsi un ombrello sotto la pioggia. Era quello che attendevo. Ed è quello che faremo. Daniele, io, i miei soci degli Uffici Teatrali, e la Compagnia Stabile del Molise: mettere un ombrello sotto le infinite letture di un testo infinito. Un ombrello che copre una parte di mondo, il palcoscenico della rappresentazione, spoglio di letture forzate, unicamente teso al gioco di analizzare perché, all’alba del ‘600, nacque un uomo che vide il mondo uscire dai suoi binari. Se si fa Amleto, oggi, è perché è infinita la malizia di Polonio, è perché è infinito il torpore morale di Gertrude, è perché è infinita la dannata verginità di Ofelia, è perché è infinita l’intuizione politica di Claudio: un impero, da Don Chisciotte, passando per il potere dell’atomo fino ai microchip odierni e per chissà quanto ancora, si può mettere a soqquadro solo con l’ausilio di una goccia di veleno. Con Amleto si porta sulle spalle un peso che lo porta ai giorni nostri: quello di un vivere nel mondo, senza ‘esserci’. La nostra messinscena invade la sala non per blasfemia pirandelliana, ma perché intende tutto l’edificio teatrale come paradigma di Elsinore, come articolazione e ‘stacco’ di stadi scenici che si sviluppano tra platea, scaletta, proscenio, sipario e palcoscenico. Che sarà nudo perché realistica sia la percezione dell’autenticità ambientale. Con Polonio, protomartire della segretezza, della manipolazione invisibile, di quel nuovo mondo che Orwell sugellerà qualche secolo dopo, a gestire il sipario, ad aprire e chiudere quell’infinito ‘arazzo’ dietro cui non si nasconde e muore il consigliere del re, ma dove si nasconde e muore la coscienza di un pubblico troppo interessato a starsene al buio, per schivare comodamente i colpi di pugnale di principi e uomini che vorrebbero, solo vorrebbero, riassettare il mondo. Filippo Gili La Compagnia Stabile del Molise La Compagnia Stabile del Molise nasce nel 2010 dall’incontro artistico tra gli attori Paola Cerimele e Raffaello Lombardi. Il punto di partenza per questo progetto è l’esperienza svoltasi al teatro Comunale di Bojano in cui si è sperimentata una nuova forma di produzione teatrale che a partire da un lavoro capillare sul territorio della regione Molise si è poi sviluppato su tutto il territorio nazionale. Molte sono state le collaborazioni artistiche che in questi anni hanno consentito la produzione e la distribuzione di numerosi allestimenti. Dei tre progetti della CSM, due sono in coproduzione con Uffici Teatrali per la regia di Filippo Gili: Sistema Cechov e Amleto, quest’ultimo con Daniele Pecci; il terzo progetto è una sfida importante in collaborazione con la Fondazione Molise Cultura: uno spettacolo sulla prima guerra mondiale, “Il cappello di ferro”, che si avvarrà della drammaturgia e della regia di Emanuele Gamba. L’Amleto di Filippo Gili, un viaggio verso la regia…e ritorno Scritto da Ilaria Guidantoni, Venerdì, 27 Marzo 2015 Con l’occasione del debutto dell’"Amleto” a Montalto di Castro, nel teatro che fa parte del circuito dei teatri regionali, abbiamo incontrato nuovamente il regista Filippo Gili per un viaggio dietro le quinte e nei laboratori di un artista. «E’ un progetto che nasce con Daniele Pecci. Quando Daniele mi ha chiesto se volevo curare la regia di un Amleto con lui protagonista, è stato come ritrovarsi un ombrello sotto la pioggia. Era quello che attendevo. Ed è quello che abbiamo cercato di fare. Mettere un ombrello sotto le infinite chance di una lettura di un testo infinito. Un ombrello che copra una sola parte di mondo, il palcoscenico della rappresentazione, ma spoglio di letture forzate, unicamente teso al gioco di analizzare perché, all’alba del ‘600, nacque un uomo che vide il mondo uscire dai suoi binari.» Come si arriva a fare il regista, con un inizio attoriale? Qual è il ruolo della regia e il peso o l’eccesso del burattinaio nel teatro e nel cinema? Queste alcune domande nel corso di una conversazione per capire come la visione della regia di Gili lo abbia portato a riscrivere il testo classico, tra i più rappresentati insieme all’"Edipo Re” e quale sia il suo rapporto con gli attori; nondimeno un’occasione per riflettere sul rapporto tra le diverse figure sul palcoscenico nel teatro che cambia, anche all’indomani della scomparsa di un grande nome quale quello di Luca Ronconi con il quale Gili ha lavorato. In questo cammino a tappe mi prometto di assistere alle prove di uno spettacolo per assaporare il senso del cantiere fino a rileggere la rappresentazione guardandola da dietro le quinte piuttosto che dal lato del pubblico perché in fondo anche quest’ultimo fa parte a tutti gli effetti della messa in scena. Nato attore, ha incontrato la scrittura drammaturgica, per poi avvicinarsi alla regia. Un percorso graduale e non sostitutivo ed è in questa convivenza, mi anticipa Filippo, che sembra aver trovato la sua strada. Andiamo per gradi. «Lo spostamento sulla regia - mi ha confidato - è molto spesso un atto “isterico” che nasce da un complesso attoriale quando il cammino teatrale inizia con l’interpretazione e per una o più ragioni non risulta appagante. La regia conferisce un senso di potere, come quello del burattinaio, in parte conseguenza di un peccato originale del teatro moderno. A teatro, in effetti - diversamente da quanto avviene nel cinema - il punto di riferimento imprescindibile è rappresentato dagli attori e, in secondo luogo dal testo, anche se la regia è il filo che lega gli elementi, caratterizzandoli e dando unità». Per te il testo mi sembra fondamentale, probabilmente anche perché sei autore. «Credo che il passaggio alla scrittura teatrale abbia temperato possibili fughe in qualche modo deliranti. E’ il testo l’ancoraggio al quale fanno riferimento sia il regista sia gli attori e che consente la ripetitività nel tempo sebbene con infinite possibili varianti. Tornando alle origini del teatro, viene in luce la nascita da meccanismi liturgici che, messi per iscritto, possono essere ripetibili.» Qual è la malattia del regista allora? «La lacerazione tra essere la rappresentazione del potere senza in realtà esercitarlo se non in forme coercitive che purtroppo, diffuse, pesano sugli attori, ingabbiandone la creatività. Essa nasce a sua volta da un complesso di superiorità e inferiorità ad un tempo.» I suoi sintomi sono visibili sul palcoscenico? «Sono la ricerca di una codificazione personale quasi a priori. Spesso risulta troppo visibile la tentazione di raccontarsi e diventa una trappola che rende il teatro soffocante e vecchio. Ho l’impressione che negli spettacoli sia troppo forte l’odore del regista.» Probabilmente e tristemente è anche una regola del mercato, rendere riconoscibile un brand, il timbro d’autore, facilmente ripetibile con piccole variazione. Accade sempre più spesso anche nell’opera d’arte. «Solo che quando si è troppo definiti, si finisce per essere limitati, asfittici, se non sterili; prova ne è che non nascono scuole, direi proprio dai grandi artisti. Solo se e quando si arriva ad avere un buon equilibrio si riesce ad allontanarsi da se stessi.» Un processo complesso anche per uno scrittore: ad un certo punto però succede che si voglia prendere distanza dai propri personaggi dai quali ci sente perfino intrappolati fino a desiderare di giocare con l’invenzione creando realtà altre da sé. «A me ha fatto certamente bene diversificare l’attività teatrale, per cui non prendo nessun ruolo - l’essere attore, autore e regista - troppo sul serio. Credo che la regia sia l’infrastruttura del teatro, un elemento fondamentale in termini cognitivi ed estetici ma non la conditio sine qua non, considerato anche il teatro nella storia; diversamente si mortifica l’attore erodendone la libertà.» Non si può certo pensare al teatro in formule ma esiste una ricetta di massima? «La lettura del testo; la codificazione dei suoi punti cruciali per l’interpretazione; quindi la vita dove le emozioni consentono al teatro di passare nello spettatore e prima ovviamente di risuonare nell’interprete. Questo è possibile a condizione che l’anima sia viaggiatrice della parola e non semplice turista. Troppo spesso si è, al contrario, prigionieri della falsa modernità delle emozioni, dell’idea di libertà come erranza senza disciplina, quindi alla fine confusione scenica. A questo si aggiunga un elemento che sembra l’antitesi di un tale atteggiamento ma di fatto lo supporta: il manicheismo tra bene e male che ha contagiato il pubblico come il regista e quindi gli attori. C’è la preoccupazione di essere politicamente corretti, di offrire un giudizio sulla vita come valore aggiunto: il messaggio, sovente per altro non originale ma frutto dell’adesione a uno dei due schieramenti antitetici nella visione della vita.» In questo tuo spettacolo come traduci questa visione del teatro?<<Ho provato a regalare una pelle di toro agli attori sperando che costruissero una città, come Didone con Cartagine. Il regista deve segnare il tracciato…della libertà.» Come nasce la scelta per Amleto e che lavoro hai fatto sul testo? «E’ una mia lettura e riscrittura dove c’è un lavoro di semplificazione rispetto alla “schiuma” barocca che rende Shakespeare figlio del suo tempo, senza alterarne la storia. La passione per questo testo è nata una quindicina di anni fa e mi ricorda una triste vacanza per una condizione personale di sofferenza. Da quella prima lettura nacque “Macchia di grano”, una sceneggiatura sulla falsa riga dell’”Amleto”. La passione per questa storia, come del resto per l’”Edipo re” è quella per la centralità della famiglia. Qualsiasi uomo è solo il tralice che si attualizza nella relazione: è la famiglia che gli dà un nome e un cognome. La relazione familiare è l’archetipo dell’umano. Shakespeare lascia in tal senso un segno geniale perché ci racconta il passaggio dal mondo medioevale, quello del sensibile al periodo moderno e post-moderno dove domina l’invisibile: l’infinitamente piccolo inversamente proporzionale alla sua potenza, in grado di distruggere il colosso dai piedi di argilla. E’ questo il principio che porterà all’affermazione e al dominio dell’atomo, dell’inconscio - che non è semplicemente la dimensione onirica - fino al virtuale.» Scompare così la corrispondenza e la gerarchia tra due mondi a vantaggio del prevalere dell’entropia: cadono le certezze e dilaga il senso di precarietà e fragilità umana. «Teatralmente basta il “gioco” del fazzoletto di Jago per mettere in crisi una storia, annientarla. Solo ruminando il testo si coglie l’associazione tra piccolo e invincibile per la quale l’istante vince il millennio. E’ Polonio il vero vincitore, anche se viene ucciso. Sul palcoscenico si pone per la prima volta, nell’epoca moderna, la domanda sul senso della vita e si evidenzia il meccanismo dell’interpretazione e del vissuto psicologico che con il sipario ho cercato di visualizzare come la quarta parete.» In fondo nella tragedia greca che tu hai citato c’è molta più modernità che nel teatro successivo, anche se gli stilemi sono ovviamente figli del loro tempo, perché ci sono gli archetipi e in nuce con il coro si mette già in primo piano il valore dell’inconscio, ancora in termini collettivi: il ruolo prevale sul singolo. Un altro elemento che rende la tragedia greca classica è il transfert dell’azione scenica nel pubblico dove l’elemento didascalico non è a priori ma un vissuto in diretta. Come si traduce nel tuo teatro? «Con il tentativo di recuperare un teatro che passi in chi partecipa e non semplicemente assista alla rappresentazione, che è il vizio dall’affermazione della borghesia ottocentesca in avanti. In tal senso cerco di dare continuità allo spazio palcoscenico-platea mettendo spesso tutti in luce, come nelle prove, ed eliminando i costumi nei termini tradizionali. Ho anche cercato di ridurre, come ho accennato, quegli elementi estetici del testo shakespeariano che sono stati cristallizzati nel tempo e che già allora nacquero sia in linea con il gusto dominante sia per facilitare l’apprendimento a memoria. Ho cercato di semplificare senza involgarire, schiacciando gli arabeschi e le decorazioni eccessive senza tradire la complessità verticale del testo. Senza esagerare anche l’idea di imparare pedissequamente un’opera a memoria che ripropone la catechesi del teatro, lontana dalla mia idea di azione scenica sociale e interattiva, anche se il termine oggi è decisamente abusato.» Potremmo dire che la partecipazione deve se non superare accostarsi alla rappresentazione per non fossilizzarla. E sugli attori che tipo di lavoro hai fatto? «Ho cercato di rendere viva la parola anche evitando di imprigionarli nei costumi, pur mantenendo una coerenza con il linguaggio scelto e con la storia. L’ispirazione è quella di “Festen” e della festa di famiglia, caratterizzando i personaggi senza ridondanza. Ho inoltre provato a recuperare il sentire del popolo, quell’umore della plebe che è scomparso dalla nostra memoria. Come far sentire il marcio che c’è in Danimarca e che poi è ovunque? Attraverso il fumo che la gente della strada percepisce senza spiegarsi, come una nevrosi, una compulsione di fronte all’inconscio che ci dice che l’utopia è sconfitta e quindi qualsiasi tentativo di fuga o di lotta si rivelerà inutile. E’ come l’agitazione scomposta delle farfalle prima di un terremoto.» Com’è stata la risposta del pubblico e degli attori? «Mi è sembrata buona. Gli attori con i quali lavoro sono una squadra da anni, la compagnia Uffici Teatrali, e Daniele Pecci il mio Amleto, si è avvicinato proprio condividendo un teatro più vicino al vivo che al vero.» In questa tua visione pensi possa esserci spazio per gli attori da strada come avviene nel cinema? «Direi di no. Al cinema si può fare. A teatro questa soluzione è possibile solo marginalmente perché vige la legge della necessità di ripetere e ogni rappresentazione è unica ma nello stesso tempo si deve garantire ogni volta la qualità. Ci vuole disciplina e studio per poterli poi superare e scardinare se serve. Daniele Pecci, il mio Amleto ''Sono 25 anni che sogno questo ruolo. È il personaggio cui aspira chiunque in palcoscenico. Ed è il testo che, quando lo le lessi la prima volta, mi ha fatto capire che volevo fare questo mestiere''. Così Daniele Pecci diventa per la prima volta Amleto. Forse il ruolo più complesso per un attore, di certo quello che ha portato il volto di tutti i grandi, da Gassman in poi. Il principe di Danimarca di Pecci ha debuttato al Padovani di Montalto di Castro (VT) e si replica il 26 a Campobasso e il 23-24 aprile a L'Aquila, in un primo assaggio della tournèe più lunga della prossima stagione, nella versione diretta da Filippo Gili e realizzata con la Compagnia Stabile del Molise. Un banco di prova personale, ma anche una sfida produttiva collettiva. ''Sono stato più volte sul punto di interpretare Amleto racconta Pecci all'ANSA a poche ore dal debutto - ma con i tempi drammatici che corrono oggi per il teatro, in Italia e a Roma in particolare, non è mai andata in porto. Ora ci siamo riusciti, con i soldi con cui uno stabile non paga nemmeno una sola prova. Abbiamo tutti, me compreso, accettato una paga minima, più simile a un rimborso spese. Solo per amore del teatro''. Via tutti gli orpelli, dunque, nessuna scenografia, ne' costumi storici. 'Solo' 13 attori (che non sono pochi) a vivere la tragedia di Shakespeare in ogni spazio tra palcoscenico e platea con cordami a vista, luci in sala, il sipario che diventa l'arazzo del terzo atto e tutto il teatro trasformato nel castello di Elsinore. ''Abbiamo fatto della nostra debolezza, la mancanza di soldi - spiega Pecci - la nostra virtù. Il testo è quasi integrale e ci siamo riappropriati di quel modo di portarlo in scena che era già del Teatro Elisabettiano. Come allora gli attori indossavano abiti contemporanei con un particolare in più, una corona o un mantello, lo stesso accade a noi, che indossiamo smoking''. Ma perché proprio Amleto? ''Perché ogni volta che lo leggi, è come se ti parlasse per la prima volta - prosegue l'attore - Nella storia ha 30 anni, io 44: per arrivarci devi avere una certa esperienza. Ho riletto tutto il dramma dal suo punto di vista, liberandomi anche delle versioni che ho visto e amato, da Lawrence Olivier a Zeffirelli e Rory Kinnear al National Theatre. E ho trovato un Amleto diviso in due. Dalla vita in giù è figlio di suo padre e dell'epoca feudale. Dalla cintola in su è figlio del razionalismo, un uomo che deve riflettere su tutto. Da qui il suo immobilismo, il dramma tra ciò che dovrebbe e non riesce fare, i monologhi che sono le nevrosi di un uomo che parla da solo. Amleto pensa di mettere solo in scena la follia, ma il confine è molto sottile. Se dopo 400 anni riesce a parlarci ancora così - prosegue - è perché Shakespeare ha preso un uomo e la sua problematica impellente e l'ha elevata a preoccupazione del mondo e dell'uomo moderno. Il tutto, con parole bellissime. Finchè avrò forza e me lo lasceranno fare - assicura Pecci - continuerò a portarlo in scena, con questa versione di cui spero si apprezzi lo sforzo che va al di là dei rapporti politici con i grandi stabili. Perché in uno stabile io non sono mai stato neanche chiamato a fare un provino. E i privati devono fare cassa. Qui invece non ci guadagna nessuno''. Intanto a ottobre si torna in tv nella fiction di Canale 5 ''I misteri di Laura'', 8 episodi con Carlotta Natoli e Gianmarco Tognazzi, per la regia di Alberto Ferrari. ''Per la prima volta - conclude Pecci - sono un agente un po' alla 'Serpico', che parla romanesco e porta barba e capelli lunghi. Uno che viene dalla squadra anti-furti di Palermo e si ritrova a Torino, in un ambiente sofisticato, alle prese con casi cervellotici''.(ANSA).
Scaricare